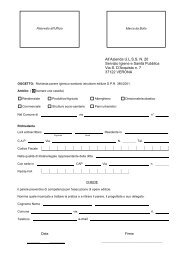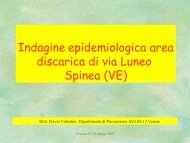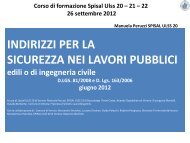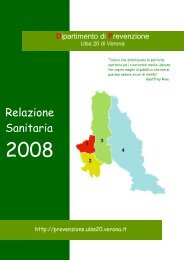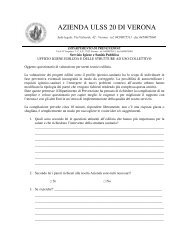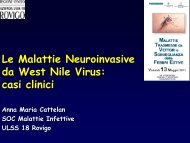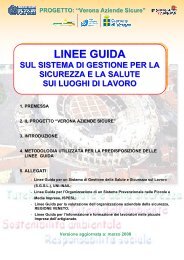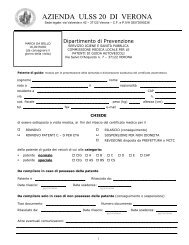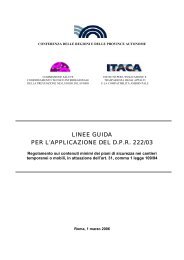Programmi - Dipartimento di Prevenzione Ulss 20 di Verona
Programmi - Dipartimento di Prevenzione Ulss 20 di Verona
Programmi - Dipartimento di Prevenzione Ulss 20 di Verona
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
5.0 Tutela della salute nelle attività sportive<br />
5.1. Tutela della salute nelle attività fisiche e/o sportive – lotta alla sedentarietà<br />
Referente: Massimo Valsecchi <strong>Dipartimento</strong> <strong>di</strong> <strong>Prevenzione</strong> Az.ULSS<strong>20</strong> <strong>Verona</strong><br />
Gruppo <strong>di</strong> lavoro: Mario Merzari SISP Az. ULSS 6 Vicenza, Luca Sbrogiò Ufficio <strong>Programmi</strong><br />
Regionali <strong>di</strong> Sanità Pubblica Az.ULSS 7 Pieve <strong>di</strong> Soligo (TV), Paola Corziali Direzione Sanitaria<br />
Az.ULSS 9 Treviso, Paolo Coin SISP Az.ULSS 15 Camposampiero (PD), Paolo Costa Servizio<br />
Assistenza Specialistica Az. ULSS <strong>20</strong> <strong>Verona</strong>.<br />
5.1.1 Descrizione del problema <strong>di</strong> salute<br />
L’attività fisica regolare è associata ad una vita più sana e più lunga. Le persone fisicamente attive<br />
hanno meno rischi <strong>di</strong> malattie car<strong>di</strong>ocircolatorie, alta pressione, <strong>di</strong>abete, obesità, e alcuni tipi <strong>di</strong><br />
cancro (colon).<br />
L’attività fisica inoltre contribuisce ad avere ossa, muscoli ed articolazioni in buona salute, riduce il<br />
dolore per artrosi, riduce i sintomi <strong>di</strong> ansietà e depressione. L’esercizio dell’attività fisica comporta<br />
dunque importanti benefici per la salute, a fronte dell’esposizione a modesti rischi che possono<br />
essere così riassunti: infezioni (micosi, verruche, infezioni dermatologiche varie), infortuni,<br />
esposizione ad eventuale inquinamento indoor, cui si possono aggiungere rari accidenti<br />
car<strong>di</strong>ovascolari.<br />
Nonostante queste evidenze epidemiologiche e le problematiche dovute a danni farmacologici<br />
(doping), il Servizio Sanitario Nazionale è tuttora orientato su attività <strong>di</strong> ispezione, vigilanza ed<br />
aspetti autorizzativi, non avendo ancora sviluppato adeguatamente gli aspetti <strong>di</strong> promozione alla<br />
lotta alla sedentarietà. Nello specifico l’attività dei Servizi Sanitari è costituita da: 1) attività <strong>di</strong><br />
vigilanza e controllo in fase progettuale, <strong>di</strong> realizzazione e funzionamento per: 1a) gli impianti<br />
sportivi in genere che prevedono il rilascio <strong>di</strong> agibilità da parte della Commissione Vigilanza<br />
Pubblico Spettacolo; 1b) impianti annessi alle strutture scolastiche; 1c) impianti natatori; 1d) pareri<br />
richiesti da enti pubblici e/o privati per l’apertura <strong>di</strong> palestre. E’ da evidenziare al riguardo che<br />
attualmente l’attività <strong>di</strong> vigilanza è <strong>di</strong> iniziativa e organizzata solo nel campo degli impianti<br />
natatori (Circolare M.S. 1971 n. 128). Il SSN prevede anche la tutela dell’attività sportiva, che viene<br />
però svolta come me<strong>di</strong>cina dello sport, solo a livello ambulatoriale, con valutazioni <strong>di</strong> tipo clinico<br />
rivolto ai singoli in<strong>di</strong>vidui, iscritti a società sportive, al solo fine del rilascio del certificato <strong>di</strong><br />
idoneità all’attività sportiva <strong>di</strong> tipo agonistico. Non vengono invece effettuate, salvo poche<br />
eccezioni <strong>di</strong> carattere locale, attività <strong>di</strong> prevenzione collettiva strutturate in strategie organiche.<br />
Gli italiani che praticano regolarmente uno sport, oggi sono una minoranza e numericamente pochi<br />
anche nell’età giovanile (tab.1):<br />
Tab. 1 Gli Italiani e lo sport<br />
italiani che praticano sport regolarmente (%)<br />
uomini 22<br />
donne 14<br />
tra i 15 e i 19 anni (%)<br />
ragazzi 50,7<br />
ragazze 32,6<br />
tra i 35 e i 65 anni (%)
uomini 19,4<br />
donne 12,7<br />
oltre i 65 anni (%)<br />
uomini 4,2<br />
donne 2.1<br />
da “ La nostra salute - Lo stato sanitario del Paese <strong>20</strong>01” – Ministero della Salute<br />
Dai dati presentati si evince che praticano attività sportiva soprattutto i giovani e in misura minore<br />
gli adulti, mentre la percentuale <strong>di</strong> ultrasessantacinquenni, che pure beneficerebbero <strong>di</strong> attività<br />
motoria, è molto bassa.<br />
Se i risultati <strong>di</strong> una mo<strong>di</strong>fica degli stili <strong>di</strong> vita sono tanto positivi, perché mai è così <strong>di</strong>fficile metterli<br />
in atto in un programma complessivo <strong>di</strong> prevenzione su larga scala?<br />
In realtà introdurre mo<strong>di</strong>fiche permanenti negli stili <strong>di</strong> vita dei pazienti è notoriamente un’impresa<br />
<strong>di</strong>fficile. Si tratta <strong>di</strong> un compito arduo che deve essere affrontato e gestito con determinazione e<br />
senza improvvisazioni da parte dei professionisti della sanità, in primis dei me<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> famiglia, con<br />
supporti formativi ed organizzativi che, nella maggior parte dei casi, le ASL non forniscono.<br />
Incidono negativamente in quest’ambito alcuni aspetti:<br />
• una sopravvalutazione del rischio (smentito dai dati a <strong>di</strong>sposizione) che i loro pazienti possano<br />
incorrere in incidenti car<strong>di</strong>ovascolari acuti durante le sessioni <strong>di</strong> attività motoria;<br />
• una scarsa preparazione dei me<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> famiglia ad in<strong>di</strong>viduare per i singoli pazienti proposte<br />
concrete e personalizzate (adatte al paziente) <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica degli stili <strong>di</strong> vita. Appare, infatti,<br />
evidente che le esigenze e le modalità <strong>di</strong> intervento per incrementare l’attività motoria e<br />
correggere eventuali squilibri nutrizionali nei confronti della popolazione generale sono molto<br />
<strong>di</strong>versificate. Dall’esame della letteratura risulta che si riesce a centrare gli obiettivi solo<br />
quando i soggetti sedentari, da avviare all’attività motoria e ad un riequilibrio <strong>di</strong>etetico, siano<br />
oggetto non <strong>di</strong> generiche raccomandazioni, ma <strong>di</strong> un consiglio specifico e “personalizzato” per<br />
le loro esigenze;<br />
• la carenza <strong>di</strong> opportunità organizzate, all’aperto e nelle palestre, <strong>di</strong> corsi <strong>di</strong> attività motoria<br />
verso le quali in<strong>di</strong>rizzare i propri utenti. Per evidenziare queste <strong>di</strong>fficoltà, si porta l’esempio<br />
dell’ULSS <strong>di</strong> <strong>Verona</strong> dove, su circa 4<strong>20</strong>.000 abitanti, 70.000 persone hanno già compiuto 65<br />
anni. Porsi il solo obiettivo <strong>di</strong> organizzare occasioni che possano incrementare l’attività motoria<br />
nel 50% <strong>di</strong> questa popolazione, significa affrontare un compito <strong>di</strong> vaste <strong>di</strong>mensioni nei cui<br />
confronti non è ancora consolidato, nei Dipartimenti <strong>di</strong> <strong>Prevenzione</strong>, un modello <strong>di</strong> intervento.<br />
Un altro dato che emerge dalla letteratura (1) è che un progetto <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica dello stile <strong>di</strong> vita ha<br />
molte più probabilità <strong>di</strong> riuscire e <strong>di</strong> permanere nel tempo quanto più la proposta è complessiva. È,<br />
in altri termini, più efficace intervenire sull’attività motoria e sull’alimentazione piuttosto che su<br />
uno solo <strong>di</strong> questi due <strong>di</strong>versi comportamenti. Risulta pertanto necessario che il me<strong>di</strong>co <strong>di</strong> famiglia<br />
e le strutture <strong>di</strong> prevenzione articolino su entrambi questi parametri una strategia complessiva e<br />
personalizzata per i loro utenti.<br />
In sintesi possiamo <strong>di</strong>re che reinterpretare il ruolo della sanità pubblica oggi e delle attività <strong>di</strong><br />
prevenzione in questo campo significa sviluppare capacità organizzative e modelli operativi in<br />
grado <strong>di</strong> aumentare il numero <strong>di</strong> quanti praticano un’attività fisica regolare, in particolar modo<br />
giovani ed anziani, riorientando e coor<strong>di</strong>nando le risorse umane e strutturali già presenti nel<br />
territorio, monitorando le attività e valutando l’efficacia degli interventi attuati.<br />
2
5.1.2 Obiettivi<br />
Obiettivi Generali<br />
1) Promuovere una cultura <strong>di</strong> promozione della salute che preveda un regolare esercizio fisico in<br />
particolar modo tra i giovani e gli anziani.<br />
Obiettivi Specifici<br />
Organizzativi<br />
1. Definire con chiarezza il target degli interventi;<br />
2. definire la rete delle collaborazioni esterne che deve essere attivata per ognuno dei target;<br />
3. definire e qualificare il coinvolgimento dei me<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cina generale;<br />
4. monitorare la prevalenza <strong>di</strong> soggetti che praticano regolarmente attività fisica;<br />
5. preparare un percorso <strong>di</strong> attività motoria ad almeno il 10% dei residenti/ospiti delle case <strong>di</strong><br />
riposo del 66% della Az. ULSS;<br />
6. definire un protocollo <strong>di</strong> intesa tra <strong>Dipartimento</strong> <strong>di</strong> <strong>Prevenzione</strong> e Centro Anti <strong>di</strong>abetico<br />
aziendale (in rif. ad obiettivo <strong>di</strong> salute n. 2).<br />
Di salute<br />
1. aumentare del 10% la quota dei giovani e degli anziani che praticano regolarmente (almeno una<br />
volta alla settimana) attività fisico-sportiva nel tempo libero (PSN 1998-<strong>20</strong>00);<br />
2. aumentare del 15% la quota <strong>di</strong> <strong>di</strong>abetici che praticano regolarmente (almeno una volta alla<br />
settimana) attività fisico-sportiva nel tempo libero.<br />
5.1.3 Pratiche efficaci/efficienti<br />
Una grande mole <strong>di</strong> ricerche sul campo testimonia l’effetto dell’attività motoria sulla salute e anche<br />
incomincia ad in<strong>di</strong>viduare i meccanismi biochimici attraverso i quali l’attività motoria esercita i<br />
suoi effetti favorevoli sulla salute umana. Un secondo aspetto importante è dato dall’evidenza che è<br />
in realtà possibile (anche se non facile) indurre la popolazione a mo<strong>di</strong>ficare consolidati stili <strong>di</strong> vita a<br />
favore <strong>di</strong> altri più idonei a prevenire la comparsa o l’aggravamento <strong>di</strong> patologie cronico<br />
degenerative.<br />
“Clinical Evidence”, e<strong>di</strong>to perio<strong>di</strong>camente dal BMJ Publishing Group, ha esaminato la produzione<br />
scientifica <strong>di</strong>sponibile <strong>di</strong> buon livello metodologico e conclude affermando che “la pratica <strong>di</strong> attività<br />
fisica riduce il rischio <strong>di</strong> incidenti car<strong>di</strong>aci mortali e non. Nella popolazione fisicamente attiva - che<br />
pratica attività fisica moderata tutti i giorni o quasi – si evidenzia una riduzione del 30-50% del<br />
rischio relativo <strong>di</strong> malattie coronariche rispetto alla popolazione sedentaria, a parità <strong>di</strong> altri fattori <strong>di</strong><br />
rischio (2)”.<br />
Da un’analisi della letteratura internazionale emerge chiaramente l’efficacia dell’attività fisica sia<br />
nel ridurre il rischio per eventi car<strong>di</strong>ovascolari in soggetti affetti da <strong>di</strong>abete <strong>di</strong> tipo II sia nel<br />
prevenire la comparsa <strong>di</strong> <strong>di</strong>abete con soggetti con intolleranza gluci<strong>di</strong>ca già in atto (New England<br />
Journal of Me<strong>di</strong>cine, <strong>20</strong>01). Inoltre induce negli stessi soggetti una mo<strong>di</strong>ficazione degli in<strong>di</strong>ci<br />
3
ioumorali quali la emoglobina glicosilata. Vi è ampia evidenza inoltre che l’attività motoria<br />
rappresenta un valido ausilio anche nella prevenzione dell’ipertensione arteriosa (Archives of<br />
Internal Me<strong>di</strong>cine, <strong>20</strong>02).<br />
Infine, una valutazione <strong>di</strong> efficacia degli interventi volti a combattere l’obesità ed il sovrappeso,<br />
noti fattori <strong>di</strong> rischio car<strong>di</strong>ovascolari, evidenzia come l’attività motoria sia importante per il<br />
mantenimento nel tempo della per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> peso acquisita con la <strong>di</strong>eta, e come soggetti che combinano<br />
l’esercizio fisico con la <strong>di</strong>eta e con il trattamento comportamentale, possono perdere dal 5 al 10%<br />
del loro peso entro un intervallo <strong>di</strong> tempo che varia dai 4 ai 6 mesi (New England Journal of<br />
Me<strong>di</strong>cine <strong>20</strong>02).<br />
Una sintesi delle attività preventive efficaci è rinvenibile in “The Community Guide” – Promoting<br />
physical activities (all. 1)<br />
5.1.4 Linee guida operative per i SISP della Regione del Veneto<br />
5.1.4.1 Aspetti organizzativi<br />
Affidamento <strong>di</strong> specifica responsabilità all’interno del SISP con compiti specifici <strong>di</strong>:<br />
1. Coor<strong>di</strong>namento <strong>di</strong> iniziative volte alla promozione dell’attività motoria attraverso il<br />
coinvolgimento <strong>di</strong> varie figure professionali coinvolte (Me<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>cina Generale,<br />
Me<strong>di</strong>ci Specialisti) e non specialistiche (rappresentanti degli utenti, operatori professionali).<br />
Preliminare, rispetto a qualsiasi programma <strong>di</strong> intervento organico, è curare il<br />
coinvolgimento dei me<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> famiglia attraverso corsi <strong>di</strong> aggiornamento e specifici<br />
programmi <strong>di</strong> interventi. Ad esempio, è già stato organizzato con buoni risultati a <strong>Verona</strong>,<br />
negli scorsi mesi, un corso per 80 MMG che, a gruppi <strong>di</strong> <strong>20</strong>, si sono incontrati per<br />
aggiornarsi e mettere a punto un percorso comune <strong>di</strong> identificazione dei consigli da dare alle<br />
varie tipologie dei loro assistiti.<br />
2. Creazione <strong>di</strong> un tavolo intersettoriale. E’ chiaro che un progetto complessivo <strong>di</strong> queste<br />
<strong>di</strong>mensioni esce dallo specifico ambito sanitario e richiede un forte coinvolgimento delle<br />
comunità locali per ottenere supporto culturale, organizzativo e logistico. Alcune realtà<br />
comunali hanno iniziato a recepire questo tipo <strong>di</strong> orientamento e si <strong>di</strong>spongono a tener conto<br />
nelle loro scelte urbanistiche della necessità <strong>di</strong> favorire la creazione <strong>di</strong> spazi e strutture<br />
destinate all’attività motoria. Un ruolo rilevante va assegnato, in questo tipo <strong>di</strong><br />
progettazione, alle associazioni <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>ni e/o <strong>di</strong> pazienti (ad es. le associazioni dei pazienti<br />
<strong>di</strong>abetici) che vanno stimolate ad organizzare <strong>di</strong>rettamente iniziative <strong>di</strong> attività motoria<br />
tagliate specificamente sulle loro esigenze. Anche in questo caso il ruolo della struttura<br />
sanitaria deve essere quello della consulenza e della verifica dei risultati e, per quanto<br />
possibile, non quello della gestione <strong>di</strong>retta.<br />
3. Monitoraggio epidemiologico della prevalenza <strong>di</strong> soggetti che praticano attività motoria.<br />
4. Definizione con chiarezza del target degli interventi;<br />
I target dovrebbero almeno essere tre, fra loro <strong>di</strong>fferenziati:<br />
a) la popolazione in genere nei confronti della quale vanno organizzate delle iniziative <strong>di</strong><br />
promozione generalizzata ed in<strong>di</strong>fferenziata. Facendo riferimento ad una ASL <strong>di</strong> circa 450.000<br />
4
abitanti, l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> grandezza <strong>di</strong> questo target può essere stimato nelle decine <strong>di</strong> migliaia <strong>di</strong><br />
persone;<br />
b) la popolazione a cui sono <strong>di</strong>retti programmi organizzati e monitorati (giovani ed anziani ultra<br />
65enni). Sempre riferendosi ad una popolazione <strong>di</strong> 450.000 abitanti, l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> grandezza <strong>di</strong> questo<br />
target può essere stimato nelle migliaia <strong>di</strong> abitanti;<br />
c) soggetti affetti da patologie cronico degenerative, come i <strong>di</strong>abetici. A titolo esemplificativo,<br />
l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> grandezza <strong>di</strong> questo target può essere stimato nelle centinaia <strong>di</strong> abitanti;<br />
d) personale sanitario delle Aziende ULSS, in quanto, per poter essere promotore efficace e più<br />
cre<strong>di</strong>bile verso la popolazione, è importante che il personale sanitario delle Aziende ULSS venga<br />
coinvolto in un progetto <strong>di</strong> promozione specifico al fine <strong>di</strong> favorire in questa stessa categoria un<br />
aumento dell’attività fisica.<br />
Per ognuno <strong>di</strong> questi target è necessario definire un assetto logistico-organizzativo <strong>di</strong>fferenziato. È,<br />
infatti, chiaro che negli interventi sul primo punto il ruolo della struttura sanitaria si deve limitare ad<br />
una funzione <strong>di</strong> stimolo e consulenza nei confronti delle realtà comunali che devono svolgere il<br />
ruolo <strong>di</strong> attore principale nel promuovere le con<strong>di</strong>zioni per uno stile <strong>di</strong> vita sano dei citta<strong>di</strong>ni. Non<br />
sono tuttavia esclusi interventi anche ampi <strong>di</strong> marketing sociale a gestione <strong>di</strong>retta specie se cofinanziati<br />
dall’area del privato.<br />
Per il secondo punto il ruolo <strong>di</strong> consulenza e verifica dei risultati sanitari delle iniziative <strong>di</strong>venta più<br />
stringente; nel terzo punto l’impegno delle strutture sanitarie deve essere ancora maggiore, dato che<br />
si tratta <strong>di</strong> un target particolarmente sensibile ed i singoli soggetti che appartengono a questo gruppo<br />
sono quelli che più degli altri possono usufruire dei maggiori vantaggi <strong>di</strong> salute a seguito <strong>di</strong> una<br />
mo<strong>di</strong>fica delle loro abitu<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> vita.<br />
Per quanto concerne l’ultimo punto, possono essere effettuate dalla struttura sanitaria anche azioni<br />
specifiche e <strong>di</strong>rette <strong>di</strong> tipo organizzativo (es. palestra per i <strong>di</strong>pendenti nei maggiori luoghi <strong>di</strong> lavoro,<br />
specifiche convenzioni con strutture esterne, ecc.).<br />
5.1.4.2 Aspetti tecnico - professionali<br />
Me<strong>di</strong>co epidemiologo-igienista. Sviluppo delle capacità professionali al fine <strong>di</strong> condurre:<br />
1a) una attiva collaborazione alla definizione della strategia <strong>di</strong> promozione dell’attività motoria;<br />
1b) la formazione degli operatori coinvolti localmente;<br />
1c) il coor<strong>di</strong>namento dell’attività <strong>di</strong> altri professionisti e degli operatori professionali coinvolti;<br />
1b) il monitoraggio epidemiologico e la valutazione delle attività.<br />
2. Tecnici della prevenzione per:<br />
2a) la vigilanza ed i sopralluoghi a norma <strong>di</strong> legge in continuità con le pratiche ispettive ora<br />
operanti;<br />
2b) la formazione degli operatori professionali del privato<br />
3. Assistenti Sanitarie Visitatrici per:<br />
3a) attività <strong>di</strong> counselling ed educazione alla salute in tema <strong>di</strong> attività motoria;<br />
3b) la formazione degli operatori professionali del privato<br />
5
5.1.4.3 Aspetti <strong>di</strong> qualità percepita<br />
Rilevazione del gra<strong>di</strong>mento e della partecipazione <strong>di</strong> giovani, adulti e target specifici (<strong>di</strong>abetici).<br />
5.1.5 In<strong>di</strong>catori per la valutazione degli esiti e degli standard attesi<br />
a) <strong>di</strong> piano regionale:<br />
1. definire con chiarezza il target degli interventi (giugno <strong>20</strong>03);<br />
2. definire la rete delle collaborazioni esterne che deve essere attivata per ognuno dei target<br />
sopradescritti (giugno <strong>20</strong>03);<br />
3. pre<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> protocolli regionali con i Me<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>cina Generale (<strong>di</strong>cembre <strong>20</strong>03).<br />
b) <strong>di</strong> attività:<br />
1. il 50% delle az. ULSS in 3 anni raggiunge almeno il 10% della popolazione ultra 65enne<br />
coinvolgendola in attività motoria (<strong>di</strong>cembre <strong>20</strong>05)<br />
2. il 50% delle az. ULSS in 2 anni raggiunge almeno il 10% della popolazione <strong>di</strong>abetica<br />
proponendo iniziative <strong>di</strong> attività motoria (<strong>di</strong>cembre <strong>20</strong>04)<br />
3. almeno in un comune per 3 az. ULLS attivare strumenti urbanistici che prevedono percorsi tipo<br />
“kids walk to school” (<strong>di</strong>cembre <strong>20</strong>04)<br />
c) <strong>di</strong> esito:<br />
1. incrementare del <strong>20</strong>% il n. dei soggetti impegnati in attività motoria rispetto alla situazione <strong>di</strong><br />
base (da rilevare) su piccoli target (es. <strong>di</strong>abetici seguiti dal CAD, anziani autosufficienti in CdR).<br />
5.1.6 Implementazione<br />
5.1.6.1 Adeguamenti legislativi<br />
1. incentivare le strutture pubbliche e private e degli Enti che partecipano ai programmi <strong>di</strong> salute;<br />
2. favorire la realizzazione da parte dei Comuni <strong>di</strong> opere finalizzate all’esercizio fisico (piste<br />
ciclabili, percorsi salute, impianti sportivi);<br />
3. realizzazione <strong>di</strong> programmi regolari <strong>di</strong> attività fisica nelle scuole materne;<br />
4. prevedere una qualifica professionale per gli operatori delle palestre.<br />
5.1.6.2 Formazione<br />
E’ necessario prevedere una formazione specifica degli:<br />
a) operatori dell’Igiene Pubblica (Me<strong>di</strong>ci, Tecnici della formazione, Assistenti Sanitarie Visitatrici);<br />
b) vari operatori del S.S.R. (Me<strong>di</strong>ci sportivi, Me<strong>di</strong>ci Me<strong>di</strong>cina Generale);<br />
c) operatori <strong>di</strong> categoria;<br />
6
finalizzata all’acquisizione delle capacità professionali in<strong>di</strong>cate al punto 5.1.4.2.<br />
5.1.6.3 Risorse<br />
1. finanziamento delle attività formative richieste a livello regionale e locale;<br />
2. riallocare personale esistente.<br />
3. acquisire nuovo personale quando necessario;<br />
5.1.6.4 Sistema informativo<br />
1. creazione <strong>di</strong> un flusso informativo con tutte le Associazioni sportive, <strong>di</strong> Volontariato e i Privati<br />
sul tema, avviando un sistema <strong>di</strong> monitoraggio ad hoc.<br />
5.1.7 Bibliografia<br />
1. Yanovsky SZ, Yanovsky JA. Drug Therapy: Obesity. N Engl J Med <strong>20</strong>02; 346: 591-602.<br />
2. Clinical Evidence, e<strong>di</strong>zione italiana n. 1, <strong>20</strong>01. <strong>Prevenzione</strong> primaria pag. 48-74.<br />
3. Cohen JD. Superior Physician and the treatment of Hypertension. Arch Int Med <strong>20</strong>02; 162: 387-<br />
8.<br />
4. Hu FB, Stampfer MJ, Solomon C et al: Physical activity and risk for car<strong>di</strong>ovascular events in<br />
<strong>di</strong>abetic woman. Ann Intern Med <strong>20</strong>01; 135: 930-1.<br />
5. Schena F, Luzi Crivellini A, Terranova L, Lanza M., Raschellà G, Valsecchi M. La promozione<br />
della salute in pazienti <strong>di</strong>abetici. Atti del XXIX Congresso Nazionale SITI. Ferrara, 24-27<br />
settembre <strong>20</strong>00.<br />
6. Tuomilehto J, Lindstrom ., Eriksson JG et al. Prevention of type 2 <strong>di</strong>abetis mellitus by changes<br />
in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. N Engl J Med <strong>20</strong>01; 344: 1343-50.<br />
7. The Community Guide, Promoting physical activity, updated 26 12 <strong>20</strong>02.<br />
8. Cana<strong>di</strong>an Task Force on Preventive Health Care, Physical Activity Counselling,<br />
www.ctfphc.org/tables_printable/Ch47tab.htm visitato in data 09.01.<strong>20</strong>03.<br />
7
Allegato I<br />
Inter<br />
Raccomandazioni<br />
vento<br />
Informazione come strategia per incrementare l’attività fisica<br />
Campagne rivolte alla popolazione<br />
Raccomandata (forte evidenza)<br />
Punti in cui si induce la motivazione<br />
Raccomandati (evidenza sufficiente)<br />
Educazione alla salute in classe focalizzata sul Evidenza insufficiente per determinarne<br />
fornire informazioni<br />
l’efficacia<br />
Campagne me<strong>di</strong>atiche<br />
Evidenza insufficiente per determinarne<br />
l’efficacia<br />
Educazione fisica a scuola<br />
Raccomandata (forte evidenza)<br />
Supporto sociale extrafamiliare<br />
Raccomandato (forte evidenza)<br />
Approccio sociale e comportamentale per incrementare l’attività fisica<br />
Cambiamento comportamentale <strong>di</strong> salute Raccomandato (forte evidenza)<br />
adattato all’in<strong>di</strong>viduo<br />
Educazione a spegnere la tv e i videogiochi Evidenza insufficiente per determinarne<br />
l’efficacia<br />
Educazione fisica e educazione alla salute Evidenza insufficiente per determinarne<br />
nell’età del College<br />
l’efficacia<br />
Supporto sociale non basato sulla famiglia Evidenza insufficiente per determinarne<br />
l’efficacia<br />
Approccio politico e ambientale per incrementare l’attività fisica<br />
Creare o aumentare l’accesso a luoghi in cui si Raccomandato (forte evidenza)<br />
svolge attività fisica assieme ad un’aumentata<br />
attività <strong>di</strong> informazione<br />
Cambiamenti nelle infrastrutture e nelle politiche In corso<br />
<strong>di</strong> trasporto per promuovere il trasporto non<br />
motorizzato<br />
Approcci <strong>di</strong> pianificazione urbanistica – In corso<br />
sud<strong>di</strong>visione in zone e utilizzo del territorio<br />
Tratto da “The Community Guide” – Promoting physical activities.<br />
8