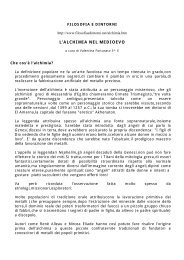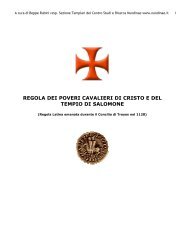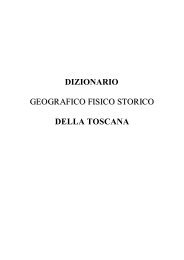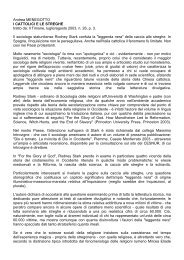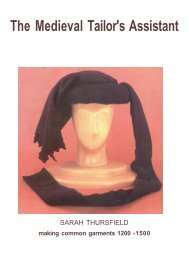IL LABIRINTO - tavola di smeraldo
IL LABIRINTO - tavola di smeraldo
IL LABIRINTO - tavola di smeraldo
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Nuova Serie. Numero 18 - Luglio 2013<strong>IL</strong> <strong>LABIRINTO</strong>Reg. Tribunale <strong>di</strong> Torino n.50 del 09/10/2009PERIODICO TELEMATICO DI INFORMAZIONE CULTURALERIVISTA UFFICIALE DEL:In evidenza in questo numero:TORTURA E MORTE PERSTREGONERIA OGGIA cura <strong>di</strong> Katia SomàVESTA E <strong>IL</strong> FUOCO DI ROMAA cura <strong>di</strong> Paolo GalianoLA BIBLIOTECA MALATESTIANAA cura <strong>di</strong> Katia Somà
<strong>IL</strong> <strong>LABIRINTO</strong> N.18 Luglio 2013Perio<strong>di</strong>co telematico <strong>di</strong> informazione culturale a cura del Circolo Culturale Tavola <strong>di</strong> SmeraldoEDITORIALESOMMARIOE<strong>di</strong>toriale pag 2La Stregoneria nelle Alpi Occidental i pag 3Comandare la tempesta pag 4Tortura e morte per stregoneria oggi pag 7Vesta e il fuoco <strong>di</strong> Roma pag 10Il Barbiere della Peste (Pt. 2°) pag 14La Biblioteca Malatestiana <strong>di</strong> Cesena pag. 17Rubriche- Le nostre recensioni pag. 20- Conferenze ed Eventi pag. 21Perio<strong>di</strong>co BimestraleNuova Serie – Numero 18 Anno IV - Luglio 2013RedazioneVia Maiole 5/A 10040, Leinì (TO)E<strong>di</strong>toreCircolo Culturale Tavola <strong>di</strong> SmeraldoSede Legale: Via Carlo Alberto n°37, 10088 Volpiano (TO)Direttore E<strong>di</strong>torialeSandy FurliniDirettore ResponsabileLeonardo RepettoDirettore ScientificoFederico BottigliengoComitato E<strong>di</strong>torialeFederico Bottigliergo, Paolo Galiano, Katia SomàImpaginazione e Progetto GraficoSandy FurliniFoto <strong>di</strong> CopertinaMostra “Stregoneria, Torture ed Inquisizione”. Rivara 2013.Foto <strong>di</strong> Katia SomàSection e<strong>di</strong>torsAntico Egitto: Federico BottigliengoStregoneria in Piemonte: Massimo CentiniArcheologia a Torino e <strong>di</strong>ntorni: Fabrizio DiciottiFruttuaria: Marco NotarioAntropologia ed Etnome<strong>di</strong>cina: Antonio GuerciPsicologia e psicoterapia: Marilia Boggio MarzetTerminato il primo semestre <strong>di</strong> attività culturali, il CircoloTavola <strong>di</strong> Smeraldo si prepara ad affrontare una nuovaimpresa: la Rassegna Riflessioni su… in programma per iprossimi 26 e 27 Ottobre. Nel frattempo volgiamo lo sguardoin<strong>di</strong>etro e osserviamo: la 4° e<strong>di</strong>zione del convegno LaStregoneria nelle Alpi Occidentali è terminata con un bilancionettamente positivo: un palinsesto <strong>di</strong> relatori tutto nuovo eoriginale ha accompagnato la platea per un paio <strong>di</strong> giorni incui la figura della strega è stata per la prima volta analizzatasotto il profilo delle arti contemporanee. Massimo Centini,storico collaboratore del Circolo ha terminato il suo interventorichiamando l’attenzione a soffermarci sul significato dellastrega nel mondo contemporaneo e a quanto pregnante èancora la sua immagine nella vita <strong>di</strong> tutti i giorni.Nuove promesse e progetti sono stati <strong>di</strong>scussi al tavolo delleautorità politiche che questa volta propongono ad<strong>di</strong>rittura unarie<strong>di</strong>zione del Convegno tutto a spese della Regionenell’autunno 2013… Beh… credo che questa volta sia statosparato proprio in alto… Ma dovevamo mettere in pie<strong>di</strong> unevento a spese nostre per farci <strong>di</strong>re bravi??? No, è ora <strong>di</strong>smetterla con questi formalismi acchiappavoti: grazie per laproposta ma ci penseremo…. Intanto voci nuove giungono daNord e l’aria <strong>di</strong> una e<strong>di</strong>zione biennale rilassa tutti, la sedeproposta è molto allettante e prestigiosa.. Il contesto ancor <strong>di</strong>più… vedremo.Intanto vi offriamo questo nuovo numero del <strong>LABIRINTO</strong>, connuovi articoli e forti riflessioni ancora sul mondo dellastregoneria e non solo. Aspettiamo Ottobre, il mese dellame<strong>di</strong>tazione interiore e quest’anno del Testamento Biologico.Buona lettura.(Sandy Furlini)Registrazione Tribunale <strong>di</strong> Torino n°50 del 09/10/2009Tutti i <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> proprietà sono riservati a: Circolo Culturale Tavola <strong>di</strong> Smeraldo nella figura del suoLegale RappresentanteLa Rivista “<strong>IL</strong> <strong>LABIRINTO</strong>” viene pubblicata al sito web www.<strong>tavola</strong><strong>di</strong><strong>smeraldo</strong>.it, visionabile escaricabile gratuitamente. L’eventuale stampa avviene in proprio e con <strong>di</strong>stribuzione gratuita fino anuova deliberazione del Comitato E<strong>di</strong>toriale.La riproduzione anche parziale degli articoli o immagini è espressamente riservata salvo <strong>di</strong>versein<strong>di</strong>cazioni dell’autore (legge 22 Aprile 1941 n.633)Ogni autore è responsabile delle proprie affermazioniLe immagini sono tutte <strong>di</strong> Katia Somà. Per quelle specificate, la redazione si è curata della relativa autorizzazione degliaventi <strong>di</strong>ritto. Hanno collaborato per questo numero: Christian Cometto, Carlo Doato, Alessandro Silvestri, AnnamariaCamoletto, Gianluca Sinico, Fior MarioCircolo Culturale Tavola <strong>di</strong> SmeraldoSede Legale: Via Carlo Alberto n°37 10088 Volpiano (TO)C.F.= 95017150012Reg. Uff Entrate <strong>di</strong> Rivarolo C.se (TO) il 09-02-2009Atto n° 211 vol.3ATel. 335-6111237http://www.<strong>tavola</strong><strong>di</strong><strong>smeraldo</strong>.itmail: <strong>tavola</strong><strong>di</strong><strong>smeraldo</strong>@msn.comAssociazione culturale iscrita all‘albo delle Associazioni del Comune <strong>di</strong> Volpiano (TO).Art. 3 Statuto Associativo:L’Associazione persegue lo scopo <strong>di</strong> organizzare ricerche culturali storiche, filosofiche, etiche ed antropologiche destinate alla crescita intellettuale dei propri soci edella collettività cui l’Associazione si rivolge.Stu<strong>di</strong>a in particolar modo la storia e la cultura Me<strong>di</strong>evale.Con la sua attività, promuove l'interesse e la conoscenza dei beni culturali ed ambientali del territorio.Collabora con Associazioni culturali nell’intento <strong>di</strong> rafforzare il recupero delle nostre ra<strong>di</strong>ci storiche in un’ottica <strong>di</strong> miglioramento del benessere collettivo. Particolareè l’impegno riguardo agli stu<strong>di</strong> etici, filosofico/antropologici nonché simbolici che possono essere <strong>di</strong> aiuto nel perseguimento degli obiettivi statutari.Pag.2
<strong>IL</strong> <strong>LABIRINTO</strong> N.18 Luglio 2013Perio<strong>di</strong>co telematico <strong>di</strong> informazione culturale a cura del Circolo Culturale Tavola <strong>di</strong> SmeraldoLA STREGONERIA NELLE ALPI OCCIDENTALIUNA QUARTA EDIZIONE STIMOLANTE(a cura <strong>di</strong> Sandy Furlini)Si è concluso il Convegno sulla stregoneria tenutosi a Rivara(TO) il 25 e 26 Maggio 2013. Una e<strong>di</strong>zione tutta nuova, fatta<strong>di</strong> interventi ad ampio respiro, portati in sala da appassionatied esperti del mondo della stregoneria a 360 gra<strong>di</strong>. Non si ètrattato infatti <strong>di</strong> una <strong>di</strong>samina storica ed eru<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> eventi odocumenti ma bensì <strong>di</strong> una carrellata <strong>di</strong> ciò che la figura dellastrega a lasciato oggi, nel nostro mondo, quello fatto <strong>di</strong>pellicola cinematografica, <strong>di</strong> internet e <strong>di</strong> espressioneartistica. Senza dubbio ar<strong>di</strong>ta impresa è stata quella <strong>di</strong>proporre una due giorni <strong>di</strong> arricchimento culturale oggi,periodo in cui null’altro importa, pare, se non le sorti dei nostrigovernanti che i più getterebbero fra le fiamme dei roghi aguisa <strong>di</strong> stregoni condannati all’ultimo supplizio.Ebbene, nonostante tutto, compresa una minacciaincombente sul canavese <strong>di</strong> imperiosi rovesci metereologici, ilparco <strong>di</strong> Villa Ogliani <strong>di</strong> Rivara ha ospitato il suo eventoraccogliendo ampi consensi dai convenuti. Anche quest’annoregistriamo partecipanti da terre lontane: Milano, Pavia,Aosta: una grande sod<strong>di</strong>sfazione per l’organizzazione, segnoche il lavoro che si sta facendo è in<strong>di</strong>rizzato sulla stradagiusta.L’apertura del Convegno con: Sandy Furlini (Presidente Tavola <strong>di</strong> Smeraldo),Laura Allice (Assessore alla Cultura del Comune <strong>di</strong> Levone –TO-), FabrizioComba (Vicepresidente del Consiglio Regionale del Piemonte), Rosy Falletti(Assessore alla Cultura Comune <strong>di</strong> Saint-Denis -AO-)Foto Katia SomàIl Gruppo storico <strong>IL</strong> MASTIOKatia Somà (Segretario del Circolo Tavola <strong>di</strong> Smeraldo) el’antropologo Massimo Centini (Collaboratore del Centro Stu<strong>di</strong>e Ricerche sulla Stregoneria in Piemonte)Durante i due giorni dei lavori del Convegno, il pubblico hapotuto vivere una atmosfera molto suggestiva nel Parcoche ci ha ospitati: un grande accampamento allestito instile me<strong>di</strong>evale dai gruppi storici ospiti ha regalatomomenti <strong>di</strong> grande interesse e curiosità: dalle botteghe deimestieri alle armi dei cavalieri, alle tende allestite deisignori del luogo e venuti da lontano. Per l’occasioneerano presenti i Gruppi: il Mastio (Ivrea), Dulcadanza(Magnano), Genti del Maloch (Chieri), Ordo Regius (Susa),Arcieri della Rupe <strong>di</strong> Viana (Rivara) e Castrum Vulpiani <strong>di</strong>Volpiano. Una accattivante e ricca mostra sulle torture el’Inquisizione ha tenuto impegnato il pubblico fraricostruzioni e pannelli espositivi con descrizioniminuziose.Pag.3
<strong>IL</strong> <strong>LABIRINTO</strong> N.18 Luglio 2013Perio<strong>di</strong>co telematico <strong>di</strong> informazione culturale a cura del Circolo Culturale Tavola <strong>di</strong> SmeraldoCOMANDARE LA TEMPESTA(a cura <strong>di</strong> Massimo Centini)La credenza che attribuiva alle masche il potere <strong>di</strong>suscitare temporali e comandare a loro piacimento lecon<strong>di</strong>zioni atmosferiche ha un’origine molto antica e fumotivo <strong>di</strong> profonde <strong>di</strong>spute teologiche e <strong>di</strong> dotte<strong>di</strong>squisizioni scientifiche e religiose. I teologi me<strong>di</strong>evalicredevano che all’origine <strong>di</strong> alcuni fenomeni atmosfericivi fosse il <strong>di</strong>avolo e i suoi poteri elargiti alle streghe. Infondo, la presenza <strong>di</strong> demoni situati quasi in sospensionetra la terra e il cielo, capaci <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionare gli eventinaturali, fu accettata fin dall'origine del Cristianesimo:San Paolo, risentendo <strong>di</strong> una certa tra<strong>di</strong>zione astrologicavicino-orientale, si riferisce chiaramente a queste entitàmaligne . (1)Nel libro De lamiis et phitonicis mulieribus (1489) delgiurista svizzero Ulrich Molitor e nella raccolta dellepre<strong>di</strong>che Die Emeis (Le formiche) del teologo tedescoJohannes Geiler von Kaysersberg (1516), sonocontenute illustrazioni che descrivono il potere dellestreghe <strong>di</strong> suscitare tempeste e temporali.Due delle numerose xilografie del Die Emeis (attribuitead Hans Baldung Grien) offrono un chiaro riferimentoalla cosiddetta magia tempestaria. Una in particolare,propone tre streghe che effettuano le loro pratichetempestarie mentre dal cielo si sta già per abbattere untemporale che pare agitare un animale domesticopresente in secondo piano.Tutto intorno sono presenti simboli che rendonoulteriormente drammatica la ricostruzione: ossa e crani inparticolare. Una strega sorregge uno strano stendardo <strong>di</strong><strong>di</strong>fficile interpretazione. Sulla destra un misterioso esserepare fuoriuscire dal tronco <strong>di</strong> un albero: forse un demonepartecipante al sabba, in cui sono presenti formaliriconducibili alle <strong>di</strong>vinità boschive. In un’altra incisione <strong>di</strong>Hans Baldung Grien, intitolata Le streghe (1516) econservata nella Civica Raccolta Bertarelli del CastelloSforzesco <strong>di</strong> Milano, è raffigurato un misteriosocontenitore (reso ancor più criptico da una serie <strong>di</strong>decorazioni e da alcuni caratteri indecifrabili) dal qualefuoriesce una potenza oscura in cui si intravedono, oltre adei soggetti indefiniti, anche dei piccoli animali: forse rospi.Hans Baldung GrienStreghe. Hans Baldung Grien. 1516È Infatti noto che l’attività delle streghe tempestarietendeva spesso a colpire non solo i raccolti, ma anche lemandrie.Nella seconda xilografia, la scena è tipica del sabba in cuitre streghe, due delle quali nude, lasciano fuoriuscire daun contenitore una strana dynamis che si alza verso ilcielo.Una delle streghe porge un piatto in cui sono contenuti duevolatili spennati e cotti. La strega che cavalca il capro,sorregge con un forcone, un vaso colmo fino all’orlo, dalquale escono due corna.L’opera è particolarmente articolata e tenebrosa,indubbiamente costituisce una delle realizzazioni in cui iprodotti magici usati come ingre<strong>di</strong>enti risultano inseriti inuna traiettoria iconografica particolarmente esplicativa.Già a partire dal IX secolo, la Chiesa dovette far fronte allacredenza popolare che riconosceva non solo al <strong>di</strong>avolo,ma anche alle streghe, la capacità <strong>di</strong> determinaretempeste, temporali, ecc. ecc.Nel testo me<strong>di</strong>evale più caratteristico su questa <strong>di</strong>ffusacredenza, il Liber contra insulsam opinionem de gran<strong>di</strong>neet tonitruis <strong>di</strong> Agobardo <strong>di</strong> Lione (+840), ogni fenomeno,sia esso dovuto alle streghe o al <strong>di</strong>avolo, è ritenutopossibile solo “per praeceptum dei”.Agobardo considerava comunque i tempestari frutto <strong>di</strong> unasciocca superstizione, sopravvissuta attraverso lapenetrazione incontrollata <strong>di</strong> elementi pagani all'internodella tra<strong>di</strong>zione popolare: “in queste regioni quasi tutti gliuomini, nobili o no, citta<strong>di</strong>ni o conta<strong>di</strong>ni, vecchi e giovani,ritengono che la folgore e il tuono possano obbe<strong>di</strong>re alcomando degli uomini (...) <strong>di</strong>cono in effetti quando sentonoil tuono e vedono la folgore: Aura levatitia est. Se poi sichiede loro che cosa significhi aura levatitia, confessano,con vergogna e a volte con rimorso, oppurefiduciosamente, come nel caso degli ignoranti, che folgoree tuono sono scatenati da incantesimi <strong>di</strong> uomini dettitempestarii, e che perci si <strong>di</strong>ce Levatitiam auram (…)Pag.4
<strong>IL</strong> <strong>LABIRINTO</strong> N.18 Luglio 2013Perio<strong>di</strong>co telematico <strong>di</strong> informazione culturale a cura del Circolo Culturale Tavola <strong>di</strong> SmeraldoSe dunque Dio onnipotente, grazie alla Sua potenza, flagella inemici dei giusti con inondazioni, gran<strong>di</strong>ne e pioggia, ed allaSua mano è impossibile sfuggire, sono del tutto ignorantidelle cose <strong>di</strong> Dio quanti affermano che anche gli uominipossono fare una cosa del genere. Di fatti, se gli uominipotessero far gran<strong>di</strong>nare sarebbero anche capaci <strong>di</strong> farpiovere: <strong>di</strong> fatti non si è mai visto una gran<strong>di</strong>nata che nonfosse accompagnata dalla pioggia. Si potrebbero cosìven<strong>di</strong>care dei loro avversari non solo rubando loro le messi,ma ad<strong>di</strong>rittura togliendo loro la vita: quando <strong>di</strong> fatti i nemicidegli stregoni tempestari si trovassero in viaggio oppure alloscoperto nei campi, questi potrebbero suscitare contro <strong>di</strong> lorouna gran<strong>di</strong>nata tanto potente da ucciderli. In effetti, certi<strong>di</strong>cono che vi sono tempestari i quali possono adunare in unpunto solo e là farla cadere tutta la gran<strong>di</strong>ne che cade sparsain una regione, essi sono in grado <strong>di</strong> concentrarla su unfiume, su una selva non coltivata, ad<strong>di</strong>rittura su un barilesotto il quale il nemico loro si nascondesse. Di frequente hou<strong>di</strong>to affermare con sicurezza da alcuni che essi sapevanoche cose del genere erano accadute; ma non ho ancorasentito nessuno testimoniare <strong>di</strong> averle vedute <strong>di</strong> persona.Una volta mi fu detto <strong>di</strong> uno che <strong>di</strong>ceva <strong>di</strong> averlepersonalmente constatate. Io mi affrettai a conferire con lui ecosì feci. E <strong>di</strong>scutendo poiché‚ egli assicurava <strong>di</strong> essere statotestimone oculare con molte preghiere e scongiuri e perfinocon minaccia <strong>di</strong> sanzioni spirituali, lo costrinsi a promettereformalmente <strong>di</strong> non <strong>di</strong>re che la verità. A quel punto eglicontinuò ad affermare che ciò che <strong>di</strong>ceva corrispondeva averità e citò persone presenti e circostanze <strong>di</strong> luogo e <strong>di</strong>tempo: ma dovette anche confessare che da parte sua nonera stato presente <strong>di</strong> persona” (2). In Occidente, la credenzapotrebbe aver avuto origine nella tra<strong>di</strong>zione che attribuiva allesacerdotesse dei Celti (le cosiddette druide, ammesso chesiano realmente esistite) la capacità <strong>di</strong> suscitare tempeste etemporali: ma siamo a livello <strong>di</strong> supposizione, <strong>di</strong>fficile daverificare vista la scarsità <strong>di</strong> fonti (3).Per abbattere il potere delle streghe erano in uso “formuleantitempestarie”: aspersione <strong>di</strong> acqua benedetta, a cui siaggiungevano processioni e rogazioni per fugare gli spiritiimmon<strong>di</strong> ed erranti, per allontanare ogni nefasta potenza del<strong>di</strong>avolo, per sterminare i fantasmi e le minacce <strong>di</strong>aboliche (4).Giove Pluvio. Colonna AurelianaDe Lamiis et pythonicis mulieribus <strong>di</strong> Ulrich Molitor, 1849La Lex Wisigothorum prevedeva che i tempestarifossero fustigati, rasati e “così condotti per le terre ovesi credeva che, con arti magiche, fossero stati lacausa <strong>di</strong> devastanti nubifragi e uragani”.Inoltre, secondo Agobardo, la magia tempestarlapoteva anche essere una forma <strong>di</strong> ritorsione attuatadalle streghe che, prima <strong>di</strong> attivare il loro potere<strong>di</strong>struttivo, imponevano ai conta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> pagare unasorta <strong>di</strong> “protezione”; qualora non fossero statesod<strong>di</strong>sfatte le loro richieste, le adepte <strong>di</strong> Satanaavrebbero scatenato Giove pluvio.La fantasia popolare ha naturalmente esasperato i fattifino al parossismo; emblematica un’altra notiziaproveniente ancora da Agobardo: “Io stesso ho vistomolti <strong>di</strong> questi folli che prendevano per vere leaffermazioni più assurde. Mostrarono alla follaradunata tre uomini e una donna i quali si sarebberoimbattuti in navi volanti sulle nuvole ed erano tenuti incatene da molti giorni. Quin<strong>di</strong> li portarono al miocospetto e dovevano essere lapidati”.Di fatto, il vescovo <strong>di</strong> Lione si poneva comunque sullascia <strong>di</strong> una credenza piuttosto ra<strong>di</strong>cata; basti ricordareche durante il sinodo <strong>di</strong> Parigi, nell’829, si puntualizzò:“Si <strong>di</strong>ce che i maghi possano provocare anchetempeste e piogge <strong>di</strong> gran<strong>di</strong>ne, prevedere il futuro,sottrarre ad alcuni i raccolti e il latte per darli ad altri einnumerevoli cose <strong>di</strong> questo genere. Quando siscoprono uomini o donne responsabili <strong>di</strong> questicrimini, li si deve punire molto severamente, perchéessi non temono <strong>di</strong> servire apertamente il <strong>di</strong>avoloscellerato”. In effetti, streghe e stregoni tempestari, inparticolare nell’Alto Me<strong>di</strong>oevo, dovettero fare i conticon una giurisprudenza che fu particolarmente severa.Sul potere dei <strong>di</strong>avoli capaci <strong>di</strong> influenzare lecon<strong>di</strong>zioni atmosferiche, Tommaso d'Aquino scrisse:“È necessario ammettere che, con il permesso <strong>di</strong> Dio i<strong>di</strong>avoli possano causare perturbazioni atmosferiche,stimolare e convogliare i venti e far cadere fuoco dalcielo.Pag.5
<strong>IL</strong> <strong>LABIRINTO</strong> N.18 Luglio 2013Perio<strong>di</strong>co telematico <strong>di</strong> informazione culturale a cura del Circolo Culturale Tavola <strong>di</strong> SmeraldoSebbene infatti la natura del corpo non obbe<strong>di</strong>sca come aun cenno agli angeli, sia buoni sia cattivi, ma al solo Diocreatore per quanto riguarda la trasformazione delle forme,tuttavia è proprio della natura corporea nata solo per ilmoto locale <strong>di</strong> obbe<strong>di</strong>re a quella spirituale, il cui giu<strong>di</strong>zioappare nell'uomo: le membra infatti si muovono al solocomando della volontà che soggettivamente è nell'anima,cosicché‚ proseguano nel loro moto, nel modo <strong>di</strong>spostodalla volontà. Dunque tutto ciò che può avvenire per solomoto locale, può essere compiuto dalla capacità naturalenon solo <strong>di</strong> un angelo buono, ma anche <strong>di</strong> un malvagio, ameno che ciò non sia proibito <strong>di</strong>vinamente. I venti, lepiogge e le altre perturbazioni atmosferiche possonoavvenire con il solo movimento dei vapori che si liberanodalla terra e dall'acqua, per cui per causare fenomeni <strong>di</strong>questa natura è sufficiente la capacità naturale delDiavolo” (5).Tutto ciò era possibile solo se Dio lo permetteva, comespecificava anche Giovanni Nider, nel Formicarius (1437),che rifacendosi all'autorità veterotestamentaria(specificatamente la vicenda <strong>di</strong> Giobbe (Gb 1,6)affermava: “senza alcun dubbio possono (le streghe,n.d.a.) procurare fulmini, gran<strong>di</strong>ne e simili cose, ma solo seDio lo consente”.In seguito, nel Malleus maleficarum (Strasburgo 1486, cap.XV) H. Institor e J. Sprenger affermarono che le tempestecausate dalle streghe erano una sorta <strong>di</strong> punizionemandata agli uomini attraverso la me<strong>di</strong>azione dei <strong>di</strong>avoli,quasi responsabili delle punizioni per i peccatori: “lesventure che accadono nel mondo, quasi per nostrarichiesta, Dio ce le infligge me<strong>di</strong>ante i <strong>di</strong>avoli quasi infunzione <strong>di</strong> carnefici”.Secondo Lutero le streghe: “sono le prostitute del <strong>di</strong>avolo,che rubano il latte, suscitano le tempeste, cavalcanocaproni o scope, azzoppano o storpiano la gente,tormentano i bambini nella culla, tramutano gli oggetti informe <strong>di</strong>verse: sicché‚ un essere umano sembra un bue ouna vacca, e spingono la gente all'amore eall'immoralità”...F.M. Guazzo, nel suo Compen<strong>di</strong>um maleficarum (1608,cap. VI), forniva una serie <strong>di</strong> rime<strong>di</strong> “contro gran<strong>di</strong>ne etempesta” basati sostanzialmente sulla formuladell’esorcismo: “l’esorcista d non deve scomunicarle oesorcizzarle (le tempeste, n.d.a.), ma, bene<strong>di</strong>cendo Dio,pregare quest’ultimo <strong>di</strong> tenerle per misericor<strong>di</strong>a lontane, eimporre ai demoni, nel nome <strong>di</strong> Gesù, che nuvole, venti,fulmini, non ci colpiscano”.Di certo, le credenze connesse alla magia tempestariahanno avuto il loro peso nel sostenere le credenze sullemasche, nelle quale sono confluite tra<strong>di</strong>zioni del sostratofolklorico ed echi provenienti dalla caccia alle streghe cheha segnato la storia dell’Occidente.Davanti al fenomeno della cosiddetta magia tempestaria,riaffiora una vecchia domanda: è possibile fare la storiadella stregoneria, o si può fare solo la storia del concetto <strong>di</strong>stregoneria? Di fatto la storia della caccia alle streghe edei suoi residui folklorici?Chiarisce Franco Car<strong>di</strong>ni: “ammesso che il concetto <strong>di</strong>residuo sia a sua volta sotto il profilo antropologico-storicoplausibile, e che non sia invece l’esisto <strong>di</strong> un pregiu<strong>di</strong>zioevoluzionistico-deterministico, cosa che io personalmentepropendo a ritenere.In altri termini, ritengo che solo il corto circuito tra unacultura religiosa tra<strong>di</strong>zionalmente antimagica come ilcristianesimo, la maturazione del razionalismoteologico-filosofico tomistico (e non la caduta in qualcheirrazionale) e l’insorgere della crisi europea treseicentescaabbiano potuto determinare lo sviluppodell’immagine della malefica, nel senso a questa parolaattribuito da Sprenger e da Kramer e <strong>di</strong>venutopara<strong>di</strong>gmatico” (6).Nelle pratiche legate all’evocazione della pioggia - nelcaso della stregoneria considerata una presenza<strong>di</strong>struttiva - possono comunque essere scorte in nuceampie espressioni della ritualità magico-religiosaconnessa al controllo dei fenomeni meteorologici eclimatici. Sul piano etno-antropologico, ne ha offertoun’importante attestazione A.M. Di Nola: “la pioggia e ifenomeni meteorologici-climatici ad essa connessi(siccità, eccesso <strong>di</strong> pioggia, perio<strong>di</strong>cità delle piogge,inondazioni, gran<strong>di</strong>ne, tempesta, uragano, ecc.) sonoelementi fondamentali nei <strong>di</strong>fferenti ambiti economiciculturali,per la <strong>di</strong>retta <strong>di</strong>pendenza dei cicli <strong>di</strong>produzione o della <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> preda e <strong>di</strong> beni <strong>di</strong>raccolta dalle variazioni climatiche (…) La sicurezzavitale ed economica può <strong>di</strong>pendere dall’arrivo dellepiogge stagionali, dalla loro costanza perio<strong>di</strong>ca, o anchedalla cessazione del periodo piovoso. Parallelamente,in culture che connettono la propria garanzia <strong>di</strong> essereal ciclo piovoso costante e perio<strong>di</strong>co, la pioggia puòdeterminare situazioni <strong>di</strong> crisi e <strong>di</strong> rischio se si presentaal <strong>di</strong> fuori dei tempi economicamente utili (nei perio<strong>di</strong> <strong>di</strong>maturazione terminale o <strong>di</strong> raccolto; inondazione,pioggia tempestosa, uragano, ecc.). Viceversa, intalune culture che connettono la loro sicurezza <strong>di</strong>essere al periodo asciutto, la pioggia può presentarsicome vicenda utile, attesa, desiderata quando la siccitàsi intensifica. Vi è quin<strong>di</strong>, una relatività dei valorieconomicamente utili <strong>di</strong> pioggia” (7).NOTE1) Ef 6,12.2) Liber de gran<strong>di</strong>ne et tronituis, in Patrologia latina, CIV, 151-152.3) Tacito, Annali, XIV, 30. L’idea che fosse possibile agire sulla naturaattraverso formule magiche era particolarmente <strong>di</strong>ffusa anche nei<strong>di</strong>versi strati della tra<strong>di</strong>zione folklorica, emblematica la testimonianza<strong>di</strong> Bucardo <strong>di</strong> Worms: “Hai fatto quel che certe donne sono solitefare? Quando non piove, e se ne hanno bisogno, allora molte fanciullesi adunano e scelgono quasi a loro guida una giovinetta vergine, ladenudano e in<strong>di</strong> la conducono fuori dal villaggio, in un luogo dove cisia l'erba chiamata giusquiamo, che in lingua tedesca si <strong>di</strong>ce belisa;fanno sra<strong>di</strong>care quest'erba da quella vergine, legandogliela al mignolodel piede destro. In<strong>di</strong> le fanciulle tenendo in mano ciascuna unbastoncello, accompagnano la vergine che si trascina <strong>di</strong>etro l'erba finoad un fiume, con i bastoncelli l'aspergono dell'acqua <strong>di</strong> quel fiume;con questi loro incantesimi sperano <strong>di</strong> procurarsi la pioggia. In<strong>di</strong>tenendosi per mano, riconducono la vergine sempre nuda dal fiumeal villaggio, camminando <strong>di</strong> traverso come i granchi. Se lo hai fatto ovi sei stata consenziente, <strong>di</strong>giuna per venti giorni”, Corrector etme<strong>di</strong>cus (Decretorum liber XIX), 5,in Patrologia Latina, CXL, 976.4) Oratio ad debellendam tempestatem, in A. Franz, Die kirchlichenBene<strong>di</strong>ktionen im Mittelalter, II, Friburgo, 1909.5) T. d’Aquino, Expositio in Jobem, I,3.6) F. Car<strong>di</strong>ni, Le ra<strong>di</strong>ci della stregoneria, Rimini 2000, pagg. 7-8.7) A. M. Di Nola, Pioggia, siccità, fenomeni meteorologici e climatici inEnciclope<strong>di</strong>a delle religioni, Firenze 1968, pagg.1645-1646.Pag.6
<strong>IL</strong> <strong>LABIRINTO</strong> N.18 Luglio 2013Perio<strong>di</strong>co telematico <strong>di</strong> informazione culturale a cura del Circolo Culturale Tavola <strong>di</strong> SmeraldoTORTURE E MORTE PER STREGONERIA OGGI(a cura <strong>di</strong> Katia Somà)L'art. 5 della Dichiarazione universale dei <strong>di</strong>ritti umani,approvata dalle Nazioni Unite il 10 <strong>di</strong>cembre 1948, recitache "nessuno sarà sottoposto a tortura, pene o trattamenticrudeli, inumani e degradanti". Da allora sono stati elaborati,tanto da parte dell'ONU quanto da parte <strong>di</strong> organismigovernativi internazionali, altri importanti documenti nei qualisi proibisce la pratica della tortura, considerata graveviolazione dei <strong>di</strong>ritti all'integrità fisica e alla <strong>di</strong>gnità <strong>di</strong> ogniessere umano, a prescindere dalla sua con<strong>di</strong>zione e daireati <strong>di</strong> cui può essersi macchiato. Si possono ricordare ilPatto internazionale sui <strong>di</strong>ritti civili e politici (ONU, 1966), laCarta africana dei <strong>di</strong>ritti umani dei popoli (Organizzazioneper l'unità africana, 1981), la Convenzione interamericanaper la prevenzione e la punizione della tortura(Organizzazione degli Stati americani, 1985), laConvenzione europea per la prevenzione della tortura e deitrattamenti o punizioni inumani o degradanti (Consigliod'Europa, 1987).Atti del <strong>di</strong>ritto internazionale sanciscono l'inammissibilitàdella tortura anche nei casi estremi: le Convenzioni <strong>di</strong>Ginevra del 1949, che costituiscono la base del <strong>di</strong>rittoumanitario in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> guerra e conflitti armati,proibiscono in modo categorico il maltrattamento tanto <strong>di</strong>prigionieri militari quanto <strong>di</strong> quelli civili.Nel 1996 Amnesty International ha denunciato casi <strong>di</strong>tortura in 125 paesi; nel 1997 in 117 paesi; nel 1998l'organizzazione per i <strong>di</strong>ritti umani ha nuovamente rilevatol'uso della tortura in 125 paesi. Di questi ultimi, 33 sonoafricani (esclusi i paesi del Maghreb), 21 sono americani, 22sono asiatici, 31 sono europei, 18, infine, sono me<strong>di</strong>orientalio maghrebini. Se è vero che in alcuni paesi la tortura è unaprassi sistematica adottata in centri <strong>di</strong> detenzione, è anchevero che essa non è mai stata completamente sra<strong>di</strong>cata innessuna regione del mondo.La Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenticrudeli, <strong>di</strong>sumani o degradanti (in inglese, United NationsConvention against Torture and Other Cruel, Inhuman orDegra<strong>di</strong>ng Treatment or Punishment) è uno strumentointernazionale per la <strong>di</strong>fesa dei <strong>di</strong>ritti umani, sotto lasupervisione dell'ONU.La Convenzione prevede una serie <strong>di</strong> obblighi per gliStati aderenti, fra i quali: autorizza ispettori dell'ONU eosservatori dei singoli Stati a visite a sorpresa nellestrutture carcerarie per verificare l'effettivo rispetto dei<strong>di</strong>ritti umani, stabilisce il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> asilo per le personeche al ritorno in patria potrebbero essere soggetti atortura. Il Comitato contro la Tortura, tra i vari comitatidei Diritti Umani, è uno <strong>di</strong> quelli più efficaci ed incisivi,tuttavia il Comitato può esercitare controlli solo se unoStato contraente <strong>di</strong>chiara espressamente <strong>di</strong> accettarli.La Convenzione è stata approvata dall'Assembleadell'ONU a New York il 10 <strong>di</strong>cembre 1984, ed è entratain vigore il 26 giugno 1987. Al Giugno 2008, è stataratificata da 145 Paesi. Il 26 giugno è la giornatainternazionale <strong>di</strong> sostegno alle vittime della tortura.L'Italia ha sottoscritto la Convenzione, ma, nonostantemolti solleciti anche a livello internazionale, ilParlamento italiano non ha ancora approvato la legge<strong>di</strong> ratifica e conseguentemente la Convenzione non èancora operante in Italia, che ha anche <strong>di</strong>sattesoall'obbligo assunto <strong>di</strong> introdurre il reato <strong>di</strong> tortura nelCo<strong>di</strong>ce Penale .Il 30 novembre 1786 Pietro Leopoldo, granduca <strong>di</strong>Toscana e futuro imperatore d'Austria, abolì, primosovrano al mondo, la pena <strong>di</strong> morte e la tortura. Adoggi sono più <strong>di</strong> cinquanta i paesi della comunitàinternazionale che continuano ad applicare la penacapitale; alla luce <strong>di</strong> ciò è ancora utile e <strong>di</strong>estrema attualità ricordare l'importanza storica <strong>di</strong> unsimile gesto, voluto da un uomo considerato, ancoraoggi, come uno dei più illuminati del suo tempo.All’inizio del ventunesimo secolo sono ancora migliaiagli uomini che continuano a subire questa terribilepratica. Secondo i dati raccolti da Amnesty negli ultimitre anni in oltre 150 paesi la polizia commette torture emaltrattamenti e più <strong>di</strong> 80 questi hanno provocatodecessi. In 50 paesi nel mondo vengono torturati iminori. La tortura avviene anche laddove vige lademocrazia, è praticata e colpisce persone <strong>di</strong> tutte leestrazioni sociale. Il <strong>di</strong>ritto internazionale la consideraillegale e 119 paesi hanno ratificato il principale trattatoche la mette al bando. Spesso l’o<strong>di</strong>o razziale e la<strong>di</strong>scriminazione sessuale sono alla base <strong>di</strong> atti <strong>di</strong>tortura e maltrattamenti. In <strong>di</strong>versi paesi le donnesubiscono mutilazione genitali e punizioni corporali innome della religione e della tra<strong>di</strong>zione.Riportiamo una parte <strong>di</strong> “TORTURA E STATO DICOSCIENZA” della psicologa Marilia Boggio Marzetpubblicato in Atti del II Convegno “La Stregoneria nelleAlpi Occidentali” “<strong>IL</strong> <strong>LABIRINTO</strong>” Numero Speciale.Aprile 2011Partiamo dal significato etimologico del temine“tortura” e cioè dal latino tortus, participio passato <strong>di</strong>torquere ossia tormentare le membra torcendole e dalsignificato psicologico e cioè il proce<strong>di</strong>mento atto aledere l’integrità fisica e/o mentale <strong>di</strong> un soggetto perun secondo fine.Pag.7
<strong>IL</strong> <strong>LABIRINTO</strong> N.18 Luglio 2013Perio<strong>di</strong>co telematico <strong>di</strong> informazione culturale a cura del Circolo Culturale Tavola <strong>di</strong> SmeraldoL'associazione mon<strong>di</strong>ale dei me<strong>di</strong>ci nella <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong>Tokyo del 1975 definisce come tortura"le sofferenze fisicheo mentali inflitte in modo deliberato, sistematico o arbitrarioda una o più persone che agiscono da sole o su or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong>una autorità per obbligare un'altra persona a fornireinformazioni, a fare una confessione o per qualunque altraragione".La <strong>di</strong>stanza fra il campo <strong>di</strong> applicazione della psicologia oggie gli stu<strong>di</strong> sulla stregoneria nel me<strong>di</strong>oevo è soltantoapparente. Purtroppo le fonti me<strong>di</strong>evali sono scarsissime epressoché inesistenti ma possiamo operare una utileestrapolazione <strong>di</strong> cosa poteva accadere durante una torturaanalizzando ciò <strong>di</strong> cui <strong>di</strong>sponiamo oggi. Tutto sommato gliesseri umani non sono molto <strong>di</strong>versi se analizziamo le<strong>di</strong>namiche esistenti fra aguzzino e vittima: che si tratti <strong>di</strong>episo<strong>di</strong> occorsi nell’operazione Iraq Freedom o in unaprigione del XV secolo, le <strong>di</strong>namiche intrapsichiche sono lestesse, cambia soltanto la cornice contestuale ideologica.Occorre operare uno sforzo mentale depurando il settingme<strong>di</strong>evale da tutte le interferenze storiche ed analizzaresoltanto gli atti <strong>di</strong> violenza compiuti e le possibili reazionidelle vittime.Indubbiamente tale operazione non risulterà facile esoprattutto comprensibile ad una prima analisi. Lemotivazioni filosofiche e teologiche sono <strong>di</strong>verse, il contestopolitico cambia, le <strong>di</strong>namiche sociali sono molto <strong>di</strong>fferenti…detto ciò una vittima rimane una vittima, un aguzzino è pursempre un aguzzino e ciò che li lega è la tortura, nelsignificato etimologico espresso in precedenza.Le tipologie della tortura sono svariate: dalla intenzionalealla sistematica o occasionale; con o senza un or<strong>di</strong>ne;conscopo mirato; sofferenza fisica o mentale.E’ praticamente impossibile stilare una lista <strong>di</strong> meto<strong>di</strong> cherisulti esauriente. Tuttavia sembra utile riportare l’elenco deimaltrattamenti che il Protocollo <strong>di</strong> Istanbul include nelconcetto <strong>di</strong> tortura.Va ricordato che la tortura può essere sia fisica chepsicologica, anche se, per la stretta connessione fraquesti due aspetti della persona umana, tale<strong>di</strong>stinzione ha sempre confini poco netti. La tortura,anche quando si sostanzia in un abuso semplicementefisico, porta nel suo intento stesso (piegare la volontàdella vittima, renderla inerme) una violenzapsicologica. La tortura psicologica, d’altro canto, èquasi sempre accompagnata da sofferenze checoinvolgono l’intero organismo prendendo spesso laforma <strong>di</strong> più o meno gravi <strong>di</strong>sturbi psicosomatici.Stante questa premessa Il Protocollo <strong>di</strong> Istanbulinclude nel concetto <strong>di</strong> tortura <strong>di</strong>verse tipologie <strong>di</strong>maltrattamento sud<strong>di</strong>videndole in tre categorie:tortura fisica, considerata in base all’affetto chesortisce e al tipo <strong>di</strong> dolore che induce nella vittimatortura sessuale la quale potrebbe rientrare nellacategoria delle torture fisiche ma viene descrittaseparatamente a causa del grande impatto sociale epsicologico che essa causatortura psicologica, che a <strong>di</strong>fferenza dellaprecedente, mira a <strong>di</strong>struggere l’identità della vittima ea spossarla psicologicamente attraverso ripetuteumiliazioni, violazioni e messaggi.Scopi della torturaCome enunciato nella definizione <strong>di</strong> tortura èessenziale che ci sia uno scopo od un obiettivoall'origine della tortura. In mancanza <strong>di</strong> un fine o <strong>di</strong> unoscopo non si può parlare <strong>di</strong> tortura. Le ragioni possonoessere numerose e queste variano da caso a caso, aseconda della personalità della vittima e delle accuse.Alcuni degli scopi della tortura sono i seguenti:1. Ottenere informazioni: dopo l'arresto una personaè normalmente soggetta a tortura allo scopo <strong>di</strong>ottenere informazioni sulle attività e sulle persone e leorganizzazioni coinvolte. Il torturatore continua atorturare la persona finché le informazioni sono stateottenute. Se le informazioni date risultano false lapersona verrà ancora torturata.2. Estorcere una confessione: il torturatore tortura lavittima allo scopo <strong>di</strong> costringerla a confessare uncrimine. La vittima è costretta a firmare una<strong>di</strong>chiarazione scritta in cui ammette <strong>di</strong> aver commessoil crimine. Frequentemente la vittima firma la<strong>di</strong>chiarazione anche se non ha commesso il crimine,per evitare ulteriori torture.Pag.8
<strong>IL</strong> <strong>LABIRINTO</strong> N.18 Luglio 2013Perio<strong>di</strong>co telematico <strong>di</strong> informazione culturale a cura del Circolo Culturale Tavola <strong>di</strong> Smeraldo3. Avere una testimonianza per incriminare altrepersone: talvolta le vittime sono obbligate a firmare una<strong>di</strong>chiarazione che accusa altre persone <strong>di</strong> un crimine o <strong>di</strong>attività sospette. Come risultato <strong>di</strong> ciò il torturatore puòarrestare le persone che vuole e sottoporle a tortura.4. Ven<strong>di</strong>carsi: il torturatore può torturare la vittima solo pervendetta personale. Talvolta si tortura non solo l'in<strong>di</strong>viduo,ma anche elementi della sua famiglia e membri dellacomunità. Lo stupro della moglie <strong>di</strong> un nemico, della sorellao della figlia è un ben noto mezzo <strong>di</strong> vendetta.5. Terrorizzare la comunità: ciò accade specialmente in unregime <strong>di</strong>ttatoriale. Chiunque osi alzare la voce contro ilregime è torturato senza pietà. La vittima è poi uccisa oreintrodotta nella comunità con i segni fisici e mentali dellatortura. Ciò crea terrore nella comunità e soffoca sulnascere eventuali proteste. Il <strong>di</strong>ttatore in questo modorafforza il suo regime. Ciò accade anche in una societàarretrata <strong>di</strong> tipo feudale. In molti villaggi nel Nepal e in In<strong>di</strong>ail signore o "zamindar" continua ad avere molta influenza eusa la tortura per mantenere il suo potere.6. Distruggere la personalità: In un regime <strong>di</strong>ttatorialel’attenzione non viene puntata solo verso quelle personeche osano levare la loro voce contro i regimi <strong>di</strong>ttatoriali ol'oppressione della società e mobilitano la gente dellacomunità contro il regime. Le vittime vengono scelte inmodo “irregolare” (che consiste nel punire arbitrariamente eimpreve<strong>di</strong>bilmente ogni categoria <strong>di</strong> persone, e nel mutarecostantemente i canoni che separano ciò che non épermesso da ciò che é concesso) allarga e potenzia l'areadel terrore, ribadendo il messaggio che il potere può arrivaree colpire ovunque e che non ci sono categorie e situazioni alriparo.Oggi, per quanto possa apparire impossibile, esistonoancora casi <strong>di</strong> persone uccise perché accusate <strong>di</strong>stregoneria. Queste vengono torturate e maltrattate cosìcome avviene da centinaia <strong>di</strong> anni. Dal Corrieredellasera.itdel 09 Aprile 2013 si legge:“Continuano a fare vittime le credenze nella stregoneria,<strong>di</strong>ffuse in parti della Papua Nuova Guinea, nel Pacifico. Duedonne anziane sono state torturate per tre giorni e poidecapitate nell'isola orientale <strong>di</strong> Bougainville, riferisce ilquoti<strong>di</strong>ano nazionale Courier Post. La polizia, chiamata pertentare <strong>di</strong> liberare le donne, era presente all'uccisione mauna folla numerosa e aggressiva ha impe<strong>di</strong>to agli agenti <strong>di</strong>intervenire. Torturate per tre giorni, ferite a colpi <strong>di</strong> coltello eascia sono state alla fine decapitate; la polizia ha detto <strong>di</strong>aver tentato <strong>di</strong> negoziare la loro liberazione ma senzasuccesso. Le donne erano state catturate e fatte prigionieredai parenti <strong>di</strong> un ex insegnante <strong>di</strong> scuola morto pochi giorniprima. L'episo<strong>di</strong>o avviene sei giorni dopo un'altra condannapopolare per stregoneria decretata nelle SouthernHighlands, negli altipiani occidentali: sei donne torturate conferri roventi collocate sui genitali e poi bruciate vive duranteun "rito pasquale". Il mese scorso una giovane madre,accusata della morte <strong>di</strong> un bimbo <strong>di</strong> 6 anni con pratichemagiche, era stata denudata, cosparsa <strong>di</strong> benzina ebruciata viva <strong>di</strong>nanzi a una folla tra cui anche un gruppo <strong>di</strong>scolari.Amnesty International ha fatto appello al governo <strong>di</strong>Port Moresby perché combatta con più vigore lecredenze <strong>di</strong> stregoneria e le violenze che essealimentano contro le donne.. Nel poverissimo Stato delPacifico c'è una <strong>di</strong>ffusa credenza nella magia nera:molti faticano ad accettare che siano cause naturali aprovocare infortuni, malattie, eventi tragici o la morte,ma spesso utilizzano le accuse per giustificare atti <strong>di</strong>violenza contro le donne. Secondo Amnesty, nel 2008sono state almeno 50 le donne morte per cause legatealla stregoneria.In un altro sito <strong>di</strong> informazionewww.giornalettismo.com, compaiono raccapricciantiarticoli sul tema che lega torture al reato <strong>di</strong> stregoneriae magia.01/11/2011 - In Arabia Sau<strong>di</strong>ta un sudanese <strong>di</strong> 44 anniè stato decapitato perché ritenuto colpevole <strong>di</strong> avercreato un incantesimo per riconciliare le coppie. Tra ipaesi in cui è ancora in vigore la pena <strong>di</strong> morte,l’Arabia Sau<strong>di</strong>ta è quello con i meto<strong>di</strong> più cruenti,sopratutto per reati che altrove non sono definibili tali:la prova, l’esecuzione <strong>di</strong> un citta<strong>di</strong>no sudanese <strong>di</strong> 44anni, Abdul Hamid Bin Hussain Bin Moustafa al-Fakki,decapitato perchè accusato <strong>di</strong> essere uno stregone.L’esecuzione si è svolta in un parcheggio pubblico,davanti a numerosi testimoni, i quali hanno ripreso lascena con telefoni cellulari. L’esecuzione <strong>di</strong> Al Fakki èstata la quarantaquattresima nel paese dall’iniziodell’anno, e l’un<strong>di</strong>cesima che coinvolge citta<strong>di</strong>nistranieri, mentre altri 140 sono nel braccio della mortein attesa della sentenza.12/12/2011 - In Arabia Sau<strong>di</strong>ta Una donna sau<strong>di</strong>ta èstata decapitata oggi dopo essere stata accusata <strong>di</strong>praticare atti <strong>di</strong> stregoneria, vietati nel regnoconservatore. Amina bint Abdulhalim Nassar è statagiustiziata nella provincia settentrionale <strong>di</strong> Jawf peraver “praticato stregoneria e magia’, ha detto ilministero in un comunicato. Non ci sono dati esatti suquante donne sono state giustiziate nel regno, maun’altra è stata decapitata a ottobre per aver ucciso ilmarito dando fuoco alla sua abitazione. Quest’annosono 73 le decapitazioni eseguite in Arabia Sau<strong>di</strong>ta.Pag.9
<strong>IL</strong> <strong>LABIRINTO</strong> N.18 Luglio 2013Perio<strong>di</strong>co telematico <strong>di</strong> informazione culturale a cura del Circolo Culturale Tavola <strong>di</strong> SmeraldoVESTA E <strong>IL</strong> FUOCO DI ROMA(a cura <strong>di</strong> Paolo Galiano)Vesta è Dèa antichissima (1), e, anche se non è notal’esistenza <strong>di</strong> un Flamen Vestalis, poiché <strong>di</strong> due deiFlamines minores non conosciamo il nome, come ricordaDumézil (2), egli si potrebbe forse trovare tra questi, anchese, data la posizione eccellente della Dèa nel pantheonromano, ci sembra <strong>di</strong>fficile che a lei fosse dato un Flamen <strong>di</strong>secondaria importanza. Di certo il suo sacerdote vaidentificato con il Pontifex Maximus, il quale nei confrontidelle Vestali aveva le prerogative <strong>di</strong> un padre e <strong>di</strong> un marito,così come a loro volta le Vestali erano vergini ma allostesso tempo madri <strong>di</strong> ogni civis romano, ed infattil’eventuale rapporto sessuale tra una <strong>di</strong> esse ed un citta<strong>di</strong>nocomportava l’accusa <strong>di</strong> incestus, col significato <strong>di</strong> rapportotra consanguinei.Il tempio <strong>di</strong> Vesta al tempo della sua riscoperta da parte delLanciani (dal Lanciani cit.).La Dèa, non ostante le interpretazioni antiche e moderne,nulla ha a che vedere con Hestia, apparentemente suaomologa nel mondo greco: se Hestia deriva da una ra<strong>di</strong>ce*sueit con significato <strong>di</strong> bruciare, per cui Hestia è *suit-tia“il fuoco del focolare”, Vesta origina da *wes (3), abitare,<strong>di</strong>morare, e quin<strong>di</strong> è la <strong>di</strong>vinità del focolare e della casastessa, la quale in un certo senso custo<strong>di</strong>sce tra le suepareti il focolare.La concezione della <strong>di</strong>vinità del fuoco e del focolare che neè il “luogo” è comune presso i popoli indoeuropei, e inparticolare le tra<strong>di</strong>zioni dell’In<strong>di</strong>a e <strong>di</strong> Roma sulla sacralitàdel fuoco possono essere sovrapposte e si spieganoreciprocamente, avendo sempre presente la <strong>di</strong>fferenza trai due sistemi religiosi, più metafisico e minuzioso nellaprocedura rituale quello in<strong>di</strong>ano, più tecnico e giuri<strong>di</strong>coquello Romano. Il fuoco è sacro perché è, in primo luogo, ilmezzo del sacrificio; per mezzo <strong>di</strong> lui l’oblazione vienetrasformata in fumo che può giungere agli Dèi: “Il fuoco èconcepito nei Veda come il tramite che unisce il mondodegli uomini a quello degli Dèi, poiché egli trasporta incielo l’oblazione offerta dagli uomini nell’atto sacrificale,dal mondo visibile a quello invisibile” (4). Quin<strong>di</strong> è sacro ilfocolare perché è il luogo del fuoco, e se sono sacri tutti ifocolari familiari supremamente sacro sarà il focolaredello Stato e quin<strong>di</strong> chi lo accu<strong>di</strong>sce.Il fuoco è il tramite tra l’uomo e il cielo, Dyaus (da cuiDyaus Pater, Juppiter): “Il cielo azzurro fu la più antica<strong>di</strong>vinità degli Arii e verso <strong>di</strong> esso fiammeggiava la vampa,quasi dalla terra al cielo trasportando le preghiere e leofferte degli uomini” (5). E aggiunge Giamblico: “L’offertadei sacrifici consuma la sua materia nel fuoco che laassimila a sé e la rende non simile alla materia ma latrasforma in fuoco <strong>di</strong>vino, celeste, immateriale… Così noisiamo elevati nei sacrifici e portati dalla purificazione delfuoco al fuoco degli Dèi, come il fuoco riduce le cosepesanti e dure alle <strong>di</strong>vine e celesti” (6).Il culto <strong>di</strong> Vesta risale alla prima Età Regia, masicuramente si tratta della prosecuzione <strong>di</strong> una forma <strong>di</strong>culto ancora più antica, che si può far risalire almeno alperiodo della presenza dei Siculi sul Palatino (Età delBronzo Me<strong>di</strong>o, secondo Caran<strong>di</strong>ni), quando Caca, lasorella-figlia-moglie <strong>di</strong> Caco (in<strong>di</strong>stinzione caotica delruolo tipica delle età più arcaiche), era la sacerdotessadel Fuoco del Re.Vesta è la Dèa del focolare come luogo <strong>di</strong>manifestazione del Fuoco, potere generatore; nellaconcezione sacrale dei Romani, come <strong>di</strong> altri popoliindoeuropei, è il fuoco l’elemento generatore che fecondaattivamente il focolare, il quale costituisce l’elementopassivo della coppia, e “il bambino appena nato venivaomologato al tizzone e cioè al frutto nato dal fuoco,sperma pyròs, che era stato deposto nella matricefocolaredella moglie dal padre” (7). Il potere generatorea Roma si identifica con Mars e con Volcanus, ambedueDèi generatori ma sul piano materiale (Marte comeVulcano è padre <strong>di</strong> eroi fondatori: Caco a Roma e Ceculoa Praeneste figli <strong>di</strong> Vulcano, e Mo<strong>di</strong>o Fabi<strong>di</strong>o a Cures ePico ad Alba, figli <strong>di</strong> Marte, come i due Gemelli) ma nonsu quello cosmico.Ci sembra quin<strong>di</strong> corretto quanto scrive Baistrocchi: “Taleattribuzione [<strong>di</strong> paredro <strong>di</strong> Vesta] dovrebbe con ogniverosimiglianza essere riservata a colui che precede tuttigli altri Dèi, Janus Pater, il fuoco celeste che costituiscel’origine prima, il Principio <strong>di</strong> ogni generazione” (8).Dumézil ha <strong>di</strong>mostrato (9) il rapporto tra Janus e Vestadal punto <strong>di</strong> vista rituale: se il Rex Sacrorum è ilsacerdote <strong>di</strong> Janus, il Pontifex Maximus per la sua strettacorrelazione con Vesta e le sacerdotesse Vestali puòessere considerato il sacerdote della Dèa, e in tal casol’ordo sacerdotum riportato da Festo, cioè l’or<strong>di</strong>ne in cuiprendevano posto nei banchetti sacri i primi cinquesacerdoti <strong>di</strong> Roma, manifesta in modo chiaro che ilsacerdote <strong>di</strong> Janus è il primo e quello <strong>di</strong> Vesta l’ultimo,così come da altri scrittori romani viene affermatospettare nelle preghiere e nei sacrifici il primo posto aJanus e l’ultimo a Vesta (10): il primo apre, essendoquesta la sua funzione in modo eminente, e la seconda,punto <strong>di</strong> contatto tra il mondo degli Dèi e quello degliuomini, chiude ogni atto religioso.Pag.10
<strong>IL</strong> <strong>LABIRINTO</strong> N.18 Luglio 2013Perio<strong>di</strong>co telematico <strong>di</strong> informazione culturale a cura del Circolo Culturale Tavola <strong>di</strong> SmeraldoMa non è solo sul piano metafisico e liturgico che Vesta eJanus sono accomunati: sul piano fisico a Vesta, che è lacasa, il focolare, il penus, la <strong>di</strong>spensa che conserva laricchezza che viene prodotta dall’uomo e il posto più internodella casa in cui sono conservati i beni accumulati,corrisponde Janus, il Dio che presiede ai passaggi e allestrade, rector viarum, e quin<strong>di</strong> anche al movimento dellegreggi e ai lavori dei campi e più in generale allacircolazione della ricchezza, Janus a cui “è riconosciuta lapaternità del denaro, il cui nome latino pecunia conserva inmodo trasparente la sua connessione con le mandrie” (11).Quin<strong>di</strong> ambedue sono fonte e luogo della ricchezzamateriale che gli Dèi concedono all’uomo.La capacità generatrice <strong>di</strong> Janus come fuoco è connessaalla sua identificazione con il Sole, come scrive Macrobionei Saturnalia (12): “Chiamarono Apollo Patrôos non per ilculto particolare <strong>di</strong> una stirpe o <strong>di</strong> una città, ma come autore<strong>di</strong> ogni generazione: il sole, prosciugando l'umi<strong>di</strong>tà, <strong>di</strong>edeorigine alla vita… Per questo anche noi chiamiamo Gianopadre, venerando con tale nome il sole”.Questo consente <strong>di</strong> ampliare ulteriormente il <strong>di</strong>scorso sulsignificato <strong>di</strong> Janus, <strong>di</strong>vinità complessa e misteriosa inquanto primor<strong>di</strong>ale e quin<strong>di</strong> poco comprensibile già per glistessi Romani: Janus è il Sole ma è soprattutto il principiodel Fuoco cosmico grazie al quale viene in essere lacreazione, e questo si manifesta nel rito <strong>di</strong> accensione espegnimento del fuoco <strong>di</strong> Vesta il primo giorno <strong>di</strong> Marzo,quando quello che si spegne è il fuoco materiale mentrequello principiale rimane eternamente perenne: “Lospegnimento del Fuoco adombra il processo dell’ecpirosi ecioè il passaggio, attraverso la totale combustione e quin<strong>di</strong>l’esaurimento <strong>di</strong> tutte le potenzialità della Manifestazione,nell’immobilità assoluta, nell’Immanifesto, mentre la suaaccensione simboleggia il passaggio da tale stato al mondomanifestato” (13).Ciò non significa che Janus o Volcanus o Mars siano daconsiderare i coniugi <strong>di</strong> Vesta (come si può vedere nellatarda ricostruzione del Portico degli Dèi Consenti fatta daVettio Agorio Pretestato nel 367 d.C., dove Vulcano e Vestaerano in coppia (14)): Vesta è eternamente Vergine edeternamente Madre, in quanto funzione <strong>di</strong> Vesta è avere incura il creato e mantenerlo in essere secondo l’Or<strong>di</strong>ne<strong>di</strong>vino.Per questo nella sua custo<strong>di</strong>a sono il Palla<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Troia(simbolo della continuità della Tra<strong>di</strong>zione dall’italicoDardano alla Samotracia dei Misteri Cabìrici e a Troia perpoi tornare <strong>di</strong> nuovo in Italia con Enea nella terra del LatiumVetus), i Penates, cioè gli Antenati <strong>di</strong>vinizzati dei civesromani che rappresentano la prosecuzione nel tempo dellastirpe, e forse il fascinus, il simulacro del fallo generatore(15) : sono questi i Pignora custo<strong>di</strong>ti nel penus del suotempio, poiché degli altri Pignora è esplicitamente dettotrovarsi in altri luoghi (16).Un argomento non con<strong>di</strong>vi<strong>di</strong>amo della sapientericostruzione del rapporto tra Vesta e Janus fatta daBaistrocchi, là ove egli definisce Vesta come simbolo dellacreazione scrivendo: “la Dèa impersonava anche lamaternità esuberante e prolifica e quin<strong>di</strong>, più in generale, lafertilità inesauribile della natura” (17): Vesta non è collegata,neanche nei miti tar<strong>di</strong>vi, alla procreazione ma è sempreVergine e tale rimane pur avendo l’appellativo <strong>di</strong> Madre.L’episo<strong>di</strong>o raccontato da Ovi<strong>di</strong>o <strong>di</strong> un tentativo da parte <strong>di</strong>Priapo <strong>di</strong> violarla rimasto senza successo ne è un chiaroin<strong>di</strong>zio (18).Vesta è quin<strong>di</strong> la Vergine Madre, a lei non spetta lacreazione <strong>di</strong> qualcosa, come per Tellus o Ceres o le altreGran<strong>di</strong> Madre romane, le quali hanno cura dellagenerazione delle messi come delle mandrie e deglistessi umani, ma è eternamente Vergine ed eternamenteMadre <strong>di</strong> tutto ciò che viene all’esistenza.Busto <strong>di</strong> una VestaleMassima: si noti il nodoparticolare che chiude laveste in vita, detto “Nodo <strong>di</strong>Ercole” (dal Giannelli cit.).Il suo essere “la casa del fuoco” e il prototipo dellaMatrona, della padrona della casa, richiama alla menteuna figura <strong>di</strong> <strong>di</strong>vinità anch’essa Vergine e Madre, poichéil suo unico figlio nasce da un rapporto magico e nonfisico: inten<strong>di</strong>amo Iside, il cui nome si scrive con ilgeroglifico st, “trono”, simbolo del potere che in essarisiede e che si manifesta nella sua capacità <strong>di</strong> essere laMaga per eccellenza, la quale rimane incinta e partorisceil figlio Horus, il Sole, con un atto magico, poiché il fallo <strong>di</strong>Osiride è andato perduto quando è stato fatto a pezzi dalfratello Seth.Rileviamo che Hestia, corrispondente greca (anche sesolo in modo parziale) <strong>di</strong> Vesta, è a volte raffigurataseduta sull’omphalos, il quale appartiene ad Apollo-Solema <strong>di</strong> cui essa sembra esserne custode: “Estia era lacustode, il trono dell’onfalo” <strong>di</strong>ce Baistrocchi (19), cosìcome il trono rientra nel nome <strong>di</strong> Iside; ciò sembraconfermare ulteriormente il possibile accostamento <strong>di</strong>Vesta ad Iside.Sarebbe infine da esaminare in che modo sia possibileun accostamento <strong>di</strong> queste due Vergini Madri con unaterza figura <strong>di</strong> Vergine Madre, Maria madre del Cristo,ma questo ci porterebbe troppo lontani dall’argomentodel presente saggio.Come scrive Sabbatucci, il quale meglio <strong>di</strong> molti altri neha compreso il significato religioso e metafisico: “Vestanon era né la terra né il focolare ma una centralitàinterioritàcosmica, che poteva essere rilevata nellospazio domestico (l’atrio e il focolare), così come nellospazio assoluto [perché il suo tempio è circolare,simbolo dell’infinito] o come nel tempo [in quanto annus,anno, è correlato ad anulus, cerchio, e forma circolare hail tempio <strong>di</strong> Vesta]”.Pag.11
<strong>IL</strong> <strong>LABIRINTO</strong> N.18 Luglio 2013Perio<strong>di</strong>co telematico <strong>di</strong> informazione culturale a cura del Circolo Culturale Tavola <strong>di</strong> SmeraldoLe sue sacerdotesse erano le vergini Vestali, in origine figlie<strong>di</strong> famiglia patrizia (come patrizia erano Caca, sorellamogliedel Re Caco, e Rea Silvia, figlia del Re Numitore emadre dei Gemelli). Le funzioni delle Vestali eranomolteplici: oltre ad accu<strong>di</strong>re il tempio della Dèa e a vegliareil Fuoco perché non si spegnesse mai, avevano il compito <strong>di</strong>preparare tre prodotti particolari (21) che venivano utilizzatiin molte cerimonie: il suffimen (adoperato nelle purificazionidei Parilia <strong>di</strong> Aprile), la mola salsa (una focaccia fatta con ilsale ed il farro della raccolta primiziale <strong>di</strong> Maggio, che erausata nei riti sacri e costituiva in particolare l’offerta da farea Vesta) e la muries (sale cotto al forno e poi triturato emesso in salamoia in acqua <strong>di</strong> fonte) (22).Le cerimonie a cui prendevano parte le Vestali eranonumerose e si andarono man mano arricchendo fino all’etàimperiale; tra <strong>di</strong> esse vogliamo solo ricordare: i Parentalia <strong>di</strong>Febbraio, in cui la Vestale Massima celebrava per contodello Stato la parentatio alla tomba <strong>di</strong> Tarpea; la cerimoniadelle Kalendae <strong>di</strong> Marzo, in cui veniva spento e riacceso ilfuoco sacro del tempio <strong>di</strong> Vesta; i For<strong>di</strong>ci<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Aprile,quando le ceneri dei feti <strong>di</strong> vacche gravide sacrificate aTellus venivano recati alle Vestali per la preparazione delsuffimen; i Parilia sempre in Aprile, giorno in cui le Vestali<strong>di</strong>stribuivano il suffimen da loro preparato per lapurificazione degli uomini, degli armenti e degli ovili; lapartecipazione alle Eidus <strong>di</strong> Maggio alla cerimonia del lanciodei simulacra degli Argei dal ponte Sublicio; i Consualia <strong>di</strong>Agosto, in cui le Vestali celebravano il rito con il FlamenQuirinalis, e i successivi Opeconsivia dello stesso mese,celebrati nel sacrario della Regia de<strong>di</strong>cato ad Ops,accessibile solo al Pontifex Maximus e alle Vestali; la festa<strong>di</strong> Bona Dèa a Dicembre, celebrazione notturna da partedelle matrone e delle Vestali (equiparate quin<strong>di</strong> alle matronepur essendo virgines) (23).Il “Nodo <strong>di</strong> Ercole” in un anello del IV – II sec. a.C.(Museo del Louvre - dal web).Per completare, vogliamo ricordare come nel 394 d.C.Teodosio abrogò definitivamente con il suo e<strong>di</strong>tto i cultidegli Antichi Dèi <strong>di</strong> Roma: conosciamo bene la fine <strong>di</strong>quello <strong>di</strong> Vesta , perché Zosimo (24) ci ha lasciato unavivida descrizione dell’ultimo insulto alla Dèa e dellapunizione <strong>di</strong> chi lo aveva commesso.Il “Nodo <strong>di</strong> Ercole” come ornamento <strong>di</strong> una testafemminile del II sec. a.C. (Museo Archeologico <strong>di</strong>Taranto - dal web).Nel settembre 394, con la sconfitta da parte <strong>di</strong> TeodosioII dell’imperatore Eugenio, eletto dai senatori gentili <strong>di</strong>Roma, le ultime vestigia dei templi e dei riti romanivennero <strong>di</strong>strutte per or<strong>di</strong>ne dell’imperatore e le Vestaliallontanate dal tempio e dall’Atrio <strong>di</strong> Vesta, ma in modoonorevole e senza essere perseguitate, come successeinvece ad altri or<strong>di</strong>ni sacerdotali (pensiamo per esempioai sacerdoti <strong>di</strong> Mithra, trucidati dai fanatici cristiani, e aisuoi luoghi sacri, devastati e occultati sotto le macerie).Come scrive Lanciani (25), che aveva riportato alla lucel’Atrio <strong>di</strong> Vesta: “Le nostre Vergini non contaminarono gliultimi anni della loro vita con innovazioni alla priscapurezza del rito: esse caddero, come suol <strong>di</strong>rsi, tutte d’unpezzo, fedeli al loro istituto un<strong>di</strong>ci volte secolare, scevreda ogni sospetto <strong>di</strong> cattiva condotta e rispettate anchedagli avversari”.A lungo i sacri luoghi non vennero turbati dalla plebe cheormai vi aveva accesso, essendo <strong>di</strong>venuti proprietà deldemanio imperiale, e, prosegue Lanciani, “non fudanneggiata la fabbrica, né fu recato oltraggio alle opered’arte che conteneva. Noi abbiamo ritrovato statue, busti,pie<strong>di</strong>stalli in perfetto stato <strong>di</strong> conservazione, e talvoltanon mossi <strong>di</strong> posto”.Nel 401, Serena, figlia <strong>di</strong> Teodosio, osò rubare un moniled’oro dalla statua <strong>di</strong> Vesta: “Serena, deridendo questecose [cioè i riti aboliti dal padre], volle visitare il tempiodella Gran Madre (26): appena vide che la statua <strong>di</strong> Rheaportava al collo una collana degna del culto riservato aduna Dèa [che quin<strong>di</strong> nessuno aveva osato toccare dal394, quando il culto era stato proibito], la tolse dal collodella statua e la mise al suo. E quando una vecchia, unadelle vergini Vestali che era rimasta, le rinfacciò la suaempietà, essa la oltraggiò. Allora costei lanciò controSerena, il marito e i figli tutte le imprecazioni che il suoatto sacrilego meritava… E la Giustizia riuscì a compiereil suo dovere: Serena non poté sfuggire al suo destinoma porse al cappio quel collo che aveva cinto conl’ornamento della Dèa”.Pag.12
<strong>IL</strong> <strong>LABIRINTO</strong> N.18 Luglio 2013Perio<strong>di</strong>co telematico <strong>di</strong> informazione culturale a cura del Circolo Culturale Tavola <strong>di</strong> SmeraldoNOTE1) Di Vesta, dei suoi riti e delle sacerdotesse Vestali che ne curavanoil culto abbiamo trattato in un saggio a lei de<strong>di</strong>cato (GALIANO Vesta eil fuoco <strong>di</strong> Roma, ed. Simmetria, Roma 2011), dal quale ripren<strong>di</strong>amoqui alcuni temi principali, rinviando al testo citato per una più completaconoscenza dell’argomento..2) DUMÉZ<strong>IL</strong> La religione romana arcaica, ed. Rizzoli, Milano 1977pag. 105: nel luogo citato Dumézil parla <strong>di</strong> tre nomi mancanti alla lista,perché non considera sicuro il nome del Portunalis, che invece cita apag. 107, per cui consideriamo solo due i nomi assenti.3) DEVOTO Origini indoeuropee - Il lessico indoeuropeo, Firenze1962, Tabelle n° 441.4) F<strong>IL</strong>IPPANI RONCONI Agni-Ignis, metafisica del Fuoco sacro, in “LaCittadella” anno I, 2001, 4.5) GIANNELLI Il Sacerdozio delle Vestali romane, Firenze 1913 pag.10.6) GIAMBLICO De Misteriis, cit. in VIGNA Roma, simbologia delperiodo regio, Roma 1998 pagg. 80-81.7) BAISTROCCHi Arcana Urbis, considerazioni su alcuni rituali arcaici<strong>di</strong> Roma, Genova 1987 pag. 192.8) BAISTROCCHI Arcana Urbis cit. pag. 190; per il complessoargomento del significato <strong>di</strong> Janus e del suo rapporto con Vestariman<strong>di</strong>amo ad un’attenta lettura del capitolo V del testo <strong>di</strong> Baistrocchiintitolato Il fuoco sacro: Giano e Vesta pagg. 188-248.9) DUMÉZ<strong>IL</strong> Juppiter, Mars, Quirinus, Torino 1955 pagg. 342-349.10) DUMÉZ<strong>IL</strong> riporta tra le altre conferme della sua asserzione la seriedelle <strong>di</strong>vinità invocate nelle preghiere degli Atti dei Fratelli Arvali,alcuni passi <strong>di</strong> Ovi<strong>di</strong>o e <strong>di</strong> Cicerone ed altre possibili concordanze, percui si rimanda al luogo citato.11) BAISTROCCHi Arcana Urbis cit. pag. 222 nota 73.12) MACROBIO Saturnalia I, 17, 42.13) BAISTROCCHI Arcana Urbis cit. pag. 205.14) BARTOLI Il Foro romano e il Palatino, Milano 1924 tav. 26.15) PLINIO affermava che tra i pignora conservati nel tempio <strong>di</strong> Vestavi fosse la raffigurazione <strong>di</strong> un membro virile: “Fascinus inter sacraromana a Vestalibus colitur” (Naturalis Historia XXVIII, 39).16) Il loro elenco è riportato da SERVIO in una nota all’Eneide (AdAen VII, 188): “Acus Matris Deorum, Quadriga fictili Veiorum, CineresOrestes, Sceptrum Priami, Velum Ilionae, Palla<strong>di</strong>um, Ancilia”. Daquanto scrivono gli Autori latini si deduce che il Palla<strong>di</strong>o si trovava neltempio <strong>di</strong> Vesta; l’Acus Matris, cioè la pietra nera simulacro <strong>di</strong> Cybele,nel tempio <strong>di</strong> Cybele sul Palatino; la Quadriga <strong>di</strong> terracotta nel tempio<strong>di</strong> Juppiter O M sul Capitolium; le ceneri <strong>di</strong> Oreste nel tempio <strong>di</strong>Saturnus; gli ancilia Martis nella Curia dei Salii Palatini sul Palatium,forse nello stesso luogo ove in epoca arcaica esisteva la capannasacrario<strong>di</strong> Mars accanto alla Regia del Re; del velo <strong>di</strong> Ilione non vi ècenno sul luogo in cui fosse conservato e così anche dello scettro <strong>di</strong>Priamo, anche se potrebbe essere stato deposto in un tempio sulPalatino. Roma possedeva altri pignora imperii, per i quali riman<strong>di</strong>amoal nostro testo su Vesta sopra citato.17) BAISTROCCHI Arcana Urbis cit. pag. 195.18) OVIDIO (VI 318 – 347) riporta un mito in cui Cibele invita tutte le<strong>di</strong>vinità ad una festa e Priapo, vedendo Vesta che riposa sul prato,“prova un desìo osceno e tenta furtivo accostarsi / e va in punta <strong>di</strong>pie<strong>di</strong> col cuore che trema”, ma un asino ragliando sveglia la Dèa chefugge atterrita. Priapo è la brama maschile priva del controllo dellavolontà, forza generatrice cieca che nulla ha a che vedere con lacapacità creatrice del Fuoco, per cui non può in alcun modocongiungersi con la matrice <strong>di</strong> ogni potenziale creazione, eternamenteVergine.19) BAISTROCCHI Arcana Urbis cit. pag. 225 nota 89.20) SABBATUCCI La religione <strong>di</strong> Roma antica, ed. Il saggiatore,Milano 1988 pag. 205.21) Abbiamo descritto la preparazione <strong>di</strong> tali prodotti in Vesta e ilFuoco <strong>di</strong> Roma cit. pagg. 61-62.22) L’acqua <strong>di</strong> acquedotto era proibita per qualunque uso nel tempio<strong>di</strong> Vesta, per cui si poteva utilizzare solo quella proveniente dallasorgente della ninfa Egeria come Numa aveva prescritto (PLUTARCOVita Num 13).23) SABBATUCCI pagg. 161–163. Nella prima celebrazione <strong>di</strong>Bona Dèa all’1 Maggio non si fa parola della presenza delleVestali: questa si svolgeva nel tempio della Dèa sull’Aventino,mentre quella <strong>di</strong> Dicembre nella casa <strong>di</strong> un magistrato inpossesso dell’imperium. Secondo PLUTARCO (Vita Caes, 9) “ledonne mentre sono sole si <strong>di</strong>ce che compiano molti riti assaisimili a quelli orfici”.24) ZOSIMO Storia nuova, ed. Rusconi, Milano 1977, V, 38, 3–4.25) LANCIANI L’Atrio <strong>di</strong> Vesta - Notizie degli scavi del mese <strong>di</strong><strong>di</strong>cembre 1883, Roma 1884 pag. 50.26) LANCIANI pag. 53 ritiene che Zosimo intenda riferirsi aVesta e al suo tempio, dato che poi parla <strong>di</strong> una “vecchiaVestale”. La condanna a morte <strong>di</strong> Serena fu causata dalsospetto che essa avesse stretto alleanza segreta con Alaricocontro l’Imperatore.Casa delle Vestali. Foro Romano.Foto <strong>di</strong> Katia Somà 2011Tempio <strong>di</strong> Vesta . Foro Romano.Foto <strong>di</strong> Katia Somà 2009Pag.13
<strong>IL</strong> <strong>LABIRINTO</strong> N.18 Luglio 2013Perio<strong>di</strong>co telematico <strong>di</strong> informazione culturale a cura del Circolo Culturale Tavola <strong>di</strong> SmeraldoGIAN GIACOMO MORA, <strong>IL</strong> BARBIERE DELLA PESTEMANZONIANA – 2° parte(a cura <strong>di</strong> Mauro Colombo)La sentenza del senato milaneseIn uno degli ultimi giorni <strong>di</strong> quel maledetto luglio del 1630 (vi èincertezza sulla data), il Senato milanese emanò, dopo quasiun mese e mezzo <strong>di</strong> indagini, interrogatori, torture, arresti, lapiù terribile delle condanne, a danno del Piazza e del Mora,che troveranno così la morte pochi giorni dopo, il 1° agosto.Come previsto dalla sentenza capitale, i due untori rei confessi,legati schiena a schiena, furono caricati su <strong>di</strong> un carro trainatoda buoi, attorniato da una folla inferocita. Il corteo partì dalpalazzo del Capitano <strong>di</strong> giustizia (attuale comando dellaVigilanza Urbana) e, passando prima accanto al Duomo esnodandosi poi attraverso le varie tortuose contrade deiMercanti d'oro, dei Pennacchiari, della Lupa, della Palla, <strong>di</strong> S.Giorgio al palazzo (che ora, rettificate, formano la via Torino),raggiunse il Carrobbio. Poi imboccò la strada <strong>di</strong> S. Bernar<strong>di</strong>noalle monache, dove i due vennero tormentati con tenagliearroventate, successivamente proseguì per S. Pietro incamminadella, e, sostando davanti alla bottega del Mora, aicondannati si amputò la mano destra. Infine, il macabro corteosi arrestò nell'attuale piazza della Vetra, tristemente famosoprato ove era abitualmente allestito il patibolo.Fatti scendere sullo sterrato gremito <strong>di</strong> popolo, i condannatifurono legati alla “ruota” (strumento molto in voga all’epoca) ecolpiti duramente con bastoni fino alla rottura <strong>di</strong> tutte le ossa.Seppure in agonia, i due poveretti rimasero per sei ore espostialla pubblica vista, affinché tutti potessero me<strong>di</strong>tare sullaterribile sorte riservata agli untori.Al termine del rituale, si pose fine alle loro sofferenzescannandoli, bruciandoli, e gettando le loro ceneri nella Vetrache scorreva lì accanto.Morti i due, si <strong>di</strong>ede seguito alle <strong>di</strong>sposizioni della sentenza delSenato, demolendo dalle fondamenta la casa del barbiere, esullo slargo così creatosi si innalzò una colonna <strong>di</strong> granito, conin cima una sfera <strong>di</strong> pietra, la colonna infame, a perennericordo della malvagità degli artefici dell'epidemia. Sul murodella casa <strong>di</strong> fronte venne affissa una grossa lapide, la qualericordasse quali furono le colpe dei due criminali, quale la penaloro riservata, e il monito affinché nessuno mai osasserie<strong>di</strong>ficare sui resti della bottega del barbiere Mora.Riportiamo <strong>di</strong> seguito il testo latino della lapide, con latraduzione fatta del Verri:HIC.UBI.HAEC.AREA.PATENS.ESTSURGEBAT.OLIM.TONSTRINAJO.JACOBI.MORAEQUI.FACTA.CUM.GULIELMO.PLATEAPUB.SANIT.COMMISSARIOET.CUM.ALIIS.CONJURATIONEDUM.PESTIS.ATROX.SAEVIRETLAETIFERIS.UNGUENTIS.HUC.ET.<strong>IL</strong>LUC.ASPERSISPLURES.AD.DIRAM.MORTEM.COMPULITHOS.IGITUR.AMBOS.HOSTES.PATRIAE.JUDICATOSEXCELSO.IN.PLAUSTROCANDENTI.PRIUS.VELLIICATOS.FORCIPEET.DEXTERA.MULCTATOS.MANUROTA.INFRINGIROTAQUE.INTEXTOS.POST.HORAS.SEX.JUGULARICOMBURI.DEINDEAC.NE.QUID.TAM.SCELESTORUM.HOMINUMRELIQUI.SITPUBLICATIS.BONISCINERES.IN.FLUMEN.PROJICISENATUS.JUSSITCUJUS.REI.MEMORIA.AETERNA.UT.SITHANC.DOMUM.SCELERIS.OFFICINAMSOLO.AEQUARIAC.NUNQUAM.IMPOSTERUM.REFICIET.ERIGI.COLUMNAMQUAE.VOCETUR.INFAMISPROCUL.HINC.PROCUL.ERGOBONI.CIVESNE.VOS.INFELIX.INFAME.SOLUMCOMACULETMDCXXX.KAL.AUGUSTIPag.14
<strong>IL</strong> <strong>LABIRINTO</strong> N.18 Luglio 2013Perio<strong>di</strong>co telematico <strong>di</strong> informazione culturale a cura del Circolo Culturale Tavola <strong>di</strong> SmeraldoQui dov'è questa piazzasorgeva un tempo la barbieria<strong>di</strong> Gian Giacomo Morail quale congiurato con Guglielmo Piazza pubblicocommissario <strong>di</strong> sanitàe con altrimentre la peste infieriva più atrocesparsi qua e là mortiferi unguentimolti trasse a crudele mortequesti due adunque giu<strong>di</strong>catinemici della patriail senato comandò che sovra alto carromartoriati prima con rovente tanagliae tronca la mano destrasi frangessero colla ruotae alla ruota intrecciati dopo sei ore scannatiposcia abbruciatie perché d'uomini così scelleratinulla resticonfiscati gli averisi gettassero le ceneri nel fiumea memoria perpetua <strong>di</strong> tale reatoquesta casa officina del delittoil senato medesimo or<strong>di</strong>nò spianaree giammai rialzarsi in futuroed erigere una colonnache si appelli infamelungi adunque lungi da quibuoni citta<strong>di</strong>niche voi l'infelice infame suolonon contamini1° agosto 1630Da un primo ed approssimativo conteggio Milanorisultava "ridotta però a cinquantamila abitanti solamente,mentre, fattosi melio il conto, centocinquantamila ne hatolto la contagione <strong>di</strong> questo infelice anno, mentre nelleville, et per le terre del paese continuano a <strong>di</strong>morare lanobiltà tutta et molti altri, che a tempo sono fuggiti dallaimminenza del pericolo" (Dispaccio 11 <strong>di</strong>cembre 1630).Concludendo sui numeri dei morti causati dalla peste,bisogna in ogni caso <strong>di</strong>re che fornire una cifra esattarisulta a tutt'oggi assai <strong>di</strong>fficile, anche perché non sicuroè il numero degli abitanti prima dello scatenarsi delcontagio (gli storici dell'epoca Ta<strong>di</strong>no e Ripamontiparlano, rispettivamente, <strong>di</strong> 250.000 e 200.000 abitanti).Per il numero dei morti, il Ta<strong>di</strong>no lo calcola sui 165.000,mentre il Ripamonti 140.000.Accanto a questi calcoli coevi, riportiamo quelli effettuatia metà ottocento da Francesco Cusani, che farebberoammontare a 150.000 gli abitanti <strong>di</strong> Milano prima dellapeste, e a 86.000 i morti.Gli ultimi mesi dell’epidemiaLa morte dei due innocenti non placò ovviamente la furia delcontagio, che in agosto, anche a causa della caluraopprimente, toccò il suo picco massimo. I morti giornalieri,anche se le cifre tramandateci dagli storici sono purtropposempre alquanto approssimative, ammontavano ormai a600, e si <strong>di</strong>ceva che almeno 4.000 fossero i cadaveriinsepolti che giacevano lungo le vie o abbandonati nellecase. Continuarono anche gli arresti <strong>di</strong> untori, e qualcunoiniziò ad ipotizzare che in città si aggirasse un vero esercitostraniero, col <strong>di</strong>abolico compito <strong>di</strong> ungere tutta Milano. Consettembre iniziarono a mancare i generi <strong>di</strong> prima necessitàe, quel che è peggio, iniziarono a scarseggiare i monatti.Una grida del 22 luglio, del resto, già aveva intimato <strong>di</strong> non"gettare, far gettare, lasciare o far lasciare in strada dallefinestre alcun cadavere, se non nell'atto che i monatti liricevono".Una missiva del 31 agosto 1630 testualmente <strong>di</strong>ce che"ormai a Milano è rimasta assai poca gente, e vi sono case<strong>di</strong>sabitate, e i morti, dall'inizio del contagio, ammontano asettantaduemila".Fortunatamente, a <strong>di</strong>cembre, grazie al freddo, il contagiocominciò a perdere vigore, e a partire dai primi mesi del1631 l'epidemia poteva <strong>di</strong>rsi in ritirata.Vicende della colonna infame fino ai giorni nostriLa colonna rimase saldamente al suo posto anchequando venne livellata la Vetra dei citta<strong>di</strong>ni, per portarlaalla stessa altezza del corso <strong>di</strong> Porta Ticinese (metà del1700). Ma le cose erano destinate presto a mutare.Come racconta il Bertarelli, nel 1770 il poeta Balestrieriinviava a Vienna (sotto il cui giogo nel frattempo Milanoera passata), al barone <strong>di</strong> Sperges, la traduzionemilanese della Gerusalemme liberata, ove si faceva unaccenno alla colonna infame.La lettera <strong>di</strong> ringraziamento dello Sperges, con la qualesi rammaricava della presenza in città <strong>di</strong> quel simbolo <strong>di</strong>antichi errori giu<strong>di</strong>ziari che <strong>di</strong>sonorava il Senatomilanese, fu letta a casa del conte <strong>di</strong> Firmian, il quale siripromise <strong>di</strong> intervenire quanto prima. Tuttavia il Governoaustriaco non aveva fatto i conti col Senato, contrarioassai fermamente a qualsiasi possibilità <strong>di</strong> rimozionedella colonna, dato che ciò sarebbe finito con l'apparireun'accusa ad una propria precedente sentenza, seppuremessa in perio<strong>di</strong> storici ben <strong>di</strong>fferenti, quando la parolailluminismo neppure esisteva.Pag.15
<strong>IL</strong> <strong>LABIRINTO</strong> N.18 Luglio 2013Perio<strong>di</strong>co telematico <strong>di</strong> informazione culturale a cura del Circolo Culturale Tavola <strong>di</strong> SmeraldoIl braccio <strong>di</strong> ferro tra le due autorità, nel quale si inserirono gliscritti del Verri e del Beccaria, si risolse grazie ad una vecchialegge citta<strong>di</strong>na, la quale prevedeva, per i simboli e i monumentid’infamia, il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> restauro. Così fu sufficiente danneggiareun po’ il basamento della colonna, per spingere l’Anziano delquartiere a domandare il suo abbattimento per motivi <strong>di</strong>sicurezza.Il Senato, strenuamente, si oppose alla richiesta, ma ilGoverno, deciso a chiudere la questione, nella notte tra il 24 eil 25 agosto 1778, bloccati i due accessi alla via, mandò sulposto una squadra <strong>di</strong> muratori, che prima dell’alba aveva giàatterrato, demolito e sgomberato il terreno della colonnainfame, i cui avanzi furono frettolosamente gettati nella cantinadella demolita casa.Il racconto <strong>di</strong> quella demolizione riparatrice <strong>di</strong> errori passati fusteso dal farmacista Porati, residente <strong>di</strong> fronte allo slargo, epubblicato poi col titolo: "L’abbattimento della colonna infameraccontato da un testimone oculare".La lapide fu invece rimossa nel 1803, ed è visibile tuttora alCastello Sforzesco, dov’è esposta sotto il portico del cortiledella Rocchetta.Proprio in quell'anno infatti venne e<strong>di</strong>ficata una nuova casa,che finì così per trovarsi proprio dove un tempo sorgeval'antica bottega, sull'angolo tra il corso <strong>di</strong> Porta Ticinese e laVetra dei citta<strong>di</strong>ni, presto però ribattezzata, con decisionemunicipale del 17 <strong>di</strong>cembre 1868 "via Gian Giacomo Mora"(magra consolazione per il barbiere più sfortunato <strong>di</strong> Milano).Purtroppo quella casa ottocentesca, come del resto migliaiad'altre, crollò sotto i bombardamenti anglo-americani del 1943.Al suo posto, nell'imme<strong>di</strong>ato dopoguerra, venne costruita unabassa e brutta costruzione, sede prima <strong>di</strong> un emporio <strong>di</strong> mobili epoi <strong>di</strong> una riven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> legna e carbone. L’area è statarecentemente oggetto <strong>di</strong> demolizione e successiva costruzione<strong>di</strong> un nuovo palazzetto ad uso abitativo. Proprio all’angolo tra ilcorso e la via Mora il nuovo e<strong>di</strong>ficio si presenta con un piccoloportico angolare, sotto il quale è stata murata una sculturabronzea che rappresenta con un gioco <strong>di</strong> vuoti lo spazio cheoccupava la colonna. La relativa targa, posta <strong>di</strong> fronte allascultura in una posizione poco visibile al passante frettoloso,racconta succintamente questa tragica storia milanese:Scultura <strong>di</strong> Ruggero Menegon anno 2005QUI SORGEVA UN TEMPO LA CASA DI GIANGIACOMO MORAINGIUSTAMENTE TORTURATO E CONDANNATO A MORTECOME UNTORE DURANTE LA PEST<strong>IL</strong>ENZA DEL 1630."... E' UN SOLLIEVO PENSARE CHE SE NON SEPPEROQUELLO CHE FACEVANO,FU PER NON VOLERLO SAPERE, FU PER QUELL'IGNORANZACHE L'UOMOASSUME E PERDE A SUO PIACERE, E NON E' UNA SCUSA MAUNA COLPA".Alessandro Manzoni, Storia della Colonna infameBIBLIOGRAFIA-Bertarelli, Tre secoli <strong>di</strong> storia milanese, 1929-Borromeo F., La peste <strong>di</strong> Milano, a c. <strong>di</strong> A. Torno, 1987-Brentari O., Le vie <strong>di</strong> Milano, 1900-Canosa R., La vita quoti<strong>di</strong>ana a milano in età spagnola, 1996-Farinelli G., Paccagnini E., Processo agli untori, 1988-Fava F., Storia <strong>di</strong> Milano, 1997-Formentini M., La dominazione spagnuola in lombar<strong>di</strong>a, 1881Gridario generale della gride, ban<strong>di</strong>, or<strong>di</strong>ni, e<strong>di</strong>tti, provisioni, prematiche,decreti ed altro (…), 1688I cinque libri degl'avvertimenti, or<strong>di</strong>ni, gride et e<strong>di</strong>tti, fatti et osservati inMilano ne' tempi sospettosi della peste, ne gli anni MDLXXVI e LXXVII,1579-Manzoni A., Storia della colonna infame 1840-42-Pellegrino B., Porta ticinese, 1991-Porati A., L'abbattimento della colonna infame raccontata da untestimone oculare, 1892-Ripamonti J., De peste quae fuit anno MDCXXX libri quinque, 1641-Settala L., Preservatione della peste, 1630-Verri P., Osservazioni sulla tortura, 1777-Vianello C.A., Il Senato <strong>di</strong> Milano organo della dominazione straniera,1935Pag. 16
<strong>IL</strong> <strong>LABIRINTO</strong> N.18 Luglio 2013Perio<strong>di</strong>co telematico <strong>di</strong> informazione culturale a cura del Circolo Culturale Tavola <strong>di</strong> SmeraldoLA BIBLIOTECA MALATESTIANA DI CESENA(a cura <strong>di</strong> Katia Somà)La Biblioteca Malatestiana <strong>di</strong> Cesena è una bibliotecamonastica <strong>di</strong> particolare importanza storica. Fondata allametà del XV secolo, detiene due primati assoluti: è stata laprima biblioteca civica d'Italia e d'Europa; è l'unicoesempio <strong>di</strong> biblioteca monastica umanistica giunta fino anoi perfettamente conservata nell'e<strong>di</strong>ficio, negli arre<strong>di</strong> enella dotazione libraria, riconosciuta dall’Unesco,inserendola, prima in Italia, nel Registro della Memoire duMonde.Oggi vi sono conservati quasi 250 000 volumi, <strong>di</strong> cui 287incunaboli, circa 4000 cinquecentine, 1753 manoscritti chespaziano fra il XVI secolo e il XIX secolo e oltre 17000lettere e autografi.L’idea della biblioteca va attribuita ai frati del convento <strong>di</strong>San Francesco, che avevano in animo <strong>di</strong> costruirne una aduso dello stu<strong>di</strong>um, annesso al loro convento fin dalTrecento.Nel 1450 è documentato il primo intervento <strong>di</strong> MalatestaNovello, signore <strong>di</strong> Cesena, che fece proprio il progetto deifrati e nel loro convento eresse la sua libraria. Al modelloinaugurato nella biblioteca del convento domenicano <strong>di</strong>San Marco a Firenze da Michelozzo (1444), si ispira laMalatestiana <strong>di</strong> Cesena, cui Matteo Nuti, esaltato comeDedalus alter nell’epigrafe che si legge accanto alla portad’ingresso, pose il sigillo del suo nome: “MCCCCLIIMatheus Nutius Fanensi ex urbe creatus Dedalus alteropus tantum deduxit ad unguem” (“1452. Matteo Nuti, natoa Fano, secondo Dedalo, condusse a compimento una taleopera”).Interno della Biblioteca MalatestianaLa Biblioteca Malatestiana, illustre testimone della culturaumanistica nella città <strong>di</strong> Cesena, è considerata uno degliesempi più significativi <strong>di</strong> biblioteca quattrocentescaitaliana. Le ragioni <strong>di</strong> questa sua importanza risiedonoprincipalmente nel fatto che la Malatestiana ha preservatonei secoli la sua immagine pressoché immutata.Questo significa che la struttura, l’intonaco, lapavimentazione, gli arredamenti e i co<strong>di</strong>ci si presentano anoi, oggi, come ai visitatori <strong>di</strong> cinque secoli fa. Taleperfetta conservazione è tutt'altro che un fenomenocomune alle biblioteche del medesimo periodo, le qualihanno spesso conosciuto eventi negativi che ne hanno,sotto vari aspetti, minato l'integrità e la bellezza originaria.Interno Biblioteca Malatestiana - CesenaLa costruzione della biblioteca cominciò, presumibilmente,nell'estate del 1447 per mano dell'architetto Matteo Nuti, siaper l'esigenza dei frati minori francescani <strong>di</strong> una libreria piùampia in cui contenere i loro testi (già nel 1445 essiavevano richiesto ed ottenuto dal Papa Eugenio IV ilpermesso <strong>di</strong> utilizzare il lascito <strong>di</strong> un citta<strong>di</strong>no in favore dellalibreria), sia per il volere dell'illuminato Signore della città,Domenico dei Malatesti detto Malatesta Novello. Labiblioteca <strong>di</strong> tipo umanistico-conventuale, che sorse nelbraccio orientale del convento <strong>di</strong> S. Francesco, un tempoa<strong>di</strong>bito a dormitorio, fu terminata nel 1452, come testimonial'epigrafe muraria collocata sul lato destro del portale dellabiblioteca stessa, ma può <strong>di</strong>rsi definitivamente completatasolo il 15 Agosto del 1454, quando fu collocato in situ ilportale ligneo ad opera <strong>di</strong> Cristoforo da S. Giovanni inPersiceto, le cui due ante sono sud<strong>di</strong>vise in quarantottopiccoli riquadri riportanti alternativamente gli stemmimalatestiani.L’aula della biblioteca ha pianta basilicale a tre navate – piùalta e stretta quella centrale con volta a botte, più larghe ebasse quelle laterali coperte a crociera – quin<strong>di</strong> non più unambiente rettangolare con un’unica navata secondo latra<strong>di</strong>zione me<strong>di</strong>evale, bensì un nuovo progetto basato sulmodello della biblioteca del convento domenicano <strong>di</strong> S.Marco a Firenze, voluta da Cosimo de Me<strong>di</strong>ci e realizzatadal Michelozzo tra 1437 e 1444, un’elegante architettura poi<strong>di</strong>venuta il prototipo delle biblioteche umanistiche. Solo laMalatestiana ha tuttavia miracolosamente conservato neisecoli la sua integrità originaria.Le tre navate sono <strong>di</strong>vise da venti snelle colonne <strong>di</strong> marmobianco su due file, con archi a tutto sesto, sormontate daeleganti capitelli con gli emblemi dei Malatesta (le tre teste,le bande a scacchi, lo steccato, la rosa selvatica).Originale è ancora l’intonaco verde, riportante i nomi deivisitatori quattrocenteschi (tra cui quelli <strong>di</strong> Malatesta Novelloe della moglie Violante), originale il pavimento in cottorosso, arricchito ad ogni campata nella navata centrale dalapi<strong>di</strong> de<strong>di</strong>catorie a Malatesta Novello.Pag.17
<strong>IL</strong> <strong>LABIRINTO</strong> N.18 Luglio 2013Perio<strong>di</strong>co telematico <strong>di</strong> informazione culturale a cura del Circolo Culturale Tavola <strong>di</strong> SmeraldoQuesta stessa <strong>di</strong>citura compare anche nelle parti interne esopra l’architrave della porta d’ingresso. L’aula è illuminatadalla luce che penetra dal rosone posto nella parete <strong>di</strong>fondo e dalle finestre archiacute nei due lati lunghi dell'aula.All'interno <strong>di</strong> questo ambiente l'arredamento è costituito da58 plutei, ovvero banchi, <strong>di</strong> legno <strong>di</strong> pino provenienti in granparte dalla pineta <strong>di</strong> Ravenna, 29 per ciascuna fila postanelle navate laterali. Ogni pluteo riporta sui fianchi glistemmi malatestiani decorati a colori. L’armonia e laperfezione della struttura della Sala del Nuti, ispirata allacultura fiorentina e anche a Leon Battista Alberti, attivo aRimini nel 1450, le conferiscono un equilibrio singolare edesemplare. L'accuratezza della Biblioteca Malatestianainsieme ad una pressoché perfetta conservazionedetermina un ambiente talmente suggestivo da permettereal visitatore <strong>di</strong> eliminare virtualmente le incolmabili <strong>di</strong>stanzespazio-temporali che lo separano dall'effettivo momento incui essa fu creata.I preziosi co<strong>di</strong>ci sono tuttora incatenati ai plutei lignei concatenelle <strong>di</strong> ferro battuto, come da tra<strong>di</strong>zionequattrocentesca che intendeva così evitare il furto e laper<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> libri <strong>di</strong> tale pregio. Inoltre, i banchi avevano laduplice funzione <strong>di</strong> leggio, svolta dal piano reclinato, e <strong>di</strong>deposito dei libri nel piano sottostante, ove i co<strong>di</strong>ci,generalmente 5 per pluteo, si trovavano in posizioneorizzontale e sud<strong>di</strong>visi per materia.Sul timpano del portale campeggia l’elefante, emblemadei Malatesta, con il motto “Elephas Indus culices nontimet” (“L’elefante in<strong>di</strong>ano non teme le zanzare”),mentre ai lati dell’architrave e sui capitelli delle lesene,sono raffigurati i simboli aral<strong>di</strong>ci della grata, delle treteste e della scacchiera. La porta in legno scuro è opera<strong>di</strong> Cristoforo da San Giovanni in Persiceto e reca ladata 15 agosto 1454. L’aral<strong>di</strong>ca dei Malatesta èriprodotta anche all’interno, sui capitelli delle colonnedella sala e sui 58 plutei (29 per parte), gli imponentibanchi <strong>di</strong> legno <strong>di</strong> pino in cui si conservano i co<strong>di</strong>ci.Una epigrafi sul pavimento, rinnova la memoria deldonatore: “Mal(atesta) Nov(ellus) Pan(dulphi) fil(ius)Mal(atestae) nep(os) de<strong>di</strong>t” (“Malatesta Novello figlio <strong>di</strong>Pandolfo nipote <strong>di</strong> Malatesta <strong>di</strong>ede”).Anche il colore riveste un ruolo preciso: il bianco dellecolonne me<strong>di</strong>ane, il rosso del pavimento in cotto e dellesemicolonne e il verde dell’intonaco, riportato alla lucedai restauri degli anni Venti del Novecento, rimandanoai colori degli stemmi malatestiani.Per dotare la sua libraria <strong>di</strong> un corredo <strong>di</strong> volumiadeguati e consoni al progetto <strong>di</strong> biblioteca che siprefiggeva, il signore <strong>di</strong> Cesena promosse uno scrittorioche, con attività organizzata e pianificata, produssenell’arco <strong>di</strong> circa un ventennio oltre centoventi co<strong>di</strong>ci. Imanoscritti commissionati o acquistati da MalatestaNovello (circa 150 esemplari) integrarono il preesistentefondo conventuale. Si aggiunsero alla raccolta i testi <strong>di</strong>me<strong>di</strong>cina e <strong>di</strong> scienze, ma anche <strong>di</strong> letteratura efilosofia, donati dal riminese Giovanni <strong>di</strong> Marco, me<strong>di</strong>co<strong>di</strong> Malatesta Novello e come lui appassionatocollezionista <strong>di</strong> co<strong>di</strong>ci. Quattor<strong>di</strong>ci co<strong>di</strong>ci greci, acquistatimolto probabilmente da Malatesta Novello aCostantinopoli, sette ebraici e altri donati al Novello, piùqualche co<strong>di</strong>ce aggiunto nei secoli successivicompletarono la raccolta, che ammonta a 343manoscritti. La soluzione a tre navate con volta adottataa Cesena per la Malatestiana e a Firenze per laBiblioteca <strong>di</strong> San Marco <strong>di</strong>venne un modello per lasuccessiva costruzione <strong>di</strong> rinomate bibliotechemonastiche italiane, le cui sale oggi si trovano spesso incattivo stato <strong>di</strong> conservazione; per citarne alcune, sitratta della biblioteca del convento Santa Maria dellePag.18
<strong>IL</strong> <strong>LABIRINTO</strong> N.18 Luglio 2013Perio<strong>di</strong>co telematico <strong>di</strong> informazione culturale a cura del Circolo Culturale Tavola <strong>di</strong> SmeraldoGrazie a Milano (1469), della biblioteca <strong>di</strong> SanDomenico a Perugia (1474) e <strong>di</strong> quella della bibliotecanel convento benedettino <strong>di</strong> San Giovanni a Parma(1523).Dopo morte <strong>di</strong> Novello e l’arrivo del lascito <strong>di</strong> Giovanni<strong>di</strong> Marco, la vita della Malatestiana si esaurisce per lopiù nelle pratiche <strong>di</strong> conservazione e poco significativesono le acquisizioni librarie, fino alle soppressioni <strong>di</strong> etànapoleonica.Alcune particolarità nella Simbologia MalatestianaStemmi, simboli ed aral<strong>di</strong>ca dei Malatesta ricorrono piùvolte negli elementi architettonici, d’arredo e nei co<strong>di</strong>ci.Elefante: nell’iconografia malatestiana l'elefante ègeneralmente <strong>di</strong> colore nero, ovvero è un elefanteasiatico ritenuto più forte <strong>di</strong> quello africano. I Malatestiscelsero questa effige in omaggio alla vittoria del loropresunto antenato Scipione l'Africano su Annibale;inoltre l'intelligenza attribuita a questo animale dovetteessere un motivo ulteriore per sceglierlo arappresentare una Signoria protettrice della cultura,come fu quella dei Malatesti.Nell'Europa Occidentale tra XIII e XIV secolo furonopoche le occasioni <strong>di</strong> vedere degli elefanti veri, per cuigli artisti malatestiani lo raffigurarono in maniera non deltutto realistica, ispirandosi ad immagini del pachidermapresenti su monete romane o in monumenti antichi.Racchiuso nel timpano triangolare sovrastante il portaled'entrata alla Biblioteca Malatestiana vi è il bassorilievodell’elefante, scolpito da Agostino <strong>di</strong> Duccio, con ilcelebre motto sulla fascia, forse voluto da MalatestaNovello: "ELEPHAS INDUS CULICES NON TIMET"(l’elefante in<strong>di</strong>ano non teme le zanzare), che qualchestorico ha interpretato come un'allusione offensiva allemire del fratello Sigismondo alle sue terre, oppurepotrebbe avere valore <strong>di</strong> motteggio verso i rivali DaPolenta, signori <strong>di</strong> Ravenna, zona infestata dallezanzare.Stemma delle bande a scacchi: le tre bande scaccatepotrebbero rappresentare l'evoluzione astratta <strong>di</strong> tretorri che si trovano raffigurate su un boccale dei primidel Trecento (<strong>di</strong> proprietà della Cassa <strong>di</strong> Risparmio <strong>di</strong>Rimini e conservato nel museo <strong>di</strong> Rimini), con una "M"malatestiana e un pen<strong>di</strong>o a banda.Stemma delle tre teste: verde, a tre teste d'oro.Questo stemma viene chiamato anche stemma parlanteperché la figura rappresentatavi rivela il nome dellafamiglia a cui appartiene. Quin<strong>di</strong> le tre teste <strong>di</strong> Mori oEtiopi suggeriscono il significato <strong>di</strong> teste "cattive" =male teste.Stemma dello steccato: steccato militare <strong>di</strong>sposto abanda, con aste <strong>di</strong> tre colori, bianco, rosso e verde, suun campo bianco. Forse simbolo della forzadell'usbergo (armatura me<strong>di</strong>evale <strong>di</strong> metallo, a maglie)<strong>di</strong> Malatesta Novello, delle virtù teologali <strong>di</strong> cui sonoemblematici i colori bianco (fede), rosso (speranza) everde (carità). I tre colori utilizzati per lo steccato sonoperò anche i colori principali della Libraria Domini(bianco delle colonne, rosso del pavimento in cotto edelle semicolonne addossate alle pareti, verdedell'intonaco e delle tele che verosimilmente nel 1500proteggevano i banchi) e neppure questo,probabilmente, è casuale.Lo steccato non è tra<strong>di</strong>zionale dei Malatesti, è utilizzatosolo da quelli <strong>di</strong> Cesena, Andrea Malatesta e MalatestaNovello.Rosa Quadripetala o Fiore Pandolfesco: rosa a quattropetali, da sola o all'interno <strong>di</strong> uno scudo. La si ritrovaintagliata nel portale della Biblioteca Malatestiana. Lostemma fu scelto dai Malatesti a metà del Trecento perpotersi attribuire la <strong>di</strong>scendenza dalla prestigiosa famigliaromana degli Scipioni, il cui stemma era appunto una rosa.L’origine è molto antica, anche l'Arco <strong>di</strong> Augusto a Riminiriporta una rosa quadripetala scolpita.Farfalla: simbolo miniato nei co<strong>di</strong>ci per Malatesta Novello(il miniatore probabilmente ferrarese viene chiamato"Maestro della farfalla"), associata ad altri elementidecorativi. La farfalla nell'arte è simbolo della spiritualitàdell'anima capace <strong>di</strong> <strong>di</strong>vincolarsi dalla materia bruta cosìcome la crisalide dal suo bozzolo. Questo insetto,raffigurato in un testo scritto, può voler rappresentarel'assurgere della mente umana, attraverso la lettura e lostu<strong>di</strong>o, alla vera conoscenza. Nel caso specifico dellapresenza della farfalla in un co<strong>di</strong>ce malatestiano, si ritieneche essa possa avere significato <strong>di</strong> augurio <strong>di</strong> fertilità perViolante, moglie <strong>di</strong> Malatesta Novello. Questo tipo <strong>di</strong>decorazione è <strong>di</strong> gusto protorinascimentale ferrarese e lasi trova nei manoscritti commissionati da MalatestaNovello.La Biblioteca Malatestiana nel registro UNESCO“Memoria del Mondo”Il programma Memoria del Mondo, avviato dall'UNESCOnel 1992, si propone <strong>di</strong> stabilire, come avviene per ilPatrimonio culturale e naturale dell'Umanità, una lista <strong>di</strong>beni documentari caratterizzati dalla loro unicità e dalloro rilievo per la storia dell'umanità. Nel giugno del 2005l'Unesco ha riconosciuto l'importanza culturale dellaBiblioteca Malatestiana <strong>di</strong> Cesena inserendola, prima inItalia, nel Registro della Memoria del Mondo con laseguente motivazione:“La biblioteca contiene lavori <strong>di</strong> filosofia, teologia e scritti<strong>di</strong> natura biblica, così come <strong>di</strong> letteratura scientifica eclassica, <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenti provenienze. È un raro esempio <strong>di</strong>una completa e meravigliosa collezione conservata dallametà del XV secolo, appena prima dell'avvento dellastampa in Europa. La collezione è un esempio unico <strong>di</strong>biblioteca umanistica del Rinascimento, momento in cuile prime valutazioni sugli scritti e sugli insegnamenticristiani lasciavano la strada a varie considerazionisecolari. La collezione è contenuta nell’originale e<strong>di</strong>ficio<strong>di</strong> Cesena.”http://www.goethe.de/ins/it/mai/itindex.htmhttp://www.malatestiana.it/http://it.wikipe<strong>di</strong>a.org/wiki/Biblioteca_MalatestianaPag.19
<strong>IL</strong> <strong>LABIRINTO</strong> N.18 Luglio 2013Perio<strong>di</strong>co telematico <strong>di</strong> informazione culturale a cura del Circolo Culturale Tavola <strong>di</strong> SmeraldoALLIETARE LA MENTE...LE NOSTRE RECENSIONIRUBRICHEVIAGGIO NEI BORGHI DELLE STREGHEBorin RobertoUgo Mursia E<strong>di</strong>tore , 2011180 p., brossuraPrezzo <strong>di</strong> copertina: € 14,00ISBN: 8842543446, 9788842543442Un viaggio in cinque tappe nei borghi italiani in cui, tra Quattrocento eSeicento, si sono levate le fiamme dei roghi delle streghe. Donne tenebrosee romantiche, condannate a morire dai tribunali laici o dell'Inquisizione,rivivono in questo percorso da Cavalese in Val <strong>di</strong> Fiemme a Bormio inValtellina, dal grande processo <strong>di</strong> Triora in Liguria, in cui furono coinvoltequasi duecento donne, a Villacidro in Sardegna, fino ai Gran<strong>di</strong> Sabba che sisvolgevano all'ombra del noce magico <strong>di</strong> Benevento. Guaritrici, levatrici,taumaturghe, detentrici <strong>di</strong> un sapere arcaico, seguaci <strong>di</strong> riti <strong>di</strong>onisiaci,semplicemente donne, messe al bando dalla cultura dominante del V-VIsecolo e costrette a confessare l'inconfessabile nel corso <strong>di</strong> processicrudelissimi, fra atroci sofferenze. In mezzo, racconti strappati dallaviolenza: le colpe del mondo che ricadevano su un genere, quellofemminile. Un'indagine storica e antropologica su un capitolo controversodel nostro passato, attraverso l'esame accurato delle fonti documentali edelle pergamene dei processi. E, ancora, un'indagine su cosa resta oggidella caccia alle streghe nei toponimi, nella cultura, nel folklore e nellaleggenda <strong>di</strong> quei luoghi.<strong>IL</strong> VISCHIO E LA QUERCIASpiritualità celtica nell'Europa drui<strong>di</strong>caAutore: Riccardo TaraglioE<strong>di</strong>zione: L’età dell’AcquarioAnno <strong>di</strong> pubblicazione Gennaio 2001Pag 456 - 14,5x21,5Prezzo <strong>di</strong> copertina: € 28,00ISBN: 8871361512Chi erano i Celti? Quali furono le loro origini? Qual è la ragione per cuiancora oggi il loro patrimonio <strong>di</strong> idee e tra<strong>di</strong>zioni influenza la culturaeuropea, nonostante secoli <strong>di</strong> dominazione romana e <strong>di</strong> «monopolio»culturale cristiano?Il popolo dei Celti ha fondato la propria forza su una visione sacra della Vita,su una concezione «alta» <strong>di</strong> valori quali la <strong>di</strong>gnità e l'onore in<strong>di</strong>viduali. Il loropensiero ha aspetti <strong>di</strong> grande modernità, se si pensa che riconoscevano lostesso valore all'uomo e alla donna e che consideravano la libertà piùimportante della vita stessa.La spiritualità celtica non è una religione nel senso corrente del termine - unsistema <strong>di</strong> norme regolate dalla presenza dei Drui<strong>di</strong>, i sacerdoti pagani<strong>di</strong>pinti dal Cristianesimo come stregoni - ma piuttosto una tra<strong>di</strong>zioneanimista, immanentista, universale, legata a un'espressione popolare (la<strong>di</strong>vinità è insita nella creazione e non al <strong>di</strong> fuori). Il libro <strong>di</strong> Riccardo Taraglio,qui presentato in un'e<strong>di</strong>zione rivista e aggiornata, è il più completo eapprofon<strong>di</strong>to saggio mai pubblicato in Italia sulla ricchissima tra<strong>di</strong>zioneculturale <strong>di</strong> un popolo che è stato protagonista in Europa lungo un arcotemporale vastissimo, dal 1000 a.C. all'800 d.C.Pag.20
<strong>IL</strong> <strong>LABIRINTO</strong> N.18 Luglio 2013Perio<strong>di</strong>co telematico <strong>di</strong> informazione culturale a cura del Circolo Culturale Tavola <strong>di</strong> SmeraldoCONFERENZE, EVENTIFiera Me<strong>di</strong>evale <strong>di</strong> San Rocco a Magnano (BI), 10 e 11 AgostoMOSTRA SULLA STREGONERIA, TORTURE ED INQUISIZIONEIn collaborazione con l’Associazione Genti del Maloch Onlus, vieneriproposta la mostra il cui soggetto principale è la tortura nel periodoinquisitoriale. Si tratta <strong>di</strong> un percorso storico-antropologico attraversol’inquietante tribunale dell’Inquisizione e la sua deliberata scelta <strong>di</strong> utilizzarela tortura come metodo per ottenere la confessione delle streghe...Ricostruzioni storiche dei più importanti strumenti<strong>di</strong> tortura utilizzati per estorcere le confessionidegli eretici e delle streghe nel periodo Me<strong>di</strong>evale.Il 15 Maggio 1252 il Papa Innocenzo IV promulga lafamigerata bolla “Ad Extirpanda” in cui rende lecito l’usodella tortura come strumento <strong>di</strong> ottenimento dellaconfessione del reo, in particolare nei processidell'Inquisizione. Numerosi sono i musei italiani sullatortura: i più famosi sono quelli <strong>di</strong> San Gimignano, Sienae San Marino. Nel nostro territorio, importanti documentisono presenti nel Castello <strong>di</strong> Mazzè (TO), sede <strong>di</strong> unamostra sulla tortura ed Inquisizione.Pag. 21
<strong>IL</strong> <strong>LABIRINTO</strong> N.18 Luglio 2013Perio<strong>di</strong>co telematico <strong>di</strong> informazione culturale a cura del Circolo Culturale Tavola <strong>di</strong> Smeraldo“TAVOLA DI SMERALDO SORRIDE CON LORO’”“RIFLESSIONI SU... INVECCHIAMENTO E DISAB<strong>IL</strong>ITA -<strong>IL</strong> TESTAMENTO BIOLOGICO’”VOLPIANO (TO) 26 e 27 OTTOBRE 2013L’Associazione culturale Tavola <strong>di</strong> Smeraldo <strong>di</strong> Volpiano(TO) ha ideato un progetto dal titolo “Tavola <strong>di</strong> Smeraldosorride con loro….” in cui i protagonisti saranno i bambini.La musica, il canto ed il teatro faranno da collegamento trale persone al fine <strong>di</strong> dar vita ad una ManifestazioneBenefica che porti tutti ad avvicinarsi al delicato mondo del<strong>di</strong>sagio infantile.L’associazione Tavola <strong>di</strong> Smeraldo coopererà insiemeall’associazione Telefono Azzurro per uno scopo comuneovvero <strong>di</strong>mostrare a tutti i bambini vittime <strong>di</strong> soprusi,sfruttamenti e violenze, che la vita non è soltantosofferenza, tristezza e pianto ma anche e soprattutto gioia,aggregazione, <strong>di</strong>vertimento e famiglia.La manifestazione “Tavola <strong>di</strong> Smeraldo sorride con Loro”sarà un vero e proprio spettacolo in cui i protagonistisaranno i bambini. Si susseguiranno sul palco varie scuole<strong>di</strong> danza e musica e associazioni, con spettacoli, preparatiappositamente per la serata, tutti interpretati da bambini.Inoltre l’Associazione Tavola <strong>di</strong> Smeraldo, grazie allacollaborazione <strong>di</strong> alcuni maestri <strong>di</strong> musica, ha organizzatoun corso <strong>di</strong> canto che inizierà a Marzo e avrà cometermine lo spettacolo <strong>di</strong> Ottobre. I bambini sono statireclutati nelle scuole elementari <strong>di</strong> Volpiano, San BenignoC.se e Settimo T.se.Questo è solo il nocciolo principale <strong>di</strong> una manifestazioneche coinvolgerà numerosi enti ed associazioni a livelloorganizzativo e logistico ma che raccoglie in sé notevolisignificati per tutti i bambini e non solo: noi abbiamo moltoda imparare stando insieme a loro.Infatti un bambino può insegnare sempre tre semplici magran<strong>di</strong> cose ad un adulto: essere sempre contento anchesenza motivo apparente, essere sempre occupato conqualche cosa <strong>di</strong> <strong>di</strong>vertente e perseguire con ogni suaforza quello che desidera.Questo progetto entra a far parte <strong>di</strong> una Rassegnapromossa dalla Tavola <strong>di</strong> Smeraldo biennalmente e chenel 2013 raggiunge la sua terza e<strong>di</strong>zione. TaleRassegna, dal titolo “Riflessioni su ....”, prevede ad ognie<strong>di</strong>zione, l’approfon<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> tematiche socialmentesensibili dal punto <strong>di</strong> vista sanitario ed etico come lo sonostate il dolore, la sofferenza e l’assistenza alla fine dellavita. Quest’anno il tema sarà l’invecchiamento ed ilconseguente stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>sabilità che verrà affrontato in unConvegno aperto alla popolazione che si svilupperà laDomenica 27 Ottobre. Cre<strong>di</strong>amo che il temadell’invecchiamento si possa bene coniugare con quellodell’infanzia: per invecchiare dobbiamo essere statibambini ed un bambino che vive un’infanzia felice eserena, potrà affrontare la vecchiaia con maggiortranquillità e consapevolezza.Nel pomeriggio sarà affrontato un argomento <strong>di</strong> grandeattualità: il Testamento Biologico. Una interessante <strong>tavola</strong>rotonda ospiterà le varie Chiese presenti sul territorio inun <strong>di</strong>battito aperto con il pubblico. Aprirà il <strong>di</strong>battitol’ospite d’onore della giornata, il Sig Beppino Englaro,padre <strong>di</strong> Eluana, portandoci la sua dolorosa e combattutaesperienza.Aggiornamenti su:www.<strong>tavola</strong><strong>di</strong><strong>smeraldo</strong>.itFB: Circolo Culturale Tavola <strong>di</strong> SmeraldoContattare il Responsabile Sandy Furlini al335-6111237COME ASSOCIARSI alla Tavola <strong>di</strong> SmeraldoPossono iscriversi al Circolo solo i maggiorenni (Art 4 dello statuto)Per le attività destinate ai soli soci, i minorenni interessati potrannopartecipare solo se accompagnati da uno o più genitori che siano socied in regola con la quota associativa. Non sono previstiaccompagnatori NON soci. (Deliberazione del CD del 28-12-09)1) Collegati al sito www.<strong>tavola</strong><strong>di</strong><strong>smeraldo</strong>.it nella sezione “ISCRIVITI”2) Leggi lo Statuto Associativo3) Scarica il modulo <strong>di</strong> iscrizione e compilalo in tutte le sue parti4) Effettuare il versamento tramite bonifico bancario Unicre<strong>di</strong>t Ag. <strong>di</strong>Volpiano (TO) Via Emanuele FilibertoIBAN IT85M02008312300001008615665) Invia per posta prioritaria o consegna a mano copia del bonifico conil pagamento avvenuto + modulo <strong>di</strong> iscrizione debitamente compilato a"Circolo Culturale Tavola <strong>di</strong> Smeraldo c/o Dr S. Furlini Via CarloAlberto n°37 Volpiano (TO), 10088".Oppure invia il tutto via FAX: 011-9989278Pag.22