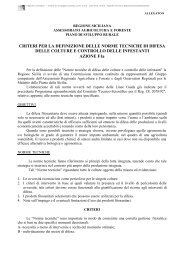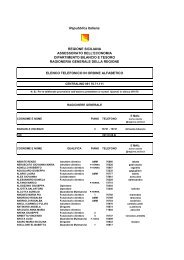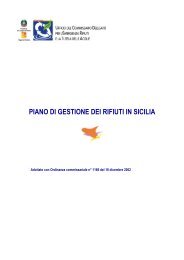- Page 3: Casa museo Antonino Uccello
- Page 6 and 7: Unione Europea POR SICILIA 2000/200
- Page 9 and 10: Nicola Leanza* | Nel corso della XI
- Page 11 and 12: THE GREAT LEARNING. PARAGRAPH 5- LA
- Page 14: PALERMO ASCOLTA MALAGA- VIE DELLA C
- Page 18: ERNST REIJSEGER- LA CUBA, 2006- THE
- Page 22: DARIO BUCCINO- LA CUBA, 2007- PALER
- Page 26: MIRIAM PALMA- LA CUBA, 2006- SIMONE
- Page 29 and 30: 3 Guida all’ascolto 165 CD 1 - La
- Page 31 and 32: Gaetano Pennino | Vivere poeticamen
- Page 33 and 34: alcuni personaggi), dediti alla cos
- Page 35 and 36: della Sicilia mai realizzata e defi
- Page 37: programmi e le caratteristiche dell
- Page 41 and 42: timi, alcuni avevano lavorato in pa
- Page 43 and 44: Egli era consapevole di aver creato
- Page 45: con le Autorità delegate all’ord
- Page 48 and 49: TrasformAzioni |1
- Page 50 and 51: manifestazioni ed eventi volti a il
- Page 52 and 53: adolescenti nel post ’68, afferma
- Page 54 and 55: in modo disinibito eppure accorto s
- Page 56 and 57: tra la musica nuova di genere inusu
- Page 58 and 59: za con la Provincia di Palermo (con
- Page 60 and 61: vuole affermare, però, che il putt
- Page 62 and 63: della rassegna Il Suono dei Soli, q
- Page 64 and 65: […] Il titolo è tratto da una le
- Page 66 and 67: Sarà la nuova edizione de La music
- Page 68 and 69: varie Istituzioni italiane e strani
- Page 70 and 71: La morte e la fanciulla di Schubert
- Page 72 and 73: sea (1924) di Walt Disney. Fra le p
- Page 74 and 75: morarsi delle proprie idee nel luss
- Page 77: saggi2
- Page 80 and 81: ignorata dal mainstream e dal marke
- Page 82 and 83: mettendo sul piacere prodotto dal s
- Page 84 and 85: Giovanni Damiani | I Soli di Palerm
- Page 86 and 87: liberatore dei suoni dai dominii de
- Page 88 and 89:
Stefano Zorzanello | Una strada dif
- Page 90 and 91:
usare una sintetica quanto efficace
- Page 92 and 93:
fosse la più refrattaria a quest
- Page 94 and 95:
Antonio Guida | Curva in divenire N
- Page 96 and 97:
John Tilbury | Il Paragrafo 5 del G
- Page 98 and 99:
Pietro Misuraca | Il Suono dei Soli
- Page 100 and 101:
Ancora a Giacinto Scelsi Il Suono d
- Page 102 and 103:
l’amico dilettissimo per flauto b
- Page 104 and 105:
Sicilia di un frammento da Treatise
- Page 106 and 107:
Non di un semplice concerto, bensì
- Page 108 and 109:
versa o introversa che sia)». Funz
- Page 110 and 111:
Il suono non lascia scampo: in gene
- Page 112 and 113:
Marcello Faletra | Destini del suon
- Page 114 and 115:
Il grido di un bambino appena nato
- Page 116 and 117:
musica degli afro-americani, il lor
- Page 118 and 119:
ta al museo sarebbe dovuta avvenire
- Page 120 and 121:
principale per la realizzazione del
- Page 122 and 123:
Orto Botanico del capoluogo sicilia
- Page 124 and 125:
denti modificandone la disposizione
- Page 126 and 127:
sivo, una linea rigorosa o il filon
- Page 128 and 129:
senza alcun dubbio, noi siamo attua
- Page 130 and 131:
Mi si chiede di curvare, piegare, l
- Page 132 and 133:
Sara Patera | L’attività nelle s
- Page 134 and 135:
“Diciamo che nel tempo ho avuto l
- Page 136 and 137:
Girolamo Sorrentino | Una dissertaz
- Page 138 and 139:
all’utilizzo di elementi sonori d
- Page 140 and 141:
orientarsi in un territorio dove si
- Page 142 and 143:
II puntata Vita Povera Arte No La m
- Page 144 and 145:
dialettica degli opposti congiunzio
- Page 146 and 147:
MEMORIA SUONA RISUONA RAGGIUNGE …
- Page 148 and 149:
quanto controlla e limita l’emiss
- Page 150:
SILVIA SCHIAVONI- CANTIERI CULTURAL
- Page 154:
STRADE DEL CINEMA- CONSERVATORIO VI
- Page 158:
THE GREAT LEARNING, PARAGRAPH 5- LA
- Page 162:
THE GREAT LEARNING, PARAGRAPH 5- LA
- Page 166 and 167:
Guida all’ascolto | Due selezioni
- Page 168 and 169:
CD 1 | La musica attraversa/o i suo
- Page 170 and 171:
traccia 10. brano Improtoot autore/
- Page 172 and 173:
Nel brano New cued, una sorta di sc
- Page 174 and 175:
le colonne sonore per film di Amos
- Page 176 and 177:
7. x 4 Gianni Gebbia, Lelio Giannet
- Page 178 and 179:
In una rara (per latitudine) uggios
- Page 180 and 181:
CD 2 | Il Suono dei Soli traccia 1.
- Page 182 and 183:
traccia 10, 11, 12, 13. brano Bagat
- Page 184 and 185:
ottenere, ma quali moti compiere co
- Page 186 and 187:
musica di Pennisi: il flauto gorghe
- Page 188 and 189:
nati, selvatici; non sono infatti a
- Page 190 and 191:
I capolavori di Damiani sembrano ra
- Page 192 and 193:
sonando, sia in lezioni, analisi e
- Page 194 and 195:
le palline di gomma. Dopo 3’47”
- Page 196 and 197:
traccia 8. brano Skatti keu testo /
- Page 198 and 199:
prevalentemente oggetto di studio,
- Page 200 and 201:
dagliati fin nelle parti più intim
- Page 202 and 203:
Dispinseri bon latruni, Dispensiere
- Page 204 and 205:
dezza della disperazione del defini
- Page 206 and 207:
Il quinto brano [CD3: 5] è tratto
- Page 208 and 209:
7. KKaaààggoommaaii kkaaààggoom
- Page 210 and 211:
Il secondo è uno stralcio di un co
- Page 212 and 213:
Listening guide | The CDs attached
- Page 214 and 215:
CD 1 | La musica attraversa/o i suo
- Page 216 and 217:
Track 10. Title Improtoot Author(s)
- Page 218 and 219:
(a guitar and an electric double ba
- Page 220 and 221:
4. Bastiancontrario (Contrarian) Se
- Page 222 and 223:
7. x 4 Gianni Gebbia, Lelio Giannet
- Page 224 and 225:
In an overcast night of December 20
- Page 226 and 227:
CD 2 | Il Suono dei Soli Track 1. T
- Page 228 and 229:
Track 10, 11, 12, 13. Title Bagatel
- Page 230 and 231:
e produced, but rather the movement
- Page 232 and 233:
(“nightingale” in ancient Greek
- Page 234 and 235:
are amazed and stunned: the harmoni
- Page 236 and 237:
Damiani’s masterpieces seem to bl
- Page 238 and 239:
Chinese Cultural Revolution, Cardew
- Page 240 and 241:
Mi dico n. 2+3 is the result of the
- Page 242 and 243:
Track 8. Title Skatti keu Lyrics /
- Page 244 and 245:
consider it mostly an object of stu
- Page 246 and 247:
landscape in an ineludible dimensio
- Page 248 and 249:
Li muciara bon latruni, The fisherm
- Page 250 and 251:
Songs) - recalls the atmosphere of
- Page 252 and 253:
Track 5 [CD3: 5] is taken from the
- Page 254 and 255:
7. KKaaààggoommaaii kkaaààggoom
- Page 256 and 257:
Balkan melody, thus generating a de
- Page 258:
L’ISTINTO E IL RIGORE: GERMOGLI-
- Page 262:
ADALGISA BADANO, MARCO CRESCIMANNO-
- Page 266:
OPEN… WORKSHOP- CANTIERI CULTURAL
- Page 270:
THOMAS LEHN, HÉLÈNE BRESCHAND- TE
- Page 274 and 275:
1997 Pratiche inusuali del fare mus
- Page 276 and 277:
1999 Il Contrabbasso parlante, cinq
- Page 278 and 279:
Catania, Auditorium Nevskij 28 dice
- Page 280 and 281:
adicale e musiche originali (prima
- Page 282 and 283:
A. Schöenberg: Pierrot Lunaire, pe
- Page 284 and 285:
nale, performance su più dimension
- Page 286 and 287:
per percussione, pianoforte, clarin
- Page 288 and 289:
2003 Il Pensiero Elettronico, ciclo
- Page 290 and 291:
16 aprile, I Candelai Daan Vandewal
- Page 292 and 293:
un’IMPROVVIS’AZIONE ACUSTICO- R
- Page 294 and 295:
ca in musica, seminario a cura di L
- Page 296 and 297:
Improvvisazione non idiomatica, a c
- Page 298 and 299:
turale); Andatura, per duduk armeno
- Page 300 and 301:
Grottacalda - Alt(r)isuoni rassegna
- Page 302 and 303:
di musica ambientale, performanceco
- Page 304 and 305:
Beppe Lo Meo chitarra, live perform
- Page 306 and 307:
Antonino Errera, Francesco Prestigi
- Page 308 and 309:
Conferenza a cura di Davide Barbari
- Page 310 and 311:
e Daniela Orlando (maestro preparat
- Page 312 and 313:
2007 La musica attraversa/o i suoni
- Page 314 and 315:
il manifesto | 13 agosto 1998 I dia
- Page 316 and 317:
A Orsara invece non succede quasi n
- Page 318 and 319:
Di mattina Maggie era andata al mer
- Page 320 and 321:
acustico e l’elettronica dal vivo
- Page 322 and 323:
Jazzthetik | n. 13, dicembre 1999-g
- Page 324 and 325:
edizione si è guardata dal mostrar
- Page 326 and 327:
e alla Pubblica Istruzione e dell
- Page 328 and 329:
il Theremin. Ma con tutta l’acqua
- Page 330 and 331:
Mannucci ed il 31 marzo e il 1 apri
- Page 332 and 333:
il manifesto | 29 marzo 2003 Fátim
- Page 334 and 335:
Nottoli e da compositori legati in
- Page 336 and 337:
Giornale di Sicilia | 28 aprile 200
- Page 338 and 339:
Giornale di Sicilia | 19 novembre 2
- Page 340 and 341:
una somma di gruppo di grande compa
- Page 342 and 343:
Questo ci obbliga a individuare un
- Page 344 and 345:
inter nazionale. A portare questo t
- Page 346 and 347:
lino, Pino Guarrella, violoncello,
- Page 348 and 349:
serà su alcuni capolavori di quel
- Page 350 and 351:
di quest’anno sco lastico, con il
- Page 352 and 353:
hanno ben compreso l’angoscia del
- Page 354 and 355:
la Repubblica | 13 maggio 2007 10 a
- Page 356 and 357:
INCONTRI MUSICALI DI CONFINE- LIBRE
- Page 358 and 359:
358
- Page 360 and 361:
CURVA MINORE- TESSERE SOCIALI, 2001
- Page 362 and 363:
TREATISE- BROCHURE, 2002- IL PENSIE
- Page 364 and 365:
IL SUONO DEI SOLI- CARTOLINA (FRONT
- Page 366 and 367:
IL SUONO DEI SOLI- LIBRETTO, 2005-
- Page 368 and 369:
368
- Page 370 and 371:
IL SUONO DEI SOLI- MANIFESTO, 2007-
- Page 372 and 373:
IL SUONO DEI SOLI- CARTOLINA, 2007-
- Page 374 and 375:
CURVA MINORE- LOCANDINA, 2007- CURV
- Page 376 and 377:
CURVA MINORE- CARTOLINA (FRONTE), 2
- Page 378 and 379:
CURVA MINORE- MANIFESTO, 2009- DIVI
- Page 380 and 381:
Note biografiche | Paolo Angeli App
- Page 382 and 383:
Teatro Comunale di Bologna, Orchest
- Page 384 and 385:
to dolce e musica d’insieme per s
- Page 386 and 387:
Lazzaretti sull’Afghanistan, vinc
- Page 388 and 389:
Axel Doerner Nato a Colonia nel 196
- Page 390 and 391:
fa parte di Zephir Ensemble, per il
- Page 392 and 393:
Tristan Honsinger Violoncellista e
- Page 394 and 395:
Martin Küchen Sassofonista nato ne
- Page 396 and 397:
che lo porterà ad esibirsi in Ital
- Page 398 and 399:
sua decennale attività nel teatro
- Page 400 and 401:
Michael Moore Clarinettista, sassof
- Page 402 and 403:
Cile, Uruguay, Israele, Giappone pe
- Page 404 and 405:
numerosi teatri di prosa italiani t
- Page 406 and 407:
te di catturare le conversazioni de
- Page 408 and 409:
Louis Sclavis Nato a Lione nel 1953
- Page 410 and 411:
Louis Sclavis, Ab Baars). Collabora
- Page 412 and 413:
Vincenso Vasi Polistrumentista, suo
- Page 414 and 415:
Wolter Wierbos È considerato uno d
- Page 416 and 417:
Kolkowski, Phil Minton, Jon Rose, O
- Page 418 and 419:
Generali | d. = edizione discografi
- Page 420 and 421:
Cage, John 1977 Per gli uccelli. Co
- Page 422 and 423:
Lombardi Satriani, Luigi 1988 Un in
- Page 424 and 425:
Sachs, Curt 1948 Our musical herita
- Page 426 and 427:
Damiani, Giovanni 2007 Note introdu
- Page 428 and 429:
Razete, Gigi 1999 contributo introd
- Page 430 and 431:
Crediti Regione Siciliana (Presiden
- Page 432:
finito di stampare: Officine Grafic