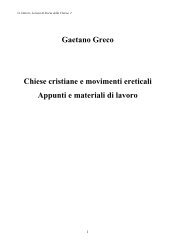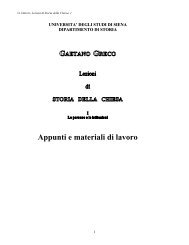SIENA NELL'ETÀ DI DUCCIO - Dipartimento di Storia
SIENA NELL'ETÀ DI DUCCIO - Dipartimento di Storia
SIENA NELL'ETÀ DI DUCCIO - Dipartimento di Storia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
G. PICCINNI, Siena nell’età <strong>di</strong> Duccio, in Duccio. Alle origini della pittura senese, a<br />
cura <strong>di</strong> Alessandro Bagnoli, Roberto Bartalini, Luciano Bellosi, Michel Laclotte,<br />
Milano, SilvanaE<strong>di</strong>toriale, 2003, pp. 27-35<br />
1- La civiltà comunale italiana al suo apogeo<br />
Il titolo <strong>di</strong> questo contributo riecheggia consapevolmente, in tono inevitabilmente minore e<br />
meno pregnante, un fortunato uso con cui la storiografia fiorentina ha identificato come “età <strong>di</strong><br />
Dante” gli anni a cavallo tra Due e Trecento 1 : gli stessi che qui ci interessano, dal momento che<br />
l’attività documentata in Siena <strong>di</strong> Duccio figlio <strong>di</strong> Buoninsegna si <strong>di</strong>stende nel quarantennio che va<br />
dal 1278, quando i critici ce lo propongono come un giovane pittore che ottiene le commesse <strong>di</strong><br />
lavori “minori”, fino al 1318. Al <strong>di</strong> là della occasione per la quale questo testo viene steso, occorre<br />
però chiedersi se utilizzare come riferimento cronologico “l’età <strong>di</strong> Duccio” abbia davvero un senso<br />
per la storia <strong>di</strong> Siena e, nel caso, <strong>di</strong> quale senso possa trattarsi. Che cos’era Siena quando Duccio<br />
elaborava il suo particolare linguaggio pittorico?<br />
Non c’è bisogno <strong>di</strong> spendere molte parole per ricordare che si tratta <strong>di</strong> una stagione<br />
particolarmente fertile della storia d’Italia intera, prima <strong>di</strong> tutto perché la popolazione, con una<br />
crescita vertiginosa avvenuta soprattutto in ambito urbano, toccò il punto più alto dell’intero arco<br />
plurisecolare del Me<strong>di</strong>oevo e poi perché la civiltà comunale, <strong>di</strong> cui fu la culla la sua parte centro-<br />
settentrionale, raggiunse il suo massimo sviluppo istituzionale, politico, sociale, economico e<br />
culturale. Tutt’oggi è sufficiente passeggiare per le strade <strong>di</strong> molte città italiane per percepire quanta<br />
parte del tessuto urbano, se non ad<strong>di</strong>rittura dei singoli e<strong>di</strong>fici, sia ancora riconducile all’espansione<br />
duecentesca 2 . Come se non bastasse, concorre ad identificare un ciclo con una sua coerenza interna<br />
il fatto, storicamente degno <strong>di</strong> nota, che quegli anni abbiano rappresentato, almeno ai nostri occhi, il<br />
culmine <strong>di</strong> una crescita ma insieme anche il punto <strong>di</strong> una svolta, perché fu allora che iniziarono ad<br />
essere elaborate forme nuove sul piano economico, politico, istituzionale, culturale, religioso 3 .<br />
E’ anche ben noto, tuttavia, che l’Italia non era tutta eguale né dal punto <strong>di</strong> vista<br />
dell’evoluzione istituzionale delle forme <strong>di</strong> governo con cui si reggevano le popolazioni, come è<br />
ben presente a tutti, né da quello della concentrazione demografica, a causa della <strong>di</strong>versa <strong>di</strong>ffusione<br />
del fenomeno urbano e del <strong>di</strong>verso peso economico e politico delle città; e basta in questa sede<br />
ricordare che nell’Italia a nord <strong>di</strong> Roma crescevano quattro ‘giganti’ quali Milano, che sfiorava i<br />
200.000 abitanti, e Venezia, Firenze, Genova, che, con i loro circa 100.000, non avevano uguali non<br />
1 Come ha scritto Giovanni Cherubini (G. CHERUBINI, Le città italiane dell’età <strong>di</strong> Dante, Pacini, Pisa 1991, pp. 13-14)<br />
“larghi passi delle opere del poeta forniscono una conoscenza ineguagliabile <strong>di</strong> quell’età e <strong>di</strong> quel mondo urbano”.<br />
2 Gli e<strong>di</strong>fici me<strong>di</strong>evali più significativi si concentrano essenzialmente tra gli ultimi decenni del XIII e la metà del XIV:<br />
I. MORETTI, Siena, in Enciclope<strong>di</strong>a dell’arte me<strong>di</strong>evale, ad vocem.<br />
3 CHERUBINI, Le città italiane cit., p. 12.<br />
1
solo nel resto d’Italia ma neanche in Europa, dove queste <strong>di</strong>mensioni erano raggiunte solo da Parigi<br />
e da Costantinopoli, vale a <strong>di</strong>re dalla capitale <strong>di</strong> un grande regno e da quella <strong>di</strong> un impero.<br />
La Toscana, in questo quadro <strong>di</strong> preminenza, era una regione urbanizzata in maniera<br />
particolare e presentava a sua volta proprie punte d’eccellenza perché nel suo spazio si trovavano<br />
<strong>di</strong>verse città per l’epoca molto gran<strong>di</strong>, tra cui Siena, e una davvero gran<strong>di</strong>ssima, Firenze. Si trattava<br />
<strong>di</strong> una regione contrad<strong>di</strong>stinta da molti poli economici, dal momento che le sue città erano tutte<br />
economicamente vivaci, <strong>di</strong>verse nelle attitu<strong>di</strong>ni produttive anche perché molto vicine tra sé, inserite<br />
com’erano per la maggior parte - con l’esclusione proprio <strong>di</strong> Siena, la più meri<strong>di</strong>onale – nel<br />
triangolo nord della regione e specie intorno a quel gran produttore <strong>di</strong> paesaggi umani che fu il<br />
bacino dell’Arno 4 .<br />
Firenze, Lucca, Pisa, Siena, Pistoia, Arezzo, Massa Marittima, Volterra, Prato e poi altri<br />
centri minori come Cortona, Montepulciano, Colle, S. Gimignano arrivavano ad ospitare, insieme,<br />
in quegli anni o poco dopo, un terzo <strong>di</strong> quei circa 1.300.000 d’abitanti che, secondo i calcoli <strong>di</strong><br />
Giuliano Pinto, popolavano la Toscana e collocandola con sicurezza tra le regioni a più alto carico<br />
<strong>di</strong> popolazione in Europa 5 . Il culmine demografico fu raggiunto proprio intorno all’ultimo quarto<br />
del Duecento, quando il rapporto numerico tra la popolazione delle città e quella delle campagne in<br />
qualche caso arrivò a rasentare il pareggio. Cinte murarie che racchiudevano gli spazi urbani con<br />
<strong>di</strong>fese sempre più imponenti, si stagliarono come quinte sul palcoscenico <strong>di</strong> campagne fortemente<br />
umanizzate, già coperte all’epoca da una rete molto fitta <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amenti minori e case sparse sui<br />
campi, più <strong>di</strong> tutto evidente in quelle colline al centro della regione laddove si avviavano rapporti<br />
mezzadrili che già erano una realtà non trascurabile proprio intorno a Firenze e a Siena 6 , soprattutto<br />
4 Per gli anni che ci riguardano rinvio al quadro <strong>di</strong> sintesi tracciato da G. CHERUBINI, La Toscana <strong>di</strong> fronte all’Italia e<br />
all’Europa al tempo <strong>di</strong> Arnolfo <strong>di</strong> Cambio, in corso <strong>di</strong> stampa e, soprattutto al recente, bel volume dove lo stesso autore<br />
propone sette saggi sulle città <strong>di</strong> Firenze, Pisa, Lucca, Siena, Arezzo, Prato e Pistoia, cioè le sette maggiori città toscane<br />
del tempo, tutte se<strong>di</strong> <strong>di</strong> un vescovo e dunque centro <strong>di</strong> un territorio <strong>di</strong>ocesano, con l’aggiunta del castello <strong>di</strong> Prato, che<br />
formalmente non poteva <strong>di</strong>rsi città in quanto non era sede <strong>di</strong> <strong>di</strong>ocesi, ma assurgeva lentamente alla consistenza<br />
demografica (più o meno allo stesso livello <strong>di</strong> Arezzo o Pistoia), ma soprattutto alle ambizioni e al ruolo <strong>di</strong> centro<br />
urbano: G. CHERUBINI, Città comunali <strong>di</strong> Toscana, Bologna, Clueb, 2003.<br />
5 Circa 300.000 sarebbero vissuti in quattro gran<strong>di</strong> città e nei nove centri urbani me<strong>di</strong> e minori (G. PINTO, La Toscana<br />
nel tardo Me<strong>di</strong>oevo, Ambiente, economia rurale, società, Sansoni, Firenze 1982, pp. 62,78 e CHERUBINI, Città comunali<br />
cit., pp. 191.<br />
6 Alla metà del XIII secolo la mezzadria era già presente in almeno 16 dei comuni in cui è attualmente <strong>di</strong>visa la<br />
provincia <strong>di</strong> Siena, e più saldamente in quelli <strong>di</strong> Asciano, Siena, Sovicille, Monteroni e Rapolano. Intensamente<br />
mezzadrili le Crete propriamente dette (Asciano, Monteroni, Buonconvento e San Giovanni d'Asso); un secolo dopo era<br />
già una forma <strong>di</strong> conduzione della terra <strong>di</strong>ffusissima anche nei territori compresi nei comuni attuali <strong>di</strong> Monteriggioni,<br />
Castelnuovo Berardenga, Montalcino, Pienza, Trequanda, Torrita e Sinalunga. Per il quadro della <strong>di</strong>ffusione della<br />
mezzadria nella toscana me<strong>di</strong>evale, almeno G. CHERUBINI, La mezzadria toscana delle origini,in Conta<strong>di</strong>ni e<br />
proprietari nella Toscana moderna. Atti del Convegno <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong> in onore <strong>di</strong> Giorgio Giorgetti, vol. I, Dal Me<strong>di</strong>oevo<br />
all'età moderna, Firenze, 1979, pp. 131-152, ora in ID., Scritti toscani. L’urbanesimo me<strong>di</strong>evale e la mezzadria, Firenze,<br />
Salimbeni, 1991, pp. 189-207, G. PINTO, L'agricoltura delle aree mezzadrili,, in Le Italie del tardo Me<strong>di</strong>oevo, a cura <strong>di</strong><br />
Sergio Gensini, Pisa, Pacini 1990, pp. 433-448, e il recente M. GINATEMPO, La mezzadria delle origini. L’Italia centrosettentrionale<br />
nei secoli XIII-XV, “Rivista <strong>di</strong> storia dell’agricoltura”, XLII (2002), pp.49-110 (con una ricca bibliografia<br />
ragionata), cui si aggiunga quanto si desume dai tre volumi su Il contratto <strong>di</strong> mezzadria nella Toscana me<strong>di</strong>evale I,<br />
Contado <strong>di</strong> Siena, sec. XIII-1348, a cura <strong>di</strong> G. Pinto e P. Pirillo, Olschki, Firenze 1987, II, Contado <strong>di</strong> Firenze, sec. XIII,<br />
2
per il precoce arrivo, anche tramite la politica dei piccoli prestiti ai conta<strong>di</strong>ni, <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>ni dotati <strong>di</strong><br />
capitali che servirono per l’accorpamento poderale e per costruire, a poco a poco, nuove case dove<br />
potessero vivere e lavorare le famiglie dei coltivatori e soggiornare, con la bella stagione, quelle<br />
degli stessi proprietari.<br />
2. Siena in Toscana<br />
Quale ruolo aveva Siena nell’ambito del Toscana? Sappiamo che la città aveva goduto,<br />
insieme a Lucca, <strong>di</strong> una ripresa economica molto precoce, ma che mai fece parte del novero delle<br />
città che si erano can<strong>di</strong>date, nei secoli, alla guida della regione 7 e tra le quali aveva finito per<br />
prevalere Firenze che aveva vissuto una continua, progressiva ascesa dal XII secolo e che, proprio<br />
negli anni in cui Duccio vedeva la luce, aveva messo in atto l’ar<strong>di</strong>ta impresa del conio del fiorino<br />
d’oro che, a partire dal 1252, aveva dato uno strumento e un simbolo prestigioso alla sua<br />
partecipazione ai gran<strong>di</strong> commerci 8 .<br />
Per la verità, proprio poco dopo la metà del Duecento, quando Duccio <strong>di</strong> Boninsegna era<br />
probabilmente ancora un bambino, anche Siena, la più meri<strong>di</strong>onale delle protagoniste della<br />
rivoluzione commerciale nel Me<strong>di</strong>oevo, aveva vissuto la brevissima illusione <strong>di</strong> un’egemonia sulla<br />
Toscana, quando l’intrepido capo Provenzano d’Il<strong>di</strong>bran<strong>di</strong>no Salvani, chiamato da Dante il ‘sire<br />
quando fu <strong>di</strong>strutta la rabbia fiorentina’ e del cui nome ‘Toscana sonò tutta’, rappresentò il punto <strong>di</strong><br />
riferimento dei ghibellini in appoggio a re Manfre<strong>di</strong> contro i guelfi e Firenze, cercando nella grande<br />
<strong>di</strong>visione tra una parte pontificia e una imperiale che, a partire dagli anni Venti e Trenta, si era<br />
ra<strong>di</strong>calizza in Italia e in Toscana, l’occasione per affiancare un forte ruolo politico nello scacchiere<br />
nazionale a quella posizione <strong>di</strong> primo piano che i banchieri senesi da qualche decennio detenevano<br />
nel quadro del cre<strong>di</strong>to e della finanza internazionale. Illusione, <strong>di</strong>cevo, inebriante e breve, nata<br />
intorno ad uno scontro – la battaglia <strong>di</strong> Montaperti del 4 settembre 1260 - che per qualche anno<br />
sembrò poter essere quello decisivo. Un epos straor<strong>di</strong>nario circondò la battaglia vittoriosa per Siena,<br />
specchio non casuale <strong>di</strong> un momento particolarmente intenso per la maturazione dell’autocoscienza<br />
citta<strong>di</strong>na, al punto che i senesi tuttora la mantengono nella propria memoria, così come mantengono<br />
a cura <strong>di</strong> O. Muzzi, M.D. Nenci, Olschki, Firenze 1988, III, Contado <strong>di</strong> Siena, 1349-1518. Appen<strong>di</strong>ce: la normativa,<br />
1256-1510, a cura <strong>di</strong> G. Piccinni, Olschki, Firenze 1992.<br />
7 La prima era stata Lucca, capitale della Marca <strong>di</strong> Toscana quattrocento anni prima dei fatti che ci riguardano e poi<br />
centro <strong>di</strong> produzione europeo, tra i maggiori, dell’industria della seta. La città aveva però un contado esiguo, montuoso,<br />
che non le consentì <strong>di</strong> mantenere un peso politico a livello regionale; la seconda era stata Pisa che duecento anni prima<br />
aveva costruito la sua prosperità sul commercio nel Me<strong>di</strong>terraneo ma che proprio alla metà del Duecento cedeva<br />
inesorabilmente quel primato a Genova, avviando una fase <strong>di</strong> declino demografico ed economico, trasformandosi da<br />
porto me<strong>di</strong>terraneo in un porto tirrenico, attivo sbocco solo delle città dell’interno, la terza, infine, era stata e rimase<br />
Firenze. Inquadra Siena in questo contesto O. REDON, Lo spazio <strong>di</strong> una città. Siena e la Toscana meri<strong>di</strong>onale (secoli<br />
XIII-XIV), Roma, Viella, 1999, p. 63.<br />
8 CHERUBINI, La Toscana <strong>di</strong> fronte all’Italia e all’Europa cit.<br />
3
quella del loro antico ghibellinismo, durato nella sua forma più ra<strong>di</strong>cale al massimo un trentennio, e<br />
<strong>di</strong>menticano quella del loro successivo e lungo guelfismo.<br />
In realtà Siena, anche nei tormentati decenni in cui le posizioni avevano teso a ra<strong>di</strong>calizzarsi,<br />
era stata città filoimperiale, ma non per questo automaticamente e interamente antipapale, e proprio<br />
il ra<strong>di</strong>calismo <strong>di</strong> Provenzano, il suo desiderio <strong>di</strong> dare a se stesso e alla città un ruolo politico <strong>di</strong><br />
rilievo, la stessa vittoria ottenuta a Montaperti, finirono per marcare l’avvio <strong>di</strong> una lacerazione del<br />
tessuto sociale e del gruppo <strong>di</strong>rigente <strong>di</strong> proporzioni che la città non aveva mai conosciuto. Cartina<br />
<strong>di</strong> tornasole era stata la contromossa con la quale il pontefice aveva fatto esplodere le contrad<strong>di</strong>zioni<br />
che già all’indomani della sconfitta guelfa a Montaperti avevano opposto all’orientamento<br />
ghibellino del governo la convenienza particolare dei più ricchi banchieri che, come vedremo,<br />
trafficavano con la Curia pontificia ricavandone larghi proventi: il nuovo pontefice Urbano IV<br />
aveva conferito effetti economici alla sanzione <strong>di</strong> scomunica lanciata alla città dal suo predecessore<br />
fino a or<strong>di</strong>nare la cancellazione dei cre<strong>di</strong>ti delle compagnie senesi, minacciandone in tutta Europa<br />
gli affari e completando l’opera con una mossa <strong>di</strong> notevole scaltrezza politica, cioè compilando le<br />
liste <strong>di</strong> quelle, a lui fedeli, che erano esentate dalle conseguenze economiche <strong>di</strong> quelle sanzioni<br />
spirituali; infine, in risposta all'atto <strong>di</strong> obbe<strong>di</strong>enza e devozione <strong>di</strong> quanti giurarono <strong>di</strong> operare "pro<br />
defensione libertatis ecclesiae ac pacifico statu fidelium", aveva preso i fuoriusciti sotto la sua<br />
protezione offrendo loro ricetto e sostegno nel borgo <strong>di</strong> Ra<strong>di</strong>cofani 9 . Il gruppo <strong>di</strong>rigente senese ne<br />
era uscito spaccato 10 .<br />
Con la morte <strong>di</strong> Provenzano e l’avvio della sua damnatio memoriae 11 , tra alterne vicende -<br />
sconfitte militari come quella che i ghibellini toscani subirono a Colle nel 1269, rientro <strong>di</strong> fuorusciti<br />
guelfi, tentativi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione, giuramento <strong>di</strong> fedeltà agli angioini e alla Chiesa, controesodo dei<br />
ghibellini, resa dei conti, rappresaglie e nuove <strong>di</strong>struzioni <strong>di</strong> palazzi e torri che, come ferite vive,<br />
9 Conosciamo il contenuto delle bolla <strong>di</strong> Urbano IV per una allusione fatta nella lettera pontificale spe<strong>di</strong>ta il 26 gennaio<br />
1262 da Viterbo con la quale il papa esclude il mercante Vivolo <strong>di</strong> Salvanello dalla sentenza <strong>di</strong> scomunica, nella quale<br />
si legge che “Licet nuper in cives senenses ex certa causa mandaverimus excommunicationis sententiam generaliter<br />
promulgari, ac etiam inhiberi ne quis illis vel eorum alicui de debitis respondeat eorundem, quia tamen devotionis tue<br />
obsequium habemus circa nostra et apostolice se<strong>di</strong>s negozia […] personam tuam huismo<strong>di</strong> inclu<strong>di</strong> sententia nolumus"<br />
(J. GUIRAUD, Les registres d'Urbain IV (1261-1264), Camerale, Paris, 1990, I, n. 71). Nella lettera del 5 gennaio 1263<br />
con la quale Urbano IV trasmette l'or<strong>di</strong>ne a tutti i re, principi e secolari dei <strong>di</strong>fferenti or<strong>di</strong>ni religiosi d'Europa <strong>di</strong><br />
sod<strong>di</strong>sfare gli obblighi pecuniari che essi abbiano assunto verso quelli che egli ormai definisce i suoi "<strong>di</strong>lecti filii",<br />
compaiono in una lista nominativa 60 uomini riferibili a 14 gruppi parentali senesi che, si <strong>di</strong>ce, hanno risposto al suo<br />
invito <strong>di</strong> tornare "ad gremium ecclesie" (L. DOREZ - J. GUIRAUD, Les registres d'Urbain IV, Paris, 1899-1958, II, n.<br />
175). Le promesse successive furono in<strong>di</strong>rizzate a 107 uomini nei quali è stato in<strong>di</strong>viduato il primo nucleo della<br />
nascente pars guelforum senese (Ivi, II, n. 274).<br />
10 Ho ripercorso queste vicende, dall’ottica molto particolare della produzione letteraria, in G. PICCINNI, Un intellettuale<br />
ghibellino nell’Italia del Duecento: Ruggirei Apugliese, dottore e giullare in Siena. Note intorno all’uso storico <strong>di</strong><br />
alcuni testi poetici, “Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Me<strong>di</strong>o Evo”, 105 (2003), pp. 53-85.<br />
11 La pur “assurda tra<strong>di</strong>zione” del tra<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> Provenzano nella battaglia <strong>di</strong> Colle è significativa “<strong>di</strong> una lunga<br />
memoria della <strong>di</strong>scor<strong>di</strong>a interna determinata in Siena dalla contrapposizione tra Guelfi e Ghibellini”: P.<br />
CAMMAROSANO, Il comune <strong>di</strong> Siena dalla solidarietà imperiale al guelfismo: celebrazione e propaganda, in Le forme<br />
4
esero la sopraffazione <strong>di</strong> una fazione sull’altra fisicamente percepibile nel tessuto urbano 12 -<br />
proprio dal ghibellinismo <strong>di</strong> Provenzano scaturirono regimi <strong>di</strong> governo guelfo, prima nel 1271<br />
quello detto dei Trentasei e poi, dopo che una legislazione speciale escluse dal governo il blocco <strong>di</strong><br />
una sessantina famiglie dell'aristocrazia (1277) 13 , quello detto dei Nove, che resse Siena dal 1287<br />
fino al 1355, per oltre settanta anni, regalandole una lunga stagione – che è proprio il cuore <strong>di</strong> quella<br />
<strong>di</strong> cui ci occupiamo in questa sede - <strong>di</strong> relativa tranquillità ed equilibrio politico, anche se si<br />
appannarono allora certe proiezioni senesi sullo scenario internazionale.<br />
Negli anni della giovinezza <strong>di</strong> Duccio, dunque, si avviò in Siena un governo popolare<br />
particolarmente longevo composto da mercanti “de la mezza gente” 14 , con l’esclusione <strong>di</strong> gran parte<br />
delle famiglie <strong>di</strong> affaristi appartenenti al ceto magnatizio che pure erano state protagoniste del<br />
passaggio dal ghibellinismo al guelfismo, ma poi escluse dal governo guelfo.<br />
3. Una parabola in crescita con segni <strong>di</strong> ce<strong>di</strong>mento<br />
Nell’età considerata in queste pagine Siena, in ciò allineandosi a quello che avvenne nel<br />
resto l’Europa, raggiunse il massimo della sua consistenza demografica, ulteriormente passando dai<br />
circa 15.000 abitanti che possiamo assegnarle per la prima metà del XII secolo, e che potevano<br />
essere forse raddoppiati alla metà del Duecento, ai 47-50.000 raggiunti intorno agli anni Venti-<br />
Trenta dal Trecento 15 , quando, dopo aver saturato gli spazi interni alle mura, i senesi pre<strong>di</strong>sposero<br />
della propaganda politica nel Due e nel Trecento, a cura <strong>di</strong> Paolo Cammarosano, Roma, École française de Rome,<br />
1994, pp. 455-467, alla p. 461.<br />
12<br />
A. CARNIANI, I Salimbeni. Quasi una signoria, Siena, Protagon, 1995, p. 39 e nota; Archivio <strong>di</strong> stato <strong>di</strong> Siena,<br />
Consiglio Generale 10, cc. 94-98v.<br />
13<br />
In verità fu allora che per la prima volta un ceto sociale in partenza non omogeneo si trovò nella necessità <strong>di</strong><br />
presentarsi come se lo fosse, come spesso accade, sono proprio le leggi <strong>di</strong>scriminanti che consentono l'identificazione<br />
sociale del ceto <strong>di</strong>scriminato. Non a caso da allora i membri <strong>di</strong> quelle famiglie senesi si autoidentificarono e vennero<br />
dagli altri identificati come i "gran<strong>di</strong>", i "casati" (quelli che altrove vengono detti magnati) e "si inventò" così una unità<br />
un gruppo eterogeneo <strong>di</strong> milites, <strong>di</strong> certi mercanti, <strong>di</strong> certi membri <strong>di</strong> una aristocrazia consolare cristallizzatasi tra XII e<br />
XIII secolo, <strong>di</strong> certi signori <strong>di</strong> castelli <strong>di</strong> contado che si erano inurbati tempo ad<strong>di</strong>etro costruendo nella città i loro<br />
inse<strong>di</strong>amenti fortificati. Si veda R. MUCCIARELLI, Potere economico e potere politico a Siena tra XIII e XIV secolo:<br />
percorsi <strong>di</strong> affermazione familiare, in Poteri economici e poteri politici. Secoli XIII-XVIII, a cura <strong>di</strong> S. Cavaciocchi,<br />
Firenze, 1999, Atti della XXX settimana <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong> dell’Istituto Internazionale <strong>di</strong> <strong>Storia</strong> economica Francesco Datini,<br />
(Prato 27 aprile - 1 maggio 1998), pp. 569-590 e EADEM, I lignaggi e le loro strategie, in <strong>Storia</strong> della civiltà toscana, I,<br />
Comuni e Signorie (1200-1434), a cura <strong>di</strong> F. Car<strong>di</strong>ni, Firenze, Le Monnier, 2000, pp. 137-150.<br />
14<br />
Per il regime <strong>di</strong> governo novesco in<strong>di</strong>spensabile il riferimento a W. M. BOWSKY, Le finanze del Comune <strong>di</strong> Siena<br />
1287-1355, Firenze 1976. W. M. BOWSKY, Un comune italiano nel Me<strong>di</strong>oevo. Siena sotto il regime dei Nove, 1287-<br />
1355, Bologna 1986 e almeno G. CHERUBINI, I mercanti e il potere, in Banchieri e mercanti <strong>di</strong> Siena, prefazione <strong>di</strong><br />
Carlo Maria Cipolla, Roma, De Luca 1987, pp. 163-222, recentemente rie<strong>di</strong>to, con aggiornamenti e con il titolo I<br />
mercanti e il potere a Siena in ID., Città comunali cit., pp. 297-348. Coloro che detenevano le cariche politiche più<br />
importanti si stabilì che “sieno et essere debiano de’ mercatanti della città <strong>di</strong> Siena o vero de la meza gente”, secondo Il<br />
Costituto del Comune <strong>di</strong> Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX, a cura <strong>di</strong> A. Lisini, voll. 2, Siena 1903, vol. II, p.<br />
492 (da ora nella nuova e<strong>di</strong>zione Il Costituto del Comune <strong>di</strong> Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX, e<strong>di</strong>zione<br />
critica a cura <strong>di</strong> Mahmoud Salem Elsheikh, Siena, Fondazione Monte dei Paschi, 2002).<br />
15<br />
Il calcoli <strong>di</strong> Beloch in base alla superficie contenuta dentro le mura <strong>di</strong> Siena davano 47.500 abitanti, quanto possono<br />
desumersi dal cronista Agnolo <strong>di</strong> Tura che per il 1328 conta 11.710 capifamiglia (AGNOLO <strong>DI</strong> TURA DEL GRASSO,<br />
Cronaca senese, in Cronache senesi, a cura <strong>di</strong> A. Lisini e F. Iacometti (Rerum Italicarum scriptores, seconda e<strong>di</strong>z., XV,<br />
parte VI), Bologna, Zanichelli 1931-39, pp. 487-488); un po’ più alti quelli <strong>di</strong> Bowsky desunti dalla Tavola delle<br />
5
un nuovo quartiere, il borgo <strong>di</strong> Santa Maria, che, per qualche anno, accolse, nelle balze retrostanti il<br />
palazzo pubblico, i flussi degli inurbati, a sua volta saturo nel giro <strong>di</strong> pochi anni 16 . Una<br />
documentazione molto particolare, come la Tavola delle possessioni, ci dà la rara opportunità <strong>di</strong><br />
collocare con esattezza all’interno del settennio 1324-1331 – e perciò poco dopo la probabile morte<br />
<strong>di</strong> Duccio - il culmine della curva demografica e della costruzione del borgo. Conferma il cronista<br />
proprio per quegli anni un’attività e<strong>di</strong>lizia nella costruzione <strong>di</strong> nuove porte nella cinta muraria a sud<br />
“per cresciare la città, la quale era piccola a la giente che Siena faceva, e ancho perché fusse la città<br />
più forte e più magnia” 17 .<br />
Il <strong>di</strong>segno del circuito delle mura urbane, ci aiuta a visualizzare meglio questa curva e<br />
accompagna i nostri calcoli: negli anni Venti del XIII secolo la città aveva terminato il poderoso<br />
sforzo <strong>di</strong> costruzione della terza cerchia delle sue mura, segno <strong>di</strong> una fase espansiva della<br />
popolazione, alla metà del secolo aveva messo mano ad un loro nuovo ampliamento, l’ultima cinta<br />
fu programmata nel 1323-26 per <strong>di</strong>fendere completamente gli ultimi borghi già nati a ventaglio<br />
verso sud e includere ampi spazi e<strong>di</strong>ficabili per una futura espansione, ma poi messa in atto<br />
lentamente, per stralci, fino al Quattrocento. Quel borgo, nato tra il 1324 e il 1331, si sarebbe<br />
rivelato dunque l’ultimo, e anche gli spazi rimasti vuoti in vista <strong>di</strong> una nuova espansione sarebbero<br />
rimasti tali. Da allora il <strong>di</strong>segno della città si è mantenuto, nella sostanza, abbastanza intatto, se si<br />
esclude la prima "rottura" della cinta muraria, avvenuta negli anni Venti del XX secolo, che ha<br />
determinato la creazione dei giar<strong>di</strong>ni della Lizza e la nascita del quartiere <strong>di</strong> S. Prospero.<br />
Duccio, dunque, vide il vertice della parabola demografica senese. Possiamo aggiungere che<br />
vide anche quello dello sviluppo della sua economia, almeno <strong>di</strong> quella che si <strong>di</strong>spiegava sui mercati<br />
internazionali con tale intensità che proprio in questa prima, fortunata, età più o meno<br />
cronologicamente coincidente con il massimo demografico, viene vista la chiave segreta della forza<br />
e della vitalità <strong>di</strong> Siena, “che giunsero fino alle gloriose ancorché sfortunate pagine <strong>di</strong> libertà scritte<br />
a metà Cinquecento e oltre”, per usare le parole <strong>di</strong> Franco Car<strong>di</strong>ni 18 .<br />
E’ noto che la potenza delle città toscane in Europa fu costituita soprattutto sul commercio a<br />
<strong>di</strong>stanza e sulle attività, ad esso connesse, <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to e <strong>di</strong> cambio delle monete. Se, all’inizio del XIII<br />
possessioni del 1316-20, che davano 52.000. La superficie all’interno dell’ultima cerchia <strong>di</strong> mura copre circa 165 ettari,<br />
la circonferenza invece è <strong>di</strong> 6.666 metri. Lando Bortolotti, che riporta questi dati, e al quale rinvio, commenta che “la<br />
sproporzione tra perimetro e superficie denuncia <strong>di</strong> per sé l’irregolarità della forma urbana, e la frequenza <strong>di</strong> rientranze<br />
nella cerchia”: L. BORTOLOTTI, Siena, Bari, Laterza, 1983, p. 30. Inserisce il dato senese in mezzo ai dati<br />
dell’estensione delle città toscane CHERUBINI, Città comunali cit., p. 140: Firenze 144 ettari, Pisa 185, Lucca 140,<br />
Arezzo 107.<br />
16 Sull’espansione trecentesca <strong>di</strong> Siena D. BALESTRACCI, G. PICCINNI, Siena nel Trecento. Assetto urbano e strutture<br />
e<strong>di</strong>lizie, Firenze, Clusf, 1977, pp. 30-37.<br />
17 Cronaca senese dei fatti riguardanti la città e il suo territorio <strong>di</strong> autore anonimo del secolo XIV, in Cronache senesi<br />
ci., p. 134<br />
18 F. CAR<strong>DI</strong>NI, L’argento e i sogni: cultura, immaginario, orizzonti mentali, in Banchieri e mercanti <strong>di</strong> Siena, prefazione<br />
<strong>di</strong> Carlo Maria Cipolla, Roma, De Luca 1987, pp. 291-375, alla p. 298.<br />
6
secolo gli operatori toscani erano secon<strong>di</strong> ai “lombar<strong>di</strong>”, come oltralpe venivano spesso chiamati<br />
tutti insieme i mercanti e i banchieri <strong>di</strong> Milano, Piacenza, Cremona, Pavia, Asti, Chieri, nel giro <strong>di</strong><br />
appena cinquant’anni si era fatto schiacciante, tra gli italiani, il predominio dei toscani, che avevano<br />
preso la testa dello sviluppo commerciale: emergendo i fiorentini come mercanti impren<strong>di</strong>tori,<br />
dominando i senesi per il cre<strong>di</strong>to e la banca.<br />
I primi segni della precoce espansione delle compagnie bancarie senesi si colgono già alla<br />
fine del XII secolo, ma esse sono in piena esplosione nella prima metà del XIII, e mostrano i loro<br />
tratti più tipici e i livelli più alti nella sua seconda metà. Perno dei loro affari fu l’area della<br />
Champagne 19 che costituivano il centro degli scambi commerciali e finanziari <strong>di</strong> tutta l’Europa: i<br />
senesi a queste fiere erano impegnati, senza specializzazioni <strong>di</strong> sorta, nell’acquisto <strong>di</strong> lane, tessuti,<br />
spezie, pellami, nella ven<strong>di</strong>ta regolare e continua delle varie mercanzie <strong>di</strong> origine italiana - cera,<br />
fustagni, allume, seta - ma soprattutto in operazioni <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to, deposito, versamenti <strong>di</strong> sal<strong>di</strong>,<br />
contratti <strong>di</strong> cambio, speculazioni valutarie <strong>di</strong> ogni tipo. Non meno importanti erano stati i rapporti<br />
d’affari che essi avevano sviluppato nelle Fiandre, in Inghilterra, in Germania (Colonia, Magonza),<br />
in Lorena, nella Francia meri<strong>di</strong>onale (Marsiglia, Nîmes, Montpellier) e occidentale (Bordeaux). Più<br />
importanti ancora gli affari con la Curia pontificia 20 , basti ricordare i rapporti con la Santa Sede<br />
stretti dalle famiglie dei Buonsignori (la Gran tavola da essi fondata nel 1209 fu forse, tra 1255 e<br />
1273, una delle più potenti compagnie bancarie europee 21 ), degli Angiolieri o dei Salimbeni che<br />
ottennero anche l'appalto delle gabelle dell'Impero e prestarono consistenti somme <strong>di</strong> denaro al re<br />
d'Inghilterra.<br />
Questa impronta economica modellava anche lo spazio urbano in forme nuove. Fino ad<br />
allora le tipologie e<strong>di</strong>lizie <strong>di</strong> maggiore spicco, anche perché allineate lungo i crinali delle colline,<br />
erano state quelle realizzate dalla nobiltà rurale inurbata e dall’antica oligarchia consolare. Le torri e<br />
le case-torri in pietra, le strette porte d’accesso e finestre <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni minime, strette e allungate<br />
come feritoie, ostentavano un vigore quasi guerresco, una vocazione <strong>di</strong>fensiva. Come fortezze,<br />
massicce, generalmente a pianta quadrata, i castellari, <strong>di</strong>more <strong>di</strong> Salvani, Ugurgeri, Malavolti,<br />
Rossi, racchiudevano in uno spazio fortificato e intorno ad una corte le abitazioni della famiglia, gli<br />
19 In particolare nelle fiere della Champagne le compagnie senesi “giocarono un ruolo <strong>di</strong> assolute protagoniste” e pare<br />
che il più antico consolato <strong>di</strong> cui si abbia ricordo alla Champagne sia proprio quello senese del 1246: M. TANGHERONI,<br />
Siena e il commercio internazionale nel Duecento e nel Trecento, in Banchieri e mercanti <strong>di</strong> Siena cit., pp. 101-103,<br />
alla p. 28.<br />
20 Impossibile qui dar conto della bibliografia sul tema: basti per tutti il rinvio al classico E. SESTAN, Siena avanti<br />
Montaperti, "Bullettino Senese <strong>di</strong> <strong>Storia</strong> Patria", LVIII, 1961, pp. 28-74 ora in ID., Italia me<strong>di</strong>evale, Napoli, 1966, pp.<br />
151-192, ed ai già citati Banchieri e mercanti <strong>di</strong> Siena e BORTOLOTTI, Siena.<br />
21 M. CASSANDRO, La banca senese nei secoli XIII e XIV, in Banchieri e mercanti <strong>di</strong> Siena cit. , pp. 107-160, alla p.<br />
110; A. SAPORI, Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> storia economica. Secoli XIII-XIV-XV, volume I, pp. 630, 786; e, ovviamente, M. CHIAUDANO, I<br />
Rothschild del Duecento. La Gran Tavola <strong>di</strong> Orlando Bonsignori, «BSSP», XIII, 1935, pp. 103-142.<br />
7
e<strong>di</strong>fici dei servi, degli armati 22 . Vicino ad essi nel XIII secolo avevano cominciato ad essere<br />
costruiti i primi palazzi, che acquistavano in ampiezza, comfort e ricercatezza quello che perdevano<br />
in altezza. Ampi portali avevano messo in comunicazione l’esterno e l’interno; a piano terra le<br />
botteghe, i magazzini e gli spazi <strong>di</strong> riunione ne sottolineavano il legame con il mondo degli affari.<br />
Così il palazzo dei Salimbeni, così quello dei Tolomei, ambedue tutt’oggi se<strong>di</strong> <strong>di</strong> banche, come se il<br />
duecentesco “trafficar <strong>di</strong> denaro” vi avesse impresso un suo segno indelebile.<br />
Ma dal punto <strong>di</strong> vista economico l’espansione senese, per quanto gran<strong>di</strong>osa e precoce fosse<br />
stata, non presentò caratteri <strong>di</strong> continuità. Essa durò poco più <strong>di</strong> un secolo, almeno in quella forma.<br />
Nell’età <strong>di</strong> Duccio anche la curva in salita <strong>di</strong>segnata dallo sviluppo stava, infatti, raggiungendo il<br />
culmine e Siena raccoglieva i frutti della stagione in cui era <strong>di</strong>venuta centro importante per il<br />
commercio del denaro: ma ci è ben chiaro – guardandola con il privilegio della <strong>di</strong>stanza - anche il<br />
segnale della sua particolare svolta, il profilarsi <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> cambiamenti che sarebbero stati ben<br />
più visibili dalla metà del XIV secolo. Si tratta <strong>di</strong> un momento <strong>di</strong> trasformazione sostanziale nel<br />
sistema economico senese, sul cui significato e sugli esiti nel breve e nel lungo periodo la ricerca<br />
storica non ha trovato ancora, a mio avviso, tutte le sue risposte.<br />
E’ certo che i senesi, nel volgere <strong>di</strong> qualche decennio, si ritirarono da un giro d’affari <strong>di</strong><br />
vasto raggio. Dalla fine del XIII secolo la decadenza delle fiere della Champagne, prima come nodo<br />
dei traffici monetari che tanto coinvolgevano proprio i senesi, poi anche come luogo dello scambio<br />
delle merci; la trasformazione del mercato finanziario, sempre più indotto a privilegiare l’oro<br />
rispetto all’argento; l’incremento della produzione laniera delle gran<strong>di</strong> città italiane, risultarono<br />
ostacoli insormontabili.<br />
Siena, infatti, non aveva avuto l’acqua <strong>di</strong> un fiume a creare con<strong>di</strong>zioni minime per lo<br />
sviluppo della manifattura che fece grande Firenze nella produzione <strong>di</strong> tessuti <strong>di</strong> lana <strong>di</strong> lusso e che<br />
fu vivificata dal commercio nel quale i suoi operatori erano maestri e dalla sua popolazione<br />
particolarmente consistente. Non aveva vicino nemmeno il mare 23 . Aveva avuto, questo sì, una<br />
strada – la francigena - che le aveva reso prossime Roma e la Curia pontificia più, e prima ancora,<br />
che i mercati nel cuore d’Europa ai quali pure portava <strong>di</strong>ritta, e aveva l’argento delle colline<br />
metallifere; su denaro e collegamenti aveva dunque fatto forza, costruendo su <strong>di</strong> essi, finché era<br />
stato possibile, la sua clamorosa fortuna, continuando però a mancare <strong>di</strong> una struttura produttiva in<br />
grado sia <strong>di</strong> reggere il confronto con l’agguerrita concorrenza fiorentina sul piano manifatturiero sia<br />
22 Un quadro generale e bibliografia in F. GABBRIELLI, Stilemi senesi e linguaggi architettonici nella Toscana del Due-<br />
Trecento, in L’architettura civile in Toscana. Il Me<strong>di</strong>oevo, a cura <strong>di</strong> Amerigo Restucci, Pisa, Amilcare Pizzi, 1995 (per<br />
Monte dei Paschi <strong>di</strong> Siena), pp. 309-310.<br />
23 Nel saggio già citato, che rimane ancora uno dei più luci<strong>di</strong> contributi alla storia <strong>di</strong> Siena, Ernesto Sestan definiva<br />
questa città come «figlia della strada» (SESTAN, Siena avanti Montaperti cit.). Una espressione «cruda», <strong>di</strong>ceva egli<br />
8
<strong>di</strong> fornirle una spina dorsale continuativa alla quale agganciare l’economia finanziaria e che avrebbe<br />
potuto permetterle almeno <strong>di</strong> ammortizzarne, se non <strong>di</strong> superarne, le inevitabili fasi <strong>di</strong> debolezza o<br />
<strong>di</strong> crisi.<br />
Firenze, intanto, consacrata come una potenza economica internazionale, sintesi della<br />
rinascita italiana, perché aveva saputo integrare perfettamente i tre settori fondamentali, si<br />
proponeva già anche come leader in<strong>di</strong>scussa dell’elaborazione culturale: Giovanni Cherubini<br />
ricorda che l’eccellenza fiorentina in questo campo non è rappresentata soltanto da una prevalenza<br />
numerica <strong>di</strong> uomini <strong>di</strong> cultura rispetto alle altre città della regione, ma dalla congiunta presenza,<br />
all’interno delle sue mura, <strong>di</strong> tre giganti innovatori quali Dante, Arnolfo <strong>di</strong> Cambio e Giotto, un<br />
evento mai riscontrato altrove per una città del me<strong>di</strong>oevo, che ha sempre sorpreso e continua a<br />
sorprendere 24 .<br />
Fu forse per questo concorso <strong>di</strong> cause che, quando la moneta d’oro soppiantò quella<br />
d’argento nei gran<strong>di</strong> scambi, quando le compagnie private <strong>di</strong> banchieri senesi incontrarono le<br />
maggiori <strong>di</strong>fficoltà nel mercato internazione ed emersero chiari i limiti della sua debolezza<br />
produttiva, Siena cominciò, in varie forme, ad “investire” nello Stato.<br />
Fu così che, proprio dagli anni <strong>di</strong> Duccio, il territorio senese si <strong>di</strong>latò e organizzò fino a<br />
comprendere un terzo della regione, in cui le cosiddette terre censuali (o <strong>di</strong>stretto), con la<br />
Maremma, le prime pen<strong>di</strong>ci dell’Amiata, il porto <strong>di</strong> Talamone, si aggiungevano al ‘contado storico’<br />
<strong>di</strong>rettamente sottoposto alla città, che rimase in verità sempre piuttosto piccolo 25 . E fu nel prestito al<br />
Comune <strong>di</strong> Siena e ai Comuni del territorio che venne impegnata una parte della ricchezza che<br />
aveva smesso <strong>di</strong> trovare impiego nel grande mercato internazionale del denaro 26 . Anche il passaggio<br />
da una attività <strong>di</strong> banca condotta sullo scacchiere internazionale ad una al servizio dello Stato, se<br />
così si può <strong>di</strong>re, è un dato acquisito dalla storiografia che consente <strong>di</strong> sfatare l’idea <strong>di</strong> un crollo e <strong>di</strong><br />
stesso, nella spiegazione della quale stava però il segreto della fortuna me<strong>di</strong>evale <strong>di</strong> Siena, «prodotto più dell’uomo che<br />
della natura».<br />
24 CHERUBINI, La Toscana <strong>di</strong> fronte all’Italia e all’Europa cit.<br />
25 M. ASCHERI, Lo stato <strong>di</strong> Siena: un’introduzione alla sua organizzazione politico-amministrativa, in Archivio storico<br />
e giuri<strong>di</strong>co sardo <strong>di</strong> Sassari. Stu<strong>di</strong> e memorie. In memoria <strong>di</strong> Ginevra Zanetti, Sassari 1994, pp. 73-96; REDON, Lo<br />
spazio cit., in particolare l’utilissima cartografia; B. SOR<strong>DI</strong>NI, Il porto della 'gente vana'. Lo scalo <strong>di</strong> Talamone tra il<br />
secolo XIII e il secolo XV, Siena, Protagon E<strong>di</strong>tori Toscani, 2001, pp. 285.<br />
26 Si veda CASSANDRO, La banca senese cit., pp. 154-156. La ridefinizione a scala locale è ora arricchita dagli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
CARNIANI, I Salimbeni cit.; R. MUCCIARELLI, I Tolomei banchieri <strong>di</strong> Siena. La parabola <strong>di</strong> un casato nel XIII e XIV<br />
secolo, Siena, Protagon e<strong>di</strong>tori, toscani, 1995; EAD., Un caso <strong>di</strong> emigrazione mercantile: i Tolomei <strong>di</strong> Siena, in<br />
Demografia e Società nell’Italia Me<strong>di</strong>evale (secoli IX-XIV), a cura <strong>di</strong> R. Comba e I. Naso, Atti del Convegno<br />
Internazionale (Cuneo-Carrù 28-30 aprile 1994), Cuneo, 1994, pp. 475-492 e Ead., I Piccolomini <strong>di</strong> Siena. Nobili e<br />
gentiluomini in una città comunale alla fine del Me<strong>di</strong>oevo, tesi <strong>di</strong> Dottorato <strong>di</strong> ricerca in ‘<strong>Storia</strong> Urbana e Rurale’, IX<br />
ciclo (1993-1996), sede amministrativa Perugia, coor<strong>di</strong>nato dai proff. Attilio Bartoli Langeli e Vittor Ivo Comparato.<br />
9
un abbandono repentino delle attività cre<strong>di</strong>tizie dei senesi documentando, al contrario, come la<br />
tra<strong>di</strong>zione finanziaria <strong>di</strong> questi operatori non venisse mai meno nemmeno durante il Trecento 27 .<br />
Sappiamo, infatti, che la nuova strategia delle società si orientò a sod<strong>di</strong>sfare la domanda<br />
interna <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to al consumo e, soprattutto, quella che proveniva dal <strong>di</strong>savanzo dei bilanci<br />
comunali 28 , il cui crescente fabbisogno determinava una ancor più sicura domanda cre<strong>di</strong>tizia. Molti<br />
uomini d’affari si videro costretti a ridurre le loro ambizioni: alcuni, nel quadro <strong>di</strong> generale<br />
insicurezza determinato dal fallimento della compagnia dei Buonsignori - la Gran Tavola insi<strong>di</strong>ata<br />
dall’ingresso dei fiorentini, forti del valido appoggio del fiorino d’oro, nell’orbita della Curia<br />
pontificia - irretiti in spirali <strong>di</strong> debiti e pendenze da cui non si sarebbero più liberati, scivolarono in<br />
procedure fallimentari lunghissime; altri, come alcuni Tolomei, presero la singolare la decisione <strong>di</strong><br />
dare vita ad una nuova società il cui raggio d’azione avrebbe dovuto essere il mercato<br />
internazionale ma che ebbe vita solo per qualche anno 29 ; altri ancora, come i Piccolomini, forse più<br />
pronti <strong>di</strong> molti colleghi a capire la chiusura delle prospettive internazionali e prendere atto della fine<br />
<strong>di</strong> un ciclo, anticiparono il fallimento cessando l’attività e riconvertendo imme<strong>di</strong>atamente capitali e<br />
risorse in una <strong>di</strong>mensione locale dove il primo referente fu, appunto, la finanza pubblica 30 .<br />
Per la parte restante, tutt’altro che insignificante, i capitali privati ritirati prima dal settore<br />
del cre<strong>di</strong>to internazionale e più tar<strong>di</strong> anche dalle imprese minerarie, vennero orientati<br />
principalmente verso la ren<strong>di</strong>ta fon<strong>di</strong>aria. I senesi compravano terra, che era abbondante e<br />
potenzialmente produttiva, accentuando la tendenza a vivere della ren<strong>di</strong>ta delle terre coltivate <strong>di</strong> un<br />
contado che si faceva molto più vasto, quando alla minore <strong>di</strong>namicità e voglia <strong>di</strong> rischiare che con<br />
l’avanzare del Trecento contrad<strong>di</strong>stinse i suoi operatori, avrebbe fatto da spalla l’interesse, questo<br />
invece cresciuto, per un'agricoltura molto ben protetta e sostenuta dal pubblico, oltre che per<br />
investimenti red<strong>di</strong>tizi nel settore speculativo costituito dall'allevamento del bestiame 31 . Tutto questo<br />
ha fatto parlare - dopotutto giustamente, fatto salvo il problema come sempre non secondario della<br />
misura, sulla quale occorrerà ragionare ancora - <strong>di</strong> una ‘ruralizzazione’ dell’economia senese alla<br />
fine del Me<strong>di</strong>oevo.<br />
27 Si assiste ad un trasferimento delle competenze e dei denari dal giro internazionale a quello della finanza citta<strong>di</strong>na, sia<br />
privata che, soprattutto, pubblica dove il carattere a breve termine dei prestiti, gli alti in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> retribuzione degli<br />
interessi che oscillavano da un minimo del 10% ad un massimo del 30% garantirono margini <strong>di</strong> profitto forse<br />
limitatissimi rispetto a quelli <strong>di</strong> alcuni decenni prima, ma <strong>di</strong> livello “non trascurabile” in anni che furono critici:<br />
CASSANDRO, La banca senese cit., p. 156.<br />
28 MUCCIARELLI, Potere economico e potere politico a Siena cit., con esempi <strong>di</strong> prestiti al comune <strong>di</strong> Massa Marittima<br />
da parte <strong>di</strong> esponenti <strong>di</strong> famiglie magnatizie senesi.<br />
29 Tre anni più tar<strong>di</strong> la compagnia manifestò i primi segnali preoccupanti <strong>di</strong> crisi che la portarono <strong>di</strong> lì a poco al<br />
fallimento nel 1310: MUCCIARELLI, I Tolomei cit., pp. 285-297.<br />
30 MUCCIARELLI, I Piccolomini <strong>di</strong> Siena cit.<br />
31 Ho trattato questi temi in varie occasioni. Per tutte Il contratto <strong>di</strong> mezzadria cit.<br />
10
Duomo<br />
4. Due ‘imprese’ <strong>di</strong> carattere pubblico: l’ospedale S. Maria della Scala e l’Opera del<br />
Già si è detto che la storia <strong>di</strong> Siena appare segnata da un forte senso del pubblico, e si può<br />
aggiungere che anche lo Stu<strong>di</strong>o, cioè quella che oggi chiamiamo l’Università, si era configurato, e<br />
fin dal Duecento, come un ufficio comunale e che nel Quattrocento per iniziativa pubblica sarebbe<br />
nato anche il Monte Pio, in controtendenza con quanto avveniva altrove in Italia, dove tutti i Monti<br />
<strong>di</strong> Pietà scaturivano dall’iniziativa francescana. Ma negli anni che qui si trattano crebbero in Siena<br />
anche alcune importanti iniziative con un chiaro carattere impren<strong>di</strong>toriale, sulla quali vale la pena <strong>di</strong><br />
soffermarsi prima <strong>di</strong> tratteggiare un profilo dell’azione generale del governo dei Nove. Si trattava <strong>di</strong><br />
un’impren<strong>di</strong>toria <strong>di</strong> carattere pubblico, i cui caratteri segnarono un segmento importante della storia<br />
della città. Tra esse voglio ricordare almeno l’ospedale <strong>di</strong> Santa Maria della Scala, una delle<br />
maggiori istituzioni del genere a livello europeo, e l’Opera del Duomo.<br />
Nel maggio del 1309 il consiglio generale della città, che sosteneva l’istituzione ospedaliera<br />
e già ne nominava i revisori dei conti, aveva approvato una controversa delibera con il fine <strong>di</strong><br />
collocare le proprie insegne ai due lati della porta d'ingresso del complesso, a mo’ <strong>di</strong> tabella <strong>di</strong><br />
possesso, per affermare il principio che "lo detto spedale Sancte Marie sia del Comune <strong>di</strong> Siena" 32 :<br />
atto nella sostanza simbolico che aveva rappresentato anche, forse soprattutto, un passo rilevante in<br />
<strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> un impegno <strong>di</strong>retto dei poteri municipali sul versante dell'assistenza ai poveri, ai<br />
trovatelli, ai pellegrini, ai malati, a tutti i bisognosi, in sintonia con un processo testimoniato in tutta<br />
Europa tra XIII e XV secolo, <strong>di</strong>venendo l’in<strong>di</strong>zio formale ed il sigillo “<strong>di</strong> quel nuovo patronato<br />
comunale sui gran<strong>di</strong> enti assistenziali citta<strong>di</strong>ni cui i secoli successivi avrebbero dato compiuta<br />
espressione” 33 .<br />
La consapevolezza della natura pubblica dei servizi forniti dai maggiori ospedali citta<strong>di</strong>ni<br />
aveva già condotto ad un riconoscimento del carattere comunale degli enti che li erogavano, tra i<br />
quali il più importante era ormai l’ospedale <strong>di</strong> santa Maria della Scala, che più avanti avrebbe<br />
ricoperto, almeno per un certo periodo dal 1348 ma probabilmente anche prima , il ruolo ine<strong>di</strong>to <strong>di</strong><br />
una banca “pubblica”, accettando in custo<strong>di</strong>a i depositi in denaro dei pellegrini <strong>di</strong> passaggio e<br />
accogliendo anche il risparmio dei citta<strong>di</strong>ni sotto forma <strong>di</strong> depostiti sui quali pagava interessi, del<br />
tutto incurante delle prudenze suggerite dalla Chiesa in tema <strong>di</strong> usure: gli interessi erogati in questo<br />
modo ai citta<strong>di</strong>ni consentivano loro <strong>di</strong> sostenere meglio anche il prelievo fiscale e il sistema dei<br />
32 La vicenda della segnatura degli e<strong>di</strong>fici con le armi del Comune <strong>di</strong> Siena è ora approfon<strong>di</strong>ta e commentata da M.<br />
PELLEGRINI, L’ospedale e il Comune, in Arte e assistenza a Siena. Le copertine <strong>di</strong>pinte dell’Ospedale <strong>di</strong> Santa Maria<br />
della Scala, cura <strong>di</strong> Gabriella Piccinni e Carla Zarrilli, Pisa, Pacini, 2003, pp. 29-45, contestualizzabile in ID, Istituzioni<br />
ecclesiastiche, vita religiosa e società citta<strong>di</strong>na nella prima età comunale, in Chiesa e vita religiosa a Siena dalle<br />
origini al grande giubileo, atti del Convegno <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> (Siena 25-27 ottobre 2000), Siena 2002, pp. 101-134.<br />
33 M. PELLEGRINI, L’ospedale e il Comune cit., p. 33<br />
11
“prestiti forzosi” esatti dallo Stato, mentre il denaro depositato veniva messo a frutto dall’ospedale<br />
per finanziare le attività istituzionali 34 .<br />
Attraverso la documentazione del cospicuo archivio dell’ente, dall’osservazione dell’e<strong>di</strong>ficio,<br />
dagli scavi archeologici, siamo informati del fatto che la sua organizzazione interna si basava su più<br />
“centri” <strong>di</strong> attività, che la sua attività assistenziale si rivolgeva a più soggetti tra i quali i trovatelli, i<br />
malati, i viandanti, le vedove, che il suo rapporto con il potere e la politica citta<strong>di</strong>na si basava su una<br />
rete <strong>di</strong> relazioni a più livelli e che le sue proprietà immobiliari si facevano sempre più ampie, dando<br />
vita a poderi e poi a fattorie particolarmente ricche e produttive. E’ impossibile in questa sede<br />
soffermarsi sul complesso sviluppo duecentesco e trecentesco della fabbrica ospedaliera, ma può<br />
essere utile segnalare almeno la costruzione del palazzo dove abitava il rettore, e alcune delle<br />
acquisizioni più recenti della ricerca storica e archeologica. Dai lavori e<strong>di</strong>lizi <strong>di</strong> questi ultimi anni e<br />
dalle stonacature necessarie al restauro del complesso dopo l’esaurirsi della funzione sanitaria<br />
contemporanea 35 , è, infatti, emersa una duecentesca “strada interna”, in origine una via pubblica a<br />
cielo aperto, situata nelle vicinanze della cinta <strong>di</strong> mura civiche, che era venuta a trovarsi nella<br />
naturale <strong>di</strong>rettrice d’espansione verso valle delle strutture ospedaliere. Esse, proprio dagli anni dei<br />
quali qui trattiamo, avevano finito per scavalcarla, facendone un percorso privato funzionale alle<br />
esigenze interne e mantenendola come spina dorsale del complesso e<strong>di</strong>lizio e principale asse<br />
<strong>di</strong>stributore delle <strong>di</strong>verse funzioni da un livello all’altro: nascosta <strong>di</strong>etro una facciata lunga un<br />
centinaio <strong>di</strong> metri la serie <strong>di</strong> corpi addossati gli uni altri e gli uni sugli altri precipitava infatti sotto il<br />
livello stradale per tre altissimi piani appoggiandosi alla collina e poi sprofonda nelle sue viscere<br />
con una serie <strong>di</strong> passaggi scavati nel tufo. Le integrazioni che la struttura originaria aveva richiesto<br />
per funzionare ne facevano “più un episo<strong>di</strong>o urbanistico che architettonico”, per usare le parole <strong>di</strong><br />
Italo Moretti 36 : già evidente a metà del XV secolo se, quando Francesco Sforza si rivolse ai suoi<br />
ambasciatori <strong>di</strong> Siena e <strong>di</strong> Firenze per avere notizie sugli ospedali <strong>di</strong> quelle città "a similitu<strong>di</strong>ne de'<br />
quali" voleva l'ospedale maggiore <strong>di</strong> Milano, Nicodemo Tranche<strong>di</strong>ni, da Siena, gli rispose<br />
mostrandosi perplesso <strong>di</strong> questa richiesta perché l'architettura dell'e<strong>di</strong>ficio “situato in monte” non<br />
era riproducibile “in paese piano” e aveva una pianta “che non dessegneria Giotto se vivesse”. Il<br />
ripido pen<strong>di</strong>o naturale sul quale era stato costruito e le <strong>di</strong>fferenti attività d’assistenza che si erano<br />
svolte al suo interno, insomma, avevano determinato un <strong>di</strong>segno che, nella sua unicità, non era<br />
34 Fornisco un’anteprima in G. PICCINNI, L’ospedale e il mondo del denaro: le copertine <strong>di</strong>pinte come specchio<br />
dell’impresa, in Arte e assistenza a Siena. Le copertine <strong>di</strong>pinte dell’Ospedale <strong>di</strong> Santa Maria della Scala, cura <strong>di</strong><br />
Gabriella Piccinni e Carla Zarrilli, Pisa, Pacini, 2003, pp. 17-27.<br />
35 La bibliografia sull’ospedale senese <strong>di</strong> Santa Maria della Scala curata da Beatrice Sor<strong>di</strong>ni è consultabile on-line nella<br />
pagina web del <strong>Dipartimento</strong> <strong>di</strong> <strong>Storia</strong> dell’Università <strong>di</strong> Siena (www.storia.unisi.it) nella quale sono reperibili anche<br />
altri materiali documentari relativi all’ospedale.<br />
36 MORETTI, Siena cit.<br />
12
esportabile. Anche oggi la fabbrica si presenta ai nostri occhi con la faccia dell’estrema complessità<br />
che nel 1452 aveva sgomentato il Tranche<strong>di</strong>ni facendogli invocare l’aiuto del talento <strong>di</strong> Giotto.<br />
Sulla facciata dell’ospedale, nel 1335 Pietro e Ambrogio Lorenzetti e Simone Martini<br />
affrescavano le quattro storie della Vergine, poi andate perdute: un ciclo esemplare, come lo ha<br />
definito Luciano Bellosi riferendosi "alla immensa fortuna <strong>di</strong> cui questi affreschi godettero come<br />
esempi e modelli per i pittori successivi ogni volta che si trovarono a trattare soggetti come quelli<br />
raffigurati sulla facciata dello Spedale; così questa decorazione, più <strong>di</strong> ogni altra impresa artistica<br />
citta<strong>di</strong>na, <strong>di</strong>ventò per molte generazioni il simbolo della grandezza solo imitabile e non più<br />
raggiungibile della pittura senese della prima metà del Trecento" 37 .<br />
Anche l’Opera <strong>di</strong> Santa Maria, nata per accompagnare la manutenzione della fabbrica del<br />
Duomo gestendo il continuo cantiere delle sue trasformazioni, <strong>di</strong>venne nel corso del XIII secolo<br />
un’istituzione civica, coinvolta nelle gran<strong>di</strong> opere dell’e<strong>di</strong>lizia citta<strong>di</strong>na, controllata nel personale e<br />
finanziata dal Comune. La fisionomia complessiva dell’Opera, abbastanza sfumata nei primi<br />
decenni del Duecento, aveva cominciato a definirsi, ancora una volta, alla metà degli anni<br />
Cinquanta, raggiungendo in un breve periodo un più compiuto assetto istituzionale. Uno dei suoi<br />
Operai più intraprendenti, il converso dell’abbazia cistercense <strong>di</strong> S. Galgano, frate Melano, ricoprì<br />
l’incarico <strong>di</strong> Operaio dalla vigilia <strong>di</strong> Montaperti al 1275, mentre altri cistercensi – considerati e<br />
utilizzati ovunque come esperti sia sul piano tecnico che su quello amministrativo - ricoprivano<br />
incarichi non meno rilevanti come camerlenghi della magistratura comunale <strong>di</strong> Biccherna. Si<br />
trattava <strong>di</strong> un personaggio <strong>di</strong> rilievo nel vita citta<strong>di</strong>na, legato strettamente ad ambienti ghibellini,<br />
che pare avesse un ruolo anche nella pacificazione che seguì la transizione dal ghibellinismo al<br />
guelfismo.<br />
Gli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Andrea Giorgi e Stefano Moscadelli hanno ormai chiarito che alcune rubriche<br />
della celebre compilazione statutaria della città del 1262, che assorbì la legislazione precedente,<br />
testimoniano <strong>di</strong> una fase in cui il Comune si assicurò una <strong>di</strong>retta responsabilità <strong>di</strong> controllo su ogni<br />
iniziativa in merito alla costruzione della fabbrica, con un forte intervento pubblico nella scelta<br />
dell’operaio 38 . Si tratta significativamente degli stessi anni in cui fu concepito il completamento<br />
della porzione orientale della cattedrale, iniziata intono al 1260. Pochi anni dopo, intorno al 1296-<br />
37 L. BELLOSI, Il terzo polo artistico <strong>di</strong> Siena, in Spedale <strong>di</strong> Santa Maria della Scala, Atti del Convegno<br />
internazionale <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong> del novembre 1986, Siena, 1988., pp. 35-36, che ricorda come ancora nel 1451,<br />
quando si commissionò a Sano <strong>di</strong> Pietro la tavola per la Cappella del Palazzo Pubblico, si prescrivesse che le storie<br />
della Vergine della predella fossero "come sono quelle della faccia dello Spedale".<br />
38 La bibliografia più aggiornata sull’Opera <strong>di</strong> Santa Maria: L’Archivio dell’Opera metropolitana <strong>di</strong> Siena. Inventario, a<br />
cura <strong>di</strong> Stefano Moscadelli, München, Bruckmann, 1995; A. GIORGI, S. MOSCADELLI, Quod omnes cerei ad opus<br />
deveniant. Il finanziamento dell’opera del Duomo <strong>di</strong> Siena nei secoli XIII e XIV, “Nuova Rivista Storica”, LXXXV,<br />
(2001), pp. 489-584; A. GIORGI, S. MOSCADELLI, L’Opera <strong>di</strong> S. Maria <strong>di</strong> Siena tra XII e XIII secolo, in Chiesa e vita<br />
religiosa a Siena cit., pp. 77-100.<br />
13
97, il nuovo regime dei Nove pose rime<strong>di</strong>o ad una situazione che appariva <strong>di</strong>sastrosa sia<br />
nell’amministrazione dell’Opera che nella gestione dello stesso cantiere della cattedrale e l’Operaio<br />
venne nominato <strong>di</strong>rettamente dal governo e dai Consoli della mercanzia. Nel 1274 lo statuto del<br />
comune guelfo garantì e regolò la principale forma d’autonomo finanziamento dell’Opera, costituita<br />
dall’annuale offerta <strong>di</strong> cera.<br />
5. Gli anni del governo dei Nove, splendori e memorie<br />
Si sarà già compreso che gli anni del governo dei Nove, nei quali visse e operò Duccio, sono<br />
considerati per tra<strong>di</strong>zione storiografica l’età d’oro senese. Per la maggior parte <strong>di</strong> quei settanta anni<br />
<strong>di</strong> governo, la città fu amministrata in modo stabile e, tutto sommato, in pace. “La città – scrive il<br />
cronista - stava in grande pace e tranquillità, e ognuno attendeva ai suoi guadagni e così il contado,<br />
e tutti s’amavano come fratelli” 39 . E’ certo che si trattò <strong>di</strong> una stagione <strong>di</strong> sogni <strong>di</strong> grandezza, anche<br />
se <strong>di</strong>versi da quelli attuati nella precedente, che, come scrive Franco Car<strong>di</strong>ni, “parvero <strong>di</strong> volta in<br />
volta realizzarsi nell’ar<strong>di</strong>ta architettura della torre del Mangia, nella conchiglia mattonata del<br />
campus fori, nella fortunata sequenza <strong>di</strong> sottomissioni dei castelli del contado” 40 . Alcune gran<strong>di</strong><br />
opere pubbliche furono, infatti, concepite nel giro <strong>di</strong> pochi anni, tra la fine del Duecento e il primo<br />
quarto circa del secolo successivo, anche se non tutte furono portate a termine in quel periodo, e<br />
anzi alcune <strong>di</strong> esse furono in seguito mo<strong>di</strong>ficate nei programmi realizzativi o ad<strong>di</strong>rittura<br />
abbandonate.<br />
E’ senza dubbio in<strong>di</strong>cativo che proprio nei primi anni <strong>di</strong> attività del regime dei Nove si<br />
avviassero i lavori per la costruzione del nuovo grande palazzo pubblico affacciato sulla conca del<br />
Campo. Il lavoro venne portato avanti dal 1298 a ritmi serrati e nel 1310 il governo si installò nel<br />
nuovo e<strong>di</strong>ficio. Da allora il palazzo, nel quale vennero co<strong>di</strong>ficati tutti gli stilemi dell’architettura<br />
me<strong>di</strong>evale senese 41 , venne anche proposto come consapevole modello e<strong>di</strong>lizio, dal momento che si<br />
stabilì per statuto che da allora tutte le finestre degli e<strong>di</strong>fici affacciati sulla piazza “si debiano fare a<br />
colonnelli” 42 . Nel 1325, in occasione <strong>di</strong> una nuova fase <strong>di</strong> lavori, fu posta la pietra angolare della<br />
torre del Mangia, “e l’operaio del duomo misse in fondo <strong>di</strong> detta tore alquante monete per memoria<br />
<strong>di</strong> detta tore, e fuvvi messo in ogni canto <strong>di</strong> detta tore nel fondo una pietra con lettare greche,<br />
ebraiche e latine, perché non fusse percossa da tuono né da tempesta” 43 .<br />
Il desiderio, e forse anche la necessità, <strong>di</strong> organizzare il consenso intorno ad un’esperienza<br />
<strong>di</strong> governo interamente popolare e guelfo nato in mo<strong>di</strong> e anni tormentati da un governo ghibellino e<br />
39 AGNOLO <strong>DI</strong> TURA DEL GRASSO, Cronaca senese cit.<br />
40 CAR<strong>DI</strong>NI, L’argento e i sogni cit.<br />
41 GABBRIELLI, Stilemi senesi cit., p. 326<br />
42 Il Costituto del Comune <strong>di</strong> Siena volgarizzato vol. II p. 29.<br />
43 AGNOLO <strong>DI</strong> TURA DEL GRASSO, Cronaca senese, in Cronache senesi cit., p. 428.<br />
14
“misto” tra popolari e magnati, produsse, insomma, oltre a continui sforzi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione politica,<br />
programmi gran<strong>di</strong>osi d’abbellimento del tessuto urbano, come la sistemazione della piazza<br />
principale del Campo o il nuovo acquedotto o il palazzo pubblico o la costruzione del nuovo<br />
battistero o gli ampliamenti del duomo (compresi gli ultimi, progettati uno nel 1316 e l’altro, più<br />
imponente, suggerito da Lorenzo Maitani nel 1322, attuato dal 1339 e poi abbandonato dopo la<br />
peste del 1348 44 ), e le commesse pubbliche <strong>di</strong> autentici splendori artistici: basti citare per tutti, nel<br />
palazzo sul Campo, almeno la Maestà <strong>di</strong> Simone Martini nella sala delle Balestre (1316) e gli<br />
affreschi del Buono e cattivo governo <strong>di</strong> Ambrogio Lorenzetti nella sala <strong>di</strong> riunione del governo<br />
stesso (1338), tra quelli in cui è lampante l’intento <strong>di</strong> tramandare un’immagine idealizzata <strong>di</strong> sé. Gli<br />
sforzi dei committenti e degli artisti sembrano in<strong>di</strong>rizzarsi verso imprese a carattere pubblico, e<br />
certo proprio in questa sede non è necessario ricordare ulteriormente che fu il Comune a<br />
commissionare a Duccio, nel 1287, la grande vetrata circolare (la “finestra rotonda magna”) che sta<br />
in alto, nella parete terminale del coro, e nel 1308 la stupenda Maestà che nel 1311 venne collocata<br />
sull’altare maggiore del Duomo. “Nessun tipo <strong>di</strong> affetto o <strong>di</strong> passione sembra soverchiare, nei<br />
senesi, quelli per la loro città” 45 e questo ha fatto parlare <strong>di</strong> un “mecenatismo pubblico” proprio <strong>di</strong><br />
Siena, contrapposto al più usuale “mecenatismo privato” fiorentino.<br />
Duccio ebbe certo negli occhi, fin dall’infanzia e ancor più nella sua giovinezza,<br />
quest’esplosione <strong>di</strong> gran<strong>di</strong>osità nei cantieri degli e<strong>di</strong>fici pubblici e nell’attività e<strong>di</strong>lizia che plasmava<br />
il <strong>di</strong>segno urbano, e che può aver rappresentato per la sua sensibilità artistica qualcosa <strong>di</strong> più <strong>di</strong> uno<br />
spazio in cui trovare occasioni <strong>di</strong> lavoro.<br />
Le enormi somme <strong>di</strong> denaro accumulate dai mercanti-banchieri duecenteschi erano state,<br />
dunque, reinvestite anche sulla città, permettendo la costruzione non soltanto <strong>di</strong> palazzi privati, ma<br />
soprattutto <strong>di</strong> quei gran<strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici pubblici laici e religiosi, <strong>di</strong> quelle fonti, <strong>di</strong> quelle piazze che hanno<br />
segnato per sempre il volto urbano <strong>di</strong> Siena e ne hanno fatto un patrimonio prezioso dell’umanità.<br />
Ma ci fu anche altro, in quegli anni <strong>di</strong> trasformazione. Come accadeva a parte del loro denaro,<br />
anche l’esperienza <strong>di</strong> gestione delle imprese era stata riciclata nel pubblico, dove i mercanti “de la<br />
mezza gente” dettero vita a sperimentazioni nuove e ar<strong>di</strong>te <strong>di</strong> amministrazione, come la<br />
magistratura dei Viarii che si dette nel 1290 uno statuto <strong>di</strong> ben 260 provvisioni, consegnandoci la<br />
chiave per comprendere il funzionamento <strong>di</strong> un intero e importante settore amministrativo 46 ; o,<br />
ancora, come lo statuto citta<strong>di</strong>no, volgarizzato in uno stupendo italiano nel 1309-10, e scritto in<br />
“lettera grossa”, cioè in caratteri calligrafici gran<strong>di</strong> e, come fa notare Mario Ascheri, anche con<br />
44<br />
Per le notizie sul Duomo rimando per tutti a E. CARLI, Il Duomo <strong>di</strong> Siena, Siena, Monte dei Paschi <strong>di</strong> Siena, 1979.<br />
45<br />
CAR<strong>DI</strong>NI, L’argento e i sogni cit., p. 300.<br />
46<br />
Viabilità e legislazione <strong>di</strong> uno statuto citta<strong>di</strong>no del duecento. Lo statuto dei Viari <strong>di</strong> Siena, a cura <strong>di</strong> D. Ciampoli e T.<br />
Szabò, Siena, 1992.<br />
15
pochissimi segni abbreviativi perché potesse essere letto anche dalle “povare persone et altre<br />
persone che non sanno grammatica” 47 ; o, infine, come la Tavola delle possessioni, precocissimo<br />
catasto nel quale nel 1316-1320 furono descritti i beni immobili esistenti in città e in 295 comuni<br />
del territorio 48 , un'operazione gigantesca considerando l'epoca, scelta <strong>di</strong> razionalità, come ha scritto<br />
Giovanni Cherubini 49 , primo tentativo organico <strong>di</strong> un Comune italiano <strong>di</strong> descrivere e valutare tutti i<br />
beni all’interno <strong>di</strong> una città e del suo territorio, utilizzando dei mensuratores professionisti anziché<br />
poggiare sulle auto-<strong>di</strong>chiarazioni dei singoli proprietari.<br />
Le prime crepe del lungo regime politico novesco si videro, tuttavia, già nei primi decenni<br />
del Trecento, quando il governo fu messo in pericolo più volte da congiure <strong>di</strong> nobili e popolani,<br />
come nel 1318 e nel 1328 quando si coagulò lo scontento <strong>di</strong> alcuni magnati, <strong>di</strong> gruppi <strong>di</strong> carnaioli<br />
(grossisti <strong>di</strong> bestiame scontenti della politica <strong>di</strong> rigore novesca sui pesi, sui prezzi e sulla qualità) e<br />
<strong>di</strong> notai e giu<strong>di</strong>ci (per le parcelle tenute basse). Ci furono in quegli anni anche dure carestie, delle<br />
quali sono ampie testimonianze nelle cronache, e basti ricordare, per tutte, la drammatica sommossa<br />
scoppiata in occasione della grande carestia del 1329, quando – ricorda il cronista Agnolo <strong>di</strong> Tura -<br />
“i Signori e i citta<strong>di</strong>ni ebero gran paura che Siena non fusse messa a sacco dai povari 50 ”. Quando,<br />
nel 1338-39, Ambrogio Lorenzetti riceverà la commessa per <strong>di</strong>pingere i suoi tre famosi affreschi nel<br />
palazzo pubblico, sui quali sono corsi fiumi d’inchiostro, il messaggio sarà tutto puntato sul buon<br />
governo, perché i governanti avranno bisogno <strong>di</strong> proporsi come i pala<strong>di</strong>ni del benessere e della<br />
sicurezza, ma soprattutto della concor<strong>di</strong>a civica, con messaggio che il gruppo <strong>di</strong>rigente rivolgeva<br />
prima <strong>di</strong> tutto a se stesso.<br />
La Siena conosciuta da Duccio, dunque, fu quella demograficamente più consistente,<br />
quando crescevano popolazione, chiese, palazzi e strade, quando la città <strong>di</strong>segnava il suo contado e<br />
la ricchezza più grande le proveniva ancora dagli affari dei suoi banchieri, quando l’orizzonte<br />
economico era ancora internazionale, quando la memoria della grandezza che solo allora accennava<br />
47 M. ASCHERI, La Siena del ‘Buon Governo’ (1287-1355), in Politica e cultura nelle repubbliche italiane dal me<strong>di</strong>oevo<br />
all’età moderna, a cura <strong>di</strong> Simonetta Adorni Braccasi e Mario Ascheri, Roma 2001, pp. 81-107, alle pp. 84-85<br />
48 Una deliberazione del Consiglio generale del 19 ottobre 1317 progetta la Tavola delle Possessioni come “tabula<br />
possessionum civitatis, comitatus et iuris<strong>di</strong>ctionis Senarum et mobilium et patrimonium personarum civitatis, comitatus<br />
et iuris<strong>di</strong>ctionis Senarum” [Archivio <strong>di</strong> Stato <strong>di</strong> Siena, Consiglio Generale, 89, c. 158v]: essa avrebbe dovuto dunque<br />
comprendente tutti i beni mobili e immobili della città e del territorio, ma in realtà i beni mobili rimasero esclusi dal<br />
lavoro <strong>di</strong> rilevazione. I dati raccolti furono registrati in oltre cinquecento registri che costituirono il materiale<br />
preparatorio per la Tavola vera e propria. Le particelle furono descritte con precisione una per una, dando per ciascuna<br />
il nome del proprietario con il luogo <strong>di</strong> residenza, una descrizione sommaria, i nomi dei proprietari confinanti, la misura<br />
in staiori e tavole e la stima. Le informazioni contenute in queste tavolette preparatorie furono copiate in altri registri<br />
secondo criteri topografici, raggruppando sotto il nome <strong>di</strong> ogni singolo proprietario tutti i suoi beni immobili in città e<br />
nel contado. Il valore della fonte fu per la prima volta messo in luce da L. BANCHI, La lira, la tavola delle Possessioni e<br />
le preste della Repubblica <strong>di</strong> Siena, “Archivio Storico Italiano”, s. III, t. VII (1868), parte II, pp. 53-58. Il primo<br />
importante lavoro <strong>di</strong> elaborazione <strong>di</strong> dati condotto sulla Tavola è stato quello coor<strong>di</strong>nato da Giovanni Cherubini i cui<br />
risultati sono stati restituiti in G. CHERUBINI, Proprietari, conta<strong>di</strong>ni e campagne senesi all'inizio del Trecento, in<br />
IDEM, Signori, conta<strong>di</strong>ni, borghesi. Ricerche sulla società italiana del basso me<strong>di</strong>oevo, Firenze 1974, pp. 230-311.<br />
49 CHERUBINI, I mercanti e il potere cit., p. 187<br />
16
a trascorrere poteva ancora essere orgogliosamente lanciata verso i posteri nel magnifico testo della<br />
petizione che il 9 agosto 1298 un gruppo dei soci Buonsignori in<strong>di</strong>rizzò al governo per invocare<br />
provve<strong>di</strong>menti pubblici in grado <strong>di</strong> salvare la compagnia: ricordatevi sempre, <strong>di</strong>ssero, che tra le altre<br />
società <strong>di</strong> Toscana e Lombar<strong>di</strong>a e <strong>di</strong> tutto il mondo la nostra è stata la più onorevole e nota, quella<br />
alla quale è stata data maggior fiducia dai pontefici, dai car<strong>di</strong>nali, dai patriarchi, dagli arcivescovi,<br />
dai vescovi e dai prelati, dai re, dai baroni, dai conti, dai mercanti e da tutti gli uomini, <strong>di</strong> qualunque<br />
con<strong>di</strong>zione siano stati 51 .<br />
I seguaci <strong>di</strong> Duccio già avrebbero conosciuto il cambiamento. Ma le trasformazioni, se<br />
allontanavano dallo scacchiere internazionale e avvicinavano alla terra, portavano anche verso la<br />
finanza pubblica, verso l’assistenza pubblica, alle gran<strong>di</strong> opere pubbliche, alla grande committenza<br />
artistica pubblica: tutti ‘luoghi’ dove non mancò neanche il coraggio <strong>di</strong> alcune ar<strong>di</strong>te<br />
sperimentazioni, tanto che resta in ogni caso arduo liquidare quella nuova stagione con parole nette<br />
come “involuzione” o “restringimento” o “decadenza” o “ ripiegamento”.<br />
Tutt’oggi la banca pubblica, la campagna e l’arte, con il loro indotto <strong>di</strong> attività produttive,<br />
rappresentano la forza economica e i motivi centrali della tenuta del tessuto sociale della città <strong>di</strong><br />
Siena e del suo territorio.<br />
50 AGNOLO <strong>DI</strong> TURA DEL GRASSO, Cronaca senese cit., p. 485.<br />
51 “Et ideo, licet credant vos scire, tamen ad memoriam vobis reducunt quod inter alias sotietates Tuscie, Lombar<strong>di</strong>e, ac<br />
etiam totius mun<strong>di</strong>, ipsa fuit honorabilior omnibus aliis et magis nominata, et cui maior fides fuit adhibita a romanis<br />
pontificibus, a car<strong>di</strong>nalibus, patriarchis, archiepiscopis, episcopis et aliis ecclesiarum prelatis, a regibus, baronibus,<br />
comitibus, mercatoribus et aliis hominibus cuiuscumque con<strong>di</strong>tionis sint; etiam utilis, immo utilissima, Comuni<br />
Senarum in romana Curia, ultra montes et citra montes, et ambassiatoribus Comunis Senarum ad expe<strong>di</strong>tionem<br />
negotiorum pro quibus mictebantur, et etiam pro solutione pecunie tam pro ipsis negotiis expe<strong>di</strong>en<strong>di</strong>s quam pro eorum<br />
expensis”: SAPORI, Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> storia economica cit., pp. 788 e 796.<br />
17