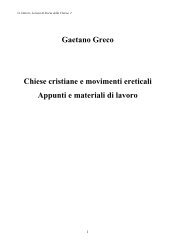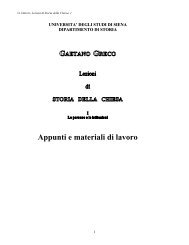Le famiglie nobili senesi fra Settecento e Ottocento* Questo paper ...
Le famiglie nobili senesi fra Settecento e Ottocento* Questo paper ...
Le famiglie nobili senesi fra Settecento e Ottocento* Questo paper ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
TOMMASO DETTI - CARLO PAZZAGLI<br />
<strong>Le</strong> <strong>famiglie</strong> <strong>nobili</strong> <strong>senesi</strong> <strong>fra</strong> <strong>Settecento</strong> e Ottocento *<br />
[«Bollettino di demografia storica», 1994, n. 21, pp. 45-64.<br />
Ringraziamo la SIDeS per averci consentito di riprodurlo]<br />
<strong>Questo</strong> <strong>paper</strong> rende conto dei primi, provvisori risultati di una ricerca in<br />
corso sulla nobiltà senese <strong>fra</strong> la metà del <strong>Settecento</strong> e la metà dell'Ottocento: il<br />
secolo, cioè, durante il quale il ceto dominante dell'età moderna subì come<br />
forse nessun'altra componente della società di ancien régime l'impatto della<br />
contemporaneità. Ormai acquisita a livello europeo, tale periodizzazione calza<br />
particolarmente bene alla Toscana, dove proprio nel 1750 una legge organica<br />
emanata dal sovrano fece ordine per la prima volta nella materia. Con essa la<br />
«nobiltà civile» subì un processo di omologazione a quelle dell'Europa delle<br />
monarchie, perdendo la propria plurisecolare autonomia ma ottenendo in<br />
cambio un formale e conclusivo riconoscimento.<br />
L'applicazione di questa legge ha prodotto una ricca serie di fonti, che<br />
consente un censimento nominativo pressoché completo dei <strong>nobili</strong> toscani e<br />
fornisce informazioni sufficienti ad aggiornare nel tempo i dati sulle <strong>famiglie</strong>,<br />
anche se non sempre sui loro singoli membri. La chiave di volta di tale<br />
documentazione è costituita com'è noto dai Libri d'oro della nobiltà e dalle<br />
carte dei processi di <strong>nobili</strong>tazione. Una biografia collettiva di questo ceto esige<br />
tuttavia il ricorso ad altre fonti locali che colmino le accertate lacune degli atti<br />
della Deputazione sopra la nobiltà e li integrino in senso diacronico.<br />
Per Siena ci siamo serviti dell'elenco dei matrimoni celebrati in città dai<br />
membri delle <strong>famiglie</strong> <strong>nobili</strong> tra il 1738 e il 1817 e del registro dei battesimi<br />
delle stesse <strong>famiglie</strong> dal 1738 agli anni '30 dell'Ottocento, conservati<br />
nell'Archivio di Stato di Siena. Abbiamo inoltre utilizzato gli almanacchi<br />
ufficiali e i ruoli dei funzionari pubblici e degli istituti cittadini, i campioni del<br />
catasto leopoldino, l'Indice dei possidenti della Toscana tratto nel 1836 dal catasto<br />
medesimo, il censimento della popolazione del 1841 e il coevo registro delle<br />
tasse di residenza custodito nell'Archivio del Comune. Oltre alle note<br />
genealogie delle carte Ceramelli Papiani e Sebregondi dell'Archivio di Stato di<br />
Firenze, di notevole utilità sono infine risultati alcuni elenchi delle <strong>famiglie</strong><br />
<strong>nobili</strong> conservati all'Archivio di Stato di Siena e nel fondo Pecci della<br />
Biblioteca Riccardiana di Firenze.<br />
Punto di partenza dell'indagine sono dunque le <strong>famiglie</strong> <strong>nobili</strong> riconosciute<br />
dalla Deputazione nelle sedute del 1753-54 dedicate a Siena, che nella Tab. I<br />
vengono suddivise tra patrizie e <strong>nobili</strong> secondo il disposto della legge, nonché<br />
per numero di casati e di rami. Intendiamo per rami le linee genealogiche<br />
corrispondenti alle singole domande di <strong>nobili</strong>tazione presentate, per casati<br />
l'insieme dei rami che portano lo stesso cognome. La Tab. II, che contiene i
dati delle <strong>famiglie</strong> riconosciute dopo il 1754, aggiorna la precedente fino alla<br />
metà dell'Ottocento.<br />
TAB. I – CASATI E RAMI PATRIZI E NOBILI RICONOSCIUTI NEL 1753-54<br />
Casati % Rami % Rami / Casato<br />
Patrizi 103 76,3 184 83,3 1,79<br />
Nobili 32 23,7 37 16,7 1,16<br />
Totale 135 100,0 221 100,0 1,64<br />
TAB. II – CASATI E RAMI PATRIZI E NOBILI RICONOSCIUTI DAL 1755 AL 1850<br />
Casati % Rami % Rami / Casato<br />
Patrizi 21 38,9 24 42,1 1,14<br />
Nobili 33 61,1 33 57,9 1,00<br />
Totale 54 100,0 57 100,0 1,06<br />
Il primo dato da sottolineare è costituito dall'alto numero dei rami, tanto<br />
più che è ragionevole presumere che questi si suddividessero a loro volta in un<br />
numero più elevato di aggregati familiari. Anche se in realtà alcuni <strong>nobili</strong><br />
<strong>senesi</strong> non risiedevano a Siena, vedremo che non saremmo lontani dal vero<br />
stimando 900 <strong>nobili</strong> in una popolazione di circa 15.000 persone. Si tratta di<br />
una percentuale incomparabilmente più alta di quelle rilevate in altre città più<br />
grandi (Firenze, Venezia) e in altri paesi (Mayer), che si ritrova invece in centri<br />
urbani medio-piccoli. A Volterra, ad esempio, il fenomeno ha dato luogo<br />
all'ipotesi di una relazione inversa tra le dimensioni della città e il numero dei<br />
<strong>nobili</strong> «civili», mantenutosi elevato per garantire lo stesso governo cittadino; si<br />
è inoltre ritenuto che questo ceto risulti sovradimensionato perché le sue<br />
radici si collocano in una fase di forte espansione urbana. In seguito la sua<br />
tenuta - grazie anche all'appropriazione del contado - sarebbe stata più alta di<br />
quella della città nel suo insieme.<br />
A Siena come altrove si nota inoltre un'assoluta prevalenza delle <strong>famiglie</strong><br />
patrizie (cioè con più di 200 anni di appartenenza ai primi onori cittadini), che<br />
alla prima applicazione della legge coprono oltre tre quarti dei casati. Si tratta<br />
di <strong>famiglie</strong> la cui «antichità» risale molto spesso ben al di là dei due secoli<br />
previsti dalla legge, affondando le loro radici tra il XII e il XV secolo. Che nel<br />
caso dei rami il rapporto salga addirittura sopra i quattro quinti testimonia del<br />
fatto che - come nella Firenze studiata da Boutier - i casati più antichi e<br />
ramificati hanno opposto maggiore resistenza all'usura del tempo (Baker,<br />
Marrara). Inutile soffermarsi sull'importanza di tale dato, che conferma una<br />
continuità particolarmente forte con l'antico ceto dirigente cittadino e<br />
repubblicano di origine medievale, segnalando una chiusura verso l'esterno<br />
che è funzione della lunga durata di questo gruppo. Nella scarsa consistenza
della nobiltà più recente si riflette a sua volta un meccanismo di cooptazione<br />
ridotto al minimo fisiologico necessario alla sopravvivenza. Un fenomeno,<br />
questo, destinato a prolungarsi anche nel secolo successivo, come prova il<br />
basso numero di <strong>nobili</strong>tazioni della Tab. II, sebbene nel 1838 venisse fatta<br />
anche a Siena un'infornata senza precedenti di 16 uomini nuovi. La Tab. III,<br />
aggiornata in base all'elenco ufficiale del 1904, mostra quanto in realtà fosse<br />
rischioso persistere in strategie familiari patrilineari: per rimanere al nucleo<br />
forte dei rami patrizi, nel corso di un secolo essi risultano quasi dimezzati, per<br />
assottigliarsi ancora di più nel cinquantennio successivo.<br />
TAB. III – RAMI NOBILI NEL 1753-54, 1850 E 1904<br />
Rami <strong>nobili</strong> 1753-54 1850 % 1904 %<br />
Patrizi 184 98 53,3 57 31,0<br />
Nobili 37 47 127,0 30 81,1<br />
Totale 221 145 65,6 87 39,4<br />
Una piena conferma a queste indicazioni proviene dall'andamento dei<br />
matrimoni: i 596 dei quali attingendo a tutte le fonti disponibili abbiamo<br />
potuto individuare la data per ciò che riguarda i maschi patrizi e <strong>nobili</strong>, antichi<br />
e recenti, si distribuiscono con tale regolarità lungo un secolo e mezzo, da non<br />
lasciare dubbi sul fatto che i comportamenti di questo ceto continuassero<br />
sempre ad obbedire a quelle stesse logiche che non a caso ne provocarono il<br />
crescente declino demografico. Non stupisce dunque che dalla scena cittadina<br />
non cessassero di scomparire i nomi di grandi <strong>famiglie</strong>. Ai Pecci e ai Petrucci,<br />
ad esempio, si aggiunsero nel corso dell'Ottocento i Bichi Ruspoli, i Finetti, i<br />
Sansedoni, gli Spannocchi e i Saracini.<br />
TAB. IV – MATRIMONI DEI MASCHI NOBILI SENESI DAL 1700 AL 1841<br />
Periodi Matrimoni Periodi Matrimoni<br />
1700-1720 78 1780-1800 88<br />
1720-1740 80 1800-1820 82<br />
1740-1760 89 1820-1840 90<br />
1760-1780 89 Totale 596<br />
Per ricostruire più in dettaglio la fisionomia di questo universo abbiamo<br />
integrato e corretto le notizie notoriamente lacunose dei Libri d'oro (Boutier)<br />
con i già citati elenchi dei matrimoni e dei battesimi dei <strong>nobili</strong>, effettuando una<br />
ricostruzione delle <strong>famiglie</strong> sul modello di quella classica di Henry e Fleury. Si<br />
tratta di una ricostruzione per molti versi incompleta sia perché le sfugge una<br />
parte dei battesimi e dei matrimoni celebrati fuori Siena, sia soprattutto per
l'assenza di notizie sistematiche sulla mortalità, ma tuttavia sufficiente a far<br />
emergere alcuni dati di notevole interesse.<br />
<strong>Le</strong> <strong>famiglie</strong> così ricostruite per il 1738-1817 sono 403, ma nella Tab. V<br />
abbiamo calcolato l'età media al primo matrimonio soltanto sulle 196 donne e<br />
sui 122 uomini di cui conosciamo entrambe le date necessarie. Per l'intero<br />
periodo questo dato non si discosta nella sostanza da quelli già noti di altre<br />
aristocrazie europee ed italiane, confermando la presenza di una notevole<br />
uniformità di comportamenti. Anche la forte differenza di età tra i sessi, che si<br />
aggira intorno ai 10 anni, rientra in una norma che può giungere fino ai casi<br />
limite di Firenze (Lichtfield) e di Volterra (entrambi attorno ai 14 anni). Per<br />
ciò che riguarda il mutare dei dati nel tempo, premesso che le cifre assolute<br />
dei primi decenni, anche accorpate, sono davvero troppo esigue per fornire<br />
indicazioni appena attendibili, sembra profilarsi una contenuta tendenza ad<br />
abbassare l'età al matrimonio dei maschi, con qualche analogia con quanto<br />
rilevato ad esempio da Zanetti per il patriziato milanese.<br />
TAB. V – ETÀ MEDIA AL PRIMO MATRIMONIO, PER DECENNI, DAL 1738 AL 1817<br />
Decenni<br />
Maschi<br />
Media Casi<br />
Femmine<br />
Media Casi<br />
Differenza<br />
1738-1767 33,2 5 20,7 14 12,5<br />
1768-1777 28,4 12 20,5 28 7,9<br />
1778-1787 34,2 14 23,3 30 10,9<br />
1788-1797 32,1 34 22,5 43 9,6<br />
1798-1807 31,6 33 21,4 39 10,2<br />
1808-1817 29,2 24 20,5 42 8,7<br />
Totale 31,3 122 21,6 196 9,7<br />
Nessuna particolare sorpresa, infine, neppure per quanto riguarda le<br />
seconde nozze, che sono 19 per i maschi e 7 per le femmine. Anche a Siena la<br />
consuetudine prevede che le vedove rimangano nella casa coniugale, e a<br />
risposarsi sono soltanto alcune delle più giovani o delle più ricche. Non a caso<br />
tre su sette sono proprietarie di beni fondiari e le altre - prima <strong>fra</strong> tutte la<br />
principessa Maria Alessandra Corsini, che sposa in seconde nozze Alessandro<br />
Bindi Sergardi - godono di doti cospicue.<br />
Tenuto conto dell'isolamento che caratterizza <strong>fra</strong> Sette e Ottocento la<br />
decaduta società senese, appaiono di particolare interesse le notizie che queste<br />
fonti possono darci sulle politiche matrimoniali. La Tab. VI mostra come<br />
quasi il 60% dei matrimoni fosse contratto <strong>fra</strong> <strong>nobili</strong> <strong>senesi</strong>. Per quanto<br />
riguarda gli scambi, questi dati suggeriscono l'ipotesi (verificata per Volterra e<br />
in corso di verifica anche per Pescia e Cortona) che la nobiltà «minore»,<br />
ovvero quella delle città più piccole, importasse donne dai patriziati<br />
«maggiori»: balza agli occhi, infatti, come soltanto da Firenze prendessero la
strada di Siena più gentildonne che gentiluomini, mentre l'esatto contrario<br />
avveniva da tutti gli altri poli del mercato matrimoniale. Ciò indica che la<br />
nobiltà della seconda capitale del Granducato occupava un rango di rilievo<br />
ben al di là dei confini toscani, come prova anche il fatto che <strong>fra</strong> i partners delle<br />
nobildonne <strong>senesi</strong> andate spose in altri Stati si incontrano <strong>fra</strong> gli altri un<br />
Brignole Sale, un Carafa e uno Spinola.<br />
TAB. VI – MATRIMONI DAL 1738 AL 1817: ENDOGAMIA GEOGRAFICA<br />
Mariti N. i. Siena Firenze Tosc. Stato Altri Tot. Tot. %<br />
Mogli <br />
Pont.. Stati<br />
N. i. 2 25 1 1 1 1 31 7,7<br />
Siena 11 238 5 30 26 13 323 80,1<br />
Firenze - 13 - - - - 13 3,2<br />
Toscana 1 16 - 1 1 - 19 4,7<br />
St. Pont. - 8 - - 1 - 9 2,2<br />
Altri Stati - 7 - - 1 - 8 2,0<br />
Totale 14 307 6 32 30 14 403 100<br />
Tot. % 3,5 76,2 1,5 7,9 7,4 3,5 100<br />
Il dato più interessante della tabella è comunque costituito da una peculiare<br />
apertura verso lo Stato pontificio, dove le <strong>nobili</strong> <strong>senesi</strong> si accasavano in buon<br />
numero ad Orvieto come a Viterbo e a Città della Pieve. Un segno, questo,<br />
della minore rigidità dei confini sud orientali del Granducato e al tempo stesso<br />
un residuo dell'antica contrapposizione di Siena a Firenze, evidente anche nel<br />
ridotto incontro dei due gruppi dirigenti nel mercato dei matrimoni. Nel corso<br />
di tutta l'età moderna due sole grandi <strong>famiglie</strong> <strong>senesi</strong> - un ramo dei<br />
Pannocchieschi d'Elci e gli Amerighi - si trasferiscono a Firenze e non uno dei<br />
palazzi fiorentini porta un nome senese, mentre la Roma papale ospita rami<br />
titolati dei Patrizi e dei Chigi, dei Borghesi e dei Piccolomini.<br />
Che quello <strong>nobili</strong>are senese fosse un universo molto chiuso è ribadito dai<br />
livelli di quella che potremmo definire endogamia «sociale» o di status, illustrati<br />
nella Tab. VII limitatamente ai 238 matrimoni celebrati <strong>fra</strong> coniugi entrambi<br />
di Siena: non risulta infatti neppure uno strappo alla regola che vuole i <strong>nobili</strong><br />
sposati con altri <strong>nobili</strong>. Anche mettendo nel conto qualche lacuna della fonte,<br />
si tratta di dati che non sembrano ammettere replica. Occorre attendere gli<br />
anni '30 dell'Ottocento perché borghesi anche ricchi e potenti come Niccolò e<br />
Filippo Pozzesi, la cui famiglia si tramanda l'appalto delle poste, possano<br />
sposare una Bianchi Bandinelli e una Malavolti Ugurgeri. A loro volta i<br />
Griccioli, ex manifattori tessili, suggellano la propria ascesa sociale alla fine<br />
degli anni '20 imparentandosi ai Piccolomini e ottenendo la <strong>nobili</strong>tazione. Ciò<br />
non toglie che alcune eccezioni vi fossero, ma è significativo che la fonte le<br />
releghi tra i matrimoni con un solo coniuge senese. È il caso del nobile
Tommaso Cosatti, sposato a una donna che l'elenco non registra neppure con<br />
il nome, ma come «una orvietana di bassa estrazione». Si tratta com'è noto di<br />
casi sporadici, accolti con qualche pudore negli alberi genealogici della nobiltà<br />
di tutto il mondo.<br />
TAB. VII – MATRIMONI CELEBRATI DAL 1738 AL 1817<br />
FRA PARTNERS ENTRAMBI SENESI: ENDOGAMIA «SOCIALE»<br />
Mogli Mariti Patrizio Nobile Totale Tot. %<br />
Patrizia 203 14 217 91,2<br />
Nobile 19 2 21 8,8<br />
Totale 222 16 238 100,0<br />
Tot. % 93,3 6,7 100,0<br />
Anche sulla fecondità le nostre fonti possono darci informazioni di qualche<br />
interesse, benché sicuramente incomplete sia perché alcuni neonati delle<br />
<strong>famiglie</strong> <strong>nobili</strong> <strong>senesi</strong> non venivano battezzati in città, ma nelle loro ville di<br />
campagna, sia per l'assenza di notizie sistematiche sulla mortalità. Ciò<br />
premesso, nelle 307 <strong>famiglie</strong> su 403 il cui capofamiglia era un nobile senese<br />
risulta che nascessero 1.329 figli, 683 dei quali maschi e 646 femmine. Il tasso<br />
di mascolinità - pari a 105,7 - dimostra che una volta tanto anche le figlie,<br />
solitamente trascurate nei documenti ufficiali, sono state registrate. Il numero<br />
medio dei figli per famiglia nell'intero periodo è 4,3 (2,2 maschi e 2,1<br />
femmine), ma le <strong>famiglie</strong> feconde sono soltanto 257 - l'83,7% - e per esse la<br />
ci<strong>fra</strong> sale a 5,2 (2,7 maschi e 2,5 femmine). Occorre infine tener conto che<br />
dagli anni '20 dell'Ottocento il registro delle nascite non venne più aggiornato<br />
regolarmente, cosicché la discendenza delle ultime coorti di matrimoni è<br />
registrata solo parzialmente.<br />
Scomponendo questi dati per coorti decennali di matrimoni dei genitori,<br />
come abbiamo fatto nella Tab. VIII, emerge una media eccezionalmente<br />
elevata nella prima riga: tanto alta, anzi, da doversi ipotizzare l'influenza di<br />
fattori congiunturali, che non abbiamo ancora individuato. Prescindendo per<br />
adesso da tale dato ed escludendo i matrimoni del 1808-17 perché i loro figli<br />
sono sicuramente sottostimati, le medie delle diverse coorti oscillano con una<br />
certa regolarità attorno a quella generale. Ciò pone in evidenza una forte<br />
continuità dei comportamenti riproduttivi su valori inizialmente analoghi a<br />
quelli di altre realtà coeve, le quali tendono però a ridursi nel tempo.<br />
TAB. VIII – NUMERO MEDIO DEI FIGLI PER COORTI DECENNALI DI MATRIMONI<br />
DAL 1738 AL 1807<br />
Coorti Famiglie Numero figli Figli / famiglia feconda<br />
Tot. Fec. M F T M F T<br />
1738-1747 33 27 114 114 228 4,22 4,22 8,44
1748-1757 32 26 67 66 133 2,58 2,54 5,12<br />
1758-1767 35 30 63 72 135 2,10 2,40 4,50<br />
1768-1777 51 41 123 101 224 3,00 2,46 5,46<br />
1778-1787 35 30 78 63 141 2,60 2,10 4,70<br />
1788-1797 51 46 116 121 237 2,52 2,63 5,15<br />
1798-1807 39 31 67 73 140 2,16 2,35 4,51<br />
Totale 276 231 628 610 1238 2,66 2,51 5,17<br />
A sposarsi sono 366 figli su 1.329, di cui 226 femmine su 646 (35%) e 140<br />
maschi su 683 (20,5%). I primogeniti sono 257, 94 dei quali si sposano (55<br />
femmine su 131, pari al 42% e 39 maschi su 126, pari al 31%). Dato che non<br />
sappiamo quanti di loro morissero prima dell'età adulta, tali percentuali non<br />
possono darci una misura esatta del celibato e del nubilato, che pure sappiamo<br />
non essere diminuiti, ma indicano come anche in questo periodo storico<br />
continuassero a sposarsi in numero molto maggiore i primogeniti.<br />
Per quanto riguarda la fecondità ci siamo riferiti soltanto alle 113 <strong>famiglie</strong><br />
feconde e residenti a Siena per le quali disponiamo di dati abbastanza completi<br />
e ai loro 473 figli. L'intervallo protogenesico risulta di 1,52 anni, quello<br />
intergenesico medio dei figli minori di 2,03. Rinviando all'Appendice per<br />
un'analisi più dettagliata dei tassi di fecondità matrimoniale, un primo dato<br />
significativo è posto in evidenza dalla Tab. IX, che mostra come la lunghezza<br />
del periodo riproduttivo di queste <strong>famiglie</strong> fosse particolarmente breve per<br />
tutte le coorti di matrimoni dal 1758 al 1807. Vero è che non sappiamo quante<br />
coppie venissero precocemente sciolte dalla morte e che occorre tener conto<br />
di una subfecondità crescente con il numero dei parti, ma ciò nonostante<br />
questi dati suggeriscono l'ipotesi che le <strong>famiglie</strong> <strong>nobili</strong> <strong>senesi</strong> praticassero una<br />
sorta di controllo delle nascite.<br />
L'elevata età al matrimonio dei maschi può esserne stata il principale<br />
strumento, ma è lecito domandarsi se non vi fosse anche una consapevole<br />
limitazione della discendenza, che interveniva dopo un primo periodo di alta<br />
fecondità, finalizzato a garantire la successione. Gli intervalli intergenesici<br />
aumentano infatti con la durata del matrimonio, passando da 1,4 anni nel<br />
primo quinquennio a 2,1 nel secondo, a 2,5 nel terzo, a 3,5 nel quarto e a 4,4<br />
nel periodo da 20 anni in su. Ove questa ipotesi venisse confermata, con ogni<br />
probabilità non saremmo tanto in presenza di comportamenti «moderni», ma<br />
di freni anche in questo caso funzionali alle logiche familiari e patrimoniali<br />
tipiche della nobiltà di ancien régime.<br />
TAB. IX – ETÀ DELLE MADRI ALL'ULTIMO PARTO E LUNGHEZZA DEL PERIODO<br />
RIPRODUTTIVO PER COORTI DI MATRIMONI ED ETÀ AL MATRIMONIO<br />
Coorti Età Periodo Casi<br />
1758-1767 31.1 9.8 9<br />
Età al matrimonio<br />
Età Periodo Casi
1768-1777 30.4 10.2 20 -20 29.5 11.3 36<br />
1778-1787 34.8 10.1 19 20-24 31.6 9.5 51<br />
1788-1797 31.3 9.0 31 25-29 33.1 6.4 10<br />
1798-1807 30.5 9.6 22 30+ 46.3 4.9 4<br />
Totale 31.6 9.6 101 Tutte le età 31.6 9.6 101<br />
Avendo rilevato nominativamente il censimento della popolazione senese<br />
del 1841, possiamo a questo punto ricostruire in dettaglio il nostro universo<br />
sul finire del periodo considerato. Tale fonte ci permette infatti di rintracciare<br />
le <strong>famiglie</strong> <strong>nobili</strong> presenti a Siena, individuandone i singoli aggregati domestici.<br />
Al '41, tuttavia, abbiamo preferito avvicinarci seguendo passo dopo passo le<br />
genealogie dei rami familiari da cui siamo partiti (quelli rappresentati nelle<br />
Tabb. I e II). Il risultato di questo lavoro è consegnato alla Tab. X e ribadisce<br />
che a Siena la crisi demografica della nobiltà - tipica di tutta l'Europa fino alla<br />
metà del <strong>Settecento</strong> - non accenna a diminuire neppure agli inizi del XIX<br />
secolo; come abbiamo visto, anzi, il fenomeno si prolunga addirittura fino al<br />
XX. Nel 1841, cioè in meno di 90 anni, 123 dei 221 rami riconosciuti nel<br />
1753-54 sono usciti di scena, senza essere lontanamente rimpiazzati dalle 57<br />
<strong>famiglie</strong> di più recente <strong>nobili</strong>tazione. Tutto ciò fornisce una chiara prova di<br />
quanto fosse ancora precario l'equilibrio tra le contraddittorie esigenze di far<br />
sopravvivere la famiglia e garantire l'unitarietà del patrimonio, che anche in<br />
questa fase continuano ad essere il fulcro di strategie matrimoniali immutate.<br />
Basta scorrere gli alberi genealogici, in effetti, per avvertire quanto fosse<br />
ancora corposo il fenomeno del celibato e del nubilato. Anche in assenza di<br />
dati completi sulla mortalità, d'altronde, il lungo e malinconico elenco di nomi<br />
ripetuti di <strong>fra</strong>tello in <strong>fra</strong>tello che può essere estratto dal registro delle nascite<br />
mostra inequivocabilmente che la speranza di vita di chi vedeva la luce era<br />
appesa a un filo come nel passato. Per non citare che due delle tante storie<br />
familiari, <strong>fra</strong> i sette figli che nacquero a Giulio Luigi Pannilini e Olimpia<br />
Buonsignori dal 1777 al 1788 si contano tre Faustine e due Girolami. Solo la<br />
terzogenita Vittoria giunse a sposarsi e la famiglia si estinse, continuando<br />
indirettamente solo nel nome, aggiunto come spesso accadeva a quello di un<br />
ramo dei Piccolomini. Anche Pietro Buoninsegni ebbe sette figli, ma l'alta<br />
mortalità e le scelte matrimoniali della famiglia non permisero a questo ramo<br />
di prolungarsi per più di una generazione.<br />
TAB. X – SOPRAVVIVENZA DEI RAMI FAMILIARI FINO AL 1841<br />
Rami Estinti Sopravviv. Assenti Attesi 1841<br />
Patrizi 1753-54 184 103 83 16 67<br />
Nobili 1753-54 37 20 17 8 9<br />
Nobilitati 1755 + 57 12 45 23 22<br />
Totale 278 133 145 47 98
Dei 145 rami ancora esistenti, inoltre, 47 non avremmo potuto trovarli a<br />
Siena nel 1841 perché risiedevano altrove: alcuni provvisoriamente, come un<br />
ramo dei Sergardi e la famiglia del barone Giovan Battista Spannocchi,<br />
governatore di Livorno; alcuni perché trasferiti da tempo in altre città, come il<br />
ramo principesco dei Chigi e altri dei casati Piccolomini, Patrizi e de' Vecchi -<br />
che vivevano a Roma - o il ramo dei Pannocchieschi d'Elci stabilitosi a<br />
Firenze. Originari della provincia, taluni erano inoltre iscritti alla nobiltà<br />
senese solo perché attratti dal rango della seconda capitale: è il caso <strong>fra</strong> gli altri<br />
degli Avignanesi, dei Samuelli e dei Tarugi di Montepulciano, degli Dei di<br />
Chiusi e dei Luci di Colle Val d'Elsa. Dal canto suo il patrizio senese conte<br />
Cervini viveva stabilmente in campagna, nella rocca del Vivo d'Orcia, ma si<br />
tratta dell'unica eccezione degna di nota nella Toscana della nobiltà «civile»,<br />
oltre a quella di Bettino Ricasoli.<br />
Tolti dunque dal conto i rami estinti e quelli assenti, ce ne restavano 98:<br />
tanti, quanti ne abbiamo rintracciati a Siena nel censimento del 1841,<br />
rappresentati in molti casi da più unità familiari, più spesso da singoli aggregati<br />
domestici e qualche volta unicamente da un «solitario». Dei 16 <strong>nobili</strong>tati nel<br />
1838, di cui non resta traccia nelle fonti ufficiali coeve e nel Libro d'oro,<br />
conoscevamo 11 cognomi soltanto perché sopravvissuti fino a comparire<br />
nell'elenco ufficiale del 1904; di tutti abbiamo potuto accertare le generalità<br />
grazie a un documento del 1837-38 conservato nell'Archivio del Comune e<br />
soprattutto allo spoglio della stessa fonte censuaria. Di questi 98 rami,<br />
peraltro, 11 erano domiciliati nella parrocchia di S. Cristofano, il cui fascicolo<br />
è andato perduto; ne abbiamo notizia dal registro delle tasse di residenza, ma<br />
la nostra analisi dovrà limitarsi agli 87 rami rimanenti, ai quali corrispondono<br />
118 nuclei familiari per un totale di 396 persone.<br />
Su questa base, considerato che l'ampiezza media delle <strong>famiglie</strong> <strong>nobili</strong> è di<br />
3,36 individui, possiamo intanto stimare la consistenza dell'aristocrazia senese,<br />
che con i residenti in S. Cristofano ammonterebbe a 433 persone, per salire a<br />
585 con gli assenti dalla città. Se poi applichiamo l'ampiezza media e il<br />
rapporto rami/<strong>famiglie</strong> del 1841 all'universo <strong>nobili</strong>are della Tab. I, nella Siena<br />
del 1754 esso risulta composto da quasi 900 persone su 15.000 abitanti.<br />
Trattandosi di una stima verosimilmente approssimata per difetto, è quindi<br />
ragionevole ritenere che da allora i <strong>nobili</strong> <strong>senesi</strong> fossero scesi dal 6 al 3% della<br />
popolazione, addirittura al 2,3% se - com'è giusto - si considerano soltanto i<br />
residenti in città. Il declino demografico di questo ceto trova così una misura<br />
sintetica di grande eloquenza.<br />
Il risultato forse più significativo ottenuto dall'analisi del censimento<br />
riguarda tuttavia le tipologie familiari. La Tab. XI mostra in primo luogo una<br />
forte prevalenza della famiglia nucleare, tronca o completa che sia, ma in<br />
questo caso i numeri rischiano di risultare fuorvianti. Sebbene l'alto numero
dei solitari celibi suggerisca l'ipotesi di un ridimensionamento della famiglia<br />
estesa orizzontale, questa conserva pur sempre una certa consistenza e sembra<br />
anzi svolgere un ruolo ancora rilevante, come indica la quasi totale assenza di<br />
nubili che lasciano il tetto paterno, anche se ereditato da un <strong>fra</strong>tello: ne<br />
abbiamo infatti individuate soltanto tre, due delle quali ex religiose.<br />
TAB. XI – TIPOLOGIA DELLE FAMIGLIE NOBILI SENESI NEL 1841<br />
Tipi di famiglia Famiglie % Persone % Ampiezza<br />
Solitari 28 23,7 28 7,1 1,0<br />
Nucleari 58 49,2 227 57,3 3,9<br />
Estese verticali 7 5,9 27 6,8 3,9<br />
Estese orizzontali 14 11,9 67 16,9 4,8<br />
Multiple verticali 3 2,5 19 4,8 6,3<br />
Multiple orizzontali - - - - -<br />
Senza struttura 8 6,8 28 7,1 3,5<br />
Totale 118 100,0 396 100,0 3,4<br />
Stando ai numeri, la famiglia estesa verticale risulterebbe invece poco<br />
rappresentata. Tuttavia dei dodici vedovi che si contano <strong>fra</strong> i solitari i due<br />
maschi e nove femmine su dieci non hanno figli viventi; tre vedove risultano<br />
per giunta le ultime del loro ramo. Abbiamo inoltre individuato soltanto sette<br />
coppie che abitano da sole e tutte sono prive di figli viventi. Ciò mostra come<br />
non abbia molto senso considerare le <strong>famiglie</strong> nucleari, quelle estese e anche le<br />
multiple verticali come modelli distinti o addirittura contrapposti. Quelli che a<br />
un'analisi statica appaiono come tipi, altro non riflettono in realtà che<br />
momenti diversi del ciclo familiare. L'alto numero delle <strong>famiglie</strong> nucleari, in<br />
effetti, si spiega semplicemente con l'elevata età al matrimonio dei maschi, che<br />
riduceva il periodo di convivenza <strong>fra</strong> le generazioni.<br />
Il modello di comportamento più diffuso nella nobiltà senese era dunque il<br />
seguente: un figlio sposato succedeva al padre nel palazzo di famiglia,<br />
continuando a convivere eventualmente con la madre vedova, sempre con le<br />
sorelle nubili e in molti casi con i <strong>fra</strong>telli celibi, pronti però ad andarsene in<br />
caso di matrimonio. Una logica ancora imperniata sul modello patrilocale,<br />
insomma, che alla metà del XIX secolo non accenna a scomparire e conferma<br />
l'accentuata continuità con il passato già emersa dalla permanenza di strategie<br />
familiari e matrimoniali tradizionali. Ciò non toglie tuttavia che nella Siena del<br />
1841, come nella Firenze <strong>fra</strong>ncese studiata da Gozzini e in molte altre città,<br />
l'arcaico modello di organizzazione plurinucleare costituito dalla famiglia<br />
multipla orizzontale fosse definitivamente scomparso.<br />
Molto potrebbero dirci anche i dati sui domestici e sulle altre figure che<br />
risultano coresidenti con le <strong>famiglie</strong> <strong>nobili</strong> nel censimento del 1841. Compresi<br />
i loro congiunti sono 268 persone, <strong>fra</strong> cui 196 tra servi e camerieri, 17 cuochi,
12 cocchieri, 2 fattori, 2 governanti, 2 «guardarobba», un pittore, un<br />
giardiniere, un sellaio, una balia, un cacciatore e un sacerdote precettore. La<br />
fonte dà inoltre utili notizie sui titoli onorifici, sulle cariche pubbliche e sulle<br />
posizioni occupate nelle gerarchie ecclesiastiche dall'aristocrazia senese.<br />
L'impianto sintetico del nostro contributo ci obbliga tuttavia a concentrarci<br />
sul problema, sotto ogni profilo prioritario, dei patrimoni.<br />
È accertato che la proprietà fondiaria era la base fondamentale della<br />
ricchezza di un ceto <strong>nobili</strong>are come quello senese, il quale nonostante la sua<br />
natura «civile» simboleggiata dai palazzi cittadini aveva la sua prima risorsa<br />
nella terra. Di questo fenomeno indubbiamente cruciale possiamo ricomporre<br />
con insolita precisione un quadro completo ricorrendo all'Indice dei possidenti<br />
della Toscana tratto nel 1836 dal catasto leopoldino. Come per il censimento di<br />
sette anni dopo, abbiamo effettuato su tale fonte una ricerca nominativa che ci<br />
ha permesso di rintracciare la quasi totalità dei rami esistenti in questo<br />
periodo. Fra residenti e assenti da Siena sono 135, ma in questo caso abbiamo<br />
escluso dal computo soltanto le <strong>famiglie</strong> che, oltre a non risiedere a Siena, non<br />
avevano mai avuto vere radici in città o le avevano tagliate da lungo tempo. Si<br />
tratta degli Amerighi, dei Giuntarelli d'Ambra e dei Lami, ormai<br />
«fiorentinizzati», dei chianini Griffoli e Neri Serneri e inoltre dei Mori<br />
Ubaldini, dei Salucci e dei Luci, di fatto <strong>senesi</strong> soltanto ad honorem.<br />
I rimanenti 127 rami <strong>nobili</strong>, a cui fanno capo 268 patrimoni diversamente<br />
intestati, possiedono in tutto una superficie di 607.741 quadrati toscani (pari a<br />
206.997 ha) e una rendita imponibile di 1.878.926 lire toscane. I valori medi,<br />
per quanto significato possono avere, sono di 4.785 quadrati e 14.795 lire per<br />
ramo familiare. Livelli di ricchezza tutt'altro che trascurabili, cioè, se è vero<br />
che un gruppo di circa 500 persone deteneva il 9,9% della superficie e il 4,2%<br />
della rendita imponibile dell'intero Granducato. Il divario tra i due valori,<br />
d'altronde, pone subito in evidenza come si trattasse per lo più di grandi<br />
latifondi a coltura estensiva.<br />
Dato che la nostra fonte ci consente anche di collocare tali possedimenti sul<br />
territorio toscano, ne abbiamo rappresentato la distribuzione in due carte<br />
tratte da quella del Manetti del 1834, che visualizzano la loro incidenza<br />
percentuale sulla superficie e la rendita complessive di ciascuna comunità. La<br />
differenza tra le carte rispecchia lo scarto or ora sottolineato tra i due valori,<br />
ma non inficia la sostanza di un disegno che mostra come questi patrimoni<br />
fossero ancora concentrati quasi per intero entro i confini dell'antica<br />
repubblica di Siena e in particolare, naturalmente, della cosiddetta Provincia<br />
Superiore.
CARTA 1 – SUPERFICIE IMPONIBILE DEI NOBILI SENESI (% SULLA SUPERFICIE TOTALE DI<br />
CIASCUNA COMUNITÀ). FONTE: INDICE DEI POSSIDENTI DELLA TOSCANA, 1836.
CARTA 2 – RENDITA IMPONIBILE DEI NOBILI SENESI (% SULLA RENDITA TOTALE DI CIASCUNA<br />
COMUNITÀ). FONTE: INDICE DEI POSSIDENTI DELLA TOSCANA, 1836.<br />
Viceversa è di notevole interesse che il ceto dominante della città appaia<br />
poco presente in altre aree dell'odierna provincia senese: è il caso della Val<br />
d'Elsa, dell'alto Chianti e - più significativo di tutti - del territorio della città<br />
nobile di Montepulciano, storico avamposto dello Stato fiorentino alle spalle<br />
di Siena. Neppure un nobile senese possiede d'altronde nel vecchio contado<br />
volterrano, a riprova che i giochi erano davvero già fatti in epoca medievale.<br />
Del resto le poche proprietà dei <strong>nobili</strong> <strong>senesi</strong> nella Toscana settentrionale<br />
appaiono spesso sporadiche e casuali, legate a matrimoni o a cambi di<br />
residenza come nel caso già ricordato del ramo fiorentino dei Pannocchieschi<br />
d'Elci, che possiedono nei contadi di Firenze e di Pistoia, ma conservano i<br />
loro antichi possessi in tutta la provincia senese e tengono casa aperta a Siena.
Il dato più emblematico sotto questo profilo resta però la presenza di<br />
Corradino e Rolando Chigi in Lunigiana, ottenuta per linea femminile in<br />
seguito all'estinzione dei conti Benedetti.<br />
Che i beni dei <strong>nobili</strong> <strong>senesi</strong> consistessero essenzialmente in proprietà<br />
fondiarie e non immobiliari è confermato dalla macchia puntiforme chiara che<br />
nelle carte segnala la comunità urbana di Siena. La loro presenza in città copre<br />
infatti il 15,1% della superficie e il 27,8% della rendita: valori molto inferiori a<br />
quelli delle campagne circostanti, cioè, anche se pur sempre di rilievo. Il dato<br />
sulla rendita, in particolare, attesta la qualità e il pregio dei beni posseduti dalle<br />
<strong>famiglie</strong> <strong>nobili</strong> entro le mura della città. Ma basta uscire dalle sue porte, per<br />
imbattersi in tutt'altra incidenza della proprietà <strong>nobili</strong>are: nelle due Masse,<br />
dove pure è naturale che siano presenti in misura non irrilevante i ceti urbani<br />
descritti più tardi da Federigo Tozzi, essa rasenta il 50% della superficie<br />
imponibile. Un valore, questo, che sale ancora nelle Crete, in Val d'Orcia e in<br />
alcune aree della montagna amiatina e della Chiana, con punte superiori al<br />
60% ad Asciano, a Monteroni e a Rapolano, fino a oltrepassare il 70% nelle<br />
più popolose terre della Montagnola.<br />
Questa mappa riproduce insomma il punto d'arrivo del processo di<br />
appropriazione del contado da parte della città, realizzato in prima persona da<br />
una classe dirigente trasformatasi da mercantile e borghese in una potente<br />
aristocrazia fondiaria in grado di resistere al tempo. In un'ampia fascia che fa<br />
corona alla città tutte le maggiori tenute, che talvolta sono veri e propri borghi<br />
attorno ai quali ruota l'organizzazione del territorio, fanno capo alle <strong>famiglie</strong> di<br />
questo ceto. Che tale processo risalga al pieno Medioevo è provato anche<br />
soltanto dal fatto che l'83% di questa immensa proprietà fondiaria è nelle<br />
mani del patriziato di più antica origine. Non a caso al vertice della piramide<br />
rappresentata nella Tab. XII troviamo nell'ordine nomi storici come quelli dei<br />
Chigi Zondadari, dei Bianchi Bandinelli, dei Saracini, dei Piccolomini<br />
Clementini e dei Sergardi, mentre il primo dei <strong>nobili</strong> occupa solo il 21° posto.<br />
Se poi per ipotesi volessimo prendere in considerazione le proprietà di<br />
soggetti non appartenenti a questo ceto, a parte l'arcivescovo e qualche ente<br />
religioso, sopra le 10.000 lire di rendita troveremmo soltanto i <strong>fra</strong>telli Pozzesi<br />
e Andreini, che non a caso si ritrovano puntualmente nell'elenco dei<br />
<strong>nobili</strong>tandi del 1837. Alla base, accanto ad aristocratici di recente nomina, si<br />
incontrano peraltro anche a Siena rami decaduti di antiche <strong>famiglie</strong>.<br />
TAB. XII – RAMI NOBILI SENESI PER FASCE DI RENDITA E TIPO DI NOBILTÀ<br />
Rendita Patrizi Nobili Nobilitati Totale<br />
imponibile<br />
N° % N° % N° % N° %<br />
- 1000 6 6,5 - - 3 15,8 9 7,1<br />
1000-5000 18 19,4 5 3,7 3 15,8 27 21,3
5000-10000 20 21,5 3 21,4 5 26,3 28 22,0<br />
10000-20000 19 20,4 5 35,7 4 21,1 28 22,0<br />
20000-30000 11 11,8 1 7,1 3 15,8 15 11,8<br />
30000-40000 12 12,9 - - 1 5,3 13 10,2<br />
40000-50000 2 2,2 - - - - 2 1,6<br />
50000+ 5 5,4 - - - - 5 3,9<br />
Totale 93 100,0 14 100,0 19 100,0 127 100,0<br />
Se dal livello generale dei rami familiari ci inoltriamo nello studio dei singoli<br />
patrimoni, il problema si fa più complesso sia perché occorre distinguere<br />
quelli spettanti a ciascuna famiglia all'interno dei rami, sia perché, all'interno di<br />
ogni famiglia, è necessario verificare l'effettiva titolarità dei numerosi beni<br />
posseduti in comproprietà e il loro rapporto con quelli individuali. In attesa di<br />
completare il lavoro che abbiamo avviato sui meccanismi di successione e<br />
l'analisi del rapporto <strong>fra</strong> relazioni di parentela e patrimoni, ci limitiamo qui a<br />
proporre alcuni elementi di sintesi e qualche ipotesi interpretativa.<br />
La Tab. XIII mostra intanto la netta prevalenza dei patrimoni individuali,<br />
che detengono i tre quarti della superficie e della rendita complessive. Ciò non<br />
toglie che siano presenti importanti proprietà indivise, come quelle dei quattro<br />
<strong>fra</strong>telli Borghesi Bichi (15.795 qt per 33.246 lt), di Luigi e Carlo Bianchi<br />
Bandinelli (8.430 qt per 46.654 lt), dei tre <strong>fra</strong>telli Piccolomini Bandini Naldi<br />
(8.096 qt per 27.566 lt) e soprattutto di Marc'Antonio e Alessandro Saracini<br />
(14.731 qt per 54.549 lt). Si tratta quindi di capire se l'alto numero di singoli<br />
proprietari sia il risultato di una tenace strategia patrilineare tendente a far<br />
convergere i patrimoni su uno solo dei figli o all'opposto di una loro<br />
suddivisione paritaria tra i maschi, secondo il dettato della legge in vigore nella<br />
Toscana della Restaurazione.<br />
Intestatari singoli<br />
- Coniugati<br />
- Celibi<br />
- Coniugate<br />
- Nubili<br />
Totale singoli<br />
TAB. XIII – SUPERFICIE E RENDITA IMPONIBILI POSSEDUTE<br />
DALLE «DITTE» NOBILI SENESI NEL 1836<br />
«Ditte» Superficie Sup. media Rendita Rend. media<br />
121<br />
50<br />
34 3<br />
208<br />
350.583<br />
90.540<br />
19.940<br />
3.601<br />
464.664<br />
2.897,4<br />
1.810,8<br />
586,5<br />
1.200,3<br />
2.234,0<br />
1.066.671<br />
262.082<br />
99.130<br />
9.082<br />
1.436.965<br />
8.815,5<br />
5.241,6<br />
2.915,6<br />
3.027,3<br />
6.908,5<br />
Comproprietà 60 143.077 2.384,6 441.961 7.366,0<br />
Totale 268 607.741 2.267,7 1.878.926 7.010,9<br />
Una prima ma già chiara indicazione di massima la dà a questo proposito la<br />
stessa Tab. XIII, che mostra la netta inferiorità dei maschi celibi,<br />
evidentemente ancora soggetti a una logica patrimoniale che privilegia la
famiglia rispetto all'individuo. Il fenomeno è tra l'altro più accentuato di<br />
quanto qui non appaia perché i celibi - come si è detto ancora molto numerosi<br />
- solo in parte compaiono nel catasto. A tale logica obbedisce ad esempio<br />
Alessandro Sansedoni, che pur avendo quattro figlie nomina suo «erede<br />
beneficiato» il nipote ex <strong>fra</strong>tre Giovanni al fine di ricostituire l'unità del<br />
patrimonio familiare: una strategia ben congegnata, che però non evita<br />
l'estinzione della famiglia perché Giovanni muore celibe nel 1837. Anche<br />
quando i patrimoni appaiono indivisi, d'altronde, a una più attenta analisi<br />
risulta già preparata la via alla successione di uno solo dei figli: l'abate<br />
Francesco Ballati Nerli, minore di due <strong>fra</strong>telli, ha in realtà diritto soltanto alla<br />
rendita della parte legittima di un patrimonio destinato a rimanere in toto al<br />
primogenito Girolamo e ai suoi discendenti.<br />
Com'è noto, infine, le donne erano escluse di fatto dalla proprietà dei beni<br />
fondiari e ad esse veniva riservata la sola legittima, quasi sempre in forma di<br />
dote matrimoniale o monacale. Ciò spiega il basso numero di intestatarie da<br />
noi individuate nel catasto e l'esiguità dei loro possessi. Quasi tutte, inoltre, si<br />
trovano nella condizione di «ultima di sua casa», necessaria anche se non<br />
sempre sufficiente per ereditare i beni paterni. Né sorprende che soltanto tre<br />
di loro fossero nubili, considerata la buona quotazione delle ereditiere sul<br />
mercato dei matrimoni.<br />
In conclusione, le diverse prospettive da cui abbiamo condotto questa<br />
prima analisi della nobiltà senese alla fine dell'età moderna concorrono a<br />
costruire un'immagine di resistenza e di continuità nel tempo, nella misura in<br />
cui queste <strong>famiglie</strong> mantengono la loro plurisecolare egemonia. Al tempo<br />
stesso, però, l'incapacità di aggiornare i tradizionali modelli di comportamento<br />
espone questo gruppo a un declino quantitativo e anche a una graduale perdita<br />
di peso nel contesto pur notoriamente statico della loro antica patria nobile.<br />
Senza dubbio alla metà dell'Ottocento esse svolgono ancora un ruolo da<br />
protagonisti nel «sistema cittadino», ma al tempo stesso è ormai evidente la<br />
loro decadenza. Quel ceto che era stato riconosciuto nobile proprio in quanto<br />
classe di governo, dopo l'Unità d'Italia occupava ancora una posizione di<br />
spicco nella politica senese, ma questa non era più un suo esclusivo privilegio:<br />
tra i nomi dei consiglieri comunali avvicendatisi nel primo decennio<br />
postunitario, infatti, soltanto un terzo era scritto nei Libri d'oro della nobiltà.<br />
APPENDICE<br />
<strong>Le</strong> Tabb. XVIII, XIX, XX, XXII e XXIII si riferiscono alle <strong>famiglie</strong> con CF senese; i<br />
decenni 1738-58 non vi sono considerati perché il numero dei casi con età della madre<br />
indicata è troppo basso, quello 1808-17 perché è incompleto il registro delle nascite. La<br />
Tab. XXI riguarda 113 <strong>famiglie</strong> con CF senese e dati completi. Nella Tab. XXIV i dati<br />
relativi alla comunità di Siena non comprendono i 1207 individui viventi in convivenze e<br />
altri 5 privi dell'indicazione dello stato civile.
TAB. XIV – CASATI PATRIZI E NOBILI RICONOSCIUTI NEL 1753-54<br />
PER NUMERO DI RAMI<br />
N. rami C. patrizi % C. <strong>nobili</strong> % Totale %<br />
1 63 61,2 43 89,6 106 70,2<br />
2 16 15,5 5 10,4 21 13,9<br />
3 17 16,5 - - 17 11,3<br />
4 3 2,9 - - 3 2,0<br />
5 2 1,1 - - 2 1,3<br />
7 1 1,9 - - 1 0,7<br />
9 1 1,9 - - 1 0,7<br />
Totale 103 100,0 48 100,0 151 100,0<br />
TAB. XV – NUMERO MEDIO DEI FIGLI PER COORTI DECENNALI DI MATRIMONI<br />
DAL 1738 AL 1807<br />
Coorti Famiglie Numero figli Figli / famiglia feconda<br />
Tot. Fec. M F T M F T<br />
1738-1747 33 27 114 114 228 4,22 4,22 8,44<br />
1748-1757 32 26 67 66 133 2,58 2,54 5,12<br />
1758-1767 35 30 63 72 135 2,10 2,40 4,50<br />
1768-1777 51 41 123 101 224 3,00 2,46 5,46<br />
1778-1787 35 30 78 63 141 2,60 2,10 4,70<br />
1788-1797 51 46 116 121 237 2,52 2,63 5,15<br />
1798-1807 39 31 67 73 140 2,16 2,35 4,51<br />
Totale 276 231 628 610 1238 2,66 2,51 5,17<br />
TAB. XVI – MATRIMONI DEI FIGLI PER COORTI DECENNALI DI MATRIMONI DELLE FAMIGLIE<br />
D'ORIGINE E ORDINE DI NASCITA<br />
Coorti<br />
Figli Primogeniti sposati Altri sposati<br />
Totale Spos S/T M F T M F T<br />
1738-1747 228 73<br />
%<br />
32,0 2 6 8 24 41 65<br />
1748-1757 133 44 33,1 3 6 9 16 19 35<br />
1758-1767 135 54 40,0 8 8 16 12 26 38<br />
1768-1777 224 77 34,4 9 11 20 22 35 57<br />
1778-1787 141 41 29,1 4 9 13 12 16 28<br />
1788-1797 237 53 22,4 9 10 19 10 24 34<br />
1798-1807 140 17 12,1 3 2 5 4 8 12<br />
1808-1817 91 7 7,7 1 3 4 1 2 3<br />
Totale 1329 366 27,5 39 55 94 101 171 272<br />
TAB. XVII – FIGLI SPOSATI PER OGNI FAMIGLIA, PER COORTI DECENNALI<br />
DI MATRIMONI DELLE FAMIGLIE D'ORIGINE<br />
Coorti Figli / famiglia
Totale Sposati S / T %<br />
1738-1747 8,44 2,70 32,0<br />
1748-1757 5,12 1,73 33,1<br />
1758-1767 4,50 1,80 40,0<br />
1768-1777 5,46 1,88 34,4<br />
1778-1887 4,70 1,37 29,1<br />
1788-1897 5,15 1,17 22,4<br />
1798-1807 4,51 0,58 12,1<br />
1808-1817 3,50 0,27 7,7<br />
Totale 5,17 1,44 27,5<br />
TAB. XVIII – NUMERO DEI FIGLI PER COORTI DI MATRIMONI E DURATA<br />
Coorti 0-5 5-10 10-15 15-20 20+ Tot. Tot.%<br />
1758-67 24 9 4 1 - 38 8.0<br />
1768-77 44 29 21 6 1 101 21.4<br />
1778-87 49 19 15 5 - 88 18.6<br />
1788-97 67 40 21 13 2 143 30.2<br />
1798-07 59 24 13 4 3 103 21.8<br />
Totale 243 121 74 29 6 473 100.0<br />
Tot.% 51.4 25.6 15.6 6.1 1.3 100.0<br />
TAB. XIX – NUMERO DEI FIGLI PER DURATA E ORDINE DI NASCITA<br />
Durata<br />
Ordine di nascita<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+ Tot. %<br />
0-5 91 73 56 19 4 243 51.4<br />
5-10 3 6 11 34 32 17 13 4 1 121 25.6<br />
10-15 2 3 6 18 13 13 13 6 74 15.6<br />
15-20 1 2 6 4 6 10 29 6.1<br />
20+ 1 5 6 1.3<br />
Totale 94 79 69 56 42 36 28 23 19 12 15 473 100<br />
Tot. % 19.9 16.7 14.6 11.8 8.9 7.6 5.9 4.9 4.0 2.5 3.2 100<br />
TAB. XX – NUMERO DEI FIGLI PER ETÀ DELLA MADRE AL MATRIMONIO E AL PARTO<br />
Età al<br />
matrimonio<br />
N.<br />
madri<br />
Età al parto<br />
-20 20-24 25-29 30+ Tot. %<br />
-20 45 26 85 40 39 190 40.2<br />
20-24 53 66 90 87 243 51.4<br />
25-29 10 14 17 31 6.6<br />
30+ 5 9 9 1.9<br />
Totale 113 26 151 144 152 473 100.0<br />
Tot. % 5.5 31.9 30.4 32.1 100.0
TAB. XXI – TASSI DI FECONDITÀ PER ETÀ AL MATRIMONIO ED ETÀ AL PARTO<br />
Età al<br />
Età al parto<br />
matrimonio<br />
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 TFTL<br />
-20 133,3 259,5 188,5 187,5 118,2 100,0 4,60<br />
20-24 175,0 252,8 189,3 208,3 150,0 4,40<br />
25-29 188,9 200,0 125,0 100,0 2,59<br />
30+ 100,0 150,0 200,0 100,0 2,50<br />
Tutte le età 133,3 216,3 221,1 188,5 158,6 140,0 100,0<br />
TAB. XXII – TASSI DI FECONDITÀ PER COORTI DI MATRIMONI E DECENNI DI NASCITA<br />
Coorti 1758-67 1768-77 1778-87 1788-97 1798-07 1808-17 1818-27 Totale<br />
1758-67 250,0 200,0 25,0 4,75<br />
1768-77 188,9 300,0 66,7 5,6 5,61<br />
1778-87 223,5 247,1 47,1 5,18<br />
1788-97 186,2 251,7 51,7 3,5 4,93<br />
1798-07 218,2 195,5 54,6 4,68<br />
TAB. XXIII – TASSI DI FECONDITÀ PER COORTI DI MATRIMONI<br />
E QUINQUENNI DI DURATA<br />
Coorti 0-4 5-9 10-14 15-19 20 + Totale<br />
1758-67 250,0 150,0 62,5 12,5 4,75<br />
1768-77 194,4 183,3 133,3 44,4 5,6 5,61<br />
1778-87 241,2 152,9 76,5 41,2 5,9 5,18<br />
1788-97 200,0 148,3 79,3 48,3 17,2 4,93<br />
1798-07 236,4 122,7 72,7 22,7 13,6 4,68<br />
Stato civile<br />
TAB. XXIV – NOBILI E TOTALE DELLA COMUNITÀ DI SIENA PER SESSO<br />
E STATO CIVILE AL CENSIMENTO DEL 1841<br />
Nobili Comunità di Siena<br />
M % F % M % F %<br />
Celibi/nubili 131 33,1 89 22,5 4797 27,3 4858 27,7<br />
Coniugati/e 68 17,2 67 16,9 3139 17,9 3189 18,2<br />
Vedovi/e 16 4,1 25 6,3 423 2,4 1139 6,5<br />
Totale 215 54,3 181 45,7 8359 47,6 9186 52,4
PIRAMIDE DELLE ETÀ DELLA POPOLAZIONE DI SIENA AL CENSIMENTO DEL 1841<br />
NOBILI E TOTALE DELLA COMUNITÀ<br />
* Viene qui sviluppato un lavoro seminariale svolto negli anni accademici 1990/91 e<br />
1992/93 con gli studenti di Storia economica nell'età moderna e di Storia del Risorgimento<br />
della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Siena. Vi hanno partecipato Maria Pia<br />
Amorusi, Stefania Barbetti, Adamo Biancucci, Veronica Bonelli, Stefania Brulli, Andrea<br />
Bufardeci, Arcangela Carbone, Cristina Catani, Lorella Chechi, Rosa Maria Chinni,<br />
Antonietta Cutillo, Filippo Franchi, Gianna Lumia, Maresa Magini, Maurizio Muzzi, Irene<br />
Pertici, Tiziana Petreni, Emanuela Pisanu, Andrea Sallese, Pina Sangiovanni e Tiziana<br />
Serino. Abbiamo inoltre utilizzato alcuni dati tratti dalla tesi di laurea di Donatella Fabbri,<br />
La classe dirigente senese dopo l'Unità, Facoltà di <strong>Le</strong>ttere e filosofia dell'Università di Siena, a. a.<br />
1993-94. Una sorta di traccia per questa indagine, infine, è costituita da C. Pazzagli, Nobiltà<br />
civile e sangue blu. Il patriziato volterrano alla fine dell'età moderna, Olschki, Firenze 1996.