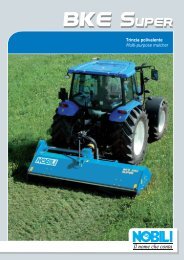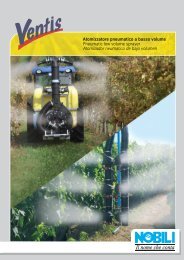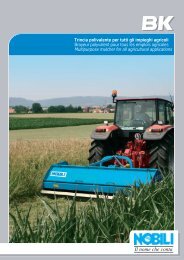NOBILI BNE-SDS, INERBIMENTO SOSTENIBILE IN ...
NOBILI BNE-SDS, INERBIMENTO SOSTENIBILE IN ...
NOBILI BNE-SDS, INERBIMENTO SOSTENIBILE IN ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
TECNICA<br />
<strong>NOBILI</strong> <strong>BNE</strong>-<strong>SDS</strong>, <strong><strong>IN</strong>ERBIMENTO</strong><br />
<strong>SOSTENIBILE</strong> <strong>IN</strong> ARBORICOLTURA<br />
Una sperimentazione su questa trincia-<br />
andanatrice ne ha evidenziato la capacità<br />
di ridurre gli interventi di diserbo necessari<br />
n diPierPaoloPagni 1 ,MatteoMontanari 2 ,MarcoVieri 1<br />
1 DipartimentodiEconomia,Ingegneria,ScienzeeTecnologieAgrarie<br />
eForestali-SezionediIngegneriadeiBiosistemiAgro-Forestali-<br />
UniversitàdegliStudidiFirenze<br />
2 Progettista,ufficiotecnicoricercaesperimentazioneNobili<br />
Il sempre più attuale approccio<br />
sostenibile e biologico<br />
delle produzioni agricole<br />
e la crescente spinta<br />
verso l’integrazione tra coltivazione,<br />
ambiente e paesaggio<br />
sta portando negli<br />
ultimi anni alla riscoperta di<br />
innovative, quanto interessanti,<br />
tecniche e tecnologie<br />
di “meccanizzazione ecocompatibile”<br />
abbandonate<br />
dalla seconda metà del 1900<br />
a causa dello sviluppo di<br />
pratiche quali lavorazioni intensive<br />
e ripetute dei suoli e<br />
controllo chimico delle infestanti.<br />
La difesa e il mantenimento<br />
dell’ecosistema di coltivazione,<br />
sia esso un vigneto o<br />
un frutteto, si attua a partire<br />
da una ragionata gestione<br />
integrata di input e output<br />
colturali e in primo luogo da<br />
una corretta gestione del<br />
suolo che inevitabilmente si<br />
riflette sulle caratteristiche<br />
qualiquantitative delle produzioni.<br />
La stragrande<br />
maggioranza dei suoli sul<br />
territorio nazionale sono ormai<br />
degradati a causa principalmente<br />
dell’azione antropica<br />
che ha caratterizzato<br />
l’agricoltura del secolo<br />
passato, a scapito della stabilità<br />
e conservazione dei<br />
suoli.<br />
Tra i fattori principali che<br />
concorrono alla degradazione<br />
dei suoli agricoli si<br />
possono evidenziare:<br />
erosione;<br />
compattamento del suolo<br />
agricolo causato dai ripetuti<br />
n Fig. 1 Intervento di diserbo chimico associato<br />
a inerbimento interfilare.<br />
n Fig. 2 Trinciaandanatrice <strong>BNE</strong><strong>SDS</strong> con scarico<br />
monolaterale.<br />
passaggi di macchine agricole<br />
e da una gestione<br />
estremamente intensiva dei<br />
suoli;<br />
formazione di suola di lavorazione,<br />
la quale porta allo<br />
sconvolgimento delle<br />
proprietà fisicoidrologiche<br />
dei suoli, con una separazione<br />
netta tra suolo lavorato<br />
e orizzonti sottostanti;<br />
impoverimento della sostanza<br />
organica. Le frequenti<br />
lavorazioni provocano<br />
un notevole aumento della<br />
velocità di ossidazione dei<br />
suoli e conseguentemente<br />
un incremento del ciclo di mineralizzazioneumificazione<br />
della sostanza organica, che<br />
spesso però è resa indisponibile<br />
alle piante.<br />
Gestionedifferenziata<br />
Sulla base di questi presupposti<br />
negli ultimi anni una<br />
delle tecniche di gestione<br />
che si è maggiormente distinta<br />
per compatibilità ambientale<br />
e risultati qualitativi<br />
ottenibili è l'inerbimento nelle<br />
sue più svariate forme,<br />
per il quale numerose ricer<br />
che hanno evidenziato molteplici<br />
riscontri positivi a livello<br />
fisiologico, ambientale<br />
e di miglioramento delle<br />
condizioni di biodiversità<br />
all'interno degli appezzamenti<br />
agricoli.<br />
La gestione dei suoli inerbiti<br />
ha subito negli anni interessanti<br />
sviluppi che prevedono<br />
la riduzione o addirittura<br />
l’eliminazione degli interventi<br />
di controllo chimico<br />
delle infestanti nella zona<br />
sottofilare che nella stragrande<br />
maggioranza dei<br />
casi ancora oggi sono complementari<br />
alla gestione dell’inerbimento<br />
interfilare tramite<br />
trinciatura (Fig. 1).<br />
A partire dal 2008 la ditta costruttrice<br />
Nobili ha sviluppato<br />
e collaudato la innovativa<br />
operatrice <strong>BNE</strong><strong>SDS</strong> (Side<br />
Delivery System) nata dalla<br />
integrazione di una tradizionale<br />
trinciatrice con un sistema<br />
di scarico laterale<br />
della biomassa triturata (andanatura<br />
sottofilare) con effetto<br />
pacciamante. La <strong>BNE</strong><br />
<strong>SDS</strong> (Fig. 2) è in grado di tagliare<br />
il manto erboso spontaneo<br />
o dedicato, i residui di<br />
m&ma-n.9-2010 45
TECNICA<br />
potatura e eventuali altre<br />
colture consociative e di trasferire,<br />
laddove si ritenesse<br />
necessario, la biomassa ottenuta<br />
dall'interfilare al sottofila<br />
con la conseguente<br />
formazione di un "tappeto<br />
pacciamante" di spessore e<br />
caratteristiche variabili in<br />
funzione di epoca di intervento,<br />
essenze erbacee<br />
presenti e caratteristiche<br />
specifiche dell'inerbimento<br />
(umidità, sviluppo ecc.).<br />
A partire dal 2009 la collaborazione<br />
con il gruppo di ricerca<br />
di Ingegneria delle<br />
produzioni vitivinicole<br />
dell'Università di Firenze, ha<br />
portato al collaudo in campo<br />
della <strong>SDS</strong> nel comprensorio<br />
vitivinicolo del Chianti Classico<br />
con l'allestimento di<br />
due diversi siti di sperimentazione<br />
nei comuni di Castelnuovo<br />
Berardenga (in<br />
collaborazione con la Fondazione<br />
Monte dei Paschi di<br />
Siena) e Greve in Chianti<br />
(con la collaborazione della<br />
stazione sperimentale per la<br />
viticoltura sostenibile e<br />
l'azienda vinicola Fontodi).<br />
Particolaricostruttivi<br />
Il sistema di convogliamento<br />
dei residui di trinciatura è<br />
stato posizionato nel vano<br />
reso disponibile dal cofano<br />
posteriore apribile per la manutenzione.<br />
In questa posizione<br />
è stata ricavata la sede<br />
per una o due coclee coassiali<br />
(Fig. 3) con asse parallelo<br />
al rotore della trinciatrice,<br />
per permettere, in base alle<br />
esigenze operative e alla dimensione<br />
dello spazio interfilare<br />
degli impianti, lo scarico<br />
mono o bilaterale della<br />
pacciamatura.<br />
Le coclee vengono<br />
azionate grazie a un motore<br />
idraulico e a una trasmissione<br />
a catena. La velocità di rotazione<br />
del sistema di convogliamento<br />
si può regolare<br />
grazie ad una apposita valvola<br />
a bordo della <strong>SDS</strong> (particolare<br />
evidenziato in Fig. 4),<br />
in modo da smaltire e distribuire<br />
al meglio la biomassa<br />
triturata al variare della velocità<br />
della trattrice ed evitare<br />
un qualsiasi intasamento del<br />
sistema andanatore. Nei casi<br />
in cui il trattore non dovesse<br />
avere la portata d’olio necessaria<br />
per il funzionamento<br />
della macchina, è prevista<br />
l’installazione di un serbatoio<br />
dedicato con una pompa<br />
che prende il moto dalla presa<br />
di forza del trattore tramite<br />
il gruppo di rinvio.<br />
La trinciaandanatrice può<br />
poggiare su un rullo o su<br />
ruote che ne regolano l'altezza<br />
di lavoro.<br />
Proveoperativeerisultati<br />
Durante la stagione 2009<br />
sono state allestite le prime<br />
prove sperimentali volte a<br />
monitorare le dinamiche di<br />
comportamento della pacciamatura<br />
sottofilare, i rapporti<br />
di questa con lo sviluppo<br />
di infestanti e l’andamento<br />
delle condizioni di umidità<br />
dei primi strati di suolo, in<br />
confronto alle più tradizionali<br />
tecniche per la gestione<br />
del vigneto quali il controllo<br />
chimico mediante prodotti<br />
diserbanti e il controllo meccanico<br />
mediante lavorazioni<br />
interceppo ripetute.<br />
Le prove sono state<br />
organizzate<br />
presso l’azien<br />
n Fig. 3 Particolare progettuale del sistema andanatore.<br />
n Fig. 4 Posteriore della <strong>SDS</strong> con particolare evidenziato<br />
della regolazione di velocità delle coclee.<br />
da agricola Poggio Bonelli<br />
(Castelnuovo Berardenga,<br />
Siena) di proprietà dei Tenimenti<br />
Monte dei Paschi di<br />
Siena. Per le prove sono<br />
stati individuati due diversi<br />
vigneti aziendali contigui tra<br />
loro. In una porzione rappresentativa<br />
di ciascun vigneto<br />
sono state organizzare<br />
rispettivamente le prove<br />
volte a comprendere gli<br />
effetti della pacciamatura<br />
sul contenimento delle infestanti<br />
(Tesi 1, Vigneto Santa<br />
Caterina Basso) e sull’ andamento<br />
del contenuto di<br />
umidità dei primi strati di<br />
suolo (Tesi 2, Vigneto Santa<br />
Caterina Alto); i siti di sperimentazione<br />
sono evidenziati<br />
sulla foto aerea di Fig. 5.<br />
Per la Tesi 1 sono stati individuati<br />
10 filari rappresentativi<br />
del vigneto di riferimento<br />
(evidenziato in rosso) sui<br />
quali la macchina <strong>SDS</strong> ha<br />
operato secondo le quotidiane<br />
direttive aziendali,<br />
così da valutare la risposta<br />
della flora infestante<br />
alla presenza<br />
dello strato pacciamante<br />
sottofilare. Per<br />
la Tesi 2 (evidenziata in<br />
giallo) sono stati individuati<br />
3 filari rappresentativi,<br />
omogenei per tipologia<br />
di suolo e per presenza<br />
di infestanti e all’ interno di<br />
questi sono state allestite<br />
tre differenti prove su una<br />
lunghezza di circa 15 m per<br />
filare. Per chiarezza le prove<br />
in questione sono denominate<br />
tesi 2 testimone (diserbo),<br />
tesi 2 lavorata, tesi 2<br />
<strong>SDS</strong>.<br />
Sullo spazio in capezzagna<br />
del vigneto Santa Caterina<br />
Alto (tesi 2) è stata installata<br />
una stazione meteorologica<br />
di precisione della ditta Davis<br />
Instruments modello<br />
WirelessVantageProII, modificata<br />
in maniera specifica<br />
per le prove con l’allestimento<br />
di tre sonde WatermarkSoil<br />
Moisture Sensor<br />
per il monitoraggio dei dati<br />
di umidità e temperaturadel<br />
suolo. Ciascuna delle tre<br />
sonde, tramite collegamento<br />
con tubazione corrugata<br />
sotterranea, è stata posizionata<br />
nelle tre prove di Tesi<br />
2, a una profondità di circa<br />
25 cm. La centralina di controllo<br />
meteo è stata configurata<br />
per la ricezione dei dati<br />
dalle 3 sonde installate con<br />
un intervallo impostato di 30<br />
minuti. La grande mole di<br />
dati registrata è stata inviata,<br />
tramite collegamento telefonico,<br />
dalla centralina alla<br />
base server aziendale, precedentemente<br />
allestita con<br />
apposito software per raccolta,<br />
elaborazione e rappresentazione<br />
grafica dei<br />
dati meteorologici ricevuti.<br />
In Fig. 6a e 6b vengono riportati<br />
due interessanti gra<br />
46 m&ma-n.9-2010
Fig. 6a-b - Umidità del suolo misurata con sensore Watermark in condizioni di diversa gestione della zona sottofilare<br />
Livello di tensione dell'acqua<br />
nel suolo (centibar)<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
21/07/2009<br />
20/07/2009<br />
Controllo<br />
chimico<br />
22/07/2009<br />
24/07/2009<br />
23/07/2009<br />
Lavorazione<br />
sottofilare<br />
27/07/2009<br />
26/07/2009<br />
fici elaborati durante le prove<br />
sperimentali che bene<br />
riescono a identificare e sottolineare<br />
il comportamento<br />
dello strato pacciamante<br />
creato dalla <strong>SDS</strong> sulle dinamiche<br />
dei livelli di umidità nei<br />
primi centimetri di suolo in<br />
vigneto.<br />
Secondo la letteratura<br />
scientifica, come riferimento<br />
per i risultati presentati<br />
possono essere presi ad<br />
esempio valori da 0 a 20<br />
centibar per indicare lo stato<br />
del terreno nella condizione<br />
che va dalla saturazione<br />
alla capacità di campo<br />
(acqua gravitazionale o drenabile),<br />
valori intorno a 30<br />
centibar per identificare<br />
convenzionalmente lo stato<br />
di capacità di campo del terreno,<br />
al quale la capacità di<br />
29/07/2009<br />
28/07/2009<br />
01/08/2009<br />
31/07/2009<br />
02/08/2009<br />
Pacciamatura<br />
sottofilare con <strong>SDS</strong><br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
03/08/2009<br />
Pioggia (mm)<br />
Pioggia<br />
ritenzione è massima, l’aria<br />
occupa i macropori e le<br />
piante devono vincere pressioni<br />
negative svolgendo in<br />
maniera ottimale tutte le attività<br />
fisiologiche.<br />
Salendo nella scala dei valori<br />
di riferimento il terreno va incontro<br />
a progressivo disseccamento<br />
per perdita di<br />
umidità (con intensità diverse<br />
in base al tipo di coltura)<br />
fino a raggiungere il valore<br />
limite della scala pari a 200<br />
centibar corrispondente, in<br />
linea teorica, alla soglia di intervento<br />
per irrigazione delle<br />
colture arboree in una gestione<br />
di Regulated Deficit<br />
irrigation, (Goodwin I., Boland<br />
A.M.(2002): Scheduling<br />
deficit irrigation of fruit<br />
trees for optimizing water<br />
use efficiency. FAO Water<br />
Reports n. 22, pp.6778).<br />
Quindi, per valori di tensione<br />
vicini allo 0 centibar la pianta<br />
deve svolgere un lavoro minimo<br />
per l’assorbimento di<br />
acqua, mentre per valori superiori<br />
a 100 centibar il lavoro<br />
richiesto aumenta, anche<br />
notevolmente, a seconda<br />
della specie e della cultivar.<br />
Durante il periodo di osservazione<br />
in assenza di piogge<br />
(Fig. 6a) è facile notare come<br />
lo strato pacciamante dell’operatrice<br />
<strong>SDS</strong> (Tesi 3) riesca,<br />
nonostante l’assenza di<br />
eventi meteorici, a mantenere<br />
un costante livello di umidità<br />
nel terreno che resta<br />
compreso nell’ intervallo 20<br />
120 centibar rispetto alle altre<br />
due tesi di confronto che<br />
rispettivamente tendono a<br />
un maggiore disseccamento<br />
dello strato superficiale di<br />
suolo in ragione del +30%<br />
circa per Tesi 2, e del +60%<br />
circa per Tesi 3.<br />
Lo stesso fenomeno mostrato<br />
si ripete nel periodo di<br />
monitoraggio di Fig. 6b caratterizzato<br />
da ripetuti fenomeni<br />
atmosferici di intensità<br />
non trascurabile. Si può notare<br />
inizialmente come il<br />
trattamento di diserbo chimico<br />
di Tesi 1 porti a una<br />
condizione di suolo pressoché<br />
impermeabile, negando<br />
al terreno la possibilità di<br />
assorbire qualsiasi quantitativo<br />
di acqua meteorica (in<br />
dipendenza ovviamente anche<br />
al tipo di terreno pre<br />
TECNICA<br />
sente nel vigneto sperimentale).<br />
Al contrario la lavorazione<br />
del suolo (tesi 2) e la<br />
pacciamatura sottofilare<br />
(tesi 3) mostrano di recepire<br />
le acque meteoriche con<br />
differenze trascurabili tra loro.<br />
Rimane invece marcato il<br />
divario nel mantenimento<br />
delle condizioni di umidità<br />
dei primi strati di suolo, condizione<br />
nella quale lo strato<br />
pacciamante riesce a garantire<br />
un più prolungata disponibilità<br />
idrica alle piante.<br />
Nel complesso i primi risultati<br />
ottenuti sembrano confermare<br />
l’interessante possibilità<br />
offerta dalla gestione<br />
della zona sottofilare mediante<br />
la trinciaandanatrice<br />
<strong>SDS</strong>, in ragione soprattutto<br />
della dimostrata capacità<br />
dello strato pacciamante<br />
andanato di contrastare lo<br />
sviluppo di infestanti e di assicurare<br />
nel tempo, anche in<br />
condizioni critiche per le riserve<br />
idriche del terreno,<br />
una condizione favorevole<br />
per lo sviluppo del vigneto. I<br />
vantaggi applicativi più immediati<br />
riscontrati sono<br />
quelli di una riduzione sensibile,<br />
e in casi come quello<br />
specifico del Chianti Classico<br />
di un annullamento, del<br />
numero di interventi di diserbo<br />
necessari al controllo<br />
delle infestanti e in aggiunta<br />
quelli di evitare, in base alle<br />
condizioni climatiche annuali,<br />
eventuali interventi di<br />
irrigazione localizzata. n<br />
m&ma-n.9-2010 47<br />
Livello di tensione dell'acqua nel suolo<br />
(centibar)<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
14/09/2009<br />
Controllo<br />
chimico<br />
15/09/2009<br />
16/09/2009<br />
Lavorazione<br />
sottofilare<br />
17/09/2009<br />
18/09/2009<br />
19/09/2009<br />
Pacciamatura<br />
sottofilare con <strong>SDS</strong><br />
Nel grafico A si evidenziano le condizioni di umidità in assenza di pioggia; nel grafico B invece i dati sono riferiti a periodo “piovoso”. L’andamento inverso della relazione tensione umidità è<br />
evidenziatodall’andamentodellecurveditensioneincorrispondenzadeglieventipiovosi.<br />
n Fig. 5 – Individuazione e georeferenziazione degli<br />
appezzamenti oggetto di sperimentazione. In rosso evidenziato<br />
il sito per Tesi 1, in giallo il sito per Tesi 2 e con il segnaposto<br />
arancio la posizione della centralina di controllo meteo.<br />
20/09/2009<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
Pioggia (mm)<br />
Pioggia