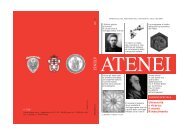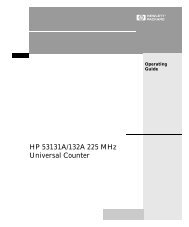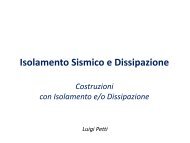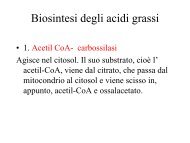Antichità Romane - Università degli Studi di Salerno
Antichità Romane - Università degli Studi di Salerno
Antichità Romane - Università degli Studi di Salerno
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
1 Corso <strong>di</strong><br />
Sito WEB:<br />
5. 3. Roma Organizzazione dal periodo dell’Italia arcaico romana al IV secolo http://www.dsa.unisa.it/Organigramma/<br />
a.C.<br />
Docenti/La_Greca/fernando_la_greca.php<br />
4<br />
<strong>Antichità</strong> <strong>Romane</strong><br />
A.a. 2009-2010<br />
Dott. Fernando La Greca<br />
flagreca@unisa.it<br />
Strabone e gli<br />
straripamenti<br />
del Salso<br />
- Le acque del Salso<br />
hanno proprietà<br />
calcaree e<br />
hanno formato<br />
nel tempo estesi<br />
e spessi banchi<br />
<strong>di</strong> tufo, nella<br />
piana e nella<br />
stessa città una<br />
volta<br />
abbandonata.<br />
11. Paestum romana (2)<br />
11. Paestum romana (2)<br />
Appunti ad esclusivo uso <strong>di</strong>dattico<br />
per gli studenti del corso<br />
(non sostituiscono i testi <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o)<br />
Dipartimento <strong>di</strong> Scienze dell’<strong>Antichità</strong><br />
<strong>Università</strong> <strong>degli</strong> <strong>Stu<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>Salerno</strong><br />
2<br />
11. Paestum romana (2)<br />
Strabone e gli<br />
straripamenti<br />
del Salso<br />
- Al tempo <strong>di</strong> Augusto il<br />
geografo Strabone scrive<br />
che la città <strong>di</strong> Paestum è<br />
resa insalubre da un fiume<br />
che nei suoi pressi si spande<br />
in palude.<br />
- Si tratta del fiumicello ora<br />
chiamato Salso o<br />
Capo<strong>di</strong>fiume, che scorre<br />
dalle colline <strong>di</strong> Capaccio<br />
Vecchia al mare con corso<br />
costante.<br />
5<br />
11. Paestum romana (2)<br />
Strabone e gli<br />
straripamenti<br />
del Salso<br />
- Molti autori hanno voluto<br />
vedere negli impaludamenti<br />
descritti da Strabone la<br />
causa <strong>di</strong> una presunta<br />
decadenza della città nel<br />
periodo imperiale e del suo<br />
definitivo abbandono nel<br />
me<strong>di</strong>oevo, ma sono<br />
contraddetti da numerose<br />
testimonianze letterarie ed<br />
archeologiche sulla vitalità<br />
della città fino in epoca<br />
tarda.<br />
3<br />
6<br />
11. Paestum romana (2)<br />
11. Paestum romana (2)<br />
Strabone e gli straripamenti<br />
del Salso<br />
- Il passo <strong>di</strong> Strabone va correttamente riferito solo al periodo successivo<br />
alla presenza <strong>di</strong> Annibale in Italia, e alla conseguente crisi delle regioni<br />
meri<strong>di</strong>onali: povertà, abbandono dei terreni, latifon<strong>di</strong>, calo demografico.<br />
- Tuttavia i Pestani ben potevano correre ai ripari, come avevano sempre fatto,<br />
e regolare il corso del fiume e delle acque.<br />
- La vittoria delle palu<strong>di</strong> si ebbe solo nel me<strong>di</strong>oevo, dopo l’abbandono della<br />
città, e non ne fu la causa, ma la conseguenza.
7<br />
11. Paestum romana (2)<br />
Dal I sec. a.C.<br />
al I sec. d.C.<br />
- La crisi del II sec. fu sicuramente superata nel I sec. a.C., come<br />
attestano molti documenti.<br />
- Viene completato il cd. Tempio della Pace, attribuito alla dea Mens, con un<br />
rifacimento dell’e<strong>di</strong>ficio precedente e forse della decorazione (metope).<br />
- Si avvia la costruzione e/o il restauro <strong>di</strong> numerosi e<strong>di</strong>fici.<br />
- La città continua a battere moneta, fino al tempo dei primi imperatori, e<br />
questo è un in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> floridezza.<br />
10<br />
11. Paestum romana (2)<br />
Dal I sec. a.C.<br />
al I sec. d.C.<br />
- La dea Mens acquista nel<br />
primo periodo imperiale<br />
l’appellativo Augusta, e<br />
viene a far parte delle<br />
<strong>di</strong>vinità vicine<br />
all’imperatore (es. ILP<br />
12).<br />
8<br />
11. Paestum romana (2)<br />
Dal I sec. a.C.<br />
al I sec. d.C.<br />
- La numismatica e l’epigrafia ci<br />
danno molte attestazioni del<br />
culto <strong>di</strong> Mens nel I sec. a.C.<br />
- Una moneta rappresenta la dea<br />
seduta in un tempio e<br />
leggente.<br />
11<br />
11. Paestum romana (2)<br />
Dal I sec. a.C.<br />
al I sec. d.C.<br />
- Nel I sec. a.C. era molto <strong>di</strong>ffuso nelle città<br />
dell’Italia l’evergetismo, ossia la<br />
munificenza privata, che attraverso la<br />
costruzione e/o il restauro <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici<br />
pubblici, assicurava alle classi <strong>di</strong>rigenti<br />
locali consenso e prestigio.<br />
- Verso il 15 a.C. la basilica <strong>di</strong> Paestum<br />
viene restaurata ed abbellita a spese <strong>di</strong><br />
una matrona, Mineia, moglie del senatore<br />
cesariano Cocceio Flacco.<br />
- Una moneta che celebra il restauro della<br />
basilica da parte <strong>di</strong> Mineia porta dal lato<br />
opposto la testa <strong>di</strong> Mens.<br />
9<br />
11. Paestum romana (2)<br />
Dal I sec. a.C.<br />
al I sec. d.C.<br />
- Alcune iscrizioni sono<br />
relative a basi sulle<br />
quali erano poste<br />
statue della dea Mens.<br />
- Es. ILP 10: L(ucius)<br />
Fundanius L(uci)<br />
l(libertus) Hermes /<br />
Mag(ister) / Bonae<br />
Menti sacrum.<br />
12<br />
11. Paestum romana (2)
13<br />
16<br />
11. Paestum romana (2)<br />
11. Paestum romana (2)<br />
Dal I sec. a.C.<br />
al I sec. d.C.<br />
- Nell’angolo nord-ovest<br />
del santuario<br />
meri<strong>di</strong>onale viene<br />
costruito fra<br />
repubblica e impero<br />
un impianto<br />
termale, <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>mensioni modeste<br />
ma importante per la<br />
sua centralità.<br />
- Fu restaurato più volte<br />
nel corso del III sec.<br />
d.C.<br />
14<br />
17<br />
11. Paestum romana (2)<br />
11. Paestum romana (2)<br />
Dal I sec. a.C.<br />
al I sec. d.C.<br />
- Verso la metà del I secolo<br />
a.C. i duoviri Clau<strong>di</strong>o<br />
e Sestilio curano<br />
l’installazione <strong>di</strong> una<br />
vasta rete idrica in<br />
città, con numerose<br />
fontane pubbliche e<br />
vasche.<br />
- Altri duoviri curano opere<br />
pubbliche deliberate e<br />
finanziate dal senato<br />
citta<strong>di</strong>no.<br />
Iscrizione su fontana pubblica,<br />
Paestum, I sec. a.C.<br />
15<br />
11. Paestum romana (2)<br />
Dal I sec. a.C.<br />
al I sec. d.C.<br />
- Mineia probabilmente fa<br />
restaurare anche il tempio <strong>di</strong><br />
Mens (cd. “Tempio della<br />
Pace”); alcuni magistri <strong>di</strong> Mens<br />
le de<strong>di</strong>cano un’iscrizione (ILP<br />
18).<br />
18<br />
Paestum, fontana<br />
pubblica e relative<br />
condutture <strong>di</strong><br />
piombo per<br />
l’alimentazione<br />
idrica<br />
11. Paestum romana (2)
19<br />
22<br />
11. Paestum romana (2)<br />
Paestum, condutture dell’acquedotto proveniente dalla collina <strong>di</strong> Capaccio<br />
11. Paestum romana (2)<br />
20<br />
23<br />
11. Paestum romana (2)<br />
Carta dei <strong>di</strong>ntorni <strong>di</strong> Paestum, 1769, con il percorso dell’acquedotto<br />
11. Paestum romana (2)<br />
Dal I sec. a.C.<br />
al I sec. d.C.<br />
- Nell’area della Piscina, interrata,<br />
sono costruiti una serie <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici<br />
de<strong>di</strong>cati al culto imperiale,<br />
curato dagli Augustales, per la<br />
famiglia Giulio-Clau<strong>di</strong>a e poi per<br />
altre <strong>di</strong>nastie.<br />
- Da questi e<strong>di</strong>fici provengono<br />
sculture, statue, iscrizioni (ad es.<br />
l’altare de<strong>di</strong>cato dall’augustale<br />
Aviano).<br />
- Il culto imperiale è comunque<br />
pervasivo, ed è attestato in tutti gli<br />
spazi pubblici <strong>di</strong> ogni città.<br />
21<br />
Dal I sec. a.C.<br />
al I sec. d.C.<br />
11. Paestum romana (2)<br />
- Incerta è la<br />
cronologia<br />
dell’anfiteatro,<br />
probabilmente<br />
costruito nella<br />
tarda repubblica<br />
presso il foro (dove<br />
si tenevano già in<br />
precedenza<br />
spettacoli in<br />
ambiente italico) e<br />
poi restaurato e<br />
ampliato in età<br />
imperiale flavia.<br />
24<br />
11. Paestum romana (2)<br />
Dal I sec. a.C.<br />
al I sec. d.C.<br />
- Il santuario <strong>di</strong> Venere in località<br />
Santa Venera viene ricostruito /<br />
restaurato ed abbellito a cura <strong>di</strong><br />
due sacerdotesse, prima Sabina,<br />
moglie <strong>di</strong> un Flacceius Flaccus, poi<br />
Valeria, nipote <strong>di</strong> Sabina.<br />
- Numerose sono le statue <strong>di</strong> Afro<strong>di</strong>te<br />
- Venere rinvenute nel santuario.<br />
C’è probabilmente anche un<br />
rinnovamento dei riti, in senso<br />
orientale e misterico.
25<br />
11. Paestum romana (2)<br />
Dal I sec. a.C.<br />
al I sec. d.C.<br />
- Nelle case <strong>di</strong> età imperiale<br />
dell’aristocrazia pestana<br />
si sviluppano<br />
ulteriormente i modelli<br />
ellenistici: grande<br />
peristilio e giar<strong>di</strong>no<br />
interno, sculture e giochi<br />
d’acqua, terme private,<br />
spazi de<strong>di</strong>cati al lusso e<br />
all’otium.<br />
- Un esempio <strong>di</strong> questa<br />
nuova concezione è la cd.<br />
“Casa della Piscina”, <strong>di</strong> I-<br />
II sec. d.C.<br />
28<br />
11. Paestum romana (2)<br />
I roseti <strong>di</strong> Paestum<br />
Fra i tanti scrittori antichi, il<br />
primo a parlarci delle rose <strong>di</strong><br />
Paestum è Virgilio (Georgiche,<br />
IV, 116-124):<br />
>.<br />
26<br />
11. Paestum romana (2)<br />
Dal I sec. a.C.<br />
al I sec. d.C.<br />
- L’arredo scultoreo delle<br />
case imperiali evoca<br />
ricchezza e cultura, e<br />
<strong>di</strong>venta un elemento<br />
in<strong>di</strong>spensabile dell’autorappresentazione<br />
delle classi <strong>di</strong>rigenti.<br />
- Sono comunque sculture<br />
realizzate in serie, “<strong>di</strong><br />
moda”, molto <strong>di</strong>ffuse<br />
nelle città romane fra le<br />
classi me<strong>di</strong>o-alte.<br />
29<br />
I roseti <strong>di</strong><br />
Paestum<br />
- Questa fama<br />
presuppone una<br />
precedente e<br />
prolungata<br />
produzione, forse<br />
già dalla<br />
fondazione della<br />
colonia, se non<br />
prima.<br />
11. Paestum romana (2)<br />
Festoni <strong>di</strong> rose nelle tombe<br />
lucane <strong>di</strong> Paestum<br />
Donne-fiore dagli scavi <strong>di</strong><br />
Foce Sele<br />
27<br />
11. Paestum romana (2)<br />
I roseti <strong>di</strong> Paestum<br />
- Alla seconda metà del I sec. a.C.<br />
appartengono le più antiche<br />
testimonianze sui roseti <strong>di</strong><br />
Paestum: ne parlano Virgilio,<br />
Properzio, Ovi<strong>di</strong>o.<br />
- Si tratta <strong>di</strong> colture <strong>di</strong> rose<br />
propriamente pestane, coltivate<br />
a Paestum, e visibili per chi<br />
visitasse allora la città.<br />
30<br />
Pompei, affreschi dalla “Casa<br />
del Bracciale d’oro”<br />
11. Paestum romana (2)<br />
I roseti <strong>di</strong> Paestum<br />
- Delle rose pestane parlano<br />
nel secolo successivo (I<br />
d.C.) Columella e<br />
Marziale.<br />
- Sono attestate ancora<br />
colture fiorenti, e<br />
un’organizzazione<br />
produttiva e<br />
commerciale che le<br />
faceva giungere a Roma<br />
anche d’inverno.<br />
Marziale (I-II sec. d.C.), Epigrammi, VI, 80:<br />
.
31<br />
11. Paestum romana (2)<br />
I roseti <strong>di</strong> Paestum<br />
- Oltre alle rose è attestata la<br />
produzione <strong>di</strong> fiori (viole,<br />
ligustri), che copriva ampie<br />
<strong>di</strong>stese coltivate (arva, rura).<br />
- Dobbiamo immaginare quin<strong>di</strong><br />
non terreni paludosi, ma<br />
asciutti, fertili, ben coltivati<br />
dal costante labor dei<br />
pestani.<br />
34<br />
11. Paestum romana (2)<br />
I roseti <strong>di</strong> Paestum<br />
- Come spiegare il successo sul<br />
mercato (antico) delle rose e<br />
dei fiori <strong>di</strong> Paestum?<br />
- Forse si trattò <strong>di</strong> una antica<br />
operazione <strong>di</strong> marketing:<br />
poiché Omero ed il mito<br />
ponevano le Sirene su<br />
un’isola fiorita, identificata<br />
con Licosa, cosa c’era <strong>di</strong><br />
meglio, per un’azienda sita a<br />
Paestum presso il santuario<br />
della sirena Leucosia, che<br />
produrre rose, fiori, e<br />
profumi “delle Sirene”?<br />
32<br />
11. Paestum romana (2)<br />
I roseti <strong>di</strong> Paestum<br />
- Parte della produzione <strong>di</strong> rose e <strong>di</strong> fiori<br />
doveva essere spe<strong>di</strong>ta nei mercati via<br />
mare, con collaudate operazioni <strong>di</strong><br />
marketing.<br />
- Il rimanente era utilizzato per la<br />
produzione in loco <strong>di</strong> profumi,<br />
unguenti, me<strong>di</strong>cinali, a base <strong>di</strong> olio <strong>di</strong><br />
oliva.<br />
- Notevole è la presenza <strong>di</strong> una<br />
profumeria nel foro <strong>di</strong> Paestum, con<br />
una base <strong>di</strong> torchio, recentemente<br />
stu<strong>di</strong>ata.<br />
35<br />
L’antica<br />
Rosa<br />
Pestana<br />
era <strong>di</strong> un<br />
rosso<br />
intenso,<br />
molto<br />
profumata<br />
e in grado<br />
<strong>di</strong> fiorire<br />
due volte<br />
in un<br />
anno.<br />
11. Paestum romana (2)<br />
33<br />
36<br />
Torchio per 11. olio Paestum e profumi romana (2)<br />
Foro <strong>di</strong> Paestum<br />
11. Paestum romana (2)<br />
In base alle fonti antiche,<br />
specialmente Enno<strong>di</strong>o, sono<br />
stati promossi <strong>degli</strong><br />
esperimenti per riprodurre la<br />
rosa pestana, con innesto <strong>di</strong><br />
rose su rovo e su<br />
biancospino (e in generale<br />
su piante spinose delle<br />
rosacee).
37<br />
11. Paestum romana (2)<br />
L’esperimento <strong>di</strong> innesto sul<br />
biancospino è perfettamente<br />
riuscito, e sembra spiegare il<br />
costante labor dei pestani<br />
per far sì che le “spine”<br />
producessero rose...<br />
40<br />
11. Paestum romana (2)<br />
Dal I sec. a.C.<br />
al I sec. d.C.<br />
- Nelle sue composizioni poetiche,<br />
Orazio parla più volte della Lucania<br />
(lui stesso, <strong>di</strong> Venosa, si definisce<br />
sia Apulo che Lucano).<br />
- In Epist., I, 15, Orazio chiede<br />
informazioni all’amico Numonio<br />
Vala, possessore <strong>di</strong> ville nella<br />
regione, informazioni sul clima <strong>di</strong><br />
<strong>Salerno</strong> e <strong>di</strong> Velia, per passarvi<br />
una vacanza.<br />
- Nelle Satire (II, 3 e II, 8), ricorda le<br />
fatiche dei cacciatori <strong>di</strong> cinghiali in<br />
Lucania, che pernottano fra le nevi,<br />
per non far mancare questo cibo<br />
sulla mensa dei ricchi.<br />
38<br />
11. Paestum romana (2)<br />
Dal I sec. a.C.<br />
al I sec. d.C.<br />
- Tutto ciò che si è detto<br />
testimonia anche la<br />
presenza e la vitalità del<br />
porto o dei porti <strong>di</strong><br />
Paestum, dovunque si<br />
vogliano collocare<br />
(sommersi nel mare;<br />
sotto le dune fra la città<br />
e il mare; nella antica<br />
laguna nei pressi <strong>di</strong><br />
porta Marina; ai lati del<br />
promontorio <strong>di</strong> Agropoli;<br />
alla foce del Solofrone;<br />
alla foce del Sele e lungo<br />
il suo corso).<br />
41<br />
Dal I sec. a.C.<br />
al I sec. d.C.<br />
- Dagli scavi sono<br />
emerse due testeritratto<br />
marmoree<br />
<strong>di</strong> ottima fattura,<br />
dell’imperatore<br />
Tiberio e della<br />
madre Livia<br />
(moglie <strong>di</strong><br />
Augusto).<br />
11. Paestum romana (2)<br />
39<br />
11. Paestum romana (2)<br />
Dal I sec. a.C.<br />
al I sec. d.C.<br />
- Numerosi personaggi e<br />
gentes prestigiose sono<br />
presenti a Paestum fra il I<br />
sec. a.C. e il I d.C.;<br />
numerosi sono anche i<br />
patroni collegati con<br />
Roma, che potevano<br />
procurare benefici alla<br />
città.<br />
- Fra questi c’è forse il ricco<br />
Numonio Vala amico del<br />
poeta Orazio e<br />
destinatario <strong>di</strong> alcune sue<br />
composizioni.<br />
42<br />
Dal I sec. a.C.<br />
al I sec. d.C.<br />
11. Paestum romana (2)<br />
- Altre due statue quasi<br />
complete <strong>di</strong> Tiberio<br />
e <strong>di</strong> Livia<br />
provenienti da<br />
Paestum sono al<br />
museo <strong>di</strong> Madrid<br />
(furono scavate<br />
durante la<br />
costruzione della<br />
linea ferroviaria<br />
dopo l’unità d’Italia,<br />
appaltata al<br />
marchese <strong>di</strong><br />
Salamanca).
43<br />
11. Paestum romana (2)<br />
Dal I sec. a.C.<br />
al I sec. d.C.<br />
- In una grande statua <strong>di</strong> togato è stata<br />
vista la raffigurazione<br />
dell’imperatore Clau<strong>di</strong>o.<br />
- In queste statue si riflette il lealismo e<br />
la devozione della città verso gli<br />
imperatori Giulio-Clau<strong>di</strong>, con qualche<br />
indubbio vantaggio per la<br />
citta<strong>di</strong>nanza.<br />
46<br />
11. Paestum romana (2)<br />
L’allevamento suino<br />
- Appare plausibile che nelle zone<br />
boscose sia stato rilevante, come in<br />
tutta la Lucania antica, l’allevamento<br />
dei maiali e la produzione <strong>di</strong><br />
lucaniche, salsicce <strong>di</strong> carne porcina<br />
affumicata molto richieste sulle tavole<br />
romane.<br />
44<br />
11. Paestum romana (2)<br />
Dal I sec. a.C.<br />
al I sec. d.C.<br />
- Il territorio <strong>di</strong> Paestum va<br />
compreso tra il fiume Sele a Nord<br />
e, a Sud, il promontorio <strong>di</strong><br />
Agropoli, o meglio l’isolotto <strong>di</strong><br />
Licosa, sede del culto della sirena<br />
Leucosia/Leucotea, comune ai<br />
Pestani ed ai Velini.<br />
- Il territorio si estendeva poi verso<br />
l’interno, sia nella valle del<br />
Calore, sia nelle valli dell’attuale<br />
Cilento, e faceva parte della<br />
regione denominata Lucania e<br />
Bruzio.<br />
47<br />
11. Paestum romana (2)<br />
La Lucania antica aveva un<br />
prodotto “tipico”: le lucaniche,<br />
ossia le salsicce <strong>di</strong> carne porcina.<br />
Furono chiamate così perché i<br />
Romani le assaggiarono per la prima<br />
volta conquistando la Lucania<br />
(contro Taranto e Pirro: 282-272<br />
a.C.), e ne furono conquistati.<br />
Nella stessa occasione<br />
conobbero l’elefante, e lo<br />
chiamarono “luca bos”, bue<br />
lucano.<br />
Nella stessa occasione<br />
coniarono una moneta<br />
(“quadrilatero”) con elefante e<br />
scrofa.<br />
45<br />
48<br />
11. Paestum romana (2) Strade <strong>di</strong> collegamento<br />
romane fra Paestum e Velia<br />
nel Cilento<br />
11. Paestum romana (2)<br />
Polibio (II sec. a.C.) ci<br />
attesta il più antico modo <strong>di</strong><br />
allevare i maiali in Italia<br />
(Storie, XII, 4). Essi ogni<br />
mattina, da più proprietari,<br />
sono condotti dalle stalle ai<br />
pascoli comuni, nei querceti.<br />
La sera i pastori con la<br />
tromba intonano musiche<br />
<strong>di</strong>verse, ed i maiali,<br />
riconoscendo il suono, si<br />
separano seguendo ciascuno<br />
il loro padrone fin nella<br />
stalla.
49<br />
11. Paestum romana (2)<br />
Le lucaniche erano fatte con<br />
un impasto <strong>di</strong> carne porcina ben<br />
tritata (1/3 grassa, 2/3 magra),<br />
sale, erbe aromatiche me<strong>di</strong>terranee<br />
(ruta, prezzemolo, alloro,<br />
finocchio), vino; l’impasto era<br />
insaccato in un budello lungo e<br />
sottile, infine sospeso al fumo.<br />
Questa ricetta ci è data dal<br />
buongustaio Apicio, vissuto al<br />
tempo <strong>di</strong> Augusto (De re<br />
coquinaria, II, 4), ed è qui riportata<br />
con le varianti dalla tra<strong>di</strong>zione<br />
popolare cilentana.<br />
52<br />
11. Paestum romana (2)<br />
Nell’operetta “Descrizione <strong>di</strong><br />
tutto il mondo” (IV sec.<br />
d.C.), 53 si <strong>di</strong>ce:<br />
.<br />
La carne <strong>di</strong> maiale servì in<br />
epoca tarda anche a pagare<br />
le tasse, insieme al vino.<br />
50<br />
11. Paestum romana (2)<br />
Nelle lucaniche, erbe e spezie<br />
mescolate con la carne hanno un’azione<br />
antiossidante, batteriostatica ed<br />
antibiotica. Si produce acido lattico, che<br />
agisce da conservante ed esalta l’aroma.<br />
La sospensione al fumo crea una barriera<br />
contro insetti e batteri.<br />
I processi chimico-biologici<br />
fondamentali erano noti agli antichi<br />
agronomi ed agli addetti alla lavorazione<br />
<strong>degli</strong> alimenti: grazie alla loro attività,<br />
l’inverno non esisteva...<br />
Ciò era <strong>di</strong> grande importanza per i<br />
rifornimenti alimentari dell’esercito<br />
(600.000 uomini lungo le frontiere): cibi<br />
svariati con conservanti naturali a base <strong>di</strong><br />
acido acetico, cloruro <strong>di</strong> so<strong>di</strong>o, fermenti<br />
lattici, lieviti.<br />
53<br />
11. Paestum romana (2)<br />
L’allevamento suino era uno<br />
dei più red<strong>di</strong>tizi in<br />
assoluto; secondo Varrone<br />
un gregge-modello con 100<br />
scrofe e 10 verri, una volta<br />
entrato a regime,<br />
assicurava circa 1600<br />
maiali all’anno da vendere<br />
una volta raggiunto il loro<br />
peso massimo.<br />
La zootecnia romana aveva<br />
raggiunto buoni livelli<br />
tecnologici, stu<strong>di</strong>ando<br />
razze, cibi, infrastrutture,<br />
processi <strong>di</strong> crescita, costi e<br />
benefici.<br />
51<br />
11. Paestum romana (2)<br />
Tutti i Romani erano ghiotti <strong>di</strong><br />
lucaniche, da Cicerone, che le<br />
gustava insieme alle olive ver<strong>di</strong> (Ad<br />
Famil., IX, 16), all’imperatore<br />
Caracalla (Historia Augusta,<br />
Caracall., 5, 6).<br />
Una volta, scherzando, Caracalla<br />
<strong>di</strong>sse in senato: io ho vinto i<br />
Germani, e mi avete chiamato<br />
Germanico. E se avessi vinto i<br />
Lucani? Mi avreste chiamato forse<br />
Lucanico? (ossia, per i Romani <strong>di</strong><br />
allora, “Salsicciotto”).<br />
54<br />
Ricostruzione <strong>di</strong> un<br />
allevamento <strong>di</strong> suini<br />
nella villa romana <strong>di</strong><br />
Settefinestre<br />
(Orbetello, Toscana)<br />
11. Paestum romana (2)
55<br />
11. Paestum romana (2)<br />
La carne <strong>di</strong> maiale era quella <strong>di</strong><br />
maggior consumo nel mondo<br />
romano. L’imperatore Clau<strong>di</strong>o<br />
affermò in senato che era<br />
impossibile vivere senza la<br />
carne <strong>di</strong> maiale salata.<br />
Me<strong>di</strong>ci e <strong>di</strong>etologi (Galeno)<br />
affermavano che la carne <strong>di</strong><br />
maiale adulto era fra tutti i cibi<br />
l’alimento più nutriente, più<br />
<strong>di</strong>geribile e più adatto alla<br />
conservazione.<br />
Per questo era particolarmente<br />
consigliata per gli atleti, ed<br />
assicurava alte prestazioni.<br />
58<br />
11. Paestum romana (2)<br />
Ricostruendo ipoteticamente quanto detto nei termini del<br />
moderno marketing, gli antichi operatori:<br />
1) avevano creato il bisogno coinvolgendo gli eserciti<br />
romani <strong>di</strong> passaggio;<br />
2) avevano creato il marchio “lucanica”;<br />
3) avevano coinvolto me<strong>di</strong>ci, <strong>di</strong>etologi, sportivi per una<br />
pubblicità “scientifica” sulla carne porcina;<br />
4) avevano messo su allevamenti DOC puntando sulla<br />
tecnologia e sulla qualità;<br />
5) avevano creato una corporazione, i suarii, che si<br />
occupava <strong>di</strong> tutti i passaggi interme<strong>di</strong> fra allevatori e<br />
produttori, e imponeva i prezzi in una situazione <strong>di</strong><br />
quasi-monopolio.<br />
Qualcosa <strong>di</strong> simile era stato fatto anche per le rose ed i<br />
fiori <strong>di</strong> Paestum. Perché invece oggi gli operatori attuali<br />
non sanno valorizzare questa ricchezza che viene dal<br />
passato, dalla storia?<br />
56<br />
11. Paestum romana (2)<br />
Per il commercio della carne <strong>di</strong><br />
maiale a Roma fu creata una<br />
apposita corporazione, quella<br />
dei suarii, che curava la<br />
raccolta (anche sotto forma <strong>di</strong><br />
tasse) il trasporto a Roma <strong>degli</strong><br />
animali vivi, la ven<strong>di</strong>ta<br />
all’ingrosso, la macellazione, la<br />
ven<strong>di</strong>ta al dettaglio.<br />
A volte sorgevano controversie tra<br />
gli allevatori lucani e il fisco: ad<br />
esempio, a chi addebitare la<br />
per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> peso <strong>degli</strong> animali<br />
durante il tragitto dalla Lucania<br />
a Roma?<br />
59<br />
11. Paestum romana (2)<br />
Prodotti dell’antica Lucania<br />
e valorizzazione o<strong>di</strong>erna<br />
Noi con<strong>di</strong>vi<strong>di</strong>amo con gli antichi lo<br />
stesso territorio, e la conoscenza della<br />
storia e delle risorse economiche che gli<br />
antichi traevano dal territorio è importante<br />
per valorizzare ed utilizzare ancora oggi<br />
queste stesse risorse, per renderle <strong>di</strong> nuovo<br />
fonti <strong>di</strong> ricchezza e <strong>di</strong> sviluppo.<br />
Non solo i monumenti, ma anche i<br />
prodotti agroalimentari dell’antica<br />
Lucania e dell’antica Paestum (le rose, le<br />
lucaniche…) sono beni culturali,<br />
determinanti per la crescita, la ricchezza, la<br />
sopravvivenza <strong>degli</strong> abitanti del territorio<br />
nella storia.<br />
57<br />
11. Paestum romana (2)<br />
E<strong>di</strong>tto dei prezzi <strong>di</strong> Diocleziano (301 d.C.):<br />
Salsiccia comune: 6 denarii al kg<br />
Lucanica: 30 denarii al kg<br />
Carne <strong>di</strong> maiale o lardo: 36 denarii al kg<br />
Carne <strong>di</strong> bue o <strong>di</strong> capra: 24 denarii al kg<br />
Carne <strong>di</strong> maiale salata: 48 denarii al kg<br />
Prosciutto: 60 denarii al kg<br />
Salario giornaliero <strong>di</strong> un operaio: 25 denarii con vitto<br />
Salario giornaliero <strong>di</strong> un artigiano: 50 denarii con vitto<br />
Salario giornaliero <strong>di</strong> un maestro elementare: 50 denarii per 30 allievi<br />
60<br />
11. Paestum romana (2)<br />
Prodotti dell’antica Lucania<br />
e valorizzazione o<strong>di</strong>erna<br />
Ogni territorio possiede almeno due <strong>di</strong>mensioni. Solitamente noi ve<strong>di</strong>amo<br />
la prima, quella geografica, a noi contemporanea.<br />
La seconda <strong>di</strong>mensione, importantissima, è la <strong>di</strong>mensione storica. Milioni<br />
<strong>di</strong> uomini, nel tempo, hanno abitato le nostre contrade. Come vivevano? Quali<br />
risorse sfruttavano? Come funzionava la loro economia?<br />
Il bello della <strong>di</strong>mensione storica è che le risposte sono tante, numerose,<br />
<strong>di</strong>verse secondo le epoche storiche. D’improvviso, il quadro si amplia, si fa<br />
ricco, e le risposte della <strong>di</strong>mensione storica, applicate alla realtà o<strong>di</strong>erna, ci<br />
aprono la mente e ci fanno capire che abbiamo numerose possibilità <strong>di</strong><br />
intervento e <strong>di</strong> sviluppo, sfruttando nel modo migliore le stesse risorse utilizzate<br />
dagli antichi nostri predecessori.
61<br />
11. Paestum romana (2)<br />
Prodotti della<br />
Lucania antica<br />
- foreste, legname, pece;<br />
- pascoli abbondanti;<br />
- allevamenti bovini;<br />
- all. <strong>di</strong> cavalle;<br />
- all. <strong>di</strong> maiali;<br />
- all. <strong>di</strong> capre e pecore;<br />
- vitigni, uva, vino;<br />
- frutta;<br />
- olive ver<strong>di</strong>, olio;<br />
- fiori, rose, viole;<br />
- ortaggi, cavoli, broccoli, erbe me<strong>di</strong>cinali;<br />
- grano, farro, ceci;<br />
- sorgenti e acque terapeutiche;<br />
- caccia (orsi, cinghiali);<br />
- pesca, tonni;<br />
- lavorazioni artigiane/industriali (lucaniche/salsicce, lardo, formaggi, cuoio, pelli, lana,<br />
tessuti, pesce salato, garum (salsa <strong>di</strong> pesce), profumi, unguenti, oggetti <strong>di</strong> vimini,<br />
carri agricoli, cantieri navali).<br />
62<br />
11. Paestum romana (2)<br />
Si potrebbe <strong>di</strong>re che questi prodotti esistevano anche altrove. Ma gli antichi<br />
abitanti della Lucania avevano dalla loro parte:<br />
- La Qualità, la ricerca del meglio per vendere anche su mercati lontani a<br />
prezzi alti (es. olio d’oliva denocciolata - vino da vitigni capaci <strong>di</strong> prosperare<br />
all’ombra - animali nutriti con cibi naturali e <strong>di</strong> grande qualità)<br />
- L’Inventiva, la capacità <strong>di</strong> abbinare prodotti <strong>di</strong>versi per avere qualcosa <strong>di</strong><br />
assolutamente unico (es. rose nuove derivate da innesti - rosatum, vino con<br />
petali <strong>di</strong> rose - latte me<strong>di</strong>cinale da animali nutriti con erbe me<strong>di</strong>cinali)<br />
- L’Iniziativa, l’intraprendenza economica, l’ispirazione del marketing alla<br />
tra<strong>di</strong>zione esistente (mito delle Sirene sull’isola fiorita).<br />
63<br />
11. Paestum romana (2)<br />
Prodotti antichi riproponibili:<br />
1) Olio extra vergine da olive<br />
denocciolate<br />
2) Rose e derivati (rosaceum,<br />
olio <strong>di</strong> rose, per la salute, la<br />
cosmesi, l’alimentazione;<br />
rosatum, vino alle rose);<br />
fiori; erbe me<strong>di</strong>cinali; miele<br />
3) Lucaniche, salsicce<br />
stagionate, fatte con carni<br />
suine <strong>di</strong> prima scelta, erbe<br />
aromatiche locali e vino<br />
4) Vino, <strong>di</strong> prima qualità, da<br />
vitigni selezionati, usato<br />
anche per le sue proprietà<br />
me<strong>di</strong>cinali<br />
5) Latte <strong>di</strong> capre nutrite con erbe<br />
me<strong>di</strong>cinali, denso, e formaggi<br />
vari, anche con miele<br />
6) Pesci <strong>di</strong> scoglio e pesce<br />
azzurro, salagione, garum<br />
7) Fichi secchi, al forno,<br />
aromatizzati, in varie<br />
preparazioni<br />
8) Ceci, <strong>di</strong> prima qualità, e farine<br />
per varie preparazioni, anche<br />
dolci<br />
9) Ortaggi, in particolare cavoli,<br />
broccoli, lattughe, cetrioli,<br />
cicorie, prezzemolo, asparagi