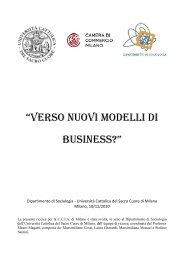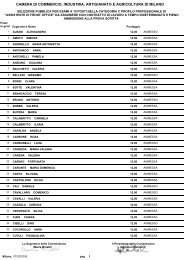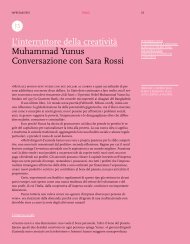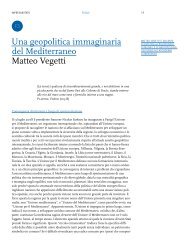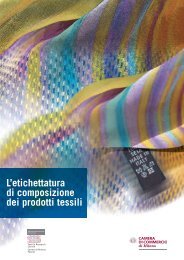Metamorfosi dell'abitare di Elena Granata* e Arturo Lanzani**
Metamorfosi dell'abitare di Elena Granata* e Arturo Lanzani**
Metamorfosi dell'abitare di Elena Granata* e Arturo Lanzani**
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Metamorfosi</strong> dell’abitare<br />
<strong>di</strong> <strong>Elena</strong> <strong>Granata*</strong> e <strong>Arturo</strong> <strong>Lanzani**</strong><br />
*Ricercatrice presso la Facoltà <strong>di</strong> Architettura e Società, Politecnico <strong>di</strong> Milano<br />
** Professore Associato presso La Facoltà <strong>di</strong> Architettura e Società, Politecnico<br />
Una rilettura <strong>di</strong> Milano<br />
<strong>di</strong> Milano<br />
Andare a vivere nella campagna urbana che circonda le gran<strong>di</strong> città, senza rinunciare<br />
ai benefici del vivere urbano. Fuggire dalle città per andare a vivere nel borgo.<br />
Rimanere a lungo presso la famiglia d’origine anche dopo avere terminato gli stu<strong>di</strong>.<br />
Accu<strong>di</strong>re i genitori anziani, inventando soluzioni abitative d’emergenza. Decidere <strong>di</strong><br />
sposarsi o avviare una relazione <strong>di</strong> coppia stabile, mantenendo ciascuno la propria<br />
casa. Cercare comunità <strong>di</strong> simili con i quali instaurare rapporti <strong>di</strong> vicinato pacifici<br />
anche se artificiali. Tornare a scoprire alcune parti della città per il loro tono <strong>di</strong><br />
mescolanza, <strong>di</strong> varietà. Trascorrere la propria vita in bilico tra due case, tra due città,<br />
tra due tempi <strong>di</strong> vita alternativi.<br />
Le forme dell’abitare sono sempre più complesse. Se per un lungo tempo che ci ha<br />
appena preceduto la casa era un dato, un sito naturale che ospitava la famiglia e il<br />
suo futuro, un elemento <strong>di</strong> stabilità legato a un progetto e al suo sviluppo; se la casa<br />
era il segno esplicito <strong>di</strong> uno status, <strong>di</strong> una posizione sociale. Raggiunta o mancata.<br />
Oggi non sono più così certe quelle variabili che rendevano vera quell’equazione:<br />
lavoro, casa, famiglia, luogo. Il fatto più evidente è certamente il venire meno della<br />
linearità <strong>di</strong> alcune sequenze, quella che Sennet definisce “la linearità del tempo delle<br />
nostre vite”: anni e anni passati intorno a un lavoro sempre uguale, un giorno uguale<br />
all’altro, “e in un tempo lineare i risultati sono cumulativi: Enrico e Flavia<br />
controllavano ogni settimana l’incremento dei loro risparmi, e misuravano la loro vita<br />
domestica nei termini dei miglioramenti e ampliamenti che apportavano alla loro<br />
villetta. In definitiva, vivevano in modo pre<strong>di</strong>cibile” 1 .<br />
L’abitare è oggi una pratica sempre meno corredata e supportata da una tra<strong>di</strong>zione in<br />
grado <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care percorsi certi, che assume sempre più i toni del mestiere. Un<br />
mestiere che attiva capacità molteplici, che impegna intorno alla ridefinizione <strong>di</strong> un<br />
luogo privato <strong>di</strong> vita (la casa nelle sue multiformi valenze), ma anche alla ricerca <strong>di</strong><br />
una <strong>di</strong>mensione relazionale del vivere, come occasione per entrare in relazione con<br />
altri e con<strong>di</strong>videre un certo numero <strong>di</strong> valori comuni, per fare amicizia con un<br />
ambiente naturale. Non tragico come il “mestiere <strong>di</strong> vivere” <strong>di</strong> Pavese, ma neppure<br />
effimero come quello della continua e selettiva <strong>di</strong>stinzione del proprio stile <strong>di</strong> vita,<br />
secondo logiche assimilabili a quelle della personalizzazione del prodotto,<br />
dell’in<strong>di</strong>vidualismo <strong>di</strong> massa dei consumi contemporanei. Spesso <strong>di</strong>fficile, faticoso,<br />
pieno <strong>di</strong> aspettative e delusioni 2 .<br />
Un “mestiere” che si costruisce più con esperienza e arguzia tattica, che con un<br />
progetto e una strategia (come ci insegna magistralmente de Certeau 2001), che, in<br />
senso figurato (come appunto nel caso del “mestiere <strong>di</strong> vivere”), rinvia a <strong>di</strong>mensione<br />
<strong>di</strong> capacità e <strong>di</strong> abilità che sfumano altri significati legati a una pratica appresa dal<br />
passato.<br />
Dove, come, con chi, sono variabili che possono mutare nel corso dell’esistenza.<br />
Anche con una certa frequenza. Ma soprattutto sono terreno <strong>di</strong> scelte e opzioni. La
scelta, ad esempio, concernente il “dove” stabilire una parte della vita, o quanto meno<br />
alcuni tempi <strong>di</strong> essa, è una delle opzioni che si possono giocare nel percorso che<br />
conduce alla ricerca del benessere, dello stare bene; il “dove” <strong>di</strong>viene una variabile<br />
importante, non si tratta più solo della ricerca <strong>di</strong> un bene posizionale ma è legato allo<br />
schiudersi <strong>di</strong> possibilità: quella <strong>di</strong> raggiungere una con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> vita più felice (magari<br />
solo presunta), <strong>di</strong> incrociare altri destini, <strong>di</strong> immaginare tempi e spazi <strong>di</strong> vita<br />
maggiormente ospitali rispetto alle aspettative soggettive e familiari. Se da un lato,<br />
possiamo interpretare questo moltiplicarsi degli immaginari come una delle<br />
espressioni <strong>di</strong> quella <strong>di</strong>ffusa e continua rincorsa alla “<strong>di</strong>stinzione sociale del gusto” 3 ,<br />
tuttavia esso è anche in<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> una crescente “libertà” dell’abitare dentro un più vasto<br />
orizzonte <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidualizzazione e libertà 4 , <strong>di</strong> quella “<strong>di</strong>ffusa” pratica <strong>di</strong> invenzione del<br />
quoti<strong>di</strong>ano.<br />
Una libertà e una invenzione che tuttavia a Milano si confronta con un campo assai<br />
strutturato che presenta molti vincoli, molti duri con<strong>di</strong>zionamenti e offre poche prese,<br />
che risulta fortemente <strong>di</strong>fferenziato per soggetti con <strong>di</strong>verso capitale economico,<br />
culturale, relazionale. Questa particolare strutturazione del campo porta da un lato a<br />
esperienze e con<strong>di</strong>zioni dell’abitare non solo <strong>di</strong>verse, ma anche <strong>di</strong>seguali (da tempo<br />
Milano non conosceva con<strong>di</strong>zioni così <strong>di</strong>ffuse <strong>di</strong> coabitazione o un numero così elevato<br />
<strong>di</strong> baraccopoli), seppure in forme nuove poco preve<strong>di</strong>bili, e in particolare non più<br />
riconducibili a una classica immagine <strong>di</strong> periferia 5 , dall’altro si arricchisce (ancora una<br />
volta come in passato) dalla possibilità <strong>di</strong> darsi, <strong>di</strong> costruirsi in territori plurali (i tanti<br />
ambienti della regione urbana) ed entro materiali urbani <strong>di</strong>fferenti (l’enorme varietà <strong>di</strong><br />
oggetti <strong>di</strong> manufatti depositati al suolo) che presentano nella regione milanese una<br />
varietà, un sistema <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenze che nonostante l’azione omologante del mercato e<br />
della politica ha ancora pochi paragoni con quello <strong>di</strong> altre gran<strong>di</strong> metropoli 6 .<br />
La grammatica dell’abitare nelle sue stesse asimmetrie <strong>di</strong>venta, allora, una chiave <strong>di</strong><br />
volta importante per comprendere la città, il suo mutamento: le pratiche quoti<strong>di</strong>ane<br />
dell’abitare milanese scar<strong>di</strong>nano la rigi<strong>di</strong>tà dei gran<strong>di</strong> progetti urbani, aggirano e<br />
soverchiano la rigi<strong>di</strong>tà delle offerte del mercato; se osservate con attenzione ci<br />
consentono <strong>di</strong> tracciare il profilo <strong>di</strong> una varietà <strong>di</strong> famiglie, <strong>di</strong> lavori, <strong>di</strong> luoghi e <strong>di</strong><br />
proporre una rilettura <strong>di</strong> Milano, forse, almeno in parte, ine<strong>di</strong>ta, dando spazio a quella<br />
<strong>di</strong>mensione del quoti<strong>di</strong>ano troppo spesso negata da molti racconti del mutamento.<br />
La scomposizione dell’alloggio<br />
Le relazioni forti e univoche tra i termini della nostra equazione (famiglia, lavoro, casa<br />
luogo) sono naturalmente un prodotto storico. Nella prima modernità, tra il<br />
Cinquecento e l’inizio dell’Ottocento, pur nel loro costruirsi rimangono molto più<br />
aperte <strong>di</strong> quanto certe attuali letture un po’ ideologiche facciano credere 7 . Non solo, la<br />
stessa storia del Novecento italiano evidenzia modelli o perlomeno traiettorie <strong>di</strong><br />
modernizzazione assai <strong>di</strong>fferenziati e scarti notevoli rispetto a un ipotetico modello<br />
standard, anche nella regione milanese ad esempio nella famiglia-impresa/casaofficina/città-<br />
<strong>di</strong>ffusa della pianura asciutta dell’Alto milanese e della Brianza. Pur<br />
tuttavia quel legarsi in una equazione generale o meglio in tante traiettorie in<strong>di</strong>viduali<br />
lineari delinea un movimento <strong>di</strong>ffuso, una <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> sviluppo prevalente, una<br />
limitata possibilità <strong>di</strong> imprevisti accavallamenti tra queste variabili nella società<br />
milanese del secolo appena passato.<br />
Il termine famiglia che all’origine della modernità in<strong>di</strong>cava un insieme variegato <strong>di</strong><br />
soggetti che vivevano sotto lo stesso tetto e una medesima autorità e che<br />
successivamente a lungo si declinerà al plurale, nel novecento e in una realtà come<br />
quella milanese viene sempre più ricondotto al modello nucleare <strong>di</strong> famiglia (per<br />
quanto le reti famigliari rimangano anche a Milano assai rilevanti), anche<br />
nell’urbanizzazione fuori Milano, anche per chi arriva dalle montagne e pianure<br />
lombarde, dal Veneto o dal Mezzogiorno. Il matrimonio si lega sempre più all’atto <strong>di</strong><br />
“metter su casa” (rispetto all’andar a casa dei suoi); tanto che fare famiglia e metter<br />
su casa <strong>di</strong>ventano espressioni intercambiabili. La conquista <strong>di</strong> un posto <strong>di</strong> lavoro fuori<br />
dal settore agricolo si lega sempre più allo stabilizzarsi dei rapporti <strong>di</strong> lavoro,
specialmente nel settore pubblico e nelle me<strong>di</strong>e e gran<strong>di</strong> imprese industriali (ma in<br />
mo<strong>di</strong> <strong>di</strong>versi anche nella piccola impresa) e alla scelta <strong>di</strong> un nuovo luogo dove stare,<br />
un luogo ben connesso, ma non necessariamente prossimo al lavoro. Nello stesso<br />
tempo anche la piccola e me<strong>di</strong>a impresa dei <strong>di</strong>stretti intrametropolitani, pur nel<br />
quadro più aperto del progetto impren<strong>di</strong>toriale e della crescente competizione è in<br />
qualche misura anch’esso un posto: è ra<strong>di</strong>cata al suolo, si trasmette a figli, è centro <strong>di</strong><br />
relazioni (il “posto” è un luogo e al tempo stesso un lavoro/impresa stabile; è una<br />
àncora, potremmo <strong>di</strong>re del vivere-abitare). La casa, d’altra parte, come “insieme <strong>di</strong><br />
alloggi” già <strong>di</strong>ffusasi nell’e<strong>di</strong>lizia civile ottocentesca tuttavia si consolida, si <strong>di</strong>ffonde in<br />
tutta la nuova produzione e<strong>di</strong>lizia e quasi si “naturalizza” nella forma<br />
dell’appartamento negli anni trenta a Milano e solo negli anni cinquanta nei comuni<br />
esterni che ospitano una quota rilevante della crescita della metropoli. All’interno<br />
dell’alloggio infine si definisce tra gli anni Trenta e i primi anni Sessanta una<br />
organizzazione dello spazio standard con la sud<strong>di</strong>visione tra una zona notte e una<br />
giorno, tra spazi in<strong>di</strong>viduali e <strong>di</strong> relazione, secondo un modello che ancora oggi guida<br />
la quasi totalità della produzione <strong>di</strong> mercato e pubblica.<br />
Non è <strong>di</strong>fficile dar conto <strong>di</strong> come oggi siano cambiate le con<strong>di</strong>zioni generali<br />
dell’abitare, anche suolo muovendo dalle singole variabili <strong>di</strong> quella equazione.<br />
Il lavoro è sempre meno stabile. Precarietà e flessibilità caratterizzano il lavoro meno<br />
qualificato e pagato (ad esempio il lavoro autonomo atipico, il lavoro nero nel terziario<br />
<strong>di</strong> servizio, ma anche parte del lavoro industriale e nella pubblica amministrazione che<br />
permane) così come molti lavori qualificati e intellettuali nel campo del design,<br />
dell’informatica, della moda. Milano e la regione urbana, continuano a dar lavoro e/o<br />
consentono l’impresa in<strong>di</strong>viduale (sono ancora uno straor<strong>di</strong>nario campo <strong>di</strong> possibilità<br />
<strong>di</strong> impresa e <strong>di</strong> lavoro, specie da chi guarda Milano da fuori), ma si tratta spesso <strong>di</strong> un<br />
lavoro esposto al rischio e alla precarietà (i tassi <strong>di</strong> mortalità delle nuove imprese sono<br />
elevati quasi quanto quelli <strong>di</strong> natalità) rende più <strong>di</strong>fficile la costruzione <strong>di</strong> un progetto<br />
<strong>di</strong> vita e abitativo più stabile; Milano è sempre più spesso una città che consente <strong>di</strong><br />
lavorare ma non <strong>di</strong> vivere 8 . Le conseguenze <strong>di</strong> questa precarizzazione del lavoro<br />
sull’abitare sono contrad<strong>di</strong>ttorie. Chi possiede una casa propria, bene <strong>di</strong> famiglia,<br />
risponde all’incertezza del futuro trasformando in rifugio quella casa e quella famiglia:<br />
da cui conseguono sempre più rallentati processi <strong>di</strong> autonomizzazione (coabitando con<br />
i genitori da adulti e inseriti nel mercato del lavoro, pur in un contesto metropolitano<br />
meno propenso a questa pratica rispetto a quello <strong>di</strong> altre zone d’Italia), ritardo nella<br />
scelta <strong>di</strong> metter su casa e <strong>di</strong> avere figli e una riduzione dei propri livelli <strong>di</strong> mobilità<br />
residenziale, lavorativa e relazionale 9 . Per chi non possiede una casa e viene da fuori e<br />
si impatta su uno dei mercati urbani abitativi con i valori più proibitivi a livello europeo<br />
la scelta quasi obbligatoria è la coabitazione cresciuta enormemente negli ultimi<br />
quin<strong>di</strong>ci anni, non solo tra immigrati extracomunitari o per qualche segmento <strong>di</strong> nuova<br />
immigrazione dal Mezzogiorno <strong>di</strong> Italia, ma anche tra nuovi lavoratori laureati italiani.<br />
L’alternativa appena si può è il riadattamento residenziale <strong>di</strong> spazi altri (il sottotetto,<br />
ma anche il negozio, il laboratorio) i cui costi sono leggermente inferiori oppure una<br />
fortissima compressione degli spazi abitati (che certo qualche legame ha con la scelta<br />
<strong>di</strong> ritardare fino a escludere la riproduzione generazionale).<br />
Nello stesso tempo la flessibilizzazione del lavoro, comporta il ritorno, seppure in<br />
forme <strong>di</strong>verse, <strong>di</strong> una relazione più stretta e <strong>di</strong> parziale sovrapposizione tra spazio <strong>di</strong><br />
residenza e <strong>di</strong> lavoro. Non solo in forme che hanno qualche analogia con quelle della<br />
casa-laboratorio <strong>di</strong> tipo storico artigianale o della piccola impresa <strong>di</strong>strettuale (ad<br />
esempio nel binomio casa piccolo ufficio affiancato), ma anche in parte ine<strong>di</strong>te con<br />
frammenti <strong>di</strong> lavoro che entrano più intimamente nella casa, campo base <strong>di</strong> un<br />
lavorare (<strong>di</strong>pendente o autonomo) sempre più itinerante.<br />
Il rapporto con il luogo cambia forse ancor più ra<strong>di</strong>calmente del lavoro e l’esperienza<br />
della mobilità connota un numero crescente <strong>di</strong> pratiche e <strong>di</strong> soggetti in essi coinvolti.<br />
Molto si potrebbe <strong>di</strong>re sulla <strong>di</strong>sarticolazione spaziale degli spazi <strong>di</strong> relazione della vita<br />
collettiva rispetto a quelli <strong>di</strong> prossimità e delle loro implicazioni sull’abitare e sul luogo<br />
dove si risiede dentro la regione urbana milanese, sui flussi e sulle navigazioni che<br />
emergono nello spazio della metropoli fuori dalle forme tra<strong>di</strong>zionali <strong>di</strong> pendolarismo<br />
casa-lavoro, nelle pratiche del consumo e del tempo libero, in nuove forme <strong>di</strong>
socialità, nel costituirsi <strong>di</strong> comunità <strong>di</strong> pratiche assai cangianti e fluttuanti, del<br />
significati mutevoli della prossimità 10 . In questa sede ci limitiamo a segnalare il<br />
carattere itinerante che talvolta assume la stessa residenza, in rapporto al lavoro. Gli<br />
uomini d’affari, ma anche alcuni lavoratori meno privilegiati dell’economia “innovativa”<br />
metropolitana sperimentano talvolta un abitare itinerante tra <strong>di</strong>verse città (dove si sta<br />
ora in appartamenti in proprietà, ora in case ammobiliate affittate da imprese o<br />
in<strong>di</strong>vidualmente ora in residence, ora per chi è nel segmento più basso <strong>di</strong> questa<br />
popolazione, sul sofà <strong>di</strong> un amico). Altri lavoratori “in proprio” o “a progetto” attirati<br />
da Milano da tutto il Nord Italia, ora per scelta, ora per i vincoli del mercato<br />
immobiliare milanese, ora per una combinazione <strong>di</strong> possibilità e <strong>di</strong> vincoli abitano due<br />
località: si abita la città <strong>di</strong> origine (Sondrio, Modena, Verona, Ivrea…) dove non solo si<br />
abita la casa <strong>di</strong> famiglia, ma dove ci si fa una propria nuova casa relativamente ampia<br />
e naturalmente si abita Milano, dove ora si coabita, ora si vive in uno spazio ibrido <strong>di</strong><br />
lavoro e <strong>di</strong> residenza (un piccolo ufficio-abitato), ora si mette su una delle due case<br />
(dagli spazi più contenuti, più funzionale, meno legata a un progetto-stile <strong>di</strong> vita che si<br />
esprime sempre più non solo con scelte lavorative, ma anche in stili/forme <strong>di</strong><br />
consumo, <strong>di</strong> gestione del tempo libero, <strong>di</strong> mobilità e appunto <strong>di</strong> residenza). Altri<br />
ancora tornano ad abitare case <strong>di</strong> famiglia ubicate altrove (ma accessibili in<br />
due/quattro ore), le case abbandonate dai genitori quando immigrati negli anni<br />
Cinquanta nell’area milanese, oppure seconde case “vicine” in Brianza, sui laghi, nelle<br />
zone della riviera e <strong>di</strong> montagna più accessibili, sempre meno abitate come case <strong>di</strong><br />
vacanza, ma in fine settimana lunghi, o stagionalmente. Altri ancora riducono gli spazi<br />
<strong>di</strong> residenza in Milano e fanno casa nel Monferrato, nell’Oltrepò, o in territori lenti<br />
semi-abbandonati dove più facilmente si esprime una <strong>di</strong>mensione personale e creativa<br />
dell’abitare 11 . In tutti i casi la vita <strong>di</strong> famiglia e il lavoro transita nelle due case,<br />
l’abitare si fa itinerante e si intreccia a un lavoro mobile nel territorio 12 . Le esperienze<br />
<strong>di</strong> abitare temporaneo a Milano sono in forte crescita anche per due altre <strong>di</strong>versissime<br />
ragioni. La prima è legata all’esclusione abitativa che investe segmenti rilevanti <strong>di</strong><br />
immigrazione clandestina e/o <strong>di</strong> terza ondata, più precaria e meno legata a una sicura<br />
offerta <strong>di</strong> lavoro e progetto migratorio, slegata dai ricongiungimenti familiari (sono<br />
circa 50.000 le persone ospitate nelle baraccopoli milanesi, secondo la ricerca<br />
Multiplicity, in corso <strong>di</strong> pubblicazione, a cui si affiancano sempre più numerosi posti<br />
letto). La seconda è legata a molti atipici consumatori non milanesi <strong>di</strong> servizi<br />
dell’eccellenza formativi od ospedalieri e <strong>di</strong> cura e che <strong>di</strong>versamente ora in pensionati,<br />
ora in case <strong>di</strong> accoglienza, ora appartamenti ammobiliati abitano in mo<strong>di</strong> nuovi Milano.<br />
Infine, cambia anche la “variabile” famiglia 13 in almeno quattro <strong>di</strong>rezioni rilevanti per le<br />
sue implicazioni sulle pratiche dell’abitare. Innanzitutto, la fragilizzazione della<br />
famiglia tra<strong>di</strong>zionale e la frequenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>vorzi e separazioni oltre a situazioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>sagio<br />
abitativo (e <strong>di</strong> ritorno alla coabitazione) <strong>di</strong> uno dei coniugi (non necessariamente la<br />
donna a cui sono affidati i figli), può comportare a una doppia abitazione dei figli<br />
(negli affi<strong>di</strong> congiunti) e a nuove ricomposizioni famigliari, che creano spazi ine<strong>di</strong>ti<br />
(flessibili, e/o utilizzati temporaneamente) e nuove forme <strong>di</strong> coabitazioni entro<br />
l’alloggio. In secondo luogo le nuove forme <strong>di</strong> convivenza possono investire anche lo<br />
spazio abitativo, come ad esempio nelle relazioni <strong>di</strong> coppia che prevedono il<br />
mantenimento <strong>di</strong> due case o che comportano, siano esse legate a relazioni amorose o<br />
a maggior ragione amicali (ad esempio tra due anziani che coabitano, tra amici) che<br />
definiscono uno spazio abitativo con<strong>di</strong>viso, ma non più legato a una idea forte <strong>di</strong><br />
fusione, uno spazio interno dove si sviluppa un rapporto <strong>di</strong> co-esistenza, uno spazio<br />
dove è più forte la <strong>di</strong>mensione in<strong>di</strong>viduale, che in qualche misura reintroduce<br />
nell’alloggio (per quanto è possibile) degli spazi <strong>di</strong> relativa reciproca autonomia, ma<br />
che porta anche <strong>di</strong>versamente ad abitare lo spazio esterno. In terzo luogo, più<br />
<strong>di</strong>ffusamente il rapporto genitori-figli entro la casa è investito da una profonda e<br />
ine<strong>di</strong>ta democratizzazione 14 e dà vita a una continua faticosa e al tempo stesso<br />
esilarante “contrattazione” degli spazi interni, degli uni e degli altri, dentro e fuori gli<br />
stessi locali. Infine l’allungamento della vita porta a ine<strong>di</strong>te scomposizioni <strong>di</strong> quei nessi<br />
forti tra casa e famiglia. Non tanto e non solo nell’esperienza dell’abitare in una<br />
Residenza socio assistenziale, o in qualche meno deprivante spazio dell’abitare<br />
(comunità alloggio), ma anche nelle case abitate da anziani soli e sottoutilizzate, nelle
convivenze che vi si creano con badanti fisse e figli che si alternano nell’aiuto <strong>di</strong> chi<br />
non è autosufficiente e naturalmente nel movimento centripeto che riporta i genitori a<br />
vivere coi figli nelle loro case. In molti <strong>di</strong> questi casi è il nesso famiglia-alloggio che<br />
viene meno e sono le situazioni <strong>di</strong> convivenza altre (più collettive come un tempo<br />
erano quelle monastiche o militari) che ritornano al centro dell’interesse, in altri è la<br />
rigi<strong>di</strong>tà dell’alloggio che abbiamo segnalato essere definito nella sua formula standard<br />
tra la metà dell’Ottocento e la metà del Novecento che viene messa in evidenza, per<br />
l’assenza <strong>di</strong> un doppio ingresso <strong>di</strong> una sua parziale scomponibilità in due semi-unità (è<br />
intuitivo comprendere come in una casa a corte e a ballatoio tra<strong>di</strong>zionale che poco<br />
garantisce la privacy del singolo, risulta viceversa un <strong>di</strong>spositivo spaziale per la<br />
famiglia che cura un anziano, più autonomia e momenti <strong>di</strong> privacy e qualche<br />
facilitazione, per la presenza <strong>di</strong> uno spazio collettivo-non pubblico, per la mutua<br />
assistenza).<br />
Cambia la famiglia, il lavoro, la relazione con i luoghi e le forme <strong>di</strong> mobilità e con esse<br />
le pratiche dell’abitare, nonostante la casa-alloggio <strong>di</strong> nuova produzione (ma anche <strong>di</strong><br />
gran parte degli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione) rimanga pressoché immutata, co<strong>di</strong>ficata<br />
in un modello unitario e ormai co<strong>di</strong>ficato da tempo (perché la sua domanda e il valore<br />
<strong>di</strong> questo poco a che fare con la ricerca <strong>di</strong> qualche congruenza con le forme<br />
dell’abitare, ma a logiche <strong>di</strong> investimento, <strong>di</strong> tesaurizzazione della ricchezza, <strong>di</strong><br />
andamenti della ren<strong>di</strong>ta).<br />
Il mutamento delle pratiche abitative si realizza così essenzialmente attraverso sia<br />
una <strong>di</strong>ffusa attività <strong>di</strong> reintepretazione degli spazi così rigi<strong>di</strong> (appunto con esercizi <strong>di</strong><br />
scomposizione dell’alloggio), <strong>di</strong> piccoli adattamenti pur sempre possibili, sia<br />
recuperando spazi “altri”, materiali urbani più porosi e vaghi ed esplorando nuovi<br />
territori dell’abitare, dove accanto a spazi interni <strong>di</strong>versi, ritrovare un <strong>di</strong>verso rapporto<br />
con l’esterno.<br />
Oltre la casa, il paesaggio<br />
L’abitare nel suo significato più ampio non si esaurisce nell’oggetto della casa, ma è<br />
una esperienza, un processo che ci riporta ai soggetti, agli “abitanti”, alle loro storie,<br />
alle loro biografie, così spesso ignorate e rimosse dai fautori del libero mercato<br />
urbano, dalle politiche e dai piani urbanistici, sempre più focalizzate sul confronto tra<br />
pubblica amministrazione e promotori immobiliari. L’abitare, tuttavia, non si esaurisce<br />
neppure nella “vita” che attraversa la casa, nella relazione mutevole tra questo<br />
interno e i suoi abitanti, che spesso sovvertono or<strong>di</strong>namenti tipologici, funzionali,<br />
sociali. Si abita pertanto non solo la casa, ma anche un vario insieme <strong>di</strong> spazi esterni<br />
prossimi all’abitazione, il cortile, la panchina sotto casa, la strada, e una pluralità <strong>di</strong><br />
“spazi <strong>di</strong> vita” variamente ubicati e <strong>di</strong>ffusi (il supermercato, il treno e la metropolitana<br />
dei movimenti ripetuti quoti<strong>di</strong>ani, il marciapiede all’uscita della scuola dei figli, il<br />
grande parco metropolitano, la rete <strong>di</strong>scontinua <strong>di</strong> luoghi con<strong>di</strong>visa da una comunità <strong>di</strong><br />
pratiche sportive, culturali).<br />
Nell’esperienza dell’abitare si incontra così non solo lo spazio della casa, ma anche<br />
quello più ampio, aperto e relazionale del paesaggio.<br />
Lo spazio “interno”, come abbiamo cominciato a osservare, ha avuto storicamente una<br />
grande rilevanza nell’abitare lombardo e milanese. Nei paesi della pianura asciutta<br />
l’abitato voltava le spalle alle strade, i movimenti e la vita comune avvenivano nelle<br />
corti. La stessa storia della piccola e me<strong>di</strong>a industria muove da questi interni, non ne<br />
sovverte l’or<strong>di</strong>ne, al massimo si affianca al tessuto storico occupando per intero un<br />
isolato. La grande corte della bassa d’altra parte era luogo <strong>di</strong> lavoro e <strong>di</strong> vita, l’interno<br />
un microcosmo dove legami solidaristici e organizzazione capitalistica dell’agricoltura<br />
si intrecciano in forme originali. Anche Milano era una città <strong>di</strong> interni <strong>di</strong> case decorose,<br />
austere, che celano la loro bellezza, che proiettano la loro vitalità all’interno nei cortili<br />
aristocratici e borghesi, ma anche popolari. La vita della strada è sempre stata a<br />
Milano più povera, meno vitale che altrove, meno ricca <strong>di</strong> imprevisti, <strong>di</strong> momenti <strong>di</strong><br />
socialità (che semmai si sviluppa negli interni collettivi o in spazi ancor più intimi). Lo<br />
spazio esterno a Milano e in Lombar<strong>di</strong>a ha tratti <strong>di</strong>versi; il decoro e la misura della
strada urbana, la <strong>di</strong>ffusa e variegata presenza delle acque e l’estensione e l’ampiezza<br />
della vista che dall’interno della pianura si apre verso la corona dei monti.<br />
Abitare in questi interni voleva tuttavia <strong>di</strong>re per molti anche abitare in stanze e<br />
abitazioni quasi sempre prive <strong>di</strong> servizi basilari (acqua calda, servizi igienici) e<br />
soprattutto in uno stato <strong>di</strong> elevato sovraffollamento. Infatti, nonostante i buoni<br />
andamenti dell’economia milanese e regionale, ancora negli anni Trenta e ancora più<br />
duramente dopo la guerra (in ragione delle ingenti <strong>di</strong>struzioni belliche) le con<strong>di</strong>zioni<br />
abitative erano in senso stretto gravissime ed erano alla ra<strong>di</strong>ce delle principali e<br />
<strong>di</strong>ffuse con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> miseria e povertà che troviamo a Milano.<br />
Inizia negli anni Cinquanta la storia della conquista <strong>di</strong> un alloggio, <strong>di</strong> un interno<br />
privato: dapprima <strong>di</strong>gnitoso e decoroso, con servizi e confortevole, poi sempre più<br />
ampio, lussuoso, opulento. Una storia che attraversa tutta l’Italia, ma che trova forse<br />
il suo epicentro in Lombar<strong>di</strong>a e a Milano, perché qui coinvolge non solo molti milanesi<br />
e abitanti della sua provincia, ma anche una grande mole <strong>di</strong> lombar<strong>di</strong>, veneti,<br />
meri<strong>di</strong>onali che venendo nella metropoli milanese, per lavoro, realizzano qui il loro<br />
riscatto residenziale. Una storia che non solo nel condominio come nella casa isolata<br />
vede sparire la corte e il cortile della casa lombarda (in analogia con la crisi dell’isolato<br />
come principio organizzativo della città europea) ma anche più sorprendentemente<br />
(rispetto alle vicende <strong>di</strong> altri paesi europei) si sviluppa parallelamente all’abbandono e<br />
al progressivo degrado dello spazio esterno, la cui cura e articolazione e varietà invece<br />
in tutte le città europee cresce in parallelo alla crisi dell’isolato 15 . Questa vicenda è per<br />
molti versi epica: si esce da abitazioni senza servizi, affollate, da coabitazioni <strong>di</strong>fficili.<br />
Si conquista la casa con impegnative mobilitazioni in<strong>di</strong>viduali (ma anche collettive, <strong>di</strong><br />
cui è espressione la storia della cooperazione e anche dell’e<strong>di</strong>lizia pubblica), focalizzate<br />
sulla conquista della casa confortevole e possibilmente in proprietà. Una casa sicura,<br />
stabile come il “posto” <strong>di</strong> lavoro spesso affiancato, talvolta intrecciata con gli spazi<br />
dove si è promossa una propria impresa (a Nord <strong>di</strong> Milano, ma anche nella sua<br />
periferia), una casa quando si può è affiancata da un’altra da affittare e/o per i figli e<br />
intesa non tanto (allora) come un patrimonio, un oggetto prezioso da inerire nel<br />
forziere, ma come elemento a supporto e sostegno dei propri progetti e <strong>di</strong> quelli dei<br />
figli, un “capitale fisso famigliare” mobilitato in un processo (<strong>di</strong>ffuso) <strong>di</strong> ascesa sociale.<br />
Una vicenda anche amara, perché è accompagnata da un impoverimento dell’esterno,<br />
che con il suo degrado mina l’abitabilità <strong>di</strong> un urbanizzato che non ha più urbanità,<br />
che assomiglia a un ammasso <strong>di</strong> case (<strong>di</strong> un <strong>di</strong>ffuso ceto me<strong>di</strong>o) più che a una città.<br />
Lo spazio esterno che supporta le nuove urbanizzazioni a partire dagli anni Cinquanta<br />
perde misura e decoro, si fa “sterro” a eterna pozzanghera. La strada viene ridotta a<br />
un puro supporto funzionale sempre meno raccordata agli e<strong>di</strong>fici e al suolo<br />
circostante. Parchi urbani e giar<strong>di</strong>ni non <strong>di</strong>ventano supporto vivo delle nuove<br />
urbanizzazioni (semplicemente perché fino alla fine degli anni Settanta non vengono<br />
realizzati). Si costruisce una contrapposizione ra<strong>di</strong>cale tra la qualità del design degli<br />
interni, del mobile (con la sua fiera sempre più importante) e la pochezza o meglio<br />
l’assenza <strong>di</strong> una pratica anche solo decorosa <strong>di</strong> urban design (da Empoli…). Non solo.<br />
Anche la campagna con la sua ricca or<strong>di</strong>tura si impoverisce: spariti i filari e le siepi,<br />
recintati i percorsi, degradati i canali i campi la campagna a Sud <strong>di</strong> Milano perde valori<br />
urbani, mentre ancor peggio nell’urbanizzazione <strong>di</strong>ffusa della città infinita la campagna<br />
è ridotta a spazio <strong>di</strong> attesa, a <strong>di</strong>scarica, deposito a cielo aperto. Oppure laddove se ne<br />
riconosce il valore <strong>di</strong>venta “terreno” <strong>di</strong> una appropriazione rapace che raramente porta<br />
a escludere altri, più spesso con il suo <strong>di</strong>ffuso uso si “<strong>di</strong>strugge” come ben cogliamo<br />
muovendoci nella Brianza collinare alle porte <strong>di</strong> Milano (tecnicamente il paesaggio da<br />
sfera quoti<strong>di</strong>ana del vivere, <strong>di</strong>viene puro bene posizionale e vive il dramma inevitabile<br />
<strong>di</strong> questa particolare tipologia <strong>di</strong> beni). Amara infine anche perché l’interno<br />
confortevole che si conquista progressivamente vede una sorta <strong>di</strong> implosione e<br />
ripiegamento della famiglia sempre più incapace <strong>di</strong> aprirsi a nuove imprese a essere<br />
trampolino <strong>di</strong> lancio sempre più luogo <strong>di</strong> rifugio (nella precarizzazione) o terreno <strong>di</strong><br />
crescita <strong>di</strong> un nuovo familismo focalizzato sul consumo in<strong>di</strong>viduale, privo <strong>di</strong> relazioni.<br />
Ai <strong>di</strong>sagi e ai paradossi <strong>di</strong> questa introversione, rispondono sempre più spesso le<br />
“mosse” dei molti che cercano <strong>di</strong> fuoriuscire da un abitare che garantisce<br />
comfort ma non più benessere e felicità.
C’è chi riscopre un interesse per gli spazi del proprio paese, per giar<strong>di</strong>ni, strade e<br />
spazi aperti verso cui a lungo si è stati in<strong>di</strong>fferenti e <strong>di</strong> cui ora si reclama una cura,<br />
una sistemazione; chi torna ad abitare le case a corte dei padri e dei nonni in molti<br />
centri città della regione urbana e in Milano, talvolta stravolgendone la struttura fisica<br />
e il principio organizzativo, talvolta aprendosi a un’abitare <strong>di</strong> prossimità, relazionale <strong>di</strong><br />
cui quella forma conserva la memoria ne è in qualche misura simbolo. L’apertura<br />
all’esterno può portare a ricercare quei tessuti della città più porosi e variegati da<br />
sempre capaci <strong>di</strong> ospitare attività e popolazioni <strong>di</strong>fferenti, che non hanno perso il<br />
sapore del quartiere e che si trovano stretti tra spinte alla gentrification e processi <strong>di</strong><br />
metamorfosi meno selettivi (all’Isola, a Greco, tra viale Monza e viale Padova alla<br />
Bovisa,…), ma può anche comportare la riscoperta <strong>di</strong> alcune <strong>di</strong>fferenti qualità spaziali<br />
(legate essenzialmente allo spazio aperto verde) <strong>di</strong> alcuni storici quartieri popolari<br />
<strong>di</strong>ffusamente riscattati, specie se affiancati da un grande parco (a Feltre-Parco<br />
Lambro) o la ricerca <strong>di</strong> situazioni ibride dove si intreccia un borgo storico, nuovi<br />
quartieri parchi <strong>di</strong> recente formazione (a Niguarda-Parco Nord). Riflessioni e<br />
valutazioni sulla natura dello spazio esterno in relazione a <strong>di</strong>fferenti fasi <strong>di</strong> vita della<br />
famiglia e rapporti con il lavoro sono alla base della scelta <strong>di</strong> riabitare una sequenza <strong>di</strong><br />
loft in un grande recinto produttivo (a Porta Genova o via Mecenate), oppure le rigide<br />
combinazione <strong>di</strong> palazzina-parco-supermercato in alcune realtà suburbane o <strong>di</strong> alcune<br />
rie<strong>di</strong>ficate ex zone produttive milanesi. In altri casi lo scatto è più netto, sancisce<br />
un’uscita dalla città, dalle realtà più congestionate per andare ad abitare la campagna<br />
urbana metropolitana, oppure un brandello <strong>di</strong> residuo del paesaggio collinare che si fa<br />
bene comune e possibile elemento relazionale, sfera dell’abitare e non solamente<br />
“veduta e scena”, bene posizionale o ancora un borgo, un piccolo centro interno alla<br />
metropoli ma meno coinvolto dalla crescita degli ultimi quarant’anni. Più ra<strong>di</strong>calmente,<br />
infine, molte pratiche dell’abitare sviluppano una <strong>di</strong>mensione itinerante resa possibile<br />
dalle nuove forme <strong>di</strong> convivenza e <strong>di</strong> lavoro.<br />
Le pratiche dell’abitare ci appaiono allora come delle esplorazioni, dei tentativi <strong>di</strong><br />
trovare nuovi mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> fare esperienza dei luoghi, <strong>di</strong> entrare in relazione con gli altri;<br />
sono la traccia <strong>di</strong> questo cercare, gravido <strong>di</strong> aspettative, <strong>di</strong> insofferenza, <strong>di</strong> delusioni,<br />
<strong>di</strong> felici sorprese. Sono la spia della riscoperta <strong>di</strong> alcune <strong>di</strong>mensioni dell’urbanità<br />
(l’abitare relazionale, il valore della compresenza della co-esistenza, il rapporto con<br />
oggetti che permangono) e della ruralità (il tema della cura e del rapporto coi tempi<br />
<strong>di</strong>fferenti della natura) entro paesaggi ibri<strong>di</strong> e instabili che travalicano la netta<br />
separazione tra città e campagna. In questa ricerca sono in tensione tra loro due<br />
spinte contrad<strong>di</strong>ttorie. Una prima, sente la relazione con l’altro e soprattutto con il<br />
<strong>di</strong>verso, con lo straniero, come una fragilità da evitare per raggiungere una vita<br />
veramente felice e propone la fuga dalla città, la ricerca <strong>di</strong> «comunità <strong>di</strong> simili». La<br />
seconda, accetta la fragilità intrinseca nelle relazioni umane, accetta la <strong>di</strong>fficoltà della<br />
convivenza con chi è <strong>di</strong>verso, non teme prossimità e meticciati.<br />
Dare spazio all’abitare<br />
Il mestiere d’abitare si fa largo tra vincoli e rigi<strong>di</strong>tà, si misura con spinte<br />
contrad<strong>di</strong>ttorie, sconta l’ineguale <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> capacità e risorse, è sottoposto agli<br />
imponderabili contraccolpi del tempo. Si muove con astuzia e tattica entro un campo<br />
da gioco strutturato, in cui stato e mercato definiscono regole e mo<strong>di</strong> d’accesso al<br />
consumo del bene casa.<br />
Un bene particolare, dai forti tratti simbolici e affettivi, dalle molte valenze<br />
economiche, e soprattutto, particolarmente esposto a meccanismi <strong>di</strong> “produzione<br />
collettiva della scarsità”: una produzione che vede il coinvolgimento <strong>di</strong> una pluralità <strong>di</strong><br />
attori sociali, che ha stretto legame con il modo nel quale una società interpreta e<br />
riproduce le proprie relazioni sociali, con lo sguardo con il quale affronta il futuro, con<br />
il modo nel quale gestisce i beni e il rapporto con i beni 16 ; una produzione che ha<br />
ricadute sulla vita delle persone, nella forma <strong>di</strong> nuove povertà, e sui contesti, nella<br />
forma <strong>di</strong> nuove periferie 17 . In tal senso la comprensione <strong>di</strong> questi meccanismi è<br />
cruciale per descrivere le trasformazioni nella metropoli.
1. Milano <strong>di</strong>venta “fabbrica <strong>di</strong> periferie” quando la casa, da capitale fisso familiare che<br />
consente l’ar<strong>di</strong>re dell’iniziativa economica, viene tesaurizzata e ridotta a forziere: un<br />
gioiello che produce ren<strong>di</strong>ta ma che non produce più beni relazionali, non ha effetti<br />
generativi sul contesto ospitante. Ma produce una metamorfosi genetica che rompe i<br />
legami e snatura i luoghi, <strong>di</strong>fficile da metabolizzare forse anche da una città che ha<br />
resistito alle gran<strong>di</strong> trasformazioni, alle crisi, alle ondate migratorie, ai mutamenti<br />
repentini.<br />
Sono, infatti, molto profonde le trasformazioni in corso nella sua struttura sociale.<br />
L’osservazione della con<strong>di</strong>zione socio-abitativa mette in evidenza emergenti e <strong>di</strong>ffusi<br />
tratti <strong>di</strong> “perifericità sociale”: la compresenza <strong>di</strong> un fenomeno consistente <strong>di</strong><br />
fragilizzazione e indebolimento del ceto me<strong>di</strong>o e un allargamento dell’area<br />
dell’esclusione; un <strong>di</strong>sagio <strong>di</strong>ffuso e grave nel campo abitativo; una sorta <strong>di</strong><br />
“cannibalizzazione” nelle <strong>di</strong>namiche del ceto me<strong>di</strong>o con processi <strong>di</strong> investimento dei<br />
segmenti più alti proprio nel settore immobiliare, che assieme ad altri processi più<br />
propri delle città globali, delle loro popolazioni e <strong>di</strong> mobilità del capitale finanziario,<br />
favoriscono l’espulsione dei segmenti più deboli dello stesso me<strong>di</strong>o e un incremento<br />
delle <strong>di</strong>suguaglianze sociali.<br />
Il processo <strong>di</strong> impoverimento e <strong>di</strong> consumo degli aspetti generativi dell’abitare è<br />
pervasivo e investe in<strong>di</strong>fferentemente il cuore della città come le sue molte periferie,<br />
fino a renderli omogenei e irriconoscibili. La periferia si va frantumando in frammenti<br />
sempre più <strong>di</strong>ffusi e sempre meno visibili: una periferia interstiziale nella quale si<br />
manifestano sia le forme più ra<strong>di</strong>cali <strong>di</strong> povertà, <strong>di</strong> esclusione, sia gran parte delle<br />
<strong>di</strong>fficoltà del vivere e dell’abitare che investono una crescente parte della popolazione.<br />
Vengono meno i confini stessi delle periferie storiche, allorquando alcune porzioni del<br />
centro storico e quartieri <strong>di</strong> più antica formazione si configurano egualmente come<br />
aree <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>sagio, <strong>di</strong> degrado e <strong>di</strong> emarginazione; quando alcune porzioni abbandonate del<br />
centro storico, così come interi stabili e strutture produttive in <strong>di</strong>suso <strong>di</strong>vengono<br />
rifugio temporaneo per le popolazioni più marginali in cerca <strong>di</strong> un ricovero.<br />
In un simile contesto la libertà dell’abitare è fortemente messa in <strong>di</strong>scussione; laddove<br />
i pilastri della sicurezza sociale <strong>di</strong>ventano la casa da allocare e il patrimonio in borsa 18 ,<br />
tale libertà <strong>di</strong>viene sempre più libertà <strong>di</strong> qualcuno, mentre molti restano intrappolati<br />
entro luoghi inabitabili, dove regnano stati <strong>di</strong> negazione e incapacitazione. La ren<strong>di</strong>ta<br />
che tesaurizza la casa è il maggior freno alla libertà e contribuisce ad aumentare il<br />
numero <strong>di</strong> coloro che non possono in alcun modo esercitarla.<br />
2. Milano lavora come una “fabbrica <strong>di</strong> periferie” quando rinuncia a riconoscere e a<br />
dare risposte alla varietà <strong>di</strong> domande <strong>di</strong> scomposizione/ricomposizione dell’alloggio:<br />
domande <strong>di</strong> semi autonomia dei figli nella famiglia, <strong>di</strong> presenza del lavoro nella casa,<br />
<strong>di</strong> ospitalità <strong>di</strong> anziani non autosufficienti, <strong>di</strong> badanti, <strong>di</strong> ospiti, <strong>di</strong> presenza <strong>di</strong> parte del<br />
lavoro nella casa, <strong>di</strong> momentanee possibilità <strong>di</strong> introiti per affitto. L’adattamento<br />
dell’offerta a queste nuove con<strong>di</strong>zioni generali dell’abitare, a una domanda <strong>di</strong><br />
reinvenzione dell’alloggio risulta oggi quasi del tutto assente, sia perché la funzione<br />
tesaurizzante dell’alloggio e il peso della ren<strong>di</strong>ta garantiscono la ven<strong>di</strong>ta delle case a<br />
prescindere dalle “domande dell’abitare” (si rapporta a una domanda <strong>di</strong> case che solo<br />
in parte ha a che fare con le domande dell’abitare), sia perché da anni astrattezza,<br />
aspazialità, lontananza <strong>di</strong> parte della ricerca sociale dal progetto (e dalle pratiche) e<br />
all’opposto formalismo procedurale o architettonico <strong>di</strong> molte politiche urbanistiche<br />
offrono pochi stimoli culturali in questa <strong>di</strong>rezione.<br />
Sia le <strong>di</strong>namiche del mercato, con l’enorme incremento del costo degli immobili e degli<br />
affitti, con i suoi modelli <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>lizia residenziale, <strong>di</strong> omologazione spaziale, sia le<br />
politiche urbane con la rinuncia a governare i processi <strong>di</strong> microtrasformazione, <strong>di</strong><br />
metamorfosi dei tessuti, con l’estrema semplificazione spaziale proposta nelle aree <strong>di</strong><br />
trasformazione intensiva (dove la rigida microzonizzazione e separazione, dove<br />
l’accostarsi <strong>di</strong> tanti recinti è anche figlia delle politiche urbanistiche e non solo delle<br />
scelte degli operatori), con la semplificazione dei processi decisionali a pochi attori,<br />
stanno enormemente comprimendo lo spazio <strong>di</strong> queste domande.
Con il rischio che i meccanismi con cui si alimenta socialmente il processo <strong>di</strong> selezione<br />
della popolazione sacrifichino proprio le sue componenti più fragili: i giovani, le<br />
famiglie <strong>di</strong> nuova formazione, gli anziani, gli immigrati in cerca <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>camento.<br />
3. Milano assomiglia a una “fabbrica <strong>di</strong> periferie” quando una sempre più accentuata<br />
centralità della ren<strong>di</strong>ta ha come effetto una scarsa abitabilità dei quartieri urbani che<br />
si estende omogeneamente su tutto il territorio. Da un lato, case <strong>di</strong> passaggio per<br />
uomini d’affari, se<strong>di</strong> prestigiose <strong>di</strong> banche, show room della moda introverse e chiuse,<br />
rivolte a un pubblico selezionato, residence, mansarde trasformate in prestigiosi attici,<br />
interi palazzi abbandonati durante il fine settimana, spazi del lavoro polverizzati e<br />
<strong>di</strong>spersi, case per figli che ancora vivono in famiglia e non si sa dove andranno a<br />
vivere, case dove semplicemente depositare come in un forziere la propria ricchezza,<br />
dall’altro, processi <strong>di</strong> produzione e<strong>di</strong>lizia ancora dominata da un modello for<strong>di</strong>sta<br />
cancellano le <strong>di</strong>fferenze sul territorio e tendendo ad omologare i paesaggi dell’abitare.<br />
Alcune politiche <strong>di</strong> ristrutturazione urbanistica e processi <strong>di</strong> valorizzazione immobiliare,<br />
la politica regolativa, così come più in generale l’immaginario della “grande Milano”,<br />
degli anni Ottanta e Novanta, hanno mortificato quel tratto <strong>di</strong> mescolanza costitutivo<br />
<strong>di</strong> molte periferie storiche citta<strong>di</strong>ne contribuendo a renderle meno riconoscibili. Se<br />
pensiamo alle periferie storiche milanesi descritte da Ermanno Olmi e Giancarlo De<br />
Carlo, la Bovisa operaia con il suo tessuto misto e la forte <strong>di</strong>fferenziazione tra<br />
popolazione <strong>di</strong>urna e notturna, Affori mista operaia e artigianale ma con una più<br />
decisa componente residenziale, Niguarda borgo residenziale inglobato, Bicocca con i<br />
suoi gran<strong>di</strong> recinti produttivi e i quartieri popolari, Porta Genova industriale e agricola<br />
al tempo stesso con la sua <strong>di</strong>versa residenza, le periferie con i tanti nomi propri e<br />
biografie a essi così intrecciate (basti pensare a Leopoldo Pirelli o a Mario Mosca), le<br />
periferie degli operai e del ceto impiegatizio, esse ci appaiono come straor<strong>di</strong>nari<br />
sistemi <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenze e <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssonanze. Ci appaiono luoghi <strong>di</strong> integrazione tra il lavoro e<br />
le forme dell’abitare: lavoro e abitare erano <strong>di</strong>mensioni continuamente rinsaldate tra<br />
loro da pratiche quoti<strong>di</strong>ane <strong>di</strong> rinforzo, da legami <strong>di</strong> parentela. L’abitare incorporando<br />
il lavoro, le relazioni sociali e i tempi <strong>di</strong> vita, configurava anche comunità <strong>di</strong> destino.<br />
Forse oggi quella pluralità <strong>di</strong> forme e <strong>di</strong> paesaggi <strong>di</strong> cui si componeva la città ha un<br />
tono meno evidente, e questo fatto rende ancora più urgente e necessaria una politica<br />
che riconosca varietà e <strong>di</strong>fferenze, opponendosi a processi omologanti; una politica<br />
che <strong>di</strong>a spazio alla libertà <strong>di</strong> invenzione nel quoti<strong>di</strong>ano e la renda possibile a molti; una<br />
politica che si apra alla costruzione <strong>di</strong> immaginari al futuro. Una prospettiva che<br />
costringe a ripensare l’abitare (e in primo luogo la casa) non solo come bene <strong>di</strong><br />
comfort o sola ren<strong>di</strong>ta, ma anche come pratica intrinsecamente relazionale, che cerchi<br />
<strong>di</strong> coniugare libertà in<strong>di</strong>viduale con qualche forma <strong>di</strong> comunanza, che implichi<br />
prendersi cura del proprio ambiente <strong>di</strong> vita e tornare a sbilanciarsi verso una<br />
<strong>di</strong>mensione pubblica e collettiva. Una prospettiva che fa dell’abitabilità dei luoghi una<br />
questione pubblica cruciale che ha a che fare certamente con la vita e la quoti<strong>di</strong>anità<br />
delle persone, con la varietà dei paesaggi or<strong>di</strong>nari, ma anche con le stesse possibilità<br />
<strong>di</strong> sviluppo e <strong>di</strong> competizione della regione urbana milanese.<br />
Bibliografia<br />
Alvi G., Una repubblica fondata sulle ren<strong>di</strong>te, Mondadori, Milano, 2006<br />
Balducci, S. et al, Città <strong>di</strong> città, Un progetto strategico per la provincia, Provincia <strong>di</strong><br />
Milano-Diap<br />
Beck U., I rischi della libertà, Il Mulino, Bologna, 2000<br />
Boeri, S, Lanzani, A,. Marini E., (1993), Il territorio che cambia. Ambienti, paesaggi e<br />
immagini della regione urbana milanese, Segesta-Aim, Milano, 1993<br />
Bonomi A., Rullani E., Il capitalismo personale. Vite al lavoro, Einau<strong>di</strong>, Torino, 2005<br />
Bour<strong>di</strong>eu P., La <strong>di</strong>stinzione, Bologna, Il Mulino, Bologna, 1979<br />
Crosta. P.L., L’abitare itinerante come “pratica dell’abitare” che costruisce territori e<br />
popolazioni. Politicità delle pratiche, Venezia, 2006<br />
Da Empoli G., La sindrome <strong>di</strong> Meucci. Contro il declino italiano, Marsilio, Venezia, 2006
De Certau M., L’invenzione del quoti<strong>di</strong>ano, E<strong>di</strong>zioni lavoro, Roma, 2001<br />
Doninelli L., Il crollo delle aspettative. Scritti insurrezionali su Milano, Garzanti, Milano,<br />
2005<br />
Granata, E., “Abitare: mestiere <strong>di</strong>fficile”, in Territorio, n. 34, 2005<br />
Granata, E., Lanzani A. “La fabbrica delle periferie”, Animazione sociale n 8/9, 2006<br />
Lancerini E., Lanzani A., Granata E., Carbonara S., Robiglio M., De Rita G., “Territori<br />
lenti”, in Territorio, n. 34, 2005<br />
Lanzani A., I paesaggi italiani, Meltemi, Roma, 2003<br />
Lanzani, Granata et al, Esperienze e paesaggi dell’abitare, Aim-Segesta, Milano, 2006<br />
Magatti M. e De Bene<strong>di</strong>ttis M., I nuovi ceti popolari. Chi ha preso il posto della classe<br />
operaia?, Feltrinelli, Milano, 2006<br />
Magatti M., et al, Milano, nodo della rete globale. Un itinerario <strong>di</strong> analisi e proposte,<br />
Bruno Mondatori, Milano, 2005<br />
Micheli G., Ranci C., (a cura <strong>di</strong>), IReR, Equilibri fragili. Vulnerabilità e vita quoti<strong>di</strong>ana<br />
delle famiglie lombarde, Guerini e Associati, Milano, 2003<br />
Rahnema M., Quando la povertà <strong>di</strong>venta miseria, Einau<strong>di</strong>, Torino, 2005<br />
Saraceno, C, Sociologia della famiglia, Il Mulino, Bologna 1998<br />
Sarti, R., Vita <strong>di</strong> casa, Laterza, Bari 2003<br />
Sennett R., L’uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita<br />
personale, Feltrinelli, Milano,1999<br />
Turri, E., Semiologia del paesaggio italiano, Longanesi, Milano 1979<br />
Note<br />
1. (Sennet, 1999, pag. 13).<br />
2. (Granata 2005).<br />
3. Bour<strong>di</strong>eu 1979.<br />
4. Beck 2000.<br />
5. Granata Lanzani 2006.<br />
6. Boeri, Lanzani, Marini 1993; Lanzani e Granata et al 2006.<br />
7. Sarti 2003.<br />
8. Doninelli 2005.<br />
9. Magatti e De Bene<strong>di</strong>ttis 2006, Bonomi e Rullani 2005, Magatti et al 2005.<br />
10. Balducci et al 2006.<br />
11. Lancerini et al 2005.<br />
12. Lanzani e Granata 2006, Crosta 2006.<br />
13. Saraceno 1998, Micheli e Ranci 2003.<br />
14. Beck 2000.<br />
15. Turri 1979; Lanzani 2003.<br />
16. Rahnema, 2005.<br />
17. Granata e Lanzani, 2006.<br />
18. Alvi, 2006.