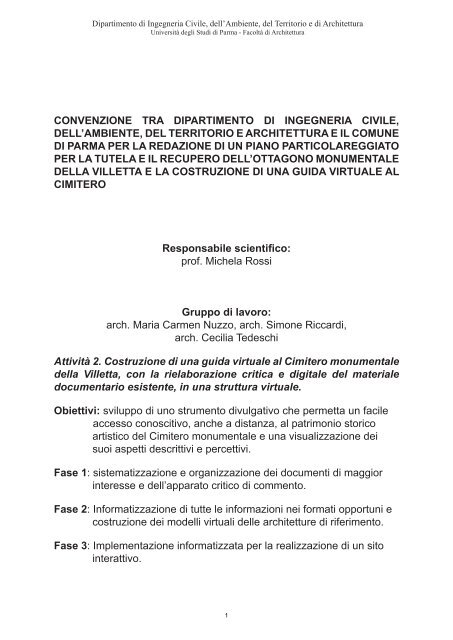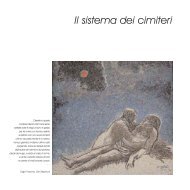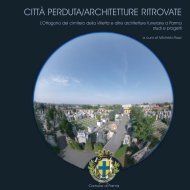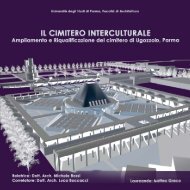relazione di presentazione - Cimitero La Villetta
relazione di presentazione - Cimitero La Villetta
relazione di presentazione - Cimitero La Villetta
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
CONVENZIONE TRA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE,<br />
DELL’AMBIENTE, DEL TERRITORIO E ARCHITETTURA E IL COMUNE<br />
DI PARMA PER LA REDAZIONE DI UN PIANO PARTICOLAREGGIATO<br />
PER LA TUTELA E IL RECUPERO DELL’OTTAGONO MONUMENTALE<br />
DELLA VILLETTA E LA COSTRUZIONE DI UNA GUIDA VIRTUALE AL<br />
CIMITERO<br />
Responsabile scientifico:<br />
prof. Michela Rossi<br />
Gruppo <strong>di</strong> lavoro:<br />
arch. Maria Carmen Nuzzo, arch. Simone Riccar<strong>di</strong>,<br />
arch. Cecilia Tedeschi<br />
Attività 2. Costruzione <strong>di</strong> una guida virtuale al <strong>Cimitero</strong> monumentale<br />
della <strong>Villetta</strong>, con la rielaborazione critica e <strong>di</strong>gitale del materiale<br />
documentario esistente, in una struttura virtuale.<br />
Obiettivi: sviluppo <strong>di</strong> uno strumento <strong>di</strong>vulgativo che permetta un facile<br />
accesso conoscitivo, anche a <strong>di</strong>stanza, al patrimonio storico<br />
artistico del <strong>Cimitero</strong> monumentale e una visualizzazione dei<br />
suoi aspetti descrittivi e percettivi.<br />
Fase 1: sistematizzazione e organizzazione dei documenti <strong>di</strong> maggior<br />
interesse e dell’apparato critico <strong>di</strong> commento.<br />
Fase 2: Informatizzazione <strong>di</strong> tutte le informazioni nei formati opportuni e<br />
costruzione dei modelli virtuali delle architetture <strong>di</strong> riferimento.<br />
Fase 3: Implementazione informatizzata per la realizzazione <strong>di</strong> un sito<br />
interattivo.<br />
1
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
Il Museo <strong>di</strong>gitale della <strong>Villetta</strong><br />
<strong>La</strong> ricerca, quando è condotta con passione, sembra<br />
destinata a non esaurirsi mai: quando si comincia a capire<br />
il senso <strong>di</strong> quello che si sta stu<strong>di</strong>ando e si crede <strong>di</strong> essere<br />
vicini al termine del lavoro, improvvisamente si intuiscono<br />
spazi inesplorati, che inducono ad indagare campi limitrofi,<br />
seguendo un filo conduttore comune. Poco per volta<br />
sembra <strong>di</strong> passare da un tema ad un altro, ma questo aiuta<br />
a capire in modo più profondo le relazioni e le molteplici<br />
sfaccettature dell’argomento principale, al quale riconduce<br />
ogni <strong>di</strong>vagazione.<br />
Così accade che alla fine la ricerca sottolinei l’importanza<br />
<strong>di</strong> aspetti dapprima sottovalutati, producendo risultati<br />
inaspettati, con ricadute positive anche in ambiti<br />
apparentemente <strong>di</strong>stanti dai presupposti iniziali.<br />
Tanto si evince dai molteplici risvolti scaturiti a partire dai<br />
rilievi svolti in ambito <strong>di</strong>dattico all’interno del <strong>Cimitero</strong> della<br />
<strong>Villetta</strong> a Parma, incerto inizio <strong>di</strong> una ricerca <strong>di</strong> ampio<br />
respiro impostata e condotta in stretta collaborazione con<br />
gli Uffici competenti del Comune <strong>di</strong> Parma.<br />
Lo stu<strong>di</strong>o dell’architettura funeraria e dei suoi elementi<br />
formali, oltre a portare alla luce una grande quantità <strong>di</strong><br />
documenti <strong>di</strong> indubbio interesse, ha messo in risalto come<br />
nel cimitero si siano se<strong>di</strong>mentatati i ricor<strong>di</strong> della storia<br />
civica e nazionale, l’identità sociale delle comunità urbane<br />
con i loro valori, ma anche innumerevoli riferimenti formali<br />
alla città dei vivi, appena fuori del camposanto.<br />
Così il rilievo <strong>di</strong>dattico, inevitabilmente un po’ estemporaneo,<br />
ha sottolineato -ma chi si occupava della gestione del bene<br />
non poteva non esserne ben consapevole- la necessità <strong>di</strong><br />
una conoscenza più rigorosa e articolata, basata su una<br />
schedatura impostata secondo parametri omogenei, come<br />
fondamento della tutela e riqualificazione <strong>di</strong> un monumento<br />
carico <strong>di</strong> valori ma dolorosamente dequalificato sia al suo<br />
interno, che nel rapporto urbano.<br />
<strong>La</strong> schedatura architettonica che ne è derivata, finalizzata<br />
a rendere <strong>di</strong>sponibile una serie <strong>di</strong> informazioni utili alla<br />
gestione or<strong>di</strong>naria <strong>di</strong> un patrimonio culturale da tutelare,<br />
ha evidenziato la complessità intrinseca del monumento,<br />
dovuta alla sua scala ambigua <strong>di</strong> architettura urbana,<br />
costituita da una moltitu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> elementi in<strong>di</strong>pendenti,<br />
riuniti all’interno <strong>di</strong> un contesto unitario. Tale complessità<br />
ha quin<strong>di</strong> richiesto la riorganizzazione della moltitu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong><br />
informazioni e documenti raccolti in un sistema informativo,<br />
2
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
destinato a costituire in futuro il nucleo iniziale <strong>di</strong> un ben più<br />
articolato sistema <strong>di</strong> gestione, che dovrà essere sviluppato<br />
come strumento <strong>di</strong> attuazione e <strong>di</strong> controllo del Piano<br />
Regolatore Cimiteriale. Quest’ultimo costituisce la prima<br />
applicazione concreta delle conoscenze emerse dallo<br />
stu<strong>di</strong>o dell’Ottagono della <strong>Villetta</strong>, piccola città autonoma,<br />
chiusa in sé stessa e cresciuta all’interno del suo recinto.<br />
Il paragone tra la città dei morti e la città dei vivi non è<br />
un’espressione retorica: il cimitero è effettivamente –e<br />
come tale si comporta e quin<strong>di</strong> può e deve essere trattato-<br />
un modello ridotto della città, della quale riflette forme<br />
e valori nei manufatti che esprimono le aspirazioni e la<br />
presenza degli abitanti.<br />
Così, mentre dallo stu<strong>di</strong>o dell’architettura si passava a<br />
quello dell’infrastruttura urbanistica con le sue relazioni<br />
con la periferia e il territorio, emergevano le trasformazioni<br />
in atto nella composizione sociale e nelle abitu<strong>di</strong>ni della<br />
popolazione, fondamentali per la pianificazione degli<br />
interventi in <strong>relazione</strong> al fabbisogno. E mentre si procedeva<br />
alla successiva redazione <strong>di</strong> un piano particolareggiato<br />
per la tutela della parte monumentale del cimitero, si<br />
continuavano ad accumulare informazioni e conoscenze<br />
che riportavano l’attenzione all’architettura e alla sua<br />
articolazione, alle caratteristiche costruttive e ai significati<br />
dei suoi elementi costitutivi, espressione <strong>di</strong> un periodo<br />
caratterizzato da trasformazioni incisive e fermenti formali<br />
innovativi.<br />
Quando l’architettura nasce come elemento <strong>di</strong> memoria,<br />
essa richiama inevitabilmente la storia, così tra i monumenti<br />
funebri del cimitero si ritrovano il racconto e le tracce degli<br />
ultimi due secoli della nostra città. L’arte racconta la storia<br />
attraverso il ricordo delle persone che l’anno vissuta,<br />
lasciando un segno tangibile nelle loro opere e nelle<br />
loro azioni, qualche volta nel loro sacrificio. Personaggi<br />
celebri e famiglie conosciute, chi ha lottato per la nascita e<br />
l’in<strong>di</strong>pendenza della Nazione e chi per il suo onore o la sua<br />
libertà, tutti insieme in un unico archivio della memoria che<br />
illustra le ragioni della toponomastica della città.<br />
Così, approfondendo lo stu<strong>di</strong>o dell’architettura, sono<br />
apparse sempre più forti le relazioni con gli altri valori del<br />
cimitero e tutti i suoi riferimenti alla storia, all’arte, alla città<br />
stessa.<br />
Questo mette in risalto l’importanza <strong>di</strong> offrire ad un pubblico<br />
più vasto la possibilità <strong>di</strong> con<strong>di</strong>viderne la conoscenza,<br />
attraverso la restituzione delle informazioni raccolte in<br />
3
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
percorsi personalizzabili tra i documenti e tra i monumenti.<br />
<strong>La</strong> volontà <strong>di</strong> evitare una musealizzazione eccessiva<br />
del nucleo monumentale del cimitero, unita alla <strong>di</strong>fficoltà<br />
evidente <strong>di</strong> restituire la molteplicità delle chiavi <strong>di</strong> lettura<br />
dell’architettura del cimitero come documento della città,<br />
ha stimolato l’idea <strong>di</strong> ricorrere agli strumenti offerti dalla<br />
tecnologia informatica, con la creazione <strong>di</strong> una guida<br />
virtuale, ovvero <strong>di</strong> un museo <strong>di</strong>gitale nel quale fosse<br />
possibile raccogliere le informazioni <strong>di</strong>sponibili, e quin<strong>di</strong><br />
consultarle secondo percorsi e livelli <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>mento<br />
personali.<br />
Lo strumento fondamentale ha la struttura informatica <strong>di</strong> un<br />
data-base, concettualmente simile a quello utilizzato per<br />
la schedatura architettonica, aperto all’inserimento futuro<br />
<strong>di</strong> nuove informazioni anche da parte degli stessi utenti,<br />
ma dotato <strong>di</strong> un interfaccia facilmente leggibile e quin<strong>di</strong><br />
accessibile al grande pubblico.<br />
Questo museo <strong>di</strong>gitale non intende sostituirsi al cimitero,<br />
bensì affiancarlo, integrando la visita reale con la<br />
possibilità <strong>di</strong> seguire percorsi tematici e trovare facilmente<br />
informazioni che permettano al visitatore <strong>di</strong> comprendere<br />
meglio i valori e i riferimenti dei monumenti.<br />
Come documento accessibile dalla rete esso <strong>di</strong>venta un<br />
invito alla visita turistica, un biglietto da visita della città e<br />
della sua storia.<br />
Come scelta <strong>di</strong> fondo, il museo <strong>di</strong>gitale non intende simulare<br />
lo spazio reale come un generico museo virtuale, ma vuole<br />
restituire alla conoscenza comune le informazioni e le<br />
relazioni che spiegano gli elementi formali delle architetture<br />
dell’Ottagono e da queste si <strong>di</strong>panano, raccontando fatti e<br />
persone della storia civica.<br />
<strong>La</strong> rap<strong>presentazione</strong> <strong>di</strong>gitale sullo schermo <strong>di</strong>venta così,<br />
com’è il <strong>di</strong>segno, lo strumento per la visualizzazione <strong>di</strong><br />
uno spazio mentale all’interno del quale ognuno possa<br />
ricostruire le molteplici relazioni della memoria e il continuo<br />
riflesso tra la città dei morti e quella dei vivi, restituzione <strong>di</strong><br />
un rilievo <strong>di</strong> ampio respiro dell’Ottagono Monumentale.<br />
Così il museo <strong>di</strong>gitale della <strong>Villetta</strong> è allo stesso tempo un<br />
invito alla visita e un racconto della storia recente della<br />
città.<br />
Di seguito sono sintetizzate alcune note illustrative<br />
dei presupposti che sono alla base della concezione<br />
del “museo” e della sua organizzazione in quella<br />
struttura informatizzata che ne costruisce lo spazio <strong>di</strong><br />
rap<strong>presentazione</strong> all’interno del quale si svolgono i possibili<br />
4
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
percorsi della memoria della visita virtuale.<br />
Un secondo approfon<strong>di</strong>mento illustra brevemente i<br />
contenuti, le caratteristiche e la rielaborazione delle<br />
informazioni collezionate, finalizzate all’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong><br />
possibili percorsi fruitivi delle architetture della memoria e<br />
del ricordo dei citta<strong>di</strong>ni illustri. Questi percorsi organizzati<br />
per oggetti, soggetti e personaggi sono destinati a legare<br />
tra loro architettura, arte e storia.<br />
Questi aspetti innovativi della restituzione <strong>di</strong> informazioni<br />
su larga scala, sono stati approfon<strong>di</strong>ti da due dottoran<strong>di</strong><br />
del Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del<br />
Territorio e Architettura dell’Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma,<br />
come esperienze <strong>di</strong> ricerca sperimentali nell’ambito del<br />
rilievo e della rap<strong>presentazione</strong> dell’architettura.<br />
5
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
Il progetto del Museo <strong>di</strong>gitale<br />
Simone Riccar<strong>di</strong><br />
Il Museo <strong>di</strong>gitale della <strong>Villetta</strong> <strong>di</strong> Parma rappresenta lo<br />
strumento ideale <strong>di</strong> organizzazione e <strong>di</strong> rielaborazione<br />
delle informazioni che l’Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma<br />
ha raccolto sino ad oggi all’interno <strong>di</strong> un database georeferenziato.<br />
Si è reso necessario organizzare il Museo <strong>di</strong>gitale tramite<br />
un sito web 2d ampiamente riconoscibile e fruibile dalla<br />
maggioranza degli utenti, per garantire facilità <strong>di</strong> accesso<br />
alle informazioni contenute. Non si nega un suo possibile<br />
sviluppo futuro anche in ambienti più complessi, come<br />
sono gli spazi virtuali tri<strong>di</strong>mensionali.<br />
<strong>La</strong> realtà virtuale e il museo<br />
Il progetto del Museo <strong>di</strong>gitale della <strong>Villetta</strong> <strong>di</strong> Parma<br />
scaturisce da una serie <strong>di</strong> ri essioni e stu<strong>di</strong> sulla realtà<br />
virtuale e sui suoi possibili utilizzi nella museogra a.<br />
<strong>La</strong> prima parte <strong>di</strong> analisi volge un sintetico sguardo al<br />
concetto <strong>di</strong> realtà virtuale, ed ai suoi sviluppi sino ad oggi<br />
nelle applicazioni informatiche. Il termine ‘virtuale’, dal<br />
latino ‘virtus’, è in riferimento alla “virtù”, nel signi cato <strong>di</strong><br />
“potenziale”, “che può accadere”.<br />
Si contrappone al concetto <strong>di</strong> virtuale quello <strong>di</strong> reale: ‘è<br />
reale ciò su cui agisco e insieme ciò che percepisco’.<br />
Tomas Maldonado speci ca a riguardo: “Un’azione senza<br />
oggetto è un mimo, una percezione senza oggetto è<br />
un’allucinazione”.<br />
I me<strong>di</strong>a hanno reso il con ne tra realtà e non-realtà molto<br />
più sottile e facilmente attraversabile ( g. 1).<br />
Il virtuale acquisisce oggi sempre più importanza, si passa<br />
dai caratteri neri scritti su carta ingiallita racchiusi nei libri<br />
( g. 2), agli spazi sempre più ‘immersivi’ dei mon<strong>di</strong> virtuali<br />
online.<br />
Oggi conosciamo tutti quanti le potenzialità offerteci da<br />
strumenti come Google Earth ( g. 3), che in pochi click<br />
ci mette a <strong>di</strong>sposizione la super cie geogra ca dell’intero<br />
pianeta terra (in fase <strong>di</strong> sviluppo anche per la Luna e<br />
Marte). Si pensi solo a quanto era <strong>di</strong>f cile accedere ad<br />
informazioni <strong>di</strong> questo tipo solo 5 anni fa, quando questa<br />
possibilità non esisteva. Potremmo considerare Google<br />
Earth come un grande museo a scala urbana, dove si<br />
trovano, <strong>di</strong>rettamente collocati in cartogra a,<br />
6<br />
g. 1 Scena tratta dal lm “Il Tagliaerbe”<br />
g. 2 Il virtuale nella storia<br />
g. 3 Vista a volo d’uccello in Google-<br />
Earth<br />
g. 4 Avatar: Reale-Virtuale
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
svariati punti <strong>di</strong> interesse.<br />
Un passo recente della virtualità <strong>di</strong>gitale è la realizzazione<br />
<strong>di</strong> spazi profondamente immersivi, come le realtà<br />
tri<strong>di</strong>mensionali dei mon<strong>di</strong> online ( g. 4). Esistono tutt’oggi<br />
repliche fruibili in tempo reale <strong>di</strong> parti <strong>di</strong> città italiane come<br />
Mantova, Venezia ( g. 5) o Assisi ( gg. 6-7). Questi pezzi<br />
<strong>di</strong> città si uniscono tra loro a formare un vero e proprio<br />
sistema urbano visitabile in prima persona attraverso<br />
strumenti come ‘There’ o ‘Secondlife’. <strong>La</strong> ricostruzione<br />
3D <strong>di</strong> Assisi in Second Life equivale ad un’idea <strong>di</strong> museo<br />
gratuito, in cui il visitatore può ammirare in prima persona<br />
gli affreschi <strong>di</strong> Giotto oppure muoversi liberamente negli<br />
spazi tri<strong>di</strong>mensionali, creati ad immagine perfetta <strong>di</strong> quelli<br />
reali. Un progetto <strong>di</strong> questo tipo, alla pari <strong>di</strong> quello un sito<br />
internet 2D, è accessibile in qualsiasi istante, da qualsiasi<br />
parte al mondo.<br />
Alcune avanguar<strong>di</strong>e <strong>di</strong> Musei Virtuali immersivi in Second<br />
Life sono la ricostruzione della Galleria d’arte <strong>di</strong> Dresda<br />
oppure il Museo <strong>di</strong>gitale <strong>di</strong> Vincent Van Gogh. Quest’ultimo<br />
è un percorso completamente buio che conduce alle opere<br />
<strong>di</strong> Van Gogh riprodotte in grande scala, come ambienti<br />
immersivi, nei quali è possibile entrare e muoversi in prima<br />
persona.<br />
Inversamente agli spazi museali entrati in programmi <strong>di</strong>gitali,<br />
troviamo gran<strong>di</strong> quantità <strong>di</strong> tecnologie virtuali che invadono<br />
i Musei della realtà, attraverso proiezioni luminose, touchscreens,<br />
pannelli <strong>di</strong>gitali intelliggenti, computer palmari, che<br />
facilitano la visita all’interno del museo o contribuiscono a<br />
renderla più suggestiva ( g. 8).<br />
<strong>La</strong> gestione delle informazioni<br />
Tutte le informazioni che vengono mostrate all’interno<br />
dei programmi <strong>di</strong>gitali, sia che facciano parte <strong>di</strong> software<br />
solamente o che siano integrati all’interno <strong>di</strong> strumenti più<br />
complessi, risiedono all’interno dei ‘Database’.<br />
Possiamo dare un’immagine rappresentativa <strong>di</strong> database,<br />
pensando ad una grande biblioteca stracolma <strong>di</strong> libri ( g. 9)<br />
riposti or<strong>di</strong>natamente all’interno degli scaffali delle librerie.<br />
Nel nostro caso il database raccoglie le migliaia <strong>di</strong><br />
informazioni <strong>di</strong>gitali elaborate dall’Università degli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
Parma per il Piano Cimiteriale della <strong>Villetta</strong>.<br />
Queste informazioni sono presenti sotto forma <strong>di</strong> mappe<br />
<strong>di</strong>gitali, <strong>di</strong> immagini, <strong>di</strong> vettori e <strong>di</strong> testi.<br />
Il sito web del Museo <strong>di</strong>gitale della <strong>Villetta</strong> è la messa in<br />
rete <strong>di</strong> questi dati e la loro connessione con <strong>di</strong>versi sistemi<br />
noti come Google map, Wikype<strong>di</strong>a, etc.<br />
7<br />
g. 5 Venezia su Secondlife<br />
g. 6 Esterno della Basilica <strong>di</strong> Assisi<br />
su SL<br />
g. 7 Interno della Basilica <strong>di</strong> Assisi<br />
su SL<br />
g. 8 Pannelli luminosi al KUB <strong>di</strong><br />
Bregenz<br />
g. 9 Biblioteca come Data Base
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
Il modello Minerva:<br />
Il progetto Minerva, che ha avuto la sua tappa principale e<br />
fondativa proprio a Parma nel novembre 2003, ha affrontato<br />
il tema importante dell’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> standard <strong>di</strong><br />
qualità per le applicazioni Web culturali pubbliche.<br />
Il contributo culturale <strong>di</strong> questo progetto europeo è ancora<br />
attivo e sarà parte del convegno dal titolo: “Museums and<br />
the Web 2008” che si terrà a Montreal (Quebec, Canada)<br />
nel mese <strong>di</strong> aprile 2008.<br />
I 5 obiettivi principali emersi dal progetto Minerva, e con<strong>di</strong>visi<br />
dal progetto del Museo Digitale della <strong>Villetta</strong>, sono:<br />
1. Adoperarsi per un’ampia <strong>di</strong>ffusione della cultura;<br />
2. Far parte <strong>di</strong> una comunità <strong>di</strong> soggetti culturali;<br />
3. Appro ttare dell’ef cacia dei nuovi canali <strong>di</strong><br />
comunicazione;<br />
4. Adottare un uso consapevole del Web;<br />
5. Considerare la qualità come risultato del processo<br />
<strong>di</strong> incontro tra soggetti culturali e utenti.<br />
Inoltre, il progetto Minerva riconosce 4 criteri fondament<br />
ali per la redazione <strong>di</strong> un sito web <strong>di</strong> qualità:<br />
1. il contenuto;<br />
2. la navigazione;<br />
3. la visualizzazione gra ca;<br />
4. i servizi offerti.<br />
A partire da tali criteri, la qualità dei siti web culturali<br />
non va valutata in maniera in<strong>di</strong>pendente ma sem-<br />
pre in <strong>relazione</strong> con il soggetto culturale interrogandosi<br />
sui seguenti obiettivi da raggiungere:<br />
a. qual è l’utilità del sito per quel soggetto culturale;<br />
b. quali sono gli scopi che ci si pre gge nel momento<br />
stesso in cui ci si dota <strong>di</strong> un sito;<br />
c. qual è l’au<strong>di</strong>ence e quali sono gli utenti cui princip-<br />
almente si rivolge.<br />
Gli obiettivi che dovrebbe pre ggersi un soggetto cult<br />
urale pubblico (SCP) nell’elaborazione <strong>di</strong> un sito inter<br />
net perciò sono i seguenti:<br />
1. rappresentare l’identità del SCP;<br />
2. rendere trasparente l’attività del SCP;<br />
3. rendere trasparenti gli obiettivi dell’AWCP;<br />
4. svogere un ruolo ef cace nei network <strong>di</strong> settore;<br />
5. presentare norme e standard <strong>di</strong> settore;<br />
6. <strong>di</strong>ffondere contenuti culturali;<br />
7. sostenere il turismo culturale;<br />
8<br />
g. 10 Progetto Europeo Minerva
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
8. offrire servizi <strong>di</strong>dattici;<br />
9. offrire servizi per la ricerca scienti ca;<br />
10. offrire servizi ai professionisti del settore ;<br />
11. offrire servizi per le prenotazioni e gli acquisti;<br />
12. promuovere comunità telematiche <strong>di</strong> settore.<br />
Il progetto del Museo <strong>di</strong>gitale della <strong>Villetta</strong> <strong>di</strong> Parma ha rispettato<br />
le raccomandazioni e i principi generali in<strong>di</strong>viduati<br />
nel “Manuale per la qualità dei siti web pubblici culturali”<br />
del progetto Minerva, pubblicato alla pagina web: http://<br />
www.minervaeurope.org/publications/qualitycriteria-i.htm.<br />
In particolare, il Manuale per la qualità sottolinea che “i<br />
Soggetti Culturali Pubblici (SCP) devono essere in prima<br />
linea nella <strong>di</strong>ffusione delle buone pratiche e degli standard<br />
per la conservazione a lungo termine dei materiali pubblicati<br />
su Internet, patrimonio informativo del nostro presente<br />
da tramandare per il futuro”. In accordo con questa<br />
importante in<strong>di</strong>cazione del modello Minerva, il Museo<br />
<strong>di</strong>gitale della <strong>Villetta</strong>, considerato come un’Applicazione<br />
Web Culturale Pubblica (AWCP), fornirà informazione e<br />
<strong>di</strong>vulgazione culturale, e sarà strumento per l’educazione<br />
e la ricerca scienti ca.<br />
Segue in Appen<strong>di</strong>ce l’estratto dello stu<strong>di</strong>o sui 12 punti<br />
che dovrebbero essere seguiti da un sito internet <strong>di</strong> un s<br />
oggetto culturale pubblico.<br />
9
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
I riferimenti progettuali<br />
<strong>La</strong> struttura del Museo è stata stu<strong>di</strong>ata prendendo come<br />
riferimento alcuni esempi <strong>di</strong> Musei virtuali 2D già esistenti,<br />
considerati rilevanti, e perciò stu<strong>di</strong>ati come esempi <strong>di</strong><br />
riferimento. Questi precedenti si sono rilevati essenziali<br />
per considerare come sono state risolte alcune casistiche<br />
<strong>di</strong> problemi riscontrati.<br />
Tra i siti-web <strong>di</strong> Musei presi in considerazione spicca quello<br />
del Louvre. Il sitoweb del Louvre è un chiaro esempio <strong>di</strong><br />
sintesi delle informazioni possedute sulle migliaia <strong>di</strong> opere<br />
che il museo contiene al suo interno. Vengono mostrate,<br />
con la loro collocazione spaziale, le venti opere più<br />
importanti. Di queste opere possiamo accedere ad una<br />
breve descrizione e immagine fotogra ca, oppure volendo,<br />
si può accedere ad un loro maggiore dettaglio.<br />
10<br />
g. 11 Sito web del Museo del Louvre<br />
g. 12 Sito web della Tate Modern Gallery
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
<strong>La</strong> Tate Modern Gallery ha un’interfaccia web piacevole e<br />
facilmente navigabile. Mette a <strong>di</strong>sposizione la consultazione<br />
<strong>di</strong> tutte le opere esposte al suo interno; accessibili tramite<br />
mappa assonometrica oppure tramite motore <strong>di</strong> ricerca su<br />
autore e/o opera.<br />
Avvicinandoci al tema cimiteriale troviamo due esempi<br />
<strong>di</strong> siti web correlati a cimiteri monumentali <strong>di</strong> grande<br />
importanza come quello <strong>di</strong> Pere-<strong>La</strong>chaise <strong>di</strong> Parigi e quello<br />
Monumentale <strong>di</strong> Milano.<br />
Il primo sito, quello <strong>di</strong> Parigi è stato preso come riferimento<br />
per la progettazione dell’interfaccia utente del sito della<br />
<strong>Villetta</strong> <strong>di</strong> Parma.<br />
Dall’analisi dei siti esistenti è stato possibile prendere<br />
in considerazione alcuni aspetti caratteristici dei musei<br />
virtuali 2D, che dovevano essere riproposti in quello<br />
11<br />
g. 13 Sito web del <strong>Cimitero</strong> <strong>di</strong> Parigi<br />
g. 14 Sito web del Monumentale <strong>di</strong><br />
Milano
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
della <strong>Villetta</strong>, tra questi in particolare: la chiarezza e la<br />
semplicità dell’interfaccia, la presenza <strong>di</strong> una mappa per<br />
la navigazione, la possibilità <strong>di</strong> una ricerca rapida dei<br />
contenuti, la necessità <strong>di</strong> sintesi, e quini <strong>di</strong> limitare n da<br />
subito in modo chiaro i contenuti, scegliendo le opere e le<br />
informazioni più rilevanti.<br />
L’usabilità<br />
delle barriere che un sito web potrebbe generare con la<br />
collocazione e l’utilizzo errato dei contenuti.<br />
Perciò si prendono come riferimento i punti che Jackob<br />
Nielsen in<strong>di</strong>vidua come facilitatori d’accesso e <strong>di</strong> fruizione<br />
delle informazioni:<br />
● Leggibilità<br />
● Link<br />
● Contenuto<br />
● Ricerche<br />
● multi-Browser<br />
● Moduli <strong>di</strong> registrazione<br />
● Dimensione delle pagine<br />
1 del Museo <strong>di</strong>gitale<br />
Nello sviluppo del progetto del Museo <strong>di</strong>gitale non si può<br />
trascurare la parte riguardante la chiarezza dei contenuti<br />
e la loro massima accessibilità. Anche per le informazioni<br />
<strong>di</strong>gitali si deve tenere in considerazione un annullamento<br />
L’integrazione con Wikipe<strong>di</strong>a<br />
Wikipe<strong>di</strong>a è ormai un importantissimo strumento, che<br />
viene sempre più utilizzato per la ricchezza dei contenuti<br />
<strong>di</strong>sponibili nelle varie lingue dei vari paesi. Lo strumento<br />
open-source fornito da wikipe<strong>di</strong>a ( Wikime<strong>di</strong>a ) sarà<br />
integrato all’interno del sito per costituire un importante<br />
ruolo <strong>di</strong>dattico per le scuole e per tutti coloro che volessero<br />
12<br />
g. 15 Home Page <strong>di</strong> Wikipe<strong>di</strong>a
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
approfon<strong>di</strong>re gli argomenti correlati alla <strong>Villetta</strong> <strong>di</strong> Parma.<br />
<strong>La</strong> struttura del Museo <strong>di</strong>gitale<br />
Il sito web della <strong>Villetta</strong> <strong>di</strong> Parma sarà caratterizzato da due<br />
parti principali, una costituisce il racconto narrativo in cui<br />
sono selezionabili e visitabili gli oggetti più importanti del<br />
Museo, mentre l’altra parte costituisce le risorse <strong>di</strong>dattiche<br />
e tutti gli approfon<strong>di</strong>menti (il wiki).<br />
<strong>La</strong> struttura della parte narrativa è sud<strong>di</strong>visa su vari livelli:<br />
i percorsi principali in<strong>di</strong>viduati dalla storia, dalle persone<br />
illustre e dall’arte; i percorsi secondari che entrano nello<br />
speci co <strong>di</strong> ogni percorso principale; gli approfon<strong>di</strong>menti<br />
che rimandano alla parte <strong>di</strong>dattica del wiki.<br />
l Template (la veste grafi ca)<br />
<strong>La</strong> veste gra ca dell’interfaccia utente è stata stu<strong>di</strong>ata e<br />
sviluppata creando <strong>di</strong>verse copie confrontabili.<br />
13<br />
g. 16 Struttura del Museo <strong>di</strong>gitale<br />
g. 17 Interfaccia Gra ca: Stu<strong>di</strong>o 1
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
Il sito web ha subito <strong>di</strong>versi sta<strong>di</strong> <strong>di</strong> evoluzione, durante i<br />
quali si è perseguito un continuo miglioramento sia degli<br />
strumenti <strong>di</strong> gestione e sia della veste gra ca che ha<br />
assunto toni luminosi e leggeri.<br />
<strong>La</strong> scelta dello sfondo azzurro e i toni <strong>di</strong> grigio danno<br />
lucentezza ed eleganza all’interfaccia web.<br />
14<br />
g. 18 Interfaccia Gra ca: Stu<strong>di</strong>o 2<br />
g. 19 Interfaccia Gra ca: Stu<strong>di</strong>o 3
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
c. d. e.<br />
<strong>La</strong> HomePage<br />
<strong>La</strong> Homepage, porta <strong>di</strong> accesso all’intero sistema museale, è<br />
costituita da una veste essenziale e altamente “usabile”.<br />
Il Museo <strong>di</strong>gitale sarà costituito da più sezioni (con la possibilità<br />
<strong>di</strong> aggiungerne altre in caso <strong>di</strong> necessità), le sezioni saranno<br />
a loro volta costituite da sottosezioni sino ad un terzo livello <strong>di</strong><br />
approfon<strong>di</strong>mento.<br />
Le macro-sezioni sono costituite da ( g. 20):<br />
a. I percorsi della memoria<br />
b. <strong>La</strong> navigazione cartogra ca<br />
c. <strong>La</strong> Wiki-<strong>Villetta</strong><br />
d. Le news o comunicazioni speciali<br />
e. Le news o comunica- zioni speciali<br />
f. <strong>La</strong> zona gestionale con accesso riservato<br />
Una cartina introduce le risorse <strong>di</strong>sponibili e rende la<br />
comprensione del museo <strong>di</strong> facile leggibilità. I percorsi sono<br />
percorribili tramite una serie <strong>di</strong> etichette poste al <strong>di</strong> sopra della<br />
mappa e una selezione degli “oggetti” contenuti all’interno del<br />
“museo della <strong>Villetta</strong>” è consultabile tramite le microimmagini<br />
poste sul fondo della pagina.<br />
<strong>La</strong> scelta <strong>di</strong> utilizzare un sistema interattivo <strong>di</strong> gestione del<br />
museo partendo da una mappa nasce dai successi riportati<br />
negli ultimi anni da progetti altamente interattivi (e UCG2 )<br />
15<br />
a.<br />
Login<br />
b.<br />
f.<br />
g. 20
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
come google-map e google earth.<br />
Il me<strong>di</strong>a della mappa è uno strumento essenziale per<br />
comunicare contenuti narrativi come quelli del Museo<br />
<strong>di</strong>gitale. Testo ed immagini risultano pertanto georeferenziati<br />
e vengono mostrati con un semplice click del mouse sulla<br />
cartina interattiva.<br />
<strong>La</strong> Navigazione<br />
Proviamo ora a simulare una navigazione all’interno del<br />
nuovo sito web.<br />
Consultiamo la parte relativa ai percorsi della memoria, nel<br />
nostro caso clicchiamo sul percorso della storia, che viene<br />
imme<strong>di</strong>atamente evidenziato in giallo.<br />
Il percorso storico ha due tipologie <strong>di</strong> visualizzazione: una<br />
tri<strong>di</strong>mensionale e una sottoforma <strong>di</strong> mappa cartogra ca 2d.<br />
Questo “racconto visivo” ci mostra la sequenza storica<br />
<strong>di</strong> realizzazione della villetta <strong>di</strong> Parma, iniziando con la<br />
fondazione, per passare alla realizzazione della Galleria Sud,<br />
della Galleria Nord e della Galleria Sud-Est.<br />
<strong>La</strong> visualizzazione 3D ( g. 21) mostra una visione prospettica<br />
della <strong>Villetta</strong> nei vari perio<strong>di</strong>, svelando così delle visuali che ad<br />
oggi sono rese impossibili dala presenza delle cappelle poste<br />
all’interno dell’ottagono.<br />
16<br />
g. 21
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
17<br />
g. 22<br />
g. 23
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
Il secondo tipo <strong>di</strong> visualizzazione, quello con mappa la<br />
interattiva ( g. 22), evidenzia con il colore giallo i punti e le<br />
aree <strong>di</strong> interesse. Al passaggio del mouse sopra queste aree<br />
e punti <strong>di</strong> interesse, il loro colore cambia e viene sottolineata<br />
la capacità interattiva dell’oggetto trasformando il puntatore<br />
del mouse in una manina (che ha la funzione comunicativa <strong>di</strong><br />
esprimete il concetto <strong>di</strong> Link).<br />
18<br />
g. 24<br />
g. 25
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
Cliccando sull’area interessata all’interno della mappa oppure<br />
nei sottomenu della sezione storia, viene centrato e zoommato<br />
l’oggetto richiesto ( g. 23) e ne esce un fumetto (come siamo<br />
abituati a vederlo in google map), che lo descrive in modo<br />
sintetico ( g. 24).<br />
19<br />
g. 26<br />
g. 27
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
Nel fumetto sono presenti una breve descrizione, una o più<br />
immagini, e alcuni link correlati. Volendo esiste la possibilità<br />
<strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>re l’argomento cliccando su leggi tutto. In questo<br />
modo si viene rimandati nella sezione <strong>di</strong>dattica del Wiki-<strong>Villetta</strong><br />
( g. 25).<br />
Se ad esempio volessimo intraprendere il percorso dei<br />
personaggi basterebbe cliccare sopra al menu personaggi,<br />
che si attiverebbe in giallo, e mostrerebbe in mappa i vari<br />
punti in cui risiedono personaggi illustri ( g. 26).<br />
Al passaggio del mouse sui punti gialli, compare il nome del<br />
personaggio - nel nostro caso Niccolò Paganini - cliccandoci<br />
20<br />
g. 28<br />
g. 29
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
sopra si apre il fumetto con all’interno una breve biogra a,<br />
foto e links <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>mento e <strong>di</strong> connessione con altri<br />
personaggi od argomenti correlati ( g. 27).<br />
Utilizzando il modulo <strong>di</strong> ricerca si possono in<strong>di</strong>viduare<br />
univocamente gli oggetti d’interesse. In questo caso<br />
pren<strong>di</strong>amo come ipotesi la ricerca <strong>di</strong> informazioni relative a<br />
Padre Lino.<br />
Scriviamo all’interno del modulo “Padre Lino” ( g. 28),<br />
schiacciamo sulla freccia (o sul tasto invio) e automaticamente<br />
il motore <strong>di</strong> ricerca del sito in<strong>di</strong>viduerà nel database il nome<br />
corrispondente alla nostra ricerca e se questo nome esiste ci<br />
mostrerà in cartina la localizzazione dell’oggetto.<br />
<strong>La</strong> cartina si muoverà in modo <strong>di</strong>namico ( g. 29), centrando<br />
e ingrandendo l’oggetto d’interesse. Un fumetto con la<br />
descrizione <strong>di</strong> Padre Lino ci darà le informazioni richieste ( g.<br />
30).<br />
Note<br />
1 In riferimento ai punti introdotti dallo stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Jackob Nielsen<br />
sull’Usability: Leggibilità, Link, Contenuto, Ricerche, Browser,<br />
Moduli <strong>di</strong> registrazione, Dimensione delle pagine<br />
2 User Generated Contents: contenuti generati dagli utenti<br />
3 Contents Managment System: Sistema <strong>di</strong> Gestione dei Contenuti<br />
21<br />
g. 30
APPENDICE<br />
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
“Le politiche <strong>di</strong> <strong>di</strong>gitalizzazione nei centri <strong>di</strong> ricerca e <strong>di</strong> formazione e il Web<br />
Un sito Web de<strong>di</strong>cato a un centro <strong>di</strong> ricerca e formazione prevede generalmente la messa a <strong>di</strong>s<br />
posizione <strong>di</strong> una notevole quantità i materiale anche grezzo nella stesura, ma comunque propo<br />
sto in formato <strong>di</strong> documento standard. Una particolare a enzione deve essere posta all’in<strong>di</strong>cizz<br />
azione e quin<strong>di</strong> alla rintracciabilità pubblica del materiale stesso m<strong>di</strong>ante l’uso <strong>di</strong> lessici, thesa<br />
uri ecc., integrati nella base <strong>di</strong> dati <strong>di</strong>stribuita.<br />
Le cara eristiche stesse della comunità scienti ca spingono verso una ra nazione delle tecnich<br />
e <strong>di</strong> comunicazione sincrona (chat) o asincrona (forum, newsle er) e l’evoluzione <strong>di</strong> pia aform<br />
e per questo in ambito possibilmente open-source. Esiste una consolidata tra<strong>di</strong>zione nelle istitu<br />
zioni accademiche o assimilabili, a favore dell’adozione <strong>di</strong> so ware e soluzioni tecniche non pro<br />
prietarie.<br />
3.3.7 Proge i culturali<br />
<strong>La</strong> realizzazione <strong>di</strong> un sito Web è spesso tra le nalità stesse <strong>di</strong> un proge o culturale pubblic<br />
o, in <strong>relazione</strong> alla vocazione del proge o, mirato al miglioramento e al ra orzamento delle str<br />
ategie <strong>di</strong> creazione e <strong>di</strong> usione <strong>di</strong> contenuti culturali.<br />
Lo strumento telematico perme e sia <strong>di</strong> comunicare informando gli utenti presenti in rete sull<br />
e cara eristiche e gli obie ividel proge o (comunicazione esterna), sia <strong>di</strong> gestire alcuni degli a<br />
spe i del proge o utilizzando spazi riservati (comunicazione interna). <strong>La</strong> con<strong>di</strong>visione delle inf<br />
ormazioni sviluppate nell'ambito <strong>di</strong> un determinato proge o culturale perme e lo sviluppo e l'<br />
accrescimento culturale avviatosi grazie alla Società dell'informazione e della conoscenza. Pubbl<br />
icare, all'interno <strong>di</strong> un sito Web <strong>di</strong> un proge o culturale pubblico, una selezione <strong>di</strong> risorse ut<br />
ili sia allo svolgimento del proge o stesso sia alla comprensione e al raggiungimento <strong>di</strong> inizia<br />
tiv consimili così come pubblicare i documenti prodo i è un'azione che dà valore e visibilità a<br />
l proge o e lo investe delle prospe ive proprie della "Società dell'informazione". Un'adeguata<br />
piani cazione della strategia <strong>di</strong> comunicazione esterna perme erà la promozione <strong>di</strong> una chiara<br />
comprensione del progeto a raverso la coesione, la sussi<strong>di</strong>arietà, la cooperazione e il pluralism<br />
o. Nell'ambito dei siti Web <strong>di</strong> proge i culturali è importante infa i che essi abbiano un esplic<br />
ito legame con sviluppi e tendenze culurali in a o nella società: anche a raverso l'appartenenz<br />
a a reti e portali; che siano strumenti innovativi <strong>di</strong> <strong>di</strong> usione culturale; che siano promotori d<br />
ei risultati raggiunti sia in comunità specialistiche sia in un ampio bacino <strong>di</strong> utenza. Gli spaz<br />
i ad accesso riservato possono essere un utile strumento <strong>di</strong> lavoro e favorire la comunicazione<br />
interna alle a ività peviste dal proge o. Ciò si realizza dando la <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> visionare e s<br />
caricare materiale aggiornato, presentando un'agenda con gli appuntamenti e le scadenze <strong>di</strong> sv<br />
olgimento del proge o e rendendo raggiungibili telematicamente tu i i partecipnti al proge o.<br />
Alcuni elementi utili sono forum, liste <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione e bolle ini telematici riservati.<br />
È possibile che un proge o culturale preveda la realizzazione <strong>di</strong> banche dati che possano essere<br />
implementate anche via Web. In questo caso, o emperando alle norme <strong>di</strong> tutela e privacy dei<br />
contenuti, l'AWCP <strong>di</strong>viene non solo strumento <strong>di</strong> comunicazione, ma <strong>di</strong> realizzazione stessa d<br />
el proge o. Per o imizzare la comunicazione esterna si suggerisce <strong>di</strong> de<strong>di</strong>care particolare a en<br />
zione alla realizzazione <strong>di</strong> comunicati stapa da inviare alle centrali me<strong>di</strong>a presenti on-line al <br />
ne <strong>di</strong> informare sulle a ività e sui risultati raggiunti.<br />
I proge i culturali e gli obie ivi delle AWCP<br />
L'analisi degli speci ci obie ivi delle applicazioni Web culturali pubbliche, nel caso <strong>di</strong> un pro<br />
ge o culturale, coinvolge sia i SCP che gli eventuali partner privati che partecipano al proget<br />
to.<br />
Obie ivo n. 1 - Rappresentare l’identità del SCP<br />
22
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
Si realizza fornendo in<strong>di</strong>cazioni sulle nalità (descri e anche in rapporto alle esigenze culturali<br />
che la società civile ha posto in essere), gli obie ivi (fornendo una documentazione degli scop<br />
i del proge o) e sull'organizzazione del proge o. L'AWCP presenterà inoltre in modo chiaro e<br />
d evidente tu i i partecipanti, siano essi istituzioni, imprese, enti pubblici o privati.<br />
Obie ivo n. 2 - Rendere trasparente l’a ività del SCP<br />
Prevede l'in<strong>di</strong>cazione dei tempi <strong>di</strong> svolgimento e a uazione del proge o, la pubblicazione dell'a<br />
genda e <strong>di</strong> informazioni legate agli aspe i economici e nanziari. È necessario che vengano co<br />
llegate le nalità del proge o alle a ività del SCP e/o enti coinvolti nel proge o, dando in<strong>di</strong>ca<br />
zioni sui responsabili dei SCP partecipanti, sulle modalità e i tempi <strong>di</strong> integrazione tra i risul<br />
tati o enuti dal proge o e le a ività dei SCP e/o enti coinvolti.<br />
Obie ivo n. 3 - Essere trasparenti sulla missione dell’AWCP<br />
Richiede la <strong>presentazione</strong> delle cara eristiche tecnologiche dell'applicazione, delle nalità che ess<br />
a si pone rispe o al proge o e quin<strong>di</strong> degli strumenti che o re per la realizzazione degli obiet<br />
tivi dl proge o. Verrà data in<strong>di</strong>cazione anche dei tempi <strong>di</strong> aggiornamento.<br />
Obie ivo n. 4 - Svolgere un ruolo e cace nei network <strong>di</strong> se ore<br />
È fondamentale per il perseguimento degli obie ivi e delle nalità poste da un proge o cultur<br />
ale. <strong>La</strong> con<strong>di</strong>visione e la promozione dei risultati raggiunti, la coesione e la collaborazione ad<br />
altri proge i culturali on-line consimili, conclusi o in a o, come pure la messa in comune <strong>di</strong><br />
strumenti telematici <strong>di</strong> riferimento (banche dati, thesauri, linkope<strong>di</strong>e) avviene a raverso la pa<br />
rtecipazione o la creazione <strong>di</strong> reti e portali tematici. Quest’obie ivo costituisce uno dei princip<br />
ali orizzonti della Società dell'informazione e della conoscenza.<br />
Obie ivo n. 5 - Presentare norme e standard <strong>di</strong> se ore<br />
È realizzabile esclusivamente se è un obie ivo previsto dal proge o culturale.<br />
Obie ivo n. 6 - Di ondere contenuti culturali<br />
È collegato all'obie ivo n. 4, con<strong>di</strong>videndo il cara ere culturale rispe o allo sviluppo della Soc<br />
ietà dell’informazione e della conoscenza. Possano essere in<strong>di</strong>viduate fasce <strong>di</strong> utenza che <strong>di</strong>vers<br />
amente fruiscono dei contenuti presentati e sviluppati in un'applicazione Web de<strong>di</strong>cata a un p<br />
roge o culturale. In questo caso si rende necessario uno stu<strong>di</strong>o a nché corrispondano il lingu<br />
aggio e la tipologia dell'informazione e del servizio al pro lo dell'utente selezionato, o empera<br />
ndo le norme <strong>di</strong> tutela della privacy e del copyright dei contenuti.<br />
Obie ivo n. 7 - Sostenere il turismo culturale<br />
È realizzabile esclusivamente se è un obie ivo previsto dal proge o culturale.<br />
Obie ivo n. 8 - O rire servizi <strong>di</strong>da ici<br />
È realizzabile esclusivamente se è un obie ivo previsto dal proge o culturale.<br />
Obie ivo n. 9 - O rire servizi per la ricerca scienti ca<br />
È collegato all'obie ivo n. 6. Un sito Web de<strong>di</strong>cato a un proge o culturale può prevedere infa<br />
i servizi rivolti alla ricerca scienti ca, rendendo fruibili le banche dati eventualmente svilupp<br />
ate all'interno del proge o. Per motivi <strong>di</strong> riservatezza dei dati è possibile che siano ad accesso<br />
riservato.<br />
Alcuni possibili servizi: analisi dei dati (ossia ricercare e visualizzare i dati secondo parametri<br />
prestabiliti, come cronologia, parole-chiave ecc.), registrazione dei criteri <strong>di</strong> ricerca selezionati,<br />
salvataggio della ricerca e e uata, oppure invio nella propria casella <strong>di</strong> posta ele ronica, so os<br />
crizione <strong>di</strong> un abbonamento che, automaticamente, secondo un determinato intervallo <strong>di</strong> tempo,<br />
invii gli aggiornamenti apportati nella base <strong>di</strong> dati, <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> immagini con maggior de<br />
nizione.<br />
23
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
Obie ivo n. 10 - O rire servizi ai professionisti del se ore<br />
Coincide con l'obie ivo n. 9.<br />
Obie ivo n. 11 - O rire servizi per le prenotazioni e gli acquisti<br />
Si realizza quando i servizi esposti nell'obie ivo n. 9 (comuni all'Obie ivo n. 10) prevedono t<br />
ransazioni economiche.<br />
Obie ivo n. 12 - Promuovere comunità telematiche <strong>di</strong> se ore<br />
Prevede l'o erta <strong>di</strong> servizi informativi e intera ivi mirati alla comunicazione e partecipazione<br />
degli utenti ai risultati o enuti. Tra questi: realizzazione <strong>di</strong> forum, newsle er e bolle ini telem<br />
atici rivolti in particolare a determinati gruppi <strong>di</strong> pro li <strong>di</strong> utenza a inenti alle cara eristche<br />
culturali e scienti che previste dal proge o. Per sensibilizzare e implementare la comunità è o<br />
pportuno che vengano ado ate strategie <strong>di</strong> <strong>di</strong> usione (comunicati stampa, iscrizione a liste <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>stribuzione e forum <strong>di</strong> riferimento) e che siano curate da personale culturalmente competente<br />
tu e le a ività intera ive <strong>di</strong> comunicazione e scambio, compreso il canale della posta ele ron<br />
ica.<br />
I proge i culturali e gli utenti del Web<br />
L'interazione tra sogge o e utente si realizza sia o rendo strumenti intera ivi come un canale<br />
"conta i" o "comunità" deputato a rispondere alle richieste che giungono per posta ele ronica,<br />
sia me endo a punto forum, liste <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione e bolle ini telematici con la nalità <strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
ondere e con<strong>di</strong>videre i risultati raggiunti all'interno del proge o.<br />
Considerando che un proge o culturale pubblico può coinvolgere partner pubblici e partne<br />
r privati, il sito Web può <strong>di</strong>ventare luogo aperto dove incoraggiare lo scambio, la cooperazione,<br />
il coinvolgimento e la partecipazione <strong>di</strong> ulteriori sogge i pubblici e/o privati.<br />
Le politiche <strong>di</strong> <strong>di</strong>gitalizzazione nei proge i culturali e il Web<br />
<strong>La</strong> <strong>relazione</strong> fra l'applicazione Web e i proge i <strong>di</strong> <strong>di</strong>gitalizzazione è <strong>di</strong>re a e prioritaria rispe<br />
o ad altri canali <strong>di</strong> comunicazione. Considerando che la Società dell'informazione e della conos<br />
cenza è basata sulla <strong>di</strong>gitalizzazione dei programmi <strong>di</strong> contenuti culturali è naturale che la ret<br />
e Intrnet costituisca il primo sbocco dei proge i culturali pubblici.<br />
Nella fase <strong>di</strong> piani cazione <strong>di</strong> un proge o <strong>di</strong>gitale è importante operare una scelta critica <strong>di</strong> q<br />
uale materiale tra are e pubbicare. I criteri <strong>di</strong> selezione del materiale <strong>di</strong>pendono dagli obie ivi<br />
del proge o, dai vincoli tecnologici e nanziari, dai <strong>di</strong>ri i <strong>di</strong> copyright e <strong>di</strong> IPR e da eventual<br />
i altri proge i <strong>di</strong>gitali realizzati in quel determinato se ore. Naturalmente anche l'accesso al m<br />
ateriale è un fa ore da considerare: la con<strong>di</strong>zione degli originali, la loro reperibilità e l'eventua<br />
le <strong>di</strong>sponibilità anche in formato <strong>di</strong>gitale; ado are una politica <strong>di</strong> preservazione degli originali,<br />
quando questi siano in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> conservazione critiche o scarsamente utilizzabili per il pu<br />
bblico, rendendo <strong>di</strong>sponibili versioni <strong>di</strong>gitali; l'appropriatezza della “sorgente” del materiale risp<br />
e o alla fruizione on-line; i costi <strong>di</strong> <strong>di</strong>gitalizzazione sono tra i criteri fondamentali per la selez<br />
ione del materiale da <strong>di</strong>gitalizzare.<br />
Per quanto riguarda il <strong>di</strong>ri o <strong>di</strong> copyright provvedere eventualmente alla marchiatura delle im<br />
magini prote e con marcature o igrane invisibili.<br />
È importante che un SCP, ponendosi obie ivi speci ci <strong>di</strong> determinati proge i culturali, conside<br />
ri gli aspe i collegati all'interoperabilità e al riutilizzo dei dati. I beni e le a ività connesse a<br />
lla <strong>di</strong>gitalizzazione sono infa i <strong>di</strong>pendenti dalle tecnologie che evolvono rapidamente, per quest<br />
o motivo va tenuto debitamente conto dell'organizzazione dei dati, dell'utilizzazione <strong>di</strong> standar<br />
d tecnologici avanzati e <strong>di</strong> pratiche mirate alla conservazione della cultura e del patrimonio <strong>di</strong><br />
gitale.<br />
Assicurare un uso appropriato dei metadati a nché siano possibili ricerche <strong>di</strong> materiali/ogge i<br />
appartenenti a <strong>di</strong>verse collezioni <strong>di</strong>gitali; ado are l'uso <strong>di</strong> vocabolari controllati (ad esempio, pe<br />
r descrivere un luogo o un artista). Sono elementi che perme ono che un proge o <strong>di</strong>gitale sia<br />
logicamente connesso con proge i simili, a ivando la consultazione e navigazione trasversale.<br />
Garantiscono inoltre la migrazione dei dati <strong>di</strong>gitali da uno standard tecnologico all'altro.<br />
24
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
Considerare nel passaggio dell'ogge o <strong>di</strong>gitale alla fruizione on-line le procedure <strong>di</strong> compressio<br />
ne dei documenti ed eventualmente la realizzazione <strong>di</strong> immagini <strong>di</strong> grandezza minore (thumbn<br />
ail image); o rire la possibilità <strong>di</strong> salvare i documenti in <strong>di</strong> erenti versioni, risoluzioni, format<br />
i e grandezze.<br />
<strong>La</strong> fruizione delle banche dati e delle informazioni elaborate all'interno <strong>di</strong> un proge o può av<br />
venire anche in base a una fascia <strong>di</strong> utenza <strong>di</strong>versi cata: quella generica e quella registrata e/<br />
o autorizzata.<br />
<strong>La</strong> prima classe <strong>di</strong> utenti ha l'accesso a tu i i servizi e alle banche dati pubbliche o erte all'<br />
interno del proge o, mentre la seconda classe <strong>di</strong> utenza, a raverso procedure <strong>di</strong> riconosciment<br />
o e autenticazione, può accedere alle informazioni e alle banche dati (riservate o no) con possi<br />
bilità <strong>di</strong> erenziate <strong>di</strong> visualizzare i dati e con l'opzione <strong>di</strong> implementarle <strong>di</strong>re amente on-line.<br />
Questo signi ca, per quanto riguarda la proge azione <strong>di</strong> questo servizio on-line, l'in<strong>di</strong>viduazio<br />
ne dei <strong>di</strong>versi pro li <strong>di</strong> utenti associati in gruppi ai quali corrispondono uno stesso set <strong>di</strong> per<br />
messi.<br />
25
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
L’organizzazione delle informazioni<br />
Maria Carmen Nuzzo<br />
Il Co<strong>di</strong>ce dei beni culturali del paesaggio<br />
Quando si parla <strong>di</strong> patrimonio storico-artistico, e soprattutto<br />
del modo con cui questo deve essere raccolto e<br />
trasmesso, è necessario fare ricorso ai termini e alle<br />
definizioni che sono state elaborate dal Co<strong>di</strong>ce Urbani<br />
entrato in vigore il 1°maggio 2004 il quale, nel regolamentare<br />
in modo organico la tutela del patrimonio culturale,<br />
storico ed artistico del nostro paese ha riba<strong>di</strong>to<br />
a chiare lettere che i beni del patrimonio culturale <strong>di</strong><br />
appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione e<br />
alla collettività 1 .<br />
Nella definizione <strong>di</strong> bene culturale, ovvero, “le cose immobili<br />
e materiali che presentano interessse artistico,<br />
storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e<br />
bibliografico 2” , rientrano le “raccolte <strong>di</strong> musei, pinacoteche,<br />
gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle<br />
regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonchè <strong>di</strong><br />
ogni altro ente ed istituto pubblico ”3 .<br />
<strong>La</strong> legislazione italiana definisce il museo, secondo<br />
il decreto legislativo del Co<strong>di</strong>ce Urbani, “una struttura<br />
permanente che acquisisce, conserva, or<strong>di</strong>na ed<br />
espone i beni culturali per finalità <strong>di</strong> educazione e <strong>di</strong><br />
stu<strong>di</strong>o” 4 ; il comma 3 <strong>di</strong> tale legge prosegue definendo<br />
che gli “istituti e i luoghi che appartengono a soggetti<br />
pubblici sono destinanti alla pubblica fruizione”.<br />
A livello internazionale esiste un organismo che è<br />
espressione del mondo dei musei: l’ICOM, International<br />
Council of Museums, che all’art. 2.1 del suo statuto<br />
definisce il museo come “un’istituzione permanente,<br />
senza scopo <strong>di</strong> lucro, al servizio della società e del suo<br />
sviluppo, aperta al pubblico che compie ricerche sulle<br />
testimoniamze materiali dell’uomo e del suo ambiente,<br />
le acquisisce, le conserva, le comunica e soprattutto le<br />
espone a fini <strong>di</strong> educazione <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o e <strong>di</strong> <strong>di</strong>letto” 5 .<br />
In questa definizione viene posto l’accento sull’attività<br />
<strong>di</strong> ricerca che determina il concetto stesso <strong>di</strong> museo<br />
e in questo senso è innovativa rispetto la definizione<br />
italiana.<br />
In riferimento alla definizione <strong>di</strong> mostra le norme che si<br />
devono richiamare sono l’art.10, comma n.2, l’art.48 e<br />
26
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
l’art.74-quater del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633.<br />
In particolare, l’art.74-quater fornisce <strong>di</strong>sposizioni in<br />
materia <strong>di</strong> attività spettacolistiche elencate nella tabella<br />
C allegata al medesimo DPR n.633. Il punto 5 della<br />
citata tabella stabilisce, per la parte che qui interessa,<br />
che nel novero delle attività <strong>di</strong> spettacolo rientrano le<br />
“mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche,<br />
artistiche e industriali … ed altre manifestazioni similari”.<br />
Appare quin<strong>di</strong> palese la riconducibilità delle mostre<br />
culturali in esame al genus delle attività spettacolistiche.<br />
Museo <strong>di</strong>gitale<br />
<strong>La</strong> struttura espositiva della museo <strong>di</strong>gitale riunisce al<br />
suo interno l’idea del museo e quello della mostra.<br />
<strong>La</strong> mostra è un’organizzazione temporanea che si costruisce<br />
e si sviluppa mono-tematicamente, in contrapposizione<br />
al museo, come riassemblaggio trasversale<br />
delle collezioni che normalmente lo caratterizzano.<br />
Il museo possiede collezioni che si possono arricchire<br />
nel tempo, ma tematicamente definite. Questo costruisce<br />
la sua identità e ne determina la specificità e il ruolo<br />
rispetto ad altri.<br />
Il museo <strong>di</strong>gitale offre una proiezione comunicativa “a<br />
tutto campo” del museo reale. Ciò significa far parlare le<br />
opere attraverso gli strumenti offerti dalla tecnologia. Al<br />
suo interno sarà possibile creare sale virtuali <strong>di</strong> qualunque<br />
natura, dove scegliere le opere e accostarle ad altre<br />
del museo stesso o ad altri oggetti/immagini in base alle<br />
esigenze comunicative o alla scelta del visitatore.<br />
L’obbiettivo sarà quin<strong>di</strong> l’organizzare <strong>di</strong> spazi virtuali,<br />
legati alle innumerevoli potenzialità del trattamento<br />
dell’immagine, in <strong>relazione</strong> allo spazio reale, attraverso<br />
le tecnologie grafico-interattive, per costruire mon<strong>di</strong> e<br />
racconti visivi che prescindono dalla necessità <strong>di</strong> simulare<br />
lo spazio reale, evocando suggestioni attraverso le<br />
immagini.<br />
Questa idea <strong>di</strong> museo s’ispira e rielabora l’esperienza<br />
del gruppo “Stu<strong>di</strong>o Azzurro” 6 <strong>di</strong> Milano in <strong>relazione</strong> al<br />
27<br />
fig.1<br />
fig.2<br />
fig.3<br />
fig.4<br />
Il museo della resistenza, Sarzana 2007:<br />
i volti narranti.
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
“Museo della resistenza” 7 <strong>di</strong> Sarzana, dove i volti narranti<br />
sono un’esplosione <strong>di</strong> segni ed espressività che<br />
testimoniano la drammaticità degli eventi (fig. 1-2).<br />
Partigiani, conta<strong>di</strong>ni, sacerdoti, operai, sono le tessere<br />
<strong>di</strong> un quadro complesso, <strong>di</strong> una memoria storica non<br />
ancora pacificata e pienamente elaborata che è offerta<br />
alla riflessione dello spettatore.<br />
I volti segnati dall’età dei testimoni e le loro voci <strong>di</strong> volta<br />
in volta decise od esitanti, imperiose o flebili ci parlano<br />
dell’unicità irriducibile <strong>di</strong> ogni esperienza umana, eppure<br />
i racconti ci rimandano l’eco <strong>di</strong> altre storie, <strong>di</strong> altre vite<br />
parallele, <strong>di</strong> altri dolori e <strong>di</strong> altre gioie (fig. 2-3-4).<br />
<strong>La</strong> parte sonora conferisce una <strong>di</strong>mensione au<strong>di</strong>ovisiva:<br />
la rap<strong>presentazione</strong> <strong>di</strong>viene un’esplosione segnica ed<br />
espressiva in cui il gesto e il racconto conferiscono una<br />
duplice valenza al museo.<br />
I presupposti del museo <strong>di</strong>gitale sono quin<strong>di</strong>:<br />
- raccontare con la lingua me<strong>di</strong>atica,<br />
- utilizzare la tecnologia informatica in modo efficace.<br />
Questo facilita una riflessione personale durante l’ascolto<br />
e la lettura delle informazioni.<br />
Il museo virtuale raccoglie emozioni, le trasmette e le<br />
riattiva: è un laboratorio informativo aperto alla rielaborazione<br />
personale del fruitore.<br />
Questo può relazionarsi con la parte invisibile degli oggetti,<br />
con gli eventi che li hanno costruiti e con la spazialità<br />
del luogo, attraverso immagini e richiami.<br />
<strong>La</strong> memoria è il bagaglio personale rielaborato dal fruitore,<br />
il materiale multime<strong>di</strong>ale <strong>di</strong>venta patrimonio con<strong>di</strong>viso<br />
e non viene <strong>di</strong>sperso.<br />
Se le installazioni sono come opere d’arte, i musei virtuali<br />
possono essere come cicli <strong>di</strong> affreschi, laboratori<br />
aperti che si interfacciano con il fruitore, nei quali la tecnologia<br />
<strong>di</strong>venta il motore <strong>di</strong> emozioni e sensazioni.<br />
Le chiavi <strong>di</strong> lettura del museo, in mano al fruitore, sono<br />
quin<strong>di</strong>, la comunicazione visiva e il racconto.<br />
<strong>La</strong> comunicazione visiva è più efficace <strong>di</strong> quella linguistico-testuale,<br />
allo stesso modo il racconto è particolarmente<br />
efficace per suscitare e mantenere attenzione,<br />
invitando poi alla lettura degli approfon<strong>di</strong>menti.<br />
<strong>La</strong> struttura del racconto e il meccanismo della storia,<br />
intesa come “memoria”, rappresentano quin<strong>di</strong> gli elementi<br />
basilari del museo <strong>di</strong>gitale, dove l’ambientazione<br />
costituta dal binomio sala e opere accoglie opere car<strong>di</strong>ne,<br />
al servizio delle quali occorre mostrare altri oggetti<br />
o immagini.<br />
Dagli oggetti selezionati per animare l’ambiente virtua-<br />
28<br />
fig.5<br />
fig.6<br />
Il giar<strong>di</strong>no delle anime, 1997- interattive<br />
video environment, New Metropolis Science<br />
and Tecnology Center, Amsterdam:<br />
fig.1:bozzetti; fig.2 scena interattiva<br />
fig.7<br />
fig.8<br />
Il soffio sull’angelo primo nafragio del pensiero,<br />
1997-videoinstallazione interattiva,<br />
Università Normale, Pisa; fig.3-4
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
le è possibile navigare in spazi immaginari, che costituiscono<br />
il punto <strong>di</strong> partenza dei racconti visivi che introducono<br />
nuovi percorsi: attraverso ancore visive essi<br />
andranno a popolare altri ambienti, la cui selezione farà<br />
partire altri racconti.<br />
Colonne sonore ed effetti che la moderna tecnologia <strong>di</strong>spone<br />
potranno integrare la visita: così le nuove tecnologie<br />
potranno indurre sensazioni multisensoriali.<br />
Alla fine del percorso il visitatore/spettatore dovrà avere<br />
capito l’opera, letto e assimilato compiutamente il suo<br />
messaggio. Questa è la <strong>di</strong>fferenza principale tra museo<br />
reale e museo virtuale: il secondo fa parlare e raccontare<br />
<strong>di</strong>rettamente gli oggetti.<br />
Quin<strong>di</strong> l’obbiettivo del museo è la creazione <strong>di</strong> una realtà<br />
virtuale 8 per elaborare uno spazio mentale, ideato e<br />
costruito a piacere dal visitatore.<br />
Come accade nelle videoinstallazioni che il gruppo artistico<br />
sopra menzionato ha proposto ne Il giar<strong>di</strong>no delle<br />
anime (Fig. 5-6), oppure ne Il soffio sull’angelo primo<br />
nafragio del pensiero, (Fig. 7-8): in entrambi i movimenti<br />
degli angeli o <strong>di</strong> anime che si legano all’incantesimo<br />
<strong>di</strong> una musica nascosta, fanno partecipare ed interagire<br />
lo spettatore; ma, misteriosi spazi semiaerei, teatri<br />
impalpabili del naufragio del pensiero non si lasciano<br />
penetrare e rimangono, come un soffio, sospesi nella<br />
virtualità.<br />
Mon<strong>di</strong> del passato possono tornare a vivere come se<br />
fossero contemporanei attraverso la visione <strong>di</strong> documenti<br />
storici, dando la possibilità <strong>di</strong> percepire visivamente<br />
le informazioni e restituendo al visitatore la possibilità<br />
<strong>di</strong> rielaborarle mentalmente. Calandosi in un vorticoso<br />
viaggio a ritroso nel tempo, il visitatore può scegliere<br />
i percorsi capaci <strong>di</strong> rispondere alle sue domande o arrivare<br />
in spazi nuovi e magari perdersi in mon<strong>di</strong> prima<br />
sconosciuti.<br />
29
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
Il target è il visitatore comune, che va preso per mano e<br />
guidato su un sentiero sicuro, sia quello che conosce il<br />
tema e cerca approfon<strong>di</strong>menti.<br />
Quin<strong>di</strong> coesistono due livelli <strong>di</strong> lettura:<br />
- le informazioni sintetiche sugli argomenti principali,<br />
- gli approfon<strong>di</strong>menti critici con richiami alle fonti.<br />
Il progetto “<strong>Villetta</strong>”<br />
Il sistema informativo, che raccoglie la grande quantità<br />
<strong>di</strong> informazioni sul monumento, attraverso la schedatura<br />
architettonica fatta sul cimitero della <strong>Villetta</strong> a Parma,<br />
pur non garantendone la conservazione, ne può trasmette<br />
la conoscenza. Qui emerge l’importanza della<br />
<strong>di</strong>vulgazione per la sensibilizzazione alla valorizzazione<br />
e riqualificazione. Ma le informazioni trasmesse dal sistema<br />
informativo nella sua forma base si rivolgono a<br />
specialisti e non possono avvicinare il largo pubblico,<br />
che necessita <strong>di</strong> strumenti <strong>di</strong> più facile accesso, con un<br />
approccio critico e non solo descrittivo.<br />
Se il cimitero rappresenta un museo all’aperto <strong>di</strong> storia,<br />
arte e architettura, occorre aiutare il pubblico a percorrere<br />
consapevolmente i percorsi della memoria che esso<br />
custo<strong>di</strong>sce: questo è possibile con una guida virtuale<br />
che consenta il riferimento veloce tra oggetto e testo,<br />
costruita a partire dal sistema informativo attraverso<br />
una selezione critica dei dati raccolti.<br />
Come simulazione dello spazio mentale del ricordo in<br />
una raccolta virtuale <strong>di</strong> documenti reali, essa deriva da<br />
una sintesi critica del materiale del sistema informativo,<br />
con un ribaltamento del rapporto tra iconografia e testo,<br />
rispetto ad una guida cartacea.<br />
Questo nuovo data-base riservato ai soli oggetti <strong>di</strong> maggior<br />
pregio selezionati, rende più “leggero” il sistema informatico<br />
del museo <strong>di</strong>gitale e quin<strong>di</strong> più snella e veloce<br />
la visita da parte del fruitore.<br />
L’organizzazione del museo <strong>di</strong>gitale nasce quin<strong>di</strong><br />
dall’esigenza <strong>di</strong> ricomporre la grande quantità <strong>di</strong> materiale<br />
censito in una struttura capace <strong>di</strong> essere una<br />
“guida” facilmente fruibile che porti alla luce la memoria<br />
racchiusa nel cimitero: una promenade architettonica,<br />
artistica e storica che “<strong>di</strong>sveli” quelle sepolture emblematiche<br />
della riproduzione in mortem dell’habitat dei<br />
vivi, ma anche altri possibili percorsi tematici, che mettano<br />
alla luce materiali documentati dai rilievi e dalle ricerche<br />
archivistiche.<br />
Nell’insieme questo “racconta” la scultura, l’architettura<br />
e la pittura, ma anche le memorie pubbliche e private<br />
30
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
che si sono accumulate negli ultimi due secoli valorizzando<br />
in tal senso il patrimonio culturale 9 sotto la cui<br />
definizione è ascrivibile il cimitero stesso.<br />
Questa guida virtuale, la cui organizzazione bene risponde<br />
al binomio tutela e valorizzazione che definisce<br />
il concetto <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a 10 del bene, concorre a preservare<br />
la memoria della comunità nazionale e del suo<br />
territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.<br />
Essa vuole quin<strong>di</strong> essere un percorso che racconta le<br />
architetture ritrovate in una città perduta: senza sostituirsi<br />
ai monumenti, essa intende essere un’integrazione<br />
e richiamo, un orientamento al riconoscimento dell’oggetto<br />
d’arte, al quale resta il compito <strong>di</strong> svelarsi completamente<br />
“dal vero”, raccontando altre storie.<br />
I percorsi<br />
<strong>La</strong> struttura del racconto è quella <strong>di</strong> un albero, i cui<br />
rami in<strong>di</strong>viduano percorsi <strong>di</strong> fruizione, organizzati in tre<br />
macroambienti 11 in cui arte e storia s’intrecciano in una<br />
struttura complessa, nella quale si possono costruire<br />
percorsi <strong>di</strong> lettura alternativi:<br />
- i manufatti (arte e architettura),<br />
- gli artefici (defunti e autori),<br />
- la storia.<br />
Questi percorsi tematici che ne contengono altri, sono<br />
il risultato della lettura comparativa degli oggetti architettonici<br />
accumulati nel cimitero che, con le loro forme,<br />
illustrano l’opera degli artisti locali e con altri riferimenti<br />
raccontano la storia citta<strong>di</strong>na attraverso le persone che<br />
l’hanno con<strong>di</strong>zionata.<br />
Tutte le informazioni sono state quin<strong>di</strong> organizzate in<br />
schede riferite a singoli oggetti/personaggi selezionati,<br />
nelle quali la compilazione dei campi specifici e la<br />
presenza <strong>di</strong> parole chiave permette il collegamento ai<br />
<strong>di</strong>versi percorsi, cui possono essere relazionati gli elementi<br />
del museo <strong>di</strong>gitale.<br />
In ogni scheda, riferita agli oggetti, sono compilati campi<br />
che permettono d’in<strong>di</strong>viduare:<br />
- nome e descrizione artistica degli oggetti,<br />
- la collocazione planimetrica,<br />
- la tipologia,<br />
- lo stile <strong>di</strong> riferimento/ l’autore/ le date <strong>di</strong> costruzione,<br />
- immagini correlate (fotografie-<strong>di</strong>segni <strong>di</strong> progetto),<br />
- riferimenti bibliografici e archivistici,<br />
- defunti importanti,<br />
31
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
- presenza <strong>di</strong> elementi ornamentali e opere d’arte,<br />
- l’eventuale collegamento ad altre informazioni contenute<br />
nel sistema informativo principale.<br />
Nelle schede degli artefici sono contenute le note biografiche<br />
(tratte da: Roberto <strong>La</strong>sagni, Dizionario biografico<br />
dei parmigiani, Parma,1999 - G.Capelli, Architetti del<br />
primo Novecento, 1975 e Gli anni del Liberty, 1993), la<br />
posizione delle sepolture e/o delle opere ed eventualmente<br />
la residenza e/o le opere nella città dei vivi, e<br />
infine le parole chiave che permettono <strong>di</strong> inquadrare il<br />
personaggio nelle categorie <strong>di</strong> appartenenza riferite a<br />
possibili percorsi tematici.<br />
L’elemento base della schedatura è l’architettura, ricondotta<br />
alle costruzioni comuni delle parti collettive del<br />
cimitero (ottagono, gallerie, oratorio…), alle sepolture<br />
(archi, cappelle, e<strong>di</strong>cole, tombe) e ai monumenti commemorativi.<br />
Come supporto <strong>di</strong> elementi ornamentali essa è infatti<br />
il primo riferimento al quale collegare, quando saranno<br />
<strong>di</strong>sponibili, anche le informazioni derivate dalla schedatura<br />
artistica degli stessi manufatti.<br />
Gli oggetti selezionati, nelle loro valenze architettoniche<br />
e scultoree, sono caratterizzati da un linguaggio architettonico<br />
che permette la loro classificazione per stile.<br />
Pertanto il tema ARTE e ARCHITETTURA può essere<br />
letto secondo percorsi stilistici predefiniti, che possono<br />
<strong>di</strong>ventare vere e proprie lezioni <strong>di</strong> storia dell’arte locale:<br />
- Neoromanico,<br />
- Neogotico,<br />
- Liberty,<br />
- Eclettismo,<br />
- Decò e Simbolismo.<br />
Il percorso che riguarda gli ARTEFICI presenta gli autori<br />
delle opere (architetti, scultori, pittori) e i defunti celebri<br />
(scienziati, artisti, politici ed eroi <strong>di</strong> guerra): come i primi<br />
hanno costruito la città, i secon<strong>di</strong> ne hanno fatto la<br />
storia.<br />
Il percorso della STORIA, racconta la trasformazione<br />
fisica dell’ottagono monumentale nelle sue fasi <strong>di</strong> fondazione,<br />
costruzione e crescita, riferita ai principali avvenimenti<br />
della città e della Nazione.<br />
I percorsi secondari nei quali si articola la lettura storica<br />
sono principalmente quelli temporali significativi per la<br />
32
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
crescita del cimitero, raccontati dalle gesta dei defunti e<br />
dai loro manufatti commemorativi.<br />
Ai percorsi stilistici principali se ne aggiungono altri,<br />
come quello degli autori (i principali artefici dell’architettura)<br />
e degli artisti (a cui possono essere ricondotti<br />
mosaici, pitture, sculture ed altre opere), ma anche i riferimenti<br />
tipologici e simbolici che spiegano gli oggetti<br />
attraverso l’accesso ad un glossario critico in cui sono<br />
stati inseriti i termini riguardanti l’arte funeraria e un abaco<br />
dei simboli e dei loro significati.<br />
Altri approfon<strong>di</strong>menti rimandano alla simbologia del recinto<br />
con le sue valenze simboliche, storiche e architettoniche.<br />
Importante il riferimento (descritto dalle biografie<br />
collegate ai percorsi) alle famiglie, ai defunti illustri e<br />
alle loro gesta che nel loro insieme permettono <strong>di</strong> ricostruire<br />
la storia civica.<br />
Ulteriori riferimenti riguardano ambiti tematici inerenti<br />
l’architettura:<br />
- la tipologia della tomba nella sua evoluzione stori ca;<br />
- l’in<strong>di</strong>viduazione dei modelli <strong>di</strong> riferimento e dei loro caratteri<br />
spaziali;<br />
- l’interpretazione attraverso la comparazione tipologica<br />
dei modelli.<br />
I percorsi s’intrecciano quin<strong>di</strong> tra loro. Lo schema dell’albero<br />
a tre rami si articola in una forma intrecciata che<br />
ricorda quella <strong>di</strong> una pianta rampicante.<br />
Gli ulteriori approfon<strong>di</strong>menti sono testi relativi agli stu<strong>di</strong><br />
critici esistenti in formato PDF e le schede WIKI che potranno<br />
essere aggiornate e integrate dagli stessi utenti.<br />
33
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
Esempi <strong>di</strong> un percorso critico:<br />
Approfon<strong>di</strong>mento dell’architettura<br />
<strong>La</strong> ricerca nell’ambito dell’architettura funeraria, ha evidenziato<br />
uno stretto legame formale e simbolico tra<br />
quella che era la “domus dei morti” nelle civiltà etrusche<br />
e romane e quella che è ai giorni nostri. L’analisi architettonica<br />
e simbolica <strong>di</strong> incisioni riguardanti “gli antichi<br />
sepolcri etruschi e romani” ha permesso <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare<br />
i tre spazi (funzionali e formali) caratterizzanti queste<br />
architetture e le forme primarie <strong>di</strong> riferimento (cerchio,<br />
il quadrato e il triangolo rappresentate dalle tombe <strong>di</strong><br />
Cecilia Metella e quella <strong>di</strong> Caio Cestio) che si ritrovano<br />
nell’“architettura parlante “dell’illuminismo.<br />
<strong>La</strong> dromos, la tomba e il vano della tomba a tholos etrusca,<br />
e <strong>di</strong> quella romana <strong>di</strong> Anna Regilla (tipologia a tempietto)<br />
lungo la Via Appia, si traducono nel protiro, nel<br />
sepolcro e nel vano delle cappelle gentilizie dei cimiteri<br />
neoclassici.<br />
Le tipologie ricorrenti in<strong>di</strong>viduano la tomba come archetipo<br />
<strong>di</strong> casa in quanto <strong>di</strong>mora eterna, sepolcro, luogo<br />
che accoglie l’uomo a nuova vita: le loro origini possono<br />
essere in<strong>di</strong>viduate nella forma del mausoleo che, fin<br />
dal periodo romano, è stato usato per in<strong>di</strong>care i sepolcri<br />
innalzati alla memoria <strong>di</strong> eroi e citta<strong>di</strong>ni illustri. Nello<br />
schema architettonico è in generale una tomba regale o<br />
gentilizia, il cui principale riferimento tipologico è quello<br />
del Pantheon. A questo “tipo” sono riconducibili tre principali<br />
tipologie <strong>di</strong> tombe <strong>di</strong> matrice romana-ellenistica: la<br />
tomba a e<strong>di</strong>cola, la tomba a torre e la colonna commemorativa.<br />
34<br />
SEPOLCRI ETRUSCHI E ROMANI: in<strong>di</strong>viduazione<br />
delle tipologie e delle forme primarie<br />
(cerchio, quadrato, triangolo)
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
35<br />
LE TOMBE A THOLOS (IPOGEE), de<strong>di</strong>cate<br />
alle sepolture regali: un corridoio conduce<br />
alla tomba in cui era collocato il sarcofago<br />
del re.<br />
Gli elementi spaziali sono: il portico(dromos),<br />
tomba e vano.<br />
LE TOMBE A TEMPIETTO: strutturate su<br />
un alto po<strong>di</strong>o a cui si accede me<strong>di</strong>ante<br />
scalinate che conducono alla sepoltura. Il<br />
dromos, la tomba e il vano strutturano con<br />
forme <strong>di</strong>verse lo spazio della sepoltura.<br />
IL PALAZZO DEL RE E’IL MODELLO DEL-<br />
LA TOMBA A TEMPIETTO: l’ingresso e la<br />
sala del trono (megaron) si configurano<br />
come il dromos e la tomba.<br />
Quin<strong>di</strong> il sarcofago prende il posto del trono
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
36<br />
I MODELLI DELL’ANTICHITA’: l’e<strong>di</strong>cola, la<br />
tomba a torre, la colonna commemorativa<br />
L’INTERPRETAZIONE NEL CIMITERO<br />
DELLA VILLETTA:<br />
il recinto e la porta sono gli elementi caratterizzanti<br />
sia l’impianto cimiteriale che la<br />
singola “domus”<br />
SCHEMI TIPOLOGICI DELLE CAPPELLE<br />
FUNERARIE: le linee invisibili che strutturano<br />
il dromos, la tomba e il vano.<br />
Mario Mongui<strong>di</strong> (Spaggiari, Zanzucchi,<br />
Stori).
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
37<br />
SCHEMI TIPOLOGICI DELLE CAPPELLE<br />
FUNERARIE: le linee invisibili che strutturano<br />
il dromos, la tomba e il vano.<br />
Ennio Mora (Ghiretti, Villa, Peracchi,<br />
Molinari,Vietta).<br />
ORGANIZZAZIONE DEI RECINTI CIMI-<br />
TERIALI PARMENSI:<br />
Il recinto e la porta sono gli elementi caratterizzanti<br />
sia l’impianto cimiteriale sia<br />
la singola “domus”; il riferimento al primo<br />
cimitero settecentesco realizzato da Milizia<br />
traduce una matrice tipologica (il recinto)<br />
per il cimitero neoclassico che trova nel<br />
cimitero della villetta un esempio significativo.<br />
L’origine simbolica e tipologica del recinto<br />
è quella del Pantheon (25 a.c.) (dal greco:<br />
παν, pan, “tutti” e θεόν, theon, “dèi”) che<br />
si <strong>relazione</strong> nella sua forma spaziale con<br />
il cimitero <strong>di</strong> Choaux realizzato d Viollet Le<br />
Duc (1775).<br />
LA SCULTURA E L’ARCHITETTURA<br />
SONO SINONIMI;<br />
L’angelo della morte nella veste <strong>di</strong> guerriero,<br />
<strong>di</strong> suonatore o <strong>di</strong> uomo piangente è il<br />
simbolo dominante per tutto il cimitero.<br />
Di matrice bistolfiana trova i riferimenti alle<br />
figure imprigionate nella materia...(i prigioni<br />
michelangioleschi)
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
38<br />
<strong>La</strong> <strong>relazione</strong> tra la forma dell’architettura<br />
e lo spazio dell’ornamento in<strong>di</strong>vidua nella<br />
porta l’elemento dominante attraverso l’ornamento.<br />
L’ornamento è tradotto sia come<br />
entità stilistica che come simbolo: la scultura<br />
è l’ornamento stesso, la forma architettonica<br />
che mantiene gli spazi degli antichi<br />
sepolcri si veste <strong>di</strong> una <strong>di</strong>mensione simbolica<br />
che dà carattere alla sua forma.<br />
Progetto per una tomba: il delfino simbolo<br />
del Cristo, è la forma che con-figura il progetto<br />
<strong>di</strong> un tomba per i cimitero <strong>di</strong> Parma.
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
Note<br />
1 Secondo l’art. 2 del Co<strong>di</strong>ce, il patrimonio culturale è costituito dai<br />
beni culturali e paesaggistici<br />
2 Art.10, 1° comma del Co<strong>di</strong>ce dei beni culturali.<br />
3 Art.10, 2° comma lettera a)<br />
4 Art. 101 dlg. 42/2004, Istituti e luoghi della cultura, lettera a) comma<br />
2-3<br />
5 Art. 2.1 dello Statuto dell’ICOM<br />
6 Le opere <strong>di</strong> questo gruppo artistico, sono considerate dei classici<br />
che hanno cambiato la storia dell’arte contemporanea.<br />
L’esperienza artistica condotta riguarda la ricerca <strong>di</strong> un luogo possibile<br />
e non finito, rivolto ad un uomo che cerca <strong>di</strong> uscire dalla sua<br />
gabbia senza riuscirci mai. Un mondo che è sogno e incubo.<br />
Alla fine, come per lo Shakespear in Romeo and Juliet, ci si dovrebbe<br />
chiedere quale sia mai la “sostanza dei sogni”.<br />
Ciò che rende unico il loro lavoro è la straor<strong>di</strong>naria capacità <strong>di</strong><br />
emozionare attraverso la tecnologia, assumendo la sfida tecnologica<br />
per trasmetterla in un’emozione che è anche trasferimento <strong>di</strong><br />
sapere; queste opere traducono nella forma visiva e in quella del<br />
racconto la parte non fisica delle cose.<br />
Sono pochi gli artisti italiani che negli ultimi venti anni sono stati<br />
esposti nel mondo e copiati come Stu<strong>di</strong>o Azzurro.<br />
7…..Attorno ad un tavolo si sono decisi i destini <strong>di</strong> uomini, su <strong>di</strong> un<br />
tavolo si è scritto il sapere dell’umanità, ci si riunisce ad un tavolo<br />
per confrontarsi e ricordare, ci si appoggia ad un tavolo con un libro<br />
per leggere testi e anche per vedere immagini. Il tavolo è l’essenza<br />
del museo <strong>di</strong> Sarzana, è una superficie della memoria, che accoglie<br />
le testimonianze e la storia: se sfiorato, restituisce ai visitatori<br />
i suoni e le immagini che virtualmente e invisibilmente trattiene.<br />
Antiche forme narrative, come la tra<strong>di</strong>zione del racconto orale, e<br />
nuove tecnologie, come video proiezioni sincronizzate e interattive,<br />
convivono nel grande tavolo del museo, a sua volta sovrastato da<br />
un lungo schermo su cui vengono proiettati i volti, antichi e spesso<br />
sconosciuti, dei protagonisti e dei testimoni della resistenza. Lo<br />
schermo, sottile velo verticale, corre per tutta la lunghezza del tavolo<br />
e ne <strong>di</strong>vide i due lati: esso rappresenta il luogo della memoria,<br />
dei ricor<strong>di</strong>, delle testimonianze appassionate. Sfiorando appena,<br />
con un solo movimento, la superficie del tavolo i volti degli uomini e<br />
delle donne si animano e, in sintonia con le immagini proiettate sui<br />
modelli <strong>di</strong> libri e raccoglitori che il tavolo espone, ci parlano della<br />
storia attraverso le loro intense esperienze personali. E’ possibile<br />
ascoltare attenti i racconti, completati da fotografie e filmati <strong>di</strong> repertorio,<br />
e nello stesso tempo osserviamo i volti che, attraverso le<br />
rughe, il candore dei capelli, i segni del tempo e dell’età, rimandano<br />
l’eco<strong>di</strong> altre vite, vicine e parallele a quelle che ci vengono narrate.<br />
Una pluralità <strong>di</strong> storie, volti, ed immgini.<br />
8 Virtuale agg. dal lat. me<strong>di</strong>oevale dei filosofi scolastici virtualis,<br />
der. <strong>di</strong> virtus, virtù, facoltà, potenza, sinonimo <strong>di</strong> potenziale, cioè<br />
esistente in potenza – contrapposto ad attuale, reale, effettivo. Definizione<br />
tratta dal Vocabolario Treccani.<br />
9 Art. 2, del Co<strong>di</strong>ce dei beni culturali: “il patrimonio culturale è costituito<br />
dai beni culturali e dai beni paesaggistici”; sono “beni culturali<br />
le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10,11, presentano<br />
interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico,<br />
archivistico e bibliografico e le altre cose in<strong>di</strong>viduate dalla legge o<br />
in base alla legge quali testimonianze aventi valore <strong>di</strong> civiltà”.<br />
10 Art. 1, 1° comma del Co<strong>di</strong>ce dei beni culturali.<br />
11 S’intendono gli ambienti interattivi realizzati con i mezzi tecnologici<br />
più avanzati (installazioni interattive o videoproiezioni).<br />
39
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
Dal monumento alla città<br />
Cecilia Tedeschi<br />
Come un Oroboro -che è la fi gura simbolo della continuità<br />
e del principio che tutto comincia nel preciso istante<br />
in cui termina- lo stesso che dalla sommità del portale<br />
d’ingresso accoglie i visitatori della <strong>Villetta</strong>, vorrei<br />
riallacciarmi alle parole introduttive laddove, parlando<br />
<strong>di</strong> ricerca, si sottolineano le molteplici derivazioni a cui è<br />
possibile giungere da un qualsiasi tema.<br />
Così, dal generale al particolare -dalla conoscenza<br />
della schedatura, alle in<strong>di</strong>cazioni progettuali del piano<br />
particolareggiato, fi no alla trasmissione delle informazioni<br />
del museo <strong>di</strong>gitale- in un percorso lineare predefi nito, si<br />
sono avvicendati numerosi scenari collaterali, altrettanto<br />
vali<strong>di</strong> della medesima considerazione riservata al primo.<br />
Nella raccolta delle informazioni necessarie alla schedatura<br />
dei manufatti cimiteriali già erano emersi continui riman<strong>di</strong><br />
alla città dei vivi: nel nome dei defunti, nelle loro vicende<br />
o nelle gesta personali <strong>di</strong> cui si erano resi protagonisti; ma<br />
anche nel nome <strong>di</strong> coloro invece che sono stati gli autori,<br />
i progettisti dei manufatti stessi e quin<strong>di</strong> della bellezza<br />
dell’intero complesso cimiteriale. Figure che attraverso la<br />
loro storia, fatta <strong>di</strong> vicende ma soprattutto <strong>di</strong> ideologie e <strong>di</strong><br />
cultura, hanno saputo dare un valido contributo non solo<br />
allo sviluppo economico, politico della società ma anche a<br />
quello urbanistico ed architettonico della città storica.<br />
In questo senso, alla storia del cimitero si affi anca quella<br />
più vasta e complessa del tessuto urbano, con relazioni<br />
molteplici per cui dall’invito al cimitero che era (ed è) nelle<br />
intenzioni del museo <strong>di</strong>gitale si passa a quello più articolato<br />
nei confronti della città e alla sua conoscenza.<br />
Così che il progetto del museo <strong>di</strong>gitale <strong>di</strong>venta strumento<br />
<strong>di</strong> visualizzazione delle possibili relazioni tra le due città<br />
ed il ciclo dell’Oroboro prosegue nella continuità del suo<br />
percorso.<br />
Quanto sopra è emerso ancor più chiaramente nella<br />
costruzione del modello 3d necessario alla simulazione<br />
del processo <strong>di</strong> crescita del cimitero e quin<strong>di</strong> nella<br />
rap<strong>presentazione</strong> dello sviluppo storico-architettonico<br />
della <strong>Villetta</strong>: un modello 3d estremamente semplifi cato,<br />
realizzato con l’intenzione <strong>di</strong> mostrare la saturazione<br />
avvenuta nel tempo dello spazio interno del cimiterio<br />
e la conseguente alterazione percettiva del porticato<br />
40<br />
LA CRESCITA DELLA VILLETTA<br />
1817: il recinto<br />
1876: la galleria sud<br />
1879: i campi<br />
1905: la galleria Nord
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
ottagonale; la cui simulazione fotorealistica -che sembra<br />
essere una delle caratteristiche <strong>di</strong>stintive <strong>di</strong> quello che oggi<br />
comunemente viene defi nito “museo virtuale” - sarebbe<br />
risultata eccessiva.<br />
<strong>La</strong> simulazione della crescita è stata possibile attraverso la<br />
preventiva in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> otto soglie storiche; le prime<br />
coincidenti a interventi costruttivi eseguiti all’interno della<br />
<strong>Villetta</strong>, mentre le ultime a date ed eventi storici legati alla<br />
storia sociale e politica della città:<br />
1817: costruzione del recinto ottagonale;<br />
1876: costruzione della Galleria Sud;<br />
1879: doc. iconografi ca relativa al cimitero<br />
della <strong>Villetta</strong>;<br />
1905: costruzione Galleria Nord;<br />
1912-25: piano regolatore del cimitero -<br />
addossati alla Galleria Sud (anni 20);<br />
1925-30: gallerie addossate al lato sud-est del<br />
portico;<br />
1930-45: Galleria est (’31) – fi ne guerra<br />
Mon<strong>di</strong>ale;<br />
1945-2007: ricostruzione ed età moderna.<br />
Ed è proprio in questa organizzazione, nella scelta<br />
preventiva delle fasi storiche, che rinveniamo non solo la<br />
storia <strong>di</strong> quanto avvenuto all’interno del recinto cimiteriale<br />
–gli interventi costruttivi in primis- ma anche gli eventi<br />
esterni da cui questi hanno avuto origine: della ripresa<br />
demografi ca avvenuta a partire dal 1881, ma soprattutto<br />
del considerevole aumento della mortalità derivato in<br />
seguito all’epidemia <strong>di</strong> colera del 1884-85. Avvenimento<br />
che nel 1888 portò alla realizzazione <strong>di</strong> un primo strumento<br />
<strong>di</strong> pianifi cazione per la gestione delle sepolture nei campi<br />
e, nel 1893, al progetto della Galleria Nord che nello stu<strong>di</strong>o<br />
realizzato in occasione della costruzione della Galleria Sud<br />
era invece stato previsto per il primo decennio del secolo<br />
successivo.<br />
A tutto questo si aggiunge la mortalità della prima e seconda<br />
guerra mon<strong>di</strong>ale ed, in particolare, <strong>di</strong> quella dell’ultimo<br />
dopoguerra che ha condotto alla completa saturazione dei<br />
campi centrali, nonostante gli ampliamenti della Galleria<br />
Perimetrale, del Campo Sud, del San Pellegrino, ecc.<br />
Ma le vicende del costruito in ambito cimiteriale, oltre che<br />
alle vicende belliche o <strong>di</strong> particolari eventi naturali, sono<br />
anche strettamente correlate alla politica urbanistica<br />
41<br />
1912-25:il piano regolatore cimiteriale<br />
- gli addossati della galleria sud<br />
1925-30: le gallerie minori<br />
1930-45: la galleria sud-est<br />
1945-2007: il secondo dopoguerra
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
dell’Amministrazione Comunale e che, soprattutto nel<br />
periodo post-unitario, venne defi nita e <strong>di</strong>segnata allo scopo<br />
<strong>di</strong> migliorare le con<strong>di</strong>zioni sociali della popolazione: al <strong>di</strong><br />
là della effettiva crescita demografi ca e con un’attenzione<br />
particolare rivolta non tanto alle con<strong>di</strong>zioni igieniche quanto<br />
a quelle ambientali ed infrastrutturali. Parallelamente alle<br />
vicende cimiteriali si accostano dunque i progetti idraulici<br />
per il rifacimento e la costruzione <strong>di</strong> alcuni tratti <strong>di</strong> argini<br />
fl uviali (pennelli), il progetto <strong>di</strong> riforma dei ponti –eseguito<br />
nel 1870, conseguentemente alla piena del 1868- i progetti<br />
relativi alle demolizioni dei rampari e delle porte urbane,<br />
fi no a quelli per il potenziamento della rete potabile ed<br />
elettrica, che portarono alla effettiva modernizzazione<br />
dell’intero sistema urbano. Interventi questi realizzati<br />
dall’Amministrazione Comunale, molti dei quali –soprattutto<br />
nel trentennio successivo all’unifi cazione d’Italia- progettati<br />
dall’Ing. Marco Sante Bergamaschi; una fi gura che,<br />
nonostante la mancata segnalazione da parte della<br />
toponomastica citta<strong>di</strong>na, molto <strong>di</strong>ede non solo alla città ma<br />
alla <strong>Villetta</strong> stessa: con la costruzione della Galleria Sud,<br />
della Galleria Nord, così come nella pianifi cazione interna<br />
dei campi e nello stu<strong>di</strong>o delle infrastrutture al <strong>di</strong> là del<br />
recinto cimiteriale.<br />
E’ dunque in questo <strong>di</strong>segno progettuale unitario del sistema<br />
urbano, che nel tentativo <strong>di</strong> assolvere al meglio le necessità<br />
della società postunitaria, la <strong>Villetta</strong> viene ad inserirsi. E<br />
42<br />
iconografi a del cimitero allegata<br />
alla <strong>relazione</strong> del 1888 - ASC,<br />
1890, carteggio, culto, b. 936
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
43
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
44<br />
il viale della <strong>Villetta</strong><br />
1862, pianta del Nuovo Foro Boario -<br />
ASC, 1867, carteggio, polizia 3, b.168
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e <strong>di</strong> Architettura<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma - Facoltà <strong>di</strong> Architettura<br />
se questo avviene alla scala urbana attraverso operatori<br />
della pubblica amministrazione quali il Bergamaschi, non<br />
dobbiamo <strong>di</strong>menticarci <strong>di</strong> coloro invece che, pur rimanendo<br />
ad operare nella sfera del privato, con le loro opere hanno<br />
contribuito a mo<strong>di</strong>fi care l’immagine e la percezione formale<br />
dentro e fuori il cimitero.<br />
Solo per citarne alcuni, rimanendo nell’ambito dei<br />
manufatti privati dei campi, si ricordano gli architetti:<br />
Moderanno Chiavelli (progettista del palazzo delle Poste);<br />
Ettore Leoni (sta<strong>di</strong>o Tar<strong>di</strong>ni); Camillo Uccelli (chiesa <strong>di</strong><br />
San Leonardo); Ennio Mora (palazzo del Podestà); Mario<br />
Mongui<strong>di</strong> (monumento a Filippo Corridoni); ecc. Architetti<br />
che hanno lasciato un segno importante anche sulla<br />
città novecentesca: cresciuta sulle grazie degli interventi<br />
infrastrutturali del tardo Ottocento e sfociata nella modernità<br />
del ventennio tra le due guerre, come evidenziato in una<br />
recente indagine archivistica degli interventi architettonici<br />
ed urbanistici realizzati in questo particolare momento<br />
storico. Degli avvenimenti e dei personaggi signifi cativi<br />
che hanno caratterizzato questi perio<strong>di</strong> si trova traccia<br />
nella memoria conservata nel cimitero, come un rifl esso <strong>di</strong><br />
quanto avvenuto nella città dei vivi. Altro nome signifi cativo<br />
in questo senso è infatti quello <strong>di</strong> Giuseppe Rizzar<strong>di</strong> Polini:<br />
sovrintendente ai lavori pubblici alla fi ne dell’Ottocento<br />
ed autore delle residenze <strong>di</strong> molti dei proprietari (altoborghesi)<br />
degli archi dell’Ottagono. In questo modo, dai<br />
manufatti funerari -siano essi pubblici o privati- l’invito al<br />
cimitero, che è nelle intenzioni del museo <strong>di</strong>gitale, arriva al<br />
sistema urbano e alla conoscenza <strong>di</strong> coloro che tale hanno<br />
reso la nostra città.<br />
45<br />
1870, progetto <strong>di</strong> riforma del ponte <strong>di</strong><br />
sotto detto Ponte Verde, <strong>di</strong> sette archi -<br />
ASC, carteggio, acque 2-3, b.452<br />
1886, progetto <strong>di</strong> un ponte sul Parma -<br />
ASC, 1889, carteggio, acque 2, b.892<br />
1897, Macello <strong>di</strong> via Saffi -<br />
ASC, 1902, carteggio, b.1398