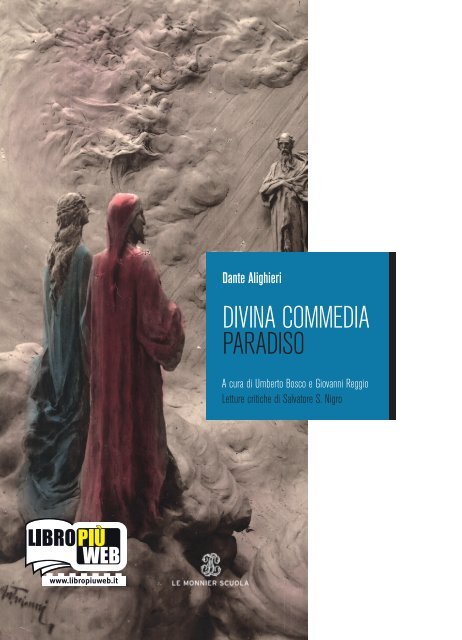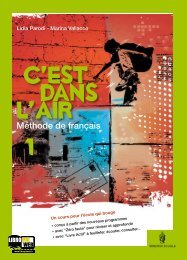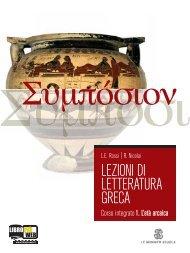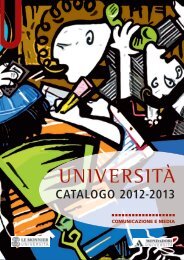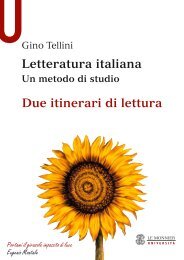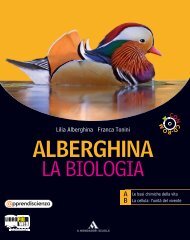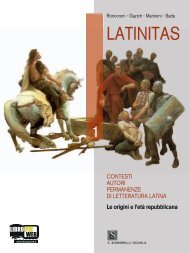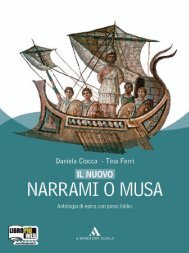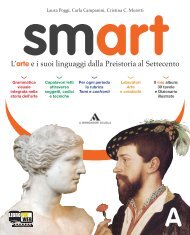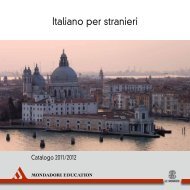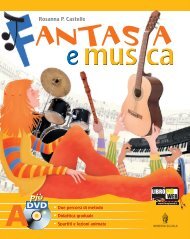Divina commeDia PaRaDiSo - Mondadori Education
Divina commeDia PaRaDiSo - Mondadori Education
Divina commeDia PaRaDiSo - Mondadori Education
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Dante Alighieri<br />
<strong>Divina</strong> <strong>commeDia</strong><br />
<strong>PaRaDiSo</strong><br />
a cura di Umberto Bosco e Giovanni Reggio<br />
Letture critiche di Salvatore S. nigro
INDICE<br />
La perenne “traducibilità” della Commedia di Salvatore Silvano Nigro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII<br />
Commentare la Commedia di Umberto Bosco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII<br />
Indicazioni bibliografiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX<br />
Il «terzo regno»: il Paradiso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1<br />
ASCOLTA LA<br />
COMMEDIA<br />
Canto I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5<br />
LETTURA D’AUTORE • I rischi della navigazione nel mare dell’essere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23<br />
IL PUNTO DELLA CRITICA • «con miglior / voci si pregherà…»: quali voci pregheranno Cirra? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27<br />
Canto II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31<br />
ASCOLTA LA<br />
COMMEDIA<br />
Canto III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48<br />
LETTURA D’AUTORE • Parabole claustrali e perfezioni imperfette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62<br />
Canto IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64<br />
Canto V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76<br />
ASCOLTA LA<br />
COMMEDIA<br />
Canto VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89<br />
LETTURA D’AUTORE • Giustiniano, l’Impero e l’aquila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106<br />
IL PUNTO DELLA CRITICA • «luce la luce di Romeo»: Romeo di Villanova alter ego di Dante? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109<br />
Canto VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113<br />
Canto VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125<br />
ASCOLTA LA<br />
COMMEDIA<br />
Canto IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143<br />
IL PUNTO DELLA CRITICA • «Cunizza fui chiamata, e qui refulgo»: perché una donna dai molti amanti merita il Paradiso? . . . . . 160<br />
Canto X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164<br />
LETTURA D’AUTORE • Il paradiso dei sapienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181<br />
ASCOLTA LA<br />
COMMEDIA<br />
Canto XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183<br />
LETTURA D’AUTORE • La parola del Vangelo per raccontare san Francesco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200<br />
IL PUNTO DELLA CRITICA • «Francesco e Povertà per questi amanti…»: fredda allegoria o vivo misticismo? . . . . . . . . . . . . 203<br />
Canto XII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207<br />
LETTURA D’AUTORE • Il gioco dello specchio: Domenico e Francesco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223<br />
Canto XIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225<br />
Canto XIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238<br />
V
VI<br />
INDICE<br />
ASCOLTA LA<br />
COMMEDIA<br />
Canto XV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253<br />
LETTURA D’AUTORE • La strada di Cacciaguida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269<br />
Canto XVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271<br />
Canto XVII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288<br />
LETTURA D’AUTORE • La croce di Dante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305<br />
IL PUNTO DELLA CRITICA • «Tutta tua visïon fa manifesta»: la Commedia è fictio poetica o visione profetica? . . . . . . . . . . . . 307<br />
Canto XVIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312<br />
Canto XIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327<br />
Canto XX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342<br />
Canto XXI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357<br />
Canto XXII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372<br />
Canto XXIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387<br />
LETTURA D’AUTORE • La duplice visione: melodia e oblio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402<br />
Canto XXIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404<br />
ASCOLTA LA<br />
COMMEDIA<br />
Canto XXV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421<br />
IL PUNTO DELLA CRITICA • L’Epistola a Cangrande: autentica o no? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436<br />
Canto XXVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440<br />
ASCOLTA LA<br />
COMMEDIA<br />
Canto XXVII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455<br />
IL PUNTO DELLA CRITICA • «Così si fa la pelle bianca nera / nel primo aspetto …»: chi è la «bella figlia»? . . . . . . . . . . . . 471<br />
Canto XXVIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475<br />
Canto XXIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489<br />
Canto XXX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505<br />
ASCOLTA LA<br />
COMMEDIA<br />
Canto XXXI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519<br />
Canto XXXII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533<br />
ASCOLTA LA<br />
COMMEDIA<br />
Canto XXXIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547<br />
LETTURA D’AUTORE • Verso Dio: la preghiera…e la visione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565<br />
IL PUNTO DELLA CRITICA • Un canto unitario o no? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569<br />
Vedere Dante. Interpretazioni figurative della Commedia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601
ASCOLTA LA<br />
COMMEDIA<br />
Canto<br />
I due motivi fondamentali<br />
La protasi e il tema<br />
della luce<br />
La difficoltà di capire<br />
e addirittura ricordare<br />
L’invocazione ad Apollo<br />
Il monito costante<br />
contro la superbia<br />
Dove<br />
Personaggi<br />
TEMI E STRUTTURA DEL CANTO<br />
I<br />
Dal Paradiso terrestre verso i cieli<br />
del Paradiso.<br />
Dante e Beatrice.<br />
Introduzione<br />
Questo primo canto contiene già i temi essenziali dell’intera terza cantica ed è retto fondamentalmente<br />
da due motivi di pensiero e di poesia: l’universo nel pugno del suo artefice «che tutto<br />
move», l’immenso, il vario, il tutto nell’uno; e il volo dell’anima, di una singola anima, infinitesima<br />
particella del tutto, per giungere a lui: in essa l’universo si riflette ed è compreso.<br />
I primi dodici versi rappresentano la protasi del Paradiso. Caeli enarrant gloriam Dei, si dice nei<br />
Salmi; ma se la perfezione dei cieli è la miglior testimonianza e glorificazione della potenza divina,<br />
anche le cose e gli esseri più piccoli, imperfetti e caduchi testimoniano e glorificano Dio. La<br />
potenza di Dio, la sua onnipresenza che non è presenza dall’alto e dal di fuori, ma costituisce,<br />
come si spiegherà nel canto seguente, il modo intimo di essere di ogni creatura sono per Dante<br />
«gloria». La gloria è luce: divinus radius sive divina gloria, spiega Dante nell’epistola a Cangrande<br />
(Ep XIII 64) identificando il concetto di Dio con quello di luce (vedi anche per questo l’Introduzione<br />
al canto II). Sono i temi principali della poesia del Paradiso: Dio concepito come luce, la quale<br />
man mano che l’anima si eleva si fa sempre più intensa e trionfale. Proprio la luce, cioè la meno<br />
corporea, almeno per i tempi di Dante, delle cose belle terrene, si spiritualizza sempre più fino a<br />
diventare, al di sopra dei cieli ‘corporali’, pura luce intellettuale.<br />
Dio è dappertutto; Dante, che ha avuto il privilegio di godere da vivo di quella massima luce, ne dà qui alto<br />
ma umile annuncio. Accanto al ricordo del privilegio, cita anche quello delle deboli forze sue e di tutti<br />
gli uomini, dell’insufficienza non solo a concepire Dio, ma perfino a ricordare. Spiega poi di non sapere<br />
perché non ricorda. La memoria non può rifare il cammino già fatto, per una sola eccezionale occasione,<br />
dall’intelletto sprofondatosi nella divinità. Appare qui per la prima volta un altro dei costanti modi della<br />
poesia del Paradiso: la recusatio, la protesta della propria insufficienza rispetto al tema, era abituale nei<br />
poeti augustei (come ricordato da Paratore) ma assume in Dante un diverso significato: è lo sgomento del<br />
poeta dinanzi alla sua materia; l’altezza di questa è indirettamente rappresentata da quello sgomento.<br />
Ai vv. 13-36 Dante spiega che se per le altre due cantiche era stato sufficiente l’aiuto delle Muse, ora<br />
gli occorre l’ausilio anche dell’altro giogo di Parnaso, quello sacro al dio della poesia: Apollo deve<br />
entrare in lui, respirare e cantare in lui, con quella stessa pienezza di canto con la quale aveva vinto<br />
il satiro Marsia, che aveva osato sfidarlo. Anche nel chiedere all’inizio del Purgatorio l’aiuto delle Muse,<br />
Dante aveva rievocato una sfida fatta da mortali a immortali, e la conseguente punizione: le Pieridi<br />
trasformate in piche. Perché questa insistenza? Perché così Dante rivolge a se stesso un monito che<br />
è, come sappiamo, uno dei più costanti dell’intera Commedia e sarà solennemente ribadito anche<br />
5
6<br />
CANTO I<br />
Ancora<br />
nel Paradiso terrestre<br />
Il nuovo paesaggio<br />
L’inizio del volo nei cieli:<br />
il tendere a Dio<br />
INTRODUZIONE<br />
all’inizio del canto seguente: è possibile affrontare in poesia i temi più ardui per le forze umane, purché<br />
si sappia che si tratta di un dono divino, si riconosca che è la divinità stessa a parlare per bocca<br />
del poeta. Dante si pone in guardia contro quella che egli sa bene essere la sua nemica, la superbia.<br />
Marsia e le Pieridi erano mortali convinti di poter contare solo sulle proprie forze umane, senza, anzi<br />
contro, la divinità: e sono stati con irrisoria facilità sconfitti e puniti. L’ingegno deve dunque essere<br />
costantemente guidato dal pensiero di Dio: pena altrimenti la perdita del bene eterno. Se gli uomini<br />
riconosceranno l’eccellenza della sua poesia, se lo premieranno con la corona di alloro, Dante sa bene<br />
che il merito non è suo, ma della materia e della divinità che lo ha sorretto: «vedra’mi al piè del tuo<br />
diletto legno / venire, e coronarmi de le foglie / che la materia e tu mi farai degno» (vv. 25-27). Da<br />
questa umiltà verso Dio rampolla l’umiltà verso gli uomini: «Poca favilla gran fiamma seconda: / forse<br />
di retro a me con miglior voci / si pregherà perché Cirra risponda» (vv. 34-36). I migliori poeti del futuro<br />
non sono, propriamente, coloro che avranno maggiori forze poetiche, ma coloro che sapranno<br />
meglio pregare perché solo così raggiungeranno una meta poetica più alta.<br />
All’inizio del canto Dante è ancora nel Paradiso terrestre, presso la sorgente del Letè e dell’Eunoè:<br />
una scena ancora terrestre, dalle linee concrete, anche se impregnate di simboli. Un momento<br />
prima avevamo assistito a un’affollata scena e ascoltato un fitto dialogo: le sette ninfe si erano<br />
improvvisamente fermate, Dante aveva chiesto spiegazioni, Beatrice aveva delegato la risposta a<br />
Matelda che aveva dichiarato di non aver nulla da aggiungere al già detto; Beatrice aveva scusato<br />
la dimenticanza di Dante e poi aveva esortato Matelda a guidarlo all’Eunoè; la bella donna aveva<br />
annuito, non senza prima avere invitato Stazio a unirsi a Dante. Da un punto di vista paesaggistico<br />
il Paradiso terrestre è un angolo di bosco alpino: acque fredde che scorrono nella penombra,<br />
tra foglie verdi e rami che, al confronto, sembrano neri.<br />
Ed ecco che a un tratto tutto ciò sparisce: nella fantasia di Dante e nella nostra appare un altro<br />
paesaggio, insieme concreto e astratto. Il poeta non completa il racconto né segnala lo stacco:<br />
attraverso una determinazione cronologica particolarmente ampia e solenne (vv. 37-42), al paesaggio<br />
alpino si sostituisce la visione dell’immenso orizzonte illuminato dal sole, quasi come fosse<br />
naturale, concreto, concepibile con mezzi terreni.<br />
Qui inizia il volo del poeta nei cieli di cui Dante mette in evidenza la ‘facilità’, immaginando di<br />
meravigliarsene e di chiederne spiegazioni a Beatrice che risponde paragonandolo al tendere del<br />
fuoco verso l’alto, della Terra verso il centro, cioè a fatti fisici. Allo stesso modo, subito dopo (vv.<br />
43-48), quando Beatrice si rivolge a guardare il sole come un’aquila, non abbiamo la rappresentazione<br />
di un luogo determinato, ma quella dell’intera sfera terrestre, da una parte tutta in ombra<br />
dall’altra tutta in luce. Anche Dante fissa il sole (vv. 49-72) obbedendo alla necessità; non è un<br />
UNA QUESTIONE: QUANDO INIZIA ESATTAMENTE IL VOLO DI DANTE?<br />
Ènel momento in cui fissa il sole che, senza accorgersene,<br />
Dante si stacca dalla terra? Molti e autorevoli interpreti ne<br />
sono convinti basandosi sul fatto che a Dante sembra<br />
che la luce raddoppi (infatti, dice che gli pare che Dio abbia<br />
creato un altro sole). Ma Dante spiega anche che la possibilità<br />
che egli ebbe allora di fissare il sole oltre l’uso umano dipende<br />
unicamente dal suo essere nel Paradiso terrestre, nel<br />
«loco / fatto per proprio de l’umana spece» (vv. 56-57): dunque<br />
in questo istante egli è ancora sulla cima della montagna<br />
del Purgatorio. Se ne distaccherà subito dopo, quando<br />
sposterà lo sguardo dal sole per fissarlo in quello di Beatrice:<br />
allora, e allora soltanto, si sente trasumanato. Comincia<br />
cioè la sua ascensione in vita nell’alto dei cieli, verso la contemplazione<br />
della gloria di Dio.<br />
Si è accennato alla questione non perché importi molto farsi<br />
malinconici misuratori e cronometristi del viaggio dantesco,<br />
ma perché il fatto che sia stata posta dimostra che Dante non<br />
ha indicato in modo preciso il momento del suo distaccarsi da<br />
terra. E non lo ha fatto perché non si tratta di un gesto materiale,<br />
ma di qualcosa che riguarda l’anima, fuori dello spazio e<br />
del tempo: Dante non si accorge dello stacco; il cambiamento<br />
è solo dentro di lui. Nell’Inferno e nel Purgatorio, invece, Dante<br />
segna le tappe del suo procedere, le difficoltà e lo sforzo.
INTRODUZIONE<br />
Il corpo e l’anima<br />
di Dante nel Paradiso<br />
Il Paradiso: musica e luce<br />
Il primo dubbio di Dante<br />
e il nuovo ruolo di Beatrice<br />
Il secondo dubbio di Dante<br />
atto di volontà il suo: qui, nei cieli, egli non può fare altro che tendere a Dio. Infatti, ai vv. 48, 54,<br />
65, 66, insiste sulla fissità del proprio sguardo e di quello di Beatrice, cioè sull’intensità e la fermezza<br />
del desiderio di Dio. Non c’è bisogno che Beatrice lo esorti: non una parola fra loro: il desiderio<br />
di Dio si comunica dall’una all’altro con una forza irresistibile. Il soprannaturale diventa<br />
naturale perché l’uomo è trasumanato.<br />
Dante, fissando il suo sguardo in quello di Beatrice, s’innalza sempre più: è solo la sua anima a<br />
salire, o anche il corpo? E come ciò avviene? Nessun dubbio che Dante immagini un volo anche<br />
corporeo ma di sicuro non lo afferma esplicitamente: infatti dice «lo sa Dio» (vv. 73-75), ricalcando<br />
le parole di san Paolo, che aveva lasciato nell’indeterminatezza quale parte di lui fosse salita<br />
al terzo cielo: «Non so se nel corpo, non so se fuori del corpo: Dio lo sa». Forse il poeta è volutamente<br />
ambiguo per la necessità di non precisare troppo un’esperienza (Sapegno). Il corpo, che<br />
tanto lo aveva fatto faticare alle prime salite del Purgatorio e che faceva ombra, suscitando la<br />
meraviglia dei penitenti, si era tuttavia sempre più alleggerito lungo la salita. Ora, nel Paradiso,<br />
Dante ha, sì, sempre il suo corpo, dato che la perfezione si attua solo nell’unione di anima e<br />
corpo, nel castigo come nel premio (Pd XIV 43-51), ma è un peso non più tale perché privo di<br />
peso fisico e di consistenza, quindi più leggero dell’aria e del fuoco. Non è più d’impaccio<br />
all’anima che si eleva, ma tutt’uno con essa; il dualismo anima-corpo è scomparso. Dal punto<br />
di vista fisico e da quello morale il corpo ha perso ogni carattere specifico e Dante, pur avendolo,<br />
non lo avverte (vedi anche Il punto della critica al canto XXVII).<br />
Dal v. 76, il Paradiso si rivela a Dante come dolce ebbrezza di musica e luce: la musica è armonia<br />
prodotta dalle sfere celesti nel loro ruotare (Dante trascura quindi l’opinione di Aristotele e<br />
della scolastica, seguendo invece il Cicerone del Somnium Scipionis). I suoni sono distinti eppure<br />
fusi insieme, temperati dalla legge dell’armonia divina: ecco che subito Dante sottolinea come<br />
l’immensamente molteplice e vario resti tale e al tempo stesso formi un tutt’uno concorde.<br />
Insieme al suono, la luce allaga il cielo. Secondo molti esegeti, Dante attraversa la sfera del fuoco.<br />
Il poeta però rappresenta solo l’allargarsi dell’orizzonte: vede il cielo più vicino e più ampio e più<br />
acceso di sole che mai avesse visto dalla Terra e con occhi terreni.<br />
«La novità del suono e ’l grande lume» accendono in Dante, ancora ignaro di essersi staccato<br />
dalla Terra, il desiderio di conoscere la ragione dell’uno e dell’altro. Beatrice chiarisce, ma<br />
suscita subito un nuovo dubbio, ancora più grande. Dubbio che la donna spiega, ai vv. 89-141,<br />
assumendo il suo ufficio che non è tanto quello di guida, bensì di maestra di varia scienza, proprio<br />
dell’intera cantica. La sua prima risposta è semplice e schematica: tu immagini il falso,<br />
credi di essere ancora in Terra, e questo falso immaginare ti rende ottuso; in realtà, stai tornando<br />
in cielo, dove è la vera sede della tua anima, giacché la dimora terrena dell’uomo è provvisorio<br />
esilio; e questo ritorno avviene con la stessa naturalità e velocità – quasi istantaneità –<br />
della folgore che fa il cammino inverso, lasciando la sua sede celeste per scendere in terra. Il<br />
sorriso con cui Beatrice pronuncia queste parole si concilia con la gravità della spiegazione,<br />
colorandola di affettuosa indulgenza.<br />
Ma ora Dante ha un nuovo dubbio: come possa, con il suo corpo pesante, essere più leggero dei<br />
corpi lievi, come l’aria e il fuoco, e quindi volare attraverso di essi. La maestra Beatrice è presentata<br />
come una madre che sospira e guarda sconsolata il figlio che dice cose senza senso. La<br />
sua spiegazione supera la domanda per abbracciare tutto l’universo, con lo stesso procedimento<br />
del canto seguente. Infatti, nel particolare che è Dante si riflette l’intero creato: «Le cose tutte<br />
quante / hanno ordine tra loro, e questo è forma / che l’universo a Dio fa simigliante» (vv. 103-<br />
105): l’essenza del mondo consiste nel suo ordine, che è armonia, e proprio in ciò somiglia a<br />
Dio. L’ordine «dà all’anima del poeta il senso di una conquista – razionale e morale – definitiva»<br />
(Sansone). Qui è l’impronta del creatore; e il fine di questo ordine è giungere a lui: il fuoco tende<br />
naturalmente e irresistibilmente verso l’alto; la Terra al contrario si restringe in se stessa e pesa,<br />
collocandosi al centro del creato; i «cor mortali» dei bruti si muovono obbedendo all’istinto loro<br />
dato: «Questi ne porta il foco inver’ la luna; / questi ne’ cor mortali è permotore; / questi la terra<br />
in sé stringe e aduna» (vv. 115-117). Dante ribadisce che dentro a ciascun istinto c’è un’unica<br />
CANTO I<br />
7
8<br />
CANTO I<br />
Due immagini<br />
La chiusa del canto<br />
e la ripresa del tema<br />
fondamentale<br />
Canto I<br />
PROEMIO AL PARADISO<br />
volontà ordinatrice, tutto tende a un’unica meta. Così, anche gli uomini tendono per istinto a<br />
Dio: sono mossi dal desiderio di lui, essi che hanno «intelletto e amore»: amore consapevole,<br />
«amore d’animo». Perciò ora Beatrice e Dante tendono naturalmente a Dio. Come nell’immenso<br />
mare le navi tendono tutte alla riva, anche se si dirigono ciascuna a un diverso porto, così<br />
tutte le creature tendono ad adeguarsi, ciascuna a suo modo, all’ordine divino. Balena la visione<br />
delle creature sperdute nella vastità paurosa del mondo e la sicurezza di una mano invisibile<br />
che le guida: «onde si muovono a diversi porti / per lo gran mar de l’essere, e ciascuna / con<br />
istinto a lei dato che la porti» (vv. 112-114).<br />
Le due immagini, della vastità e varietà, e della sicurezza con cui ogni creatura è diretta al suo<br />
fine, si compenetrano l’una nell’altra. La cantica inizia con l’immagine di Dio che «move» tutto<br />
l’universo e si concluderà con un’altra immagine di armonioso unico moto: «l’amor che move il<br />
sole e l’altre stelle» (Pd XXXIII 145). L’anima umana è come una folgore, che nulla può fermare;<br />
essa è saettata da Dio a un segno, a un bersaglio infallibile: «e ora lì, come a sito decreto, / cen<br />
porta la virtù di quella corda / che ciò che scocca drizza in segno lieto» (vv. 124-126). Come la<br />
freccia, scoccata dal buon arciere, toccherà sicuramente il segno, così il sito dell’uomo è «decreto»,<br />
stabilito ab aeterno; il raggiungerlo è una necessità. Il fine dell’uomo è la felicità.<br />
Il primo canto del Paradiso è suggellato dal silenzioso sguardo di Beatrice fisso al cielo: «Quinci<br />
rivolse inver’ lo cielo il viso» (v. 142). Il volo di lei è in quello sguardo, in quel desiderio di volo senza<br />
moto. Già al principio del canto, tra le innumerevoli perifrasi possibili per indicare Dio, Dante aveva<br />
scelto quella di Dio come desiderio: «appressando sé al suo disire» (v. 7). Più oltre, egli aveva nel<br />
desiderio di Dio indicata la causa del muoversi dei cieli e della loro eternità: «Quando la rota che<br />
tu sempiterni / desiderato...» (vv. 76-77). Qui è il centro del canto; ed è anche il motivo essenziale<br />
di tutto il Paradiso: Dio non è fuori di noi, ma dentro di noi, nel bisogno che abbiamo di lui.<br />
Proemio al Paradiso (1-36). – Trasumanazione e ascensione di Dante (37-81). – Primo dubbio di Dante<br />
(82-93). – Secondo dubbio e soluzione di Beatrice: l’ordine dell’universo (94-142).<br />
La gloria di colui che tutto move<br />
per l’universo penetra, e risplende<br />
1-36. Proemio al Paradiso. Dante dichiara di essere stato nel più alto dei cieli, l’Empireo, dove ha visto «cose» che la<br />
mente umana non è in grado di ricordare del tutto; materia del suo canto sarà ciò che la memoria ha potuto<br />
conservare e per questo invoca Apollo: se il dio della poesia lo aiuterà nel suo compito, egli potrà sperare nella<br />
corona d’alloro, il cui solo desiderio sarà tanto più gradito al dio quanto più raro è sulla Terra, per «colpa e<br />
vergogna» degli uomini i cui desideri sono rivolti a tutt’altro.<br />
1-36. La gloria... risponda: al breve proemio dell’Inferno di una<br />
sola terzina (II 7-9), già si era contrapposto quello del<br />
ARGOMENTO DELLA CANTICA<br />
Purgatorio che indicava il più grande impegno e la<br />
coscienza di una più alta materia trattata. A maggior
ARGOMENTO DELLA CANTICA PROEMIO AL PARADISO<br />
CANTO I<br />
3 in una parte più e meno altrove.<br />
Nel ciel che più de la sua luce prende<br />
fu’ io, e vidi cose che ridire<br />
6 né sa né può chi di là sù discende;<br />
ragione, quindi, la materia del Paradiso, ardua e sottile,<br />
per cui erano necessari un più intenso lavoro e un impegno<br />
più profondo, richiedeva un adeguato proemio che si<br />
sviluppa per ben dodici terzine. Nelle prime quattro è<br />
indicato l’argomento, le rimanenti otto contengono l’invocazione.<br />
Già le quattro terzine proemiali del Purgatorio<br />
segnalavano l’atmosfera poetica della seconda cantica<br />
mentre l’ampio proemio della terza si diversifica ancora<br />
grazie alla maggiore solennità dell’apertura (vv. 1-3), alla<br />
dichiarata ineffabilità della materia trattata (vv. 5-9) e<br />
all’affermazione (da parte del poeta) della coscienza del<br />
proprio valore (vv. 16-18; 25-27).<br />
1. La gloria: vocabolo pregnante, carico di significati religiosi di<br />
ascendenza biblica; cfr. Ps. XVIII 2: Caeli enarrant gloriam<br />
Dei («I cieli narrano la gloria di Dio»); Eccli. XLII 16: gloria Domini<br />
plenum est opus eius («della gloria del Signore è piena<br />
l’opera sua») ecc. Il vocabolo non va inteso solo nel senso di<br />
«potenza» o «magnificenza» ma, come suggerisce Dante<br />
stesso nell’Epistola a Cangrande, divinum lumen, «luce divina»<br />
(Ep XIII 61): la luce è motivo dominante della cantica,<br />
anzi elemento fondamentale della stessa cosmologia dantesca<br />
(Busnelli).<br />
di colui che tutto move: Dio, motore primo e immobile dell’universo,<br />
secondo la formula aristotelica, di cui Dante<br />
dà ragione nell’Epistola a Cangrande (XIII 54-57). Nella simmetria<br />
costruttiva della cantica, questo primo verso si salda<br />
con l’ultimo (l’amor che move il sole e l’altre stelle,<br />
XXXIII 145), sigillando circolarmente il Paradiso col nome<br />
di Dio.<br />
2. per... risplende: penetrat, quantum ad essentiam; resplendet,<br />
quantum ad esse («penetra, quanto all’essenza, risplende,<br />
quanto all’essere», Ep XIII 64). Altra immagine è di ascendenza<br />
biblica; Dante stesso richiama Geremia (XXIII 24:<br />
caelum et terra ego impleo, «io riempio il cielo e la terra»), la<br />
Sapienza (I 7: spiritus Domini replevit orbem terrarum, «lo<br />
spirito del Signore riempie tutto l’universo»), l’Ecclesiastico<br />
(XLII 16: gloria Domini plenum est opus eius, «della gloria<br />
del Signore è piena l’opera sua»), e persino una fonte pagana:<br />
Lucano (Phars. IX 580: Iuppiter est quodcumque vides,<br />
quodcumque moveris, «Giove è, comunque guardi, dovunque<br />
vai»).<br />
3. in una... altrove: dice Dante nell’Epistola a Cangrande: videmus<br />
in aliquo excellentiori gradu essentiam aliquam, aliquam vero<br />
in inferiori; ut patet de celo et elementis, quorum quidem illud<br />
incorruptibile, illa vero corruptibilia sunt («... vediamo un’essenza<br />
in un grado più eccellente, e un’altra in uno inferiore;<br />
come è chiaro del cielo e degli elementi, dei quali quello è<br />
incorruttibile, e questi corruttibili»). Il lume divino quindi risplende<br />
in una parte più e meno altrove secondo la maggiore<br />
o minore capacità di ciascuna cosa ad accoglierlo. Nel Convivio<br />
aveva sostenuto il concetto fondamentale per la filosofia<br />
scolastica (cfr. san Tommaso, Summa theol. I, q. VIII, a.<br />
1): «... la divina bontade in tutte le cose discende, e altrimenti<br />
essere non potrebbero; ma avvegna che questa bontade si<br />
muova da simplicissimo principio, diversamente si riceve,<br />
secondo più o meno, da le cose riceventi» (Cv III VII 2). Cfr.<br />
anche VE I XVI 5.<br />
4. Nel ciel... prende: l’Empireo. Ce lo conferma l’Epistola a Cangrande<br />
(XIII 66-68), in particolare l’affermazione: cum dicit<br />
‘in illo celo, quod plus de luce Dei recipit’, intelligit circumloqui<br />
Paradisum, sive celum empyreum («quando dice ‘nel ciel che<br />
più de la sua luce prende’ intende indicare con perifrasi il Paradiso,<br />
o il cielo empireo», ibid. 74). Altri (Porena, Chimenz<br />
ecc.) ritengono invece trattarsi del Paradiso in generale: vedi<br />
le note ai vv. 7-9 e al v. 10.<br />
5. fu’ io: in posizione di rilievo, rivela la consapevolezza del<br />
poeta della grazia particolare che gli è stata concessa.<br />
6. né sa... discende: nell’Epistola a Cangrande: nescit quia oblitus,<br />
nequit quia, si recordatur et contentum tenet, sermo tamen<br />
deficit. Multa namque per intellectum videmus quibus signa<br />
vocalia desunt («non sa perché dimentico, non può perché,<br />
se ricorda e ritiene il contenuto, manca però l’espressione.<br />
Infatti vediamo mediante l’intelletto molte cose cui<br />
mancano i segni linguistici», ibid. 83-84). La spiegazione<br />
dell’Epistola a Cangrande, in realtà, va oltre rispetto a quanto<br />
spiegato nei versi seguenti dove si dice che l’ineffabilità<br />
di ciò che ha visto è dovuta alla deficienza della memoria,<br />
non all’incapacità espressiva. Vero è che accenni a tale<br />
incapacità, cioè all’inadeguatezza del linguaggio a esprimere<br />
tali visioni, sono assai frequenti nel corso della cantica<br />
e in particolare negli ultimi canti. Forse col pensiero a<br />
tali accenni, la chiosa dell’Epistola a Cangrande è andata oltre<br />
il testo. Per le due «ineffabilitati» dovute alla memoria<br />
e al linguaggio, cfr. anche Cv III III 13-15.<br />
9
10<br />
CANTO I<br />
PROEMIO AL PARADISO<br />
perché appressando sé al suo disire,<br />
nostro intelletto si profonda tanto,<br />
9 che dietro la memoria non può ire.<br />
Veramente quant’io del regno santo<br />
ne la mia mente potei far tesoro,<br />
12 sarà ora materia del mio canto.<br />
O buono Appollo, a l’ultimo lavoro<br />
fammi del tuo valor sì fatto vaso,<br />
7-9. perché... ire: i versi danno la spiegazione del perché Dante, disceso<br />
dal Cielo, né sa né può ridire ciò che ha visto. È l’excessus<br />
mentis dei mistici, chiarito poi nell’Epistola a Cangrande: ... sciendum<br />
est quod intellectus humanus in hac vita, propter connaturalitatem<br />
et affinitatem quam habet ad substantiam intellectualem<br />
separatam, quando elevatur, in tantum elevatur, ut memoria post<br />
reditum deficiat propter trascendisse humanum modum («... è da<br />
sapere che l’intelletto umano in questa vita per la connaturalità<br />
e affinità che ha alla sostanza intellettuale separata [gli angeli],<br />
quando si eleva, si eleva tanto che dopo il ritorno manca la memoria<br />
per avere trasceso la facoltà umana», 78). Come ha spiegato<br />
Nardi («L’Alighieri», I, 1960, 1, 5-13) la memoria non è l’abditum<br />
mentis, l’abstrusior mentis profunditas di sant’Agostino,<br />
cioè una delle facoltà dell’anima razionale (vedi anche Pg XXV<br />
83 ss.), bensì l’habitus del «senso comune» e della «fantasia», cioè<br />
uno dei «sensi interni», di cui parlava Aristotele. Nel concetto aristotelico,<br />
filtrato attraverso la filosofia medievale da Averroè ad<br />
Alberto Magno e a san Tommaso, la memoria s’identifica con<br />
l’immaginazione da cui l’intelletto «trae quello ch’el vede» (Cv III<br />
v 9), ed essa quindi non può seguire l’intelletto quando questo<br />
penetra solo per mezzo di un fulgore (Pd XXXIII 141) nel mistero<br />
divino uscendo di se stesso (cfr. Pd XXIII 43-45: la mente mia<br />
così, tra quelle dape / fatta più grande, di sé stessa uscìo, / e che si<br />
fesse rimembrar non sape). Per spiegare questo mistico excessus<br />
mentis Dante, nell’Epistola a Cangrande, rimanda non solo alle<br />
testimonianze di san Paolo (II Cor. XII 2) e di altri testi biblici<br />
(Matteo, Ezechiele), ma anche a testi specifici: il De quantitate<br />
animae di sant’Agostino, il Tractatus de consideratione di san Bernardo<br />
e il De gratia contemplationis di Riccardo da san Vittore.<br />
Più che i primi due, che non ci danno elementi decisivi, vale quest’ultimo<br />
(l’autore ebbe indubbiamente grande influenza su<br />
Dante). Nell’opera citata, ricordando i tre modi della contemplazione:<br />
mentis dilatatio, mentis sublevatio, mentis alienatio, Riccardo<br />
dice che l’alienazione della mente è quando la memoria<br />
delle cose presenti esce fuori della memoria, e ancora più chiaramente:<br />
cum enim per mentis excessum supra sive intra nosmetipsos<br />
in divinorum contemplationem rapimur, exteriorum omnium<br />
statim imo non solum eorum quae extra nos verum etiam eorum<br />
quae in nobis sunt omnium obliviscimur. Et item cum ab illos<br />
sublimitatis statu ad nosmetipsos redimus, illa quae prius supra<br />
ARGOMENTO DELLA CANTICA<br />
nosmetipsos vidimus in ea veritate vel claritate qua prius perspeximus<br />
ad nostram memoriam revocare omnino non possumus<br />
(«quando per un eccesso della mente siamo rapiti sopra noi stessi<br />
nella contemplazione delle cose divine, delle cose esterne dimentichiamo<br />
non solo quelle che sono fuori di noi, ma anche<br />
quelle che sono in noi. E quando poi da quello stato di sublimità<br />
ritorniamo in noi stessi non possiamo assolutamente richiamare<br />
alla nostra memoria quelle cose che prima abbiamo visto sopra<br />
di noi con quella verità e chiarezza che prima avevamo visto»,<br />
VI 23). Da tutto ciò e sulla base delle conclusioni a cui è giunto<br />
Nardi nell’articolo citato (quasi indiscutibile, date l’autorità e la<br />
profonda dottrina filosofica del grande medievalista), resta inequivocabilmente<br />
sicuro che il ciel che più de la sua luce prende del<br />
v. 4 è l’Empireo e non il cielo in generale. Vedi anche nota al v. 10.<br />
7. al suo disire: a Dio, oggetto e meta ultima del desiderio (disire)<br />
di conoscenza dell’intelletto (suo).<br />
8. si profonda: si addentra, si immerge profondamente. Il verbo,<br />
raro e poetico, si trova solo qui e in Pd XXVIII 107 riferito<br />
agli angeli, sempre per esprimere il rapimento delle creature<br />
nel penetrare l’essenza divina; correlativo, dice Mattalìa,<br />
della metafora biblica di Dio-abisso.<br />
10. Veramente: tuttavia, come il latino verumtamen.<br />
regno santo: qui, dato il contesto in cui l’espressione si trova, va<br />
inteso come cielo in generale. L’interpretazione di Porena,<br />
Chimenz e di altri, che identificano il ciel di v. 4 con questa<br />
espressione (regno santo), è da considerarsi inesatta. Infatti<br />
nei vv. 7-9, come detto in nota, Dante accenna all’ineffabilità<br />
della visione divina nell’Empireo, mentre qui indica, come<br />
materia della cantica, quel poco di cui la memoria ha potuto<br />
far tesoro (al v. 23 la dirà ombra). La sequenza logica è<br />
quindi un’altra: Dante dice di esser stato nell’Empireo e di<br />
aver visto ciò che è ineffabile (cfr. Pd XXXIII 140-142): quel<br />
poco che nella salita attraverso i dieci cieli è rimasto nella<br />
memoria diventerà la materia del suo canto.<br />
11. mente: memoria. Cfr. If II 6 e 8.<br />
12. materia: argomento. Di tale materia è detto nell’Epistola a<br />
Cangrande (ibid. 85): que qualia sint et quanta, in parte executiva<br />
patebit («quali e quante siano queste cose apparirà nella<br />
parte esecutiva»). Termina qui la prima parte del prologo e<br />
la proposizione retorica dell’argomento. Questi primi dodici
INVOCAZIONE AD APOLLO PROEMIO AL PARADISO<br />
CANTO I<br />
15 come dimandi a dar l’amato alloro.<br />
Infino a qui l’un giogo di Parnaso<br />
assai mi fu; ma or con amendue<br />
18 m’è uopo intrar ne l’aringo rimaso.<br />
Entra nel petto mio, e spira tue<br />
sì come quando Marsïa traesti<br />
21 de la vagina de le membra sue.<br />
versi corrispondono ai vv. 1-6 del primo canto del Purgatorio;<br />
dunque la proposizione del Paradiso è doppia rispetto a<br />
quella della cantica precedente. Vedi la nota iniziale.<br />
13. O buono Appollo: l’invocazione continua fino al v. 36. Nella<br />
scolastica partizione dell’Epistola a Cangrande è divisa in due<br />
parti: in prima invocando petit; in secunda suadet Apollini petitionem<br />
factam, remunerationem quandam prenuntians («nella<br />
prima chiede invocando; nella seconda persuade Apollo<br />
alla richiesta fatta preannunciando un premio»). Per il valore<br />
di buono = valente, eccellente, cfr. If I 71. Nell’Inferno (II<br />
7) e nel Purgatorio (I 8) Dante aveva invocato le Muse: ora il<br />
loro aiuto non basta più: la materia del Paradiso abbisogna<br />
dell’aiuto del dio stesso della poesia. Vedi Introduzione. Per<br />
la grafia con la doppia «p», cfr. PETROCCHI, I 452.<br />
ultimo lavoro: l’ultima fatica del poeta, che è anche la più ardua.<br />
Da notare il latinismo «lavoro» = «fatica», eco virgiliana:<br />
extremum hunc, Arethusa, mihi concede laborem: «accordami,<br />
o Aretusa, quest’ultima fatica», Buc. X 1.<br />
14-15. fammi... alloro: letteralmente: fammi un vaso così pieno del<br />
tuo valore poetico, quanto tu stesso richiedi per concedere<br />
l’alloro da te amato. In altre parole: infondi in me tanto della<br />
tua ispirazione, quanto tu richiedi per concedere l’incoronazione<br />
poetica. Il termine «vaso» deriva dalle Sacre Scritture:<br />
cfr. Act. Ap. IX 15 dove san Paolo è detto vas electionis; e cfr.<br />
If II 28. L’alloro è allusione al mito di Dafne, amata dal dio e trasformata<br />
in lauro (cfr. Ovidio, Met. I 452-567). Per il tema preannunciato<br />
dell’incoronazione poetica vedi nota al v. 26.<br />
16. l’un giogo di Parnaso: il Parnaso è un massiccio montuoso della<br />
Grecia centrale, che separa la Focide dalla Locride occidentale<br />
e dalla Beozia. La vetta doppia, consacrata ad Apollo e a<br />
Bacco, era ricordata dai poeti antichi (Ovidio, Met. I 316-317;<br />
Lucano, Phars. V 72-73 ecc.). Forse da una notizia di Servio,<br />
Isidoro di Siviglia indica i due gioghi col nome di Cirra e Nisa,<br />
ma aggiunge che i gioghi prendono il nome di Citerone ed Elicona<br />
(Etym. XIV VIII 11); ciò forse ha determinato la confusione<br />
del Parnaso con l’Elicona, che è invece un altro massiccio<br />
montuoso (cfr. nota a Pg XXIX 40). Il fatto però che il Parnaso<br />
fosse simbolo classico di poesia, come lo era l’Elicona sacro<br />
alle Muse, può essere all’origine della confusione che appare<br />
in Isidoro e che si è protratta fino ai giorni nostri, in cui non<br />
mancano commentatori che indicano in l’un giogo di Parnaso<br />
l’Elicona. Ma naturalmente non sappiamo cosa Dante conoscesse,<br />
né ci aiutano gli antichi commentatori, alcuni dei quali<br />
come Pietro di Dante e Benvenuto – sulla scorta della notizia<br />
di Isidoro, e forse dei versi di Lucano – pensano che Dante<br />
considerasse Apollo e Bacco come nomi poetici per indicare<br />
l’unica vera divinità, mentre altri spiegano solo il significato<br />
simbolico delle due cime (la scienza naturale e la scienza divina).<br />
Non è da escludersi però che Dante, confondendo l’Elicona,<br />
sede delle Muse, con il Parnaso o con parte di esso,<br />
avendo invocato le Muse nelle cantiche precedenti, voglia qui<br />
significare, con un giogo, quelle dee, e con l’altro, Apollo. È<br />
certo comunque che il discorso ha valore metaforico.<br />
17. ma or con amendue: con l’aiuto delle Muse e di Apollo.<br />
18. aringo rimaso: l’argomento che rimane da trattare. Il vocabolo,<br />
di origine germanica (dal gotico *hari-hrings) indicava<br />
propriamente il campo in cui si svolgeva una gara o un torneo,<br />
poi, per estensione, la gara stessa. Qui in senso figurato<br />
indica la prova che Dante deve affrontare con l’ardua materia<br />
del Paradiso.<br />
19. spira tue: ispirami tu (tue). Tue con la più volte vista epitesi<br />
in -e.<br />
20-21. sì come... sue: come quando vincesti Marsia e poi lo traesti<br />
fuori dalla pelle, scorticandolo. Allusione al racconto ovidiano<br />
di Met. VI 382-400. Il satiro Marsia osò sfidare Apollo in una<br />
gara di bravura musicale: egli suonava il flauto e il dio la cetra.<br />
Naturalmente fu sconfitto e Apollo, per punirlo dell’audacia, lo<br />
legò a un albero e lo scorticò. Da notare la simmetria col primo<br />
canto del Purgatorio, dove è ricordata la vittoria delle Muse sulle<br />
Piche (vv. 10-12). Si è già osservato più volte che Dante sintetizza,<br />
per lo più con estrema efficacia, il racconto classico dei<br />
miti. Qui è assai evidente la profonda differenza dalla narrazione<br />
ovidiana, dove lo scorticamento del satiro è descritto nei<br />
particolari macabri e disgustosi: «non la pelle è tratta al satiro,<br />
ma il satiro dal tocco onnipotente del dio è tratto egli fuor dalla<br />
pelle di un sol colpo: fu come sfoderare una spada il trarlo<br />
dalla vagina delle sue membra» (G. Mazzoni). La sintesi dantesca<br />
rappresenta meglio l’azione di un dio, che nel testo ovidiano<br />
è abbassato invece al livello di un comune mortale.<br />
21. vagina: guaina, fodero.<br />
11
12<br />
CANTO I<br />
PROEMIO AL PARADISO<br />
O divina virtù, se mi ti presti<br />
tanto che l’ombra del beato regno<br />
24 segnata nel mio capo io manifesti,<br />
vedra’mi al piè del tuo diletto legno<br />
venire, e coronarmi de le foglie<br />
27 che la materia e tu mi farai degno.<br />
Sì rade volte, padre, se ne coglie<br />
per trïunfare o cesare o poeta,<br />
30 colpa e vergogna de l’umane voglie,<br />
che parturir letizia in su la lieta<br />
22. se mi ti presti: se ti concedi a me, cioè se mi dai il tuo aiuto.<br />
23. l’ombra: perché ciò che può rimanere nella memoria di tante<br />
ineffabili bellezze non può essere altro che un’immagine<br />
sbiadita.<br />
beato regno: il cielo in generale, il Paradiso nel suo complesso.<br />
Cfr. nota al v. 10.<br />
25-26. vedra’mi... coronarmi: le altre edizioni leggevano: «venir vedra’mi<br />
al tuo diletto legno, / e coronarmi allor di quelle fronde<br />
/ che...» ecc. Per la giustificazione della lezione a testo, cfr.<br />
PETROCCHI, I 222 e IV 6.<br />
25. diletto legno: cfr. v. 15 amato alloro. Metonimia per indicare<br />
l’alloro e quindi la gloria poetica.<br />
26. coronarmi: solo nel Paradiso si trova un esplicito accenno all’incoronazione<br />
poetica. Qui, e più ancora nel celebre inizio<br />
del canto XXV, Dante manifesta la speranza che la cantica del<br />
Paradiso possa ottenergli la corona d’alloro. Nella corrispondenza<br />
poetica col grammatico bolognese Giovanni del Virgilio,<br />
che presumibilmente è coeva al canto XXV, Dante dichiara,<br />
in esametri del tutto degni della sua migliore poesia, che<br />
cum mundi circumflua corpora cantu / astricoleque meo velut infera<br />
regna patebunt, / devincire caput hedera lauroque iuvabit<br />
(«quando i corpi che ruotano intorno all’universo e gli abitanti<br />
dei cieli saranno palesi nel mio canto come i regni inferi,<br />
piacerà cingere il capo di edera e di alloro», Eg II 48-50). Questo<br />
insistente motivo (nel 1315 Albertino Mussato era stato solennemente<br />
incoronato) indica in modo significativo la consapevolezza<br />
che il poeta ha del valore della sua poesia e, in particolare,<br />
della grande poesia del Paradiso. Consapevolezza che<br />
verrà proclamata nei primi versi del prossimo canto (II 1-15).<br />
27. la materia e tu: l’altezza della materia trattata e il tuo aiuto.<br />
Nella frase il relativo «che» vale «di cui» e il verbo è concordato<br />
con uno solo dei due soggetti.<br />
28-33. Sì rade... asseta: il senso delle due terzine è il seguente<br />
(chiarimenti particolari verranno dati nelle note): così raramente<br />
si coglie l’alloro per il trionfo di un imperatore o<br />
di un poeta, colpa e vergogna dei desideri umani non più<br />
rivolti ad aspirare alla gloria, che il solo fatto che l’alloro<br />
(la fronda peneia) desti in alcuno il desiderio di sé, dovreb-<br />
INVOCAZIONE AD APOLLO<br />
be generare (parturir) letizia sulla lieta divinità di Apollo<br />
(delfica deïtà).<br />
28. padre: epiteto proprio dei vati e degli dèi.<br />
29. per trïunfare: per il fatto che trionfi.<br />
cesare o poeta: un imperatore o un poeta: cfr. vatumque ducumque...<br />
laurus («l’alloro dei vati e dei condottieri», Stazio, Achill.<br />
I 15-16). Così poi Petrarca del lauro: «onor d’imperatori e di<br />
poeti» (Canz. CCLXIII 2).<br />
30. colpa... voglie: segno di decadimento dei tempi.<br />
31. in su la lieta: è costrutto, nota Porena, un po’ strano, spiegabile<br />
«per l’influenza del concetto che letizia si accumulerebbe<br />
su letizia».<br />
32. delfica deïtà: perifrasi per indicare Apollo, particolarmente<br />
venerato a Delfi, dove si trovava il più celebre dei suoi templi.<br />
Strano il costrutto delle due terzine, perché qui si parla<br />
di Apollo in terza persona; mentre nel v. 28 il poeta si è rivolto<br />
a lui direttamente e con il vocativo «padre». Si tratta di<br />
una costruzione irregolare, che ha spinto parecchi commentatori<br />
a ipotizzare altre interpretazioni.<br />
32-33. la fronda peneia: l’alloro, detto con questa perifrasi perché<br />
Dafne, la ninfa amata da Apollo e tramutata appunto in lauro,<br />
era figlia del fiume Peneo.<br />
33. di sé asseta: cfr. Pg XXXI 129: suscita desiderio; il verbo è<br />
in relazione alla metafora «sete-desiderio».<br />
34. Poca... seconda: un grande incendio (fiamma) segue (seconda)<br />
una piccola (poca) favilla. Cfr. Cino da Pistoia: «Gran foco nasce<br />
di poca favilla» (CLXX, 12 [ed. Marti]): assurdo e anacronistico,<br />
o per lo meno rischioso, pensare a interdipendenze:<br />
la frase doveva avere carattere proverbiale assai diffuso. (Cfr.<br />
Girolamo, Ep. CXXI).<br />
35. di retro a me: dopo di me.<br />
con miglior voci: da poeti migliori di me (l’interpretazione più<br />
diffusa). È un atto di umiltà. Ma il passo è stato variamente<br />
interpretato per cui vedi Il punto della critica p. 27.<br />
36. si pregherà... risponda: si chiederà l’aiuto di Apollo. Cirra era<br />
propriamente una città della Focide sul golfo di Corinto. Collegata<br />
con Delfi, fu spesso designata a significare Apollo stesso<br />
(cfr. Lucano, Phars. V 95-96; Stazio, Theb. III 106-107, 454-
INVOCAZIONE AD APOLLO PROEMIO AL PARADISO<br />
CANTO I<br />
delfica deïtà dovria la fronda<br />
33 peneia, quando alcun di sé asseta.<br />
Poca favilla gran fiamma seconda:<br />
forse di retro a me con miglior voci<br />
36 si pregherà perché Cirra risponda.<br />
Surge ai mortali per diverse foci<br />
la lucerna del mondo; ma da quella<br />
39 che quattro cerchi giugne con tre croci,<br />
con miglior corso e con migliore stella<br />
37-81. Trasumanazione e ascensione di Dante. Riprende la narrazione del viaggio interrotta dalla fine della seconda cantica.<br />
Indicato il momento cronologico dell’azione, Dante narra che, tornato dall’Eunoè, vede Beatrice girata a sinistra<br />
a fissare il sole. Anch’egli fa altrettanto e, riuscendo a figgervi gli occhi, scorge una grande luce. Tornato<br />
con lo sguardo a Beatrice si sente trasumanare: pur non accorgendosene, sta salendo con la sua donna verso<br />
il cielo. Solo da un fatto nuovo è colpito: una dolce armonia e una straordinaria luminosità.<br />
455, 474-475 ecc.). Nella tradizione più tarda fu designato con<br />
quel nome uno dei gioghi del Parnaso (cfr. la nota al v. 16).<br />
37-42. Surge... suggella: ordina e intendi letteralmente: il sole (la<br />
lucerna del mondo) sorge per i mortali da diversi punti dell’orizzonte<br />
(foci), ma da quel punto (quella) in cui quattro<br />
cerchi si intersecano formando tre croci, esso esce congiunto<br />
con una migliore costellazione (stella) procedendo<br />
con un corso migliore, e plasma (tempera) e impronta<br />
(suggella) meglio la materia del mondo (la mondana cera)<br />
con l’efficacia della sua virtù formativa (più a suo modo).<br />
Più complesso e assai discusso il preciso significato astronomico,<br />
che verrà illustrato via via nelle note. Dante, al momento<br />
di riprendere la narrazione, indica il tempo dell’inizio<br />
dell’ultima parte del suo viaggio, come aveva fatto per l’Inferno<br />
(If II 1-5) e per il Purgatorio (Pg I 13 ss. 115-117). Si tratta<br />
probabilmente dell’equinozio primaverile quando il sole è<br />
nella costellazione dell’Ariete, posizione giudicata assai favorevole.<br />
L’ora verrà designata (ma anche essa è oggetto di discusse<br />
interpretazioni) nella terzina successiva (vv. 43-45):<br />
forse indica mezzogiorno.<br />
37. ai mortali: dativo di vantaggio.<br />
foci: per il senso generale di «sbocco», «uscita», cfr. If XXIII<br />
129. Qui è più evidente la metafora pensando al sole «quasi<br />
fiume di luce», come dice Varchi.<br />
38. la lucerna del mondo: il sole. La perifrasi è classica (Virgilio,<br />
Aen. III 637; IV 6; VII 148), ma i commentatori citano Ristoro<br />
d’Arezzo (La Composizione del mondo, I 18, § 5: «[il sole è]<br />
en questo mondo come la lucerna e·lla casa»). Parodi ricorda<br />
invece il Roman de Thèbes (v. 9069 «soz la luiserne del soleil»):<br />
cfr. Lingua, II 381.<br />
quella: sottinteso «foce».<br />
39. quattro... croci: è un passo arduo, che ha messo alla prova<br />
astronomi dantisti e dantisti profani di astronomia. In realtà<br />
le indicazioni fornite da Dante non vanno prese alla lettera.<br />
Si può intendere che tre cerchi (l’Equatore, l’Eclittica e il Coluro<br />
equinoziale) si congiungono in un punto nell’equinozio<br />
di primavera. Poiché il sole sorge sull’orizzonte, questo sarà<br />
il quarto cerchio, che viene a intersecarsi con gli altri tre nel<br />
punto in cui sorge il sole. Si tratta di croci in senso lato, perché<br />
solo Equatore e Coluro sono perpendicolari: se consideriamo<br />
però l’orizzonte come il punto di osservazione del<br />
sorgere della lucerna del mondo, nessuna delle tre croci che<br />
si vengono a formare (Orizzonte + Coluro, Orizzonte +<br />
Eclittica, Orizzonte + Equatore) è una croce regolare con i<br />
quattro bracci perpendicolari. Di quale orizzonte si tratta?<br />
Dante non lo dice. Dobbiamo ragionevolmente pensare che<br />
sia l’orizzonte comune del Purgatorio e di Gerusalemme (cfr.<br />
Pg IV 68-71). Non mancano altre interpretazioni (vedi «Bull.»<br />
IX 126; X 231; XXI 236 ss.). Gli antichi commentatori interpretano<br />
in senso allegorico e pensano alle tre virtù teologali<br />
e alle quattro cardinali, ritenendo quindi che la grazia divina<br />
splenda più benefica dove esse sono congiunte. Così anche<br />
G. Mazzoni (L. D. sa.).<br />
40. miglior corso: con l’equinozio primaverile comincia il miglior<br />
periodo dell’anno: i giorni si allungano, la natura si ridesta.<br />
Non occorre scomodare Virgilio (Georg. II 336) che dice essere<br />
avvenuta in primavera la prima crescentis origo mundi: che<br />
Dante conoscesse le Georgiche è incerto. Nel Medioevo era<br />
credenza comune che, al momento della Creazione, le costellazioni<br />
si trovassero nelle posizioni dell’equinozio primaverile.<br />
13
14<br />
CANTO I<br />
PROEMIO AL PARADISO<br />
esce congiunta, e la mondana cera<br />
42 più a suo modo tempera e suggella.<br />
Fatto avea di là mane e di qua sera<br />
tal foce, e quasi tutto era là bianco<br />
45 quello emisperio, e l’altra parte nera,<br />
quando Beatrice in sul sinistro fianco<br />
vidi rivolta e riguardar nel sole:<br />
48 aguglia sì non li s’affisse unquanco.<br />
E sì come secondo raggio suole<br />
uscir del primo e risalire in suso,<br />
51 pur come pelegrin che tornar vuole,<br />
così de l’atto suo, per li occhi infuso<br />
migliore stella: la costellazione dell’Ariete, in cui si trova il sole<br />
nell’equinozio primaverile, era considerata assai favorevole<br />
(cfr. If I 38 ss.).<br />
41. la mondana cera: la materia elementare del mondo, paragonata<br />
alla cera, a cui il benefico influsso del cielo in quel particolare<br />
momento dà la sua impronta (tempera e suggella).<br />
L’immagine del suggello è frequente nel poema: cfr. nota a<br />
Pg XXXIII 80.<br />
43-45. Fatto... nera: tal foce (quel punto dell’orizzonte) aveva fatto<br />
di là (nel Purgatorio) mattino e di qua (sulla terra abitata)<br />
sera e quell’emisfero là (dove si erge il monte del Purgatorio)<br />
era quasi tutto illuminato (bianco) e l’altra parte<br />
(l’emisfero della terra emersa) buia, oscura (nera), quando<br />
vidi ecc. Abbiamo legato strettamente i vv. 44-45 da e quasi<br />
con la terzina seguente: il perché lo vedremo tra poco. La lezione<br />
dell’edizione del ’21 e di altre edizioni (per es. Sapegno)<br />
è: «tal foce quasi, e tutto era là bianco». Con la lezione a testo<br />
suffragata «dall’autorevole testimonianza di Urb. (cioè del codice<br />
urbinate latino 366 della Biblioteca Apostolica Vaticana)» come<br />
avverte Petrocchi, e già sostenuta da altri (Chimenz, Porena<br />
ecc.), si restituisce piena esattezza alla seconda indicazione<br />
(vv. 44-45), garantendo validità alla prima (vv. 43-44). Infatti,<br />
se è vero che solo nel giorno dell’equinozio il sole esce esattamente<br />
da quel punto, è anche vero che l’emisfero del Purgatorio<br />
non è mai tutto illuminato «neppure a mezzogiorno del solstizio<br />
di dicembre e tanto meno lo è nel tempo dell’equinozio»<br />
(Porena): quindi il quasi non può che andare unito all’espressione<br />
successiva. Di quale ora si tratta? Si sostenne sia la mattina,<br />
sia il mezzogiorno. Indipendentemente dai versi che stiamo<br />
esaminando, e guardando solo alla costruzione simmetrica<br />
delle tre cantiche, dovremo stabilire che si tratta del mezzogiorno,<br />
perché l’inizio del viaggio infernale è la notte (If II 1-3)<br />
e quella del Purgatorio la mattina (Pg I 13 ss. e 115-117): «La<br />
notte rappresenta molto propriamente la disperazione; l’alba<br />
la speranza; il mezzogiorno la perfezione» (Moore, Accenni, 11-<br />
12). Se poi esaminiamo attentamente la terzina in questione,<br />
XXXX<br />
potremo concludere con Porena che in essa Dante ha indicato<br />
due momenti: 1) il sorgere del sole solamente per indicare con<br />
esattezza il punto sull’orizzonte in cui si determina l’incrocio<br />
dei cerchi (vv. 43-44); 2) l’ora del mezzodì nel momento in cui<br />
Dante guarda Beatrice rivolta a sinistra (vv. 44-47). Infatti la<br />
proposizione principale dei vv. 44-45, congiunta strettamente<br />
alla secondaria temporale dei vv. 46-47, è diversa dalla constatazione<br />
precedente. A convalidare la tesi del mezzogiorno stanno<br />
inoltre due fatti importanti. Nel Paradiso terrestre, Beatrice<br />
era rivolta verso levante (Pg XXXII 16-18): se ora guarda a sinistra<br />
è perché il sole è a mezzodì; infatti nel Purgatorio esso procede<br />
verso nord (cfr. Pg IV 55-75): se fosse mattina il sole sarebbe<br />
in faccia e Beatrice non avrebbe bisogno di voltarsi. Inoltre<br />
in Pg XXXIII 104, Dante indica chiaramente che è mezzogiorno:<br />
da allora è passato pochissimo, il tempo di bere l’acqua<br />
dell’Eunoè.<br />
47. rivolta e riguardar: costruzione, col verbo videndi, analoga a Pd<br />
XII 48.<br />
48. aguglia... unquanco: anche questa similitudine meglio si adatta<br />
a Beatrice che fissa il sole nel suo massimo splendore, a mezzogiorno.<br />
Nonostante le ragioni addotte da Petrocchi – l’alternanza<br />
del termine di formazione popolare «aguglia» e di quello<br />
classico «aquila» è condizionata solo dalle diversità degli accenti<br />
tonici (I 418) – talvolta la più ampia letterarietà del termine<br />
«aquila» è da preferire in un contesto di maggior impegno<br />
poetico come in questo caso. Che l’aquila fissasse il sole<br />
abituando anche i piccoli a tenere questo comportamento,<br />
era opinione assai diffusa fin dall’età classica (cfr. Aristotele,<br />
De animalibus, IX XXXIV; Lucano, Phars. IX 902-905; Brunetto<br />
Latini, Tresor, I v 8 e Dante stesso, Pd XX 31-32).<br />
unquanco: mai (lat. umquam).<br />
49-50. E sì... suso: con i termini della fisica moderna il paragone<br />
dantesco significa: e come il raggio di riflessione (secondo<br />
raggio) suole uscire, nascere, dal raggio d’incidenza (primo)<br />
e risalire in su (suso). Dante paragona il fenomeno fisico<br />
del raggio incidente e riflesso all’atto di Beatrice di guar
XXXX PROEMIO AL PARADISO<br />
CANTO I<br />
ne l’imagine mia, il mio si fece,<br />
54 e fissi li occhi al sole oltre nostr’uso.<br />
Molto è licito là, che qui non lece<br />
a le nostre virtù, mercé del loco<br />
57 fatto per proprio de l’umana spece.<br />
Io nol soffersi molto, né sì poco,<br />
ch’io nol vedessi sfavillar dintorno,<br />
60 com’ ferro che bogliente esce del foco;<br />
e di sùbito parve giorno a giorno<br />
essere aggiunto, come quei che puote<br />
63 avesse il ciel d’un altro sole addorno.<br />
dare nel sole che, giunto attraverso gli occhi nella facoltà immaginativa<br />
del poeta, genera in lui un atto consimile per cui<br />
anch’egli fissa gli occhi nel sole. Il fenomeno è già stato accennato<br />
in Pg XV 16-21.<br />
51. pur come... vuole: su questa similitudine nella similitudine sono<br />
state date due interpretazioni. C’è chi ha voluto vedere<br />
nel pelegrin il falco peregrinus (cfr. Chimenz, in «Giorn. St.»<br />
CXXXIII 180-185) e chi intende nel senso più ovvio pelegrin<br />
come «chi è lontano dalla sua patria, da casa sua». La seconda<br />
interpretazione sembra migliore perché affianca alla similitudine<br />
del raggio, quasi freddamente tecnica, quella del<br />
pellegrino, affettuosamente umana. Gli antichi commentatori,<br />
ad eccezione del Buti, riferivano pelegrin al raggio stesso<br />
che sarebbe interpretazione per sé accettabile se non<br />
l’impedisse il nesso pur come, che introduce ovviamente<br />
una seconda similitudine.<br />
52-54. così... uso: intendi: così dall’atto di Beatrice (quello di riguardar<br />
nel sole), trasmesso (infuso) per mezzo degli occhi<br />
nella mia facoltà immaginativa (imagine), si generò (si<br />
fece) il mio (atto), e fissai gli occhi nel sole al di là delle<br />
possibilità umane (nostr’uso).<br />
52. de: da.<br />
infuso: penetrato.<br />
53. imagine: facoltà immaginativa, fantasia. Cfr. Pg XVII 7 e 21.<br />
54. nostr’uso: nel Convivio Dante aveva detto, riferendosi alla<br />
potenza del raggio solare, che «l’occhio nol può mirare» (Cv<br />
II XIII 15). L’essere riuscito a fissare gli occhi nel sole è quindi<br />
un atto superiore alla capacità umana e Dante ne darà la<br />
ragione nella terzina seguente.<br />
55. là: nel Paradiso terrestre.<br />
qui: sulla Terra.<br />
non lece: non è lecito (lat. non licet).<br />
56. a le nostre virtù: alle nostre facoltà, ai sensi umani.<br />
mercé del loco: grazie al luogo.<br />
57. fatto... spece: il Paradiso terrestre era stato creato da Dio come<br />
dimora dell’uomo che, uscito perfetto dalle mani del<br />
creatore, possedeva facoltà sensibili in grado assai maggiore<br />
di quanto rimasero in lui dopo il peccato e la cacciata dall’Eden.<br />
Dante, purificato, è nelle condizioni di Adamo prima<br />
del peccato.<br />
58. nol soffersi molto: non lo sopportai a lungo, non riuscii a<br />
reggere la vista per lungo tempo.<br />
né sì poco: ma non così poco tempo.<br />
60. com’... foco: come il ferro incandescente che sprizza faville<br />
(sfavillar) tutt’intorno.<br />
61-62. parve... aggiunto: sembrò che la luce del giorno fosse raddoppiata.<br />
quei che puote: Dio onnipotente.<br />
63. addorno: adornato (per la forma con la doppia, cfr. Pg IX<br />
54). Si deve pensare che questa luce raddoppiata, di cui si fa<br />
cenno anche ai vv. 79-81, ma di cui non si parlerà più nel resto<br />
del poema, sia l’effetto dell’avvicinarsi alla sfera del fuoco,<br />
che gli antichi immaginavano posta fra la Terra e il cielo<br />
della Luna. Secondo la concezione dantesca, l’universo ha al<br />
centro la Terra, immobile, in cui sono presenti due elementi,<br />
la terra e l’acqua; essa è circondata dall’aria (terzo elemento),<br />
uno strato sferico che gira trascinato dal movimento<br />
del Primo Mobile (cfr. Pg XXVIII 103-104). Sopra all’aria<br />
c’è la sfera del fuoco (quarto elemento) a cui tutto il fuoco<br />
che è sulla terra tende (cfr. Pd I 115), tranne il fulmine (Pd I<br />
133-134). Al di sopra della sfera del fuoco stanno i nove cieli,<br />
sfere concentriche di forma sempre più grande a partire<br />
dalla Terra, formati di un quinto elemento, l’etere, materia<br />
trasparente e pura, invisibile e impalpabile. In Cv III III 2 Dante<br />
dice che la sfera del fuoco è lungo il cielo della Luna e non<br />
sotto, ma ciò non impedisce di intendere che sia questa la<br />
sfera a cui Dante si avvicina e che attraversa. Il poeta qui<br />
non ne fa espressa menzione, forse perché egli non sa ancora<br />
di salire verso il cielo: glielo spiegherà Beatrice ai vv. 91-<br />
93. Né d’altronde Dante indica con precisione il momento<br />
in cui si stacca dalla Terra, perché il viaggio nel Paradiso è un<br />
fatto tutto spirituale. Vedi l’Introduzione.<br />
15
16<br />
CANTO I<br />
PROEMIO AL PARADISO<br />
Beatrice tutta ne l’etterne rote<br />
fissa con li occhi stava; e io in lei<br />
66 le luci fissi, di là sù rimote.<br />
Nel suo aspetto tal dentro mi fei,<br />
qual si fé Glauco nel gustar de l’erba<br />
69 che ’l fé consorto in mar de li altri dèi.<br />
Trasumanar significar per verba<br />
non si poria; però l’essemplo basti<br />
72 a cui esperïenza grazia serba.<br />
S’i’ era sol di me quel che creasti<br />
novellamente, amor che ’l ciel governi,<br />
64. ne l’etterne rote: i cieli rotanti; secondo il v. 47, dovrebbe valere<br />
semplicemente «nel sole» e così pensa ad esempio Chimenz;<br />
ma l’espressione analoga a alte rote di Pd X 7, a superne<br />
rote di Pg VIII 18, a rote magne di Pg XIX 63 e XXX<br />
109, a stellate rote di Pg XI 36, a etterni giri di Pg XXX 93 autorizza<br />
l’interpretazione proposta.<br />
66. le luci: gli occhi.<br />
di là sù rimote: distolte dal sole (di là sù). Da notare la replicazione<br />
fissa / fissi.<br />
67. Nel suo aspetto: nel guardarla. Aspetto (dal lat. aspicere) ha<br />
valore attivo, cioè «l’azione del guardare», e suo valore oggettivale:<br />
espressione di valore analogo a Pg XXIV 142.<br />
mi fei: mi feci, divenni.<br />
68. Glauco: mitico pescatore della Beozia di cui parla Ovidio (Met.<br />
XIII 898-968). Glauco notò che se i pesci pescati assaggiavano<br />
una particolare erba, riprendevano vigore e balzavano in acqua;<br />
perciò ne volle mangiare anche lui e balzò in acqua, trasformato<br />
in una divinità marina. Il paragone mitologico è usato<br />
dal poeta per indicare un fatto sovrumano impossibile a rappresentarsi<br />
a parole (vedi oltre vv. 70-72). Sia pure in un contesto<br />
diverso, Virgilio aveva già adoperato un esempio mitologico,<br />
quello di Meleagro, per chiarire un dubbio di Dante in Pg<br />
XXV 22: è l’explanatio per argumenta exemplorum usata dagli<br />
scolastici, cioè il procedimento che tenta di spiegare e rendere<br />
comprensibile un concetto teologico particolarmente difficile<br />
ricorrendo a esempi.<br />
69. consorto: partecipe della medesima sorte, in quanto Glauco<br />
si trasformò in una divinità e gli dèi marini lo accolsero<br />
fra loro.<br />
70. Trasumanar: oltrepassare i limiti della natura umana. Di<br />
recente Selene Sarteschi (2006) ha suggerito come valga «la<br />
pena di notare che il verbo è quasi al centro del canto formato<br />
da 142 versi: in tale verso Dante inscrive l’evento del<br />
viaggio più rilevante per lui; inoltre il numero 70 del verso<br />
potrebbe non essere casuale: si tratta come sappiamo di un<br />
numero fondamentale che rappresenta la lunghezza della vita<br />
umana (nel mezzo del cammin)».<br />
significar: etimologicamente esprimere, indicare per mezzo<br />
ASCENSIONE<br />
di segni. I «segni» sono quelli del linguaggio, cioè le parole.<br />
per verba: espressione latina: per mezzo di parole. Per Parodi<br />
verba è forma italiana, cioè un latinismo ricalcato sui neutri<br />
plurali latini, come minugia (If XXVIII 25), essordia (Pg XVI<br />
19) ecc. (cfr. PARODI, Lingua, II 247).<br />
71. poria: potrebbe, condizionale in -ìa, formato dall’infinito più<br />
l’imperfetto del verbo «avere» (habebam) (cfr. ROHLFS, II 330<br />
ss.). Ecco una prima dichiarazione di ineffabilità («la lingua<br />
non è di quello che lo ’ntelletto vede compiutamente seguace»,<br />
Cv III III 15) che verrà più volte ripetuta lungo la cantica.<br />
71-72. però... serba: perciò (però) basti l’esempio (di Glauco) a<br />
colui al quale (a cui) la Grazia riserba l’esperienza. Il lettore<br />
dovrà accontentarsi di questa analogia mitologica, poiché<br />
le parole sono insufficienti a spiegare la trasumanazione: allorché<br />
egli sarà chiamato alla beatitudine eterna, la Grazia<br />
divina gli darà modo di farne esperienza diretta.<br />
73-75. S’i’ era... levasti: la terzina, sciolta dalle perifrasi, significa:<br />
se io ero solo anima (di me quel che creasti novellamente) lo<br />
sai tu o Dio (amor che ’l ciel governi), che mi sollevasti con<br />
la tua grazia (lume). È chiara l’eco di san Paolo, quando narra<br />
il suo rapimento al terzo cielo: sive in corpore sive extra<br />
corpus nescio, Deus scit («se in corpo o senza corpo non so,<br />
lo sa Dio», II Cor. XII 3). Poiché già in questo canto (vv. 98-<br />
99), e altrove, Dante sembra indicare che egli è salito anche<br />
con il corpo (cfr. Pd XXI 11 e 61), l’ambiguità è voluta ed è<br />
forse il riflesso delle dispute teologiche sul passo paolino.<br />
Dante ha sottolineato spesso, lungo il cammino nell’Inferno<br />
e in particolare nel Purgatorio, il peso di quel d’Adamo, ma<br />
ha anche sperimentato che, man mano che saliva, la fatica<br />
dell’ascesa si faceva sempre minore fino a scomparire. Il suo<br />
corpo è ora quasi come quello degli spiriti beati dopo la resurrezione<br />
della carne, materia senza peso. Per la questione<br />
vedi Il punto della critica al canto XXVII.<br />
73-74. quel che creasti novellamente: quella parte di me che creasti<br />
per ultima (novellamente), cioè l’anima razionale, infusa da<br />
Dio nel corpo dopo che le anime vegetativa e sensitiva sono<br />
già pienamente sviluppate (cfr. Pg XXV 71-75).<br />
74. amor che ’l ciel governi: Dio, che con un atto di amore hai
PRIMO DUBBIO DI DANTE PROEMIO AL PARADISO<br />
CANTO I<br />
75 tu ’l sai, che col tuo lume mi levasti.<br />
Quando la rota che tu sempiterni<br />
desiderato, a sé mi fece atteso<br />
78 con l’armonia che temperi e discerni,<br />
parvemi tanto allor del cielo acceso<br />
de la fiamma del sol, che pioggia o fiume<br />
81 lago non fece alcun tanto disteso.<br />
La novità del suono e ’l grande lume<br />
di lor cagion m’accesero un disio<br />
84 mai non sentito di cotanto acume.<br />
Ond’ella, che vedea me sì com’io,<br />
creato i cieli e li conservi in eterno. I commentatori citano<br />
Boezio: coelo imperitans amor (Cons. Ph. II c. 8, 15).<br />
76-81. Quando... disteso: intendi così le due terzine: quando il movimento<br />
dei cieli (la rota che tu sempiterni desiderato) attrasse<br />
a sé la mia attenzione (mi fece atteso) con quell’armonia<br />
che tu, o Dio, regoli (temperi) e distingui (discerni),<br />
allora mi parve accesa così gran parte del cielo dalla luce<br />
del sole, che la pioggia o un fiume, straripando, non fece<br />
mai un lago così ampio. È assai probabile, per le ragioni addotte<br />
nella nota al v. 63, che con questa straordinaria luminosità<br />
si alluda al passaggio attraverso la sfera del fuoco.<br />
Non sono mancate però altre interpretazioni: cfr. NARDI, Saggi,<br />
86-88.<br />
76-77. la rota... desiderato: letteralmente: il movimento rotatorio<br />
dei cieli che tu rendi eterno (sempiterni) col desiderio che<br />
essi hanno di unirsi a te. Dante spiega così il moto velocissimo<br />
del Primo Mobile: «per lo ferventissimo appetito ch’è<br />
in ciascuna parte di quello nono cielo, che è immediato a<br />
quello [l’Empireo], d’esser congiunta con ciascuna parte di<br />
quello divinissimo ciel quieto, in quello si risolve con tanto<br />
desiderio, che la sua velocitade è quasi incomprensibile» (Cv<br />
II III 9). L’influenza dell’Empireo sugli altri cieli è affermata da<br />
san Tommaso (Summa theol. I, q. LXVI, a. 3) e da altri, per<br />
cui Dante riporta la causa finale dei movimenti celesti al desiderio<br />
che i cieli hanno di congiungersi con Dio.<br />
78. armonia: la dottrina pitagorica e platonica dell’armonia delle<br />
sfere celesti, che scaturisce dal loro movimento rotatorio,<br />
era stata respinta da Aristotele (De coelo, II 9) e dai suoi tre<br />
grandi commentatori: Averroè, Alberto Magno e san Tommaso.<br />
Si trattava di una teoria assai diffusa, come dimostrano<br />
gli esempi anche in scritture volgari di carattere popolare<br />
riferiti da BARBI (Problemi, I 285). Certamente la fonte più<br />
diretta di Dante è il Somnium Scipionis di Cicerone, ben noto<br />
nel Medioevo attraverso il commento di Macrobio, ma<br />
non mancavano anche nella tradizione teologica cristiana<br />
testimonianze favorevoli (Origene, sant’Ambrogio, Onorio<br />
d’Autun). Nardi ha dimostrato come, anche nella stessa tradizione<br />
del pensiero aristotelico, la teoria dell’armonia delle<br />
sfere fosse stata difesa da Simplicio nel commento al De coelo<br />
aristotelico, che, una cinquantina d’anni prima di Dante,<br />
era stato tradotto dal greco in latino e poteva quindi esser<br />
noto al poeta (cfr. NARDI, Saggi, 81-86). È notevole però che<br />
di quest’armonia delle sfere non si parli più: i canti che Dante<br />
udrà nei cieli saranno quelli dei beati e dei cori angelici. Il<br />
riferimento a Pg XXX 93 resta dubbio, data la genericità dell’espressione<br />
in quel luogo.<br />
temperi e discerni: i due termini sembrerebbero avallare l’ipotesi<br />
che, con il termine armonia, Dante non intendesse indicare<br />
solo il generico senso di «musica», ma implicitamente facesse<br />
riferimento alla tecnica contrappuntistica (cfr. E. D. s. v.<br />
«armonia»).<br />
79. tanto... del cielo: costruzione latineggiante con l’avverbio e il<br />
genitivo partitivo: tanta parte di cielo.<br />
80. che: consecutivo da unirsi a tanto del verso precedente.<br />
82-93. Primo dubbio di Dante. La novità della dolce armonia e della grande luminosità suscita in Dante il desiderio di<br />
conoscerne la ragione, poiché egli crede di essere ancora sulla Terra. Beatrice, che legge il dubbio nella mente<br />
di Dante, senza essere interrogata, gli spiega che essi stanno salendo velocissimamente verso il cielo.<br />
83. di lor cagion... disio: accesero in me un desiderio (disio) di conoscerne<br />
la causa.<br />
84. mai... acume: mai sentito con tanta acutezza (acume,<br />
compl. di modo). Ma di cotanto acume potrebbe anche esse-<br />
re un genitivo di qualità dipendente da disio: un desiderio<br />
così acuto; anche se è preferibile la prima.<br />
85. vedea me sì com’io: vedeva dentro di me come mi vedevo io<br />
stesso; cioè leggeva i miei pensieri.<br />
17
18<br />
CANTO I<br />
PROEMIO AL PARADISO<br />
a quïetarmi l’animo commosso,<br />
87 pria ch’io a dimandar, la bocca aprio<br />
e cominciò: «Tu stesso ti fai grosso<br />
col falso imaginar, sì che non vedi<br />
90 ciò che vedresti se l’avessi scosso.<br />
Tu non se’ in terra, sì come tu credi;<br />
ma folgore, fuggendo il proprio sito,<br />
93 non corse come tu ch’ad esso riedi».<br />
S’io fui del primo dubbio disvestito<br />
per le sorrise parolette brevi,<br />
96 dentro ad un nuovo più fu’ inretito<br />
e dissi: «Già contento requïevi<br />
di grande ammirazion; ma ora ammiro<br />
86. commosso: agitato, turbato, dallo stupore della novità vista<br />
e dal desiderio di conoscerne la causa. Cfr. Cv IV xxv<br />
5: «lo stupore è uno stordimento d’animo per grandi e maravigliose<br />
cose vedere o udire o per alcun modo sentire: che<br />
in quanto paiono grandi, fanno reverente a sé quelli che le<br />
sente; in quanto paiono mirabili, fanno voglioso di sapere<br />
di quelle».<br />
87. aprio: aprì, con epitesi in -o dei verbi ossitoni. Nel Paradiso,<br />
più che nel Purgatorio, le anime risolvono i dubbi di<br />
Dante senza che il poeta lo chieda, leggendogli nel pensiero.<br />
Anche Virgilio leggeva nella mente di Dante, e così le<br />
anime del Purgatorio, ma forse il poeta ha voluto sottolineare<br />
questa differenza.<br />
88. e cominciò: la stessa didascalia in apertura di verso e di terzina<br />
al v. 103, ha una certa solennità e appare altre volte,<br />
specie nel Paradiso.<br />
ti fai grosso: ti rendi ottuso. «Grosso» in senso figurato vale<br />
SECONDO DUBBIO<br />
«rozzo», «ignorante», «ottuso di mente»: cfr. If XXXIV 92; Pg<br />
XI 93 ecc.<br />
89. col falso imaginar: col supporre di esser ancora sulla Terra.<br />
90. scosso: rimosso, scacciato (sott. il falso imaginar).<br />
92. fuggendo il proprio sito: allontanandosi dalla sua sede naturale,<br />
la sfera del fuoco. Il fulmine era ritenuto un fuoco che,<br />
contro la legge naturale (cfr. in questo stesso canto il v. 115),<br />
si allontana dalla sua dimora e scende sulla terra. Il rapporto<br />
«fuoco-Dante» e «sfera del fuoco-Paradiso» fa escludere che il<br />
proprio sito sia la nube, come pure qualcuno ha inteso.<br />
93. non corse... riedi: il fulmine, cadendo sulla terra, non è mai<br />
sceso così velocemente come Dante sale ora verso «il proprio<br />
sito» (ad esso), cioè il cielo. Il Paradiso è la sede naturale<br />
dell’anima umana. Cfr. in questo canto i vv. 124-126. Alcuni,<br />
non bene, intendono la sfera del fuoco, ma il verbo riedi («ritorni»)<br />
non lascia dubbi che esso sia il proprio sito dell’anima,<br />
cioè il cielo. Dante non può ritornare alla sfera del fuoco.<br />
94-142. Secondo dubbio e soluzione di Beatrice: l’ordine dell’universo. Sorge in Dante un nuovo dubbio: come mai egli,<br />
corpo pesante, riesce ad attraversare «questi corpi levi». Ne chiede la ragione a Beatrice che gli spiega<br />
come tutte le cose siano ordinate e dirette al proprio fine, per raggiungere il quale una forza speciale,<br />
l’istinto, dà loro l’impulso. Il fine dell’uomo è Dio, da cui può, ingannato da beni fallaci, deviare volontariamente.<br />
Ma Dante è purificato e libero da ogni legame terreno e perciò tende verso Dio: ci sarebbe<br />
da meravigliarsi se in tale nuova e migliore condizione fosse rimasto sulla Terra, come se la fiamma viva<br />
non tendesse in alto verso la propria sfera.<br />
94. del primo dubbio: cioè la novità del suono e il grande lume (vv.<br />
82-84).<br />
disvestito: liberato, spogliato.<br />
95. per le... brevi: per le poche (brevi) parole dette sorridendo.<br />
Il verbo «sorridere» è usato in forma transitiva, per cui il participio<br />
passato ha valore passivo. La forma parolette non è<br />
un vero diminutivo: nella lingua del tempo di Dante aveva<br />
spesso il valore della forma non alterata (anche il moderno
L’ORDINE DELL’UNIVERSO PROEMIO AL PARADISO<br />
CANTO I<br />
99 com’io trascenda questi corpi levi».<br />
Ond’ella, appresso d’un pïo sospiro,<br />
li occhi drizzò ver’ me con quel sembiante<br />
102 che madre fa sovra figlio deliro,<br />
e cominciò: «Le cose tutte quante<br />
hanno ordine tra loro, e questo è forma<br />
105 che l’universo a Dio fa simigliante.<br />
Qui veggion l’alte creature l’orma<br />
de l’etterno valore, il qual è fine<br />
108 al quale è fatta la toccata norma.<br />
Ne l’ordine ch’io dico sono accline<br />
tutte nature, per diverse sorti,<br />
«soletto» è un falso diminutivo): cfr. anche snelletto in Pg II<br />
41. Qui significa solo breve discorso, senza che si voglia attribuire<br />
al vocabolo una povertà di valori intellettuali, dottrinali<br />
o altro.<br />
96. ad un nuovo: sottinteso «dubbio».<br />
inretito: avvolto come in una rete (Benvenuto: illaqueatus in<br />
rete), dove rete ha valore figurato di «impedimento».<br />
97. requïevi: non latinismo, ma verbo latino (perfetto di requiesco).<br />
Ecco perché c’è un corsivo nel testo: letteralmente riposai,<br />
qui mi sono acquietato; cfr. quïetarmi del v. 86.<br />
98. di grande ammirazion: complemento di relazione: riguardo al<br />
mio stupore, rispetto alla mia meraviglia.<br />
ammiro: mi stupisco, mi meraviglio. Da notare la replicazione:<br />
ammirazion / ammiro.<br />
99. questi corpi levi: questi corpi leggeri, rispetto al corpo pesante:<br />
sono l’aria e il fuoco. Evidentemente Dante pensa<br />
di salire anche con il corpo. Cfr. i vv. 73-75 e la nota relativa.<br />
100. pïo sospiro: il sospirare pietoso di Beatrice è il segno della<br />
pietà del beato verso la pochezza e la debolezza umana, ma<br />
è anche un tocco di umanità alla figura di Beatrice, rafforzato<br />
dal paragone con la madre.<br />
101. con quel sembiante: con quell’atteggiamento affettuosamente<br />
premuroso e al tempo stesso dolorosamente preoccupato.<br />
102. deliro: delirante, che perciò dice poche parole senza senso.<br />
Immagine analoga in Pd XXII 4-6.<br />
103. e cominciò: per l’espressione vedi nota al v. 88. Comincia<br />
qui, e prosegue fino alla fine del canto, la spiegazione di Beatrice.<br />
In realtà Beatrice non risponde alla domanda di Dante<br />
(come la gravità del suo corpo potesse trascendere gli elementi<br />
leggeri) bensì allarga il problema della naturale tendenza<br />
dell’anima a Dio a una straordinaria visione dell’ordine<br />
universale. Ne risulta una pagina di grande efficacia e potenza.<br />
La grandiosa immagine dell’Universo, dove Le cose<br />
tutte quante / hanno ordine tra loro, simile in ciò a Dio stesso,<br />
imprime un tono di altissima poesia al discorso di Beatrice,<br />
che solo a una lettura superficiale può sembrare freddamente<br />
didascalico.<br />
103-104. Le cose... tra loro: l’ordine di tutte le cose create, tale da<br />
formare un tutto armonico, è concetto della teologia scolastica:<br />
cfr. san Tommaso, Summa theol. I, q. XV, a. 1 e I,<br />
q. XLVII, a. 3.<br />
104. forma: nel linguaggio scolastico significa il principio essenziale,<br />
ciò che dà a ogni cosa il suo specifico essere. L’ordine<br />
delle cose è quindi la forma che rende l’universo simile<br />
a Dio, che è ordine per eccellenza.<br />
106. Qui: in questo ordine, in questa «forma».<br />
l’alte creature: gli esseri razionali, cioè gli angeli e gli uomini.<br />
107. l’etterno valore: Dio.<br />
107-108: il qual è... norma: il quale Dio è il fine per cui è dato<br />
all’universo quell’ordine (norma) di cui si è accennato<br />
(toccata). Cfr. san Tommaso, Summa theol. I, q. XLIV, a. 4:<br />
omnia appetunt Deum ut finem («tutte le cose tendono a<br />
Dio, come fine»).<br />
109. sono accline: hanno una inclinazione (lat. acclinis), cioè<br />
partecipano. Cfr. Cv I I 1: «ciascuna cosa, da providenza di<br />
propria natura impinta, è inclinabile a la sua propria perfezione».<br />
Per i plurali femminili di terza in -e cfr. PARODI,<br />
Lingua, II 249.<br />
110. per diverse sorti: secondo la condizione avuta in sorte da<br />
ciascuna. Cfr. san Tommaso, Summa theol. I, q. LIX, a. 1:<br />
cum omnia procedant ex voluntate divina, omnia suo modo per<br />
appetitum inclinantur in bonum, sed diversimode («poiché tutte<br />
le cose procedono dalla volontà divina, tutte a modo loro<br />
inclinano verso il bene per appetito naturale, ma in forme diverse»).<br />
Di tale differenza, che deriva dal diverso modo di ricevere<br />
la bontà divina da parte delle creature, Dante parla<br />
nel Convivio (III VII 2-5).<br />
19
20<br />
CANTO I<br />
PROEMIO AL PARADISO<br />
111 più al principio loro e men vicine;<br />
onde si muovono a diversi porti<br />
per lo gran mar de l’essere, e ciascuna<br />
114 con istinto a lei dato che la porti.<br />
Questi ne porta il foco inver’ la luna;<br />
questi ne’ cor mortali è permotore;<br />
117 questi la terra in sé stringe e aduna;<br />
né pur le creature che son fore<br />
d’intelligenza quest’arco saetta,<br />
120 ma quelle c’hanno intelletto e amore.<br />
La provedenza, che cotanto assetta,<br />
del suo lume fa ’l ciel sempre quïeto<br />
123 nel qual si volge quel c’ha maggior fretta;<br />
e ora lì, come a sito decreto,<br />
111. più... vicine: più o meno vicine a Dio, loro principio.<br />
112. a diversi porti: a fini, a mete diverse. Il termine con valore<br />
metaforico è usatissimo. Il verso è a rima equivoca con il v.<br />
114: porti (sostantivo) – porti (verbo).<br />
113. per lo gran mar de l’essere: grandiosa immagine per indicare<br />
l’immensità e la molteplicità delle vite esistenti nell’universo.<br />
Dalla metafora del mare scaturisce quella del porto.<br />
114. istinto: l’impulso, la tendenza naturale («naturale inclinazione»<br />
chiosa il Buti) che spinge ogni essere a realizzare la<br />
propria essenza. Il concetto si chiarisce bene con la terzina<br />
successiva.<br />
115-117. Questi... aduna: la terzina spiega, esemplificando, ciò<br />
che è stato dichiarato nelle terzine precedenti. L’ordine universale<br />
comporta la realizzazione della propria essenza da<br />
parte di ogni essere: di qui la necessaria forza che porta<br />
questi esseri a tale realizzazione. Dante dà tre esempi di<br />
istinto: quello che fa salire il fuoco verso la propria sfera (cfr.<br />
anche Pg XVIII 28-30); quello che regola negli animali irrazionali<br />
la vita sensitiva; quello, infine, che fa tendere ogni<br />
corpo al centro della Terra, cioè la forza di gravità che rende<br />
compatta la Terra stessa.<br />
115. ne: pleonastico.<br />
inver’ la luna: si credeva che la sfera del fuoco fosse «lungo lo<br />
cielo de la luna» (Cv III III 2).<br />
116. ne’ cor mortali: negli esseri irrazionali, negli animali bruti,<br />
la cui vita sensitiva ha origine nel cuore. L’anima sensitiva,<br />
propria degli esseri irrazionali, è mortale.<br />
permotore: principio motore, che stimola l’azione. «Permuovere»<br />
è in Guittone (Lettere XXI 87) col senso di «spingere fortemente»,<br />
dove il prefisso «per» rafforza il verbo.<br />
117. stringe: perché è la forza di coesione.<br />
L’ORDINE DELL’UNIVERSO<br />
aduna: perché la forza di gravità fa convergere tutto al centro<br />
della Terra.<br />
118. né pur: né soltanto.<br />
118-119. che son fore d’intelligenza: che sono prive d’intelligenza,<br />
di ragione; cioè le creature irrazionali (animali e cose inanimate).<br />
119. quest’arco: l’istinto. La metafora continua ovviamente nel<br />
verbo («saetta» = «colpisce»).<br />
120. ma quelle... amore: gli angeli e gli uomini, dotati di intelligenza<br />
e di volontà. Amore è amore... d’animo (Pg XVII 92-<br />
93), amore di elezione, quindi volontà.<br />
121-123. La provedenza... fretta: intendi: la provvidenza divina,<br />
che ordina così meravigliosamente l’universo (cotanto<br />
assetta), appaga (fa... quïeto) della sua luce (lume) l’Empireo,<br />
cioè il cielo immobile, nel quale si muove il Primo<br />
Mobile (quel c’ha maggior fretta). La terzina significa semplicemente<br />
che Dio risiede nell’Empireo. Il Primo Mobile<br />
è, nella cosmogonia dantesca, la sfera celeste più veloce<br />
che imprime il suo moto alle sfere successive: esso ruota<br />
nell’Empireo, il cielo quieto, sede della Divinità.<br />
124. lì: nell’Empireo.<br />
sito decreto: sede destinata, stabilita.<br />
125-126. cen porta... lieto: continua la metafora dell’arco (v. 119). Letteralmente:<br />
ci porta la forza (virtù) della corda di quell’arco<br />
che dirige (drizza) ciò che scocca ad un lieto bersaglio (segno).<br />
Fuor di metafora: a portarci nell’Empireo è la forza di<br />
quell’istinto che indirizza ogni creatura al proprio fine, in<br />
cui troverà il suo acquietarsi e la sua felicità (lieto). La metafora<br />
dell’arco forse è un’eco di san Tommaso (Summa theol.<br />
I, q. XXIII, a. 1), ma l’arco e le frecce erano allora le armi più<br />
comuni in guerra, e la metafora era frequente in poesia.
L’ORDINE DELL’UNIVERSO PROEMIO AL PARADISO<br />
CANTO I<br />
cen porta la virtù di quella corda<br />
126 che ciò che scocca drizza in segno lieto.<br />
Vero è che, come forma non s’accorda<br />
molte fïate a l’intenzion de l’arte,<br />
129 perch’a risponder la materia è sorda,<br />
così da questo corso si diparte<br />
talor la creatura, c’ha podere<br />
132 di piegar, così pinta, in altra parte;<br />
e sì come veder si può cadere<br />
foco di nube, sì l’impeto primo<br />
135 l’atterra torto da falso piacere.<br />
Non dei più ammirar, se bene stimo,<br />
lo tuo salir, se non come d’un rivo<br />
138 se d’alto monte scende giuso ad imo.<br />
127. Vero è che: formula di trapasso a carattere restrittivo frequente<br />
nel poema (cfr. If IV 7; IX 22; XXIX 112; Pg III 136; X<br />
136 ecc.).<br />
non s’accorda: non corrisponde.<br />
128. a l’intenzion de l’arte: all’intenzione, all’idea dell’artista. Arte<br />
è forma astratta usata invece del concreto.<br />
129. perch’... sorda: perché la materia con cui l’artista esegue<br />
l’opera non è arrendevole, è restia (sorda) a ricevere la forma<br />
che ad essa l’artista vuol imprimere. Il paragone indica<br />
la possibilità che ha l’uomo, dotato di libero arbitrio e<br />
quindi padrone delle sue scelte, di allontanarsi dalla via del<br />
bene a cui l’istinto lo dirige e lo stimola. In tal modo Dante,<br />
sviluppando la teoria dell’istinto, come impulso dato a ogni<br />
essere per attuare il proprio fine, salva nell’uomo la libertà<br />
di volere e non cade così in una forma di determinismo, a<br />
cui la teoria dell’istinto avrebbe potuto condurre.<br />
130. da questo corso: la via del bene che conduce a Dio, a cui lo<br />
sospinge l’istinto.<br />
131. la creatura: l’uomo, ovviamente, dotato di libero volere.<br />
ha podere: ha possibilità.<br />
132. così pinta: pur così spinta (pinta) dalla forza dell’istinto.<br />
in altra parte: verso il male. Cfr. Pg XVI 73-82.<br />
133-134. e sì... nube: il fulmine scende verso la terra, contro il<br />
suo istinto che, in quanto fuoco, dovrebbe portarlo verso<br />
l’alto. Il paragone è un ulteriore esempio del fatto che si<br />
può deviare dall’istinto. Naturalmente è solo un esempio<br />
relativo, perché in esso manca quella debolezza della volontà<br />
che è invece la causa dello sviare umano. Nella fisica<br />
del tempo il fulmine era considerato un fuoco che si genera<br />
all’interno della nube per l’urto dei vapori secchi e<br />
cade sulla terra per dilatazione, dopo aver squarciato la<br />
nube. Nell’edizione del ’21 la frase è posta fra parentesi,<br />
e, tolto il punto e virgola dopo il v. 132, questo viene unito<br />
a ciò che segue con la lezione: se l’impeto... a terra è torto<br />
ecc. Vedi la nota al verso seguente.<br />
135. l’atterra... piacere: e come si può veder cadere il fulmine<br />
(verso terra, invece che verso l’alto), così la naturale inclinazione<br />
(l’impeto primo) atterra, spinge verso i beni terreni,<br />
l’uomo (la creatura, v. 131) traviato (torto) da falso<br />
piacere. Altre edizioni hanno s’atterra, lezione congetturale,<br />
non presente in alcun manoscritto: la lezione a testo è<br />
giustificata e spiegata da Petrocchi, in quanto i manoscritti<br />
hanno laterra o latterra e inoltre «la ‘naturale inclinazione’...<br />
non può volgere sé stessa ai beni terreni, ma deve volgere<br />
qualche cosa (da che è torto da falso piacere), e cioè la creatura<br />
umana» (I 223). Insomma, l’allettamento dei falsi piaceri<br />
agisce sulla volontà umana e questa a sua volta agisce<br />
in tal modo sull’impeto primo che esso, deviando, spinge<br />
l’uomo verso i beni terreni. Naturalmente anche le altre lezioni<br />
(Porena: s’a Terra ecc.) significano più o meno la stessa<br />
cosa: la lezione a testo ha però il vantaggio di essere fedele<br />
alla tradizione manoscritta, senza operare congetture,<br />
di render meno impacciata la sintassi dell’intero periodo<br />
(vv. 127-135) e di dare posizione e sviluppo autonomo alle<br />
due similitudini.<br />
136. dei: devi.<br />
ammirar: stupirti, meravigliarti (vedi v. 98).<br />
137-138. se non... imo: altra similitudine che offre un ulteriore<br />
esempio di legge naturale: il fiume (rivo) scende dal monte<br />
verso il basso (imo) per naturale impulso, come per naturale<br />
impulso il fuoco sale verso l’alto e come la terra è<br />
compatta (vv. 115-117).<br />
21
22<br />
CANTO I<br />
PROEMIO AL PARADISO<br />
Maraviglia sarebbe in te se, privo<br />
d’impedimento, giù ti fossi assiso,<br />
com’a terra quïete in foco vivo».<br />
142 Quinci rivolse inver’ lo cielo il viso.<br />
139. in te: nei tuoi riguardi.<br />
139-140. privo d’impedimento: libero dal peccato, puro e disposto a<br />
salire a le stelle (Pg XXXIII 145).<br />
140. giù ti fossi assiso: fossi rimasto fermo sulla Terra; ma assiso<br />
vale proprio «seduto», «messo a sedere» e indica una posizione<br />
di riposo che presuppone quasi una volontà di rimanere<br />
lungamente in un luogo.<br />
141. com’... vivo: come sulla Terra (sottinteso: farebbe meraviglia),<br />
la quiete, cioè lo star fermo, nel fuoco vivo<br />
che per sua natura è mobile e tende a salire (cfr. Pg<br />
XVIII 28-30). Esso è quieto solo nel suo principio, nella<br />
sfera del fuoco, cioè nel suo stato di perfezione che, ovviamente,<br />
non è sulla Terra (cfr. san Tommaso, Summa theol.<br />
I, q. VI, q. 3). Ancora l’esempio del fuoco (v. 115). Porena<br />
obietta che «quanto ha detto Beatrice dovrebbe applicarsi<br />
agli uomini viventi in terra, i quali, se puri o purificati di<br />
peccato, dovrebbero elevarsi al cielo in anima e corpo, come<br />
ora Dante: il che non è»; tuttavia la condizione di Dante<br />
dopo l’espiazione, sia pure simbolica, attraverso le va-<br />
L’ORDINE DELL’UNIVERSO<br />
rie cornici del Purgatorio, dopo l’immersione nel Letè e<br />
l’acqua dell’Eunoè bevuta, non è quella degli uomini sulla<br />
Terra, per quanto puri o purificati dal peccato, bensì quella<br />
delle anime del Purgatorio quando hanno compiuto totalmente<br />
la loro espiazione. Prescindendo dal fatto che la<br />
Commedia è un’opera di poesia e non un resoconto di<br />
viaggio, bisogna riconoscere che il centro di gravità di<br />
questa ampia spiegazione di Beatrice è un altro, e poco<br />
importa se al dubbio di Dante Beatrice non abbia rigorosamente<br />
risposto. Il fulcro di tale discorso dottrinale è la<br />
voluta insistenza sul «naturale» salire di Dante. La sua<br />
ascesa non è un miracolo, bensì rientra nell’ordine naturale<br />
dell’universo, data la condizione particolare in cui il<br />
poeta si trova. La speciale grazia che Dante ha ottenuto da<br />
Dio è quella di aver potuto vedere da vivo i regni dell’Oltretomba:<br />
la salita al cielo è il naturale compimento dell’espiazione<br />
totale e non ha quindi nulla di miracoloso.<br />
142. Quinci: poi, dopo aver parlato.<br />
il viso: gli occhi, lo sguardo (lat. visus).
CANTO I<br />
LETTURA D’AUTORE<br />
I rischi della navigazione<br />
nel mare dell’essere<br />
Un vaso<br />
Il silenzio del pellegrino<br />
« I<br />
l poeta che scrive la Commedia è un pellegrino tornato da un lungo viaggio. Salvo, custode<br />
di una visione sublime, si rivolge ora al lettore con un volto umile. Si teme incapace<br />
di riferire ciò che ha visto. Non solo la parola umana, come scopriremo nell’ultimo<br />
canto, è inadatta a rendere conto di una simile esperienza, addirittura la stessa memoria<br />
appare vuota. Allo scrittore, già pellegrino, che la interroga per dare vita al testo, pare non<br />
avere nulla da dire. Silenziosa, si è ridotta allo stato di «ombra» (Pd I 23) opaca. Dante si presenta<br />
come un «vaso» (Pd I 14) vuoto, un libro dalle pagine bianche. Il divino si tocca a rischio<br />
della propria umana consistenza: la visione eccezionale concessa in vita ha svuotato Dante.<br />
Sul fondo di quel vaso, però, si è incisa un’ombra. Per richiamarla in vita, il poeta invoca l’aiuto<br />
di Apollo e della «divina virtù» (Pd I 13-27). L’ombra si animerà grazie alla gioia provocata<br />
dalla visione che l’uomo ha conservata dentro di sé, come sigillo indelebile impresso da Dio<br />
La memoria e il desiderio stesso. Ma, se il contenuto letterale della visione è opaco, quasi un’ombra del vero, il sapore<br />
del desiderio soddisfatto è invece rimasto tenace nella bocca del cuore del pellegrino. Se<br />
«appressando sé al suo disire, / nostro intelletto si profonda tanto, / che dietro la memoria non<br />
può ire» (Pd I 7-9), nella memoria rimane fisso il ricordo del piacere provato. La memoria, esile<br />
se misurata col metro delle esperienze materiali, mantiene tuttavia intatta l’orma del piacere<br />
che la visione ha procurato. Il ricordo del desiderio esaudito rigenera la memoria, e anima la<br />
fantasia del poeta. Quasi a suggerire, all’inizio della cantica più intrisa di dottrina e perciò più<br />
amara per il lettore, che la delizia promessa alla fine del viaggio sarà una gioia non semplicemente<br />
intellettuale. Il vaso si riempirà di piacere e gioia, di letizia e soddisfazione, non solo<br />
di dottrina e verità. L’oblio non è quindi assoluto. Al contrario, l’ombra della visione è a poco<br />
a poco richiamata in vita dalla memoria incancellabile della gioia provata a conclusione del<br />
viaggio. Il vaso trabocca, il desiderio esonda: come un fiume la memoria del pellegrino richiama<br />
in vita l’ombra fioca da cui risorge il suo Paradiso. Narrare il passato è rivivere con l’occhio<br />
della mente. Su questo fiume straripante di desiderio che potenzia la memoria, Dante si<br />
appresta a compiere l’ultima tappa del viaggio.<br />
Il geometra divino<br />
e l’ordine dell’universo<br />
Elogio dell’ordine<br />
L’universo perfettamente calibrato della creazione divina appare come una vastità feconda,<br />
che si spande in ogni direzione. Che permette ogni direzione, soprattutto. Il «gran mar de l’essere»<br />
(Pd I 113) è la totalità delle creature divine, tutte insieme disposte nel mare aperto dell’esistenza<br />
la cui meta terrena, la morte, è certa, ma il destino ultraterreno no. I sentieri che<br />
le creature devono seguire, le «sorti» (Pd I 110) diverse per cui ciascuna di esse è messa, indicano<br />
una ineliminabile condizione di fragilità. Segnalano, però, anche la geometrica equidistanza<br />
della meta, il porto felice della casa divina, da qualsiasi punto e da qualunque rotta.<br />
Nel Convivio, era stato lo stesso Dante a citare Salomone (Proverbi, 8): «Quando Iddio apparecchiava<br />
li cieli, io era presente; quando con certa legge e con certo giro vallava li abissi, quando<br />
suso fermava [l’etera] e suspendeva le fonti de l’acque, quando circuiva lo suo termine al<br />
23
24<br />
CANTO I<br />
Il viaggio e il rischio<br />
del naufragio<br />
Navigazioni dell’anima<br />
Ordine e libertà<br />
mare e poneva legge a l’acque che non passassero li suoi confini, quando elli appendeva li<br />
fondamenti de la terra, con lui e io era, disponente tutte le cose, e dilettavami per ciascuno<br />
die» (Convivio III XV). Il mare è urbanizzato dal geometra divino. Se le navi-creature «muovono<br />
a diversi porti» (Pd I 112), vuol dire che la divina «provedenza» (Pd I 121), quasi nostromo<br />
che traccia i destini sul mare, permette a ciascuna di attraversare il mare dell’esistenza per<br />
raggiungere Dio. Allora ciascun viaggio è pari a tutti gli altri, pur nella sua incancellabile singolarità<br />
di scelte, traiettorie, pericoli: «Le cose tutte quante / hanno ordine tra loro, e questo è<br />
forma / che l’universo a Dio fa somigliante» (Pd I 103-105). Dalla creatura più umile e priva di<br />
intelletto all’uomo, ciascuna delle navi costruite da Dio porta inscritta nella solidità del suo<br />
legno la certezza della felice riuscita del viaggio. L’amore naturale e l’amore d’animo, sapientemente<br />
definiti proprio da Virgilio che naufragò non per mancanza di intelletto o di natura<br />
(nella cornice degli accidiosi, Pg XVII 91-139), sono i due timonieri che si contendono la<br />
guida. Il primo è sempre sicuro e saldo nel seguire l’impulso dell’istinto naturale, il secondo è<br />
invece passibile di errore, perché troppo fiducioso nella capacità della ragione di distinguere<br />
scogli e secche da porti e mete. Unica tra le navi di Dio, sull’uomo pende il pericolo del naufragio.<br />
Abbandonato dal creatore nella vastità dell’esistenza dopo la cacciata dall’Eden, egli<br />
può trasformare in un naufragio la strada del ritorno. Inabissarsi nel «mar sì crudele», «torto»<br />
dall’ingannevole nostromo del «falso piacere» e delle «imagini di ben […] false» (Pg XXX 131),<br />
è il rischio sempre appiattato dietro ogni svolta della vita dell’uomo.<br />
Il mare dell’essere<br />
LETTURA D’AUTORE<br />
Il «trasumanar» (Pd I 70) è il traboccare del vaso pieno del desiderio del pellegrino di concludere<br />
il viaggio. Insieme ad esso, trabocca dal «vaso» il desiderio del poeta di ripercorrere l’ultima<br />
parte del viaggio. Che sia letteralmente l’abbandono del corpo da parte dell’anima o una trasfigurazione<br />
potenziata del composto corpo-anima, è poco importante in questo caso. Il vuoto iniziale,<br />
raffigurato dal pericolo dell’oblio, si muta nel suo opposto. Il pieno del desiderio è il motore<br />
che anima la scrittura dell’ultima cantica, così come è la nave su cui il pellegrino sale per fare<br />
rotta verso l’Empireo. L’immaginazione indossa da subito metafore marittime. Se già quello<br />
infernale era stato paragonato ad un viaggio per mare (l’Inferno è il «mar sì crudele», Pg I 3) -<br />
che, del resto, si concludeva con l’approdo su una spiaggia, non meno marittima era stata la scalata<br />
del monte purgatoriale, costellata di scogli (Belacqua), di isole (la valletta dei principi), di<br />
Sirene (il sogno della «femmina balba») e, sul finire dell’ascesa, segnato da un simbolico attraversamento<br />
di acque (il Leté). Adesso però la metafora del mare acquista un significato nuovo.<br />
Se nelle prime due cantiche la navigazione terragna di Dante si era servita di tale immagine per<br />
alludere alle difficoltà dell’impresa, ora l’intero creato e il cielo stesso appaiono assimilati al<br />
mare. Da una parte è la metafora del viaggio a esigere che l’immagine della navigazione si allarghi<br />
all’ultima cantica; dall’altra è il rapporto tra creatura e Dio a reclamare che il poeta continui<br />
ad usarla. Il «gran mar de l’essere» non è Dio. Dante non avrebbe mai potuto concepire una<br />
nozione così tinta di panteismo. Territorio fitto di rischi e incertezze su cui l’animale terrestre e<br />
terreno muove il piede artificiosamente, il mare diventa qui simbolo di una creazione feconda.<br />
In esso si fondono ordine e libertà. L’amore di Dio per la creatura è il punto in cui ordine e libertà<br />
sono in equilibrio. La volta celeste, inondata dalla luce del sole, sembra farsi più che lago.<br />
Acquista una consistenza marina: «parvemi tanto allor del cielo acceso / de la fiamma del sol,<br />
che pioggia o fiume / lago non fece alcun tanto disteso» (Pd I 79-81). Da una parte il cielo, con i<br />
suoi meccanismi sferici e circolari di pianeti e orbite, di stelle e intelligenze motrici, di gerarchie<br />
angeliche e beati; dall’altra il mare, immagine di una totalità percorribile in un numero infinito<br />
di direzioni. Dall’alto verso il basso e viceversa, dall’infinitamente basso del centro della Terra,<br />
in cui è conficcato Lucifero, all’eccezionalmente sublime dell’Empireo. E, sulla superficie, percorribile<br />
in una varietà pressoché infinita di rotte.
LETTURA D’AUTORE<br />
L’ascesa<br />
I rischi della navigazione<br />
Mare, metafora potente<br />
Le tempeste dell’anima<br />
Elogio del desiderio<br />
Il pellegrino che si prepara ad uscire dalla sfera terrestre è ormai libero dall’insidiosa protervia<br />
della ragione. Virgilio ha restaurato in lui il libero arbitrio (Pg XXVII 139-142), Beatrice lo ha poi<br />
fortificato con la condanna dell’errore passato, e Matelda col doppio bagno nel Leté e<br />
nell’Eunoè. Il pellegrino adesso, sulla cima del Purgatorio, è animato dal ritrovato amore naturale<br />
e da un amore d’animo puro e rinfrancato. Amore naturale e amore d’animo in lui sono perfettamente<br />
fusi e quasi coincidenti: la sanità del secondo doppia e rafforza la naturale santità del<br />
primo. Come un semplice elemento naturale che fugge al «sito decreto» (Pd I 124), Dante inizia<br />
l’ascesa verso l’Empireo. Solo un errore della ragione potrebbe fargli sbagliare rotta o scambiare<br />
uno scoglio o una spiaggia qualsiasi per la meta finale. Questo, però, non può più accadere a<br />
questo punto del viaggio. Il chiarimento di Beatrice vale quindi da ammonizione per il lettore<br />
(«l’impeto primo / l’atterra torto da falso piacere», Pd I 134-135), più che per il pellegrino.<br />
Beatrice era già apparsa, nell’Eden purgatoriale, in veste d’«ammiraglio» (Pg XXX 58) e nocchiero<br />
sul carro trionfale della Chiesa. Adesso, come un sapiente timoniere, indirizza il viaggio del<br />
pellegrino con la linea dello sguardo. Intenta «nel sole» (Pd I 47), la gentilissima; e Dante scorge<br />
la meta dietro la scia del suo sguardo. La forza naturale con cui Dante è trascinato in cielo non<br />
ha ostacoli. Il timoniere guida con sguardo sicuro la rotta del pellegrino. Questa si tempera e<br />
accorda col movimento naturale e certo del cielo: «Beatrice tutta ne l’etterne rote / fissa con li<br />
occhi stava» (Pd I 64-65). Le sirene del desiderio «torto da falso piacere» sono rimaste dietro di<br />
lui. Il desiderio, oltre che il libero arbitrio, è risanato e restaurato nella sua originaria purezza. La<br />
sicurezza del volo marino di Dante non cancella però del tutto il rischio connaturato nel destino<br />
dell’uomo. Il saggio Salomone, da parte sua, si era mostrato cauto nell’augurare buon viaggio al<br />
navigante: «Tre cose mi sono difficili, anzi quattro, che io non comprendo: il sentiero dell’aquila<br />
nell’aria, il sentiero del serpente sulla roccia, il sentiero della nave in alto mare, il sentiero dell’uomo<br />
in una giovane» (Proverbi, 30). Il «podere / di piegar […] in altra parte» (Pd I 130-131) è<br />
dote divina che contraddistingue l’uomo tra le creature sospese sul «mar de l’essere». La volontà,<br />
corroborata dall’intelletto, può trasformarsi però nel peso che lo fa colare a picco, o perdersi<br />
senza uscita in una selva inestricabile, qualora «da questo corso di diparte» (Pd I 130).<br />
Il pericolo del naufragio<br />
I Padri della Chiesa sono affascinati dalla capacità del mare di piegarsi a molteplici significati allegorici.<br />
Ambrogio, forse, più di tutti. Nel commento alla Genesi ne sviluppa numerosi. Dai versetti<br />
della Genesi passa ai Vangeli, da questi al libro di Giobbe e quindi alla descrizione di mari e fiumi<br />
reali. Tanta è la potenza metaforica dell’immagine che, scrive il santo, gli sembra di «straripare»<br />
con la penna dal foglio stesso. La metafora della vita come pericolosa navigazione marina è di<br />
ascendenza classica ma, a partire dai Padri, prende un nuovo colore. Il mare non è più solo il<br />
mondo della natura ostile e dura in cui l’uomo è gettato. È creatura divina. Anzi, è simbolo dell’intero<br />
cosmo creato, cui Dio ha posto limiti e leggi precise. Nella Genesi Dio colloca entro confini<br />
stabili ciò che per definizione è incontenibile: il mare. Agisce da geometra, lo contiene: mette<br />
degli argini e segna un percorso sicuro sul quale l’uomo si pone per raggiungere la meta assegnatagli.<br />
Il mare diventa allora, come già per il mondo classico-pagano, metafora dell’esistenza. Ma<br />
con una novità. I pericoli di cui è ricco provengono dall’interno dell’uomo. Ambrogio cita Dio che<br />
si rivolge a Giobbe: «Chi ha chiuso tra due porte il mare, quando erompeva uscendo dal seno<br />
materno, quando lo circondavo di nubi per veste e per fasce di caligine folta? Poi gli ho fissato un<br />
limite e gli ho messo chiavistello e porte e ho detto: “Fin qui giungerai e non oltre e qui s’infrangerà<br />
l’orgoglio delle tue onde”». (Giobbe, XXXVIII 8-11). A dimostrazione, commenta Ambrogio, che<br />
il mare, con i suoi flutti prepotenti, è la volontà dell’uomo sempre incline alle tempeste della cupidigia.<br />
La legge, le «porte» sono messe da Dio a contenimento dell’esuberanza del mare. L’uomo è<br />
CANTO I<br />
25
26<br />
CANTO I<br />
Il buon marinaio<br />
Goethe ovvero la solitudine<br />
del viaggiatore<br />
L’Ulisse dantesco:<br />
il cattivo marinaio<br />
un mare, o meglio, possiede dentro di sé un gorgo difficilmente contenibile di volizioni e desideri.<br />
Il pericolo non è quindi nei beni esteriori, ma nella possibilità che l’«impeto primo» (Pd I 134)<br />
si faccia piegare dalla volontà umana. La rotta dell’esistenza appare come il tragitto che l’uomo<br />
ha tracciato, riversando fuori di sé le acque delle sue passioni e dei suoi desideri. Il mare che attraversa<br />
l’uomo in vita simboleggia quindi le tempeste del desiderio. Dio, che ha messo sotto chiave<br />
quel mare, è il legislatore. Dio, d’altra parte, è anche il porto sicuro cui giunge l’uomo che ha<br />
attraversato felicemente il mare della vita, sulle tracce della rotta che egli stesso ha segnato per<br />
la creatura (la «provedenza»). Il mare è quindi metafora che unisce interno ed esterno, e suggerisce<br />
che per il cristiano la vita dell’uomo, la rotta nel «mar de l’essere», è la traduzione esteriore<br />
di un percorso interiore. I flutti attentano alla sicurezza del viaggiatore dall’interno.<br />
Elogio della navigazione<br />
LETTURA D’AUTORE<br />
La metafora del viaggio per mare non perde del tutto il suo antico significato di pericolo. Per portare<br />
il viaggio a buon fine, occorre una nave robusta. Anche un timoniere attento, e lesto a tenere<br />
la rotta. Che sappia distinguere, però. Le sirene del desiderio ingannano sovente i marinai, ne<br />
torcono la ragione con il loro richiamo. Possono far scambiare uno scoglio per una spiaggia. Allo<br />
stesso modo, ansioso di mettersi sulle tracce di chi precede, per non trovarsi solo e privo di bussola<br />
nel «gran mar de l’essere», il marinaio inesperto, magari mosso da «l’ardore / […] a divenir<br />
del mondo esperto» (If XXVI 97-98), sbaglierebbe se seguisse una scia qualunque. L’acqua può<br />
richiudersi come un monito e una tomba sopra il solco aperto dalla nave. Il marinaio in quel caso<br />
scoprirà con terrore di essersi spinto troppo oltre, dietro la traccia del desiderio, come Ulisse, per<br />
il quale la meta non fu l’approdo sulla terraferma, ma «ire in giù […] / infin che ‘l mar fu sovra<br />
noi richiuso» (If XXVI 141-142).<br />
Dante rivitalizza nel Paradiso anche questo significato della metafora. Il «vaso» si trasforma ben<br />
presto in «legno» (Pd II 3) sicuro e possente. Pensi bene al pericolo del naufragio chi, non sufficientemente<br />
munito, si arrischia a seguire il poeta su una «piccioletta barca» (Pd II 1). Il solco inciso<br />
dai versi del poema nel «gran mar de l’essere», all’inizio dell’ultimo e più difficile tratto di «pelago»<br />
(Pd II 5), può infatti diventare un presagio temibile.<br />
Cinque secoli dopo, l’immagine torna in Goethe, carica di un senso tragico della vita umana.<br />
Ogni spirito attraversa il mare dell’esistenza a rischio della morte. Che naufraghi o arrivi a destinazione<br />
felicemente, il suo esempio non servirà da guida agli altri. Ciascuno compirà il proprio<br />
viaggio da solo: «come l’acqua che viene spostata da una nave si ricompone immediatamente<br />
dietro di essa, così anche l’errore; dopo che spiriti eccellenti l’hanno eliminato aprendosi un<br />
largo varco, questo si richiude molto in fretta dietro di loro, secondo le leggi della natura»<br />
(Poesia e verità, I, 1814). Ogni progresso umano, per Goethe, diventa rotta non più percorribile<br />
dalle generazioni future. L’uomo, come sul mare, non sembra capace di incidere un segno indelebile<br />
sulla natura e sulla storia.<br />
Non così per Dante. Il mare periglioso dell’esistenza gli appare costellato di moniti e relitti.<br />
Scia diventata lapide fu ad esempio quella che, gorgogliante in un quadruplice vortice, si chiuse<br />
sulla «piccioletta barca» di Ulisse (un altro marinaio animato da inopportuna sete di «canoscenza»,<br />
If XXVI 120). Anche lui, Ulisse, come i lettori inesperti, era desideroso di prendere<br />
un’«acqua» che «già mai non si corse» (Pd II 7). La scia, che i marinai ben provvisti conservano<br />
davanti a sé come guida, prima che il mare torni a chiudersi su se stesso uguale a prima<br />
e a sempre («dinanzi a l’acqua che ritorna equale», Pd II 15), può anche essere un sinistro<br />
monito per il marinaio superbo.
ILPUNTODELLACRITICA<br />
IL PUNTO DELLA CRITICA<br />
«con miglior / voci si pregherà…»:<br />
quali voci pregheranno Cirra?<br />
La difficoltà della terza<br />
cantica e il suo intrinseco<br />
legame con la materia<br />
Un dubbio interpretativo<br />
tutto nuovo<br />
Nel Trecento<br />
Fra Quattro e Cinquecento<br />
I moderni: l’Ottocento<br />
Il dibattito<br />
Per il lettore odierno il Paradiso presenta difficoltà che superano di gran lunga quelle delle due cantiche<br />
precedenti. Tuttavia, questa fatica, invece di sconfortare deve essere intesa come parte stessa<br />
della lettura e della comprensione dell’ultima cantica: Dante era convinto che, proprio attraverso i<br />
trentatré canti finali, il pellegrino celeste, l’autore stesso e i lettori si sarebbero resi degni della visione<br />
di Dio grazie all’intenso e complesso percorso fra i misteri più alti e sublimi del creato. Nel pensiero<br />
di Dante, infatti, la missione ammaestratrice del poema è tutt’uno con l’esigenza di scriverlo,<br />
anzi ne è il motore trainante. Questa idea, oltre a conferire un senso speciale a ogni singolo verso<br />
dell’ultima cantica, è anche implicata in molte questioni esegetiche e in alcune possibili soluzioni<br />
interpretative a passaggi sostanziali del testo. Uno di questi passaggi è già, ovviamente, nel I canto<br />
e la sua particolarità è che è stato ‘scoperto’ in quanto possibile crucem solo in tempi assai recenti:<br />
nella terzina ai vv. 34-36, a un primo verso proverbiale segue l’auspicio (incerto, come indica il<br />
«forse») che in futuro delle voci «migliori», cioè più efficaci, possano pregare per ottenere un risultato<br />
più grande. Poiché si trovano all’interno dell’invocazione ad Apollo, i versi sono sempre stati<br />
riferiti all’ambito della poesia: le «voci» appartengono a poeti futuri ispirati dalla lettura della<br />
Commedia. Quindi Dante, lo stesso che si presenta come il poeta investito da Dio di una missione<br />
mai tentata, pensa ad altri suoi ‘colleghi’ che in futuro ripeteranno la medesima missione, e<br />
anzi faranno meglio. Non c’è dubbio che il ragionamento suoni paradossale. Ecco perché alcuni<br />
lettori novecenteschi hanno sollevato un dibattito critico di cui qui ti rendiamo conto.<br />
Tesi 1. Le «miglior voci» appartengono a poeti del futuro<br />
Ciò che ad alcuni moderni può parere strano, non lo era affatto per gli esegeti trecenteschi, tutti convinti<br />
che le «miglior voci» appartenessero a poeti del futuro: ne è certo il figlio di Dante, Pietro, nel<br />
suo Comentarium, e lo è l’Anonimo che scrive: «Qui soggiunge l’Auttore a sua persuasione che, sì<br />
come alla picciola favilla del fuoco, si segue gran fiamma, così forse drieto da lui, ch’è picciol poeta,<br />
seguiranno degli altri che diverranno eccellenti in poetria». Francesco da Buti, sul finire del secolo,<br />
parafrasava: «così dal mio piccolo ingegno nascerà e genererassi uno grande lume e splendore di<br />
fama, la qual cosa fia incitamento alli altri di fare mellio di me vedendo me tanta fama avere acquistato<br />
[...] sì che io sarò cagione esemplare agli altri che nella poesia s’affatichino». Il commentatore<br />
però precisava che questo è quanto si ricava da una lettura del testo dantesco «secondo la lettera»;<br />
invece, «secondo l’allegoria» è come se Dante dicesse «per esempio di me molti si daranno più fermamente<br />
di me alle virtù et avranno maggior merito in vita eterna»: in questa convivenza di piani<br />
di significato diversi – del tutto spontanea per gli antichi e sempre molto ostica per noi moderni –<br />
finivano per fondersi quelli che oggi sono invece due indirizzi interpretativi ben distinti.<br />
Nel 1481 Cristoforo Landino, artefice del primo commento a stampa della Commedia, riteneva che<br />
le «miglior voci» appartenessero a futuri poeti e in accordo con lui, contrariamente al consueto, si<br />
mostrava Alessandro Vellutello, autore nel 1544 della Nova esposizione della Commedia dantesca in<br />
cui – proprio in polemica con l’allegorismo del Landino – sperimentava una lettura del poema<br />
incentrata sulla fedeltà al testo nel tentativo, molto moderno, di spiegare Dante con Dante.<br />
Nella seconda metà dell’Ottocento, a Lipsia uscirono i tre volumi del commento al poema dello sviz-<br />
27
28<br />
CANTO I<br />
Il Novecento<br />
Modestia<br />
L’umiltà<br />
La ripresa del termine<br />
«favilla» nel XXXIII canto<br />
IL PUNTO DELLA CRITICA<br />
zero Giovanni Andrea Scartazzini, la cui lettura della Commedia, rivista poi da Giuseppe Vandelli per<br />
l’edizione italiana del 1893, ha rappresentato una pietra miliare nell’esegesi del poema. Secondo<br />
Scartazzini, l’espressione «miglior voci» è così ovvia da non richiedere spiegazione in nota; di ciò si è<br />
molto meravigliato Robert Hollander che nel suo articolo dedicato alla questione ha notato come<br />
proprio Scartazzini abbia proposto una soluzione assai valida per un luogo molto vicino a questo dal<br />
punto di vista contenutistico (Pd XXX 34-35) e qui abbia invece sorvolato.<br />
Anche larga parte della critica del Novecento non ha colto alcunché di oscuro nel passo: nell’opera<br />
novecentesca di riferimento per tutto ciò che riguarda Dante e i suoi testi, cioè l’Enciclopedia<br />
Dantesca, Domenico Consoli ha stilato il termine «voce», dove a proposito di Pd I 35, si limita a<br />
dire che «Dante pensa a qualche poeta che dopo di lui, e per lo stimolo della Commedia – la favilla<br />
cui forse seguirà una gran fiamma – invochi la Musa con ‘voci migliori’ della sua». Nelle parole<br />
di Dante non trova nulla di strano Guido Mazzoni «essendo vero che i discepoli fan presto a impadronirsi<br />
dell’arte dei maestri». Momigliano stringatamente appunta: «qualche poeta più valente<br />
di me» e Sapegno (1957) intende «poeti meglio dotati», la stessa parafrasi proposta da Grabher e<br />
da Bosco e Reggio, sulla cui ampia nota esplicativa torneremo.<br />
Se con un pizzico di ironia, nell’Ottocento, Antonio Cesari esclamava che «qui Dante vuol fare il<br />
Ser Modesto», al debutto del secolo successivo un’autorità come Francesco Torraca (1901) riprendeva<br />
il concetto di modestia e ne faceva il movente di Dante nell’auspicare che nuovi poeti lo<br />
seguissero e superassero. Più di recente, Anna Maria Chiavacci Leonardi ritiene che proprio «l’aggettivo<br />
miglior [sia] forma di modestia, tuttavia temperato, non dimentichiamolo, da un forse».<br />
La modestia è strettamente connessa con l’umiltà e su questo concetto ruotano le osservazioni di<br />
Bosco e Reggio i quali davano conto, in nota e nell’Introduzione al canto, della possibile interpretazione<br />
alternativa – per cui vedi Tesi 2 – ma si mostravano anche convinti che il verso fosse un<br />
esplicito atto di umiltà del poeta. Infatti, ora che è giunto per Dante il momento di render conto<br />
ai lettori del passaggio più incredibile, esaltante e di conseguenza pericoloso della sua straordinaria<br />
impresa, l’argomento principale fra quelli sottesi al canto è la superbia: narrare la propria ascesa<br />
nei cieli, da vivo, primo e unico dopo san Paolo, ha un alto potenziale di superbia, tanto più<br />
per chi, come Dante, se ne è confessato peccatore (incontrando i superbi in Purgatorio, il poeta<br />
si è raffigurato nella loro identica postura di penitenti). Come ha scritto Umberto Bosco, così<br />
facendo «Dante si pone in guardia contro quella che egli sa bene essere la sua nemica, la superbia<br />
[...] Se gli uomini riconosceranno l’eccellenza della sua poesia, se lo premieranno con la corona<br />
di alloro, egli sa bene che il merito non è suo, ma della materia e della divinità che lo ha sorretto<br />
(vv. 25-27). Da questa umiltà verso Dio rampolla naturalmente l’umiltà verso gli uomini: (vv.<br />
34-36). I migliori poeti del futuro non sono, propriamente, coloro che avranno maggiori forze di<br />
poesia, ma coloro che sapranno meglio pregare perché solo così raggiungeranno una meta poetica<br />
più alta». Interessante distinzione questa conclusiva, che individua una sfumatura forse non<br />
colta da Hollander.<br />
Nella recente e complessa lettura del canto di Selene Sarteschi (2002), che segue l’interpretazione<br />
tradizionale, l’accento è posto sul termine «favilla» con cui il poema è definito; Toffanin (vedi<br />
Tesi 2) basa la sua proposta di lettura alternativa proprio sulla stranezza di definire il poema una<br />
semplice e piccola scintilla. Invece, la Sarteschi sembra l’unica ad aver colto una successiva ricorrenza,<br />
nient’affatto casuale, di «favilla»: il termine, infatti, ritorna unito a «gloria» nell’ultimo canto<br />
del Paradiso, là dove il poeta invoca Dio di concedergli le parole perché egli «possa lasciare a la<br />
futura gente» almeno una «favilla» di ciò che ha visto mentre contemplava la sua Gloria (Pd XXXIII<br />
71-72). La stessa parola in due invocazioni e in due momenti così nodali del poema illumina reciprocamente<br />
i due passi e consente a Dante-autore di attestare «l’unicità di un’impresa che s’identifica<br />
con la stesura del poema e con la missione del poeta che dall’età antica, proiettandosi verso<br />
il futuro, tramanda il messaggio dell’epica classica in quella cristiana». Addirittura, «il termine<br />
favilla in una dialettica di umiltà e grandezza connota l’iter dantesco»: infatti, era già stato usato<br />
nel Purgatorio al momento dell’incontro fra Virgilio e Stazio e torna ai vv. 67-72 del canto finale<br />
della Commedia, dove «favilla» è «conferma della magnanimità poetica cercata da Dante».
IL PUNTO DELLA CRITICA<br />
Nessuna umiltà in Dante<br />
Un dubbio<br />
Le «miglior voci» come<br />
esaltazione messianica<br />
di Dante<br />
Un’idea poco convincente<br />
Il Cielo stesso pregherà<br />
Le «miglior voci» sono preghiere<br />
Ad alcuni interpreti la Tesi 1 è parsa inaccettabile perché «l’idea che Dante possa prospettare che<br />
anche un solo poeta (per non parlare di una schiera) possa seguirlo sembra insensata». Sono queste<br />
le parole con cui Robert Hollander ha sollevato la questione e proposto una lettura alternativa (vedi<br />
Tesi 2B). Come chiarisce lo stesso dantista americano, uno dei più autorevoli dei nostri giorni, ricostruendo<br />
la storia esegetica di queste terzine, già Rocco Montano nel 1963 aveva individuato una<br />
contraddizione fra il Dante conscio del suo compito e delle sue capacità e il fatto che immagini futuri<br />
poeti migliori di lui. Montano scrive: «Si crede in genere che in questo verso e nei successivi vi sia<br />
come un’espressione di umiltà. È così assurdo che Dante possa pensare a poeti meglio dotati di lui.<br />
Si ha l’impressione che, pur con tanti studi, assai spesso si rimanga davvero molto lontani dalla comprensione<br />
dell’anima di Dante. Possibile che proprio ora che ha invocato l’aiuto di Apollo, accostatosi<br />
a una materia che nessun altro ha avuto il coraggio di affrontare, quel poeta stesso che già si era<br />
vantato di fare meglio di Ovidio, meglio di Lucano, e che sa che nessun altro avrebbe potuto nemmeno<br />
adombrare la bellezza di Beatrice, possibile che proprio ora Dante sminuisca non solo se stesso<br />
ma anche la materia del suo scritto dicendo che egli e la sua opera valgono poco, ma dopo di lui<br />
verranno poeti più valenti?». D’altronde, bisogna ricordare che nel Purgatorio, nel canto dedicato ai<br />
superbi penitenti, il poeta, con Oderisi da Gubbio, aveva affermato la relatività di ogni fama artistica,<br />
e dunque anche di ogni capacità poetica, che potrà sempre essere superata da una migliore.<br />
Tesi 2. Preghiera di Beatrice e dei beati<br />
Di norma si ritiene che sia stato Giuseppe Toffanin il primo, nel 1947, a suggerire che le miglior voci<br />
non fossero voci o parole di poeti futuri bensì preghiere; questa interpretazione nasce alla luce del verso<br />
successivo in cui viene usato il verbo ‘pregare’. Tuttavia, nel verso si cita Cirra, luogo consacrato ad<br />
Apollo che colloca l’area semantica della terzina nel terreno della poesia e non in quello della preghiera<br />
(ed è questo, forse, ciò che rende l’ipotesi esegetica poco sicura). Secondo Toffanin, l’interpretazione<br />
consueta della terzina è «inconciliabile con quanto sappiamo della <strong>Divina</strong> Commedia e di Dante»<br />
perché «sarebbe un’incongruenza logica ed estetica a quel sentimento messianico di sé e della propria<br />
missione poetica»: infatti, secondo la Tesi 1 si deve intendere «poca favilla» come una perifrasi per<br />
indicare il poema, lo stesso che fra qualche canto verrà definito «poema sacro / al quale ha posto mano<br />
e cielo e terra» (Pd XXV 1-2). Toffanin propone allora di parafrasare: «ma io non sarò solo a pregare;<br />
la mia preghiera solitaria (poca favilla) avrà una grande eco (gran fiamma). Di retro a me altre voci<br />
si leveranno e invocheranno da voi [o Dio, o divine gerarchie della poesia] il compimento della mia<br />
missione di poeta». In pratica, «la mia preghiera, egli dice, sarà secondata dalla preghiera degli stessi<br />
beati e di quanti partecipano la speranza di cui essa è messaggera: sarà secondata dalla preghiera di<br />
Beatrice». Costoro pregheranno perché «alla salvezza di Dante e quindi al suo viaggio e al suo poema<br />
è interessato tutto il Paradiso e il mondo cristiano»; negando ogni accento di modestia, Toffanin conclude<br />
che «l’esaltazione messianica mai s’è espressa in una terzina più pura e più dantesca».<br />
Bosco e Reggio, nel dare conto in nota del suggerimento interpretativo di Toffanin, lo definiscono<br />
suggestivo, «ma forse troppo sottile». L’idea è stata ripresa da Mattalìa, che però si è limitato<br />
a citarla e pare non condividerla, e da Paratore il quale si domanda se sia possibile che Dante,<br />
convinto della sua investitura da parte del Cielo di una grande missione redentrice e assertore,<br />
fra non molti versi, dell’eccezionalità del suo canto («L’acqua ch’io prendo già mai non si corse»,<br />
Pd II 7), ritenesse che dopo di lui altri, invocando «con miglior voci» l’aiuto divino, potesse percorrere<br />
la stessa strada. Hollander, invece, ha definito questa «una strana interpretazione» perché<br />
in Paradiso i beati non sembrano pregare per quelli che sono in Terra e porta a esempio il fatto<br />
che, quando Beatrice e san Bernardo pregheranno perché Dante possa contemplare Dio, questa<br />
assoluta novità verrà indicata esplicitamente.<br />
Interessanti sono le riflessioni del già citato Montano, allievo di Toffanin, secondo cui «il poeta<br />
dice che alla propria preghiera ad Apollo si aggiungerà forse la preghiera dall’alto di Beatrice, della<br />
Madonna: altri nel mondo della Grazia pregherà per Dante perché egli sia aiutato nella grande<br />
CANTO I<br />
29
30<br />
CANTO I<br />
La scelta di Sermonti<br />
Una lettura tutta nuova<br />
Una terza via<br />
impresa. È tutto il contrario di dire che la propria opera è un’umile cosa e altri più valenti poeti<br />
verranno incoraggiati dall’esempio a fare meglio. Dante vuole dire che data l’incomparabile materia<br />
il Cielo stesso pregherà». Per Hollander questa «posizione minoritaria non pare persuasiva perché<br />
le preghiere affinché Dante compia la sua missione dovrebbero essere immediate, mentre dal<br />
testo sembra di arguire che si parli di futuro».<br />
Vittorio Sermonti non prende posizione esplicita e tuttavia, con il piglio critico che contraddistingue la<br />
sua lettura del poema, lascia intendere quale soluzione lo convinca di più. Scrive infatti: «I più sono<br />
convinti che queste miglior voci [...] siano di poeti prossimi venturi: i meno che sian le voci di beati e<br />
d’angeli, destinate a caldeggiare di cielo in cielo la preghiera del poeta presso lo Spirito Santo, col prestigio<br />
delle loro intercessioni ‘per soli e coro’. Non sarebbe la prima volta, se i meno avessero ragione».<br />
Tesi 3. Preghiera dei lettori<br />
IL PUNTO DELLA CRITICA<br />
Come egli stesso rivendica con qualche orgoglio, l’unico a pensare a una nuova ipotesi interpretativa<br />
per l’espressione è stato, come già più volte accennato, Robert Hollander: nell’articolo The<br />
‘miglior voci’ of Paradiso 1.35 (2005) spiega di voler «proporre una soluzione a un problema che<br />
di solito non è riconosciuto come tale» e racconta di aver letto per molti anni i versi in questione<br />
«dando loro un senso che credevo fosse comune a tutti i lettori: secondo me questi versi rappresentano<br />
l’unico punto della Commedia in cui Dante ci dice chiaramente qual è lo scopo che intende<br />
raggiungere scrivendo il poema». Hollander si è accorto di essere l’unico a intendere così il<br />
passaggio oggetto del dibattito solo quando si è accinto a comporre le note per l’edizione in lingua<br />
inglese del poema curata insieme alla moglie Jean: allora ha scoperto, «con sorpresa, non solo<br />
che la mia lettura era inusuale ma che sembrava anche unica» e confessa di non aver trovato<br />
«finora» nessun altro che la condivida. Eppure gli pare degna di essere rivendicata perché «sembra<br />
la spiegazione più semplice in assoluto». «C’è, per fortuna, una terza via [alle due esaminate<br />
rispettivamente nella Tesi 1 e nella Tesi 2A]: dal punto di vista letterale i versi esprimono la speranza<br />
che la Commedia aiuterà i lettori a pregare in modo più efficace e li spingerà sulla via della<br />
salvezza». La terzina 34-36 dunque non fa altro che ribadire il proposito più volte dichiarato dal<br />
poeta «di portare chi vive nella prigione del peccato verso la libertà della Gloria eterna», come ben<br />
spiegato anche nell’Epistola a Cangrande. Per Hollander, quindi, Dante è «molto semplicemente<br />
lo scriba dei [...] e il suo ruolo di poeta è quello di assisterci nelle nostre preghiere perché non c’è<br />
nulla di più grande che un poeta cristiano possa proporsi di fare».<br />
Bibliografia essenziale<br />
A. Cesari, Bellezze della Commedia, Verona, Tipografia Paolo Libanti, 1824-1826.<br />
R. Hollander, «Why did Dante write the Commedia?», in «Dante Studies», CXI, 1993.<br />
Id, «The miglior voci of Paradiso I.35», versione ampliata, «Letteratura italiana antica», Roma,<br />
Moxedano, 7, 2007.<br />
G. Mazzoni, Almae luces, malae cruces, Bologna, Zanichelli 1941.<br />
R. Montano, Storia della poesia di Dante, Napoli, Quaderni di Delta, 1963.<br />
E. Paratore, Tradizione e struttura in Dante, Firenze, Sansoni, 1968.<br />
S. Sarteschi, «Canto I», in Lectura Dantis Turicensis (a cura di G. Güntert e M. Picone), Firenze,<br />
Cesati, 2002; ora in Il percorso del poeta cristiano. Riflessioni su Dante, Ravenna, Longo, 2006.<br />
V. Sermonti, Il Paradiso di Dante, Milano, Rizzoli, 2001.<br />
G. Toffanin, Sette interpretazioni dantesche, Napoli, Libreria Scientifica Editore, 1947.
Vedere<br />
Dante<br />
PARADISO IN IMMAGINI
Vedere Dante<br />
Interpretazioni figurative della Commedia<br />
dall’Ottocento al Novecento<br />
Illustrare l’intero poema<br />
Molte le rappresentazioni episodiche dell’universo dantesco<br />
(Delacroix, Ingres, Corot, Rodin, Boccioni, Füssli: tutti autori<br />
che si sono ispirati esclusivamente all’Inferno), più circoscritte<br />
le imprese che mirano ad abbracciare l’intero poema. Le<br />
incisioni dello scultore inglese John Flaxman portano a compimento<br />
con metodo uniforme l’incarico ricevuto a Roma<br />
nel 1792 dal banchiere olandese Thomas Hope di illustrare<br />
la Commedia, riducendo le tre cantiche al medesimo segno<br />
rigoroso di matrice classica. William Blake si accinge all’impresa<br />
nel 1818: a più di sessant’anni, infastidito dalle traduzioni<br />
inglesi del poema, si mette a imparare l’italiano per poter<br />
meglio interpretare l’universo dantesco; ma dei numerosi<br />
schizzi a penna, disegni e acquarelli soltanto sette saranno<br />
le incisioni definitive. Gustave Doré, nel 1861, fornisce di fatto<br />
l’iconografia ufficiale del poema, ma, numeri alla mano,<br />
la maggior parte delle tavole risulteranno destinate all’Inferno<br />
(72 per la prima cantica contro le 42 del Purgatorio e le<br />
18 del Paradiso). Il genovese Amos Nattini, esponente di un<br />
naturalismo che si esaspera nella resa anatomica, con tenacia<br />
pone fine al suo ambizioso progetto di trasformare la<br />
Commedia in un oggetto per pochi eletti cultori del bello e in<br />
vent’anni, dal 1919 al 1939, compie l’impresa, illustrando<br />
ogni canto con un acquarello destinato a corredare la sua<br />
personale e dispendiosa edizione del poema. L’incontro con<br />
Dante di Salvador Dalì, che lavora per circa un decennio (dal<br />
1950 al 1959) a un centinaio di acquarelli, poi trasformati in<br />
xilografie, è l’incontro tra due visionari: il pittore surrealista<br />
esaspera della Commedia il misticismo e la dimensione onirica.<br />
Alberto Martini si dedica alla traduzione in immagini<br />
dell’opera di Dante per circa quarant’anni, realizzando un<br />
corpus vario ma non sistematico di disegni, litografie e acqueforti.<br />
Renato Guttuso pubblica nel 1970 il ‘suo Dante’,<br />
cinquantasei tavole fortemente compromesse con l’umano<br />
e caratterizzate da un realismo drammatico, risultato di un<br />
lavoro condotto sul poema dal 1959 al 1961. Più libera da terrene<br />
compromissioni l’interpretazione che della Commedia<br />
ci fornisce Aligi Sassu: l’artista sardo trascende la cronaca,<br />
appiglio sicuro per gli interpreti ottocenteschi, in un’interiorità<br />
allucinata e nei suoi acrilici (uno per ciascun canto del<br />
poema, composti tra 1981 e il 1986) uniforma nel segno della<br />
luce e del colore l’universo dantesco. Episodica e frammentata,<br />
l’arte novecentesca si allontana irreversibilmente<br />
dalla dimensione universale della Commedia e sempre più rarefatte<br />
si fanno le incursioni figurative nell’ultramondo cantato<br />
da Dante: tra le prove più recenti si ricordano le illustrazioni<br />
di tre maestri del fumetto, Mattotti, Glaser e Moebius.<br />
Il Paradiso: la cantica irrappresentabile<br />
La terza cantica, tradizionalmente la più ardua anche<br />
per gli illustratori, ha pochi pittori appassionati e visionari<br />
che si cimentano nel difficile compito di dare visibilità<br />
all’invisibile, all’incorporeo, alla spiritualità tutta<br />
luce, alla geometria rigorosa ma monotona dell’ultimo<br />
regno. I trionfi angelici e le maestà medievali e rinascimentali,<br />
l’oro dei miniaturisti da codici, non stimolano<br />
l’estro pittorico di quegli artisti, pochi, che a partire<br />
dalla fine del Settecento affrontano la sfida più dura.<br />
Blake e Füssli dimenticano l’approdo del viaggio dantesco<br />
per felici incursioni nell’Inferno e nel Purgatorio,<br />
mentre John Flaxman, sostenuto dal suo segno nitido<br />
e cristallino d’incisore, raggiunge i risultati più convincenti<br />
proprio nelle tavole dedicate al Paradiso. Le illustrazioni<br />
dedicate alla terza cantica andranno quindi<br />
ricercate in quegli artisti che, in un processo di totale<br />
immedesimazione con lo stesso Dante, con tenacia e<br />
determinazione seguono il pellegrino fino alla fine del<br />
viaggio, dando così visibilità alla sua meta. La fantasia<br />
accentuatamente naturalistica di Doré raggiunge i suoi<br />
risultati migliori nei più corposi e foschi scenari infernali,<br />
mentre per magnificare la luce e la potenza di<br />
Dio, con le sue geometriche architetture celesti e i suoi<br />
indistinti e innumerevoli beati, risulta rigoroso ma<br />
monotono. Amos Nattini, pur non abbandonando mai<br />
la sua vena realistica e fedele alla dimensione volumetrica,<br />
esplora tutte le possibilità tonali del giallo-oro e<br />
si dedica a illustrare con precisione storico-filologica gli<br />
abiti dei beati (le tiare e il pastorale dei papi, il saio dei<br />
frati francescani, l’abito dei domenicani), unico appiglio<br />
concreto alla variazione coloristica nella monotonia<br />
delle sfere celesti. Aligi Sassu, grazie alla luce e al<br />
colore, risolve, con adesione al tempo stesso ingenua e<br />
fedele, veramente mistica, anche i passi più ardui; ultimo<br />
in ordine di tempo, Moebius dichiara, presentando<br />
la sua opera dedicata esclusivamente alla terza cantica:<br />
«Scegliere il Paradiso non è semplice. È una questione<br />
di giudizio pare, ma anche di immaginario. Tutti<br />
abbiamo l’impressione di rappresentare meglio<br />
l’Inferno… il diavolo ha qualcosa di umano… Ma il<br />
Paradiso… come rappresentarlo?... Gustave Doré era la<br />
mia sola via d’accesso». Le tavole dedicate al Paradiso<br />
si configurano così come un omaggio all’incisore ottocentesco,<br />
rivisitato con l’estro del fumettista di gran<br />
classe, del disegnatore di mondi altri, esperto in saghe<br />
fantastiche e fantascientifiche.<br />
603
604<br />
VEDERE DANTE<br />
«Trasumanar significar per verba / non si poria…»: e per immagini?<br />
Il momento dell’ascesa di Dante nell’alto dei cieli, quell’indicibile<br />
«trasumanar», impossibile da riferire in versi,<br />
presenta non poche difficoltà anche per gli illustratori.<br />
Nel canto proemiale per la cantica dedicata al terzo<br />
regno, è il cruciale gioco di sguardi tra Dante, Beatrice e<br />
l’«etterne rote» al centro della tavola di Flaxman, mentre<br />
la versione di Doré annulla il rapporto tra i due protagonisti,<br />
raffigurandoli statici e immobili, spettatori di uno<br />
John Flaxman, «Beatrice tutta ne l’etterne rote...» (Pd I), 1793.<br />
PARADISO IN IMMAGINI<br />
spettacolo che è il ruotare eterno e incessante delle sfere<br />
celesti. Va oltre Nattini immaginando e rappresentando<br />
il volo di Dante al seguito della sua guida. Su un punto<br />
concordano gli artisti, interpretando correttamente la<br />
parola del poeta: il tramite necessario per il trapasso è<br />
dato da Beatrice, senza la cui presenza sarebbe stato<br />
impossibile «trasumanar», impossibile l’esperienza del<br />
Paradiso e della visione di Dio.<br />
Dante, concentrato e immobile, si appresta a compiere il suo estremo atto di fede: lo sguardo è<br />
fisso su Beatrice che, con maggior eleganza e disinvoltura, con una grazia quasi mondana, si volge<br />
verso l’«etterne rote», qui simbolicamente rappresentate da un sole che raggiunge con i suoi<br />
raggi i due protagonisti.
PARADISO IN IMMAGINI<br />
Amos Nattini, Paradiso Canto I, 1939.<br />
In piedi su nuvole spesse e dense in posizione gerarchicamente<br />
connotata (Beatrice è in prima fila,<br />
a Dante spetta un posto subalterno), i due spettatori<br />
sono concentrati nella visione del vortice angelico<br />
e luminoso.<br />
Gustave Doré, Paradiso Canto I, 1868.<br />
VEDERE DANTE<br />
Sospesi nel vuoto, Dante e Beatrice salgono in alto appesantiti<br />
da una corporeità che Nattini, appassionato disegnatore<br />
di volumi e dettagli, non abbandonerà mai: le vesti<br />
agitate dal vento, il velo della donna, il copricapo del<br />
pellegrino portano nell’atmosfera immateriale e senza<br />
tempo del Paradiso dei particolari che sanno di terrestre<br />
mondanità.<br />
Lontano, in basso, il Paradiso terrestre coi suoi colori tenui<br />
e sfumati e la sua foresta lussureggiante attraversata<br />
dal corso d’acqua rappresenta l’ultimo addio del pittore al<br />
paesaggio, a cui per i prossimi 32 canti dovrà rinunciare.<br />
605
606<br />
VEDERE DANTE<br />
Nel cielo di Venere<br />
È nel cielo di Venere, quello degli spiriti che hanno<br />
amato troppo e che dalla potenza dell’amore si sono<br />
lasciati vincere e condurre, che Dante incontra i personaggi<br />
più densi di storia e di spessore umano della<br />
terza cantica: le loro biografie, romantiche e appassionanti,<br />
parlano chiaro. E Carlo Martello, Cunizza<br />
da Romano, Folchetto da Marsiglia, grazie ai versi<br />
John Flaxman, «Indi si fece l’un più presso a noi...» (Pd VIII), 1793.<br />
PARADISO IN IMMAGINI<br />
danteschi, stimolano con forza maggiore l’estro<br />
degli illustratori: la fine precoce del giovane re franco<br />
e l’avventurosa vita sentimentale di Cunizza forniscono<br />
lo spunto anche agli artisti più refrattari alla<br />
terza cantica (è il caso di Guttuso, che delle appena<br />
sei tavole per il Paradiso ne dedica proprio una a<br />
Cunizza).<br />
Un principe dal volto di fanciullo, circondato dalle anime dei beati invece<br />
che da dignitari e funzionari di corte, è quello che si presenta a Dante. Elegante<br />
e pieno di grazia, le preziose insegne del potere che ne ingentiliscono<br />
la figura (la coroncina, la spada), Carlo Martello incarna, con leggerezza e<br />
coerenza nella versione dell’incisore inglese, l’ideale di cavalleria e cortesia<br />
vagheggiato da Dante.
PARADISO IN IMMAGINI<br />
Moebius, Carlo Martello, 1999.<br />
Per sostenere la pesante corporeità dei beati, tutt’altro<br />
che immateriali ma individuati con precisione<br />
nei tratti somatici, negli abiti e nelle acconciature,<br />
nei gesti e nelle espressioni, Nattini rende<br />
solide e spesse le nuvole celesti: spumose volute di<br />
candido stucco in grado di sopportare il peso evidente<br />
delle figure.<br />
Amos Nattini, Paradiso Canto IX, 1939.<br />
VEDERE DANTE<br />
Possente e inquietante come un eroe da fumetto fantastico,<br />
Carlo Martello giganteggia nella versione di<br />
Moebius: la grazia cortese e quasi infantile del principe<br />
franco è qui cancellata in una rappresentazione<br />
che altera in nome della potenza e della forza dell’immagine<br />
il dato storico e il dettato dantesco.<br />
607
608<br />
VEDERE DANTE<br />
John Flaxman, «Qui si tacette...» (Pd IX), 1793.<br />
Come una Francesca salvata e non dannata,<br />
Cunizza è ritratta da Guttuso nel<br />
momento della passione: è un episodio<br />
della vita terrena della beata che il pittore<br />
siciliano sceglie di rappresentare.<br />
L’amore umano, evidente e carnale,<br />
espresso dalla coppia di amanti risulta<br />
l’unico che l’artista è in grado di rendere<br />
visibile.<br />
Renato Guttuso, Cunizza, 1970.<br />
PARADISO IN IMMAGINI<br />
Circondata dalla danza armoniosa<br />
dei beati di cui essa<br />
stessa fa parte, la delicata<br />
figura di Cunizza si materializza<br />
di fronte ai due spettatori,<br />
accoccolati come durante<br />
uno spettacolo di piazza:<br />
il volto di Dante è atteggiato<br />
a un sorriso, suscitato<br />
dalla grazia tutta femminile<br />
della donna che gli si rivolge.
PARADISO IN IMMAGINI<br />
Grandi uomini, grandi personaggi: Giustiniano e san Francesco<br />
Nel canto VI Dante torna alla politica con sguardo più<br />
ampio, universale: è la volta dell’impero, identificato<br />
nell’aquila il cui percorso è raccontato da Giustiniano,<br />
nell’ottica di Dante restauratore dell’unità imperiale.<br />
«Cesare fui e son Iustinïano»: così si presenta l’imperatore<br />
nei versi danteschi; ma la sua figura è indissolubilmente<br />
legata al simbolo dell’Impero, l’aquila,<br />
Duilio Cambellotti, Giustiniano e l’aquila imperiale (Pd VI), 1900.<br />
VEDERE DANTE<br />
e così interpretano correttamente gli illustratori.<br />
Accanto alla dimensione grandiosamente politica<br />
dell’imperatore ecco il santo d’Assisi, il sole la cui<br />
parabola illuminante è raccontata nel canto XI da san<br />
Tommaso. Dopo la glorificazione del potere imperiale,<br />
la dura rampogna contro la Chiesa, troppo lontana<br />
dalla carità indicata da Francesco.<br />
Soprannaturale e quasi onirica l’apparizione di Giustiniano a Dante nell’interpretazione<br />
di Cambellotti. Dal buio profondo del sonno, completamente<br />
cancellata la luce accecante del terzo regno, ecco emergere l’imponente e severa<br />
figura dell’imperatore alle cui spalle si staglia l’aquila. Le ali aperte e<br />
gigantesche del «santo uccello» alludono alla forza e alla potenza del volo.<br />
609
610<br />
VEDERE DANTE<br />
È la fiamma rossa della fede che uniforma la tavola dedicata da Sassu<br />
al canto VI. Anche qui la simbiosi tra l’imperatore e il «sacrosanto segno»<br />
dell’impero è evidente: uniti in una raffigurazione dinamica che<br />
sembra riprodurre la velocità del volo, Giustiniano e l’aquila appaiono<br />
come trascinati da un vento impetuoso.<br />
Aligi Sassu, Cielo di Mercurio. Giustiniano (Pd VI), 1980-1986.<br />
PARADISO IN IMMAGINI
PARADISO IN IMMAGINI<br />
Nella visione di Sassu è il Francesco dei<br />
Fioretti che viene esaltato, quello della<br />
leggenda popolare. Sorridente, circondato<br />
dagli animali, dalle piccole creature di<br />
Dio, questo è il «poverello d’Assisi» della<br />
predica agli uccelli che in Dante non compare.<br />
Soltanto il rosa acceso scelto da Sassu<br />
rimanda all’ardore di carità che infiamma<br />
il santo nei versi danteschi: «tutto<br />
serafico in ardore» (Pd XI 37).<br />
Aligi Sassu, Cielo del sole.<br />
San Francesco (Pd XI), 1980-1986.<br />
VEDERE DANTE<br />
Giuseppe Mentessi,<br />
San Francesco e la povertà<br />
(Pd XI), 1900.<br />
Fedele al dettato dantesco è il mistico<br />
matrimonio con madonna Povertà<br />
che Mentessi sceglie di mettere<br />
al centro della tela e della sua veristica<br />
interpretazione del canto XI.<br />
L’allegoria diventa bozzetto realistico,<br />
studio dal vero: della strana<br />
unione Mentessi esaspera il dato<br />
più fisico e sgradevole: la bruttezza<br />
della Povertà che nessuno vuole e<br />
che Francesco, invece, ha amato,<br />
sposato e seguito per tutta la vita.<br />
611
612<br />
VEDERE DANTE<br />
I luoghi e i simboli: la scala d’oro e la candida rosa<br />
Pochi appigli concreti offre il paesaggio paradisiaco<br />
con le sue sfere ruotanti, le armonie celesti fatte di<br />
musica, luce e grazia divina; due sono però i luoghi che<br />
emergono in modo visivamente rappresentabile e che<br />
hanno non a caso relazioni strette con oggetti reali,<br />
tutti terreni: una scala e una rosa. Al canto XXI, nel<br />
cielo di Saturno, ecco che a Dante appare una scala<br />
d’oro che si erge verso l’alto e di cui il pellegrino non<br />
riesce a vedere la fine: «di color d’oro in che raggio traluce<br />
/ vid’io uno scaleo eretto in suso / tanto, che non<br />
seguiva la mia luce» (Pd XXI 28-30). Le anime dei beati<br />
John Flaxman, «Vid’io uno scaleo eretto in suso...» (Pd XXI), 1793.<br />
PARADISO IN IMMAGINI<br />
che salgono e scendono sulla scala stimolano la fantasia<br />
degli artisti che trasformano le luci in movimento in<br />
personaggi a passeggio su una regale scalinata. Così il<br />
fiume di luce e le faville che si rivelano al poeta<br />
nell’Empireo prendono forma floreale: «quanta è la larghezza<br />
/ di questa rosa ne l’estreme foglie!» (Pd XXX<br />
117-118). L’immagine è ribadita all’inizio del canto successivo:<br />
«In forma dunque di candida rosa / mi si<br />
mostrava la milizia santa» (Pd XXXI 1-2). La «candida<br />
rosa» diventa, dunque, nuvole spumose per Nattini,<br />
luminosi vortici ruotanti per Moebius che rivisita Doré.<br />
Tutta mondana e cortese l’interpretazione proposta da Flaxman per la scala d’oro:<br />
come lungo le ampie scale di un palazzo signorile i beati scendono e salgono abbigliati<br />
da eleganti cortigiani per una festa o una cerimonia di gala. Le anime passeggiano<br />
a gruppi, intrattenendosi piacevolmente in amabili conversazioni, mentre la<br />
luminosità dorata che le circonda è resa da Flaxman con rapidi e sintetici segni.
PARADISO IN IMMAGINI<br />
Amos Nattini, Paradiso Canto XXII, 1939.<br />
Dante e Beatrice, macchie scure dal colore di terra<br />
bagnata, semplici spettatori esclusi dal giallo<br />
dominante dell’architettura celeste, sono davanti<br />
alla scala d’oro, qui affrontata in una prospettiva<br />
laterale che permette al pittore di delinearne<br />
il semplice e nitido profilo di gradini ascendenti.<br />
In primo piano due angeli stilizzati in rosso osservano<br />
un altro angelo che, dinamico e ‘futurista’,<br />
sale quasi correndo lo «scaleo d’oro».<br />
Salvador Dalì, Trittico ventunesimo. La scala, 1950-1959.<br />
VEDERE DANTE<br />
Beati individuati da precise caratteristiche<br />
somatiche e differenziati nelle vesti e nelle<br />
acconciature affollano una scala vertiginosamente<br />
sospesa nel vuoto. A ricordarci la<br />
dimensione celeste ci sono le candide nuvole,<br />
i globi lucenti, il simbolo dorato della costellazione<br />
dei Pesci.<br />
613
614<br />
VEDERE DANTE<br />
Amos Nattini, Paradiso Canto XXXI, 1939.<br />
Neanche nella raffigurazione della candida rosa<br />
Nattini dimentica il peso corporeo: le bianche e<br />
spesse nuvole sono affollate di corpi in volo che ad<br />
esse sembrano intrecciarsi e aggrapparsi. La Vergine<br />
è portata in trionfo dal turbinio caotico dei beati,<br />
mentre in basso Dante e san Bernardo, col bianco<br />
saio svolazzante, restano sospesi nel vuoto.<br />
Moebius, La candida rosa, 1999.<br />
PARADISO IN IMMAGINI<br />
Più astratta e geometrica la visione di Moebius, che rispetto alla tavola<br />
di Doré, di cui ripropone identica l’impostazione, deforma e ammorbidisce<br />
le figure, aggiungendo il colore: il giallo accecante al centro,<br />
filologicamente corretto («nel giallo de la rosa sempiterna» è il lago<br />
di luce in cui ruotano gli angeli, Pd XXX 24), il verde e poi il blu. Il<br />
candore della rosa celeste scompare dalla tavolozza dell’illustratore.
PARADISO IN IMMAGINI<br />
Preghiera e visione<br />
Due sono i momenti dell’ultimo canto del poema: la preghiera<br />
e la visione. Più accessibile l’orazione di san<br />
Bernardo, che recita con fervore la preghiera di tutti. Gli<br />
elementi iconografici messi in gioco per questo primo<br />
momento sono tanti e di lunga tradizione nell’arte religiosa:<br />
la figura dell’orante, l’immagine della Madonna in<br />
trionfo tra gli angeli, l’estasi mistica, la preghiera del<br />
Alberto Martini, Vergine Madre Figlia... (Paradiso XXXIII), 1937.<br />
VEDERE DANTE<br />
fedele… Ed è in genere a questo primo momento che gli<br />
illustratori dedicano la tavola per il canto XXXIII. Meno<br />
facile dare forma alla visione di Dio, esperienza ineffabile<br />
per eccellenza, approdo ultimo del pellegrino, meta<br />
finale del suo lungo viaggio. L’astrazione del puro segno,<br />
la scelta geometrica e antinaturalistica di Flaxman sembrano,<br />
in questo caso, proporre la soluzione migliore.<br />
Due ravvicinati primi piani per<br />
illustrare l’ultimo canto del<br />
poema: san Bernardo, l’orante,<br />
è raffigurato di faccia, lo sguardo<br />
perso nell’estasi mistica; a<br />
fianco, di profilo, il pellegrino<br />
celeste è a occhi chiusi, in profonda<br />
concentrazione, per meglio<br />
far propria la preghiera del<br />
santo.<br />
615
616<br />
VEDERE DANTE<br />
Amos Nattini, Paradiso Canto XXXIII, 1939.<br />
Rivisita l’Assunta di Tiziano la proposta di<br />
Nattini per l’ultimo canto. Con la sua gerarchia<br />
verticale e la gestualità magniloquente<br />
dei personaggi sacri, l’impostazione<br />
della tavola ricorda, infatti, le pale cinquecentesche.<br />
Al vertice della composizione<br />
il Padre e il Figlio, al centro la Madonna,<br />
in basso Dante e san Bernardo: tutti<br />
unificati e collegati dalla luce divina.<br />
L’ultima tavola dedicata al poema da Flaxman è anche la più<br />
apprezzata dalla critica novecentesca: «i tre giri / di tre colori<br />
e d’una contenenza» (Pd XXXIII 116-117) sono tradotti con<br />
sintesi efficace in un’immagine che riunisce la rappresentazione<br />
della Trinità e dell’Incarnazione. La leggera puntinatura<br />
che delinea la figura umana è la trasposizione visiva dei<br />
versi danteschi: «dentro da sé, del suo colore stesso, / mi parve<br />
pinta de la nostra effige» (Pd XXXIII 130-131).<br />
John Flaxman, «De l’alto lume parvemi tre giri...» (Pd XXXIII), 1793.<br />
PARADISO IN IMMAGINI