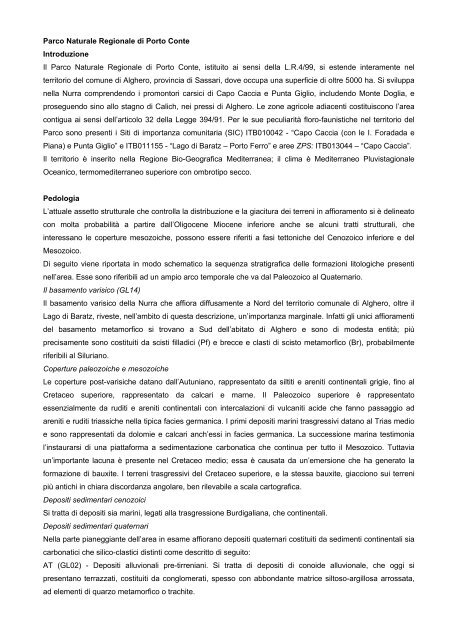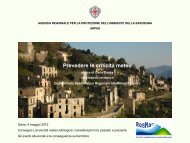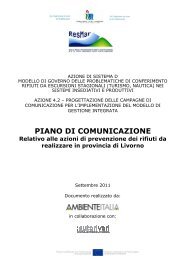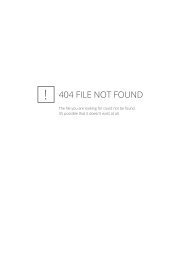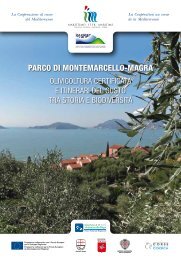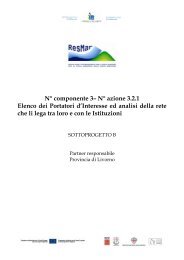Analisi ambientale iniziale del territorio di Porto Conte - RES - MAR
Analisi ambientale iniziale del territorio di Porto Conte - RES - MAR
Analisi ambientale iniziale del territorio di Porto Conte - RES - MAR
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Parco Naturale Regionale <strong>di</strong> <strong>Porto</strong> <strong>Conte</strong><br />
Introduzione<br />
Il Parco Naturale Regionale <strong>di</strong> <strong>Porto</strong> <strong>Conte</strong>, istituito ai sensi <strong>del</strong>la L.R.4/99, si estende interamente nel<br />
<strong>territorio</strong> <strong>del</strong> comune <strong>di</strong> Alghero, provincia <strong>di</strong> Sassari, dove occupa una superficie <strong>di</strong> oltre 5000 ha. Si sviluppa<br />
nella Nurra comprendendo i promontori carsici <strong>di</strong> Capo Caccia e Punta Giglio, includendo Monte Doglia, e<br />
proseguendo sino allo stagno <strong>di</strong> Calich, nei pressi <strong>di</strong> Alghero. Le zone agricole a<strong>di</strong>acenti costituiscono l’area<br />
contigua ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 32 <strong>del</strong>la Legge 394/91. Per le sue peculiarità floro-faunistiche nel <strong>territorio</strong> <strong>del</strong><br />
Parco sono presenti i Siti <strong>di</strong> importanza comunitaria (SIC) ITB010042 - “Capo Caccia (con le I. Foradada e<br />
Piana) e Punta Giglio” e ITB011155 - “Lago <strong>di</strong> Baratz – <strong>Porto</strong> Ferro” e aree ZPS: ITB013044 – “Capo Caccia”.<br />
Il <strong>territorio</strong> è inserito nella Regione Bio-Geografica Me<strong>di</strong>terranea; il clima è Me<strong>di</strong>terraneo Pluvistagionale<br />
Oceanico, termome<strong>di</strong>terraneo superiore con ombrotipo secco.<br />
Pedologia<br />
L’attuale assetto strutturale che controlla la <strong>di</strong>stribuzione e la giacitura dei terreni in affioramento si è <strong>del</strong>ineato<br />
con molta probabilità a partire dall’Oligocene Miocene inferiore anche se alcuni tratti strutturali, che<br />
interessano le coperture mesozoiche, possono essere riferiti a fasi tettoniche <strong>del</strong> Cenozoico inferiore e <strong>del</strong><br />
Mesozoico.<br />
Di seguito viene riportata in modo schematico la sequenza stratigrafica <strong>del</strong>le formazioni litologiche presenti<br />
nell’area. Esse sono riferibili ad un ampio arco temporale che va dal Paleozoico al Quaternario.<br />
Il basamento varisico (GL14)<br />
Il basamento varisico <strong>del</strong>la Nurra che affiora <strong>di</strong>ffusamente a Nord <strong>del</strong> <strong>territorio</strong> comunale <strong>di</strong> Alghero, oltre il<br />
Lago <strong>di</strong> Baratz, riveste, nell’ambito <strong>di</strong> questa descrizione, un’importanza marginale. Infatti gli unici affioramenti<br />
<strong>del</strong> basamento metamorfico si trovano a Sud <strong>del</strong>l’abitato <strong>di</strong> Alghero e sono <strong>di</strong> modesta entità; più<br />
precisamente sono costituiti da scisti filla<strong>di</strong>ci (Pf) e brecce e clasti <strong>di</strong> scisto metamorfico (Br), probabilmente<br />
riferibili al Siluriano.<br />
Coperture paleozoiche e mesozoiche<br />
Le coperture post-varisiche datano dall’Autuniano, rappresentato da siltiti e areniti continentali grigie, fino al<br />
Cretaceo superiore, rappresentato da calcari e marne. Il Paleozoico superiore è rappresentato<br />
essenzialmente da ru<strong>di</strong>ti e areniti continentali con intercalazioni <strong>di</strong> vulcaniti acide che fanno passaggio ad<br />
areniti e ru<strong>di</strong>ti triassiche nella tipica facies germanica. I primi depositi marini trasgressivi datano al Trias me<strong>di</strong>o<br />
e sono rappresentati da dolomie e calcari anch’essi in facies germanica. La successione marina testimonia<br />
l’instaurarsi <strong>di</strong> una piattaforma a se<strong>di</strong>mentazione carbonatica che continua per tutto il Mesozoico. Tuttavia<br />
un’importante lacuna è presente nel Cretaceo me<strong>di</strong>o; essa è causata da un’emersione che ha generato la<br />
formazione <strong>di</strong> bauxite. I terreni trasgressivi <strong>del</strong> Cretaceo superiore, e la stessa bauxite, giacciono sui terreni<br />
più antichi in chiara <strong>di</strong>scordanza angolare, ben rilevabile a scala cartografica.<br />
Depositi se<strong>di</strong>mentari cenozoici<br />
Si tratta <strong>di</strong> depositi sia marini, legati alla trasgressione Bur<strong>di</strong>galiana, che continentali.<br />
Depositi se<strong>di</strong>mentari quaternari<br />
Nella parte pianeggiante <strong>del</strong>l’area in esame affiorano depositi quaternari costituiti da se<strong>di</strong>menti continentali sia<br />
carbonatici che silico-clastici <strong>di</strong>stinti come descritto <strong>di</strong> seguito:<br />
AT (GL02) - Depositi alluvionali pre-tirreniani. Si tratta <strong>di</strong> depositi <strong>di</strong> conoide alluvionale, che oggi si<br />
presentano terrazzati, costituiti da conglomerati, spesso con abbondante matrice siltoso-argillosa arrossata,<br />
ad elementi <strong>di</strong> quarzo metamorfico o trachite.
Tv (GL02) - Depositi travertinosi <strong>di</strong> ambiente lacustre o palustre costituiti essenzialmente da calcari marnosi<br />
teneri oppure compatti e duri. Si presentano sempre in banchi <strong>di</strong> spessore variabile fino a 5-6 m (Pre-<br />
Tirreniano).<br />
DA (GL02) - Arenarie dunari pre-tirreniane con <strong>di</strong>screta <strong>di</strong>agenesi, generalmente ben cementate con cemento<br />
carbonatico secondario.<br />
qm (GL02) – Depositi marino-litorali <strong>del</strong> Tirreniano, riferibili alla formazione “Panchina Tirreniana”, affioranti<br />
lungo la costa antistante lo Stagno <strong>del</strong> Calich. La panchina è <strong>di</strong> facies prevalentemente arenaceoconglomeratica:<br />
la parte inferiore risulta composta da ciottoli appiattiti <strong>di</strong> calcare e trachite, mentre i livelli<br />
superiori <strong>del</strong> complesso sono prettamente arenacei. La potenza complessiva è <strong>di</strong> 5 m.<br />
QS (GL02) - Calcari a car<strong>di</strong>um. Giacciono sui calcari travertinosi pre-tirreniani ed hanno uno spessore che<br />
varia tra 50 cm e 1 m. Si sono formati a seguito <strong>del</strong>l ingressione tirreniana che fece sì che le acque dolci <strong>del</strong>la<br />
precedente palude<br />
venissero salate (Tirreniano).<br />
dt, L, AI e S (GL01) - Depositi quaternari recenti (Olocene). Si tratta <strong>di</strong> detriti <strong>di</strong> pen<strong>di</strong>o (dt), depositatesi ai<br />
pie<strong>di</strong> dei plateaux ignimbritici, <strong>di</strong> depositi litoranei eolici e <strong>di</strong> spiaggia, costituiti da sabbia incoerente (L),<br />
depositi alluvionali debolmente terrazzati, prevalentemente ciottolosi (AI) e infine alluvioni <strong>di</strong> fondo valle attuali<br />
lungo le sponde dei principali corsi d’acqua e limi palustri o salmastri in prossimità <strong>del</strong>lo Stagno <strong>del</strong> Calich (S).<br />
I depositi quaternari olocenici e pleistocenici sono stati ulteriormente classificati, secondo le in<strong>di</strong>cazioni<br />
riportate nelle linee guida <strong>del</strong>l’adeguamento <strong>del</strong> PUC al PAI e al PPR, in relazione alle litologie, alle<br />
granulometrie ed ai processi geomorfologici che li hanno caratterizzati.<br />
Depositi pleistocenici<br />
La classificazione dei depositi pleistocenici è la seguente:<br />
021A - Travertini e calcari continentali. In questa classe sono compresi sia i calcari a car<strong>di</strong>um (QS) <strong>del</strong><br />
Tirreniano, sia i depositi travertinosi <strong>di</strong> ambiente lacustre o palustre pre-tirreniani (Tv).<br />
022B - Depositi alluvionali terrazzati: ghiaie prevalenti. Comprendono i depositi alluvionali pre-tirreniani<br />
costituiti da conglomerati ad elementi <strong>di</strong> quarzo metamorfico o trachite (AT).<br />
024B - Sabbie prevalenti (arenarie cementate). Si tratta <strong>del</strong>le arenarie pre-tirreniane che generalmente si<br />
presentano ben cementate da un cemento carbonatico secondario (DA).<br />
024C - Depositi eluvio-colluviali: coperture <strong>di</strong> materiale a granulometria fine (limi e sabbie), con rari frammenti<br />
litoi<strong>di</strong> grossolani; processi <strong>di</strong> alterazione e/o trasporto <strong>di</strong> entità non precisabile. Essi comprendono i depositi<br />
arenceo-conglomeratici <strong>del</strong> Tirreniano riferibili alla Panchina Tirreniana, affioranti lungo la costa antistante lo<br />
Stagno <strong>del</strong> Calich.<br />
017A - Depositi <strong>di</strong> versante: accumuli lungo i versanti <strong>di</strong> frammenti litoi<strong>di</strong>, eterometrici, angolosi, talora<br />
stratificati, con matrice sabbiosa o sabbiosa-limosa. In questa classe ricadono i detriti <strong>di</strong> pen<strong>di</strong>o (dt) che si<br />
sono accumulati ai pie<strong>di</strong> dei rilievi ignimbritici nella parte meri<strong>di</strong>onale <strong>del</strong> <strong>territorio</strong> <strong>di</strong> Alghero.<br />
011B - Depositi alluvionali attuali, senza in<strong>di</strong>cazione <strong>del</strong>la granulometria. Essi comprendono le alluvioni <strong>di</strong><br />
fondo valle accumulatesi lungo le sponde dei principali corsi d’acqua e in prossimità <strong>del</strong>lo Stagno <strong>del</strong> Calich<br />
(S).<br />
013C - Depositi alluvionali terrazzati: ghiaie e sabbie. Si tratta dei depositi alluvionali debolmente terrazzati in<br />
prevalenza ciottolosi (AI) che affiorano ad Ovest a Maristella e nella penisola <strong>di</strong> Capo Caccia.
Cartografia idrogeologica<br />
Nella carta idrogeologica, in scala 1:10000, vengono riportate le principali informazioni idrogeologiche: la<br />
classificazione <strong>del</strong>le litologie in funzione dei valori <strong>di</strong> permeabilità, le principali unità e complessi idrogeologici,<br />
le relative piezometriche, un numero rappresentativo <strong>di</strong> punti <strong>di</strong> prelievo (pozzi e sorgenti). Le classi <strong>di</strong><br />
permeabilità sono state definite utilizzando le informazioni litologiche ricavate dalla carta geo-litologica: queste
sono state raggruppate in unità e complessi idrogeologici. Per ciascuna unità è stato definito un grado <strong>di</strong><br />
permeabilità, dove è riportata una descrizione qualitativa <strong>del</strong>la permeabilità.<br />
Flora<br />
La Flora, costituita da circa 800 specie <strong>di</strong> piante vascolari, è caratterizzata da un notevole contingente <strong>di</strong><br />
specie me<strong>di</strong>terranee termofile, da un elevato numero <strong>di</strong> specie endemiche sarde o sardo-corse e da <strong>di</strong>verse<br />
entità ad areale poco esteso o che trovano in Sardegna il limite <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione.<br />
Tra la specie <strong>di</strong> maggior interesse si possono citare Anchusa sardoa, che ha nel Parco e nelle aree<br />
imme<strong>di</strong>atamente circostanti (duna <strong>di</strong> <strong>Porto</strong> <strong>Conte</strong> – spiaggia <strong>di</strong> Mugoni) la sua <strong>di</strong>stribuzione mon<strong>di</strong>ale;<br />
Limonium nymphaeum, Genista sardoa, Centaurea horrida, Astragalus terracianoi e Anchusa crispa. ssp.<br />
crispa presenti nel Parco rappresentano una porzione ragguardevole all’areale <strong>del</strong>le specie. Altre endemiche,<br />
più <strong>di</strong>ffuse nell’isola e presenti anche nei <strong>di</strong>versi habitat <strong>del</strong> Parco, sono le sarde Galium schmi<strong>di</strong>i, Bituminaria<br />
morisiana e Vinca sardoa. Notevole è il contingente <strong>del</strong>le endemiche sardo-corse: Allium parciflorum, Crocus<br />
minimus., Ero<strong>di</strong>um corsicum, Polygonum scoparium., Genista corsica, Ornithogalum corsicum., Seseli bocconi<br />
subsp. praecox, Silene corsica, Silene nodulosa, Bryonia mormorata. Sono inoltre presenti le specie<br />
endemiche sardo-corso-tirreniche: Arum pictum. subsp. pictum, Romulea requienii, Stachys glutinosa.,<br />
Pancratium illyricum, Urtica atrovirens, Scrophularia trifoliata, la sardo-corso-sicula Euphorbia cupanii e la<br />
sardo-corso-balearica Bellium belli<strong>di</strong>oides. Recentemente sono state rinvenute Ferula arrigonii, Ptilostemon<br />
casabonae, una piccola popolazione <strong>di</strong> Linaria flava. subsp. sardoa, entità inclusa nell’All. II <strong>del</strong>la Direttiva<br />
Habitat e confermato la presenza a Cala <strong>del</strong>la Barca <strong>del</strong>l’endemica sardo-corsa Evax rotundata e sulle<br />
arenarie tra Cala Viola e Porticciolo <strong>del</strong>l’endemica tirrenica Scrophularia ramosissima. Sono inoltre presenti<br />
nella Nurra entità <strong>di</strong> particolare interesse fitogeografico: Anthyllis barba–jovis, Brassica insularis e<br />
Chamaerops humilis.<br />
Tra queste entità rivestono particolare interesse quelle che concorrono a caratterizzare l’elemento storico<br />
genetico <strong>del</strong>la flora <strong>del</strong>l’area: Centaurea horrida è un paleoendemismo senza verosimili affinità genetiche e<br />
quin<strong>di</strong> presumibilmente <strong>di</strong>fferenziatosi in epoche remote; <strong>di</strong> antica origine sono anche alcune specie<br />
endemiche ad areale <strong>di</strong>scontinuo come Stachys glutinosa e Genista corsica.<br />
Arrigoni (1983) inserisce la Sardegna nel quadro fitogeografico <strong>del</strong>la regione me<strong>di</strong>terranea e riconosce in<br />
questo ambito un dominio sardo-corso in base all’esistenza <strong>di</strong> tre generi monospecifici (<strong>di</strong> cui uno, Nananthea,<br />
presente nella Nurra), e <strong>di</strong> un endemismo specifico molto sviluppato, in buona parte <strong>di</strong> antica origine. In<strong>di</strong>vidua<br />
inoltre un settore specifico sardo, <strong>di</strong>stinto dal quello corso, e in questo riconosce <strong>di</strong>versi sottosettori, tra cui il<br />
sotto-settore costiero e collinare, nel quale viene compresa la regione <strong>del</strong>la Nurra. In quest’ultimo sono<br />
presenti <strong>di</strong>versi endemismi esclusivi. Notevole è invece il contingente sardo-corso esclusivo <strong>del</strong> sottosettore e<br />
presente anche nella Nurra. In generale si può affermare che la zona costiera è caratterizzata da endemismi<br />
<strong>di</strong> conservazione e neoendemismi, come attualmente confermato nella Nurra dalla presenza <strong>di</strong> tre specie <strong>di</strong><br />
Limonium (Limonium laetum, L. acutifolium, L. nymphaeum) che si reputano microneoendemismi e <strong>del</strong>la<br />
paleoendemica relittuale Centaurea horrida.<br />
Anche il paesaggio vegetale <strong>del</strong>l’area è notevolmente caratterizzato nei suoi aspetti fitocenotici, soprattutto<br />
negli ambiti dei microgeosigmeti costieri, dalla presenza <strong>del</strong> contingente endemico e <strong>di</strong> interesse<br />
fitogeografico, che contribuiscono alla <strong>del</strong>imitazione <strong>del</strong>le tipologie fitocorologiche <strong>del</strong>la flora sarda.<br />
La flora <strong>del</strong>l’area SIC si può stimare in 500-600 specie. La flora <strong>del</strong>lo Stagno <strong>di</strong> Calich è stata stimata in 180-<br />
200 entità.
Conservazione <strong>del</strong>la Flora<br />
Circa 60 specie vegetali presenti nell’area <strong>del</strong> parco devono essere prese in considerazione come target <strong>di</strong><br />
azioni <strong>di</strong> conservazione, in quanto protette dalla normativa nazionale e comunitaria o da convenzioni<br />
internazionali, o in quanto endemiche o d’interesse fitogeografico.<br />
Complessivamente possiamo così ripartire le entità vegetali endemiche e d’interesse fitogeografico presenti<br />
nel Parco:<br />
Esclusive <strong>del</strong> Parco: Anchusa sardoa, Genista sardoa;<br />
Esclusive <strong>del</strong> <strong>territorio</strong> <strong>di</strong> Alghero: Limonium nymphaeum;<br />
Endemiche sarde: Centaurea horrida, Echium anchusoides, Galium schmi<strong>di</strong>i, Bituminaria morisiana, Silene<br />
beguinotii e Vinca sardoa;<br />
Endemiche sardo-corse: Allium parciflorum, Anchusa crispa ssp. crispa, Astragalus terraccianoi, Crocus<br />
minimus, Ero<strong>di</strong>um corsicum, Evax rotundata, Genista corsica, Linaria flava subsp. sardoa, Ophrys sphegodes<br />
ssp. praecox, Ornithogalum corsicum., Polygonum scoparium, Scilla autumnalis. var. corsica, Seseli bocconi<br />
subsp. praecox, Silene corsica, Silene nodulosa, Bryonia mormorata;<br />
Endemiche sardo-corso-tirreniche: Arum pictum subsp. pictum, Carex microcarpa, Helichrysum microphyllum.<br />
ssp. tyrrhenicum, Leucanthemum flosculosum Pancratium., Ptilostemon casabonae, Romulea requienii,<br />
Scrophularia ramosissima, Scrophularia trifoliata, Stachys glutinosa, Urtica atrovirens;<br />
Endemiche sardo-corso-sicule: Euphorbia cupanii;<br />
Endemiche sardo-corso-baleariche Bellium belli<strong>di</strong>oides;;<br />
Endemiche sardo-nordafricane: Ferula arrigonii, Scilla obtusifolia ssp. obtusifolia;<br />
Entità <strong>di</strong> interesse fitogeografico: Anthyllis barba–jovis, Brassica insularis, Chamaerops humilis, Ephedra<br />
<strong>di</strong>stachya, Piptatherum caerulescens, Thymelaea tartonraira.<br />
Vegetazione<br />
Caratterizzazione fitosociologica<br />
La vegetazione naturale presente all’interno <strong>del</strong> Parco può essere sud<strong>di</strong>visa, in gran<strong>di</strong> linee, in due tipologie<br />
<strong>di</strong>stinte, <strong>di</strong>verse per caratteristiche ecologiche, per tipo <strong>di</strong> specie presenti (e quin<strong>di</strong> per inquadramento<br />
fitosociologico), ma soprattutto per la potenzialità. A loro volta queste due tipologie sono sud<strong>di</strong>visibili in<br />
comunità (associazioni) vegetali <strong>di</strong>stinte:<br />
Vegetazione azonale: comunità psammofile, alo-rupicole, alofile e igrofile.<br />
Vegetazione seriale: comunità erbacee, camefitiche, arbustive e forestali che tendono <strong>di</strong>namicamente verso<br />
comunità forestali (vegetazione potenziale naturale <strong>del</strong> Parco);<br />
VEGETAZIONE STAGNALE<br />
1 - Vegetazione fanerogamica sommersa<br />
Vegetazione fanerogamica sommersa <strong>del</strong>le acque salmastre a sviluppo invernale-primaverile, inclusi gli stagni<br />
salati retrodunali a completo <strong>di</strong>sseccamento estivo. Dominate da specie <strong>di</strong>verse <strong>del</strong> genere Ruppia, queste<br />
comunità presentano una <strong>di</strong>versa composizione floristica a seconda <strong>del</strong> regime idrico (stagni permanenti o<br />
stagionali), <strong>del</strong>la salinità e <strong>del</strong>la profon<strong>di</strong>tà <strong>del</strong>le acque.<br />
2 - Vegetazione alofita annuale<br />
Lungo i bor<strong>di</strong> degli stagni, nelle depressioni più interne, nelle radure <strong>del</strong>la vegetazione alofila perenne, in aree<br />
a prolungata inondazione e successivo prosciugamento estivo, sono presenti comunità pioniere <strong>di</strong> terofite
alofile. Analoghe comunità si rinvengono su substrati drenanti, sabbiosi o limosi, costantemente asciutti o mai<br />
inondati.<br />
L’associazione Suaedo maritimae- salicornietum patulae perime<strong>di</strong>terranea è stata rinvenuta nelle depressioni<br />
retrodunali e lungo le rive <strong>del</strong>lo Stagno <strong>di</strong> Calich. Occupa i substrati leggermente più elevati rispetto alle altre<br />
formazioni terofitiche alofile e quin<strong>di</strong> più secchi in estate e presumibilmente più salati.<br />
Il Salicornietum emerici è un’associazione monospecifica a Salicornia emerici che si sviluppa in aree<br />
lungamente inondate aperte al mare, che rimangano debolmente umide anche in estate. E’ presente nelle<br />
zone marginali, leggermente depresse, <strong>del</strong>lo Stagno <strong>di</strong> Calich, a contatto con formazioni elofitiche subalofile e<br />
con la vegetazione camefitica <strong>del</strong>l’associazione Puccinellio festuciformis-Sarcocornietum fruticosae.<br />
Ai bor<strong>di</strong> <strong>del</strong>lo Stagno <strong>del</strong> Calich, su suoli argilloso-sabbiosi d’accumulo, ari<strong>di</strong> in estate e sottoposti a<br />
pascolamento e calpestio, si sviluppano pratelli terofitici, subnitrofili, a fioritura primaverile, dominati da<br />
Hordeum marinum, Polypogon monspeliensis e Spergularia salina (formando l’associazione Spergulario<br />
salinae-hordeetum marini), generalmente in mosaico con le formazioni perenni <strong>del</strong>la classe Salicornietea<br />
fruticosae.<br />
3 Vegetazione alofita emicriptofitica<br />
Su suoli costantemente umi<strong>di</strong>, perio<strong>di</strong>camente inondati, si rinvengono tre tipi <strong>di</strong> comunità, dominate da<br />
emicriptofite e geofite, che marcano la variazione <strong>del</strong> gra<strong>di</strong>ente <strong>di</strong> salinità, al passaggio dalla zona <strong>di</strong> comunità<br />
francamente alofile a quelle alotolleranti. Tra <strong>di</strong> esse lo Scirpo-juncetum subulati su suoli allagati in inverno ma<br />
asciutti in estate, con conseguente innalzamento <strong>del</strong>la salinità, che si sviluppano in giuncheti, a composizione<br />
paucispecifica, in cui domina Juncus subulatus. Questa comunità è stata rinvenuta nelle depressioni<br />
peristagnali <strong>del</strong>lo Stagno <strong>di</strong> Calich. In con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> maggiore salinità ed eventuale <strong>di</strong>sseccamento estivo più<br />
prolungato, si evidenzia la subass. a Sarcocornia fruticosa.<br />
La comunità a Inulo-Juncetum maritimi, dominata fisionomicamente da Juncus maritimus, è situata nelle<br />
depressioni retrodunali ad allagamento prolungato, su suoli sabbiosi, umi<strong>di</strong> anche in estate. Si rinviene<br />
spora<strong>di</strong>camente sulle sponde <strong>del</strong>lo Stagno <strong>di</strong> Calich, in modo frammentario, mentre esempi migliori si hanno<br />
nelle depressioni retrodunali umide <strong>del</strong> cordone dunale <strong>di</strong> Maria Pia, in particolare in corrispondenza<br />
<strong>del</strong>l’attuale rotatoria stradale, un tempo sede <strong>di</strong> un ulteriore sbocco a mare <strong>del</strong>la laguna. Questa comunità è<br />
presente anche ai margini <strong>di</strong> una palude dulciacquicola retrostante il litorale <strong>di</strong> Mugoni, tra la villa omonima e<br />
la villa romana <strong>di</strong> Sant’Imbenia. Talvolta nello stagno <strong>di</strong> Calich all’associazione si accompagnano nuclei <strong>di</strong><br />
Spartina juncea.<br />
4 Vegetazione alofita camefitica<br />
Solitamente nelle zone umide salmastre la <strong>di</strong>stribuzione spaziale <strong>del</strong>le associazioni permette <strong>di</strong> evidenziare la<br />
variazione <strong>del</strong> gra<strong>di</strong>ente <strong>di</strong> salinità. La quasi totale assenza <strong>di</strong> tale gra<strong>di</strong>ente nello Stagno <strong>di</strong> Calich è<br />
probabilmente dovuta alla omogeneità chimico-fisica (salinità costante al 31-32‰) e strutturale <strong>del</strong>la laguna,<br />
notevolmente semplificata dagli interventi antropici <strong>del</strong> XX secolo.<br />
Su suoli limoso-sabbiosi, raramente soggetti ad allagamento, dei margini <strong>del</strong>le depressioni e <strong>del</strong>le bordure dei<br />
canali, a quote leggermente più elevate rispetto alle altre formazioni che costituiscono le praterie alofile, si<br />
rinviene la vegetazione dominata da Halimione portulacoides, abbondante lungo le sponde <strong>del</strong>lo Stagno <strong>di</strong><br />
Calich, dove viene pascolata.<br />
L’associazione dominata da Arthrocnemum macrostachyum occupa i livelli me<strong>di</strong>o-alti <strong>del</strong>le depressioni salate,<br />
su suoli argillosi umi<strong>di</strong> in inverno ma asciutti in estate dove risulta legata a terreni sempre iperalini, situati ad<br />
una quota me<strong>di</strong>a inferiore rispetto all'associazione precedente.
I livelli me<strong>di</strong>o-bassi <strong>del</strong>le depressioni salate, su suoli argillosi iperalini, umi<strong>di</strong> anche in estate sono occupati<br />
dall’associazione più <strong>di</strong>ffusa nel litorale <strong>del</strong>la Nurra, il Puccinellio festuciformis- Sarcocornietum fruticosae,<br />
dove si rinviene in stagni, depressioni retrodunali e vasche <strong>del</strong>le saline. L’associazione risulta spesso priva<br />
<strong>del</strong>la specie <strong>di</strong>fferenziale Puccinellia. festuciformis che si rinviene in una popolazione costituita da pochissimi<br />
in<strong>di</strong>vidui nella sponda destra idrografica <strong>del</strong> Calich.<br />
5. Vegetazione fluviale e stagnale <strong>del</strong>le acque dolci<br />
Sulle sponde dei corsi d’acqua immissari <strong>del</strong>lo Stagno <strong>di</strong> Calich e in una palude dulciacquicola retrostante il<br />
litorale <strong>di</strong> Mugoni, tra la villa omonima e la villa romana <strong>di</strong> Sant’Imbenia, si sviluppano comunità vegetali legate<br />
ad acque lente o ferme, dolci o debolmente salate, eutrofiche. Si tratta <strong>di</strong> formazioni <strong>di</strong> elofite, geofite ed<br />
emicriptofite (fragmiteti, tifeti, cariceti e scirpeti) che si sviluppano con apparato ipogeo totalmente sommerso<br />
per buona parte <strong>del</strong>l’anno. Sulle sponde dei corpi idrici si stabiliscono comunità forestali a pioppi, salici e olmi,<br />
talora tamerici, legate ai corsi d’acqua dolce.<br />
Attualmente tutte queste comunità vegetali sono notevolmente regre<strong>di</strong>te, talora <strong>del</strong> tutto scomparse, a causa<br />
<strong>del</strong>l’errata gestione <strong>del</strong>lo stagno, <strong>del</strong>le aree palustri e degli immissari fluviali. Infatti nello stagno sono<br />
totalmente scomparse le comunità d’acqua dolce, a vantaggio <strong>di</strong> quelle alofile e subalofile, mentre le sponde<br />
dei fiumi sono gestite come canali, limitando lo spazio per la vegetazione naturale. L’area più importante per<br />
queste comunità, è costituita da una palude dulciacquicola retrostante il litorale <strong>di</strong> Mugoni, tra la villa omonima<br />
e la villa romana <strong>di</strong> Sant’Imbenia, purtroppo sconosciuta ai più.<br />
Il Phragmitetum communis è l’unico tipo <strong>di</strong> vegetazione d’acqua dolce ormai rimasto nello stagno <strong>di</strong> Calich,<br />
presente anche in una palude dulciacquicola retrostante il litorale <strong>di</strong> Mugoni, tra la villa omonima e la villa<br />
romana <strong>di</strong> Sant’Imbenia. I tifeti risultano attualmente completamente scomparsi, mentre i fragmiteti sono molto<br />
ridotti <strong>di</strong> superficie rispetto al passato e alterati dalla presenza <strong>di</strong> Arundo donax, canna comune che tende a<br />
sostituire la cannuccia <strong>di</strong> palude, Phragmites australis.<br />
In una depressione retrostante il litorale <strong>di</strong> Mugoni, tra la villa omonima e la villa romana <strong>di</strong> Sant’Imbenia, è<br />
sopravvissuta una palude dulciacquicola <strong>di</strong> notevole valore <strong>ambientale</strong>. Si tratta <strong>di</strong> uno dei pochi esempi<br />
rimasti nella Sardegna settentrionale <strong>di</strong> palude ad acque dolci o solo debolmente salmastre, perennemente<br />
allagata, con una copertura vegetale densa, dominata da Carex otrubae e Calystegia saepium, alle quali si<br />
accompagnano Phragmites australis, Typha sp., Juncus sp. e <strong>di</strong>verse altre specie perenni <strong>del</strong>le palu<strong>di</strong> dolci. Il<br />
sito, <strong>di</strong> cui si allega la mappa è l’unica vera palude <strong>del</strong> Parco.<br />
VEGETAZIONE DUNALE<br />
1 – La vegetazione psammofila terofitica alo-nitrofila<br />
La vegetazione psammofila terofitica alo-nitrofila è costituita da comunità annuali che crescono sulla zona<br />
<strong>del</strong>la spiaggia inondata in inverno, sulla quale le mareggiate lasciano consistenti depositi <strong>di</strong> sostanza<br />
organica, soprattutto resti <strong>di</strong> Posidonia oceanica (L.) Delile.<br />
L’associazione Salsolo kali-Kakiletum maritimae è costituita da piante annuali effimere, propria <strong>del</strong>la prima<br />
parte <strong>del</strong>la spiaggia emersa; <strong>di</strong>ffusa su tutte le coste <strong>del</strong> Me<strong>di</strong>terraneo, sui litorali <strong>del</strong> Parco è presente in<br />
maniera spora<strong>di</strong>ca e frammentata nella spiaggia <strong>di</strong> <strong>Porto</strong> <strong>Conte</strong> e a Porticciolo, a causa <strong>del</strong>la pulizia<br />
meccanica dei litorali. Per lo stesso motivo risulta assente a Lazzaretto.<br />
2 - Vegetazione psammofila geofisica ed emicriptofitica<br />
Comunità perenni dominate da piante specializzate, ascrivibili alle medesime unità superiori <strong>di</strong> vegetazione<br />
(Euphorbio paraliae-Ammophiletea australis), ma occupanti ambienti ecologicamente <strong>di</strong>versi, influenzati da un<br />
gra<strong>di</strong>ente decrescente <strong>di</strong> salinità e uno crescente <strong>di</strong> evoluzione <strong>del</strong>la duna e lontananza dal mare, nonché
dalla <strong>di</strong>versa granulometria <strong>del</strong> substrato. Sia le singole comunità che la seriazione risultano molto alterate nei<br />
litorali stu<strong>di</strong>ati, a causa <strong>del</strong>la destrutturazione dei sistemi dunali indotta dal massiccio afflusso turistico estivo e<br />
dagli usi ad esso collegati.<br />
3 - Vegetazione psammofila camefitica<br />
Si tratta <strong>di</strong> garighe primarie che si sviluppano nei settori più interni, sul lato continentale <strong>del</strong>la duna, con sabbie<br />
stabili e compatte, <strong>del</strong>le cosidette dune grigie. Sono cenosi estremamente vulnerabili in seguito alla<br />
destrutturazione <strong>del</strong>la duna bianca e oltremodo pregiate, in quanto caratterizzate da entità fitogeograficamente<br />
rilevanti come Anchusa sardoa, Anchusa crispa, Echium sabulicolum, Helichrysum italicum ssp. microphyllum<br />
ed Ephedra <strong>di</strong>stachya, oltre che Crucianella maritima. Nell’area <strong>del</strong> Parco sono state in<strong>di</strong>viduate quattro<br />
comunità. Tra <strong>di</strong> esse l’associazione Cruccianello-Helichrysetum microphylli si rinviene sulle superfici<br />
retrodunali <strong>del</strong>la spiaggia <strong>di</strong> Porticciolo, su sabbie fini, stabili e relativamente umide. Si presenta ricca in<br />
nanofanerofite, che in<strong>di</strong>cano il contatto catenale con forme più evolute <strong>del</strong>la macchia retrodunale, inquadrabili<br />
nella subass. thymelaeetosum tartonrairae. Da evidenziare inoltre la comunità a Scrophulario-Helichrysetum<br />
microphylli in<strong>di</strong>viduata nell’area <strong>del</strong> Parco solo durante il 2010. Occupa affioramenti <strong>di</strong> arenaria nell’entroterra<br />
compreso tra Cala Viola e <strong>Porto</strong> Ferro. Sebbene si rinvenga a <strong>di</strong>verse centinaia <strong>di</strong> metri dal mare, le sue<br />
esigenze ecologiche tipicamente psammofile vengono rispettate dal substrato sul quale si è inse<strong>di</strong>ata. Oltre<br />
alle due specie endemiche caratterizzanti (Helichrysum microphyllum subsp. tyrrhenicum, Scrophularia<br />
ramosissima), sono presenti <strong>di</strong>verse altre camefite d’interesse fitogeografico dei generi Teucrium, Ajuga e<br />
Fumana. A mosaico con questa comunità camefitica, a bassa copertura, si sviluppano i pratelli annuali<br />
caratterizzati dalla presenza <strong>del</strong>la specie d’interesse comunitario Linaria flava subsp. sardoa.<br />
4 Vegetazione psammofila terofitica<br />
A mosaico con i tipi <strong>di</strong> vegetazione perenne <strong>del</strong>le dune embrionali, mobili e fisse <strong>del</strong> litorale, si rinvengono<br />
comunità terofitiche a fenologia tardo invernale-primaverile come il Senecioni leucanthemifolii-matthioletum<br />
tricuspidatae, un’associazione aeroalina, che nell’area stu<strong>di</strong>ata cresce nella sommità <strong>di</strong> dune a substrato<br />
grossolano nella spiaggia <strong>del</strong> Porticciolo esposte all’aerosol marino, su superfici interessate da perio<strong>di</strong>che<br />
attività <strong>di</strong> pascolo estensivo, nonché su sfatticcio in terrazzi <strong>di</strong> falesie raggiunte dagli spruzzi marini. In base<br />
alla composizione floristica e alla rarità <strong>del</strong>la cenosi, quin<strong>di</strong> al suo valore naturalistico per la Corsica, Géhu &<br />
Bion<strong>di</strong> (1994a) ne propongono l’inserimento nel libro rosso <strong>del</strong>le fitocenosi litorali <strong>del</strong>la Francia. Un aspetto<br />
nitrofilo <strong>del</strong>l’associazione caratterizzato dalla presenza <strong>del</strong>l’endemica Anchusa crispa ssp. crispa, specie<br />
prioritaria ai sensi <strong>del</strong>la Direttiva Habitat (All. II), permette <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenziare la subass. anchusetosum crispae.<br />
Questa comunità si sviluppa preferibilmente alla base <strong>del</strong>le dune, nel versante continentale protetto<br />
dall’aerosol marino, dove per gravità arrivano maggiori quantità <strong>di</strong> detriti organici. La sua <strong>di</strong>stribuzione<br />
nell’area <strong>del</strong> Parco, esclusivamente nella spiaggia <strong>di</strong> Porticciolo, coincide con quella <strong>di</strong> Anchusa crispa ssp.<br />
crispa che appare legata alle vie nitrofile annuali <strong>del</strong>le dune (Géhu & Géhu-Franck, 1985), a forte<br />
determinismo antropico, caratterizzate dall’impoverimento <strong>del</strong>le specie caratteristiche <strong>del</strong>l’or<strong>di</strong>ne<br />
Malcolmietalia e costante penetrazione <strong>di</strong> specie nitrofile <strong>del</strong>l’or<strong>di</strong>ne Brometalia rubenti-tectorum (Para<strong>di</strong>s,<br />
1990).<br />
L’associazione Hypecooprocumbentis-Silenetumnummicae è caratterizzata da terofite prostrate e dominata da<br />
Hypecoum procumbens e da Silene nummica (Valsecchi, 1995), occupa superfici sabbiose piatte, compattate<br />
dal calpestio. Si tratta <strong>di</strong> una comunità subnitrofila, terofitica, a sviluppo tardo invernale, particolarmente<br />
comune nei luoghi a<strong>di</strong>biti, nella stagione estiva, a parcheggi, campeggi e transito pedonale da e verso le<br />
spiagge. Anche la fenologia <strong>del</strong>le specie che la caratterizzano è ben adattata alla <strong>di</strong>versa presenza <strong>del</strong>l'uomo<br />
nel <strong>territorio</strong> durante l’anno: la fioritura avviene tra la fine <strong>del</strong>l’inverno e l’inizio <strong>del</strong>la primavera, mentre la
fruttificazione si completa entro il mese <strong>di</strong> maggio. La presenza <strong>di</strong> S. nummica e H. procumbens, sembra<br />
essere favorita dal calpestio (Bion<strong>di</strong> et al., 2001).<br />
5 Vegetazione psammofila fanerofitica<br />
La successione <strong>del</strong>le comunità che colonizzano le sabbie dei sistemi dunali si chiude con la formazione <strong>di</strong><br />
macchie a ginepro prevalentemente Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa ma talvolta con esemplari <strong>di</strong> J.<br />
turbinata. La vegetazione forestale psammofila, sulle dune <strong>di</strong> <strong>Porto</strong> <strong>Conte</strong>, era in passato costituita da<br />
boscaglie a Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa. I rimboschimenti a Pinus sp. pl. effettuati nel sito hanno<br />
eliminato quasi completamente l’originaria copertura forestale: attualmente rimangono pochi in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong><br />
ginepro coccolone che andrebbero salvaguardati e propagati per la ricostituzione <strong>del</strong> ginepreto potenziale su<br />
duna. Nei restanti sistemi dunali <strong>del</strong> Parco (Lazzaretto e Porticciolo) l’associazione è assente per cause<br />
naturali, relative alla piccola estensione <strong>del</strong>le dune.<br />
VEGETAZIONE DELLE FALESIE<br />
Le caratteristiche litologiche e geomorfologiche <strong>del</strong>le falesie, la loro esposizione, il tipo <strong>di</strong> degradazione e la<br />
micromorfologia, la possibilità d’accumulo <strong>di</strong> detriti e <strong>di</strong> suolo con<strong>di</strong>zionano l’instaurarsi <strong>del</strong>la vegetazione<br />
casmofitica aeroalina e <strong>di</strong>versamente alo-tollerante dalle formazioni terofitiche a quelle <strong>di</strong> gariga e <strong>di</strong> macchia.<br />
La falesia deve quin<strong>di</strong> considerarsi come un insieme <strong>di</strong> microhabitat variamente con<strong>di</strong>zionati dai fattori<br />
ecologici che vengono evidenziati dalla presenza <strong>del</strong>le <strong>di</strong>verse comunità vegetali.<br />
1 Vegetazione casmofitica aeroalina<br />
La vegetazione raggiunta <strong>del</strong>l’aerosol marino che si sviluppa nelle fessure <strong>del</strong>le rocce è ben rappresentata su<br />
tutte le coste <strong>del</strong>la Nurra, con caratteristiche <strong>di</strong>fferenti tra i <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> substrato.<br />
Limonium nymphaeum, <strong>di</strong>ffusa sulle coste calcaree comprese tra Alghero e Capo Caccia costituite<br />
prevalentemente da rocce carbonatiche, caratterizza l’associazione Crithmo maritimi-Limonietum nymphaei,<br />
esclusivamente calcicola. Nelle zone più elevate <strong>del</strong>la falesie <strong>di</strong> Capo Caccia l’associazione viene a contatto<br />
con specie <strong>del</strong>la classe Parietarietea judaicae, come evidenziato dalla subass. seselietosum praecocis. Sulle<br />
arenarie eoliche a cemento calcitico <strong>di</strong> Porticciolo e Cala Viola, a seguito <strong>di</strong> fenomeni erosivi, si forma un<br />
substrato detritico sottoposto a nitrificazione antropozoogena, sul quale l’associazione Crithmo maritimi-<br />
Limonietum nymphaei viene a contatto con le garighe nitrofile a C. monspeliaca originando la nuova subass.<br />
camphorosmetosum monspeliacae.<br />
2 Vegetazione casmofitica<br />
Le zone più elevate <strong>del</strong>le falesie <strong>di</strong> Punta Giglio e Capo Caccia sono raggiunte da vento meno carico <strong>di</strong><br />
aerosol marino per cui la vegetazione che le colonizza perde il carattere francamente alofilo. Si possono<br />
quin<strong>di</strong> rilevare aspetti <strong>di</strong> vegetazione rupicola da riferire alla classe Parietarietea judaicae.<br />
L’associazione Brassico insularis-Seselietum praecocis, che si sviluppa sulle parti più elevate <strong>del</strong>le falesie<br />
calcaree <strong>di</strong> Capo Caccia su pareti ripide, ampiamente soleggiate ad esposizione est e sud-est, è<br />
caratterizzata dall’endemica sardo-corsa Seseli bocconi subsp. praecox, entità rupicola che vive sia sulle<br />
coste sia sulle pareti rocciose interne <strong>del</strong>la Sardegna, sino a circa 1500 m <strong>di</strong> altitu<strong>di</strong>ne (Diana, 1980) e dalla<br />
specie d’interesse comunitario Brassica insularis (Greuter et al., 1986) anch’essa presente in Sardegna nei<br />
settori costieri e sulle rupi interne anche a quote elevate.<br />
3 Garighe camefitiche subalofile<br />
Nella zona <strong>di</strong> cerniera tra la vegetazione alofila <strong>del</strong>la falesia con quella <strong>del</strong>la macchia o dei suoi aspetti<br />
sostitutivi, si sviluppa una gariga primaria o subprimaria, permanente e specializzata, caratterizzata da
camefite pulvinanti alotolleranti con alta percentuale <strong>di</strong> endemismi. Il recupero <strong>del</strong>la vegetazione forestale ha<br />
determinato la forte riduzione nell’estensione <strong>di</strong> queste comunità nelle aree <strong>del</strong> Parco rispetto a quanto<br />
evidenziato in articoli apparsi alcuni decenni orsono.<br />
Di particolare rilievo la specie prioritaria Centaurea horrida è pulvinante, spinosa, endemica <strong>del</strong>la Sardegna<br />
dove è presente solo in aree limitate dei settori nord-occidentali: isola <strong>del</strong>l’Asinara, penisola <strong>di</strong> Stintino,<br />
promontorio <strong>di</strong> Capo Caccia e, nel settore nord-orientale, l’isola <strong>di</strong> Tavolata. La vegetazione dominata da C.<br />
horrida forma garighe che uniscono le parti sommitali <strong>del</strong>la falesia con la prima porzione dei territori interni<br />
ancora raggiunti <strong>di</strong>rettamente dai venti marini, sempre su substrati rocciosi, fino a collegarsi con la macchia<br />
<strong>del</strong>la classe Quercetea ilicis. Questa vegetazione si inquadra nell’associazione Centaureetum horridae<br />
descritta da Molinier & Molinier (1955) per Stintino. Alcuni aspetti pionieri, su falesie più ventose, in<strong>di</strong>cano il<br />
contatto con la vegetazione casmofitica alofila in<strong>di</strong>viduabile per la presenza <strong>di</strong> specie <strong>del</strong>la classe Crithmo-<br />
Limonietea. In particolare per le alte falesie <strong>di</strong> Cala <strong>del</strong>la Barca a Capo Caccia è riconoscibile la subass.<br />
limonietosum nymphaei. Le situazioni <strong>di</strong> maggiore evoluzione floristica e strutturale <strong>del</strong>l’associazione sono<br />
invece in<strong>di</strong>cate dalla presenza <strong>di</strong> Astragalus terraccianoi, arbusto spinoso pulvinante endemico sardo-corso .<br />
Sulla testa <strong>del</strong>la falesia calcarea e nelle zone esposte al vento, sempre presso Cala <strong>del</strong>la Barca e Marina <strong>di</strong><br />
Lioneddu si sviluppa una densa popolazione <strong>di</strong> Genista sardoa la quale, mentre nel settore più interno va a<br />
dare origine all’associazione Rosmarino officinalis-Genistetum sardoae, nella parte più esposta verso il mare<br />
si collega all’associazione Centaureetum horridae, <strong>del</strong>la quale va a <strong>di</strong>fferenziare la subass. genistetosum<br />
sardoae, poco <strong>di</strong>ffusa ma <strong>di</strong> elevato valore naturalistico in quanto rappresenta una fitocenosi ricca <strong>di</strong><br />
endemismi e con una precisa caratterizzazione ecologica e sin<strong>di</strong>namica.<br />
Sui calcari mesozoici, in aree sottoposte a vincoli <strong>di</strong> protezione, la vegetazione a C. horrida è decisamente<br />
regre<strong>di</strong>ta, occupando una fascia limitata ai versanti <strong>di</strong> depressioni carsiche nelle quali si sviluppa attualmente<br />
la vegetazione forestale edafica e xerofila. C. horrida si spinge oltre il limite <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffusione <strong>del</strong>l’associazione<br />
penetrando, internamente e nelle zone più elevate, nelle garighe secondarie a Genista corsica<br />
<strong>del</strong>l’associazione Stachy<strong>di</strong> glutinosae-Genistetum corsicae.<br />
Descritta per l’isola <strong>di</strong> La Maddalena nella Sardegna nord-orientale (Bion<strong>di</strong>, 1992), l’associazione Euphorbio<br />
pithyusae-Helichrysetum microphylli, endemica sardo-corsa, inquadra formazioni subprimarie <strong>di</strong> gariga<br />
pioniera su suoli iniziali o erosi. Nell’area <strong>del</strong> Parco si rinviene in zone anche interne, precedendo la<br />
costituzione <strong>di</strong> formazioni forestali o preforestali a ginepro. Nella Nurra <strong>di</strong> Alghero l’associazione sostituisce il<br />
Centaureetum horridae su depositi marnosi o paleosuoli placcati su substrato roccioso, originando contatti<br />
topografici con associazioni <strong>del</strong>la classe Crithmo-Limonietea: gli aspetti <strong>di</strong> transizione tra queste comunità<br />
vengono evidenziati dalla subassociazione limonietosum nymphaei.<br />
VEGETAZIONE DEI TERRITORI INTERNI<br />
Oltre la linea costiera nel <strong>territorio</strong> si sviluppano le comunità vegetali che partecipano a definire il paesaggio<br />
vegetale <strong>del</strong> Parco, che vengono presentate raggruppate in funzione <strong>del</strong>le loro caratteristiche fisionomicostrutturali.<br />
1 Vegetazione terofitica<br />
La vegetazione terofitica è rappresentata da comunità pioniere che si localizzano nelle radure <strong>del</strong>la<br />
vegetazione a Juniperus turbinata e <strong>del</strong>le formazioni forestali, oltre che nelle garighe <strong>di</strong> degradazione.<br />
Nei settori calcarei le radure <strong>del</strong>la macchia sono occupate da una comunità terofitica dominata da varie specie<br />
<strong>di</strong> Leguminosae, fra le quali per frequenza e copertura prevale Scorpiurus muricatus. Questa cenosi a<br />
prevalenza <strong>di</strong> specie euri- e stenome<strong>di</strong>terranee, è <strong>di</strong>fferenziata geograficamente da Bupleurum fontanesii. È
iferita all’associazione Bupleuro fontanesii-Scorpiuretum muricati, pioniera su terre rosse in tasche <strong>di</strong> suolo<br />
pianeggianti <strong>del</strong>le zone calcaree costiere <strong>del</strong>la Nurra<br />
2 Vegetazione emicriptofitica<br />
Sui depositi argilloso-limosi placcati sul substrato roccioso, nelle zone <strong>del</strong>le falesie, ricche in nitrati per attività<br />
antropozoogena, e sui suoli argillosi profon<strong>di</strong> dei depositi alluvionali si inse<strong>di</strong>ano tipi <strong>di</strong>versi <strong>di</strong> vegetazione<br />
erbacea perenne che comprendono formazioni emicriptofitiche, subnitrofile e talvolta subalofile che<br />
appartengono alle associazioni <strong>di</strong> seguito in<strong>di</strong>cate.<br />
Gli aspetti più xerofili <strong>del</strong>la vegetazione emicriptofitica sono rappresentati da praterie a Brachypo<strong>di</strong>um<br />
ramosum, presenti in maniera <strong>di</strong>scontinua sui calcari mesozoici dove si originano mosaici con le formazioni<br />
<strong>del</strong>la gariga e <strong>del</strong>la macchia, su suoli detritici poco ricchi in argilla. Si tratta <strong>di</strong> un tipo <strong>di</strong> vegetazione attribuibile<br />
all’associazione Aspho<strong>del</strong>o microcarpi-Brachypo<strong>di</strong>etum ramosi. Sulle pen<strong>di</strong>ci <strong>del</strong> M. Doglia questa<br />
vegetazione è inoltre presente nella subass. ononidetosum minutissimae, che rappresenta uno sta<strong>di</strong>o <strong>di</strong><br />
transizione verso le formazioni <strong>di</strong> gariga. Gli esempi meglio conservati <strong>di</strong> queste comunità rimangono<br />
soprattutto nelle fasce tagliafuoco, quando gestite con l’abbruciamento e lo sfalcio.<br />
Nella penisola <strong>di</strong> Capo Caccia nelle tasche dei calcari mesozoici, ripiene <strong>di</strong> terra rossa con elevato contenuto<br />
<strong>di</strong> argilla, sono presenti praterie emicriptofitiche <strong>di</strong>scontinue secondarie o subprimarie. Sono caratteristiche<br />
<strong>del</strong>l’associazione Kundmannia sicula e Anthyllis vulneraria, tra le specie più frequenti si rinvengono Dianthus<br />
sylvestris e Iris sisyrinchium. L’associazione è più costiera <strong>del</strong>l’associazione Aspho<strong>del</strong>o microcarpi-<br />
Brachypo<strong>di</strong>etum ramosi e si rinviene sempre su terre rosse, su superfici pianeggianti, in contatto seriale con la<br />
vegetazione terofitica <strong>del</strong>l’associazione Bupleuro fontanesii-Scorpiuretum muricati.<br />
L’associazione Loto cytisoi<strong>di</strong>s-dactyletum hispanicae inquadra le praterie che si rinvengono sulle siltiti rosse<br />
con granulometria fine e con una buona capacità <strong>di</strong> ritenzione idrica, intercalate alle arenarie nelle località <strong>di</strong><br />
Porticciolo e Cala Viola. Si tratta <strong>di</strong> formazioni emicriptofitiche, dense, dominate da Dactylis hispanica e Lotus<br />
cytisoides, alla cui composizione floristica partecipano numerose geofite tra cui Iris sisirynchium e le<br />
endemiche Crocus minimus e Pancratium illyricum, che <strong>di</strong>fferenziano un aspetto più igrofilo <strong>del</strong>la comunità,<br />
in<strong>di</strong>cato dalla subass. iridetosum sisyrinchii.<br />
Nel Parco le praterie <strong>del</strong>le zone interne, su suoli alluvionali, sono caratterizzate da emicriptofite e geofite a<br />
fenologia autunnale e tardo-invernale, fra le quali dominano Bellis sylvestris, Ambrosinia bassii e Anemone<br />
hortensis. Questa combinazione floristica peculiare, determinata da specie a prevalente <strong>di</strong>stribuzione<br />
me<strong>di</strong>terraneo-occidentale, permette <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare l’associazione Scillo obtusifoliae-Bellidetum sylvestris, <strong>del</strong>la<br />
quale sono specie caratteristiche Scilla obtusifolia, Urginea undulata, Ranunculus bullatus, Ornithogalum<br />
corsicum e Salvia verbenaca.<br />
3 Vegetazione camefitica e nanofanerofitica<br />
Nel <strong>territorio</strong> <strong>del</strong>la Nurra, come sulla gran parte <strong>di</strong> quello me<strong>di</strong>terraneo, sono presenti garighe secondarie che<br />
derivano principalmente dall’uso tra<strong>di</strong>zionale <strong>del</strong> fuoco nelle pratiche agro-pastorali.<br />
Il Rosmarino officinalis-Thymelaeetum tartonrairae è caratterizzata dalla presenza <strong>di</strong> Thymelaea tartonraira,<br />
Rosmarinus officinalis, Cistus salvifolius e Helichrysum microphyllum, quest’associazione costituisce garighe<br />
primarie nelle zone più elevate ma pianeggianti <strong>del</strong> sistema <strong>del</strong>le dune consolidate che ricoprono il substrato<br />
roccioso.<br />
Nei settori calcarei <strong>del</strong>la Nurra Valsecchi in<strong>di</strong>vidua un aggruppamento camefitico a Dorycnium pentaphyllum<br />
legato <strong>di</strong>namicamente alle formazioni boschive <strong>del</strong> Quercion ilicis. Attualmente nei calcari interni (M. Doglia) è<br />
presente una formazione camefitica e nanofanerofitica, affine a quella riportata da Valsecchi, dominata da<br />
Cistus eriocephalus, Dorycnium pentaphyllum e Ononis minutissima. Questa cenosi richiama anche un altro
aggruppamento camefitico, a Fumana laevipes, Carex flacca ssp. serrulata (sub Carex cuspidata Auct. an<br />
Host) e Phagnalon rupestre, riportato da Valsecchi: in entrambe le tabelle è presente O. minutissima, camefita<br />
<strong>di</strong> piccola taglia che raccorda la prateria a Brachypo<strong>di</strong>um ramosum (Aspho<strong>del</strong>o microcarpi-Brachypo<strong>di</strong>etum<br />
ramosi ononidetosum minutissimae) con le formazioni camefitiche e nanofanerofitiche. L’associazione<br />
Dorycnio pentaphylli-Cistetum eriocephali, con la subass. tipo ononidetosum minutissimae, presenta contatti<br />
seriali con le macchie a Pistacia lentiscus e Chamaerops humilis nella serie <strong>del</strong>le leccete calcaree termofile<br />
(Prasio majoris-Querco ilicis chamaeropetosum humilis sigmetum).<br />
L’associazione Stachy<strong>di</strong> glutinosae-Genistetum corsicae è presente anche nella Sardegna nord-occidentale.<br />
Si rinviene a quote più elevate o in posizione più interna rispetto alle garighe alofile <strong>del</strong>l’associazione<br />
Centaureetum horridae, su creste esposte ai venti, ma non interessate dall’influsso <strong>del</strong>l’aerosol marino, su<br />
substrati rocciosi con suoli erosi. Sui calcari <strong>del</strong> Parco sono dominanti Genista corsica e Stachys glutinosa.<br />
La vegetazone a Genista sardoa è <strong>di</strong>ffusa soprattutto nella fascia costiera <strong>del</strong>la penisola <strong>di</strong> Capo Caccia (Cala<br />
<strong>del</strong>la Barca, Marina <strong>di</strong> Lioneddu), dove si inserisce, nelle zone più interne, negli sta<strong>di</strong> <strong>di</strong> degradazione <strong>del</strong>la<br />
macchia, mentre in quelli costieri va a contatto con le formazioni tipicamente camefitiche <strong>del</strong> Centaureetum<br />
horridae e va a sostituire le garighe secondarie <strong>del</strong>lo Stachy<strong>di</strong>-Genistetum corsicae con la subass.<br />
teucrietosum mari.<br />
Sulle arenarie viola <strong>del</strong> litorale da Porticciolo a <strong>Porto</strong> Ferro G. sardoa costituisce garighe che si raccordano<br />
<strong>di</strong>namicamente alle formazioni climaciche <strong>del</strong> Chamaeropo-Juniperetum turbinatae arbutetosum unedonis<br />
(ve<strong>di</strong> oltre). Queste garighe, più acidofile <strong>del</strong>le precedenti, sono <strong>di</strong>fferenziate da Cistus salvifolius, C.<br />
monspeliensis, Calicotome villosa ed Erica arborea.<br />
4 Vegetazione <strong>di</strong> macchia<br />
Gli sta<strong>di</strong> più evoluti <strong>del</strong>la macchia sono rappresentati da formazioni a Juniperus turbinata inquadrabili<br />
nell’or<strong>di</strong>ne Pistacio-Rhamnetalia alaterni, dense, alte 2-4 m, generalmente a contatto con le garighe che si<br />
rinvengono fino alla sommità <strong>del</strong>le falesie, al limite con la vegetazione aeroalina. La vegetazione a ginepro<br />
costituisce la testa <strong>di</strong> serie <strong>del</strong>le successioni <strong>di</strong>namiche sui calcari. In altre situazioni la macchia è secondaria<br />
in quanto partecipa, come vegetazione <strong>di</strong> sostituzione, alle serie <strong>di</strong>namiche <strong>del</strong>la vegetazione forestale a<br />
Quercus ilex, talvolta con Q. suber.<br />
La vegetazione a Juniperus turbinata e Chamaerops humilis, presente sui calcari mesozoici <strong>del</strong>la Nurra,<br />
<strong>di</strong>ffusa nel Parco. C. humilis è particolarmente <strong>di</strong>ffusa nella Nurra <strong>di</strong> Alghero dove svolge essenzialmente un<br />
ruolo pioniero. La prima fase <strong>di</strong> ricostituzione <strong>del</strong> ginepreto è infatti rappresentata da cenosi pure <strong>di</strong> C. humilis<br />
che successivamente si arricchiscono in Pistacia lentiscus. Stu<strong>di</strong> sulla <strong>di</strong>stribuzione spaziale <strong>del</strong>la vegetazione<br />
nella stessa area rivelano che queste due entità si associano dove, a causa <strong>del</strong> substrato roccioso, la<br />
copertura è più rada.<br />
Sulle arenarie quarzifere <strong>di</strong> Cala Viola e sulle sabbie eoliche <strong>del</strong> Lago <strong>di</strong> Baratz, su suoli più profon<strong>di</strong> ed umi<strong>di</strong><br />
<strong>del</strong>la terra rossa calcarea, questa associazione sviluppa contatti con l’associazione Erico-Arbutetum (ve<strong>di</strong><br />
oltre), <strong>di</strong> degradazione dei boschi a Quercus ilex, che negli ambienti costieri si rinvengono esclusivamente in<br />
vallecole nelle quali si realizza una certa compensazione edafica originando la subass. arbutetosum unedonis.<br />
Nell’ambito <strong>di</strong> questa subass. è in<strong>di</strong>viduabile una fase regressiva postincen<strong>di</strong>o, evidenziata da Calicotome<br />
villosa.<br />
Una subass. rupestre, limitata alla Penisola <strong>di</strong> Capo Caccia, è caratterizzata da Anthyllis barba-jovis ed<br />
Euphorbia dendroides. A. barba-jovis, presente in Sardegna unicamente in questo sito e nell’isola <strong>di</strong> Bu<strong>del</strong>li,<br />
Arcipelago <strong>del</strong>la Maddalena, partecipa a formazioni riferibili all’or<strong>di</strong>ne Pistacio-Rhamnetalia alaterni anche in<br />
altre aree costiere <strong>del</strong> Me<strong>di</strong>terraneo.
L’associazione Pistacio-Chamaeropetum humilis, <strong>di</strong>ffusa nel settore calcareo costiero <strong>del</strong> Parco, rappresenta<br />
la fase regressiva sia <strong>del</strong>le formazioni forestali a Juniperus turbinata sui calcari costieri, dove sono evidenti<br />
contatti seriali con il Centaureetum horridae, sia <strong>di</strong> quelle a Quercus ilex dei calcari interni e <strong>del</strong>le zone<br />
pianeggianti costiere, dove in seguito alla degradazione <strong>del</strong>la macchia alta a Pistacia lentiscus, specialmente<br />
in seguito al passaggio <strong>del</strong> fuoco, si sviluppa una variante pioniera a Cistus monspeliensis. Il ruolo<br />
colonizzatore <strong>di</strong> P. lentiscus è particolarmente evidente in tutto il settore costiero <strong>del</strong>la Sardegna nordoccidentale<br />
dove svolge un ruolo non trascurabile nell’evoluzione <strong>del</strong>le formazioni vegetali più mature. Per la<br />
piattaforma carsica <strong>di</strong> Cala <strong>del</strong>la Barca stu<strong>di</strong> sulla <strong>di</strong>stribuzione spaziale evidenziano come P. lentiscus e<br />
Chamaerops humilis tendano a scomparire nelle zone a maggior grado <strong>di</strong> copertura. Sulle arenarie quarzifere<br />
<strong>di</strong> Cala Viola e su superfici pianeggianti presso Nuraghe Palmavera nei pressi <strong>di</strong> Alghero, con suoli più<br />
profon<strong>di</strong> ed aci<strong>di</strong> <strong>del</strong>la terra rossa calcarea circostante, in <strong>di</strong>namiche <strong>di</strong> recupero post-incen<strong>di</strong>o, è presente una<br />
variante acidofila in<strong>di</strong>cata dalla subass. calicotometosum villosae, in contatto seriale con il Chamaeropo-<br />
Juniperetum turbinatae arbutetosum unedonis.<br />
La regressione <strong>del</strong>le formazioni forestali <strong>del</strong>la piana alluvionale <strong>del</strong>la Nurra, su suoli potenti, porta alla<br />
costituzione <strong>di</strong> una cenosi nanofanerofitica <strong>di</strong> sostituzione, mesofila, caratterizzata da specie <strong>del</strong>l’or<strong>di</strong>ne<br />
Pistacio-Rhamnetalia ma <strong>di</strong>fferenziata, rispetto a formazioni più xerofile, da alcune specie arbustive<br />
caducifoglie <strong>del</strong>la classe Rhamno-Prunetea: Pyrus amygdaliformis e Crataegus monogyna. L’associazione<br />
proposta nella piana <strong>del</strong>la Nurra si può rinvenire in contatto catenale con formazioni più igrofile che si<br />
sviluppano lungo i fossi e che sono state recentemente riferite all’associazione Crataego monogynae-Pyretum<br />
amygdaliformis, la cui struttura è dominata da specie <strong>del</strong>la classe Rhamno-Prunetea.<br />
L’associazione Erico arboreae-Arbutetum unedonis, molto <strong>di</strong>ffusa su suoli aci<strong>di</strong> <strong>del</strong> settore metamorfico <strong>del</strong>la<br />
Nurra settentrionale, nel Parco si rinviene nelle zone interne retrostanti al litorale da Cala Viola a <strong>Porto</strong> Ferro,<br />
nonché in alcuni tratti <strong>del</strong>le formazioni calcaree su terre rosse lisciviate e decarbonatate (Monte Doglia, Monte<br />
Timidone).<br />
Questa fitocenosi, che in alcuni casi raggiunge il litorale per compensazione edafica, nelle aree pianeggianti<br />
costiere <strong>di</strong> solito prende contatto seriale con formazioni <strong>di</strong> gariga riferibili all’associazione Rosmarino<br />
officinalis-Genistetum sardoae nella subass. cistetosum salvifolii.<br />
5 Vegetazione forestale<br />
La vegetazione forestale che si sviluppa nei settori interni <strong>del</strong> Parco è principalmente rappresentata da cenosi<br />
relitte a dominanza <strong>di</strong> Quercus ilex che si <strong>di</strong>versificano in rapporto alle caratteristiche <strong>del</strong> substrato e alle<br />
con<strong>di</strong>zioni mesoclimatiche dei luoghi. Molto importanti anche le comunità potenziali a sughera, olivastro e i<br />
boschi riparali.<br />
La vegetazione forestale a olivastro è attualmente presente in maniera frammentaria soprattutto sui versanti<br />
meri<strong>di</strong>onali dei complessi calcarei mesozoici, in particolare Monte Doglia e Monte Timidone. Tuttavia,<br />
nonostante la sua attuale rarità, essa costituisce la testa <strong>di</strong> una serie edafo-xerofila e termofila che sarebbe<br />
molto <strong>di</strong>ffusa nel Parco se non fossero intervenuti tagli e incen<strong>di</strong> nei decenni passati.<br />
L’associazione Prasio majoris- Quercetum ilicis, nei settori calcarei e arenacei costieri <strong>del</strong>la Nurra, si rinviene<br />
localizzata nella Penisola <strong>di</strong> Capo Caccia (Foresta demaniale Prigionette: canale <strong>di</strong> Barinaldo) e P.ta Giglio,<br />
nel complesso <strong>di</strong> M. Doglia e a <strong>Porto</strong> Ferro. In questi luoghi la vegetazione in stu<strong>di</strong>o appare confinata in<br />
impluvi e su versanti con suolo evoluto e leggero surplus idrico, in esposizioni settentrionali e comunque<br />
riparate dai venti salsi. Questa formazione, attualmente in netta ripresa, si presenta ricca in specie<br />
<strong>del</strong>l’alleanza Oleo-Ceratonion.<br />
Agricoltura e paesaggi agrari
Sintesi<br />
Il paesaggio e la sua tutela sono assunti come strategie integrate <strong>di</strong> supporto allo sviluppo <strong>del</strong>l'attività agricola<br />
e al riconoscimento <strong>del</strong>l'alto valore <strong>del</strong>la multifunzionalità nel <strong>territorio</strong> <strong>del</strong> Parco e <strong>del</strong>l’area pre-parco.<br />
L’urgenza <strong>di</strong> affrontare la “questione rurale” -rapida contrazione <strong>di</strong> terre coltivate e attività connesse in tutte le<br />
aree rurali <strong>del</strong>l’UE- si desume, nell’Algherese come in altre aree a forte sviluppo turistico, già dal confronto tra<br />
la situazione <strong>del</strong> 1980 con quella <strong>del</strong> 2000 (Istat, in attesa dei dati 2010) qui sotto esemplificato attraverso<br />
alcuni sintetici in<strong>di</strong>catori:<br />
Uso <strong>del</strong> suolo 1980 2000 Variazione % (±)<br />
Terre agrarie 15.795 ettari 7.563 ettari - 52,1<br />
Prati e pascoli 6.088 ettari 1.840 ettari - 69,8<br />
Seminativi 5.547 ettari 3.390 ettari - 38,9<br />
Oliveti, 2.311 ettari 1.267 ettari - 45,2<br />
Vigneti, 1.730 ettari 942 ettari - 45,5<br />
Numero <strong>di</strong> capi bovini 1.589 767 - 51,7<br />
Numero <strong>di</strong> capi ovini 10.739 7.678 - 28,5<br />
Numero occupati in<br />
agricoltura<br />
1.551 970 -37,5<br />
Numerosità aziende<br />
agraria<br />
1.348 1.715 + 20,4<br />
Numerosità aziende<br />
olivicole<br />
718 1.129 + 57,2<br />
Numero case 14.086 23.632 + 67,8<br />
Il paesaggio, agricolo e rurale, è in continua evoluzione per la <strong>di</strong>namica comportamentale degli attori coinvolti,<br />
funzionale all’andamento <strong>del</strong> mercato globale <strong>del</strong>le derrate agricole. L’agricoltura algherese, dal Secondo<br />
Dopoguerra in costante declino per superfici occupate e addetti impegnati, è così passata da un’impronta<br />
zootecnico-cerealicola -dove la filiera <strong>del</strong>la bovinicoltura da latte risultava centrale- a una temporanea fase<br />
espansiva <strong>del</strong>l’ovino da latte per giungere negli ultimi anni a concentrarsi su viticoltura e olivicoltura. La tutela<br />
<strong>del</strong> paesaggio agricolo tra<strong>di</strong>zionale deve, quin<strong>di</strong>, svolgersi ottemperando le esigenze dei cambiamenti sociali<br />
ed economici con la conservazione <strong>di</strong> alcuni tratti storici fondamentali –un esempio tra tutti i segni <strong>del</strong>le due<br />
Riforme agrarie con l’appoderamento e la geometrica rete <strong>di</strong> canali e frangivento <strong>di</strong> eucalitti- senza limitare le<br />
scelte impren<strong>di</strong>toriali.<br />
La gestione integrata <strong>del</strong> <strong>territorio</strong> suggerisce <strong>di</strong> costruire l’or<strong>di</strong>namento spaziale anche in funzione <strong>del</strong>la<br />
progettualità: nel caso <strong>del</strong>l’ area vasta, nei due ambiti PPR 13 e 14 ovvero nella macroarea <strong>del</strong> “Sassarese”<br />
proposta dal PUP-PTC, per l’area preparco nell’intero <strong>territorio</strong> comunale, nell’area <strong>del</strong>le Bonifiche ovvero nel<br />
comprensorio irriguo <strong>del</strong>la Nurra. Sotto il profilo agro-forestale il <strong>territorio</strong> comunale <strong>di</strong> Alghero si articola in<br />
quattro campi e nove subcampi:<br />
- il campo <strong>del</strong>la selvicoltura (4.600 ha); con i subcampi dei coniferamenti litoranei e retro litoranei (4.548 ha), e<br />
<strong>del</strong>la foresta urbana (52 ha)<br />
- il campo <strong>del</strong> pastoralismo (1.027 ha); con i subcampi M. Zirra-Pedrosu e dei rilievi effusivi<br />
- la Piana <strong>di</strong> Alghero (12.036 ha); con i subcampi <strong>del</strong>le Gran<strong>di</strong> Aziende (3.964 ha) e <strong>del</strong>le Riforme agrarie<br />
(8.072 ha)<br />
- l’agricoltura periurbana (2.898 ha); con i subcampi <strong>del</strong>l Agro misto degli oliveti e dei vigneti (871 ha),<br />
<strong>del</strong>l’Agro olivetato collinare (1.957 ha) e <strong>del</strong>la fascia degli orti (70 ha).<br />
L’area vasta<br />
L’integrazione ecologica ed economica <strong>del</strong>le risorse territoriali e dei processi in atto richiede che l’analisi sia<br />
sviluppata in primis a livello <strong>di</strong> area vasta, rappresentabile dagli ambiti <strong>di</strong> paesaggio n. 13 e 14 <strong>del</strong> PPR <strong>del</strong>la
RAS (Fig. 2). Tra le fonti informative si ricordano la Carta <strong>di</strong> Uso <strong>del</strong> Suolo <strong>del</strong>la Regione Sardegna e gli stessi<br />
elaborati inclusi nel Piano Paesaggistico Regionale, il PFAR (Piano Forestale Ambientale Regionale.<br />
approvato con DGR n.3/21 <strong>del</strong> 24.01.2006), il Piano Urbanistico Provinciale (Piano Territoriale <strong>di</strong><br />
Coor<strong>di</strong>namento) <strong>del</strong>la provincia <strong>di</strong> Sassari, gli elaborati interme<strong>di</strong> <strong>del</strong> Piano Urbanistico Comunale <strong>di</strong> Alghero, i<br />
dati settoriali Istat e le informazioni fornite da Agenzia Laore e Cantina Sociale S. Maria La Palma.<br />
Premesso che nel complesso il <strong>territorio</strong> rurale occupa il 99,6% <strong>del</strong>la superficie <strong>del</strong>la Sardegna e la<br />
popolazione ivi residente ammonta al 90% <strong>del</strong> totale regionale, si sottolinea che il paesaggio rurale <strong>del</strong><br />
<strong>territorio</strong> <strong>del</strong> Parco conserva estese tracce <strong>di</strong> passate attività agricole oggi sempre meno <strong>di</strong>ffuse, mentre<br />
l’agricoltura è ancora viva nelle aree contermini soprattutto con le due colture legnose, e relative filiere, <strong>del</strong>la<br />
vite e <strong>del</strong>l olivo. La prima ha i suoi punti <strong>di</strong> forza nei centri <strong>di</strong> trasformazione e commercializzazione <strong>di</strong> Santa<br />
Maria La Palma (cooperativo) e <strong>del</strong>la Sella & Mosca (gruppo Campari), il secondo in un attivo gruppo <strong>di</strong><br />
produttori-imbottigliatori tra i quali spicca per <strong>di</strong>mensioni la Domenico Manca SpA con il marchio “San Giuliano<br />
Alghero”.<br />
L’intervento pubblico <strong>di</strong> infrastrutturazione territoriale ha operato in misura importante in quest’area, sia in<br />
territori oggi ricadenti all interno <strong>del</strong> Parco dove negli Anni Sessanta e Settanta <strong>del</strong> secolo scorso si è attuato<br />
un esteso programma <strong>di</strong> coniferamento con funzione sistematoria idraulica <strong>di</strong> aree pendenti e retrolitoranee<br />
sia nei territori limitrofi al Parco con la Bonifica integrale <strong>del</strong> periodo fascista, la Riforma agraria ETFAS degli<br />
Anni Sessanta e l’infrastrutturazione irrigua operata dal Consorzio <strong>di</strong> Bonifica <strong>del</strong>la Nurra negli ultimi decenni<br />
<strong>del</strong> secolo scorso (Fig. 3). Più <strong>di</strong> recente l intervento pubblico si è in<strong>di</strong>rizzato verso la tutela <strong>ambientale</strong> con<br />
l istituzione <strong>di</strong> regimi <strong>di</strong> protezione per aree <strong>di</strong> particolare pregio riferibili alla rete comunitaria Natura 2000<br />
(Protezione e conservazione degli habitat e <strong>del</strong>le specie animali e vegetali: Europe’s nature for you), in<br />
riferimento alla quale –nel quadro <strong>del</strong>le cosiddette <strong>di</strong>rettive habitat e Uccelli la pianificazione <strong>ambientale</strong><br />
regionale ha <strong>del</strong>imitato Siti <strong>di</strong> Interesse Comunitario (come quelli <strong>di</strong> Capo Caccia e Punta <strong>del</strong> Giglio, Lago <strong>di</strong><br />
Baratz e <strong>Porto</strong> Ferro) e Zone <strong>di</strong> Protezione Speciale. Il Parco, in particolare, si sovrappone all Area Marina<br />
Protetta <strong>di</strong> Capo Caccia-Isola Piana, include lo stagno <strong>del</strong> Calich sottoposto a tutela come area SIC e ZPS e<br />
confina a nord con il SIC <strong>di</strong> <strong>Porto</strong> Ferro – Lago <strong>di</strong> Baratz in gran parte ricadente in comune <strong>di</strong> Sassari (Fig. 4).<br />
L’area è ovviamente interessata anche dal Piano <strong>di</strong> Assetto Idrogeologico (PAI) e dal Piano Paesaggistico<br />
Regionale (PPR) <strong>del</strong>la RAS; in merito a quest’ultima progettualità il Parco <strong>di</strong> <strong>Porto</strong> <strong>Conte</strong> ricade nell’ambito n.<br />
13 “Golfo <strong>di</strong> Alghero”.<br />
In linea con quanto si registra in tutte le società post-industriali l'agricoltura provinciale ha imboccato, dagli<br />
Anni Settanta <strong>del</strong> secolo scorso, una fase regressiva in sintesi così riassumibile:<br />
i. le terre agrarie sono passate dai 319.399 ha <strong>del</strong> 1990 ai 242.280 ha <strong>del</strong> 2000 (- 77.119 ha)<br />
ii. l'incidenza <strong>del</strong>l'agricoltura sulla totale superficie provinciale è scesa dal 75% <strong>del</strong> 1990 al 57% <strong>del</strong> 2000<br />
iii. le superfici coltivate si sono ridotte <strong>del</strong> 24 %.
Figura 2– Uso <strong>del</strong> suolo(UDS – RAS, 2008) nell’ipotesi <strong>di</strong> Area vasta basata sui due Ambiti PPR 13 e 14<br />
Figura 3 – Infrastrutturazione agraria <strong>del</strong>l’area vasta
Figura 4 – Aree protette ricadenti nell’area vasta<br />
Le quattro macroregioni in<strong>di</strong>viduate dalla pianificazione territoriale <strong>di</strong> livello provinciale nel Nord Ovest hanno,<br />
però, risposto in modo <strong>di</strong>fferenziato al cambiamento (Figg. 5 e 6): le terre agrarie hanno registrato una<br />
regressione molto rapida per coltivazioni e allevamenti nelle aree con ampio sviluppo costiero dove il trend<br />
demografico risulta positivo per flussi interni e turistici (come il Sassarese, macroregione che comprende<br />
anche l’Algherese e, quin<strong>di</strong>, il Parco <strong>di</strong> <strong>Porto</strong> <strong>Conte</strong>), un ritmo meno incalzante in Anglona (dove si è registrato<br />
un lieve aumento <strong>del</strong> patrimonio ovino) e ad<strong>di</strong>rittura un'espansione dei seminativi nell'unica macroregione che<br />
non ha contatti con la costa (MonteAcuto - Goceano), dove la mancanza <strong>di</strong> alternative all'agricoltura ha<br />
sostenuto, almeno sino al 2000, un processo <strong>di</strong> ammodernamento <strong>del</strong> settore primario che ha portato alla<br />
scomparsa <strong>del</strong>le imprese zootecniche <strong>di</strong> minore <strong>di</strong>mensione. In tutta la provincia si assiste, poi, all'espansione<br />
<strong>del</strong>la vegetazione forestale, processo che deve essere interpretato tenendo presente quella che è l'attuale<br />
definizione <strong>di</strong> bosco .<br />
Il database UDS RAS evidenzia che il cuore agricolo <strong>del</strong>la macroregione <strong>del</strong> Sassarese è in<strong>di</strong>viduabile nel<br />
sistema <strong>del</strong>le terre irrigue, aree <strong>di</strong> piano sottoposte a sistemazione idraulica e collegate a gran<strong>di</strong> bacini <strong>di</strong><br />
raccolta: la Nurra, la cui rete <strong>di</strong>stributiva, coor<strong>di</strong>nata dall omonimo Consorzio <strong>di</strong> Bonifica e alimentata dal<br />
sistema Cuga–Temo, coinvolge i comuni <strong>di</strong> Sassari, Alghero, <strong>Porto</strong> Torres e Olmedo; la piana <strong>di</strong> Chilivani-<br />
Ozieri, collegata al sistema <strong>di</strong> Monte Lerno, è occupata da attività zootecniche e quella <strong>di</strong> Perfugas<br />
(allevamento ovino e ortive) e Valledoria (ortive) collegate al sistema <strong>del</strong> Coghinas.<br />
Il sistema Nurra, dopo un lungo periodo <strong>di</strong> ridotta efficienza, è andato a regime alla fine degli Anni Novanta <strong>del</strong><br />
secolo scorso garantendo l’effettiva <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> notevoli corpi d acqua ai consorziati9. L'area é,<br />
comunque, ricca <strong>di</strong> acque sotterranee ancorché ad elevata durezza per l’elevato contenuto salino. Le aziende<br />
sono <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni me<strong>di</strong>e, impegnate nella filiera <strong>del</strong> latte, sia ovino che bovino (soprattutto il secondo in
costante arretramento), in viticoltura, olivicoltura e orto-frutticoltura, con quest’ultimo comparto incentrato sulla<br />
coltivazione <strong>del</strong> carciofo e <strong>del</strong> pesco. La superficie geografica complessiva <strong>del</strong> Consorzio è <strong>di</strong> 83.574 Ha, <strong>di</strong><br />
cui 22.353 irrigui e 18.555 attrezzati. Nel quinquennio 2005-2009 le colture irrigue si sono estese, però; solo<br />
4.500 ettari, il 72% dei quali occupati da sole quattro colture: vite, mais, me<strong>di</strong>ca e ortive (Fig. 7 e Tab. 1). I<br />
fruttiferi, l olivo e la vite conoscono una fase <strong>di</strong> espansione e innovazione con un crescente impiego<br />
<strong>del</strong>l efficiente tecnica <strong>di</strong> irrigazione a goccia, in regressione appare il carciofo, sostanzialmente stabili erbai<br />
autunno-vernini, mais, me<strong>di</strong>ca e ortive (Fig. 8).<br />
9 La rete <strong>di</strong>stributiva <strong>del</strong> C.B.N. dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel recupero <strong>del</strong>le acque reflue <strong>del</strong><br />
depuratore <strong>di</strong> Alghero che al momento contribuiscono all‟eutrofizzazione <strong>del</strong>lo stagno <strong>del</strong> Calik<br />
Figura 7 – Ripartizione colturale <strong>del</strong>le superfici irrigue nel 2009 (fonte: C. B. N.)<br />
Tabella 1 – Dinamica temporale <strong>del</strong>la ripartizione colturale nella Nurra irrigua (fonte: C.B.N.)<br />
COLTURE<br />
(Ha)<br />
2005 2006 2007 2008 2009 MEDIA<br />
Barbabietol<br />
a autun.<br />
25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0<br />
Barbabietol<br />
a primav.<br />
195,8 1,0 0,0 0,0 0,0 39,4<br />
Carciofo 249,1 261,4 230,2 194,9 186,7 224,5<br />
Carciofo (a<br />
goccia)<br />
51,0 23,1 21,3 16,9 10,2 24,5<br />
Carciofo,<br />
totale<br />
300,1 284,5 251,5 211,8 196,9 249,0<br />
Protette 9,8 10,8 9,0 9,8 8,1 9,5<br />
Cereali 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 3,0<br />
Erbai aut.vernini<br />
170,3 210,1 136,4 148,9 167,0 166,5<br />
Extra<br />
agricolo<br />
10,9 15,2 0,0 0,0 0,0 5,2<br />
Floreali (a 3,9 4,3 2,0 0,5 16,9 5,5
goccia)<br />
Floreali<br />
pieno<br />
campo<br />
6,5 3,6 3,2 2,1 2,8 3,6<br />
Foraggere 33,8 15,8 15,3 7,1 2,0 14,8<br />
Forestali 5,8 4,5 4,8 4,1 4,5 4,7<br />
Forestali (a<br />
goccia)<br />
25,2 25,5 24,9 23,5 9,5 21,7<br />
Frutteti 88,1 99,2 116,6 114,4 107,5 105,2<br />
Frutteti (a<br />
goccia)<br />
75,3 76,9 73,0 77,1 107,9 82,0<br />
Frutteti,<br />
totale<br />
163,4 176,1 189,6 191,5 215,4 187,2<br />
Mais 909,1 784,8 701,6 948,5 748,1 818,4<br />
Mais (a 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6<br />
goccia)<br />
Mais, totale 912,1 784,8 701,6 948,5 748,1 819,0<br />
Me<strong>di</strong>ca 728,1 777,4 705,9 787,8 864,5 772,7<br />
Officinali 0,0 4,0 1,5 1,3 2,3 1,8<br />
Oleaginose 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,4<br />
Olivo 77,7 72,3 79,4 91,4 92,0 82,6<br />
Olivo (a<br />
goccia)<br />
107,9 119,5 110,4 132,6 155,3 125,1<br />
Olivo,<br />
totale<br />
185,6 191,8 189,8 224,0 247,3 207,7<br />
Ortive 413,2 470,7 430,6 467,8 445,1 445,5<br />
Ortive (a<br />
goccia)<br />
267,4 209,3 252,3 218,2 199,6 229,4<br />
Ortive,<br />
totale<br />
680,6 680,0 682,9 686,0 644,7 674,8<br />
Pomodoro 0,7 0,2 1,0 1,2 0,2 0,7<br />
Pomodoro<br />
(a goccia)<br />
1,1 1,0 1,7 0,2 2,9 1,4<br />
Prati pol. e<br />
mon.<br />
183,8 229,2 251,1 252,9 212,0 225,8<br />
Sorgo 121,7 91,1 64,8 51,5 61,6 78,1<br />
Vigneti 191,4 197,8 189,3 173,2 163,5 183,0<br />
Vigneti (a<br />
goccia)<br />
726,1 822,9 851,1 868,0 885,7 830,8<br />
Vigneti,<br />
totale<br />
917,5 1.020,7 1.040,4 1.041,2 1.049,2 1.013,8<br />
TOTALE 4.681,6 4.533,3 4.290,4 4.593,8 4.455,7 4.511,0<br />
L’Algherese<br />
L’analisi <strong>di</strong> livello locale può prendere avvio dai Censimenti Generali <strong>del</strong>l’Agricoltura (Istat: 1980, 1990 e 2000)<br />
che confermano la crisi <strong>del</strong> settore con rapido e imponente ridursi <strong>di</strong> addetti, unità produttive e superfici<br />
investite. Il trend negativo procede, nell’Algherese, con un ritmo molto più accelerato <strong>di</strong> quello riscontrabile a<br />
livello provinciale e regionale: tra il 1990 e il 2000 le superfici agricole, totale e coltivata, si riducono circa <strong>del</strong><br />
45%, i seminativi <strong>del</strong> 50%, i vigneti e gli oliveti rispettivamente <strong>del</strong> 29 e 17%, le aziende zootecniche<br />
<strong>di</strong>minuiscono <strong>del</strong> 66% e il numero <strong>di</strong> capi allevati <strong>del</strong> 50 (ovini) e 60% (bovini) (Tabb. 2 e 3). Il crollo <strong>del</strong>la<br />
zootecnia nurrese indebolisce l’intera filiera e comporta, in una prima tappa, lo spostamento <strong>del</strong>le strutture<br />
trasformative <strong>del</strong>la Coapla (Cooperativa allevatori e produttori latte <strong>di</strong> Sassari) dalla sede storica <strong>di</strong> S. Maria<br />
La Palma ai moderni stabilimenti <strong>di</strong> Sassari a metà Anni Novanta, strategia insufficiente per contrastare la<br />
globalizzazione <strong>del</strong> mercato che impone, in una seconda tappa, la confluenza nella 3A <strong>di</strong> Arborea nei primi<br />
anni duemila. Contrasta con questo vero e proprio tracollo <strong>del</strong>l’agricoltura algherese la crescita <strong>del</strong> 20%<br />
registrata dalle aziende olivicole tra gli anni Novanta (860 aziende con una superficie me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> 1,78 Ha) e il
2000 (1.129 aziende con una superficie me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> 1,12 Ha), incremento che coincide con un’importante<br />
regressione <strong>del</strong>la superficie occupata dagli oliveti: tra il 1980 e il 2000 da 2.311 a 1.267 ettari con una per<strong>di</strong>ta<br />
<strong>del</strong>l’82%, passando per i 1.532 ettari degli Anni Novanta. Il consumo degli oliveti riguarda presumibilmente la<br />
corona circostante Alghero, mentre l’apparente contrad<strong>di</strong>zione con l’incremento degli oliveti irrigui (Tab. 1) va<br />
interpretata avendo presente che la coltura si è espansa sia nelle open lands <strong>del</strong>la Nurra sia nell’area <strong>del</strong>la<br />
Bonifica sotto la spinta <strong>di</strong> una favorevole politica comunitaria e <strong>del</strong> crescente apprezzamento <strong>del</strong>la <strong>di</strong>eta<br />
me<strong>di</strong>terranea con conseguente lievitare <strong>del</strong> regime dei prezzi, crollati solo <strong>di</strong> recente.<br />
La progettualità a sostegno dei tra<strong>di</strong>zionali paesaggi agrari, e dei saperi e <strong>del</strong>la bio<strong>di</strong>versità ad essi collegati, è<br />
sviluppata per ambiti territoriali omogenei ottenuti attraverso un processo <strong>di</strong> zonazione funzionale<br />
all’or<strong>di</strong>namento spaziale <strong>del</strong>le principali coperture vegetali e all’assetto geo-morfologico e pedologico; si<br />
ottengono, così, dei campi, e subcampi, agrari e forestali da intendersi come ambiti progettuali che<br />
valorizzano la relativa omogeneità interna nella ricerca <strong>di</strong> soluzioni e strategie comuni per affrontare specifiche<br />
criticità (Fig. 9).<br />
Figura 9 – Campi agricoli, aree <strong>del</strong>la Riforma Agraria e Fon<strong>di</strong>aria ETFAS sulla base <strong>del</strong>la Carta UDS – RAS<br />
1. Il campo <strong>del</strong>la selvicoltura; esteso per circa 4.600 ettari, comprende la gran parte <strong>del</strong>l’area protetta come<br />
conseguenza degli interventi <strong>di</strong> sistemazione idraulico forestale svolti sia dalla prima (nuclei <strong>di</strong> Cuguttu-Maria
Pia e <strong>del</strong>l’Arenosu12) che dalla seconda Riforma Agraria tra gli anni Cinquanta (punta Giglio, ad esempio) e<br />
Settanta (Capo Caccia) <strong>del</strong> secolo scorso ad opera <strong>del</strong>l ETFAS, che coor<strong>di</strong>nava anche gli interventi <strong>del</strong>l’allora<br />
Azienda Foreste Demaniali e Ispettorato Forestale <strong>del</strong>la Regione Sarda (oggi rispettivamente Ente Foreste e<br />
Corpo Forestale e <strong>di</strong> Vigilanza Ambientale <strong>del</strong>la Sardegna); anche la Società Bonifiche Sarde ha avuto un<br />
ruolo nel processo <strong>di</strong> coniferamento. L’intervento si è sostanzialmente sviluppato in due <strong>di</strong>fferenti unità <strong>di</strong><br />
paesaggio: i depositi alluvionali ed eolici pleistocenici, come quelli intorno al lago <strong>di</strong> Baratz e nell’area <strong>di</strong> Maria<br />
Pia, e i più superficiali suoli <strong>del</strong>le formazioni calcaree, in genere mesozoiche, che formano la penisola <strong>di</strong> Capo<br />
Caccia e l’area tra la punta <strong>del</strong> Giglio e capo Galera13. Non mancano, però, pinete su terre rosse<br />
me<strong>di</strong>terranee come in località Punta <strong>del</strong> Gallo – l’Arenosu, ovvero lembi <strong>di</strong> macchia, lecceta, ginepreta e<br />
vegetazione igrofila nelle aree interstiziali o dove il fuoco ha aperto la foresta <strong>di</strong> conifere.<br />
1.1 I coniferamenti litoranei e retro litoranei; occupano circa 4.548 ettari, ricoperti in prevalenza dal pino<br />
d’Aleppo e domestico a formare degli ecosistemi semplificati che uniscono all’originale funzione protettiva<br />
quella turistico- ricreativa. In generale si rileva una carenza <strong>di</strong> cure colturali (sfolli, <strong>di</strong>radamenti, potature) che<br />
unita a una forte pressione antropica responsabile <strong>di</strong> spora<strong>di</strong>ci incen<strong>di</strong>, eccessivo calpestio <strong>di</strong> alcuni tratti e<br />
<strong>di</strong>scariche abusive svolge un’imponente azione <strong>di</strong> degrado con compromissione sia <strong>del</strong>la vitalità e go<strong>di</strong>bilità<br />
<strong>del</strong>l’attuale soprassuolo sia <strong>del</strong>la sua rinnovazione naturale pregiu<strong>di</strong>cando il mantenimento <strong>del</strong>la copertura<br />
vegetale ovvero la sua evoluzione verso tipologie vegetazionali <strong>di</strong>fferenti. L’urgenza degli interventi<br />
manutentori è confermata dalle sempre più frequenti pullulazioni <strong>del</strong> coleottero Tomicus destruens, capace <strong>di</strong><br />
portare a morte le conifere indebolite da siccità e danni da incen<strong>di</strong>o; grande preoccupazione desta, inoltre, la<br />
possibile comparsa <strong>del</strong>la cocciniglia corticola <strong>del</strong> pino marittimo (Matsucoccus feytau<strong>di</strong> Ducasse), originaria<br />
<strong>del</strong> Me<strong>di</strong>terraneo orientale e <strong>di</strong> recente introduzione in Italia e già responsabile <strong>di</strong> estesi danni ai popolamenti<br />
liguri e toscani, per la quale non si esclude la possibilità <strong>di</strong> sviluppo sui pini domestico e d’Aleppo.<br />
Le linee guida <strong>del</strong>la gestione possono essere così riassunte:<br />
- popolamenti ricadenti in zone A; preservazione <strong>del</strong>l’esistente, conseguente aumento <strong>del</strong>la capacità <strong>di</strong><br />
autorganizzazione e graduale incremento <strong>del</strong>la complessità <strong>del</strong> sistema con innalzamento <strong>del</strong>la bio<strong>di</strong>versità<br />
attraverso la naturale <strong>di</strong>ffusione <strong>del</strong>le specie <strong>del</strong>la macchia (il lentisco <strong>di</strong>mostra qui grande capacità <strong>di</strong><br />
ricolonizzazione), ginepro e leccio;<br />
- popolamenti in zone B e C; gestione conservativa me<strong>di</strong>ante l’adozione <strong>di</strong> moduli colturali inquadrabili nella<br />
selvicoltura sistemica, basati su cauti, continui e capillari <strong>di</strong>radamenti <strong>del</strong>le pinete ovvero moduli colturali che<br />
si avvicinano al trattamento a tagli successivi;<br />
- popolamenti in zone C e D; qui si registra la maggiore frequentazione turistica (come la Bramassa nell’area<br />
<strong>di</strong> punta <strong>del</strong> Giglio) e la gestione si basa su tecniche <strong>di</strong> selvicoltura tra<strong>di</strong>zionale finalizzate, ad esempio, al<br />
mantenimento <strong>del</strong> pino d’Aleppo nel piano dominante per l’ombreggiamento e la frescura che assicura nel<br />
periodo estivo.<br />
In ogni caso il processo evolutivo deve essere sempre preceduto dalla pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> specifici Piani <strong>di</strong><br />
Assestamento (<strong>di</strong> Gestione) che attraverso la compartimentazione dei perimetri forestali possano dettagliare<br />
le in<strong>di</strong>spensabili linee guida15. Un esempio <strong>di</strong> compartimentazione è rappresentato nelle figure 10 e 11.<br />
L’or<strong>di</strong>namento spaziale dei popolamenti consente <strong>di</strong> enucleare singole unità gestionali:<br />
• le pinete <strong>del</strong>la fascia <strong>del</strong>le cale; ubicate lungo la fascia costiera da <strong>Porto</strong> Ferro a Cala Viola, proteggono<br />
dall’azione battente <strong>del</strong> maestrale le colture agrarie retrolitoranee.
• le pinete <strong>del</strong> golfo <strong>di</strong> <strong>Porto</strong> <strong>Conte</strong> (Mugoni); rappresentano l’ideale cerniera tra i soprassuoli coniferati <strong>di</strong><br />
Punta Giglio-Capo Galera e Capo Caccia. Hanno grande valenza <strong>ambientale</strong> e turistico- ricreativa poiché<br />
contribuiscono alla saldezza dei suoli e all’utilizzo estivo <strong>del</strong>la fascia litoranea.<br />
• le pinete <strong>del</strong> golfo <strong>di</strong> Alghero (Lazzaretto e Punta Negra); si collegano, con modeste soluzioni <strong>di</strong> continuità,<br />
alle pinete <strong>di</strong> Punta Giglio, a ovest, e a quelle <strong>del</strong>l’Arenosu - Maria Pia, a est.<br />
Figura 10 – Compartimentazione <strong>del</strong> complesso forestale <strong>di</strong> Punta Giglio (fonte: Fois, 2009)<br />
Figura 11 – Compartimentazione <strong>del</strong>la penisola <strong>di</strong> Capo Caccia (fonte: Denti B., 2004/2005)
1.2 La foresta urbana; si ritiene che possa occupare circa 52 ettari concentrati nei centri urbani <strong>di</strong> Alghero e<br />
Fertilia. Assume grande importanza per un <strong>territorio</strong> che basa il proprio mo<strong>del</strong>lo <strong>di</strong> sviluppo sull’eccellenza<br />
<strong>ambientale</strong> funzionale all’attrattività turistica. Il verde pubblico e privato <strong>di</strong> Alghero può essere sud<strong>di</strong>viso in<br />
periurbano –dallo storico viale <strong>di</strong> pino domestico che unisce S. Maria La Palma alla piazza principale <strong>di</strong><br />
Fertilia, fortemente degradato, alla pineta <strong>di</strong> Maria Pia e ai nuclei isolati <strong>di</strong> oliveti tra<strong>di</strong>zionali, o storici, interclusi<br />
nel tessuto urbano- e urbano -dalla Passeggiata Busquets <strong>di</strong> viale Barcellona, alle alberate storiche <strong>di</strong> olmo<br />
siberiano e fitolacca, agli esemplari adulti <strong>di</strong> Washingtonia e ai nuclei <strong>di</strong> ailanto inse<strong>di</strong>atisi nell’aree ruderali <strong>del</strong><br />
centro storico.<br />
La valorizzazione <strong>del</strong> verde urbano passa attraverso un’organica progettualità fondata su gli elaborati tecnici<br />
<strong>del</strong> Piano <strong>del</strong> Verde e <strong>del</strong> Censimento <strong>del</strong> Verde –documento inventariale con spazializzazione <strong>di</strong> aree, arre<strong>di</strong><br />
ed elementi vegetali- che potrebbero trovare spazio all’interno <strong>del</strong> PUC, e il continuo aggiornamento<br />
professionale degli operatori tecnici incaricati degli interventi manutentori che non possono essere improntati a<br />
criteri “agricoli” poco rispettosi non solo <strong>del</strong>la fisiologia <strong>del</strong>l’albero ma anche <strong>del</strong> suo ruolo estetico e<br />
salutistico.<br />
2. Campo <strong>del</strong> pastoralismo; oggi ridotto a soli 1.027 ettari, nel passato l’allevamento brado (anche caprino) era<br />
molto più <strong>di</strong>ffuso poiché praticato sia sui rilievi calcarei <strong>del</strong> monte Doglia e Zirra, sia in quelli effusivi a sud est<br />
<strong>di</strong> Alghero al confine col Villanovese.<br />
2.1 Il subcampo <strong>di</strong> Monte Zirra; modesto rilievo <strong>di</strong> calcari mesozoici alle spalle <strong>del</strong>la borgata <strong>di</strong> Santa Maria La<br />
Palma, rivestito <strong>di</strong> macchia degradata dagli incen<strong>di</strong> e da un passato pastorale può assumere un certo ruolo<br />
quale area ricreativa e punto panoramico sia per la popolazione <strong>del</strong>la borgata e <strong>del</strong>l’inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong>ffuso, sia<br />
per un turismo scolastico-culturale sostenuto dalla sua vicinanza non solo al Parco ma anche al sistema lago<br />
<strong>di</strong> Baratz – rada <strong>di</strong> porto Ferro. Ai pie<strong>di</strong> <strong>del</strong> colle, sul versante occidentale, sono presenti vigneti e oliveti che<br />
possono integrarsi nel processo <strong>di</strong> valorizzazione.<br />
2.2 Il subcampo dei rilievi effusivi; territori localizzati a est e sud-est <strong>del</strong> centro urbano al confine col comune <strong>di</strong><br />
Villanova MonteLeone dove il paesaggio conserva tracce <strong>di</strong> tra<strong>di</strong>zionali attività pastorali basate<br />
sull’allevamento brado <strong>del</strong> bovino da carne, alternato all’allevamento <strong>del</strong>l olivo e piccoli vigneti padronali. Il<br />
subcampo si articola nei due ambiti <strong>di</strong> “Scala Picada” e “Poglina”. Il primo presenta un’orografia collinare con<br />
suoli dotati <strong>di</strong> ridotta potenza dove sono, comunque, presenti modeste attività zootecniche estensive basate<br />
sia su allevamenti ovini che bovini (linea vacca-vitello). Gli impren<strong>di</strong>tori sono in parte villanovesi, anche se non<br />
mancano allevatori algheresi e <strong>del</strong>la Sardegna centrale. Le attività zootecniche hanno un forte impatto<br />
<strong>ambientale</strong> in relazione all’orografia accidentata con conseguenti problemi per l’assetto idrogeologico <strong>del</strong><br />
<strong>territorio</strong>; le comunità vegetali, che potrebbero evolvere verso formazioni boschive, sono infatti mantenute a<br />
livello <strong>di</strong> cespugliame o macchia dal sovrapascolamento e dall’assenza <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> recupero. In quest’area<br />
si colloca presumibilmente la gran parte dei 1.800 ettari <strong>di</strong> prati permanenti e pascoli presenti nel <strong>territorio</strong><br />
comunale (Tab. 2). L’ambito si incunea nell’agro <strong>di</strong> Alghero coi nuclei <strong>di</strong> monte Calvia e monte Pedrosu, aree<br />
<strong>di</strong> rilevante valenza <strong>ambientale</strong> e paesaggistica sia per la presenza <strong>di</strong> una macchia-foresta termoxerofila<br />
(olivastro, fillirea, ecc) che per la vicinanza al centro urbano. Lambito <strong>di</strong> “Poglina” é costituito da un area<br />
allungata da nord a sud, localizzata nella parte meri<strong>di</strong>onale <strong>del</strong> <strong>territorio</strong> comunale sino alla spiaggia <strong>del</strong>la<br />
Speranza. Di modesta rilevanza agricola e <strong>di</strong> grande valenza <strong>ambientale</strong>, dovrà, tra l’altro, essere sottoposta a<br />
processi <strong>di</strong> rinaturalizzazione al fine <strong>di</strong> consentire alla copertura vegetale <strong>di</strong> evolversi positivamente<br />
raggiungendo uno stato <strong>di</strong> equilibrio meno precario <strong>del</strong>l’attuale.<br />
3. Campo de La Piana <strong>di</strong> Alghero; vasto <strong>territorio</strong> (12.036 ha) pressoché pianeggiante localizzato a nord e a<br />
nord-ovest <strong>del</strong> centro urbano sino al confine col <strong>territorio</strong> <strong>di</strong> Olmedo, <strong>Porto</strong> Torres e Sassari, <strong>del</strong>imitato a
occidente dalle pinete <strong>del</strong> “mare <strong>di</strong> fuori” e dalla penisola <strong>di</strong> Capo Caccia, rappresenta circa il 45% <strong>del</strong>l’intero<br />
agro comunale. Pur non rientrando <strong>di</strong>rettamente nell’area protetta, rappresenta la fascia pre-parco per la<br />
quale è opportuno <strong>del</strong>ineare una strategia sinergica per rafforzare il contributo <strong>del</strong>l agricoltura allo sviluppo<br />
<strong>del</strong> <strong>territorio</strong>.<br />
3.1 Il subcampo <strong>del</strong>le gran<strong>di</strong> aziende; vasta area (3.964 ha) localizzato a nord-est <strong>del</strong> centro urbano chiuso a<br />
occidente dal rio Filibertu, ospita le importanti aziende agrarie <strong>di</strong> Surigheddu e Mamuntanas (nel passato<br />
impegnate in innovative attività zootecniche), <strong>di</strong> San Marco e <strong>del</strong>la Sella & Mosca (località “I Piani”),<br />
specializzata nella viticoltura ad uva da vino. Nel ventennio 1950-70 le attività agricole <strong>del</strong> <strong>territorio</strong> erano<br />
caratterizzate dall allevamento bovino a duplice attitu<strong>di</strong>ne (latte e carne) abbinato alla coltivazione <strong>del</strong><br />
frumento, mo<strong>del</strong>lo sviluppato con tecniche avanzate da gran<strong>di</strong> aziende private quali Mamuntanas e<br />
Surigheddu (già operanti nella prima parte <strong>del</strong> secolo e tra le prime a introdurre in Sardegna la razza da latte<br />
“frisona”). A partire dagli anni Sessanta il grano duro segnalava una forte regressione per la concorrenza<br />
esercitata dall’orzo (cerale a esclusivo impiego zootecnico) che accompagnava la fase espansiva<br />
<strong>del</strong>l’allevamento ovino poi arrestatasi negli Anni Novanta.<br />
Gli anni Ottanta avevano visto la crescente infrastrutturazione irrigua <strong>del</strong>l area, con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> vantaggio che<br />
non arrestava la regressione <strong>del</strong>la bovinicoltura e la chiusura <strong>del</strong>le due gran<strong>di</strong> aziende private <strong>di</strong> Surigheddu e<br />
Mamuntanas, trend che si completa con la recente chiusura <strong>del</strong>l’azienda Donna Ricca, peraltro in comune <strong>di</strong><br />
Sassari (La Corte). Di contro l’allevamento ovino ha evidenziato, come a livello regionale e provinciale, una<br />
maggiore tenuta rinviando il successivo tracollo agli Anni Novanta.<br />
Sempre attiva e competitiva risulta, invece, la Sella & Mosca che coi suoi 550 ettari <strong>di</strong> vigneti ubicati in località<br />
I Piani rappresenta una realtà unica in Sardegna e circa la metà dei vigneti algheresi; ad essi si aggiungono<br />
strutture produttive <strong>di</strong> minore superficie ubicate in Gallura e Sulcis Iglesiente come anche l’acquisizione <strong>di</strong> uve<br />
<strong>di</strong> particolare pregio finalizzate ad alcune particolari tipologie enologiche. La Sella&Mosca (gruppo Campari)<br />
controlla dal 1994 anche il marchio Zedda&Piras che, nelle strutture industriali ospitate all interno<br />
<strong>del</strong>l’azienda “I Piani”, alimenta la filiera liquoristica “tipica” legata soprattutto al liquore <strong>di</strong> mirto; completano la<br />
gamma <strong>del</strong> brand <strong>di</strong>stillati da vinacce e infusi idro-alcolici <strong>di</strong> scorza <strong>di</strong> limone. La strategia commerciale <strong>del</strong><br />
gruppo ha sempre sottolineato il rapporto <strong>del</strong> prodotto col <strong>territorio</strong> e l’ambiente <strong>di</strong> coltivazione (terroir)<br />
configurandosi come un possibile partner <strong>del</strong> Parco in un progetto <strong>di</strong> tutela che sfrutti la positiva immagine che<br />
un area protetta riscontra nell’immaginario collettivo.<br />
3.2. Il subcampo <strong>del</strong>le Riforme agrarie; questo secondo subcampo, esteso per 8.072 ha e situato a nord e<br />
nord-ovest <strong>di</strong> Alghero, è costituito da una piana alluvionale dominata dai rilievi <strong>di</strong> calcare mesozoico <strong>di</strong> monte<br />
Doglia (a sud) e Zirra, dove ad iniziare dagli anni Trenta <strong>del</strong> secolo scorso si avviò, per opera <strong>del</strong>l’Ente<br />
Ferrarese <strong>di</strong> Colonizzazione, la bonifica <strong>di</strong> circa 30mila ettari, <strong>di</strong> cui 8.000 messi in coltura. L’intervento era<br />
finalizzato alla bonifica idraulica <strong>del</strong>le aree <strong>di</strong> ristagno temporaneo (pauli) formate dai deflussi <strong>del</strong> complesso<br />
collinare racchiuso tra monte Forte - monte Zirra – monte Doglia, che defluivano verso lo stagno <strong>del</strong> Calich<br />
scorrendo in <strong>di</strong>rezione sud. I poderi si collocano lungo i due principali assi viari (Fig. 12), con geometrico<br />
<strong>di</strong>segno spaziale, collegati da una rete <strong>di</strong> canali <strong>di</strong> regimazione idrica <strong>di</strong>sposti perpen<strong>di</strong>colarmente a imitazione<br />
<strong>del</strong>la centuriazione <strong>di</strong> epoca classica. La “città nuova” <strong>di</strong> Fertilia costituisce il centro servizi <strong>del</strong>l’area.<br />
La Bonifica integrale è completata ed estesa negli anni Cinquanta a seguito <strong>del</strong>l intervento ETFAS (nel 1942<br />
l'Ente Ferrarese <strong>di</strong> Colonizzazione è rinominato “Ente Sardo <strong>di</strong> Colonizzazione”, nel 1953 è assorbito dall'Ente<br />
<strong>di</strong> Trasformazione Fon<strong>di</strong>aria ed Agraria in Sardegna) che gestì a lungo il <strong>territorio</strong> bonificato <strong>del</strong>la Nurra sul<br />
quale erano intervenute le campagne antimalariche condotte in Sardegna tra il 1946 e il 1950 dai tecnici <strong>del</strong>la<br />
Fondazione Rockefeller. Nel 1984 l’ETFAS è sostituito dall’ERSAT, che nel 2007 confluisce nell Agenzia
Laore. L’ETFAS, a partire dal 1951 e a seguito <strong>del</strong>la Legge sulla Riforma Agraria, avviava un imponente<br />
programma <strong>di</strong> trasformazione fon<strong>di</strong>aria con l'appoderamento <strong>di</strong> migliaia <strong>di</strong> ettari <strong>di</strong> terreno (Fig. 13) e la<br />
contemporanea realizzazione <strong>di</strong> importanti centri <strong>di</strong> servizio, tra questi i borghi <strong>di</strong> Santa Maria La Palma e Sa<br />
Segada. La prima ha a lungo ospitato il “monte granario”, la Cooperativa Allevatori e Produttori Latte COAPLA<br />
(poi trasferita in Sassari e, quin<strong>di</strong>, assorbita dalla 3A <strong>di</strong> Arborea) e l’omonima Cantina Sociale.<br />
Figura 12 – La prima Bonifica <strong>del</strong>la Nurra <strong>di</strong> Alghero in una mappa realizzata da Le Lannou nel 1939
Figura 13 – La seconda bonifica e l’appoderamento ETFAS in una carta <strong>del</strong> 1963 (fonte: PPR – RAS)<br />
Il PPR RAS identifica i territori sottoposti a bonifica come quelle aree «che sono state interessate<br />
principalmente da “l insieme dei lavori <strong>di</strong> risanamento e <strong>di</strong> trasformazione agraria; questi prevedono il<br />
miglioramento <strong>di</strong> determinate aree attraverso un complesso <strong>di</strong> misure idrauliche, agrarie, agricole, igieniche e<br />
sociali, al fine <strong>di</strong> eliminare gli specchi <strong>di</strong> acque ferme”. ». Il PPR precisa che «l area <strong>del</strong>le bonifiche <strong>di</strong> Alghero<br />
circoscrive complessivamente un <strong>territorio</strong> <strong>di</strong> circa 7.641 ettari, compreso nei Comuni <strong>di</strong> Alghero e Sassari.<br />
Nella scheda <strong>del</strong> “Sistema <strong>del</strong>le bonifiche <strong>di</strong> Alghero-Fertilia”, allegata al PPR (Relazione Generale, volume 3-<br />
7 “Componenti <strong>di</strong> paesaggio e sistemi con valenza storico culturale – Schede”) la voce “descrizione” riporta<br />
che nel Sistema “sono inquadrati tutti gli elementi architettonici e infrastrutturali <strong>del</strong>la bonifica, avviata negli<br />
anni ‘30 dall’Ente Ferrarese <strong>di</strong> Colonizzazione”. Gli elementi caratterizzanti tale sistema sono così definiti:<br />
− l’area <strong>di</strong> bonifica;<br />
− l’appoderamento;<br />
− le infrastrutture viarie storiche;<br />
− le borgate;<br />
− i centri <strong>di</strong> servizio;<br />
− le architetture civili e religiose.<br />
Sono inoltre preesistenze significative <strong>del</strong>l’area:<br />
− i fabbricati agricoli;<br />
− gli antichi appro<strong>di</strong>.<br />
La norma (art. 59, comma 1 <strong>del</strong>le NTA) precisa che tali sistemi sono funzionali alla pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong><br />
programmi <strong>di</strong> conservazione e valorizzazione paesaggistica.<br />
Nell’area <strong>del</strong>le Riforme assume particolare rilevanza la filiera vitivinicola sostenuta dalla Società cooperativa<br />
agricola per Azioni “Cantina Santa Maria la Palma Alghero” che, superati gli effetti <strong>del</strong>la politica comunitaria <strong>di</strong><br />
riduzione <strong>del</strong>le eccedenze enoiche, concretizzatasi nei premi all’espianto, ha svecchiato le strutture produttive<br />
e rinnovato le attrezzature industriali. Oggi la Cantina sociale raccoglie le uve <strong>di</strong> 322 soci, con una superficie<br />
vitata <strong>di</strong> circa 680 Ha <strong>di</strong>stribuita tra i comuni <strong>di</strong> Alghero, Olmedo e Sassari; ben 480 ettari sono formati da<br />
vigneti a Denominazione <strong>di</strong> Origine Controllata. Pertanto il contributo <strong>del</strong> polo cooperativo alla viticoltura
algherese è prossimo a quello fornito dal polo privato <strong>del</strong>la Sella&Mosca (Tab. 4); anche le rese unitarie<br />
(vicine alle 10 t/Ha) e la <strong>di</strong>ffusione <strong>del</strong>le produzioni a Denominazione <strong>di</strong> Origine Controllata testimoniano<br />
l’efficienza <strong>del</strong>la filiera viticola cooperativa. La Cantina, creata subito dopo la fine <strong>del</strong>la seconda guerra<br />
mon<strong>di</strong>ale, riveste gran<strong>di</strong>ssima importanza nell’economia <strong>del</strong> <strong>territorio</strong>. Le uve annualmente trasformate<br />
ammontano, come me<strong>di</strong>a annua, a circa 5.000 tonnellate. Le attrezzature e gli impianti <strong>di</strong> trasformazione sono<br />
<strong>di</strong>sposti su una superficie aziendale <strong>di</strong> 40.000 mq, dei quali 7.200 coperti; da alcuni anni l’azienda ha ottenuto<br />
la certificazione ISO 1991:2000.<br />
La potenzialità <strong>del</strong> centro cooperativo non pare utilizzata appieno poiché la rete <strong>di</strong> poderi <strong>del</strong>la Bonifica, in<br />
gran parte soci conferitori, <strong>di</strong>spone <strong>di</strong> vaste superfici olivicole sottoutilizzate, che potrebbero attraverso un<br />
organico progetto <strong>di</strong> rilancio affiancare la filiera <strong>del</strong>l’olio extravergine a quella <strong>del</strong> vini, sfruttando in modo<br />
sinergico la rete <strong>di</strong> contatti e marketing <strong>di</strong> cui la Cantina <strong>di</strong>spone; molti gran<strong>di</strong> produttori <strong>di</strong> vino abbinano<br />
l olio, e i sott’oli (carciofini, car<strong>di</strong>, melanzane, ecc), ai loro vini. In tempi più lunghi la Cantina, in una strategia<br />
comune con l Ente Parco, potrebbe <strong>di</strong>venire volano <strong>di</strong> un progetto <strong>di</strong> rilancio <strong>del</strong>la filiera ortofrutticola, un<br />
tempo presente nel <strong>territorio</strong> e oggi limitata a spora<strong>di</strong>ci impianti <strong>di</strong> fruttiferi (pesco in modo particolare) e a<br />
sempre più ridotte estensioni <strong>di</strong> carciofo spinoso sardo.<br />
Tabella 4- Produzioni e relativa superficie in Ha, per varietà nel periodo 2006-2010, <strong>del</strong>le uve conferite alla<br />
cantina S. Maria La Palma<br />
DENOMINAZIONE PRODUZIONI (q) Superficie (Ha)<br />
2010 2009 2008 2007 2006<br />
VERMENTI<br />
NO DI<br />
SARDEGNA<br />
DOC<br />
35˙916,8 37˙451,0 33˙370,6 34˙067,6 33˙452,2 307,5<br />
CANNONA<br />
U DI<br />
SARDEGNA<br />
DOC<br />
7˙362,4 11˙799,6 10˙578,8 10˙000,9 10˙612,8 116,0<br />
ALGHERO<br />
ROSSO<br />
DOC<br />
10˙737,0 12˙246,8 11˙522,6 11˙954,2 13˙094,4 118,7<br />
ALGHERO<br />
BIANCO<br />
DOC<br />
2˙171,6 2˙124,6 2˙319,2 2˙566,2 3˙146,8 25,4<br />
MONICA DI<br />
SARDEGNA<br />
3˙026,8 3˙520,0 3˙395,4 3˙226,2 2˙440,0 35,4<br />
UVE<br />
COMUNI<br />
823,4 979,2 1˙009,0 1˙378,6 2˙148,0 41,4<br />
TOTALI 60˙038,0 68˙121,2 62˙195,6 63˙193,7 64˙894,2 644,4<br />
4. L’agricoltura periurbana; la storica <strong>di</strong>sposizione spaziale <strong>del</strong>le colture all intorno <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>ne e villaggi è<br />
ancora visibile nella corona <strong>di</strong> 2.898 ettari che circonda Alghero, soprattutto per la presenza <strong>di</strong> oliveti<br />
tra<strong>di</strong>zionali e storici, mentre la fascia orticola è stata quasi <strong>del</strong> tutto consumata dall’espansione urbana.<br />
4.1 L’agro misto degli oliveti e dei vigneti; si estende per 871 ettari a est e nord - est <strong>del</strong> centro urbano, mentre<br />
a nord-ovest risulta <strong>del</strong>imitato dallo stagno <strong>del</strong> Calich e dal rio Barca. Le attività agricole prevalenti sono<br />
costituite da oliveti e vigneti <strong>di</strong> ridotta estensione, spesso finalizzati all’autoconsumo familiare. La<br />
polverizzazione fon<strong>di</strong>aria e una <strong>di</strong>ffusa urbanizzazione ne riducono la valenza agricola, mentre l’elevata<br />
estetica <strong>del</strong> paesaggio e la vicinanza <strong>del</strong>l’ecosistema palustre assegnano all’area una grande valore
<strong>ambientale</strong> e inse<strong>di</strong>ativo. Solo l’olivicoltura rappresenta in taluni casi un’attività significativa sotto il profilo<br />
economico.<br />
4.2 L’agro olivetato collinare; i suoi 1.957 ettari, che confinano a est sud est con l’imme<strong>di</strong>ata periferia <strong>del</strong><br />
centro urbano, mostrano un orografia piuttosto mossa per la presenza <strong>di</strong> modeste alture quali i “monti”<br />
Barrano, Barate, Sisinni e il colle <strong>di</strong> San Giuliano. L’olivicoltura rappresenta il principale mo<strong>del</strong>lo agronomico<br />
anche se persistono piccole superfici occupate da vigneti e pascoli. Anche questo ambito é sottoposto a una<br />
forte pressione abitativa che ha comportato, appunto, la contrazione <strong>del</strong>le superfici coltivate. L’area olivetata<br />
ha, infatti, subito una marcata erosione e il frazionamento in unità produttive <strong>di</strong> insufficiente estensione per<br />
l’ottenimento <strong>del</strong>le necessarie economie <strong>di</strong> scala; la vegetazione arborea ben si abbina, infatti, alle esigenze <strong>di</strong><br />
qualità <strong>del</strong>la vita tipiche <strong>del</strong>l’inse<strong>di</strong>amento urbano nelle cosiddette “aree <strong>di</strong> frangia”.<br />
Nei passati decenni l’olivo aveva, invece, rappresentato per la popolazione algherese un settore economico<br />
primario, sia per l’impegno impren<strong>di</strong>toriale profuso che per l’assorbimento <strong>di</strong> una cospicua forza-lavoro. Infatti<br />
il contributo <strong>del</strong>l’olivicoltura all’economia e ai livelli occupazionali <strong>del</strong> comune si è mantenuto elevato sino agli<br />
anni Sessanta, quando il crescente costo dei fattori <strong>del</strong>la produzione e la relativa stabilità <strong>di</strong> prezzo <strong>del</strong>l’olio <strong>di</strong><br />
oliva riducevano la red<strong>di</strong>tività <strong>del</strong>la coltura. Le superfici, erose anche dall’espansione e<strong>di</strong>lizia, sono così<br />
<strong>di</strong>minuite dai 1.908 ha <strong>del</strong> 1960-62 ai 1.872 <strong>del</strong> 1978-80, per passare a soli 1.532 ha nel 1990 (Tab. 2). In<br />
particolare, il confronto tra gli ultimi due Censimenti Generali <strong>del</strong>l’Agricoltura evidenzia una regressione <strong>del</strong>la<br />
superficie olivetata <strong>del</strong> 34% (non si tiene conto dei nuovi impianti).<br />
Nel corso degli anni Novanta il prezzo <strong>del</strong>l’olio, sia per la negativa influenza climatica sulle produzioni<br />
spagnole che per una più <strong>di</strong>ffusa conoscenza dei pregi <strong>di</strong>etetici e <strong>del</strong> suo ruolo centrale nella “<strong>di</strong>eta<br />
me<strong>di</strong>terranea”, ha subito notevoli incrementi restituendo alle migliori produzioni regionali una buona<br />
competitività economica; l’elevata produzione spagnola nell annata 1996/97 e i buoni risultati ottenuti nella<br />
campagna in corso, stanno, però, favorendo un allarmante riduzione dei prezzi alla produzione nelle aree<br />
meri<strong>di</strong>onali (Puglia e Calabria, in particolare). In Sardegna la tendenza al ribasso dei prezzi alla produzione<br />
sembra essere meno rilevante, anche se al momento è <strong>di</strong>fficile fornire precise in<strong>di</strong>cazioni.<br />
4.3. La fascia degli orti; oltre all’importante contrazione superficiale si registra anche un logorio <strong>del</strong> subcampo,<br />
ovvero una per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> densità <strong>del</strong>le stesse strutture agricole a seguito <strong>del</strong>lo sviluppo e<strong>di</strong>lizio <strong>del</strong> secondo<br />
Dopoguerra. Oggi sono riconoscibili circa 70 ettari.<br />
La fauna<br />
Introduzione<br />
La componente faunistica vertebratica terrestre <strong>del</strong> Parco Naturale Regionale <strong>di</strong> <strong>Porto</strong> <strong>Conte</strong> è senza dubbio<br />
un elemento caratterizzante l’intera area. Essa ha conosciuto nell’arco degli ultimi 60 anni una profonda<br />
mo<strong>di</strong>ficazione con l’estinzione <strong>di</strong> alcune specie <strong>di</strong> rilevante interesse come la Foca monaca e il Falco<br />
pescatore e l’introduzione <strong>di</strong> alcune specie <strong>di</strong> Mammiferi come il Daino, il cavallino <strong>del</strong>la Giara e l’asinello<br />
bianco <strong>del</strong>l’Asinara e l’asinello grigio sardo. Inoltre, alcune specie particolarmente sensibili come la Berta<br />
maggiore stanno subendo una forte pressione involontaria da parte <strong>del</strong> mondo <strong>del</strong>la pesca e la colonia dei<br />
Grifoni ha raggiunto negli ultimi anni una consistenza numerica che potrebbe portare questa specie ad<br />
estinguersi dal <strong>territorio</strong> <strong>del</strong> Parco. Infine, la presenza <strong>del</strong> cinghiale che all’interno <strong>del</strong>l’area <strong>del</strong> Parco trova<br />
protezione, costituisce un elemento <strong>di</strong> forte conflittualità con gli agricoltori che operano nelle imme<strong>di</strong>ate<br />
vicinanze <strong>del</strong> Parco.<br />
La presente relazione introduttiva, intende fornire una conoscenza sullo status faunistco, sulla fenologia, sul<br />
livello <strong>di</strong> minaccia e <strong>di</strong> conservazione <strong>di</strong> ciascuna <strong>del</strong>le specie dei vertebrati terrestri appartenenti alle Classi
degli Anfibi, dei Rettili, degli Uccelli e dei Mammiferi che si riproducono all’interno <strong>del</strong> Parco. Inoltre,<br />
considerata l’importanza che la Sardegna, per la sua posizione geografica nel centro <strong>del</strong> Me<strong>di</strong>terraneo<br />
occidentale, riveste per le specie <strong>di</strong> uccelli migratori e svernanti, si fornisce un primo eleco <strong>di</strong> tutte le specie <strong>di</strong><br />
uccelli migratoti, svernanti e ni<strong>di</strong>ficanti riscontrati negli ultimi 35 anni all’interno <strong>del</strong>l’attuale area <strong>del</strong> Parco.<br />
Uccelli<br />
Specie ni<strong>di</strong>ficanti<br />
I censimenti sono stati effettuati nell’arco temporale esteso da aprile a luglio nel periodo 1990-2010, me<strong>di</strong>ante<br />
la tecnica dei punti <strong>di</strong> ascolto senza limiti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza (Blon<strong>del</strong> et al., 1981) <strong>di</strong> 10 minuti <strong>di</strong> durata (Fornasari et<br />
al., 1998), metodologia utilizzata nel programma <strong>di</strong> monitoraggio degli Uccelli comuni ni<strong>di</strong>ficanti denominato<br />
MITO2000 (Monitoraggio ITaliano Ornitologico). Secondo tale metodologia, in ogni stazione si effettua un solo<br />
rilevamento, in con<strong>di</strong>zioni meteorologiche non sfavorevoli (vento o pioggia intensa). Vengono rilevati gli<br />
uccelli visti e sentiti. Per quanto riguarda gli uccelli notturni (Occhione) sono stati utilizzati censimenti al<br />
playback: tale tecnica consiste nello stimolare una risposta territoriale <strong>del</strong>la specie da censire, me<strong>di</strong>ante la<br />
riproduzione <strong>del</strong> canto con un registratore, simulando la presenza <strong>di</strong> un conspecifico. Per quanto riguarda gli<br />
altri uccelli notturni (Barbagianni, Civetta, Assiolo e Succiacapre) sono stati effettuati transetti a pie<strong>di</strong> e in<br />
macchina rilevando la presenza <strong>del</strong>le specie me<strong>di</strong>ante il canto. Sono stati, inoltre, utilizzati dati forniti da<br />
persone terze e successivamente vagliati criticamente e dati bibliografici.<br />
Specie svernanti e migratrici<br />
Per quanto riguarda le specie svernanti e migratrici nell’area vasta si è fatto riferimento a censimenti effettuati<br />
dall’autore nel periodo 1990-2010 e a dati bibliografici<br />
La metodologia utilizzata è quella dei transetti lineari senza misurazione <strong>del</strong>le <strong>di</strong>stanze (Burnham et al., 1980).<br />
Questo metodo prevede che l’osservatore, stabilito un itinerario (transetto), proceda lentamente (1-2 Km/h) e<br />
registri tutti gli uccelli visti o sentiti durante il tempo impiegato per percorrere l’intero transetto<br />
I dati relativi alla Laguna <strong>del</strong> Calich sono stati raccolti dall’autore nel periodo 1978 al 2010 me<strong>di</strong>ante la<br />
metodologia dei punti <strong>di</strong> osservazione e si riferiscono alle sole specie <strong>di</strong> uccelli acquatici e cioè a quelle<br />
appartenenti agli or<strong>di</strong>ni dei Po<strong>di</strong>cipe<strong>di</strong>formes, Pelecaniformes, Ciconiiformes, Anseriformes, Gruiformes e<br />
Charadriiformes. A queste si aggiungono il Falco <strong>di</strong> palude appartenente all’or<strong>di</strong>ne degli Accipitriformes e<br />
l’Usignolo <strong>di</strong> fiume, la Cannaiola e il Cannareccione tutte e tre appartenenti all’or<strong>di</strong>ne dei Passeriformes in<br />
quanto specie ecologicamente <strong>di</strong>pendenti dalle zone umide.<br />
<strong>Analisi</strong> faunistica: specie riproducentisi<br />
Status faunistico<br />
In totale sono state censite 121 specie <strong>di</strong> Vertebrati terrestri pari al 50,2% <strong>del</strong>la fauna vertebratica terrestre<br />
sarda. Tre specie (33,3% <strong>del</strong> totale sardo) appartengono alla Classe degli Anfibi, 13 specie (59,1% <strong>del</strong> totale<br />
sardo) alla Classe dei Rettili, 83 specie (49,7% <strong>del</strong> totale sardo) agli Uccelli e 22 specie (53,5% <strong>del</strong> totale<br />
sardo) ai Mammiferi. Centosette (107) specie sono a riproduzione certa, quattro a riproduzione probabile,<br />
sette a riproduzione possibile e 3 a riproduzione storica.<br />
Anfibi<br />
Tutte le specie appartengono all’Or<strong>di</strong>ne degli Anura. Una specie appartiene alla Famiglia Discoglossidae, una<br />
alla Famiglia Bufonidae ed una alla Famiglia Hylidae. Tutte le specie sono a riproduzione certa.
Rettili<br />
Cinque specie appartengono all’Or<strong>di</strong>ne dei Testu<strong>di</strong>nes e otto all’Or<strong>di</strong>ne degli Squamata. Una specie<br />
appartiene alla Famiglia deigli Emydae, due specie alla Famiglia dei Testu<strong>di</strong>nidae, tre specie alla Famiglia dei<br />
Gekkonidae, tre specie alla famiglia dei Lacertidae, due specie alla Famiglia dei Scincidae e due specie alla<br />
famiglia dei Colubridae. Do<strong>di</strong>ci specie sono a riproduzione certa e una probabile.<br />
Uccelli<br />
Quarantuno specie sono Non-Passeriformes (49,4%) e quarantadue Passeriformes (50,6%) e appartengono a<br />
18 Or<strong>di</strong>ni e 37 Famiglie <strong>di</strong> cui 23 Non-Passeriformes e 14 Passeriformes.<br />
La percentuale elevata dei Non-Passeriformes sul totale <strong>del</strong>le specie presenti fornisce una prima in<strong>di</strong>cazione<br />
positiva sull’eterogeneità <strong>ambientale</strong> <strong>del</strong>l’area <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o. Infatti, l’incidenza dei non Passeriformes in una<br />
comunità ornitica può essere un valido strumento per valutare la complessità strutturale <strong>di</strong> un determinato<br />
ambiente (Farina, 1984).<br />
Tra le specie ni<strong>di</strong>ficanti 71 sono a riproduzione certa (85,5% <strong>del</strong>le specie ni<strong>di</strong>ficanti), 3 a riproduzione<br />
probabile (3,6% <strong>del</strong>le specie ni<strong>di</strong>ficanti), 7 sono a riproduzione possibile (8,4% <strong>del</strong>le specie ni<strong>di</strong>ficanti) e 2<br />
specie a riproduzione storica (2,4% <strong>del</strong>le specie ni<strong>di</strong>ficanti).<br />
Mammiferi<br />
Tre specie appartengono all’Or<strong>di</strong>ne Insectivora, cinque specie appartengono all’Or<strong>di</strong>ne dei Chiroptera, due<br />
specie all’Or<strong>di</strong>ne dei Lagomorpha, cinque specie ai Rodentia, cinque specie ai Carnivora e tre specie agli<br />
Ungulata. Una specie appartiene alla Famiglia degli Erinaceidae, due specie alla Famiglia dei Soricidae, tre<br />
specie alla Famiglia Rhinolophidae, due specie alla famiglia dei Vespertilionidae, due specie ai Leporidae,<br />
quattro sepcie ai Muridae, una specie ai Myoxidae, una specie ai Canidae, due specie ai Mustelidae, una<br />
specie ai Phocidae, una specie ai Suidae e una specie ai Cervidae. Ventuno specie sono a riproduzione certa<br />
e una a riproduzione storica.<br />
Status <strong>di</strong> protezione a livello internazionale<br />
Tra le 121 specie che si riproducono nell’area <strong>del</strong> Parco, venti specie sono incluse nell’Appen<strong>di</strong>ce 1 <strong>del</strong>la<br />
Direttiva 409/79 (specie per cui sono previste misure speciali <strong>di</strong> conservazione per quanto riguarda l’habitat,<br />
per garantire la loro sopravvivenza e la riproduzione nell’ area <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione), do<strong>di</strong>ci specie nell’App. 2 <strong>del</strong>la<br />
Direttiva 43/92 (Specie Animali e Vegetali d’interesse Comunitario la cui conservazione richiede la<br />
designazione <strong>di</strong> Zone Speciali <strong>di</strong> Conservazione), <strong>di</strong>ciannove specie nell’App. 4 <strong>del</strong>la Direttiva 43/92 (Specie<br />
Animali e Vegetali <strong>di</strong> Interesse Comunitario che richiedono una protezione rigorosa), settantatre specie sono<br />
incluse nell’Appen<strong>di</strong>ce 2 <strong>del</strong>la Convenzione <strong>di</strong> Berna (Specie strettamente protette), ventidue specie<br />
nell’Appen<strong>di</strong>ce 3 <strong>del</strong>la Convenzione <strong>di</strong> Berna (Specie protette), 1 nell’Appen<strong>di</strong>ce 1 <strong>del</strong>la Convenzione <strong>di</strong> Bonn<br />
(elenca le specie <strong>di</strong> flora selvatica che è vietato cogliere, collezionare, tagliare o sra<strong>di</strong>care intenzionalmente) e<br />
<strong>di</strong>ciannove specie nell’Appen<strong>di</strong>ce 2 <strong>del</strong>la Convenzione <strong>di</strong> Bonn (elenca le specie <strong>di</strong> fauna selvatica che sono<br />
anche oggetto <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizioni legislative o regolamentari opportune per assicurare la loro conservazione).<br />
Avifauna<br />
In totale sono state rilevate 188 specie ( 53,9% <strong>del</strong> totale <strong>del</strong>le specie sarde) <strong>di</strong> cui 83 ni<strong>di</strong>ficanti, 2 specie si<br />
sono estinte dal <strong>territorio</strong> <strong>del</strong> Parco <strong>di</strong> <strong>Porto</strong> <strong>Conte</strong> (Falco pescatore e Cavaliere d’Italia). Settantatre (73) sono
migratrici e svernanti regolari, sette (7) migratrici regolari e svernanti irregolari, una (1) specie è migratrice e<br />
svernante irregolare, sessantotto (6) specie sono migratrivi regolari, tre (3) specie sono migratrici irregolari e<br />
due (2) specie sono accidentali.<br />
Centoventi specie sono Non-Passeriformes e 70 Passeriformes. I Non-Passeriformes comprendono 17 Or<strong>di</strong>ni<br />
e 32 Famiglie. I Passeriformes comprendono 17 Famiglie.<br />
L’ in<strong>di</strong>ce Non Passeriformes/Passeriformes pari a 1,7 risulta essere un valore molto elevato che sta a<br />
significare un buon in<strong>di</strong>catore <strong>del</strong>la complessità <strong>del</strong> popolamento ornitico e un’elevata qualità <strong>ambientale</strong>.<br />
Molte <strong>del</strong>le specie <strong>di</strong> Non-Passeriformes sono rapaci migratori; trovandosi questa categoria sistematica ai<br />
vertici <strong>di</strong> catene trofiche complesse, la loro presenza sta a significare una buona qualità <strong>ambientale</strong>.<br />
L’elevato numero <strong>di</strong> specie migratrici e svernanti conferma l’importanza <strong>del</strong> <strong>territorio</strong> <strong>del</strong> Parco <strong>di</strong> <strong>Porto</strong> <strong>Conte</strong><br />
per la migrazione e la sosta invernale grazie alla elevata <strong>di</strong>versità <strong>ambientale</strong> e alla grande <strong>di</strong>sponibilità<br />
alimentare durante i perio<strong>di</strong> fred<strong>di</strong>.<br />
Cinquantaquattro (154) specie sono incluse nell’All. 1 Direttica 409/79.<br />
Centocinque (105) sono incluse tra le specie SPEC (ve<strong>di</strong> tabella 2) e costituiscono il 55,8% <strong>del</strong> totale <strong>del</strong>le<br />
specie censite. Tre specie (0,2% <strong>del</strong> totale SPEC) appartengono alla categoria SPEC 1 (specie globalmente<br />
minacciate o <strong>di</strong>pendenti da interventi <strong>di</strong> conservazione o con insufficienti informazioni <strong>di</strong>sponibili). Se<strong>di</strong>ci<br />
specie (15,2% <strong>del</strong> totale SPEC) appartengono alla categoria SPEC 2 (specie con uno status <strong>di</strong> conservazione<br />
sfavorevole) e col 50% <strong>del</strong>le popolazioni concentrate in Europa. Cinquantuno specie (48,6% <strong>del</strong> totale SPEC)<br />
appartengono alla categoria SPEC 3 (specie con uno status <strong>di</strong> conservazione sfavorevole e non concentrate<br />
in Europa) ed infine trentacinque specie (33,3%% <strong>del</strong> totale SPEC) appartengono alla categoria SPEC 4<br />
(specie con uno status <strong>di</strong> conservazione favorevole e con il 50% <strong>del</strong>la popolazione concentrata in Europa).<br />
Ricchezza faunistica degli habitat (n° totale <strong>di</strong> specie riproducentisi)<br />
Come si può vedere dalla tabella 3, gli habitat con maggior numero <strong>di</strong> specie sono risultati i boschi <strong>di</strong> conifere<br />
(rimboschimenti) e le formazioni sclerofile sempreever<strong>di</strong> con 47 specie ciascuna (2 specie <strong>di</strong> Anfibi, 3 specie<br />
<strong>di</strong> rettili, 32 specie <strong>di</strong> Uccelli, 10 specie <strong>di</strong> mammiferi), la macchia me<strong>di</strong>terranea con 40 specie (2 specie <strong>di</strong><br />
Anfibi, 7 specie <strong>di</strong> Rettili, 16 specie <strong>di</strong> Uccelli e15 specie <strong>di</strong> Mammiferi), le praterie secche con 38 specie (1<br />
specie <strong>di</strong> Anfibi, 4 specie <strong>di</strong> Rettili, 25 specie <strong>di</strong> Uccelli e 8 specie <strong>di</strong> Mammiferi), seguiti dai coltivi con 31<br />
specie, dalla macchia/pascolo con 27 specie, e dalle zone umide con 26 specie e dalle falesie con 24 specie.<br />
Seguono alcuni habitat con valori compresi tra 22 e 4 specie.<br />
Va evidenziato che per quanto riguarda la comunità faunistica <strong>del</strong>le dune si è fatto riferimento alla porzione<br />
<strong>del</strong>le stesse prive <strong>di</strong> vegetazione arbustiva ed arborea.<br />
I valori ottenuti confermano quanto già ampiamente descritto in bibliografia e cioè che la <strong>di</strong>versità specifica<br />
<strong>del</strong>le popolazioni soprattutto d’uccelli è <strong>di</strong>rettamente proporzionale alla complessità <strong>del</strong>la struttura <strong>del</strong>la<br />
vegetazione, specialmente per quanto riguarda la stratificazione verticale.<br />
Habitat N° specie Anfibi Rettili Uccelli Mam.<br />
Falesie marine e scogliere 24 5 18 1<br />
Dune e spiagge sabbiose costiere (senza<br />
13<br />
vegetazione o con comunità <strong>di</strong> erbe annuali)<br />
7<br />
4 2<br />
Caverne e grotte 10 4 6
Zone umide 26 3 4 17 2<br />
Invasi <strong>di</strong> ritenuta 13 3 2 7 1<br />
Corsi d’acqua e loro alveo 22 3 2 15 2<br />
Zone rocciose (<strong>del</strong>l’interno) 18 5 12 1<br />
Gariga costiera 4 2 2<br />
Formazioni sclerofille semprever<strong>di</strong> 47 2 3 32 10<br />
Machia me<strong>di</strong>terranea 40 2 7 16 15<br />
Macchia – pascolo/pascolo-macchia 27 2 21 4<br />
Boschi <strong>di</strong> conifere (pinete <strong>di</strong> pini me<strong>di</strong>terranei) 47 2 2 33 10<br />
Praterie secche (pascoli) 38 1 4 25 8<br />
Coltivi (seminativi) 31 1 4 21 5<br />
Tab. 3. n° <strong>di</strong> specie riproducentisi (ricchezza faunistica) in ciascuno dei 14 habitat in<strong>di</strong>viduati nell’area <strong>di</strong><br />
stu<strong>di</strong>o.<br />
50<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
N. specie riproducentisi nei singoli habitat<br />
Falesie marine e scogliere<br />
Dune e spiagge sabbiose costiere<br />
(senza vegetazione o con comunità<br />
<strong>di</strong> erbe annuali)<br />
Caverne e grotte<br />
Zone umide<br />
Invasi <strong>di</strong> ritenuta<br />
Corsi d’acqua e loro alveo<br />
Pareti rocciose (<strong>del</strong>l’interno)<br />
Gariga costiera<br />
Formazioni sclerofille semprever<strong>di</strong><br />
Macchia me<strong>di</strong>terranea<br />
Macchia – pascolo/pascolomacchia<br />
Boschi <strong>di</strong> conifere (pinete <strong>di</strong> pini<br />
me<strong>di</strong>terranei)<br />
Praterie secche (pascoli)<br />
Coltivi (seminativi)<br />
Fig 4. Ricchezza <strong>del</strong>le comunità ornitologiche ni<strong>di</strong>ficanti in ciascun habitat rilevato.<br />
Numero <strong>di</strong> specie minacciate per habitat<br />
Nel paragrafo precedente è stata calcolata la ricchezza faunistica totale <strong>di</strong> ciascun habitat, in quello presente<br />
vengono esposti i risultati relativi alla ricchezza faunistica degli habitat prendendo in considerazione solo le<br />
specie riproducentisi appartenenti alla Classe degli Uccelli incluse nell’Allegato 1 <strong>del</strong>la Direttiva 409/79 e alla<br />
categoria SPEC 1 SEPC 2, SPEC 3 e <strong>del</strong>le Classi degli Anfibi, Rettili e Mammiferi incluse nell’All. 2 <strong>del</strong>la<br />
Direttiva 43/92.<br />
I risultati, esposti nella tabella seguente, evidenziano che le falesie marine e piccole isole con 12 specie è<br />
quello con il maggior numero <strong>di</strong> specie minacciate, seguito dai pascoli-macchia/macchia-pascoli con 11<br />
specie, dalle praterie secche e dalla macchia me<strong>di</strong>terranea con 10 specie ciascuna, dalle zone umide e dai
coltivi con 9 specie ciascuna, dalle caverne e grotte, dalle formazioni sclerofille semprever<strong>di</strong> e dai boschi <strong>di</strong><br />
conifere con 8 specie ciascuna. Infine seguono cinque habitat con un numero inferiore tra 7 e 2 specie.<br />
Habitat N° specie<br />
Falesie marine e piccole isole 12 50<br />
Dune e spiagge sabbiose costiere (senza vegetazione<br />
6<br />
o con comunità <strong>di</strong> erbe annuali)<br />
46,1<br />
Caverne e grotte 8 80<br />
Zone umide 9 34,6<br />
Invasi <strong>di</strong> ritenuta 3 23,1<br />
Corsi d’acqua e loro alveo 7 31,8<br />
Zone rocciose (<strong>del</strong>l’interno) 7 38,9<br />
Gariga costiera 2 50<br />
Formazioni sclerofille semprever<strong>di</strong> 8 17<br />
Machia me<strong>di</strong>terranea 10 25<br />
Macchia – pascolo/pascolo-macchia 11 40,7<br />
Boschi <strong>di</strong> conifere (pinete <strong>di</strong> pini me<strong>di</strong>terranei) 8 17<br />
Praterie secche (pascoli) 10 26,3<br />
Coltivi (seminativi) 9 29<br />
% rispetto alla<br />
ricchezza totale<br />
Quadro sintetico <strong>del</strong>lo stato economico e sociale nel comune <strong>di</strong> Alghero<br />
Le brevi note che seguono contengono alcuni aspetti <strong>del</strong> sistema economico e sociale <strong>del</strong> comune <strong>di</strong> Alghero.<br />
Il loro contenuto informativo è stato tratto in gran parte dal Piano urbanistico comunale, mentre si sono<br />
aggiunte <strong>del</strong>le considerazioni, preliminari ai successivi sviluppi <strong>del</strong> Piano <strong>del</strong> Parco <strong>di</strong> <strong>Porto</strong> <strong>Conte</strong>.<br />
I dati e le in<strong>di</strong>cazioni raccolti per il comune <strong>di</strong> Alghero riguardano la struttura economico-produttiva, il sistema<br />
locale e l’occupazione. Si tratta d’informazioni <strong>di</strong> base <strong>del</strong>le quali, quando possibile, si evidenziano<br />
l’evoluzione e alcune fra le relazioni che le caratterizzano. Non sono considerati i collegamenti fra struttura<br />
economica e Parco <strong>di</strong> <strong>Porto</strong> <strong>Conte</strong>.<br />
Di tale istituzione, strumento, metodo e mo<strong>del</strong>lo - perché numerose sono le sue prerogative - si <strong>di</strong>scuterà nei<br />
documenti successivi, fino a pre<strong>di</strong>sporne il Piano che lo riguarda, e tuttavia dovrebbe essere anche<br />
necessario che emerga, per la sua conduzione e gestione, un consenso politico preventivo, oltre che una<br />
comprensione quanto più estesa, intorno alla scelta <strong>del</strong>lo sviluppo sostenibile. Intanto perché, una volta che si<br />
voglia applicare, “sustainable development is a term that everyone likes, but nobody is sure of what it means”,<br />
e poi perché tale sviluppo dovrebbe prevedere il ri<strong>di</strong>mensionamento dei mo<strong>del</strong>li economici fondati<br />
sull’espansione quantitativa <strong>del</strong>le attività produttive (crescita), per sostituirli con mo<strong>del</strong>li economici qualitativi,<br />
basati invece sullo sviluppo; in questo caso, vi possono essere legittimi interessi particolari1, soprattutto a<br />
livello locale, che pongono limiti <strong>di</strong> attuazione.<br />
1 Sono istituzioni, organizzazioni e associazioni economiche e politiche che per statuto e struttura degli interessi<br />
giu<strong>di</strong>cano e valutano quantitativamente sulla crescita e a loro buon <strong>di</strong>ritto si oppongono alla sostituzione <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo<br />
tra<strong>di</strong>zionale con qualcosa che spesso percepiscono come indefinibile e impegnativo, e che per <strong>di</strong> più prevede uno<br />
sviluppo <strong>di</strong> tipo qualitativo.
Sono vari e numerosi gli esempi nei quali l’accordo apparente, coagulato intorno al senso e al contenuto <strong>del</strong>la<br />
sostenibilità, si sia basato su un frainteso e vago significato <strong>di</strong> sviluppo sostenibile. Nella sua concezione più<br />
generale il termine richiama il legame fra attività economiche ed ecosistema2. In questa connessione, le<br />
attività economiche richiedono all’ecosistema, come inputs, materie prime e risorse naturali, mentre<br />
trasferiscono all’ecosistema, come propri outputs, rifiuti, inquinamento e mo<strong>di</strong>fiche funzionali degli spazi fisici.<br />
Il senso compiuto <strong>del</strong>lo sviluppo sostenibile mantiene quegli inputs e outputs a livelli ecologicamente<br />
sostenibili.<br />
Nell’elaborazione <strong>del</strong> Piano <strong>del</strong> Parco <strong>di</strong> <strong>Porto</strong> <strong>Conte</strong> è dunque opportuno, in primo luogo, evidenziare lo stato<br />
economico e sociale <strong>del</strong> comune <strong>di</strong> Alghero, per poi inserirlo nel più ampio mo<strong>del</strong>lo <strong>di</strong> sviluppo sostenibile che<br />
include anche il Parco.<br />
1. La struttura economico-produttiva <strong>del</strong> comune <strong>di</strong> Alghero<br />
Nel decennio intercensuario 1991/20013 la struttura economico-produttiva <strong>del</strong> comune <strong>di</strong> Alghero si è<br />
caratterizzata per il ruolo preminente che hanno avuto le attività <strong>di</strong> Commercio e riparazioni, gli Alberghi e i<br />
pubblici esercizi: il loro peso è stato superiore al 40% sul totale <strong>del</strong> numero d’imprese e sul totale <strong>del</strong> numero<br />
<strong>di</strong> addetti presenti nel <strong>territorio</strong> comunale, mentre i comparti maggiormente <strong>di</strong>namici sono stati quelli <strong>del</strong>le<br />
Attività immobiliari, <strong>del</strong>le Costruzioni e dei Trasporti.<br />
Sempre nel decennio considerato si rileva una flessione importante nel numero d’imprese e addetti <strong>del</strong>le<br />
attività Pesca, piscicoltura e servizi connessi, mentre le restanti attività hanno avuto invece una <strong>di</strong>minuzione<br />
nella <strong>di</strong>mensione me<strong>di</strong>a d’impresa, in conseguenza <strong>del</strong>l’incremento <strong>del</strong> numero d’imprese rispetto agli addetti.<br />
Nel 1991, gli addetti <strong>del</strong> comune <strong>di</strong> Alghero contavano nell’economia <strong>del</strong>la provincia <strong>di</strong> Sassari per il 6,8%,<br />
salito al 7% nel 2001 (si ricorda che la provincia <strong>di</strong> Sassari in entrambi i perio<strong>di</strong> include l’attuale provincia<br />
Olbia-Tempio). Alghero è stato l’unico comune <strong>del</strong>la Provincia a registrare un aumento proporzionale nel<br />
numero dei suoi addetti, mantenendo la sua posizione in graduatoria <strong>di</strong>etro Sassari e Olbia (che arretrano, pur<br />
mantenendo rispettivamente il 30,6% e il 15,3% degli addetti) e davanti a <strong>Porto</strong> Torres (5,5%) e Arzachena<br />
(4,2%).<br />
Agricoltura<br />
Dai dati <strong>del</strong>l’ultima rilevazione censuaria nell’anno 2000 emerge che il settore agricolo ad Alghero è composto<br />
<strong>di</strong> 1.715 aziende (+20,44% rispetto al 1991), ripartite su una superficie <strong>di</strong> 10.546 ettari.<br />
La <strong>di</strong>stribuzione <strong>del</strong>le superfici agricole per numero <strong>di</strong> aziende può essere meglio osservata attraverso il<br />
rapporto <strong>di</strong> concentrazione <strong>di</strong> Gini (Tab. 1), che assume valore minimo (tipicamente zero) quando il carattere è<br />
equi<strong>di</strong>stribuito e aumenta fino al massimo (uno) quando una sola unità lo possiede completamente. Il rapporto<br />
<strong>di</strong> concentrazione (R) è dato dalla formula:<br />
2 L’ecosistema è un insieme <strong>di</strong> essere viventi, <strong>del</strong>l’ambiente circostante e <strong>di</strong> relazioni chimico-fisiche in uno spazio<br />
<strong>del</strong>imitato.<br />
3 In attesa dei dati censuari <strong>del</strong>la fine <strong>del</strong> primo decennio degli anni 2000, le uniche informazioni, fra loro confrontabili,<br />
sulla struttura produttiva regionale rimangono i Censimenti Nazionali, ossia informazioni raccolte seguendo meto<strong>di</strong><br />
statistici palesi e replicabili. Sono utilizzabili altre fonti statistiche, ma ciascuna fa capo a sé, e assai raramente restituisce<br />
le regole e tecniche <strong>di</strong> raccolta <strong>del</strong>le informazioni, così da renderle confrontabili e validabili. In questo breve scritto si è<br />
dunque preferito affidarsi a statistiche “certe”, anche se oramai datate. Nello sviluppo <strong>del</strong> lavoro riguardante gli aspetti<br />
economico sociali <strong>del</strong> Piano <strong>del</strong> Parco <strong>di</strong> <strong>Porto</strong> <strong>Conte</strong> saranno utilizzate anche ulteriori fonti aggiornate, secondo i temi<br />
specifici che lo riguardano.
R= [1-Σi (Pi – Pi - 1)(Qi + Qi - 1)]<br />
Pi in<strong>di</strong>cano la frazione <strong>del</strong>le unità economiche, il cui carattere è inferiore o uguale all’estremo superiore <strong>del</strong>la<br />
classe e Qi in<strong>di</strong>cano la frazione sull’ammontare complessivo <strong>del</strong>le unità economiche, il cui carattere è inferiore<br />
o uguale all’estremo superiore <strong>del</strong>la classe i. Nella prima colonna la Tabella 1 presenta sette classi <strong>di</strong><br />
superficie, nella seconda e terza colonna sono in<strong>di</strong>viduati come somme cumulate, rispettivamente, il numero<br />
<strong>di</strong> aziende e le superfici (superficie totale e superficie agricola utilizzata (SAU). La terza colonna contiene i<br />
valori <strong>di</strong> Pi, ossia il rapporto fra il numero cumulato <strong>di</strong> aziende per classe <strong>di</strong> superficie e il numero <strong>di</strong> aziende<br />
totali, la quarta colonna in<strong>di</strong>vidua Qi, ossia il rapporto fra l’estensione cumulata <strong>di</strong> ettari <strong>di</strong>sponibili per classe<br />
<strong>di</strong> superficie e la superficie totale <strong>di</strong>sponibile. Le restanti colonne presentano le informazioni utilizzate per il<br />
calcolo <strong>del</strong> rapporto <strong>di</strong> concentrazione R.<br />
Il rapporto <strong>di</strong> concentrazione, sia per la superficie totale, come per la SAU, è molto vicino all’unità (0,80 e 0,79,<br />
per rispettivamente la superficie totale e per la SAU, con ciò in<strong>di</strong>viduando una <strong>di</strong>stribuzione <strong>del</strong>le superfici<br />
concentrata intorno a particolari classi. Questa stessa ripartizione è già in<strong>di</strong>viduabile osservando come le<br />
aziende che detengono il 53,8% <strong>del</strong>la superficie totale sono ben il 98% <strong>del</strong> totale (1.684), mentre per meno <strong>del</strong><br />
2% <strong>del</strong>le aziende (31) è <strong>di</strong>sponibile oltre il 46% <strong>del</strong>la superficie. Simile composizione si ritrova anche nel caso<br />
<strong>del</strong>la SAU.<br />
Nell’arco <strong>di</strong> due decenni, la superficie totale e la SAU si sono in pratica <strong>di</strong>mezzate, mentre il numero <strong>di</strong><br />
aziende è cresciuto <strong>del</strong> 27%. Nel 1980, infatti, si contavano1.348 aziende su una superficie totale <strong>di</strong> 19.313<br />
ettari e una SAU <strong>di</strong> 15.801 ettari. L’aumento <strong>del</strong> numero <strong>del</strong>le aziende e la riduzione <strong>del</strong>la superficie, totale e<br />
SAU, ha portato a una <strong>di</strong>minuzione <strong>del</strong>la superficie me<strong>di</strong>a per azienda, passata dai circa quattor<strong>di</strong>ci ettari <strong>del</strong><br />
1990 ai poco più <strong>di</strong> sei ettari <strong>del</strong> 2000.<br />
A fronte <strong>del</strong>la crescita <strong>del</strong> numero totale d’imprese, si è invece registrata una forte <strong>di</strong>minuzione, fra il 1990 e il<br />
2000, <strong>del</strong>le aziende <strong>del</strong>le classi interme<strong>di</strong>e (dai cinque ai venti addetti), che si sono ridotte <strong>del</strong> 37%. Sono<br />
invece sensibilmente aumentate le aziende con meno <strong>di</strong> 1 ettaro (+55% e +67%, a seconda che si faccia<br />
riferimento alla superficie totale e alla SAU).<br />
Classi <strong>di</strong> superficie Dati cumulati<br />
Aziende Superfici Pi Qi<br />
SUPERFICIE TOTALE<br />
Meno <strong>di</strong> 1 ettaro 839 364 0,489 0,035 0,489 0,035 0,017<br />
1--2 1.157 788 0,675 0,075 0,185 0,109 0,020<br />
2--5 1.347 1.340 0,785 0,127 0,111 0,202 0,022<br />
5--10 1.494 2.450 0,871 0,232 0,086 0,359 0,031<br />
10--20 1.636 4.363 0,954 0,414 0,083 0,646 0,053<br />
20--50 1.684 5.679 0,982 0,538 0,028 0,952 0,027<br />
50 e oltre 1.715 10.546 1,000 1,000 0,018 1,538 0,028<br />
Totale 0,198<br />
R=0,802<br />
SAU
Meno <strong>di</strong> 1 ettaro 982 376 0,753 0,050 0,573 0,050 0,028<br />
1--2 1.239 730 0,722 0,097 0,15 0,146 0,022<br />
2--5 1.403 1.234 0,818 0,163 0,096 0,260 0,025<br />
5--10 1.542 2.291 0,899 0,303 0,081 0,466 0,038<br />
10--20 1.644 3.897 0,970 0,516 0,071 0,819 0,058<br />
20--50 1.701 4.893 0,992 0,647 0,022 1,163 0,025<br />
50 e oltre 1.715 7.558 1,000 1,000 0,008 1,647 0,013<br />
Totale 0,210<br />
R=0,79<br />
Tab. 1 – Rapporto <strong>di</strong> concentrazione <strong>del</strong> Gini (P.U.C. – Alghero, 2009).<br />
La crescita <strong>del</strong>le imprese <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni ridotte segnala chiaramente la proliferazione <strong>di</strong> attività non<br />
professionali, con produzioni destinate in prevalenza all’autoconsumo o alla ven<strong>di</strong>ta occasionale. A<br />
determinare quest’andamento hanno concorso anche altri fattori, collegati con la Politica Agraria Comunitaria<br />
(PAC), in particolare l’espianto dei vigneti, la rotazione <strong>del</strong>le colture e la <strong>di</strong>sponibilità d’incentivi finanziari per la<br />
sospensione <strong>del</strong>la coltivazione (set aside). A ciò si aggiunge la <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> coltivazioni <strong>di</strong> nicchia e <strong>di</strong> prodotti<br />
biologici, <strong>del</strong> florovivaismo e <strong>del</strong>le produzioni in serra. Infine, rispetto al 1990, l’utilizzazione dei terreni è<br />
caratterizzata dalla riduzione <strong>di</strong> seminativi, prati e pascoli, a favore <strong>del</strong>le coltivazioni permanenti, mentre un<br />
ruolo importante nell’organizzazione e nella <strong>di</strong>mensione <strong>del</strong>le imprese lo ha avuto l’espansione <strong>del</strong>le attività<br />
<strong>del</strong>l’agriturismo.<br />
1.2 Industria e Servizi<br />
Anche per Industria e Servizi i Censimenti sono la principale fonte d’informazioni quantitative. Nel 2001<br />
operavano ad Alghero “2.348 imprese4 dei settori industria e servizi, con poco più <strong>di</strong> 6.000 addetti, <strong>di</strong> cui<br />
2.872 <strong>di</strong>pendenti (ovvero iscritti nei libri paga <strong>del</strong>l'impresa) e 3.138 in<strong>di</strong>pendenti (ovvero che svolgono la<br />
propria attività lavorativa senza vincoli <strong>di</strong> subor<strong>di</strong>nazione)” (P.U.C. - Alghero 2009). Nell’intervallo<br />
intercensuario il numero <strong>del</strong>le imprese è cresciuto <strong>del</strong> 19,5%, mentre il totale degli addetti è aumentato <strong>del</strong><br />
10,8%.<br />
Le attività che hanno più contribuito alla crescita <strong>del</strong> numero d’imprese sono stati le Costruzioni, l’Istruzione e i<br />
Trasporti. Al contrario, hanno contribuito negativamente le imprese <strong>del</strong>l’attività Agricoltura, Pesca e<br />
Piscicoltura, censite nel settore industriale. Gli apporti positivi in termini <strong>di</strong> addetti provengono, invece, dalle<br />
attività dei Trasporti e <strong>del</strong>l’Estrazione dei minerali, mentre quelli negativi derivano ancora dall’Agricoltura,<br />
Pesca e Piscicoltura (-83,7%) e dall’Interme<strong>di</strong>azione Monetaria e Finanziaria (-11%). Quest’ultime variazioni<br />
sono da considerarsi <strong>del</strong> tutto negative, infatti, sia l’Agricoltura, sia l’Interme<strong>di</strong>azione Finanziaria è segnata “da<br />
profon<strong>di</strong> processi <strong>di</strong> liberalizzazione/integrazione derivanti dal completamento <strong>del</strong> Mercato Unico e<br />
4 Definite come unità giuri<strong>di</strong>co-economiche che producono beni e servizi (imprese in<strong>di</strong>viduali, società <strong>di</strong> persone,<br />
società <strong>di</strong> capitali, società cooperative, aziende speciali <strong>di</strong> comuni o province o regioni). Sono assimilati alle imprese<br />
anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti. Le unità locali rappresentano il luogo fisico (es. agenzia, albergo, bar,<br />
cava, domicilio, laboratorio, negozio, ristorante e altri) nel quale un'unità giuri<strong>di</strong>co-economica (impresa, istituzioni<br />
pubbliche e istituzioni non profit) esercita una o più attività economiche.
dall’introduzione <strong>del</strong>l’euro, con conseguente ristrutturazione <strong>del</strong>l’organizzazione aziendale in funzione <strong>di</strong> una<br />
maggiore efficienza (a favore dei beneficiari finali, consumatori e imprese)” (P.U.C. - Alghero, 2009).<br />
Si analizzano <strong>di</strong> seguito i principali mutamenti riscontrati in tre attività economiche <strong>del</strong> settore servizi che sono<br />
maggiormente legate alla specializzazione turistica <strong>del</strong>la città: “Alberghi e ristoranti”, “Trasporti,<br />
magazzinaggio e comunicazioni” e “Attività immobiliari, noleggio, informatica”.<br />
Nel periodo intercensuale, l’attività Alberghi e ristoranti subisce una <strong>di</strong>minuzione nel numero <strong>di</strong> addetti <strong>del</strong><br />
7,4%. Fra gli Alberghi la flessione principale riguarda i motel con ristorante, mentre alla riduzione nel numero<br />
degli addetti <strong>di</strong> ristoranti, trattorie, pizzerie e altri, si contrappone un andamento positivo per rosticcerie,<br />
friggitorie e per i servizi <strong>di</strong> ristorazione in self-service.<br />
Nell’attività Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, si può vedere la <strong>di</strong>saggregazione dei gruppi economici<br />
in classi, dove i due ambiti maggiormente in crescita sono quelli <strong>del</strong> trasporto con taxi, che quadruplica nel<br />
periodo, e <strong>del</strong> trasporto <strong>di</strong> merci su strada, che raddoppia rispetto all’anno <strong>iniziale</strong>.<br />
L’analisi degli altri gruppi rende evidente che nel 1991 gli addetti alla classe “trasporti marittimi e costieri” e<br />
“altre attività connesse ai trasporti” erano in pratica inesistenti (ricor<strong>di</strong>amo che stiamo parlando <strong>di</strong> addetti alle<br />
imprese private), nel 2001 si notano rilevanti valori positivi per entrambe le classi (+12 addetti la prima e +79<br />
addetti per la seconda, con valori pari a 1 e 0 rispettivamente nell’anno base).<br />
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, professionali e impren<strong>di</strong>toriali, mettono in luce un piccolo<br />
cambiamento strutturale dovuto all’emergere <strong>di</strong> attività prima assenti, come la ricerca e lo sviluppo. Nello<br />
stesso tempo si osserva la crescita <strong>del</strong>le altre attività professionali e impren<strong>di</strong>toriali, che aumentano il loro<br />
peso sul totale in termini <strong>di</strong> addetti passando dal 63% <strong>del</strong> 1991 al 73% <strong>del</strong> 2001.<br />
Infine, parallelamente alla riduzione <strong>di</strong> servizi quali la pubblicità e le investigazioni, si registra un aumento<br />
rilevante <strong>di</strong> attività avanzate, quali quelle legali, <strong>di</strong> consulenza, d’indagini <strong>di</strong> mercato, architettura-ingegneria<br />
ed altre attività tecniche, nonché <strong>di</strong> servizi più tra<strong>di</strong>zionali come pulizie e <strong>di</strong>sinfestazioni.<br />
1.3 Commercio<br />
Le attività commerciali hanno occupato “nel periodo 1991-2001 una me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> 1.805 addetti <strong>di</strong>stribuiti su circa<br />
755 imprese” (P.U.C. - Alghero, 2009). Nell’arco <strong>del</strong> decennio, il peso dei commerci si è ridotto <strong>di</strong> un punto<br />
percentuale in termini <strong>di</strong> numero <strong>di</strong> addetti e <strong>di</strong> più <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci punti in termini <strong>di</strong> numero d’imprese. Le cause sono<br />
da ricercare non solo nella maggiore crescita relativa <strong>del</strong>le altre attività, almeno negli addetti, ma anche in una<br />
riduzione significativa nel numero <strong>di</strong> imprese esercenti, conseguenza anche <strong>di</strong> processi <strong>di</strong> aggregazione e<br />
fusione.<br />
Per una più puntuale valutazione, l’attività sarà scomposta in tre comparti: “Commercio collegato agli<br />
autoveicoli, Commercio all’ingrosso e interme<strong>di</strong>ari (esclusi gli autoveicoli) e Commercio al dettaglio” (P.U.C. -<br />
Alghero, 2009). Ne risulta una crescita eccezionale <strong>del</strong> commercio all’ingrosso e degli interme<strong>di</strong>ari <strong>del</strong><br />
commercio (+189,2%), “accompagnata, tuttavia, da una flessione degli altri due comparti”. In particolare,<br />
<strong>di</strong>saggregando ulteriormente la <strong>di</strong>visione relativa al Commercio all’ingrosso e gli interme<strong>di</strong>ari, “è proprio la<br />
crescita degli interme<strong>di</strong>ari <strong>del</strong> commercio (+505%) e <strong>del</strong> commercio all’ingrosso dei macchinari (+250%) a<br />
trainare la crescita <strong>del</strong> numero degli addetti” (P.U.C. - Alghero, 2009).<br />
Per quanto concerne gli interme<strong>di</strong>ari è da notare la crescita soprattutto degli addetti all’interme<strong>di</strong>azione nel<br />
commercio alimentare (da 1 a 21 addetti), mentre per il commercio al dettaglio si osserva una leggera<br />
flessione nel decennio (-3,4%) cui si contrappone l’aumento degli addetti al gruppo dei dettaglianti non<br />
specializzati e a quello dei prodotti farmaceutici, cosmetici e <strong>di</strong> articoli <strong>di</strong> profumeria.
1.4 Turismo<br />
Considerando i dati riscontrati dall’Assessorato al Turismo <strong>del</strong>la Provincia <strong>di</strong> Sassari (2005-2009), Alghero<br />
evidenzia una buona tra<strong>di</strong>zione turistica. Fra italiani e stranieri, nell’anno 2005, la Città evidenziava oltre 892<br />
mila presenze e quasi 208 mila arrivi. L’anno successivo ha fatto registrare 857 mila presenze e oltre 197 mila<br />
arrivi, mentre nel 2007 il flusso turistico è stato caratterizzato da più <strong>di</strong> 915 mila presenze e 241 mila arrivi. Per<br />
gli ultimi due anni analizzabili sono emersi i seguenti dati: nel 2008 circa 954 mila presenze e quasi 240 mila<br />
arrivi, infine il 2009 ha fatto rilevare ben oltre 888 mila presenze e più <strong>di</strong> 232 mila arrivi. Analizzando tali valori<br />
si comprende come il trend negli ultimi tre anni abbia subìto un incremento, per poi essere caratterizzato da<br />
una flessione nel 2009. Esattamente, le presenze riscontrate tra il 2007 e il 2008 hanno visto una crescita <strong>del</strong><br />
4,3%, subendo poi un calo <strong>del</strong> 6,9% nel 2009.<br />
L’andamento degli arrivi si è <strong>di</strong>mostrato pressoché in linea con quello <strong>del</strong>le presenze, anche se manifesta già<br />
una <strong>di</strong>minuzione nella stagione 2007-2008, seppur lieve, pari allo 0,41% rispetto l’anno precedente. Nel 2009<br />
tale tendenza è confermata, facendo registrare una variazione negativa <strong>del</strong> 3,3%.<br />
La componente straniera, nell’ambito <strong>del</strong> turismo relativo alla Riviera <strong>del</strong> Corallo, ha sempre rivestito una<br />
notevole importanza, sia in termini <strong>di</strong> presenze che <strong>di</strong> arrivi. Nel 2007 le presenze straniere erano pari al<br />
62,6% <strong>del</strong> totale, gli arrivi facevano registrare il 59,2%. Il 2008 ha evidenziato presenze nella misura <strong>del</strong><br />
57,9% ed arrivi costituiti dal 55,4%. Il 2009 si è chiuso con il 60,2% <strong>di</strong> presenze e il 58,4% <strong>di</strong> arrivi. Le<br />
percentuali mettono in risalto l’importanza <strong>del</strong>la componente straniera, caratterizzata da una flessione nel<br />
2008, anche se già in ripresa nel 2009.<br />
Dando uno sguardo ai flussi italiani si nota come nel 2007, rispetto al movimento turistico totale, essi hanno<br />
costituito ben il 40,8% <strong>del</strong>le presenze e il 37,4% degli arrivi. Nel 2008 le presenze hanno fatto registrare il<br />
42,1%, gli arrivi il 44,6%. Infine, il 2009, è stato caratterizzato da presenze pari al 39,8%, mentre gli arrivi<br />
hanno rappresentato il 41,6%. Ciò evidenzia come la componente italiana sia stata contrad<strong>di</strong>stinta da un<br />
incremento avvenuto nell’anno 2008, successivamente seguito dal calo riscontrato nel 2009.<br />
“La presenza straniera assume un ruolo fondamentale non solo nella determinazione <strong>del</strong>l'entità ma anche<br />
<strong>del</strong>la <strong>di</strong>namica <strong>del</strong> fenomeno turistico locale” (P.U.C. - Alghero, 2009). La domanda turistica più numerosa<br />
proviene dai paesi <strong>del</strong>l’Unione europea e nel corso <strong>del</strong> 2007 ha originato me<strong>di</strong>amente oltre il 75% <strong>del</strong> volume<br />
turistico estero. Al primo posto troviamo la Gran Bretagna, che con un totale <strong>di</strong> circa un milione <strong>di</strong> presenze si<br />
attesta su una quota pari al 30% circa nel corso <strong>del</strong> 2007. Nella graduatoria dei Paesi <strong>di</strong> provenienza emerge<br />
il secondo posto <strong>del</strong>la Germania (213.863 presenze pari circa 16% <strong>del</strong> totale estero); seguono la Svezia<br />
(337.435 presenze), l’Irlanda (233.952), la Spagna (213.863), la Francia (211.567) e, infine, come nazione<br />
extraeuropea gli Stati Uniti circa 50.000 presenze.<br />
Le presenze turistiche rilevano caratteristiche significativamente <strong>di</strong>fferenti tra la componente italiana ed estera.<br />
La prima <strong>di</strong>fferenza riguarda la concentrazione <strong>del</strong>le presenze italiane nel mese <strong>di</strong> agosto, cui segue il mese <strong>di</strong><br />
luglio, anche se negli ultimi anni si è registrato un aumento <strong>del</strong>le presenze anche nel mese <strong>di</strong> giugno.<br />
Per quanto riguarda la componente internazionale, invece, si nota una predominanza <strong>del</strong>le presenze nel mese<br />
<strong>di</strong> luglio, con una tendenza all’aumento <strong>del</strong>le presenze nei mesi <strong>di</strong> spalla, principalmente primaverili e<br />
autunnali (settembre ed ottobre).<br />
“A livello complessivo, si registra una ridottissima presenza <strong>di</strong> turisti nel periodo invernale, tuttavia, si nota che<br />
nell’ultimo decennio vi è una tendenza all’aumento <strong>del</strong>le presenze turistiche straniere durante i mesi invernali.<br />
La seconda <strong>di</strong>fferenza tra le due componenti riguarda le quote relative: la quota internazionale è aumentata<br />
dagli anni ’80 agli anni ‘00, raggiungendo il 47,9%. Negli ultimi quattro anni la quota straniera è maggiore <strong>del</strong><br />
50% e nel 2007 ha raggiunto la ragguardevole quota <strong>del</strong> 62,4%. Simile analisi si può tracciare per gli arrivi
turistici internazionali, che hanno subìto variazioni positive nelle quote, passando da un valore percentuale<br />
pari a 22,8% negli anni ’80 a un valore pari a 47,7% negli anni ‘00” (P.U.C. - Alghero, 2009).<br />
Anche Alghero <strong>di</strong>mostra <strong>di</strong> risentire <strong>del</strong>la stagnazione economica in cui versa gran parte <strong>del</strong>l’economia<br />
mon<strong>di</strong>ale in conseguenza <strong>del</strong>la crisi, prima finanziaria poi reale, iniziata alla fine <strong>del</strong> 2007 e dalla quale<br />
soltanto ora, e limitatamente ad alcuni paesi, si comincia a uscire. La <strong>di</strong>minuzione <strong>del</strong> red<strong>di</strong>to <strong>di</strong>sponibile o,<br />
comunque, la sua stagnazione ha influito su tutti i consumi e, quin<strong>di</strong>, anche sul turismo. Ne hanno risentito <strong>di</strong><br />
meno le destinazioni particolarmente forti per capacità <strong>di</strong> attrazione e quelle più competitive in termini <strong>di</strong><br />
prezzo.<br />
La <strong>di</strong>ffusione dei voli low cost rende continuamente <strong>di</strong>sponibili nuove destinazioni, ampliando la gamma <strong>del</strong>le<br />
scelte e mo<strong>di</strong>ficando gli stili <strong>di</strong> vacanza. Come <strong>di</strong>mostrano i dati sugli arrivi e le presenze ad Alghero, l’elevato<br />
aumento dei flussi turistici, dovuto all’inserimento <strong>di</strong> Alghero nelle rotte dei voli low cost, da qualche tempo<br />
prevalgono gli andamenti congiunturali che richiedono una risposta adeguata da parte degli operatori privati e<br />
pubblici.<br />
Qualche in<strong>di</strong>cazione sull’evoluzione dei comportamenti si ricava dall’analisi <strong>del</strong>la durata <strong>del</strong> soggiorno me<strong>di</strong>o,<br />
calcolata dal rapporto tra il numero <strong>del</strong>le presenze e il numero degli arrivi, ad Alghero. Come detto in<br />
precedenza la componente nazionale ed estera denotano un andamento <strong>di</strong>fferente. Dalla prima metà degli<br />
anni Duemila, la permanenza me<strong>di</strong>a degli italiani tende a mantenersi relativamente costante, a parte il calo<br />
registratosi nel 2007. La permanenza me<strong>di</strong>a degli stranieri si riduce con il passare dei decenni, da una me<strong>di</strong>a<br />
pari a 7 giornate negli anni Ottanta ad una me<strong>di</strong>a pari a circa 4 giornate negli anni Duemila, fino a giungere ad<br />
una me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> quasi due giornate nel 2009. Tale tendenza è da correlare, probabilmente, all’introduzione dei<br />
voli low-cost, che hanno reso possibile una più facile accessibilità all’Isola, con un conseguente soggiorno più<br />
contenuto nella destinazione prescelta.<br />
Nei tre decenni, complessivamente, il soggiorno nel comparto alberghiero è meno prolungato <strong>di</strong> quello che si<br />
registra nel comparto extralberghiero. Con il passare <strong>del</strong> tempo, si nota in particolar modo una permanenza<br />
relativamente più prolungata degli italiani nelle strutture complementari. Dunque, con il passare <strong>del</strong> tempo, c’è<br />
stata la tendenza <strong>del</strong>la componente nazionale a soggiornare nelle strutture ricettive algheresi per un numero<br />
<strong>di</strong> giornate leggermente superiore, pari me<strong>di</strong>amente a 4.<br />
Le informazioni statistiche su arrivi e partenze sono ovviamente da porre in relazione con la struttura ricettiva,<br />
sia quella presente nell’Isola, sia quella inse<strong>di</strong>ata nel comune <strong>di</strong> Alghero. Il parco ricettivo complessivo <strong>del</strong>la<br />
Sardegna (ISTAT, 2006) è costituito da 1.884 esercizi, <strong>di</strong> cui 763 bed and breakfast (B&B), per un totale<br />
complessivo <strong>di</strong> 170.847 posti letto. Nel settore alberghiero si contano 777 esercizi, 88.655 posti letto, 37.753<br />
camere e 37.564 bagni. Il settore extralberghiero è formato da 344 esercizi e 78.423 posti letto.<br />
A livello provinciale, “la leadership spetta alla provincia <strong>di</strong> Olbia-Tempio che conta il 32,7% <strong>del</strong>l’offerta<br />
complessiva in termini <strong>di</strong> esercizi e il 40% dei posti letto. Segue la provincia <strong>di</strong> Cagliari che ha una capacità <strong>di</strong><br />
accoglienza complessiva relativamente superiore rispetto alla provincia <strong>di</strong> Sassari” (P.U.C. - Alghero, 2009).<br />
La <strong>di</strong>stribuzione territoriale dei B&B ha invece una composizione <strong>di</strong>fferente, infatti, “l’attuale provincia <strong>di</strong><br />
Sassari detiene le quote più elevate a livello regionale, sia in termini <strong>di</strong> esercizi che <strong>di</strong> posti letto, e la provincia<br />
<strong>di</strong> Oristano gli è subito vicina con il 25,2% degli esercizi e il 26,4% <strong>di</strong> posti letto. Al contrario, nelle restanti<br />
nuove province (a parte quella cagliaritana) non si è avuto un rilevante sviluppo <strong>di</strong> questa tipologia <strong>di</strong><br />
ricettività; Olbia-Tempio conta, ad esempio, soltanto l’8% <strong>del</strong>l’offerta regionale” (P.U.C. - Alghero, 2009).<br />
Alghero detiene “una posizione <strong>di</strong> leadership rispetto a ciascuna tipologia <strong>di</strong> struttura ricettiva” (P.U.C. -<br />
Alghero, 2009). Riguardo l’incidenza <strong>del</strong> parco ricettivo <strong>del</strong> comune <strong>di</strong> Alghero, facendo riferimento ai dati<br />
provinciali riportati dall’Assessorato al Turismo-Provincia <strong>di</strong> Sassari (2006-2009), si nota come la città catalana
costituisca una risorsa importante. Nel 2006 si registrava un’incidenza sulla ricettività provinciale totale pari al<br />
32,5%, salita poi al 43,6% nel 2007. L’anno successivo evidenziava il 43,7% <strong>del</strong>la ricettività complessiva,<br />
mentre il 2008 è stato caratterizzato dal 43,3%.<br />
Tra il 2006 e il 2009 si è verificato un incremento degli esercizi alberghieri che nel 2006 costituivano il 42,3%<br />
<strong>del</strong>la ricettività algherese, il successivo anno il 56%. Nel 2008 si riscontrava il 54,5%, mentre nel 2009 si è<br />
giunti al 53,5%.<br />
Si può osservare come nel 2008-2009 ci sia stata un’inversione <strong>di</strong> tendenza, con gli esercizi complementari<br />
(campeggi, villaggi turistici, B&B e altri) capaci <strong>di</strong> offrire un maggior numero <strong>di</strong> posti letto. Questa tendenza<br />
trova riscontro nello sviluppo <strong>di</strong> strutture ricettive alternative quali i B&B, che hanno avuto una notevole<br />
<strong>di</strong>ffusione nel comune <strong>di</strong> Alghero, riducendo nello stesso tempo la <strong>di</strong>mensione ricettiva me<strong>di</strong>a <strong>del</strong> comparto,<br />
poiché si tratta <strong>di</strong> strutture piuttosto piccole che dotano me<strong>di</strong>amente <strong>di</strong> 2 camere per esercizio.<br />
Gli esercizi alberghieri <strong>del</strong>la provincia <strong>di</strong> Sassari, tra il 2006 e il 2007, fanno registrare una variazione positiva<br />
<strong>del</strong> 2,8%, che si mantiene costante anche nell’anno successivo. Il numero <strong>di</strong> tali esercizi <strong>di</strong>minuisce nel 2009,<br />
mostrando una variazione negativa (-5,9%). Le residenze turistico-alberghiere si mantengono invece costanti<br />
per tutto il periodo considerato (2006-2009).<br />
Osservando gli esercizi complementari spiccano notevolmente le variazioni positive riscontrate per i B&B.<br />
Infatti, nel 2007, si è registrato un aumento d’essi pari al 26%, avvenuto anche nell’anno successivo, se pure<br />
in misura minore, <strong>del</strong> 22,2%. Il 2009 faceva registrare ancora un incremento <strong>di</strong> questa tipologia <strong>di</strong> esercizi<br />
(+10,2%). Nell’ambito <strong>del</strong>le strutture ricettive complementari, si è verificato un aumento degli alloggi in affitto<br />
gestiti in forma impren<strong>di</strong>toriale (+33,3% nel 2007, +47% nel 2008 e nessun incremento nel 2009), così come<br />
per le case <strong>di</strong> ferie, variate solo nel 2008 (+50%). Campeggi, villaggi turistici e ostelli per la gioventù non<br />
hanno mostrato variazioni numeriche.<br />
Analizzando le <strong>di</strong>mensioni <strong>del</strong>le strutture alberghiere si nota un complessivo e consistente aumento (2006-<br />
2009), quantificato nella misura <strong>del</strong> 79,5% per le camere e <strong>del</strong> 44% per i posti letto.<br />
La capacità ricettiva negli esercizi complementari ha visto gli incrementi maggiori nei B&B, che dal 2006 al<br />
2009 manifestano un incremento <strong>di</strong> posti letto <strong>del</strong> 46,5%, come accaduto alle case per le ferie (+30,2%) e agli<br />
alloggi in affitto gestiti in forma impren<strong>di</strong>toriale (+35,9%). Rimane invariata, invece, la <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> posti letto<br />
per campeggi, villaggi turistici e ostelli per la gioventù.<br />
La <strong>di</strong>mensione degli alberghi varia notevolmente secondo la categoria. Si calcola che dal 2006 al 2009 gli<br />
esercizi <strong>di</strong> categoria più modesta, costituiti dagli alberghi a uno e due stelle, sono <strong>di</strong>minuiti <strong>del</strong> 300%, mentre<br />
quelli a tre e quattro stelle sono rimasti pressoché invariati, con i secon<strong>di</strong> che presentano una piccola<br />
<strong>di</strong>minuzione <strong>di</strong> camere (-6,3%) e posti letto <strong>di</strong>sponibili (-5,1%). Dal 2006 vi è da registrare un incremento degli<br />
esercizi a 5 stelle, che passano da 1 a 2 strutture, facendo riscontrare nel 2009 un incremento <strong>di</strong> camere<br />
(+78%) e posti letto (+79,6%).<br />
Le residenze turistico-alberghiere, come detto in precedenza, dal 2006 al 2009 rimangono invariate nel<br />
numero, ma anche nelle camere e nei posti letto <strong>di</strong>sponibili.<br />
A conclusione <strong>del</strong>l’analisi effettuata occorre rilevare che nel 2009 le strutture ricettive comunali, rispetto al<br />
2006, denotano un aumento superiore al 40%.<br />
Oltre alla ricettività ufficiale, vi è certamente una ricettività sommersa, che sfugge <strong>di</strong> conseguenza alla<br />
rilevazione statistica. Non sono dunque rilevabili le case private date in affitto ai turisti da titolari non iscritti al<br />
REC (l’albo professionale al quale devono iscriversi coloro che intendono intraprendere attività turisticoricettiva),<br />
nonostante siano un numero consistente.
La ricettività sommersa, in termini economici, rappresenta una forma <strong>di</strong> concorrenza nei confronti degli<br />
esercizi classificati, anche se offre un non trascurabile contributo all’economia locale, generando effetti positivi<br />
e integrati con l’attività agricola, la <strong>di</strong>stribuzione al dettaglio e la produzione <strong>di</strong> materiali <strong>di</strong> uso turistico. Non si<br />
possono però negare gli effetti negativi <strong>del</strong> fenomeno che si ripercuote sulla collettività poiché un numero non<br />
quantificabile ma sicuramente rilevante <strong>di</strong> non residenti, esercita forti pressioni sulla popolazione residente,<br />
incidendo negativamente sull’uso <strong>di</strong> beni e servizi pubblici, come risorse idriche, smaltimento <strong>di</strong> rifiuti e altro,<br />
contribuendo in modo importante al deterioramento <strong>del</strong>le risorse ambientali.<br />
Per avere una stima, sia pure approssimativa, <strong>del</strong>la consistenza <strong>del</strong> settore ricettivo non classificato si può<br />
“prendere in considerazione il totale <strong>del</strong>le abitazioni non occupate identificabili come seconde case” (P.U.C. -<br />
Alghero, 2009).<br />
Pertanto si rileva che queste strutture immettono sul mercato <strong>del</strong>le vacanze un’offerta ricettiva costituita da<br />
29.450 unità, ossia il 71,9% <strong>del</strong>l’offerta ricettiva totale (ISTAT, 2006).<br />
2. Demografia, Sistema locale e occupazione<br />
Definite le con<strong>di</strong>zioni strutturali che caratterizzano i settori portanti <strong>del</strong>l’economia nel comune <strong>di</strong> Alghero,<br />
saranno esaminati <strong>di</strong> seguito tre <strong>di</strong>versi caratteri: lo stato <strong>del</strong>la demografia, il cosiddetto Sistema Locale <strong>del</strong><br />
lavoro (SLL) e, seppure solo per alcuni cenni, il mercato <strong>del</strong> lavoro. Se il significato e contenuto dei termini<br />
demografia e mercato <strong>del</strong> lavoro è sufficientemente esplicito, il SSL richiede invece una spiegazione<br />
appropriata.<br />
Per SLL si intende una aggregazione <strong>di</strong> comuni aventi particolari caratteristiche, la prima <strong>del</strong>le quali, utile a<br />
in<strong>di</strong>viduarli, riguarda gli spostamenti quoti<strong>di</strong>ani per motivi <strong>di</strong> lavoro. Si tratta <strong>di</strong> unità territoriali costituite da più<br />
comuni contigui fra loro, geograficamente e statisticamente comparabili.<br />
La configurazione territoriale dei SLL cambia nel tempo poiché riflette i mutamenti <strong>del</strong>l’organizzazione<br />
territoriale <strong>del</strong>la società e <strong>del</strong>l’economia <strong>del</strong> <strong>territorio</strong>. In Sardegna i SLL passano dai 46 <strong>del</strong> 1991 ai 45 nel<br />
2001, con una variazione % pari a -2,17 (in Italia è -12,5%). Ciò non significa che un solo Sistema Locale sia<br />
stato inglobato in un altro, ma che vi sono state più ampie variazioni in termini <strong>di</strong> creazione <strong>di</strong> nuovi SLL e<br />
scomparsa <strong>di</strong> altri.<br />
La 15/a e<strong>di</strong>zione <strong>del</strong> Rapporto annuale sulla situazione <strong>del</strong> Paese 2006 affermava che la Sardegna, insieme<br />
con l’Abruzzo, <strong>di</strong>mostra una situazione dei sistemi locali <strong>del</strong> lavoro significativamente migliore <strong>di</strong> quelle <strong>del</strong>la<br />
me<strong>di</strong>a <strong>del</strong>le regioni <strong>del</strong> Sud Italia, in sintesi "la combinazione <strong>del</strong> tasso <strong>di</strong> occupazione e <strong>di</strong> quello <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>soccupazione" nel 2006 era stata positiva.<br />
A questo proposito, è utile riportare nella tabella seguente la <strong>di</strong>stribuzione dei SLL per classe d’ampiezza<br />
demografica riguardante la Sardegna, e lasciare a un momento successivo la presentazione <strong>del</strong> SLL <strong>del</strong><br />
comune <strong>di</strong> Alghero:<br />
Classi <strong>di</strong> ampiezza demografica 2001- 2006<br />
2001 2006<br />
fino a 11.000 14 13<br />
11.001 - 20.000 13 14<br />
20.001 - 50.000 11 12<br />
50.001 - 100.000 5 4<br />
100.001 - 250.000 1 1<br />
oltre 250.000 1 1
Venendo all’inquadramento generale <strong>del</strong>la demografia in Sardegna la sua evoluzione è con<strong>di</strong>zionata da fattori<br />
riguardanti la struttura economica, sociale, culturale e storica <strong>del</strong>la popolazione. Tali variabili provocano<br />
mutamenti che tendono a consolidarsi lungo un arco temporale <strong>di</strong> ampiezza non quantificabile a priori,<br />
riflettendo poi situazioni contingenti che possono avere natura perio<strong>di</strong>ca, occasionale o <strong>del</strong> tutto casuale.<br />
Dal secondo dopoguerra, la Sardegna è <strong>di</strong>venuta da terra ad alta natalità a terra a bassissima fecon<strong>di</strong>tà e<br />
crescita naturale negativa (è in questo momento la regione italiana a più bassa fecon<strong>di</strong>tà e più rapido<br />
invecchiamento). Inoltre, da bacino <strong>di</strong> emigrazione è <strong>di</strong>venuta meta <strong>di</strong> immigrazione esterna, seppur con realtà<br />
molto <strong>di</strong>versificate al suo interno.<br />
Soprattutto nella parte settentrionale <strong>del</strong>l’Isola, dopo la stabilità demografica che ha caratterizzato gli anni<br />
novanta <strong>del</strong> secolo scorso, nell’ultimo decennio si è assistito a una ripresa <strong>del</strong>la crescita demografica a tassi<br />
più sostenuti rispetto a quelli regionali, anche se ciò è da imputare esclusivamente all’incremento <strong>del</strong>la<br />
popolazione <strong>di</strong> pochi comuni, a fronte <strong>del</strong> decremento generalizzato che interessa vaste aree <strong>del</strong> <strong>territorio</strong>.<br />
Nell’ambito <strong>del</strong>lo stu<strong>di</strong>o <strong>del</strong>le <strong>di</strong>namiche <strong>di</strong> sviluppo <strong>del</strong>le popolazioni si è accresciuta, negli ultimi anni,<br />
l’esigenza <strong>di</strong> previsioni demografiche sempre più articolate secondo componenti territoriali e strutturali, come il<br />
sesso e l’età. L’Istat ha sviluppato previsioni <strong>del</strong>la popolazione nazionale italiana, con il dettaglio <strong>del</strong>la<br />
struttura, fino al 2051, fornendo le stesse stime a livello regionale e provinciale, così da garantire un’identica<br />
qualità <strong>di</strong> informazione ad enti e decisori locali.<br />
Al riguardo, l’Istat propone tre <strong>di</strong>stinti scenari <strong>di</strong> previsione demografica per i prossimi decenni in Sardegna:<br />
un’ipotesi “centrale”, che fornisce le <strong>di</strong>mensioni e la struttura <strong>del</strong>la popolazione più “verosimile” analizzando le<br />
recenti tendenze demografiche territoriali; e altri due scenari, un’ipotesi “bassa” ed una “alta”, che hanno il<br />
ruolo <strong>di</strong> definire il possibile campo <strong>di</strong> variazione all’interno <strong>del</strong> quale dovrebbe andare a collocarsi la<br />
popolazione sulla base <strong>di</strong> presupposti <strong>di</strong> fecon<strong>di</strong>tà, mortalità e migrazione, rispettivamente più e meno<br />
pessimistici rispetto allo scenario ritenuto più probabile.<br />
Il calo <strong>del</strong>la popolazione sarda dovrebbe assumere caratteristiche marcate nel lungo termine, con una<br />
riduzione fino a 1,470 milioni nel 2050 (-11,6%). Nel breve-me<strong>di</strong>o termine la popolazione regionale si<br />
dovrebbe invece mantenere pressoché stabile, pur con una struttura per età <strong>del</strong>la popolazione molto<br />
sbilanciata verso le classi anziane. Nel 2020 si conterebbero due ultra sessantacinquenni per ogni giovane tra<br />
0 e 14 anni. L’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> vecchiaia andrebbe poi ad aumentare in maniera proporzionale, fino a oltre 3 anziani<br />
per ogni giovane al termine <strong>del</strong> periodo <strong>di</strong> previsione.<br />
Le attese <strong>del</strong>l’Istat confermano la tendenza <strong>del</strong>la popolazione <strong>del</strong>l’Isola anche nell’ipotesi “alta” che, grazie a<br />
sal<strong>di</strong> migratori più marcatamente positivi e miglioramenti considerevoli nella fecon<strong>di</strong>tà e nella sopravvivenza,<br />
permetterebbero una leggera crescita <strong>del</strong> valore assoluto fino al 2016 e un successivo calo prima lento, poi<br />
più consistente, fino a 1,554 milioni nel 2050 (-6,6% rispetto al 2007). Se si considerasse infine la previsione<br />
nell’ipotesi “bassa”, la popolazione sarda si ridurrebbe <strong>del</strong> 2% nei primi quin<strong>di</strong>ci anni, ma <strong>di</strong> quasi il 20% dopo<br />
altri venticinque anni.<br />
2.1 Demografia nel comune <strong>di</strong> Alghero<br />
In tale inquadramento, “il comune <strong>di</strong> Alghero è tra quelli che hanno consentito la ripresa <strong>del</strong>la crescita<br />
demografica nella provincia <strong>di</strong> Sassari” (P.U.C. - Alghero, 2009): la sua popolazione supera <strong>di</strong> poco le 40 mila<br />
unità (ISTAT, 2007), anche se considerando la fonte anagrafica comunale si attesterebbe ad oltre 43.000<br />
abitanti.<br />
“La particolare struttura per età <strong>del</strong>la popolazione, frutto <strong>del</strong>la storia demografica <strong>del</strong>la Città, ha consentito sino<br />
al 2004 <strong>di</strong> mantenere i tassi <strong>di</strong> natalità, seppur molto inferiori all’attuale dato me<strong>di</strong>o nazionale (9,4-9,5 per
mille), su livelli capaci ancora <strong>di</strong> contrastare l’incremento dei tassi <strong>di</strong> mortalità5” (P.U.C. - Alghero, 2009).<br />
Questi ultimi, tuttora molto bassi per la scarsa presenza relativa <strong>di</strong> popolazione nelle classi <strong>di</strong> età più<br />
avanzate, nei prossimi anni tenderanno a crescere in modo deciso. “Già nel me<strong>di</strong>o periodo, con<br />
l’approssimarsi alle età più anziane, con probabilità <strong>di</strong> morte crescenti <strong>di</strong> contingenti sempre maggiori <strong>di</strong><br />
popolazione, i tassi <strong>di</strong> mortalità saranno destinati a crescere ben oltre il valore nazionale che, attualmente, si<br />
attesta intorno al 9,4 per mille, in linea con il tasso <strong>di</strong> natalità” (P.U.C. - Alghero, 2009).<br />
Il regime demografico naturale negli ultimi anni ha segnato il passaggio da sal<strong>di</strong> tendenzialmente positivi a<br />
<strong>di</strong>fferenziali negativi crescenti, a causa <strong>del</strong> calo <strong>del</strong>la fecon<strong>di</strong>tà dei decenni passati e <strong>del</strong> conseguente<br />
invecchiamento <strong>del</strong>la popolazione. Per quanto riguarda i movimenti migratori appare <strong>di</strong>fficile effettuare <strong>del</strong>le<br />
previsioni, a causa <strong>del</strong>la minor rigi<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> tali comportamenti demografici rispetto alla storia passata <strong>del</strong>la<br />
popolazione. Negli ultimi <strong>di</strong>eci anni sembra consolidarsi un’eccedenza piuttosto marcata <strong>del</strong>le nuove iscrizioni<br />
rispetto alle cancellazioni anagrafiche per emigrazione. L’incremento <strong>del</strong>la popolazione è da attribuirsi ormai<br />
totalmente alla componente migratoria, la quale in futuro avrà un ruolo determinante per garantire la stabilità<br />
demografica o, quantomeno, contrasterà l’ampiamente avviato processo <strong>di</strong> invecchiamento e il decremento <strong>di</strong><br />
popolazione che ne conseguirebbe. Infatti, le migrazioni, oltre a contribuire all’evoluzione numerica <strong>del</strong>la<br />
popolazione, possono incidere, anche notevolmente, sui comportamenti demografici.<br />
La mobilità <strong>del</strong>le persone fra i 20 e i 40 anni deriva da ragioni sia biologiche che socio-economiche; “è proprio<br />
in questa fascia <strong>di</strong> età che avviene il <strong>di</strong>stacco dalla famiglia <strong>di</strong> origine, la formazione <strong>di</strong> un nuovo nucleo<br />
familiare, la ricerca <strong>di</strong> un lavoro e <strong>di</strong> una casa” (P.U.C. - Alghero, 2009). Tutti eventi che comportano anche<br />
importanti scelte <strong>di</strong> localizzazione, che possono essere influenzate in maniera decisiva da <strong>di</strong>namiche<br />
economiche e finanziarie contingenti.<br />
Nonostante il trend positivo <strong>di</strong> attrazione <strong>di</strong> nuovi residenti dall’esterno, deve essere rilevata una consistente<br />
per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> giovani coppie con bambini che si spostano principalmente verso comuni limitrofi, caratterizzati da<br />
un mercato immobiliare più accessibile.<br />
La fascia anziana <strong>del</strong>la popolazione fa registrare una consistente eccedenza <strong>di</strong> immigrazioni rispetto alle<br />
emigrazioni. Tali movimenti sono sempre più legati al trasferimento <strong>di</strong> residenza <strong>di</strong> persone al termine <strong>del</strong><br />
proprio ciclo lavorativo o già in pensione.<br />
Alghero, pur mantenendo sal<strong>di</strong> positivi nei confronti <strong>di</strong> gran parte <strong>del</strong> <strong>territorio</strong> regionale e <strong>del</strong> resto d’Italia,<br />
presenta <strong>di</strong>fferenziali migratori negativi verso l’estero e, soprattutto, soffre <strong>di</strong> una consistente emorragia<br />
demografica verso il vicino comune <strong>di</strong> Olmedo. Questo comune, nell’ultimo quinquennio,, ha infatti assorbito<br />
circa 350 algheresi, con una quota importante <strong>di</strong> giovani, che tendono a spostare la propria residenza ad<br />
Olmedo in un mercato immobiliare più accessibile e orientato verso unità abitative più adatte alla vita<br />
residenziale.<br />
Per quanto riguarda la presenza degli stranieri nel <strong>territorio</strong> comunale, in questo momento poco più <strong>del</strong> 2%<br />
(905 unità) <strong>del</strong>la popolazione citta<strong>di</strong>na, si osserva che il loro numero è raddoppiato in appena sei anni;<br />
solamente nel 2007 il numero <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>ni stranieri residenti è aumentato ad<strong>di</strong>rittura <strong>del</strong> 20%. La componente <strong>di</strong><br />
citta<strong>di</strong>nanza straniera è costituita per circa i tre quinti da donne, le quali si concentrano nelle classi <strong>di</strong> età tra i<br />
25 e i 39 anni, potenzialmente le più feconde. “I sal<strong>di</strong> migratori positivi degli ultimi anni potrebbero contrastare<br />
parzialmente l’invecchiamento e il declino <strong>del</strong>la popolazione nel me<strong>di</strong>o-lungo termine, anche se la<br />
5<br />
I tassi sono calcolati come rapporto tra i nati, tassi <strong>di</strong> natalità o i morti, tassi <strong>di</strong> mortalità, <strong>di</strong> una popolazione in un<br />
determinato anno solare, e la popolazione me<strong>di</strong>a residente in quello stesso anno.
composizione <strong>del</strong>la citta<strong>di</strong>nanza straniera per paese <strong>di</strong> origine non permette <strong>di</strong> ipotizzare tassi <strong>di</strong> fecon<strong>di</strong>tà<br />
molto più alti <strong>di</strong> quelli che si misurano nella popolazione locale” (P.U.C. - Alghero, 2009).<br />
Per quanto riguarda l’immigrazione straniera, sono “tre i segmenti omogenei <strong>di</strong>stinguibili: quello costituito da<br />
in<strong>di</strong>vidui provenienti da paesi in via <strong>di</strong> sviluppo extraeuropei, tra i quali prevalgono i maschi (almeno per gli<br />
asiatici e gli africani); quello degli stranieri provenienti dai paesi <strong>del</strong>l’est europeo, <strong>di</strong> composizione<br />
prevalentemente femminile, alimentato negli ultimi anni dalla richiesta <strong>di</strong> “badanti”, in parallelo con<br />
l’incremento <strong>del</strong>la presenza <strong>di</strong> anziani nella popolazione locale; infine si deve citare la corrente migratoria <strong>di</strong><br />
citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> età me<strong>di</strong>a elevata che ha origine nei principali bacini <strong>di</strong> domanda turistica internazionale (in<br />
particolare Regno Unito e Germania)” (P.U.C. - Alghero, 2009).<br />
2.2 Sistema locale e occupazione nel comune <strong>di</strong> Alghero<br />
Il SLL <strong>di</strong> Alghero rientra nella classe (sottoclasse e gruppo) dei “sistemi senza specializzazione”: aree dove “le<br />
specializzazioni che comunque emergono non sono legate a fattori <strong>di</strong> localizzazione specifici, ma seguono<br />
una <strong>di</strong>stribuzione sul <strong>territorio</strong> sostanzialmente proporzionale alla presenza <strong>di</strong> popolazione residente” (ISTAT,<br />
Rapporto Annuale, 2006). Questo gruppo comprende attualmente 220 (su 686) sistemi locali, per lo più <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>mensioni molto piccole, situati in prevalenza nel Mezzogiorno.<br />
Il SLL è identificato all’interno <strong>del</strong> sistema urbano regionale come sistema territoriale a scala locale,<br />
considerando le relazioni giornaliere casa-lavoro, ossia gli spostamenti giornalieri per motivi <strong>di</strong> lavoro.6<br />
“I sistemi locali <strong>del</strong> lavoro rappresentano i luoghi <strong>del</strong>la vita quoti<strong>di</strong>ana <strong>del</strong>la popolazione che vi risiede e lavora.<br />
Si tratta <strong>di</strong> unità territoriali costituite da più comuni contigui fra loro, geograficamente e statisticamente<br />
comparabili. I sistemi locali <strong>del</strong> lavoro sono uno strumento <strong>di</strong> analisi appropriato per indagare la struttura<br />
socio-economica <strong>del</strong>l'Italia secondo una prospettiva territoriale” (ISTAT, Rapporto Annuale, 2006).<br />
Per capire meglio il perché <strong>del</strong>la mancata appartenenza al gruppo dei “sistemi turistici”, va osservato che la<br />
variabile chiave in questo caso è la concentrazione territoriale degli addetti nei servizi al consumatore rispetto<br />
agli addetti in tutte le attività economiche, le unità locali <strong>di</strong> imprese e istituzioni. “Più precisamente, si<br />
considera il coefficiente <strong>di</strong> concentrazione calcolato come rapporto fra la quota <strong>di</strong> addetti nei servizi al<br />
consumatore in un determinato SLL e la quota <strong>di</strong> addetti nei servizi al consumatore in Italia” (P.U.C. - Alghero,<br />
2009).<br />
Nonostante Alghero rappresenta un importante polo turistico locale, la sua attuale configurazione economica<br />
non capitalizza i vantaggi comparati potenziali legati al comparto turistico, né sembra avviata verso particolari<br />
forme <strong>di</strong> specializzazione. Per i gran<strong>di</strong> settori, si nota “come quello dei servizi prevale in tutti e tre i SLL<br />
considerati (seguono industria e agricoltura) ma raggiunge il valore più elevato ad Alghero” (P.U.C. - Alghero,<br />
2009), proprio in virtù <strong>del</strong> peso <strong>del</strong>le attività legate al turismo. Ha inoltre rilievo la presenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse<br />
importanti aziende <strong>del</strong> comparto agroalimentare e l’ampia <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> attività integrative dei red<strong>di</strong>ti agricoli<br />
quali l’agriturismo.<br />
Questo secondo aspetto trova riscontro nei dati presenti “nella Relazione sulla situazione <strong>del</strong> comparto<br />
agrituristico in Sardegna, 2007 (Regione Autonoma <strong>del</strong>la Sardegna - Assessorato <strong>del</strong>l’Agricoltura e Riforma<br />
Agro-Pastorale), nell’ambito <strong>del</strong>la nuova provincia <strong>di</strong> Sassari (dove si contano 135 aziende attive pari al 18,8%<br />
<strong>del</strong> totale regionale)” (P.U.C. - Alghero, 2009): nel solo <strong>territorio</strong> <strong>di</strong> Alghero operano ben 32 aziende, cui si<br />
6 La procedura d’identificazione dei SLL è contenuta in: ISTAT (1997), I sistemi locali <strong>del</strong> lavoro 1991, Argomenti n. 10,<br />
Roma.
aggiungono 3 aziende a Olmedo, 2 a Villanova Monteleone e 1 a Putifigari. Nel 1997 le aziende agrituristiche<br />
operanti nel <strong>territorio</strong> <strong>di</strong> Alghero erano appena do<strong>di</strong>ci.<br />
Nel Registro imprese <strong>del</strong>la Camera <strong>di</strong> Commercio Industria e Artigianato nel 2004 erano attive nel comune <strong>di</strong><br />
Alghero 3.139 imprese, più <strong>di</strong> un terzo <strong>del</strong>le quali operanti nel settore <strong>del</strong> Commercio e in quello degli Alberghi<br />
e ristorazione, seguite dall'Agricoltura e dal settore dei Servizi. Tre anni dopo, nel 2007, il numero complessivo<br />
<strong>di</strong> imprese iscritte è aumentato <strong>del</strong>l’8,28%, ma la struttura è rimasta sostanzialmente la stessa.<br />
Nel 2009 il numero <strong>del</strong>le imprese attive è salito a 3.526, facendo registrare un incremento, rispetto al 2007,<br />
pari al 3,73%. Il primo settore trainante è il Commercio, seguono Agricoltura, Caccia e selvicoltura e i Servizi.<br />
Emerge il continuo ri<strong>di</strong>mensionamento <strong>del</strong> comparto <strong>del</strong>la pesca (che perde l’11% <strong>di</strong> imprese attive) al quale si<br />
contrappone un aumento apprezzabile <strong>del</strong>le imprese iscritte nei Servizi e nelle Costruzioni. Nel 2008, anno<br />
influenzato parzialmente dalla crisi economica mon<strong>di</strong>ale, si osserva un lieve aumento <strong>del</strong> numero <strong>di</strong> imprese<br />
attive (+2,7%) in un quadro <strong>di</strong> relativa stabilità <strong>del</strong>le quote settoriali (si riprende la Pesca, flette ulteriormente<br />
l’Agricoltura, le Costruzioni aumentano meno che in passato).<br />
In una fase <strong>di</strong> crisi, il confronto col dato provinciale mostra una certa resilienza <strong>di</strong> Alghero rispetto al resto<br />
<strong>del</strong>la provincia. “In termini <strong>di</strong> tasso <strong>di</strong> crescita <strong>del</strong>le imprese (calcolato come rapporto fra saldo<br />
iscrizioni/cancellazioni su totale registrazioni all’inizio <strong>del</strong>l’anno precedente), i dati <strong>del</strong> 2007 in<strong>di</strong>cano per<br />
Alghero un valore <strong>del</strong> 2,15%, contro l’1,29% <strong>del</strong>la provincia <strong>di</strong> Sassari, il 2,28% <strong>del</strong>la provincia Gallura, lo<br />
0,70% <strong>del</strong>la Sardegna e lo 0,75% <strong>del</strong>l’Italia. Quest’andamento trova conferma anche nei dati pubblicati dalla<br />
CCIIAA relativi al 2008: mentre ad Alghero si osservano tassi <strong>di</strong> crescita <strong>del</strong>le imprese operanti pari all’1,80%,<br />
nel resto <strong>del</strong>l’Isola si registra lo 0,82% per la provincia <strong>di</strong> Sassari, l’1,69% per la provincia Gallura, lo 0,52%<br />
per la Sardegna. Il valore me<strong>di</strong>o italiano si attesta invece sullo 0,59%” (P.U.C. - Alghero, 2009). Ne scaturisce<br />
che i tassi <strong>di</strong> crescita positivi si sono sempre tenuti entro una fascia relativamente ristretta, con tassi me<strong>di</strong><br />
annui nel periodo 2001- 2008 pari all’1,69% per la provincia <strong>di</strong> Sassari e all’1,58% per la Sardegna.<br />
Occorre infine ricordare una caratteristica saliente <strong>del</strong>la demografia <strong>di</strong> impresa nella nostra regione,<br />
contrariamente a ciò che avviene nelle aree più prospere, dove le popolazioni <strong>di</strong> imprese tendono ad essere<br />
più stabili (meno <strong>di</strong>namiche dal punto <strong>di</strong> vista demografico), la Sardegna è caratterizzata da un elevato<br />
turnover. Ma questo dato non riflette processi <strong>di</strong> <strong>di</strong>struzione creativa associati a ingressi massicci <strong>di</strong> aziende<br />
innovative, solo una parte <strong>del</strong>le nuove imprese infatti riescono a superare la fase critica <strong>del</strong>lo start-up e ad<br />
affermarsi sul mercato.<br />
Per inquadrare la configurazione produttiva <strong>del</strong>l’area si possono osservare le statistiche essenziali riguardanti i<br />
SLL, ovvero le aggregazioni <strong>di</strong> comuni contigui fra loro, geograficamente e statisticamente comparabili,<br />
caratterizzati dalla maggior concentrazione dei movimenti effettuati per motivi <strong>di</strong> lavoro dalla popolazione <strong>di</strong><br />
riferimento. Gli stessi SLL <strong>del</strong> lavoro costituiscono un’entità socio-economica identificata da occupazione,<br />
acquisti, relazioni e opportunità sociali.<br />
I dati più recenti (fonte: Sardegna Statistiche) evidenziano che il SLL <strong>di</strong> Alghero rappresenta uno dei 45 SLL<br />
<strong>del</strong>la Sardegna ed in particolare uno dei 12 SLL che si colloca nella classe <strong>di</strong> ampiezza demografica 20.001-<br />
50.000. Il rapporto fra popolazione residente e superficie è decisamente inferiore alla me<strong>di</strong>a italiana ma<br />
superiore alla me<strong>di</strong>a <strong>del</strong>la Sardegna. Come termini <strong>di</strong> paragone per il SLL <strong>di</strong> Alghero (che ricomprende i<br />
comuni <strong>di</strong> Monteleone Rocca Doria, Olmedo, Putifigari, Villanova Monteleone) si sono scelti quelli <strong>di</strong> Sassari<br />
(Ittiri, Muros, Nulvi, Osilo, Ossi, <strong>Porto</strong> Torres, Sassari, Sennori, Sorso, Tissi, Uri, Usini, Stintino) e <strong>di</strong> Thiesi<br />
(Banari, Bessude, Bonnanaro, Borutta, Cheremule, Romana, Siligo, Thiesi, Torralba).<br />
Si osserva che nell’insieme dei SLL <strong>di</strong> Alghero, Sassari e Thiesi risiedono circa 250.000 abitanti, una frazione<br />
superiore al 15% <strong>del</strong>la popolazione regionale; si calcola una presenza <strong>di</strong> unità locali e <strong>di</strong> addetti alle unità
locali pari rispettivamente al 17% e al 22% <strong>del</strong> valore complessivo regionale. Il sistema urbano <strong>di</strong> area vasta si<br />
configura come l’unico bacino demograficamente rilevante <strong>del</strong>la Sardegna dopo l’area metropolitana <strong>di</strong><br />
Cagliari e come una <strong>del</strong>le poche zone caratterizzate da una crescita <strong>di</strong> popolazione, seppure in gran parte, a<br />
<strong>di</strong>scapito <strong>del</strong>le aree interne <strong>del</strong>la Provincia.<br />
Il valore <strong>del</strong> fatturato nel sistema locale <strong>di</strong> Alghero consegue, nel periodo 1999-2005, un aumento<br />
<strong>del</strong>l’in<strong>di</strong>catore superiore alla me<strong>di</strong>a <strong>del</strong> Paese (+32,5%), anche se non si traduce in un aumento <strong>del</strong>la<br />
produttività (fatturato per addetto) altrettanto consistente. Nei sistemi locali <strong>del</strong> Sud e <strong>del</strong>le Isole le imprese<br />
sono cresciute molto <strong>di</strong> più in termini <strong>di</strong> occupazione che non per <strong>di</strong>mensione economica, soprattutto a causa<br />
<strong>del</strong>la specializzazione in settori a bassa produttività. Quest’ultima <strong>di</strong>pende sia dal comportamento <strong>del</strong>l’impresa<br />
che dalla sua collocazione settoriale, quanto da fattori esterni ricadenti sotto il dominio <strong>del</strong>le politiche<br />
pubbliche.<br />
Un altro aspetto rilevante, in un’epoca <strong>di</strong> forte integrazione internazionale, è rappresentato dalla capacità dei<br />
territori <strong>di</strong> agganciarsi ai mercati mon<strong>di</strong>ali, trovando nuovi sbocchi e nuove opportunità <strong>di</strong> crescita <strong>del</strong>la<br />
produzione. “A riguardo, l’ISTAT, ha sviluppato una metodologia che permette <strong>di</strong> stimare il valore <strong>del</strong>le<br />
esportazioni per ciascuno dei 686 SLL <strong>del</strong>l’Italia” (P.U.C. - Alghero, 2009).<br />
Purtroppo, per il SLL <strong>di</strong> Alghero, si conferma l’appartenenza a quel segmento che ricomprende i SLL con un<br />
valore <strong>del</strong>le esportazioni inferiore alla me<strong>di</strong>ana <strong>del</strong>la <strong>di</strong>stribuzione. I risultati più strettamente finanziari<br />
possono essere valutati attraverso l’analisi dei dati <strong>del</strong>l’Osservatorio Economico <strong>del</strong>la Sardegna, basati sul<br />
NAB (Nuovo Archivio dei Bilanci). “Quest’ultimo registra i dati <strong>del</strong>le imprese soggette all’obbligo <strong>di</strong> deposito <strong>del</strong><br />
bilancio (società <strong>di</strong> capitali e cooperative a responsabilità limitata) con fatturato maggiore o uguale a 500.000<br />
euro. Da notare innanzitutto come il valore dei parametri fondamentali che definiscono la posizione me<strong>di</strong>ana<br />
<strong>del</strong>le imprese, in termini <strong>di</strong> fatturato (ricavi dalle ven<strong>di</strong>te) e <strong>di</strong> valore aggiunto (in pratica il valore <strong>del</strong> prodotto <strong>di</strong><br />
un’impresa meno il valore dei beni interme<strong>di</strong>, come materie prime e servizi, che ha dovuto acquistare per<br />
realizzarlo), in<strong>di</strong>chi per il SLL <strong>di</strong> Alghero scarti rispetto ai corrispondenti valori nazionali pari al 50% per il<br />
fatturato e al 10% per il valore aggiunto. Se poi si estende il confronto al SLL <strong>di</strong> Thiesi, principale <strong>di</strong>stretto <strong>del</strong><br />
comparto lattiero caseario regionale, lo scarto fra i valori me<strong>di</strong>ani è ancora più ragguardevole.<br />
Se il valore <strong>di</strong> posizione colloca il SLL <strong>di</strong> Alghero nel segmento basso <strong>del</strong>la <strong>di</strong>stribuzione <strong>del</strong> fatturato e <strong>del</strong><br />
valore aggiunto <strong>del</strong>le imprese coperte dal NAB, gli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> red<strong>di</strong>tività evidenziano una realtà <strong>di</strong>fferente,<br />
almeno a metà periodo (2005). Infatti, entrambi gli in<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> red<strong>di</strong>tività, il ROE e ROI, che esprimono<br />
rispettivamente la red<strong>di</strong>tività <strong>del</strong> capitale proprio e la red<strong>di</strong>tività degli investimenti <strong>di</strong> una impresa, assumono<br />
valori superiori tanto alla me<strong>di</strong>ana nazionale quanto alla me<strong>di</strong>ana degli altri SLL considerati” (P.U.C. - Alghero,<br />
2009). Gli in<strong>di</strong>ci mostrano l’entità degli investimenti effettuati per ogni euro <strong>di</strong> capitale finanziato<br />
esclusivamente dai mezzi propri, leggermente superiore alla me<strong>di</strong>ana nazionale ma inferiore a quella <strong>di</strong> altri<br />
SLL <strong>del</strong>la regione.<br />
Questo in<strong>di</strong>catore misura il rischio finanziario <strong>del</strong>l’impresa, dunque il fatto <strong>di</strong> collocarsi all’interno <strong>del</strong>l’intervallo<br />
<strong>del</strong>imitato dai valori me<strong>di</strong>ani <strong>del</strong> paese (notoriamente meno esposto a questo tipo <strong>di</strong> rischio) e degli altri SLL<br />
<strong>del</strong>l’area è certamente rassicurante. Al contrario, la variazione percentuale <strong>del</strong> fatturato e <strong>del</strong> valore aggiunto<br />
in<strong>di</strong>ca per l’anno in questione una rilevante flessione <strong>del</strong>lo sviluppo <strong>del</strong>le imprese locali. A conclusione <strong>di</strong> tali<br />
valutazioni, si può affermare che nel periodo osservato, le imprese <strong>del</strong> SLL, mostravano una buona<br />
prestazione in termini <strong>di</strong> red<strong>di</strong>tività, una bassa rischiosità ma in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> sviluppo modesti.<br />
Si considerano, infine, alcune questioni riferibili allo stato <strong>del</strong> mercato <strong>del</strong> lavoro, quali: lavoro, con<strong>di</strong>zione<br />
lavorativa e livello <strong>di</strong> scolarizzazione <strong>del</strong>la popolazione, considerate variabili importanti per spiegare alcuni<br />
stati e comportamenti <strong>del</strong>la popolazione residente.
Ad Alghero appare evidente come la presenza <strong>di</strong> vaste aree urbane che mostrano caratteristiche <strong>di</strong><br />
deprivazione sociale e <strong>di</strong> scarsa integrazione <strong>del</strong>le donne nel mercato <strong>del</strong> lavoro, influisce negativamente sui<br />
comportamenti demografici che conducono a un percorso sostenibile. Ad esempio, vi sono aree urbane<br />
caratterizzate da forte <strong>di</strong>sagio sociale, come la Pietraia, dove il bassissimo livello me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> scolarizzazione<br />
(meno <strong>di</strong> un quarto <strong>del</strong>la popolazione residente ha conseguito almeno il <strong>di</strong>ploma), probabilmente, influenza<br />
negativamente l’accesso al lavoro e la ricerca stessa <strong>di</strong> un’occupazione. Altre aree limitrofe, in particolare<br />
quella costiera <strong>del</strong> Lido, sono caratterizzate da con<strong>di</strong>zioni economiche e sociali più evolute e integrate.<br />
Il censimento <strong>del</strong> 2001 ha mostrato che il comune <strong>di</strong> Alghero registrava un tasso <strong>di</strong> attività pari al 46,73%, un<br />
tasso <strong>di</strong> occupazione <strong>del</strong> 35,79% e un tasso <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione <strong>del</strong> 23,42%7. Sebbene i dati non siano<br />
omogenei, secondo le rilevazioni nel SLL <strong>di</strong> Alghero nel 2005, vi sarebbe un tasso <strong>di</strong> attività pari al 48,25%, un<br />
tasso <strong>di</strong> occupazione <strong>del</strong> 41,39% e un tasso <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione <strong>del</strong> 14,21%. Il fenomeno <strong>del</strong>la <strong>di</strong>soccupazione,<br />
come accaduto nel resto <strong>del</strong> Paese, avrebbe quin<strong>di</strong> subìto un rilevante calo, anche se il livello raggiunto si<br />
colloca sopra il dato me<strong>di</strong>o regionale e nazionale.<br />
I tassi <strong>di</strong> partecipazione e i tassi <strong>di</strong> occupazione sono inferiori alla me<strong>di</strong>a regionale e nazionale. Nel tempo<br />
dunque, la <strong>di</strong>soccupazione ad Alghero si è ridotta, ma la forbice esistente con i valori me<strong>di</strong> regionali, riguardo<br />
alla partecipazione al mercato <strong>del</strong> lavoro, la crescita degli occupati e la <strong>di</strong>soccupazione, a metà periodo,<br />
appaiono essere leggermente maggiori. Ciò si collega con i problemi riguardanti la struttura demografica e alla<br />
mancata ricerca attiva <strong>di</strong> un posto <strong>di</strong> lavoro.<br />
I bassi tassi <strong>di</strong> attività, influenzati dalla crescita <strong>del</strong>la forza lavoro femminile, evidenziano la <strong>di</strong>fficoltà ad<br />
attrarre questa parte <strong>del</strong>la popolazione che, nella scelta <strong>di</strong> partecipare al mercato <strong>del</strong> lavoro, considera qualità<br />
e accessibilità dei servizi requisiti importanti per trovare un punto <strong>di</strong> equilibrio fra occupazione ufficiale e lavoro<br />
domestico.<br />
7 Il tasso <strong>di</strong> partecipazione o <strong>di</strong> attività è la frazione <strong>del</strong>la popolazione in età <strong>di</strong> 15 anni o più, appartenente alle forze <strong>di</strong><br />
lavoro; il tasso <strong>di</strong> occupazione è la frazione <strong>del</strong>la popolazione in età compresa fra i 15 e i 65 anni che possiede<br />
un’occupazione; il tasso <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione è la frazione <strong>del</strong>la popolazione <strong>di</strong> 15 anni e più in cerca <strong>di</strong> occupazione.
Le schede <strong>di</strong> analisi <strong>del</strong>le componenti ambientali<br />
Scheda 1: Acqua<br />
Fonte dei dati<br />
- Piano <strong>di</strong> Tutela <strong>del</strong>le Acque (PTA) <strong>del</strong>la Regione Autonoma <strong>del</strong>la Sardegna approvato dalla Giunta<br />
Regionale con Delibera <strong>del</strong> 4 aprile 2006, n. 14/16;<br />
- Piano <strong>di</strong> Gestione <strong>del</strong> Distretto Idrografico <strong>del</strong>la Sardegna, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 223 <strong>del</strong> 25<br />
settembre 2009;<br />
- Ministero <strong>del</strong>la Salute - Rapporto sulla qualità <strong>del</strong>le acque <strong>di</strong> balneazione Anno 2008, (Dati 2007);<br />
- Dati Abbanoa;<br />
- Dati Comune <strong>di</strong> Alghero - Settore Ambiente ed Ecologia;<br />
- Dati ARPAS;<br />
- Dati Azienda Sanitaria Locale <strong>del</strong>la Provincia <strong>di</strong> Sassari.<br />
Livello e qualità dei dati<br />
Me<strong>di</strong>a<br />
Priorità tematismo<br />
Alta<br />
- Stato attuale <strong>del</strong>la componente<br />
Il <strong>territorio</strong> <strong>del</strong> Comune <strong>di</strong> Alghero risulta, nel PTA, compreso nell'Unità Idrografica Omogenea (UIO) Barca, la<br />
cui estensione è pari a 555,46 Kmq ed è formata, oltre che dall’omonimo bacino principale, da una serie <strong>di</strong><br />
bacini costieri tra i quali spicca per importanza quello <strong>del</strong> Canale Urune, che interessa l’area <strong>di</strong> Capo Caccia.<br />
Per quanto concerne la qualità dei corpi idrici, la normativa vigente in materia <strong>di</strong> tutela <strong>del</strong>le acque<br />
dall’inquinamento, ha in<strong>di</strong>viduato gli obiettivi minimi <strong>di</strong> qualità <strong>ambientale</strong> per i corpi idrici significativi, da<br />
garantirsi su tutto il <strong>territorio</strong> nazionale. Dove, sono considerati corpi idrici significativi quelli che le autorità<br />
competenti in<strong>di</strong>viduano sulla base <strong>del</strong>le in<strong>di</strong>cazioni contenute nell’Allegato 1 <strong>del</strong> D.lgs 152/99 (“Monitoraggio e<br />
classificazione <strong>del</strong>le acque in funzione degli obiettivi <strong>di</strong> qualità <strong>ambientale</strong>”), che conseguentemente saranno<br />
monitorati e classificati al fine <strong>del</strong> raggiungimento degli obiettivi <strong>di</strong> qualità <strong>ambientale</strong>. Tali obiettivi <strong>di</strong> qualità<br />
“sono definiti in funzione <strong>del</strong>la capacità dei corpi idrici <strong>di</strong> mantenere i processi naturali <strong>di</strong> autodepurazione e <strong>di</strong><br />
supportare comunità animali e vegetali ampie e ben <strong>di</strong>versificate” (art.4). Le caratteristiche dei corpi idrici<br />
significativi sono riassunte nella seguente tabella<br />
CORPI IDRICI SUPERFICIALI<br />
Corsi d’acqua superficiali<br />
Sono significativi almeno i seguenti corsi d’acqua:<br />
• tutti i corsi d’acqua naturali <strong>di</strong> primo or<strong>di</strong>ne (cioè quelli recapitanti <strong>di</strong>rettamente in mare) il cui bacino<br />
imbrifero abbia una superficie maggiore <strong>di</strong> 200 km2 ;<br />
• tutti i corsi d’acqua naturali <strong>di</strong> secondo or<strong>di</strong>ne o superiore il cui bacino imbrifero abbia una superficie<br />
maggiore a 400 km2 .<br />
Non sono significativi i corsi d’acqua che per motivi naturali hanno avuto portata uguale a zero per più <strong>di</strong> 120<br />
giorni l’anno, in un anno idrologico me<strong>di</strong>o.<br />
Laghi<br />
Sono significativi i laghi aventi superficie <strong>del</strong>lo specchio liquido pari a 0,5 km2 o superiore. Tale superficie è<br />
riferita al periodo <strong>di</strong> massimo invaso.<br />
Acque marine costiere<br />
Sono significative le acque marine comprese entro la <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> 3.000 metri dalla costa e comunque entro<br />
la batimetrica dei 50 metri.<br />
Acque <strong>di</strong> transizione<br />
Sono significative le acque <strong>del</strong>le lagune, dei laghi salmastri e degli stagni costieri. Le zone <strong>di</strong> <strong>del</strong>ta ed<br />
estuario vanno invece considerate come corsi d’acqua superficiali.<br />
Corpi idrici artificiali<br />
Sono considerati significativi tutti i canali artificiali aventi portata <strong>di</strong> esercizio <strong>di</strong> almeno 3 m3/s e i laghi<br />
artificiali o i serbatoi aventi superficie <strong>del</strong>lo specchio liquido almeno pari a 1 km2 o con volume <strong>di</strong> invaso
almeno pari a 5 milioni <strong>di</strong> m3. Tale superficie è riferita al periodo <strong>di</strong> massimo invaso.<br />
CORPI IDRICI SOTTERRANEI<br />
Acque sotterranee<br />
Sono significativi gli accumuli d’acqua contenuti nel sottosuolo permeanti la matrice rocciosa, posti al <strong>di</strong><br />
sotto <strong>del</strong> livello <strong>di</strong> saturazione permanente. Fra esse ricadono le falde freatiche e quelle profonde (in<br />
pressione o no) contenute in formazioni permeabili, e, in via subor<strong>di</strong>nata, i corpi d’acqua intrappolati entro<br />
formazioni permeabili con bassa o nulla velocità <strong>di</strong> flusso. Le manifestazioni sorgentizie, concentrate o<br />
<strong>di</strong>ffuse (anche subacquee) si considerano appartenenti a tale gruppo <strong>di</strong> acque in quanto affioramenti <strong>del</strong>la<br />
circolazione<br />
Tab_4.2.2./a Caratteristiche dei corpi idrici significativi<br />
Spetta alle Regioni classificare i corpi idrici; nell'Unità Idrografica Omogenea (UIO) Barca, il Piano <strong>di</strong> Tutela<br />
<strong>del</strong>le Acque (PTA) <strong>del</strong>la Regione Autonoma <strong>del</strong>la Sardegna, in<strong>di</strong>vidua come unico corso d’acqua significativo<br />
è il Rio Barca, tra i laghi e gli invasi oltre al Lago <strong>di</strong> Baratz, unico lago naturale, <strong>del</strong>la Sardegna, sono<br />
significativi e pertanto monitorati anche il Lago <strong>del</strong> Rio Cuga a Nuraghe Attentu, mente tra le acque <strong>di</strong><br />
transizione l’unico corpi idrico significativo è lo Stagno <strong>di</strong> Calich. Per quanto riguarda le acque marino<br />
costiere la rete <strong>di</strong> monitoraggio interessa solo il lungomare <strong>del</strong>la città <strong>di</strong> Alghero.<br />
I corsi d’acqua, che attraversano il <strong>territorio</strong>, hanno un regime pluviale, cioè sono fortemente con<strong>di</strong>zionati dalle<br />
precipitazioni atmosferiche. Si tratta per lo più <strong>di</strong> corsi d’acqua, permanenti o temporanei, con un regime<br />
variabile caratterizzato da forti piene e da estreme magre.<br />
Come detto il principale corso d’acqua è il Rio Barca, che raccoglie tutte le acque <strong>del</strong>la Nurra <strong>di</strong> Alghero e<br />
che alimenta la piccola laguna costiera, denominata Stagno <strong>del</strong> Calich.<br />
Lo Stagno <strong>del</strong> Calich, è l’unica laguna salmastra presente nel contesto algherese: <strong>di</strong> circa 70 ettari, con una<br />
profon<strong>di</strong>tà massima <strong>di</strong> due metri e con una ampia foce, localizzato a Nord <strong>del</strong>l’abitato <strong>di</strong> Alghero è formato<br />
dalle foci <strong>del</strong> Rio Fangal a sud, <strong>del</strong> Rio Barca a est e <strong>del</strong> canale Oruni a nord, nel quale si convoglia una<br />
buona parte <strong>del</strong>le acque <strong>del</strong>la regione; lo stagno è alimentato dal Rio Barca stesso. Lo stagno comunica con il<br />
mare attraverso il canale <strong>di</strong> Fertilia, una apertura naturale allargata durante i lavori <strong>di</strong> bonifica <strong>del</strong> 1938-40. Le<br />
acque <strong>del</strong>la laguna sono salmastre ed i valori <strong>del</strong>la salinità subiscono forti variazioni nei <strong>di</strong>versi perio<strong>di</strong><br />
<strong>del</strong>l’anno: durante l’estate l’apporto <strong>di</strong> acqua dolce è quasi nullo ed il ricambio idrico è determinato quasi<br />
esclusivamente dal flusso e dal riflusso <strong>del</strong>le maree. La laguna presenta una forma allungata, parallela alla<br />
linea <strong>di</strong> costa; il nome potrebbe derivare da questa sua forma a calice il cui gambo, penetrando all’interno<br />
<strong>del</strong>la Nurra, si allunga in un braccio <strong>di</strong>stinto, noto con il <strong>di</strong>minutivo <strong>di</strong> Calighèt, dove l’acqua è più dolce.<br />
2. Qualità dei corpi idrici superficiali<br />
La Normativa prevede che per ciascun bacino idrografico devono essere raccolte le informazioni sullo stato<br />
qualitativo e quantitativo <strong>del</strong>le risorse idriche.<br />
Lo stato <strong>di</strong> qualità <strong>ambientale</strong> dei corpi idrici superficiali è definito sulla base <strong>di</strong> tre stati:<br />
- stato ecologico: descrive la complessità degli ecosistemi acquatici, e la natura fisica e chimica <strong>del</strong>le<br />
acque e dei se<strong>di</strong>menti, le caratteristiche <strong>del</strong> flusso idrico e la struttura fisica <strong>del</strong> corpo idrico; gli<br />
elementi chimici che saranno considerati per la definizione <strong>del</strong>lo stato ecologico saranno, a<br />
seconda <strong>del</strong> corpo idrico, i parametri chimici e fisici <strong>di</strong> base relativi al bilancio <strong>del</strong>l’ossigeno ed allo<br />
stato trofico. Per la valutazione <strong>del</strong>lo stato ecologico si utilizza generalmente l’in<strong>di</strong>ce biotico esteso<br />
(I.B.E.) per i corsi d’acqua superficiali;<br />
- stato chimico: è definito in base alla presenza <strong>di</strong> microinquinanti ovvero <strong>di</strong> sostanze chimiche<br />
pericolose. La valutazione <strong>di</strong> questo stato è effettuata inizialmente in base ai valori soglia riportate<br />
nella <strong>di</strong>rettiva 76/464/CEE e nelle <strong>di</strong>rettive da essa derivate, nelle parti riguardanti gli obiettivi <strong>di</strong><br />
qualità nonché nell’allegato 2 sezione B; nel caso per gli stessi parametri siano riportati valori<br />
<strong>di</strong>versi, deve essere considerato il più restrittivo.<br />
- stato <strong>ambientale</strong>: è definito in relazione al grado <strong>di</strong> scostamento rispetto alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> un corpo<br />
idrico <strong>di</strong> riferimento, quello, cioè, con caratteristiche biologiche, idromorfologiche, e fisico-chimiche.<br />
tipiche <strong>di</strong> un corpo idrico relativamente immune da impatti antropici.<br />
Carichi prodotti da fonte puntuale e da fonte <strong>di</strong>ffusa.<br />
Il Piano <strong>di</strong> Tutela <strong>del</strong>le Acque (PTA) <strong>del</strong>la Regione Autonoma <strong>del</strong>la Sardegna ha in<strong>di</strong>viduato per ciascuna<br />
l'Unità Idrografica Omogenea i centri <strong>di</strong> pericolo potenziale: nella U.I.O. <strong>del</strong> Barca il centro <strong>di</strong> pericolo<br />
potenziale puntuale più rilevanti è dato dall’area industriale <strong>di</strong> Alghero, mentre per quanto riguarda i centri <strong>di</strong><br />
pericolo <strong>di</strong> carattere <strong>di</strong>ffuso l’ U.I.O. <strong>del</strong> Barca ricade una <strong>del</strong>le aree a maggiore vocazione agricola, quella<br />
<strong>del</strong>la Nurra – Sassarese, nella quale le attività <strong>di</strong> coltivazione intensive possono essere considerate dei CDP<br />
<strong>di</strong>ffusi. Si riporta <strong>di</strong> seguito uno stralcio <strong>del</strong> PTA relativo ai carichi prodotti da fonte puntuale e da fonte <strong>di</strong>ffusa.
Fig_4.2.2./a Stralcio PTA: carichi prodotti da fonte puntuale e da fonte <strong>di</strong>ffusa.<br />
- Monitoraggio dei corpi idrici superficiali<br />
Le reti <strong>di</strong> monitoraggio in<strong>di</strong>viduate dal PTA nella U.I.O. <strong>del</strong> Barca sono in<strong>di</strong>cate <strong>di</strong> seguito:<br />
Corsi d’acqua<br />
Le stazioni sono ubicate sul Rio Barca, prima <strong>del</strong>la sua immissione nello Stagno <strong>di</strong> Calich, poco a<br />
valle <strong>del</strong>la confluenza <strong>del</strong> suo affluente Riu Serra, sullo stesso Riu Serra, e su un altro suo affluente<br />
che è il Rio Su Mattone. Purtroppo le informazioni derivanti dal monitoraggio non hanno consentito <strong>di</strong><br />
classificare la prima <strong>di</strong> queste stazioni <strong>di</strong> monitoraggio, che è quella che presenta maggiori criticità.<br />
Laghi e invasi<br />
Anche per quanto riguarda il Lago <strong>di</strong> Baratz, anch’esso compreso nel programma <strong>di</strong> monitoraggio, gli<br />
esiti <strong>di</strong> questo non hanno consentito <strong>di</strong> pervenire a una classificazione e, <strong>di</strong> conseguenza, <strong>di</strong><br />
identificare criticità e obiettivi.<br />
Acque <strong>di</strong> transizione<br />
Per la definizione <strong>del</strong>lo stato <strong>ambientale</strong> <strong>del</strong>le acque lagunari e degli stagni costieri si valuta il numero<br />
<strong>di</strong> giorni <strong>di</strong> anossia/anno che coinvolgono oltre il 30% <strong>del</strong>la superficie <strong>del</strong> corpo idrico misurata nelle<br />
acque <strong>di</strong> fondo secondo lo schema <strong>del</strong>la tabella 18 <strong>del</strong>l’Allegato 1 <strong>del</strong> D. Lgs 152/99.<br />
I risultati <strong>del</strong> monitoraggio effettuato secondo il suddetto criterio, per lo Stagno <strong>di</strong> Calich, sono riportati<br />
in Tabella. Purtroppo il solo in<strong>di</strong>catore previsto dal D.Lgs. 152/99 non è sufficiente a caratterizzare il<br />
corpo idrico e le sue eventuali problematiche. Lo stesso PTA ritiene necessario, al fine <strong>di</strong> una migliore<br />
comprensione <strong>del</strong> fenomeno, un monitoraggio continuo dei principali parametri chimico-fisici da<br />
attuare me<strong>di</strong>ante monitoraggio automatico in continuo oppure tramite prelievi ed analisi giornaliere<br />
perlomeno nei perio<strong>di</strong> potenzialmente critici.<br />
Per quanto riguarda la qualità <strong>del</strong>lo Stagno <strong>del</strong> Calich, si riportano sotto le osservazioni tratte dal PTC (Piano<br />
Territoriale <strong>di</strong> Coor<strong>di</strong>namento) <strong>del</strong>la Provincia <strong>di</strong> Sassari, secondo cui, “La laguna versa in<br />
con<strong>di</strong>zioniecologiche precarie con concentrazioni <strong>di</strong> fosforo totale comprese tra 40 e 120 mg P m-3 in<br />
relazione allastagione, azoto sino a 1230 mg N m3, ammoniaca 200 mg N m3; questi valori determinano <strong>del</strong>le<br />
elevateconcentrazioni <strong>di</strong> biomassa vegetale, soprattutto nella componente macrofitica (500 g m2)”.<br />
- Criticità evidenziate nel PTA<br />
La criticità rappresenta quantitativamente una misura <strong>del</strong>la “<strong>di</strong>stanza” <strong>del</strong>lo stato qualitativo attuale dagli<br />
obiettivi <strong>di</strong> qualità definiti dal D.Lgs.152/99: maggiore è la <strong>di</strong>stanza, maggiore risulta essere il livello <strong>di</strong> criticità,<br />
ossia un dato corpo idrico è affetto in maniera più significativa <strong>di</strong> altri da problemi <strong>di</strong> inquinamento qualitativo.<br />
Sulla base, infatti, <strong>del</strong>le conoscenze <strong>di</strong>sponibili relative allo stato <strong>di</strong> qualità <strong>del</strong>le acque, al sistema fisico e alle<br />
attività antropiche insistenti sui bacini analizzati (carichi inquinanti recapitanti all’interno <strong>di</strong> ciascuno <strong>di</strong> essi), il<br />
PTA ha in<strong>di</strong>viduato una serie <strong>di</strong> aree cosiddette “problema”, ossia aree considerate problematiche in relazione<br />
alla tutela <strong>del</strong>la qualità, al rispetto degli obiettivi ambientali e all’uso <strong>del</strong>le risorse idriche, e definito le relazioni<br />
intercorrenti fra tali problematiche ed i fattori naturali ed antropici che le determinano.<br />
- Corsi d’acqua<br />
Nel PTA l’analisi <strong>del</strong>le criticità per la qualità <strong>ambientale</strong> dei corsi d’acqua è stata effettuata rapportando, per<br />
ciascun inquinante (BOD5, COD, P, NO3, NH4, %O2 alla saturazione, Escherichia Coli), il valore derivante<br />
dalla classificazione <strong>del</strong>lo stato ecologico e la concentrazione relativa al livello 3 <strong>del</strong>la Tabella 7 – Livello <strong>di</strong><br />
inquinamento espresso dai macrodescrittori, contenuta nell’Allegato 1 al D.Lgs.152/99.
Livello Colore Descrizione<br />
A<br />
B<br />
ROSSO<br />
ARANCIO<br />
Il rapporto tra valore derivante dalla classificazione <strong>del</strong> SECA e livello 3<br />
(Tab.7, All.1 D.Lgs.152/99) è superiore a 1<br />
Il rapporto tra valore derivante dalla classificazione <strong>del</strong> SECA e livello 3<br />
(Tab.7, All.1 D.Lgs.152/99) è compreso tra 0.8 e 1<br />
C<br />
Il rapporto tra valore derivante dalla classificazione <strong>del</strong> SECA e livello 3<br />
GIALLO (Tab.7, All.1 D.Lgs.152/99) è compreso tra 0.5 e 0.8<br />
D -- Il rapporto tra valore derivante dalla classificazione <strong>del</strong> SECA e livello 3<br />
(Tab.7, All.1 D.Lgs.152/99) è inferiore a 0.5<br />
Tab_4.2.2./b Livelli <strong>di</strong> criticità definiti per i corsi d’acqua<br />
Al fine <strong>di</strong> pervenire a una ipotesi sulle possibili cause <strong>del</strong>le criticità sono stati calcolati i carichi effettivi, che<br />
insistono su ciascuna <strong>del</strong>le stazioni <strong>di</strong> monitoraggio, sud<strong>di</strong>visi per fonti puntuali (carichi <strong>di</strong> tipo civile e<br />
industriale) e <strong>di</strong>ffuse (carichi zootecnici e agricoli). Nella Tabelle seguenti viene riportata la percentuale <strong>di</strong><br />
carico sul totale che compete a ogni singolo comparto, che insiste sulla singola stazione, in maniera tale da<br />
rendere possibile un’analisi <strong>del</strong> legame causa – effetto tra carico effettivo e criticità e da mettere in evidenza il<br />
peso che ogni comparto esercita, in termini <strong>di</strong> contributo <strong>di</strong> inquinante, sulla singola stazione.<br />
Tab_4.2.2./c Criticità per i corsi d’acqua per i macrodescrittori BOD5, COD, P, NH4, NO3
Tab_4.2.2./d Criticità per i corsi d'acqua per i macrodescrittori %O2 alla saturazione e Escherichia – coli<br />
- Laghi e invasi<br />
La definizione <strong>del</strong>le criticità per la qualità <strong>ambientale</strong> dei laghi si è basata sulla definizione <strong>di</strong> livelli <strong>di</strong> criticità<br />
per i quattro parametri necessari alla classificazione <strong>del</strong>lo stato ecologico dei laghi, cioè Trasparenza,<br />
Ossigeno Ipolimnico, Clorofilla “a” e Fosforo Totale. Analogamente a quanto effettuato per i corsi d’acqua, le<br />
criticità sono state <strong>di</strong>stinte in livelli (A, B, C, D) e sono state associate ad un colore che ne esplicita la<br />
rilevanza: i livelli <strong>di</strong> criticità sono stabiliti per singolo macrodescrittore in funzione <strong>del</strong>la classe <strong>del</strong> SECA.<br />
Livello Colore Descrizione<br />
A<br />
B<br />
ROSSO<br />
ARANCIO<br />
Classe 5 <strong>del</strong>la Tab.11, All.1 D.Lgs. 152/99, così come mo<strong>di</strong>ficata dal<br />
Decreto n.391/2003.<br />
Classe 4 <strong>del</strong>la Tab.11, All.1 D.Lgs. 152/99, così come mo<strong>di</strong>ficata dal<br />
Decreto n.391/2003.<br />
C<br />
Classe 3 <strong>del</strong>la Tab.11, All.1 D.Lgs. 152/99, così come mo<strong>di</strong>ficata dal<br />
GIALLO Decreto n.391/2003.<br />
D -- Classi 1-2 <strong>del</strong>la Tab.11, All.1 D.Lgs. 152/99, così come mo<strong>di</strong>ficata<br />
dal Decreto n.391/2003.<br />
Tab_4.2.2./e Livelli <strong>di</strong> criticità definiti per i laghi<br />
Le criticità per i laghi <strong>del</strong>la U.I.O. <strong>del</strong> Barca sono invece esplicitate in Tabella, dove sono in<strong>di</strong>cati anche i<br />
carichi <strong>di</strong> fosforo che insistono su ciascun singolo corpo idrico, come contributo percentuale <strong>di</strong> ciascun<br />
comparto (civile, industriale, agricolo, zootecnico)<br />
Tab_4.2.2./f Criticità per i laghi e carico effettivo <strong>di</strong> P afferente<br />
- Acque <strong>di</strong> transizione<br />
Per quanto sottolineato sopra, i dati derivanti dal monitoraggio per le acque <strong>di</strong> transizione <strong>del</strong>la U.I.O. <strong>del</strong><br />
Barca, non sono in grado <strong>di</strong> evidenziare la presenza <strong>di</strong> eventuali criticità.<br />
Il PTA peraltro non evidenzia “criticità significative: per quanto infatti lo stagno <strong>di</strong> presenti in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> trofia<br />
elevate, il buon ricambio idrico e la forte turbolenza sembrano garantire buone con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> ossigenazione, e<br />
quin<strong>di</strong> scongiurare l’instaurarsi <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni anossiche. Inoltre dal momento che lo stagno ha una notevole
importanza ai fini produttivi, e che una <strong>di</strong>minuzione <strong>del</strong>la trofia avrebbe sicuramente <strong>del</strong>le ripercussioni<br />
negative sulla produttività ittica, la situazione rilevata dallo stu<strong>di</strong>o rappresenta quella ottimale per lo stagno”.<br />
- Aspetto: qualità <strong>del</strong>le acque <strong>di</strong> balneazione<br />
1. Normativa<br />
Il DPR. 470/82 con il quale è stato recepita la Direttiva Europea 76/160, regolamenta il comparto <strong>del</strong>le acque<br />
<strong>di</strong> balneazione. Tale decreto stabilisce che il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> idoneità alla balneazione venga espresso in base alla<br />
conformità a valori limite <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> parametri microbiologici e chimico fisici.<br />
Ai sensi <strong>del</strong>l’art.4 <strong>del</strong> DPR 470/82, competono alle Regioni:<br />
a) la redazione e l’invio al Ministero <strong>del</strong>la sanità […] <strong>del</strong>la mappa degli scarichi, dei corsi d’acqua e dei<br />
punti in cui saranno effettuati i campionamenti e le analisi a cura dei presi<strong>di</strong> e servizi multizonali<br />
previsti dall’art. 22 <strong>del</strong>la legge n. 833/1978 e, fino all’attivazione degli stessi, dai laboratori provinciali<br />
<strong>di</strong> igiene e profilassi;<br />
b) l’in<strong>di</strong>viduazione <strong>del</strong>le zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati <strong>del</strong>le analisi e <strong>del</strong>le eventuali<br />
ispezioni effettuate durante il periodo <strong>di</strong> campionamento relativo all’anno precedente. Tale<br />
in<strong>di</strong>viduazione dovrà essere portata a conoscenza <strong>del</strong>le amministrazioni comunali interessate almeno<br />
un mese prima <strong>del</strong>l’inizio <strong>del</strong>la stagione balneare.<br />
Le acque si considerano balneabili quando per il periodo <strong>di</strong> campionamento relativo all’anno precedente le<br />
analisi dei campioni prelevati in<strong>di</strong>cano che i parametri <strong>del</strong>le acque in questioni sono conformi a quelli <strong>del</strong>la<br />
tabella riportata in Allegato 1 <strong>del</strong> decreto per:<br />
- almeno il 90% dei casi;<br />
- quando nei casi <strong>di</strong> non conformità i valori dei parametri numerici non si <strong>di</strong>scostino più <strong>del</strong> 50% dai<br />
corrispondenti valori.<br />
Per i parametri microbiologici, il pH e l’ossigeno <strong>di</strong>sciolto, non si applica la limitazione <strong>del</strong> 50%; per i<br />
parametri coliformi totali, coliformi fecali e streptococchi fecali la percentuale dei campioni conformi è ridotta<br />
all’80% (art. 6).<br />
Il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> idoneità alla balneazione all’inizio <strong>del</strong>la stagione è subor<strong>di</strong>nato ai risultati favorevoli <strong>del</strong>le analisi<br />
effettuate su un minimo <strong>di</strong> cinque campioni prelevati nel mese antecedente l’inizio <strong>del</strong>la stessa e sugli ultimi<br />
cinque campioni <strong>del</strong>la stagione balneare precedente.<br />
Per valutare la qualità <strong>del</strong>le acque <strong>di</strong> balneazione ad Alghero, sono stati presi in considerazione i parametri<br />
microbiologici: coliformi totali, coliformi fecali e streptococchi.<br />
I valori limiti fissati dal DPR 470/82, per questi parametri sono riportati nell’Allegato 1 <strong>del</strong> decreto e sono<br />
riassunti nella tabella<br />
PARAMETRO VALORE LIMITE U.M.<br />
Coliformi totali 2000 Unità Formanti Colonia in 100 millilitri 100 Ufc/100ml<br />
Coliformi fecali 100 Unità Formanti Colonia in 100 millilitri 100 Ufc/100ml<br />
Streptococchi fecali 100 Unità Formanti Colonia in 100 millilitri 100 Ufc/100ml<br />
Tab_4.2.2./g Requisiti <strong>di</strong> qualità <strong>del</strong>le acque <strong>di</strong> balneazione: valori limite (All.1 <strong>del</strong> DPR 470/82)<br />
2. Balneabilità<br />
Le principali criticità per le acque <strong>di</strong> balneazione sono identificate con la presenza <strong>di</strong> tratti <strong>di</strong> costa in cui vi è<br />
una inter<strong>di</strong>zione permanente per inquinamento, a causa <strong>del</strong>la presenza <strong>di</strong> scarichi a mare. Oltre tali tratti,<br />
possono considerarsi critici anche i tratti <strong>di</strong> costa permanentemente interdetti alla balneazione per<br />
inquinamento dovuto alla presenza <strong>di</strong> foci fluviali.<br />
Relativamente alla situazione <strong>di</strong> Alghero, si è fatto riferimento a due tipi <strong>di</strong> dati:<br />
- i risultati <strong>del</strong>le analisi condotte dal Presi<strong>di</strong>o Multizonale <strong>di</strong> Prevenzione (PMP) <strong>di</strong> Alghero nelle 27<br />
stazioni <strong>di</strong> campionamento;<br />
- i risultati <strong>del</strong>le campagne estive <strong>di</strong> informazione sulle acque <strong>di</strong> balneazione “Goletta verde” condotte da<br />
Legambiente,<br />
I prelievi dei tecnici <strong>di</strong> Legambiente sono stati eseguiti sia nei punti monitorati dall’ASL, sia in altri punti<br />
suggeriti dai circoli locali <strong>di</strong> Legambiente, in corrispondenza <strong>di</strong> scarichi sospetti. La qualità <strong>del</strong>le acque <strong>di</strong>
alneazione è stata valutata considerando i parametri positivi, la percentuale cioè <strong>di</strong> campioni trovati in regola.<br />
L’unica stazione nella quale le concentrazioni <strong>di</strong> Colifecali e Straptococchi fecali pur rimanendo nei limiti<br />
presentano valori prossimi al limite stesso, è localizzata a Fertilia nel 2002 e 2003 e al Lazzaretto 2003.<br />
ANNO LOCALITA’<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
Le Bombarde: spiaggia<br />
Lazzaretto: Stab. “Maristella”<br />
Fertilia: spiaggia<br />
Le Bombarde: spiaggia<br />
Lazzaretto: Stab. “Maristella”<br />
Fertilia: spiaggia<br />
Pineta maria pia: sx la palafitta<br />
S.giovanni: Stab.lido<br />
Le Bombarde: spiaggia<br />
Lazzaretto: Stab. “Maristella”<br />
Fertilia: spiaggia<br />
Le Bombarde: spiaggia<br />
Lazzaretto: Stab. “Maristella”<br />
Fertilia: spiaggia<br />
Le Bombarde: spiaggia<br />
Lazzaretto: Stab. “Maristella”<br />
Fertilia: spiaggia<br />
Le Bombarde: spiaggia<br />
Le Bombarde: spiaggia<br />
COLI FECALI<br />
(Ufc/100ml)<br />
60<br />
10<br />
80<br />
STREPTOCOCCH<br />
I FECALI<br />
(Ufc/100ml)<br />
scarico 26.<br />
Con la stessa or<strong>di</strong>nanza ha altresì ha eliminato il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> balneazione permanente in loc. <strong>Porto</strong> <strong>Conte</strong><br />
ZPISS729 prospicente lo scarico n. 77 in condotta <strong>del</strong> depuratore <strong>di</strong> Maristella.<br />
- Sistema <strong>di</strong> trattamento <strong>del</strong>le acque<br />
1. Efficienza <strong>del</strong> sistema <strong>di</strong> trattamento: portate<br />
Per meglio considerare la variazione <strong>del</strong>la capacità <strong>di</strong> trattamento degli impianti <strong>di</strong> depurazione, in funzione<br />
<strong>del</strong>la popolazione fluttuante, si è scelto <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinguere gli in<strong>di</strong>catori per quanto possibile per il periodo estivo e<br />
per il periodo invernale.<br />
Nel 2009 Alghero era dotata <strong>di</strong> cinque depuratori <strong>di</strong> cui quattro citta<strong>di</strong>ni: Mariotti, San Marco, S. Maria La<br />
Palma, Maristella e uno industriale: San Marco La gestione dei tre impianti citta<strong>di</strong>ni è affidata ad una <strong>di</strong>tta<br />
specializzata dal comune <strong>di</strong> Alghero mentre l’impianto <strong>del</strong>l’area industriale è gestita dall’ASI. Nel 2010<br />
l’obbiettivo è <strong>di</strong> avere solo due depuratori citta<strong>di</strong>ni ovvero quello <strong>di</strong> San Marco e quello <strong>di</strong> S. Maria La Palma<br />
facendo funzionare il Mariotti e il Maristella come stazioni <strong>di</strong> pompaggio.<br />
Per il controllo <strong>del</strong>l’efficienza <strong>del</strong>la depurazione vengono effettuate analisi in entrata ed in uscita dagli impianti<br />
che riguardano i principali parametri <strong>di</strong> controllo <strong>di</strong> qualità <strong>del</strong>lo scarico; le analisi vengono quin<strong>di</strong> inviate al<br />
gestore unico Abbanoa.<br />
I parametri costantemente controllati sono quelli <strong>del</strong>la richiesta <strong>di</strong> ossigeno per ossidazione biochimica a<br />
cinque giorni (BOD5), <strong>del</strong>la richiesta <strong>di</strong> ossigeno per ossidazione chimica (COD), dei soli<strong>di</strong> sospesi totali (SST)<br />
e se<strong>di</strong>mentabili (SS), <strong>del</strong> contenuto <strong>di</strong> azoto nelle sue <strong>di</strong>verse forme e <strong>del</strong> contenuto <strong>di</strong> fosforo.<br />
I primi due impianti sono i più gran<strong>di</strong>: l’impianto dei San Marco è <strong>di</strong>mensionato per un carico <strong>di</strong> 77.500 ab/eq,<br />
l’impianto <strong>del</strong> Mariotti per un carico <strong>di</strong> 110.000 ab/eq, l’impianto <strong>di</strong> Santa Maria <strong>del</strong>la Palma, realizzato per<br />
servire principalmente il caseificio <strong>del</strong>la COAPLa ora <strong>di</strong>messo, è <strong>di</strong>mensionato per un carico <strong>di</strong> 12.900 ab/eq.<br />
Un dato interessante riguarda la variabilità <strong>del</strong>la portata me<strong>di</strong>a giornaliera in arrivo agli impianti; nei grafici che<br />
seguono sono riportate le portate degli impianti citta<strong>di</strong>ni rispettivamente nel 2008 e nel 2009.<br />
28.000<br />
27.000<br />
26.000<br />
25.000<br />
24.000<br />
23.000<br />
22.000<br />
21.000<br />
20.000<br />
19.000<br />
18.000<br />
17.000<br />
16.000<br />
24.500<br />
22.500<br />
20.500<br />
18.500<br />
16.500<br />
14.500<br />
12.500<br />
10.500<br />
8.500<br />
6.500<br />
4.500<br />
2.500<br />
500<br />
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov <strong>di</strong>c<br />
Fig_4.2.2./b Mariotti: portate me<strong>di</strong>e giornaliere mc/g anno 2008<br />
Portata me<strong>di</strong>a Mariotti Portata me<strong>di</strong>a S.Marco<br />
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov <strong>di</strong>c<br />
Fig_4.2.2./c Mariotti e S. Marco: portate me<strong>di</strong>e giornaliere mc/g anno 2009
28000<br />
27000<br />
26000<br />
25000<br />
24000<br />
23000<br />
22000<br />
21000<br />
20000<br />
19000<br />
18000<br />
17000<br />
16000<br />
Portata me<strong>di</strong>a autorizzata S.Marco Tot ale port at e<br />
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov <strong>di</strong>c<br />
Fig_4.2.2./d Mariotti + S. Marco: portate me<strong>di</strong>e giornaliere mc/g anno 2009<br />
Facendo la somma <strong>del</strong>le portate dei due impianti principali, Alghero centro e San Marco che servono la città,<br />
nell’anno 2009 si rilevano variazioni <strong>del</strong>la portata me<strong>di</strong>a giornaliera tra i mesi invernali ed quelli estivi: ad<br />
esempio, la portata me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> novembre è stata <strong>di</strong> 18.917 mc mentre ad agosto la portata è stata <strong>di</strong> 21.779<br />
mc.<br />
E’ interessante notare che nel “1° Rapporto sullo stato <strong>del</strong>l’ambiente” si rilevava una variabilità tra mesi estivi<br />
ed invernali più marcata, ad esempio, nell’ l’impianto <strong>del</strong> Mariotti la portata me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> febbraio 2001 era <strong>di</strong><br />
17.400 mc mentre ad agosto la portata era <strong>di</strong> 26.960 mc. Questa variabilità è dovuta non solo alla presenza <strong>di</strong><br />
popolazione fluttuante, fenomeno molto caratterizzante <strong>del</strong>la realtà <strong>di</strong> Alghero, ma anche alla piovosità, infatti<br />
sono ancora numerosi gli sfiori <strong>del</strong>le acque bianche nella rete fognaria citta<strong>di</strong>na. Da marzo 2010 tutti i reflui<br />
<strong>del</strong>la città saranno convogliati nell’impianto <strong>di</strong> San Marco la cui portata me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> scarico è <strong>di</strong> 24.000<br />
mc/giorno, come da autorizzazione <strong>del</strong>la Provincia <strong>di</strong> Sassari n. 16/2008; come si evince dal grafico nei mesi<br />
estivi e in quelli piovosi le portate me<strong>di</strong>e in entrata <strong>del</strong> depuratore si avvicinano alla portata me<strong>di</strong>a autorizzata.<br />
Si riportano sotto le portate mensili e me<strong>di</strong>e dei depuratori citta<strong>di</strong>ni rispettivamente nel 2008 e nel 2009:
Portata mensile<br />
Porata me<strong>di</strong>a<br />
TOTALE<br />
PERIODO<br />
MEDIA<br />
PORTATE<br />
<strong>MAR</strong>IOTTI<br />
data m3<br />
GENNAIO 651.651<br />
FEBBRAIO 602.620<br />
<strong>MAR</strong>ZO 593.650<br />
APRILE 560.760<br />
MAGGIO 630.850<br />
GIUGNO 602.400<br />
LUGLIO 684.263<br />
AGOSTO 744.341<br />
SETTEMBRE 676.410<br />
OTTOBRE 713.124<br />
NOVEMBRE 726.618<br />
DICEMBRE 598.610<br />
GENNAIO 21.021<br />
FEBBRAIO 20.780<br />
<strong>MAR</strong>ZO 19.150<br />
APRILE 18.692<br />
MAGGIO 20.350<br />
GIUGNO 20.080<br />
LUGLIO 22.073<br />
AGOSTO 24.011<br />
SETTEMBRE 22.547<br />
OTTOBRE 23.004<br />
NOVEMBRE 24.221<br />
DICEMBRE 19.310<br />
Tab_4.2.2./l Portate depuratore citta<strong>di</strong>no 2008<br />
7.785.297<br />
21.270<br />
Portata<br />
mensile<br />
Porata me<strong>di</strong>a<br />
TOTALE<br />
PERIODO<br />
MEDIA<br />
PORTATE<br />
SAN <strong>MAR</strong>CO <strong>MAR</strong>IOTTI<br />
SAN <strong>MAR</strong>CO+<br />
<strong>MAR</strong>IOTTI<br />
data m3 m3 m3<br />
GENNAIO 402.380 402.380<br />
FEBBRAIO 215.152 215.152<br />
<strong>MAR</strong>ZO 455.545 218.426 673.971<br />
APRILE 456.600 149.970 606.570<br />
MAGGIO 583.770 35.040 618.810<br />
GIUGNO 434.598 100.605 535.203<br />
LUGLIO 479.725 156.565 636.290<br />
AGOSTO 493.148 182.016 675.164<br />
SETTEMBRE 492.270 160.368 652.638<br />
OTTOBRE 510.694 135.773 646.467<br />
NOVEMBRE 448.230 119.292 567.522<br />
DICEMBRE 483.832 131.238 615.070<br />
GENNAIO 12.980 12.980<br />
FEBBRAIO 7.684 7.684<br />
<strong>MAR</strong>ZO 14.695 7.046 21.741<br />
APRILE 15.220 4.999 20.219<br />
MAGGIO 18.831 1.130 19.962<br />
GIUGNO 14.487 3.354 17.840<br />
LUGLIO 15.475 5.050 20.525<br />
AGOSTO 15.908 5.871 21.779<br />
SETTEMBRE 16.409 5.346 21.755<br />
OTTOBRE 16.474 4.380 20.854<br />
NOVEMBRE 14.941 3.976 18.917<br />
DICEMBRE 15.607 4.233 19.841<br />
4.838.412 2.006.825 6.845.237<br />
15.805 5.504 18.675<br />
Tab_4.2.2./m Portate mensili e me<strong>di</strong>e giornaliere depuratori citta<strong>di</strong>ni 2009<br />
NB: a gennaio e febbraio al S. marco non erano presenti misuratori <strong>di</strong> portata
Portata mensile<br />
Porata me<strong>di</strong>a<br />
TOTALE<br />
PERIODO<br />
MEDIA<br />
PORTATE<br />
S.M.LA PALMA <strong>MAR</strong>ISTELLA<br />
data m3 m3<br />
GENNAIO 31.019 21.099<br />
FEBBRAIO 20.358 12.250<br />
<strong>MAR</strong>ZO 23.575 13.078<br />
APRILE 26.580 22.440<br />
MAGGIO 15.162 31.567<br />
GIUGNO 15.939 52.449<br />
LUGLIO 20.881 35.798<br />
AGOSTO 22.369 34.301<br />
SETTEMBRE 20.235 46.950<br />
OTTOBRE 16.523 29.350<br />
NOVEMBRE 16.578 36.009<br />
DICEMBRE 17.490 38.399<br />
GENNAIO 1.001 681<br />
FEBBRAIO 727 438<br />
<strong>MAR</strong>ZO 760 422<br />
APRILE 886 748<br />
MAGGIO 489 1.018<br />
GIUGNO 531 1.748<br />
LUGLIO 674 1.155<br />
AGOSTO 722 1.106<br />
SETTEMBRE 675 1.565<br />
OTTOBRE 533 947<br />
NOVEMBRE 553 1.200<br />
DICEMBRE 564 1.239<br />
246.709 373.690<br />
676 1.022<br />
Tab_2.1.2/n Portate mensili e me<strong>di</strong>e giornaliere depuratori borgate 2009<br />
Sopra sono in<strong>di</strong>cate le portate me<strong>di</strong>e mensili dei due depuratori che servono rispettivamente la borgata <strong>di</strong> S.M. La<br />
Palma e <strong>di</strong> Maristella; anche per questi come per quelli citta<strong>di</strong>ni si rilevano variazioni <strong>del</strong>la portata me<strong>di</strong>a<br />
giornaliera tra i mesi invernali ed quelli estivi dovuta sicuramente alla presenza <strong>di</strong> popolazione fluttuante: è<br />
in<strong>di</strong>cativo il picco <strong>del</strong>la portata <strong>del</strong>l’impianto <strong>di</strong> Maristella, che serve anche gli alberghi <strong>del</strong>la zona, nel mese <strong>di</strong><br />
giugno nel quale tra l’altro la piovosità si è attestata tra i 20 e i 40 mm/g. Nei mesi <strong>di</strong> gennaio, aprile, settembre,<br />
novembre e <strong>di</strong>cembre la piovosità è stata tra 80 e 150 mm/g e può aver influito sulle portate.<br />
113
1800<br />
1700<br />
1600<br />
1500<br />
1400<br />
1300<br />
1200<br />
1100<br />
1000<br />
900<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
1800<br />
1700<br />
1600<br />
1500<br />
1400<br />
1300<br />
1200<br />
1100<br />
1000<br />
900<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov <strong>di</strong>c<br />
Fig_2.1.2/e S. M. La Palma portate me<strong>di</strong>e giornaliere mc/g anno 2009<br />
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov <strong>di</strong>c<br />
Fig_4.2.2./f Maristella portate me<strong>di</strong>e giornaliere mc/g anno 2009<br />
2. Efficienza <strong>del</strong> sistema <strong>di</strong> trattamento: capacità <strong>di</strong> trattamento<br />
La capacità <strong>di</strong> trattamento degli impianti <strong>di</strong> depurazione è data dalla potenzialità degli impianti in abitanti<br />
equivalenti rispetto alla popolazione servita in abitanti equivalenti compresa la popolazione fluttuante. L'abitante<br />
equivalente è definito all'art. 74 comma 1 lett.a) <strong>del</strong> D.Lgs. 152/06 come "carico organico biodegradabile avente<br />
una richiesta <strong>di</strong> ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi <strong>di</strong> ossigeno al giorno" pertanto il numero degli<br />
abitanti equivalenti (ab.eq.) si ottiene con la seguente formula: Ab.Eq. = BOD5 g/d :60 g/d<br />
Per l’impianto <strong>di</strong> San Marco si sono presi due campioni <strong>di</strong> acqua reflua in ingesso rispettivamente il 09/07/2009<br />
ed il 03.11.2009; nel primo a fronte <strong>di</strong> una portata giornaliera <strong>di</strong> 15400 mc/d ed un BOD <strong>di</strong> 175 mg/l si ha una<br />
capacità <strong>del</strong>l’impianto <strong>di</strong> 44.916 ab. eq. mentre nel secondo a fronte <strong>di</strong> una portata giornaliera <strong>di</strong> 15590 mc/d e un<br />
BOD <strong>di</strong> 40 mg/l si ha una capacità <strong>del</strong>l’impianto <strong>di</strong> 10.393 ab.eq.<br />
Anche per l’impianto <strong>del</strong> Mariotti si sono presi due campioni <strong>di</strong> acqua reflua in ingesso rispettivamente il<br />
17/07/2009 ed il 05.12.2009; nel primo a fronte <strong>di</strong> una portata giornaliera <strong>di</strong> 4763 mc/d ed un BOD <strong>di</strong> 161.2 mg/l si<br />
ha una capacità <strong>del</strong>l’impianto <strong>di</strong> 12.797ab. eq. Mentre nel secondo a fronte <strong>di</strong> una portata giornaliera <strong>di</strong> 2000<br />
mc/d e un BOD <strong>di</strong> 45.7 mg/l si ha una capacità <strong>del</strong>l’impianto <strong>di</strong> 1.523 ab.eq.<br />
Per quanto riguarda l’impianto <strong>di</strong> S. Maria La Palma si sono presi i due campioni <strong>di</strong> acqua reflua in ingesso<br />
rispettivamente col COD più alto e più basso il 22/08/2009 ed il 03.09.2009; nel primo a fronte <strong>di</strong> una portata<br />
giornaliera <strong>di</strong> 723 mc/d ed un BOD <strong>di</strong> 174.3mg/l si ha una capacità <strong>del</strong>l’impianto <strong>di</strong> 2.100 ab. eq. Mentre nel<br />
secondo a fronte <strong>di</strong> una portata giornaliera <strong>di</strong> 453 mc/d e un BOD <strong>di</strong> 41.1 mg/l si ha una capacità <strong>del</strong>l’impianto <strong>di</strong><br />
310 ab.eq. Considerato che l’impianto è <strong>di</strong>mensionato per un carico <strong>di</strong> 12.900 ab.eq. possiamo <strong>di</strong>re che a fronte<br />
degli abitanti equivalenti risultanti è sovra<strong>di</strong>mensionato.<br />
Per l’impianto <strong>di</strong> Maristella i due campioni <strong>di</strong> acqua reflua in ingesso rispettivamente col COD più alto e più basso<br />
sono <strong>del</strong> 22/08/2009 ed <strong>del</strong> 05.12.2009; nel primo a fronte <strong>di</strong> una portata giornaliera <strong>di</strong> 1100 mc/d ed un BOD <strong>di</strong><br />
388mg/l si ha una capacità <strong>del</strong>l’impianto <strong>di</strong> 7.113 ab. eq. Mentre nel secondo a fronte <strong>di</strong> una portata giornaliera <strong>di</strong><br />
1200 mc/d e un BOD <strong>di</strong> 35.6 mg/l si ha una capacità <strong>del</strong>l’impianto <strong>di</strong> 712 ab.eq.. Considerato che<br />
l’impianto <strong>di</strong> è <strong>di</strong>mensionato per un carico <strong>di</strong> 12.900 ab.eq. possiamo <strong>di</strong>re che a fronte degli abitanti equivalenti<br />
risultanti è sovra<strong>di</strong>mensionato.<br />
114
INVERNO<br />
Depuratori<br />
Periodo<br />
BOD<br />
INGRSSO<br />
PORTATA<br />
MEDIA<br />
SAN <strong>MAR</strong>CO<br />
ABITANTI<br />
EQUIVALENTI<br />
BOD/60<br />
POTENZIALITA<br />
IMPIANTO<br />
CAPACITA<br />
TRATAMEN<br />
mg/l mc A.E. A.E. %<br />
Ottobre 90,0 16.474 24.711 77.500 31,89<br />
Novembre 90,0 14.941 22.412 77.500 28,92<br />
Dicembre 87,0 15.607 22.630 77.500 29,20<br />
Gennaio 0 77.500<br />
Febbraio 0 77.500<br />
Marzo 0 77.500<br />
TOTALE PERIODO 89,0 5.202 23.251 77.500 30,00<br />
ESTATE<br />
Aprile 0 77.500<br />
Maggio 0 77.500<br />
Giugno 78,0 14.487 18.833 77.500 24,30<br />
Luglio 150,0 15.475 38.688 77.500 49,92<br />
Agosto 128,0 15.908 33.937 77.500 43,79<br />
Settembre 100,0 16.409 27.348 77.500 35,29<br />
TOTALE PERIODO 114,0 15.570 29.702 77.500 38,32<br />
INVERNO<br />
Tab_4.2.2./o San Marco: calcolo abitanti equivalenti e capacità <strong>di</strong> trattamento anno 2009<br />
Depuratori<br />
Periodo<br />
Ottobre<br />
Novembre<br />
BOD<br />
INGRSSO<br />
PORTATA<br />
MEDIA<br />
<strong>MAR</strong>IOTTI<br />
ABITANTI<br />
EQUIVALENTI<br />
BOD/60<br />
POTENZIALITA<br />
IMPIANTO<br />
CAPACITA<br />
TRATAMEN<br />
mg/l mc A.E. A.E. %<br />
Dicembre 45,7 4.233 3.224 110.000 2,93<br />
Gennaio 233,0 12.980 50.406 110.000 45,82<br />
Febbraio 218,0 7.684 27.919 110.000 25,38<br />
Marzo 160,5 7.046 18.848 110.000 17,13<br />
TOTALE PERIODO 164,3 7.986 25.099 110.000 22,82<br />
ESTATE<br />
Aprile 95,8 4.999 7.982 110.000 7,26<br />
Maggio<br />
Giugno<br />
Luglio 161,2 5.050 13.568 110.000 12,33<br />
Agosto<br />
Settembre 590,3 5.346 52.596 110.000 47,81<br />
TOTALE PERIODO 282,4 5.132 24.715 110.000 22,47<br />
Tab_4.2.2./p Mariotti: calcolo abitanti equivalenti e capacità <strong>di</strong> trattamento anno 2009<br />
Le tabelle riportate, una per ciascun depuratore, nelle quali a partire dal BOD me<strong>di</strong>o giornaliero, ricavato dai dati<br />
<strong>del</strong>le analisi campione e dalla portata me<strong>di</strong>a giornaliera, vengono in<strong>di</strong>cati gli abitanti equivalenti risultanti sud<strong>di</strong>visi<br />
115
per periodo invernale ed estivo, nonché la capacità <strong>di</strong> trattamento <strong>di</strong> ciascun impianto.<br />
INVERNO<br />
Depuratori<br />
Periodo<br />
BOD<br />
INGRSSO<br />
SANTA <strong>MAR</strong>IA LA PALMA<br />
PORTATA<br />
MEDIA<br />
ABITANTI<br />
EQUIVALENTI<br />
BOD/60<br />
POTENZIALITA<br />
IMPIANTO<br />
CAPACITA<br />
TRATAMEN<br />
mg/l mc A.E. A.E. %<br />
Ottobre 0<br />
Novembre 0<br />
Dicembre 59,4 564 559 12.900 4,33<br />
Gennaio 67,3 1.001 1.122 12.900 8,70<br />
Febbraio 99,8 727 1.209 12.900 9,38<br />
Marzo 71,3 761 904 12.900 7,01<br />
TOTALE PERIODO 74,5 763 949 12.900 7,35<br />
ESTATE<br />
Aprile 68,8 886 1.016 12.900 7,88<br />
Maggio 107,7 489 878 12.900 6,80<br />
Giugno 146,8 531 1.300 12.900 10,08<br />
Luglio 166,4 674 1.868 12.900 14,48<br />
Agosto 174,3 722 2.096 12.900 16,25<br />
Settembre 41,1 675 462 12.900 3,58<br />
TOTALE PERIODO 117,5 663 1.270 12.900 9,84<br />
INVERNO<br />
Tab_4.2.2./q S.M. La Palma: calcolo abitanti equivalenti e capacità <strong>di</strong> trattamento anno 2009<br />
Depuratori<br />
Periodo<br />
BOD<br />
INGRSSO<br />
PORTATA<br />
MEDIA<br />
<strong>MAR</strong>ISTELLA<br />
ABITANTI<br />
EQUIVALENTI<br />
BOD/60<br />
POTENZIALITA<br />
IMPIANTO<br />
CAPACITA<br />
TRATAMEN<br />
mg/l mc A.E. A.E. %<br />
Ottobre 0<br />
Novembre 0<br />
Dicembre 59,4 1.238 1.226 2.500 49,02<br />
Gennaio 67,3 680 763 2.500 30,51<br />
Febbraio 99,8 438 728 2.500 29,11<br />
Marzo 71,3 422 501 2.500 20,06<br />
TOTALE PERIODO 74,5 694 804 2.500 32,18<br />
ESTATE<br />
Aprile 68,8 749 858 2.500 34,33<br />
Maggio 107,7 1.018 1.828 2.500 73,11<br />
Giugno 146,8 1.748 4.278 2.500 171,10<br />
Luglio 166,4 1.155 3.203 2.500 128,11<br />
Agosto 174,3 1.107 3.214 2.500 128,58<br />
116
Settembre 41,1 1.565 1.072 2.500 42,88<br />
TOTALE PERIODO 117,5 1.224 2.409 2.500 96,35<br />
Tab_4.2.2./r Maristella: calcolo abitanti equivalenti e capacità <strong>di</strong> trattamento anno 2009<br />
Trattamento <strong>del</strong>le acque<br />
I quattro impianti <strong>di</strong> depurazione <strong>del</strong>le acque reflue (San Marco, Alghero centro, Maristella e Santa Maria La<br />
Palma), che componevano nel 2009 il sistema <strong>di</strong> depurazione, sono schematizzati sotto:<br />
1. Impianto <strong>di</strong> depurazione liquami Loc. San Marco<br />
• Stazione <strong>di</strong> pompaggio per il rilancio <strong>di</strong> parte <strong>del</strong> refluo <strong>del</strong>l’impianto <strong>di</strong> Via Degli Orti in Loc. M.<br />
Agnese<br />
• Condotta in pressione che collega l’impianto <strong>di</strong> Via Degli Orti alla stazione <strong>di</strong> pompaggio in Loc. M.<br />
Agnese<br />
• Condotta per caduta che collega la stazione <strong>di</strong> pompaggio <strong>di</strong> M. Agnese all’impianto <strong>di</strong> depurazione in<br />
Loc. S.Marco: innesto <strong>del</strong>la condotta proveniente dalla zona artigianale Ungis Galantè<br />
Parte dei reflui <strong>del</strong>la città <strong>di</strong> Alghero che raggiungono l’impianto <strong>di</strong> Via degli Orti nel 2009 sono stati convogliati<br />
tramite una condotta premente nella stazione <strong>di</strong> pompaggio <strong>di</strong> M. Agnese e da qui tramite una condotta per<br />
caduta convogliati nel depuratore in Loc. S.Marco. In questo tratto si innesta la condotta proveniente dalla<br />
zona artigianale <strong>di</strong> Ungis Galantè ed è in progetto l’innesto <strong>del</strong>la condotta <strong>del</strong>la borgata <strong>di</strong> Sa Segada.<br />
2. Impianto <strong>di</strong> depurazione liquami Via Degli Orti<br />
• Stazione <strong>di</strong> pompaggio per il rilancio <strong>del</strong> refluo urbano presso Bigagli (Incrocio tra Via Garibal<strong>di</strong> e Via<br />
Degli Orti)<br />
• Condotta in pressione che collega la stazione <strong>di</strong> pompaggio al depuratore<br />
• Stazione <strong>di</strong> pompaggio per il rilancio <strong>del</strong> refluo urbano in Loc. Taulera<br />
• Stazione <strong>di</strong> pompaggio per il rilancio <strong>del</strong> refluo urbano in Via Lido<br />
I reflui <strong>del</strong>la città <strong>di</strong> Alghero che non raggiungono l’impianto per caduta sono convogliati nella stazione <strong>di</strong><br />
pompaggio <strong>di</strong> Bigagli e da qui tramite una condotta in pressione, lunga circa 1 Km scaricate nel depuratore. La<br />
stazione <strong>di</strong> pompaggio in Località Taulera, invece, serve per il rilancio dei reflui degli inse<strong>di</strong>amenti abitativi<br />
<strong>del</strong>la zona verso la fognatura comunale. La stazione <strong>di</strong> pompaggio <strong>di</strong> Via Lido, infine, serve per il rilascio dei<br />
reflui <strong>del</strong>la zona litoranea nord verso la fognatura comunale.<br />
Nel 2010 in questo impianto sarà effettuata solo la grigliatura e un primo accumulo dei reflui successivamente<br />
inviati all’impianto in Loc. S.Marco.<br />
3. Impianto <strong>di</strong> depurazione liquami in Loc. Maristella<br />
L’impianto <strong>di</strong> depurazione <strong>di</strong> Maristella è un piccolo impianto a fanghi attivi, <strong>di</strong>mensionato per un carico <strong>di</strong><br />
2.500 ab/eq al servizio <strong>del</strong>la borgata e degli alberghi limitrofi. Nel 2010 questo sarà <strong>di</strong>messo e i reflui inviati<br />
tramite una premente all’impianto <strong>di</strong> S. M. La Palma.<br />
4. Impianto <strong>di</strong> depurazione liquami in Loc. S.Maria La Palma<br />
• Stazione <strong>di</strong> pompaggio per il rilancio <strong>del</strong> refluo urbano in Fertilia<br />
• Stazione <strong>di</strong> pompaggio per il rilancio <strong>del</strong> refluo <strong>del</strong>la Cooperativa “Fertilia” e <strong>del</strong> nuovo ostello <strong>del</strong>la<br />
gioventù in Fertilia<br />
• Condotta in pressione che collega la borgata <strong>di</strong> Fertilia al depuratore <strong>di</strong> S. Maria La Palma<br />
L’impianto <strong>di</strong> depurazione <strong>di</strong> S. Maria La Palma raccoglie e depura i reflui <strong>del</strong>la borgata limitrofa e quelli <strong>del</strong>la<br />
frazione Fertilia che vi giungono tramite condotta forzata, alla quale attualmente è collegato lo scarico fognario<br />
<strong>del</strong>l’Aeroporto militare e <strong>del</strong> Motel Fertilia. L’impianto è stato <strong>di</strong>mensionato per un carico inquinante <strong>di</strong> 12.900<br />
ab/eq, dal momento che tratta anche gli scarichi <strong>del</strong>la cantina sociale ubicata in prossimità <strong>del</strong>la Borgata.<br />
117
Venivano trattati anche i reflui <strong>del</strong> caseificio COAPLA ora <strong>di</strong>messo; sono previsti due nuovi allacci un albergo<br />
in prossimità <strong>del</strong>la borgata e la cooperativa Palmavera.<br />
La stazione <strong>di</strong> pompaggio <strong>di</strong> Fertilia è collegata al depuratore tramite una condotta in pressione, lunga circa<br />
6.300 m. La stazione <strong>di</strong> pompaggio Cooperativa “Fertilia” e nuovo Ostello <strong>del</strong>la Gioventù serve per inviare in<br />
fognatura, collocata ad una quota più alta, i reflui <strong>di</strong> alcuni inse<strong>di</strong>amenti <strong>del</strong>la zona, tra i quali appunto l’Ostello<br />
<strong>del</strong>la gioventù.<br />
- <strong>Analisi</strong> swot<br />
PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA OPPORTUNITA’ RISCHI<br />
- Ridotta <strong>di</strong>sponibilità - Promozione <strong>di</strong> misure - Ingressione in<br />
<strong>del</strong>le risorse idriche finalizzate alla falda <strong>di</strong> acque<br />
conservazione, al marine<br />
risparmio, al riutilizzo ed<br />
al riciclo <strong>del</strong>le risorse<br />
idriche<br />
- Presenza <strong>di</strong> tratti <strong>di</strong><br />
costa in cui vi è una<br />
inter<strong>di</strong>zione permanente<br />
per inquinamento<br />
- <strong>Analisi</strong> quantitativa e qualitativa: gli in<strong>di</strong>catori<br />
Legenda:<br />
fenomeno in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> stabilità<br />
fenomeno in <strong>di</strong>minuzione/miglioramento<br />
fenomeno in aumento/peggioramento<br />
☺ positivo<br />
incerto<br />
negativo<br />
- Raggiungimento o<br />
mantenimento degli<br />
obiettivi <strong>di</strong> qualità fissati<br />
per i corpi idrici<br />
- Recupero e<br />
salvaguar<strong>di</strong>a <strong>del</strong>le<br />
risorse idriche per lo<br />
sviluppo <strong>del</strong>le attività<br />
produttive<br />
-Mantenimento e<br />
<strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> pratiche e<br />
sistemi agricoli in grado<br />
<strong>di</strong> favorire il risparmio<br />
idrico e la riduzione dei<br />
carichi inquinanti per<br />
l’acqua<br />
Giu<strong>di</strong>zio sintetico componente:<br />
TUTELA DELLA RISORSA DIRICA<br />
SPR<br />
Aspetto In<strong>di</strong>catore u.m. Valore<br />
incerto<br />
Giu<strong>di</strong>zio<br />
sintetico<br />
Trend<br />
118
8<br />
Pressione<br />
Consumo<br />
idrico<br />
QUALITA’ DELLE ACQUE<br />
Stato<br />
Fabbisogno idrico per uso<br />
civile<br />
(Periodo invernale)<br />
Fabbisogno idrico per uso<br />
civile<br />
(Periodo estivo)<br />
Fabbisogno idrico per uso<br />
irriguo<br />
Fabbisogno idrico per uso<br />
industriale<br />
Mm 3<br />
/a<br />
Mm 3<br />
/a<br />
Mm 3<br />
/a<br />
Mm 3<br />
/a<br />
n.d. <br />
n.d.<br />
n.d.<br />
n.d.<br />
Aspetto In<strong>di</strong>catore u.m. Valore<br />
Qualità <strong>del</strong>le<br />
acque <strong>di</strong><br />
balneazione 1<br />
Tratto <strong>di</strong> costa interdetta<br />
temporaneamente alla<br />
balneazione<br />
% <strong>di</strong> costa interdetta<br />
temporaneamente alla<br />
balneazione<br />
Tratto <strong>di</strong> costa interdetta<br />
permanentemente alla<br />
balneazione per motivi<br />
d’inquinamento<br />
% <strong>di</strong> costa interdetta<br />
permanentemente alla<br />
balneazione per motivi<br />
d’inquinamento<br />
SISTEMA DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE 8<br />
Stato<br />
Stato<br />
Km<br />
0.10<br />
%<br />
0,0128<br />
Km<br />
3,310<br />
%<br />
4,258<br />
Tav_2.1.2<br />
/a<br />
Aspetto In<strong>di</strong>catore u.m. Valore<br />
Trattament<br />
o <strong>del</strong>le<br />
acque<br />
reflue<br />
Efficienza<br />
<strong>del</strong><br />
sistema <strong>di</strong><br />
gestione<br />
Efficienza<br />
<strong>del</strong><br />
sistema <strong>di</strong><br />
gestione<br />
Tipologie <strong>di</strong> trattamenti previsti<br />
degli impianti <strong>di</strong> depurazione<br />
Popolazione servita<br />
dall’impianto <strong>di</strong> depurazione<br />
area urbana<br />
(Periodo invernale)<br />
Popolazione servita<br />
dall’impianto <strong>di</strong> depurazione<br />
area urbana<br />
(Periodo estivo)<br />
Popolazione servita dalla rete<br />
fognaria<br />
area urbana<br />
(Periodo invernale)<br />
%<br />
%<br />
%<br />
Impianti a<br />
fanghi<br />
attivi<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Giu<strong>di</strong>zio<br />
sintetico<br />
☺ <br />
Giu<strong>di</strong>zio<br />
sintetico<br />
Trend<br />
Tren<br />
d<br />
☺ <br />
100 ☺ <br />
100 ☺ <br />
100 ☺ <br />
119
Stato<br />
Pressione<br />
Carico<br />
inquinante<br />
potenziale<br />
CARTOGRAFIA<br />
Popolazione servita dalla rete<br />
fognaria<br />
area urbana<br />
(Periodo invernale)<br />
Capacità <strong>di</strong> trattamento<br />
<strong>del</strong>l’impianto <strong>di</strong> depurazione:<br />
potenzialità impianto (in ab.<br />
equivalenti) rispetto a<br />
popolazione servita (in ab.<br />
Equivalenti) (Periodo invernale)<br />
Capacità <strong>di</strong> trattamento<br />
<strong>del</strong>l’impianto <strong>di</strong> depurazione:<br />
potenzialità impianto (in ab.<br />
equivalenti) rispetto a<br />
popolazione servita (in ab.<br />
Equivalenti)<br />
(Periodo estivo)<br />
Carichi potenziali <strong>di</strong> BOD da<br />
attività civili<br />
Carichi potenziali <strong>di</strong> BOD da<br />
attività industriali<br />
Carichi potenziali <strong>di</strong> COD da<br />
attività civili<br />
Carichi potenziali <strong>di</strong> COD da<br />
attività industriali<br />
Carichi potenziali <strong>di</strong> azoto da<br />
attività civili<br />
Carichi potenziali <strong>di</strong> azoto da<br />
attività industriali<br />
Carichi potenziali <strong>di</strong> azoto da<br />
attività agricole<br />
Carichi potenziali <strong>di</strong> fosforo da<br />
attività civili<br />
Carichi potenziali <strong>di</strong> fosforo da<br />
attività industriali<br />
Carichi potenziali <strong>di</strong> fosforo da<br />
attività agricole<br />
%<br />
%<br />
%<br />
t/a n.p.<br />
t/a n.p.<br />
t/a n.p.<br />
t/a n.p.<br />
t/a<br />
t/a<br />
t/a<br />
t/a<br />
t/a<br />
t/a<br />
100 ☺ <br />
dalla<br />
Tab_2.1.2/<br />
o<br />
alla<br />
Tab_2.1.2/<br />
r<br />
dalla<br />
Tab_2.1.2/<br />
o<br />
alla<br />
Tab_2.1.2/<br />
r<br />
☺ <br />
☺ <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
n.p. <br />
n.p. <br />
n.p. <br />
n.p. <br />
n.p. <br />
n.p. <br />
Tab_2.1.2/a Caratteristiche dei corpi idrici significativi<br />
Fig_2.1.2/a Stralcio PTA: carichi prodotti da fonte puntuale e da fonte <strong>di</strong>ffusa.<br />
Tab_2.1.2/b Livelli <strong>di</strong> criticità definiti per i corsi d’acqua<br />
Tab_2.1.2/c Criticità per i corsi d’acqua per i macrodescrittori BOD5, COD, P, NH4, NO3<br />
Tab_2.1.2/d Criticità per i corsi d'acqua per i macrodescrittori %O2 alla saturazione e<br />
Escherichia – coli<br />
Tab_2.1.2/e Livelli <strong>di</strong> criticità definiti per i laghi<br />
Tab_2.1.2/f Criticità per i laghi e carico effettivo <strong>di</strong> P afferente<br />
120
1<br />
Tab_2.1.2/g Requisiti <strong>di</strong> qualità <strong>del</strong>le acque <strong>di</strong> balneazione: valori limite (All.1 <strong>del</strong> DPR 470/82)<br />
Tab_2.1.2/h Giu<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> balneabilità Presi<strong>di</strong>o Multizonale <strong>di</strong> Prevenzione (PMP) <strong>di</strong> Alghero<br />
Tab_2.1.2/i Risultati <strong>di</strong> balneabilità tratti dalla campagna estiva <strong>di</strong> Legambiente “Goletta<br />
verde”<br />
Tav_2.1.2/a Tratti <strong>di</strong> costa interdetti alla balneazione<br />
Fig_2.1.2/b Mariotti: portate me<strong>di</strong>e giornaliere mc/g anno 2008<br />
Tav_2.1.2/b Localizzazione degli impianti <strong>di</strong> depurazione<br />
Fig_2.1.2/c Mariotti e S. Marco: portate me<strong>di</strong>e giornaliere mc/g anno 2009<br />
Fig_2.1.2/d Mariotti + S. Marco: portate me<strong>di</strong>e giornaliere mc/g anno 2009<br />
Tab_2.1.2/l Portate depuratore citta<strong>di</strong>no 2008<br />
Tab_2.1.2/m Portate mensili e me<strong>di</strong>e giornaliere depuratori citta<strong>di</strong>ni 2009<br />
Tab_2.1.2/n Portate mensili e me<strong>di</strong>e giornaliere depuratori borgate 2009<br />
Fig_2.1.2/e S. M. La Palma portate me<strong>di</strong>e giornaliere mc/g anno 2009<br />
Fig_2.1.2/f Maristella portate me<strong>di</strong>e giornaliere mc/g anno 2009<br />
Tab_2.1.2/o San Marco: calcolo abitanti equivalenti e capacità <strong>di</strong> trattamento anno 2009<br />
Tab_2.1.2/p Mariotti: calcolo abitanti equivalenti e capacità <strong>di</strong> trattamento anno 2009<br />
Tab_2.1.2/q S.M. La Palma: calcolo abitanti equivalenti e capacità <strong>di</strong> trattamento anno 2009<br />
Tab_2.1.2/r Maristella: calcolo abitanti equivalenti e capacità <strong>di</strong> trattamento anno 2009<br />
Solo nel caso <strong>di</strong> comuni costieri<br />
- Scheda 2: Aria<br />
Fonte dei dati<br />
- Piano <strong>di</strong> Tutela <strong>del</strong>le Acque (PTA) <strong>del</strong>la Regione Autonoma <strong>del</strong>la Sardegna approvato dalla Giunta<br />
Regionale con Delibera <strong>del</strong> 4 aprile 2006, n. 14/16;<br />
- Piano <strong>di</strong> Gestione <strong>del</strong> Distretto Idrografico <strong>del</strong>la Sardegna, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 223<br />
<strong>del</strong> 25 settembre 2009;<br />
- Ministero <strong>del</strong>la Salute - Rapporto sulla qualità <strong>del</strong>le acque <strong>di</strong> balneazione Anno 2008, (Dati 2007);<br />
- Dati Abbanoa;<br />
- Dati Comune <strong>di</strong> Alghero - Settore Ambiente ed Ecologia;<br />
- Dati ARPAS;<br />
- Dati Azienda Sanitaria Locale <strong>del</strong>la Provincia <strong>di</strong> Sassari.<br />
Livello e qualità dei dati<br />
Me<strong>di</strong>a<br />
Priorità tematismo<br />
Alta<br />
- Stato attuale <strong>del</strong>la componente<br />
Il Comune <strong>di</strong> Alghero non è dotato <strong>di</strong> rete <strong>di</strong> rilevamento <strong>del</strong>la qualità <strong>del</strong>l'aria. Considerando tale con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong><br />
base, lo stu<strong>di</strong>o <strong>del</strong>lo stato attuale <strong>del</strong>la qualità <strong>del</strong>l'aria verrà elaborato attraverso i pochi dati relativi alle<br />
rilevazioni effettuate:<br />
- dal "Laboratorio mobile <strong>di</strong> rilevamento <strong>del</strong>la qualità <strong>del</strong>l'aria", tra 11 <strong>di</strong>cembre e il 20 <strong>di</strong>cembre 2007 dalla<br />
Provincia <strong>di</strong> Sassari Settore VIII Ambiente,<br />
- dal "Piano <strong>di</strong> prevenzione, conservazione e risanamento <strong>del</strong>la qualità <strong>del</strong>l'aria ambiente" effettuato tra il 6 e il 14<br />
settembre 2004 dalla Regione Sardegna.<br />
L’analisi sarà effettuata confrontando i dati a <strong>di</strong>sposizione con i valori <strong>di</strong> soglia dei <strong>di</strong>versi inquinanti in<strong>di</strong>cati dalla<br />
Normativa:<br />
-D.M. n.60 <strong>del</strong> 4 aprile 2002 - “Recepimento <strong>del</strong>la <strong>di</strong>rettiva 1999/30/CE <strong>del</strong> Consiglio <strong>del</strong> 22 aprile 1999<br />
concernente i valori limite <strong>di</strong> qualità <strong>del</strong>l’aria ambiente per il biossido <strong>di</strong> zolfo, il biossido <strong>di</strong> azoto, gli ossi<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
azoto, le particelle e il piombo e <strong>del</strong>la <strong>di</strong>rettiva 2000/69/CE relativa ai valori limite <strong>di</strong> qualità <strong>del</strong>l’aria ambiente per<br />
il benzene ed il monossido <strong>di</strong> carbonio”;<br />
-Decreto Legislativo 3 agosto 2007, n. 152 - "Attuazione <strong>del</strong>la <strong>di</strong>rettiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il<br />
cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente ";<br />
-Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 183 - "Attuazione <strong>del</strong>la <strong>di</strong>rettiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria".<br />
Non essendo il <strong>territorio</strong> dotato <strong>di</strong> rete <strong>di</strong> rilevamento permanente <strong>del</strong>la qualità <strong>del</strong>l'aria, l’analisi <strong>del</strong>la componente<br />
scheda risulta pertanto carente <strong>di</strong> alcuni dati <strong>di</strong> base e altri seppur presenti sono insufficienti per una reale<br />
valutazione; non è stato possibile per esempio sud<strong>di</strong>videre gli in<strong>di</strong>catori per periodo invernale e per periodo<br />
121
estivo, per il quale si ha un notevole aumento in termini <strong>di</strong> pressione antropica data dal traffico veicolare e<br />
presenza turistica.<br />
Come riportato sia nel “Piano <strong>di</strong> prevenzione, conservazione e risanamento <strong>del</strong>la qualità <strong>del</strong>l'aria ambiente", che<br />
nella “Relazione annuale sulla qualità <strong>del</strong>l’aria in Sardegna per l’anno 2008” (redatta nel novembre 2009)<br />
entrambi <strong>del</strong>la Regione Sardegna, il <strong>territorio</strong> <strong>di</strong> Alghero è in<strong>di</strong>cato come zona da tenere sotto controllo con un<br />
adeguato monitoraggio, in quanto sono presenti pressioni ambientali <strong>di</strong> rilievo, come porti e aeroporti.<br />
- Rilievi effettuati per il "Piano <strong>di</strong> prevenzione, conservazione e risanamento <strong>del</strong>la qualità <strong>del</strong>l'aria ambiente" dalla<br />
RAS dal 6 al 14.09.2004<br />
L’attività <strong>di</strong> monitoraggio è stata eseguita utilizzando <strong>di</strong>versi meto<strong>di</strong> e tecnologie <strong>di</strong>sponibili, al fine <strong>di</strong> poter<br />
contare in un più ampio spettro <strong>di</strong> analisi:<br />
1. Stazione mobile equipaggiata per l’analisi in continuo dei principali inquinanti atmosferici “convenzionali” (SO2,<br />
CO, NO-NO2-NOX, O3, BTX, PTS, PM10) e dei parametri meteo.<br />
2. Campionatori <strong>di</strong>ffusivi (BTX, NO2, NOX, SO, O3, NH3).<br />
3. Deposimetri (IPA, , metalli pesanti come in<strong>di</strong>cati nell’Allegato I <strong>del</strong> d.lgs n. 351/99, Cromo, Cromo esavalente,<br />
Vana<strong>di</strong>o, Rame, Berillio, <strong>di</strong>ossine).<br />
I siti in<strong>di</strong>viduati per il monitoraggio ad Alghero con i campionatori <strong>di</strong>ffusi sono il Campo Sportivo e i Giar<strong>di</strong>ni<br />
Pubblici mentre con la stazione mobile la Scuola <strong>del</strong>la Pietraia.<br />
La tabella seguente riporta i risultati <strong>del</strong> monitoraggio con i campionatori <strong>di</strong>ffusivi; tutti i risultati sono riportati in<br />
µg/m3.<br />
SS<br />
Localizzazione<br />
Alghero ex<br />
mattatoio<br />
SS Alghero giar<strong>di</strong>ni<br />
Benzene<br />
Toluene<br />
Etilbenz.<br />
0.91 6.45 0.75 2.96 15.92 26.62<br />
2.18 11.06 2.43 9.10 25.38 33.79<br />
Xileni NO2 NOx O3 NH3 SO2<br />
146.91<br />
234.53<br />
Tab_4.2.2./a Risultati <strong>del</strong> monitoraggio con i campionatori <strong>di</strong>ffusivi<br />
64.43 24.32<br />
54.02 5.56<br />
La tabella seguente riporta i risultati <strong>del</strong> monitoraggio con la stazione mobile; tutti i risultati sono riportati in µg/m3.<br />
Me<strong>di</strong>e<br />
Massimi<br />
SO2 NO NO2 NOX CO PM10 O3 Benzene Toluene O-xil<br />
data ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 mg/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3<br />
6/9/2004 1.8 1.9 0.1 1.8 0.8 10.5 100.0 3.6 6.1 6.0<br />
7/9/2004 2.7 3.6 9.5 12.6 1.4 12.5 84.4 1.8 5.0 3.2<br />
8/9/2004 2.3 4.3 13.2 18.1 0.1 12.6 85.2 0.8 3.4 2.0<br />
9/9/2004 3.3 4.4 13.8 18.8 0.1 10.0 80.0 0.8 3.3 1.7<br />
10/9/2004 2.4 4.7 15.3 20.7 0.1 10.4 69.7 0.8 3.7 2.0<br />
11/9/2004 3.2 3.3 11.9 11.2 0.1 10.1 84.0 0.8 3.8 2.1<br />
12/9/2004 2.8 3.3 14.9 18.2 0.2 8.3 71.9 0.9 4.4 2.4<br />
13/9/2004 3.1 5.8 14.0 21.1 0.1 6.4 66.3 0.8 3.3 2.0<br />
14/9/2004 2.9 5.0 14.4 20.2 0.2 10.8 57.9 0.8 3.9 2.9<br />
6/9/2004 2.3 3.0 0.2 10.3 4.9 12.7 113.4 15.6 10.6 17.3<br />
7/9/2004 6.9 17.4 37.5 44.0 15.2 17.8 129.2 18.7 10.9 10.1<br />
8/9/2004 5.3 21.6 34.2 62.0 0.2 20.2 135.5 1.3 5.8 3.2<br />
9/9/2004 9.0 20.2 35.8 61.4 0.2 16.0 132.0 1.3 6.5 2.6<br />
10/9/2004 4.7 18.3 37.6 62.4 0.3 15.1 121.1 1.7 8.8 4.2<br />
11/9/2004 8.1 12.9 28.7 42.7 0.3 14.1 134.5 1.7 8.8 4.1<br />
12/9/2004 6.2 11.0 45.6 60.7 0.5 13.4 117.3 2.0 11.0 5.1<br />
13/9/2004 6.0 27.0 36.0 75.6 0.2 10.9 120.4 1.2 6.7 3.2<br />
14/9/2004 7.1 20.2 44.8 74.0 0.4 17.2 89.9 1.0 5.7 7.1<br />
122
Me<strong>di</strong>e 2.7 4.0 11.9 15.9 0.3 10.2 77.7 1.2 4.1 2.7<br />
Massimi 9.0 27.0 45.6 75.6 15.2 20.2 135.5 18.7 11.0 17.3<br />
Tab_4.2.2.//b Risultati <strong>del</strong> monitoraggio con la stazione mobile R.A.S.<br />
Si può subito osservare che i campionatori <strong>di</strong>ffusivi hanno in genere sovrastimato le concentrazioni <strong>di</strong> quasi tutti<br />
gli inquinanti, fuorché il benzene. In modo particolare i dati relativi all’ozono, destano qualche sospetto essendo<br />
particolarmente alti rispetto ai dati riportati dalla stazione mobile. Ciò come vedremo in seguito è dovuto al fatto<br />
che le concentrazioni <strong>di</strong> O3 sono influenzate da un serie <strong>di</strong> variabili in modo particolare da quelle<br />
meteorologiche.<br />
- Campagna rilevamento <strong>del</strong>la qualità <strong>del</strong>l’aria effettuata dalla Provincia <strong>di</strong> Sassari dal 11 al 20.12.2007<br />
L’attività <strong>di</strong> monitoraggio è stata eseguita utilizzando una stazione mobile nel seguente sito: giar<strong>di</strong>no interno <strong>del</strong>la<br />
Scuola Me<strong>di</strong>a n.3 Via Malta.<br />
La tabella seguente riporta i risultati <strong>del</strong> monitoraggio con la stazione mobile; tutti i risultati sono riportati in µg/m 3 .<br />
Me<strong>di</strong>e<br />
Massimi<br />
SO2 NO NO2 NOX CO PM10 O3<br />
Benzene<br />
Toluene<br />
data ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 mg/m3 ug/m3 ug/m3<br />
ug/m3 ug/m3<br />
ug/m3<br />
11/12/2007 1.8 14,3 22,6 44,4 0,7 34 26 2 8,2 2,8<br />
12/12/2007 2,3 12,7 22,3 41,7 0,7 34 26,1 2,2 9,1 2,4<br />
13/12/2007 1,2 11,1 21,2 38,3 0,6 35 16,6 1,9 7,7 1,6<br />
14/12/2007 1,8 12,6 20,1 39,5 0,6 25 17,9 2,3 8,8 2,2<br />
15/12/2007 2,5 3,7 9,2 14,9 0,4 17 40,1 1,4 7 0,6<br />
16/12/2007 1,7 3,6 8,1 13,7 0,5 11 38,5 1,6 7 0,6<br />
17/12/2007 1 4,1 11,6 17,8 0,6 10 40,7 1,5 7 0,7<br />
18/12/2007 2 3,5 11,3 16,8 0,6 12 40,3 1,8 7 1,2<br />
19/12/2007 2,1 6,7 15,2 25,5 0,7 21 23,7 2,2 6,8 0,9<br />
20/12/2007 1,3 7,9 16,6 28,7 0,7 23 26 1,7 6,8 0,9<br />
O-xil<br />
11/12/2007 4,8 53,8 42,4 124,9 1,5 47,5 5,3 22,8 10,2<br />
12/12/2007 4,9 57,8 44,4 133 1,8 48,9 7,6 26,3 10,6<br />
13/12/2007 3,2 29,7 31,9 70,4 1 39,5 3,8 10,3 3,3<br />
14/12/2007 6,6 65,9 54,6 155,6 1,7 46,1 8 28,3 12,2<br />
15/12/2007 4,7 4,8 23,5 27,3 0,5 47,8 2,1 7,2 0,9<br />
16/12/2007 3 4,5 16,5 20,2 0,5 45,3 2 7,2 0,6<br />
17/12/2007 2,7 8,2 24,4 35,4 0,7 51,9 2,8 7,2 1,8<br />
18/12/2007 3,1 5,8 25 33,1 0,8 55 2,9 7,2 7,1<br />
19/12/2007 3,6 22,4 30,8 55,2 0,9 43,4 3,9 8,5 2,4<br />
20/12/2007 2 25 30,9 69,2 0,9 48,7 2,8 7,5 2,5<br />
Me<strong>di</strong>e 1,59 8,02 15,82 28,13 0,61 22,2 29,59 1,86 7,54 1,39<br />
Massimi 3,86 27,79 32,44 72,43 1,03 47,41 4,12 13,25 5,16<br />
Tab_4.2.2.//c Risultati <strong>del</strong> monitoraggio con la stazione mobile Provincia <strong>di</strong> Sassari<br />
- Superamento dei limiti <strong>di</strong> legge<br />
1. Soglie <strong>di</strong> valutazione.<br />
Le norme in<strong>di</strong>cate in premessa stabiliscono limiti <strong>di</strong> accettabilità, ai fini <strong>del</strong>la protezione <strong>del</strong>la salute umana, per i<br />
seguenti parametri:<br />
Polveri - PM10<br />
123
Ozono - O3<br />
Biossido <strong>di</strong> Azoto - NO2<br />
Biossido <strong>di</strong> Zolfo - SO2<br />
Monossido <strong>di</strong> Carbonio - CO<br />
Benzene - C6H6<br />
La misura dei parametri Toluene, Xyleni e Idrocarburi non metanici, in quanto potenziali precursori <strong>del</strong>l'ozono, è<br />
prevista <strong>del</strong> DL 18312004; per tali composti non vengono tuttavia in<strong>di</strong>cati limiti o soglie <strong>di</strong> attenzione.<br />
Si riportano <strong>di</strong> seguito i valori limite per i soli inquinanti per i quali sono definiti i limiti <strong>di</strong> accettabilità ai fini <strong>del</strong>la<br />
protezione <strong>del</strong>la salute umana, con in<strong>di</strong>cazione <strong>del</strong>l'agente inquinante, <strong>del</strong> tipo <strong>di</strong> limite, <strong>del</strong> tipo <strong>di</strong> elaborazione<br />
dei dati e <strong>del</strong>la base temporale <strong>di</strong> applicazione, tenuto conto dei margini <strong>di</strong> tolleranza previsti dalla legge e<br />
applicabili per 1' anno 2007 (DM 6012002).<br />
Fig_4.2.2./a Valori limite dei principali agenti inquinanti<br />
Data la limitazione temporale <strong>del</strong>le campagne <strong>di</strong> rilevamenti, nella tabella non sono riportati i valori limite<br />
riguardanti tempi <strong>di</strong> elaborazione superiori alle 24 ore. Inoltre i limiti in<strong>di</strong>cati non sono applicabili e possono essere<br />
considerati solo come termini in<strong>di</strong>cativi <strong>di</strong> confronto con i valori rilevati, ai fini <strong>di</strong> una prima stima <strong>del</strong>la qualità<br />
<strong>del</strong>l'aria.<br />
Le misurazioni effettuate rientrano pertanto nella categoria <strong>del</strong>la "Valutazione preliminare <strong>del</strong>la qualità <strong>del</strong>l'aria<br />
ambiente" secondo quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 <strong>del</strong> DLgs 35 1/99.<br />
In particolare tali valutazioni sono previste al fine <strong>di</strong> stabilire il confronto tra i livelli <strong>di</strong> inquinamento presenti in una<br />
determinata zona e le seguenti soglie :<br />
• soglia <strong>di</strong> valutazione superiore: un livello al <strong>di</strong> sotto <strong>del</strong> quale le misurazioni possono essere combinate<br />
con le tecniche <strong>di</strong> mo<strong>del</strong>lizzazione al fine <strong>di</strong> valutare la qualità <strong>del</strong>l'aria ambiente;<br />
124
• soglia <strong>di</strong> valutazione inferiore: un livello al <strong>di</strong> sotto <strong>del</strong> quale è consentito ricorrere soltanto alle tecniche <strong>di</strong><br />
mo<strong>del</strong>lizzazione o <strong>di</strong> stima oggettiva al fine <strong>di</strong> valutare la qualità <strong>del</strong>l’aria ambiente.<br />
E' utile sottolineare che eventuali superamenti <strong>del</strong>le soglie <strong>di</strong> valutazione, superiore/inferiore, vanno determinati<br />
sulla base <strong>del</strong>le concentrazioni <strong>del</strong> quinquennio precedente, laddove siano <strong>di</strong>sponibili dati sufficienti; si considera<br />
superata una soglia <strong>di</strong> valutazione se essa, sul quinquennio precedente è stata superata durante almeno tre anni<br />
non consecutivi.<br />
Per determinare i superamenti <strong>del</strong>le soglie <strong>di</strong> valutazione, superiore e inferiore, si possono combinare campagne<br />
<strong>di</strong> misurazione <strong>di</strong> breve durata, nel periodo <strong>del</strong>l'anno e nei siti rappresentativi dei massimi livelli <strong>di</strong> inquinamento.<br />
La provincia <strong>di</strong> Sassari auspicava, per una valutazione definitiva sulla qualità <strong>del</strong>l'aria <strong>del</strong> sito esaminato la<br />
ripetizione <strong>di</strong> altre campagne <strong>di</strong> breve durata, fino al 2011; nei fatti da allora 2007 non si sono ripetute alti<br />
rilevamenti.<br />
Si riportano sotto le soglie <strong>di</strong> valutazione superiore e inferiore, in<strong>di</strong>cate nell'Allegato VII <strong>del</strong> DM 60/2002.<br />
125
Fig_ 4.2.2./b Soglie <strong>di</strong> valutazione superiore e inferiore dei principali agenti inquinanti<br />
126
2. Biossido <strong>di</strong> Zolfo - SO2<br />
Le concentrazioni massime, e a maggior ragione quelle me<strong>di</strong>e, rilevate sono sempre inferiori a 15 µg /mc, non<br />
risulta mai superata la soglia <strong>di</strong> valutazione inferiore <strong>di</strong> 50 µg /mc per la me<strong>di</strong>a giornaliera. Ad eccezione <strong>del</strong> dato<br />
rilevato nell’area <strong>del</strong>l’ex mattatoio con i campionatori <strong>di</strong>ffusivi che come detto hanno sovrastimato alcuni<br />
parametri.<br />
Fig_ 4.2.2./c Rilevamenti me<strong>di</strong> e soglie <strong>di</strong> valutazione SO2<br />
3. Biossido <strong>di</strong> Azoto - NO2<br />
I valori massimi orari giornalieri, e a maggior ragione quelli me<strong>di</strong>, in<strong>di</strong>cano che non è mai stata superata la soglia<br />
<strong>di</strong> valutazione inferiore <strong>di</strong> 100 µg /mc.<br />
127
Fig_ 4.2.2./d Rilevamenti me<strong>di</strong> e soglie <strong>di</strong> valutazione NO2<br />
4. Monossido <strong>di</strong> carbonio - CO<br />
Le concentrazioni me<strong>di</strong>e rilevate sono sempre inferiori a 2 µg /mc e non risulta superata la soglia <strong>di</strong> valutazione<br />
inferiore <strong>di</strong> 5 µg /mc per la me<strong>di</strong>a giornaliera. Il 7 settembre 2004 la concentrazione massima rilevata è <strong>di</strong> 15.2 µg<br />
/mc, <strong>di</strong> molto superiore alla soglia <strong>di</strong> valutazione superiore <strong>di</strong> 7 µg /mc per la me<strong>di</strong>a<br />
giornaliera.<br />
Fig_4.2.2./e Rilevamenti me<strong>di</strong> e soglie <strong>di</strong> valutazione CO<br />
5. Materiale articolato- PM10<br />
Nel monitoraggio <strong>del</strong> 2004 le concentrazioni me<strong>di</strong>e giornaliere i PM10 sono risultate contenute entro la soglia <strong>di</strong><br />
valutazione inferiore pari a 20 µg /mc mentre in quello <strong>del</strong> 2007 l’11, 12 e 13 <strong>di</strong>cembre le concentrazioni sono<br />
risultate maggiori <strong>del</strong>la soglia <strong>di</strong> valutazione superiore paria a 30 µg /mc e il 14, 19 e 20 <strong>di</strong>cembre le<br />
concentrazioni sono risultate maggiori <strong>del</strong>la soglia <strong>di</strong> valutazione inferiore paria a 20 µg /mc.<br />
Fig_4.2.<br />
2./f<br />
Rilevam<br />
enti<br />
me<strong>di</strong> e<br />
soglie <strong>di</strong><br />
valutazi<br />
one<br />
PM10<br />
6.<br />
Ozono -<br />
O3<br />
Le<br />
concentr<br />
azioni<br />
rilevate<br />
dalla<br />
provinci<br />
a sono<br />
allineate<br />
128
con i valori me<strong>di</strong> stagionali e risultano modulate dalle con<strong>di</strong>zioni metereologiche, mentre per quelle <strong>del</strong>la Regione<br />
Autonoma <strong>del</strong>la Sardegna non essendo stati riportati i parametri meteorologici non è possibile effettuare una<br />
valutazione.<br />
Per l’ozono infatti è necessario precisare che è un inquinante secondario che si origina per reazioni chimiche,<br />
favorite dalla ra<strong>di</strong>azione solare, tra inquinanti primari che vengono immessi <strong>di</strong>rettamente nell'atmosfera, quali gli<br />
ossi<strong>di</strong> <strong>di</strong> azoto e gli idrocarburi, che svolgono la funzione <strong>di</strong> precursori. Gli inquinanti secondari, quin<strong>di</strong>, si<br />
originano da complesse reazioni chimiche, che combinano inquinanti primari e componenti or<strong>di</strong>narie. Più<br />
precisamente la luce solare innesca una serie <strong>di</strong> reazioni chimiche tra questi inquinanti e l’ossigeno presente<br />
nell’aria (O2): il risultato è l’Ozono.<br />
Tuttavia le concentrazioni <strong>di</strong> O3 sono influenzate da un serie <strong>di</strong> variabili:<br />
• variabili meteorologiche<br />
• intensità <strong>del</strong>la luce<br />
• temperatura<br />
• velocità e <strong>di</strong>rezione <strong>del</strong> vento<br />
Più precisamente, nel periodo estivo (o comunque durante le ore <strong>di</strong>urne) le particolari con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> alta pressione,<br />
elevate temperature e scarsa ventilazione favoriscono il ristagno e l’accumulo degli inquinanti primari mentre il<br />
forte irraggiamento solare innesca una serie <strong>di</strong> reazioni fotochimiche che determinano concentrazioni <strong>di</strong> ozono<br />
più elevate rispetto al livello naturale.<br />
Nelle aree urbane, dove è più forte l’inquinamento atmosferico, l’ozono si forma e si trasforma con grande<br />
rapi<strong>di</strong>tà, con un comportamento molto <strong>di</strong>verso da quello osservato per gli altri inquinanti. Gli inquinanti primari,<br />
che costituiscono i “generatori” <strong>del</strong>l’ozono, sono gli stessi che possono provocarne la rapida <strong>di</strong>struzione. Inoltre, il<br />
vento trasporta l’ozono dalle aree urbane alle zone suburbane, rurali o <strong>di</strong> montagna, dove il minore<br />
inquinamento rende la sostanza più stabile e causa un apparente effetto <strong>di</strong> accumulo: non deve stupire il fatto<br />
che spesso le concentrazioni <strong>di</strong> ozono sono spesso più elevate lontano dalle città.<br />
Il monitoraggio corretto <strong>di</strong> questo inquinante va fatto prendendo in considerazione anche le località più periferiche<br />
<strong>del</strong>le città e i parchi, e sopratutto tenendo conto <strong>del</strong> vento prevalente.<br />
7. Benzene –C6H6<br />
Per tale parametro il DM 60/2002 definisce <strong>del</strong>le soglie <strong>di</strong> valutazione su base annuale pertanto, a causa <strong>del</strong>la<br />
brevità <strong>del</strong>le compagne, non è possibile comparare i rilevamenti eseguiti con tali soglie <strong>di</strong> valutazione.<br />
Fig 4.2.2./g Rilevamenti me<strong>di</strong> e soglie <strong>di</strong> valutazione C6H6<br />
129
- Sistema <strong>di</strong> rilevamento<br />
1. Stazioni <strong>di</strong> rilevamento<br />
Nella campagna <strong>del</strong> 2004 effettuata dalla RAS si sono utilizzati <strong>di</strong>versi meto<strong>di</strong> e tecnologie <strong>di</strong>sponibili:<br />
• la stazione mobile un laboratorio automatico <strong>di</strong> analisi approntato all’interno <strong>di</strong> una speciale cella,<br />
installata su un furgone equipaggiata per l’analisi in continuo <strong>del</strong>le specie inquinanti. Inoltre è stata<br />
equipaggiata con la apparecchiatura meteorologica:<br />
• Il campionatore <strong>di</strong>ffuso ANALYST® che nella sua formulazione base è costituito da:<br />
• un corpo cilindrico in vetro aperto ad un’estremità;<br />
• un mezzo assorbente ricoperto con la soluzione specifica per l’inquinante da determinare;<br />
• una ghiera fornita <strong>di</strong> reticella d’acciaio che si usa nella fase <strong>di</strong> esposizione per chiudere l’ANALYST®;<br />
• un gancio per appendere il campionatore ad un idoneo supporto;<br />
• un tappo in polietilene fornito <strong>di</strong> guarnizione, per chiudere l’ANALYST® prima e dopo l’esposizione.<br />
Per applicazioni particolari il campionatore ANALYST® contiene una parte interna che supporta il<br />
mezzo assorbente e mo<strong>di</strong>fica il cammino <strong>di</strong>ffusionale <strong>del</strong>l’inquinante da determinare.<br />
Nella campagna <strong>del</strong> 2007 effettuata dalla Provincia si è utilizzata invece solo la stazione mobile SARTEC<br />
anch’essa dotata <strong>di</strong> una stazione metrologica.<br />
2. Localizzazione <strong>del</strong>le centraline<br />
Nella campagna <strong>del</strong> 2004 effettuata dalla RAS è stato localizzato un sito per la stazione mobile e precisamente la<br />
Scuola La Pietraia mentre per i campionatori <strong>di</strong>ffusi due siti l’ex Mattatoio o Campo sportivo e i Giar<strong>di</strong>ni pubblici.<br />
Nella campagna <strong>del</strong> 2007 effettuata dalla Provincia il sito localizzato per la stazione mobile è stato il giar<strong>di</strong>no<br />
interno <strong>del</strong>la Scuola Me<strong>di</strong>a n.3 Via Malta.<br />
3. Dotazione <strong>di</strong> rilevatori.<br />
Nella campagna <strong>del</strong> 2004 effettuata dalla RAS la stazione mobile <strong>di</strong> analisi è stata equipaggiata per l’analisi in<br />
continuo <strong>del</strong>le seguenti specie inquinanti:<br />
• SO2<br />
• CO<br />
• NO, NO2, NOX<br />
• O3<br />
• BTEX<br />
• PM10<br />
Inoltre è stata equipaggiata con la seguente apparecchiatura meteorologica:<br />
• Direzione vento e velocità vento<br />
• Temperatura <strong>del</strong>l’aria<br />
• Umi<strong>di</strong>tà relativa<br />
• Pressione atmosferica<br />
• Pluviometro<br />
• Ra<strong>di</strong>azione solare.<br />
Nella campagna <strong>del</strong> 2007 effettuata dalla Provincia la strumentazione utilizzata, conforme ai requisiti stabiliti dal<br />
DM 6012002 ove richiesto, era la seguente:<br />
• Misuratore <strong>di</strong> polveri PM10 mod. VEREWA mod. F701<br />
• Analizzatore <strong>di</strong> NO2-NO-NOx Teledyne mod. M200E<br />
• Analizzatore <strong>di</strong> Ben-Tol-Xil Synspec mod. GC855<br />
• Analizzatore <strong>di</strong> O3 Teledyne mod. M400E<br />
• Analizzatore <strong>di</strong> CO Teledyne mod. M300E<br />
130
• Analizzatore <strong>di</strong> SO2 Teledyne mod. M 100A<br />
• Analizzatore <strong>di</strong> CH4/NMHc Synspec Alfa<br />
Mentre la strumentazione utilizzata per il rilevamento dei parametri meteorologici era la seguente :<br />
• Anemometro combinato (DVEN + VVEN) mod. NESA<br />
• Termoigrometro (TEMP + UREL) mod LASTEM DMA575<br />
• Barometro (PATM) mod. LASTEM DQA208<br />
• Ra<strong>di</strong>ometro (RADS) mod. LASTEM DPA559<br />
• Pluviometro (PREC) mod. LASTEM DQAO3O<br />
Tutte le misure fornite dalla strumentazione <strong>del</strong> Laboratorio Mobile sono state acquisite, memorizzate ed<br />
elaborate da un sistema informativo locale costituito da un Personal Computer dotato <strong>di</strong> software SARTEC<br />
DELTAW.<br />
- Con<strong>di</strong>zioni anemometriche<br />
1. Direzione, intensità e frequenza <strong>del</strong> vento<br />
Nella campagna <strong>del</strong> 2004 effettuata dalla RAS nell’appen<strong>di</strong>ce “a” “La Campagna <strong>di</strong> misura” non è stato riportato<br />
il rilevamento dei parametri meteorologici, mentre nella campagna <strong>del</strong> 2007 effettuata dalla Provincia vengono<br />
riportati i valori massimi, minimi e me<strong>di</strong> giornalieri <strong>di</strong> ciascun parametro meteorologico nonché i <strong>di</strong>agrammi <strong>di</strong><br />
Brewer.<br />
131
Fig_ 4.2.2/h Parametri meteorologici e <strong>di</strong>agrammi <strong>di</strong> Brewer - Rilevamento 2007<br />
Fig_ Tab_4.2.2./i Temperatura massima, minima e me<strong>di</strong>a giornaliera – Rilevamento 2007<br />
132
- Conclusioni <strong>del</strong>lo stato attuale <strong>del</strong>la componente<br />
Da una analisi con i dati a <strong>di</strong>sposizione emerge che il <strong>territorio</strong> <strong>del</strong> Comune <strong>di</strong> Alghero non rientra in zone critiche<br />
o potenzialmente critiche per la salute umana dal punto <strong>di</strong> vista <strong>del</strong>l’inquinamento atmosferico, nel senso che i<br />
valori <strong>di</strong> concentrazione dei principali inquinanti atmosferici risultano sufficientemente contenuti e in molti casi<br />
inferiori alle soglie <strong>di</strong> valutazione inferire previste dalla normativa.<br />
Si riba<strong>di</strong>sce comunque che sarebbe opportuno, come peraltro rilevato nel “Piano <strong>di</strong> prevenzione, conservazione e<br />
risanamento <strong>del</strong>la qualità <strong>del</strong>l'aria ambiente", che in<strong>di</strong>ca la città <strong>di</strong> Alghero come “zona a maggiore priorità da<br />
sottoporre a qualche forma <strong>di</strong> controllo” e nel piano <strong>di</strong> zonizzazione allegato prevede una stazione <strong>di</strong><br />
monitoraggio, che il comune si dotasse <strong>di</strong> una centralina mobile <strong>di</strong> misurazione autonoma.<br />
Un monitoraggio continuo permetterebbe sia la sud<strong>di</strong>visione degli in<strong>di</strong>catori per periodo invernale e per periodo<br />
estivo, che la <strong>di</strong>stinzione <strong>del</strong>le fonti e dei tassi <strong>di</strong> inquinamento <strong>di</strong>stinta per aree: 1 <strong>di</strong> fondo, 2 rurale, 3 urbane, 4<br />
industriali.<br />
Un <strong>di</strong>scorso a parte meritano le emissioni puntuali in atmosfera infatti la Provincia ha rilevato che “nel <strong>territorio</strong><br />
sono presenti <strong>di</strong>versi impianti ed attività che per tipologia rappresentano una emissione puntuale in atmosfera”;<br />
attualmente però non esiste un censimento <strong>di</strong> tali emissioni.<br />
Nell’appen<strong>di</strong>ce b al “Piano <strong>di</strong> prevenzione, conservazione e risanamento <strong>del</strong>la qualità <strong>del</strong>l'aria ambiente” nel<br />
quale proprio il comune <strong>di</strong> Alghero è stato selezionato a titolo <strong>di</strong> esempio per l’applicazione dei calcoli che<br />
portano alla definizione <strong>del</strong>le zone, nello stu<strong>di</strong>o vengono considerate puntuali tutte le sorgenti fisse le cui<br />
<strong>di</strong>mensioni spaziali sono trascurabili rispetto all’area <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o e il cui rateo emissivo sia superiore a 10 t/anno<br />
almeno per un inquinante convenzionale, oppure superiore a 250 kg/anno per i metalli; in pratica sono<br />
classificabili come sorgenti puntuali solo alcuni camini <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> stabilimenti industriali. Viene inoltre considerata la<br />
<strong>di</strong>stanza dalle sorgenti puntuali, assegnando 1 ai comuni i cui centri abitati (precisamente i baricentri dei centri<br />
abitati) <strong>di</strong>stano meno <strong>di</strong> 10 km dalle sorgenti puntuali e 0 a quelli che <strong>di</strong>stano più <strong>di</strong> 10 km. Alghero non possiede<br />
sorgenti puntuali (secondo la convenzione precedente) e <strong>di</strong>sta oltre 10 km dalla più vicina, quin<strong>di</strong> totalizza il<br />
punteggio 0 sotto questo aspetto.<br />
In ogni caso la Provincia – settore ambiente- in collaborazione con l’ARPAS ed il Comune <strong>di</strong> Alghero sarebbe<br />
<strong>di</strong>sponibile ad avviare sia il censimento, eventualmente georeferenziato, che il carico inquinante <strong>di</strong> tali emissioni;<br />
tale stu<strong>di</strong>o comunque richiederebbe un tempo superiore a quello necessario per la redazione <strong>del</strong>la VAS.<br />
Sarebbe comunque opportuno inserite nella fase 4 <strong>di</strong> attuazione e monitoraggio <strong>del</strong>la VAS tale in<strong>di</strong>catore.<br />
- <strong>Analisi</strong> swot<br />
PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA OPPORTUNITA’ RISCHI<br />
- Il Comune <strong>di</strong> Alghero<br />
non rientra in zone<br />
critiche o<br />
potenzialmente critiche<br />
per la salute umana dal<br />
punto <strong>di</strong> vista<br />
<strong>del</strong>l’inquinamento<br />
atmosferico.<br />
(Piano<br />
<strong>di</strong> Risanamento<br />
<strong>del</strong>la qualità <strong>del</strong>l’aria<br />
- RAS)<br />
- Il <strong>territorio</strong> non è dotato<br />
<strong>di</strong> una rete <strong>di</strong><br />
rilevamento <strong>del</strong>la qualità<br />
<strong>del</strong>l’aria<br />
- Realizzazione <strong>di</strong> una<br />
stazione <strong>di</strong> monitoraggio<br />
e dotazione <strong>di</strong> centralina<br />
mobile <strong>di</strong> misurazione<br />
autonoma.<br />
- Incentivazione <strong>del</strong>l’uso<br />
<strong>del</strong>le fonti <strong>di</strong> energia<br />
alternativa e rinnovabile<br />
- Incentivazione <strong>del</strong><br />
trasporto pubblico non<br />
inquinante;<br />
- Aumento dei percorsi<br />
pedonali e ciclabili<br />
- Incentivazione <strong>di</strong><br />
attività quali il bikesharing<br />
- Promozione <strong>di</strong><br />
soluzioni <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia<br />
sostenibile.<br />
-Sensibilizzazione ed<br />
informazione sulle azioni<br />
<strong>di</strong> comportamenti corretti<br />
-Aumento <strong>del</strong><br />
traffico veicolare<br />
- Presenza <strong>di</strong> porti<br />
e aeroporti<br />
133
- <strong>Analisi</strong> quantitativa e qualitativa: gli in<strong>di</strong>catori<br />
Legenda:<br />
fenomeno in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> stabilità<br />
fenomeno in <strong>di</strong>minuzione/miglioramento<br />
fenomeno in aumento/peggioramento<br />
☺ positivo<br />
incerto<br />
negativo<br />
Pressione<br />
Stato<br />
in termini <strong>di</strong><br />
riduzione <strong>del</strong>le emissioni<br />
Giu<strong>di</strong>zio sintetico componente:<br />
incerto<br />
In<strong>di</strong>catore Unità <strong>di</strong> misura Valore Giu<strong>di</strong>zio sintetico Trend<br />
Emissioni <strong>di</strong> SO2 t/a n.p <br />
Emissioni <strong>di</strong> NO2 t/a n.p <br />
Emissioni <strong>di</strong> PM10 t/a n.p <br />
Emissioni <strong>di</strong> CO t/a n.p <br />
Emissioni PM2.5 t/a n.p <br />
Emissioni <strong>di</strong> C6H6 t/a n.p <br />
Concentrazione<br />
SO2<br />
µg/m 3 1,59 ☺ <br />
(Periodo invernale)<br />
Concentrazione<br />
SO2 (Periodo<br />
estivo)<br />
Concentrazione <strong>di</strong><br />
NO2 (Periodo<br />
invernale)<br />
Concentrazione <strong>di</strong><br />
NO2 (Periodo<br />
estivo)<br />
Concentrazione <strong>di</strong><br />
PM10 (Periodo<br />
invernale<br />
Concentrazione <strong>di</strong><br />
PM10 (Periodo<br />
estivo<br />
Concentrazione <strong>di</strong><br />
CO (Periodo<br />
invernale)<br />
Concentrazione <strong>di</strong><br />
PM25 (Periodo<br />
estivo)<br />
Concentrazione <strong>di</strong><br />
PM2.5 (Periodo<br />
estivo<br />
Concentrazione <strong>di</strong><br />
CO (Periodo<br />
estivo)<br />
Concentrazione <strong>di</strong><br />
O3 (Periodo<br />
invernale)<br />
µg/m 3 2,7 ☺ <br />
µg/m 3 15,82 ☺ <br />
µg/m 3 11,9 ☺ <br />
µg/m 3 22,2 ☺ <br />
µg/m 3 10,2 ☺ <br />
µg/m 3 0,61 ☺ <br />
µg/m 3 n.p <br />
µg/m 3 n.p <br />
µg/m 3 0,3 ☺ <br />
µg/m 3 29,59 ☺ <br />
Concentrazione <strong>di</strong> µg/m 3 77,7 ☺ <br />
134
Risposta<br />
O3 (Periodo estivo)<br />
Concentrazione <strong>di</strong><br />
C6H6 (Periodo<br />
invernale)<br />
Concentrazione <strong>di</strong><br />
C6H6 (Periodo<br />
estivo)<br />
Superamenti dei<br />
limiti <strong>di</strong> legge dei<br />
parametri <strong>di</strong><br />
qualità <strong>del</strong>l’aria, ai<br />
sensi <strong>del</strong>la<br />
normativa<br />
vigente(Periodo<br />
invernale)<br />
me<strong>di</strong>e giornaliere<br />
Stazioni fisse <strong>di</strong><br />
monitoraggio<br />
Centraline mobili <strong>di</strong><br />
rilevamento <strong>del</strong><br />
Comune<br />
Georeferenziazione<br />
<strong>del</strong>le fonti<br />
inquinanti<br />
potenziali<br />
Monitoraggio <strong>del</strong>le<br />
emissioni dalle fonti<br />
inquinanti<br />
- Cartografia <strong>di</strong> riferimento e Figure<br />
µg/m 3 1,86 ☺ <br />
µg/m 3 1,2 ( (<br />
n.<br />
n.<br />
n<br />
3<br />
PM10(soglia<br />
superiore)<br />
3<br />
PM10(soglia<br />
inferiore)<br />
Si/No Si<br />
Si/No Si<br />
Tab_2.1.1/a Risultati <strong>del</strong> monitoraggio con i campionatori <strong>di</strong>ffusivi<br />
Tab_2.1.1/b Risultati <strong>del</strong> monitoraggio con la stazione mobile R.A.S.<br />
Tab_2.1.1/c Risultati <strong>del</strong> monitoraggio con la stazione mobile Provincia <strong>di</strong> Sassari<br />
Fig_2.1.1/a Valori limite dei principali agenti inquinanti<br />
Fig_2.1.1/b Soglie <strong>di</strong> valutazione superiore e inferiore dei principali agenti inquinanti<br />
Fig_2.1.1/c Rilevamenti me<strong>di</strong> e soglie <strong>di</strong> valutazione SO2<br />
Fig_2.1.1/d Rilevamenti me<strong>di</strong> e soglie <strong>di</strong> valutazione NO2<br />
Fig_2.1.1/e Rilevamenti me<strong>di</strong> e soglie <strong>di</strong> valutazione CO<br />
Fig_2.1.1/f Rilevamenti me<strong>di</strong> e soglie <strong>di</strong> valutazione PM10<br />
Fig_2.1.1/g Rilevamenti me<strong>di</strong> e soglie <strong>di</strong> valutazione C6H6<br />
Tav_2.1.1/a Localizzazione campionatori <strong>di</strong>ffusi e stazioni mobili<br />
Fig_2.1.1/h Parametri meteorologici e <strong>di</strong>agrammi <strong>di</strong> Brewer - Rilevamento 2007<br />
( (<br />
135
Scheda 3: Rumore<br />
Fonte dei dati<br />
Piano <strong>di</strong> classificazione acustica <strong>del</strong> Comune <strong>di</strong> Alghero<br />
Livello e qualità dei dati<br />
Me<strong>di</strong>a<br />
Priorità tematismo<br />
Alta<br />
- Stato attuale <strong>del</strong>la componente<br />
In riferimento al D.P.C.M. 14.11.1997, che prevede che tutti i comuni si dotino <strong>di</strong> un proprio Piano <strong>di</strong><br />
classificazione acustica il quale, coerentemente con le destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici e<br />
sulla base <strong>del</strong>le classi in<strong>di</strong>viduate dallo stesso decreto, dovrebbe stabilire, per le <strong>di</strong>verse zone <strong>del</strong> <strong>territorio</strong><br />
comunale, i livelli <strong>di</strong> rumore ammissibili, il Comune <strong>di</strong> Alghero ha pre<strong>di</strong>sposto nel 2007, il proprio Piano <strong>di</strong><br />
classificazione acustica.<br />
L’obiettivo <strong>del</strong>l’analisi è stato quello <strong>di</strong> calcolare dei parametri quantitativi <strong>di</strong> presenza dei vari fenomeni acustici<br />
presenti sul <strong>territorio</strong> comunale. In questo modo è stato possibile sovrapporre all’elemento geografico <strong>di</strong> base le<br />
informazioni <strong>di</strong>sponibili in funzione dei valori che queste assumono per la classificazione <strong>del</strong> <strong>territorio</strong> dal punto <strong>di</strong><br />
vista acustico.<br />
La classificazione in zone acustiche <strong>del</strong> <strong>territorio</strong> comunale, in accordo con quanto espresso dalla normativa<br />
nazionale e regionale, è basata sulle destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici generali.<br />
L’obiettivo <strong>del</strong>la classificazione <strong>del</strong> <strong>territorio</strong> comunale è <strong>di</strong> tutelare i recettori sensibili e le zone non inquinate dal<br />
deterioramento acustico, e al contempo <strong>di</strong> fornire uno strumento <strong>di</strong> pianificazione, prevenzione e <strong>di</strong> risanamento<br />
<strong>del</strong>lo sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale ed industriale.<br />
Il primo passo, nella redazione <strong>del</strong> piano, è stato quello <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare le aree da considerare come zone protette<br />
(Classe I) e come zone industriali (Classe V e VI) in funzione <strong>di</strong> valutazioni urbanistiche.<br />
Successivamente si è proceduto alla classificazione <strong>del</strong>le rimanenti aree <strong>del</strong> <strong>territorio</strong> comunale.<br />
Gli in<strong>di</strong>catori presi in considerazione sono stati:<br />
- densità <strong>di</strong> popolazione;<br />
- densità <strong>di</strong> attività commerciali;<br />
- densità <strong>di</strong> attività artigianali;<br />
- tipologia e intensità <strong>di</strong> traffico;<br />
In prima analisi si è ritenuto opportuno procedere all’esame dei soli primi tre parametri in<strong>di</strong>catori ai fini <strong>di</strong> una<br />
preliminare classificazione acustica <strong>del</strong>l’area territoriale omogenea considerata (isolato), per poi determinare su <strong>di</strong><br />
essa l’influenza derivante dal traffico urbano ivi esistente.<br />
In considerazione <strong>del</strong>l’attribuzione <strong>del</strong>le classi acustiche al <strong>territorio</strong> comunale, all’in<strong>di</strong>viduazione <strong>del</strong>le fasce <strong>di</strong><br />
transizione e <strong>del</strong>le fasce <strong>di</strong> pertinenza, si è pervenuti alla classificazione acustica <strong>del</strong> comune <strong>di</strong> Alghero.<br />
In merito alla stratificazione <strong>del</strong> campione secondo la tipologia <strong>di</strong> sorgente sonora sono state prese in<br />
considerazione le seguenti sorgenti:<br />
- traffico veicolare;<br />
- traffico ferroviario (linea Sassari – Alghero);<br />
- agglomerati industriali e aree produttive.<br />
Per quanto attiene alla destinazione d’uso <strong>del</strong> <strong>territorio</strong> sono state considerate le aree ad uso agricolo e quelle <strong>di</strong><br />
particolare tutela acustica, ulteriormente <strong>di</strong>versificate in scuole, case <strong>di</strong> cura, <strong>di</strong> interesse storico paesaggistico.<br />
I punti <strong>di</strong> misurazione sono stati in<strong>di</strong>viduati in base alle tipologie <strong>di</strong> sorgenti sonore presenti sul <strong>territorio</strong> comunale<br />
(strade, ferrovie, industrie, ecc.) ed in base alla presenza <strong>di</strong> recettori acustici sensibili (ospedali, scuole, aree<br />
ver<strong>di</strong>, ecc.).<br />
Inoltre i punti sono stati scelti in modo da essere rappresentativi <strong>del</strong>le varie situazioni <strong>di</strong> rumorosità presenti, sia<br />
come livelli sia come tipologie <strong>di</strong> sorgenti sonore predominanti.<br />
Ciò ha consentito <strong>di</strong> acquisire una prima serie <strong>di</strong> dati significativi per <strong>del</strong>ineare un quadro preliminare sullo stato<br />
<strong>del</strong>l’inquinamento acustico <strong>ambientale</strong>.<br />
Dalle risultanze dei sopralluoghi effettuati, si è pervenuti all’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> 35 posizioni <strong>di</strong> rilevamento, illustrate<br />
nella Fig_ 2.1.11/a ed elencate nella Tabella 2.1.11/b. La maggiore concentrazione <strong>del</strong>le posizioni <strong>di</strong> rilevamento<br />
nelle aree abitate a ridosso <strong>del</strong> centro storico e lungo gli assi principali <strong>del</strong>la rete stradale locale.<br />
136
Fig_4.2.2/a: <strong>di</strong>stribuzione dei punti <strong>di</strong> misura (Fonte: Piano <strong>di</strong> classificazione acustica <strong>del</strong> Comune <strong>di</strong> Alghero)<br />
L’andamento <strong>del</strong> tempo <strong>del</strong> rumore <strong>ambientale</strong> presenta caratteristiche <strong>di</strong> variabilità assai <strong>di</strong>versificate,<br />
<strong>di</strong>pendendo non solo dalle modalità <strong>di</strong> emissione sonora <strong>del</strong>le sorgenti ma anche dai molteplici fenomeni che<br />
contrad<strong>di</strong>stinguono la propagazione <strong>del</strong>le onde sonore nell’atmosfera.<br />
Un esempio emblematico al riguardo è costituito dal rumore <strong>del</strong> traffico veicolare, fenomeno <strong>di</strong> inquinamento<br />
acustico <strong>di</strong> natura tipicamente aleatoria in quanto costituito dall’insieme <strong>del</strong>le emissioni sonore associate al<br />
transito dei singoli veicoli che compongono il flusso veicolare. Quest’ultimo è assai <strong>di</strong>versificato nelle sue<br />
configurazioni (flusso scorrevole, congestionato, intermittente, ecc.) e a questa variabilità si aggiunge quella<br />
derivante dalle caratteristiche dei veicoli stessi <strong>di</strong>fferenti per tipologia (veicoli leggeri, pesanti, motocicli, ecc.),<br />
modalità <strong>di</strong> guida, stato <strong>di</strong> manutenzione, ecc. Ne deriva una casistica assai ampia che va dal rumore con<br />
fluttuazioni assai contenute, rilevabili in strade a traffico intenso nel quale risulta <strong>di</strong>fficile <strong>di</strong>scriminare il rumore<br />
prodotto dal transito dei singoli veicoli, a quello con fluttuazioni ampie presente in strade locali a traffico scorso<br />
per il quale invece sono in<strong>di</strong>viduabili gli eventi sonori associati al passaggio dei singoli veicoli.<br />
I rilevamenti nelle posizioni descritte sono stati eseguiti nei giorni feriali dal lune<strong>di</strong> al vener<strong>di</strong> durante il periodo<br />
compreso tra le ore 08:00 e le 20:00 per la fascia <strong>di</strong>urna e tra le ore 22:00 e le 02:00 per la fascia notturna.<br />
La scelta <strong>di</strong> tale periodo ha tenuto conto <strong>del</strong>la necessità <strong>di</strong> acquisire informazioni durante le ore <strong>di</strong> punta <strong>di</strong>urne e<br />
durante fasce orarie rappresentative. Esso risulta sufficiente per estrapolare, me<strong>di</strong>ante specifici mo<strong>del</strong>li numerici,<br />
dal valore misurato <strong>del</strong> livello LAeq una stima <strong>del</strong> livello LAeq per l’intero periodo <strong>di</strong>urno (ore 06 – 22) e per<br />
l’intero periodo notturno (ore 22 – 06) con un’accuratezza adeguata alle finalità <strong>del</strong>lo stu<strong>di</strong>o.<br />
In ciascuna <strong>del</strong>le posizioni si è proceduto al rilievo <strong>del</strong>la rumorosità <strong>ambientale</strong> e alla memorizzazione dei valori<br />
assunti dal livello <strong>di</strong> pressione sonora LA in dB(A) e con costante temporale “Fast” (125 ms) durante l’intero<br />
tempo <strong>di</strong> misurazione.<br />
Questa notevole risoluzione temporale dei dati consente nell’analisi successiva <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare ed escludere eventi<br />
sonori atipici non riconducibili alla rumorosità <strong>ambientale</strong> e/o a quella <strong>del</strong>la sorgente sonora predominante,<br />
nonché <strong>di</strong> valutare l’evoluzione nel tempo <strong>del</strong> livello LAeq e <strong>di</strong> determinare i valori dei parametri acustici<br />
relativamente a risoluzioni temporali meno elevate. In particolare, facendo riferimento all’intero tempo <strong>di</strong><br />
misurazione,<br />
sono stati determinati per ciasscuna posizione:<br />
a) livello continuo equivalente LAeq in dB(A);<br />
b) analisi <strong>di</strong>stributiva e cumulativa dei livelli LA in in dB(A);<br />
137
c) valori massimo Lmax e minimo Lmin <strong>del</strong> livello LA in in dB(A);<br />
d) livelli statistici percentili L5, L10, L50, L90, L95 e L99 in dB(A) “Fast”, rappresentativi dei livelli più elevati (L5,<br />
L10) imputabili a sorgenti transitorie o ad emissione <strong>di</strong>scontinua, e <strong>di</strong> quelli più bassi (L90, L95 e L99) associabili<br />
al rumore residuo.<br />
Il microfono <strong>del</strong>la catena strumentale <strong>di</strong> misurazione è stato collocato per quanto possibile in prossimità <strong>del</strong>la<br />
sorgente sonora predominante, ove presente, oppure in posizioni atte a caratterizzare la generica rumorosità<br />
<strong>ambientale</strong>, con l’accortezza <strong>di</strong> evitare fenomeni acustici <strong>di</strong> varia natura (schermature, riflessioni) influenti sulla<br />
misurazione.<br />
I rilevamenti sono stati eseguiti sempre in con<strong>di</strong>zioni metorologiche sod<strong>di</strong>sfacienti (assenza <strong>di</strong> pioggia, assenza <strong>di</strong><br />
vento o vento moderato) evitando inoltre fenomeni che potessero alterare l’emissione sonora <strong>del</strong>la sorgente<br />
predominante: ad esempio nel caso <strong>di</strong> traffico stradale sono stati<br />
esclusi tratti <strong>del</strong>la rete viaria interessati da cantieri <strong>di</strong> manutenzione, anche se<br />
provvisori.<br />
Per i siti nei quali il traffico stradale costituiva la sorgente sonora predominante si è proceduto anche al<br />
rilevamento contemporaneo, per l’intera durata <strong>del</strong>la misurazione, <strong>del</strong> flusso veicolare, <strong>di</strong>versificato per tipologie<br />
veicolari (motocicli, veicoli leggeri, pesanti) e <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> marcia.<br />
È stata inoltre stimata la velocità me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> marcia dei veicoli.<br />
I rilevamenti sono stati eseguiti in con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> superficie stradale asciutta e,ove possibile, priva <strong>di</strong> <strong>di</strong>scontinuità<br />
accidentali<br />
Nella Tab_ 2.1.11/a viene riportato per ogni singola posizione <strong>di</strong> misura il valore in decibel misurato durante<br />
l’indagine.<br />
Co<strong>di</strong>ce<br />
sito<br />
Posizione <strong>del</strong> rilevamento<br />
Leq<br />
dB(A)<br />
DIURNI (06:00 – 22:00)<br />
R 01 Via I° Maggio - Ospedale Marino + Istituto Statale d’Arte 55,6<br />
R 02 Stazione Pulmann+SFS 52,2<br />
R 03 Via Dominzoni - Ospedale Civile 62.3<br />
R 04 Via Vittorio Emanuele angolo Via IV Novembre - carcere 62.9<br />
R 05 Via Catalunia - Giar<strong>di</strong>ni Pubblici 60.9<br />
R 06<br />
Via Tarragona - scuola me<strong>di</strong>a Grazia Deledda +IPSSAR convitto +<br />
Ufficio <strong>di</strong> igiene pubblico<br />
66.7<br />
R 07<br />
Via Giovanni XXIII - Chiesa <strong>del</strong>la Mercede, Scuola 2° circolo, Parco<br />
Pubblico<br />
63.9<br />
R 08 Piazza Sulis – Lungomare Dante - Scuola Alberghiera 63.5<br />
R 09 Via Carlo Alberto angolo Piazza Sulis Liceo Classico 64.3<br />
R 10 Via XX settembre - Liceo Scientifico 64.1<br />
R 11 Via S. Anna - Municipio+scuola 54.2<br />
R 12 Via <strong>del</strong>la Resistenza - casa <strong>di</strong> Riposo Centro Serena 50.4<br />
R 13. Via Parenzo - FERTILIA – scuola me<strong>di</strong>a 3° circolo, scuola infanzia 53.4<br />
R 14 Via Malta - 2°circolo,scuola me<strong>di</strong>a,”PEDRARA” 64.8<br />
R 15 Via Diaz - Istituto Tecnico Geometri Commerciale Turistico 62.9<br />
R 16 Via degli Orti – Istituto Professionale Industria e Artigianato 63.7<br />
R 17 Via Corsica – Scuola elementare “PEDRARA” 56.2<br />
R 18 Zona Industriale San Marco 55.6<br />
R 19 Zona Maristella 45<br />
R 20 Santa Maria La Palma - Chiesa 53.2<br />
R 21 <strong>Porto</strong> <strong>Conte</strong> Località Tramariglio 46<br />
R22 Ingresso Cantina Sociale Sella e Mosca 62<br />
R 23 Località Sa Segada – Chiesa + Scuola 50.8<br />
R 24 Lungomare Dante angolo Via Gramsci 58.2<br />
R 25 Via Sassari 62.6<br />
R 26 Via Fratelli Kennedy 63.6<br />
R 27 Via Palomba angolo Via Giolitti 62.8<br />
R 28 Via Carrabuffas - scuola N.S. <strong>del</strong>la Mercede 64.3<br />
R 29 Via Manca -Scuola elementare La Cunetta 61.8<br />
R 30 Via XX Settembre angolo Via Veneto 64.9<br />
138
R 31 Via Vittorio Emanuele angolo Via Cravellet 65.3<br />
R 32 Via Marconi angolo Via Leonardo 64.7<br />
R 33 Via Lido angolo Via Ales - scuola elementare S. Giovanni 63.9<br />
R 34 Nucleo Maria Pia 58.8<br />
R 35 Località Monte Agnese<br />
NOTTURNI (22:00 – 06:00<br />
55.2<br />
R 01 N Via I° Maggio - Ospedale Marino + Istituto Statale d’Arte 50,4<br />
R 02 N Stazione Pulmann+SFS 47.8<br />
R 03 N Via Dominzoni - Ospedale Civile 55,5<br />
R 05 N Via Catalunia - Giar<strong>di</strong>ni Pubblici 51,3<br />
R 06 N<br />
Via Tarragona - scuola me<strong>di</strong>a Grazia Deledda +IPSSAR convitto +<br />
49,3<br />
Ufficio <strong>di</strong> igiene pubblico<br />
R 08 N Piazza Sulis – Lungomare Dante - Scuola Alberghiera 56,3<br />
R 09 N Via Carlo Alberto angolo Piazza Sulis Liceo Classico 50,3<br />
R 11 N Via S. Anna - Municipio+scuola 47,2<br />
R 12 N Via <strong>del</strong>la Resistenza - casa <strong>di</strong> Riposo Centro Serena 46,8<br />
R 18 N Zona Industriale San Marco 44,6<br />
R 21 N <strong>Porto</strong> <strong>Conte</strong> Località Tramariglio 42,1<br />
R 23 N Località Sa Segada – Chiesa + Scuola 46,8<br />
R 35 N Località Monte Agnese 44,5<br />
Tab_ 2.1.11/a: <strong>di</strong>stribuzione dei punti <strong>di</strong> misura (Fonte: Piano <strong>di</strong> classificazione acustica <strong>del</strong> Comune <strong>di</strong> Alghero)<br />
- <strong>Analisi</strong> swot<br />
PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA OPPORTUNITA’ RISCHI<br />
Piano <strong>di</strong> classiifazione Livelli <strong>di</strong> traffico veicolare Monitorare le <strong>di</strong>namiche<br />
acustica<br />
in continua crescita <strong>del</strong>le fonti <strong>di</strong><br />
inquinamento da rumore<br />
fin qui rilevate, quali il<br />
traffico veicolare<br />
citta<strong>di</strong>no, garantendo<br />
livelli <strong>di</strong> risposta tale per<br />
cui il rumore non sia<br />
causa <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo e<br />
minaccia<br />
pubblica.<br />
<strong>del</strong>la salute<br />
-Aumentare la<br />
percentuale <strong>di</strong> superficie<br />
pedonale all'interno <strong>del</strong><br />
centro urbano<br />
-Aumentare la quantità<br />
<strong>di</strong> piste ciclabili e<br />
conseguentemente<br />
incentivare l'uso <strong>del</strong>la<br />
bicicletta<br />
- <strong>Analisi</strong> quantitativa e qualitativa: gli in<strong>di</strong>catori<br />
Nella Tabella a seguire vengono riportati i principali in<strong>di</strong>catori per la componente rumore<br />
.<br />
Legenda:<br />
fenomeno in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> stabilità<br />
fenomeno in <strong>di</strong>minuzione/miglioramento<br />
fenomeno in aumento/peggioramento<br />
Giu<strong>di</strong>zio sintetico componente<br />
negativo<br />
139
☺ positivo<br />
incerto<br />
negativo<br />
Stato<br />
Pressione<br />
Risposta<br />
Risposta<br />
Risposta<br />
In<strong>di</strong>catore Unità<br />
<strong>di</strong><br />
misura<br />
Strumenti <strong>di</strong> pianificazione<br />
Percentuale <strong>di</strong> <strong>territorio</strong> ricadente in<br />
SI<br />
Classe I <strong>di</strong> cui al D.P.C.M.<br />
14.11.1997<br />
Percentuale <strong>di</strong> <strong>territorio</strong> ricadente in<br />
%<br />
Classe II <strong>di</strong> cui al D.P.C.M.<br />
14.11.1997<br />
Percentuale <strong>di</strong> <strong>territorio</strong> ricadente in<br />
%<br />
Classe III <strong>di</strong> cui al D.P.C.M.<br />
14.11.1997<br />
Percentuale <strong>di</strong> <strong>territorio</strong> ricadente in<br />
%<br />
Classe IV <strong>di</strong> cui al D.P.C.M.<br />
14.11.1997<br />
Percentuale <strong>di</strong> <strong>territorio</strong> ricadente in<br />
%<br />
Classe V <strong>di</strong> cui al D.P.C.M.<br />
14.11.1997<br />
Percentuale <strong>di</strong> <strong>territorio</strong> ricadente in<br />
%<br />
Classe Vi <strong>di</strong> cui al D.P.C.M.<br />
14.11.1997<br />
%<br />
Percentuale <strong>di</strong> popolazione esposta<br />
ad emissioni acustiche > 60 Leq<br />
dBA<br />
Inquinamento acustico dBA<br />
Stato <strong>di</strong> attuazione <strong>del</strong> piano <strong>di</strong><br />
classificazione acustica<br />
Classificazione acustica <strong>del</strong>l’area<br />
<strong>del</strong>l’aeroporto<br />
Stu<strong>di</strong>o <strong>del</strong>le emissioni sonore<br />
prodotte dagli esercizi pubblici<br />
%<br />
SI/NO SI<br />
SI/NO<br />
SI/NO<br />
Valore Giu<strong>di</strong>zio<br />
sintetico<br />
SI<br />
SI<br />
Trend<br />
140
- Cartografia, Figure, Tabelle<br />
Inquadramenti dei piani <strong>di</strong> classificazione acustica<br />
Fig_ 2.1.11/a<br />
Tab_ 2.1.11/a<br />
Scheda 4: Suolo<br />
Fonte dei dati<br />
- Carta dei suoli <strong>del</strong>la Sardegna, 1:250.000_Regione Autonoma <strong>del</strong>la Sardegna – Università <strong>di</strong> Cagliari.<br />
- Comune <strong>di</strong> Alghero<br />
- Carta <strong>del</strong>le aree sensibili alla desertificazione_ Regione Autonoma <strong>del</strong>la Sardegna<br />
- ARPAS (_ Regione Autonoma <strong>del</strong>la Sardegna<br />
- Carta <strong>di</strong> sintesi <strong>del</strong>la pericolosità da frana_ Regione Autonoma <strong>del</strong>la Sardegna<br />
- Carta <strong>di</strong> sintesi <strong>del</strong>la pericolosità idraulica_ Regione Autonoma <strong>del</strong>la Sardegna, Assessorato <strong>del</strong>l'Industria<br />
Servizio Attività Estrattive<br />
- Comune <strong>di</strong> Alghero, Settore Ambiente Ecologia<br />
- Piano <strong>di</strong> prevenzione, conservazione e risanamento <strong>del</strong>la qualità <strong>del</strong>l'aria ambiente. RegioneAutonoma <strong>del</strong>la<br />
Sardegna, approvato con D.G.R. n.55/6 <strong>del</strong> 29/11/200.<br />
Livello e qualità dei dati<br />
Buona<br />
Priorità tematismo<br />
Alta<br />
- Stato attuale <strong>del</strong>la componente<br />
Il <strong>territorio</strong> <strong>di</strong> Alghero è caratterizzato da una notevole complessità geologica, morfologica, pedologica e, grazie<br />
ad una frequentazione antropica plurimillenaria, anche nella copertura vegetale e nell’uso <strong>del</strong> suolo.<br />
Sono descritti sinteticamente i principali lineamenti <strong>del</strong>le caratteristiche ambientali.<br />
- Caratteristiche geologiche<br />
Nel <strong>territorio</strong> algherese sono presenti formazioni geologiche che chiudono un arco temporale che si estende,<br />
quasi senza soluzione <strong>di</strong> continuità, dal tardo Paleozoico all’Olocene.<br />
La genesi <strong>di</strong> queste formazioni è imputabile ad una serie <strong>di</strong> complesse attività tettoniche che hanno dato origine a<br />
depositi continentali, quali ad esempio le arenarie rosso-violacee <strong>del</strong> Permiano, <strong>di</strong>ffuse principalmente lungo la<br />
costa sia tra Punta <strong>del</strong> Gall e <strong>Porto</strong> Ferro, sia in aree <strong>di</strong> minore estensione tra Calabona e Poglina, o alle alluvioni<br />
terrazzate plio-pleistoceniche <strong>del</strong>la Nurra, ma anche ai depositi marini legati alle ingressioni marine <strong>del</strong> Giura-<br />
Creta che responsabili <strong>del</strong>la genesi dei rilievi occidentali.<br />
Si riconoscono tre paesaggi principali.<br />
a) Paesaggio dei rilievi se<strong>di</strong>mentari<br />
Sono <strong>del</strong>le imponenti formazioni se<strong>di</strong>mentarie calcaree legate alle ingressioni marine che hanno interessato la<br />
Sardegna durante il Giurassico e il Cretacico (Mesozoico). In particolare sono stati attribuiti al Giurassico i rilievi<br />
<strong>di</strong> Monte Doglia, Timidone e Zirra, risalirebbero al Cretacico le punte estreme <strong>del</strong>le penisole <strong>di</strong> Capo Caccia e <strong>di</strong><br />
punta Giglio, l’area <strong>del</strong> Lazzaretto e il tratto <strong>di</strong> costa compreso tra Punta Negra e Fertilia.<br />
Queste forme si collegano a nord ai depositi arenacei rosso-violacei che chiudono la linea <strong>di</strong> costa da Punta <strong>del</strong><br />
Gall fino a <strong>Porto</strong> Ferro. Le formazioni calcaree si innalzano bruscamente dal mare dando origine a pareti verticali<br />
o quasi verticali la cui altezza varia dagli oltre 300 m <strong>di</strong> Punta Cristallo ai pochi metri in prossimità <strong>del</strong> porto <strong>di</strong><br />
Tramariglio.<br />
b) Paesaggio <strong>del</strong>le formazioni effusive cenozoiche<br />
I terrazzi alluvionali <strong>del</strong>la Nurra sono limitati ad est da una serie <strong>di</strong> rilievi che senza soluzione <strong>di</strong> continuità si<br />
spingono dall’imme<strong>di</strong>ato entroterra <strong>del</strong>la spiaggia <strong>di</strong> Poglina fino al confine, a nord, con Olmedo e Ittiri.<br />
La genesi <strong>di</strong> questi rilievi è ascrivibile agli importanti fenomeni effusivi che hanno interessato la Sardegna centrale<br />
e centro-occidentale durante l’Oligocene e il primo Miocene. Questi rilievi, esempio Monte Calvia, Monte Riccio,<br />
Monte San Giuliano, sono spesso caratterizzati da sommità tabulari, o mesas, originate da colate laviche che<br />
hanno protetto dall’erosione le sottostanti formazioni, ignimbriti, trachiandesiti, ecc..<br />
c) Paesaggio dei depositi alluvionali ed eolici <strong>del</strong> Pliocene e <strong>del</strong> Pleistocene<br />
141
La vasta piana <strong>del</strong>la Nurra, compresa tra i rilievi se<strong>di</strong>mentari ad ovest e quelli effusivi a est, è caratterizzata dalla<br />
presenza <strong>di</strong> una potente coltre <strong>di</strong> depositi alluvionali terrazzati. Depositi originatisi, a partire dal tardo Pliocene a<br />
tutto il Pleistocene, a spese dei citati rilievi se<strong>di</strong>mentari.<br />
Fortemente incisa dal reticolo idrografico attuale questa serie <strong>di</strong> terrazzi è interessata dalla presenza <strong>di</strong> accumuli<br />
<strong>di</strong> carbonati secondari che hanno dato origine a lenti calcaree che, quasi senza soluzione <strong>di</strong> continuità, si<br />
estendono dalle dune eoliche <strong>di</strong> <strong>Porto</strong> Ferro (Sassari) fin quasi alle rive settentrionali <strong>del</strong> Calich.<br />
Dalla periferia <strong>del</strong> centro abitato fino ai pie<strong>di</strong> dei rilievi effusivi, lungo un arco che si estende dal Calich alla<br />
Speranza lungo la provinciale per Bosa, sono presenti potenti pacchi <strong>di</strong> depositi eolici pleistocenici. La genesi <strong>di</strong><br />
queste antiche dune, ricche in fossili <strong>di</strong> cervi<strong>di</strong>, è legata ai cicli <strong>di</strong> glaciazione e quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> trasgressione marina<br />
che hanno interessato l’Isola durante questa epoca geologica.<br />
Anche questi depositi sono stati interessati dai depositi <strong>di</strong> carbonati secondari causati dal <strong>di</strong>lavamento dei rilievi<br />
calcarei, sia <strong>del</strong>le stesse sabbie. Depositi che hanno dato origine a pacchi <strong>di</strong> arenarie a <strong>di</strong>verso grado <strong>di</strong><br />
cementazione, utilizzate fino ad un recente passato come materiale da costruzione. Materiale in<strong>di</strong>cato localmente<br />
con il termine <strong>di</strong> massacà.<br />
La presenza <strong>di</strong> queste arenarie è responsabile <strong>di</strong> una linea <strong>di</strong> costa, tra l’abitato e Poglina dalle pareti quasi<br />
verticali, la cui altezza varia da poche decine a qualche metro. Pareti interrotte localmente solo da pochi appro<strong>di</strong>,<br />
ad esempio Cala Bona, Cala Burantinu, <strong>di</strong> modesta estensione ed ampiezza.<br />
- Caratteristiche geomorfologiche<br />
Il <strong>territorio</strong> <strong>di</strong> Alghero è stato caratterizzato nel succedersi <strong>del</strong>le ere geologiche da profon<strong>di</strong> mutamenti <strong>del</strong> proprio<br />
paesaggio. Mutamenti legati ai movimenti tettonici che hanno ripetutamente interessato l’Isola comportando una<br />
alternanza <strong>di</strong> fasi <strong>di</strong> continentalità con importante ingressioni marine.<br />
Un altro potente agente <strong>di</strong> mo<strong>del</strong>lamento sono state le variazioni climatiche a cui si deve la gran parte dei<br />
processi morfogenetici verificatisi durante le citate fasi <strong>di</strong> continentalità.<br />
Un esempio <strong>del</strong>la loro interazione è offerto dai rilievi <strong>del</strong>le penisole <strong>di</strong> Capo Caccia e <strong>di</strong> Punta Giglio e degli<br />
a<strong>di</strong>acenti Monte Doglia, Zirra, ecc., testimonianze <strong>del</strong>la ingressione marina <strong>del</strong> Giura-Creta, fatti oggetto nel<br />
tempo a processi carsici. Questi processi hanno determinato sia lo smantellamento <strong>del</strong> rilievo, mettendo a nudo i<br />
loro nuclei centrali più resistenti i quali hanno assunto la caratteristica forma a cupola degli inselberg, sia la<br />
formazione <strong>di</strong> una fitta rete <strong>di</strong> cunicoli e cavità sotterranei.<br />
A partire dal Miocene lo smantellamento <strong>di</strong> questi rilievi se<strong>di</strong>mentari è responsabile <strong>del</strong>la formazione <strong>di</strong> potenti<br />
depositi <strong>di</strong> versante, ad esempio tra le località Palmavera e Le Bombarde, dove livelli <strong>di</strong> ghiaie e <strong>di</strong> ciottoli si<br />
alternano a materiali più fini a <strong>di</strong>verso grado <strong>di</strong> pedogenizzazione.<br />
A loro volta questi depositi localmente, ad esempio lungo i versanti sud-occidentali <strong>di</strong> Monte Doglia, sono<br />
interessati dalla presenza <strong>di</strong> depositi eolici pleistocenici che possono raggiungere più metri <strong>di</strong> potenza.<br />
I depositi <strong>di</strong> versante dei rilievi se<strong>di</strong>mentari si raccordano con quelli <strong>del</strong>le alluvioni pleistoceniche terrazzate <strong>del</strong>la<br />
piana <strong>del</strong>la Nurra, i cui materiali derivano in parte dallo smantellamento <strong>di</strong> precedenti depositi alluvionali, tracce<br />
dei quali sono state osservate in alcune tasche carsiche nella cava <strong>di</strong> ghiaie <strong>di</strong> Monte Doglia.<br />
Sulle alluvioni pleistoceniche si sono sviluppati suoli caratterizzati sia da orizzonti a <strong>di</strong>verso grado <strong>di</strong><br />
cementazione carbonatica, testimonianza <strong>di</strong> importanti movimenti <strong>di</strong> acque durante le fasi climatiche più umide <strong>di</strong><br />
questa epoca, sia <strong>di</strong> accumuli <strong>di</strong> ossi<strong>di</strong> <strong>di</strong> ferro e alluminio, anche loro in<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni climatiche oggi<br />
riscontrabili nelle aree tropicali africane.<br />
Alle variazioni climatiche pleistoceniche, conseguenza <strong>del</strong>la alternanza <strong>di</strong> fasi glaciali e interglaciali, devono<br />
essere attribuiti gran parte dei perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> trasgressione <strong>del</strong>le acque marine, fino all’attuale batimetrica – 100 m,<br />
registrati in questa epoca.<br />
Trasgressioni queste, responsabili <strong>del</strong>la formazione degli importanti depositi <strong>di</strong> sabbie eoliche, che dalla sinistra<br />
<strong>del</strong> rio Barca si spingono dalla costa fino ai pie<strong>di</strong> dei rilievi effusivi mesozoici. Questi depositi sono stati fatti<br />
oggetto a più episo<strong>di</strong> <strong>di</strong> pedogenizzazione e a processi <strong>di</strong> cementazione per evaporazione <strong>di</strong> acque carbonatiche<br />
<strong>di</strong> infiltrazione laterale e profonda durante le fasi <strong>di</strong> ari<strong>di</strong>tà stagionale o a sta<strong>di</strong> <strong>di</strong> cambiamento climatico.<br />
Alle stesse fasi <strong>di</strong> trasgressioni marine è legata la genesi <strong>del</strong> complesso dunale <strong>di</strong> <strong>Porto</strong> Ferro che interessa in<br />
parte il <strong>territorio</strong> algherese.<br />
Durante le fasi più aride <strong>del</strong>la glaciazione wurmiana, circa 80.000 anni B.P. il ritiro <strong>del</strong>la linea <strong>di</strong> costa ha favorito il<br />
trasporto eolico <strong>di</strong> ingenti quantità <strong>di</strong> sabbie <strong>del</strong> fondale marino. Sabbie che hanno colmato <strong>del</strong>le preesistenti<br />
depressioni scavate dalle acque fluviali nelle arenarie permiane.<br />
Processo <strong>di</strong> deposito ripetutosi più volte sia durante il Pleistocene che l’Olocene come testimoniato dalla<br />
presenza, nelle dune, <strong>di</strong> tre orizzonti cementati dalle acque carbonatiche. L’ultimo <strong>di</strong> questi è ricoperto da uno<br />
strato <strong>del</strong>la potenza <strong>di</strong> alcuni decimetri <strong>di</strong> sabbie fortemente pedogenizzate a sua volta ricoperto da un deposito <strong>di</strong><br />
sabbie eoliche incoerenti. Le analisi al C14 <strong>del</strong>l’orizzonte pedogenizzato hanno in<strong>di</strong>cato una età <strong>di</strong> circa<br />
1425±140 anni B.P.<br />
142
Ben <strong>di</strong>fferente è stata l’azione dei processi morfogenetici sui paesaggi effusivi. Le acque hanno inciso<br />
profondamente queste formazioni dando origine all’attuale, articolato reticolo idrografico e a depositi <strong>di</strong> versante<br />
<strong>di</strong> ridotta estensione e potenza se paragonati a quelli dei rilievi se<strong>di</strong>mentari. Le stesse acque hanno agito<br />
selettivamente sui <strong>di</strong>versi strati effusivi erodendo i <strong>di</strong>versi strati in funzione <strong>del</strong>la loro resistenza e alterabilità. Il<br />
risultato è la comparsa <strong>di</strong> rilievi dai versanti gradonati, le cuestas, con gli strati più resistenti all’erosione e alla<br />
alterazione chimica appaiono come pareti verticali, prive o quasi prive <strong>di</strong> vegetazione. I versanti gradonati sono<br />
spesso raccordati alle citate forme tabulari sommitali, le mesas.<br />
La presenza <strong>di</strong> queste formazioni effusive è responsabile lungo la costa, tra Poglina e Bosa, <strong>di</strong> una serie<br />
ininterrotta <strong>di</strong> imponenti falesie.<br />
- Reticolo idrografico e sorgenti<br />
La rete idrografica algherese è dominata dal sistema degli affluenti <strong>del</strong>lo stagno <strong>del</strong> Calich: rio Barca, Canale<br />
Oruni e rio Calvia.<br />
La rete è caratterizzata da corsi d’acqua a carattere torrentizio, dal tracciato irregolare, con portate massime nei<br />
mesi tardo invernali grazie alle maggiori precipitazioni che si registrano da ottobre a febbraio.<br />
La ricostruzione <strong>del</strong>le aste fluviali è complicata dai numerosi cambiamenti <strong>di</strong> nome che le stesse subiscono<br />
talvolta anche nello spazio <strong>di</strong> pochi chilometri. Si cita quale esempio il rio Barca la cui asta principale, lunga circa<br />
25 km, assume nel suo tratto superiore i nomi <strong>di</strong> rio Sassu, su Mattone e Cuga.<br />
Nel bacino <strong>del</strong> rio Barca sono stati realizzati due importanti invasi artificiali le cui riserve sono destinate ad usi<br />
irrigui e potabili. Il più importante <strong>di</strong> questi, con una capacità complessiva <strong>di</strong> circa 25 milioni <strong>di</strong> mc, è sul rio Cuga.<br />
Il secondo invaso, realizzato totalmente nell’agro algherese in località Surigheddu sul rio Serra affluente in<br />
sinistra <strong>del</strong> Barca, ha una capacità <strong>di</strong> invaso <strong>di</strong> circa 2 milioni <strong>di</strong> mc.<br />
Le caratteristiche idrogeologiche <strong>del</strong> <strong>territorio</strong> sono fortemente influenzate dalla presenza dei depositi se<strong>di</strong>mentari<br />
mesozoici interessati da processi carsici che nel tempo hanno dato origine ad una rete <strong>di</strong> canali sotterranei e<br />
vaste cavità, la più nota <strong>del</strong>le quali è la grotta <strong>di</strong> Nettuno nella penisola <strong>di</strong> Capo Caccia.<br />
Le frequenti emergenze a mare <strong>di</strong> questi processi carsici, un esempio è osservabile in località le Bombarde, sono<br />
responsabili <strong>del</strong>le basse temperature <strong>del</strong>le acque marine lungo tutto l’arco costiero e riducono in modo<br />
significativo il possibile apporto alle falde freatiche <strong>del</strong>le piene alluvionali. Le falde freatiche fino ad un recente<br />
passato sono state interessate da importanti emungimenti per usi civili ed irrigui, in alcuni casi responsabili <strong>di</strong> una<br />
parziale salinizzazione <strong>di</strong> alcune falde.<br />
La presenza dei processi carsici e la morfologia pianeggiante <strong>di</strong> gran parte <strong>del</strong> <strong>territorio</strong> algherese concorrono a<br />
ridurre sensibilmente le emergenze idriche sia come numero, poco più <strong>di</strong> una ventina, sia come portate. Fatta<br />
eccezione per quattro sorgenti, Matte Arghentu (rio Filibertu), Sa Fighera (Canale Oruni) Sant’Imbenia, collegate<br />
ai fenomeni carsici, e Su Cantaru (Cala Bona) che hanno portate superiori ai 5 l/s, le restanti hanno valori sempre<br />
inferiori ad 1 l/s, anche durante la fase <strong>di</strong> massima portata primaverile.<br />
- Caratteristiche pedologiche<br />
La complessità geologica e morfologica <strong>del</strong> <strong>territorio</strong> algherese si traduce in una analoga complessità <strong>del</strong>le sue<br />
caratteristiche pedologiche.<br />
Tra i <strong>di</strong>versi tipi pedologici presenti, assumono particolare importanza, dal punto <strong>di</strong> vista <strong>del</strong>la loro utilizzazione<br />
agronomica, i suoli sviluppatisi sulle alluvioni e depositi eolici pleistocenici. La concomitanza <strong>di</strong> più fattori quali la<br />
morfologia da pianeggiante a terrazzata nelle alluvioni, il notevole spessore sia <strong>del</strong>le alluvioni che <strong>del</strong>le sabbie, la<br />
stagionalità <strong>del</strong>le precipitazioni e la loro passata abbondanza, hanno favorito la genesi e l’evoluzione <strong>di</strong> suoli<br />
profon<strong>di</strong>, caratterizzati dalla presenza <strong>di</strong> strati o orizzonti <strong>di</strong> accumulo <strong>di</strong> argille <strong>di</strong> trasporto illuviale.<br />
Questi orizzonti, in<strong>di</strong>cati nelle descrizioni dei profili pedologici con la sigla Bt, sono caratterizzati da una<br />
permeabilità sensibilmente inferiore a quella degli orizzonti sovrastanti, in<strong>di</strong>cati con la sigla A o Ap se lavorati.<br />
Minore permeabilità che comporta nelle micromorfologie depresse e nei compluvi con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> ristagno idrico più<br />
o meno prolungati nel tempo ma, allo stesso tempo, nelle restanti aree permette al suolo <strong>di</strong> conservare più a<br />
lungo la propria umi<strong>di</strong>tà compensando in parte la loro ridotta capacità a trattenere gli elementi nutritivi.<br />
I processi <strong>di</strong> trasporto illuviale e quelli <strong>di</strong> circolazione <strong>di</strong> acque <strong>di</strong> falda sub superficiali arricchite in carbonati sono<br />
responsabili <strong>del</strong>la formazione, all’interno o alla sommità degli orizzonti illuviali, <strong>di</strong> accumuli <strong>di</strong> carbonati secondari<br />
in<strong>di</strong>viduati con le sigle Btk e Bk in funzione <strong>del</strong>la quantità <strong>di</strong> CaCO3 accumulatasi. Accumulo che può raggiungere<br />
un livello tale da dare origine agli orizzonti cementati, in<strong>di</strong>cati con la sigla Bkm, simili ai travertini nei depositi<br />
alluvionali e alle arenarie in quelli eolici, più volte citati.<br />
Tra i <strong>di</strong>versi suoli presenti nel <strong>territorio</strong> assumono particolare importanza naturalistica i suoli sviluppatisi sui calcari<br />
cristallini mesozoici. La loro genesi è legata ai processi carsici <strong>di</strong> decarbonatazione. Processi che liberano le<br />
minime quantità <strong>di</strong> argille e <strong>di</strong> ossi<strong>di</strong> <strong>di</strong> Fe e Al presenti come impurezza o residuo insolubile nelle rocce<br />
carbonatiche. Da questo residuo, trattenuto nelle fratture carsiche si svilupperanno suoli dal caratteristico colore<br />
rossastro. Le superfici interessate da questi suoli, che sono caratterizzate dalla presenza <strong>di</strong> ampi tratti <strong>di</strong> roccia<br />
143
affiorante, devono alla presenza <strong>di</strong> un orizzonte Bt illuviale in grado <strong>di</strong> trattenere maggiori quantità <strong>di</strong> elementi<br />
nutrivi la formazione <strong>di</strong> una macchia me<strong>di</strong>terranea evoluta nei rilievi e <strong>del</strong>le colture erbacee o arboree, in funzione<br />
<strong>del</strong>la propria potenza, nelle morfologie pianeggianti o debolmente ondulate.<br />
- Capacità d’uso <strong>del</strong> <strong>territorio</strong><br />
Le caratteristiche pedologiche e morfologiche sono state utilizzate per una valutazione, intesa come giu<strong>di</strong>zio<br />
esperto, <strong>del</strong>la capacità d’uso, Land Capability, <strong>del</strong> <strong>territorio</strong> in stu<strong>di</strong>o. Capacità d’uso intesa come livello <strong>di</strong><br />
intensità <strong>di</strong> utilizzo in agricoltura, superato il quale, ci sono elevate probabilità <strong>di</strong> comparsa <strong>di</strong> processi <strong>di</strong> degrado<br />
<strong>del</strong> <strong>territorio</strong>. I più comuni <strong>di</strong> questi processi sono quelli <strong>di</strong> erosione idrica laminare ed incanalata dei versanti dei<br />
rilievi effusivi e se<strong>di</strong>mentari e quella eolica <strong>del</strong>le dune costiere.<br />
La valutazione ha permesso <strong>di</strong> evidenziare come nell’area in stu<strong>di</strong>o, comprensiva oltre che <strong>del</strong> <strong>territorio</strong> comunale<br />
anche <strong>di</strong> un buffer <strong>di</strong> 500 m (richiesto dalla Regione Sardegna per facilitare il raccordo con la cartografia dei<br />
comuni confinanti), siano presenti 14.564 ha (58,9%) destinabili ad usi agricoli intensivi (classi <strong>di</strong> Land Capability<br />
da I a IV compresa). La superficie destinabile ai soli usi estensivi, ovvero al miglioramento pascoli,<br />
rimboschimento meccanizzato finalizzato alla protezione <strong>del</strong> suolo, è pari a 664 ha (2,7%).<br />
Nelle situazioni interme<strong>di</strong>e, dove la complessità <strong>del</strong>le caratteristiche morfologiche e pedologiche ha imposto<br />
l’attribuzione <strong>del</strong>le superfici ad un range <strong>di</strong> classi <strong>di</strong> Land Capability interme<strong>di</strong>e tra gli usi intensivi e quelli<br />
estensivi, sono stati attribuiti 165 ha (0,7%).<br />
Infine, la stessa valutazione ha in<strong>di</strong>cato come non adatta agli usi agricoli ma al solo rimboschimento finalizzato<br />
alla protezione <strong>del</strong> suolo, al pascolo <strong>di</strong> carichi controllati <strong>di</strong> razze <strong>di</strong> elevata rusticità e agli usi turistici e ricreativi,<br />
la classe VIII <strong>di</strong> Land Capability, 7.514 ha, pari al 30,4% <strong>del</strong> <strong>territorio</strong> valutato.<br />
Rimangono da segnalare 1.305 ha che non sono stati fatti oggetto <strong>di</strong> valutazione in quanto interessati da opere <strong>di</strong><br />
urbanizzazione, dalle acque <strong>del</strong> Calich e degli invasi artificiali, da spiagge o gravati da servitù e vicoli militari,<br />
archeologici, ecc., che al momento ne limitano fortemente l’uso agricolo.<br />
Il quadro brevemente descritto, confermato dalle carte <strong>del</strong>l’uso <strong>del</strong> suolo e <strong>del</strong>la copertura vegetale, è quello <strong>di</strong> un<br />
<strong>territorio</strong> caratterizzato da vaste aree ad elevata vocazione agricola. A queste aree sono associate situazioni <strong>di</strong><br />
elevata naturalità o quasi naturalità o, comunque, ritenute tali dall’opinione pubblica. Entrambe dovrebbero<br />
essere valorizzate attraverso l’adozione <strong>di</strong> opportune politiche, da locali a comunitarie, <strong>di</strong> tutela e <strong>di</strong> gestione in<br />
quanto rappresentano uno dei principali valori aggiunti per l’industria turistico-alberghiera algherese.<br />
- Uso <strong>del</strong> suolo e copertura vegetale<br />
Attraverso l’analisi cartografica realizzata utilizzando le ortofoto a colori prodotte dalla Regione Autonoma <strong>del</strong>la<br />
Sardegna sulla base <strong>di</strong> un volo <strong>del</strong> 2003, si è ottenuto un quadro preciso ed aggiornato <strong>del</strong>le destinazioni d’uso<br />
presenti nel <strong>territorio</strong> <strong>di</strong> Alghero. Viene confermata la vocazione agricola e naturalistica emersa con la valutazione<br />
<strong>del</strong>la sua capacità d’uso.<br />
In particolare le unità <strong>di</strong> uso <strong>del</strong> suolo (UDS) sono state determinate per tutto il <strong>territorio</strong> in stu<strong>di</strong>o fino al livello 3<br />
<strong>del</strong>la legenda CORINE Land Cover <strong>del</strong>l’Unione Europea. Per alcune destinazioni d’uso, ad esempio i seminativi,<br />
la descrizione è stata spinta fino al livello 4 <strong>del</strong>la stessa legenda.<br />
La restituzione nel sistema informativo geografico <strong>del</strong>la fotointerpretazione e dei controlli in campo, ha permesso<br />
<strong>di</strong> attribuire ai seminativi una superficie <strong>di</strong> 7.006,2 ha (28,2% <strong>del</strong>l’area stu<strong>di</strong>ata). Di questi 3.698,5 pari al 52,8%,<br />
ricadono in aree irrigue. Seguono per <strong>di</strong>ffusione gli oliveti con 2.420.8 ha (9,75) e i vigneti con poco più <strong>di</strong> 1.244<br />
ha (5,0%).<br />
Tra le destinazioni d’uso non agricole, quella maggiormente <strong>di</strong>ffusa è rappresentata dalle aree a vegetazione<br />
sclerofilla, con 3.258,8 ha (13,1%), o interessate da cespuglieti ed arbusteti con poco più <strong>di</strong> 3.139 ha (12,6%).<br />
Infine al pascolo naturale sono attribuiti 2.359,7 ha (9,5%).<br />
L’antropizzazione <strong>del</strong>l’agro algherese è evidenziata dalla superficie occupata da due destinazioni d’uso.<br />
La prima è rappresentata dai sistemi colturali e particellari complessi che interessano una superficie <strong>di</strong> 1.564,8 ha<br />
(6,3%). In questa UDS sono state ascritte aree prossime ai centri urbani, o ai fabbricati rurali <strong>di</strong> civile abitazione,<br />
caratterizzate da un elevato frazionamento <strong>del</strong>la proprietà fon<strong>di</strong>aria o da una pluralità <strong>di</strong> colture, quali orti, frutteti,<br />
vigneti, oliveti, ecc., nella stessa parcella. Colture, la cui produzione è generalmente destinata all’autoconsumo<br />
familiare.<br />
La seconda destinazione d’uso, in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> elevata antropizzazione, è quella <strong>del</strong> tessuto urbano <strong>di</strong>scontinuo.<br />
Questa UDS interessa 473,4 ha circa (1,9%) e 3.245 poligoni (il 64,7% <strong>di</strong> quelli in<strong>di</strong>viduati), <strong>di</strong> cui 3.226 per<br />
complessivi 362,6 ha sono stati attributi alla UDS <strong>di</strong> 4° livello dei fabbricati rurali.<br />
144
- <strong>Analisi</strong> SWOT:<br />
PUNTI DI FORZA<br />
-Territorio<br />
particolarmente<br />
pregiato ed<br />
eterogeneo: litorali<br />
turistici; coste alte;<br />
terreni agricoli e<br />
produttivi; aree silvopastorali;<br />
ecc.<br />
-<br />
<strong>ambientale</strong><br />
<strong>Conte</strong>sto<br />
favorevole<br />
sviluppo<br />
allo<br />
<strong>del</strong>l’agricoltura<br />
ecosostenibile<br />
PUNTI DI<br />
DEBOLEZZA<br />
- Degrado <strong>ambientale</strong><br />
dovuto all’abbandono<br />
<strong>del</strong>le colture<br />
- Fenomeni erosivi<br />
legati alla riduzione<br />
<strong>del</strong>la copertura<br />
vegetale naturale e<br />
seminaturale<br />
- Sottrazione <strong>del</strong>le<br />
funzionalità<br />
ambientali portanti<br />
<strong>del</strong> sistema spiaggia,<br />
<strong>del</strong>le dune e <strong>del</strong><br />
sistema umido a<br />
causa <strong>del</strong> progressivo<br />
incremento <strong>del</strong>la<br />
pressione inse<strong>di</strong>ativa<br />
- Presenza <strong>di</strong> versanti<br />
ed aree instabili<br />
oggetto <strong>di</strong> movimenti<br />
franosi e <strong>di</strong> fenomeni<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>ssesto<br />
- Scarsa attenzione ai<br />
corsi d’acqua ed alle<br />
loro aree <strong>di</strong><br />
pertinenza<br />
- <strong>Analisi</strong> quantitativa e qualitativa: gli in<strong>di</strong>catori<br />
Legenda:<br />
fenomeno in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> stabilità<br />
fenomeno in <strong>di</strong>minuzione/miglioramento<br />
fenomeno in aumento/peggioramento<br />
☺ positivo<br />
incerto<br />
negativo<br />
OPPORTUNITA’ RISCHI<br />
- <strong>Conte</strong>nimento dei<br />
danni provocati dagli<br />
incen<strong>di</strong><br />
- Riduzione <strong>del</strong><br />
numero degli incen<strong>di</strong><br />
nei boschi e nelle<br />
campagne<br />
- In<strong>di</strong>viduazione e<br />
<strong>del</strong>imitazione le aree<br />
a rischio idraulico e a<br />
rischio frana<br />
- Rilevamento degli<br />
inse<strong>di</strong>amenti, dei<br />
beni, degli interessi e<br />
<strong>del</strong>le attiità vulnerabili<br />
nelle aree pericolose<br />
- Promozione <strong>di</strong><br />
sistemi agricoli e<br />
forestali finalizzati alla<br />
tutela <strong>del</strong>la risorsa<br />
suolo al fine <strong>di</strong><br />
contrastare i<br />
fenomeni <strong>di</strong> erosione<br />
e <strong>di</strong> desertificazione<br />
- Impatto <strong>ambientale</strong><br />
<strong>del</strong>le attività agricole<br />
sulle acque lacustri,<br />
<strong>di</strong> falda e marine<br />
- Eccessiva pressione<br />
<strong>del</strong> pascolamento<br />
- Incen<strong>di</strong> nei boschi e<br />
nelle campagne<br />
- Aumento <strong>del</strong> livello<br />
<strong>di</strong> pericolosità per le<br />
aree a rischio a<br />
causa<br />
<strong>del</strong>l’introduzione <strong>di</strong><br />
attività antropiche<br />
Giu<strong>di</strong>zio sintetico componente Suolo:<br />
incerto<br />
145
USO DEL SUOLO<br />
DPSIR ASPETTO INDICATORE U.M<br />
Stato<br />
Stato<br />
Stato<br />
Stato<br />
Stato<br />
Stato<br />
Capacità d’uso dei suoli<br />
Rapporto tra la superficie<br />
appartenente alla classe<br />
I 9<br />
(secondo la<br />
classificazione <strong>del</strong>la<br />
capacità d’uso dei suoli<br />
<strong>del</strong>le zone agricole –<br />
zone E) e la superficie<br />
comunale<br />
Rapporto tra la superficie<br />
appartenente alla classe<br />
II (secondo la<br />
classificazione <strong>del</strong>la<br />
capacità d’uso dei suoli<br />
<strong>del</strong>le zone agricole –<br />
zone E) e la superficie<br />
comunale<br />
Rapporto tra la superficie<br />
appartenente alla classe<br />
III (secondo la<br />
classificazione <strong>del</strong>la<br />
capacità d’uso dei suoli<br />
<strong>del</strong>le zone agricole –<br />
zone E) e la superficie<br />
comunale<br />
Rapporto tra la superficie<br />
appartenente alla classe<br />
IV (secondo la<br />
classificazione <strong>del</strong>la<br />
capacità d’uso dei suoli<br />
<strong>del</strong>le zone agricole –<br />
zone E) e la superficie<br />
comunale<br />
Rapporto tra la superficie<br />
appartenente alla classe<br />
V (secondo la<br />
classificazione <strong>del</strong>la<br />
capacità d’uso dei suoli<br />
<strong>del</strong>le zone agricole –<br />
zone E) e la superficie<br />
comunale<br />
Rapporto tra la superficie<br />
appartenente alla classe<br />
VI (secondo la<br />
classificazione <strong>del</strong>la<br />
capacità d’uso dei suoli<br />
<strong>del</strong>le zone agricole –<br />
zone E) e la superficie<br />
comunale<br />
9 Le classi in<strong>di</strong>cate sono quelle <strong>di</strong> cui alla cartografia dei suoli <strong>del</strong>la Sardegna<br />
%<br />
%<br />
%<br />
%<br />
%<br />
%<br />
VALOR<br />
E<br />
-<br />
GIUDIZIO<br />
SINTETICO<br />
TREND<br />
<br />
0,6630 <br />
0,0878 <br />
0,3733 <br />
0,0028 <br />
0,0295 <br />
146
Stato<br />
Stato<br />
Stato<br />
Stato<br />
Stato<br />
Stato<br />
Stato<br />
Uso <strong>del</strong> suolo<br />
Co su o d suo o<br />
suolo occupato<br />
nell’espansione dagli<br />
anni ’50 a oggi<br />
relativamente alle<br />
<strong>di</strong>verse classi d’uso dei<br />
Rapporto tra la superficie<br />
appartenente alla classe<br />
VII (secondo la<br />
classificazione <strong>del</strong>la<br />
capacità d’uso dei suoli<br />
<strong>del</strong>le zone agricole –<br />
zone E) e la superficie<br />
comunale<br />
Rapporto tra la superficie<br />
appartenente alla classe<br />
VIII (secondo la<br />
classificazione <strong>del</strong>la<br />
capacità d’uso dei suoli<br />
<strong>del</strong>le zone agricole –<br />
zone E) e la superficie<br />
comunale<br />
Superficie urbanizzata:<br />
rapporto tra la superficie<br />
appartenente alla classe<br />
1 10 (aree artificiali) e la<br />
superficie comunale<br />
Superficie destinata a<br />
uso agricolo: rapporto tra<br />
la superficie<br />
appartenente alla classe<br />
2 (aree agricole) e la<br />
superficie comunale<br />
Superficie occupata da<br />
boschi e aree<br />
seminaturali: rapporto tra<br />
la superficie<br />
appartenente alla classe<br />
3 (aree boschive e<br />
seminaturali) e la<br />
superficie comunale<br />
Superficie destinata a<br />
verde urbano: rapporto<br />
tra la superficie a verde<br />
urbano esistente e la<br />
popolazione residente<br />
Superficie occupata<br />
nell’espansione dagli<br />
anni ’50 a oggi<br />
appartenente alla classe<br />
I 11 : rapporto tra la<br />
superficie interessata<br />
dall’espansione e<br />
appartenente alla classe<br />
I e la superficie<br />
comunale<br />
10 Le classi in<strong>di</strong>cate sono quelle <strong>di</strong> cui alla classificazione CORINE LAND COVER<br />
11 Le classi in<strong>di</strong>cate sono quelle <strong>di</strong> cui alla cartografia dei suoli <strong>del</strong>la Sardegna<br />
%<br />
%<br />
%<br />
%<br />
%<br />
m 2 /<br />
ab<br />
%<br />
0,0045 <br />
0,3596 <br />
6,40<br />
<br />
49,26 ☺ <br />
43,75 ☺ <br />
1,70 <br />
-<br />
<br />
147
Stato<br />
Stato<br />
Stato<br />
Stato<br />
Stato<br />
Superficie occupata<br />
nell’espansione dagli<br />
anni ’50 a oggi<br />
appartenente alla classe<br />
II: rapporto tra la<br />
superficie interessata<br />
dall’espansione e<br />
appartenente alla classe<br />
II e la superficie<br />
comunale<br />
Superficie occupata<br />
nell’espansione dagli<br />
anni ’50 a oggi<br />
appartenente alla classe<br />
III: rapporto tra la<br />
superficie interessata<br />
dall’espansione e<br />
appartenente alla classe<br />
III e la superficie<br />
comunale<br />
Superficie occupata<br />
nell’espansione dagli<br />
anni ’50 a oggi<br />
appartenente alla classe<br />
IV: rapporto tra la<br />
superficie interessata<br />
dall’espansione e<br />
appartenente alla classe<br />
IV e la superficie<br />
comunale<br />
Superficie occupata<br />
nell’espansione dagli<br />
anni ’50 a oggi<br />
appartenente alla classe<br />
V: rapporto tra la<br />
superficie interessata<br />
dall’espansione e<br />
appartenente alla classe<br />
V e la superficie<br />
comunale<br />
Superficie occupata<br />
nell’espansione dagli<br />
anni ’50 a oggi<br />
appartenente alla classe<br />
VI: rapporto tra la<br />
superficie interessata<br />
dall’espansione e<br />
appartenente alla classe<br />
VI e la superficie<br />
comunale<br />
%<br />
1,26 <br />
% - <br />
%<br />
%<br />
%<br />
0,04 <br />
- <br />
- <br />
148
Stato<br />
Stato<br />
Superficie occupata<br />
nell’espansione dagli<br />
anni ’50 a oggi<br />
appartenente alla classe<br />
VII: rapporto tra la<br />
superficie interessata<br />
dall’espansione e<br />
appartenente alla classe<br />
VII e la superficie<br />
comunale<br />
EROSIONE E DESERTIFICAZIONE<br />
Superficie occupata<br />
nell’espansione dagli<br />
anni ’50 a oggi<br />
appartenente alla classe<br />
VIII: rapporto tra la<br />
superficie interessata<br />
dall’espansione e<br />
appartenente alla classe<br />
VIII e la superficie<br />
comunale<br />
DPSIR ASPETTO INDICATORE U.M. VALORE<br />
Stato<br />
Stato<br />
Stato<br />
Stato<br />
Stato<br />
Rischio <strong>di</strong> erosione<br />
costiera<br />
Rischio <strong>di</strong> desertificazione<br />
Pericolosità<br />
da frana<br />
Lunghezza dei litorali a<br />
rischio erosione<br />
Aree potenziali (In<strong>di</strong>ce<br />
ESAs 12= 1.17 – 1.22)<br />
Aree fragili (In<strong>di</strong>ce ESAs<br />
= 1.23 – 1.37)<br />
Aree critiche (In<strong>di</strong>ce<br />
ESAs = 1.38 – 1.41)<br />
Aree a pericolosità da<br />
frana ricadenti in classe<br />
Hg1<br />
km 2<br />
km 2<br />
km 2<br />
% - <br />
%<br />
km<br />
km 2<br />
0,03 <br />
GIUDIZIO<br />
SINTETICO<br />
TREND<br />
- <br />
7,76 <br />
129,80 <br />
258,36 <br />
0 <br />
12<br />
La classificazione <strong>del</strong>le aree a rischio <strong>di</strong> desertificazione si riferisce allo Stu<strong>di</strong>o realizzato dall’ERSAT volto alla “Realizzazione <strong>del</strong> sistema informativo<br />
geografico per l’in<strong>di</strong>viduazione ed il monitoraggio <strong>del</strong>le aree sensibili alla desertificazione in Sardegna”<br />
149
Stato<br />
Stato<br />
Stato<br />
Stato<br />
Stato<br />
Stato<br />
Stato<br />
Risposta<br />
Pericolosità idraulica<br />
P<strong>RES</strong>ENZA DI CAVE E MINIERE<br />
Pressione<br />
Cave e miniere<br />
Aree a pericolosità da<br />
frana ricadenti in classe<br />
Hg2<br />
Aree a pericolosità da<br />
frana ricadenti in classe<br />
Hg3<br />
Aree a pericolosità da<br />
frana ricadenti in classe<br />
Hg4<br />
Aree a pericolosità<br />
idraulica ricadenti in<br />
classe Hi1<br />
Aree a pericolosità<br />
idraulica ricadenti in<br />
classe Hi2<br />
Aree a pericolosità<br />
idraulica ricadenti in<br />
classe Hi3<br />
Aree a pericolosità<br />
idraulica ricadenti in<br />
classe Hi4<br />
Ricostruzione<br />
<strong>del</strong>l’assetto idrogeologico<br />
<strong>del</strong>l’area comunale<br />
Cave: (id., stato,<br />
materiale)<br />
72001, Autorizzata,<br />
Calcare<br />
72002, Archiviata,<br />
Arenaria<br />
72004, Cava Dismessa<br />
Storica, Calcare<br />
72007, Cava Dismessa<br />
Storica, Calcare<br />
72009, Cava Dismessa<br />
Storica, Calcare<br />
73001, In Chiusura,<br />
Ignimbrite<br />
78005, Cava Dismessa<br />
Storica, Calcare<br />
km 2<br />
km 2<br />
km 2<br />
km 2<br />
km 2<br />
Km 2<br />
Km 2<br />
349,01 <br />
120,81 <br />
130,16 <br />
99,67 <br />
64,59 <br />
16,55 <br />
132,18 <br />
SI/NO SI \ <br />
n.<br />
7 <br />
150
Pressione<br />
Stato<br />
Stato<br />
CONTAMINAZIONE DEL SUOLO<br />
Pressione<br />
Pressione<br />
Pressione<br />
Pressione<br />
Pressione<br />
Pressione<br />
Risposta<br />
Siti<br />
contaminati<br />
Bonifica dei<br />
siti<br />
contaminati<br />
Miniere: (id., nome,<br />
stato, tipo)<br />
5005001, Calabona,<br />
Archiviata, Argento<br />
5005002, Calabona,<br />
Archiviata, Argento<br />
5005003, Calabona,<br />
Archiviata, Argento<br />
Aree occupate da<br />
cave/miniere attive<br />
Aree occupate da<br />
cave/miniere <strong>di</strong>messe<br />
Siti contaminati da<br />
<strong>di</strong>scariche non<br />
controllate<br />
Siti contaminati da<br />
attività industriali<br />
Siti contaminati da<br />
amianto<br />
Punti ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong><br />
carburanti<br />
Progetti <strong>di</strong> bonifica<br />
n.<br />
Km 2<br />
Km 2<br />
n.<br />
m 2<br />
n.<br />
m 2<br />
Tipologi<br />
a<br />
inquinan<br />
te<br />
n.<br />
m 2<br />
n.<br />
m 2<br />
n.<br />
3<br />
<br />
0.282 <br />
0.026 <br />
1 <br />
68.307 <br />
1<br />
32.675<br />
n.p<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
4 ☺<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
151
Risposta<br />
Risposta<br />
Risposta<br />
Pianificazione <strong>di</strong> settore<br />
Interventi <strong>di</strong> bonifica<br />
avviati<br />
Interventi <strong>di</strong> messa in<br />
sicurezza d’emergenza<br />
Siti bonificati<br />
n.<br />
n.<br />
n.<br />
-<br />
-<br />
-<br />
( (<br />
( (<br />
( (<br />
Adeguamento alle previsioni <strong>del</strong> Piano <strong>di</strong> assetto idrogeologico e Piano <strong>di</strong> Bonifica siti inquinati<br />
Cartografia<br />
- Carta geo-litologica (Dati giaciturali, coperture detritiche, presenza <strong>di</strong> geositi secondo meto<strong>di</strong> e<br />
legende standar<strong>di</strong>zzati – scala 1:10.000)<br />
- Carta geologico-tecnica (scala 1:10.000)<br />
- Carta geomorfologia (Rilevamento <strong>del</strong>le forme <strong>del</strong> <strong>territorio</strong>, processi <strong>di</strong> morfogenesi, acclività,<br />
esposizione, presenza <strong>di</strong> morfositi – scala 1:10.000)<br />
- Carta idrogeologica (Permeabilità, altezza falda, grado <strong>di</strong> fatturazione – scala 1:10.000)<br />
- Carta <strong>del</strong>le aree a significativa pericolosità idraulica o geomorfologia (non <strong>di</strong>rettamente perimetrale<br />
dal PAI) – scala 1: 2000<br />
- Carta pedologica o Carta <strong>del</strong>le Unità <strong>del</strong>le Terre (acquisizione <strong>di</strong> parametri relativi ai suoli –<br />
granulometria, porosità, contenuto <strong>di</strong> sostanza organica, fertilità, presenza <strong>di</strong> strati impermeabili,<br />
attitu<strong>di</strong>ne dei suoli ad usi <strong>di</strong>versi -, in<strong>di</strong>viduazione dei processi <strong>di</strong> pedogenesi, processi <strong>di</strong><br />
degradazione, presenza <strong>di</strong> pedositi – scala 1:10.000)<br />
- Carta <strong>del</strong>l’uso <strong>del</strong> suolo (scala 1:10.000)<br />
152
Scheda 5: Energia e inquinamento elettromagnetico<br />
Fonte dei dati:<br />
Comune <strong>di</strong> Alghero; Enel<br />
Livello e qualità dei dati:<br />
scarsa<br />
Priorità tematismo<br />
Me<strong>di</strong>a<br />
- Stato attuale <strong>del</strong>la componente<br />
Consumo energetico<br />
I dati comunali <strong>di</strong>sponibili relativi ai consumi <strong>di</strong> energia elettrica settoriali sono quelli pubblicati nel Rapporto sullo<br />
stato <strong>del</strong>l’ambiente nell’anno 2003.<br />
Analizzando questi dati, è facile vedere che, su un totale <strong>di</strong> oltre 116 giga wattora utilizzate, il settore nel quale si<br />
registrano i consumi più alti è quello degli usi produttivi non industriali (46,5%), seguito dal settore domestico<br />
(41,7%) mentre il consumo per usi industriali risulta essere abbastanza limitato (11,8%).<br />
Andamento analogo è riscontrabile per il Comune <strong>di</strong> Sassari dove, a fronte <strong>di</strong> un impegno totale <strong>di</strong> circa 370 giga<br />
wattora, il settore produttivo non industriale ne consuma il 49,8%, quello domestico ne utilizza circa il 38,9%<br />
mentre il restante 11,3% va agli usi industriali.<br />
I dati provinciali si <strong>di</strong>scostano invece leggermente da questo andamento: dei circa 2140 giga wattora utilizzati, il<br />
48,7% è relativo agli usi produttivi non industriali, il 27,5% va agli usi domestici ed il 23,7% va agli usi industriali.<br />
Dunque ad Alghero, come nella provincia <strong>di</strong> Sassari, il sistema dei consumi energetici evidenzia una incidenza<br />
prevalente dei consumi nel settore terziario.<br />
Confrontando poi i consumi per le utenze non residenti, si nota facilmente come il dato <strong>di</strong> Alghero sia più basso<br />
rispetto a quello me<strong>di</strong>o <strong>del</strong>la provincia <strong>di</strong> Sassari, evidenziando un uso <strong>del</strong>le abitazioni prevalentemente<br />
stagionale.<br />
Iniziative <strong>di</strong> risparmio energetico<br />
Il Comune <strong>di</strong> Alghero ha avviato, nel corso <strong>del</strong> 2002, un intervento <strong>di</strong> razionalizzazione <strong>del</strong> sistema integrato <strong>di</strong><br />
illuminazione pubblica ed efficienza energetica degli e<strong>di</strong>fici pubblici, attraverso l’utilizzo <strong>di</strong> tecnologie<br />
illuminotecniche innovative e la sostituzione dei punti luce con lampade ad alto risparmio energetico. Il progetto<br />
pilota mira a <strong>di</strong>mostrare come, attraverso una gestione integrata <strong>del</strong> sistema energetico, si possano ottenere<br />
risparmi nell’or<strong>di</strong>ne <strong>del</strong> 50% sia in termini economici che energetici.<br />
Iniziative <strong>di</strong> utilizzo <strong>di</strong> fonti energetiche alternative<br />
Alghero ha intrapreso alcune iniziativa inerenti l’utilizzo <strong>di</strong> fonti rinnovabili <strong>di</strong> energia <strong>di</strong> utilizzo <strong>di</strong> fonti energetiche<br />
alternative come il solare termico, l’eolico, le biomasse per impianti a bassa e me<strong>di</strong>a tensione, collegati anche a<br />
centri <strong>di</strong> consumo <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni. In generale, dalle analisi effettuate sul regime dei consumi, tipologia <strong>di</strong><br />
fonti energetiche utilizzate e potenzialità <strong>di</strong> impiego <strong>di</strong> fonti rinnovabili, pare <strong>di</strong> interesse la possibilità <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>versificare le fonti <strong>di</strong> approvvigionamento energetico <strong>del</strong>la Sardegna, attualmente <strong>di</strong>pendenti pressoché<br />
interamente da combustibili tra<strong>di</strong>zionali quali carbone e derivati <strong>del</strong> petrolio.<br />
Il sistema energetico <strong>del</strong>la provincia <strong>di</strong> Sassari è caratterizzato da una totale <strong>di</strong>pendenza dal petrolio (99% contro<br />
il 94,4% <strong>del</strong>la Sardegna, il 54,6% Nazionale e il 44% Europeo) e da una ridottissima <strong>di</strong>versificazione <strong>del</strong>le fonti <strong>di</strong><br />
energia.<br />
153
Un obiettivo minimo per lo sviluppo <strong>del</strong>le fonti <strong>di</strong> energia rinnovabile nella provincia <strong>di</strong> Sassari è quello <strong>di</strong> elevare il<br />
valore attuale <strong>del</strong> consumo interno lordo dall’1% al 4,5% nel 2010, limite fissato dalla U.E. per la realizzazione dei<br />
programmi energetici. Ciò potrà consentire <strong>di</strong> concorrere alla necessaria <strong>di</strong>versificazione <strong>del</strong>le fonti energetiche,<br />
alla maggiore utilizzazione <strong>del</strong>le risorse locali e alla <strong>di</strong>ffusione <strong>del</strong>le competenze nel settore.<br />
Emissioni elettromagnetiche<br />
Il Comune <strong>di</strong> Alghero, con la collaborazione <strong>del</strong>lo Stu<strong>di</strong>o Associato d’Ingegneria STAI <strong>di</strong> Sassari, ha definito nel<br />
2001 il “Piano Generale <strong>di</strong> Settore” relativo all’inquinamento elettromagnetico sul <strong>territorio</strong>.<br />
L’indagine preliminare sul <strong>territorio</strong> ha identificato le sorgenti <strong>di</strong> campi elettomagnetici (Tabella 60) e le aree<br />
interdette per l’installazione ovvero asili, scuole ed istituti.<br />
<strong>Analisi</strong> swot<br />
PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA OPPORTUNITA’ RISCHI<br />
Piano generale <strong>di</strong><br />
settore per<br />
l’inquinamento<br />
elettromagnetico<br />
sostituzione degli<br />
impianti <strong>di</strong> illuminazione<br />
pubblica e impianti<br />
semaforici tra<strong>di</strong>zionali<br />
con impianti volti al<br />
risparmio energetico;<br />
organizzazione <strong>di</strong><br />
campagne <strong>di</strong><br />
incentivazione,<br />
sensibilizzazione e<br />
informazione sulla<br />
opportunità e necessità<br />
<strong>di</strong> utilizzare fonti <strong>di</strong><br />
Elevate emissioni <strong>di</strong><br />
CO2<br />
proporzionalmente alla<br />
popolazione presente;<br />
Scarsa propensione<br />
all'utilizzo <strong>del</strong>le fonti<br />
energetiche alternative<br />
per il trasporto e la<br />
movimentazione<br />
pubblici e privati;<br />
scarsa propensione<br />
all'utilizzo <strong>del</strong> servizio<br />
pubblico quale sistema<br />
154
<strong>Analisi</strong> quantitativa e qualitativa: gli in<strong>di</strong>catori<br />
energia alternativa e<br />
rinnovabile;<br />
proposizione <strong>di</strong> specifici<br />
strumenti per la<br />
creazione <strong>di</strong> nuove<br />
lottizzazioni e la<br />
ristrutturazione <strong>di</strong> vecchi<br />
e<strong>di</strong>fici con <strong>del</strong>le regole<br />
volte al risparmio<br />
energetico e ad un<br />
utilizzo più razionale<br />
<strong>del</strong>le fonti localmente<br />
<strong>di</strong>sponibili<br />
Nella Tabella a seguire vengono riportati i principali in<strong>di</strong>catori per la componente rumore<br />
.<br />
Legenda:<br />
Giu<strong>di</strong>zio sintetico componente<br />
fenomeno in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> stabilità<br />
fenomeno in <strong>di</strong>minuzione/miglioramento<br />
fenomeno in aumento/peggioramento<br />
incerto<br />
☺ positivo<br />
incerto<br />
negativo<br />
alternativo <strong>di</strong> trasporto<br />
e movimentazione;<br />
scarso utilizzo dei<br />
principi <strong>del</strong>la<br />
bioclimatica e<br />
bioarchitettura ai fini<br />
<strong>del</strong> risparmio<br />
energetico nelle<br />
costruzioni<br />
ENERGIA<br />
SPR Aspetto In<strong>di</strong>catore<br />
Consumi finali <strong>di</strong> energia<br />
u.m. Valore Giu<strong>di</strong>zio<br />
sintetico<br />
Trend<br />
elettrica per usi<br />
residenziali<br />
Consumi finali <strong>di</strong> energia<br />
MWh/anno 48.496 ( (<br />
elettrica per usi produttivi<br />
non industriali<br />
kWh/anno 54.172 ( (<br />
Pressione<br />
Stato<br />
Consumo<br />
energetico<br />
Produzione<br />
<strong>di</strong> energia<br />
elettrica da<br />
fonti<br />
rinnovabili<br />
Consumi finali <strong>di</strong> energia<br />
elettrica per usi industriali<br />
Consumi finali <strong>di</strong> energia<br />
elettrica per i trasporti<br />
Consumo procapite <strong>di</strong><br />
energia elettrica (utenze<br />
residenti)<br />
Consumo procapite <strong>di</strong><br />
energia elettrica (utenze<br />
non residenti)<br />
Potenza installata da fonti<br />
rinnovabili (settore civile e<br />
pmi)<br />
kWh/anno 13.713 ( (<br />
kWh/anno n.d. ( (<br />
KWh/ab.<br />
anno<br />
KWh/ab.<br />
anno<br />
3.241 ( (<br />
683 ( (<br />
kW n.d. ( (<br />
Impianti solari installati n. n.d. ( (<br />
Superficie comunale<br />
destinata a impianti per la<br />
produzione <strong>di</strong> energia da<br />
fonti rinnovabili<br />
m2 n.d. ( (<br />
155
Risposta<br />
Risparmio<br />
energetico<br />
Strumenti <strong>di</strong><br />
pianificazion<br />
E<strong>di</strong>fici pubblici che si<br />
sono dotati <strong>di</strong> impianti<br />
fotovoltaici<br />
Piano <strong>di</strong> illuminazione<br />
pubblica (conforme alle<br />
linee guida regionali<br />
(DGR 60/23 DEL<br />
5/4/2008)<br />
e comunale % <strong>di</strong> tratti <strong>di</strong> impianto<br />
adeguate alle Linee guida<br />
regionali (DGR 60/23<br />
DEL 5/4/2008)<br />
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO<br />
Sviluppo linee elettriche<br />
aeree<br />
Pressione<br />
Stato<br />
Fonti<br />
inquinanti<br />
Stazioni trasmissione<br />
ra<strong>di</strong>omobile<br />
Stazioni trasmissione<br />
ra<strong>di</strong>otelevisiva<br />
Intensità inquinamento<br />
Inquina- elettrico<br />
mento Intensità inquinamento<br />
elettromagnetico<br />
n. n.d. ☺ <br />
SI/NO NO <br />
% n.d. <br />
m n.d. (<br />
n. n.d. ( (<br />
n. n.d. ( (<br />
V/m n.d. ( (<br />
A/m n.d. ( (<br />
156
Scheda 6: Rifiuti<br />
Fonte dei dati<br />
Comune <strong>di</strong> Alghero, Settore Ecologia e Ambiente<br />
Regione Autonoma <strong>del</strong>la Sardegna, Piano Regionale <strong>di</strong> Gestione dei Rifiuti - Sezione rifiuti urbani, adottato<br />
con Delibera <strong>di</strong> Giunta Regionale n. 21/59 <strong>del</strong>l’8 aprile 2008<br />
Livello e qualità dei dati<br />
Buona<br />
Priorità tematismo<br />
Alta<br />
- Stato attuale <strong>del</strong>la componente<br />
- Produzione totale <strong>di</strong> rifiuti<br />
1. Andamento storico <strong>del</strong>la produzione dei rifiuti<br />
E’ interessante osservare che, rispetto al 2008, si è avuta una leggero aumento nella produzione totale dei rifiuti<br />
urbani, pari al 1.0% (+ 555t) , dovuto non all’aumento <strong>del</strong>la produzione <strong>del</strong> rifiuto che va allo smaltimento, che<br />
anzi <strong>di</strong>minuisce, ma all’aumento <strong>del</strong>la quantità dei rifiuti raccolti in forma <strong>di</strong>fferenziata che ammonta nel 2009 a<br />
9.298 tonnellate, a fronte <strong>del</strong>le 8.586 tonnellate raccolte nel 2008. Questo incremento ha portato la raccolta<br />
<strong>di</strong>fferenziata al 35,47 %, a fronte <strong>del</strong> 33,46% raggiunto lo scorso anno<br />
Milioni<br />
Kg/anno<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
2007 2008 2009<br />
Totale In<strong>di</strong>fferenziata Differenziata<br />
Fig_4.2.2/a Produzione rifiuti: confronto 2007-2008-2009<br />
157
30.000.000<br />
25.000.000<br />
20.000.000<br />
15.000.000<br />
10.000.000<br />
5.000.000<br />
0<br />
2007 2008 2009<br />
Fig_4.2.2/b Produzione RSU e RD: confronto 2007-2008-2009<br />
2007 2008 2009<br />
Variazione<br />
2006-2007<br />
Variazione<br />
2007-2008<br />
t/anno t/anno t/anno % %<br />
Tab_4.2.2./a Variazione percentuale rifiuti nel periodo 2007- 2009<br />
R.S.U R. D.<br />
Variazione<br />
2008-2009<br />
Comune 26 890 25 658 26 213 - 2,7 -4,6 1,0<br />
Provincia 168 939 164 027 - 0,2 -2,9 -<br />
Regione 862 452 846 664 - 0,2 -1,8 -<br />
- -<br />
Nella tabella sono riportate le quantità <strong>di</strong> rifiuti prodotti nel periodo 2007-2009 e le variazioni percentuali; nelle<br />
figure successive si riportano le mappe tematiche <strong>del</strong>l’intera regione, dove è possibile osservare la variazione<br />
nella produzione <strong>di</strong> RU tra il 2006 –2007 ed il 2007 -2008, a dettaglio comunale estrapolate dai Rapporti sulla<br />
gestione dei rifiuti urbani in Sardegna.Dalla tabella si evince come nel comune la variazione percentuale 2006-<br />
2007 sia in controtendenza rispetto alle percentuali sia <strong>del</strong>la provincia che <strong>del</strong>la regione registrandosi una<br />
<strong>di</strong>minuzione <strong>di</strong> produzione; <strong>di</strong>minuzione più consistente nel periodo 2007-2008. Nel 2009 registriamo invece,<br />
come su detto, un aumento <strong>del</strong>la produzione rispetto al 2008, comunque inferire a quella <strong>del</strong> 2007.<br />
%<br />
158
Fig_4.2.2./c Variazione percentuale produzione rifiuti urbani tra 2007 e 2008<br />
2. La produzione dei rifiuti urbani su base mensile.<br />
La produzione totale <strong>di</strong> rifiuti urbani comunale è stata stimata secondo le modalità <strong>di</strong> calcolo dai Rapporti sulla<br />
gestione dei rifiuti urbani in Sardegna ovvero calcolando la somma <strong>del</strong>le quantità provenienti dalla Raccolta<br />
Differenziata, nelle sue <strong>di</strong>verse frazioni, cui si aggiungono i “Rifiuti allo smaltimento”, costituiti dall’insieme dei<br />
RU misti (CER 200301), dai Rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale (CER 200303) e dagli Ingombranti<br />
non avviati al recupero (200307). La scelta <strong>di</strong> utilizzare lo stesso criterio metodologico ha lo scopo <strong>di</strong> garantire<br />
una continuità nei criteri <strong>di</strong> acquisizione <strong>del</strong>le informazioni, valutazione e analisi dei dati.<br />
La quantità totale <strong>di</strong> rifiuti urbani prodotti nel 2009, espresso come somma <strong>di</strong> tutte le frazioni, è pari a 26 213<br />
tonnellate (25 657 nel 2008). Di questa somma, sono destinate allo smaltimento 16 915 tonnellate (17 072 nel<br />
2008) derivanti da 16 393 tonnellate (16 457) <strong>di</strong> rifiuto in<strong>di</strong>fferenziato (CER 200301), 5 tonnellate (15) <strong>di</strong> rifiuti<br />
ingombranti (CER200307), e 517 tonnellate (600) derivanti dallo spazzamento stradale (CER 200303). La<br />
quantità <strong>di</strong> rifiuto <strong>di</strong>fferenziato compresi gli speciali e i pericolosi ammonta a 9 298 tonnellate a fronte <strong>di</strong> 8 586<br />
tonnellate <strong>del</strong> 2008.<br />
Si osserva che è stato stimata la quota <strong>di</strong> rifiuto dovuta agli abitanti residenti che è pari a 21.496 tonnellate, e il<br />
contributo riferito agli abitanti fluttuanti, valutati come numero <strong>di</strong> presenze turistiche principalmente legate ai<br />
mesi estivi, che ammonta a 4 196 tonnellate, <strong>di</strong> cui 2 973 tonnellate <strong>di</strong> rifiuto in<strong>di</strong>fferenziato e 1 223 tonnellate<br />
<strong>di</strong> rifiuto <strong>di</strong>fferenziato.<br />
Tale contributo è stato valutato attraverso un criterio <strong>di</strong>fferente da quello utilizzato dai Rapporti sulla gestione dei<br />
rifiuti urbani in Sardegna, basato non sulla valutazione <strong>del</strong>la variazione <strong>del</strong>la produzione rispetto alla<br />
<strong>di</strong>stribuzione mensile dei conferimenti ai <strong>di</strong>versi impianti <strong>di</strong> smaltimento, ma <strong>del</strong>la produzione mensile rilevata<br />
dai dati <strong>del</strong> Settore Ecologia ed Ambiente <strong>del</strong> Comune <strong>di</strong> Alghero.<br />
159
R.S.U.<br />
spazz.<br />
mec.<br />
ingombranti<br />
Totale rifiuti<br />
allo smalti<br />
mento: rsu,<br />
spazzamento<br />
ingombranti<br />
RSU da<br />
abitanti<br />
residenti<br />
RSU da<br />
popolazione<br />
fluttuante<br />
Totale RD<br />
compresi<br />
speciali e<br />
pericolosi<br />
RD da<br />
abitanti<br />
residenti<br />
RD da<br />
popolazione<br />
fluttuante<br />
Totale<br />
raccolte<br />
Produzi<br />
one pro<br />
capite<br />
Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg/ab<br />
Gennaio 1.088.660 41.400 1.130.060 1.088.660 - 601.618 601.618 1.731.678 42<br />
Febbraio 942.320 51.640 993.960 942.320 - 584.603 584.603 1.578.563 39<br />
Marzo 1.125.960 48.760 1.174.720 1.125.960 - 714.720 695.079 19.641 1.889.440 46<br />
Aprile 1.215.560 52.340 1.267.900 1.144.836 70.724 672.540 672.540 1.940.440 47<br />
Maggio 1.360.900 32.740 1.393.640 1.144.836 216.064 750.846 695.079 55.767 2.144.486 52<br />
Giugno 1.514.680 53.480 1.568.160 1.144.836 369.844 886.598 695.079 191.519 2.454.758 60<br />
Luglio 1.855.700 33.120 4.960 1.893.780 1.144.836 710.864 1.050.625 695.079 355.546 2.944.405 72<br />
Agosto 2.169.320 30.260 2.199.580 1.144.836 1.024.484 1.065.857 695.079 370.778 3.265.437 80<br />
Settembre 1.551.980 24.140 1.576.120 1.144.836 407.144 826.260 695.079 131.181 2.402.380 59<br />
Ottobre 1.318.620 41.320 1.359.940 1.144.836 173.784 793.373 695.079 98.294 2.153.313 53<br />
Novembre 1.102.760 45.380 1.148.140 1.102.760 - 686.600 686.600 1.834.740 45<br />
Dicembre 1.146.520 62.300 1.208.820 1.146.520 - 664.702 664.702 1.873.522 46<br />
- -<br />
TOTALE PESI 16.392.980 516.880 4.960 16.914.820 13.420.072 2.972.908 9.298.342 8.075.616 1.222.726 26.213.162 641<br />
Tab_4.2.2./b Produzione dei rifiuti urbani nell’anno 2009.<br />
160
3.500.000<br />
3.250.000<br />
3.000.000<br />
2.750.000<br />
2.500.000<br />
2.250.000<br />
2.000.000<br />
1.750.0 00<br />
1.500.000<br />
1.250.000<br />
1.000.000<br />
750.0 00<br />
500.000<br />
250.000<br />
2.500.000<br />
2.250.000<br />
2.000.000<br />
1.750.000<br />
1.500.000<br />
1.250.000<br />
1.000.000<br />
750.000<br />
500.000<br />
250.000<br />
0<br />
0<br />
TOTALE<br />
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic<br />
Fig_4.2.2./d Produzione totale rifiuti anno 2009<br />
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic<br />
Fig_4.2.2./e Produzione RSU e RD anno 2009<br />
R.S.U R. D.<br />
161
Gennaio<br />
Febbraio<br />
Marzo<br />
Aprile<br />
Maggio<br />
Giugno<br />
Luglio<br />
Agosto<br />
Settembre<br />
Ottobre<br />
Novembre<br />
Dicembre<br />
TOTALE<br />
PESI<br />
R.S.U.<br />
spazz.<br />
mec.<br />
ingombra<br />
nti<br />
Totale rifiuti<br />
allo smalti<br />
mento: rsu,<br />
spazzamento<br />
ingombranti<br />
RSU da<br />
abitanti<br />
residenti<br />
RSU da<br />
popolazione<br />
fluttuante<br />
Totale RD<br />
compresi<br />
speciali e<br />
pericolosi<br />
Tab_4.2.2/c Produzione dei rifiuti urbani nell’anno 2008<br />
RD da<br />
abitanti<br />
residenti<br />
RD da<br />
popolazio<br />
ne<br />
fluttuante<br />
Totale<br />
raccolte<br />
Produzione<br />
pro capite<br />
Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg/ab<br />
1.172.500 66.440 4.000 1.242.940 1.172.500 543.818 543.818<br />
1.027.620 42.980 4.020 1.074.620 1.027.620 636.290 636.290<br />
1.177.060 45.100 4.020 1.226.180 1.177.060 632.946 632.946<br />
1.193.640 39.320 1.232.960 1.185.723 7.917 694.072 654.192<br />
1.355.220 36.260 1.660 1.393.140 1.185.723 169.497 659.663 654.192<br />
1.456.140 37.420 1.493.560 1.185.723 270.417 734.416 654.192<br />
1.888.800 41.920 1.580 1.932.300 1.185.723 703.077 990.735 654.192<br />
2.127.420 55.620 2.183.040 1.185.723 941.697 1.019.746 654.192<br />
1.549.800 38.960 1.588.760 1.185.723 364.077 794.464 654.192<br />
1.264.380 58.120 1.322.500 1.185.723 78.657 689.416 654.192<br />
1.097.440 80.180 1.177.620 1.097.440 600.646 600.646<br />
1.147.000 57.180 1.204.180 1.147.000 589.980 589.980<br />
16.457.020 599.500 15.280 17.071.800<br />
13.921.681 2.535.339 8.586.192 7.583.024<br />
39.880<br />
5.471<br />
80.224<br />
336.543<br />
365.554<br />
140.272<br />
35.224<br />
1.003.168<br />
1.786.758 44<br />
1.710.910 42<br />
1.859.126 45<br />
1.927.032 47<br />
2.052.803 50<br />
2.227.976 54<br />
2.923.035 71<br />
3.202.786 78<br />
2.383.224 58<br />
2.011.916 49<br />
1.778.266 43<br />
1.794.160 44<br />
- -<br />
25.657.992 628<br />
162
3.500.000<br />
3.250.000<br />
3.000.000<br />
2.750.000<br />
2.500.000<br />
2.250.000<br />
2.000.000<br />
1.750.000<br />
1.500.000<br />
1.250.000<br />
1.000.000<br />
750.000<br />
500.000<br />
250.000<br />
0<br />
2.500.000<br />
2.250.000<br />
2.000.000<br />
1.750.000<br />
1.500.000<br />
1.250.000<br />
1.000.000<br />
750.000<br />
500.000<br />
250.000<br />
0<br />
TOTALE<br />
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic<br />
Fig_4.2.2/f Produzione totale rifiuti anno 2008<br />
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic<br />
Fig_4.2.2/g Produzione RSU e RD anno 2008<br />
3. Produzione <strong>di</strong> rifiuti da popolazione residente e da fluttuanti<br />
R.S.U R. D.<br />
La stima <strong>del</strong>la produzione pro-capite rappresenta un punto critico nell’ambito <strong>del</strong>l’analisi sulla produzione <strong>di</strong><br />
rifiuti: infatti si osserva una variabilità <strong>di</strong> questo contributo derivata dalla presenza <strong>di</strong> quella quota <strong>di</strong><br />
popolazione, denominata “fluttuante”, che non fa parte <strong>del</strong>la citta<strong>di</strong>nanza residente, ma rappresenta, attraverso<br />
il flusso turistico, un fenomeno critico che, soprattutto nei mesi estivi, ha come conseguenza un incremento<br />
abbastanza in<strong>di</strong>cativo <strong>del</strong>la produzione <strong>di</strong> rifiuti. E’ molto <strong>di</strong>fficile stimare con certezza il numero <strong>di</strong> tali presenze,<br />
poiché non sono ancora definiti con precisione gli in<strong>di</strong>catori che ne consentirebbero in maniera univoca la<br />
valutazione. In sostanza, per analizzare tale fenomeno, si è fatto riferimento al criterio in base al quale sono<br />
state valutate le eccedenze <strong>del</strong>le punte <strong>di</strong> produzione <strong>del</strong> rifiuto sia secco in<strong>di</strong>fferenziato che <strong>di</strong>fferenziati, così<br />
come rilevato dai dati forniti dal Settore Ecologia ed Ambiente <strong>del</strong> Comune <strong>di</strong> Alghero. Applicando questo<br />
163
criterio è stato possibile valutare, sul totale prodotto, la quantità <strong>di</strong> rifiuto secco in<strong>di</strong>fferenziato e <strong>di</strong>fferenziato<br />
derivato dagli abitanti fluttuanti, e attraverso questo analizzare le produzioni procapite. Come si evince dalle<br />
tabelle, la produzione pro capite annua in riferimento alla produzione totale <strong>di</strong> rifiuto, espressa in kg per<br />
abitante si attesta a 641Kg nel 2009, in leggero aumento rispetto ai 628 Kg <strong>del</strong> 2008 ma inferiore ai 659 Kg<br />
<strong>del</strong> 2007. Come ci si aspettava il comune ha una produzione pro capite <strong>di</strong> molto superiore a quella regionale<br />
che era <strong>di</strong> 507 Kg nel 2008 e <strong>di</strong> 518 kg nel 2007 dovuto proprio alla presenza <strong>del</strong>la popolazione fluttuante.<br />
Fig_4.2.2/h Produzione pro capite rifiuti urbani kg/ab/anno 2008<br />
Ma se an<strong>di</strong>amo ad analizzare lo stesso contributo riferito però alla stima <strong>di</strong> produzione da parte <strong>del</strong>la sola<br />
popolazione residente si osserva un decremento <strong>del</strong>la produzione pro capite pari a 526 Kg nel 2009 pressoché<br />
invariato dal 2008. Nella mappa è riportata la <strong>di</strong>stribuzione, a livello comunale, <strong>del</strong>la produzione pro_capite e<br />
come atteso, i comuni costieri hanno un’incidenza maggiore rispetto a quelli <strong>del</strong>l’entroterra.<br />
- Produzione dei rifiuti per tipologie<br />
1. Andamento storico raccolta <strong>di</strong>fferenziata<br />
La tabella seguente espone il dettaglio dei dati, relativo alle tipologie dei materiali raccolti in modo <strong>di</strong>fferenziato<br />
e le relative quantità.<br />
Dai valori riportati in tabella si può osservare che, nel 2009, la quantità <strong>di</strong> rifiuti raccolti in modo <strong>di</strong>fferenziato,<br />
compresi speciali e pericolosi, ammonta a 9.298 tonnellate; la % <strong>di</strong> R.D. si attesta al 35,5% superiore al<br />
risultato raggiunto nel 2008, pari al 33,5%. Si ricorda che nel 2007 la percentuale <strong>di</strong> raccolta <strong>di</strong>fferenziata è<br />
stata circa <strong>del</strong> 9,0%: il grafico riportato in precedenza sull’andamento storico <strong>del</strong>le raccolte 2007-2009 e le<br />
cartine sotto mostrano meglio come il risultato raggiunto nel 2008 ed incrementato nel 2009 ha spostato il<br />
comune <strong>di</strong> ben tre classi ovvero da < 10% nel 2007 a 30% - 40% nel 2008.<br />
164
Fig_4.2.2./i Produzione raccolta <strong>di</strong>fferenziata anno 2007 e 2008<br />
Nonostante il buon incremento nella raccolta <strong>di</strong>fferenziata avutasi nel 2008, confermato nel 2009, il comune è<br />
ancora lontano dai migliori risultati raggiunti da comuni con popolazione che supera i 10 000 abitanti, come<br />
evidenziato nella scheda estrapolata dal Rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani in Sardegna 2008.<br />
Fig_4.2.2/j Migliori risultati raccolta <strong>di</strong>fferenziata per fascia demografica 2008<br />
Nel grafico sottostante si può osservare la ripartizione <strong>del</strong> rifiuto raccolto in maniera separata fra le <strong>di</strong>verse<br />
frazioni che lo compongono;<br />
165
Scarto verde; 4,81%<br />
Plastica e lattina; 8,15%<br />
4000000<br />
3500000<br />
3000000<br />
2500000<br />
2000000<br />
1500000<br />
1000000<br />
500000<br />
Altro; 20,09%<br />
Vetro; 15,52%<br />
0<br />
Carta/cartone; 19,16%<br />
Fig_4.2.2/k Raccolta <strong>di</strong>fferenziata frazioni percentuali 2009<br />
Organico Vetro Carta Plastica<br />
Scarto alimentare; 32,27%<br />
La frazione costituita dal materiale organico, come somma <strong>del</strong>lo scarto alimentare, <strong>di</strong> poco al <strong>di</strong> sopra <strong>del</strong> 32%, e<br />
<strong>del</strong>lo scarto verde, quasi il 5% è al <strong>di</strong> sotto <strong>del</strong>la metà <strong>del</strong>l’ammontare totale.<br />
Le altre frazioni sono rappresentate con valori percentualmente più bassi: la carta raggiunge il 19.16% mentre il<br />
vetro ha superato il 15% e il multimateriale, plastica e lattine, raggiunge il 4.8%. Per un confronto con le me<strong>di</strong>e<br />
regionali si dovrà attendere la pubblicazione <strong>del</strong> Rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani in Sardegna 2009.<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
Fig_2.1.3/l Andamento storico frazioni raccolte:confronto 2007-2009<br />
Il grafico consente un’analisi <strong>del</strong>la variazione nelle produzioni relative alle <strong>di</strong>verse frazioni: si osserva la crescita<br />
esponenziale <strong>del</strong>le quantità <strong>di</strong> sostanza organica nel 2008 leggermente ri<strong>di</strong>mensionata nel 2009; altrettanto<br />
significativa la produzione <strong>del</strong>le altre tre frazioni con andamento <strong>di</strong> crescita costante.<br />
Un aspetto significativo è inoltre l’analisi <strong>del</strong>la variazione relativa <strong>del</strong>le quantità <strong>del</strong>le quattro frazioni principali nel<br />
quadro globale <strong>del</strong>la produzione <strong>di</strong> rifiuto <strong>di</strong>fferenziato.<br />
166
2009<br />
2008<br />
2007<br />
0% 20% 40% 60% 80% 100%<br />
Or ganico Vetro Carta Plastica Altro<br />
Fig_2.1.3/m Rapporti % tra le frazioni raccolte:confronto 2007-2009<br />
A tale scopo nel grafico a fianco è stato fatto un confronto nel 2007-2009, <strong>del</strong>la variazione <strong>del</strong>la composizione<br />
percentuale <strong>del</strong>la raccolta <strong>di</strong>fferenziata, sud<strong>di</strong>visa nelle varie frazioni. Analizzando il grafico è interessante<br />
osservare, come già rilevato, la crescita <strong>del</strong> dato relativo alla sostanza organica. Si osserva come le variazioni<br />
riguardanti le frazioni carta e vetro sono più contenute: infatti il contributo <strong>di</strong> tali frazioni al totale <strong>del</strong> rifiuto raccolto<br />
si mantiene più o meno costante nel corso degli anni, così come è modesto, seppure costante, il contributo <strong>del</strong>la<br />
frazione plastica.<br />
167
Tab_4.2.2/d Produzione dei rifiuti per singola tipologia anno 2009<br />
168
Tab_4.2.2/d Produzione dei rifiuti per singola tipologia anno 2009<br />
169
- Raccolta dei rifiuti<br />
1. Sistema <strong>di</strong> raccolta<br />
Per la raccolta <strong>del</strong> rifiuto in<strong>di</strong>fferenziato secco residuo e <strong>del</strong>la frazione organica il sistema <strong>di</strong> raccolta è misto<br />
ovvero sia a cassonetto che porta a porta, scelta obbligata anche in base allo specifico contesto in cui si svolge<br />
il servizio <strong>di</strong> raccolta. La mappa sottostante in<strong>di</strong>vidua le zone servite dalla raccolta porta a porta e nello specifico il<br />
centro storico, la borgata <strong>di</strong> Fertilia e due aree periferiche nelle quali a frequenza <strong>del</strong>la raccolta è giornaliera.<br />
Nelle altre aree <strong>del</strong> <strong>territorio</strong> invece la raccolta è a cassonetto sempre con frequenza <strong>di</strong> raccolta giornaliera,<br />
incrementata nella stagione estiva in caso <strong>di</strong> necessità.<br />
Per le altre frazioni <strong>del</strong>la raccolta <strong>di</strong>fferenziata: carta, plastica e vetro, si sono adottate entrambe le tecniche <strong>di</strong><br />
raccolta: per la carta e la plastica si ha la raccolta domiciliare mentre per il vetro la raccolta a campana. La mappa<br />
sottostante in<strong>di</strong>vidua le zone e le frequenze <strong>del</strong>la raccolta porta a porta.<br />
Si riporta inoltre una mappa con la <strong>di</strong>slocazione nel <strong>territorio</strong> <strong>del</strong>le isole ecologiche.<br />
2. Presenza <strong>di</strong> ecocentri<br />
Un ruolo importante per l’incremento e la migliore organizzazione <strong>del</strong>la raccolta <strong>di</strong>fferenziata è sicuramente svolto<br />
dalla presenza <strong>del</strong>l’ecocentro comunale in Località Galboneddu. Ogni singolo citta<strong>di</strong>no, con le regole e gli orari<br />
imposti dal centro stesso, conferisce i propri rifiuti al <strong>di</strong> fuori <strong>del</strong> circuito <strong>di</strong> raccolta comunale, soprattutto al fine <strong>di</strong><br />
conferire quelle frazioni per le quali non è previsto specifico circuito <strong>di</strong> raccolta: speciali, beni durevoli e RAEE.<br />
Si tratta in pratica <strong>di</strong> un area presi<strong>di</strong>ata e opportunamente allestita e organizzata, privo <strong>di</strong> strutture tecnologiche o<br />
processi <strong>di</strong> trattamento, ove i rifiuti conferiti sono raggruppati per frazioni omogenee per essere poi avviati al<br />
trasporto verso gli impianti <strong>di</strong> recupero e trattamento.<br />
La presenza <strong>del</strong>l’ecocentro, completa il sistema <strong>di</strong> raccolta e contribuisce a limitare il fenomeno <strong>del</strong>l’abbandono<br />
incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e in terreni privati e che causa danno <strong>ambientale</strong> e anche all’immagine<br />
dei territori. Il buon risultato ottenuto in questo senso ha portato l’amministrazione a realizzare altri due ecocentri,<br />
uno in Loc. Ungias Galantè oramai in fase <strong>di</strong> completamento e uno in Loc. San Marco ancora in fase <strong>di</strong><br />
progettazione. La mappa sottostante in<strong>di</strong>vidua cartograficamente le tre aree.<br />
- Trattamento dei rifiuti<br />
1. La destinazione dei rifiuti<br />
Il comune conferisce l’in<strong>di</strong>fferenziato presso la <strong>di</strong>scarica Scala Erre <strong>di</strong> Sassari, mentre la frazione organica,<br />
sud<strong>di</strong>visa nelle due categorie definite scarto alimentare e scarto verde, viene conferita all’impianto privato <strong>del</strong>la<br />
società S’Alga <strong>di</strong> Mores. Le altre frazioni <strong>di</strong>fferenziate ovvero carta/cartone, vetro/lattine e plastica vengono<br />
conferite nello stabilimento <strong>del</strong>la Gesam piattaforma che tratta tutte e tre le tipologie <strong>di</strong> materiale. Gli inerti<br />
derivanti dalle demolizioni sono conferite nella Cava <strong>di</strong> Monte Doglia dove si trova una <strong>di</strong>scarica autorizzata;<br />
infine la frazione <strong>di</strong> rifiuti speciali, dopo essere stata stoccata nell’ecocentro viene avviata in <strong>di</strong>scariche fuori dal<br />
<strong>territorio</strong> regionale.<br />
La quantità dei rifiuti destinata allo smaltimento, sud<strong>di</strong>visa nelle tre categorie RSU, spezzamento e ingombranti,<br />
nel 2009 è stata pari a 16.914 tonnellate in <strong>di</strong>minuzione rispetto al 2008 (17.071 tonnellate) e soprattutto rispetto<br />
al 2007 (24.496 tonnellate)<br />
La quantità <strong>di</strong> rifiuti destinata al recupero è data dalla somma <strong>del</strong>le quantità <strong>del</strong>la frazione organica, sud<strong>di</strong>visa<br />
nelle due categorie definite scarto alimentare e scarto verde, <strong>del</strong>la carta/cartone, <strong>del</strong> vetro e <strong>del</strong>la plastica, nel<br />
2009 è stata pari a 7.430 tonnellate in crescita rispetto al 2008 (6.962 tonnellate) e soprattutto al 2007 (2.393<br />
tonnellate)<br />
E’ evidente il progressivo ri<strong>di</strong>mensionamento <strong>del</strong>l’uso <strong>del</strong>la <strong>di</strong>scarica a favore degli impianti <strong>di</strong> recupero.<br />
Si evidenzia che nel <strong>territorio</strong> comunale non sono presenti impianti <strong>di</strong> trattamento <strong>del</strong> <strong>di</strong>fferenziato.<br />
- <strong>Analisi</strong> swot<br />
PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA OPPORTUNITA’ RISCHI<br />
- Presenza <strong>di</strong> un -Difficoltà a stimare la - Miglioramento <strong>del</strong>le<br />
ecocentro operativo e <strong>di</strong> produzione pro-capite prestazioni ambientali<br />
un altro in progetto dei rifiuti.<br />
<strong>del</strong> sistema <strong>di</strong> gestione<br />
- Ri<strong>di</strong>mensionamento<br />
dei rifiuti attraverso<br />
<strong>del</strong>lo smaltimento in<br />
la contrazione dei<br />
<strong>di</strong>scarica a favore <strong>del</strong><br />
trasporti e l’aumento dei<br />
recupero<br />
quantitativi <strong>di</strong> materiali<br />
recuperati.<br />
- In<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong><br />
localizzazioni e<br />
accorgimenti che
- <strong>Analisi</strong> quantitativa e qualitativa: gli in<strong>di</strong>catori<br />
Pressione<br />
Stato<br />
Risposta<br />
Legenda:<br />
fenomeno in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> stabilità<br />
fenomeno in <strong>di</strong>minuzione/miglioramento<br />
fenomeno in aumento/peggioramento<br />
☺ positivo<br />
incerto<br />
negativo<br />
consentano il<br />
contenimento <strong>del</strong>le<br />
ricadute ambientali <strong>del</strong>le<br />
azioni <strong>del</strong> Piano con<br />
conseguente<br />
<strong>di</strong>stribuzione dei carichi<br />
ambientali<br />
Giu<strong>di</strong>zio sintetico componente:<br />
☺ Buono<br />
In<strong>di</strong>catore Unità <strong>di</strong> Valore Giu<strong>di</strong>zio<br />
Trend<br />
misura<br />
sintetico<br />
Produzione rifiuti kg/mese Tab_2.1.3/b ☺ <br />
urbani (su base<br />
mensile anno 2009)<br />
Produzione rifiuti Kg/mese Tab_2.1.3/d ☺ <br />
urbani per singola<br />
tipologia <strong>di</strong> rifiuti (su<br />
base<br />
2009)<br />
mensile anno<br />
Rifiuti destinati a t/a<br />
7.430 ☺ <br />
impianti <strong>di</strong> recupero<br />
anno 2009<br />
Rifiuti destinati a t/a 16.914 ☺ <br />
impianti <strong>di</strong> smaltimento<br />
anno 2009<br />
Sistema <strong>di</strong> raccolta<br />
Porta a porta<br />
e cassonetto<br />
Porta a porta e<br />
cassonetto<br />
☺ <br />
Presenza<br />
ecologiche<br />
<strong>di</strong> isole si/no si ☺ <br />
Impianti <strong>di</strong> trattamento<br />
smaltimento dei rifiuti<br />
n. e t/a<br />
0<br />
si/no si/<br />
Adeuamento al Piano<br />
Regionale dei rifiuti<br />
- Cartografia e immagini<br />
Fig_2.1.3/a Produzione rifiuti: confronto 2007-2008-2009<br />
Fig_2.1.3/b Produzione RSU e RD: confronto 2007-2008-2009<br />
Tab_2.1.3/a Variazione percentuale rifiuti nel periodo 2007- 2009<br />
Fig_2.1.3/c Variazione percentuale produzione rifiuti urbani tra 2007 e 2008<br />
Tab_2.1.3/b Produzione dei rifiuti urbani nell’anno 2009<br />
Fig_2.1.3/d Produzione totale rifiuti anno 2009<br />
Fig_2.1.3/e Produzione RSU e RD anno 2009<br />
Tab_2.1.3/c Produzione dei rifiuti urbani nell’anno 2008<br />
Fig_2.1.3/f Produzione totale rifiuti anno 2008<br />
Fig_2.1.3/g Produzione RSU e RD anno 2008
Fig_2.1.3/h Produzione pro capite rifiuti urbani kg/ab/anno 2008<br />
Fig_2.1.3/i Produzione raccolta <strong>di</strong>fferenziata anno 2007 e 2008<br />
Fig_2.1.3/j Migliori risultati raccolta <strong>di</strong>fferenziata per fascia demografica 2008<br />
Fig_2.1.3/k Raccolta <strong>di</strong>fferenziata frazioni percentuali 2009<br />
Fig_2.1.3/l Andamento storico frazioni raccolte:confronto 2007-2009<br />
Fig_2.1.3/m Rapporti % tra le frazioni raccolte:confronto 2007-2009<br />
Tab_2.1.3/d Produzione dei rifiuti per singola tipologia anno 2009<br />
Tav_2.1.3/a Zone raccolta porta a porta <strong>del</strong> secco e <strong>del</strong>l’organico<br />
Tav_2.1.3/b Zone raccolta porta a porta carta e plastica a giorni alterni