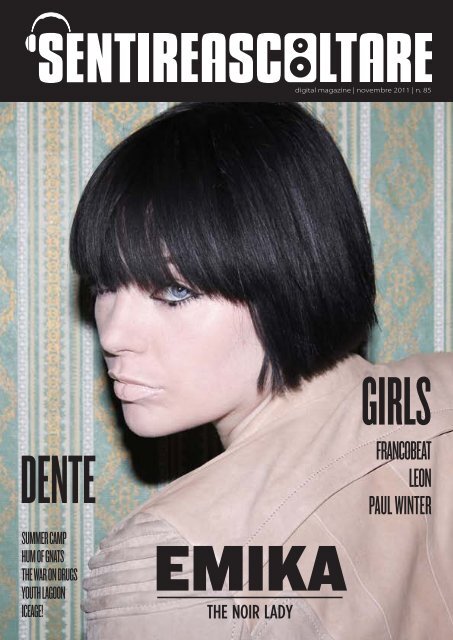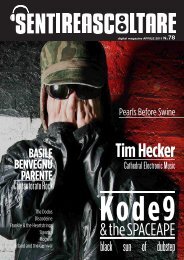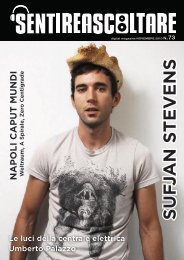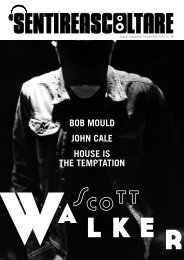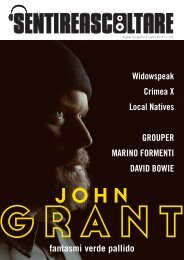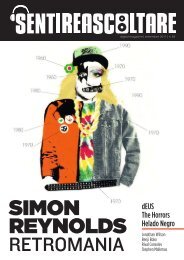francobeat Leon pauL winter - Sentireascoltare
francobeat Leon pauL winter - Sentireascoltare
francobeat Leon pauL winter - Sentireascoltare
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
dente<br />
summer camp<br />
hum of gnats<br />
the war on drugs<br />
youth Lagoon<br />
iceage!<br />
EMIKA<br />
the noir lady<br />
digital magazine | novembre 2011 | n. 85<br />
girls<br />
<strong>francobeat</strong><br />
<strong>Leon</strong><br />
<strong>pauL</strong> <strong>winter</strong>
p. 4<br />
p. 14<br />
p. 18<br />
Direttore: Edoardo Bridda<br />
Recensioni p. 42<br />
Gimme some inches » 96<br />
Re-Boot » 98<br />
Direttore responsabile: Antonello Comunale<br />
Ufficio stampa: Teresa Greco, Alberto Lepri<br />
coorDinamento: Gaspare Caliri<br />
progetto grafico e impaginazione: Nicolas Campagnari<br />
reDazione: Alberto Lepri, Andrea Simonetto, Antonello Comunale, Edoardo Bridda, Gabriele Marino,<br />
Gaspare Caliri, Marco Braggion, Nicolas Campagnari, Stefano Solventi, Stefano Pifferi, Teresa Greco,<br />
staff: Carlo Affatigato, Giulia Cavaliere, Fabrizio Zampighi, Nino Ciglio, Filippo Bordignon,<br />
Andrea Napoli, Diego Ballani, Marco Boscolo, Federica Venezia<br />
copertina: emika<br />
Turn On<br />
Summer Camp, Hum Of Gnats, The War On Drugs, Youth Lagoon, Iceage!<br />
Tune-In<br />
Francobeat, <strong>Leon</strong><br />
Drop Out<br />
Emika, Girls, Dente<br />
gUiDa spiritUale: Adriano Trauber (1966-2004)<br />
novembre N.85<br />
ReviewMirror » 101<br />
Campi magnetici » 110<br />
Classic album » 111<br />
SentireAscoltare online music magazine<br />
Registrazione Trib.BO N° 7590 del 28/10/05<br />
Editore: Edoardo Bridda<br />
Direttore responsabile: Antonello Comunale<br />
Provider NGI S.p.A.<br />
Copyright © 2009 Edoardo Bridda.<br />
Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale,<br />
in qualsiasi forma, su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo,<br />
è proibita senza autorizzazione scritta di SentireAscoltare
Summer<br />
Camp<br />
—Quando la nostalgia<br />
supera l’hipsteria—<br />
L'ennesima formazione nell'intorno<br />
60s. Dopo Best Coast, Vivian Girls e Avi<br />
Buffalo, è il turno della coppia Jeremy<br />
Warmsley-Elizabeth Sankley<br />
Turn-On.<br />
C’è tutto un mondo intorno a quello che si configura<br />
come l’ennesimo fenomeno anglofono capace di fare<br />
il filo a una molteplicità di spunti estetico-sonori. Stiamo<br />
parlando dei Summer Camp (vale a dire Jeremy<br />
Warmsley ed Elizabeth Sankley) di Welcome to Condale,<br />
una band che, dopo un lungo - e ormai consueto<br />
- corteggiamento fatto di singoloni ed EP, approda al<br />
debutto con un concept.<br />
Giochi infiniti di rimandi low fi, garage, post new romantic<br />
non possono non creare, nella mente degli affezionati<br />
poppers dell’ultima ora, facili rimandi ai surfers<br />
Best Coast, a Vivian Girls e ai più ricercati Avi Buffalo.<br />
Tuttavia, è bene dirlo, è soprattutto nelle sviolinate hipster<br />
di Bethany Cosentino e Bobb Bruno che i Summer<br />
Camp fanno rivoluzione, recuperandone alcune<br />
linee base (soprattutto vocali) per costruirci sopra una<br />
felice impalcatura psichedelica fatta di arrangiamenti<br />
tirati e nevrotici. Materiale in realtà molto più obscure<br />
punk di quanto il sound, spesso dolce nei tratti, possa<br />
farci credere.<br />
Ciò che permette alla band inglese di emergere è la<br />
scelta di far confluire ciò che oggi è sulla bocca, nelle<br />
orecchie e, soprattutto, negli abiti di tutti in un concept<br />
album che fa di un immaginario prettamente estetico e<br />
fintamente ideologico, uno spazio puro e sentimentale.<br />
Attraverso le vicende di due fanciulle che vivono tra gli<br />
anni Cinquanta e gli anni Ottanta nella fittizia città di<br />
Condale (tra feste amici e storie d’amore, come testimoniato<br />
dai video di Better off without you e Down) i Summer<br />
Camp vanno a riprenderci nel fondo di come eravamo,<br />
mostrandoci per quale motivo siamo tutti sedotti<br />
da ciò che sembra venire da lontano, da mondi emotivi<br />
non vissuti, da regni estetici solo accarezzati. Da quella<br />
che, insomma, Reynolds chiama Retromania. In poche<br />
parole la band ci regala un elogio nostalgico e personalizzato<br />
(un po’ come succede con i film di John Hughes,<br />
indiscusso idolo/ispiratore della band) di un’infanzia fatta<br />
di Fantàsia, di jeans a vita altissima e di capelli cotonati,<br />
spesa tra un Dallas e una puntata dei Ghostbusters.<br />
Il sound riesce a interpretare efficacemente l’afflato<br />
nostalgico e quel senso di perenne mancanza di un valido<br />
e alternativo ‘nuovo’, insieme all’isteria per un futuro<br />
incerto che ricorda un passato forse più dolce e colorato,<br />
tutto profumato di dolcetti e vhs sul tappeto. Prima che<br />
si andasse a rotoli, quando il consumismo per qualcuno<br />
era ancora una speranza e non una vorace e violenta<br />
realtà quotidiana.<br />
Rabbia e dolcezza (I want you), pop e sporcizia (Losing<br />
my mind, Down): tutto questo sono i Summer Camp.<br />
Capitolo numero-non-si-sa di un non necessario viaggio<br />
all’indietro abbastanza svogliato da non aver voglia di ricordarci<br />
dei Beach boys, ma a fuoco a sufficienza perchè<br />
il domani non basti.<br />
Giulia Cavaliere<br />
Hum<br />
Of Gnats<br />
—Tra cicaleccio di<br />
zanzare e scioglilingua<br />
metafisici—<br />
Hum Of Gnats è Ezio Piermattei, un<br />
altro solo-hero pronto a trafficare<br />
giocosamente con psych sfatta, field<br />
recordings, strumentazione acustica<br />
e analogica, attitudine free, ludica e<br />
ambizioni colte.<br />
4 5<br />
Turn-On.<br />
È un nerd, Ezio Piermattei. Non ce ne voglia il compositore<br />
pescarese; non vogliamo offenderlo, quanto far<br />
risaltare come la sua timidezza, il suo “escapismo”, il suo<br />
quasi imbarazzo nel rispondere alle interviste nascondano<br />
in realtà l’altra metà della sua personalità. Quella che<br />
lascia parlare in vece la sua musica. Anzi, le sue musiche.<br />
Se ora apprezziamo Hum Of Gnats, neanche un anno<br />
fa notavamo con piacere un altro suo lavoro a nome<br />
Poisucevamachenille: Scelsi quel nome perché leggendo<br />
un saggio sui “folli letterari” ero rimasto colpito da alcuni<br />
fenomeni molto comuni tra i pazienti schizofrenici, come<br />
verbigerazione e glossolalia. Mi incuriosii a tal punto che<br />
decisi di reincidere le parti vocali in una lingua “artificiale”,<br />
inventata su due piedi.<br />
Quella unica lunga traccia era una sorta di messa a fuoco<br />
di ciò che ora si mostra in Purge The Weevil From Yer<br />
Midst. Un caleidoscopio sonoro onnivoro eppure coeso,<br />
schizofrenico eppure pacificato che racchiude un universo<br />
di ascolti in espansione e in continua evoluzione:<br />
Ho cercato di ficcare dentro al disco tutto quello mi piaceva<br />
al momento: un po’ come fanno gli intrattenitori da pianobar<br />
che piazzano in scaletta Gloria Gaynor subito dopo<br />
The Final Countdown. Il tutto è presto detto: Residents,<br />
la Los Angeles Free Music Society, la scena di Canterbury,<br />
Sun City Girls, Caroliner, Peeesseye, Kemialliset Ystavat,<br />
Sunburned Hand Of The Man, Eric Copeland e mille altri<br />
ancora, perché come ci confessa “mi piaceva l’idea di<br />
registrare qualcosa di incredibilmente “slegato”, alla The<br />
Faust Tape”.<br />
Ragioni antropologiche dietro questo procedere onnivoro<br />
rimandano sicuramente agli ascolti bipolari<br />
dell’infanzia (In casa mi ritrovavo sia i dischi di musica<br />
bandistica di mio padre, che insegnava musica e dirigeva<br />
pure un’orchestrina, che i 45 giri di musica leggera di mia<br />
madre) oltre che ad un progressivo “oblomovismo” che,<br />
ci racconta, lo ha man mano fatto ritirare in un mondo<br />
circoscritto e in solitaria, fatto di ascolti tanto vari quanto<br />
incessanti e di una produzione musicale ad ampio<br />
spettro. Capace di metabolizzare in un flusso frammentato<br />
ma coerente, una quantità indescrivibile di input e<br />
schegge di suoni tra i più impensati; sovrapposti, stratificati,<br />
elaborati come dei frattali sonori pronti a schizzar<br />
via in ogni direzione.<br />
In realtà la mia musica è easy listening, anche quando è<br />
atonale. Detto da uno che inventa il moniker Hum Of<br />
Gnats per prendere in giro il proprio “tinnito””, fa un po’<br />
pensare. Ci sarà da fidarsi?<br />
Stefano Pifferi,
Youth<br />
Lagoon<br />
—Boise confidential—<br />
Ingenuità, stupore e una cameretta che<br />
suona come le montagne del North<br />
West: la profonda provincia di Youth<br />
Lagoon.<br />
Turn-On.<br />
Altri tempi quelli in cui l’urgenza di una vita acerba trovava<br />
sfogo nei strutture angolari del rock. Oggi una gioventù<br />
forse più consapevole, o forse narcotizzata dagli<br />
infiniti input (sub)culturali, trova più naturale produrre<br />
musica che funga da cassa di risonanza delle proprie<br />
ansie.<br />
Bedroom pop lo chiamiamo, perché è una poetica che<br />
nasce dalla sponda del letto fantasticando su quello che<br />
sta fuori. “Mi piace la distanza della mia musica” afferma<br />
Trevor Power, ventiduenne di Boise, Idaho, che raccoglie<br />
nel suo progetto le suggestioni del Pacific North West e<br />
le declina secondo le strutture aeree dei CocteauTwins.<br />
E’ bastato un brano come July, per segnalare il monicker<br />
Youth Lagoon fra quelli da monitorare con attenzione.<br />
Il tutto in virtù di un sound che incarna le coordinate<br />
dell’indie pop targato ‘10: melodie fragili, riverberi lunari,<br />
ingenuità a fiotti, pattern scomposti e grana lo-fi.<br />
Di suo Powers ci mette una fragilità emotiva che rispecchia<br />
la sua problematica sensibilità: “Ho lavorato a queste<br />
canzoni in uno dei momenti più difficili della mia vita. Stavo<br />
facendo sedute per curare i miei stati d’ansia, ma ho dovuto<br />
interromperle per risparmiare denaro per le registrazioni.<br />
Questo ha influenzato negativamente le mie relazioni affettive.”<br />
Un fascino misterioso, quindi, che nasce dalla natura<br />
terapeutica del suo primo lavoro The Year Of Hiberna-<br />
tion. “Realizzare la mia musica è qualcosa di cui non posso<br />
fare a meno. Ci sono tante cose che si accumulano dentro<br />
di me e questo è il mio modo di esternarle. Quindi non è<br />
errato affermare che questa per me è una specie di terapia.”<br />
I soldi per le registrazioni, racconta, li ha racimolati suonando<br />
la tastiera fino a notte fonda nei sobborghi di<br />
Boise. “I pezzi - ci tiene a precisare - sono stati concepiti<br />
nella mia camera da letto, ma sono stati registrati in un<br />
vero studio, con l’aiuto sporadico di qualche amico”.<br />
Ha fatto tutto (o quasi) da solo insomma. Sebbene ascoltando<br />
l’album, con quei suoni che si propagano in slow<br />
motion, i riverberi mesmerici di chitarra e pianoforte,<br />
sembra di trovarsi di fronte ad una vera e propria band.<br />
La voce di Powers, poi, così simile a quella del compianto<br />
Mark Linkous/Sparklehorse è in grado di far riaffiorare<br />
sentimenti che si credevano sopiti.<br />
Adesso è tempo di partire in tour. Ci sono date schedulate<br />
in mezzo mondo che lo attendono. “E’ successo<br />
tutto così velocemente - racconta incredulo - Pensa che<br />
non sono mai uscito dalla West Coast.”<br />
DieGo Ballani,<br />
Iceage!<br />
—Il nuovissimo<br />
post-punk made in<br />
Copenhagen—<br />
Mischiano Joy Division e Fucked Up,<br />
dark-wave e hardcore anni 90. Ecco<br />
come quattro teenager danesi fanno<br />
capitolare l’underground di mezzo<br />
mondo<br />
Pochi anni fa, nei primi Duemila, Copenhagen era nota,<br />
tra i pochi affezionati, come la città di una fervida scena<br />
punk i cui capostipiti erano band come Gorilla Angreb,<br />
Young Wasteners e No Hope For The Kids. Tutte<br />
riprendevano, chi in un modo chi nell’altro, il punk-rock<br />
e il primissimino hardcore californiano dando vita ad un<br />
manipolo di dischi brevi ed incendiari. Poi quei gruppi<br />
si sciolsero e dal freddo Nord giunsero solo i lavori dei<br />
colleghi Masshysteri, altrettanto efficaci ma indubbiamente<br />
più morbidi nei suoni e nell’approccio. Questo<br />
fino a pochi mesi fa quando, come una bomba carta, è<br />
esplosa una nuova sensazione tutta made in DK.<br />
Sì perché, out of the blue, i ragazzi di Copenhagen sono<br />
saliti all’onore delle cronache grazie ad album fulminante<br />
come New Brigade. Una dozzina di brani secchi,<br />
magnetici e nervosi come i teenager che li hanno composti,<br />
una scaletta che prende e fagocita Fucked Up e la<br />
wave britannica più scura, il post-punk dell’ultimo lustro<br />
e finanche le glorie dell’hardcore californiano anni Novanta<br />
(White Rune è la no wave al servizio del sing-along,<br />
in Total Drench sembrano i Joy Division tirati hardcore,<br />
in You’re Blessed è impossibile non sentire riecheggiare<br />
certe aperture à la Nofx).<br />
Tanto è bastato per far impazzire i blog e i forum del<br />
settore, portando diverse etichette a stampare e ristampare<br />
l’album sia in America che in Europa. E se Pitchfork<br />
li ha voluti in cartellone per l’omonimo festival che si<br />
terrà a Parigi il 29-29 Ottobre (insieme a Aphex Twin e<br />
Washed Out, per dire due nomi) è segno che i ragazzi<br />
danesi sono già riusciti a bucare la barriera dell’underground.<br />
Certo la repentina ribalta ha lanciato dubbi sulla<br />
street credibility del gruppo che, a detta dei più esigenti,<br />
sono solo l’ennesima posa del momento, ma di fronte<br />
alla micidiale irruenza di New Brigade c’è poco da obiettare.<br />
I nostri sapranno anche come attirare l’attenzione<br />
di un settore sempre più oberato di uscite e novità, ma<br />
la qualità dei pezzi non è in discussione.<br />
La veloce fama del quartetto è poi servita da cassa di risonanza<br />
per quella che è stata ribattezza (traendo spunto<br />
dal tatuaggio di uno dei componenti) la New Way of<br />
Danish Fuck You, ovvero una manipolo di oscure band<br />
dedite a suoni be più sporchi e ostici. Pensiamo a nomi<br />
come Sexdrome, Jackman, Pagan Youth e al loro noisepunk<br />
con spunti black-metal in salsa molto lo-fi. Etichette<br />
come Posh Isolation hanno già testimoniato in questo<br />
senso, ma la faccenda resterà cosa per pochi adepti date<br />
la chance - nulle - che hanno queste ultime band anche<br />
solo di sfiorare il grado d’attenzione mediatica che ha<br />
investito i loro, ben più indie, amici.<br />
anDrea naPoli,<br />
6 7<br />
Turn-On.
The War<br />
On Drugs<br />
—Americana revisited—<br />
Secondo disco per Adam Granduciel,<br />
il primo senza Kurt Vile: lo sguardo<br />
ancora sull’Americana, portandala a<br />
contatto con il kraut, senza dimenticare<br />
lo shoegaze<br />
Turn-On.<br />
Gente che va, gente che viene: le porte aperte di casa<br />
propria, che è anche un piccolo studio di registrazione,<br />
e un’attitudine a trovarsi in una costante condizione di<br />
equilibrio precario, sull’orlo di cadere o partire. Adam<br />
Granduciel ha nelle vene la passione per la musica degli<br />
States, per l’epica che si sono tramandate di menestrello<br />
in menestrello, di decade in decade. Si può così partire<br />
dagli ultimi eroi del genere, quegli Arcade Fire che dal<br />
Canada hanno incendiato l’indie mondiale. E i primi passi<br />
verso il passato sono facili, si tocca il Bruce Springsteen<br />
di Born To Run e di The River, roba che il Granduciel<br />
ragazzino trovava spacciata in casa direttamente dai familiari,<br />
che gradivano e mescolavano con Bob Dylan,<br />
Neil Young, Tom Petty.<br />
E’ solo con la maggior età che questo retroterra culturale,<br />
però, diviene cosciente, autonomo, e si incista su<br />
ascolti personali, come i My Bloody Valentine. Il tutto<br />
culmina nel 2003, quando - raccontano le versioni ufficiali<br />
- a un party molto alcolico avviene l’incontro con<br />
Kurt Vile. Si cazzeggia insieme, si scribacchia per un paio<br />
di anni, fincheé si mette da parte abbastanza materiale<br />
per far davvero nascere una band vera e propria: The<br />
War On Drugs. Il tempo di trovare chi coprisse il resto<br />
della formazione ed è già EP, Barrel Of Batteries (2007).<br />
A sentire le recenti dichiarazioni di Granduciel stesso, i<br />
due non hanno mai veramente scritto a quattro mani,<br />
ma si limitavano (e continuano a limitarsi) a consigliarsi<br />
l’un l’altro su come migliorare le idee che venivano portate<br />
alle prove. Un sodalizio di stima, quindi, un’affinità<br />
di intenti, ma non elettiva, non uno di quegli incontri<br />
che fanno diventare due entità una sola carne: diamo il<br />
massimo l’uno nei pezzi dell’altro con la chitarra, con la<br />
voce, con gli arrangiamenti, ma non chiedeteci le nozze.<br />
Il primo vero disco, Wagonwheel Blues è del 2008. Un<br />
album che mette in evidenza in maniera esemplare le<br />
due anime, quella della tradizione e quella della contemporaneità:<br />
un equilibrio precario, col baricentro sempre<br />
al limite, in cui le chitarre sono protagoniste via lo shoegaze<br />
MBV, assieme a liriche ingorde che forse lo appesantiscono<br />
un po’, ma resituiscono la freschezza e l’energia<br />
di una band appena nata. Le ingenuità dell’esordio,<br />
a sentire Granduciel ora, sono tutte da imputare alla<br />
fretta di far uscire il disco. Insomma: si erano finiti i soldi<br />
per registrare, ma il disco era ancora tutto da limare, da<br />
smussare e levigare. C’era la voglia di continuare a sperimentare<br />
con le registrazioni, con la post-produzione, ma<br />
quando la cassa è vuota... Il ritorno sul registrato diviene<br />
però un’operazione costante, un continuo rimaneggiare<br />
i singoli nastri, i singoli samples che da allora diventa il<br />
modus operandi di Granduciel e la sua personale ossessione.<br />
E se nulla è definitivo nella musica, sempre in cerca di<br />
un rotta da tenere, figuriamoci nella gestione della band.<br />
La fine del 2008 segna anche la separazione da Kurt Vile,<br />
che formerà i Vibrators e si incamminerà per una carriera<br />
solista che lo porterà a una non piccola notorietà.<br />
Granduciel si tiene il marchio e il progetto, che inizia,<br />
anzi non ha mai smesso di lavorare sul materiale registrato<br />
in casa. I due rimangono però in ottimi rapporti,<br />
tanto da condividere spesso serate (soprattutto nella<br />
loro hometown, Philadelphia) e continuare a scambiarsi<br />
consigli, quasi che le due anime che mai si erano davvero<br />
fuse, possano prendere tutta l’aria di cui hanno davvero<br />
bisogno.<br />
Coi i soldi messi in cascina dal primo disco, Granduciel<br />
può permettersi attrezzature per la registrazione che<br />
rendono la sua casetta un luogo che seppure nella sua<br />
fissità è testimone di un continuo mutamento: gente entra,<br />
incide un giro di basso, lavora a un brano, Granduciel<br />
ringrazia e prende questo materiale per continuare<br />
a sperimentare quello che i nuovi giochini domestici gli<br />
permettono di fare. Per oltre due anni, almeno a sentire<br />
le sue dichiarazioni più recenti (ma si sa che a posteriori<br />
è facile costruire una mitologia domestica priva di testimoni),<br />
è un lavoro di taglia e cuci che procede parallelamente<br />
alla scrittura. E’ un continuo arrovellarsi attorno<br />
alle passioni di sempre: l’Americana, le chitarre celesti dei<br />
MBV. Ma questo continuo ritornare sulle cose amplifica<br />
lo iato psichedelico che la musica di Granduciel sta respirando<br />
sempre più profondamente. La tecnologia gli<br />
permette di liberare la sua fantasia in direzioni nuove,<br />
che toccano aspetti cosmici e krauti.<br />
In pubblico le prime avvisaglie si hanno con l’EP Future<br />
Weather (6.8), tra l’altro disponibile acquistando la deluxe<br />
edition dell’ultimo disco. Fin dal titolo l’ambient(e) del<br />
tempo meteorologico, ma anche della psichedelia più<br />
compenetrata al folk e al rock, si fonde con un’elettronica<br />
idea di futuro: il contemporaneo applicato alla tradizione.<br />
Il compimento si ha con l’ultimo Slave Ambient<br />
(anche qui, con un titolo significativo) con una rilettura<br />
dell’epica Americana con gli occhi traslucidi del kraut,<br />
di tappeti sintetici che evocano spazi oscuri e illuminazioni<br />
improvvise. Droni serpeggiano in una meccanica,<br />
motoristica Original Slave, con un’armonica che si perde<br />
nel fondo elettronico. La notturna Best Night ha chitarre<br />
liquide e un magico equilibrio vocale che ricorda Jeff<br />
Tweedy e Tom Petty. City Reprise è il ponte con lo shoegaze<br />
e la psichedelia. Baby Missiles è la un guanto di sfida<br />
agli Arcade Fire, mentre la cavalcata Your Love Is Calling<br />
My Name è lo sconfinamento cosmico che però - e non<br />
potrebbe essere altrimenti - viene riportato sempre a<br />
terra.<br />
Qualcuno ha già storto il naso di fronte alla proposta di<br />
Adam Granduciel, come di chi non ha trovato ancora la<br />
quadratura compositiva, una vera rotta personale. Ma<br />
Slave Ambient mostra un interessante terreno di contatto<br />
tra la tradizione, la contemporaneità filtrata shoegaze<br />
e uno sguardo retrofuturistico dato dall’elettronica.<br />
In tempi di scarse rivoluzione, di un post-moderno che<br />
oramai è più che altro postumo, già il gusto di ricercare<br />
timbriche, atmosfere e ambiance infondendo vigore in<br />
quel passato americano cui molti sembrano incapaci<br />
di sfuggire non è cosa da buttare via o lasciar passare<br />
inosservata.<br />
MarCo BoSColo,<br />
8 9
Tune-In.<br />
Testo: Carlo Affatigato<br />
Se l’avete conosciuto in occasione dell’esibizione alla serata<br />
conclusiva del roBOt Festival 2011, significa che vi<br />
siete persi il successo che il nostrano <strong>Leon</strong> sta ottenendo<br />
fuori dai confini italiani, coi club di mezza Europa che<br />
se lo contendono, intere folle in visibilio (vedi il ritorno<br />
ricevuto in occasione del Winter Music Conference 2011)<br />
e autorità come Ricardo Villalobos, Danny Tenaglia e<br />
Laurent Garnier che pescano le sue hit per le notti in<br />
pista. Poco male, in ogni caso, perché alla saletta di Palazzo<br />
Re Enzo avete potuto assistere alla quintessenza<br />
del <strong>Leon</strong> dj: tech-house disinvolta dalla presa facilissima,<br />
che punta dritto al pubblico evitando di far troppo<br />
i sofisticati.<br />
Cassa in quattro vigorosa, irrinunciabili claps della più<br />
classica tradizione 90s, nessun bisogno di pause defaticanti<br />
e tutti i decibel di cui l’impianto audio è capace<br />
per innalzare la temperatura: sembra quasi una ricetta<br />
alla portata di tutti, ma son pochi ad avere l’abilità di<br />
proporla senza cedere alla monotonia stancando così<br />
il pubblico. Ci vuole un certo mestiere per tenere sempre<br />
su di giri la folla, captare i suoi bisogni e spingerla lì<br />
dove vuole andare. È per questo che stiamo aspettando<br />
trepidanti che da quel di Londra esploda su album una<br />
certa Maya Jane Coles, tra i giovani più promettenti<br />
del momento, ma chissà, forse la nuova stella dei 4/4 la<br />
<strong>Leon</strong><br />
—In Da Club #4—<br />
Vincente per acclamazione nei club di mezzo mondo, apprezzatissimo da producers<br />
e riviste e lanciato verso la consacrazione dell’album lungo: sarà l’Italia a partorire<br />
la prossima stella dei 4/4?<br />
partorirà proprio l’Italia nei prossimi mesi. Tra un argomento<br />
e l’altro, <strong>Leon</strong> ci dice: “Faccio molto uso dei loops.<br />
Se li dosi nel modo giusto in un pezzo house, fanno faville”.<br />
E la mente subito torna a quei Tiger & Woods emersi<br />
proprio quest’anno con Through The Green, che sui loop<br />
vocali presi dall’estetica disco d’antan han costruito i loro<br />
pezzi più efficaci. E guarda caso, anche dietro all’identità<br />
nascosta del duo tigrato sembra far capolino una colonna<br />
del djing tricolore come Marco Passarani (sono solo<br />
indiscrezioni, però...).<br />
Bel tipino, <strong>Leon</strong>. Ambizioso e cosciente dei propri mezzi,<br />
con una base consolidata di ascolti elettronici a coprire<br />
l’intero spettro. “Mi piace tutta l’elettronica, non solo quella<br />
più orientata al club. Tra i miei preferiti direi Kraftwerk,<br />
Giorgio Moroder, Depeche Mode, Daft Punk, Underworld,<br />
Chemical Brothers, Massive Attack, Groove<br />
Armada, Bent, Aphex Twin, Goldie...”. Non manca nulla,<br />
insomma. Tutti serbatoi dai quali attingere quando<br />
serve un po’ di eclettismo, attrezzi del mestiere che ti<br />
danno quel quid in più per essere imbattibile. E infatti<br />
si finisce per riaprire giocoforza la ferita dolorosa della<br />
mancanza di prospettive del nostro paese, questione già<br />
battuta durante la chiacchierata con Deep88, un altro<br />
astro nascente italico (all’estero, ovvio). <strong>Leon</strong> ci conferma<br />
un quadro italiano che anche in ambito musicale non<br />
10 11
lascia spazio ai giovani: “L’underground italico è pieno di<br />
produttori molto validi, dall’estero moltissime labels mandano<br />
richieste ai nostri producers fiutando i talenti. Ecco<br />
cosa spinge molti ragazzi ad andar via dal nostro paese: il<br />
sistema qui segue sempre lo stesso schema, punta sull’artista<br />
straniero per esser sicuro che la serata riesca. Nel frattempo<br />
però i nostri ragazzi all’estero sono apprezzatissimi,<br />
e non trovano spazio per suonare qui. È una cosa assurda.”<br />
C’è una via d’uscita? Anche stavolta la soluzione definitiva<br />
sembra non esserci. Ma se ogni rivoluzione ha inizio<br />
nel cambiare la mentalità dalla base e distruggere i luoghi<br />
comuni, allora sono anche approfondimenti come<br />
questo a dare il loro piccolo contributo, distruggendo<br />
con prove incontrovertibili il castello di carta che vede<br />
l’artista straniero come qualitativamente superiore a<br />
quello italiano. Realtà come <strong>Leon</strong>, che infatti all’estero<br />
fan favillle, ci dicono che è stupido pensare in termini di<br />
inferiorità: ogni luogo produce realtà artistiche uniche<br />
rispetto alle altre, il segreto sta nel valorizzarne le peculiarità<br />
stilistiche, dare al talento lo spazio che merita.<br />
All’estero la qualità conta più del nome, e l’entusiasmo<br />
si spende tanto per le realtà locali quanto per quelle importate.<br />
È così difficile non cadere nel pregiudizio quando<br />
si parla di made in Italy?<br />
In ogni caso, il futuro per <strong>Leon</strong> promette bene. Come ci<br />
ha spiegato nell’intervista, l’album di debutto è quasi<br />
pronto, e ci son tutti i presupposti perché non sia il solito<br />
album dance. Il nostro ragazzo ha il piglio da primo<br />
della classe, non si accontenta di far “bene”, vuol sempre<br />
battere ogni aspettativa. E non ha paura delle sfide<br />
più improbabili, come testimonia l’iniziativa che lo ha<br />
visto coinvolto nelle ore immediatamente precedenti al<br />
live a Bologna: un progetto mediatico che ha coinvolto<br />
i principali social network del web per creare un contatto<br />
diretto tra i fan e l’artista nella sua vita quotidiana. Sicuramente<br />
sentirete ancora parlare di <strong>Leon</strong>. Nel frattempo,<br />
ecco l’occasione per sentire direttamente le sue parole,<br />
nella nostra intervista esclusiva. Buona lettura.<br />
È probabile che la maggior parte del pubblico italiano<br />
ti conosca soprattutto grazie alla tua partecipazione<br />
al roBOt festival. Dicci come hai vissuto<br />
quell’esperienza e che tipo di ritorno hai ricevuto<br />
dal pubblico di Bologna.<br />
L’esperienza al roBOt festival è stata incredibilmente<br />
emozionante. La cosa che mi spaventava di più era l’orario:<br />
di solito le mie performances sono notturne, non era<br />
semplice ricevere il massimo supporto dal pubblico con<br />
un dj-set a base techno prima di cena. E invece è andato<br />
tutto a meraviglia, ho voluto proporre un set diverso dal<br />
mio solito, più contaminato, a tratti abbastanza “sporco”<br />
e la folla era impazzita, erano tutti scatenati, urlavano...<br />
è stato bellissimo! Il che è ancora più soddisfacente se<br />
pensiamo che il roBOt è uno dei festival più importanti<br />
e conosciuti d’Italia e ha un pubblico molto preparato<br />
ed esigente.<br />
La location, poi, era qualcosa di magico. Bologna è sempre<br />
stata una città “alternativa”, anti-moda, più underground<br />
rispetto alle altre. Era perfetta.<br />
Possiamo dire che sei uno di quei talenti italiani di<br />
cui andare orgogliosi per quanto risultano apprezzati<br />
all’estero. Che differenze ci sono tra suonare in<br />
Italia o fuori? Cosa preferisci?<br />
Ultimamente preferisco suonare in Italia. La gente è più<br />
calda, e col passare del tempo inizia a sembrarmi anche<br />
più preparata. Certo, ci sono luoghi come Inghilterra e<br />
Germania che sotto certi punti di vista stanno avanti<br />
rispetto a noi, ma sono convinto che la situazione elettronica<br />
italiana sia in forte crescita e stia raggiungendo<br />
ottimi livelli, soprattutto in ambito techno/house.<br />
Domanda scontata ma obbligata: c’è qualcuno in<br />
particolare a cui ti ispiri?<br />
I nomi sarebbero tantissimi, colleziono vinili dal 1995,<br />
ho visto migliaia di dj. Tra i tanti citerei per primo Danny<br />
Tenaglia, uno dei miei punti di riferimento, quasi un<br />
maestro di vita se vogliamo. Poi tantissimi altri: Laurent<br />
Garnier, Masters At Work, Richie Hawtin, Ricardo Villalobos,<br />
Steve Lawler, Jeff Mills, Carl Cox, Sasha, DJ<br />
Sneak, Carl Craig, Marco Carola... e l’italianissimo Ralf,<br />
se non ci fosse stato lui forse non sarei nemmeno qui!<br />
Al festival bolognese eri in una stanzetta abbastanza<br />
contenuta in cima al palazzo Re Enzo, per un paio<br />
d’ore di tech-house for the masses, ossia senza troppi<br />
intellettualismi: giusto un tocco all’equalizzazione<br />
per sottolineare i bassi deep e via di claps dritti e<br />
4/4 a volumi altissimi. È questa la tua ricetta anche<br />
all’estero?<br />
Potrebbe essere in effetti la mia ricetta ideale, sì. Preferisco<br />
suonare in posti piccoli, dove riesci a guardare tutti<br />
dritto in faccia. Piccoli clubs con super soundsystem,<br />
spaziosa consolle, poche luci ma tanto vibe...<br />
Suonare nei festival se vogliamo è più facile, hai davanti<br />
una massa, sono poco esigenti, puoi permetterti di suonare<br />
anche per te stesso. Ma questa non è la mia idea<br />
di dj. Il dj è quello che mette il disco giusto al momento<br />
giusto, è il primo cliente del club. Deve sapere cosa vuole<br />
la sua gente, come farti dimenticare i problemi, deve<br />
essere cosciente che è lui il responsabile del tuo piacere<br />
in quella notte! Quindi deve dare sempre il massimo, sia<br />
davanti a 100 sia davanti a 10 mila persone!<br />
Esiste un pubblico più esigente di un altro? O in definitiva<br />
se una ricetta funziona, funziona ovunque?<br />
Eh eh, molti usano la formula “se la ricetta funziona non si<br />
cambia”. Ma perché limitarsi? Il bello della musica è che<br />
appunto ti dà la possibilità di variare. Se la gente che<br />
ti segue si rende conto che proponi sempre lo stesso<br />
alla fine non ti seguirà più, è assolutamente normale.<br />
Qualsiasi dj invece potrebbe suonare ogni volta un dj-set<br />
diverso dal precedente, e sicuramente essere più apprezzato<br />
dal pubblico. Il mio dj-set al roBOt, ad esempio, è la<br />
testimonianza di quanto mi piaccia spaziare: dalla deep<br />
house alla techno, dalla drum’n’bass a... Bob Marley! Se<br />
c’è il groove, perché no?<br />
Dopo una serie di ep rilasciati negli ultimi due anni,<br />
adesso sta per avvicinarsi il momento dell’esordio su<br />
album. Cosa hai in mente per il disco? Come suonerà?<br />
L’album è quasi pronto. Ci sto lavorando da circa un<br />
anno, stiamo decidendo col mio management quando<br />
rilasciarlo, probabilmente per il prossimo WMC a Miami.<br />
Di tracce ne ho scritte tante, forse più di 20. Stiamo scegliendo<br />
le migliori, ma vorrei anche mettere nel mio album<br />
qualcosa di insolito. Magari tutti si aspettano da me<br />
un album “duro”, da dancefloor, con tanta techno-house.<br />
Sicuramente sarà così, ma non solo: ho preparato tracks<br />
anche più ambient, più soft, più noise anche e qualcosa<br />
funky e dubstep!<br />
Ci sto lavorando molto, l’album per un artista è la cosa<br />
più importante. Ci saranno anche alcune collaborazioni<br />
con artisti amici, e ovviamente sarà tutto seguito da un<br />
tour mondiale dove forse per la prima volta farò dei “live”<br />
veri e propri! Il che per me è una scommessa, perché in<br />
fondo mi sento sempre un dj.<br />
Come riesci a dividerti tra la house che finisce sui<br />
piatti, per la pista, e quella che va su disco per l’ascolto?<br />
Pensiamo a release come il Like This EP o il Fiore EP,<br />
fatti di tech-house muscolare farcita di loop vocali a<br />
rendere plateale la circolarità della dance. Hai due<br />
modalità d’approccio differenti?<br />
Sì, il lavoro in studio e quello in pista sono completamente<br />
differenti. In studio ci entro solo quando sono ispirato,<br />
in caso contrario potrei anche non metterci piede per<br />
mesi. E quando hai l’ispirazione le tracce vengono fuori<br />
in poche ore: pezzi come Like This Like That, Fiore, Body<br />
Monster sono venuti fuori così, rapidamente. Magari il<br />
lampo mi viene nei momenti più disparati della giornata,<br />
quando sono in macchina, al ristorante, in aereo...<br />
prendo qualche appunto su un foglio o sul cellulare, poi<br />
torno a casa e butto tutto sul sequencer.<br />
Per la pista invece pensi in maniera differente. Magari<br />
ci metti dentro la hit del momento, oppure no. Bisogna<br />
orientarsi verso quello che vuole il pubblico. Quando<br />
sono in studio invece tengo sempre presente che quello<br />
che faccio dovrà rappresentarmi al 100%, in modo che<br />
anche a distanza di anni, quando qualcuno sentirà il disco<br />
ci troverà dentro il MIO carattere, non quello della<br />
folla.<br />
Per le ore immediatamente precedenti al tuo live al<br />
roBOt è stato messo in piedi un interessante progetto<br />
multimediale, in cui le tue mosse venivano seguite<br />
su social network come Facebook, Youtube, Twitter e<br />
Foursquare in modo da creare un canale comunicativo<br />
bidirezionale tra te e i fan che ti seguivano. Una<br />
sorta di grande fratello per il web 2.0. Ce ne parli?<br />
È stata un’esperienza molto eccitante. Ho vissuto fuori<br />
per due giorni, 60 ore di registrazione con più di tre<br />
macchine, un’ora di intervista, diversi meeting con altri<br />
artisti e promoter, fino ad arrivare alla performance. A<br />
tratti è stato anche stressante, ma ho conosciuto un sacco<br />
di persone interessanti, ho avuto un buon riscontro<br />
sul web.<br />
E poi diciamolo, canali come facebook, twitter, ecc. sono<br />
sempre più importanti per la promozione e per ricevere<br />
riscontri diretti. È un ottimo mezzo, soprattutto se pensi<br />
che ormai praticamente tutti sono connessi tramite questi<br />
social network. Penso sia una grossa opportunità, con<br />
cui poter instaurare un rapporto intimo con i fan. Chissà,<br />
magari sarà ripresa da altri artisti in futuro...<br />
12 13
Tune-In.<br />
14<br />
Testo: Fabrizio Zampighi<br />
Francobeat<br />
Musicista originale, beat per caso, rivoluzionario armato<br />
di manopole, bottoni e una creatività difficilmente codificabile,<br />
Franco Naddei torna con un disco-libro tratto da<br />
Grammatica della fantasia di Gianni Rodari. Una sana e<br />
volontaria de-evoluzione verso la narrativa per bambini<br />
che nelle mani del musicista romagnolo diventa una<br />
ricetta contro il conformismo dell’età adulta. Il concetto<br />
di “gioco” mescolato a quelli di “musica” e “parole”, insomma,<br />
tanto per riaffermare ancora una volta la propria indole<br />
di artista acuto e versatile (tra i vari progetti anche<br />
gli ottimi Santo Barbaro) e aggiungere un nuovo tassello<br />
a quel “pop da biblioteca” inaugurato cinque anni fa col<br />
disco d’esordio Vedo Beat.<br />
Cos’è e come nasce il progetto Mondo Fantastico?<br />
Mondo fantastico è un libro di scritti originali, illustrati ad<br />
hoc, che ha tratto ispirazione da Grammatica della fantasia<br />
di Gianni Rodari. Un piccolo opuscoletto quest’ultimo,<br />
in cui lo scrittore di Omegna ci rivela alcuni trucchetti<br />
su come affrontare la scrittura e su come attivare un<br />
vero e proprio “Codice di Avviamento Fantastico” da cui<br />
partire per inventare storie, mondi, filastrocche, giochi<br />
di parole.Il CD in sè è cosa ormai superata, si sa, per cui<br />
l’idea del libro era a monte di tutto e le musiche sono<br />
diventate una specie di corollario. Una volta compreso<br />
quanto fosse difficile poter stampare i testi di Rodari, mi<br />
sono rivolto a Vanessa Sorrentino, scrittrice e coordinatri-<br />
—Elogio della creatività—<br />
Torna Francobeat con il suo “pop da biblioteca” al solito surreale e questa volta<br />
dedicato all’opera di Gianni Rodari<br />
ce di Artincanti, con la quale ho cominciato a ragionare<br />
sui contenuti del libro. Ne è nata una collettiva di scrittori<br />
e illustratori che hanno agito nelle loro arti ispirandosi<br />
alla “Grammatica” di Rodari. Nel libro ci sono racconti<br />
brevi, filastrocche e una piccola parte interattiva con alcuni<br />
giochi per poter allenare la fantasia.L’idea del disco<br />
nasce subito dopo l’uscita di Vedo Beat per Snowdonia<br />
nel 2006. Volevo proseguire il viaggio nell’esplorazione<br />
del concetto di libertà espressiva, di pensiero, di azione<br />
e soprattutto farlo in una dimensione di gioco. Prima<br />
di affrontare un disco mi faccio sempre sbattere addosso<br />
qualche libro e, se qualcuno colpisce nel segno, mi<br />
faccio contagiare. La gestazione è stata piuttosto lunga.<br />
Inizialmente volevo fare un lavoro un po’ presuntuoso<br />
che spiegasse come lentamente si perda la dimensione<br />
del gioco, della leggerezza e del pensiero libero, fino a<br />
diventare adulti con un pensiero fin troppo strutturato.<br />
Ho cercato libri che tentassero di spiegare come si forma<br />
il pensiero nei bambini e come si modifichi a seconda<br />
dell’ambiente in cui crescono, delle situazioni che vivono.<br />
Ho fatto scoperte interessantissime, ma che dovevo<br />
canalizzare in un unico sentiero percorribile sia dai grandi<br />
che dai piccini.<br />
Perché Gianni Rodari?<br />
Per la semplicità e la forza delle parole che usa. Rodari<br />
è stato a tutti gli effetti un intellettuale chiave nella<br />
15
letteratura italiana, troppo spesso confinato al ruolo di<br />
scrittore per bambini. Quando ho cominciato a leggere<br />
con attenzione le sue opere, dalle filastrocche, agli articoli<br />
di giornale, fino alle considerazioni contenute nella<br />
“Grammatica” l’ho sentito molto “beat”. Quell’irruenza<br />
della beat generation italiana l’ho sempre ricondotta<br />
all’ingenuità, tanto da pensare che se di guerra al sistema<br />
si deve trattare, allora tanto vale farla utilizzando l’ingenuità<br />
dei bambini. Per dire cose profonde non sempre<br />
occorrono parole complicate. Rodari parla di cose<br />
rivoluzionarie, racconta di mondi impossibili e ne crea di<br />
nuovi con una eleganza e un’autorevolezza tutta adulta.<br />
Riuscendo però a essere semplice, lineare e limpido<br />
com’è lo scrivere dei bambini. La sua chiara propensione<br />
al surreale ha toccato le mie corde di “cantautore”.Nel disco<br />
solo un brano è scritto di mio pugno ed è l’unico che<br />
mi son sentito di accostare agli altri. Tra l’altro è un brano<br />
dove parlo proprio di come crescendo i pensieri facciano<br />
troppa strada, complicandoci la vita. Ad ispirarmi è stato<br />
un testo meraviglioso (La parola ciao) contenuto nella<br />
“Grammatica” e scritto da un bimbo di 5 anni.<br />
Com’è per un musicista cimentarsi con testi come<br />
quelli di Rodari e, più in generale, musicare testi non<br />
concepiti per essere cantati? Immagino che il pentagramma<br />
ne esca piuttosto influenzato. L’impressione<br />
è che nel tuo caso si sia privilegiato un approccio<br />
piuttosto narrativo su una musica libera di spaziare...<br />
Musicare Rodari è stato un gioco bello e coinvolgente.<br />
In questo disco ho voluto riprendere le mie doti di arrangiatore<br />
e giocare con gli strumenti e coi suoni, così<br />
come Rodari giocava con le parole. I testi originali erano<br />
talmente belli che volevo rimanessero chiari e non<br />
soffocati in virtuosismi inutili. Testi che poi alla fine si<br />
sono fatti scegliere da soli. Dal punto di vista musicale<br />
non mi sono imposto limiti e ho visto nascere le canzoni<br />
spontaneamente. Poi le filastrocche di Rodari, oltre<br />
che esteticamente, sono “numericamente” perfette.In<br />
Vedo Beat è stato diverso. Lì c’erano anche pezzi miei e il<br />
materiale tratto dal libro è stato trattato come un unico<br />
radiodramma (citazione dei Mariposa). E’ la prima volta<br />
che canto in senso stretto materiale di qualcun altro.<br />
Grammatica della Fantasia e in generale l’opera di Rodari<br />
viene comunemente associata al mondo dell’infanzia.<br />
Che influenza ha avuto sulla scrittura del disco<br />
- se ne ha avuta - questa considerazione?<br />
In realtà ho fatto subito mio il concetto, anch’esso rodariano,<br />
di non trattare i bambini da bambini. Che la musica<br />
per bambini debba avere determinate caratteristiche<br />
lo decidiamo noi adulti. E’ ovvio che una canzone di tre<br />
accordi maggiori e con un testo di venti parole sia più<br />
indicata per un bambino, ma non è l’unica strada, se è<br />
vero che i bambini recepiscono le cose a modo loro, E’<br />
un concetto tutto da verificare il modo in cui i bambini<br />
si avvicinano a una parola, a un suono, magari a certe<br />
chitarre o a un clarinetto che ascoltano in un brano.<br />
Spero che si colga il gioco che c’è fra musica e parole. In<br />
fondo, da bravo provocatore-beat, l’idea che un CD del<br />
genere sia in un libro per bambini mi diverte molto. A<br />
mio figlio di quattro anni, ad esempio, piace. Alcune cose<br />
me le cita anche canticchiando le parti strumentali, oltre<br />
a ricordare alcuni testi. Spero che ci siano altri bimbi così.<br />
E’ un bel segno da lasciare. Un sasso gettato talmente<br />
lontano da non riuscire a vedere nemmeno dove cadrà.<br />
Come hai scelto i musicisti che suonano con te?<br />
Beh, io sono sulla piazza da ormai vent’anni anni e mi<br />
è capitato di fare tante cose con tanta gente. Con molti<br />
sono amico e posso dire che tutti quelli che han suonato<br />
nel disco sono persone con cui avevo già percorso un<br />
pezzetto della mia storia recente. Musicisti bravi, intelligenti<br />
e originali. Non è un disco di turnisti, insomma.<br />
Ho chiamato i musicisti a fare loro stessi e spero che si<br />
siano divertiti.Diego Sapignoli non si definisce neanche<br />
più batterista e se vedi il suo set dal vivo capisci perché,<br />
per esempio. Poi sicuramente volevo strumenti fiabeschi,<br />
per cui uno dei primi ad entrare in squadra è stato<br />
Achille Succi col suo clarinetto. I brani sono stati registrati<br />
con questo trio, con le mie avvisaglie elettroniche<br />
(sintetizzatori, batterie elettroniche vintage) e il mio chitarrismo<br />
inconsapevole a completare il quadro. Poi ho<br />
organizzato un paio di sessioni di improvvisazione proprio<br />
per istigare un processo di creazione istintiva, per<br />
giocare come bambini e vederne gli effetti. Con Fabrizio<br />
Tarroni, Christian Ravaglioli (oboe e duduk) e Diego,<br />
son venute fuori cose totalmente diverse e sempre in<br />
un clima di libertà. Si può dire che metà del disco sia<br />
nato così, con davvero poco editing e sovrincisioni. Un<br />
occhio ai suoni e uno all’intenzione, cosa rara nei dischi<br />
moderni dove forse si predilige la perfezione, soprattutto<br />
in ambito pop. Il disco si apre col pianoforte suonato<br />
da Guido Facchini, che ritengo un musicista incredibile<br />
per preparazione e sensibilità. Un artista che è riuscito a<br />
dare un tocco davvero sognante a un pezzo scritto dalle<br />
mie mani luride di musicista imperfetto.<br />
Come si inserisce nel percorso di Francobeat<br />
quest’opera?<br />
Il disco segue la linea del “pop da biblioteca”. A volte mi<br />
viene voglia di fare un disco con testi miei, ma credo<br />
che ci siano talmente tante cose belle già scritte e spesso<br />
poco conosciute, che ancora vale la pena tentare di<br />
buttarle in pasto a una canzone pop. Quelli della mia<br />
generazione Rodari lo conoscono tutti, ma molti giovani<br />
non sanno nemmeno chi sia. Il sottotitolo del libro “La<br />
grammatica della fantasia al tempo degli SMS” è nato<br />
pensando a quanta fantasia venga impiegata dai ragazzini<br />
per comunicare fra loro, fra faccine e simboli e acronimi<br />
vari. Se un po’ di quella creatività fosse incanalata<br />
anche per fare storie, filastrocche o mini fiabe sarebbe<br />
bello.Poi ormai sono entrato in una spirale che credo mi<br />
porterà almeno a finire quello che si prospetta essere la<br />
“Trilogia della fantasia” Il prossimo disco è già in macchina<br />
da un po’. Ci sono un paio di testi letti durante la<br />
preparazione di Mondo fantastico che non posso lasciar<br />
lì sullo scaffale.<br />
Sergio Endrigo ebbe la fortuna di collaborare con<br />
Rodari per il disco Ci vuole un fiore. Cosa pensi di quel<br />
progetto e in che cosa credi che si differenzi dal tuo?<br />
Rodari, Endrigo e Bacalov, mica bruscolini. Avevo il timore<br />
di un confronto, in primis con me stesso. Quel disco<br />
è fatto con intelligenza, classe e gusto. E se ci pensi il<br />
binomio Endrigo-leggerezza infantile parrebbe quasi<br />
azzardato. Eppure ne scaturì un disco curioso. Anche in<br />
quel caso non sono stati fatti sconti, la musica non è mai<br />
banale. E di certo non era intesa per bambini in assoluto,<br />
visto che era suonata da una vera orchestra nelle mani<br />
di un illustre arrangiatore. Se prendi l’incipit di Bambino<br />
di gesso, con quelle voci che si rincorrono e rimbalzano<br />
nell’eco a nastro, ci puoi sentire la psichedelia.Credo che<br />
il mio sia semplicemente influenzato dai suoni di oggi,<br />
dal mio background elettronico, ma trovo che l’onestà<br />
sia un elemento che accomuna i due dischi. Probabilmente<br />
i bambini stessi son cambiati e quel se sembra<br />
“per bambini” di quel disco forse non lo era quando usci<br />
nel 1974. E’ per questo che son convinto di molte scelte<br />
fatte. Credo che i bambini si sentano meno truffati con<br />
un disco come il mio rispetto a come potrebbero sentirsi<br />
ascoltando certe sigle di cartoni animati moderni. Una<br />
operazione simile, inoltre, fu fatta anche da Virgilio Savona<br />
e Lucia Mannucci del Quartetto Cetra nel ’73, con<br />
un intento totalmente diverso, direi più infantile.<br />
16 17
Emika<br />
Drop out<br />
Dai fumi urbani del trip-hop alla<br />
nuova impronta cantautoriale<br />
post-Blake: focus sulla dark-lady<br />
autrice di uno dei dischi più intensi<br />
dell’anno<br />
Testo: Carlo Affatigato<br />
—The noir lady—<br />
18 19
Il fatto che ora il nome di Emika sia sulla bocca di tutti, spottato sulle<br />
riviste cartacee e pubblicizzato sulle home page dei principali magazine<br />
online, non è solo merito del perfetto meccanismo promozionale messo in<br />
atto da una label come la Ninja Tune (che a tal riguardo ha pochi rivali, va<br />
detto). Il fatto è che l’album di debutto della nuova fiamma dark è arrivato<br />
proprio nel momento giusto: in un anno costellato di umori soul che si son<br />
spalmati a tappeto su tutti i generi, nel momento in cui la dub music sta<br />
scommettendo tutto sull’approccio cantautoriale, un ribollire che già in passato<br />
aveva mostrato la sua presenza con sporadiche scosse (basti pensare a<br />
Burial come padre spirituale dell’esplosione dub-soul di oggi). Il tappo però<br />
è stato definitivamente tolto con James Blake all’inizio dell’anno, portando<br />
il messaggio fino in fondo con un album-manifesto di questa nuova fase<br />
(chiamiamola post-dubstep o dub-soul, fa lo stesso) che ha staccato coraggiosamente<br />
con le proprie radici e ha tracciato la strada per le direzioni a<br />
venire (per conferme chiedere a gente come SBTRKT o Jamie Woon).<br />
L’album ve l’avevamo descritto prontamente come una delle tappe più<br />
importanti in questa direzione, e fa piacere scoprire direttamente con la<br />
sua autrice che ne avevamo centrato in pieno ogni risvolto. L’emozione è il<br />
baricentro su cui ruota l’intera faccenda, sbocciato lungo i binari prediletti<br />
del momento, quelli del songwriting. A differenza però dei nomi già fatti,<br />
Blake e Woon su tutti, il punto di partenza stavolta non è il dubstep: l’oscurità<br />
di Emika affonda nelle basi trip-hop di Bristol, la città in cui è artisticamente<br />
cresciuta, con un grande debito di riconoscenza verso la freddezza<br />
sofferente di Beth Gibbons e i suoi Portishead. The Long Goodbye e Count<br />
Backwards parlano chiaro, ci raccontano proprio un’evoluzione sonora che<br />
parte dalle melodie vaporose di Dummy per poi sfociare nella maggiore<br />
aggressività thrill di Third.<br />
L’oscurità. Il ‘noir’ mood, un’accezione che Emika ha trovato particolarmente<br />
azzeccata. È il suo tratto distintivo rispetto alle altre realtà dub. Pezzi<br />
come Professional Loving o Drop The Other ci raccontano un’artista congenitamente<br />
oscura, che non cerca in nessun modo di mitigare il suo buio<br />
interiore. Nessuna sfumatura ottimista che lasci intendere una via d’uscita<br />
dal tunnel, tutti gli strati della composizione viaggiano coerenti verso un<br />
buco nero pieno di tragicità esistenziale, uno spazio chiuso con le uscite di<br />
sicurezza sigillate. “Siamo qui, adesso, e affronteremo le sofferenze della vita<br />
fino in fondo, senza paura di farci male”: questo più o meno l’atteggiamento<br />
che emerge dall’album. Perché la vita è un viaggio difficile, e bisogna essere<br />
ben attrezzati per arrivare fino in fondo.<br />
E se Bristol è il punto di partenza, Berlino è quello di arrivo. Il passaggio<br />
alla capitale della techno è per Emika la scossa che ha fatto maturare la<br />
propria solidità compositiva. Frequentare i club berlinesi ha conferito una<br />
nuova robustezza al sound, rendendolo più virile e incisivo. Un’influenza<br />
che l’album ha voluto mostrare a tratti in maniera esplicita, con brani<br />
come 3 Hours o Pretend dalla carica maggiormente dancey. Un po’ il lato<br />
deep dell’emozione dark offerta dal disco. Un’attitudine al club che Emika<br />
non cerca intenzionalmente, ma che, come spiega nell’intervista, emerge<br />
spontaneamente tra le pieghe dei suoi brani, producendo nel pubblico una<br />
reazione dance le cui origini rimangono a lei oscure. La sua è musica che<br />
sa catturare ed emozionare, ma anche coinvolgere fisicamente, un duplice<br />
carattere ottenuto senza artifizio, cosa che lo rende ancora più prezioso.<br />
suo tour negli Stati Uniti, per un’intervista-fiume in esclusiva, in cui abbiamo<br />
toccato tutti i punti fondamentali della sua musica: l’eredità di Bristol, le<br />
evoluzioni dubstep, l’ambiente berlinese, il background classico. Abbiamo<br />
scavato nella Emika artista, spinti dalla sua disponibilità e dalla schiettezza<br />
con cui lei sa toccare anche le pieghe meno piacevoli della sua musica e della<br />
sua vita. E ci siamo anche fatti raccontare com’è l’ambiente alla Ninja Tune e<br />
quali sono i progetti futuri. Si è mostrata loquace e sincera, ma soprattutto<br />
felice di come avessimo colto tutti gli aspetti più genuini del suo disco. Una<br />
ragazza forte e emotiva nello stesso tempo, che ama la vita fino in fondo,<br />
sia nei momenti felici che in quelli più sofferenti.<br />
L’abbiamo battezzata “The noir lady”. Eccola.<br />
Come presentare Emika al pubblico italiano? Ti senti più una cantante,<br />
una scrittrice o un’artista dance?<br />
Sono un’artista poliedrica. E soprattutto sono l’unica artefice di ogni aspetto<br />
della mia musica: so suonare diversi strumenti e interpretare differenti stili,<br />
sono io che compongo e registro la mia musica per intero. E sono anche una<br />
live performer, esibirmi e suonare la mia musica sul palco è una fase per me<br />
molto importante.<br />
Proprio in questi giorni sei in tour negli Stati Uniti, insieme a nomi come<br />
Amon Tobin e Eskmo. Come ti presenti live? Preferisci far ballare la gente,<br />
o ti presenti più come una cantautrice?<br />
Trovo particolarmente interessante la reazione del pubblico alla mia musica.<br />
In genere quando salgo sul palco non sono particolarmente rivolta a<br />
far dance, ma succede spesso che la gente balli mentre canto. Mentre altre<br />
vote capita che il pubblico stia fermo e si lasci trasportare, emozionare. Dipende<br />
da molti fattori, conta molto anche l’ora a cui ti esibisci: a volte il live<br />
è molto presto, alle 20, e il pubblico è più “da aperitivo” [ride, ndr], pacato,<br />
mentre dopo la mezzanotte tipicamente la gente è più propensa a ballare<br />
e a “perdersi” nella musica.<br />
È stata un’impresa ardua, ma siamo riusciti a contattare Emika durante il dirty beaches<br />
20 21
Beh, questo è un aspetto interessante, significa che la tua musica può<br />
esser percepita in entrambe le direzioni, che il pubblico può recepirla<br />
sia come musica su cui ballare che come emozione.<br />
Esattamente. È curioso, ma ogni volta che salgo sul palco non ho idea di<br />
come la gente parteciperà alla mia musica. Io non sono una dj, non mi esibisco<br />
decisa a voler far ballare il pubblico. Quel che faccio è aver cura della<br />
qualità del suono e della performance, ma lascio il pubblico libero di vivere<br />
la musica nel modo in cui desidera. Anzi, per me è strano vedere la gente<br />
ballare mentre canto, non immaginavo che la mia musica avesse una componente<br />
dance così sviluppata!<br />
Eppure nel tuo album questa anima dance-oriented è facilmente percepibile.<br />
È vero, ed è percepibile anche nei live, stando alla reazione del pubblico.<br />
Ma la cosa strana è che io non ho mai scritto nulla intenzionalmente per far<br />
ballare la gente. Anzi, a dire il vero non credo sappia nemmeno come si fa<br />
a far ballare la gente! Io non faccio altro che scrivere musica con dei ritmi e<br />
dei groove che mi rispecchino. Che il pubblico ci balli su è una bella cosa,<br />
ma quali aspetti delle mie canzoni producano quest’effetto per me è un<br />
vero mistero!<br />
Il messaggio è chiaro: non guardate a Emika come ad un’artista dance,<br />
ma come una songwriter.<br />
Sì, esatto.<br />
Mi piace molto la direzione intrapresa da James Blake o Jamie Woon, è bello<br />
vedere come dietro ci sia una storia che si vuole raccontare.<br />
Una delle prime cose che si percepiscono ascoltando il tuo album è il<br />
ruolo protagonista della tua voce. La centralità della dimensione vocale<br />
e l’approccio orientato al songwriting sono degli aspetti che nella dub<br />
music stanno esplodendo proprio in questo periodo. Cosa sta succedendo?<br />
Penso che il songwriting nella musica elettronica sia un’area molto poco<br />
battuta. Non ci sono molti artisti che scrivono “canzoni elettroniche”: quasi<br />
tutti sono DJ, o producers, o entrambe le cose, tutto inizia e finisce lì e trovo<br />
la cosa abbastanza statica. Quello a cui punto è un approccio più completo,<br />
che comprenda un sound più robusto, una storia, delle emozioni da passare<br />
alla gente. Mi piace molto la direzione intrapresa da James Blake o Jamie<br />
Woon, è bello vedere come dietro ci sia una storia che si vuole raccontare.<br />
E sono convinta che questo sia il terreno in cui l’elettronica possa evolversi<br />
con più efficacia oggi. E con effetti più visibili di quanto possa fare la club<br />
music, per esempio, che invece trovo molto più statica e meno capace di<br />
distinguersi da luogo a luogo.<br />
Ok, abbiamo capito che ad Emika non piace andare per club..<br />
Ah ah, ma no, in realtà mi piace molto la club music. Compro un sacco di<br />
dischi techno e dubstep, ho frequentato spesso i club di Londra, di Bristol.<br />
E a Berlino poi, sai bene che c’è la miglior techno del mondo, e la adoro. Ma<br />
io appartengo ad una scena differente, che orienta l’elettronica più verso<br />
l’emozione. E da questo mio punto di vista la musica per club mi sembra<br />
piuttosto statica, ripetitiva. È comprensibile, no?<br />
Si, lo è.Poco fa collocavi il tuo stile compositivo vicino a quello di artisti<br />
come James Blake e Jamie Woon. È quello che abbiamo percepito anche<br />
noi ascoltando il tuo album (come si può leggere nella recensione), ma c’è<br />
una peculiarità che ti contraddistingue dagli altri: il tuo stile va a fondo<br />
nel dark mood, senza dover per forza bilanciare l’oscurità della bass<br />
music con il lato più ottimistico della voce. La tua musica è noir sotto<br />
ogni aspetto.<br />
Wow, “noir” la trovo una definizione adorabile! È vero, ho un carattere molto<br />
buio. Non è qualcosa che costruisco intenzionalmente, è qualcosa che deriva<br />
dal mio modo di amare e osservare la vita. Vivo la mia musica esattamente<br />
come vivo la mia vita, ossia lontana dall’allegria, dalla dance, dalle radio.<br />
Quindi l’intensità dell’album è l’intensità con cui ti poni nei confronti<br />
della vita. E nel tuo caso questo si è tradotto in un concentrato di emozioni<br />
oscure.<br />
Precisamente. Devo dire che ho vissuto molti eventi tragici, non si può dire<br />
che io abbia avuto una vita facile e felice. Ho sempre trovato la vita molto<br />
difficile, come difficile è capirla, entrarci dentro. Trovare la propria dimensione<br />
esistenziale per me è una grande sfida. E credo che nella mia musica<br />
tutto questo traspaia.<br />
La pioggia, quella sì che ti fa sentire differente. Ti costringe ad essere introverso.<br />
Sono convinta che il clima abbia un effetto molto forte sulla musica<br />
di una città.<br />
Sei cresciuta artisticamente a Bristol, la città del trip-hop. Quanto ti<br />
senti vicina a quel sound?<br />
Ecco, il trip-hop è esattamente il mio genere! La mia musica non somiglia al<br />
dubstep, o alla techno, ma può definirsi tranquillamente trip-hop. Non ero<br />
ancora a Bristol quando negli anni ‘90 si diffuse il trip-hop, ci sono arrivata<br />
più tardi, quando invece fu il dubstep ad esplodere. Ma mi sento molto vicina<br />
a quel sound storico, lo sento nel sangue, e questo background me lo<br />
sono portato a Berlino. Sì, amo il trip-hop. Tricky, Portishead... i miei dischi<br />
preferiti sono tutti dischi trip-hop.<br />
Come hai vissuto il periodo a Bristol?<br />
Ho assistito alla diffusione del dubstep quando ancora non sapevo nem-<br />
22 23
meno cosa fosse. Era qualcosa di rabbioso, che è partito dai club più cool<br />
e poi si è allargato come scena. Ora il dubstep lo senti ovunque, ma a quei<br />
tempi era ancora praticamente in fasce. E come sempre, la sua evoluzione<br />
è coincisa con l’allargamento della base fuori dai confini.<br />
Trip-hop nei 90s, dubstep nei 00s. Da qualsiasi angolo la guardi, Bristol<br />
è una città musicalmente cupa.<br />
È il clima. Molto piovoso e freddo. Questo spinge la gente a restare in casa,<br />
nessuno vuole andare in giro. La pioggia, quella sì che ti fa sentire differente.<br />
Ti costringe ad essere introverso. Sono convinta che il clima abbia un effetto<br />
molto forte sulla musica di una città.<br />
Cosa ti ha spinto a lasciare Bristol per Berlino?<br />
Dopo la mia laurea ho avuto alcuni problemi di salute piuttosto spiacevoli.<br />
Sono stata molto male per diversi mesi, ho subito diverse operazioni, e questo<br />
ha inciso così tanto che non sono più riuscita a tornare a sentirmi bene<br />
in quella città. E la cosa valeva anche per i miei amici, che non smettevano<br />
di esser preoccupati per la mia salute, anche dopo essermi rimessa. In quel<br />
periodo ho voluto darmi una scossa e sono andata a Berlino per un weekend<br />
lungo, da sola. E mi sono letteralemte innamorata della città, della sua storia,<br />
della gente, della cultura. È stata Berlino a catturarmi, non io a trasferirmi.<br />
Io volevo solo evadere da Bristol, staccare col passato. Berlino è arrivata nel<br />
momento più adatto. Mi sono trasferita la settimana dopo quel weekend.<br />
E musicalmente, come sei stata influenzata da Berlino?<br />
Prima di Berlino praticamente non avevo mai ascoltato techno. Passare da<br />
Bristol a Berlino è significato passare da un ambiente intriso di trip-hop e<br />
dubstep a un ambiente fortemente techno. Il mondo techno è completamente<br />
differente, nel ritmo, nei tempi, anche nella lingua. È questa la grande<br />
influenza che Berlino ha avuto sulla mia musica.<br />
Anche questo nel tuo album traspare. Penso a brani come 3 Hours, che<br />
hai posto proprio in apertura al disco. Dunque questo lato di te è figlio<br />
dell’ambiente berlinese.<br />
Sì, esatto. Sai com’è, la prima traccia di un album ha il compito di spiegare<br />
dove tutto è cominciato. Ho voluto iniziare proprio con quel brano perché<br />
è stata Berlino a far nascere questo album.<br />
Molte canzoni presenti nel tuo album sono state scritte nei due anni<br />
precedenti all’uscita, ma hai aspettato fino ad ora per pubblicarlo. Su<br />
cosa hai lavorato per fare in modo che ti soddisfasse nel complesso?<br />
Ho lavorato su molti aspetti per evitare che il mio album risultasse solo un<br />
insieme di canzoni. L’ho vissuto in ogni fase, mi sono concentrata sul recording<br />
per raggiungere la qualità del suono che volevo. Ho fatto in modo che<br />
si sentisse l’influenza del clubbing, i confronti che ho avuto con la gente nei<br />
club. Ho lavorato senza fretta, non mi ero imposta una deadline, e nemmeno<br />
la Ninja Tune me ne aveva imposta una. Volevo solo che il risultato fosse<br />
ottimo.<br />
La musica classica è pura energia emozionale. Non riguarda nient’altro, è<br />
emozione al 100%. È coinvolgere i sentimenti umani e tradurli sul piano<br />
reale, dargli una forma armonica.<br />
Puoi parlarci dell’ambiente Ninja Tune? Come ti trovi?<br />
È un ambiente fantastico. Alla Ninja Tune sono molto attenti a far crescere<br />
gli artisti, li spingono a migliorare costantemente il loro sound. Si prendono<br />
molta cura degli artisti e dell’aspetto stilistico, per evitare che le varie uscite<br />
suonino troppo vicine a qualcosa di già sentito. Conosco tante altre label,<br />
e tante persone che possiedono una label, ma ringrazio ogni giorno di<br />
essere in Ninja Tune. Mi hanno insegnato ad essere un’artista differente,<br />
a non pensare in termini di soldi, video, successo. E non mi hanno fatto<br />
sentire pressioni, ho vissuto la fase di lavorazione all’album in maniera<br />
molto rilassata.<br />
Poco fa abbiamo parlato della opening track, ora volevo concentrarmi<br />
sulla traccia di chiusura, Credit Theme. Quella traccia mi ha colpito, è<br />
un perfetto esempio di classica romantica. Mi ha ricordato Chopin.<br />
Oh sì, sono felice che questo accostamento sia emerso. Amo Chopin. L’ho<br />
ascoltato per la prima volta quando avevo 12 anni, ricordo ancora il pezzo<br />
ma non saprei dire quale fosse di preciso. Faceva così.. [ha accennato le<br />
prime note del Notturno No. 2, ndr].<br />
Sì, lo riconosco. È uno dei suoi notturni più famosi.<br />
È stupefacente. Mentre l’ascoltavo quella volta ho pianto. È stata la prima<br />
volta che ho avuto una reazione tanto forte alla musica. A quell’età suonavo<br />
già il piano, e continuo ancora oggi a scrivere pezzi per pianoforte.<br />
Quindi è stata la classica il tuo primo approccio all’emozione in musica.<br />
È un’esperienza in cui possono identificarsi in molti, spesso la prima<br />
musica che ci emoziona, da piccolissimi, è proprio la musica classica.<br />
La musica classica è pura energia emozionale. Non riguarda nient’altro, è<br />
emozione al 100%. È coinvolgere i sentimenti umani e tradurli sul piano<br />
reale, dargli una forma armonica. Ed è la musica più stupefacente di tutti i<br />
tempi. Voglio dire, pensiamo a quanto indietro sia nel tempo e a quanto sia<br />
coinvolgente ancora oggi. Prendi la musica elettronica di oggi, per esempio:<br />
ogni settimana esce qualcosa di nuovo, che fa diventare vecchio quel<br />
che era uscito la settimana prima. Il ciclo vitale di una canzone è ridottissimo.<br />
La classica invece resiste ai secoli, senza alcuna difficoltà. Possiamo dire<br />
che è la musica di maggior successo di sempre. Adoro la musica classica.<br />
Sei un’artista completa, complimenti. E ora, dopo l’esordio su album?<br />
Sono già proiettata al secondo album. In questo periodo sono stata in tour,<br />
e mi sono resa conto di quanta gente ami il suono “noir”, come lo definisci<br />
tu. Sto preparando la mia voce, raffinando lo stile. Ho intenzione di registrarlo<br />
in inverno, e iniziare la produzione in primavera.<br />
Hai già qualche idea di come suonerà?<br />
Puro e semplice.<br />
Grazie per la lunga chiacchierata, Emika!<br />
Grazie a voi, è stato un piacere! Ciao.<br />
24 25
©ilaria magliocchetti lombi<br />
dEntE<br />
—Puntini sulle i—<br />
Drop out<br />
Nuovo album, tour, la musica di<br />
ieri e di oggi, l’Italia che non c’è<br />
più, Endrigo, i Nirvana e l’enigmistica.<br />
Giuseppe Peveri a colloquio<br />
con SA...<br />
Testo: Giulia Cavaliere<br />
26 27
In occasione dell’uscita, lo scorso 11 ottobre, del suo ultimo lavoro Io tra<br />
di noi Dente è tornato sulla bocca di tutti, confermadosi come l’autore più<br />
apprezzato della nuova leva di cantautori. Naturalmente non potevamo lasciarci<br />
sfuggire la possibilità di parlare con lui del disco e del tour che partirà<br />
tra poche ore e ne abbiamo approfittato anche per allargarci un po’ e parlare<br />
della situazione della musica in Italia, di indie, di Sanremo, di cantautori e<br />
letteratura...<br />
Io tra di noi ti sta già dando grandi soddisfazioni, in ultimo il quindicesimo<br />
posto nella classifica delle vendite. Ci racconti del concepimento<br />
e della gestazione di quest’album? So che sei stato all’Isola d’Elba per<br />
ultimare i brani...<br />
Certo. Sì, è vero, sono stato all’Isola d’Elba perchè avevo bisogno di riprendere<br />
un po’ contatto con me, staccare un po’ da quello che sono stati i due anni<br />
passati cioè stare sopra un palco sempre, farsi fare le fotografie durante un<br />
concerto. Ho cercato di riprendermi e stare un po’ solo isolato in un posto in<br />
cui nessuno mi conoscesse per avere modo di riprendere in mano tutte quelle<br />
cose che avevo fatto durante i due anni e quegli scritti che avevo buttato<br />
giù a mo’ di schizzo, ho messo insieme tutto quanto e ho scritto le canzoni<br />
del nuovo lavoro. Questo disco è una raccolta di canzoni scritte nell’arco<br />
di un tempo abbastanza lungo, infatti ci sono pezzi abbastanza remoti, ad<br />
esempio Rette parallele l’ho scritta cinque anni fa, poi l’ho abbandonata e<br />
l’ho ripresa in mano a dicembre, ho finito di scrivere il testo e l’ho chiusa.<br />
Non lo chiami solo “disco” ma preferisci usare la formula “raccolta di<br />
canzoni”, mettendo quindi un po’ da parte un’idea di concept...<br />
Mi piace molto questa definizione che non si usa più, è come negli anni<br />
‘60, quando si facevano i singoli e poi raggiunto un certo numero di pezzi<br />
si faceva l’album che veniva chiamato appunto “la raccolta di canzoni” o<br />
“le canzoni più belle”, “il meglio del meglio di”. Quindi sì, alla fine siccome i<br />
casi sono due, lo chiamo così anche un po’ per dire che non si tratta di un<br />
concept, non c’è una storia unica netta, un unico filo conduttore, quest’album<br />
anche per i tempi in cui i pezzi sono stati scritti non può essere tale. Io<br />
tra di noi è figlio di un’ispirazione dilatata, ci sono canzoni d’amore dove si<br />
parla di una donna ma anche riflessioni come quella amareggiata di Piccolo<br />
destino ridicolo.<br />
La sensazione è che tu in queste canzoni abbia dato molto più spazio<br />
alla descrizione di momenti di vita vissuta, fisica, reale, lasciando da<br />
parte l’aspetto più semplicemente evocativo che nei tuoi testi precedenti<br />
sembrava preponderante. Ci sono degli oggetti qua, dei correlativi<br />
oggettivi che rimandano alle sensazioni, alla sfera emotiva. Questo<br />
è un aspetto molto bello, una forma di evoluzione e novità nella tua<br />
scrittura...<br />
Diciamo che non è una cosa che ho voluto, ricercato, non avevo una linea<br />
predefinita sul modo di raccontare queste storie, sono venute così come<br />
le ascolti, mi sono venute così quando sono andato un po’ “alla ricerca del<br />
tempo perduto”, ci sono storie, degli aneddoti, più vicini magari a pezzi precedenti<br />
che avevo scritto come Quel mazzolino ma non ho scelto io, prima di<br />
scriverle, la direzione da dare ai testi, se dare più spazio all’aspetto riflessivo<br />
o a quello del ricordo.<br />
Io tra di noi è un disco fortemente tuo nel senso meno ovvio di questa<br />
definizione, diciamo che si ha la sensazione che queste canzoni si leghino<br />
in modo stretto a quelle dei tuoi lavori precedenti, specie a L’amore<br />
non è bello. Le cifre stilistiche permangono e benchè si abbia a che fare,<br />
qua, con brani più strutturati, stratificati, arrangiati anche in maniera<br />
molto raffinata, non si nota di certo il grande passo, la svolta radicale<br />
che forse qualcuno si aspettava ora che il tuo nome ha comunque fatto<br />
più volte il giro del Paese. E’ perchè vuoi andare a piccoli passi?<br />
Sì, assolutamente, credo proprio di voler andare a piccoli passi, non mi va<br />
di bruciarmi tutto quello che posso fare nella mia vita artistica in un solo<br />
disco, se no è finita. Non sono interessato a quello che gli altri si aspettano<br />
alla fine, io credo che questo sia un buon passaggio, come dici tu il disco è<br />
molto mio, questo era uno degli obiettivi che ci eravamo preposti e sono<br />
felice che siamo riusciti a raggiungerlo, si sente molto la mano di Colliva alla<br />
produzione, sebbene mi renda conto che non tutti quelli che mi ascoltano<br />
magari hanno le conoscenze tecniche per rilevarla appieno, anche se tutti<br />
si sono accorti che qualcosa in più qua c’è. Volevo mantenere un’identità<br />
forte ma non volevo fare un disco traumatico, non volevo aggiungere cose<br />
in modo traumatico.<br />
L’altro giorno alla FNAC di Milano un ragazzo ti ha chiesto come mai,<br />
con pezzi così “semplici” tu non riesca a raggiungere la massa. Personalmente<br />
mi domando se la massa intesa come pubblico televisivo, oggi<br />
che non siamo più negli anni ‘70, non l’abbia definitivamente relegata<br />
ai confini del proprio quotidiano. Una volta i 40enni ascoltavano i<br />
dischi che adesso probabilmente verrebbero definiti “indie”... Come ti<br />
relazioni alla possibilità di diventare un cantautore di quelli grandi, di<br />
quelli che tu stesso citi?<br />
28 29<br />
©ilaria magliocchetti lombi
©ilaria magliocchetti lombi<br />
Sì, il discorso è davvero molto ampio e complicato, io non so se come dici tu<br />
in effetti quel pubblico là non esiste davvero più, io conosco un pubblico che<br />
è molto bello che è quello che segue le cose che stanno uscendo ultimamente<br />
in Italia e che io posso anche accostare magari a quello di una volta, è un<br />
pubblico di persone che si fa chilometri per andare a vedere concerti e che<br />
ha ricominciato a comprare i dischi seguendo le cose con molta attenzione.<br />
Accanto c’è un pubblico vago e generico che è in realtà la maggior parte<br />
della popolazione che io percepisco come molto distratto, molto abituato<br />
al cambiamento, ad avere il nuovo fenomeno dell’anno e l’anno dopo un<br />
altro e poi ancora, dimenticando i nuovi fenomeni degli anni precedenti.<br />
Non so se la grande massa esista ancora, e come si comporterebbe, come<br />
reagirebbe alla mia musica, bisognerebbe provare e in verità ho anche un<br />
po’ paura a farlo. Quando penso ai Sanremo di cui tu mi parli penso ad anni<br />
che non c’entrano nulla con questi in cui noi ci stiamo muovendo, penso<br />
a Lucio Dalla in televisione con Dario Fo, Benigni e Paolo Conte, oggi in<br />
televisione passano spazzatura dalla mattina alla sera, è un mondo troppo<br />
diverso e io fatico a fare un paragone. Sai, ieri ho guardato un video di Mina<br />
negli anni ‘60, hai presente quelli a Studio Uno? Era lì che cantava La musica<br />
è finita e aveva sul palco cinque pianoforti a coda. C’erano una fotografia e<br />
una luce impeccabili, una cosa da brividi.<br />
Sì, beh, quella è proprio regia, certi registi Rai in quegli anni hanno fatto<br />
cose che si avvicinavano al cinema...<br />
Ecco, esatto. E’ proprio questo che manca ora, è un mondo perduto quello,<br />
purtroppo, quindi non so se possiamo parlare di ieri e oggi come due cose<br />
vicine o se l’oggi ce lo dobbiamo inventare, sapendo che abbiamo deter-<br />
minate cose e ripartendo da lì. Per quanto mi riguarda mi sta anche molto<br />
bene come mi stanno andando le cose, voglio dire, è andato sempre tutto<br />
migliorando, non mi sono mai fermato in un punto sentendomi arrivato,<br />
non l’ho ancora visto il punto oltre il quale non andare. Io riesco a vivere<br />
con quello che faccio, ho le mie soddisfazioni, faccio dischi come li voglio<br />
fare per cui mi va anche bene così, soprattutto li faccio perchè amo farli,<br />
per il gusto che provo nel farli. Detto in sincerità non ho alcun interesse a<br />
diventare famoso, ecco, andare in televisione. Poi beh, bisogna vedere, se la<br />
massa è interessata, se la massa apprezza come apprezziamo noi. Non ti nascondo<br />
che, come ti ho detto poco fa, sono anche un po’ spaventato perchè<br />
è una lama a doppio taglio, potrebbe salvarti la vita oppure distruggertela,<br />
conosco gente che per esempio a Sanremo ci è andata e poi ha smesso di<br />
suonare, conosco invece chi da lì ha iniziato un percorso bellissimo, si è arricchita,<br />
ha fatto carriera e c’è anche gente che non ci è mai andata, ha una<br />
carriera meravigliosa e riempie i teatri e fa tour con un sacco di pubblico.<br />
A tal proposito, inizi il tour il 28 ottobre dal Fillmore di Cortemaggiore<br />
(PC), non lontano dalla tua Fidenza, puoi anticiparci qualcosa? Archi?<br />
Fiati? Effetti speciali? Come ti senti?<br />
Le prime date sono sempre quelle più agitate, poi dopo la decima si comincia<br />
a salire sul palco un po’ più tranquilli, a capire anche come il pubblico<br />
reagisce alla scaletta e tutte quelle cose che finchè provi in solitudine o nel<br />
locale vuoto non puoi capire. Vedremo. La formazione sarà sempre la stessa<br />
del tour scorso, nessun elemento in più, nessun fiato né arco, cercheremo di<br />
fare il meglio che possiamo, in scaletta ci saranno quasi tutti i pezzi del disco<br />
nuovo, i più grandi successi della storia della musica (ride, naturalmente<br />
n.d.g) e un pezzo da Anice in bocca che non ho mai fatto ma che non ti<br />
30 31<br />
©ilaria magliocchetti lombi
dico perchè è una sorpresa.<br />
A proposito, questa ristampa di Anice in bocca? Tutti i tuoi fan la stanno<br />
aspettando, insieme anche ai dischi dei La Spina, il gruppo in cui suonavi<br />
prima di iniziare il tuo percorso solista<br />
Per il momento nessuna ristampa di Anice in bocca, siamo pieni di cose da<br />
fare e di cose a cui pensare per cui rimandiamo, quanto ai La Spina non so<br />
che fine abbiano fatto quei dischi, non sono più stati ristampati ma davvero<br />
a me piacerebbe molto poterli avere e venderli ai concerti, rimetterli un<br />
attimo in piedi. Magari farò un canale su youtube per iniziare.<br />
Una curiosità: la settimana enigmatica richiama moltissimo, per accordi<br />
e anche per l’andatura del brano, Bomba o non bomba di Antonello Venditti<br />
che è uno che, tra i cantautori attivi degli anni ‘70, mi pare tu non<br />
abbia mai citato... Immagino che comunque quel brano ti piaccia e che<br />
ci sia anche un po’ lui tra i tuoi numi...<br />
Si, quel pezzo mi piace molto. Non mi dispiace quel Venditti lì, quello di Lilly,<br />
per esempio. Mi piace molto Sotto il segno dei pesci e apprezzo anche il<br />
primo disco con De Gregori, Theorius Campus, quello è molto romanaccio,<br />
molto Folk studio.<br />
Il tuo amore smisurato per la musica d’autore italiana c’è sempre stato<br />
o è qualcosa che è cresciuto anche nel momento in cui poi tu stesso ti<br />
sei sentito parte di una nuova leva di cantautori? A volte questi amori<br />
vengono dai dischi di mamma e papà, altre dopo lunghi anni di buio e<br />
metal o new wave...<br />
L’ho ascoltata sempre anche da bambino, i miei genitori avevano molti dischi,<br />
molti 45 giri italiani, e le cassettine in macchina. Ascoltavamo tanto<br />
Bindi, Endrigo, e tutti gli altri e anche se poi loro erano molto più orientati<br />
verso le canzoni dell’estate in mezzo c’erano anche le grandi mazzate, i<br />
grandi come Tenco. Da bambino la subivo ma mi piacevano tanto queste<br />
atmosfere angoscianti ed è ancora così. Da grande poi mi sono messo ad<br />
ascoltarli in modo diciamo più analitico, mi sono messo lì a capire che cosa<br />
avevano fatto, li ho ascoltati con maggiore attenzione. Questa cosa l’ho fatta<br />
soprattutto con Endrigo. I miei però per esempio non ascoltavano cose<br />
degli anni ‘70, lì c’era già la rottura, andava così per molti della loro età, per<br />
cui quelle cose le ho scoperte dopo, da solo o con la mia cerchia di amici<br />
di quando avevo tredici o quattrodici anni e abbiamo iniziato ad ascoltare<br />
quelle cose che ascoltano tutti a quell’età, Bob Marley, i Rolling Stones, i<br />
Doors e in mezzo ci sono finiti anche Camerini, Finardi, Lolli e tutti questi<br />
nomi che negli anni ‘70 hanno fatto gran belle cose.<br />
...e oggi? Ci sono influenze anche straniere nella tua musica?<br />
Oggi no, ne sto ascoltando molto poca negli ultimi anni, anni fa invece<br />
ascoltavo molte più cose, Belle and Sebastian, Kings of Convenience, il<br />
primo disco dei Phoenix ad esempio mi piaceva molto, poi mi sono un po’<br />
allontanato dalla musica straniera, non l’ho più seguita tanto. Prima sì, ne ho<br />
ascoltata molta, poi calcola che avevo 18 anni nei primi novanta quindi sono<br />
caduto nel grunge a pie’ dispari, diciamo così. Ascoltavo Nirvana, Pearl Jam,<br />
Alice in Chains, tutta roba che oggi fatico molto ad digerire ad esclusione<br />
di In Utero che continuo ad ascoltare piacevolmente e che credo sia il loro<br />
miglior album, quello che ha maggiormente resistito alla prova del tempo,<br />
Ten dei Pearl Jam oggi non funziona più.<br />
Di recente cosa ascolti? Un disco che hai consumato mentre eri in tour?<br />
Guarda, senz’altro Primitivi del futuro dei Tre allegri ragazzi morti, mi ha<br />
32<br />
©ilaria magliocchetti lombi<br />
accompagnato per tutta la seconda parte del tour, lo abbiamo consumato<br />
sul furgone. Adesso sono molto curioso di ascoltare il nuovo di Tom Waits,<br />
mi hanno detto tutti che è bellissimo e da fan sono molto interessato.<br />
Nel disco c’è anche qualche riferimento alla letteratura, specie a Ungaretti,<br />
sia in Saldati che in Casa tua, si va da Soldati all’Allegria di Naufragi,<br />
Il porto sepolto.. sei un lettore? leggi anche poesia?<br />
No, solo narrativa devo dire. Leggo romanzi quasi quotidianamente e anche<br />
saggi e manuali. Vado in libreria e mi faccio ispirare oppure seguo consigli<br />
che mi danno. Ultimamente ho acquistato dei saggi di enigmistica che è<br />
una cosa che mi interessa molto anche al di là di come io la uso nei testi<br />
anche perchè poi quella a dire il vero è ludolinguistica non enigmistica vera.<br />
Pensa che gli enigmisti ritengono che La settimana enigmistica sia proprio<br />
la feccia della disciplina. Ultimamente ho letto Lo strano caso del cane<br />
ucciso a mezzanotte, molto bello, una lettura molto piacevole. Adesso mi<br />
sono messo in testa che durante il tour voglio leggere Moby dick che non<br />
ho mai letto.<br />
Non posso esimermi dal consigliargli la traduzione di Cesare Pavese
girls —Putting<br />
the right gear—<br />
Drop out<br />
Quattro chiacchiere al telefono<br />
con un torrenziale Chet White a<br />
proposito di amps and gears, microfoni<br />
e strategie di produzione<br />
del folgorante sophomore dei<br />
Girls...<br />
Testo: Edoardo Bridda<br />
34 35
Ora che il consenso attorno a Father, Son, Holy Ghost si sta facendo unanime,<br />
i Girls possono serenamente arrivare al pubblico con quel misto di reali<br />
capacità e hype che da sempre li caratterizza.<br />
Grazie ai giornali e alle webzine che non hanno parlato d’altro in questi mesi,<br />
conosciamo ogni particolare del passato dell’icona della band Christopher<br />
Owens: dalla sua dipendenza dalle droghe alla setta in cui è cresciuto, dal<br />
rapporto problematico con la madre alle stamberie che ne hanno caratterizzato<br />
l’adolescenza. Al contrario, sappiamo pochissimo del mondo sonico<br />
che abita i testi autobiografici del songwriter. Così abbiamo deciso di raccontarvelo<br />
attraverso le parole di Chet “Jr” White, produttore, arrangiatore e in<br />
pratica deus ex machina del progetto da quasi dieci anni. Nessuno avrebbe<br />
mai sentito parlare dei Girls senza la direzione di questo torvo californiano.<br />
Sua la produzione dei dischi pubblicati finora, gli smalti 70s dell’ultimo episodio<br />
e, in generale, quella caratteristica cifra slabbrata e androgina capace<br />
surfare tra le epoche e gli stili.<br />
Non vedevamo l’ora di farci raccontare aneddoti sulle tecniche di registrazione<br />
e sulla peculiare genesi di alcune delle più emblematiche canzoni<br />
dell’album. E così alle 22.30 circa di una sera di settembre lo abbiamo sentito<br />
al telefono mentre era a New York alle prese con una session in una<br />
vecchia chiesa Polacca. Attacchiamo con qualche convenevole e veniamo<br />
sbatocchiati di chiacchiere, shit talk conditi da ogni sorta di informazioni e<br />
fascinazioni, con un Chet appassionato che non smetterà di parlare per i<br />
quaranta minuti successivi.<br />
I Girls, sono un duo allargato a band non così in erba come la gente crede.<br />
Chet e Chris hanno entrambi superato i trent’anni ma rimangono due ragazzini<br />
esaltati per la musica. Chris è il post-hippy, il junkie redento dalla<br />
musica che trae tuttora ispirazione dall’esperienza passata dentro e fuori<br />
una comune di fanatici. Chet è il classico punk-rocker della Bay Area, un<br />
autodidatta con la fissa per i suoni “da garage”. Uno di quelli che il sogno che<br />
lo accompagnava fin dall’adolescenza l’ha realizzato sul serio.<br />
Che formazione ha registrato il disco e quanti siete sul palco durante<br />
questo tour?<br />
Su disco abbiamo inciso per la prima volta come quintetto. Io ho suonato<br />
basso, parti di chitarra e qualche percussione. Chris la chitarra classica e ritmica,<br />
armonica, mellotron e voce. John Anderson chitarra e cori, Dan Eisenberg<br />
l’organo, il piano classico e elettrico, Darren Weiss la batteria. Dal vivo<br />
siamo sempre in cinque ma senza John, al suo posto c’è il fratello di Darren,<br />
Matt. Poi ci portiamo dietro tre donne che hanno cantato anche nel disco.<br />
Sono coriste gospel professioniste davvero brave e, visto quanto costano,<br />
le abbiamo con noi soltanto negli show più importanti.<br />
Mi sbaglio o trasporre dal vivo Father, Son, Holy Ghost può essere una<br />
faccenda complicata?<br />
In realtà no. E’ una produzione piuttosto semplice nata da demo che si sono<br />
arricchiti attraverso varie session e grazie allo scambio su internet. L’elemento<br />
più impegnativo è stato l’assunzione delle cantanti, anche se la semplicità<br />
rimane comunque una caratteristica fondante del nostro suono. Quello dei<br />
Girls è un suono corposo e ricco, ma con una struttura semplice. Cerchiamo<br />
di usare il meno possibile per ottenere il massimo. Per dire, invece di sparare<br />
tante chitarre una sopra l’altra puoi creare un suono in grande con una sola<br />
chitarra. E’ questa la nostra filosofia.<br />
Hai prodotto tutto tu con i Girls o vi siete fatti aiutare da qualcuno?<br />
Sì ho prodotto tutto. Nel primo ho fatto la direzione, la produzione e gli<br />
arrangiamenti. In pratica, per quanto riguarda la musica, Chris scrive gli accordi<br />
di base mentre io li arrangio e limo, dirigo il batterista, decido quali<br />
amplificatori usare ecc. Sono cresciuto registrando nel mio garage. Ed è da<br />
quando avevo 15 anni che lo faccio.<br />
...dunque sei stato tu ad aggiungere tutti questi smalti Seventies nel disco?<br />
Mi riferisco ai Pink Floyd, all’hard rock e a tutto ciò che di differente<br />
si respira rispetto al vostro esordio. Da chi sono venute queste idee?<br />
Non avevamo un’idea unica quando abbiamo iniziato le session. Non abbiamo<br />
mai avuto un’unica idea e non pianifichiamo gli album secondo secondo<br />
linee prestabilite tipo ora facciamo un disco anni “50 o “60. Avendo una personalità<br />
forte, la nostra band mescola generi e stili continuamente. La gente<br />
s’aspetta di scoprire cose differenti ogni volta da noi. Nuovi stili e trend. In<br />
effetti, in quest’ultimo album abbiamo usato strategie d’incisione tipiche dei<br />
“70. Abbiamo passato un centinaio d’ore spostando microfoni e cercando<br />
36 37
di far suonare la batteria davvero in grande. La batteria è fondamentale e<br />
siamo stati veramente fortunati ad avere una batterista fantastico come<br />
Darren. Quando gli suggerivamo un suono o uno stile, lui era veramente<br />
ricettivo. Poi sempre riguardo all’incisione: preferisco usare microfoni e altri<br />
trick per ottenere un particolare riverbero. Hai presente i dischi di una volta<br />
dove suonavano tutti attorno a un microfono? Esattamente quel tipo di<br />
suono e riverbero...<br />
Dove avete registrato l’album questa volta e perchè?<br />
Abbiamo registrato in un enorme semiterrato di cemento che appartiene<br />
ad un tipo (che poi si scoprirà essere il produttore aggiunto Doug Boehm...)<br />
che raccoglie ogni sorta d’apparecchiature d’incisione (in gergo suo “gear”).<br />
Compra gear come un drogato compra le sostanze. Ha così tanta roba: 5 mixing<br />
board, 5 plate reverb, vecchie Calrec mixing console con grandi bottoni<br />
colorati. E’ stato veramente bello registrare in una location come quella, mi<br />
ha fatto ricordare un vecchio studio, sempre in un semiterrato, dove incidevo<br />
tanto tempo fa. Per Father, Son, Holy Ghost non volevo una stanza con un<br />
suono piatto e regolare. Volevo uno spazio che avesse una grande influenza<br />
sul sound del disco. Il modo in cui un disco funziona dipende dal modo in cui<br />
ci lavori tu ma anche dal posto in cui è registrato. Puoi usare tutti i microfoni<br />
del mondo ma ci sono cose totalmente imprevedibili. Pensa ad incidere in<br />
quel seminterrato di cemento con soffitti alti quindici piedi! C’era tantissimo<br />
eco. E anche se cercavi un suono davvero pulito e in grande, quello spazio<br />
ci metteva le sue impronte aggiungendo stranezza e suoni acidi.<br />
L’aspetto produttivo del disco è davvero interessante: ma davvero avete<br />
fatto tutto da soli in quello stanzone?<br />
Abbiamo chiesto a un ingegnere di lavorare con noi. Si chiama Doug Boehm<br />
ed è anche il proprietario del semiterrato. Ha lavorato con French Kicks,<br />
Dr. Dog, The Vines ecc. poi abbiamo chiesto aiuto anche a Drew Zajicek e<br />
Camren Lister. Volevamo gente che avesse fatto grandi dischi per le radio,<br />
persone che passano mesi su un disco per ottenere il risultato più importante<br />
possibile, gente con un metodo di lavoro che lavorasse con una band<br />
come la nostra che ne ha uno suo di metodo anche se piuttosto stravagante<br />
e a volte sfilacciato.<br />
Dischi per le radio e semiterrati sono forse due modi piuttosto diversi<br />
di intendere la produzione o sbaglio?<br />
Figurati! Appena sono entrato nel semiterrato ho esclamato “holy shit, what<br />
am I gonna do with this place?!”. Ero sicuro che unendo tutti questi aspetti<br />
avremmo tirato fuori qualcosa di pazzesco. Tu pensa che Doug ha una collezione<br />
di amplificatori talmente grande che potrebbe riempire, letteralmente,<br />
una stanza con misure 20 x 20 dal pavimento al soffitto. Ci veniva da ridere<br />
pensando a quanta roba avesse. Di come aveva finito per costruire delle<br />
stanzette dentro lo stanzone: cabine dedicate solo ai Marshall per dirti.Il<br />
disco non ha quel suono super in grande che avrebbe potuto avere. La cosa<br />
più importante è che però possegga quell’elemento straniante e intenso.<br />
John Anderson è ancora dei vostri? Che contributo e esperienza chitarristica<br />
ha dato alla band?<br />
John Anderson non è più ufficialmente nella band ma voleva aiutarci. È<br />
veramente un bravo chitarrista ma non vuole far parte della touring band.<br />
John ed io lavoriamo insieme più che bene. Posso sedermi con lui con un<br />
po d’idee, gli dico cosa penso, cosa sento e lui prende e trasforma tutto in<br />
qualcosa di davvero figo. Quando abbiamo inciso il riff di Mirage abbiamo<br />
38 39
utilizzato dieci diversi amplificatori e poi abbiamo editato al PC. E l’idea era<br />
di John come sua è l’influenza pop anni “60 à la Everly Brothers di Saying<br />
I love You.<br />
Tornando alle domande più generiche: da quanti anni vi conoscete, tu<br />
e Chris? Dove vi siete incontrati?<br />
Più o meno da nove anni. Ero a San Francisco da un anno e stavo producendo<br />
alcune band in uno studio che era anche casa mia. Non avevo soldi e<br />
non ero in nessun giro importante. Un giorno ero a un concerto dove c’era<br />
anche un’amica, Lizer. Parlavo con lei altre tre amiche sue. Una abitava con i<br />
suoi in una casa bellissima che guardava il Golden Gate Bridge. Così dopo il<br />
concerto siamo andati tutti a casa sua e ci siamo rimasti per quattro giorni.<br />
Erano tutte e tre molto belle e intelligenti e così, all’improvviso, da che non<br />
avevo amici a Frisco, mi sono trovato con queste nuove amiche. Circa un<br />
anno e mezzo dopo hanno fatto lo stesso con Chris. Hanno fatto amicizia<br />
con lui e me l’hanno presentato. Ecco come è nato il nome della band, grazie<br />
a questo gruppo di “Girls”.<br />
Come avete iniziato a produrre musica assieme? So che Ariel Pink è<br />
stato una forte influenza per Chris all’inzio...<br />
Chris voleva registrare musica in proprio. Aveva alcune canzoni e voleva<br />
compare un quattro piste per registrarsele in proprio. Ariel Pink è stato<br />
un’inspirazione per lui ma a quel tempo voleva fare una cosa sua. Il perfetto<br />
timing. Io avevo un guardaroba pieno di roba per incidere che non utilizzavo<br />
e che mi ricordava quello che volevo fare davvero. Chris mi ha chiesto consigli<br />
su cosa comprare e come produrre musica e un secondo dopo stavamo<br />
lavorando assieme. Dopo una settimana abbiamo trovato un real-to-real sul<br />
internet a soli cinquecento dollari. Dopo un paio di giorni registravamo e<br />
andavamo d’accordo così bene che ho detto “bene, ora sono nella band” e<br />
lui ha risposto “fantastico, cosa vuoi suonare?” Tutto è iniziato così.<br />
Quali canzoni vi hanno maggiormente messo alla prova?<br />
Forgiveness ha richiesto il tempo maggiore. John non riusciva a trovare un<br />
assolo che lo convincesse. Ma a parte quel pezzo, solitamente lavoriamo in<br />
modo molto fluido. Le nostre canzoni finiscono sempre come le immaginavamo.<br />
E’ una questione d’esperienza ma soprattutto di consapevolezza,<br />
capire cosa distingue la tua band dalle altre, cosa la rende speciale. Quando<br />
produci canzoni devi prima capire questo e nei Girls c’è sicuramente quel<br />
qualcosa di speciale che li distingue da tutto il resto.<br />
Ho letto da qualche parte che Chris ha moltissime canzoni inedite. È<br />
vero? State già pensando a un terzo album?<br />
Sì, abbiamo parecchie inedite scritte che Chris ha scritto nella vasca di bagno<br />
o per conto suo. Ogni tanto le suoniamo da vivo e la gente ci chiede quando<br />
le pubblichiamo. Non lo sappiamo ancora ma qualcuna per il prossimo<br />
album è già lì con loro.<br />
Prima di incontrare Chris dove vivevi? Con quali band stavi lavorando?<br />
Qual’era il tuo rapporto con il mondo della musica?<br />
Ero dentro la musica punk da quando avevo appena finito la Junior school<br />
in un piccolo paese della California. Era un posto molto tranquillo e un po’<br />
noioso ma c’era un grande scena punk lì. Mi ricordo il mio primo concerto<br />
è stato fantastico! La cosa bella del punk è che qualsiasi persona può farlo.<br />
Sono subito entrato a far parte di una band. Erano in cinque ma poi dopo<br />
un po’ suonavo con solo una persona o due ragazze. Mi è sempre interessato<br />
molto di più registrare che essere “the man’. Quando ci siamo incontrati io e<br />
Chris, ho deciso che non volevo essere più in una band ma solo quello che<br />
registra i dischi.<br />
Come musicista e producer, ascolti tanta musica?<br />
In realtà no, almeno non al momento. Ascoltavo molto di più quando andavo<br />
ai concerti. Ora quando siamo in tour ascolto hip hop o solo chitarra. Non<br />
so perché...<br />
Sei un grande fan di Ariel Pink quanto lo è Chris?<br />
Si. E’ venuto da casa mia una volta con la sua band e sono rimasti per due<br />
giorni. Facevamo solo feste. E’ stato veramente bello e anche ora, quando<br />
ci becchiamo in giro, ci divertiamo un sacco.<br />
Hai qualche band inglese tra le tue preferite o preferisci band americane?<br />
Beh, a me piace tutto. Potresti nominare una band a caso e probabilmente<br />
mi piacerebbe. Recentemente ascolto rockabilly, roba tipo Gene Simmons.<br />
Un paio di persone che vengono in mente ora sono Earl, i Deads, i Byrds.<br />
Sono anche un grande fan di Three Figs.<br />
Puoi dirmi come è nata la canzone Die?<br />
Die è stata scritta un po’ di tempo fa ed il nostro vecchio batterista non riusciva<br />
mai a suonarla come volevamo. Così ogni tanto Io e Chris ci ritrovavamo<br />
a provarla da soli dopo notti fuori passate tra drink e droghe. In queste piccole<br />
jam io suonavo la batteria e provavamo questa canzone all’infinito. Era<br />
davvero ipnotica. Ma ancora non riusciamo a farla funzionare. Poi è arrivato<br />
Darren e lui ha capito tutto. L’etichetta ha avuto da ridire sul brano finito ma<br />
poi ha ceduto e tutt’ora è una canzone veramente divertente da suonare.<br />
E’ anche una delle mie preferite del disco. Sono sicuro che Die, il suo saltare<br />
da un genere all’altro, ci garantirà più libertà nel futuro...<br />
Ci vediamo in Italia presto?<br />
Fare un’intervista con la stampa Italiana ci porterà bene. Amo l’Italia. Ci ho<br />
passato un’estate intera una volta. È un sogno. La gente in America non<br />
conosce il vostro paese molto bene, conosce solo i ristoranti.<br />
40 41
— cd&lp<br />
Recensioni<br />
novembre<br />
3io - BaCk to new rootS (hell Yeah, ottoBre<br />
2011)<br />
Genere: Jazz<br />
Giochiamo a riarrangiare la dance in chiave jazz? Prendiamo<br />
le hit elettroniche che tutti conoscono (Right here<br />
right now di Fat Boy Slim, Born Slippy degli Underwolrd,<br />
Let forever be dei Chemical Brothers...) e rifacciamole<br />
con piano, basso e batteria. Back to new roots è questo.<br />
Poco più che un divertissment. Il passatempo di tre baravi<br />
jazzisti che vogliono mettersi alla prova con qualcosa<br />
di diverso. Prendono il motivo e lo suonano nel loro stile,<br />
dritto, snaturato ma riconoscibile. Si diverte il musicista<br />
a farlo, si diverte con lui chi ascolta. È come partecipare<br />
a una specie di “Sarabanda” per palati raffinati. I 3iO<br />
conducono il quiz e fanno partire la musica. L’ascoltatore<br />
gareggia per indovinare, nel minor tempo, quale pezzo<br />
si cela dietro la rivisitazione jazz. Idea perfetta per una<br />
serata da circoli radical chic. Se si è da soli, dopo averne<br />
azzeccate un paio si perde tutto il piacere.<br />
(6/10)<br />
franCeSCo aSti<br />
aa. vv./MoDeSelektor/JahCoozi - BlnrB<br />
- welCoMe to the MaDhouSe (outhere,<br />
aGoSto 2011)<br />
Genere: afro-tech<br />
Un asse artistico che collega Berlino (BLN) e Nairobi<br />
(NRB). L’ambiente deep-tech mitteleuropeo che incontra<br />
il rap afro e le sue solidità ritmiche. L’improbabile incontro<br />
tra realtà eurotechno di spicco come Modeselektor,<br />
Jahcoozi e Gebrüder Teichmann e i rappers kenyani<br />
Nazizi, Lon’ Jon, Mister Abbas e Kimya partorisce una<br />
raccolta più compatta di quanto si possa pensare.<br />
Paradossalmente il meglio vien fuori proprio quando i<br />
due mondi finiscono per stridere tra loro nel voler affermare<br />
ognuno la propria identità: prendi Living Room, con<br />
l’arroganza occidentale electro/deep che spinge verso il<br />
basso la melodia cantata di Ukoo Flani, o meglio ancora<br />
Monkeyflip, coi virtuosismi r’n’b di Nazizi soavemente<br />
torturati dal glitch-hop dei Modeselektor (a proposito,<br />
quando esattamente hanno perso quest’euforia di<br />
scrittura?). Ma la verità è che i due contributi non sono<br />
per nulla inconciliabili, e vale la pena piegare un po’ di<br />
futurismo industrializzato al servizio dei prelibati groove<br />
afro: in Madhouse è ancora Nazizi ad esibirsi disinvolta<br />
tra sinuosità killer tanto pop quanto dance dall’energia<br />
irresistibile (e qui anche due ragazze terribili come<br />
Janelle Monáe e Ms Dynamite rimarrebbero a bocca<br />
aperta), mentre sotto Msoto Millions sono i riverberi bass<br />
a illuminare la strada ai battiti afro-soul. Spessore deep<br />
e tribal arcana si scoprono fratelli di sangue (Ma Bhoom<br />
Bhoom Bhoom) e nemmeno la house New York skool rimane<br />
esclusa (è Alai K ad avvolgerla al caldo in Everyday<br />
Without You).<br />
Non son mai abbastanza i tentativi di aprire l’occidente<br />
campione di narcisismo e autocelebrazione a ciò che sta<br />
fuori. Se il progetto BLNRB funziona a dovere il Sud del<br />
mondo può dirsi un po’ più vicino. E stavolta non è colpa<br />
dello spread alle stelle.<br />
(6.9/10)<br />
Carlo affatiGato<br />
al CoholiC - GooD newS (ultra vaGue<br />
reCorDinGS, aGoSto 2011)<br />
Genere: Drum’n’Jazz<br />
Ecco uno di quei casi in cui un po’ di sano hype in più non<br />
sarebbe guastato. Esce sulla netlabel Ultra Vague l’album<br />
di debutto di Albert Yaschenko aka Al Coholic, polistrumentista<br />
ucraino che gioca tutto su un’idea semplice<br />
ma di grande impatto: combinare elementi strumentali<br />
classici dall’impronta soundtrack/jazz con le scarrellate<br />
ritmiche della drum’n’bass. Una d’n’b intelligente ben<br />
lontana dalle spacconerie da action-movie di Prodigy<br />
e Pendulum, verso un’ottica più aristocratica e raffinata<br />
che ne ripulisce il retaggio rave pur tenendone in vita<br />
l’attrazione del dinamismo.<br />
La predilezione dell’ottica d’ascolto si sente maggiormente<br />
nel lato “da camera” del disco, reso soffice dai<br />
vari inserti acid-jazz (Freeplay Sax, Days Later), corde di<br />
classica contemporanea (Good News, 2nd Page) e missioni<br />
techno-folk da National Fanfare of Kadebostany<br />
(Prelude, Release Your Mind). Ma c’è anche un volto più<br />
maschio, che pesca petrolio nero dal mare bass-groove<br />
e modella distorsioni thriller/pulp (Heavy Shower, Spy),<br />
simmetrie ambient/IDM (Release Us) e trance-beatz à la<br />
Prodigy Experience (Release Us (Future Session)). Per essere<br />
highlight<br />
aM/Shawn lee - CeleStial eleCtriC (eSl MuSiC, ottoBre 2011)<br />
Genere: funk/soul/psych<br />
Davvero mirabolante la parabola artistica di Shawn Lee. Uno che quando non è impegnato a prestare la<br />
propria musica a serie TV (tra le tante, Lost, Desperate Housewives, CSI:Miami, Ugly Betty), videogiochi o<br />
spot, fa del modernariato psych-beat-groove con la sua Pig Pong Orchestra, si spende in collaborazioni di<br />
ogni genere o magari remixa i Thievery Corporation. Il tutto con quell’indole da figlio dei fiori mancato,<br />
un entomologo in trip da blaxploitation impegnato a catalogare tutti i suoni prodotti dal pop di fine<br />
anni Sessanta e inizio Settanta (Ennio Morricone compreso).<br />
Quello è l’universo di riferimento anche per questo Celestial Electric, con un<br />
AM - tre dischi alle spalle in bilico tra pop, funk e soul - chiamato a scrivere<br />
le parti vocali su una serie di beats preparati dal multi-strumentista americano.<br />
In un dialogo che aggiunge livelli ad ogni scambio, dando origine a<br />
un’opera che dal Lee-pensiero riprende attitudine psichedelica e etnicismi<br />
ritmici assortiti, per poi virare verso una musicalità contaminata da ogni<br />
genere di additivo.<br />
Easy listening (City Boy), funky-beat (Jackie Blue), disco-psych-funk (Promies<br />
Are Never Far From Lies), tropicalismo (Down The Line), certi Radiohead assorbiti<br />
dal groove (Dark Into Light), linee vocali stoned in stile Bobby Gillespie<br />
periodo Screamadelica (Can’t Figure It Out): l’universo musicale di Celestial Electric è di quelli nostalgici<br />
solo in apparenza. Risultato in realtà di un lavoro di rielaborazione che evita l’effetto retrò fine a sè stesso<br />
e rinvigorisce gli input di partenza con una ricchezza strumentale sbalorditiva, una scrittura senza<br />
sbavature e arrangiamenti semplicemente perfetti. Da provare.<br />
(7.3/10)<br />
faBrizio zaMPiGhi<br />
l’album primo di un perfetto sconosciuto è fin troppo<br />
curato e ricco di contenuti: fosse uscito per Planet Mu li<br />
avreste visti gli apprezzamenti...<br />
(7/10)<br />
Carlo affatiGato<br />
alva noto - univrS (raSter noton De,<br />
ottoBre 2011)<br />
Genere: Glitch<br />
Alva Noto fa poker, quarta uscita discografica nel 2011.<br />
Questa volta nessuna collaborazione, l’artista tedesco si<br />
presenta da solo e riprende il discorso interrotto tre anni<br />
fa con Unitxt: si torna a parlare di linguaggio, non più da<br />
un punto di vista meramente processuale (ovvero come<br />
pattern, informazione, unità di misura) ma confrontandosi<br />
con l’idea di universalità e le diverse accezioni che<br />
ne possono derivare.<br />
Neanche a dirlo l’universalità di Noto è ancora una volta<br />
immersa nel mondo alfanumerico e matematico. Il<br />
landscape è concetrato nel data-sound: dati trasferiti,<br />
rimodulati e irradiati che rimangono fonemi sonori del<br />
progetto. Univrs ha però un maggior grado di astrazione,<br />
l’attenzione si sposta dal testo alla composizione e di<br />
conseguenza il lavoro risulta più comunicativo e diretto,<br />
in definitiva più godibile. Lo scarto è sottile eppure reale:<br />
diminuisce l’asimmetria, si alzano i beat, e le tessiture<br />
tra l’estetica click & cuts e i pattern ritmici diventano più<br />
armoniose. E’ un’altra lezioncina impartita dal maestro<br />
(Uni Deform, Uni Syc, Uni Rip).<br />
Rimane solo da decidere come collocare l’accoppiata<br />
Unitxt-Univrs nella sua discografia. Dal punto di vista<br />
concettuale questa saga è probabilmente la meno stilmolate,<br />
arrivando leggermente fuori tempo massimo<br />
rispetto all’amico Ikeda con i suoi Datamatics. Di conseguenza<br />
come direbbe Barthes, c’è lo studium ma non il<br />
punctum, anche se lo stato di grazia di quest’anno resta<br />
abbondantemente confermato.<br />
(7.1/10)<br />
Stefano Gaz<br />
42 43
aMen DuneS - throuGh DonkeY Jaw (SaCreD<br />
BoneS, ottoBre 2011)<br />
Genere: psych-wave<br />
Psichedelia confusa è la bislacca definizione che viene<br />
in mente all’ascolto di Through Donkey Jaw. Per il suo secondo<br />
album, l’americano Damon McMahon aka Amen<br />
Dunes, è passato su Sacred Bones - sempre più marchio<br />
di qualità per la crescente scena off americana - ma ha<br />
mantenuto le fondamenta personali e fragili che contraddistinguevano<br />
l’esordio Dia. Quelle di una materia<br />
musicale umorale e umbratile, scivolosa e inclassificabile,<br />
ma sempre ancorata alla quasi ossessiva attrazione<br />
per le sonorità sixties del suo unico responsabile, virate<br />
di volta in volta verso folk, wave, bedroom-pop e sempre<br />
rigorosamente in modalità lo-fi.<br />
Accanto a Damon McMahon stavolta troviamo l’apporto/supporto<br />
di qualche musicista amico, ma quella di<br />
Through Donkey Jaw è sempre farina del suo sacco. A<br />
fornire lo scarto con l’ancora incerto (ma promettente)<br />
esordio è dunque una maggiore padronanza nel gestire<br />
la materia sonora senza steccati né limitazioni ma<br />
sempre in maniera narcolettica, soffusa, sfocata. Da qui<br />
il confusa dell’incipit che tutto vuol essere tranne che<br />
termine dispregiativo. Anzi, vuol mettere in evidenza<br />
come il blob fuso e lo sfattume montante che si respira<br />
nell’album tiri in ballo un ampio spettro di referenti stilistici<br />
e musicali che, se da un lato fanno apparentemente<br />
perdere in coesione, dall’altra promettono eterogeneità<br />
e varianti non esecrabili.<br />
Le ipnosi suadenti e orientaleggianti di Baba Yaga, il<br />
folk atipico e barrettiano di For All o quello “from outer<br />
world” di Lezzy Head, le minimali nenie psych-pop<br />
(Good Bad Dreams, Lower Mind) speso deturpate come<br />
potrebbero intenderle dei Thee Oh Sees sotto dopamina<br />
(Not A Slave) e giù, fino al calderone delle devianze<br />
di effetti e rumorii vari alla Factums meets Suicide di Jill<br />
dicono di forme caleidoscopiche e personali applicazioni<br />
in divenire, migliorabili per ambire alla perfezione<br />
ma validissime come segnalazione dello state of the art<br />
sotterraneo a stelle e strisce.<br />
(7/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
anCher - verDeleGno (Manzanilla,<br />
ottoBre 2011)<br />
Genere: post-rock<br />
Immaginario nordico Sigur Rós, un’indole naturalista<br />
rimarcata dai testi e da un packaging in vero legno, un<br />
mood invernale ed etereo chiamato a far salir brume e<br />
malinconie: per i veronesi Ancher, Verdelegno rappresenta<br />
il possibile aggiornamento del post-rock matrice<br />
del gruppo fin dai tempi delle prime autoproduzioni in<br />
qualcosa di decisamente più personale. Una formula ai<br />
limiti del jazz (il crescendo orchestrale di Ho prugne nella<br />
testa) che flirta con un tropicalismo easy (Ferma Foglia)<br />
e al tempo stesso abbozza qualche citazione cantautorale<br />
(Ninna Nora) su testi in italiano. Il tutto cesellato da<br />
ritorni elettrici (Sai è da quando) e madrigali (E’ arrivato<br />
accordatore), melodia e crescendo vaporosi.<br />
Complessità e immediatezza trovano una curiosa via di<br />
mezzo in questo disco d’esordio, anche se l’impressione<br />
è che all’ascoltatore venga riservato soltanto il ruolo<br />
dell’osservatore passivo chiamato ad apprezzare le trame<br />
raffinatissime e la bravura del gruppo nel crearsi il<br />
proprio spazio estetico. Uno spazio ripiegato su sè stesso<br />
e alla ricerca della pennellata impeccabile, del colpo<br />
di teatro. In altre parole, il disco funziona e per certi versi<br />
stupisce davvero (anche grazie a una strumentazione<br />
ricchissima che comprende banjo, theremin, filicorno,<br />
flauto, archi), pur faticando a creare quel senso di empatia<br />
che invece sarebbe legittimo attendersi. Chiamatelo,<br />
se volete, “difetto”.<br />
(6.9/10)<br />
faBrizio zaMPiGhi<br />
anuSeYe - anuSeYe (interBanG reCorDS,<br />
aGoSto 2011)<br />
Genere: stoner<br />
Pochi ricorderanno, per questioni anagrafiche, uno dei<br />
primi gruppi italiani a trafficare con lo stoner nei 90s.<br />
That’s All Folks! era il nome di quell’esperienza nata,<br />
cresciuta e morta a Bari, immolata al sacro verbo dello<br />
stoner primigenio e nome che portava in nuce già un<br />
senso di malinconico addio. Quello stesso senso di malinconia<br />
virata heavyness chitarristica di cui gli Anuseye<br />
oggi raccolgono il testimone. E non a caso, viene da dire,<br />
dato che a tirare le fila di questo progetto esordiente<br />
sono proprio due colonne portanti di quella band:<br />
Claudio Colaianni, cantante e chitarrista, e Luca Stero<br />
(chitarre). Stabilizzatisi in formazione a quartetto rock<br />
classico (Michele Valla al basso e Antonello Carrante alla<br />
batteria supportano i due axemen), mettono ora in scena<br />
un disco tanto debitore del passato quanto sincero<br />
negli intenti e potente nelle risultanze.<br />
Psych, stoner, krauterie varie, rock’n’roll inacidito, desert-blues<br />
sudista, reiterazione e circolarità. Su queste<br />
coordinate - spesso mischiate in varie gradazioni - si<br />
muovono i quattro in un viaggio sonico che dai Soundgarden<br />
degli esordi passa per gli Screaming Trees più<br />
corposi, indietreggia arrivando allo stoner primordiale<br />
dei Kyuss e dopo dei Queens Of The Stone Age (Head),<br />
per riprendersi in territori acid à la Monster Magnet<br />
highlight<br />
atlaS SounD - Parallax (4aD, noveMBre 2011)<br />
Genere: psych pop<br />
Scriviamolo chiaramente, senza giri di parole: Bradford Cox è un musicista e compositore decisamente<br />
sopra la media della sua generazione. Lo testimonia non solo la creatività fuori dal comune che gli fa<br />
pubblicare una quantità di dischi, sia a nome Deerhunter che in solitaria, che ci si domanda se trovi il<br />
tempo per fare anche altro nella vita. Ma quello che già vedevamo in nuce in Halcyon Digest, con la<br />
nuova prova a nome Atlas Sound è diventato evidente: a differenza di molti act che col passare del<br />
tempo perdono in smalto, i progetti di Cox si affinano e raffinano.<br />
La nuggets-delia è la vena principale di un album dove ritroviamo tanto il il folk più pischedelico (Modern<br />
Aquatics Nightsongs) quanto certa rumorosità che lo ha sempre accompagnato, in più la wave sia<br />
primi sia ultimi 80 (The Shakes, Praying Man: roba da Bono Vox battuto sul suo terreno), il tutto esploso<br />
in un’accessibilità pop che sa di sintesi personale ma anche generazionale.<br />
La liquida e dreamy Te Amo è il compimento di He Would Have Laughed che<br />
chiudeva Halcyon Dygest: un’apertura verso atmosfere cosmiche, ribatite<br />
dalla titletrack, con le tastiere circolari a sostenere un ritornello trasognato<br />
spalmato su effettini da sci-fi. Con Mona Lisa (con il piano suonato da Andrew<br />
VanWyngarden degli MGMT, affini esploratori dell’universo psych)<br />
Cox ribadisce una passione per i R.E.M. che ha sempre fatto capolino qui<br />
e là, e Terra Incognita vede l’allampanato musicista confrontarsi con un l’intimità<br />
di un bozzetto folk-astrale con una strumentazione ridotta all’osso.<br />
Si tratta di una dimensione impensabile solo qualche anno fa, la riprova di una maggiore sicurezza nei<br />
propri mezzi ma anche la volontà di stilare una propria sintesi che sublima nella copertina curata da<br />
Mick Rock, il mitico fotografo di Raw Power, The Madcap Laughs e Transformer.<br />
Impressiona, come sempre, la cura timbrica per ogni singolo suono sia per i brani registrati in albergo<br />
(Terra Incognita e Flagstaff che fa riemergere la vena romantica e androgina di Cox), sia per quelli registrati<br />
al Rare Book Room Studios di Brooklyn assieme al produttore Nicolas Vernhes (già collaboratore<br />
ai tempi di Microcastle).<br />
Il progetto Atlas Sound appare sempre più come un’universo in espansione, nel quale Cox può liberamente<br />
attraversare il folk, il rock, il pop e tutto quello che esiste e declinarlo in una sua personale<br />
interpretazione.<br />
(7.7/10)<br />
MarCo BoSColo<br />
(The Girl At The Corner Of My Heart) o mutanti alla Tool<br />
e raggiungere lidi contemporanei di chi sta tra il misticismo<br />
degli Om e quello più abrasivo di casa Tee Pee<br />
di Naam e Quest For Fire (All Is In Your Eyes). Questa<br />
musica però è tanto mentale quanto fisica, perciò non si<br />
disdegnano nemmeno puntate verso lidi meno espansi,<br />
come quando si spinge sull’acceleratore garage (la monolitica<br />
The Betryal) o del corposo rock’n’roll abbrutito<br />
(Voodoo Lesson #1)<br />
Due ulteriori punti a favore sono la vocalità di Colaianni,<br />
risentita quanto si vuole ma perfettamente adatta<br />
ad ogni passaggio col suo mix di emotività bruciante,<br />
e l’artwork “straniantemente pop” di Massimo Gurnari<br />
che impreziosisce il vinile limited. Nel suo genere, probabilmente<br />
la migliore cosa uscita in Italia quest’anno.<br />
(7/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
BalMorhea - live at Sint-eliSaBethkerk<br />
(BalMorhea, ottoBre 2011)<br />
Genere: classica<br />
Registrato a Gent, in Belgio, nel novembre 2010, Live<br />
at Sint-Elisabethkerk è il primo disco dal vivo dei Balmorhea<br />
e non è il classico live album che ci si potrebbe<br />
aspettare.<br />
Complice il luogo sacro, la perfetta acustica e la rigida<br />
44 45
highlight<br />
BnJMn - BlaCk Square (ruSh hour, ottoBre 2011)<br />
Genere: ambient-house<br />
L’apparizione di Ben Thomas sotto il moniker BNJMN era avvenuta in grande stile all’inizio di quest’anno<br />
con Plastic World, notevole panoramica house ad ampio raggio che coniugava coscienza della tradizione<br />
‘90s e buona autorevolezza rielaborativa: le tracce lì contenute erano state realizzate nel corso degli<br />
ultimi anni e spaziavano tra microhouse, idm, tastierismi e ponti ambient con un’agilità e uno spessore<br />
tali da farlo sembrare il più naturale degli eredi dell’Actress di Hazyville.<br />
Ora però Black Square è già il secondo full-lenght in meno di un anno, con<br />
i nuovi inediti a dipingere l’immagine definitiva del producer britannico e<br />
tracciare una linea evolutiva di rilevanza superiore. E la faccenda inizia ad<br />
essere estremamente seria.<br />
Delle varie ipotesi aperte nel disco precedente BNJMN fa sbocciare quella<br />
più cerebrale e psicotropa, trovando la migliore delle sintesi tra il Nathan<br />
Fake più contemplativo e l’Arandel più minimale: l’olimpo della ambient<br />
music moderna che studia l’arte del loop alla ricerca dell’effetto ipnotico<br />
più suggestivo (vedi Wisdom Of Uncertainty che rielabora irreprensibile le<br />
recenti ricerche di The Field). L’album è attentissimo a mantenere saldi gli equilibri tra vuoto e materia,<br />
stendendo ad esempio tessuti cosmici sui tappeti micro-glitch di Primal Pathways (Four Tet meets Massimiliano<br />
Pagliara) o rimediando alle parentesi naturalistiche più soft ambient (Black Square e l’armonia<br />
Global Communication) con un maggior vigore house (Open The Floodgates è praticamente deep).<br />
Il beat soffuso sta diventando sempre più il partner ideale della nuova ambient, così tagliato per donare<br />
sensualità ad atmosfere che altrimenti rimarrebbero troppo legate alla discendenza idm (ecco allora<br />
Lava, che i nineties li conosce bene ma vuol lasciarseli alle spalle). È il terreno ideale su cui possono giocare<br />
i più ambiziosi ricercatori del suono: si lavora sul dettaglio con precisione scientifica, per catturare<br />
l’ascoltatore nelle suggestioni astratte ed avvolgerlo nel calore indotto, un movimento impercettibile e<br />
si rasenta la perfezione. Qualcosa a cui hanno ambito in tanti, da Murcof a Deepchord fino all’ultimo dei<br />
John Roberts, per poi scoprire che il manifesto estetico lo scrive un ventenne appartato un centinaio<br />
di chilometri fuori Londra. Troppa, troppa grazia.<br />
(7.4/10)<br />
Carlo affatiGato<br />
temperatura, la band unisce rigore e grande intensità<br />
in una scaletta che può contare sull’epicità di Settler e<br />
Night Squall, nella tambureggiante Clamor o in un pezzo<br />
tirato come Untiteled. Non poteva esserci miglior biglietto<br />
da visita per loro.<br />
(7/10)<br />
franCeSCo aSti<br />
BarBaGallo - live at Yoko ono<br />
(autoProDotto, SetteMBre 2011)<br />
Genere: folk blues<br />
Eravamo rimasti alla proiezione prismatica di Carlo Barbagallo<br />
in quel Quarter Century che ne concretizzava<br />
l’indole multiforme, robotica e arcaica, avanguardistica<br />
e basale, spettrale e patafisica. Una cifra espressiva in<br />
espansione che ribadiva l’estro già imprevedibile suggerito<br />
dalle pregresse esperienze (con Albanopower e<br />
Suzanne’s Silver tra le altre cose) del musicista siracusano.<br />
Ed ecco questo Live At Yoko Ono che sembrerebbe<br />
proprio un altrettanto imprevedibile rinculo verso forme<br />
più roots, salvo che trattasi semmai di un prequel dal<br />
momento che l’incisione risale al marzo 2010. Potremmo<br />
interpretarla così: il folk-blues radicale di queste tredici<br />
tracce è il motore che macina al centro del marchingegno,<br />
il cuore sommerso di una calligrafia ramificata ed<br />
espansa. Il grado zero barbagalliano, se preferite.<br />
Immortalato su un palco da solo in semiacustica simbiosi<br />
con la chitarra, eccolo prestarsi brusco e percussivo sulle<br />
corde, la voce una scorza che esala lirismo irrequieto e<br />
pensosità viscerale (Dust, No Place), non troppo distante<br />
dal primo Mark Lanegan o dal rimpianto Layne Staley.<br />
La capacità di distillare tremori contemporanei da materiali<br />
e strutture così pervicacemente “tradizionali” - ovviamente<br />
in chiave angloamericana - è l’aspetto più convincente<br />
della proposta, come è evidente in quella Wait<br />
che non fatichi ad immaginare in stridenti abiti indie, così<br />
come nel languore insidioso di Spectacle e nell’ombroso<br />
smarrimento piuttosto Howe Gelb di Nothing.<br />
Probabilmente i momenti più eterei - come la intensa<br />
Little Island - meriterebbero un tocco più leggero, una<br />
più nitida definizione di dettagli e sfumature, ma a<br />
Barbagallo sembra interessare più che altro il ribollire<br />
delle inquietudini sotto la febbre ruvida, dietro questa<br />
maschera sonora tra le molte che usa indossare. Forse,<br />
sospettiamo, una di quelle che gli somiglia di più.<br />
(6.8/10)<br />
Stefano Solventi<br />
Bill orCutt - how the thinGS SinGS<br />
(eDitionS MeGo, ottoBre 2011)<br />
Genere: alt-finGerpickinG<br />
Può capitare a tutti. Mettere sul piatto un disco con in<br />
copertina nove plettri colorati su cui campeggia il nome<br />
“Stevie Ray Vaughan”, dare l’avvio alla riproduzione e restare<br />
sconcertati e ammettere che il nostro cervello ci sta<br />
facendo pensare a Bill Orcutt. E scoprire che davvero ciò<br />
che stiamo ascoltando è produzione dell’ex-chitarrista<br />
dei Harry Pussy.<br />
How The Things Sings è evoluzione ancora più estrema,<br />
se possibile, di A New Way To Pay Old Debts, maggiormente<br />
densa di varianti e variabili, fermo restando il protagonismo<br />
struggente della seicorde bistrattata e delle<br />
distonalità alla Jandek. Orcutt eccelle nel witz o nel dilatare<br />
le rasoiate e il fingerpicking molesto in avventure meditative<br />
(accennate in The Visible Bosom, prevalenti nella<br />
title-track e paradigmatiche in A Line From Ol’ Man River).<br />
In tutta la mezzora di How The Things Sings Bill ha il controllo<br />
completo della narrazione, è onnisciente anche<br />
quando si cala in uno dei suoi personaggi muti e divelti<br />
dalle stoccate di chitarra, persino mentre segue con le<br />
corde vocali strozzate in gola il pensiero crudele della<br />
chitarra. Siamo a volte portati a pensarlo in scia a quel<br />
John Fahey che tanto ha innovato ma che tanto ha fatto<br />
nascere restauratori. Tanta aggressività verso lo strumnto,<br />
tanta incompatibilità con quelli che siamo abituati a<br />
pensare come temi e pratiche del genere, non fanno che<br />
aumentare lo stupore nello scoprire che questa è forse<br />
la vera dedizione, la vera intimità, fatta di amore e odio,<br />
nei confronti della chitarra. Ed è commuovente.<br />
(7.2/10)<br />
GaSPare Caliri<br />
BJörk - BioPhilia (one little inDian,<br />
ottoBre 2011)<br />
Genere: avant pop<br />
Si rischia di scordare la musica, le canzoni nel caravanserraglio<br />
mediatico allestito dall’islandese per questo<br />
nuovo lavoro. Un album? Macché. Il progetto è molto<br />
più ampio, muove dalle meditazioni filosofico-scientifiche<br />
attraversando come neutrini superluminali la teoria<br />
musicale, per andare poi bellamente a sbattere - pervadendole<br />
- su metafore socio-esistenziali. Parabola umana<br />
troppo umana che spazia dal cosmico al microbiologico<br />
passando dal geologico: una poetica insomma<br />
parecchio strutturata che offre pretesto per dare corpo<br />
ad una app che farà la gioia di tutti i tablet-dipendenti,<br />
ulteriormente solleticati dal fatto che molte delle registrazioni<br />
sono state realizzate con un iPad. Considerata<br />
poi l’apoteosi feticistica - destinata per molti a rimanere<br />
puro desiderio - della deluxe edition da oltre 500 euro,<br />
non si può dire che sia un’uscita di quelle che passano<br />
inosservate.<br />
Viene da chiedersi: si tratta di rumore accessorio frutto<br />
della ben nota fregola arty di Björk o dobbiamo accettare<br />
la possibilità (la necessità) che un’uscita discografica<br />
sia ormai un evento multidisciplinare, di cui la musica è<br />
un aspetto portante ma non più centrale? Sia come sia,<br />
in mezzo a tanto hype rischiamo, appunto, di scordare<br />
le canzoni. Le quali da par loro compensano il deficit di<br />
centralità con una rediviva efficacia rispetto agli ultimi<br />
due opus, vuoi anche per la scelta di soluzioni d’arrangiamento<br />
essenziali ma in compenso (ovviamente) studiatissime,<br />
un po’ come accadeva ai tempi dell’eccellente<br />
Vespertine, tenuto conto delle diverse premesse estetiche.<br />
Parliamo comunque di un disco bjorkiano dalla<br />
prima all’ultima nota (e tra le note), mosso cioè dalla<br />
brama di mettere in discussione il “corpo” del suono<br />
proprio come il corpo - recipiente e simbolo di tutto ciò<br />
che concerne l’umano - viene sottoposto alla pressione<br />
mutante dei nuovi contesti, senza mai perdere di vista<br />
il lavorio delle forze ataviche, la potenza invisibile delle<br />
leggi di natura.<br />
Un agone - mi sia consentito dire - kubrickiano che trova<br />
puntuale riflesso nella bella Cosmogony, nella quale<br />
un afflato melodico da musical anni Cinquanta decolla<br />
nello spazio profondo intanto che il coro inuit ci apparecchia<br />
un bordone angelicamente angoscioso, al punto<br />
da farti ripensare alle sequenze del monolite (il tablet<br />
primigenio?) in 2001 - Odissea nello spazio. Ecco, questo<br />
è quello che più ci piace di Björk, l’utilizzo di materiale<br />
pop con finalità espressive “alte”, di ricerca anche<br />
spirituale, tenendo salda la barra della spettacolarità.<br />
In questo senso, Virus fila dritta nel miglior canzoniere<br />
46 47
dell’islandesina, con le sue evoluzioni vocali accorate e<br />
l’ipnotico incrocio d’arpeggi orientaleggianti. Assieme<br />
a lei Crystalline, dramma algido ed esotismi stranianti<br />
(da sottolineare l’uso del “gameleste”, una diavoleria a<br />
metà strada tra gamelan e celeste) cotti su una graticola<br />
sincopata destinati ad incendiarsi drum and bass nel<br />
caotico finale.<br />
Buone notizie anche da Moon col suo loop onirico e<br />
da quella Thunderbolt che accende le bobine di Tesla<br />
facendo ripensare a certe soffici inquietudini del primo<br />
Peter Gabriel. Altrove gli intenti sembrano sovrastare<br />
le possibilità, ad esempio in una Dark Matter che s’accartoccia<br />
ostica un attimo prima di sembrare affascinante,<br />
in una Hollow che s’accontenta di sembrare Saint-Saëns<br />
dentro un incubo androide scordandosi di azzeccare la<br />
melodia, e in quella Mutual Core che tenta di saldare<br />
due buone idee - le strofe suadenti ed un ritornello che<br />
sussulta latinerie sintetiche - ma abbastanza estranee<br />
tra di loro.<br />
Da tutto ciò esco con la sensazione che l’ex-Sugarcubes<br />
abbia accettato di buon grado il fatto di non poter più<br />
competere sul fronte dell’avanguardia musicale. Magari<br />
neanche le interessava più, dopo tanto avanguardizzare,<br />
e ha preferito allargare il raggio d’azione nel solco delle<br />
possibilità e modalità offerte dai nuovi media, obbedendo<br />
così al bisogno impellente di portare lo sguardo<br />
sempre un passo oltre i margini rassicuranti del consolidato.<br />
A costo di sembrare un po’ sola in questa corsa<br />
verso l’inedito prossimo venturo.<br />
(6.9/10)<br />
Stefano Solventi<br />
Brett anDerSon - BlaCk rainBowS (B a<br />
SonGS, ottoBre 2011)<br />
Genere: rock pop<br />
Proprio quando la band originale, quegli Suede che<br />
hanno consegnato alla storia la sua figura, stanno per<br />
tornare in studio per un nuovo disco (comunque senza<br />
Bernard Butler), Brett Anderson se ne esce con la sua<br />
quarta prova solista. Ce n’era bisogno? Dopo i fallimenti<br />
delle prime prove (Brett Anderson del 2007, Wilderness<br />
del 2008, e la parziale riuscita di Slow Attack del 2009),<br />
oltre alla non riuscitissima prova di Here Come The Tears<br />
del 2005 (allora non in solitaria, ma con lo stesso Butler)<br />
forse la risposta potrebbe essere un bel no. Eppure...<br />
Eppure qualcosa deve aver spinto Brett Anderson a<br />
continuare a spingere e investire sulla propria carriera.<br />
E questo Black Rainbows non è nemmeno così terribile<br />
come le premesse potevano far credere: sarà l’indolenza<br />
romantica di Unsung, saranno gli echi tanto 90s di Crash<br />
About to Happen, sarà che per la prima volta tornano in<br />
evidenza le chitarre, ma l’ascolto non è così fastidioso<br />
come ci era capitato di sentire in altre occasioni soliste.<br />
Fatto sta che nonostante non ci si aspettasse niente di<br />
nuovo dall’opera quarta di Anderson, e nonostante la<br />
vera attesa sarà tutta per la band ritornata in carreggiata,<br />
questo Black Rainbows raggiunge la decenza. Non<br />
raccoglierà i consensi nemmeno dei nostalgici, però<br />
almeno c’è ostinazione<br />
(5.5/10)<br />
MarCo BoSColo<br />
Broken heart ColleCtor - Broken heart<br />
ColleCtor (DiSCorPorate reCorDS,<br />
SetteMBre 2011)<br />
Genere: avant-rock<br />
C’è tutto lo spirito mitteleuropeo dentro i Broken Heart<br />
Collector. D’altronde che poteva venire fuori dall’incontro<br />
di una band austriaca con una cantante slovena? C’è<br />
il sapore e l’eleganza di un Europa di inizio ‘900 che si<br />
trasfondono in atmosfere marcatamente espressioniste.<br />
Non è mero revival di un’epoca passata ma incontro tra<br />
tendenze artistiche di un’epoca (che ormai ci pare quasi<br />
più antica che passata) e contemporaneità.<br />
Nei Broken Heart Collector convivono infatti sonorità<br />
post-rock (quello degli Slint) e asperità sperimentali con<br />
una tragicità di matrice quasi gotica, di un gotico mai<br />
goth però. Rappresentazione massima di questa tendenza<br />
è Eckig dove il clarinetto di Susanna Gartmayer e<br />
la voce di Maja Osojnik intonano un canto disperato che<br />
il resto della band ingloba in un vortice che manda in<br />
pezzi tutta l’aria intorno. Ma si potrebbero anche citare<br />
il gioco di silenzi Love Reclamation Song o la più jazzata<br />
Another heart bites the dust.<br />
Il primo disco dei Broken Heart Collector convince e ci<br />
regala momenti di grande eleganza. C’è da trovare maggior<br />
concentrazione e da affinare alcune tattiche, ma è<br />
un debutto che non rimane certo inosservato.<br />
(7/10)<br />
franCeSCo aSti<br />
Cave - neverenDleSS (DraG CitY, SetteMBre<br />
2011)<br />
Genere: psych-kraut<br />
Sta tutto nel titolo il senso del comeback del duo americano.<br />
Che, a ben vedere, fa il paio con quello che contraddistingueva<br />
l’esordio vero e proprio un paio di anni<br />
addietro - Psychic Psummer, per Important - in nome di<br />
una voglia matta di psichedelia retrò. Nulla di nuovo<br />
sotto il sole, vedi alla voce Wooden Shjips et similia:<br />
una grassa psych reiterata e follemente innamorata di<br />
devianze heavy-rock quanto di elementari risvolti kraut<br />
alla Neu!. Certo che catalogarli come emuli della nuova<br />
ondata psych-kraut d’oltreoceano sarebbe limitativo e<br />
pure un po’ irrispettoso per gente che, comunque sia,<br />
sta in giro da qualche annetto. Però è innegabile che<br />
lunghe jam come OJ o WUJ si nutrano di reiterazioni<br />
ossessive e vintage, motorik di chiara matrice deutsch<br />
a tutto basso/batteria, slanci di psichedelia fluttuante<br />
alla Spacemen 3 sempre innervato da una vena sixties<br />
che scorre sottotraccia (l’organo ad libitum che guida i<br />
14 lunghi e devastanti minuti di This Is The Best) e da una<br />
capacità strumentale da panzer-attack (Adam Roberts).<br />
Tutto rigorosamente strumentale senza che l’assenza<br />
della voce risulti penalizzante.<br />
Disco godibilissimo, ma anche piuttosto statico tanto<br />
che paradossalmente l’episodio migliore risulta essere<br />
la pacificata e riflessiva On The Rise. Non che la staticità<br />
sia un difetto soprattutto in questo ambito, ma si può e<br />
si deve fare uno sforzo ulteriore.<br />
(6.5/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
Civil CiviC - ruleS (autoProDotto,<br />
noveMBre 2011)<br />
Genere: electro-rock<br />
I Civil Civic sono Aaron Cupples e Ben Green. Chitarra<br />
il primo, basso il secondo (più noises per entrambi), i<br />
due vengono dall’Australia ma si dividono tra Londra e<br />
Barcellona e ora, dopo un ep di esordio in cui rodavano<br />
la loro energica formula al guado tra wave muscolare,<br />
attitudine noise ed dance bislacca, arrivano all’esordio<br />
con Rules.<br />
Sulle dieci tracce strumentali del full-length aleggia<br />
sempre lo spettro battlesiano - le fratture ritmiche, la<br />
nuova elettronica al servizio del math-rock corposo e<br />
vario - così come il mix iconoclasta di electro virata rock<br />
in dancehall style che fu dei troppo presto dimenticati<br />
Death From Above 1979, e ci meraviglieremmo del<br />
contrario, vista l’influenza che i primi hanno avuto sul<br />
connubio electro-rock contemporaneo e la sottovalutazione<br />
che ha colpito i secondi.<br />
Con la loro fedele drum-machine The Box e qualche ammennicolo<br />
elettronico (synth e tastiere), il duo innerva<br />
le bordate di chitarra e basso muovendosi con nonchalance<br />
tra accenti nu-gaze ritmati (Airspray) e anthemiche<br />
aperture wave-disco (Run Overdrive), senza farsi mancare<br />
graffianti e incompromissorie esplosioni noise (Street<br />
Trap, Less Unless) o incursioni in territori wavey (Lights<br />
On A Leash parte come i Cure d’antan strumentali pompati<br />
oltre misura di steroidi).<br />
Le bizzarre aperture spacey-coatte in crescendo di Sky<br />
Delay o quelle noise-pop di Slack Year (lo shoegaze al<br />
tempo delle macchine?) così come le pestone reminiscenze<br />
Battles di Less Unless - più di un occhio strizzato<br />
al dancehall alternativo - dicono di una band con le<br />
idee chiare nell’unire istanze apparentemente diverse<br />
- prog, electro, indie, dance, pop, math, ecc. - con piglio<br />
irriverente e sardonico. Si definiscono “instrumental<br />
no-nonsense no-wave pop” e per quel che può valere,<br />
l’autodefinizione ha pienamente senso. Certo è che il<br />
senso di deja-vu è piuttosto evidente.<br />
(6.4/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
Clizia - koMBinat (SYnC, ottoBre 2011)<br />
Genere: ambient<br />
In cinque tracce, per 300 copie in un EP 10 pollici, consiste<br />
la materia dell’esordio di Andrea De Witt sotto il<br />
moniker Clizia. L’ex-Spin Boltak entra nella nuova decade<br />
proponendo come già accaduto una riflessione<br />
sull’ambient applicata alla ripetizione, sia come momento<br />
esecutivo sia come output musicale.<br />
La quasi assenza di ritmo dà vita a una ciclicità quasi<br />
paranoica, anche se dilatata e quindi non esplicitamente<br />
inquietante. I fine Novanta delle microwave e dilatazioni<br />
ambientali sono vicini, forse più delle parabole<br />
elettroacustiche di sottobosco che negli ultimi anni ha<br />
prodotto risultati di eccellenza in Italia. De Witt sposa in<br />
particolare sonorità riconoscibili (quella del pianoforte<br />
soprattutto, lontano come se fosse vittima di un field<br />
recording di vicinato, messo in loop mentre esegue un<br />
tema spezzato in Distance).<br />
La qualità è nella restituzione di un ambiente più che<br />
nel calibro dei timbri. Kombinat, del resto, allude alle<br />
massicce strutture produttive che furono aldilà del Muro<br />
di Berlino. Un tempo che fu, annebbiato alla meglio.<br />
(6.6/10)<br />
GaSPare Caliri<br />
ColDPlaY - MYlo xYloto (ParloPhone,<br />
ottoBre 2011)<br />
Genere: pop<br />
Ad un corso di music marketing i Coldplay sbancherebbero<br />
con un trenta e lode assicurato: annuncio di<br />
scioglimento immediatamente prima dell’uscita del disco,<br />
dichiarazioni di voler salire sul podio dello stardom<br />
internazionale e di ‘fare a gara’ con Bieber, anticipazioni<br />
di singoli con personaggi ubermainstream (Princess Of<br />
China con Rihanna), un vago sapore ‘undergound’ (il<br />
disco si dice sia stato ispirato dai graffiti newyorchesi<br />
degli anni Settanta e dalla resistenza antinazista del movimento<br />
della Rosa Bianca), tutte mosse di una perfetta<br />
strategia di vendita 2.0.<br />
48 49
Se si esula dal mercato (possiamo farne a meno?), il<br />
giudizio sul nuovo lavoro non può che evidenziare una<br />
stagnante maturità compositiva che non si discosta dalle<br />
note e abusate coordinate di riferimento del combo<br />
britannico: le chitarre in eco The Edge (Major Minus),<br />
il percussivismo indie degli Arcade Fire mescolato a<br />
una certa nostalgia wave (Hurts Live Heaven fa il verso<br />
al capolavoro dei Cure), i lunghissimi vocalizzi marchiodi-fabbrica<br />
di Chris Martin e per finire la comodissima<br />
co-produzione di Brian Eno.<br />
Il disco ha pure degli apici (l’inno da stadio Paradise, la<br />
progressività di Charlie Brown), c’è pure qualche tocco<br />
di elettronica (M.M.I.X.) mescolato alle inevitabili ballad<br />
(Us Against The World e la radioheadiana Up In Flames).<br />
Il tutto è permeato da un sentimento di positività schematico<br />
ma funzionale: la costruzione della canzone-tipo<br />
parte in sordina, con pochi strumenti e poi esplode grazie<br />
all’aggiunta di orchestrazione, effetti e armonie prevedibili<br />
e in ultima analisi consolatorie. Su questo semplice<br />
algoritmo reiterato allo sfinimento, Mylo Xyloto<br />
non aggiunge nulla a quanto già sapevamo del suono<br />
Coldplay e risulta essere il pretesto per l’ennesimo tour<br />
di sold out. Prescindibile.<br />
(5.5/10)<br />
MarCo BraGGion<br />
CuBenx - on Your own aGain (infiné,<br />
noveMBre 2011)<br />
Genere: tech-GazinG<br />
César Urbina, in arte Cubenx, sembra il nuovo erede delle<br />
poetiche di Agoria, Apparat (con cui ha lavorato nel<br />
recente The Devil’s Walk) e Telefon Tel Aviv. Il giovane<br />
messicano esce infatti per la francese InFiné, etichetta<br />
sensibile sia ai sudamericani (vedi la ristampa Murcofiana<br />
de La Sangre Iluminada), sia al suono post-minimal.<br />
Il vero e proprio debutto di César (che segue la prima<br />
uscita del 2008 The Cold Swells - una raccolta di singoli<br />
e di EP techno) deve molto alle elettroniche intimiste e<br />
minimal dei tre artisti sopra citati (Lovebirds su tutte) e<br />
aggiunge tra le sue fonti sbadilate di shoegazing chitarristico<br />
Novanta e altre coordinate apparentemente lontane:<br />
Grass sembra una delle migliori litanie dei Grant<br />
Lee Buffalo degli esordi, Noir ci va di organic-electro à<br />
la Amon Tobin mescolata a influenze prog kraut, Wait<br />
And See torna per qualche minuto ai click e ai laser deep<br />
e Sun Dried starebbe bene in uno dei prossimi singoli di<br />
Washed Out.<br />
Il passaggio dalla techno al (quasi totale) songwriting<br />
cantato e suonato non è così indolore, ma Cubenx sa<br />
come amministrare bene le sue idee, costruendo un lavoro<br />
eterogeneo e al contempo coeso, personale e con<br />
uno stile maturo, senza sbavature. Da tener d’occhio.<br />
(7/10)<br />
MarCo BraGGion<br />
CYMBalS eat GuitarS - lenSeS alien<br />
(MeMPhiS inDuStrieS, SetteMBre 2011)<br />
Genere: art rock<br />
Ci eravamo convinti che la definizione di un alternativo<br />
radiofonico dei Novanta, la possibilità di un mainstream<br />
strutturato e sghembo, indocile e visionario, struggente<br />
e minaccioso, avesse raggiunto il massimo risultato ottenibile,<br />
travolto poi dal gran bazaar del revivalismo coercitivo<br />
anni Zero. E invece no. Qualcosa di potentemente<br />
irrisolto è rimasto sospeso a metà del tuffo. Un filo<br />
sfilacciato ma ancora scoppiettante a cui si aggrappano<br />
tra gli altri i newyorkesi - di Staten Island - Cymbals Eat<br />
Guitars, quartetto che si è guadagnato le attenzioni<br />
dell’ambiente con l’esordio autoprodotto Why There<br />
Are Mountains del 2009. Di cui il fresco Lenses Alien<br />
è il degno sophomore, prova decisamente più matura<br />
e destinata ad accrescere le quotazioni della giovane<br />
band.<br />
Dieci tracce concepite per le playlist radiofoniche di un<br />
mondo migliore, disposto ad accogliere la complessità<br />
tra le caratteristiche del catchy, a farsi strattonare in<br />
luoghi emotivi diversi e inconsueti quando già si era<br />
accoccolato nella confortevolezza consueta d’una ballad,<br />
a farsi pizzicare da irrequietezze corrosive quando<br />
già cavalcava la baldanza liberatoria di un riff hardcore.<br />
Gli 8 minuti e mezzo della opener Rifle Eyesight (Proper<br />
Name) sono una specie di imprinting estetico e poetico<br />
assieme: mini suite che consuma cambi di scena e<br />
spersa visionarietà tra dinoccolata irruenza lo-fi e guizzi<br />
nevrastenici Jane’s Addiction, noise onirico e wave-folk<br />
radente Wall Of Voodoo, complicazioni arty ed incandescenze<br />
Guided By Voices.<br />
Su questo solco la scaletta dipana vampe e tremori, tensioni<br />
e rilasci, ora prevale un piglio melodico tagliente<br />
Built To Spill (Keep Me Waiting) e poi il trasporto sperso<br />
Red House Painters (Wavelenghts), altrove la calligrafia<br />
Kozelek si stempera col piglio focoso J Mascis, oppure<br />
è un arpeggio claudicante e vorticoso Pavement<br />
ad ubriacarsi di fregola hardcore e catalessi post-folk<br />
(Secret Family). Frequenze che oscillano attorno ad una<br />
portante forte, accesa di passione febbrile come i primi<br />
indimenticabili Neutral Milk Hotel, capace di sciorinare<br />
influenze diverse e sparse, tipo l’enfasi radente Waterboys<br />
tra le brume dreamy di The Current o certo didascalismo<br />
arguto Tears For Fears nelle strofe di Shore<br />
Points.<br />
Va tutto bene anzi benissimo finché i quattro - ben<br />
highlight<br />
Bonnie “PrinCe” BillY - wolfroY GoeS to town (DoMino, ottoBre 2011)<br />
Genere: country folk<br />
Stavo giusto scivolando nella patina del primo ascolto di questo Wolfroy Goes To Town, il quattordicesimo<br />
- se non ho fatto male i conti - firmato Bonnie “Prince” Billy, quando mi viene la sensazione che<br />
stavolta il buon Will ha mancato il bersaglio. Ma col barbuto di Louisville<br />
non è mai semplice come sembra. Nel bene e nel male. Infatti, come succedeva<br />
coi dischi d’una volta, già al secondo passaggio i trapassi armonici,<br />
le vibrazioni dell’arrangiamento e il fascino agrodolce delle melodie hanno<br />
preso a circolare come un carezzevole veleno. A deludermi di primo acchito<br />
era stato quel senso di conformita’ ai canoni storici del folk-rock, per nulla<br />
assolto - anzi - da qualche passaggio più meditato e scostante. In realta’ ho<br />
confuso il fine col mezzo, come spesso succede.<br />
Difatti si tratta pur sempre della tipica riarticolazione delle particelle elementari<br />
folk, che nell’Oldham degli esordi esprimeva un senso di dispersione,<br />
di perdita di fede nel mezzo e nei riferimenti. Un folk attonito, sconcertato, che pure trovava la<br />
forza di camminare sulle proprie gambe, di ricominciare a cantare la quotidiamita’ dimenticata. Già nei<br />
dischi post- Palace la sua musica godeva di una autorevolezza rinnovata, intensità e struggimento<br />
antigraziosi, ancora scossi di brume fin de siecle ma in grado come pochi di dar voce ai turbamenti<br />
dell’anima. Quel percorso, passato dai capolavori che sappiamo, trova continuità in quest’ultimo lavoro,<br />
dove i minimi termini dell’orchestrazione (acustiche con parche e mirate puntellature elettriche) rappresentano<br />
un segnale di alterità, la necessaria distanza dalla caciara delle new releases per stabilire un<br />
punto di osservazione/narrazione in grado di esprimere con ritrovata intensità situazioni di ordinaria<br />
irrequietezza esistenziale.<br />
Country-folk e folk-rock che sanno di essere stati relegati da tempo nelle retrovie di chi racconta il<br />
presente, eppure hanno la serica tenacia di proporsi come la calligrafia più opportuna per affrescare le<br />
dinamiche emotive al tempo della Grande Crisi. L’accorata mestizia di Black Captain, il Gram Parsons<br />
ruspante di Quail And Dumplings, il Cash grave e languidone di New Match, una New Tibet che si disimpegna<br />
cruda con lirismo sospeso Jason Molina, quella We Are Unhappy che ciondola sulla linea della<br />
commozione Low...<br />
Ok, non tutto convince fino in fondo, ma nulla delude o stona, ed ogni eccesso di pensosita’ e’ assolto<br />
da ambientazioni particolari (l’estro weird di New Walhing, le suggestioni british di Cow) o da un senso<br />
di solenne, pietosa, implacabile tensione (There will be a spring). Sono le manovre di assestamento di<br />
un album straordinariamente intenso sotto la quiete apparente, ben interpretato (ottimo il controcanto<br />
della brava Angel Olson) e ispirato come in tutta franchezza non ci aspettavamo piu’ da quella ucronia<br />
vivente altrimenti conosciuta come Will Oldham.<br />
(7.4/10)<br />
Stefano Solventi<br />
prodotti da quel volpone di John Agnello - tengono<br />
stretta la belva multicefala per la collottola, tanto che<br />
credi persino d’esserti finalmente imbattuto nell’inizio<br />
di qualcosa di nuovo e fruttuoso dopo anni passati ad<br />
osservare l’inaridirsi delle prospettive. Piano però con gli<br />
entusiasmi: in pezzi quali Plainclothes, Gary Condit o Definite<br />
Darkness il carosello si fa un po’ troppo schematico,<br />
il gioco non regge la tensione e scorgi le impalcature<br />
dietro le quinte. C’è insomma come un deficit di sostanza<br />
che non giustifica la partita fino in fondo. Dubbi che<br />
si aggirano come nuvolette sull’altezza delle aspettative:<br />
non vorrei che finissero per diventare “solo” i cuginetti<br />
estrosi e un po’ scellerati dei Coldplay.<br />
(6.8/10)<br />
Stefano Solventi<br />
50 51
highlight<br />
Dani Male - MitoMania (MuSiCa SBaGliata, noveMBre 2011)<br />
Genere: musicasbaGliata<br />
La sua robaccia solista non è ascoltabile, siamo all’autismo di Daniel Johnston in versione manicomio criminale.<br />
La cosa peggiore è che c’è pure chi lo fa suonare in pubblico (utente sul forum di Ondarock) (da<br />
facebook.com/danjihgfedcba).<br />
Non c’è migliore presentazione di questa per Dani Male, the one man bed,<br />
l’uomomaterasso, cantante/musicista impegnato nell’Asociale, 26 anni da<br />
Modena. Il ritratto indiziario si completa alla grande con altre tracce sparse<br />
per il web: le acide prese per il culo dell’indie italiano (Luci della centrale<br />
elettrica e Manuel Agnelli), le versioni residentsiane di Scende la pioggia di<br />
Morandi e del Christmas Carol dei Chipmunks, lo stupro ai danni dei Beatles<br />
e le rendition al contrario rispettosissime dei Velvet Underground (Heroin<br />
e Sister Ray). Dani lo avevamo già incrociato su SA, per un tributo ai Joy<br />
Division prima e poi per il primo album, Trauma Turgido (2010). Mitomania,<br />
fino all’ultimo programmato su Snowdonia (dove pure è in cantiere il<br />
concept dei Maisie su mitomani e rockstar), inaugura l’etichetta personale Musica Sbagliata e riprende,<br />
con maggiore equilibrio (ovviamente sempre storto), il discorso dell’esordio.<br />
Quella di Dani è una musica che si prende amaramente per il culo, tra raccherroll (coordinate bluesy<br />
e folkie), demenza skiantosiana e lirismo surreal-depresso: ecco, Mitomania è un disco depresso che<br />
si sforza di (far) sorridere, un disco dal candore quasi adolescenziale. Un po’ Bugo, un po’ Alessandro<br />
Fiori, un po’ Morgan (proprio per la pasta timbrica della voce), Dani sorprende con un album dalle trame<br />
musicali molto morbide (sfiorando più volte la delicatezza, come in La canzone di Tenco), stilizzate,<br />
quasi-classiche (nel senso del classic rock e del pop italiano con la P maiuscola degli anni Settanta),<br />
giocando con la banalità delle rime e delle parole, rinchiuso - al di là delle invettive socio-musicali - in un<br />
ambiente domestico che sembra l’unico orizzonte d’azione possibile, orizzonte opprimente, dimensione<br />
ad un tempo iperrealistica e onirica.<br />
Non c’è un pezzo da buttare, dagli Skiantos/Wolfango dell’incipitaria title track, fino al mantra trip-hop<br />
di Amnios, ma a noi sono piaciute particolarmente le agrodolci Congelatore, Malevita (qualcosa come dei<br />
Doors in salsa lounge/country-western, altezza Love Streets) e Novità. Per chi ama il disagio e la poesia<br />
semplice e imperfetta, da mettere accanto - ovviamente, con tutte le differenze del caso - alle meglio<br />
cose indie italiane (Dani non t’incazzare!) degli ultimi anni, tra Snowdonia, Trovarobato e dintorni.<br />
(7.5/10)<br />
GaBriele Marino<br />
DaDaMatto - aneMa e Core (faCe like a froG,<br />
noveMBre 2011)<br />
Genere: inDie rock<br />
A colpire subito, inserendo il dischetto nel lettore, è<br />
l’enorme flusso di coscienza che domina le nove tracce<br />
di questa musica libera e sghemba. Parole scritte da chi<br />
è già abbondantemente disilluso ancor prima di vedersi<br />
ingrigire la chioma. Ma anche no. Prodotto da Manuele<br />
“Max Stirner” Fusaroli (Red Worms’ Farm, Zen Circus e<br />
Brian Ritchie, tra gli altri), Anema e Core è una miccia<br />
di appena trentatre minuti, che tuttavia sorprende per<br />
la vena ironica nient’affatto scontata; un lavoro in cui la<br />
dimensione cantautorale si fonde con arrangiamenti di<br />
rilievo, e che trova nei testi il suo massimo punto di forza.<br />
Il trio di Senigallia, ormai giunto alla terza prova, ha in un<br />
certo senso tradito il punk-rock degli esordi in favore di<br />
un sound meno spigoloso e che ricorda, qua e là, i primi<br />
Baustelle e il menestrello lo-fi Bugo, senza però cadere<br />
nella fin troppo banale trappola della emulazione. Ed è<br />
così che ci si scopre ad annuire con la testa mentre Abbiam<br />
finito per perdere (“siam morti da troppi anni ormai,<br />
ma lo sappiamo solo noi/e noi venuti dopo i settanta<br />
siamo nati già morti e già sepolti ”) conduce, irrimediabilmente,<br />
ai bocconi amari di tutti i giorni.<br />
Tra dilemmi post adolescenziali (la title track posta in<br />
apertura) e citazionismo fine (“sappiate che a volte la<br />
rassegnazione all’eroismo non ha nulla da invidiare”,<br />
Sergio Citti, da Stanca Puttana), la “rabbia giovane” dei<br />
Dadamatto si fa grande ne Il cantico delle creature e si<br />
stempera nella folle arrendevolezza di Semaforo rosso;<br />
si burla dei tempi moderni (“Mi c’hai mandato pure tu,<br />
con un sms”, da Canzone in 3D) e persino d’un famoso<br />
ponte della discordia (“Tra il bene e il male c’è di mezzo il<br />
mare/Tra il dire e il fare, la voglia di nuotare/Oh mio Dio,<br />
che paura. Padre mio, che fregatura”, da Scilla e Cariddi).<br />
Ma, alla fine, “se tutto è compiuto, bisogna cogliere<br />
l’attimo” (da Il netturbino). Ed è allora uno spiraglio di<br />
luce a prevalere (“E’ un po’ che ho smesso di fumare,<br />
quanto mi costa fatica, ma in fin dei conti viva la vida”,<br />
da William Shakespeare). Indie-songs per giovani cuori<br />
infranti, nell’attesa di uccidere il sistema.<br />
(7/10)<br />
feDeriCa venezia<br />
Dark CaPtain - DeaD leGS & aliBiS (loaf,<br />
noveMBre 2011)<br />
Genere: alt - folk<br />
Ritornano a tre anni di distanza dal delizioso Miracle<br />
Kicker i Dark Captain, band alt folk londinese, capace<br />
di ridefinire con pochi tratti una scena neo folk appena<br />
dipinta in terra d’Albione, seppur sulla scia dei pesi<br />
massimi statunitensi Fleet Foxes e Midlake. Il risultato?<br />
Una mezza delusione.<br />
Il sabbioso Dead Legs & Alibis li ritrae prima affaticati nel<br />
rincorrere i My Bloody Valentine più disossati (3 Years<br />
To Go), e poi i Sophia più accelerati (Submarines), irrimediabilmente<br />
senza la divinità di Sheppard a impreziosire<br />
il tutto. L’immobilità eterea di Long Distance Driver non<br />
viene risollevata dai fiati calexiani della successiva 80000<br />
Reasons. Right Way Round ricalca le gesta stilistiche degli<br />
Stone Roses riducendo tutto all’osso, nascondendo<br />
l’anima all’ascoltatore. Il tutto ristagna in una ripetitività<br />
senza via d’uscita, così ostentata dal rendere quasi<br />
necessaria un’etichettatura dell’intero lavoro sotto la<br />
voce noia, nuda e pura. E seppur si volesse elevare la<br />
frase di cui sopra a pregio, a nota di merito, come se le<br />
critiche supposte rivelassero in realtà una precisa ragion<br />
d’essere musica - ottusa e fedele a se stessa certo, ma<br />
perlomeno minuziosa nella sua componente critica - ci<br />
si ritrova a rilegare l’intera opera ad analisi filologica, letterale<br />
e inconsapevole della componente ripetitiva poi<br />
rimodellata a noia, in bilico tra un passato non ancora<br />
metabolizzato e un futuro invisibile, senza fame.<br />
Non c’è esistenza, vita, nell’immobilità compositiva dei<br />
Dark Captain, e come la noia moraviana, il tutto scivola<br />
via, lasciando nell’aria un retrogusto alt-country piacevole<br />
e un attimo dopo dimenticabile, nient’altro.<br />
(6.1/10)<br />
feDeriCo Pevere<br />
DaviD Maranha/GaBriel ferranDini - a<br />
fonte De aretuSa (MazaGran, SetteMBre<br />
2011)<br />
Genere: impro<br />
È uno dei nostri “protetti” il portoghese David Maranha.<br />
Un artista di cui spesso ci siamo occupati e che abbiamo<br />
sempre ammirato per la capacità di fondere istanze<br />
d’avanguardia con una materia elegantemente rock,<br />
come successe per l’ottimo Marches Of The New World o<br />
per il successivo Antartica. In quei casi era il rock d’origine<br />
velvetiana ad essere sottoposto ad un trattamento<br />
di elongazione, quasi di sfaldamento del canone stesso<br />
alla base di quella materia oscuramente rock, mediato<br />
da una capacità ossessiva figlia del minimalismo meno<br />
eterodosso e dello sperimentalismo timbrico più acceso.<br />
Ora in A Fonte De Aretusa - omaggio al mitico specchio<br />
d’acqua siracusano che ha sempre attratto poeti da<br />
Pindaro a D’Annunzio, da Milton a Pope - il portoghese<br />
unisce le proprie forze con un giovane e talentuoso<br />
drummer, Gabriel Ferrandini, e sposta la propria visuale<br />
sull’avant-rock più claudicante e oscuro. La formula<br />
hammond/batteria non perde in ossessività, sia chiaro,<br />
ma l’aggiunta di un drumming così vario e pulsante rende<br />
la fiumana droney dell’organo di Maranha ancor più<br />
libera di indagare i meandri più ossessivi/ossessionati<br />
della visuale musicale del portoghese, ma facendola risultare<br />
più viva e devastante, ipnotica e cerebrale che<br />
in passato.<br />
L’album nasce da una sessione live catturata in quel<br />
del ZDB di Lisbona e poi suddivisa in due cut, uno per<br />
facciata di vinile che mettono in chiaro, se ce ne fosse<br />
bisogno, lo spessore del progetto Maranha. Dopotutto,<br />
ce lo confessava nello speciale Ad Libitum di un paio di<br />
ani fa: la visione sonora del portoghese è un continuum<br />
senza soluzione in cui le origini lontane - l’esperienza<br />
Osso Exotico, il solo album Circunscrita - non sono poi<br />
così lontane.<br />
(7.3/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
Dfrnt - eMotional reSPonSe (nu<br />
DireCtionS, luGlio 2011)<br />
Genere: post-Dubstep<br />
Lui è Alex Cowles, scozzese, e da quattro anni si fa interprete<br />
di alcune teorie bass/step personali, lontane dai<br />
trend più battuti. Era il 2009 quando l’album Metafiction<br />
52 53
portò a termine un percorso introspettivo cominciato<br />
l’anno prima nel Forward Thinking EP, chiudendo il cerchio<br />
con un dub ambientale virato IDM dalle buone<br />
prerogative emozionali. Ora però il ragazzo ingrana la<br />
marcia e prende posto tra le file post-, sfoderando nel<br />
quasi-album Emotional Response un ventaglio di proposta<br />
di tutto rispetto.<br />
Germinazioni soul lungo tessuti step mai così luminosi<br />
(con True siamo ben oltre SBTRKT), trip dal fascino<br />
Bjork riflessi attraverso il ghiaccio (Slumber) e aspirazioni<br />
al clubbing londinese (nemmeno troppo estranee alle<br />
proprie radici d’n’b/rave, Relentless), ma anche filatelia<br />
ambient-techno della miglior stoffa Plaid (Rampant Behavior)<br />
e alleggerimenti space dal synth sinuoso (Short<br />
Bus). C’è ancora abbondante spazio di manovra tra i<br />
banchetti più raffinati del nuovo dubstep, con le prospettive<br />
più interessanti che rimangono nascoste nelle<br />
uscite a breve formato. Steppers da cuffia drizzate le<br />
orecchie, la contesa per il prossimo album-bomba è già<br />
cominciata.<br />
(7/10)<br />
Carlo affatiGato<br />
Die Selektion - Die Selektion (faBrika<br />
reCorDS , SetteMBre 2011)<br />
Genere: Dark-wave / ebm<br />
I Die Selektion sono un giovanissimo trio di stanza a<br />
Berlino dedito al culto della wave mid-80’s che più corvina<br />
non si può. Non sono certo gli unici a mischiare<br />
Grauzone, i Death in June dance di Nada! e i beat di<br />
elettronica prepotenza stile EBM, ma lo fanno più che<br />
dignitosamente e questo è il loro primissimo album.<br />
Die Selektion mette in campo una sezione ritmica pestona<br />
ma anche soprattutto un cantato in lingua madre<br />
bello aggressivo e - vera chicca - una tromba, unico<br />
strumento acustico della line-up ed elemento piuttosto<br />
inconsueto per il panorama dark-wave. Ed è così che<br />
pezzi come St. <strong>Leon</strong>ard, Steine Auf Dein Haupt, Raben<br />
e Liliana, altrimenti assalti di ruvida fattura, vengono<br />
mitigati dal suono elegante dello strumento a fiato e<br />
riportano alla mente, ancora una volta, ai migliori anni<br />
del gruppo di Douglas P.<br />
C’è poi Muskelberg, singolo estratto dall’album, che<br />
con l’incedere marziale vale da solo il disco intero. E se<br />
questo non bastasse ci pensa l’EBM pulsante di Puppenspieler<br />
e quella vagamente arabeggiante di Deine Augen<br />
a rendere definitivamente giustizia alle capacità di un<br />
terzetto che in questo debutto spariglia le carte e fa<br />
girare gli sguardi. Avanti così.<br />
(7.3/10)<br />
anDrea naPoli<br />
DYno - PiCniC nello SPazio (hell Yeah,<br />
ottoBre 2011)<br />
Genere: elettronica<br />
Non giudicare un libro dalla copertina. Ovvero quante<br />
volte ci capita d’ascoltare dischi che si rivelano completamente<br />
diversi da come ce li si aspettava? È lo strano<br />
caso di Picnic nello spazio, un disco che ti prende alle<br />
spalle e ti spinge oltre l’orbita terrestre nelle profondità<br />
remote dello spazio.<br />
Nel mangiadischi solo il meglio dell’elettronica dell’ultimo<br />
ventennio: ambient oscure fatte di glitch circolari<br />
(Oceanica), tempeste elettromagnetiche tutto rumore<br />
bianco e frequenze ai limiti della soglia dell’udibile firmate<br />
Ryoji Ikeda (Giochi di basse), esplosioni annunciate<br />
da echi di techno in espansione fino al punto di<br />
collasso (Pensando), sentori Spacemen 3, glitch anfetaminica<br />
e Supersilent (Pantano 1995), spazio infiniti<br />
(Bolts dreaming), i Pan Sonic che crashano con gli Aufgehoben<br />
(Stanza del rumore due).<br />
Picnic nello spazio è un disco incredibilmente avvolgente<br />
e misterioso, senza cali d’intensità e ottimamente prodotto<br />
da Dyno stesso. Via dalle fabbriche, dalle strade,<br />
dalle città. Space is the place.<br />
(7.4/10)<br />
franCeSCo aSti<br />
etta SCollo - CuoreSenza (troCaDero,<br />
ottoBre 2011)<br />
Genere: pop D’autore<br />
Catanese trapiantata a Berlino, Etta Scollo ha alle spalle<br />
una carriera corposa spesa tra dischi orientati alla tradizione<br />
(un Canta Ro’ che omaggia Rosa Balistreri, un Il<br />
fiore splendente dedicato ai poeti arabi trapiantati in Sicilia<br />
tra il IX e il XII secolo), produzioni legate alla musica<br />
contemporanea e un’attenzione particolare per l’opera.<br />
Tanto per chiarire che con la voce pindarica che si ritrova,<br />
la nostra riesce a cantare qualsiasi cosa e in qualsiasi<br />
chiave, pop compreso.<br />
Più o meno quello che accade in Cuoresenza, un disco<br />
in cui si reinterpretano, riarrangiandoli, brani diversissimi<br />
tra loro provenienti dal patrimonio musicale italiano<br />
più nobile, oltre che dalla biografia della stessa Scollo.<br />
Quest’ultima colta a ripercorrere un fascio di ricordi personali<br />
che cita, tra gli altri, una La donna riccia di Domenico<br />
Modugno e l’Enzo Jannacci di Sopra i vetri, il<br />
Fabrizio De André trasfigurato di Canzone dell’amore<br />
perduto e una Se Telefondando presa in prestito da Mina,<br />
il Franco Battiato de La Cura e Lo scapolo di Paolo Conte.<br />
Il tutto sulla scorta di arrangiamenti pregevoli e con<br />
alle spalle un’orchestra intera e la produzione nostalgica<br />
(ma non involuta) di un Peter Hinderthür in bilico tra<br />
highlight<br />
DeaD SkeletonS - DeaD MaGiCk (a., ottoBre 2011)<br />
Genere: tribal-psych<br />
Quanto contano, a volte, i passaparola e le referenze nel modo della musica popolare. Basta che il<br />
visionario Anton Newcombe - non contento (ma chissà se davvero gli frega ) di aver retto la fiaccola<br />
neo-neo-psichedelica e mostrato la via ai vari Warlocks, Black Angels e<br />
Wooden Shjips con i Brian Jonestown Massacre - si unisca a un (power)<br />
trio di islandesi con ben altro in testa che la liricità e le trame tenui tipiche<br />
di molti loro conterranei ed ecco l’hype. Conviene nondimeno indagare a<br />
fondo per realizzarne la sostanza, toccare con mano la mistura che spumeggia<br />
da questo doppio calderone.<br />
Mano che ritiri immediatamente, urticata con piacere da un monolite che<br />
dispensa martellante (hard) rock acido qui venato di kraut e là gonfio di<br />
mesmerico minimalismo, altrimenti disposto ad alienate oasi ambientali<br />
e tuffi in profondità siderali ma pur sempre traboccante elastica possanza.<br />
Qualcosa che con fatti eloquenti sottolinea il bisogno intimo di ogni generazione all’abbandono dionisiaco,<br />
a darsi mente e corpo a una “mistica del rumore ipnotico” che, nello specifico, si rifà a un’esoterismo<br />
tribale (i riferimenti macabri fanno da padroni senza che traspaia il sospetto della “posa”) caratteristico<br />
dei popoli nordici.<br />
A qualcosa che, mutatis mutandis, ricorda i favolosi Motorpsycho di Demon Box ma tiene conto dell’acqua<br />
nel frattempo passata sotto i ponti. In tal modo il combo di Reykjavik può permettersi cavalcate tra<br />
Suicide, Can, Amon Düül II e Hawkwind come Yama, Ljósberrin e Om Mani Peme Hung senza scadere<br />
nel calligrafismo o nelle sbrodolate; trafficare con drones sulfurei nelle due versioni della title-track e<br />
omaggiare disinvolto il mentore di cui sopra; evocare lo spettro della trance californiana in When The<br />
Sun e riportare alla mente certi babà lisergici di marca Spacemen 3 attraverso la spigliata Psychodead.<br />
Talmente infervorati da risultare, con il loro ben amalgamato cocktail di infiniti ieri, una band del tempo<br />
presente come e anzi più di altre.<br />
(7.5/10)<br />
GianCarlo turra<br />
classicismi nostrani anni Sessanta, jazz e folk.<br />
Etta Scollo, dal canto suo, mette in mostra tutti i numeri<br />
del repertorio, in un perfezionismo formale ineccepibile<br />
ma che alla fine non riesce nell’impresa (a dire il<br />
vero, assai ardua) di donare nuova sensibilità a musiche<br />
con un’identità fortissima associata inevitabilmente ai<br />
rispettivi (enormi) autori.<br />
(6.8/10)<br />
faBrizio zaMPiGhi<br />
father MurPhY - live at the BriGaDiSCo’S<br />
Cave (BriGaDiSCo reCorDS, ottoBre 2011)<br />
Genere: avant-rock<br />
Se pensate che il trio italiano porti a compimento una<br />
sorta di rituale pagano ed esoterico ogni qual volta si<br />
accinga ad accendere gli ampli, allora questo live fa per<br />
voi. Registrato nella caverna della Brigadisco, etichetta<br />
del basso Lazio che si sta sempre più facendo notare<br />
per catalogo e iniziative, l’album mostra appieno il lato<br />
live del terzetto. Evidenziando, cioè, non soltanto le capacità<br />
evocative e il portato indiscutibilmente originale<br />
del contesto musicale creato dai Father Murphy - quel<br />
“psychedelic slow tempo rock doom” sintetizzato dagli<br />
stessi protagonisti - ma mostra anche come la dimensione<br />
live, quella della comunione col pubblico e<br />
dell’interazione con l’ambiente circostante, sia elemento<br />
fondamentale per una resa sonora ritualistica, convincente<br />
e coinvolgente.<br />
Mezzora di musica per sette tracce divise equamente tra<br />
le ultime uscite And He Told Us To Turn To The Sun e No<br />
Room For The Weak che disperdono toni da liturgia del<br />
dopobomba, procedere marziale, dilatate allucinazioni<br />
post-apocalisse (Until The Path Is No Longer), nenie da<br />
haunted-folk noir (So Now You Have To Choose Between<br />
54 55
My Two Black Lungs), chiesastiche e ancestrali visioni di<br />
una malinconia insopportabile. Lasciando l’ascoltatore<br />
basito da una tale forza immaginifica e struggente.<br />
Freddie Murphy, Chiara Lee e il vicario Demarin sono, forse<br />
più dal vivo che su disco, una esperienza totalizzante e<br />
irripetibile, da conservare gelosamente e di cui vantarsi. E<br />
non sono qui per mostrarvi la via per la salvezza.<br />
(7/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
fauve! GeGen a rhino - when<br />
You’re DanCinG You’re StruGGlinG<br />
(autoProDotto, ottoBre 2011)<br />
Genere: avant-electro<br />
Mentre lavorano alla riedizione ampliata del cd-r Namegivers’<br />
Avenue in uscita per Tannen, i tre Fauve! non<br />
se ne stanno con le mani in mano. Verrebbe da dire che<br />
raddoppiano, se non fosse che ai (più svegli tra i) giovani<br />
d’oggi frasi preconfezionate e cibi precotti non piacciono<br />
e così i tre triplicano.<br />
Questo ep in formato digitale, disponibile gratuitamente<br />
presso il loro bandcamp, altro non è che il primo<br />
passo di una trilogia, Palemos, incentrata sul “concetto<br />
di lotta come modalità di origine dell’evento”. In attesa<br />
dei prossimi volumi When You’re Struggling You’re Winning<br />
e When You’re Winning You’re Losing ci lasciamo<br />
inebetire dalle cinque tracce per venti minuti in cui i<br />
toscani danno mostra della stramba filosofia di vita e<br />
dell’eclettismo, ruvido e sensazionale, che avevamo<br />
avuto modo di apprezzare. Minimal beat e concrezioni<br />
concrete (Bayeux Tapestry) si amalgamano con visioni<br />
electro-spacey (Andenken) virate d’n’b dark-ambientale<br />
pronta a dilagare in spazi aperti (Resistor-Inductor) di<br />
una disarmante visionarietà (Kai Entaùtha) o verso industriali<br />
groove bellici (Ghaznavids-Seljuq). Musicalmente<br />
rilevanti e da seguire anche per gli interessanti sviluppi<br />
teorici dietro ogni loro passo.<br />
(7/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
feDeriCo BraSChi - tra le nuvole e<br />
l’aSfalto (CoSaBeat, ottoBre 2011)<br />
Genere: pop-rock<br />
Buona parte di ciò che di positivo si ascolta nel disco<br />
d’esordio del giovanissimo Federico Braschi la si deve<br />
alla produzione di Antonio Gramenteri, Franco Naddei<br />
e Dario Sapignoli. Questi ultimi bravi a nobilitare<br />
con un pop-rock in bilico tra Irlanda e frontiera a stelle<br />
e strisce dieci canzoni che arrangiate con meno cura<br />
avrebbero forse rivelato tutti i loro limiti. Nel caso del<br />
musicista romagnolo si parla infatti di un giovane cre-<br />
sciuto a Gang, Francesco Guccini, Fabrizio De Andrè,<br />
Modena City Ramblers, un mappamondo stilistico che<br />
ritorna in Tra le nuvole e l’asfalto finendo per trasformare<br />
il disco in un vero e proprio corto circuito.<br />
A poco servono gli ospiti illustri chiamati a contribuire<br />
(Gang, Massimiliano La Rocca e Lorenzo Semprini dei<br />
Miami And The Groovers, Franco D’aniello, Davide Morandi<br />
e Francesco Moneti dei Modena City Ramblers)<br />
se non a rendere ancor più chiara una filiazione che non<br />
lascia scampo. Legami parentali che nella cover di Hotel<br />
Supramonte diventano poi una sudditanza comprensibile,<br />
ma non per questo meno dannosa. Nelle dieci (pur<br />
gradevoli) tracce di Tra le nuvole e l’asfalto non c’è segno<br />
di quell’inquietudine che ti aspetteresti da un esordiente<br />
a cui viene data la possibilità di incidere un disco:<br />
tutto è classicismo forzato, monocromatismo pacificato<br />
ma di riciclo, credibilità che sfocia nella didascalia. Un<br />
ricalcare le orme dei padri che rischia seriamente di minorare<br />
il futuro dei figli.<br />
Certo c’è la giovane età (siamo sui vent’anni) a offrire<br />
giustificazioni plausibili e qui sospendiamo il giudizio,<br />
visto e considerato che in giro si ascoltano produzioni<br />
peggiori da gente con più esperienza. Il consiglio tuttavia<br />
è di ripartire da zero, non dimenticando che non<br />
sono gli errori a condannare un artista, ma la paura di<br />
fare delle scelte personali.<br />
(5/10)<br />
faBrizio zaMPiGhi<br />
florenCe anD the MaChine - CereMonialS<br />
(iSlanD, ottoBre 2011)<br />
Genere: Gothrock<br />
Dopo aver dato fiato ai polmoni, Florence Mary <strong>Leon</strong>tine<br />
Welch torna a mettere in moto la sua machine per nuovi<br />
cerimoniali. E già dal titolo ci aspettiamo una parziale<br />
conferma dei numeri che avevano determinato il fragore<br />
di due anni fa: pop declinato in tutte le salse, ma<br />
soprattutto eccessivo, bulimico, egocentrico, spesso<br />
sopra le righe. Tutto come da previsione, come mostra<br />
l’Enya mandata a duemila allora di Spectrum: un’arpa<br />
folkeggiante spaesata dentro a una cavalcata infuocata<br />
da un coro ascendente che sostiene la voce di Florence<br />
che canta a squarciagola “Say my name!”. Eccomi sono<br />
vostra, prendete e bevetene tutti, questa è la mia musica.<br />
Io sono insieme Kate Bush, Adele e il vostro sogno<br />
proibito: mangiatene e non avrete più paura.<br />
Nel frullatore di tutte le declinazioni del pop finiscono<br />
l’hip hop/r’n’b (che pare un calco dal primo non<br />
entusiasmante Big Pink) di Only If For A Night, l’errebì<br />
meno razziale (Never Let Me Go), l’accademia stonesiana<br />
(Leave My Body) e il canone dolcemente psichedelico<br />
di beatlesiana memoria (Breaking Down, che sarebbe<br />
perfetta per un fil d’animazione per ragazzi). Ma accanto<br />
all’immaginario anglosassone che spesso nelle sue<br />
incarnazioni sfocia in atmosfere magiche da cronache<br />
di Narnia, questa volta entrano nel mix sonorità meno<br />
UK: un gospel-oriented-rock (Lover to Lover), qualche<br />
tribalismo che fa tanto Bjork (Heartlines). La costante<br />
vera di tutto il disco è una costruzione delle canzoni su<br />
un crescendo che enfatizza il lato più epico di ogni composizione,<br />
come ben mostrato dal singolo Whatever The<br />
Water Gave Me, con il suo corollario un po’ magic da 70s.<br />
Non un calco del primo fortunato disco, che già le ha<br />
permesso di raccogliere vere e proprie folle sotto i suoi<br />
palchi, ma un sapiente equilibrio (dobbiamo immaginare<br />
che la sapienza produttiva di Paul Epworth centri<br />
qualcosa) tra le cose che hanno li funzionato e nuovi<br />
elementi . Qualcuno dirà maturazione e allargamento<br />
degli orizzonti, noi diciamo un sagace tentativo di<br />
aumentare vendite, date live e mega show nelle arene<br />
nordamericane.<br />
(6.9/10)<br />
MarCo BoSColo<br />
frankSPara - il Dottor CrePaPelle e<br />
l’alBero Che CaMMina (reinCanto DiSChi,<br />
noveMBre 2011)<br />
Genere: pop D’autore<br />
I Frankspara di Francesco Viani, Pit D’Aleo e Andrea<br />
Giorgetti arrivano al terzo disco sull’onda del solito - ottimo<br />
- pop d’autore. Una musica la cui leggerezza formale<br />
- tutt’altro che frivola, come dimostra la scrittura<br />
puntigliosa ed equilibrata alla base delle dieci tracce<br />
de Il dottor Crepapelle e l’albero che cammina - si rivela<br />
il vero e proprio valore aggiunto. Se l’iniziale Il suono<br />
universale ammicca inaspettatamente a certi Libertines<br />
fuori stagione, il resto del disco si muove agilmente tra<br />
un cantautorato col timone rivolto a Settanta italiani<br />
(Ma) e vaghe cadenze in stile Le vibrazioni (Voglio diventare<br />
cretino), un Max Gazzè che sbircia di soppiatto<br />
(Prima del futuro) e certe concessioni a un folk appena<br />
sussurrato (Io sono l’albero).<br />
L’impressione è che l’estrema rilassatezza che l’ascolto<br />
del disco trasmette nasconda in realtà una sicurezza invidiabile<br />
nel maneggiare materiale che sembra andare<br />
in mille direzioni pur suonando decisamente compiuto.<br />
Una musica che rispetto al precedente Soprattutto trova<br />
il modo di farsi ancora più cesellata, pur mantenendosi<br />
fedele a un immaginario che rivendica, disco dopo<br />
disco, una semplicità d’altri tempi.<br />
(7/10)<br />
faBrizio zaMPiGhi<br />
furtherSet - olD quantuM theorY eP<br />
(teChnowaGon reCorDinGS, ottoBre 2011)<br />
Genere: hypna-tech<br />
Dalle sinuose movenze ambient-house di Quantum<br />
Hand prossime al John Roberts emerso su Dial alla più<br />
decisa matrice idm/techno come da buona maniera<br />
Plaid (Harmonic Oscillator), dalla tensione hypno-dronica<br />
dei Super Minerals in Ψ alla dub-techno robusta<br />
stile Deepchord (Zeeman Effect). Quattro brani (più<br />
due remix) per segnare un’ascesa iniziata in cameretta<br />
piegato sull’Ableton e consacrata dalle presenze a Dancity<br />
Festival 2011 (con tanto di citazione su The Wire) e<br />
all’imminente Club To Club.<br />
Stile maturo e sfaccettato neanche fosse il più navigato<br />
dei James Ferraro, poi ti dicono che Furtherset è Tommaso<br />
Pandolfi, 16enne liceale di Perugia (avete capito<br />
bene), e alzi le mani arreso all’evidenza: gli Aphex Twin<br />
esistono anche qui. E voi, a quell’età che facevate?<br />
(7/10)<br />
Carlo affatiGato<br />
Gian luiGi Diana - CriStalli Sonori (Setola<br />
Di Maiale, luGlio 2011)<br />
Genere: impro-manipolazione<br />
Altro emigrante atterrato in territorio newyorchese, a<br />
dimostrazione di come purtroppo di soli cervelli in fuga<br />
(non) vive questo paese in crisi, Gian Luigi Diana se ne<br />
esce con un album ricercatissimo per la nostra - questa<br />
sì - Setola Di Maiale. Il multistrumentista friulano, esule<br />
e girovago - Berlino, Londra, India, NY: non si contano i<br />
luoghi toccati nel suo vagabondaggio psichico e fisico<br />
- si cimenta con Cristalli Sonori in solo, fatta eccezione<br />
per qualche comparsata di colleghi e amici a fiati (Patrick<br />
Holmes, Porra-Boy, Bojan Z.) e doppio basso (Lisa<br />
Dowling). Il risultato è un lavoro di ricerca basato sul<br />
live electronics e sulla manipolazione sonora che ce lo<br />
mostra artista attento al dettaglio e alla profondità del<br />
suono, ma nel contempo libero di spaziare tra intuizioni<br />
musicali ampie e guidate da uno spirito totalmente free.<br />
A cercare tra le pieghe di un suono curatissimo non esce<br />
solo fuori una attitudine impro-onnivora - citazioni e<br />
suggestioni mediorientali, suburbane, post-industriali<br />
si ammassano e stratificano le une sulle altre - ma una<br />
sensibilità ad ampio spettro capace di (ri)tirare in ballo<br />
classico (la tradizione indiana, ad esempio) e innovativo<br />
(le reminiscenze minimal-electro londinesi e berlinesi),<br />
così come analogico e digitale, scritto e improvvisato.<br />
Dal cilindro del trasformista escono così perle come<br />
l’electro virata materia di Cristalli Sonori And Clarinet Pt.4<br />
o l’impro-jazz circense e spezzettato di Improvisation #3,<br />
l’ipnotico rumorismo sotterraneo scolpito da beat indu-<br />
56 57
highlight<br />
eSPeranza - eSPeranza (GoMMa, noveMBre 2011)<br />
Genere: Dream wave<br />
Non è ancora arrivato il momento di lasciarle stare le buone vecchie wave dei Noughties. La 4ad, il lato<br />
più adulto del synth pop (Art Of Noise), lo shoegaze, il post-punk virato etnico di metà Ottanta o quello<br />
più romantico dei Bunnymen e tutto ciò che, a quasi tre lustri di distanza<br />
dai primi frullati dell’era internet, rappresenta una valida ipotesi d’indagine e<br />
riscoperta. Dunque non è giunta l’ora di abbandonare certi lidi dream, glo e<br />
tutta un’elettronica chill che dai primi 90, dal dub e dal trip hop porta indietro<br />
ai 70 psychedelici (vedi The Orb), o dalla balearica alla new age. E non è<br />
neppure il caso di scordarsi il recupero melodico classico del nostro belpaese,<br />
da anni fonte d’ispirazione per l’indie nazionale (Casa Del Mirto) e non solo.<br />
Esperanza fa le cose per bene. E’ quel tipo di progetto da musicisti/produttori<br />
fanatici per la musica con le antenne puntate sul presente e l’esperienza<br />
necessaria per sintetizzarle in uno stile che è già il loro. Gomma, l’etichetta<br />
tedesca di Who Made Who, Munk e il qui presente Cécile li sta spingendo da quest’estate non a caso. E<br />
già avevamo avuto modo d’apprezzare l’eppì con l’hit balearic soulfull che è Sirena e i suoi remix con la<br />
partecipazione di Alessio Natalizia aka Banjo Or Freakout. Quel Natalizia prezzemolo che qui ritorna<br />
perfettamente per via dei Walls, altro progetto curato dal nostro con Sam Willis e vicino a Esperanza sia<br />
per il carattere internazionale che lo contraddistingue ma anche e soprattutto per quel suono aperto e<br />
camaleontico in perfetto equilibrio tra istanze dance e d’ascolto, pulsioni e dimensioni live set e la più<br />
classica hard jam psichedelica.<br />
Cécile, Matteo Lavagna (Disco Drive) e Sergio Maggioni sono i tre catalizzatori di un marasma che è il<br />
presente sonico, un dedalo di storie che s’incontrano in un disco strumentale che sa essere tantissime<br />
cose e che pertanto apre a strategie d’ascolto differenti. Il remember rave di Aliante Giallo, gli ambienti<br />
e le melodie di Ryuichi Sakamoto e David Sylvian di Hanamachi, la Berlino techno-dub subacquea in<br />
odor di PiL di Jaipur (primo singolo ufficiale di cui c’è anche un remix dei Walls - e tutto torna), il synth<br />
pop pinkfloydeggiante che guarda ai Massive Attack di Whale.<br />
In figura, sullo sfondo, nel club, nel salotto di casa con le orecchie ben alzate davanti al vecchio stereo<br />
con il vinile sul piatto, Esperanza è l’esperienza del dopo glo-fi da fare. E una nuova mutazione sonica<br />
che dai ritmi del mare punta all’entroterra e al cosmo. Qualcuno ha un’etichetta a portata di mano?<br />
(7.4/10)<br />
eDoarDo BriDDa<br />
strial minimali di 21 Disgusting America, la disco-concreta<br />
di Brooklyn Dancing Bedbugs, la contemporanea di<br />
Cristalli Sonori And Clarinet Pt.1, le orchestrazioni di The<br />
Seven Dwarfs, Tired Of Working, Are Complaining On Their<br />
Way Back Home. Tutte, o quasi, duetti in modalità impro<br />
con la strumentazione acustica e concreta riprocessata<br />
in chiave elettronica. “In questo album considero il suono<br />
come un oggetto con le sue proprie configurazioni<br />
scultoree e spaziali e il mio processo di composizione<br />
e improvvisazione è soltanto legato a piani, volumi e<br />
densità diverse”. Massimo rispetto per tali outsider.<br />
(7.4/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
GianMaria teSta - vitaMia (ProDuzioni<br />
fuorivia, ottoBre 2011)<br />
Genere: canzone D’autore<br />
Giunto all’ottava pubblicazione compresi una raccolta<br />
e un live, Gianmaria Testa rimescola i tracciati di un<br />
percorso che l’ha visto fino ad oggi fedele a una poetica<br />
fatta di suoni acustici e parole dense. Più spazio<br />
alle chitarre elettriche in Vitamia - cosa che si era già<br />
profilata timidamente nei precedenti Altre latitudini e<br />
Da questa parte del mare - e una ricerca di nuove soluzioni<br />
giustamente ritenuta necessaria, arrivati a questo<br />
punto della carriera.<br />
Non fa trasalire più di tanto, allora, il sentore new acou-<br />
stic del singolo Nuovo (con qualche inedita rotondità<br />
radiofonica), il passo da blues ballad di Lasciami andare<br />
e quello nervosamente funky-jazz di Cordiali saluti. Pur<br />
nell’ottica di un disco registrato live in studio nel giro di<br />
una settimana che rispetto ai lavori precedenti guadagna<br />
in spontaneità ma non riesce a convincere del tutto.<br />
Il problema è principalmente una scrittura che non gira<br />
come un tempo e, in particolare, non trova quegli spunti<br />
melodici fatalmente evocativi che fecero la fortuna di<br />
pezzi come Un aeroplano a vela o Seminatori di grano.<br />
Ma è anche un problema di certe scelte sonore che già<br />
a metà opera risultano prevedibili. Così, dopo una 18<br />
mila giorni in pura classicità Testa, Aquadub finisce in un<br />
carillon di mestiere, Sottosopra è il Tom Waits di Mule<br />
Variations (fortunatamente senza calchi vocali in giro)<br />
e 20 mila leghe (in fondo al mare) insegue Vinicio Capossela<br />
sulle ultime rotte marinare abbozzando a bassa<br />
voce una bella satira antisecessionista. Le due ballate in<br />
flirt jazz Lele e Di niente metà (con gli ospiti Brunello e<br />
Petrella a cello e trombone) portano il disco poco oltre<br />
la sufficienza, mentre lo spread con la musica che scorre<br />
là fuori si allarga sempre di più. D’altra parte è la crisi.<br />
Della più classica canzone d’autore italiana, s’intende.<br />
(6/10)<br />
luCa BaraChetti<br />
Gionata Mirai - alluSioni (la teMPeSta<br />
DiSChi, noveMBre 2011)<br />
Genere: folk<br />
Con il Teatro degli orrori ormai diventato una sorta<br />
di Re Mida (a dimostrazione, i numerosi live in giro per<br />
l’Italia ai limiti del sold-out), il chitarrista della formazione<br />
veneta Gionata Mirai pensa bene di uscire allo scoperto<br />
con il suo primo progetto solista. In un momento<br />
che potremmo definire eufemisticamente propizio, almeno<br />
a giudicare dal traino di cui hanno goduto anche<br />
i redivivi One Dimensional Man (progetto del Capovilla<br />
front-man del Teatro) e da un pubblico dedicato evidentemente<br />
ricettivo e pronto a seguire i propri idoli anche<br />
su terreni più scoscesi.<br />
Come, ad esempio, questo Allusioni, che tutto è fuorché<br />
un disco semplice. Non tanto nella sostanza - si parla in<br />
fondo di un folk acustico strumentale in fingerpicking<br />
non lontano dalla tradizione di John Fahey - quanto<br />
nella forma: ventiquattro minuti di durata per un solo<br />
brano in una cavalcata ipnotica e densa fatta di microvariazioni<br />
che si accavallano, cambi di umore impercettibili,<br />
rincorrersi di arpeggi. Nulla di particolarmente<br />
nuovo per chi ha dimestichezza con la produzione della<br />
Incredible String Band, del Fahey già citato, oppure<br />
di Bert Jansch; qualcosa con cui mettersi alla prova se<br />
invece il target d’ascolto è solo ed esclusivamente il Teatro<br />
degli Orrori.<br />
Gionata però è bravo, tecnicamente preparato e capace<br />
di nobilitare il materiale con un senso spaesato di blues<br />
che immalinconisce le trame articolate e veloci di questo<br />
flusso primordiale. Un perdersi e ritrovarsi su una<br />
dodici corde che, oltre a mettere in bella mostra una<br />
sensibilità inaspettata, vive di amore per lo strumento<br />
(e per i classici del folk) e di una curiosità spigliata.<br />
(6.9/10)<br />
faBrizio zaMPiGhi<br />
Giovanni falzone - arounD ornette (ParCo<br />
Della MuSiCa reCorDS, ottoBre 2011)<br />
Genere: Jazz<br />
Giovanni Falzone è uno di quei jazzisti che ti fanno sentire<br />
vivo il jazz, mosso da un’urgenza che pesca inquietudine<br />
e suggestione dal presente pur scuotendo l’albero<br />
della tradizione fin dalle radici blues. In dischi come Big<br />
Fracture (2003), Meeting In Paris (2006) o R-Evolution<br />
Suite (2007) ha calato sul piatto visionarietà febbrile e<br />
padronanza poderosa, confermata appieno in Around<br />
Jimi del 2010 (frutto del progetto Mosche Elettriche),<br />
per non dire dello straordinario apporto come side man<br />
ad esempio nell’ottimo Tinissima Quartet. Da quest’ultimo<br />
combo provengono Francesco Bearzatti (sassofonista,<br />
che ve lo dico a fare) ed il batterista Zeno De Rossi,<br />
che assieme al bravo Paolino Della Porta (contrabbasso)<br />
e Beppe Caruso (trombone) costituiscono l’organico del<br />
nuovo quintetto di Falzone, impegnato nella fattispecie<br />
ad omaggiare una figura cardinale come Ornette<br />
Coleman.<br />
Del grande sassofonista texano vengono riletti quattro<br />
brani (Blues Connotation, Lonely Women, Free, Congeniality)<br />
risalenti alla cuspide tra anni Cinquanta e Sessanta,<br />
vale a dire un attimo prima della conclamata rivoluzione<br />
di Free Jazz (1961), in quella formidabile linea di confine<br />
dove germogliavano le ipotesi della black music futura.<br />
Una scelta emblematica rispetto al senso dell’operazione,<br />
che vede i cinque sbrigliare estro e talento nel<br />
rispetto di forme e strutture tradizionali che esaltano<br />
nel momento stesso in cui le mettono in discussione.<br />
Ciò è ancora più evidente nei quattro originali firmati<br />
dal leader, dalla spiritosa, spiazzante (e anche un po’<br />
post-moderna) rievocazione del Dixieland in Bourbon<br />
Street alla suggestiva King Of The Free (paradossalmente<br />
riconducibile alla calligrafia del secondo quintetto davisiano):<br />
come se il trombettista siciliano intendesse più di<br />
ogni altra cosa dissipare l’equivoco che vuole Coleman<br />
identificato “solo” come il principale responsabile della<br />
new thing, sottolineando quindi la vasta, complessa e<br />
58 59
profonda portata della calligrafia espressiva.<br />
In questo senso è un disco più pacato di quanto fosse<br />
lecito attendersi, coerente e compiuto certo, suonato in<br />
punta d’ispirazione e persino divertente, però lontano<br />
dalle frenetiche escursioni cui Falzone ci ha abituati in<br />
passato (discorso simile per Bearzatti) e quindi un po’<br />
troppo nei ranghi dell’autoreferenzialità jazzistica. Ragion<br />
per cui non nascondo di aver provato un pizzico<br />
di delusione. Giusto un pizzico<br />
(6.9/10)<br />
Stefano Solventi<br />
GirleSS & the orPhan - the ePiC ePitaPh of<br />
our ePheMeral ePilePtiC ePoCh eP (StoP<br />
reCorDS, SetteMBre 2011)<br />
Genere: punk folk<br />
Li avevamo lasciati fra le righe di un Reboot, ci avevano<br />
incuriosito e divertito. Con le chitarre sbarazzine e il loro<br />
punk folk acustico, i Girless & The Orphan, al loro Ep<br />
d’esordio, avevano dimostrato di saperci fare e soprattutto<br />
di voler tener dura la presa e mirare dritto all’osso.<br />
Eccoli dunque tornare, a brevissima distanza, con un Ep<br />
dal titolo fiume che vuol suggellare l’epitaffio di questo<br />
mondo epilettico. Quattro tracce, pubblicate quasi a sorpresa<br />
durante l’estate, che sono il perfetto seguito del<br />
precedente lavoro. Ci sono le conferme: l’indole punk,<br />
la strafottenza, l’incisiva emotività, la cazzonaggine di<br />
gran classe.<br />
E poi ci sono le innovazioni (perché è con quelle che<br />
un gruppo diventa un buon gruppo): arrangiamenti più<br />
curati, meno malinconia e più rabbia, qualche accenno<br />
di elettronica, la consapevolezza di aver fra le mani uno<br />
stile preciso (e scusate se è poco ). Risuonano, una volta<br />
per tutte, quei mai abbastanza apprezzati Neutral Milk<br />
Hotel, i Pogues in camicia a quadri e bicchieri pieni fino<br />
all’orlo, i Creedence senza permanente, Johnny Cash<br />
versione Riviera romagnola e un numero imprecisato<br />
di musiche da college movies americani. Azzeccare uno<br />
stile non è cosa da tutti.<br />
(7/10)<br />
nino CiGlio<br />
GoaPele - Break of Dawn (DeCon reCorDS,<br />
ottoBre 2011)<br />
Genere: neo soul<br />
Non poteva esserci annata migliore per il ritorno su album<br />
della stella soul made in USA Goapele dopo un<br />
silenzio durato sei anni. Ed è oltremodo interessante<br />
scoprire come una come lei, col suo nome ormai saldamente<br />
scolpito sulle tavole della storia r’n’b-soul moderna<br />
(l’avevano anche definita “la figlia spirituale di Sade<br />
e D’Angelo”), si inserisca in modo tanto preciso nelle<br />
sonorità del momento: due brani come Undertow e il<br />
singolo apripista Play mostrano coscienza del recente<br />
amore scoppiato tra dub e soul, con quel passo felino<br />
graffiante e quelle bassline accentuate che donano allo<br />
schema cantautoriale il quid in più cercato insistentemente<br />
da Jamie Woon ed Emika.<br />
Quelli i tocchi di classe. Per il resto l’album conferma tutte<br />
le qualità già sfoderate nel precedente Change It All<br />
(tutt’ora suo apice artistico), con la passione melodica<br />
su ritmo aggraziato che degli Stati Uniti è ormai marchio<br />
di fabbrica (Tears On My Pillow e Pieces, fronte compatto<br />
con Aaliyah e Mary J. Blige), la disinvoltura di potersi<br />
sganciare dalla regola fissa (la titletrack che non teme il<br />
mainstream, oppure una Money così tanto Jamiroquai)<br />
e una voce che ruba la scena, strepitosa come sempre<br />
(sentiti i virtuosismi in Milk & Honey?).<br />
Forse meno sentito e più pensato del suo predecessore,<br />
ma qualità ancora una volta ben oltre la media. Per certi<br />
talenti è difficile far peggio.<br />
(6.9/10)<br />
Carlo affatiGato<br />
Gotan ProJeCt - la revanCha en CuMBia (Ya<br />
BaSta!, ottoBre 2011)<br />
Genere: Gotantronica<br />
Mi ricordo quando sentii per la prima volta La Revancha<br />
Del Tango. Ero a Roma, in un ristorante trasteverino cool.<br />
Dopo due giri di basso chiesi al gestore di chi fossero<br />
quelle note. Erano i parigini ancora più o meno sconosciuti.<br />
Comprai il disco qualche giorno dopo e mi persi<br />
nel magico mondo french touch. Ci sarebbero stati altri<br />
album bomba (il doppio St. Germain su lidi più house e<br />
tutta la cricca Air, Tellier & co.), ma il suono di Philippe<br />
Cohen Solal (almeno al suo esordio) aveva una freschezza<br />
e una coolness tali che non facevano storcere i nasi<br />
ai cultori della techno e nel contempo piacevano a chi<br />
aveva qualche orecchio sintonizzato sulla world.<br />
A dieci anni da quella bomba si torna ancora sul luogo<br />
del delitto’, rivisitando la scaletta in chiave cumbia con<br />
l’aiuto di remixatori di Buenos Aires più o meno sconosciuti.<br />
Un disco che andrà ad accompagnare l’edizione<br />
deluxe della ristampa del capolavoro e che non aggiunge<br />
nulla alle note di quei fasti (si poteva per lo meno<br />
puntare a nomi più illuminati del panorama electro).<br />
Buono per chi non ha apprezzato gli standard di partenza<br />
e vuol farsi un’idea di uno dei più famosi dischi di<br />
electro-world della storia; ininfluente per tutti gli altri,<br />
a meno di nostalgie passeggere.<br />
(5/10)<br />
MarCo BraGGion<br />
Great northern x (the) - the Great<br />
northern x (in the Bottle, ottoBre 2011)<br />
Genere: psych folk<br />
La vena bollente e sparsa delle ballate folk-psych contagiata<br />
dai vibrioni stordenti del post-rock. Oppure,<br />
viceversa, il disincanto sperso del post recuperato alla<br />
pienezza emotiva del folk-rock psichedelico. Una delle<br />
due, forse entrambe, o nessuna. Il punto di equilibrio<br />
raggiunto da questo quartetto padovano all’esordio<br />
non ci permette di cogliere la direzione. In questo omonimo<br />
esordio - per il quale si sono scomodate ben tre<br />
etichette, In the Bottle Records, Fooltribe e Upupa - è<br />
tutto un gettare reti matematiche tra la spuma di un’onda<br />
impetuosa e la risacca asprigna, l’elettricità come un<br />
refolo noise a sparpagliare melodie accattivanti ma sempre<br />
un attimo prima di scivolare nell’indulgenza.<br />
Vale a dire, a tratti ricordano i più morbidi Smashing<br />
Pumpkins via Folk Implosion (Rat), degli striniti Neutral<br />
Milk Hotel (Saigon) o una versione struggente dei<br />
Jayhawks (Sickness of the Great Nothing), o ancora un<br />
incrocio sottile e scafato tra Polvo, Decemberists e<br />
Mike Scott (la notevole Loser Song, la circospetta tensione<br />
di The Seventh Tale). Nulla d’inaudito quindi, ma<br />
abbastanza congruo da risultare convincente e a tratti<br />
avvincente. Un passo oltre l’estetica del “farci” che ammorba<br />
troppe proposte nostrane. La scala per diventare<br />
grandi è tutta da salire, ma intanto è imboccata.<br />
(6.8/10)<br />
Stefano Solventi<br />
half Man half BiSCuit - 90 BiSoDol<br />
(CriMonD) (ProBe PluS, SetteMBre 2011)<br />
Genere: inDie punk rock<br />
Una quindicina di anni fa gli Half man half biscuit erano<br />
uno dei gruppi più interessanti del panorama indie<br />
britannico. Quattro ragazzi della zona di Liverpool che<br />
con il loro primo album datato 1985 avevano pensato<br />
bene di dare sfogo al loro humour tipicamente inglese<br />
(Back in the D.H.S.S. è la parodia di Back in the<br />
U.S.S.R. dei mitici scarafaggi) riuscendo anche a scalare<br />
le classifiche di genere, tanto che verrano selezionati<br />
nella storica compila c86.<br />
Ora ce li ritroviamo al dodicesimo disco, questo 90 bisodol<br />
(Crimond), ancora lì a pensare a un indie tanto<br />
radioso quanto sarcastico, dominato dal sempiterno riffone<br />
Fender Jaguar. Per l’occasione il gruppo ha deciso<br />
di darsi una ripulita: niente lo-fi o accenni weird, solo un<br />
vecchio punk rock che profuma d’Inghilterra e di provincia.<br />
Certo l’effetto nostalgia c’è, innegabile, ma non<br />
si trasforma in effetto noia grazie ad un pugno di ottimi<br />
brani: su tutti lo spoken-word di Descent of the Stipersto-<br />
nes che narra l’incontro con Lynette McMorrough (protagonista<br />
di una celebre serie tv inglese, Crossroads), il<br />
pop punk venato ska di Something’s Rotten in the back<br />
of Iceland e quello più straight di Fix it so she dreams of<br />
me, brani che a pensarci non sono poi così lontani dalle<br />
espressioni del nuovo indie sul versante Vaccines.<br />
Gli Half man half biscuit non sono cool, all’hype preferiscono<br />
la tradizione autoriale che traspare in un paio di<br />
tracce riciclate direttamente da Billy Bragg (RSVP, The<br />
coroner’s footer note), senza tralasciare lo spirito cabarettistico<br />
un po’ demodé di L’enfer c’est les autres e Fun day<br />
in the park. E’ l’old school che torna senza nulla invidiare<br />
agli sbarbatelli di turno.<br />
(7/10)<br />
Stefano Gaz<br />
hell Shovel - Sonar elaStiCi. il Pianeta<br />
Si riSveGlia (SounD of CoBra, SetteMBre<br />
2011)<br />
Genere: psych-GaraGe<br />
Eclettismo. Questa potrebbe essere la parola chiave della<br />
Sound Of Cobra, etichetta di stanza a Berlino, nata<br />
dalle ceneri della Xhol e come quella retta in solitaria da<br />
Ricky Thunder di In Zaire e G.I. Joe. Eclettismo per formati<br />
e sonorità, a dirla tutta. Dopo la tape d’esordio dei<br />
Cannibal Movie e il cd serigrafato Iter degli Orfanado,<br />
ecco il primo 12” in vinile e per giunta single-sided. A<br />
firmarlo è una sigla nuova che convoglia però nomi noti<br />
dell’underground più r’n’r caciarone d’oltreoceano, nello<br />
specifico Jeff Clarke, e Dox Grillo, entrambi di stanza nei<br />
Demon’s Claws e in un’altra miriade di band minori.<br />
Non conosciamo i legami tra i canadesi e il mondo<br />
dei b-movie sci-fi cui il titolo fa evidente riferimento.<br />
Sappiamo però benissimo cosa troveremo nei 6 pezzi<br />
dell’album: garage-rock molto più spinto sul versante<br />
psichedelico e sixties oriented di quello di Thee Oh Sees<br />
e di tutta la genia from Frisco che a quelle stesse sonorità<br />
fa riferimento. Slabbrato in qualcosa di assimilabile<br />
alla free-form (Sonar Vibration Elastic), ossessivamente<br />
sixties-oriented nel suo incedere malato (Polar Magnetic),<br />
in fissa con un suono riverberato e tremolante come<br />
se non ci fosse vita al di fuori di una caverna senza fondo<br />
(l’horror-psych di Fed To The Cat), figlio di una summer of<br />
love bruciata dai troppi acidi (Sand Piled High, la nenia<br />
acid-pastorale di Planet Awakens) ma anche memore<br />
delle origini corpose e garagey (una Blow Holes And Q-<br />
Tips degenerata e distorta). Una bella sorpresa.<br />
(7/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
60 61
highlight<br />
evanGeliSta - in aniMal tonGue (ConStellation reCorDS, ottoBre 2011)<br />
Genere: post-folk blues<br />
Una delle peculiarità meno dibattute dei dischi di Carla Bozulich/Evangelista è quel loro essere autentici<br />
eventi. Nell’era della soglia d’attenzione risicata, una rarità che richiede impegno e lascia in dote all’ascoltatore<br />
scosse emotive che lo facciano sentire più vivo. Non fa eccezione quanto ad attitudine un quarto<br />
lp che aggiusta invece il tiro dal punto di vista sonoro, lavorando di lima alla fenomenale ipotesi di Patti<br />
Smith che all’epoca Radio Ethiopia si concede al post blues-folk affiancata da Lydia Lunch. Giusto che<br />
la mutazione sia graduale per chi ha trasformato il proprio vissuto in una<br />
forma d’arte incompromissoria. Tanto più nel momento in cui rabbia e livore<br />
trascolorano in un eccellente classicismo delle forme che integra le usuali e<br />
ben focalizzate ambizioni sperimentali.<br />
Sorta di reazione a un biennio vissuto più del solito da nomade, In Animal<br />
Tongue è stato pertanto registrato in diversi luoghi però conserva unità invidiabile<br />
perché poggia sulla solidità di atmosfere ed esecuzione (Carla e i fidi<br />
Tara Barnes e Dominic Cramp, più uno stuolo di ospiti misurati e preziosi in<br />
cui spiccano membri di A Silver Mount Zion) e soprattutto sulla scrittura.<br />
Così una Artificial Lamb può dipanarsi tra inquietudine ed elevazione bussando alla porta di P.J. Harvey<br />
spalleggiando la tremolante Enter The Prince; così Hands Of Leather offre una riedizione moderna dei<br />
momenti “etnici” di Easter mentre Black Jesus e Tunnel To The Stars intessono folk-jazz da tregenda.<br />
Dove la title-track guarda fugacemente al recente passato tra ipnosi e levitazione, lo spettro di Diamanda<br />
Galas si aggira negli specchi crepati di Die Alone e Hatching ritrova i paesaggi acuminati di Tago<br />
Mago. Tanto, a scaldare l’anima resterà un picco sublime di umanità del calibro di Bells Ring Fire. Ognuna<br />
a stendere un velo sulla banalità del mondo, a cancellare le ultimissime sensazioni e i capolavori che<br />
durano quanto un cerino in un giorno di vento. Evviva.<br />
(7.5/10)<br />
GianCarlo turra<br />
huM of GnatS - PurGe the weevil froM Yer<br />
MiDSt (StrunGaPhone, noveMBre 2011)<br />
Genere: weirD<br />
E tre. Dopo Levis Hotel e Poisucevamachenille, il pescarese<br />
Ezio Piermattei inaugura un nuovo moniker sotto<br />
il quale nascondersi e confondere. Scelta dovuta per<br />
giocare autoironicamente col “tinnito” che lo perseguita<br />
e per mostrarsi ancor più sfuggente di quanto l’ambito<br />
musicalmente di riferimento pretenda. Che poi, a dirla<br />
tutta, è già un bel rebus di per sé. È arduo infatti rintracciare<br />
un contenitore, anche per meri scopi giornalistici,<br />
in cui infilare la musica di Piermattei: libera, fluviale,<br />
boundless, ispirata a tutto ciò che il termine sperimentale<br />
possa farvi venire in mente da un quarantennio a<br />
questa parte. Musica strana, free, collagista, stratificata,<br />
analogica e digitale, che procedere a zig-zag tra weirdfolk,<br />
psych, concreta, prog, impro-jazz e quant’altro, paradossalmente<br />
senza soluzione di continuità e senza che<br />
se ne avverta mai il passaggio o l’alternanza.<br />
Quattro lunghe composizioni che si muovono su ambientazioni<br />
e atmosfere umorali e altalenanti, oscillando<br />
tra paesaggi quieti e malati, malinconiche pastorali,<br />
squarci bandistici, weirdismo ancestrale alla Hexlove, inserti<br />
di fiati (ospite Napo Camassa al sax soprano nell’iniziale<br />
Hop Score, mentre il clarinetto è appannaggio del<br />
pescarese), oggettistica varia, Canterbury sound, voci<br />
trovate, elettronica povera e una infinità di altre suggestioni.<br />
Il tutto sempre esposto lucidamente, venato<br />
da una attenzione maniacale al dettaglio, elaborato in<br />
maniera coesa e fornito di una giocosa attrazione per<br />
l’aspetto ludico (vedere alla voce titoli dei pezzi, please<br />
tutti con l’iniziale H e giocati su calembour foneticolinguistici).<br />
Elementi che pongono di diritto Hum Of<br />
Gnats nell’empireo degli “strani” d’oggi.<br />
(7.5/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
in a SleePinG MooD - Draft (autoProDotto,<br />
ottoBre 2011)<br />
Genere: avant-electronic<br />
Due italiani di stanza a Londra autori di un’elettronica<br />
di chiara matrice minimal che non disdegna incursioni<br />
d’altro genere come la ambient e il post-rock. Donato<br />
Panaccio e Mauro Polito sono In A Sleeping Mood,<br />
progetto con già un album all’attivo per la giapponese<br />
Friend of Mine.<br />
Draft è la loro nuova opera, di cui la chiara partenza<br />
minimal-classica per piano e chitarra (Draft1) mette<br />
fin da subito a fuoco il concetto musicale del progetto:<br />
suoni trasportati nello spazio, bozze di idee che si<br />
trasformano in atmosfera, sensazioni contrastanti che<br />
rimandano a luoghi alieni (la dark ambient di Draft6) o<br />
che saturano l’aria di elettricità (il glitch schizofrenico di<br />
Draft2). L’approdo su lande nintendo style meets chitarra<br />
free (Draft4, un Mark McGuire regredito?) e le paranoie<br />
sonore di febbricitante insonnia degne di Aphex Twin<br />
(Draft3), dimostrano poi che c’è di più nella creatività<br />
eclettica del duo, preparando il campo a momenti nei<br />
quali si riescono a cogliere le note scansare il silenzio,<br />
ergersi per poi tornare a inabissarsi (Draft5).<br />
Gli In A Sleeping Mood sembrano riprendere il discorso<br />
lasciato aperto da John Cage e sfruttato da tanti electro-heroes<br />
contemporanei, nell’auspicare la libertà dei<br />
suoni (e dei rumori e dei silenzi) e rivisitandolo in chiave<br />
moderna grazie alle nuove tecnologie. Draft è un lavoro<br />
degno di guadagnarsi una giusta posizione all’interno<br />
dei contesti sperimentali elettronici.<br />
(7/10)<br />
MiChele MontaGano<br />
JaMeS Blake - enouGh thunDer eP<br />
(PolYDor, ottoBre 2011)<br />
Genere: soul<br />
Con Enough Thunder Blake ci fa guardare per un attimo<br />
dentro la bottega mostrandoci definitivamente che<br />
l’immaginario timbrico tecno-emotivo a cui ci aveva<br />
abituato è solo un mezzo funzionale alle proprie canzoni.<br />
Vinto il Mercury prize, sfondato il perimetro del<br />
sottobosco IDM a suon di posizioni nelle UK’s charts e<br />
diventato icona da reiterare in infinite declinazioni, il<br />
nostro è entrato nell’elite della musica pop che conta.<br />
Nel 2011, Blake non è nemmeno più specchio per le<br />
allodole di affamati giornalisti di settore, hipster improvvisati<br />
e ragazzine alla ricerca di un bel visetto con forte<br />
indie-credibility ma semplicemente un ispirato musicista<br />
che canta e scrive canzoni al pianoforte. Spogliato<br />
quasi completamente dai canoni pop-step, il suono del<br />
giovane talento inglese predilige la verticalità all’oriz-<br />
zontalità abbinando un songwriting evanescente, edonistico<br />
e ricolmo di silenzi preziosi.<br />
In Once We All Agree (una Purple Rain aggiornatissima) o<br />
Enough thunder possiamo trovare ad esempio eterne<br />
strofe scandite da una voce che più che appoggiare le<br />
parole sembra fare zig zag tra linea vocale e contrappunti<br />
pianistici.<br />
Del resto, l’attenzione per le altezze e gli spessori vocali<br />
è certosina come testimoniato dalla cover di A Case Of<br />
You di Joni Mitchell quando invece il brano con Bon<br />
Iver merita un discorso a parte. Fall Creek Boys Choir<br />
è un crocevia d’intenti, il pradigma di due carriere che<br />
avanzano in maniera inversa: Justin Vernon alla ricerca<br />
della complessità timbrica del primo Blake e Blake ad<br />
ambire alla purezza vocale dell’esordio del primo. Una<br />
collaborazione memorabile che si configura quasi come<br />
una nuova “lega poetica” (Impossibile farsi uscire dalle<br />
orecchie il rullante zoomorfo che tanto richiama le atmosfere<br />
bucoliche dei Pink Floyd di Meedle).<br />
Enough Thunder è il trionfo della sostanza di un artista<br />
maturato che ha superato pienamente gli standard<br />
compositivi dell’esordio.<br />
(7.7/10)<br />
Dario MorolDo<br />
Jane’S aDDiCtion - the Great eSCaPe artiSt<br />
(CaPitol, ottoBre 2011)<br />
Genere: rock<br />
Dunque, ci eravamo lasciati con Stray, anno 2003, che<br />
sembrava il tipico album da vecchie glorie col conto corrente<br />
da rimpolpare. Sarebbe stato meglio evitare ma<br />
pazienza, così fan (quasi) tutti. Capitolo chiuso. E invece<br />
no. Otto anni dopo Farrell, Navarro e Perkins perseverano.<br />
Anzi, di più: fanno le cose in grande. Ci credono. Si<br />
fanno produrre da un drago del mainstream alternativo<br />
come Rich Costey e chiamano Dave Sitek dei TV On The<br />
Radio a dare una mano per mettere assieme i pezzi (e a<br />
suonare il basso, già che c’è). Il risultato: una baldanzosa,<br />
accattivante, grintosissima stronzata. Il santino di Virgin<br />
Radio nel taschino e via andare.<br />
Navarro mette in mostra il suo bel repertorio di schitarrate<br />
hard modello Ikea. Perkins va liscio di percussività<br />
ingegneristica. Farrell gode come un riccio a sciorinare<br />
la sua voce finalmente libera da quei fastidiosi derapage<br />
cocainici, da quelle svisate orientaleggianti che avevano<br />
il pessimo effetto collaterale di inquietare l’ignavio<br />
ascoltatore. Non sia mai. Parola d’ordine: una energica<br />
normalità. Altrimenti, metti che ‘sto disco capiti nello<br />
stereo di un fan di Aerosmith, Bon Jovi o addirittura<br />
U2 ultimo modello (sentitevi Curiosity Kills...), che figura<br />
ci fanno? Tuttavia, i Jane’s Addiction erano pur sempre<br />
62 63
quelli di Nothing’s Shocking e Ritual De Lo Habitual,<br />
porco cane. Eh, certo. Ed ecco puntuale quindi il contentino,<br />
una Words Right Out Of My Mouth che almeno<br />
nelle strofe rammenta barbagli dell’antica nevrastenia,<br />
salvo spianarla subito con un ritornello degno dei più<br />
beceri Pearl Jam.<br />
Mettiamola così: non fosse stato per il nome che portano,<br />
avrei mollato l’ascolto dopo un paio di minuti. Invece<br />
ne ho sprecati una quarantina. Bah.<br />
(4/10)<br />
Stefano Solventi<br />
JoakiM - nothinG GolD (tiGerSuShi,<br />
SetteMBre 2011)<br />
Genere: post-soft<br />
Copertina da over 30 per Joakim. Serissimo e stempiato,<br />
dietro un paio di occhiali a specchio, barba e capelli<br />
tagliati minimal, in più l’understatement di una sola tshirt<br />
e di un’anonimo sfondo metropolitano con trompe<br />
l’oeil di grattacieli. L’immaginario di chi si è stancato<br />
dei parties? Di chi è saturo di laser? E’ proprio lui che<br />
confessa di aver sviluppato come tema principale per<br />
questo nuovo disco lo stato d’animo che sta tra la gioventù<br />
e l’età adulta. Lo senti che è un po’ invecchiato,<br />
con tutti quei rimandi ad ere geologiche pre-nu-wave,<br />
pre-nu-disco, pre-00 se vogliamo. Un riciclo di materiali<br />
per lo più analogici già sentiti nei suoi lavori passati, ma<br />
ancora una volta riproposti in modo per niente banale.<br />
Registrato l’anno scorso a Parigi negli studi della sua<br />
stilosissima Tigersushi, il disco è un manifesto post-soft<br />
(autodefinizione calzantissima dello stesso Bouaziz):<br />
ovvi rimandi alla french disco più poshy (vedi gli inevitabili<br />
Air in Piano Magic), qualche punta di slo-motion-krautrock<br />
(Nothing Gold), le atmosfere wave degli<br />
Animal Collective (Forever Young, sì lo stesso titolo<br />
dei bistrattati Alphaville), percussioni e synth à la Japan<br />
(Fight Club) o Depeche Mode (Wrong Blood), echi<br />
now’ in trip cosmici (Paranoid), suoni da Commodore<br />
64 (Perfect Kiss) e una forma di retrofilia che abbiamo già<br />
ampiamente sperimentato con l’ultimo M83 (Labyrinth).<br />
Citazionismi colti (il titolo è preso da una poesia di S.E.<br />
Hinton), sentimenti di passaggio, colpi di stile con palette<br />
sonore uberposhy (l’introduzione sembra essere presa<br />
da una sequenza del primo Tron): un caleidoscopio<br />
balearic adatto agli angry young men’ che si sentono<br />
inadatti al pogo del concerto degli LCD Soundsystem<br />
e che però hanno ancora sull’hard disk le foto della<br />
sbandata di qualche anno fa per i Rapture. Chiamatelo<br />
revisionismo, chiamatela nostalgia, ma Joakim sa come<br />
trasportarci su un mondo alieno dalle mode (esiterei<br />
infatti a definirlo glo-fi) che con la sua personalissima<br />
estetica è ancora un faro per le nuove generazioni. Fuori<br />
dal tempo.<br />
(7.3/10)<br />
MarCo BraGGion<br />
JohnnYBoY - Meat MY BeatS (autoProDotto,<br />
GiuGno 2011)<br />
Genere: sampleDelia, beats<br />
Johnny Spataro aka JohnnyBoy, calabro di origini,<br />
trapiantato a Firenze, coordinatore di quella crew<br />
OverKnights che ormai conosciamo così bene, arriva<br />
finalmente al primo beat tape, ‘’made with two faithfull<br />
samplers, many minced samples and quite a few over(k)<br />
night sessions’’.<br />
Il ragazzo è ispirato e ne viene fuori un lavoro di ottima<br />
fattura, 15 cut sampledelici tra found voices, accordi<br />
di piano, strumenti a corda, bassi gommosi, scratch (ci<br />
sono le mani di JaJa e Franco Crudo) e sample dai dischi<br />
giusti, con in testa le radici funksoul (Since Yesterday),<br />
il Madlib freejazzofilo (Another One) e smozzichi<br />
dubstepofili (Mereg’s Phillies, con lo zampino infatti di<br />
Manuele Atzeni). Il tutto imbastito su quelle ritmiche<br />
scollate - ma saldamente piantate nell’hip hop (Come<br />
Sono, Sono; Ombra) - che sono la feature chiave delle<br />
nuove produzioni strumentali nostrane, con il pregio<br />
aggiunto di non perdere mai di vista il profilo melodico<br />
del pezzo.<br />
Nel frullatore anche un paio di remix dei compagni di<br />
cordata Daretta e Millelemmi (Bye Bye Baby e Desolato<br />
Isolato) e la westernata S.P. Strollin’ già sul sampler #0.<br />
(7.2/10)<br />
GaBriele Marino<br />
Joker - the viSion (4aD, noveMBre 2011)<br />
Genere: popstep<br />
Fino a due anni fa Joker era la tenebra, uno che con<br />
singoli come Digidesign, City Hopper e Purple City aveva<br />
interpretato il lato più repulsivo e scottante del dubstep,<br />
tanto da guadagnarsi il titolo di “king of bass music”<br />
conferito da XLR8R. Ma era il 2009, i tempi cambiano e<br />
anche lui recentemente ha frequentato le ultime derive<br />
popstep, sollevando dei bei polveroni con singoli come<br />
Tron che suonavano come una rivoluzione del proprio<br />
sound.<br />
Ancora indeciso sul nuovo volto da mostrare in futuro,<br />
il giovane producer accompagna Zomby su 4AD e<br />
pubblica un primo album che segue pedissequamente<br />
le orme del Magnetic Man che fu: popstep ingentilito<br />
che guarda alle classifiche (vedi la Woon-inspired Here<br />
Come The Lights, o la Jessie Ware già vista nei pressi di<br />
SBTRKT qui presente in The Vision come clone di Katy B),<br />
highlight<br />
feiSt - MetalS (univerSal, ottoBre 2011)<br />
Genere: folk pop<br />
Tra le voci femminili di area songwriting sbocciate nella decade scorsa, quella di Leslie Feist è tra le più<br />
intriganti per quel suo modo di smarcarsi tra presente e passato, il timbro languido e disincantato di<br />
chi vive la tradizione come un gesto tra gli altri per traghettare l’oggi nel<br />
domani, e senza perdersi in nostalgie che semmai c’è da mettere in scena<br />
struggimenti e inquietudini contemporanee (e ciò spiega la scelta di due<br />
collaboratori di lungo corso come Chilly Gonzales e del somalo/canadese<br />
Mocky alla produzione). I quattro anni di attesa dal predecessore The Reminder<br />
sono una conferma dell’indole aliena di questa ragazza, refrattaria<br />
ai ritmi convulsi dell’era internet eppure per nulla a disagio nel carosello<br />
mediatico che la vede protagonista di teaser evocativi e book fotografici<br />
che sfondano lo schermo (con quella sua bellezza indocile e spigolosa da<br />
giovane Patti Smith).<br />
Una dimensione contraddittoria cui il qui presente Metals - quarto album in dodici anni - apparecchia<br />
scenografie ottimali in cui consumarsi, dodici tracce sospese in un delizioso, suggestivo strabismo<br />
estetico, il folk-pop evoluto e i detriti soul, la ballata come archetipo necessario e tela da inzaccherare<br />
con estro terrigno e post-moderno. Vedi l’incedere solenne à la Will Oldham di Graveyard, morbidezze<br />
brass di fondo e lo sconcerto sottile di quel canto da nipotina scafata di Joni Mitchell, più lo sfarfallio<br />
allegorico dei coretti che rammentano il sempre caro Sufjan Stevens. Oppure vedi la notevole A Commotion,<br />
ovvero l’incontro tra Kate Bush e PJ Harvey nell’universo parallelo del pop-rock dei nostri sogni,<br />
tensione bluesy e vampe avant sulla spinta incalzante degli archi.<br />
O ancora, con intenzioni certo più carezzevoli, confezionando quella How Come You Never Go There che<br />
diresti frutto d’una Norah Jones più autorevole e strutturata oppure d’una Joan As Police Woman ricondotta<br />
a più miti consigli roots. C’è anche modo di ripensare alla Cat Power memphisiana - di per sé<br />
già tutta una sagra di disillusione e riarticolazioni - nelle venature gospel elettrizzate della opener The<br />
Bad In Each Other, così come al country folk ruvido e fragrante di Lucinda Williams in quella Comfort<br />
Me che s’abbandona a striature liriche Joanna Newsom via Tori Amos, mentre Anti Pioneer spalma soul<br />
come bitume su una ballad che mastica inquietudini Beth Gibbons e poi si concede una stordente,<br />
azzeccatissima agnizione orchestrale.<br />
Per quanto mi riguarda Feist ha trovato la chiave giusta per realizzarsi, ha rivelato se stessa come cantautrice<br />
a cavallo tra saldezza e smarrimento, vale a dire nel pieno dell’attrito emotivo che caratterizza<br />
i nostri strani giorni.<br />
(7.3/10)<br />
Stefano Solventi<br />
alternato a momenti bass secondo ricetta Skream (My<br />
Trance Girl e la stessa Tron). Un Joker vittima dei tempi<br />
ma con un ritardo accumulato di un anno, tanto che alla<br />
fine il sopracciglio si inarca di sorpresa solo nel lato B<br />
del disco, sui tagli ghetto-rap di Lost e Back In The Days<br />
o sull’r’n’b per le chart di On My Mind e Electric Sea, figlie<br />
del Craig David più UK garage.<br />
Tutto materiale largamente consolidato e privo di una<br />
netta impronta carismatica: la tappa più attesa del talento<br />
di Bristol è una miccia inesplosa, un inciampo che,<br />
col senno di poi, era quasi annunciato. Ora sì che urge<br />
un restyling completo.<br />
(5.8/10)<br />
64 65<br />
Carlo affatiGato<br />
Jonti - twirliGiG (StoneS throw, ottoBre<br />
2011)<br />
Genere: wonky / sunshine pop<br />
Nel mondo dei ‘’giovani music maker’’ che si fanno le<br />
ossa, prima di esordire con un disco tutto loro, come<br />
turnisti per artisti già affermati, quello che sicuramente<br />
non manca è la sapienza produttiva. Quello che invece
manca spesso è quello scatto in più (leggi gusto melodico,<br />
personalità dello stile) che faccia andare oltre il pur<br />
impeccabile esercizio costruttivo, oltre il pur generoso<br />
saggio tecnico. Ecco, è questo essenzialmente, pur con<br />
tutte le diversità del caso (ma è questo il parallelo che ci<br />
è subito venuto in testa), che distingue l’esordio del pur<br />
bravissimo Jules Chaz (del giro dei Cobblestone Jazz;<br />
bravissimo davvero, ma un po’ troppo derivativo) da<br />
quello di Jonti, già collab di Mark Ronson e Santigold,<br />
al suo debutto sulla mai troppo lodata Stones Throw.<br />
La musica di Jonti, pur dichirando le proprie fonti (le<br />
produzioni di Madlib, l’etereo indie degli Stereolab, gli<br />
anni Sessanta solari, barocchi e vocali di Free Design e<br />
Beach Boys; ma anche il collagismo, la sperimentazione<br />
sui materiali e la complessità-travestita-da-semplicità<br />
del videomaker Norman McLaren), riesce a venire fuori<br />
con stile e soprattutto personalità, realizzando un’idea<br />
di musica pop contemporanea e dinamica (ed essenzialmente<br />
strumentale), magari rivestita - attorcigliata,<br />
come da titolo - da tutti gli skills produttivi del momento,<br />
ma colorata, godibile, fischiettabile: fresca come un<br />
futto tropicale.<br />
Jonti crea dei quadretti wonky eleganti, psichedelici<br />
ed esotici per i quali non si può non usare l’aggettivo<br />
delizioso: dalle carinerie fiatistiche-tastieristiche di<br />
Nightshift in Blue, all’exotica languida di Batmilk, passando<br />
per l’inciso alla Penguin Cafe Orchestra - ovviamente<br />
wonkyzzata - di Firework Spraying Moon e i Residents/<br />
James Pants di Spooky Sport. Davvero un bell’esordio,<br />
consigliato tanto agli amanti delle produzioni strumentali<br />
post-HH quanto agli indie e ai fricchettoni.<br />
(7.4/10)<br />
GaBriele Marino<br />
JuStiCe - auDio, viDeo, DiSCo (eD BanGer<br />
reCorDS, ottoBre 2011)<br />
Genere: proG touch<br />
Secondo e tanto atteso disco per Xavier de Rosnay e<br />
Gaspard Augé. Dopo quel segnaposto che è stato per<br />
moltissimi il loro esordio (Cross), si smarcano dalle paludi<br />
dell’hard rock misto al fidget - ormai solo un ricordo<br />
anche per i nostrani e sdoganati Crookers - e puntano<br />
su un memorabilia affabile degli anni Settanta. Sì, riprendono<br />
in mano le sonorità degli Yes, dei primi Queen<br />
e pure degli Eagles e le mescolano al loro modo di fare<br />
rock’ apparentemente cazzone e trasandato, come il<br />
buon Busy P insegna. Il daftismo del duo segue però<br />
una strada aliena dal conglomerato Ed Banger, che ultimamente<br />
si rivela in molti casi solo un ombrello protettivo<br />
e claustrofobico per le eventuali innovazioni dei<br />
ragazzi post-f-touch.<br />
Per uscire dal seminato si chiamano in studio - pensiamoci<br />
bene: chi non accetterebbe? - degli amici come<br />
Ali Love (la voce di Do It Again dei Chemical Brothers),<br />
Vincent Vendetta dei Midnight Juggernauts (Ohio)<br />
o Morgan Phalen dei Diamond Nights (On’n’On), ci si<br />
sputtana con le multinazionali uberpop (Civilization è<br />
stata infatti la colonna sonora di un noto spot Adidas),<br />
ci si crogiola con la retrofilia di Who e AC/DC (Newlands),<br />
Supertramp, il filtraggio Daft Punk (Helix) e per certi versi<br />
si resta ancorati a un marchio di fabbrica che riporta<br />
la tradizione più illuminata del touch (Tellier e Air in<br />
Parade), mescolando al tutto una pomposità barocca<br />
(Horsepower, Canon (Primo)) che distingue da sempre i<br />
lavori del duo crociato.<br />
Il disco non ha i singoli macinaclassifiche dell’esordio<br />
(l’unica botta probabilmente è la titletrack), non ha la<br />
freschezza di un suono-che-va-di-moda oggi, ma fa il<br />
suo lavoro in maniera egregia, si lascia ascoltare in loop<br />
sia dal pubblico dance che dal pubblico rock e merita<br />
per questo una degna considerazione nell’alveo dei figliocci<br />
adottivi di Guy-Man e Bangalter. I Justice invecchiano<br />
senza sputtanarsi. Alla lunga, scoppiata la bolla<br />
french, il loro suono sembra essere però destinato a far<br />
godere solo gli aficionados.<br />
(6.6/10)<br />
MarCo BraGGion<br />
koDiak - koDiak (Denovali, ottoBre 2011)<br />
Genere: Doom/noise/exp<br />
Novità o ristampa, questo album omonimo dei tedeschi<br />
Kodiak? Un po’ e un po’, a dir la verità. Nel doppio cd<br />
edito da una Denovali sempre più punto di riferimento<br />
per i suoni estremi - dal metal al post-rock, passando<br />
per ambient e experimental, tra cui i nostri Lento - il<br />
terzetto da Gelsenkirchen/Bochum unisce alle due tracce<br />
dell’omonimo album d’esordio, le composizioni rilasciate<br />
negli split con Nadja (MCCCXLIX The Rising End)<br />
e Black Shape Of Nexus (Town Of Machine) e il nuovo<br />
lavoro collaborativo con N, al secolo Hellmut Neidhardt,<br />
dal titolo Rn|Xe - disponibile solo in formato vinilico -<br />
oltre ad una traccia previously unreleased (By The Sea).<br />
Drone, ambient, noise, doom, attitudine “post” e slanci<br />
sperimentali è ciò che imbastiscono i tre nelle lunghissime<br />
e quasi statiche composizioni, calibrate tra improvvise<br />
aperture noisy, vuoti pneumatici fatti di assenza e<br />
rarefazione e instancabile ricerca sul suono e sulle possibilità<br />
di profondità del soundscape ambientale.<br />
Interessante notare attraverso quello che in definitiva<br />
ne rappresenta l’intero percorso, l’evoluzione sonora del<br />
trio tedesco: dal romanticismo di matrice heavy postrock<br />
degli esordi (una Beginning tesa e vibrante sulle<br />
highlight<br />
laPinGra - SalaMaStra (iMaGo, ottoBre 2011)<br />
Genere: pop contaminato<br />
Avessero prediletto solo certi intarsi comunque presenti nella loro musica (This Is Not A Test), i Lapingra<br />
sarebbero rientrati tra le miriadi di formazioni dedite a un electro-indie di pregevole fattura ma<br />
obiettivamente fin troppo inflazionato. Invece in Salamastra Paolo Testa e<br />
Angela Tommassone optano soprattutto per un pop variopinto, caleidoscopico<br />
nelle influenze e destinato a sfiorare nei momenti migliori (con tanta<br />
tenacia e altrettanta incoscienza) le altezze contaminate di artiste come St.<br />
Vincent (Run Atreyu Run, Put Them In A Box), pur rimanendo ben ancorato<br />
a una concezione minimale e ironica in stile Le-Li.<br />
Un controsenso? Certo, come tutta la produzione di questo duo a soffietto<br />
(nel senso di espandibile, soprattutto in dimensione live in cui si arriva fino<br />
a venti elementi), capace di piazzarti sotto il naso un classicismo cinematografico<br />
in salsa Björk rubato alla Moon River di Colazione da Tiffany (One Day) e certe perle pop di<br />
genuino stupore (Anacleto), una Kazu Makino in versione anime (Kangaroo) e accenni a coralità in stile<br />
Architecture In Helsinki (Whop!). E se l’unico esperimento in italiano strizza l’occhio a certe cadenze<br />
de Il genio (Solo un disegno circolare) è solo per puro caso, visto che in altri frangenti (Miracles) il mood<br />
punta dritto alle Cocorosie ma anche a un disordine consapevole fatto di produzione esemplare e<br />
soluzioni scombinate ma brillanti.<br />
Se non ci avete capito gran che non preoccupatevi: è esattamente quello a cui mira la formazione<br />
molisana. Impegnata a costruire un castello di carte che, nella sua improbabile ma meravigliosa estemporaneità<br />
fatta di archi, ottoni, strumenti giocattolo, tastiere e chissà cos’altro, regala musica nutriente<br />
e di assoluto valore.<br />
(7.3/10)<br />
faBrizio zaMPiGhi<br />
corde di un classicismo post-mogwaiano, complice il<br />
cello di Emelie Molin) all’afflato mistico-doomy che ne<br />
pervade sottotraccia lo scibile (End, lo sludge putrescente<br />
e ribassato di Town Of Machine), per arrivare alle<br />
sperimentazioni sul wall of sound d’ambito drone/soundscape<br />
(alla Sunn O))) per capirsi) del nuovo album. Un<br />
interessante e a tratti spossante fermo-immagine sullo<br />
state of the art della lentezza made in Europe.<br />
(7/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
kueDo - Severant (Planet Mu reCorDS,<br />
ottoBre 2011)<br />
Genere: kosmische music<br />
Nonostante il percorso di avvicinamento iniziato l’anno<br />
scorso con gli eppì Starfox e Dream Sequence, ascolti la<br />
prima traccia di Severant, Visioning Shared Tomorrows,<br />
puro intrattenimento kosmische anni ‘70 ascrivibile<br />
per intero a Jean-Michel Jarre e all’era delle tastiere<br />
kraut, e sembra incredibile che Kuedo sia l’invenzione<br />
di Jamie Vex’d: il responsabile di quel Degenerate datato<br />
2005 che fu tra le scosse più aggressive e penetranti<br />
dell’ondata dubstep, al quale poi cercò di dar seguito<br />
Cloud Seed rispolverandone con scarso successo i risvolti<br />
oscuri più d’ambientazione. Ora è il 2011 e il duo Vex’d<br />
si spezza seguendo due strade diverse, con l’altra metà<br />
Roly Porter che esordisce con un Aftertime denso di<br />
architetture dub-techno complesse, e Jamie che invece<br />
finisce in piena parentesi nostalgica, con la mente<br />
dispersa tra quegli anni che han segnato la definitiva<br />
affermazione dell’electronica moderna.<br />
Altro che orientamento al futuro, Severant è retrologia<br />
sistematica ricondotta alle visioni Blade Runner, con<br />
strascichi di malinconia da cameretta che rasenta lo<br />
spirito glo (Salt Lake Cuts, meno distante di quanto si<br />
pensi da un Com Truise). L’esigenza attualizzante Jamie<br />
la concentra tutta in una sezione ritmica che corre su<br />
un binario parallelo, quasi indipendente, fino a ridursi<br />
semplice espediente tecnico per dar peso alle tracce:<br />
senza scomodare inutilmente gli ascolti indicati in press<br />
66 67
highlight<br />
new look - new look (!k7, ottoBre 2011)<br />
Genere: chill-pop<br />
Ascolti l’esordio dei New Look e sembra quasi che fare un disco pop coinvolgente e carismatico al giorno<br />
d’oggi sia un gioco da ragazzi. Come se i rischi di derivatismo più o meno appariscente dai soliti ‘80<br />
e di appiattimento su un mood che nei tempi si è evoluto pochissimo fossero solo delle piccole note a<br />
margine facilmente eludibili, e non - com’è in realtà - delle trappole fatali su cui incappano nove dischi<br />
su dieci. Poi ti guardi intorno, realizzi che i casi che riescono a svincolarsi<br />
dai soliti rami genealogici synth- (gli onnipresenti Depeche Mode e New<br />
Order), dream- (Cocteau Twins sempre attualissimi) e ambient- (il filone Air<br />
detta ancora scuola) si contano sulle dita di una mano, e ti accorgi quanto<br />
sia facile apprezzare le qualità (e la spontaneità) dell’album in oggetto.<br />
Il segreto della coppia canadese è saper accostare le melodie morbide e carezzevoli<br />
disegnate dalla vocalist Sarah Ruba (una triangolazione irripetibile<br />
tra la discendenza storica di Madonna, l’r’n’b-mainstream USA tutto pepe<br />
di Beyoncé & co. e quella pasta soul che non può non ricordare una certa<br />
Sade) a delicate aperture dance da camera di decompressione, passate<br />
lungo un filtro di ricordi di decenni passati che ne addolcisce la carica. Come dire il rebirthing chill-out<br />
applicato a un pop stanco di inflazionarsi con additivi synth: a esser solleticate sono certe movenze<br />
ambient-house (vedi una Numbers che, seducente e delicatissima, chiude addirittura su nostalgici memorabilia<br />
acid) e rispolveri disco (nella patinatissima So Real rivive Donna Summer), il tutto su un fondale<br />
compatto di sedimenti electro e residui technopop presi dai Kraftwerk di The Man-Machine (Relax Your<br />
Mind, con tanto di crescendo 8bit).<br />
La mente ritorna agli apici indimenticati dei conterranei Junior Boys (A Light), o ancor prima alle ambiziose<br />
traiettorie ambient-pop dei primi Gus Gus (Drive You Home), tenendo comunque vicina la ballabilità<br />
nu-soul dei più recenti Little Dragon (Teen Need). Nessuna vera hit-bomba (anche se Numbers e Teen<br />
Need...), a vincere è l’atmosfera avvolgente, consapevole del proprio raggio d’azione e sottesa tra due<br />
vertici (neo-soul e dance) con cui flirta in modo galante e rispettoso, evitando di invaderne gli spazi.<br />
Sembra roba da niente, ma stacca di netto gran parte degli indie-pop act emersi recentemente, inclusi<br />
nomi rispettabilissimi quali Metronomy, Mirrors o Austra. Per la serie “quando il Canada è in forma,<br />
non ce n’è per nessuno”.<br />
(7.3/10)<br />
Carlo affatiGato<br />
(footwork e coke rap), questo è reflusso step anni ‘10<br />
(quell’effetto ‘ali di mosca’ di Onset o Ascension Phase<br />
rintracciato di recente in Zomby o Machinedrum), che<br />
però risulta a tratti avulso e restìo a modellarsi sulle<br />
aperture cosmiche che sottende.<br />
Va detto che l’album è sicuramente sentito, appassionato,<br />
e dalla sua ha certi colpi ben centrati, vedi brani<br />
come Ant City o Seeing The Edges densi di suggestioni<br />
dark, o una Flight Path da applausi col suo taglio sci-fi/<br />
mistery solido e sicuro. Ma rimane nell’aria un senso di<br />
accartocciamento, che riceve risposte troppo deboli da<br />
frangenti quali Scissors (irrisolte contraddizioni ritmicomelodiche)<br />
o Reality Drift (leggerezza in cerca d’autore).<br />
L’ascolto ripetuto apre più perplessità di quanto non ne<br />
risolva e restituisce un Jamie introspettivo come non<br />
mai, ma che tralascia di convincere l’ascoltatore. Di rispolveri<br />
delle primigenie electro ne sono emersi diversi<br />
negli ultimi anni (e trasversalmente a più generi), ma<br />
senza il sostegno di un’impronta caratteriale marcata<br />
una full-immersion così esplicita rischia di risultare fine<br />
a sé stessa. Incorreggibile Vex’d, riuscirà mai a mettere<br />
tutti d’accordo?<br />
(6.1/10)<br />
Carlo affatiGato<br />
l-viS 1990 - neon DreaMS (niGht SluGS,<br />
SetteMBre 2011)<br />
Genere: Dance pop<br />
Non c’è da stupirsi che James Connolly sia tra i producers<br />
più apprezzati della dance underground UK e non:<br />
la Night Slugs, da lui fondata insieme a Bok Bok, si è<br />
rivelata negli ultimi anni una delle etichette più attente<br />
alle ultime frontiere da club grazie a un mirabile roster<br />
fatto di nomi quali Egyptrixx, Jam City, Girl Unit e Lil<br />
Silva, e anche lo stesso contributo dato dalle sue uscite,<br />
dall’EP omonimo del 2008 al recente Forever You, ha<br />
disegnato un percorso mirato sempre abile a coniugare<br />
aria di novità (funky) e solidità strutturale (house). E<br />
questi sono fatti ben consolidati, tutte ragioni più che<br />
lecite per pretendere dal primo full-lenght a nome L-Vis<br />
1990 qualcosa di più che una semplice serie di pezzi<br />
dance che scorre in punta di piedi senza lasciare tracce<br />
degne di nota.<br />
La realtà invece è che Neon Dreams vuol essere fondamentalmente<br />
un disco pop, di quelli a largo consumo e<br />
facile ascolto. I vari umori deep (The Beach), le venature<br />
disco (Shy Light) o i 4/4 furbetti (Illusions) sono tutte ipotesi<br />
sfiorate con timidezza, stando bene attenti a non<br />
rischiare cali di fruibilità ad ampio raggio. Sicuramente<br />
più redditizio puntare (ancora...) sulla formula garantita<br />
degli Hercules And Love Affair (devotissime Tonight,<br />
Play It Cool e Lost In Love), giocando però a carte ancora<br />
più scoperte di quegli Azari & III che, loro malgrado,<br />
tengono ancora ben presente la lezione oldskool house.<br />
Qui l’aria è più quella dello Shit Robot dell’anno scorso,<br />
vale a dire chiudersi nelle certezze del proprio studio e<br />
passare la giornata a spolverare i cimeli fino a farli nuovamente<br />
luccicare. Tanto per evitare di sbagliare. La<br />
montagna ha partorito il topolino? Forse in realtà era<br />
solo una collinetta...<br />
(5.9/10)<br />
Carlo affatiGato<br />
le-li - BlaCk alBuM (GarrinCha DiSChi,<br />
ottoBre 2011)<br />
Genere: pop folk<br />
La loro cover di Barbie Girl degli Aqua è stata senza dubbio<br />
una delle migliori del Cantanovanta di Garrincha.<br />
I due avvistamenti precedenti (Music’s Not For Grown<br />
Up, 2008 e My Life On A Pear Tree, 2010) hanno gettato<br />
un alone misterioso e intrigante sul duo vicentinobolognese.<br />
I Le-Li giungono con questo Black Album<br />
ad un punto di svolta. Prima di tutto sperimentano<br />
l’idioma nostrano, che suggella le liriche del “lato A”. In<br />
più, decidono di aprire le porte del progetto a nuovi<br />
strumenti e strumentisti, che rendono più determinato,<br />
ficcante e saporito il prodotto.<br />
Devoti a una lunga tradizione swing-folk (che parte negli<br />
anni 50, passando per i Beatles e Norah Jones), i<br />
Le-Li tessono trame delicate, fra sogni in bianco e nero<br />
e favole al telefono. La leggerezza di fondo sfuma pian<br />
piano per lasciare spazio ad un introspezione tutta fanciullesca<br />
(Alla Befana è una tenera invocazione in chiave<br />
pop, mentre A cosa servono le tonsille è un interessante<br />
indagine sulla pratica chirurgica tanto in voga negli anni<br />
80). Strumenti giocattolo, ukulele, case delle bambole:<br />
sono piccoli tasselli che determinano il carisma e la personalità<br />
del duo.<br />
Una volta capito l’universo di Le-Li, ce ne si può facilmente<br />
appassionare, cadendo intrappolati nei ritornelli<br />
o nelle melodie di fiati (plauso speciale a Elio Dalla Casa<br />
per questi). Il lungo ponte che collega il pop alla musica<br />
d’infanzia, al folk, alla musica da strada, al cantautorato<br />
di Sergio Endrigo, è percorso a vele spiegate, rivelando<br />
solo pochi intoppi (la voce potrebbe dare di più, soprattutto<br />
nell’italiano). Con le dovute accortezze, il loro Black<br />
Album può rivelarsi una buona trapunta per superare<br />
l’inverno.<br />
(7/10)<br />
nino CiGlio<br />
loS CaMPeSinoS! - hello SaDneSS (wiChita<br />
reCorDinGS, noveMBre 2011)<br />
Genere: canaDian inDie pop<br />
Non c’è che dire, Hello Sadness è un disco inappuntabile.<br />
Formalmente ed esteticamente perfetto nel rientrare<br />
in un preciso canone, che poi è la maniera espressiva<br />
dell’indie-pop - o meglio, di certo indie-pop - dagli ultimi<br />
dieci anni a questa parte. Già quando uscì l’esordio<br />
di questi giovinastri di Cardiff (Hold On Now, Youngster,<br />
2008) il nome del gioco era talmente evidente che prima<br />
ancora di ascoltare, bastava vedere la label - Arts &<br />
Crafts, in Europa Wichita - per capire di trovarsi di fronte<br />
a una versione gallese dei Broken Social Scene. Semplicistico,<br />
direte voi. Eppure è proprio così, come hanno<br />
poi confermato le due uscite successive e adesso anche<br />
queste nuove canzoni, registrate con il veterano John<br />
Goodmanson (Bikini Kill, Wu Tang Clan, Sleater-Kinney).<br />
Provate pure la title track e Songs About Your Girlfriend:<br />
chitarre anni ’90 e grandeur tutta canadese. Orfani di<br />
Brendan Canning e Kevin Drew (da poco entrati in pausa<br />
indefinita), gioite pure.<br />
Los Campesinos! oggi sono la prova vivente che il decennio<br />
altrimenti noto come Noughties non è passato<br />
indenne: satellitare e rizomatico, certo, ma colmo di<br />
tendenze e capiscuola che adesso sono, dicevamo sopra,<br />
maniera. Quindi non stupisca se, a un ascolto più<br />
68 69
attento, emerge che alle cadenze iperaccelerate degli<br />
esordi ha fatto posto un lirismo folk-wave tutto Win Butler,<br />
magari filtrato attraverso la sua analoga scoperta del<br />
folk di matrice springsteeniana, con la sola di sostituire<br />
il Boss con Billy Bragg giusto per vicinanza geografica<br />
(Hate For The Island). “Cresceranno” è l’auspicio con cui<br />
tre anni fa chiudevamo la recensione del debutto: in<br />
effetti Gareth e gli altri sei Campesinos sono cresciuti,<br />
e sono diventati gli Arcade Fire. Non c’è che dire, il percorso<br />
di evoluzione è del tutto coerente, nel guardare<br />
al Canada come stella polare assoluta.<br />
E la personalità? Ci sarebbe, e occorre scavare nei testi<br />
ma è difficile che emerga da sé, in un set così preordinato.<br />
Per cui sì, tutto a posto, tutto bello, tutto più<br />
o meno confermato. Guardate pure a questo disco se<br />
volete quella cosa. Ma aspettarsi altro, aspettarsi di meglio,<br />
non è il caso.<br />
(6.7/10)<br />
antonio PuGlia<br />
loSt triBe - loSt triBe (BlinD ProPhet,<br />
ottoBre 2011)<br />
Genere: Goth punk<br />
Neanche il punk americano più intransigente ed incompromissorio,<br />
quello tutto chiodi di pelle, borchie e<br />
trucide toppe crust, è rimasto insensibile al revival 80’s<br />
che da qualche anno a questa parte sta facendo la fortuna<br />
di label come Sacred Bones fin giù all’etichetta più<br />
misconosciuta.<br />
Lo dimostrano i Lost Tribe, nuova band formata da<br />
membri di gruppi hardcore a stelle&strisce come SSR,<br />
Syndrome e Aghast alle prese con un sound ben più tetro<br />
a base di forti dosaggi di T.S.O.L., Christian Death e<br />
primissimi Killing Joke. Già citati su queste pagine grazie<br />
a The Dawn, la cassettina di debutto, i ragazzi in nero<br />
della Virginia arrivano al full-length per la Blind Prophet<br />
di Sean Ragon (leader dei Cult Of Youth), label già artefice<br />
dell’edizione in vinile degli album di Art Abscons e<br />
Mueran Humanos.<br />
Se in occasione della tape avevamo parlato di pezzi<br />
dark-punk in bilico tra tensione hardcore e macabro<br />
lirismo goth, Lost Tribe riprende quattro di quei cinque<br />
brani, appesantendo e inspessendo il suono, così da<br />
risultare ancora più greve e viaggiare di gran carriera<br />
su binari a dir poco scuri dove basso e batteria corrono<br />
minacciosi come scariche elettriche, chitarre e tastiere<br />
erigono fatiscenti cattedrali sonore e la voce è un sermone<br />
intriso di mestizia, un copione lirico a base di desolazione<br />
e macabro surrealismo.<br />
Per tutti coloro che, pur all’interno del vasto calderone<br />
wave-revival, sentivano la mancanza di queste sonori-<br />
tà al contempo tetre e aggressive i Lost Tribe sono un<br />
ascolto obbligato e questo debutto lo dimostra senza<br />
indugi.<br />
(7.3/10)<br />
anDrea naPoli<br />
lou reeD/MetalliCa - lulu (univerSal,<br />
noveMBre 2011)<br />
Genere: rock opera<br />
Signore e signori, habemus monstrum. Se ne è già parlato<br />
e se ne parlerà ancora tanto, di Lulu. Chissà perché,<br />
poi. “Una collaborazione insolita sarebbe stata tra Metallica<br />
e Cher. Questa è una collaborazione ovvia“, spiega<br />
Lou. Che evidentemente ha perso il pelo ma non il vizio,<br />
e chi di voi si sta ancora grattando la testa ha evidentemente<br />
dimenticato che questo signore quasi settantenne<br />
è lo stesso di Metal Machine Music. Berlin. The Bells.<br />
The Raven.European Son. Sister Ray. Meditation Music (il<br />
disco elettronico che nessuno ha ascoltato). Del maestro<br />
di Tai Chi sul palco. Dobbiamo continuare? No di certo.<br />
Allora, Lulu. Che, anzitutto, non è un disco di canzoni. È,<br />
strettamente, un’opera rock, e come tale è inseparabile<br />
dal suo libretto, ovvero i testi che Reed ha preparato per<br />
una recente messinscena berlinese di Robert Wilson dei<br />
celeberrimi drammi di Frank Wedekind, Il vaso di Pandora<br />
e Lo spirito della terra. Testi che, lo diciamo subito, ce<br />
lo restituiscono davvero al meglio: crudi, violenti, evocativi,<br />
poetici, intrisi di una forza espressiva che latitava<br />
da molto tempo (sono migliori, per dire, di quelli di The<br />
Raven, guardacaso scaturito anch’esso da una collaborazione<br />
con Wilson -POEtry - in cui però non riusciva<br />
in modo del tutto convincente a modernizzare Poe,<br />
restando troppo ancorato al modello). Per molti versi,<br />
Lulu sembra una versione pulp di Berlin: a ben vedere,<br />
tra il cuore di ghiaccio della protagonista, femme fatale<br />
archetipica e l’Alaska di Caroline corre davvero poco.<br />
Insomma, Lou gioca in casa e non solo - com’è prevedibile<br />
- vince, ma talvolta si supera. Aprire un album<br />
con un verso come “mi amputerei le gambe e le tette<br />
/ quando penso a Boris Karloff e Kinski / nel buio della<br />
luna” possono permetterselo in pochi, senza sembrare<br />
pretenziosi o ridicoli. Anzi, può permetterselo solo lui.<br />
E qui entrano in gioco i Metallica. Ok, Lou non sarà<br />
Cher, ma perché proprio loro come backing band?<br />
Anche perché oltre a non essere un disco di canzoni,<br />
Lulu non è nemmeno un disco metal. Almeno non nel<br />
senso ortodosso. James Hetfield si limita ad accennare<br />
e sottolineare qualche parola chiave (prende il timone<br />
solo in The View, scelta come anteprima con il probabile<br />
intento di accattivare i fan e sortendo invece l’effetto<br />
opposto), lasciando a Reed tutto lo spazio per divagare<br />
highlight<br />
newtone2060 - Shot (fratto9 unDer the SkY, aGoSto 2011)<br />
Genere: impro-Jazz<br />
Giungono al terzo album i Newtone2060 ma non si stancano di stupire, focalizzando<br />
ancor di più la propria proposta. Musica d’avanguardia, quella del trio<br />
Calcagnile/Albert/Sammartino (rispettivamente drums/objects/effects; voice/<br />
effects; turntables), che smussa angoli, confonde le tracce e propone derive<br />
inattese ad ogni cambio di passo, ad ogni giro di battuta.<br />
L’opener How Is Your Heart? è una roba dall’andamento claudicante e swingato<br />
come sapeva essere il soul-mutante dei Soul Coughing misto a certe robe<br />
white-hop, senza nessuna traccia di hip o negritudine, ma in grado di catapultare<br />
jazz astruso, vocalità nera, afasie ritmiche e rumorismo concreto in un calderone inarrestabile.<br />
Troppa roba? No, manco per niente. Perché il senso di Shot risiede proprio nella fagocitazione infinita di<br />
input e rimandi, come un Naked City d’antan onnivoro e tentacolare reso al ralenti e senza parossismo<br />
strumentale. O come certo “jazz” rumorista d’avanguardia di quello di base alla Setola Di Maiale, ma<br />
con un senso del groove atipico, coinvolgente e con una infinita attrazione per il collage e il montaggio.<br />
Destrutturazione e ricomposizione in set tra l’acustico e l’elettrico, capace di partire da un punto di<br />
partenza alieno - le parole di Bukowski - per arrivare su un pianeta altrettanto alieno fatto sì, di decomposizione<br />
strutturale di matrice colta (Cutler, certo, e pure i nostri A Spirale, Camusi, Illàchime Quartet<br />
e tutti quelli di Musica Improvvisa), ma anche di ricombinazioni limitrofe al pop - la resa di Through The<br />
Barricades degli Spandau Ballet, tutto un accessibile stop’n’go frankesteiniano - e di stalagmiti di fonti<br />
sonore estranee e spiazzanti (divertitevi a cercare tra i vari frammenti “echoes of italian songwriters,<br />
tango, ’80s, bebop and trash”). Così l’a-ritmo dei Sinistri va a braccetto con le schizofrenie soul della<br />
voce (Love&Fame&Death) o l’industrial per voce e ossessioni di Amazing (lyrics dal “A Challenge To The<br />
Dark” del citato scrittore americano), convivono con gli intricati pastiche vocali e i frammenti dei vinili<br />
dalle fonti più disparate, diegetiche ed extra- (marcette fischiate, sirene, stralci di piano classico, fruscii<br />
di puntine, do-bop scratchato, ecc.). Una vertigine di suoni per una fruibilità invidiabile.<br />
(7.5/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
con il suo talking stonato e, come felicemente definito<br />
da qualcuno, disancorato. E se si sta molto attenti, a<br />
parte i riffoni Sabbath della citata View e Frustration e la<br />
cavalcata thrash di Mistress Dread, non si tratta esattamente<br />
di metallo duro e puro. È pur sempre metal-Lou.<br />
Brandeburg Gate e Iced Honey sono puro vecchio stile<br />
à la Sweet Jane, rese solo più truci dai Four Horsemen;<br />
l’uso espressivo e reiterato di droni di violino e organo<br />
portano al puro suono di Metal Machine Music e della<br />
recente musica per meditazione (oltre a sembrare una<br />
strizzatina d’occhio al vecchio amico/nemico John Cale<br />
e alla moglie Laurie Anderson); e forse che la conclusiva<br />
- e notevole - Junior Dad non rinverdisce i fasti di<br />
Street Hassle? Lulu è piuttosto un disco che usa i toni<br />
del metal per veicolare certi contenuti lirici, in modo<br />
descrittivo e evocativo. Un effetto riuscito in Cheat On<br />
Me e - ottimamente - in Pumping Blood; stando alla pura<br />
brutalità di quest’ultima (si mette in scena il massacro<br />
della protagonista da parte di Jack lo Squartatore), in<br />
effetti non ci volevano i Metallica. Ci volevano gli Slayer.<br />
E se tutto questo per la maggior parte dei metalheads<br />
può risultare incomprensibile (come se unire metallo e<br />
intelletto fosse tabù, ma qualcuno si ricorda di Marianne<br />
Faithfull in The Memories Remain?), nell’ottica reediana<br />
- diremmo: velvettiana - acquista perfettamente senso.<br />
Lulu è un esperimento, così come lo era White Light /<br />
White Heat: cambia solo la forma, ma lo spirito è quello.<br />
È un esperimento riuscito? Non del tutto, perché è di<br />
fruizione palesemente difficile, soffre l’eccessiva lunghezza<br />
dell’insieme e dei singoli episodi e il matrimonio<br />
tra le due entità artistiche si in realtà si consuma solo in<br />
parte, e con esiti comprensibilmente controversi. Il suo<br />
valore, più di tutto, consiste nel rimettere in discussione<br />
le potenzialità di un genere - il rock - che qualcuno<br />
70 71
highlight<br />
riChMonD fontaine - the hiGh CountrY (DeCor, SetteMBre 2011)<br />
Genere: rock folk<br />
A due anni dal buon We Used To Think The Freeway Sounded Like A River tornano i Richmond Fontaine,<br />
band capitanata da quel Willy Vlautin che negli ultimi anni ha coronato la sua indole di scrittore<br />
con tre fortunati romanzi, da uno dei quali - The Motel Life, il debutto del 2006 - è stato anche tratto un<br />
film per la regia dei fratelli Alan e Gabe Polsky. Lo stesso impasto di fatalismo allibito carveriano e speranza<br />
dissipata McCarthy che sostanzia quelle pagine corre come un filo teso tra le diciassette tracce di<br />
The High Country, decimo lavoro in tre lustri per il quinettto da Portland, altrimenti definibile concept<br />
album ma ancora meglio un racconto che procede di canzone in canzone.<br />
La vicenda - una problematica storia d’amore tra un meccanico ed una commessa, due loser nella terra<br />
dimenticata dal Sogno Americano - si nutre per così dire degli sketch atmosferici<br />
apparecchiati dai pezzi, ma ancor più sono le canzoni a beneficiare della<br />
spinta narrativa, cavalcandone gli accumuli emotivi ed i rilasci estatici che in<br />
un certo senso diventano additivi della trama sonora. Non stupisce quindi<br />
trovare i Richmond molto più versatili e incisivi che nelle ultime prove, disposti<br />
tanto alla ballata intimista (le toccanti Deciding To Run e Let Me Dream Of The<br />
High Country - cantate dalla brava Deborah Kelly dei Damnations - o quella<br />
The Meeting On The Logging Road che coglie petali spiegazzati Howe Gelb da<br />
una margherita Eels) che alla vampa elettrica (l’impeto Decemberist via 16th<br />
Horsepower della stupenda The Chainsaw Sea, i trilli e le pennate incandescenti di Angus King Tries To<br />
Leave The House, l’inquietudine radente Stan Ridgway di Lost In The Trees), per non dire della fregola<br />
onirica che solleva da terra episodi impressionisti (in senso cinematico) quali The Mechanic Falls In Love<br />
With The Girl o I Can See A Room (Brian Wilson colto da afflizione Black Heart Procession?).<br />
Per tutto ciò, alt-country potrebbe suonare come una ben angusta definizione, individuabile al più come<br />
base sentimentale di un’Americana duttile e ramificata fin dove occorre estendere l’immaginario. Questa<br />
capacità di rappresentare una scheggia di presente - non certo tra le più comode - con toccante durezza<br />
e acceso lirismo, con un senso di necessità che non scivola nella retorica, fa di The High Country uno dei<br />
migliori titoli del repertorio Richmond Fontaine e tra i più significativi ascolti dell’anno.<br />
(7.5/10)<br />
Stefano Solventi<br />
si ostina a dare ancora per spacciato. Ci volevano un<br />
vecchietto (la cui vita è stata salvata dal rock’n’roll, se<br />
ricordate) e quattro metallari semibolliti a ricordarcelo.<br />
C’è da pensare.<br />
(7/10)<br />
antonio PuGlia<br />
luke roBertS - BiG BellS anD DiMe SonGS<br />
(thrill JoCkeY, noveMBre 2011)<br />
Genere: neo-folk<br />
Colpisce al primo ascolto il senso di intimità dell’esordio<br />
di Luke Roberts, nativo di Nashville residente a Brooklyn.<br />
Sarà forse merito della gioventù trascorsa all’aperto<br />
e consacrata alla musica, ambedue mezzi a disposizione<br />
per riempire lo spazio lasciato dalla fuga del padre. Come<br />
a dire che con un’esistenza senza punti fermi si può venire<br />
a patto e lasciarsela alle spalle usando le canzoni a<br />
mo’ di catarsi. Cosa sempre più rara nello smaliziato, ultra<br />
cinico panorama odierno e pertanto da premiare al di là<br />
di un disco che iscrive Luke al fan club di Mark Kozelek<br />
(evidenza la vibrante Unspotted Clothes) e di Will Oldham<br />
(idem per Dime Song), le melanconie rispettivamente languide<br />
e agresti dei quali sono qui lessico corrente.<br />
Il che significa composizioni di mezzi-toni arrangiate<br />
con gusto spartano però efficace (apici Somewhere To<br />
Run, la briosa Anyway, l’arazzo Epcot Women); occasionalmente<br />
- ed è lì che il ragazzo viepiù convince - attraversate<br />
da un’elettrica infiorettata di wah-wah (Just Do<br />
It Blues) che è sì Neil Young ma pure J. Mascis. Come<br />
fossero confessioni o piccoli racconti, osservi il tutto flut-<br />
highlight<br />
roCket froM the toMBS - BarflY (fire reCorDS, noveMBre 2011)<br />
Genere: Guitar-rock pre-77<br />
Immaginate di aspettare 37 anni. Facendo qualsiasi cosa, bella o brutta, della vostra quotidianità. Non<br />
propriamente un lasso di tempo breve. Immaginate ora di essere una band che aspetta di pubblicare il<br />
proprio esordio (pseudo)ufficiale. A memoria, torna in mente solo il caso dei detroitiani Death, ma lì si<br />
trattava di una riscoperta, anche se poi i tre si sono pure riformati. Quello dei Rocket From The Tombs,<br />
invece, è proprio uno di quei casi limite che ogni tanto si ritrovano nella storia<br />
del rock’n’roll. Uno di quei progetti intorno a cui la leggenda si è spesso mischiata<br />
al mito, senza che praticamente nessuno avesse avuto modo di mettere<br />
le mani su qualcosa di tangibile se non con qualche rara eccezione: giusto un<br />
cd di “live-radio and concert tapes” del 1975 (The Day The Earth Met The Rocket<br />
From The Tombs, 2002) e un altro live in studio post-reunion da vendersi come<br />
tour-cd (Rocket Redux, 2004).<br />
L’esperienza di questa band di Cleveland fu infatti breve e stitica come solo<br />
quelle delle leggende costruite sul nulla sanno essere. A parlare per i RFTT fu la filiazione diretta, per<br />
non parlare dei discendenti indiretti: da un lato i Pere Ubu di mr. David Thomas, dall’altro i Dead Boys<br />
di Cheetah Chrome, al secolo Gene O’Connor. Entrambi presenti nella prima incarnazione della band<br />
e entrambi presenti ora, in questo primo studio-album ufficiale, insieme al bassista originale Craig Bell<br />
e coadiuvati da due partner di rispetto: Steve Mehlam, attuale batterista dei Pere Ubu e l’ex-Television<br />
Richard Lloyd alla seconda chitarra a sostituire il defunto Peter Laughner. Un parterre de roi per una<br />
uscita che rinvigorisce il mito e dimostra come la classe non sia acqua e che il tempo sia un peso solo<br />
per i poveri di spirito. Barfly suona infatti al tempo stesso classico, come se fossimo nel 1975, e fresco,<br />
come se i Pere Ubu si fossero abbeverati alla fonte dell’eterna giovinezza.<br />
Guitar-rock iper-vitaminizzato (I Sell Soul), giocose retro-indagini sulla storia del rock (gli echi della The<br />
Gift velvetiana a far da scheletro portante a Good Times Never Roll), garage-rock psych & groovey come<br />
dei Dead Kennedys sotto metadone (l’indolenza del cantato di Six And Two), crooning amaro, ironico e<br />
arty (Romeo & Juliet), rock al guado tra americana e southern-rock (Pretty), punk-rock 70s retro-futurista<br />
e icastico (Anna), sarcastici carrarmati pereubuiani prima dei Pere Ubu (Sister Love Train), ballads incestuose<br />
rette da un miagolante Thomas (Birth Day), mai come ora in forma e lucido nel tirare le fila del<br />
suono della sua band primigenia.<br />
Si dirà delle assonanze col gruppo di Thomas (impossibile negarlo), si dirà che è musica datata (ma era<br />
nelle intenzioni del quintetto), si dirà che non ci piacciono le reunion (anche se qui non c’è lo scopo di<br />
lucro), ma quando si è a tali livelli possiamo anche fregarcene di tante chiacchiere. Facciamo conto che<br />
il tempo si sia fermato. O meglio, che sia tornato indietro.<br />
(7.3/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
tuare tra desiderio e ritrosia, lasciando un pizzico di mistero<br />
che indica un buon talento potenziale. E un sincero<br />
compagno col quale trascorrere le serate d’autunno.<br />
(7/10)<br />
GianCarlo turra<br />
MaGazine - no thYSelf (wire SounD ,<br />
ottoBre 2011)<br />
Genere: wheelchair wave<br />
E’ assodato che sulle reunion - analogamente ad altri<br />
aspetti sterili e morbosi del ritorno al passato - si sia ormai<br />
perso ogni freno. Nondimeno c’è chi ancora prova<br />
a cavar buchi dall’acqua come i Magazine, ritrovatisi da<br />
due anni e mezzo nella formazione dell’ultimo periodo<br />
(Howard Devoto, Dave Formula, Barry Adamson, John<br />
Doyle) integrata dal chitarrista Noko - già a fianco di Devoto<br />
nei Luxuria - a rimpiazzare il defunto John McGeoch.<br />
Passino i concerti e il rifare per intero The Correct Use<br />
Of Soap, ma con tutta la buona volontà proprio non si<br />
può salvare il materiale nuovo registrato senza un Adam-<br />
72 73
highlight<br />
SanDro Perri - iMPoSSiBle SPaCeS (ConStellation reCorDS, ottoBre 2011)<br />
Genere: post-rock<br />
Il ragazzo è canadese, ma vista l’anagrafe permetteteci di sentirci orgogliosi. Già noto per l’apprezzata<br />
attività di produttore, ingegnere del suono e remiscelatore, Perri offre dopo quattro anni la seconda<br />
prova solista pur non essendo un novellino, siccome tiene già in archivio il dub elettronico a nome<br />
Polmo Polpo e la mutant disco del progetto Glissandro ’70. Proprio da lì conviene partire, cioè dalla<br />
passione che l’uomo nutre verso il genio di Arthur Russell, rimesso in vita da questo scintillante disco<br />
e trasportato sulla tratta Canterbury-Colonia-Chicago a zonzo tra i Settanta e<br />
i Novanta. Il carburante essendo arrangiamenti curatissimi però mai leziosi -<br />
arredo sonoro da cui emerge la sapienza di chi si trova di là dal vetro con un<br />
motivo - e la scrittura, d’arguzia elaborata e passionale.<br />
Basta puntare la traccia d’apertura Changes per tastare il polso della situazione,<br />
dondolando su un passo motorik che dalla pista da ballo illividisce nei Caraibi<br />
e si spegne brusco. Oppure la samba disturbata modello ultimi Gastr Del Sol<br />
o primi Sea & Cake Love & Light; altrimenti, la seconda parte di Futureactive Kid<br />
(la prima una secca malinconia di tastiere vetrose e strumenti fantasma) che profuma di David Sylvian<br />
confuso e felice. E How Will I? I Can a un apice di giocosità avesse Holger Czukay preso la barra del comando<br />
e guardato a certo illuminato prog. Wolfman? Nientemeno che Van Dyke Parks a ridisegnare<br />
Rock Bottom con David Byrne.<br />
Alla faccia del citazionismo e della retromania, direte. Bravi, ma sappiate che le fonti originali sono intrecciate<br />
e decontestualizzate fino a istillare umanità e sorrisi nei ricordi del post rock che fu. A fungere<br />
da trama per il commiato della title-track, tenerissimo folk latino intinto nel surrealismo che suggella<br />
quello che una volta avremmo definito una gemma da culto.<br />
(7.4/10)<br />
GianCarlo turra<br />
son che il sostituto John White imita alla perfezione dal<br />
punto di vista formale.<br />
Proprio questo il punto, siccome là dove non si fa fastidiosamente<br />
il verso (The Burden Of A Song riconosce già<br />
dal titolo il ricalco da Shot By Both Sides e The Great Beautician<br />
in The Sky, ma tutto il disco rigurgita citazioni ed<br />
echi spogliati di anima e significato), Devoto si affida ad<br />
arguzie testuali e passabile mestiere (vedasi la blaxploitation<br />
Blisterpack Blues e lo sdilinquimento Pulp di Physics,<br />
certi riverberi wave-jazz e bristoliani della lenta The<br />
Worst Of Progress e il ruvido funk tardo-beefheartiano<br />
Happening In English).<br />
Il peggio giunge quando, bloccato tra il passato remoto<br />
dei maestri Bowie e Roxy Music e quello prossimo di se<br />
stesso, l’uomo plana dalle parti dei Kaiser Chiefs o rifila<br />
involuta psicanalisi e calligrafismo autoriferito. Estetica<br />
pura e spettri hanno preso il potere: non provarci più,<br />
Howard.<br />
(5/10)<br />
GianCarlo turra<br />
MakoSSa & MeGaBlaSt - SoY CoMo SoY (luv<br />
lite reCorDinGS, noveMBre 2011)<br />
Genere: afro-cuban house<br />
Torna il duo di produttori viennesi in salsa afro-beat con<br />
appunti techno animati dal battito terzomondista e primigenio<br />
che ha fatto da tempo drizzare le antenne di<br />
Kruder & Dorfmeister (il loro remake di una traccia di<br />
Rodney Hunter su G-Stone risale al 2005).<br />
Dopo il fortunato esordio con Kunuaka (sempre su G-<br />
Stone, 2007), Megablast (aka Sascha Weisz) e Makossa<br />
(Marcus Wagner-Lapierre) insistono sul background che<br />
li contraddistingue e si infatuano per coordinate baleariche<br />
(l’ottima titletrack cantata da Cleydys Villalon è<br />
già stata osannata da Villalobos, Sven Väth, Loco Dice e<br />
pure remixata dalla crew della Gigolo Records), tagliano<br />
i pezzi con l’afro beat di Tony Allen (il percussionista<br />
di Fela Kuti viene campionato in Wangu), le sincopi in<br />
slo-motion mescolate con la voce ispirata di Hubert<br />
Tubbs dei funkster londinesi Tower Of Power (Coming<br />
Home), accelerano con il beat aggiungendo tastierine<br />
progressive ai featuring della cantante dello Zimbabwe<br />
OG Spiritual Godess (Imimi), richiamano la deep tribal<br />
dei Novanta con tocchi di psichedelia (Jungo) e le visioni<br />
di Jarre fine ‘70 (Home Journey in perfetta simbiosi con<br />
le esperienze Tosca).<br />
Un ritorno molto gradito, soprattutto prima dell’inverno<br />
che si preannuncia rigido e piovoso. M & M riportano<br />
per qualche istante raggi di sole che riscalderanno i dancefloor<br />
più illuminati del pianeta. Il tutto senza strafare,<br />
con un minimalismo di forma e sostanza che merita il<br />
dovuto rispetto. Piacevole sul divano e adatto al ballo,<br />
che volete di più?<br />
(7.2/10)<br />
MarCo BraGGion<br />
Mark MCGuire - Get loSt (eDitionS MeGo,<br />
ottoBre 2011)<br />
Genere: psicheDelia<br />
Non svanisce affatto McGuire, come il titolo di questo<br />
(ennesimo) ritorno farebbe supporre. O forse sì, ma lo<br />
scopriremo in futuro. Per ora accontentiamoci del secondo<br />
album su Mego nel giro di nemmeno un anno<br />
per il chitarrista degli Emeralds dopo l’ottimo Living<br />
With Yourself.<br />
Proprio da lì, da quell’intimismo sempre meno rumoroso<br />
e molto evocativo, estremamente personale e intriso<br />
di implicazioni filosofiche limitrofe all’ipnagogico,<br />
prende le mosse anche Get Lost. L’album è suddiviso in<br />
due ideali parti: la prima è composta da canzoni che<br />
definiremmo standard per lunghezza e struttura ed in<br />
cui a farla da padrone è una sensibilità pop e una accessibilità<br />
sempre più raffinata: sia essa la reiterazione<br />
ciclica di fraseggi di chitarra marchio di fabbrica del giovane<br />
americano (l’ascendente procedere dell’iniziale Get<br />
Lost, rotto da cascate di effluvi synthetici e dalla chitarra<br />
acustica elettrificata, l’americana estatica e cosmica di<br />
Another Dead End), la pacificata atmosfera pastorale e<br />
semi-acustica di alcuni bozzetti (When You’re Somewhere<br />
col suo procedere da folk alieno) o il cantato, vera novità<br />
mcguiriana, pacioso e ipnotico di Alma, si ha sempre la<br />
sensazione di una nostalgica comunione col passato.<br />
Anche quando il lato rumorista della casa madre emerge<br />
dal fondale acustico, come nelle volute finali di Alma<br />
(Reprise)/Chances Are.<br />
A questo lato “poppy”, tarato su una personale idea di<br />
forma-canzone fa da contraltare la seconda parte, in cui<br />
a prevalere è la tessitura di più ampio respiro, con una Firefly<br />
Constellations ad occupare da sola una buona metà<br />
dell’intero minutaggio tra arpeggi gassosi, sfumature di<br />
suoni, flusso (e)statico di armonie in (apparente) perenne<br />
stallo, glitch liquidi e atmosfere malinconicamente<br />
commoventi. Sarà il caso di dire che è nata una stella?<br />
(7.5/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
MaSSiMo zaMBoni/anGela BaralDi - Solo<br />
una teraPia: Dai CCCP all’eStinzione<br />
(ultiMo Piano, ottoBre 2011)<br />
Genere: cantautorato wave<br />
“Assegnate le parti/corrono le comparse”, recita l’immortale<br />
verso di M’importa ‘na sega, cantata con impegno<br />
e posa ingrugnita da Angela Baraldi. E pare proprio<br />
che - non ce ne voglia - si riferisca a se stessa. La quale,<br />
per quanto si applichi e riesca tutto sommato a non sfigurare,<br />
rispetto alla storia delle canzoni che le vengono<br />
affidate finisce appunto per sembrare una figurante.<br />
Proprio lei, più attrice che cantante almeno da qualche<br />
anno a questa parte. Altro il peso specifico garantito<br />
a suo tempo da Nada, che nel progetto del Massimo<br />
Zamboni solista sublimava tanto la presenza che l’assenza<br />
dell’alter ego zamboniano, storicamente incarnato<br />
- ça va sans dire - dall’ineffabile Giovanni Lindo<br />
Ferretti.<br />
Mi convinceva eccome quel primo Zamboni post-CSI,<br />
per l’ipotesi di cantautorato wave che delineava, permeato<br />
cioe’ di suggestione sonica pari alla trama evocativa<br />
dei testi. Però mi è sembrato come spegnersi progressivamente<br />
in intensita’ e convinzione, accartocciarsi sui<br />
propri crucci, come se gli si fossero inaridite le prospettive.<br />
Una sensazione che questo live suggella, sciorinando<br />
una scaletta composta da tredici cartoline spedite al<br />
proprio passato piu’ o meno remoto, una carrellata di<br />
quelli che potremmo definire tranquillamente cavalli di<br />
battaglia - se mi passate il termine - firmati CCCP e CSI<br />
più appunto qualcosina estratta dagli album in solitario.<br />
Tu chiamale se vuoi cicatrici, si’, ma ormai pacificate,<br />
da mostrare come tatuaggi sbiaditi, per nulla fastidiose<br />
anzi pure carucce esteticamente parlando.<br />
Un plauso alla fibra essenziale degli arrangiamenti,<br />
chitarra “senziente” del leader come da prassi a far da<br />
mattatrice (il resto della band prevede Erik Montanari<br />
alla chitarra, Cristiano Roversi al basso ed il mitologico<br />
Gigi Cavalli Cocchi alla batteria), ma cio’ non basta ad<br />
evitare un palpabile didascalismo (in Del mondo e Cupe<br />
vampe soprattutto), mentre va a finire che i momenti<br />
migliori - forse per mancanza di fall out mnemonico da<br />
gestire - coincidono con le riletture dei brani piu’ freschi<br />
come A ritroso (con una bella tastiera spacey) e l’inedita<br />
Nove ore. Non siamo ancora all’effetto-Nomadi, ma porca<br />
miseria ci siamo maledettamente vicino.<br />
(5.5/10)<br />
Stefano Solventi<br />
74 75
highlight<br />
the SoMnaMBuliSt - live in Berlin (aCiD CoBra, ottoBre 2011)<br />
Genere: avant rock<br />
L’esordio dei Somnambulist, poco più di un anno fa, mi colpì per il felice connubio tra intensità e libertà<br />
espressiva, il desiderio di dare vita ad una proposta d’impatto (anche in senso “indie”) senza rinunciare<br />
ad inseguire l’estro sonico, l’invenzione straniante, la situazione insolita. La biografia del trio forniva in tal<br />
senso significative indicazioni: due italiani e un francese trapiantati a Berlino, uno chitarrista e cantante<br />
con trascorsi alt-rock e versatilità multidisciplinare, un altro violinista con attitudini cinematografiche e<br />
punk-folk, il restante un batterista di estrazione avant-jazz. Metti poi che questa combinazione vada ad<br />
espandersi coinvolgendo un vibrafonista belga, una fisarmonicista tedesca, un sassofonista argentino,<br />
un pianista neozelandese ed un chitarrista tedesco, e capirete come i presupposti possano esplodere a<br />
ventaglio, ramificare le traiettorie senza però smarrire la frequenza portante.<br />
Le sensibilità infatti sono disparate ma gli intenti centripeti, nella fattispecie<br />
convergenti in un progetto - la rassegna musicale Riemengast 1.3 - che ha visto<br />
il combo esibirsi per tre serate lo scorso maggio sul palco dell’Antje Øklesund.<br />
Dalle relative incisioni sono state estratte sei tracce che compongono questo<br />
Live In Berlin, un documento che testimonia lo stato di moto sparso e tenace,<br />
come è palpabile nelle tracce risalenti a Moda Borderline (con particolare<br />
riferimento a Quinto Mistero Della Gioia, bailamme espanso di latinerie noir,<br />
brume desertiche e basso motoristico col sax che sfarfalla crudo e le interferenze<br />
psicotiche delle percussioni) e ancor più nei tre pezzi inediti, che finiranno nel preannunciato<br />
nuovo album Sophia Verloren (in uscita nei primi mesi del nuovo anno).<br />
Tanto per limitarsi ad accennare - in questa sede non si può fare altrimenti - la opener My Own Paranormal<br />
Activity sbriglia tensione malinconica e febbricitante estro cabarettistico tra reminiscenze jazz-prog<br />
High Tide/Van Der Graaf Generator, mentre la futura title track s’incarica di stemperare tra caligini<br />
post certe ingrugnite tensioni Nick Cave e particelle elementari dEUS. Segnali ancora più sorprendenti<br />
provengono da ...And The Snow Still Falls: astrazioni spacey vaporizzate e fervore livido, la quiete apparente<br />
d’una ballad folk-prog presto perturbata da freevolezze scostanti e perturbazioni sintetiche, infine<br />
l’approdo sui binari di certa serialità rumoristica con retaggi fusion (tipo i Faust sognati dai Gastr Del<br />
Sol, così a spanna).<br />
Ok, a questo punto mi sembra il caso di sottolineare quanto siano più semplici - e persino divertenti<br />
- da ascoltare che da raccontare, i Somnambulist. Li attendo alla riprova del sophomore in studio. Le<br />
aspettative, non lo nascondo, sono alte.<br />
(7.2/10)<br />
Stefano Solventi<br />
Matthew herBert - one PiG (aCCiDental,<br />
ottoBre 2011)<br />
Genere: ambient opera<br />
In ritardo di qualche mese rispetto alla tabella di marcia,<br />
la trilogia herbertiana One si conclude con quello che è<br />
sin dall’inizio l’episodio maestro, il famigerato concept<br />
legato alla vita di un maiale che tanto aveva pateticamente<br />
scatenato le furie dell’organizzazione animalista<br />
PETA.<br />
Con One One a rappresentare un episodio a sé (per la<br />
scelta “a tema” che lo caratterizzava), One Pig segue<br />
dunque il canovaccio socio critico di One Club: svelare<br />
gli effettivi legami che uniscono persone, cose e strutture<br />
in una situazione specifica e localizzata. Nell’episodio<br />
precedente l’ingerenza delle multinazionali nella<br />
nightlife si traduceva in una truce techno che scendeva<br />
nei dettagli della vita del clubber fusa e infusa nel consumo<br />
legale e illegale; qui l’epopea del maiale all’interno<br />
dell’industria alimentare diventa il paradigma perfetto<br />
per svelare il reale funzionamento della nostra società.<br />
Herbert traccia una convincente antropologia muovendosi<br />
tra svariate ars elettroniche (molta ambient e<br />
proverbiali inserti proto-techno e industrial), fresche<br />
manipolazioni sulla voce (il para r’n’b kenyewestiano di<br />
August 2010), memorie mahleriane (September), folktroniche<br />
bucoliche, sprazzi 4ad (October), pastelli ambienttronici<br />
primi Novanta (Orb, Future Sound Of London)<br />
fino al folk della finale May 2011. In un’opera convincente<br />
e imprevedibile, ricca di colori e smalti, ancora<br />
residentsiana (l’ovvio riferimento a Eskimo) e lontana dal<br />
cupo strutturalismo che tutti s’aspettavano.<br />
Dopo le perplessità di One Club e un One One non memorabile,<br />
un buonissimo epilogo.<br />
(7/10)<br />
eDoarDo BriDDa<br />
MeShel nDeGeoCello - weather (naive,<br />
noveMBre 2011)<br />
Genere: soul-blues<br />
Meshel ritorna a percorrere binari standard di un<br />
buon soul infuso di americanicità e di tradizione, territori<br />
consolidati di songwriting e di professionalità<br />
a servizio di un ascoltatore adult che non si aspetta<br />
troppe news, ma che resta sempre e comunque esigente.<br />
Veste bene quindi il guardaroba classico, senza<br />
strafare, proponendo le sue ballad ad un pubblico che<br />
spazia benissimo dal bohemien hipster newyorchese<br />
all’amante del chilling (ovviamente non elettronico)<br />
da camera.<br />
La voce, che in molti punti ricorda la migliore Tracy<br />
Chapman mescolata ad un nonsoché Buckleyano,<br />
canta ballad intimiste con archi e pianoforte (Objects In<br />
Mirror Are Closer Than They Appear, Oysters), quadri pop<br />
(Chanche, Dirty World), cover più o meno note (Chelsea<br />
Hotel di <strong>Leon</strong>ard Cohen e Don’t Take My Kindness For<br />
Weakness della band soul anni sessanta Soul Children)<br />
e pure tracce con influenze dark-wave (stupenda in questo<br />
senso Rapid Fire).<br />
Prodotto da Joe Henry (Aimee Mann, Bettye Lavette,<br />
Solomon Burke, Ani DiFranco), il disco anche grazie alle<br />
comparsate di Chris Connelly (Ministry, Revolting Cocks)<br />
e Benji Hughes (collaboratore di Jeff Bridges) suona piacevolmente,<br />
producendo una sensazione di robustezza<br />
e di canonizzazione’ che solo un personaggio del genere<br />
può costruire. Lasciate perdere le derive di protesta<br />
- in una recente intervista ha dichiarato infatti che “Per<br />
lungo tempo ero contro tutti. Ho combattuto molto e ora<br />
quei sentimenti sono passati. Ho le mie opinioni, ma non<br />
sono più fonte di conflitto con il resto del mondo” - si apre<br />
da qui la strada dell’Adult Oriented Soul per la signora<br />
del basso. Una piacevole certezza per una donna che<br />
non sta mai con le mani in mano. Ha prodotto infatti da<br />
poco delle tracce per l’astro nascente del pop Selah Sue<br />
e vorrebbe registrare un disco sia con Brian Eno che con<br />
Lee Scratch Perry. You can do it, Meshell.<br />
(7.1/10)<br />
MarCo BraGGion<br />
Moha! - MeininGSlauSt oPPGulP (a<br />
SinGleS CoMPilation) (rune GraMMofon,<br />
SetteMBre 2011)<br />
Genere: free-impro-noise<br />
Autori di 3 dischi di impro-free-noise ben accolti dalla<br />
critica, i norvegesi Morten J. Olsen e Anders Hana - gente<br />
usa a trafficare con Ultralyd e tutto il giro free della<br />
Rune Grammofon - sembravano perduti dopo l’ultimo<br />
non esaltante One-Way Ticket To Candyland di 3 anni fa.<br />
Invece ora se ne escono con una raccolta di singoli e<br />
pezzi sparsi che ci pone di fronte all’amletico dubbio:<br />
presagio per un nuovo album o definitivo canto del<br />
cigno? Quale che sia l’evoluzione futura, Meiningslaust<br />
Oppgulp ci da modo di recuperare praticamente tutti i<br />
pezzi piccoli del duo norvegese: i 7” Kriisav Valgus, Jeff<br />
Carey’s Moha!, l’8” lathe cut 8-Inch #4 e i due split con<br />
Tape That e Horacio Pollard. In totale fanno 50 minuti<br />
di tipico devasto alla norvegese - blast-beats, attitudine<br />
free, schizoidi cambi di tempo, elettronica al limitare del<br />
noise, squadrati squarci math, epilessia improvvisativa<br />
- con, se possibile, una maggiore attenzione alla sperimentazione<br />
elettronica rispetto agli album interi.<br />
A fare la differenza con altri mille combo rumorosi a due<br />
in modalità chitarra-batteria è infatti l’attrazione quasi<br />
maniacale che i MoHa! hanno per l’elettronica più acida<br />
e harsh. Uno, Hana, aggiungendo electronics obsoleti e<br />
synth alla sua chitarra trattata; l’altro, Olsen, riprocessando<br />
la propria batteria attraverso software autocostruiti.<br />
Gli 11 minuti di Eg Blei Sogen Av Ein Atterganger - i primi<br />
due minuti in collaborazione con Idan Hayosh e And<br />
Vahtra sfiorano lidi harsh, il resto una brutale aggressione<br />
math-impro-free-noise -, il techno cut-up astratto di<br />
Sopp Pa Kugen (Premix) e l’iniziale Naaljos Ljom sono le<br />
punte di diamante di una compilation interessante non<br />
solo per i completisti.<br />
(6.5/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
MonSter (the) - ...PoP uP YourS! (vooDoo<br />
rhYthM, SetteMBre 2011)<br />
Genere: vintaGe GaraGe punk<br />
Arriva uno dei dischi garage punk dell’anno. La firma è<br />
quella dei Monsters, gruppo svizzero che vede arruolato<br />
tra le proprie fila lo stesso Reverend beat-man che è<br />
anche padrone di casa Voodoo, ovviamente produttrice<br />
dell’album.<br />
76 77
Questo ...Pop up yours! ha una doppia faccia: da una<br />
parte c’è un’atmosfera vintage stile Damaged goods,<br />
con roba che pare uscita da un incrocio tra Wild Billy<br />
Childish e Graham day & the Galoers (I want you, Cry,<br />
More you talk less i hear you).<br />
Dall’altra c’è l’approccio primitivo e raw oramai marchio<br />
di fabbrica dell’etichetta: Beat-man è uno screamer<br />
di prim’ordine (si direbbe più a suo agio in questa<br />
veste punk che nel blues della carriera solista), i testi<br />
contano un paio di righe se va bene (in Blow um mau<br />
mau neanche quelle), e il risultato sono delle fucilate<br />
garage trash da brividi: Watcha gonna do, In and out,<br />
Ain’t crawling back to you no more, Drifting away. E se<br />
qualcuno si annoia? Ecco un paio di pause, la ballata<br />
western di Ce soire e il rock blues di Blues for Joe. Fatto.<br />
Quattordici tracce per una trentina di minuti sudatissimi<br />
che lasciano il segno.<br />
(7.1/10)<br />
Stefano Gaz<br />
niColò CarneSi - ho PoCa fantaSia<br />
(Malintenti DiSChi, ottoBre 2011)<br />
Genere: cantautorato wave<br />
E poi succede che certi dischi ti catturano dal nulla.<br />
Come quando sei intento in altre faccende e le tue<br />
energie si raccolgono tutte intorno all’orecchio, conturbante<br />
organo estetico. Ti fai prendere da melodie,<br />
che sembrano alchimie automatiche o processi di vivificazione<br />
naturale o anche semplicemente da alcune<br />
parole incastonate in una lirica. Succede che certi suoni<br />
che non ti aspetti entrano in un disco di un cantautore<br />
siciliano, che di nome fa Nicolò Carnesi. L’ultimo di una<br />
serie di Ep s’intitola Ho poca fantasia e sparge le giuste<br />
aspettative sul primo vero album.<br />
Chi poteva scommettere di sentirsi a metà strada fra<br />
Brooklyn e Catania, fra i Drums e Battiato, ascoltando<br />
questo disco? Intelaiare un così ampio spettro di suoni è<br />
un’operazione degna dei più maturi cantautori. Carnesi<br />
si fa scherno delle incomprensioni di questo mondo,<br />
punta il fucile prima contro se stesso, poi contro i piani<br />
inclinati dei nostri giorni. Come dire, bisogna affondare<br />
su questa terra prima di poterla comprendere e criticare.<br />
“Pietrificare le cose” è come temere l’inevitabile dissoluzione<br />
del tempo, fuggendo dal “sistema” (“solare, balneare,<br />
sociale, creativo, reattivo, normale”, ecc ). E quando<br />
si parla d’amore, tutto un po’ stride, come i denti che<br />
digrignano, come “l’uomo dei sogni che arriva da Marte”.<br />
Un cinismo caldo, si potrebbe quasi dire, che sfiora<br />
l’umorismo di Dente per raggiungere le atmosfere del<br />
conterraneo Colapesce.<br />
“Tutti poeti, tutti scrittori, tutti profeti e tutti bohemien”:<br />
sintesi migliore di questa non c’è, in attesa che un long<br />
playing confermi le ottime premesse.<br />
(7.2/10)<br />
nino CiGlio<br />
noel GallaGher - noel GallaGher’S hiGh<br />
flYinG BirDS (Sour MaSh reCorDS, ottoBre<br />
2011)<br />
Genere: pop, rock<br />
Non guardateci storto, ma sarà per averli visti insieme<br />
già ai tempi d’oro degli Oasis, sarà per le pur azzeccate<br />
incursioni di Noel nei dischi del Modfather, sarà anche<br />
solo per capelli, basette e sopracciglia ecco, per il<br />
Gallagher maggiore abbiamo sempre immaginato una<br />
carriera solista alla Paul Weller. Ovvero: dischi eclettici<br />
quanto basta (niente di rivoluzionario, invero), amabilmente<br />
citazionisti, ben prodotti e (molto) ben suonati,<br />
magari non stellari nella scrittura ma sempre in grado di<br />
offrire quel paio di chicche che non sfigurano per nulla<br />
nell’illustre canzoniere. E, sì, High Flying Birds potrebbe<br />
appartenere a pieno diritto alla categoria, pur calcolando<br />
l’inevitabile distanza, artistica e non, tra i due soggetti.<br />
Volendo, passati ritualmente in rassegna i brani,<br />
potremmo anche chiudere qui; non fosse che la carriera<br />
solista del fratellone arriva dopo l’ovviamente turbolento<br />
split e, soprattutto, dopo lo sfrontatissimo condensato<br />
di liamitudine che è il disco dei Beady Eye. Non<br />
è il gossip che ci interessa (chi tra voi maliziosetti non<br />
ha pensato che la zuffa sia tutta una bella sceneggiata<br />
per rendere ancor più evento il ventennale di Morning<br />
Glory?), è solo che in tale prospettiva queste canzoni<br />
assumono, di fatto, altro valore.<br />
Noel sembra davvero voler dimostrare qualcosa: non<br />
è il semplice divertissement tanto per fare un giro da<br />
soli e vedere l’effetto che fa. Prendete gli arrangiamenti:<br />
orchestre e cori a conferire sacrali solennità stonesiane<br />
(Record Machine), fiati dixieland a guarnire inevitabili<br />
marcette Kinks (The Death Of You And Me, che alle<br />
nostre italiche orecchie suona come un mashup tra<br />
The Importance Of Being Idle e la ben più gloriosa Je<br />
so pazz’), tocchi di psichedelia al punto giusto (senza<br />
scimmiottare la coda di Strawberry Fields! Incredibile!)<br />
e così via. Come dire, dove là - da Liam e gregari - c’è<br />
pura spacconaggine laddish, qua c’è sana ambizione.<br />
Sana? Davvero? Sì, perché anche quando si cita (ancora<br />
i fratelli Davies - con tanto di village green - di Soldier<br />
Boys And Jesus Freaks, o lo stomp glam alla Gary Glitter<br />
via Nightclubbing di The Wrong Beach) o si autocita (AKA<br />
Broken Arrow, If I Had A Gun, le nipotine di Wonderwall),<br />
lo si fa con gusto. E detto a proposito di uno che senza<br />
alcun pudore ha costruito una delle sue canzoni più<br />
highlight<br />
the war on DruGS - Slave aMBient (SeCretlY CanaDian, ottoBre 2011)<br />
Genere: krautamericana<br />
Un vecchio adagio talmente connaturato alla storia della cultura e delle sue manifestazioni da sembrarci<br />
che sia sempre stato con noi dice che non vi è mai davvero nulla di nuovo sotto il sole: ogni narrazione<br />
sarebbe sempre e comunque un remix dell’Odissea o dell’Iliade. E nella musica rock degli ultimi anni,<br />
quest’impressione può apparire confermata dal fatto che ciò che davvero nuovo si può produrre in una<br />
tradizione come quella che va dal folk di Dylan all’epica USA di Springsteen e al classic rock di Tom<br />
Petty è praticamente nulla o quasi. Allora ben vengano nuove commistioni, come questa Americana dei<br />
War On Drugs che incontra il krautrock, le chitarre suonate nelle praterie che si specchiano nelle algide<br />
movenze di sintetizzatori e ritmiche morotik.<br />
A raccontarla così potrebbe sembrare la più grande cazzata del secolo, invece<br />
Slave Ambient funziona alla meraviglia e le sfumature dilatate dell’ipnotico<br />
incedere ritmico e dai discreti tapperi elettronici non fanno che aumentare<br />
pathos all’epos. Già nell’esordio del 2008, Wagonwheel Blues rumori chitarristici<br />
di stampo shoegaziano (che qui tornano in un prano docilmente psichedelico<br />
come City Reprise) avevano aiutato Adam Granduciel e Kurt Vile (uscito<br />
definitivamente già da qualche tempo e dedito alla ben nota carriera solista)<br />
a produrre un suono personale. Ora schegge di Neu! e LA Dusseldorf determinano<br />
alcuni degli episodi migliori dell’album: Come to the City, una Baby Missiles ripresa dal bell’EP<br />
del 2010 (Future Weather, con un titolo emblematico) che gioca (riuscendoci) al gioco degli Arcade Fire,<br />
Best Night e la splendida cavalcata di Your Love Is Calling My Name.<br />
I War On Drugs riescono nel congiungere gli spazi sconfinati e le atmosfere psichedeliche da viaggio<br />
evocate dalla miglior road music americana con altri spazi, forse solo erroneamente pensati lontani,<br />
come quelli di certa musica europea. Qui gli spazi dell’anima e gli spazi della mente coincidono per<br />
quarantesette minuti.<br />
(7.3/10)<br />
MarCo BoSColo<br />
celebri sulle battute iniziali di Imagine, non è poco. Ma<br />
soprattutto con Dream On, Everybody’s On The Run, AKA<br />
What A Life e la splendida Stop The Clocks arrivano le<br />
canzoni.<br />
Sì! Canzoni che sembrano avere finalmente un senso<br />
(per chi ascolta, e per Noel stesso), non buttate giù per<br />
caso per sbatterti in faccia di essere la band più fica del<br />
pianeta, e fanculo tutti gli altri. In attesa del secondo<br />
round previsto per l’anno prossimo (una collaborazione<br />
con gli Amorphous Androgynous, annunciata come<br />
“psichedelica alla Dark Side Of The Moon”), resta l’impressione<br />
di una qualità nettamente superiore rispetto ai<br />
recenti Oasis (o a simpatiche cover band con lo stesso<br />
cantante). Come dire, la reunion del 2015 può anche<br />
aspettare. Ben fatto, Pau... ehm, Noel.<br />
(7/10)<br />
antonio PuGlia<br />
okaPi/alDo kaPi orCheStra - oPera<br />
riParata (offSet, aGoSto 2011)<br />
Genere: plaGiarismo classico<br />
Ritorno in grande stile per Okapi. Il manipolatore italiano<br />
riprende un datato esperimento di Bruno Munari<br />
in collaborazione con Davide Mosconi e lo ripropone<br />
attualizzandolo alla luce della propria sensibilità plunderphonica<br />
e ricombinatoria.<br />
Opera Riparata rimanda strutturalmente - per forme e<br />
contenuti - all’Opera Rotta presentata nel 1989 alla Scala<br />
dagli sperimentatori citati in apertura: il procedimento<br />
attuato da Okapi in combutta con l’artista visuale e spirito<br />
affine Infidel (sue le video-realizzazioni che hanno<br />
accompagnato la prima dell’opera commissionata da<br />
Galaxia Medicea) prevede la (de)composizione di 40<br />
celebri opere liriche - da Mozart a Wagner, da Puccini a<br />
Godunov ci sono praticamente tutti - in altrettanti boz-<br />
78 79
highlight<br />
toM waitS - BaD aS Me (anti-, ottoBre 2011)<br />
Genere: rock blues<br />
Al milionesimo album - ok, è solo il ventesimo - e a sette dall’ultimo di inediti Real Gone, ci si potrebbero<br />
aspettare sintomi di incipiente senilità dal nuovo album del sessantunenne Tom Waits. Ed è proprio così.<br />
Ma il suo - chevvelodicoafare - è un invecchiare nutritivo. L’uomo, l’artista, si è messo fuori da certi processi<br />
di logoramento sinaptico. E’ intangibile e assieme potente allegoria di se stesso. E’ una macchietta<br />
maligna, uno spauracchio struggente, l’orco appassionato, lo spaventapasseri malvagio, uno sgorbio<br />
portentoso. Posseduto dalla sua musica, la possiede concedendosi senza lasciare indietro nessuna ferita,<br />
nessun bacio dato o perduto. Nella voce alberga tutto intero il corpo logoro e l’anima rugginosa ma viva,<br />
morbidamente disperatamente viva.<br />
Imprendibile, scentrato, outsider totale, ormai fa il verso a se stesso permettendosi<br />
il lusso d’incarnare a piacimento porzioni del proprio campionario,<br />
ad esempio - è il caso di questo Bad As Me - un eccitante (già, e il viagra non<br />
c’entra una mazza) dualismo tra il satiro blues ebbro ed il mariachi languido,<br />
tra impeto ispido, ruspante, grottesco e uno sdilinquirsi con saggia indifesa<br />
generosa vulnerabilità. Tra il male e il bene che riempie il pieno e il vuoto del<br />
nostro stare al mondo, lui ci mette queste canzoni. E il suono, scavato nella<br />
pancia degli stereotipi del genere così a fondo da scovare le radici dell’archetipo,<br />
così velenosamente artefatto, saturo di segni caratterizzanti - lo aiutano il sodale Marc Ribot, il<br />
tastierista decano Augie Meyers ed il filibustiere Keith Richards - da strappare la pelle alla messa in<br />
scena ed esplodere iperreale come un coltello che ti accarezza la pancia.<br />
Sedici pezzi, tutti godibili, qualcuno straordinario come una Face To The Highway desertica e sepolcrale,<br />
senso di atavica modernità nella tessitura liquida di chitarre e vibrafono, quel sax straniante, rantolo Nick<br />
Cave al crocicchio dei Morphine. Ed il gracidio madido di Raised Right Man, iperboli acide Screaming<br />
Jay Hawkins in un bozzolo anfetaminico Jon Spencer. E la rumba blues indemoniata di Let’s Get Lost. E<br />
il battimani demoniaco lungo il funky-psych cavernoso di Hell Broke Luce. E una Satisfied con quell’aria<br />
da John Lee Hooker strattonato da Belzebù che omaggia - chiamandoli in causa - gli Stones più efferati.<br />
Poi, d’altro canto, le tenere nostalgie fifties springsteeniane di Tell Me. Il valzer di Pay Me, fisarmonicaviolino-banjo<br />
e uno sbuffo di tromba, una di quelle cose splendide che gli vengono con la mano sinistra.<br />
E poi l’eleganza jazzy pigra, fumosa, inquieta di Kiss Me Like A Stranger (che t’immagini benissimo sulle<br />
labbra di Billie Holiday) ed Everybody’s Talking (malanimo e struggimento brass band con ectoplasmi<br />
Mingus ad aleggiare, il semifalsetto una soffice spina tra cuore ed anima). E ancora la semplice, smisurata,<br />
indolenzita tenerezza tex-mex di Put Me Back In The Crowd, e una Last Leaf da Ry Cooder sgualcito sulla<br />
strada in fondo al cono di luce (Richards al controcanto), roba che ti fa uscire le lacrime anche dal culo.<br />
Proprio così, ne è ancora capace dopo tutti questi anni, dopo tutti questi grugniti e suppliche e ardori<br />
e spasmi e tormenti sparsi nelle canzoni. Non esistono attendibili termini di paragone. Quest’uomo è<br />
fuori misura.<br />
(7.7/10)<br />
Stefano Solventi<br />
zetti re- o de-mixati in microsuites tutte della durata<br />
di 1 minuto e 11 secondi. Come nell’originale esperimento<br />
di Munari e Mosconi l’esecuzione era affidata<br />
all’interpretazione e ricomposizione casuale, cut’n’paste,<br />
rimanipolazione, ricontestualizzazione agiscono<br />
allo stesso livello in ognuno dei 40 frammenti disposti<br />
lungo i quattro atti (Preludes, Duels, Dances e Storms,<br />
rispettivamente) del disco del romano.<br />
Un lavoro che agisce allo stesso livello teorico del progetto<br />
originario - la riflessione, in netto anticipo sui tem-<br />
pi, sulle possibilità di fruizione “orizzontale” di tutta la<br />
storia della musica in un unico, eterno presente - ma lo<br />
“modernizza” attualizzandolo alla tecnologia d’oggi e<br />
facendo acquistare visionarietà e nuove traiettorie alle<br />
felici intuizioni munariane.<br />
Con l’atteggiamento ludico/serioso che lo caratterizza,<br />
Okapi rende ancor più caleidoscopico e vorticoso il tutto<br />
con lo straniamento ottenuto dall’interazione delle<br />
composizioni classiche con le textures elettroniche, le<br />
slogature ritmiche e gli umorali sbalzi della propria irriverente<br />
sensibilità plagiar-collagista. Della serie, provate<br />
a immaginare un connubio tanto alieno quanto<br />
intrigante tra le arie aperte del Preludio della Norma di<br />
Bellini e il sottofondo pulsante glitch’n’cuts tutto spilli<br />
e sibili o tra il Preludio all’Atto I del Manon Lescaut di<br />
Puccini e la techno spinta e claudicante che lo tappezza.<br />
Non c’è mash-up o bastard-pop che tenga. Qui si è su<br />
un altro pianeta, dove le coordinate spazio-temporali<br />
si infrangono.<br />
(7.5/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
Ólöf arnalDS - Ólöf SinGS (one little<br />
inDian, noveMBre 2011)<br />
Genere: folk<br />
Due album in repertorio per Ólöf Arnalds, cantantessa<br />
islandesa classe ‘80, baciata da improvvisa notorietà internazionale<br />
lo scorso febbraio causa la partecipazione<br />
di Björk al singolo Surrender. Morbidezze bucoliche e<br />
lirismo scostante su cui germogliano mutazioni folktroniche,<br />
un po’ come tante cose sonore piovute negli ultimi<br />
anni dal calderone nordico. Oculatamente, One Little<br />
indian ci tiene a tenere in caldo il nome della ragazza,<br />
perciò licenzia questo EP contenente cinque cover - anzi<br />
sei - che dovrebbero tracciare la mappa dei suoi referenti<br />
musicali/sentimentali.<br />
Interpretate nella purezza fragrante e inerme di chitarra<br />
acustica e voce, canzoni come She Belongs To Me (Bob<br />
Dylan) e Close My Eyes (Arthur Russell) sbrigliano tutto<br />
il frusto, elegante languore basale, mentre la celebre<br />
Solitary Man di Neil Diamond e l’incalzante Maria<br />
Bethânia di Caetano Veloso sono affrontate col turgore<br />
del caso. Piccola licenza poetica, un medley/mash-up<br />
tra With Tomorrow di Gene Clark e I’m On Fire di Bruce<br />
Springsteen, ciliegina su questa torta minimale, veri e<br />
propri esercizi obbligatori che la Arnalds supera in souplesse.<br />
Segniamola sul taccuino e attendiamo sviluppi.<br />
(6.6/10)<br />
Stefano Solventi<br />
oneohtrix Point never - rePliCa<br />
(Software, noveMBre 2011)<br />
Genere: hypna-hauntoloGy<br />
Sembra quasi volersi mettere a nudo, Daniel Lopatin aka<br />
Oneohtrix Point Never in questo nuovo album, almeno<br />
a giudicare da titolo e copertina. Se nel primo evidenzia<br />
tra il serioso e l’autoironico il procedere duplicativo e<br />
non originale delle sue musiche, nella seconda, giocando<br />
di rimandi addirittura con Escher, si mostra scheletrizzato<br />
e riflesso in uno specchio. Della serie, più a nudo<br />
di così non si può.<br />
All’ascolto delle 10 tracce di Replica, però, titolo e copertina<br />
assumono connotati nuovi. Sembra infatti che<br />
Lopatin abbia ancor di più accentuato il metodo “compilatorio”<br />
alla base delle sue composizioni e si sia scarnificato<br />
per potersi riassemblare addosso pelli nuove. C’è<br />
sempre quell’evidente procedimento di ricostituzione<br />
del passato, proprio e collettivo, ma stavolta non ci si<br />
limita a rielaborare le ormai ben note atmosfere hypna,<br />
quanto a recuperare gli stessi materiali di risulta, di scarto<br />
di produzione di un passato “mediatico” con una modalità<br />
quasi da revenant o da galvanismo. Replica si delinea<br />
così, più dei suoi predecessori, come un patchwork<br />
di umori contrastanti finalizzato ad una riconfigurazione<br />
di suoni perduti nell’etere, nell’ambiente, nella memoria<br />
impalpabile di ogni kid cresciuto negli ultimi 30 anni.<br />
Il piano ossessionato e le aperture atmosferiche e cinematografiche<br />
di Power Of Persuasion, la nostalgica scia<br />
di synth e voci trovate che segna trasversalmente Remember,<br />
la decadente malinconia per piano di Replica<br />
increspata di rumori ambientali e energia statica (un Satie<br />
post-kosmische?), il collage glitch-hop che disturba<br />
la pastorale ambient di Nassau, il melting-pot collagista<br />
di Sleep Dealer, fagocitano n input ricollocandoli in ambientazioni<br />
aliene alle fonti originarie. Il risultato crea<br />
spesso uno straniamento encomiabile, specie nell’uso<br />
di voci pescate e nel reindirizzamento di tracce e segni<br />
sonori “altri” (il plagiarismo di fonti vocali riassemblate<br />
in Child Soldier ne è esempio), avvicinando Replica più a<br />
certe istanze da hauntology che da hypna-stuff. A questo<br />
punto siamo curiosi di vedere gli sviluppi futuri di<br />
mr. Lopatin.<br />
(7/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
orCheStra of SPhereS - nonaGoniC now<br />
(fire reCorDS, noveMBre 2011)<br />
Genere: tribal-maDness<br />
Ogni tanto ne spunta fuori qualcuno nell’universo<br />
weird. E il bello è che ogni volta bisogna spostare più<br />
in là i labili confini della stramberia in musica. Questi Or-<br />
80 81
chestra Of Spheres sono neozelandesi e sono la punta di<br />
diamante di una sotterranea scena in quel di Wellington<br />
- provincia che più provincia non si può - facente capo<br />
alla Frederick Street Sound and Light Exploration Society.<br />
Di questa sorta di comune di spostati fuori di testa in<br />
fissa con improbabili vestiti dai colori sgargianti, musiche<br />
totalmente free (tutto o quasi nasce da infinite jam<br />
collettive) e attitudine demistificatoria e ricombinatoria<br />
(anche per quel che riguarda i 4 membri del progetto),<br />
gli Orchestra Of Spheres sono quelli col tiro più a fuoco<br />
e il giusto appeal.<br />
Caribou, non a caso, li ha fortemente voluti all’ATP di<br />
quest’anno dopo averli visti dal vivo e questo primo<br />
lascito ufficiale overseas - in realtà reissue di un lavoro<br />
autoprodotto edito tramite la comune di cui sopra - rende<br />
pienamente giustizia a una reputazione di selvaggi<br />
animali da palco o da house party costruitasi nel tempo.<br />
Nonagonic Now, ascoltabile sul loro bandcamp, porta<br />
in dote 45 minuti di groove alieno, poliritmie africane,<br />
voodoo marcio, funk bianco deformato e dall’attitudine<br />
spacey, elettroniche d’accatto, percussività incessante<br />
ed eclettica, gamelan indonesiani, tradizionali del Borneo<br />
e tutto ciò che vi può venire in mente - frullato insieme<br />
- dai 23 Skidoo ai Rapture lo ritroverete miscelato<br />
in varie dosi nei 10 pezzi dell’album, con in più una capacità<br />
teatrale non indifferente. Dopotutto da quattro<br />
schizzati che si chiamano Mos Iocoss, Baba Rossa, Jemi<br />
Hemi Mandala e E = MC303 e che suonano, tra le altre<br />
cose, theremin, gamelan, biscuit tin guitar, electric bass<br />
carillion, sexmouse marimba (?!), il minimo che ci si può<br />
aspettare è un sabba di “ancient future funk” gioioso,<br />
giocoso, nonsense e spastico. Terribilmente accattivante,<br />
mosso com’è alla ricerca della “spontaneous symmetry<br />
in sound”.<br />
(7.3/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
orfanaDo - iter (SounD of CoBra, ottoBre<br />
2011)<br />
Genere: psicheDelia acustica<br />
Quando il noiser torna alle origini la sorpresa è dietro<br />
l’angolo. Orfanando è l’ennesima perla off uscita fuori<br />
da quella fucina di campioncini delle musiche estreme<br />
cresciuti in Italia negli ultimi anni e usi a trafficare con<br />
volumi e distorsioni, noise e cospirazionismo arty. Alessandro<br />
De Zan (In Zaire, G.I. Joe) e Riccardo Mazza (Lettera<br />
22, A Flower Kollapsed, Lago Morto) lasciano da<br />
parte urla e spie al rosso e se ne escono con un progetto<br />
di folk psichedelico ancestrale, a tratti acustico, dagli<br />
effluvi mediorientali, in punta di corda e con la testa che<br />
svolazza via versi lidi alieni. Roba da frikkettoni total-<br />
mente persi nel proprio viaggio (vedi alla voce Avorio).<br />
Fahey e Jack Rose, una certa attenzione per le musiche<br />
tradizionali (il semi-fado incalzante e pagano di Iter),<br />
certi momenti del Gary Higgins più capellone o del Daniel<br />
Higgs meno paranoicamente esoterico (Mantra),<br />
un respiro mistico nato da intrecci di corde e qualche<br />
sparsa percussione: tutto rimanda ad un mondo pacificato,<br />
alle vibrazioni positive, all’happening introverso<br />
e drogadicto ottenuto con strumentazione semplice e<br />
minimale (chitarre acustiche, sitar, percussioni e strumenti<br />
a vento) e atteggiamento free. Di tanto in tanto i<br />
due non dimenticano la tempra di un tempo e lasciano<br />
emergere o vivere sottotraccia un qualcosa di oscuro<br />
e minaccioso: sia un tappeto di inserti elettronici cupi<br />
e droning (i misterici vocalizzi e le distese di suoni a<br />
tappeto di Giordania), una generale atmosfera (l’incipit<br />
di Pianti può far tornare in mente certe ossessioni<br />
neurosisiane in acustico calate in un brodo orientale)<br />
o l’ancestrale suono della foresta tropicale di Aria (Zac<br />
Nelson cresciuto alla scuola del folk atavico).<br />
Produce la italo-berlinese Sound Of Cobra del sodale<br />
Ricky Thunder, definitivamente apertasi a sonorità “altre”<br />
(in arrivo Embryo e Burial Hex), mentre il vinile è per<br />
Holidays. Stay acoustic, noisers.<br />
(7/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
Peter GaBriel - new BlooD (eMi, ottoBre<br />
2011)<br />
Genere: pop<br />
In perfetta continuità con l’ultimo album, quello Scratch<br />
My Back dello scorso anno, in cui l’artista inglese si<br />
confrontava con dodici pezzi altrui e li trasfigurava per<br />
voce e orchestra, Peter Gabriel sottopone altrettanti<br />
pezzi della sua produzione solista allo stesso trattamento.<br />
L’appetito gli è venuto mangiando, lavorando<br />
con un’orchestra che (parole sue) “è come praticare uno<br />
sport con qualcuno migliore di te”, si è domandato come<br />
si sarebbero trasformati i suoi brani, magari non quelli<br />
più famosi, ma quelli per i quali il trattamento era più<br />
indicato o, più semplicemente, quelli che oggi l’ex Genesis<br />
ha voglia di cantare e portare nuovamente in tour<br />
dal vivo.<br />
Non ci aspettavamo certo sussulti e novità da un musicista<br />
che ha attraversato oramai quarant’anni di pop internazionale,<br />
ma questo lavoro di arrangiamento, di cesello<br />
su canzoni già di per sè efficaci (Intruder, Diggind In The<br />
Dirt), non ha fatto altro che mostrare le abilità di Gabriel<br />
di giocare con i suoni. Rendere Rhythm of the Heat senza<br />
percussioni e chitarre poteva sembrare un azzardo,<br />
ma la realtà è che scarnificato e sbiancato acquista una<br />
nuova vita. L’operazione era già riuscita egregiamente<br />
sul disco precedente con The Boy In The Bubble di Paul<br />
Simon, e qui conferma la sua efficacia. Oppure il duetto<br />
con la norvegese Ane Brun, con una voce dalle parti di<br />
Kate Bush, per la magia di Don’t Give Up.<br />
Esagera David Crosby quando dice che Gabriel si è spinto<br />
in un territorio inesplorato della musica, che non è<br />
classica e non è pop: in fondo si tratta pur sempre di<br />
cover di se stesso, qualcosa di molto simile all’onanismo.<br />
Sicuramente, però, questo nuovo sangue sta facendo divertire<br />
Gabriel, che canta con entusiasmo (e precisione),<br />
e l’appositamente formata New Blood Orchestra. Settanta<br />
minuti di eleganza e mestiere.<br />
(7/10)<br />
MarCo BoSColo<br />
Peter haMMill - Pno, Gtr, vox (fie!,<br />
ottoBre 2011)<br />
Genere: art proG<br />
La voce di Peter Hammill è un genere a parte, tanto è<br />
capace di caratterizzare e determinare la rotta di una<br />
canzone. E non parliamo certo di canzonette. Nulla di<br />
strano quindi che oggi l’ultrasessantenne londinese<br />
dedichi alla propria ars canora un vero e proprio monumento<br />
in guisa di doppio album live. Lo fa presentandola<br />
in flagranza di reato, due tipi di nudità diversa, una<br />
voce-piano (il primo volume, intitolato What if I forgot<br />
my guitar?) e l’altra voce-chitarra (il secondo dischetto,<br />
What if there were no piano?).<br />
Ventisette le tracce complessive, incise durante i tour<br />
del 2010, suonate con l’espressività brusca del caso<br />
(Hammill non è certo uno strumentista virtuoso) e cantate<br />
senza rete, stecche e mezze stecche incluse. Non c’è<br />
molto da aggiungere se non che la parte chitarristica si<br />
fa apprezzare di più, in particolare con l’intenso romanticismo<br />
di Amnesiac, Central Hotel e I Will Find You. Vale<br />
invece la pena rilevare come gli ottantotto tasti pongano<br />
in evidenza il sottofondo cabarettistico, la nevrastenia<br />
teatrale a fondamento delle impalcature epiche e<br />
visionarie del Nostro.<br />
In ogni caso, si tratta di una testimonianza impressionante<br />
circa la vitalità del frontman dei Van Der Graaf<br />
Generator, che non mancherà di gratificare gli inveterati<br />
fan. Tutti gli altri potranno semplicemente prenderne<br />
atto o lasciare perdere.<br />
(6/10)<br />
Stefano Solventi<br />
Peter kernel - white Death BlaCk heart<br />
(afriCantaPe, ottoBre 2011)<br />
Genere: inDie-noise-rock<br />
C’avevano incuriosito con il singolo apripista Anthem Of<br />
Hearts e, prima ancora, con quell’esperimento strambo<br />
che era il 12” Il Pomeriggio Non Si Sa Mai Bene Cosa<br />
Fare avevano dimostrato di non essere una band a dir<br />
poco eclettica e incapace di accontentarsi.<br />
Ora i tre svizzero-canadesi in formazione mista tornano<br />
con un album lungo per AfricanTape inaugurato proprio<br />
da quel singoletto che in 3 minuti scarsi circoscrive il<br />
giardino dei desideri e indica il senso dell’intero album:<br />
un 12 tracce in grado di riesumare l’indie rock meno<br />
ortodosso dei mid-90s, capace di mischiare melodia e<br />
dissonanza, rumore e forma-canzone, energia e cesello.<br />
La Gioventù sonica di Experimental Jet-Set e Blonde Redhead<br />
sono, insieme al versante più wavey dell’indie<br />
(un nome su tutti, Deerhoof), più di una ispirazione soprattutto<br />
quando a tirare le fila di un suono irto e ispido<br />
è la voce della bassista Barbara Lehnhoff, esattamente al<br />
guado tra una ventenne Kim Gordon e una Kazu Makino<br />
mitteleuropea. Vedi alla voce Hello My Friend o I’ll Die<br />
Rich At Your Funeral - grandi intrecci vocali e interplay<br />
tra ritmiche tribali e chitarre in overdrive - per averne<br />
conferma.<br />
Messa così, però, sembrerebbe che i tre - i maschietti<br />
Aris Bassetti alla chitarra e Ema Matis alla batteria completano<br />
la formazione - siano fossilizzati ad un preciso<br />
ambito e ad un preciso periodo temporale, come una<br />
adolescenza che non vuole mai passare. Ma le svisate<br />
anthemiche da disco-punk/wave-spastica di Panico! This<br />
Is Love, la nenia post-punk al metadone di The Captain’s<br />
Drunk e l’indie-panzerkorp di Make, Love, Choose, Take<br />
dicono di una formazione capace di metabolizzare il<br />
passato e guardare al futuro. In poche parole, uno dei<br />
migliori dischi “indie” ascoltati quest’anno, senza che il<br />
virgolettato suoni come una parolaccia.<br />
(7/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
PrinCe raMa - truSt now (Paw traCkS,<br />
ottoBre 2011)<br />
Genere: now-aGe<br />
Avevamo accolto con piacere l’opera prima per Paw<br />
Tracks (e quarta in totale) Shadow Temple. Rimaniamo<br />
un po’ basiti da questo comeback che vede la formazione<br />
newyorchese ridotta a duo con la fuoriuscita del<br />
maschietto Michael Collins. Prince Rama, come da copertina,<br />
è ora appannaggio esclusivo delle due sorelle<br />
Larson, Taraka (voce, basso, chitarra, tastiere, synth) e<br />
Nimai (voce, batteria) e la differenza si sente eccome.<br />
82 83
Se infatti ci si chiedeva quanto credessero a ciò che stavano<br />
mettendo in mostra con Shadow Temple, gustoso<br />
melt di psych, freakeria raga/free-folk e now-age, Trust<br />
Now toglie ogni dubbio: queste non ci fanno, ci sono<br />
proprio. Che in musica equivale a spingere sull’acceleratore<br />
della freakness, sfiorare lande semi-new age e<br />
world alla Natacha Atlas (l’opener Rest In Peace), svicolare<br />
verso immancabili intrusioni hypna, retrocedere verso<br />
arie (quasi)classiche (Golden Silence) lasciando però un<br />
gusto amarognolo in bocca. Come se ci si ritrovasse ad<br />
ascoltare uno di quei dischi che gli “arancioni” vendono<br />
ai mercatini, ma decisamente fuori tempo massimo.<br />
Le atmosfere misticheggianti e lo scampanellare estatico<br />
(Summer Of Love), le ossessioni vocali reiterate (Trust,<br />
Portaling) sempre venate da elettronica povera, l’immaginario<br />
spirituale da “terzo occhio” (Incarnation) puntano<br />
alla deturpata sensibilità “ritual-pop” storta e weird<br />
tipica della casa madre Paw Tracks. Il problema è che<br />
purtroppo non riescono appieno, come succede in altri<br />
esempi del catalogo della label americana. Diciamo il<br />
disco ideale per la ricerca della pace interiore o una palla<br />
tremenda. Dipende dai punti di vista e dalle droghe<br />
usate. Sufficienza di stima.<br />
(6/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
PuMaJaw - DeMonMeowMeow (BeDevil,<br />
noveMBre 2011)<br />
Genere: wave folk<br />
Due anni (abbondanti) dopo il buon Curiosity Box, torna<br />
la strana coppia John Wills e Pinkie Maclure, il primo<br />
già fautore dei suoni nei Loop e la seconda chanteuse<br />
post-moderna dal piglio fascinoso e misteriosamente<br />
bizzarro. Giunti al terzo titolo sotto l’egida Pumajaw - e<br />
che titolo: Demonmeowmeow - decidono di svoltare<br />
smarcandosi da quella specie di folk mutante per imbarcare<br />
ibride suggestioni trip-hop e wave. Immaginatevi<br />
una miscela instabile di tremori Portishead e lirismo<br />
sintetico Yazoo, guarnita con un pizzico di solennità<br />
ombrosa Nico ed una spolverata d’estro acidulo weird.<br />
Soprattutto, immaginatevi che funzioni: proprio così,<br />
ogni traccia un teatrino squinternato ma dotato di consistenza<br />
progettuale, ovvero mirato ad una dimensione<br />
noir irrealistica ma in qualche modo plausibile.<br />
Tra i momenti migliori segnalerei una Mask che spalma<br />
inquietudini morriconiane su esoterico pattern digitale,<br />
la curiosa Chinny Chin Chin che guizza truce e beffardella<br />
(tipo Marianne Faithfull ammaliata Beth Gibbons), una<br />
Tallulah che incede cinematica tra turbolenze eniane (un<br />
po’ come potrebbe la cuginastra scellerata di Goldfrapp)<br />
e la opener The Mazy Laws dall’estro cavernoso che ti fa<br />
ipotizzare i Lamb in fregola dEUS. Mancano all’appello<br />
dei veri colpi di genio, ma in questi tempi di revivalismo<br />
pervadente e spesso coatto, riuscire a fare storia a sé è<br />
già un risultato considerevole.<br />
(6.8/10)<br />
Stefano Solventi<br />
raoul Sinier - GuiltY CloakS (aD noiSeaM,<br />
luGlio 2011)<br />
Genere: elettronica<br />
Raoul Sinier è un musicista che conosce alla perfezione<br />
i ferri del mestiere. Come un regista hollywoodiano da<br />
film di cassetta, usa le tecniche giuste e ottiene il risultato<br />
desiderato. Basterebbe la copertina per scovare i<br />
cliché del genere introspettivo: una sedia vuota in un<br />
luogo buio, un uomo seduto dall’aria afflitta dietro a una<br />
maschera. L’elettronica d’atmosfera cupa e fredda dell’album<br />
non fa che ribadire il concetto: l’apertura Overture 5<br />
è talmente stereotipata da arie orrorifiche e inquietanti<br />
da uscire direttamente dalla colonna sonora di un B-movie<br />
degli anni 80, così Too Late di quel periodo ripesca le<br />
melodie a 8 bit e certe sonorità synth-dark in maniera<br />
pedissequa e Summer Days. Per la serie, sotto il vestito...<br />
(5.5/10)<br />
franCeSCo aSti<br />
raS G - Down 2 earth (raMP, luGlio 2011)<br />
Genere: beats<br />
Gregory Shorter Jr. aka Ras G, dj, produttore, co-fondatore<br />
della label undeground Poo-Bah, è il più antitecnologico<br />
della cerchia dei brainfeederiani, ‘’working<br />
thru obsolete tools to reach back in time and pluck out the<br />
essence of groove’’. Abbiamo già avuto modo di apprezzarne<br />
la capacità di sintesi e l’approccio ruvido, istintivo,<br />
pesantemente psichedelico nel documentario Secondhand<br />
Sureshots della Dublab. Questa, tra cd-r, mp3 e<br />
cassettine, è la sua quinta prova lunga.<br />
Ras conferma tutto, ma senza guizzi particolari, con una<br />
raccolta di ben 21 scure schegge psichedeliche che alternano<br />
ritagli, strumentali compiuti e strumentali ‘’in<br />
attesa del rappato di qualcuno’’. Esplicita la filiazione rapblues<br />
(il profetico, millenaristico, ossessivo mantra Who<br />
will survive in America di Gil Scott-Heron) e funk (James<br />
Brown), per un buon lavoro senza cedimenti ma anche<br />
senza picchi.<br />
(6.5/10)<br />
GaBriele Marino<br />
retox - uGlY aniMalS (iPeCaC reCorDinGS,<br />
noveMBre 2011)<br />
Genere: screamo<br />
Decentrata ma non troppo, nel recente passato San Diego<br />
ha saputo offrire una “scena” assai stimolante non<br />
solo per quei Three Mile Pilot di recente tornati sulle<br />
scene, per l’errebì intinto nel garage-punk dei disciolti<br />
Rocket From The Crypt e per le contorsioni tra indie e<br />
math dei leggendari Drive Like Jehu. Approfittando del<br />
contesto geografico, l’incestuosità ha colà permesso lo<br />
sviluppo di un sottobosco composito all’insegna della<br />
bruciante creatività, che dallo straight edge degli Unbroken<br />
è giunta fino alle melodie oblique dei Pinback<br />
tramite un approccio furibondo e caotico all’hardcore - il<br />
famigerato screamo - portato avanti nei primi anni ’90<br />
da Heroin, Antioch Arrow e Swing Kids.<br />
Allo scopo di sconfiggere l’emicrania scatenata dalla ridda<br />
di sotto-sotto-generi testé elencati, potete concedere<br />
un ascolto giustappunto ai Retox, supergruppo allestito<br />
da Justin Pearson, Gabe Serbian, Michael Crain e Thor<br />
Mickey. Gente che, tra il resto, ha ricoperto un ruolo rilevante<br />
in Locust, Some Girls e Festival Of Dead Deer<br />
e della quale è conseguentemente facile intuire l’attuale<br />
proposta. Un rapidissimo, crudo assalto che sciacqua in<br />
ricordi grind-core schegge gotiche e metal-punk trattenendo<br />
forma sufficiente a impedire il caos e tratteggiando<br />
una ruvida denuncia sociale. I fan gradiranno: tutti gli<br />
altri lascino le speranze prima di entrare. A loro rischio<br />
e pericolo, sia chiaro.<br />
(7/10)<br />
GianCarlo turra<br />
roB Crow - he thinkS he’S PeoPle<br />
(teMPorarY reSiDenCe, ottoBre 2011)<br />
Genere: math inDie pop<br />
Con all’incirca una quindicina di progetti sulle spalle - i<br />
più riusciti dei quali sono probabilmente i Pinback in<br />
campo indie rock, e i Goblin Cock in area stoner-metal<br />
(imperdibili anche i loro video) - Rob Crow è uno dei<br />
musicisti più prolifici degli anni ‘00. Questa volta lo ritroviamo<br />
in veste solitaria proseguire note coordinate<br />
math-indie-pop.<br />
Va avanti a passi piccoli Rob Crow. Piccolissimi. Rispetto<br />
al predecessore (Living Well del 2007), He Thinks He’s<br />
People mette da parte lo spirito giocoso ed ha l’aria un<br />
po’ più malinconica: forse a cambiare davvero è solo<br />
questo, solo l’atmosfera. Per il resto la formula si affina<br />
ma rimane pressoché invariata, ed è destinata quindi a<br />
riscontrare gli stessi pregi e gli stessi difetti di sempre.<br />
I pregi si riassumono nei primi sei brani, che se fossero<br />
usciti come ep avrebbero fatto parlare di sé con maggior<br />
interesse. Il frullato propone: ballate in stile Pavement<br />
(Sophistructure), naturali retaggi Pinback (Tranked, Prepared<br />
To Be Mine), una sparata alla Battles (Build) e l’avvicinamento<br />
ad un pop-post-rock sulla scia degli ultimi<br />
Mogwai (Scalped). Fin qui tutto perfetto, Crow è abile<br />
nel trovare riff in stile math anche con l’acustica (This<br />
Thread), e complice la batteria pestata il lavoro riesce<br />
a discostarsi dal sapore indie più classico. I problemi<br />
nascono nella seconda metà del disco, quando la ripetizione<br />
del canovaccio inizia a mostrare la corda sul versante<br />
songwriting (Purpose, Unstable), andando anche<br />
fuori fuoco in un paio di occasioni (Locking Seth Putnam<br />
In Hot Topic e il finale di Hangnailed). Peccato perché c’è<br />
una scrittura in pieno modernariato pop (con canzoni<br />
che si aggirano attorno ai due minuti) e un innegabile<br />
talento compositivo che lasciano intravedere parecchi<br />
rimpianti per questo He Thinks He’s People.<br />
Poteva essere molto di più del solito disco onesto e sincero.<br />
(6.9/10)<br />
Stefano Gaz<br />
SChnaak - wake uP ColoSSuS (DiSCorPorate<br />
reCorDS, MaGGio 2011)<br />
Genere: noise-rock<br />
SchnAAk è la band di Mathias Jähnig e Johannes Döpping,<br />
musicisti berlinesi ma solo come dato geografico,<br />
punto sulla mappa, accidente biografico, verrebbe da<br />
dire. Il corpo sonoro di Wake Up Colossus, esordio della<br />
band, è un noise-rock eclettico preso a mani piene dai<br />
Novanta americani, adagiato però poco su allori e molto<br />
sulla ricerca di coordinate incrociate.<br />
La tradizione del rock con chitarre tirate si sfoga nelle<br />
prime tracce, per poi lasciare spazio alla complessità,<br />
e a quello spettro che dalla california del frammento e<br />
della struttura obliqua si combina a Polvo, Sonic Youth,<br />
e a tutta la scuola alternative del rock fuori classifica.<br />
Altrove le variabili aumentano con la strumentazione.<br />
Lo xilofono, i vari giocattoli usati, le tastiere e gli effetti<br />
sono però presi in carico nell’arrangiamento più come<br />
oggetti sonanti che come strumenti, quasi l’attesa della<br />
chitarra li intimidisse.<br />
Eppure i numeri gustosi non mancano: Knuus sembra<br />
provenire dai DNA o dai loro figliocci Blonde Redhead,<br />
così come Herero si spinge oltre i confini della decade<br />
e va a intercettare Deerhoof e Battles. Non c’è malizia<br />
nell’operazione ma leggerezza, cosa che più convince di<br />
SchnAAk, e che immaginiamo possa galvanizzare un uditorio<br />
teutonico meno avvezzo a revisioni Nineties così<br />
speziate. Ora aspettiamo l’esito dell’esercizio.<br />
(6.5/10)<br />
GaSPare Caliri<br />
84 85
SCuMBaG PhiloSoPher - it MeanS nothinG<br />
So it MeanS nothinG (worDS on MuSiC,<br />
GiuGno 2011)<br />
Genere: post-punk<br />
Non se ne parla più molto nei libri, eppure il revival post<br />
punk si tiene sempre vivo, nelle band di oggi, a volte<br />
con un filo di voce, altre con noncurante spavalderia. Gli<br />
Scumbag Philosopher sembrano fare parte di questa<br />
seconda corrente, e il motivo è di fatto nascosto dietro<br />
la biografia dei componenti.<br />
Il basso di Adam Green e la batteria di Anne Reekie vengono<br />
dall’esperienza Fiel Garvie nei Novanta e Fuck<br />
Dress nell’ultimo lustro (guarda caso andando a intercettare<br />
gli anni d’oro del detto revival). Oggi, insieme a<br />
Grant Madden e Jon Burke, non resta che raccogliere<br />
l’eredità e farla germogliare in un album, It Means Nothing<br />
So It Means Nothing. È impressionante la derivazione<br />
della voce di Grant dai primi Fall (a proposito<br />
di Reynolds e libri manifesto, avete mai sentito Totally<br />
Wired?), ma drizza le antenne anche la sovrapposizione<br />
tra critica sociale dei Gang Of Four e le liriche ironiche<br />
degli Scumbag. Un velo di esistenzialismo distaccato che<br />
però è condotto, musicalmente, più nel terreno degli Interpol<br />
che degli Wire (a parte qualche raro caso, come<br />
la title-track).<br />
Fossero uscite una manciata di anni fa - quando sono<br />
state pensate, probabilmente - queste nove tracce<br />
avrebbero lasciato un segno nel dibattito. Ora provocano<br />
pensieri e ricordi. E un ascolto discretamente interessato.<br />
(6.4/10)<br />
GaSPare Caliri<br />
SiSkiYou - keeP awaY the DeaD<br />
(ConStellation reCorDS, ottoBre 2011)<br />
Genere: post-folk<br />
A un anno esatto dall’esordio con questa ragione sociale,<br />
l’ex Great Lake Swimmers Colin Huebert offre l’opportunità<br />
di saggiare la maturazione della propria vena di<br />
songwriter. Immutati gli ambienti sonori all’insegna di<br />
una melanconia bucolica e dimessa, è lo smalto della<br />
calligrafia a essere superiore in una manciata di canzoni<br />
dai semitoni persuasivi. Chiarisce molto la loro origine,<br />
essendo state scritte da Huebert in uno sperduto paesino<br />
della British Columbia lungo l’inverno scorso ed -<br />
eccetto due - registrate in poche settimane con il sodale<br />
Erik Arnesen.<br />
Keep Away The Dead porta di conseguenza in dote un<br />
suono intimo e minimale anche quando insegue l’epica<br />
tipica di svariate band canadesi (la title-track in ciò<br />
esemplare), restituendo un profumo di boschi umidi e<br />
d’aria e nevischio che sferzano il volto. L’unica salvezza<br />
per oltrepassare i rigori della stagione il legarsi a doppio<br />
filo con un folk così antico da risultare senza tempo, da<br />
qualche parte tra Bonnie “Prince” Billy (vertici la cameristica<br />
So Cold, le sospese Not The Kind e Dead Right<br />
Now), Bright Eyes (Twigs And Stones, Fiery Death) e il Neil<br />
Young desolato dei primi ’70 del quale è sentitamente<br />
riletta Revolution Blues.<br />
Disco che persuade sul talento del ragazzo e sulla relativa<br />
crescita dello stesso, raccontandosi perfetto per pomeriggi<br />
freddi in cui il tramonto cala sempre più rapido.<br />
(7.1/10)<br />
GianCarlo turra<br />
Slow eleCtriC - Slow eleCtriC (PaneGYriC,<br />
noveMBre 2011)<br />
Genere: contemporanea<br />
Nasce quasi per caso da un incontro tra Tim Bowness,<br />
Peter Chilvers e il duo estone UMA (Robert Jürjendal<br />
e Aleksei Saks) questo Slow Electric, a cui presta il basso<br />
in un paio di brani il King Crimson Tony Levin. Per<br />
un’opera che si posiziona, nello stile e nelle finalità, esattamente<br />
all’altezza del percorso artistico dei musicisti<br />
coinvolti. Con un Bowness (voci, piano, mellotron, loops)<br />
in passato alle prese con Robert Fripp e Hugh Hopper<br />
(Soft Machine), un Chilvers (tastiere) collaboratore di<br />
Brian Eno e David Byrne, uno Jürjendal (chitarra, loops)<br />
sperimentatore in bilico tra contemporanea ed elettronica<br />
e un Saks (tromba) cresciuto in ambienti classici e jazz.<br />
Il risultato non può che essere un disco aulico, laccato e<br />
raffinatissimo, in cui ambient evocativo, pianoforti classici<br />
ma minimali e cantato etereo si mescolano a un’attenzione<br />
maniacale per i dettagli e la resa sonora. La tromba<br />
di Saks viaggia dispersa in cosmo dilatato e fluido, offrendo<br />
una chiave interpretativa affascinante a materiale<br />
che, minimizzata la parte ritmica, si concentra soprattutto<br />
sul mood e il landscape. Tra gli aspetti degni di nota<br />
l’ottima qualità della parte strumentale, l’immediatezza<br />
nell’ascolto e una Between The Silent Worlds finale dagli<br />
accenti vagamente kraut che da sola vale tutto il disco.<br />
(6.9/10)<br />
faBrizio zaMPiGhi<br />
SParrow anD the workShoP - SPittinG<br />
DaGGerS (DiStiller reCorDS, ottoBre 2011)<br />
Genere: inDie rock<br />
Dalle dieci tracce di questa seconda prova della band<br />
UK affiorano fortemente il sound e l’attitudine degli anni<br />
Novanta. Però rispetto alla prima prova degli Sparrow<br />
And The Workshop, quel Crystals Fall dello scorso anno<br />
che pare abbia attratto più di un interessato ascoltato-<br />
re tra i critici d’oltre manica, questo Spitting Daggers fa<br />
poco per personalizzare una proposta musicale già di<br />
per sé passatista. Ci ritroviamo PJ Harvey (Pact To Stay<br />
Cold, Against The Grain) nei momenti più movimentati,<br />
o ancora il decennio Novanta filtrato Yeah Yeah Yeahs<br />
(Snakes in the Grass), ma talvolta si scade nel grottesco (il<br />
crescendo quasi glam della titletrack. i muscoli e la voce<br />
filtrata di You Don’t Trust Anyone).<br />
(5/10)<br />
MarCo BoSColo<br />
SPeCtralS - BaD PennY (wiChita<br />
reCorDinGS, noveMBre 2011)<br />
Genere: pop inGlese<br />
Piccoli Smiths crescono in terra d’Albione. Strano come<br />
una formazione seminale come quella mancuniana sia<br />
stata fatta oggetto di decine di tributi e abbia influenzato<br />
per decenni una larga fetta trasversale di ascoltatori<br />
senza mai (o quasi) aver avuto epigoni degni di tal nome.<br />
Spectrals, il moniker sotto il quale si muove il poco più<br />
che ventenne Louis Oliver Jones da Leeds, non arriva a<br />
toccare le vette liriche di Morrisey né tantomeno quelle<br />
strumentali arrangiate da Johnny Marr, ma di sicuro si<br />
ritaglierà uno spazio di considerazione tra gli amanti del<br />
pop chitarristico ricercato e non banale. Partito, come<br />
ovvio, da lande lo-fi e bedroom pop con l’infinita messe<br />
di pezzi vinilici piccoli per le etichette più cool del<br />
momento (Captured Tracks, Underwater Peoples, Tough<br />
Love, Moshi Moshi e Slumberland), l’aka di Jones sembra<br />
seguire il percorso di molti cult-heroes sotterranei,<br />
pronti ad abbandonare la dimensione lo-fi appena hanno<br />
la possibilità di mettere le mani su uno studio professionale.<br />
Bad Penny, collezione di canzoni che parlano<br />
“dell’amore ai tempi del liceo”, non fa eccezione ripulendo<br />
il flusso spesso spectoriano col quale Spectrals sporcava<br />
e ricopriva le sue canzonette per adagiarsi su una<br />
cristallina apertura smithsiana, in cui il jingle-jangle e le<br />
melodie retrò 50s che avevamo avuto modo di apprezzare<br />
nel 7” 7th Date o nel mini Spectrals Extended Play<br />
si manifestano nella loro pienezza. L’iniziale Get A Grip, le<br />
spuntature “melodic-aggressive” strokesiane di Big Baby,<br />
la malinconia retrò di Many Happy Returns, il seventysoul<br />
di Confetti o l’evidente tributo agli Smiths di Brain<br />
Freeze misto alle dolcezze di Luck Is There To Be Pushed<br />
sono esempi perfetti di un pop semplice, accattivante e<br />
pulito. Come la faccia di questo 21enne romantico che<br />
alla fine, si dice online, ha conquistato l’amore della sua<br />
vita. Ci piace immaginare anche grazie ai 30 minuti di<br />
questo esordio.<br />
(6.8/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
SuMMer CaMP - welCoMe to ConDale (MoShi<br />
MoShi, noveMBre 2011)<br />
Genere: inDie pop<br />
Se avete avuto la sensazione, ascoltando il primo full<br />
length dei Summer Camp, di trovarvi di fronte a una<br />
piccola opera tutta adolescenziale e in odor di calzoncini<br />
e pigiama party, beh, non vi siete affatto sbagliati.<br />
Con Welcome To Condale, in uscita l’8 novembre con<br />
Moshi Moshi, infatti, il duo super indie che più indie non<br />
si può, omaggia i tempi dei telefilm dimenticati in quel<br />
limbo che sono le mattine di quando eravamo ragazzini<br />
e le serate trascorse ad obbligare tutta la famiglia a sorbirsi<br />
per la trecentesima volta un film di John Hughes<br />
che avremmo poi presto apparentemente scordato. La<br />
realtà però, ci dicono Jeremy e Elizabeth, è che nulla si dimentica<br />
davvero e quella vita che ancora non era vita da<br />
grandi, ha registrato profonde nostalgie che facilmente<br />
trasformabili in sonorità che sfrecciano dal pop più giocoso<br />
e femmineo alla potenza di un sound elettronico<br />
nient’affatto trascurabile, quello in cui i Summer Camp ci<br />
ricordano che Welcome to Condale è un concept radicato<br />
negli 80s.<br />
Evidente la presenza, in almeno un paio di episodi, dello<br />
zampino di Ash Workman, già alla produzione dell’ultimo<br />
Metronomy. Ballads romantiche su sonorità altamente<br />
stratificate che fanno incontrare low fi e raffinato<br />
bel canto, elettronica pulita, quasi sinfonica, e bassi sporchissimi,<br />
questo è Welcome to Condale. Ciò che rende<br />
interessante questo lavoro è l’aspetto più strettamente<br />
concettuale: Condale è una città che non esiste, proprio<br />
come sono immaginarie le ambientazioni delle pellicole<br />
di Hughes. A Condale i Summer Camp ambientano una<br />
storia vera e propria che vede al centro due donne, Cathy<br />
e Babe, e le loro vite parallele tra gli anni 50 e gli anni 80.<br />
Ascoltare per credere. Il concept c’è, la sostanza pure,<br />
seppure non sempre ugualmente corposa, spesso cedevole<br />
e leziosa. Spiccano la super californiana Brian<br />
Krakow che profuma un rock’n’roll sporco e sensuale cui<br />
la successiva I want you fa subito da contraltare al femminile.<br />
Non trascurabili i singoloni Better off without you<br />
e Losing my mind, brano tutto composto su una linea di<br />
richiami vocali, elettronici, pianistici eppure ruvidi. Mettetevi<br />
comunque il cuore in pace, Welcome To Condale<br />
è, in soldoni, un piccolo omaggio pop al decennio pop<br />
per eccellenza, un omaggio divertente, piacevole, giocoso<br />
e, al di là del concept, nemmeno troppo hipsterico<br />
però, diciamolo, nulla di più.<br />
(7/10)<br />
Giulia Cavaliere<br />
86 87
the GolDen filter - S Y n D r o M e S<br />
(PerfeCtlY iSolateD, ottoBre 2011)<br />
Genere: electropop<br />
Dopo esser saliti alla ribalta l’anno scorso con l’acclamato<br />
esordio Völuspà, tornano al lavoro i Golden Filter<br />
realizzando la colonna sonora del corto S Y N D R O M<br />
E S diretto dal norvegese Kristoffer Borgli. Il maggior<br />
spessore resosi necessario dal ruolo di accompagnamento<br />
all’immagine conduce il duo newyorkese verso<br />
un pop più sofferente che rifugge la luminosità del disco<br />
precedente (Kill Me e quella sensualità arrendevole<br />
venuta alla luce con The XX). È sempre quell’electropop<br />
modellato intorno alla vocalist Penelope Trappes,<br />
intagliato su quelle lunghezze malinconiche primi<br />
Goldfrapp (Mother), ma che sa anche accanirsi con<br />
carrellate electroclash votate alla Robyn più dancey<br />
(Shake). Libertà di movimento e flessibilità stilistica son<br />
doti importanti, ora tocca metterle al servizio della formula<br />
espressiva che colpisca al primo impatto. E questa<br />
è la strada giusta.<br />
(6.7/10)<br />
Carlo affatiGato<br />
the kookS - Junk of the heart (virGin,<br />
noveMBre 2011)<br />
Genere: britpop<br />
Il primo, al tempo in cui la stampa inglese li chiamava<br />
The Libertweenies e la band vendeva 2 milioni di copie,<br />
lo si perdona perché figlio dell’inesperienza e dell’irruenza<br />
della giovane età. Il secondo, che segna l’ingresso nel<br />
mainstream, meno: infatti calano vendite e apprezzamenti<br />
anche tra le file dei sostenitori della prima ora.<br />
Il terzo, sempre prodotto Tony Hoffer, lasciava sperare<br />
perlomeno in una maggiore maturità e invece si risolve<br />
in un prodotto discografico che neppure NME riesce a<br />
salvare.<br />
Il famoso mag britannico a Junk Of The Heart rifila infatti<br />
un bel 4, e noi potremmo liquidare così, senza tanti<br />
patemi, una carriera iniziata nel 2006 dalle spiagge di<br />
Brighton definitivamente approdata dalle parti di un folk<br />
pop tanto cristallino e vintage, quanto autoreferenziale<br />
e privo di originalità.<br />
Rimarrebbe soltanto da parlarvi delle risse storiche<br />
con i rivali Razorlight e Arctic Monkeys, aneddoti di<br />
gran lunga più interessanti di un disco di archi sedanti<br />
(Time Above Earth), precotto rock settantino (Fuck The<br />
World Off con lyrics da bandire), tentativi di college<br />
rock (Killing Me) e altre inutili baggianate. Accontentarsi<br />
di un guitar pop in salsa Morissey/Kinks macinato<br />
e riscaldato per l’ennesima volta? Peggio. Qui<br />
la colpa sta nel aver scelto il peggio dei cliché che<br />
manco i Coldplay. Fortuna che dura soltanto trentanove<br />
minuti...<br />
(4/10)<br />
MarCo BoSColo<br />
three in one GentleMan Suit - Pure<br />
(fooltriBe, ottoBre 2011)<br />
Genere: inDie<br />
Pure, quarto album dei TIOGS, segna il rientro in pista per<br />
la formazione emiliana dopo uno iato triennale in cui il<br />
terzetto non si è affatto risparmiato, arrivando a calcare<br />
palchi anche nella lontana Cina.<br />
Questo ritorno spariglia, però, le già buone carte messe<br />
in tavola dal precedente We Build Today, col senno di poi<br />
profetico come da titolo. Per dinamiche discografiche - il<br />
disco è in download gratuito presso il loro sito, seguendo<br />
una tendenza ormai consolidata - e per evoluzioni musicali.<br />
Abbandonati i lidi (grossomodo) post-rock trafficati<br />
in precedenza, i 3 eleganti uomini salpano in direzione<br />
ignota, mostrandosi più aperti che in precedenza ad accogliere<br />
prassi e input alieni.<br />
La produzione della premiata ditta Favero (Il Teatro Degli<br />
Orrori, One Dimensional Man) e Ferliga (Aucan) in<br />
questo senso ha molto aiutato, innervando di venature<br />
electro il versante ritmico (Green Riot, wave-caleidoscopio<br />
malinconicamente melodico e ritmicamente pompato<br />
alla Aucan) e per certe atmosfere meno opprimenti,<br />
ma è l’evoluzione interna al progetto a fornire lo scarto<br />
col percorso precedente. Dismessi i panni del progetto<br />
post-/slow, prima (Battlefields In An Autumn Scenario),<br />
e math, poi (Some New Strategies), accolti in seno alla<br />
strumentazione l’elettronica di synth, tastiere e campionatori,<br />
posta una maggiore attenzione all’amalgama di<br />
tensione e melodia, furia e elaborazione, i TIOGS colpiscono<br />
appieno il bersaglio. Che è quello decostruttivista<br />
e riaggregativo di band nazionali di cui abbiamo apprezzato<br />
le capacità negli ultimi anni (dai citati Aucan ai<br />
Lush Rimbaud, per capirsi), sempre più in grado di confrontarsi<br />
con forme nuove e personali di rielaborazione<br />
concettuale in ambito di genere (vedi alla immancabile<br />
voce Battles).<br />
Detta così, sembrerebbe di rifarsi ad un album dalle coloriture<br />
omogenee e dalle atmosfere quasi cristallizzate,<br />
mentre in realtà addentrarsi nell’ascolto di Pure lascerà<br />
scoprire tante piccole sfumature post-math emo-zionale<br />
(Confusion Is Pleasure), art-rock washingtoniano (Upcoming<br />
Poets), wave divagante (Born Nihilistic). E molto<br />
altro ancora.<br />
(7/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
thunDerCat - the GolDen aGe of aPoCalYSPe<br />
(BrainfeeDer, aGoSto 2011)<br />
Genere: funk, fusion<br />
Bassista dei Suicidal Tendencies dal 2002 e sessionman<br />
di fiducia del giro Badu-Sa-Ra-Lotus (lo troviamo su New<br />
Amerykah 1 & 2, Nuclear Evolution, Cosmogramma), il<br />
virtuoso Stephen ‘Thundercat’ Bruner esordisce come<br />
solista ovviamente su Brainfeeder. L’operazione segue<br />
la linea di pubblicazioni di musica suonata e fusion inaugurata<br />
dall’album di Austin Peralta; gli ingredienti sono<br />
quelli che la cerchia di amici (e Om’Mas Keith e Shafiq<br />
Husayn, la Badu, FlyLo e lo stesso Peralta sono appunto<br />
ospiti) lascia intendere.<br />
Funk superslappato, electropop Ottanta e ambience<br />
laser-spacey, a creare una fusion - sfumata latin - che<br />
non arriva mai però al barocchismo generoso per quanto<br />
freddo del biondissimo pianista o al progressivismo<br />
spinto del nipote di Alice Coltrane. The Golden Age of<br />
Apocalypse è molto più asciutto. E mediocre. Is It Love?<br />
ha i suoi bei saliscendi vocali di scuola baduiana (canta<br />
Om’Mas) e Golden Boy riesce a scavalcare il solito esercizio<br />
funky (il 90% del resto del disco) diventando uno studio<br />
di spezzettamento ritmico. Ma ecco, semplicemente,<br />
a Thundercat sembra mancare la stoffa del songwriter e<br />
neppure sotto il profilo dell’alto artigianato da turnista<br />
che da lui ci si aspetterebbe ci sono qui grandi cose.<br />
(5.1/10)<br />
GaBriele Marino<br />
tiGer & wooDS - wiki & leakS<br />
(autoProDotto, ottoBre 2011)<br />
Genere: Disco<br />
Dopo quel Through The Green che ha acceso definitivamente<br />
i riflettori su di loro e i due eppì estivi editi in<br />
formazione singola (Alone on The Green e On The Green<br />
Alone), i Tiger & Woods sono ancora in forma smagliante<br />
e, senza perdere un’unghia del loro smalto, rilasciano<br />
gratuitamente un altro full-lenght di inediti senza titolo<br />
ma pieni di sostanza (lo potete scaricare qui). La formula<br />
non cambia di una virgola, sempre fondata su cassa<br />
in quattro e claps vecchia maniera attentissimi a non<br />
disturbare la circolarità della materia disco (i ‘70 che ritornano<br />
in #03 o #11) e quei caratteristici campioni vocali<br />
messi in loop che ormai rappresentano il loro biglietto<br />
da visita (#01, #02 o #09, tutte naturali continuazioni del<br />
primo album).<br />
Quindici carotaggi riutilizzabili di clubbing, per la gioia<br />
dei dj che scaldano le folle. È ancora energia dance seminale<br />
(i graffi electro d’antan di #04, i synth gaudenti<br />
di #08) che non perderebbe di efficacia nemmeno tra<br />
trent’anni, carburante esplosivo che in pista ti manda<br />
avanti all’infinito (per conferme chiedete a <strong>Leon</strong>). Ripetitivo<br />
all’ascolto? L’obiezione ha un vizio di forma.<br />
(6.9/10)<br />
Carlo affatiGato<br />
tinY tiDe/anneMarie - fall to fall (kinGeM,<br />
ottoBre 2011)<br />
Genere: inDie pop<br />
Fall To Fall ovvero le quattro stagioni secondo il patologicamente<br />
fertile Mark Zonda AKA Tiny Tide, accompagnato<br />
in questo carosello meteoropatico (o semmai<br />
meteorofilo?) da Annemarie, band indonesiana la cui<br />
cantante Rimauli Dindani può vantare vocina flautata<br />
e malferma tipo una Isobell Campbell in sedicesimi,<br />
gracile ai limiti dell’inconsistenza eppure dotata della<br />
grazia agrodolce e tenace che fa alla bisogna. Son cose<br />
delicate, infatti, i cambi di stagione. C’e’ bisogno della<br />
rete di protezione d’un immaginario sfaccettato pronto<br />
a raccoglierti dopo la caduta nel lucernario psych-pop<br />
con fragore di colori, aromi e circostanze da giardinetto<br />
periferico.<br />
Detto che i due pezzi firmati Annemarie (Lovely Afternoon<br />
e Spring Bus) sciorinano ragguardevoli morbidezze &<br />
fragranze twee-soul (tra l’arguzia bucolica Gentle Waves,<br />
il languore disincantato degli Edwin Moses ed il<br />
piglio arguto dei più soffici Stereolab), non stupisce piu’<br />
oramai l’apparente semplicità con cui Zonda snocciola<br />
pezzi tra il gradevole e l’avvincente, soprattutto il pastiche<br />
della opener To Fall e la wave onirica di Vacaciones<br />
de inverno. Al solito ti ritrovi in una mischia di dimensioni<br />
estetiche sovrapposte, nella fattispecie la neo-psichedelia<br />
dei Cope e degli Hitchcock piu’ affabili, certo jingle<br />
jangle acidulo, barlumi glam e dream come se piovesse,<br />
gli sferzanti incantesimi dei The Fall (e non poteva essere<br />
altrimenti, visto il titolo) ed il lirismo indolente di Jens<br />
Lekman.<br />
Il tutto mantecato in una glassa di bassa fedelta’ da far<br />
stramazzare un audiofilo, la quale - val bene ribadire - è<br />
ingrediente essenziale come l’incarto stropicciato per la<br />
caramella, come la levigatezza porosa della tazza da cui<br />
sorseggi il té, un intimo difetto di pronuncia (cit.) come<br />
additivo mitopoietico di palpitazioni oniriche ad alzo<br />
zero. Vedi il caso della conclusiva Fall, che è anche l’unica<br />
traccia scritta in collaborazione e qualcosa di molto<br />
vicino all’idea iperuranica di “gioiellino indie-pop”.<br />
(7/10)<br />
Stefano Solventi<br />
88 89
troPiCS - ParoDia flare (Planet Mu<br />
reCorDS, SetteMBre 2011)<br />
Genere: shoeGaze Glo<br />
Se il glo-fi dovesse venire a mancare di qui a breve, probabile<br />
che sia questo il primo modo in cui verrà riempito<br />
il vuoto: un pop sfumato a colori pastello, che riversa la<br />
sua nostalgia sgranata su trame oniriche storicizzate à la<br />
Cocteau Twins, ma che fa comunque tesoro dei mood<br />
da cameretta di Memory Tapes e compagnia. La parabola<br />
glo in senso stretto la si lascia alle spalle, la si usa<br />
come lente focale per guardarci attraverso e puntare al<br />
passato remoto, e in un modo o nell’altro son sempre<br />
gli ‘80 a venir fuori.<br />
Sembra non avere altre ambizioni che questa Chris Ward,<br />
la nuova scommessa Planet Mu sotto la voce Tropics,<br />
già edito l’anno scorso con il singolo Soft Vision. L’album<br />
amplia quelle che all’inizio erano primizie electro-pop,<br />
integrandole con una malinconia tanto vicina a Toro Y<br />
Moi (Going Back) e adagiandole su tinte shoegaze melliflue<br />
(Playgrounds, Parodia Flare) se non visioni propriamente<br />
ambient (Celebrate). Senza disdegnare un pugno<br />
di ballate intimiste devote a Thom Yorke (Mouves), ma<br />
con una fedeltà vintage a un tanto così dall’acid jazz (On<br />
The Move). Tutte idee che reggono, ma che non possono<br />
prescindere da un importante dose di carattere. L’album<br />
tenue e sottile è ben accetto, ma così il rischio è che<br />
diventi impalpabile.<br />
(6.2/10)<br />
Carlo affatiGato<br />
tYCho - Dive (GhoStlY international,<br />
noveMBre 2011)<br />
Genere: ambient<br />
Scott Hansen, artista di San Francisco, in arte Tycho,<br />
ha innata l’arte della manipolazione, oltre alla capacità<br />
di conquistare il pieno riempiendolo di vuoti. Il nuovo<br />
Dive non fa altro che confermare il tutto - già santificato<br />
dagli altri - agonizzando l’ascoltatore tra piacevolezze<br />
dreamy e ottusità monocolori, prima di sparire tra le<br />
sabbie mobili di un immobilismo concettuale e sonoro,<br />
dove a mancare non è l’equilibrio, ma il cambio di passo,<br />
il lancio in profondità, o meglio, la rincorsa.<br />
La ricetta è semplice e mal digerita, come la direzione,<br />
troppo pietrificata per questi tempi disinvolti: lenzuolate<br />
oniriche in bilico tra post rock a senso unico e (tentate)<br />
sensazioni elettroniche. A fare da contorno, l’elemento<br />
disturbatore di turno, la variabile post punk (Dive), la freschezza<br />
assopita tipicamente eighties (ovunque eppure<br />
in nessun luogo) oppure saliscendi danzerecci insignificanti<br />
(Coastal Brake), o infine, senza alcuna direzione,<br />
vedi l’incompiuta Ascension, sviluppo avariato dopo un<br />
approccio sognante invidiabile. Un cambio di velocità<br />
standardizzato, dove la creatività viene sommersa dalla<br />
maniera (Hours) o dall’apparenza sintetica che non restituisce<br />
il fuoco delle intenzioni, senti la sapida Daydream.<br />
A Walk rincorre la paura di ballare dei Port Royal, e quasi<br />
si sorride estasiati, episodio raro e quasi devastante se<br />
rapportato con gli impalpabili riempitivi di Melanin ed<br />
Epigram, a futura imitazione degli irraggiungibili Board<br />
Of Canada. Dive è pelle, raramente carne e anima, un<br />
unicum sonoro fatto d’intenzioni, svuotato di azioni.<br />
Le idee, confezionate egregiamente, si contano su una<br />
mano con tre dita.<br />
La sufficienza è abbondante e d’obbligo, rincuorata<br />
dall’unica immersione, dal respiro ammaliatore di Elegy,<br />
strutturata speranza nel futuro. Dive è un’immagine<br />
senza immagini, inusuale per un’artista, ridondante per<br />
l’ascoltatore.<br />
(6.3/10)<br />
feDeriCo Pevere<br />
ultiMo attuale CorPo Sonoro - io riCorDo<br />
Con raBBia (Manzanilla, noveMBre 2011)<br />
Genere: post-rock<br />
Gestire testi rabbiosi, declamati e catartici su un’estetica<br />
che inevitabilmente richiama l’asse Massimo Volume<br />
/ Offlaga Disco Pax non è impresa facile: il rischio è di<br />
sfociare nella retorica più oltranzista e banale, come di<br />
foraggiare, musicalmente parlando, un senso di déjà vu<br />
che non può portare a nulla di buono. Per questo la scrittura<br />
diventa, ancor più nel caso degli Ultimo Attuale<br />
Corpo Sonoro, momento fondante: un soppesare i toni,<br />
un dosare l’intensità, un reggersi in bilico tra musica e<br />
parole che renda il tutto credibile e, soprattutto, condivisibile.<br />
Oltre la facile invettiva politica e alla ricerca di<br />
storie rubate alla memoria collettiva.<br />
L’esempio da seguire è quello della Empirismo eretico dedicata<br />
a Pier Paolo Pasolini nel disco d’esordio Memorie e<br />
violenze di Sant’Isabella, brano di cui Io ricordo con rabbia<br />
sembra idealmente lo sviluppo. Chiudere il cerchio - o<br />
per meglio dire ampliarlo progressivamente - con un<br />
pugno di brani al solito schierati e toccanti in cui all’imperialismo<br />
e al terrorismo di stato (la Flight Data Recorder<br />
dedicata alla tragedia di Ustica, una Undici settembre millenovecentosettantatrè<br />
ispirata dalla parabola di Salvador<br />
Allende e del musicista Victor Jara) si mescolano vittime<br />
predestinate (una Fortapàsc che ripercorre l’omicidio del<br />
giornalista Giancarlo Siani), ma anche riferimenti palesi<br />
a personaggi politici di primo piano (Tessera P2# 1816).<br />
Violenza (emotiva) e verità urlate, vicende tragiche e<br />
“oscure” da riportare a galla. Per farlo il gruppo sceglie la<br />
strada più immediata e intrigante: accelerare il post-rock<br />
etereo e stratificato che regolava il disco precedente in<br />
una copula urticante ai confini col noise in stile Godspeed<br />
You! Black Emperor. Con certi crescendo fulminanti di chitarra<br />
elettrica, basso, tastiere e batteria che si dimostrano<br />
una spalla perfetta per i testi poetici di Gianmarco Mercati,<br />
questi ultimi quasi sommersi dal flusso empatico<br />
che si sviluppa con il trascorrere dei minuti.<br />
Le retorica, dicevamo: per ora gli Ultimo Attuale Corpo<br />
Sonoro dimostrano di saperla arginare con un disco riuscito<br />
e all’altezza del già ottimo esordio. Quanto ancora<br />
un approccio di questo genere possa funzionare senza<br />
suonare autoreferenziale - il pattern stilistico in fondo<br />
non cambia di molto, è la potenza evocativa dei brani a<br />
far la differenza - non è dato saperlo.<br />
(7.2/10)<br />
faBrizio zaMPiGhi<br />
uYuni - uYuni (tafuzzY reCorDS, Marzo<br />
2011)<br />
Genere: post/finGerpickinG<br />
C’è il fuoco sacro di John Fahey dietro a Uyuni, nuovo<br />
progetto di Lompa e Inserirefloppino, già compagni<br />
di band in mrBrace e B.I.P.. C’è una memoria collettiva<br />
che dal folk-blues primitivista americano - filtrato coi toni<br />
del raga indiano - arriva a lambire il post-rock scozzese<br />
e i Novanta italiani (lo spoken word di E Adesso Dove Ci<br />
Troviamo, una sensibilità cantautoriale da Consorzio Produttori<br />
Indipendenti in Qui).<br />
La formula ricorda The Epiphany Of Glenn Jones dei<br />
Cul De Sac, pietra angolare per chi guarda al fingerpicking<br />
del maestro e lo intarsia di synth e tappeti elettronici<br />
- e di fatto canto del cigno di Fahey. La chiave<br />
compositiva e di lettura è più narrativa, meno pregna<br />
d’inquietudine e di scomposizioni paranoiche rispetto<br />
all’esperimento tardivo degli amici John e Glenn. La strada<br />
seguita da Uyuni mette di fatto sempre in prima fila<br />
i fraseggi della seicorde, la sua riconoscibilità e accessibilità,<br />
messa in discussione forse solo dalla finale Cairngormos,<br />
brano nato sotto il segno delle strutture dei<br />
June Of 44 ma quasi Neu!-iano nella distensione con<br />
cui trova una realizzazione solare nella seconda parte.<br />
Fatti i conti con ciò che risuona nell’aria mentre si ascolta<br />
l’esordio del duo, ci si rende conto che il noto non<br />
è banalmente un già sentito ma un punto di partenza,<br />
un contesto di condivisione, un mondo astratto epperò<br />
conosciuto dove sentirci a nostro agio, su cui i due lavorano<br />
e fanno emergere le penne e la scrittura. Ci è già<br />
successo qualcosa di simile affrontando il lavoro di Egle<br />
Sommacal (uno su tutti), accade lo stesso con Uyuni,<br />
capaci di smarcarsi, pur usando approcci non così divergenti,<br />
dal post-rock emozionale che continua a riempire<br />
tante, troppe etichette italiane. È il fuoco sacro, si diceva.<br />
(7/10)<br />
GaSPare Caliri<br />
vena viola - SMaSh uP (autoProDotto,<br />
aGoSto 2011)<br />
Genere: trip hop<br />
A volte lo noti subito dalla copertina. Quelle copertine<br />
che ti indirizzano, ti aprono la strada del percorso che<br />
stai per intraprendere. Quella di Smash Up dei Vena Viola<br />
da Benevento è una strada complicata. Dal cuore della<br />
Campania dritti nella fumosa Bristol del trip-hop. Non<br />
è un percorso così scontato, perché alcune volte c’è da<br />
fare i conti con altri fattori, quelli del tuo DNA, della tua<br />
terra o (per dirla con un termine brutto) delle tue radici.<br />
A Benevento non ci sono tante fabbriche quante ce ne<br />
saranno a Bristol, ma forse quel clima di provincia, di<br />
frontiera che respirano i posti come quello, non è così<br />
diverso. Infondo anche gli Almamegretta avevano già<br />
questo tipo di approccio.<br />
I temi che scottano, giorno dopo giorno in queste terre,<br />
sono il pane quotidiano per chiunque voglia intraprendere<br />
un’attività più o meno artistica. Non ci si meravigli,<br />
dunque, se l’insieme delle cose collega due mondi così<br />
apparentemente distanti. Smash Up è un album d’impatto.<br />
Pulito, ghiacciato, scuro, essenziale Più che nel<br />
mettere, la bravura dell’artista in certi contesti sta nel<br />
togliere: quando la soglia dell’ipnosi si abbassa ai soli<br />
vocalizzi di Veta, vuol dire che il gioco è vinto. L’ascoltatore<br />
rimane sotto scacco, immerso in piccole cavalcate<br />
di drum machine, e riff ossessivi di chitarra. L’essenza è<br />
tutta lì. L’onirico mondo dei Portishead, quello fatto di<br />
lontani segnali da mondi sconosciuti, è qui filtrato da<br />
ridondanti violini e organi synth, color arcobaleno, che<br />
alla fine lasciano sperare che la situazione è sotto controllo.<br />
Aggiungiamo poi che il tutto è stato concepito per contestualizzare<br />
e permeare di lampi e suoni la mostra di<br />
Gianluca Russo e si torna al percorso da intraprendere,<br />
di cui sopra. A volte non si tratta di fare canzoni, ma di<br />
scrivere delle immagini.<br />
(7.2/10)<br />
nino CiGlio<br />
verYShortShortS - MiniMal BooM! (riff<br />
reCorDS, ottoBre 2011)<br />
Genere: Jazz rock<br />
Li abbiamo scoperti lo scorso anno con Background<br />
Music For Bank Robberies, sorta di carosello di<br />
soundtrack poliziesche in differita dall’iperuranio dei<br />
film potenziali. Estro, ingegno e disinvoltura fin dove<br />
90 91
lo consentono pianoforte, violino e batteria. Il jazz furibondo<br />
math-rock, improvvisata birbona e camerismi<br />
suadenti, il pungolo cinematico sempre in tiro a pasturare<br />
l’immaginario. Per le parole, va da sé, non è luogo.<br />
Formula che trova conferma e verve rinnovata nel qui<br />
presente sophomore Minimal Boom!, il ventaglio che<br />
s’allarga a sventolare irrequietezze post e impressionismi<br />
avant, lambendo gradazioni intermedie come<br />
l’E.S.T. di Nein Ist Nein, l’impeto scarmigliato funky<br />
- come i Venus più esagitati - di While My Daughter<br />
Gently Sleeps o quella specie di Rachel’s anfetaminici<br />
di Ramachandran.<br />
Posso rimproverargli solo un eccesso di pulizia sonora,<br />
ma visto il loro background jazzistico è un po’ come<br />
rimproverare a Tom Waits d’essere roco o ai Sonic<br />
Youth d’esagerare con le distorsioni. Comunque, bene<br />
così.<br />
(6.9/10)<br />
Stefano Solventi<br />
vinCenzo faSano - il SanGue (eCleCtiC<br />
CirCuS, ottoBre 2011)<br />
Genere: cantautorato<br />
L’immaginario di Vincenzo Fasano è in qualche maniera<br />
analogo a quello de Le luci della centrale elettrica.<br />
Non tanto per lo stile musicale o i contenuti, quanto<br />
per quel saper convogliare frustrazioni umorali in un<br />
cantautorato espettorato, ruvido, urlato. Una spinta<br />
emotiva fortissima che tutto trascina, lasciando in secondo<br />
piano gli accorgimenti stilistici (un missaggio<br />
fangoso, certe elettricità sorprendenti, echoes profondi),<br />
la strumentazione a corredo dell’onnipresente chitarra<br />
(fisarmonica, basso, qualche pianoforte, batteria),<br />
forse anche gli stessi brani. In una paradossale rincorsa<br />
a un “sopra le righe” voluto ma anche credibile e senza<br />
forzature.<br />
Materiale che a differenza di quanto accade con lo stream<br />
of consciousness brondiano, si affida a strutture canoniche<br />
e tutto sommato riconoscibili: la wave confusa<br />
col cantautorato di Non ritiro quel che ho detto, il tango<br />
caposseliano sbrindellato dell’accoppiata Paiettes / Se<br />
fossi in me, il Vasco Rossi prima maniera di Mal d’africa.<br />
Filtrate da una voce a metà strada tra Giancarlo Onorato<br />
e Bugo capace di far dimenticare i punti deboli di<br />
una scrittura intuitiva, a volte brillante (La sindrome di<br />
Stoccolma, Il Sangue), ma ancora da definire pienamente.<br />
Al disco, registrato al NHQ di Ferrara e prodotto da<br />
Manuele Fusaroli (già al lavoro con Le luci della centrale<br />
elettrica, Zen Circus, Tre allegri ragazzi morti), hanno<br />
partecipato Riccardo Sinigallia, Gionata Mirai (Teatro<br />
degli Orrori) e Dino Fumaretto. Unite i puntini e capi-<br />
rete per quale motivo - in questo caso con pieno merito<br />
- sentiremo ancora parlare di Vincenzo Fasano.<br />
(6.7/10)<br />
faBrizio zaMPiGhi<br />
vintaGe trouBle - the BoMB Shelter<br />
SeSSionS (MCGhee entertainMent, ottoBre<br />
2011)<br />
Genere: southern rock<br />
Può un quartetto proveniente dalla patinata Los Angeles<br />
suonare rock vibrante ed elettrico che irrobustisce le radici<br />
black in modo credibile? Questa la domanda da porsi<br />
di fronte ai Vintage Trouble, esperti strumentisti all’esordio<br />
sotto tale ragione sociale. Perché no, a patto che la<br />
penna sia di vaglia, la conoscenza degli argomenti adeguata<br />
e si scansino luoghi comuni ed eccessiva pulizia<br />
sonora. Poiché non accade, ecco che assumono tutt’altro<br />
significato che, 1) trattasi di “protetti” del manager Doc<br />
McGhee (Bon Jovi, Motley Crue, Kiss, Guns N’ Roses);<br />
e 2) che il cantante Ty Taylor c’avesse già provato senza<br />
riuscirvi a fine ’90 con i Dakota Moon.<br />
E ulteriori dubbi emergono leggendo che lo stesso parla<br />
di soul primitivo, il che può essere vero se considerate<br />
Lenny Kravitz uno schietto interprete della tradizione<br />
e non un patetico coacervo di banalità. L’oliato e ben<br />
eseguito The Bomb Shelter Sessions scorre infatti senza<br />
sorprese né scarti particolarmente clamorosi tra mainstream<br />
e underground, ben fatto al punto da istigare il<br />
dubbio che sul palco le cose vadano diversamente e<br />
magari la formazione accantoni oleografia e belle maniere.<br />
Al loro meglio (You Better Believe It e Nobody Told<br />
Me, Run Outta You e Jezzebella) i Vintage Trouble sono in<br />
sostanza dei Black Crowes di seconda categoria e certo<br />
non depone a loro favore un incombente tour di spalla<br />
a Bon Jovi. Una faccenda entusiasmante per chi si nutre<br />
con Virgin Radio e trascorre i sabati sera sul Sunset Strip.<br />
(6.3/10)<br />
GianCarlo turra<br />
vittorio Cane - Palazzi (innaBiliS, ottoBre<br />
2011)<br />
Genere: canzone D’autore<br />
In un’epoca in cui il cantautorato indie cerca di smarcarsi<br />
dalle retrovie lo-fi per abbracciare un età adulta fatta di<br />
produzioni medio-grandi (Dente), sensibilità in crescita<br />
(Brunori Sas), deviazioni personali (33 Ore), sperimentazioni<br />
borderline (Iosonouncane), Vittorio Cane decide<br />
di non allontanarsi troppo dai consueti pruriti melodici/<br />
bughiani prima maniera. E così, lasciati perdere i modelli<br />
istituzionali forti e riconoscibili (i vari Battisti, Gaetano,<br />
Dalla, Ciampi) che ispirano i fratelli maggiori, si autocon-<br />
fina nel ruolo del busker indie dalla voce tremolante in<br />
bilico tra ironia e storie di tutti i giorni.<br />
Freno tirato, insomma, per un approccio che fino a qualche<br />
anno fa pagava ma che ora mostra un po’ la corda.<br />
Come accade a tutto ciò che subisce un processo di codifica<br />
e di condivisione, in questo caso operato da chi<br />
ascolta ma anche da una pletora di emergenti fiduciosa<br />
di affidare le proprie paturnie al lucky strike di turno.<br />
Palazzi, pur raddrizzando qualche stortura di troppo del<br />
precedente Secondo, non riesce ad imporsi come dovrebbe.<br />
E se formalmente il materiale si integra senza<br />
troppe sbavature con quella new-wave del cantautorato<br />
nostrano in voga da qualche anno a questa parte, nella<br />
sostanza non regge il confronto con i diretti concorrenti<br />
- il già citato Bugo ma anche l’ultimo Brunori Sas - che<br />
nel frattempo hanno inevitabilmente fatto passi in avanti<br />
dal punto di vista musicale e dei testi. Le cose migliori<br />
si ascoltano quando lo spartito si fa più arioso (Quello<br />
che, Mai), c’è ancora qualche buona intuizione, ma molto<br />
del materiale contenuto nel disco ci pare destinato<br />
soprattutto ai cultori più fedeli dell’opera del musicista<br />
torinese.<br />
(5.8/10)<br />
faBrizio zaMPiGhi<br />
wallS - CoraCle (koMPakt, noveMBre 2011)<br />
Genere: kraut, Disco<br />
Mellifua e blissfull, fonte irresistibile di gentilezza e maniera,<br />
capace d’estasiare attraverso costruzioni ripetitive<br />
e ordinate: quella dei Walls è musica sapiente ma leggera,<br />
una sintesi di linguaggi (krauterie e psichedelie, shoegaze<br />
e wave, techno, new age, minimalismo) veicolati da<br />
viaggi onirici che hanno molto a che fare con il sublime.<br />
Coracle segue un esordio accolto trionfalmente dalla<br />
stampa britannica e dai producer più hypati (e a ragione)<br />
del momento come James Holden, Jamie XX e quel Caribou,<br />
la cui lezione sembra lo snodo perfetto tra i due<br />
lavori. Attraverso un uso più corposo di chitarre e pedali<br />
e un approccio più mirato a Cluster, Popul Vuh e primi<br />
Kraftwerk delicatamente sposato a Detroit, il sophomore<br />
di Alessio Natalizia e Sam Willis si nutre dell’elettronica<br />
gentile dell’autore di Swim cogliendone perfettamente<br />
le intersezioni con Arthur Russell e il downtempo shoegazetronico<br />
(Into Our Midst) ma anche sapendole infondere<br />
una glassa glo che sa guardare a Frankie Knukles<br />
via Animal Collective (Hate Haze) oppure a una techno<br />
tagliata all’ananas (Sunporch).<br />
Sintesi dicevamo: la specialità della coppia sta proprio<br />
qui, ma anche nel rigore dei battiti, nel saper raccontare<br />
storie in note (Vacant), nelle mosse di lato (la wave 80s<br />
folktronica di Raw Umber / Twilight), nel lanciarsi in colori<br />
acidi, motorik e Werner Herzog (Il Tedesco), nell’accarezzare<br />
il west angolandolo sempre sulle autobahn (Ecstatic<br />
Truth) oppure concedendosi un finale romantico à la<br />
Album Leaf (Drunken Galleon).<br />
Coracle detta infine le proprie coordinate d’ascolto: più<br />
alzi il volume e più dettagli e segreti emergono in superfice.<br />
Un altro pregio dell’ennesimo gioiello di casa<br />
Walls, un progetto che è ora il perfetto contraltare di<br />
quell’Esperanza di cui vi parleremo prestissimo.<br />
(7.1/10)<br />
eDoarDo BriDDa<br />
wilD flaG - wilD flaG (wiChita reCorDinGS,<br />
noveMBre 2011)<br />
Genere: inDie<br />
Della serie: i “supergruppi” funzionano perché alla base<br />
c’è un solido sentire di stampo indie, nell’accezione<br />
felice di una parola utilizzata sempre più a sproposito<br />
nell’ultimo decennio e, più spesso che no, tristemente<br />
fraintesa. Cosa che non accade qui, dove due terzi delle<br />
disciolte Sleater-Kinney (Carrie Brownstein e Janet<br />
Weiss) incontrano la chitarrista e cantante Mary Timony<br />
- già negli Helium e con la stessa Carrie nelle The Spells,<br />
intestatarie a fine ’90 di un e.p. su K Records - e la tastierista<br />
Rebecca Cole, i cui Minders giustappunto aprirono<br />
concerti delle Sleater-Kinney.<br />
Chiaro fin dai curriculum delle partecipanti che la forza<br />
dell’operazione sta nella coesione della scena di Olympia<br />
e dintorni; in quel senso di aggregazione che svela una<br />
“comunità artistica” esemplare quanto a intenti e risultati.<br />
Ha preso forma infatti spontaneamente anche questo<br />
progetto, legato a brani strumentali per un documentario<br />
di Lynn Hershman Leeson e poi esteso a canzoni più<br />
compiute che, registrate pressoché in diretta, vibrano<br />
d’intesa ed energia strabordanti. Il che non sarebbe nulla<br />
se non fosse di elevato livello la scrittura, che volga lo<br />
sguardo alla splendida maturità di The Woods (Racehorse,<br />
Future Crimes), riverisca i Television e i più ruvidi Go-<br />
Betweens (Short Version, Romance)oppure approdi su<br />
terrori tra garage - del resto è sempre Nord-Ovest americano<br />
- e new wave (l’acidulo asso Glass Tambourine<br />
ripensa i Lost Sounds in versione “paisley undeground”;<br />
Endless Talk sono le Bangles che rifanno ? & The Mysterians<br />
con in testa le Slits).<br />
Schiaffo che è carezza e viceversa, si spera che Wild Flag<br />
non resti episodio isolato, e che a questo punto - anche<br />
alla luce dell’ottimo lavoro della Corin Tucker Band - le<br />
tre ragazze Sleater non facciano l’errore di riunirsi.<br />
(7.3/10)<br />
GianCarlo turra<br />
92 93
zoMBY - nothinG eP (4aD, noveMBre 2011)<br />
Genere: thrill-bass ‘arDkore<br />
Nemmeno sei mesi dalle abluzioni dark-emotion di Dedication<br />
ed è di nuovo Zomby, con la sua sirena memorabilia<br />
‘ardkore, le sue apprensioni 8bit che volgono al<br />
mistero e uno spessore compositivo riconoscibile lontano<br />
un miglio, che ormai non somiglia più a nient’altro<br />
che a sé stesso. Nuovo EP sempre per 4AD, sette inediti<br />
che riepilogano passato, presente e probabile futuro di<br />
uno dei producers più titolati delle lande sui generis di<br />
terra britannica.<br />
Ritornano i vecchi amori rave, non paghi di aver trovato<br />
in Where Were You in ‘92 una delle sintesi più riuscite:<br />
una Labyrinth che prima apre su synth cosmico/ambientali,<br />
poi si impenna su un breakbeat rallentato alla fase<br />
pre-jungle e in mezzo farcisce con inserti afrorap virati<br />
grime-step à la Terror Danjah, mentre invece altrove<br />
è la drum’n’bass canonica a riaffiorare con un maggior<br />
piglio retrologico (Ecstasy Versions, Sens).<br />
Il nuovo invece è in Digital Fractal e Equinox, che ci restituiscono<br />
uno Zomby mai così ritmicamente deciso, con<br />
una mano imposta sulla suggestione deep e quel suo<br />
peculiare thrilling digitale a rendere il mood surreale. In<br />
mezzo due brani come It Was All A Dream e Trapdoor che<br />
propugnano le atmosfere criptiche di Dedication parlando<br />
per fonemi UK bass.<br />
Ma qui i generi sono solo una teoria improbabile e Zomby<br />
dimostra ancora una volta di poterne fare a meno<br />
senza danni, lasciandosi definitivamente alle spalle la<br />
freakness ardita dei primi eppì: l’uomo senza volto ha<br />
davvero trovato la quadra, facendo emergere un buio<br />
enigmatico che, non riconducibile a nessun trend, può<br />
essere solo interiore. E diamine se è profondo...<br />
(7/10)<br />
Carlo affatiGato<br />
zun zun eGui - katanG (Bella union,<br />
ottoBre 2011)<br />
Genere: rock<br />
Se volete possiamo parlare di ritmi africani, melodie esotiche<br />
e di tutti gli ammennicoli della world music come<br />
se fossero ancora suoni insoliti per le nostre orecchie.<br />
Ma le derive terzomondiste di certa musica, per fortuna,<br />
le abbiamo superate. Il mondo ormai ce lo abbiamo<br />
dentro casa e più che andarlo a cercare è lui che ci ha<br />
trovato, ha fatto all’amore con le nostre madri e ci ha<br />
reso tutti dei meticci culturali. Per parlare degli Zun Zun<br />
Egui non usiamo quindi, vi prego, il termine world ma<br />
parliamo semplicemente di rock. Tra prog, geometrie<br />
matematiche e funk spastico, i colori etnici dell’album<br />
sanno di esotico tanto quanto può esserlo mangiare<br />
sushi o kebab. Altro che esploratori con cappello d’ordinanza,<br />
bermuda corte e guida autoctona a condurli!<br />
Gli Zun Zun Egui sono i ragazzi che potete trovare al<br />
bar sotto casa, in tenuta hipster, pelle olivastra e occhi<br />
leggermente a mandorla. Che poi quel bar sotto casa sia<br />
in una città che tira fuori musicisti a ciclo continuo come<br />
Bristol certo aiuta. Con la naturalezza del campione, gli<br />
inglesini scombinano stili e geografia a poderosi colpi di<br />
bacino e macinano distanze con i piedi che si muovono a<br />
tempo di irresistibili danze sincopate. Il mondo è vicino,<br />
è scritto nei nostri geni e balla insieme a noi. Per averne<br />
conferma provate a sentire come le strade di una città<br />
inglese si trasformano in una giungla brulicante (Katang)<br />
o come le ballate pacifiche e serene da godersi al sole<br />
del mare dei Caraibi possano avere lo stesso effetto se<br />
ascoltate nel grigiume dei grattacieli inglesi (Dance Of<br />
The Crickets). Se ancora non siete convinti sentite come<br />
si mischiano blues e Maghreb (Mr. Brown) o come suonano<br />
i Primus quando giocano con i Monti Appalachi e<br />
il Corno d’Africa (Cowboy). Per averne la certezza forse si<br />
dovrà aspettare di vedere i Talking Heads cadere in un<br />
fumetto (Fandango Fresh).<br />
Katang è la giungla urbana della globalizzazione. Ci<br />
sono i sapori che si mischiano in gusti impensati, ci sono<br />
le musiche che si sovrappongono fino a trovare il modo<br />
di incastrarsi, c’è tutta la variegata cromaticità del nuovo<br />
millennio inoltrato. L’ambiente sonoro dell’Occidente è<br />
oggi pieno di tutto il mondo. Il rock è diventato ancora<br />
più bastardo. Se prima c’erano solo gli schiavi africani e<br />
i puritani inglesi, ora si fa prima a dire tra tutti i popoli<br />
della Terra chi non c’è rispetto a chi c’è. Gli Zun Zun Egui<br />
sembrano volerci dire tutto questo con un disco tutto<br />
impatto e freschezza.<br />
(7.5/10)<br />
franCeSCo aSti<br />
zweiSaMkeit - il Santuario Della Pazienza<br />
(SnowDonia, ottoBre 2011)<br />
Genere: electro avant<br />
Dal cilindro Snowdonia escono gli esordienti Zweisamkeit,<br />
trio salentino dal piglio DIY e il codice genetico<br />
strapazzato wave, neo-psichedelia, risonanze cosmiche<br />
e seriali kraute, vampe industrial, emulsioni ambient e<br />
vaticinio androide Warp. Comunque in grado, malgrado<br />
la complessità delle premesse, di produrre una calligrafia<br />
solida e coerente lungo la direttrice poetica che ondeggia<br />
tra il mistico e l’apocalittico. Per dire, in apertura<br />
di questo Il santuario della pazienza - titolo preso in<br />
prestito dall’opera scultorea in cemento e rifiuti dell’artista<br />
leccese Ezechiele Leandro, di professione spazzino<br />
- c’è una Limiti urbani che scomoda l’estro spirituale di<br />
Ivan Segreto in una glassa androide radiohediana, uno<br />
di quei pezzi - l’unico “cantato” del programma - che ti<br />
fanno stringere il bracciolo della poltrona e scomodare<br />
il prurito delle cose grosse.<br />
Il resto della scaletta non è altrettanto buono - altrimenti<br />
saremmo qui a gridare al capolavoro - ma è parecchio<br />
interessante, muovendosi come un sogno estatico Neu!<br />
(la stupenda Venezia) o un conato espressionista tra Autechre<br />
e Einsturzende Neubauten (La rinascente), palleggiando<br />
sparsa acidità nella inquietamente dispersiva<br />
L’alba degli anni Novanta. Se certe soluzioni sonore appaiono<br />
votate ad un’effettistica più sensazione che altro<br />
(certe sgasate Suicide, la chitarra e-bow vagamente CSI,<br />
l’iridescenza Terry Riley...) va detto però che pennellano<br />
un quadro d’insieme suggestivo, come sguardi successivi<br />
sullo sfacelo ambientale, civile ed emotivo consumato<br />
nei paesaggi urbani contemporanei.<br />
Ai margini della tela s’intravede un’ipotesi di riscatto,<br />
come un rivolgimento dell’anima, una salvifica implosione<br />
(forse riconducibile alla fuga dal mondo verso l’intimità<br />
di un ideale rapporto a due cui allude il termine<br />
tedesco zweisamkeit, malamente traducibile come “duitudine”):<br />
l’avverti come una vibrazione di fondo costante,<br />
un bordone quasi impercettibile, ed è l’ingrediente<br />
fondamentale.<br />
(7.1/10)<br />
Stefano Solventi<br />
94 95<br />
sentireascoltare.com
Gimme Some<br />
Inches #21<br />
Novembre non è il mese dei morti qui a GSI, quanto il mese delle<br />
cassette. Tra impro-noise, sound-sculptures, etno-psych, industrial<br />
e post-punk, la nostra consueta perlustrazione del sottobosco.<br />
Questo mese su Gimmes si va di<br />
tapes, redivive testimoni di un passato<br />
che non vuole morire. La Ultramarine<br />
di Silvia Kastel fa il “piccolo”<br />
passo e dopo una serie di ottimi vinili,<br />
pubblica i suoi primi nastri. Ad<br />
inaugurare è proprio la titolare che<br />
in Love Tape va di solo per synth e<br />
voce creando spettrali ambientazioni<br />
e evanescenze (Umine), ossessioni<br />
percussive (So White) in progressivo<br />
sfasamento/sfaldamento,<br />
post-punk tribaloide e alieno (Mrs<br />
A. d.) prima di smaterializzarsi su<br />
dimensioni vocali from outer space<br />
che fanno della Kastel non solo<br />
una lungimirante label-owner, ma<br />
anche musicista di primo piano in<br />
bilico tra impro, noise e gelide atmosfere<br />
haunted.<br />
L’altra tape è appannaggio di Marcello<br />
Magliocchi, percussionista e<br />
sound-artist già protagonista del<br />
catalogo Ultramarine con un lavoro<br />
a 4 mani con Ninni Morgia. Music<br />
For Sounding Sculptures In Twenty-<br />
Three Movements è esattamente<br />
ciò che il titolo prefigura: 23 bozzetti<br />
registrati in una torre presso<br />
Villa Castello Smilea a Montale (PT)<br />
in cui il musicista barese “suona” le<br />
sculture sonore create da Andrea<br />
Dami. Agglomerati materici/metallici<br />
(acciaio, ferro, alluminio più corde,<br />
sassi, ecc.) dalle forme sinuose e<br />
dalle modulazioni eterogenee che<br />
sotto le sapienti mani di Magliocchi<br />
assumono le forme del gamelan, del<br />
flusso impro-rumorista, della poliritmia<br />
afro-industriale, dell’ambient e<br />
droning. Mostrando come una sensibilità<br />
comune possa trovare forme<br />
espressive diverse, ma convergenti.<br />
Sulla falsariga di altri noisers nostrani,<br />
vedi alla voce Orfanado, anche<br />
Stefano Isaia, cantante e frontman<br />
dei Movie Star Junkies si butta<br />
sulla psych-world dagli umori mediorientali<br />
con La Piramide Di Sangue,<br />
esordio in cassetta sotto l’esoterico<br />
moniker di Gianni Giublena<br />
Rosacroce. Nel nastro edito dalla<br />
neonata Yerevan Tapes è possibile<br />
ascoltare cabalismo fatto musica e<br />
umori “altri” a go-go, tra clarinetti<br />
non invadenti, percussioni a far da<br />
tappeto, arabeschi di suoni acustici<br />
che si disperdono come fumi di<br />
narghilè tra casbah-sound e effluvi<br />
nord-africani. Interessante world<br />
music dall’appeal apocalittico.<br />
Candelora è, invece, il primo fulllength<br />
per Spettro Family a.k.a.<br />
Stefano Iannone, dopo il 7” Strigoi.<br />
Quello del nastro è un immaginario<br />
cinematografico evidente sin dai titoli<br />
delle tracce. Operazione Condor,<br />
1978 La Fuga, Post Partum e Ottobre<br />
Nero si muovono agilmente tra horror-sound,<br />
sci-fi e soundtrack per<br />
b-movies alienati mediante electro<br />
pagana, apocalyptic prog, aperture<br />
chiesastiche e synth-music mutante<br />
e vintage che richiama evidentemente<br />
i Goblin o certa soundtrackmusic<br />
italiana anni ’60 (Fabio Frizzi,<br />
in primis) ma lascia trasparire certe<br />
sonorità alla Vangelis virato Blade<br />
Runner o qualche estemporanea<br />
escursione in un pagan-folk di<br />
esclusiva matrice elettronica. Più<br />
che una traccia o un’altra è il senso<br />
del tutto a colpire per capacità evocative<br />
e per le atmosfere lugubri e<br />
spettrali ma credibili. Come a dire,<br />
molto più vicino a certe cose targate<br />
Not Not Fun (Umberto e Xander<br />
Harris, su tutti) che alla roba witchy<br />
tutte triangoli e poseurismi.<br />
Da segnalare anche due debutti<br />
per altrettanti gruppi dediti ancora<br />
una volta si suoni più oscuri e<br />
claustrofobici che gli anni Ottanta<br />
(e l’odierna rivisitazione) ci hanno<br />
regalato. Natural Assembly, il progetto<br />
solista di Jesse Cannon, è affine<br />
ai Cold Cave degli esordi (quelli<br />
dell’ottimo Cremations, ben prima<br />
che diventassero la brutta copia<br />
degli Editors), così come ai minori<br />
Lust For Youth e Contrepoison. Per<br />
chi fosse digiuno, parliamo di una<br />
wave minimale scandita da batterie<br />
(elettroniche, manco a dirlo) grezze<br />
e potenti, dove la voce distorta<br />
e filtrata si poggia su giri synth-pop<br />
di presa immediata. Ancora grezza<br />
la produzione, ma il bello è anche<br />
quello. Assai più dediti al culto delle<br />
chitarre (pesanti) gli americani<br />
Night Sins che rilasciano la prima<br />
tape per la loro stessa Dead Living.<br />
Tre pezzi per un quarto d’ora che<br />
più nero non si può: Christian Death,<br />
Killing Joke, Sisters Of Mercy e<br />
- perché no - Every New Dead Ghost<br />
et similia.<br />
Rimanendo in ambiti color pece va<br />
detto che nemmeno il Bel Paese si fa<br />
mancare niente. Per una volta infatti<br />
è un gruppo nostrano, più precisamente<br />
bolognese, a sbaragliare la<br />
concorrenza appena citata. Stiamo<br />
parlando degli Horror Vacui, nuovo<br />
quintetto nato da membri di band<br />
del giro hardcore/crust come Sumo,<br />
Kontatto e Campus Sterminii. Per<br />
loro un demo registrato in casa e distribuito<br />
in cd-r in cui si fanno subito<br />
notare per la qualità della proposta.<br />
Tetro goth-punk con un occhio per<br />
i riff melodici e un sing-along difficilmente<br />
resistibile. Inutile citare riferimenti:<br />
questi pezzi hanno i piedi<br />
(a cui stanno insindacabilmente dei<br />
boots alti e neri) solidamente piantati<br />
negli anni Ottanta del terrore<br />
per la World War III e per l’olocausto<br />
nucleare e sono una perfetta colonna<br />
sonora anche oggi che i timori e<br />
la angosce continuano a non mancare.<br />
Chapeau. Tornando invece<br />
negli States, da uno dei due gestori<br />
della californiana Kill Shaman nasce<br />
German Army, progetto solista con<br />
cui Julian si cimenta in un collage di<br />
suoni e citazioni di matrice schiettamente<br />
pre/post-industriale. Immaginate<br />
una serie di cartoline sonore<br />
in cui si affiancano a mo’ di collage<br />
la ritmicità magnetica dei Suicide, le<br />
bizzarrie compositive dei Residents,<br />
un pizzico di tribalismo fatto in casa<br />
sull’asse Not Not Fun e l’intimismo<br />
isolazionista dei Death In June più<br />
industrial. Incollate tutto e avrete<br />
Papua Mass: gli spunti ci sono tutti<br />
anche se forse la miscela finale è ancora<br />
da affinare, ma è solo la prima<br />
tape del nostro quindi non abbiamo<br />
fretta di dare giudizi netti.<br />
Stefano Pifferi, anDrea naPoli<br />
96 97
Re-Boot #20<br />
Una sottile linea rossa (bianca e verde) tra dream-pop e cantautorato.<br />
Scosse post-punk e schermaglie industrial. Benvenuto autunno.<br />
Per i bolognesi Guidos c’è una specie<br />
di juke box scanzonato e postpunkettone<br />
a fare da premessa seria<br />
di una proposta che scorre nel solco<br />
tra cazzonismo devoluto e malanimo<br />
strisciante. L’aspetto è quello di<br />
un divertissement tra amiconi, non<br />
è chiaro quanto possano (o vogliano!)<br />
farne una cosa seria: questo<br />
Avocado (Autoprodotto, 6.3/10), il<br />
loro secondo lavoro, è frutto dalla<br />
polpa ora insipida e un attimo dopo<br />
gustosa, nei suoi momenti migliori<br />
sciorina wave italica allampanata<br />
dal retrogusto che a tratti impasta<br />
Talking Heads, Dandy Warhols e<br />
Skiantos. Tutti con la ‘s’ finale, guarda<br />
un po’. Nei peggiori azzarda nostalgie<br />
Seventies con passo slacker<br />
con la profondita d’un Max Pezzali.<br />
Urgono decisioni dirimenti.<br />
Al Lago (ViVeriVive, 6.7/10) è il mini<br />
ep d’esordio di Faro, al secolo Stefano<br />
Faraon da Vittorio Veneto. Una<br />
calligrafia dream-wave virata lo-fi,<br />
un impasto fragrante di minimi ter-<br />
mini acustici, elettrici e sintetici per<br />
sfornare ballatine argute e sognanti,<br />
l’inquietudine intenerita dei Notwist<br />
più soffici ed il disagio a fior di pelle<br />
come un cugino malinconico (e<br />
melodioso) de I Cani. La situazione<br />
e’ ancore basale, ma ci sono gia’ sufficienti<br />
premesse per impostare un<br />
discorso di lunga durata.<br />
Un attimo prima di cadere nella<br />
trappola De André, che il cantautorato<br />
lo spedisce in un buco nero<br />
da cui pochi possono permettersi di<br />
uscire, semmai guardando alla visione<br />
languida dei Faust’O e alla poesia<br />
cerebrale di Mario Castelnuovo,<br />
c’e questo omonimo ep (ViVeriVive,<br />
6.8/10) del veneto Rodolfo Toé,<br />
febbricola contemporanea sedata a<br />
forza di nostalgie sfrigolanti seventies,<br />
vaghezza lo-fi e vampe noisepsych<br />
che diresti tra Eno e Canali.<br />
Costantemente aggrappato ad una<br />
tensione che non lascia posto ad<br />
ironia di sorta nel flusso ossessivo<br />
dei correlativi emotivi, cantati tal-<br />
Un mese di ascolti<br />
emergenti italiani<br />
volta in punta d’esasperazione Vasco<br />
Brondi talaltra rammentando il<br />
lirismo acidulo del dimenticato Erz.<br />
Terzo disco autoprodotto per Martin<br />
Devil - ovvero Maurizio Guglielmelli<br />
-, un artista capace di spaziare<br />
con disinvoltura tra canzone d’autore,<br />
folk americano, rock e melodia.<br />
Vintage (Zimbalam, 6.7/10) è<br />
un’opera matura, in cui si mescolano<br />
malinconie alla Celentano prima<br />
maniera (Sogni) e un De Gregori in<br />
bilico tra slide guitar e organi (Pioggia<br />
di velluto), monografie elettriche<br />
à la Dire Straits (Strade) e certe balere<br />
sudamericane del Capossela<br />
delle origini (Parole d’amore). Manca<br />
forse un po’ di sintesi, a brani che<br />
comunque mostrano un equilibrio<br />
invidiabile e un approccio alla scrittura<br />
che conquista senza fare sconti.<br />
Ambient kafkiana sospesa in un<br />
crepitante incombere e codificata<br />
da un fluire vagamente industriale:<br />
un suono fatto di sfondi ininterrotti<br />
e primi piani malinconici su<br />
pianoforti, laptop, synth e chitarre<br />
trasfigurate. E’ espressionismo sonoro<br />
a microfoni aperti The Silent<br />
Bride (Laverna, 7.1/10) dei calabre-<br />
si Sentimental Machines (Attilio<br />
Novellino, Gianfranco Candeliere,<br />
Saverio Rosi), talmente efficacie da<br />
convincere pur non rappresentando<br />
un esempio di rottura con gli stilemi<br />
più tradizionali del genere. Reading<br />
e fondali concreti (Avril, We’ll Never<br />
Win), lentezze descrittive e intense<br />
fughe spazio-tempo, per una formazione<br />
da tenere sotto stretta osservazione.<br />
Un pop piccolo piccolo, che ha<br />
molto da apprendere, ma affascina<br />
nelle sue atmosfere retrò, fra liriche<br />
intime e chitarre arpeggiate.<br />
I Penny Press da Avellino giocano<br />
a fare i neo cantautori, come capita<br />
spesso ultimamente, ed escono con<br />
un disco omonimo (autoprodotto,<br />
6.0/10) che riscalda le atmosfere invernali.<br />
Voce maschile, imponente<br />
e piccoli inserti di una bella voce<br />
femminile. E’ vero, a volte forzano<br />
troppo il tutto (tendono ad una<br />
strana commistione fra Vasco Brondi<br />
e Dente), ma s’intuisce una certa<br />
apertura di stile, che potrebbe<br />
fruttare.<br />
Tutt’altro ambiente e background<br />
quello dei bolognesi Around A. Il<br />
loro sound è infarcito di una manciata<br />
di melodie, ben condite dalle<br />
liriche in lingua, che rende il loro<br />
pop debitore di armonie scandinave<br />
(King of Convenience, ma<br />
non solo ). Four is Not A Number<br />
(Skpmz, 6.5/10) è il nuovo Ep, che<br />
parte piano sugli arpeggi di Day By<br />
Day e cresce in chiave synth pop in<br />
The Bridge, magnifica ballata in stile<br />
Coldplay. Belli gli arrangiamenti<br />
per una produzione che mira ad un<br />
sound potenzialmente internazionale.<br />
Stefano Solventi<br />
faBrizio zaMPiGhi<br />
nino CiGlio<br />
98 99
R e a r v i e w M i r r o r<br />
— s p e c i a l e “Nessuno è ancora riuscito a cantare un epos di pace -<br />
constata amaramente Curt Bois in una scena de Il cielo<br />
sopra Berlino di Wim Wenders - cosa c’è in essa che non<br />
entusiasma a lungo?”.<br />
La risposta potrebbe avercela fornita Erich Fromm<br />
che, nel saggio Psicoanalisi dell’amore, evidenzia come<br />
la società moderna sia portata dal suo stesso spirito<br />
generativo a una regressione denominata Sindrome di<br />
Decadimento, la quale consiste nella fascinazione verso<br />
comportamenti, nel senso lato del termine, “necrofili’.<br />
All’opposto, viene identificata la Sindrome di Crescita, in<br />
cui l’individuo sviluppa la propria capacità di liberazione<br />
Paul Winter<br />
Jazz biofilo per la Nuova Era<br />
Massimo compositore dei generi World Music e New Age, Winter è jazzista destinato<br />
a una profonda rivalutazione; ne indaghiamo primati e successi, avvalendoci<br />
della sua testimonianza diretta per SA.<br />
Testo: Filippo Bordignon<br />
dai meccanismi necrofili pervenendo a un atteggiamento<br />
“biofilo’, tradotto in uno stile di vita (e, di riflesso, di<br />
Pensiero) più aderente con la Natura e le sue leggi, sia<br />
quelle scoperte attraverso il progresso scientifico che<br />
quelle “derivate’, responsabili cioè del conio delle principali<br />
religioni e di alcune filosofie.<br />
Sotto un profilo musicale, un tentativo biofilo di<br />
egregia levatura artistica ci è fornito dal compositore<br />
statunitense Paul Winter (1939, Altoona); attraverso la<br />
sua carriera infatti, egli ha contribuito alla costituzione<br />
di uno stile oggi noto come World Music, per poi finire<br />
etichettato nella discutibile sezione della così detta<br />
“New Age music’. Sfortunatamente, l’identificazione con<br />
l’omonimo movimento pseudo-culturale, ne ha relegato<br />
la discografia nel calderone di un genere considerato<br />
dai più buono come sottofondo per una seduta di massaggio<br />
rilassante. Il disinteresse dell’intellighenzia massmediatica<br />
e lo snobismo di certo jazz-che-conta, sono<br />
stati in grado di seppellirne per anni meriti e primati.<br />
Ripercorrendone la nutrita produzione però, risultano<br />
innegabili intuizioni formali e di concetto che lo confermano<br />
nei panni di compositore apripista, fedele a uno<br />
stile evolutosi alla fonte della perpetua contaminazione<br />
culturale, per dimostrare coi fatti e non coi manifesti la<br />
possibilità di una musica dimentica di categorie e distanze<br />
geografiche.<br />
L’avventura professionale di Winter si apre senza una<br />
gavetta eccessiva; Chicago, 1961, il suo gruppo si aggiudica<br />
il primo premio in un concorso rivolto alle college<br />
band: tra i membri della giuria John Hammond, produttore<br />
discografico che quello stesso anno assicura al giovane<br />
musicista un contratto con la Colombia. Si comincia<br />
perciò con l’album omonimo del neonato Paul Winter<br />
Sextet, primo di cinque lavori per la storica etichetta di<br />
Miles Davis e Bob Dylan, nei quali il nostro ha modo di<br />
farsi le ossa col jazz tradizionale. In formazione, oltre allo<br />
stesso Winter che qui si alterna tra sax alto e soprano,<br />
batteria, contrabbasso, pianoforte, tromba e sax baritono,<br />
soluzione questa, in linea con il trend bianco del<br />
momento (Gerry Mulligan in testa). La proposta è un<br />
sound “californiano’ in bilico tra west coast (la tendenza<br />
a una rigidità ritmica stemperata da una morbidezza<br />
melodica definite “cool’) ed east coast (soprattutto nella<br />
velocità d’esecuzione, derivata dal bebop). Il risultato è<br />
una raccolta swingante e ben suonata, prodotto raffinato<br />
al punto da coinvolgere anche i non appassionati<br />
al genere.<br />
Il sestetto si qualifica così per uno scambio culturale<br />
promosso dal Dipartimento di Stato che coinvolge America<br />
del Nord e del Sud, imbarcandosi per una tournée<br />
di sei mesi in America Latina: 160 concerti in 23 Paesi.<br />
Registrato tra Rio de Janeiro e New York, Jazz Meets<br />
The Bossa Nova (’62) è il primo incontro ufficializzato da<br />
un’uscita discografica tra jazz e il neonato movimento<br />
bossanova, battendo per una manciata di settimane il<br />
comunque più meritevole Jazz Samba di Stan Getz e<br />
Charlie Byrd. Le rivisitazioni di classici come il toccante<br />
Chega De Saudade, più che alla malinconia delle versioni<br />
originali, formulano un frizzante jazz latino che trascura<br />
il mood “saudade’ per concentrasi su ritmiche mutuate<br />
dalla samba. Il ritorno in patria odora di trionfo, con la<br />
first lady Jackie Kennedy che invita i nostri a esibirsi -<br />
primo gruppo jazz nella storia - presso la Casa Bianca.<br />
Intenzionata a battere il ferro finch’è caldo, la Columbia<br />
ne approfitta per lanciare sul mercato, nel 1963, altri<br />
tre lavori di facile ascolto e buona fattura: Jazz Premiere:<br />
Washington (nel quale segnaliamo il lodevole<br />
standard The Thumper), New Jazz On Campus (con alcuni<br />
rimaneggiamenti nella line-up che non sortiscono particolari<br />
scossoni) e Jazz Meets The Folk Song.<br />
A questo punto Winter sente l’esigenza di un cambiamento<br />
e, interessato ad approfondire il suo amore per la<br />
bossanova, scioglie il sestetto e si trasferisce per un paio<br />
d’anni in Brasile. L’idea si rivela lungimirante: affiancato<br />
da musicisti indigeni e dal cantante e paroliere Carlos<br />
Lyra, il compositore se ne esce con l’ottimo The Sound<br />
Of Ipanema (’65, Columbia), contenente brani in cui il<br />
mood acquatico del sax sposa mirabilmente il talento<br />
di Lyra (un esempio su tutti, Maria Ninguem). Lodato da<br />
istituzioni nazionali come il cantante e poeta Vinicius de<br />
Moraes, Winter bissa il buon successo di vendite di The<br />
Sound con lo strumentale Rio (’66), ultima godibilissima<br />
prova per la Columbia.<br />
Di ritorno negli States, l’incontro col cantautore attivista<br />
Pete Seeger sarà determinante per la maturità<br />
artistica del buon Paul: inteso l’amore del nostro per il<br />
viaggio come concetto filosofico e possibilità di arricchimento<br />
culturale, Seeger lo incoraggia a elaborare un<br />
progetto originale, veleggiando tra stili provenienti da<br />
ogni parte del mondo. È questo il manifesto mai scritto<br />
100 101
alla base del Paul Winter Consort, ensemble che debutta<br />
con un album omonimo per la A&M nel 1968. La<br />
prova prima azzarda una strumentazione distante dal<br />
jazz degli esordi comprendendo percussioni africane,<br />
corno inglese, flauto, violoncello e chitarre. Il repertorio<br />
è quanto mai eclettico, mischiando proposte commerciali<br />
(la Joni Mitchell di Both Sides Now) al trotto vivace<br />
di una danza italiana del 13simo secolo. Ispirato dall’atmosfera<br />
di libertà che si respirava al tempo, Winter itera<br />
l’impresa l’anno successivo con Something In The Wind<br />
(A&M), riscrivendo il folk di Fred Neil (Everybody’s Talkin’)<br />
e riarrangiando con mestiere capisaldi quali Bach, Ravel<br />
e Ives.<br />
Il primo masterpiece è frutto di un cambio di formazione<br />
(su tutti, l’ingresso del chitarrista classico Ralph<br />
Towner). Road (’70, A&M) vanta in apertura quella Icarus<br />
che diventerà il brano più richiesto del Consort, in virtù<br />
di uno straordinaria capacità compositiva (Towner) e di<br />
arrangiamento. Pur palesando le radici occidentali dei<br />
suoi esecutori, Icarus rilascia profumi di libertà che vengono<br />
dall’oriente, sostenuta dai tocchi di tabla di Collin<br />
Walcott e resa emozionante dalla sintonia tra l’oboe di<br />
Paul McCandless e il violoncello di David Darling. Um<br />
Abraço è trionfo di poliritmie (la grande lezione della<br />
samba) sulle quali flettono i muscoli della propria sensibilità<br />
sax e oboe. Ave Maria Stella-Andromeda è sapiente<br />
equilibrio di composizione e improvvisazione, col violoncello<br />
ad azzardare dissonanze e la voce che concede<br />
scampoli quasi free. La forma viene dunque abbandonata<br />
brevemente su Come To Your Senses, per poi ripigliare<br />
il bandolo della comunicatività nello straziante Requiem<br />
dedicato ai soldati morti in Vietnam. Africanus Brasileiras<br />
Americanus inizia prendendo a prestito certi moduli tematici<br />
del minimalismo di Terry Riley per chiudere in<br />
bellezza complicando la struttura e riassumendo tutta la<br />
grandezza di una raccolta godibile ma profonda, gioiosa<br />
ma non esaltata. A rimarcare il successo in patria della<br />
strada fin qui percorsa, l’anno successivo la Nasa utilizza<br />
Road come colonna sonora per gli astronauti durante<br />
l’allunaggio dell’Apollo 15; in quell’occasione, due crateri<br />
vengono battezzati coi nomi di brani dell’album: Ghost<br />
Beads e Icarus.<br />
Icarus (’72, Epic) è anche il nome della più celebrata<br />
fatica da studio del Consort, prodotto da quel George<br />
Martin che, nonostante il lavoro nell’arrangiamento e<br />
missagio per i Beatles in capolavori quali Sgt. Pepper’s<br />
e Abbey Road, dichiarò “Questo è il migliore progetto<br />
su cui abbia mai messo le mani”. Le nove tracce che lo<br />
compongono si attestano con infinita naturalezza come<br />
il primo e tra i più meritevoli esempi di world music,<br />
nell’accezione di una musica apolide che assorbe intui-<br />
zioni e modalità da ogni tradizione senza bastardizzarsi<br />
su questa o quella bandiera. Ode To a Fillmore Dressing<br />
Room e il raga occidentalizzato Juniper Bear (si ascolti<br />
il miracoloso dialogo chitarra-percussioni) parlano il<br />
linguaggio di un’India riletta con rispetto ma elevata<br />
dall’abilità tecnica di professionisti fregati alla scena<br />
jazz. Ne è esempio aggiuntivo il groove mozzafiato in<br />
Sunwheel, chiacchierata accesa della sezione ritmica con<br />
le tastiere. The Silence Of A Candle è nientemeno che la<br />
migliore canzone dell’intero repertorio, merito della voce<br />
impalpabile di Towner e di un testo baciato da una poetica<br />
affatto retorica. In Icarus tutto pare calcolato al punto<br />
da risultare naturale: ogni composizione contiene momenti<br />
solisti per tentare nuove dinamiche (Whole Earth<br />
Chant, punta di diamante per il violoncello di Darling) e<br />
ogni dinamica tiene alta la concentrazione di un gruppo<br />
di musicisti in cui non prevalgono le personalità, se non<br />
a fini collettivi. Si chiude con l’esecuzione di un mantra<br />
universale, Minuit, riadattamento di un pezzo dell’africano<br />
Keita Fodeba e canzone della speranza dipinta coi<br />
colori dell’alba.<br />
Appresa la lezione del maestro, Towner, Walcott e Mc-<br />
Candless lasciano per formare gli Oregon, sottovalutata<br />
formazione di space & word music, di molto debitrice<br />
dall’esperienza nel Consort ma responsabile di un sound<br />
più esoterico, ben rappresentato nelle uscite di metà<br />
Anni ’70 Distant Hills e Winter Light.<br />
Nel frattempo, Paul ne approfitta per ripensare il suo<br />
percorso artistico, estremizzando la componente ecologista<br />
e giungendo a un album (non dichiaratamente)<br />
concept, che contiene una delle sue più meritorie intuizioni:<br />
l’ispirazione, per i propri assoli, dal canto degli<br />
animali. Common Ground (’77, A&M) sarà dunque<br />
raccolta live di inediti che, sorpassati i manierismi della<br />
stucchevole soundtrack, consegna i capolavori Ocean<br />
Dream (in duetto col canto di una balena), Eagle (l’aquila)<br />
e Wolf Eyes (il lupo, uno dei vertici espressivi di ciò che<br />
qualche anno dopo sarà battezzata “New Age Music’). Il<br />
rimanente è una world-fusion di ottima fattura (The Promise<br />
Of A Fisherman), capace di non suonare mai come<br />
riempitivo.<br />
Winter si era innamorato di una registrazione dell’oggi<br />
inflazionatissimo canto delle balene già nel 1958 (si<br />
consiglia l’acquisto del classico Songs Of The Humpback<br />
Whale): a stupirlo, la scoperta che questi cetacei producono<br />
“pattern’ lunghi fino a 30 minuti, che sono capaci<br />
di replicare perfettamente dall’inizio alla fine. Non solo:<br />
tutte le balene di una certa zona, si evinse da studi specifici,<br />
tendono a riprodurre lo stesso tema (quasi fosse la<br />
hit del momento) il quale viene prontamente sostituito,<br />
l’anno successivo, da una ‘canzone’ diversa, a sua volta<br />
102 103
assimilata e riprodotta fedelmente dai vari individui. La<br />
musica, dunque, come possibilità comunicativa fondamentale<br />
per lo sviluppo della vita sociale, funzionalità<br />
questa che avevamo smarrito, negli anni del punk.<br />
L’atmosfera si fa ancor più dilatata in Callings (’80,<br />
esordio dell’etichetta fondata dal nostro, la Living Music,<br />
per la quale usciranno gli album successivi), derivato<br />
dallo studio delle voci di mammiferi marini. Si segnalano,<br />
oltre alla commovente Lullaby From The Great Mother<br />
Whale, due episodi formalmente desueti rispetto al feeling<br />
di Winter: l’atonale Sea Storm e l’enigmatica Blues<br />
Cathedral dove fa il suo ingresso il tastierista Paul Halley,<br />
da allora fedelissimo negli album del compositore di Altoona,<br />
fino ai giorni nostri.<br />
Con Missa Gaia/Earth Mass (’82) si da il via a un modus<br />
che intende sfruttare l’acustica naturale di ambienti straordinari<br />
(in questo caso la mastodontica Cattedrale di St<br />
John the Divine, a New York); bignami dell’estetica <strong>winter</strong>iana,<br />
Missa Gaia è lavoro su commissione che afferma<br />
“La sacralità della Terra, nella sua totalità”. Enfatica quel<br />
tanto da divenire un appuntamento annuale (la prima<br />
domenica di ottobre, presso St John), l’opera è prodotto<br />
tronfio di una retorica spesso zuccherosa, appesantita<br />
dal coro e dalla voce solista fastidiosamente cristallina<br />
di Susan Osborn.<br />
Con Sun Singer (’83) si torna alla semplicità, in trio,<br />
per omaggiare il Sole; abbandonandosi alla dolcezza<br />
evocativa del proprio strumento, Winter perviene ai delicati<br />
acquerelli Heaven Within e Reflections In A Summer<br />
Pond, tentando soluzioni di sorprendente originalità con<br />
Dancing Particles.<br />
Concert For The Earth (’85), registrazione di un concerto<br />
tenuto davanti alla Assemblea Generale delle Nazioni<br />
Unite, figura come una sorta di greatest hits live, con<br />
il Consort affiancato da un coro gospel di 80 elementi<br />
nell’ampollosa Sound Over All Waters.<br />
Canyon (’85) è un meritatissimo successo commerciale,<br />
suonato in quattro session di rafting/improvvisazione<br />
sonora lungo il fiume Colorado. La risultante è un<br />
ammirevole esercizio di misura e una celebrazione della<br />
Natura unica nel suo genere. A sottolineare la spiritualità<br />
non religiosa dell’operazione, l’organo a canne di Halley<br />
e il corno francese di John Clark, caricato di un’epica universale<br />
su Bedrock Cathedral.<br />
Il sottovalutato Wintersong (’86) torna alla formula di<br />
Jazz Meets The Folk Song, riarrangiando melodie di canzoni<br />
folcloristiche europee e nord americane con risultati<br />
ancor più piacevoli rispetto alle registrazioni del Sextet.<br />
L’87 è l’anno di due uscite discografiche davvero<br />
inusuali. Whales Alive propone letture da autori miscellanei<br />
dedicate alle balene avvalendosi della voce<br />
dell’attore <strong>Leon</strong>ard Nimoy (proprio lo Spock di Star<br />
Trek), alternate alle commoventi improvvisazioni di sax<br />
e tastiera (Winter e il fido Halley). Earthbeat è invece<br />
la prima opera pensata e arrangiata a quattro mani da<br />
artisti statunitensi e russi, operazione intenzionata a<br />
contribuire al di-scioglimento della Guerra Fredda tra le<br />
due superpotenze. Il fatto più sorprendente è l’estrema<br />
omogeneità di questo incontro, con le algide armonie<br />
dell’Est mischiate alle influenze afro-brasiliane del Consort<br />
in un approccio assai peculiare capace di riscrivere<br />
tradizioni millenarie diametralmente opposte tra loro.<br />
L’esempio più eclatante è il pezzo di origine cosacca The<br />
Horse Walked In The Grass, in cui la soavità dei musicisti è<br />
cavalcata dall’impeto energizzante del coro The Dimitri<br />
Pokrovsky Singers.<br />
Il nuovo decennio vanta una commissione di prestigio<br />
con tanto di premiere a Time Square, per onorare i<br />
vent’anni dell’Earth Day: Earth - Voices Of A Planet (’90) si<br />
qualifica raccolta gioiosa ma trascurabile, riscattata sul<br />
piano dell’originalità dalla sola Call Of The Elephant, interazione<br />
del flauto con la registrazione in sottofondo della<br />
voce di un elefante. Seguono due lavori che abbinano<br />
letture a intermezzi musicali sulla falsariga di Whale Alive:<br />
The Man Who Planted Trees (’90) è incentrata sul racconto<br />
omonimo dello scrittore francese Jean Giono; Turtle<br />
Island (’91) intervalla alle impro letture del premio Pulitzer<br />
per la poesia Gary Snyder. Spanish Angel (’93) mette<br />
in luce uno degli organici più affiatati per il Consort,<br />
testimonianza di una frizzante tournée in Spagna che<br />
si distingue se non altro per l’ennesimo Grammy nella<br />
categoria “New Age’ (attualmente, si contano sei vittorie<br />
della prestigiosa statuetta a forma di grammofono).<br />
Nell’ipertrofica discografia <strong>winter</strong>iana fa capolino a<br />
questo punto la prima di alcune trascurabili registrazioni<br />
live dedicate ai festeggiamenti dei solstizi estivo e invernale,<br />
appuntamenti in cui la Natura ricorda all’uomo il<br />
proprio orologio interno e suoi fenomeni conseguenti:<br />
Solstice Live! (’93), Celtic Solstice (’99) Journey With The<br />
Sun (2000), la raccolta a tiratura limitata di editi e inediti<br />
Solstice Gems (“02) e Silver Solstice (’05) sono registrazioni<br />
di concerti solitamente integrati con balletti, performance,<br />
lights show e installazioni varie, assemblati da<br />
pezzi noti e aggiunte non proprio imperdibili.<br />
Prayer For The Wild Things (’94) ha il merito di rappresentare<br />
l’inizio di un processo di astrazione che recupera<br />
la freschezza degli album storici: ispirato alle immagini<br />
della pittrice Bev Doolittle, Prayer va inteso come viaggio<br />
immaginifico che parte dall’alba e termina all’alba<br />
del giorno successivo nella cornice ambientale delle<br />
Montagne Rocciose. Pur nel dispiego di tante generose<br />
ospitate, l’album si attesta episodio felicemente medita-<br />
104 105
tivo e asciutto. L’estremizzazione di questa semplicità è<br />
il doppio Canyon Lullaby (’97), placidamente costituito<br />
dalla sola presenza del sax, il quale improvvisa fraseggi<br />
in bilico tra abbandono estatico e sonnolenza.<br />
Brazilian Days (’98) sancisce un momentaneo ritorno<br />
alla bossanova con selezioni strumentali da Jobim,<br />
Pinto, Lyra e De Moraes, in coppia col chitarrista Oscar<br />
Castro-Neves. Più che alla pregevole capacità interpretativa<br />
di Castro-Neves (si ascolti la progressione di<br />
accordi in Aula De Matemática) è il sound di Winter a<br />
tenere banco.<br />
Per venire ai giorni nostri, la giovinezza artistica del<br />
compositore statunitense è confermata da due titoli di<br />
alta caratura: in primis Crestone (’07) “evocato” più che<br />
suonato, utilizzando la suggestiva location omonima<br />
del Colorado, a 3.500 metri sopra il livello del mare. Con<br />
Miho: Journey To The Mountain (’10) si utilizza un’ambientazione<br />
artificiale, impiegando le possibilità acustiche di<br />
questo museo sito a Kyoto come se fosse un vero e proprio<br />
organismo vivente, ottenendo un nuovo vertice di<br />
rarefazione evidente nelle trasparenze sonore Morning<br />
Sun e Koto Spring.<br />
In veste di produttore e ospite negli album degli artisti<br />
della Living Music, Winter può vantare un’attività<br />
prolifica ma fedele al proprio stile, contribuendo alle<br />
ottime prove soliste di colleghi e compagni di Consort<br />
e pervenendo a risultati lusinghieri con la produzione<br />
di Pete (’96) per l’amico Segeer, premiato come migliore<br />
album folk con l’ennesimo Grammy. Nella folta mischia,<br />
consigliamo almeno il sentimentale Angel On A<br />
Stone Wall (’91) di Paul Halley e Arms Around You (’89),<br />
esordio in proprio di Eugene Frisien con un gioiellino<br />
romantic-fusion.<br />
“Oh terra che non hai voce, a me confida una voce<br />
- auspicava il poeta Walt Whitman, nella sua opera monumentale<br />
Foglie d’erba - ( ) Oh bruna terra copiosa di<br />
parti, oh grembo che bulichi all’infinito, un canto per<br />
celebrarti”. Con la testimonianza del proprio operato,<br />
Paul Winter si è rivelato, in oltre quarant’anni di carriera,<br />
l’umile ma principale cantore del Pianeta Terra, fornendoci<br />
una chiave di lettura davvero alternativa alla<br />
composizione/improvvisazione rispetto a come ce l’ha<br />
sempre indicata, pur nei suoi tanti mutamenti, il jazz comunemente<br />
inteso.<br />
L’intervista<br />
Paul, che consigli offriresti a un musicista alla ricerca<br />
della propria ‘identità’?<br />
Sperimento spesso delle session che chiamo “Avventure<br />
immersi nel suono’. Vediamo se riesco a spiegarmi:<br />
questi appuntamenti sono aperti a ogni persona, indipendentemente<br />
dalla capacità musicale; l’intenzione<br />
è far interagire tra loro tutti i componenti, i quali sono<br />
chiamati a improvvisare al buio, al fine di rendere più<br />
facile liberarsi dalle inibizioni e generare dei suoni insieme.<br />
Ciò è concepito per aiutare le persone a risvegliare<br />
la propria talvolta assopita consapevolezza e affermare<br />
con forza la potenzialità espressiva di ogni singolo<br />
elemento, che in seguito può essere utilizzata per fare<br />
musica, letteratura o anche solo per imparare a parlare<br />
in pubblico o affrontare altri ambiti difficili della vita. È<br />
mia ferma convinzione che l’espressione di sé stessi sia<br />
un diritto inalienabile e che ognuno di noi (sia esso un<br />
artista, un matematico o che altro) ha una sua “canzone’<br />
unica e irripetibile da cantare. Ciò che è necessario<br />
capire è che il mondo ha bisogno della nostra canzone<br />
specifica e non della scopiazzatura da quella di un altro:<br />
non c’è bisogno di una seconda edizione di Miles Davis<br />
o del violinista Jascha Heifetz. Se impariamo a essere<br />
noi stessi potremo contare sul fatto che nessuno riuscirà<br />
mai a imitare o rubare la nostra canzone, poichè noi ne<br />
siamo i massimi interpreti. A quel punto si evince anche<br />
l’insensatezza della competizione. L’espressione di noi<br />
stessi è la principale ricompensa che ci è concessa, il fine<br />
ultimo. Darsi e non trattenere. A giochi fatti, i vincitori<br />
saranno quelli che si sono spesi per cantare la propria<br />
canzone con onestà e generosità, non quelli che hanno<br />
dannato la loro vita per accumulare soldi e fama.<br />
Com’è cambiato, nel corso degli anni, il tuo approccio<br />
all’improvvisazione?<br />
Con il sestetto, nei primi Anni ’60, improvvisavo seguen-<br />
do le modalità del bebop, pur aspirando a mantenere<br />
ben evidente la mia propensione verso la melodia. Dalla<br />
seconda metà dei ’’60, vivere in Brasile e riscoprire la<br />
musica che mi circondava quand’ero piccolo e vivevo<br />
ancora ad Altoona, mi ha portato gradualmente a concentrarmi<br />
sulla creazione di melodie originali, lasciando<br />
ad altri la frequentazione di palestre per virtuosi.<br />
Sotto un profilo tecnico, cosa ti ha insegnato la bossanova?<br />
Ricordo ancora la notte che ascoltai per la prima volta<br />
l’album di Joao Gilberto Chega De Saudade. Ero a Chicago,<br />
nel ’62. Mi fece una fortissima impressione quella<br />
straordinaria progressione di accordi che andava a formare<br />
una musica fluttuante, cantata con gentilezza e<br />
una sorta di pacificazione. Prima di allora ero completamente<br />
assorbito in un mood, quello del bebop, che<br />
prevedeva volume alti. Stavamo appunto per imbarcarci<br />
in una tournée in America Latina organizzata dal<br />
Dipartimento di Stato ed era compreso anche un mese<br />
in Brasile. In quell’occasione incontrai la comunità della<br />
bossanova: fu per me una seconda nascita culturale. La<br />
prima era stata aver fatto parte della comunità jazz del<br />
versante sud di Chicago, tra il 1957 e il ’61.<br />
Quali sassofonisti hanno influenzato il tuo sound?<br />
Sono innamorato da sempre del sax come strumento,<br />
in buona parte in virtù della molteplicità delle sue voci;<br />
credo di poter identificare almeno un centinaio di sassofonisti<br />
riconoscendone il timbro al primo ascolto. Se ti<br />
dovessi elencare tutti quelli che mi hanno “dato’ qualcosa<br />
non basterebbe una giornata. Nonostante ciò, immagino<br />
vorrai comunque alcuni nomi. Gli imprescindibili sono,<br />
nei miei anni di formazione, il clarinetto di Benny Goodman,<br />
Phil Woods, Cannonball Adderley, ovviamente<br />
Charlie Parker, Stan Getz e Paul Desmond.<br />
Cosa ti ha spinto a scegliere proprio il soprano?<br />
Ho cominciato prestissimo con il clarinetto poi, a nove<br />
anni, i miei genitori mi comprarono un sax alto... non gli<br />
ho mai chiesto perché proprio quello e non, chessò, un<br />
tenore. Effettivamente non ci avevo mai riflettuto. Sono<br />
passato al soprano compiuti i ventun’anni anni: mi piaque<br />
subito moltissimo e per un po’ li alternai. Poi preferii<br />
specializzarmi in un fiato soltanto, per padroneggiarlo al<br />
meglio delle mie possibilità e scelsi il soprano. La ragione<br />
sta nel fatto che dal mio punto di vista è progettato<br />
meglio, quando si tratta di suonare in un ensemble e<br />
anche perché ci puoi giocare di più suonando in spazi<br />
sconfinati. Aggiungici anche che sta giusto giusto dentro<br />
uno zaino<br />
Quali sono gli album imprescindibili per tracciare il<br />
cammino evolutivo della tua vita artistica?<br />
Sto dando una scorsa alla mia discografia: al di là da ogni<br />
106 107
etorica credimi se ti dico che questi album sono davvero<br />
come figli per me e li amo tutti allo stesso modo. E come<br />
fai a scegliere tra i tuoi figli? Riascoltandoli, ciascuno mi<br />
procura la stessa gioia dell’altro, per motivi certamente<br />
diversi. Mettiamola così: la mia fortuna in questo senso<br />
è di non aver mai registrato nulla che non mi entusiasmassero<br />
totalmente.<br />
Quali sono gli album con la più intensa carica di spiritualità<br />
che tu abbia mai ascoltato?<br />
Per assurdo, le composizioni che trovo più spirituali<br />
hanno volume belli pieni: amo profondamente i tre<br />
capolavori realizzati da Gil Evans in collaborazione con<br />
Miles Davis negli Anni ’50 e dunque Miles Ahead, Porgy<br />
And Bess e Sketches Of Spain. Ma non posso tralasciare le<br />
musiche composte da Bach, Béla Bartok, Heitor Villa-<br />
Lobos e Charles Ives, forse il primo grande compositore<br />
nord-americano.<br />
Miles però ebbe a dichiarare: “I bianchi suonano in<br />
un certo modo: per dare il ritmo, si appoggiano sulle<br />
note”. Considerazione che trovo molto significativa.<br />
Non ho idea di cosa intendesse Miles. Se voleva dire che<br />
i jazzisti bianchi suonano sempre in un certo modo, beh,<br />
mi sa che è stato frainteso. Non credo proprio che la vedesse<br />
così e, a ogni modo, io non lo penso di certo.<br />
E poi senti questa di Stravinsky: “Un buon compositore<br />
non scimmiotta nessuno, si limita a rubare”.<br />
Ecco, sono d’accordo invece sul fatto che tutto ciò che<br />
possiamo concepire e suonare è enormemente influenzato<br />
dal patrimonio musicale elaborato da quelli che ci<br />
hanno preceduto.<br />
Sogni: con quali personaggi del passato avresti amato<br />
suonare?<br />
Pescando nel diciannovesimo secolo avrei amato far<br />
parte della banda del compositore tardo-romatico John<br />
Philip Sousa. E per il ventesimo secolo scelgo sicuramente<br />
Stan Kenton e la sua orchestra.<br />
Crisi del mercato discografico: chi si salverà?<br />
Ogni musicista dovrebbe ingegnarsi per trovare quella<br />
strada che renda le sue opere di una qualche incontrovertibile<br />
utilità per il mondo in cui vive (al di là dei dettami<br />
dell’arte e dell’intrattenimento): solo allora potrà<br />
dirsi al riparo dai predatori che hanno spolpato questo<br />
business dedicandosi all’individuazione e confezionamento<br />
del minimo comune denominatore per irretire<br />
attraverso una musica sottosviluppata le menti più facili<br />
da plasmare, cioè quelle dei ragazzini.<br />
Che ti ha insegnato, ascoltare il canto degli animali?<br />
Spero valga anche se non ricordo chi l’ha detto: “Le foreste<br />
sarebbero davvero silenziose se a cantare fossero<br />
soltanto i migliori”.<br />
E dagli animali all’uomo: quali le voci che potrebbero<br />
rappresentare al meglio la nostra razza?<br />
S u t u t t i , Frank S i n a t r a , l ’ a r m e n o A r t o<br />
Tunçboyacıyan (prova ad ascoltare il suo Every<br />
Day Is A New Life), Gordon Bok e la voce cristallina<br />
dell’irlandese Karan Casey. C’è poi una donna pigmea,<br />
si chiama Emilie Koule, che ha delle doti interpretative<br />
fantastiche.<br />
Qual è stato il contributo di George Martin nella registrazione<br />
di Icarus?<br />
La sua presenza è stata fondamentale; senza addentrarsi<br />
in dettagli tecnici mi limiterò a evidenziare che lui ci ha<br />
insegnato come impiegare uno studio di registrazione<br />
in maniera creativa, quasi fosse uno strumento aggiuntivo.<br />
La sua nobiltà d’animo combinata con uno spiccato<br />
senso dell’umorismo sono riuscite a tirar fuori il meglio<br />
da ogni membro del Consort.<br />
Qual è il problema principale che sta affrontando il<br />
Pianeta Terra?<br />
La nostra insaziabile dipendenza energetica: in troppi<br />
confondono ancora la richiesta con la necessità. Abbiamo<br />
perciò un urgente bisogno di reinventare la concezione<br />
dell’essere “umani’ in questo particolare periodo<br />
della nostra evoluzione. Illuminante, a tal proposito, un<br />
libro scritto dal prete cattolico passionista Thomas Berry,<br />
The great work: our way into the future.<br />
Acustica: quali, tra le innumerevoli location in cui ti<br />
sei esibito, hanno concesso le maggiori soddisfazioni?<br />
Non ho dubbi: in maniera diametralmente opposta e<br />
inspiegabile a parole, i luoghi che più hanno contribuito<br />
attivamente in questo senso sono stati il Grand Canyon,<br />
il lago Baikal in Siberia, North Crestone Lake nel<br />
Colorado, l’enorme cattedrale di Saint John the Divine<br />
a New York e, recentemente, il museo Miho a Kyoto, in<br />
Giappone.<br />
Non sono molti i tecnici del suono abili nel registrare<br />
musica acustica a un certo livello: che indicazioni<br />
specifichi loro?<br />
Cerchiamo semplicemente di ottenere con spontaneità<br />
un suono acustico il quanto più ricco possibile.<br />
Quale credi sia la ragione alla base dell’antipatia che<br />
la maggior parte delle persone nutre nei confronti<br />
della fusion?<br />
Non è che abbia mai ascoltato molta fusion in vita mia;<br />
negli Anni ’70, quando questo genere esplose, non ci<br />
feci molto caso. Ecco, diciamo che apprezzavo molto la<br />
Mahavishnu Orchestra, erano miei amici. Non ricordo<br />
di aver ascoltato altro che mi abbia entusiasmato, a eccezione<br />
di alcuni titoli per la Arista dei Brecker Brothers.<br />
E ammesso che possa essere considerata una band “fusion’,<br />
apprezzo anche il Pat Metheny Group.<br />
Chi non sopporti proprio?<br />
Gli arrivisti, le persone avide di potere e certi pseudoartisti<br />
che in realtà non sono altro che grossi bluff.<br />
Il tuo impegno più recente è Flyways<br />
Un progetto organizzato dell’associazione no-profit<br />
Music for the Earth, che intende celebrare il viaggio migratorio<br />
degli uccelli dall’Africa all’Eurasia attraverso la<br />
Grande Fossa Tettonica. Per l’occasione, si è costituito un<br />
ensemble - la Great Rift Valley Orchestra - che comprende<br />
anche musicisti del Consort e intende omaggiare le<br />
musiche tradizionali presenti in questa formazione geografica<br />
sposandole alle voci degli uccelli. Entro la fine<br />
dell’anno dovrebbe uscire un cd a raccogliere i momenti<br />
più significativi.<br />
Che qualità sono indispensabili in un musicista?<br />
Non ho dubbi: dedizione, rispetto ed entusiasmo.<br />
Quando non sei in tournée, come spendi il tempo?<br />
Godendomi la famiglia e in particolare le mie due figlie,<br />
finché sono ancora piccole. Adoro passeggiare nei boschi,<br />
fare un po di jogging tra i prati e nuotare nel fiumiciattolo<br />
che c’è vicino a dove abito.<br />
Pratichi una religione specifica?<br />
Io pratico solo il sassofono. E neanche in maniera così ‘assoluta’,<br />
visto che non mi esercito quanto vorrei. Secondo<br />
me la musica e la natura possono ristabilire nell’uomo<br />
l’equilibrio che ha smarrito più di qualunque altra cosa.<br />
Proprio sicuro che la pace sia sempre possibile?<br />
Beh, il Dalai Lama ci invita a praticare la compassione e<br />
credo che da questo punto di vista la pace sia una condizione<br />
sempre possibile.<br />
Qual è l’aspetto più straordinario dell’essere un musicista?<br />
Se ne siamo consapevoli, quando si sta “cantando’ la<br />
propria canzone ogni sorta di porta si apre davanti a<br />
noi. La musica è stata sotto molti punti di vista un incredibile<br />
passaporto per me: mi ha concesso di esplorare<br />
il mondo, incontrare persone di ogni tipo, dare alla mia<br />
anima quel senso di soddisfazione che ricercava. Se non<br />
bastasse, aggiungici che proprio durante un’esibizione<br />
a una Conferenza per la Pace in Costa Rica, incontrai la<br />
persona con cui lo scorso settembre ho festeggiato il<br />
ventesimo anniversario di matrimonio.<br />
108 109
CAMPI MAGNETICI #8<br />
Bluvertigo Beat Happening<br />
zero - ovvero la faMoSa neviCata Dell’85 (MeSCal,<br />
noveMBre 1999)<br />
E’ stata la trascinante onda di successo che ha travolto<br />
Metallo non Metallo (album del 1997 che valse alla<br />
band persino un Mtv award) a permettere a Marco<br />
Castoldi-Morgan di dare vita, con i suoi Bluvertigo, a<br />
un disco dalla portata sperimentale e concettuale unica<br />
come questo. Capitolo conclusivo di quella che fu<br />
chiamata “trilogia chimica” - facendo un po’ il verso alla<br />
più famosa “berlinese” del Thin white duke -, Zero finirà<br />
per essere il canto del cigno della band, non solo la più<br />
radicale e valida produzione.<br />
Nato dall’idea di applicare il Dogma di Lars Von Trier<br />
alla musica pop, e cioè di relazionarsi alla partitura imponendosi<br />
una serie di regole rigide entro le quali muovere<br />
la composizione, Zero si svincolerà presto da ogni<br />
principio preposto grazie all’introduzione di un’ultima<br />
regola. Una sorta di “possiamo scegliere di non seguire<br />
le regole” che permetterà più libertà ai quattro musicisti,<br />
limitando l’applicazione del Dogma alla sola title-track.<br />
Il disco è un inno al digitale, all’1 e allo 0 che regolano<br />
i sistemi informatici, al sostanziale finto contrasto<br />
tra sfera emotiva e ragione applicata, con un titolo che<br />
richiama la scienza e la matematica e un sottotitolo<br />
(ovvero la famosa nevicata dell’85) che svela il candore<br />
emotivo. Quest’ultimo riferimento alla neve che<br />
costrinse Morgan, come molti altri bambini quell’anno,<br />
a rimanere a casa da scuola e a capire che il suo gioco<br />
preferito era il sintetizzatore.<br />
I testi di Zero sono riflessivi, ragionativi, misurati, eppure<br />
capaci di aprirsi a un’emotività profondissima e lontana<br />
dallo stucchevole. Con un Morgan deciso a lasciare da<br />
parte il cinismo/divertissment dell’adolescenziale Acidi<br />
e basi e dell’electropop colorato di Metallo non Metallo<br />
per staccarsi sempre più da sé e avvicinarsi al bianco<br />
(padre di tutti i colori) e allo zero (principio e fine di tutti<br />
i numeri). Le musiche, fiore all’occhiello dell’opera, sono<br />
radicalmente legate al testo come è raro possa accadere<br />
quando si mettono assieme sound quasi esclusivamente<br />
elettronico e lingua italiana. Se brani come Lo<br />
psicopatico, Finchè saprai spiegarti, Autofraintendimento,<br />
110<br />
Sono = Sono giocano violentemente con la distorsione<br />
elettronica in un’esasperazione lenta e piacevole, pezzi<br />
come Punto di non arrivo, Sovrappensiero (con l’amato<br />
Battiato in veste di lettore e vocalist), La crisi, Zero, Forse,<br />
La comprensione e l’orchestratissima cageiana Numero,<br />
non mancando di offrire passaggi dotati di una<br />
drammaticità e di una levità compiute. Uno spettro di<br />
riferimenti ampio che cita i Nine Inch Nails, il Bowie di<br />
Low e Lodger, gli Einstürzende Neubauten, le linee<br />
elettroniche primordiali care ai Kraftwerk.<br />
A distanza di dodici anni esatti dalla sua uscita, Zero è<br />
un disco per nulla invecchiato, marcatamente distante<br />
per spessore e potenziale dai due suoi predecessori e<br />
con un’eredità sonora che in Italia nessuno ancora ha<br />
raccolto ed elaborato. Un’opera a suo modo sperimentale,<br />
senza sbavature (risultato di un’ottima produzione,<br />
ma anche della presenza di musicisti come Mauro Pagani,<br />
David Richards e di tecnici del suono come Livio<br />
Magnini), in cui anche una cover come Always crashing<br />
in the same car (uno dei brani di Bowie più ovattati, nascosti<br />
e difficili da rivisitare) si dimostra perfettamente<br />
riuscita.<br />
Giulia Cavaliere<br />
classic album<br />
S/t (k reCorDS, noveMBre 1985)<br />
Il riflusso degli anni ‘80 aveva fatto di più che confinare<br />
nell’underground quasi tutto ciò che non era mainstream<br />
frivolo, mediante un muro di Berlino con pochissimi<br />
checkpoint: da questo lato del muro, accanto e dentro<br />
al punk, erano anche cambiati l’umore e l’estetica, e la<br />
combattività indie scopriva altre dimensioni.<br />
Calvin Johnson nell’indie ci si era formato, facendo il<br />
redattore della Sub Pop ai tempi in cui era ancora una<br />
fanzine e fondando nel 1982 la K records. Nata inizialmente<br />
per rendere disponibile la musica dei gruppi amici,<br />
l’etichetta diventerà negli anni punto di riferimento<br />
dell’indie, anche grazie alla pubblicazione nel 1985 di<br />
questo esordio sulla lunga distanza del gruppo che lo<br />
stesso Calvin aveva formato tre anni prima.<br />
Johnson aveva incontrato Heather Lewis all’università,<br />
e la formazione si era stabilizzata poi con l’arrivo di Bret<br />
Lunsford intorno allo striminzito equipaggiamento di<br />
una chitarra e di un paio di maracas. I limiti diventano<br />
elementi di stile e già dai primi EP la loro poetica è chiaramente<br />
definita: tre accordi, approssimazione tecnica (i<br />
tre fanno - “democraticamente” - a rotazione tra chitarra<br />
batteria e voce) e testi di innocenza folle uniti a un talento<br />
melodico di rara efficacia, a comporre un quadro che<br />
contrappone il dilettantismo-pride all’imborghesimento<br />
formale di quello che troppo rock era diventato.<br />
“Che altro può fare un povero ragazzo oltre a suonare in<br />
una rock’n’roll band?” si chiedeva Jagger in Street Fighting<br />
Man, ed era il pieno ‘68: negli 80s non c’è davvero altro<br />
da fare, e stavolta invece della strada c’è la cameretta<br />
di uno dei tanti weirdos che il decennio aveva scacciato<br />
dal luogo-simbolo della socialità ribelle 60s e 70s.<br />
L’opposizione alle major, così, si svolge tornando non<br />
solo alla grezzaggine e all’informale del punk delle origini,<br />
ma anche al protopunk per recuperare l’infantilismo<br />
programmatico e semiserio di Jonathan Richman<br />
(benché lui, come gli altri suoi discepoli di quegli anni<br />
Violent Femmes, sapesse cantare e suonare davvero):<br />
dove infanzia significa rifiuto di integrarsi nelle regole e<br />
nel quale si dice che se “ritorno al personale e all’intimo”<br />
deve essere, scelgo io quale personale e quale intimo,<br />
ridicolizzando nella follia gli adolescenzialismi lacrimevoli<br />
del pop.<br />
Con Greg Sage degli Wipers a nascondere la produzione<br />
e raccogliendo qualcosa dagli EP precedenti, il disco<br />
mette in fila i Cramps di Bad Seed, il C-86 di Down At<br />
The Sea, un Iggy Pop senza glam e furia in I Love You,<br />
la malinconia di Fourteen, gli anni ‘50 sgangherati del<br />
frammento Honey Pot (dove manca perfino la chitarra e<br />
le percussioni potrebbero essere due posate su un tavolo),<br />
il classico Our Secret tra soul robotici e jingle-jangle,<br />
con risultati simili a quelli che in una cameretta dall’altra<br />
parte del mondo raggiungeva Chris Knox.<br />
Il lungo seguito non saranno solo gli altri dischi (dal sophomore<br />
- altrettanto lodato se non più - Jamboree alla<br />
conclusione della storia nel 1992) con un progressivo<br />
raffinamento e i molti successivi progetti musicali di Johnson,<br />
ma anche il botto che farà la campagna acquisti<br />
delle major nel mondo indie della seconda metà del<br />
decennio, Nevermind e il logo della K sulla spalla di<br />
Cobain, le ristampe che uniscono al disco svariato materiale<br />
coevo a completare il quadro dei loro primi anni,<br />
il mutamento della natura dell’indie, per finire con la<br />
nascita del lo-fi che, almeno negli USA, a questo pugno<br />
di canzoni deve il certificato di nascita.Tutto con tre stonati,<br />
una chitarra di seconda mano e un paio di maracas.<br />
Giulio PaSquali<br />
111