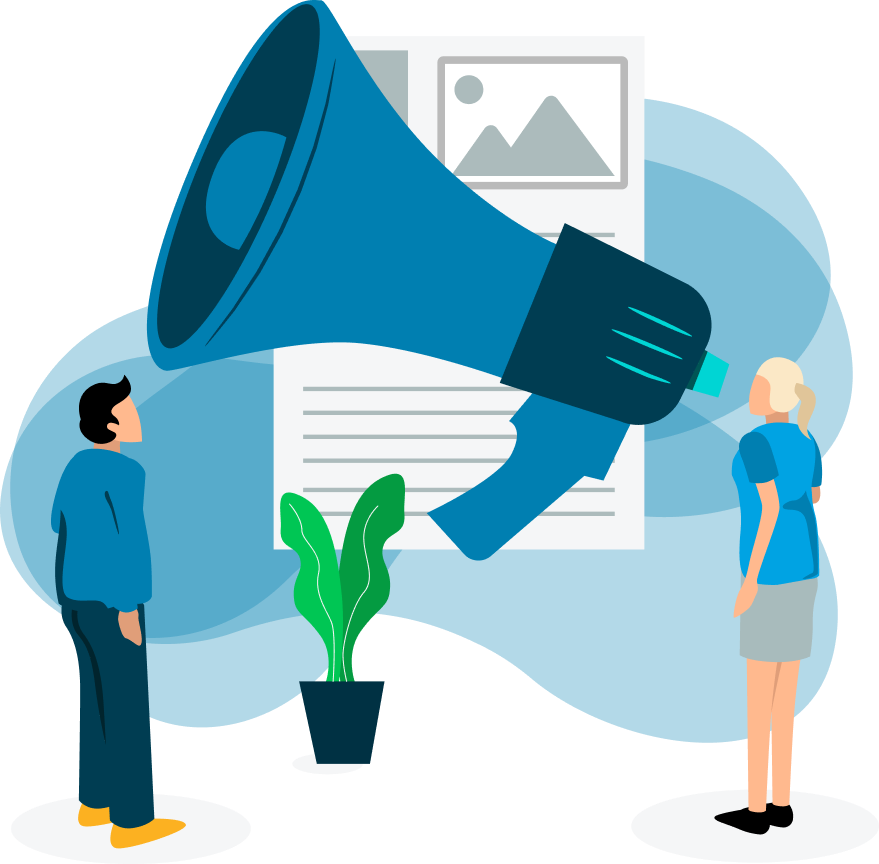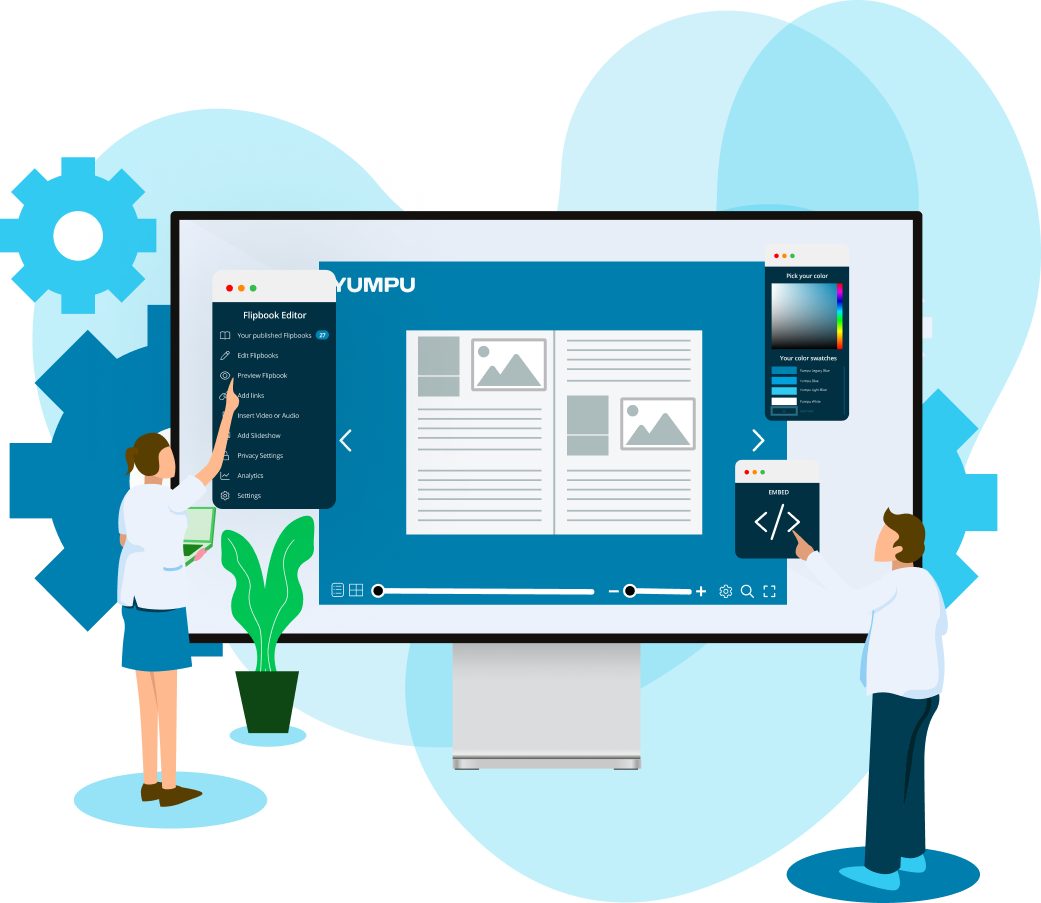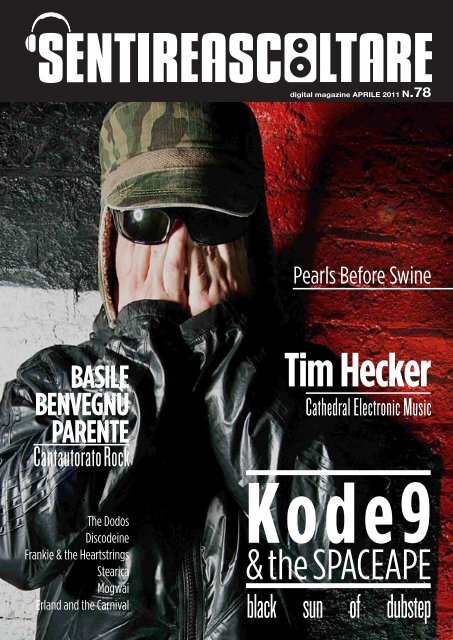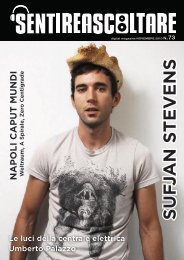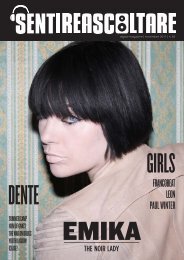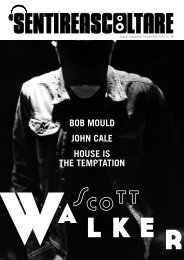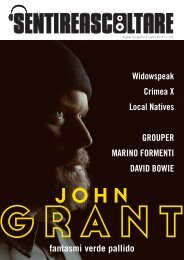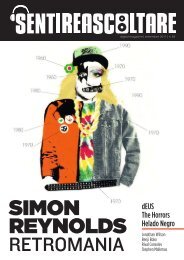Tim Hecker - Sentireascoltare
Tim Hecker - Sentireascoltare
Tim Hecker - Sentireascoltare
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Basile<br />
Benvegnù<br />
Parente<br />
Cantautorato Rock<br />
The Dodos<br />
Discodeine<br />
Frankie & the Heartstrings<br />
Stearica<br />
Mogwai<br />
Erland and the Carnival<br />
digital magazine aprile 2011 N.78<br />
Pearls Before Swine<br />
tim <strong>Hecker</strong><br />
Cathedral Electronic Music<br />
Kode9<br />
& the SPaCEaPE<br />
black sun of dubstep
sentireascoltare.com<br />
p. 4<br />
p. 12<br />
p. 20<br />
p. 50<br />
p. 114<br />
p. 106<br />
p. 108<br />
p. 110<br />
p. 122<br />
p. 123<br />
TuRn on<br />
Rubriche<br />
Di r e t t o r e : Edoardo Bridda<br />
The Dodos, Discodeine, Frankie & the Heartstrings, Stearica<br />
Tune in<br />
Mogwai, Erland and the Carnival<br />
DRop ouT<br />
Cesare Basile/Paolo Benvegnù/Marco Parente<br />
Kode9<br />
<strong>Tim</strong> <strong>Hecker</strong><br />
Recensioni<br />
Rearview Mirror<br />
Gimme some inches<br />
Reboot<br />
China Files<br />
Campi Magnetici<br />
Classic Album<br />
Di r e t t o r e re s p o n s a b i l e: Antonello Comunale<br />
Uf f i c i o st a m p a : Teresa Greco<br />
co o r D i n a m e n t o : Gaspare Caliri<br />
pro g e t to gr a f i c o e im p a g i n a z i o n e : Nicolas Campagnari<br />
SentireAscoltare online music magazine<br />
Registrazione Trib.BO N° 7590 del 28/10/05<br />
Editore: Edoardo Bridda<br />
Direttore responsabile: Antonello Comunale<br />
Provider NGI S.p.A.<br />
Copyright © 2009 Edoardo Bridda.<br />
Tutti i diritti riservati.La riproduzione totale o parziale,<br />
in qualsiasi forma, su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo,<br />
è proibita senza autorizzazione scritta di SentireAscoltare<br />
re D a z i o n e : Andrea Simonetto, Antonello Comunale, Edoardo Bridda, Gabriele Marino, Gaspare Caliri, Nicolas Campagnari, Stefano Pifferi, Stefano Solventi, Teresa Greco<br />
st a f f : Marco Boscolo, Edoardo Bridda, , Luca Barachetti, Marco Braggion, Gabriele Marino, Stefano Pifferi, Stefano Solventi, Teresa Greco, Fabrizio Zampighi, Luca<br />
Barachetti, Andrea Napoli, Diego Ballani, Mauro Crocenzi, Fabrizio Zampighi, Giulia Cavaliere, Giancarlo Turra<br />
co p e r t i n a: Aucan (foto di Giordano Garosio)<br />
gU i D a s p i r i t U a l e : Adriano Trauber (1966-2004)<br />
.<br />
Pearls Before Swine
The Dodos<br />
—Indie-rock in bianco<br />
e nero—<br />
Quarto album per la coppia di<br />
coriacei folk singer. Sempre con quel<br />
suono inconfondibile e in continua<br />
ricerca. Qualche passo indietro per<br />
guarare avanti. Ne abbiamo parlato<br />
con Logan Kroeber<br />
Turn on<br />
La storia dei Dodos, già Dodo Bird ai tempi in cui<br />
Meric Long e Logan Kroeber si conobbero tramite<br />
un amico comune divenendo duo da progetto solista<br />
del primo, arriva in questi giorni al suo quarto capitolo.<br />
Il nuovo disco si chiama No Color e ci riconsegna il<br />
gruppo in ottima forma, ancora padrone del proprio<br />
caratteristico sound che al finger-picking del bravo<br />
Meric incrocia un suono indie-rock figlio dei migliori<br />
anni ‘90 e una sempre alta qualità del songwriting.<br />
Ma il buon risultato di questi nove brani pare anche<br />
merito di una serie di riflessioni: come se il duo di<br />
San Francisco, nel tirare avanti e sperimentare qualche<br />
inedita soluzione, si fosse anche guardato indietro e<br />
avesse recuperato solo quegli elementi che sembrava<br />
avessero funzionato meglio nei precedenti lavori.<br />
Scelte oculate che crediamo verranno ripagate, se non<br />
dalle classifiche di vendita, quantomeno da quelle di<br />
fine anno; e che ci è sembrato doveroso approfondire,<br />
in una veloce chiacchierata con un evidentemente impegnato<br />
Logan Kroeber.<br />
Iniziamo dal titolo dell’album, qual è la filosofia<br />
dietro a No Color?<br />
Il titolo proviene da un discorso affrontato da me<br />
e Meric durante il mixaggio del disco. Personalmente<br />
vedo sempre determinati colori e immagini quando<br />
suoniamo certe canzoni, e mentre lavoravamo a queste<br />
nuove le immagini che ho visto erano tutte grigie e<br />
polverose. Questa percezione è cambiata un po’ adesso,<br />
un minimo di colore si sta intrufolando, ma in quel<br />
momento sembrava un buon modo per incapsulare i<br />
contenuti del disco. Nessuna filosofia, quindi, più che<br />
altro il frutto di un mio punto di vista.<br />
Dopo <strong>Tim</strong>e To Die avete voluto nuovamente<br />
John Askew come produttore del nuovo album.<br />
Come mai? Siete insoddisfatti di quel disco?<br />
In realtà lo stile di scrittura di <strong>Tim</strong>e To Die è il medesimo<br />
di questo nuovo disco, anzi penso e spero che in<br />
questo senso No Color aiuterà la gente a capire meglio<br />
<strong>Tim</strong>e To Die. Per cui non vogliamo prendere affatto le<br />
distanze da quel lavoro. Però è vero che c’erano certi<br />
esperimenti in quel disco che non volevamo ripetere<br />
nel nuovo lavoro, come ad esempio suonare su una<br />
click track.<br />
Dove avete incontrato Neko Case, e quando avete<br />
deciso di collaborare per questo nuovo disco?<br />
Abbiamo conosciuto Neko Case andando in tour<br />
con i New Pornographers l’estate scorsa. Ci siamo trovati<br />
molto bene sia con lei che con il resto del gruppo<br />
e durante le ultime date lei ha cantato sul palco con<br />
noi qualche volta. Così Meric ha pensato di chiederle<br />
se voleva cantare anche nel nostro disco, e per nostra<br />
fortuna è stata ben felice di accettare. E’ già il secondo<br />
colpo fortunato di Meric con le voci femminili, dopo<br />
Laura Gibson che cantava insieme a lui in alcune tracce<br />
di Visiter.<br />
Un altro importante elemento nel disco è la chitarra<br />
elettrica. Avete dichiarato di essere stati influenzati<br />
dai riff di certi dischi degli anni 90, come quelli<br />
degli Smashing Pumpkins.<br />
Sì, lo confermo. In realtà credo che queste influenze<br />
siano da sempre nella testa di Meric, perchè ha sempre<br />
ascoltato gli Smashing Pumpkins e ha sempre amato<br />
il tipo di crescita che ha avuto quel gruppo; però<br />
questa volta, a differenza del passato, abbiamo avuto<br />
il tempo e la pazienza di ritagliare qualcosa in più da<br />
quell’approccio e inserirlo nel nostro lavoro.<br />
Il vostro stile è sempre riconoscibile, ma il suono è<br />
più ‘epico’ stavolta. Siete in cerca di un profilo più<br />
alto?<br />
Ti dirò, abbiamo sempre mirato a un suono epico, fin<br />
dal primo giorno, ma a giudicare dai nostri live attuali<br />
direi che non siamo pronti per grossi palchi rock come<br />
quelli degli Arcade Fire. In parole semplici: non abbiamo<br />
abbastanza pubblico! Detto questo non siamo assolutamente<br />
refrattari a ‘un profilo più alto’: se arriva,<br />
sarà il benvenuto.<br />
Ciò che ho apprezzato di più nel disco è il contrasto<br />
apparente tra la musica, profondamente energica,<br />
e i testi, profondamente malinconici, Sembra che<br />
vogliate divertirvi e reagire ai momenti tristi che<br />
descrivete, come una sorta di esorcismo.<br />
Non scrivendo i testi in prima persona non posso risponderti<br />
con estrema certezza; posso dirti però che<br />
concordo in pieno sulla tua sensazione. Mentre scriviamo<br />
la musica io per primo sono eccitato perchè le<br />
energie e le melodie mi sembrano così esaltanti, poi<br />
invece sento i testi e sono così tristi! Ma se ci pensi<br />
in fondo la vita stessa è così, di tanto in tanto siamo<br />
costretti a metterne a confronto i lati negativi e quelli<br />
positivi.<br />
Simone madrau<br />
4 5
Discodeine<br />
—Haunted 2011 Funk—<br />
Assuefazioni alternative a Ed Banger<br />
e Kitsuné. Dalla Dirty arriva la disco<br />
di sintesi dei francesissimi Discodeine<br />
Turn on<br />
Pentile e Pilooski sono due personaggi del giro french-touch con una carriera di tutto rispetto, codificata per i<br />
circoli più fumosi e improbabili della capitale francese. Il loro percorso artistico li ha già portati a bazzicare le<br />
stanze di personaggi e manager culto del genere dancey gallico. Oggi approdano al disco sulla lunga distanza, già<br />
anticipato da vari singoli, che hanno fatto sentire aria di nuovo quando si sono presentati in studio personaggi del<br />
calibro di Jarvis Cocker, che presta la voce in Synchronize (stampato l’anno scorso su DFA), e Mathias Aguayo in<br />
Singular (su Dark & Lovely, l’etichetta del collettivo Dirty, cui fanno parte gli stessi P & P, che li ha lanciati nel 2008<br />
con il singolo dance Joystick).<br />
Chi sono in realtà le nuove leve dell’alt-dance french? Andando a cercare in qua e in là, si scopre di come l’eterogeneità<br />
dell’esordio non sia casuale. Il risultato è una foto onirica di mondi che collidono e che danno origine<br />
ad un ibrido che anche dopo numerosi ascolti non stanca, anzi, cresce e con orgoglio tipicamente gallico si fa<br />
sinuoso, sexy e personalissimo. Due che hanno trovato la loro voce.<br />
Pe n t i l e<br />
Pentile - al secolo Benjamin Morando - all’inizio della sua carriera, cioè nel lontano 2001, ha stampato sulla patinatissima<br />
etichetta di Benjamin Diamond un singolo di house sciccosa (Single Bell) che i fan di quei suoni sicuramente<br />
ricorderanno: in quegli anni la Diamond Traxx odorava infatti del successo con cui gli Stardust avevano<br />
sbancato le piste di mezzo mondo e che nel giro di<br />
pochi mesi avrebbe fatto cambiare la testa di Thomas<br />
Bangalter, consegnandogli su un piatto d’argento l’atmosfera<br />
pop per l’elaborazione di un mostro del calibro<br />
di Discovery.<br />
Benjamin ha fatto inoltre parte del duo France Copland<br />
con Krikor Kouchian. La collaborazione con il<br />
musicista elettronico alt-touch inizia nel 2002 e vede<br />
l’elaborazione di uno strano ghettotech influenzato<br />
dal suono di Detroit (da parte di Pentile) e dalle sperimentazioni<br />
del cervellotico istituto IRCAM (la patria<br />
accademica dei musicisti elettronici francesi, invocata<br />
dal pazzoide Krikor). I due danno alle stampe due EP<br />
oggi introvabili: Pute Et Mac EP (con una grande rivisitazione<br />
di Vangelis nell’electro progressiva a 8 bit di<br />
Rutgerhauer Song) e The Great French Institution.<br />
Per chiudere la veloce carrellata dei progetti ante-<br />
Discodeine, Pentile collabora tuttora con Suzanne Thoma<br />
al gruppo Octet, che ha stampato nel 2004 l’album<br />
Cash And Carry Songs (sempre su Diamond Traxx) e<br />
che nel 2005 ha pure remixato il singolo di Beck Girl.<br />
I due (inizialmente accompagnati anche da Francois<br />
Goujon) propongono un pop che ricorda le visioni dei<br />
Broadcast tagliate con arrangiamenti orchestrali à la<br />
Badalamenti, il tutto condito da una sensibilità affine<br />
agli Everything But The Girl, soprattutto per la somiglianza<br />
della voce di Suzanne con quella di Tracey<br />
Thorn. Attualmente il progetto è in stand by, ma da<br />
voci di corridoio dovrebbe essere pronto a breve un<br />
secondo album.<br />
Pi l o o s k i<br />
Anche Pilooski aka Cédric Marszewski conosce bene<br />
gli studi della Diamond Traxx. In passato ha utilizzato<br />
i moniker di Eddyee’s <strong>Tim</strong>e e C. Denner, due strade alternative<br />
che gli hanno permesso di esplorare territori<br />
hip hop, funk (vedi il singolo su Diamond Traxx Can’t<br />
There Be Love del 2006), jazz o new wave, sempre con<br />
il piglio ritmico in testa, dato che suona beats dall’età<br />
di 14 anni.<br />
La sua è la mano del remixatore e dell’archeologo:<br />
l’uomo è famoso infatti per numerosi re-edit di vecchi<br />
successi anni sessanta, tagliati e cuciti per l’orecchio<br />
contemporano (tra gli altri sono passati sotto le sue<br />
mani di forbice i Can, Morricone e gli Yello) e pubblicati<br />
in limitatissimi singoli su Dirty nella serie degli<br />
Edits. Ultimamente ha suonato anche al festival Nuit<br />
Sonores di Lyone, connettendosi guardacaso alla sensibilità<br />
di un’altra meteora dance off-Paris: Sébastien<br />
Devaud, in arte Agoria.<br />
DiscoDeine<br />
Sia Pilooski che Pertile fanno parte - con Clovis Goux<br />
e Guillaume Sorge - del progetto collettivo/label Dirty<br />
Sound System. Goux e Sorge sono due dei più famosi<br />
selezionatori musicali della capitale francese. Dalla<br />
fine degli anni Novanta la coppia di talent scout cerca<br />
nuove voci e idee in giro per i club più in di Parigi: in<br />
breve tempo sono diventati un punto di riferimento<br />
grazie anche al loro visitatissimo blog Alain Finkiel<br />
Krautrock, pozzo senza fondo per nuove direzioni del<br />
suono da club all’ombra della torre Eiffel, raccolte saltuariamente<br />
nelle compilation di culto Dirty Diamonds<br />
(ovviamente oggi tutte in sold out).<br />
In un’intervista velocissima - quasi uno scambio in<br />
chat - chiediamo ai due se si sentono di appartenere<br />
al french touch: a parte essere francesi non sentiamo<br />
nessuna connessione con quel suono. Qualcosa<br />
c’è comunque, dato che i due vivono a Parigi. Tra gli<br />
artisti più vicini alla loro estetica riconoscono esserci<br />
Joakim, Tigersushi e Versatile, mentre non sembrano<br />
essere molto legati alla Ed Banger di Busy P, confessando<br />
pure che la scena di Parigi rimane arroccata su<br />
posizioni di chiusura incomprensibili, tanto che nemmeno<br />
al suono Daft Punk sembrano dedicare molto<br />
spazio. Ci dicono infatti che non tutti i lavori dei due<br />
robot li aggradano... spocchia? Ma no, i due alla fine<br />
percorrono un sentiero dreamy, che più che connettersi<br />
a Guy-Man e Thomas sembra guardare alle strade<br />
della psichedelia.<br />
Se gli chiediamo di definire il loro suono ci rispondono:<br />
Haunted 2011 Funk. Se gli chiediamo quali sono<br />
i loro produttori preferiti rispondono: Anthony Shakir,<br />
DJ Koze, Errorsmith, Zongamin, Caribou e Maurice<br />
Fulton. Se gli chiediamo quali sono i loro progetti futuri<br />
ci rivelano che stanno già iniziando a registrare<br />
un secondo album e che stanno ultimando il live. Due<br />
che hanno esordito su Dark & Lovely con un 12” in stile<br />
100% disco (le tracce erano Joystick e Homo-compatible),<br />
oggi sono la punta di diamante della Dirty e possono<br />
vantare remix delle loro tracce di Simian Mobile<br />
Disco e Ivan Smagghe. Dirty è la prima concorrente<br />
di Ed Banger e Kitsuné. Si fa presto a diventare dipendenti<br />
dalla codeina... basta aggiungerci la disco.<br />
marco Braggion<br />
6 7
Frankie<br />
& The<br />
Heartstrings<br />
— No Redemption—<br />
Rockabilly filtrato giovane Scozia,<br />
Postcard sound e tanto amore per<br />
Morrisey. Frankie Francis ci racconta<br />
i suoi Heartstrings e la sa più lunga di<br />
quel che non sembrerebbe...<br />
Turn on<br />
Dietro l’angolo c’è la tentazione di scivolare in uno dei grandi luoghi comuni della musica britannica di tutto<br />
il Novecento, una di quelle dicotomia che hanno fatto la storia stessa del pop della terra d’Albione: il Nord<br />
dell’Inghilterra e la Scozia versus Londra, la swinging, la fashionable, la città nella quale le mode stesse, le tendenze<br />
(e si sa quanto contano i trend nella musica pop) vengono create.<br />
Frankie & The Hearstrings vengono da uno di quei luoghi di provincia, Sunderland, che ha sempre - necessariamente<br />
- subito il fascino della metropoli, della grande città, ma ha contemporaneamente voluto affermare<br />
orgogliosamente la propria identità. Lo ricorda anche lo stesso Frankie Francis, raggiunto al telefono per quattro<br />
chiacchiere: veniamo da una delle città meno trendy, meno fashionable dell’Inghilterra, mentre a Londra le cose<br />
stanno su un piano diverso, perché ci sono un sacco di persone, moltissimi posti dove c’è ogni sera un concerto,<br />
un reading, qualcosa che accade.<br />
La metropoli può essere un eldorado per mettere in prospettiva le proprie aspirazioni e per qualcuno, e la storia<br />
è piena di esempi in questo senso, può essere anche la fine di un percorso, perché se c’è molto fermento, aumenta<br />
anche la competizione. Non così se accetti al provincia e ne fai il tuo trampolino di lancio: “da dove veniamo<br />
noi, invece, le cose sono più facili”. Non è detto che questo sia per forza un bene, perché bisogna darsi molto da<br />
fare, costruirsi una credibilità a livello locale, magari affrontando le diffidenze di chi ti conosce da sempre e mostra<br />
tutti i suoi scetticismi. Ma se la qualità delle tue canzoni<br />
e la stoffa che sta dietro a quello che è comunque<br />
un prodotto commerciale (si parla pur sempre di ‘pop<br />
music’, intendendo ‘musica per le masse’, non certo per<br />
colte élite salottiere) non la stessa di tutti i gruppi che<br />
cercano il loro raggio di luce, allora le cose possono<br />
funzionare.<br />
Non si tratta, però, solo di questo, perché per noi è<br />
sempre importante ricordarci da dove veniamo, qual<br />
è il nostro posto, dove sono le nostre radici. Ritorna,<br />
misto a un sentimento di appartenenza di altri tempi,<br />
anche un orgoglio, lo stesso che ha dato forza a molti<br />
gruppi targati Postcard e “suono della giovane Scozia”.<br />
Al di là del solito riferimento a gruppi come gli<br />
Orange Juice e Josef K (ma ci sarebbe da aggiungere<br />
almeno i Dexys Midnight Runners), un nome che<br />
ritorna spesso sulle colonne dalla stampa quando si<br />
parla di Frankie Francis e dei suoi Heartstrings è Morissey.<br />
Un po’ perché sembra che sul palco, come afferma<br />
chi li ha visti live durante il fortunato tour di spalla ai<br />
Futureheads (altra band del nordest inglese), il giovane<br />
cantante dal look rockabilly sia capace di calamitare<br />
con il proprio carisma qualsiasi tipo di pubblico, facendo<br />
sembrare ogni gig un evento unico e speciale.<br />
Un po’ perché i riferimenti alla musica anni Cinquanta<br />
(crooning compreso), con quelle chitarre jingle-jangle<br />
e quelle melodie blue eyed soul appiccicose e spesso<br />
sbarazzine, fanno del materiale di Hunger una delle<br />
migliori scuse in circolazione per muover i piedi e le<br />
anche a ritmo, come accadeva per gli Smiths. Morrisey<br />
è sempre un paragone che lusinga, che fa piacere.<br />
Soprattutto se sei un fan, se ti piace quello che ha realizzato<br />
con la sua band.<br />
Nella voce di Frankie, però, nonostante la sicurezza<br />
che ostenta per tutto il resto delle nostre chiacchiere,<br />
qui compare qualche esitazione, quasi che comunque<br />
il pensiero di mettersi nella stessa scia, di affrontare<br />
l’ombra di colui che è sicuramente stato una delle ultime<br />
vere star prodotte nel Regno Unito abbia un peso<br />
superiore a tutte le preoccupazioni che una band<br />
all’esordio, per quanto coccolata dalla stampa e dalla<br />
blogosfera, possa avere.<br />
I riferimenti musicali dichiarati della band non si<br />
fermano qui, ma comprendono anche Prefab Sprout<br />
(sono un band molto importante, specialmente per<br />
gente come noi, che viene dalla provincia. Secondo<br />
me hanno prodotto tra le cose più belle nel pop di tutta<br />
la storia della musica pop), Echo And The Bunnymen<br />
e Talking Heads: durante le chiacchiere da pub<br />
che abbiamo fatto quando ci siamo conosciuti abbia-<br />
mo scoperto che sono due band che piacciono a tutti<br />
noi. È anche per questo che abbiamo deciso di formare<br />
la band. A proposito dei primi bisogna dire che<br />
di Killing Moon c’è più di una traccia nei brani meno<br />
energetici di Hunger e che il crooning di Frankie devo<br />
qualcosa a Ian McCulloch. Con i secondi è più difficile<br />
individuare eredità dirette, ma di sicuro li accomuna<br />
un nervosismo generale e tutto sommato il giro di chitarra<br />
di Ungreatful non è così lontano dalle abitudini<br />
di Byrne e sodali.<br />
Con la band newyorkese, però, sembrano più che<br />
altro condividere un interesse sociale non secondario,<br />
testimoniato anche dalla scelta di usare per tutte le<br />
cover di album e singoli foto di Keith Pattinson, il cui<br />
libro No Redemption è una documentazione attentissima<br />
del famoso sciopero dei minatori britannici del<br />
1984. Le sue foto, seppur non nello stile, evocano però<br />
lo stesso immaginario da working class e da provincia<br />
di una copertina come Steve McQueen dei Prefab<br />
Sprout. Insomma, si guarda a certe sottotrame degli<br />
80s, quelle che rileggono i 50s edulcorandoli e cromandoli,<br />
e lasciando da parte slanci lisergici o (retro)<br />
futuristi.<br />
L’attività live nel nordest del paese deve avere cementato<br />
fortemente la band e quando si parla dell’importanza<br />
della dimensione live, emerge un po’ di<br />
quello spirito sbruffone ma simpatico che spesso si<br />
riscontra nelle giovani band con quell’aria cazzuta che<br />
il mondo anglosassone ha sempre prodotto. Il palco<br />
è una dimensione importante per la musica, ma non<br />
si tratta solo del piacere di suonare insieme. I live set<br />
permettono un contatto diretto con l’energia della<br />
gente che ti viene a sentire e, in quelle situazioni, mi<br />
sento molto a mio agio, ho fiducia nelle mie capacità e<br />
in quelle della band: la fiducia nelle tue capacità, nelle<br />
tue canzoni, nei tuoi mezzi.<br />
È una forza che bisogna avere se vuoi provare la<br />
strada del pop, se vuoi davvero provare a diventare<br />
una sensation e poi, chissà, inseguire Morissey sulla<br />
strada della celebrità. Questo lo dirà solo il tempo.<br />
marco BoScolo<br />
8 9
Stearica<br />
—Stearica invade il<br />
mondo—<br />
Frantumano stili e codici tra<br />
elettricità ed elettronica. Italiani per<br />
provenienza, ma internazionali per<br />
ambizioni e riferimenti ci parlano<br />
della propria weltanschauung<br />
Turn on<br />
Sono italiani, ma non sembra. Non che abbiano<br />
particolari tratti somatici o nomi strani. I torinesi<br />
Francesco Carlucci (chitarre, basso, farfisa, piano, vibrafono,<br />
loops), Davide Compagnoni (batteria, piano,<br />
marimba, loops) e Luca Paiardi (basso, piano elettrico,<br />
synth), nome in codice Stearica, hanno dimostrato<br />
sin dai primi e ormai remoti passi di sentirsi stretti<br />
addosso i confini nazionali. A giudicare da etichette e<br />
partnership, collaborazioni e ospitate varie nel corso<br />
dei dieci anni e più di vita del progetto, il respiro internazionale<br />
è più che giustificato. Se Dälek, Octopus e<br />
Amy Denio, tanto per fare dei nomi, partecipavano al<br />
loro primo album Oltre, il comeback Stearica Invade<br />
AMT vede addirittura gli psycho-rockers capitanati da<br />
Kawabata Makoto pronti a dividere palchi (il tour europeo<br />
di più di 30 date) e sessioni di registrazione in<br />
modalità impro per un album a “n” mani.<br />
Una stima guadagnata sul campo, senza fossilizzarsi<br />
su confini o limiti, nè di genere nè tant meno geografici<br />
come ci ricorda Francesco: Facciamo musica<br />
dal ‘97 e non appena abbiamo sentito l’esigenza di<br />
farci ascoltare, siamo partiti senza bussola o geografia.<br />
I confini stanno spesso solo nella mente, specie se ad<br />
appena un centinaio dalla tua città si parlano lingue<br />
diverse. Così abbiamo spedito subito le prime registrazioni<br />
ovunque capitasse, infatti pensa che una delle<br />
nostre prime uscite è stata alla volta dei Paesi Baltici!<br />
L’intensa attività on stage non solo ha rodato il<br />
progetto nel corso degli anni ma ha significato anche<br />
stringere una serie di contatti umani prima che professionali:<br />
Riguardo ai musicisti che citavi, sono tutti<br />
amici conosciuti in tour, collaborazioni nate dopo aver<br />
condiviso lo stesso palco o dopo una cena consumata<br />
scherzando e trovando sintonia e umanità. Insomma<br />
gli ingredienti che riteniamo fondamentali per suonare<br />
insieme.<br />
Questo atteggiamento di completa apertura mentale<br />
si ripercuote sulle musiche del terzetto. Inclassificabili<br />
nel loro mélange a cavallo tra post-rock, sonorità<br />
90s e psych dura che unisce muscoli a macchine, elettricità<br />
ad elettronica (Il nostro suono è frutto di anni<br />
trascorsi suonando negli scantinati sino a notte fonda…abbiamo<br />
imparato a suonare con una moltitudine<br />
di strumenti acustici, elettrici o elettronici), esse<br />
hanno un pregio raro di questi tempi: il potersi dire<br />
realmente personali. A me piace questa componente<br />
personale, prosegue Francesco. Non siamo fan dei<br />
modelli preconfezionati, ma in Italia si cerca la tranquillità<br />
di ascolti rassicuranti. Non dico che chiunque<br />
sperimenti sia un eroe, ma sicuramente apprezzo di<br />
più chi ci prova ed è curioso, rispetto a chi, invece, è<br />
idolatrato riproponendo noiosamente sempre la solita<br />
minestra…rancida.<br />
La curiosità e la voglia di sperimentare seppur<br />
sempre in ambiti rock non mancano ai tre. Oltre, disco<br />
d’esordio tutt’altro che acerbo, li vedeva muoversi<br />
onnivori tra distorsioni e chiaroscuri emozionali, visionarietà<br />
e leggerezza rievocando più che un suono,<br />
un immaginario collettivo. Quello della natale Torino,<br />
città dalle mille sfaccettature, esoterica e romantica,<br />
punk dentro e ricercata fuori.<br />
Il comeback Stearica Invade Acid Mothers Temple<br />
– una unica session post ultimo concerto registrata<br />
all’Ortosonico di Pavia in cui i sette del gruppo misto<br />
hanno “invaso un pezzo di storia gli uni degli altri” – li<br />
mostra invece padroni della situazione, tanto che sembrerebbero<br />
loro ad aver preso il sopravvento sui più<br />
quotati colleghi. Segno di grossa personalità e stima<br />
da parte di Makoto & co.: La decisione comune di lasciare<br />
a me la produzione artistica ha inevitabilmente<br />
portato un accento sul nostro suono nonostante abbia<br />
cercato di mantenere lo spirito di quelle riprese. Ci<br />
saremmo aspettati che fosse Makoto ad occuparsi del<br />
mix e di realizzare il master, così come ha sempre fatto<br />
per qualunque lavoro degli AMT. Quella sera stessa, invece,<br />
nel corso della cena al termine delle registrazioni,<br />
mi ha proposto di produrre quel materiale. È stata<br />
la sua maniera per ringraziarci della splendida esperienza<br />
vissuta nel corso di quel lungo tour che stava<br />
appunto terminando con la registrazione della jam da<br />
cui è nato l’album. Era chiaro che così facendo ci stava<br />
dando una grossa occasione e dal canto nostro siamo<br />
stati davvero onorati.<br />
La grossa occasione è stata colta al volo, se è vero<br />
che a breve parteciperanno per la seconda volta alla<br />
prestigiosa compilation di The Wire, The Wire Tapper<br />
(Warp Lag, il pezzo selezionato dal magazine inglese)<br />
dopo il primo lascito targato 2008 (Occhio, la prescelta<br />
all’epoca). Poi i tre ritornerà nella sua dimensione ideale.<br />
A calcare i palchi di tutta Europa, compreso quello<br />
prestigioso del Primavera Sound. Vogliamo ancora<br />
parlare di rock italiano?<br />
Stefano Pifferi<br />
10 11
Tu n e-In L’hardcore non morirà mai ma tu sì, urlò il ragazzo dalla<br />
strada. Stuart Braithwaite in diretta dall’Alcatraz ci<br />
racconta i Mogwai, Glasgow e il settimo album...<br />
Mogwai<br />
—(Un)happy hardcore—<br />
Testo: Simone Madrau<br />
Checchè si possa dire dei vari Slint, i Mogwai rimangono<br />
probabilmente il gruppo post-rock per<br />
eccellenza, quantomeno sul piano dei numeri. Ancora<br />
oggi la band di Glasgow è un caposaldo per tutti gli<br />
appassionati del genere, un nome in grado di catalizzare<br />
attenzioni e presenze sotto il palco anche dopo<br />
le ultime controverse uscite. La più recente di queste,<br />
Hardcore Will Never Die, But You Will è lo spunto per<br />
una chiacchierata con Stuart Braithwaite in persona, in<br />
una saletta riservata dell’Alcatraz, in occasione della recente<br />
data milanese del gruppo.<br />
Il nostro fa il suo ingresso nella stanza già sorridente<br />
e visibilmente smanioso di dare il proprio meglio<br />
sul palco. A dispetto di un’affabilità che non avremmo<br />
dato per scontata, non è facile ottenere risposte molto<br />
eloquenti; emerge però con chiarezza come quel giovane<br />
indie-rocker scozzese sia rimasto tale, nei modi<br />
oltre che nei fatti: consapevole magari dello status raggiunto<br />
dal suo gruppo ma ancora refrattario a qualsivoglia<br />
sensazionalismo e totalmente focalizzato sulla<br />
sua musica.<br />
I titoli dei vostri dischi hanno sempre delle storie<br />
curiose alle spalle. Riguardo a questo nuovo, so che<br />
il termine hardcore si riferisce alla happy hardcore:<br />
un genere che credevo passato di moda negli anni<br />
90. Ma so anche che c’è di mezzo un ragazzino di<br />
Glasgow...<br />
Hai ragione sulla happy hardcore e in realtà non sta tornando<br />
di moda neanche a Glasgow: eppure, soprattutto<br />
nelle fasce più giovani, c’è chi è ancora assuefatto a<br />
questo genere che noi invece troviamo estremamente<br />
noioso. Nel caso specifico abbiamo sentito pronunciare<br />
questa frase dal ragazzino che hai citato. Voleva comprare<br />
dell’alcol in un negozio ma il titolare si rifiutava<br />
di venderglielo, così lui gli ha urlato questa frase ed è<br />
scappato. Il suono di questa espressione ci ha colpito e<br />
da lì abbiamo estrapolato il titolo dell’album.<br />
Per la registrazione e la pubblicazione di questo<br />
nuovo disco avete impiegato pochi mesi. Cosa mi<br />
dici circa la creazione delle nuove canzoni, ci è voluto<br />
molto tempo per comporle?<br />
Abbiamo lavorato ai demo delle nuove canzoni ciascuno<br />
per conto nostro, poi una volta incisi i demo delle<br />
singole parti li abbiamo provati tutti insieme e infine<br />
siamo entrati in studio a registrarli. Non abbiamo mai<br />
impiegato troppo tempo per lavorare su un nuovo disco.<br />
Quando decidiamo che è il momento di comporre<br />
nuovo materiale ci mettiamo all’opera, e finchè il disco<br />
non è finito non ci concediamo alcuna pausa, anzi programmiamo<br />
ogni cosa in modo che niente intervenga<br />
nel mezzo: solo lavoro, lavoro, lavoro.<br />
Nonostante il fatto che siate tornati a farvi produrre<br />
da Paul Savage, l’album suona molto diverso da<br />
Young Team. Suonate come un gruppo che va molto<br />
più dritto al sodo rispetto al passato.<br />
E hai ragione, infatti. Però ci tengo a dire che non è<br />
qualcosa di intenzionale: quando siamo in studio ci<br />
concentriamo semplicemente sulla realizzazione dei<br />
brani, ragionando molto poco su cosa vogliamo o su<br />
quanto vogliamo cambiare rispetto a questo o a quel<br />
disco. Anch’io la penso come te, davvero, e come me<br />
credo tutto il gruppo: ma sono considerazioni a cui<br />
arriviamo solo una volta che riascoltiamo il materiale<br />
finito.<br />
Durante una carriera musicale così lunga, le vostre<br />
vite private sono sicuramente cambiate. Quanto<br />
del vostro vissuto influenza i vostri lavori?<br />
Bè ora ho 34 anni e dieci anni fa ne avevo 24. E’ una<br />
fascia di età in cui per forza di cose molti aspetti della<br />
tua vita cambiano. Questo però ha poco a che fare con i<br />
cambiamenti sul piano strettamente tecnico: se i dischi<br />
sono diversi, è ovviamente solo perchè abbiamo voluto<br />
sperimentare nuove strade. Una questione di testa,<br />
diciamo. E lo stesso dicasi, in realtà, anche sul piano dei<br />
contenuti: cerchiamo di emozionare chi ci ascolta ma<br />
durante il lavoro in studio non siamo emozionati, non<br />
dalle nostre esperienze personali almeno. Quando lavoriamo<br />
sulle canzoni cerchiamo di isolarci e pensare<br />
solo alla musica: probabilmente poi non ci riusciamo<br />
davvero del tutto ma posso assicurare che, se c’è un<br />
condizionamento da parte del nostro vissuto, esso avviene<br />
a livello puramente inconscio.<br />
Rano Pano ha questa andatura che la rende la cosa<br />
più cantabile che abbiate mai composto. Un po’ la<br />
vostra Seven Nation Army.<br />
E’ una canzone piuttosto insolita per noi, con una me-<br />
12 13
lodia molto forte di cui siamo effettivamente molto<br />
soddisfatti. Piuttosto antemica, è vero. Anche se non<br />
riesco a immaginare migliaia di persone che la cantano<br />
in coro. Non che mi dispiacerebbe, anzi, ma quella<br />
melodia in crescendo mi fa venire in mente qualcosa di<br />
più epico e solitario, alla Ennio Morricone per intenderci.<br />
Un autore che inevitabilmente amiamo.<br />
Mexican Grand Prix è di fatto una canzone. Qualcuno<br />
la paragona ai Neu, qualcun altro agli Stereolab,<br />
nessuno ai Mogwai.<br />
In effetti è un altro brano lontano dai nostri standard.<br />
John (Cummings, altra chitarra dei Mogwai) ha riversato<br />
lì tutta la sua passione per il kraut-rock, certamente,<br />
e in particolare per i Kraftwerk e i Neu. Le parti di batteria<br />
invece le dobbiamo ai Suicide, un altro dei nostri<br />
gruppi preferiti. Ma a parte questo abbiamo cercato di<br />
personalizzare il brano, soprattutto con l’implemento<br />
della voce, successivo alla versione che avevamo sul<br />
demo. Ha reso tutto più imponente. Siamo felici del<br />
risultato.<br />
In You’re Lionel Richie c’è un recitato in italiano. Da<br />
dove arriva?<br />
E’ opera di Dr Kiko, un dj italiano che è anche nostro<br />
amico di vecchia data. Avevamo registrato queste parti<br />
vocali che fanno da intro a George Square Thatcher<br />
Death Party in gaelico, giapponese, italiano e francese.<br />
Kiko aveva fatto la parte italiana e questo per lui è stato<br />
una specie di test, siccome l’avevamo registrato al telefono<br />
e intendevamo fare lo stesso anche con il racconto<br />
che recita in You’re Lionel Richie. Ci pareva che l’effetto<br />
finale si adattasse bene all’atmosfera del brano.<br />
Vi considerate una band hardcore in qualche misura?<br />
In senso musicale certamente no, e tantomeno in sen-<br />
so umano o attitudinale. Ci sentiamo casomai vicini<br />
al mondo hardcore in termini di estrazione e di modo<br />
di intendere la musica, nel senso che proveniamo da<br />
quello stesso genere di sottocultura diy che è elemento<br />
di congiunzione tra gruppi indie-rock come il nostro<br />
e gruppi hardcore veri e propri.<br />
Cosa pensi delle molte altre band in giro che vengono<br />
generalmente connesse ai Mogwai o che si dichiarano<br />
per prime influenzate dal vostro lavoro?<br />
Credo che ci siano un sacco di band che vengono connesse<br />
a noi o vengono paragonate tra loro senza avere<br />
di fatto molto in comune. Notoriamente non amiamo<br />
le categorizzazioni e tantomeno ci piace essere considerati<br />
i capi di qualcosa. Però, per quanto suoni banale,<br />
nel momento in cui sono i gruppi stessi a dichiararsi<br />
influenzati dal nostro lavoro, lo apprezziamo. Lo apprezziamo<br />
eccome.<br />
Per finire: che mi dici della vostra etichetta, la Rock<br />
Action Records? E cosa ci dici circa l’undergorund<br />
della tua città in questo momento? Ci sono dei nomi<br />
che vale la pena di tenere d’occhio?<br />
Per quanto riguarda Rock Action abbiamo in uscita il<br />
secondo album dei Remember Remember, il terzo degli<br />
Errors e l’esordio di Blank Mass, side-project di Ben<br />
dei Fuck Buttons. Direi che stiamo attraversando un<br />
buon periodo. Per quanto riguarda Glasgow non saprei<br />
farti un nome in particolare nell’underground attuale:<br />
certo è che ci sono un sacco di gruppi interessanti, la<br />
scena cittadina è sempre attiva. Magari mancano una<br />
linea comune, un genere o una scuola di riferimento<br />
in particolare, ma d’altra parte non c’erano nemmeno<br />
quando abbiamo cominciato noi.<br />
L’appuntamento è tutti i mesi con il digital magazine in pdf<br />
e tutti i giorni su<br />
www.sentireascoltare.com<br />
News, concerti, recensioni, contest, approfondimenti<br />
tutto GRATIS<br />
e a portata di un click<br />
14 15<br />
anche su
Tu n e-In Trad-folk, letteratura, magia sporcata di psichedelia ed<br />
elettronica. Intervista a Erland Cooper per il sophomore<br />
del suo carnevale: un disco che mancava alla terra<br />
d’Albione<br />
Erland And<br />
the Carnival<br />
—Psych folk dal ventre della nave—<br />
Testo: Marco Boscolo<br />
sul treno, sto raggiungendo il resto<br />
della band negli studios della BBC a<br />
“Sono<br />
Manchester. Se cade la linea, richiamami:<br />
spero non succeda troppo spesso”. La voce all’altro<br />
capo del telefono è quella di Erland Cooper, il cui nome<br />
sta circolando di bocca in bocca tra gli appassionati di<br />
folk britannico (e non solo) assieme a quello di Simon<br />
Tong e David Nock. Insieme rispondono alla sigla sociale<br />
di Erland and the Carnival e il loro secondo disco,<br />
Nightingale, uscito il mese scorso, ci ha sorpreso positivamente,<br />
andando a riempire un vuoto, quello del<br />
folk magico-psichedelico, rimasto per qualche tempo<br />
senza nessuno che lo riempisse. È una tradizione che<br />
all’interno del panorama britannico ha radici profonde<br />
e che è emersa in superficie soprattutto con il revival<br />
degli anni Cinquanta e Sessanta, grazie a personalità<br />
come Davey Graham, il Bert Jansch solista o nella sua<br />
formazione più nota, i Pentangle (“Jansch ha avuto<br />
l’inestimabile pregio di far conoscere a un’audience<br />
molto più vasta di quella degli appassionati la tradizione<br />
folklorica della musica britannica”, ci fa sapere dal<br />
suo cellulare Erland). Non sono ovviamente che la superficie<br />
di un intero filone musicale. Molti altri saranno<br />
i nomi da aggiungere alla lista, nomi che in un fase leggermente<br />
successiva amplieranno ancora il discorso,<br />
ma Jansch e Graham sono quelli che poi ricorreranno<br />
nella conversazione con Cooper.<br />
er l a n D an D th e ca r n i v a l<br />
A mettere insieme i tre ci ha pensato il comune amore<br />
per la musica, seppure declinato in storie e con personalità<br />
molto diverse, che li ha portati a registrare assieme<br />
alcuni tradizionali scozzesi e inglesi. Ci si trova<br />
bene, ci si ritrova per suonare insieme e nella migliore<br />
tradizione serendipica, ci si ritrova con un disco tra le<br />
mani, l’esordio omonimo: una mistura personalissima<br />
di acid folk e amenità pysch varie, prese dalla tradizione<br />
ma anche da quello che offre il contemporaneo.<br />
È il 2010 e, nemmeno dodici mesi dopo, ci rigiriamo<br />
tra le mani l’opera seconda, che per intensità lirica,<br />
complessità e raffinatezza di arrangiamenti, atmosfere<br />
oscure e haunting style rappresenta un salto in avanti<br />
notevole. Alcuni storceranno il naso, adducendo che<br />
non si tratta più di trad-folk, che i tre si sono lasciati<br />
prendere la mano e che hanno deviato pesantemente<br />
dalla strada dei padri. Può sembrare così per gli innesti<br />
elettronici e l’accentazione ancor più psichedelica che<br />
hanno preso le composizioni, ma l’animo della band rimane<br />
legato alla tradizione. Non solo quella musicale<br />
dei già citati Graham e Jansch, ma anche quella letteraria,<br />
con testi che pescano dalle pagine di politica e<br />
cronaca dei quotidiani, dal Libro Egizio dei Morti, dalla<br />
letteratura e dalla poesia. Musicalmente si ritrovano<br />
nel solco (splendente) dei primi Coral e di quel progetto<br />
estemporaneo che è stato The Good The Bad And<br />
The Queen.<br />
Un progetto, quello che vedeva alla voce il sempre<br />
attivissimo Damon Albarn (che ha prestato il proprio<br />
studio per le session dell’esordio), al quale ha partecipato<br />
uno dei due veterani del gruppo, quel Simon Tong<br />
che è noto per il suo passato con i Verve. Anche la sezione<br />
ritmica e il sound engeneering non sono affidati<br />
a un ragazzino, ma a David Nock, batterista di lusso per<br />
McCartney (con i Fireman) e con una parentesi anche<br />
negli Orb. Erland, invece, è più giovane e meno noto,<br />
ma mosso da grande passione per lo studio e la ricerca<br />
di trascrizioni di antiche canzoni e melodie. Le sue radici<br />
affondano nelle isole Orkney, a nord della Scozia,<br />
un luogo che già per la sua collocazione spinge a suggestioni<br />
bucoliche. Cooper, però, non pare lo trasformi<br />
in un luogo particolare, un locus amoenus letterario, e<br />
nella nostra conversazione non le citiamo nemmeno.<br />
Però lasciateci almeno scrivere che viene spontaneo<br />
associarle ad altre isole, le Aran, disposte come vertebre<br />
di un animale gigantesco poco fuori dal golfo di<br />
Galway, in Irlanda, un luogo in cui la musica, e la musica<br />
folk, è parte della stessa aria che si respira.<br />
st u D i o ma t t o e aP P a s s i o n a t o<br />
E se le isole sono luogo d’ispirazione par excellence,<br />
ricordiamoci sempre che l’intera Gran Bretagna è un<br />
arcipelago di isole, alcune molto grandi, ma pur sempre<br />
isole. Un pensiero che deve aver attraversato anche<br />
la mente di Ralph Vaughan Williams, compositore<br />
e musicista britannico, che nella prima metà del secolo<br />
scorso si mette in strada per andare a raccogliere un<br />
16 17
patrimonio musicale e canzonistico popolare che può<br />
essere fatto risalire addirittura al periodo dei Sassoni.<br />
Delle sue attività da, diremmo oggi, etnomusicologo,<br />
più che ad Alan Lomax, Williams è accostabile a Béla<br />
Bártok e Zoltán Kodály, che insieme girano l’attuale Romania<br />
e Ungheria (allora parte dell’Impero Austroungarico)<br />
per raccogliere e trascrivere melodie e ballate. Di<br />
questa esperienza Williams ha lasciato una collezione<br />
che riempie almeno un museo a sud di Londra e la Vaughan<br />
Williams Memorial Library nella capitale: “magari<br />
non ci ho passato due anni come si legge in giro. Il fatto<br />
è che si tratta di un’istituzione importante per la storia<br />
della musica britannica, perché ne conserva una grande<br />
fetta di tradizione. Quattro o cinque anni fa il mio<br />
interesse per questo genere di cose si è fatto più serio,<br />
proprio quando ho scoperto che vicino a dove abitavo,<br />
tra Londra e Brighton, c’è questa enorme collezione di<br />
manoscritti, registrazioni sul campo, edizioni complete<br />
e altri tesori della tradizione. Quello che ho fatto è stato<br />
semplicemente di andarci il più spesso possibile”.<br />
Accanto ai repertori folk che “ti permettono di conoscere<br />
nuovi artisti semplicemente seguendo l’evolversi<br />
delle interpretazioni magari di una sola canzone”, Erland<br />
Cooper e il suo carnevale psichedelico sembrano aver<br />
forti interessi anche nella tradizione letteraria britannica.<br />
Solo a raccogliere le allusioni e le citazioni contenute<br />
nelle canzoni di Nightingale, c’è da riempire un volume<br />
di storia della letteratura: Charles Dickens, soprattutto<br />
per quanto riguarda la Londra vittoriana descritta in Oliver<br />
Twist; Lewis Carrol (se non è un viaggio psichedelico<br />
quello di Alice nel paese delle meraviglie, che cosa lo è?)<br />
e la poesia di Thomas Stearns Eliot. “Ma non voglio sembrare<br />
intelligente o che so io. Quello che mi interessa, e<br />
che interessa anche gli altri membri della band, è che i<br />
testi suonino bene, che vadano a braccetto con la musica.<br />
Carrol o Dickens sono solo argomenti di cui è capitato<br />
di parlare assieme, ma dove poi ognuno di noi vada a<br />
scovare la propria ispirazione quando scrive, questo è un<br />
altro discorso”. Ragionamento che viene contraddetto<br />
qualche interruzione telefonica più tardi: “mi piace che<br />
i testi delle canzoni siano ben scritti e che possano essere<br />
letti autonomamente, come se fossero vere e proprie<br />
poesie”. Oppure a quando ci racconta di perché hanno<br />
deciso di musicare una parte del testo di Dream of the<br />
Rood, un poema antichissimo, scritto in una lingua che<br />
assomiglia di più al sassone di Ivanohe che all’inglese di<br />
oggi. In una classica situazione da nerd e secchioncelli,<br />
“ci siamo chiesti quale fosse la più antica canzone della<br />
tradizione britannica di cui ci fosse rimasta traccia. E da<br />
lì siamo arrivati obbligatoriamente a quel testo”. Quindi<br />
qualche ambizione anche in questo senso c’è, o no? L’im-<br />
pressione generale, dovuta anche al fatto che il disco sta<br />
andando molto bene in Gran Bretagna e il tour alle porte,<br />
è che Cooper non voglia apparire pubblicamente come<br />
quello che la sa troppo lunga. Un genere di personaggi,<br />
quello dei saputelli, che raramente ha fatto scaturire<br />
grandi innamoramenti del pubblico.<br />
Tornando alla canzone, l’oscuro autore del testo originale<br />
racconta di essere rapito in sogno dall’apparizione<br />
di un angelo del cielo. Ecco, il sogno, un elemento<br />
importante per tutte le composizioni della band. “Sì,<br />
credo che effettivamente ci sia una connessione, nemmeno<br />
troppo oscura, tra la dimensione del sogno e la<br />
psichedelia”. In entrambi i casi si tratta di aperture verso<br />
dimensioni altre e le due esperienze, quella onirica<br />
e quella psichedelica, sono accomunate dalla cifra del<br />
viaggio, una delle grandi metafore dell’arte, basti pensare<br />
al ruolo che ha il viaggio nelle favole e nei romanzi<br />
di formazioni. Ma Erland Cooper sogna per fuggire dalla<br />
realtà? “Non credo che si tratti di fuga, di escapismo.<br />
Credo più che altro che fare musica sia mettere insieme<br />
parole e suoni per creare qualcosa di nuovo che prima<br />
non c’era”. Non un semplice viaggio, ma un vero atto di<br />
creazione di un mondo intero. Nel loro caso racchiuso<br />
nei pochi minuti di una canzone.<br />
il v e n t r e De l l a na v e<br />
Il disco è stato registrato in una nave attraccata sul Tamigi,<br />
in pieno centro a Londra, ma dando l’impressione<br />
alla band di stare completamente in un altro posto. “È<br />
capitato quasi per caso di poter avere in prestito il posto,<br />
ma ha avuto il grande vantaggio che ci ha permesso<br />
di registrare e suonare quando meglio credevamo, senza<br />
doverci preoccupare troppo di orari e costi di affitto<br />
di uno studio vero e proprio. Uscivamo, andavamo ai<br />
concerti e se avevamo voglia di suonare nel cuore della<br />
notte sapevamo che potevamo farlo”. Eh sì, oramai basta<br />
un laptop per registrare adeguatamente la musica<br />
ed è un attimo immaginarsi questi pirati moderni prendere<br />
possesso del loro vascello durante la notte, quando<br />
i broker della City e i turisti di passaggio sono oramai<br />
rinchiusi nei pub o rincitrulliti davanti alla televisione, e<br />
cominciare un viaggio/sogno nella musica.<br />
L’ambiente in cui è stato registrato Nightingale non<br />
ha, però, fornito solo comodità e ispirazione, ma ha<br />
messo il proprio marchio sulle registrazioni. “È vero, nel<br />
disco ci sono un sacco di riverberi naturali, dovuti al fatto<br />
che stiamo in mezzo al fiume nel ventre di una nave,<br />
che hanno contribuito in modo determinante all’atmosfera<br />
di molti dei pezzi. Ma il contributo della venue non<br />
si è fermato qua. Abbiamo anche registrato voci di passanti,<br />
rumori vari, che percepiti da lì dentro erano strani,<br />
evocativi. Sono suoni che in parte sono finiti nel disco”.<br />
une t o u c h e De él e c t r o n i q u e<br />
Qualche computer, una stiva e lo studio è fatto. Ma la<br />
ricerca di Erland Cooper e compagni ha fatto prendere<br />
decisioni ben precise sui suoni. “Abbiamo usato il<br />
computer solo per registrare, mentre quasi tutto il resto<br />
è prodotto da noi. Abbiamo preferito usare vecchi<br />
sintetizzatori che adesso si comperano per pochi soldi<br />
piuttosto che usare suoni prodotti da un software. La<br />
mia tastiera preferita, e la uso moltissimo nel disco, è<br />
un vecchio modello della Yamaha che ho comperato<br />
su eBay per 99 sterline. Ha un suono che mi fa pensare<br />
subito agli anni Ottanta e in più è unico, fatto che conferisce<br />
anche alla nostra musica una personalità precisa,<br />
non assimilabile ad altro”. Mentre la linea cade per<br />
l’ennesima volta e Erland oramai si è stufato di parlare<br />
a singhiozzo, mentre il suo treno sta entrando nella periferia<br />
di Manchester, dall’altro capo del telefono non<br />
possiamo che dirci d’accordo. Chissà se ci ha sentito.<br />
18 19
Cesare Basile<br />
Paolo Benvegnù<br />
MarCo Parente<br />
Dr o p ou t<br />
—L’insostenibile pesantezza<br />
del cantautorato rock—<br />
Tre dischi alieni piovuti nel volgere<br />
di pochi giorni sullo scenario<br />
rock italiano. A rammentarcene<br />
l’intensità perduta. Tre interviste<br />
per scavare nel vivo.<br />
Testo: Stefano Solventi,<br />
Fabrizio Zampighi<br />
I n ordine di apparizione su questo sciagurato pianeta: Cesare<br />
Basile, Paolo Benvegnù e Marco Parente, rispettivamente<br />
classe ‘64, ‘65 e ‘69. Il primo esordisce coi Candida Lilith sul finire<br />
degli Ottanta, Benvegnù avvia l’avventura Scisma nel ‘93, Parente<br />
debutta in solitario nel ‘97 dopo alcune eccellenti collaborazioni<br />
(coi CSI, ad esempio). Storie diverse le loro, come diversa è la calligrafia.<br />
Eppure hanno molto in comune, oltre al fatto d’essere nati<br />
nei Sixties e di aver fatto uscire i nuovi lavori in queste settimane.<br />
Nella diversità delle premesse e degli esiti, la loro musica definisce<br />
un’interazione profonda tra testo e suoni, persegue un’intensità<br />
che esige dall’ascoltatore una forte partecipazione emotiva ed<br />
intellettuale. In conseguenza di ciò, lo stile acquista una peculiarità<br />
inconfondibile: per la forma e la struttura delle canzoni, per le<br />
tematiche trattate e lo sviluppo delle argomentazioni, per il timbro<br />
e le inflessioni canore. C’è, insomma, un fare perno sul proprio<br />
20 21
quid poetico, sull’unicità del proprio manifestarsi, che di per sé rappresenta<br />
elemento cardine dell’espressione.<br />
Pur rischiando la trappola della generalizzazione, è evidente lo scarto rispetto<br />
alle generazioni successive dei cantautori rock, la cui missione sembra<br />
semmai quella di incarnare un pensiero debole che ama presentarsi con<br />
le sembianze del passato. Gli anni Zero dei Bugo, dei Dente, dei Brunori<br />
Sas, dei Vasco Brondi e via discorrendo, sembrano impegnati a resuscitare<br />
fantasmi del passato più o meno remoto (una più o meno definita poltiglia<br />
Battisti, Gaetano, Tenco ibridata all’uopo con modalità lo-fi, hip-hop,<br />
noise...), aggiornandone e distorcendone il verbo, vestendosene come un<br />
alibi, mascherandosi d’un linguaggio altrimenti irreperibile. E’ come se da<br />
un certo punto in avanti fosse venuto a mancare il coraggio d’essere pienamente<br />
e soltanto se stessi. Come se il presente soffrisse d’incompletezza<br />
rispetto a ciò che è stato. Come se l’incidenza del rock nelle questioni di<br />
fondo dell’esistere - dall’impegno politico alla riflessione poetico/filosofica<br />
- rappresentasse un evento inopportuno e a tratti persino illecito. Anche il<br />
più “impegnato” e impegnativo Brondi AKA Le luci della centrale elettrica,<br />
a ben vedere non fa altro che abbozzare quadri folgoranti pennellando<br />
slogan come schiaffi, esaurendo la critica nella pratica - nella tecnica - della<br />
rappresentazione.<br />
Non è certo nostra intenzione gettare la croce sulle nuove leve, che anzi<br />
riflettono puntualmente la diversità delle premesse in cui si trovano ad agire.<br />
Lo spazio vitale del rock - da sempre minoritario però storicamente fiero<br />
nel suo porsi come alternativa critica al nazionalpopolarismo - ha visto<br />
progressivamente ridursi le quote di partecipazione alla centrifuga dello<br />
shobiz, vittima impotente dei criteri di selezione delle playlist e incapace di<br />
guadagnarsi più che squarci sottilissimi ed equivoci di attenzione televisiva.<br />
Con la polverizzazione della cultura antagonista, ormai priva di leader<br />
autorevoli anzi riconoscibili, espulsa come corpo estraneo dalle dinamiche<br />
istituzionali, il rock è rimasto ideologicamente solo. Si è trovato nella<br />
posizione di dover lottare per camminare sulle proprie gambe, e quindi<br />
ha sgomitato per recuperare un aspetto appetibile, intrigante, capace di<br />
guadagnarsi fettine di palinsesto. Alternativo sì, ma non troppo profondo,<br />
casomai bizzarro ma pur sempre leggero e comunque potabile, ché altrimenti<br />
nessuno ti sopporta, nessuno è disposto a concederti ascolto. Impatto<br />
sulla quotidianità prossimo allo zero, ma almeno sei un tipo divertente,<br />
arguto, con un tot di serate garantite e forse pure l’intervista alla radio.<br />
Non è più tempo, non è più un mondo, per “dischi che ti cambiano la vita”<br />
o che falliscono provandoci. Non si cresce più con questa eventualità come<br />
compagna di viaggio: il disco, fenomenologia obsoleta, format espressivo<br />
dalle premesse decadute, è un vezzo a perdere. Un passatempo casomai<br />
arguto, a tratti e con moderazione. Pensarlo latore di massimi sistemi suona<br />
come una velleità risibile. Ecco perché i tre dischi di cui ci occupiamo<br />
questo mese e i loro autori fanno un po’ la figura degli alieni, appaiono tanto<br />
desueti quanto affascinanti, come una trasmissione radio da un mondo<br />
sul punto di estinguersi. Intendiamoci, è normale che esistano dischi così,<br />
perché nel consueto divenire delle cose il trapasso non avviene per cesure<br />
ma con un sovrapporsi di modalità e forme: lo ieri prosegue nell’oggi come<br />
un’onda lunga che si ostina residua fin nel domani. Tuttavia, la loro contemporanea<br />
apparizione ha la pregnanza di un monito, o di un colpo di coda.<br />
Dare loro ascolto è anche un esercizio di (r)esistenza. Siano benvenuti.<br />
ce s a r e Ba s i l e : l a r i v o l t a De l Do l o r e<br />
Il titolo, innanzitutto. Si può spiegare un titolo come Sette pietre per<br />
tenere il diavolo a bada?<br />
Un titolo del genere può essere raccontato in mille modi diversi e tutti affascinanti,<br />
più semplicemente è uno scongiuro, un’esorcismo, la formula di<br />
un rituale quotidiano.<br />
Hai scritto “vale ancora la pena di perdersi per ritrovarsi con un gran<br />
disco fra le mani”. E’ andata proprio così? E’ un disco nato senza un<br />
vero progetto?<br />
Sì. Canzoni scritte e registrate in circa due anni, senza sapere bene dove<br />
stessi andando a parare. Due anni difficili, pieni di confusione, voglia di<br />
smettere, scoramento, con le canzoni che continuavano a venire nonostan-<br />
22 23
te tutto. E le canzoni hanno vinto e mi hanno salvato... Almeno per questo<br />
giro.<br />
Dopo tre album affidati a nomi come Hugo Race, John Bonnar e John<br />
Parish, torni ad essere il principale produttore di un tuo disco. Sbaglio<br />
a leggerci la voglia d’indagarti più a fondo, senza filtri o interferenze?<br />
Anche questa non è stata una scelta. Diciamo che la genesi del lavoro mi ha<br />
portato naturalmente a fare a meno di un produttore, visto che non ci sono<br />
stati dei tempi di lavorazione programmati e quindi non potevo chieder a<br />
nessuno di stare dietro alle mie paturnie. Ho prodotto questo disco in maniera<br />
istintiva, sul momento, affiancato da persone come Guido Andreani,<br />
Luca Recchia e Lorenzo Corti che mi hanno seguito nel disordine dei miei<br />
appunti.<br />
Anche la lista dei collaboratori sembra riflettere il desiderio di non giocare<br />
sull’appeal da “ospite d’onore”. Parliamo pur sempre di musicisti<br />
d’eccezione, come Lorenzo Corti, Roberto Angelini, Rodrigo D’Erasmo<br />
degli Afterhours e i due Mariposa (tra le altre cose) Alessandro Fiori ed<br />
Enrico Gabrielli. Quanto sono stati funzionali alle tue esigenze espressive,<br />
e quanto hanno contribuito a determinare l’aspetto definitivo<br />
del disco?<br />
Non sono mai stato affascinato dall’appeal dell’ospite d’onore, ho sempre<br />
avuto amici a suonare nei miei dischi. Condividere le mie canzoni con persone<br />
che stimo mi aiuta a distaccarmi dalle canzoni stesse, a non coltivare il<br />
mio ego dentro quelle canzoni. E ognuno di quelli che hai citato se n’è preso<br />
un pezzo di canzone e l’ha fatta sua rendendo suo anche tutto il disco.<br />
Tra folk cantautorale, blues mediterraneo e afflato orchestrale balcanico,<br />
è difficile definirlo un album rock. Eppure è senza dubbio un album<br />
rock. Sei d’accordo?<br />
Il rock è guardarsi intorno, ascoltare, prendere cose alla rinfusa, sbatterle<br />
dentro un scatola, agitarla e ributtare tutto su un tavolo da gioco. Credo di<br />
aver fatto questo. E’ un disco di rock.<br />
Elon lan ler è stata incisa a Skopje, con l’Orchestra della Radio Televisione<br />
Nazionale Macedone, per la colonna sonora di My world is upside<br />
down, film-documentario sul musicista macedone Frane Milenski Jezek,<br />
che per la verità non conosco affatto. Come hai finito per esserne<br />
coinvolto?<br />
Mi ha contattato Petra Salisker, una documentarista slovena che aveva deciso<br />
di raccontare la vita di questa sorta di funambolo del palcoscenico,<br />
Jezek appunto. Ho scoperto un personaggio poliedrico che passva dallo<br />
scrivere canzoni al mettere in scena spettacoli per bambini, piuttosto che<br />
show televisivi e iniziative contro il governo per le quali è finito diverse volte<br />
in carcere. Era uno che sapeva raccontare e aveva capito che il racconto<br />
è il cuore dell’arte e che l’arte può essere mortale per il cuore del Potere.<br />
Petra ha chiesto a diversi musicisti della scena internazionale, tra cui Robert<br />
Fisher, Hugo Race e Chris Heckman, di riscrivere e reinterpretare nelle<br />
rispettive lingue alcune fra le canzoni di Jezek a dipanare il filo della sua<br />
vita. E’ stata un’esperienza molto forte e formativa e in questo sono stato<br />
affiancato da John Bonnar che ha scritto gli arrangiamenti d’orchestra.<br />
Uno dei momenti emotivamente più forti del programma coincide con<br />
La Sicilia havi un patruni, pezzo firmato Ignazio Buttitta e Rosa Balistreri.<br />
Una canzone del ‘78, se non erro. Però sembra di mille anni fa, o<br />
di domani. C’è un motivo particolare per cui l’hai inclusa nell’album?<br />
Perchè questa canzone parla di una Sicilia offesa e sfruttata, spesso anche<br />
accondiscendente verso i suo mali, una Sicilia che oggi come allora ha bisogno<br />
di piazza, di coscienza civile, di ritrovare una identità oltraggiata da<br />
150 anni di asservimento allo Stato Italiano e ai poteri mafiosi.<br />
A proposito di Sicilia, farai un tour tutto siciliano su iniziativa de L’Arsenale,<br />
Federazione Siciliana delle arti e della musica. Nelle note stampa<br />
ne parli come una sorta di atto dovuto, di una maledizione, di un<br />
legame con la tua terra che non c’è modo di spezzare. Che sapore ha<br />
portare la tua musica ai siciliani?<br />
E’ un legame con il quale mi sono riconciliato, mi sono arreso all’amore che<br />
ho per la mia terra e in questo tempo in cui nessuno vuole fare la sua parte<br />
ho deciso di farla la mia parte insieme ad altri uomini e donne che sognano<br />
per la Sicilia un presente diverso, una cultura dell’appartenenza fatta di<br />
scelte e di dignità.<br />
Tempo fa Dori Ghezzi ha rilasciato una dichiarazione del tipo “Vasco<br />
Rossi è l’erede di Fabrizio De André”. Ti confesso, mi ha sconcertato,<br />
anzi mortificato. Magari se ascoltasse canzoni come Lo scroccone di<br />
Cioran, Il sogno della vipera o E alavò, avrebbe due o tre cose su cui<br />
ponderare. A parte questo, quanto c’è di Faber, più o meno consapevolmente,<br />
nella tua musica?<br />
Ha ascoltato suo marito per tanti anni, non credo abbia bisogno di ascoltare<br />
le mie canzoni per rendersi conto di certe enormità. Mah, a volte penso<br />
che De Andrè sia una sorta di tavola imbandita attorno alle quale si siedono<br />
troppe persone. Per quanto mi riguarda le sue canzoni mi fanno venire voglia<br />
di scrivere le mie, la stessa cosa che mi succede con Leonard Cohen.<br />
Hai un metodo, o comunque c’è una modalità ricorrente con cui componi<br />
e realizzi le tue canzoni?<br />
Forse ho un’abitudine più che un metodo. Mi metto lì e aspetto che arrivino<br />
con la chitarra in braccio.<br />
Due parole sulle tue... parole. Spesso l’elemento atavico, o archetipo, è<br />
centrale. Le pulsioni primarie dirigono la danza. Tradizioni e superstizioni<br />
sembrano farsi beffe della civiltà. La morte tira le fila e l’amore è<br />
al più una consolazione, un’ossessione o una dolce condanna. E’ cantando<br />
la cupezza che si può costruire la speranza?<br />
L’elemento archetipo ha una riconoscibilità immediata e parla al sangue,<br />
aggira il cervello, non ti lascia ragionare, ti costringe alla scomodità e azzera<br />
la civilizzazione. Credo nel racconto del dolore come rivolta.<br />
Appartieni alla generazione dei musicisti pre-internet, formati musicalmente<br />
su vinili e magari su audiocassette. Sono nato anch’io nei<br />
Sessanta, so che esisteva una difficoltà oggettiva nel reperire dischi,<br />
soprattutto certi dischi e fuori da certi circuiti. Credi che l’attuale accessibilità<br />
dello scibile musicale sul web rappresenti una risorsa per il<br />
musicista del terzo millennio?<br />
C’era un’esigenza che educava alla ricerca, e questo dava un valore diverso,<br />
un’emozione unica ad ogni scoperta letteraria o musicale, una parola<br />
piuttosto che un suono. Se c’è un limite nella rete è che rende tutto troppo<br />
facile e questo, per i più, determina una perdita di valore della scoperta. Di<br />
contro la possibilità di veicolare notizie e controinformazione ha cambiato<br />
per sempre la comunicazione ed emancipato voci che altrimenti non potremmo<br />
sentire.<br />
Cosa significava fare un disco ai tempi del tuo debutto, quasi un quar-<br />
24 25
to di secolo fa, coi Candida Lilith? E cosa significa oggi?<br />
Io scommetto oggi come allora. Forse oggi è l’educazione alla scommessa<br />
che manca, sembra che tutto sia dovuto, soprattutto il successo, e non si<br />
capisce che fare dischi, scrivere, raccontare è di per sè una avventura meravigliosa,<br />
che il processo creativo è fatto di disciplina e non di posto fisso.<br />
Sulla nostra webzine abbiamo affrontato l’argomento della crisi della<br />
discografia, intesa come passaggio da un’epoca - coi suoi meccanismi,<br />
i codici, i rituali... - ad un’altra ancora da decifrare. Quanto ti preoccupa<br />
come professionista e come artista il momento che sta vivendo<br />
l’industria discografica?<br />
Non me ne frega niente. Comincerò a preoccuparmi solo quando non si<br />
scriveranno più canzoni. L’industria discografica è una cloaca a cielo aperto,<br />
va ricoperta di calce viva.<br />
Hai suonato un po’ ovunque, e continui a farlo. Mi giunge voce che sia<br />
in corso una fioritura di spazi dedicati al rock, soprattutto in determinate<br />
zone (in Emilia, ad esempio). Altrove, invece, pare che regni la<br />
consueta desolazione. Per quantità ed ovviamente anche per qualità,<br />
qual è la tua sensazione riguardo allo stato dei locali da concerto in<br />
Italia?<br />
Suonare e ascoltare implica una condivisione del rischio fra artista, pubblico<br />
e proprietario di locale. Ricreando questa sorta di interazione si può<br />
ricostruire un circuito fatto di condivisione e partecipazione.<br />
La musica invece a quanto pare non conosce crisi. Dal basso soprattutto,<br />
dal calderone dei cosiddetti emergenti, arrivano segnali di vitalità<br />
che autorizzano a ben sperare. Dalla Sicilia, ad esempio. Uno di questi<br />
segnali è anche l’ottimo Mellon Collie And The Infinite Power, tributo<br />
al celebre album dei Pumpkins organizzato dagli Albanopower che ha<br />
coinvolto numerose realtà sicule. Tu hai contribuito con una eccellente<br />
Bullet With Butterfly Wings. Roba da andarne fieri, no?<br />
In quella canzone ho suonato solo le percussioni, il grosso del lavoro è stato<br />
fatto dai Feldmann e dalla splendida interpretazione di Micol Martinez .<br />
Guarda, c’è così tanta gente che investe energia, soldi, emotività e sacrificio<br />
che basterebbe per anni. Il problema è la mancanza di rispetto per il cuore<br />
di ognuno di loro.<br />
mar c o Pa r e n t e : f i o r i Da un al t r o Pi a n e t a<br />
La riproduzione dei fiori arriva a cinque anni dalla doppia uscita di Neve<br />
Ridens. Cosa è successo a Marco Parente nel frattempo?<br />
Questi cinque anni sono stati propedeutici e protettivi. Li ho passati a proteggere<br />
il mio istinto e a spegnere alcuni riflettori non troppo grandi, ma<br />
per me ingombranti. Tutto quello che stava succedendo non mi piaceva.<br />
Naturalmente questo ha portato a delle scelte radicali nella mia vita, pagate<br />
anche a caro prezzo. Ho preservato l’istinto, nel senso che ho continuato<br />
a fare ricerca condividendola con altri, quasi fossi un solo lato di un binario.<br />
Ho continuato a scrivere, ho suonato tantissimo da solo, ma ho anche avuto<br />
bisogno di prendere le distanze da quello che poteva essere il mettere in<br />
moto i meccanismi che comporta fare un disco. C’è stata la parentesi Proiettili<br />
Buoni, il duo Betti Barsantini con Alessandro Fiori e allo stesso tempo<br />
ho gettato le basi per un lavoro bi-lingue che dovrebbe uscire il prossimo<br />
anno in condivisione con un songwriter di Portland, Ryland Bouchard<br />
(The Robot Ate Me). In seguito ho portato in giro lo spettacolo teatrale Il<br />
Diavolaccio, che ho messo in piedi un anno e mezzo fa con la persona che<br />
poi mi ha spinto anche a registrare materiale nuovo per il disco, Pierluigi<br />
Fontana. Mi è piaciuta l’idea di tornare a incidere, mettere i puntini sulle<br />
“i”, fare il disturbatore. Cosa che in realtà sono sempre stato, nonostante le<br />
varie “scene” in cui si è cercato di rinchiudermi, anche perchè propongo da<br />
sempre musica che non è difficile ma certamente poco rassicurante.<br />
Una musica, la tua, che forse prevede una certa “interpretazione” da<br />
parte di chi ascolta...<br />
Interpretazione che per me è in realtà “abbandono”, ovvero non porsi troppe<br />
domande e lasciarsi andare a quello che si ascolta. Se sei nella predisposizione<br />
mentale giusta puo’ anche essere che tu ti diverta e che ti piaccia,<br />
senza che ci sia un motivo ben preciso. Questo “non sapere il perchè”, per<br />
me, è abbastanza fondamentale...<br />
Mi spieghi il titolo del disco? Nel brano omonimo pare di capire che<br />
la contrapposizione tra i Fiori del male baudelairiani e i Fiori del bene<br />
“parentiani” sia una metafora. Come se il messaggio che il brano vuole<br />
trasmettere avesse a che vedere con la riscoperta di una felicità individuale<br />
(“fatti il bene, fotti il male”). In questo senso parli di riproduzione?<br />
È un concetto che tende a una sottile ironia, quello del mal di fiori. Qui si<br />
sta parlando di un modo fashion di approcciare la poetica di Baudelaire che<br />
è un travisare continuo. La facilità del lasciarsi cullare dal negativo, il cro-<br />
26 27
giolarsi nelle contraddizioni. Sono<br />
abbastanza stanco da questo modo<br />
di vedere le cose. Il vivere bene di<br />
cui si parla nella canzone può essere<br />
una buon antidoto a questo tipo di<br />
mentalità. Il concetto di “riproduzione”<br />
ha a che fare con il fiore. Il fiore<br />
si riproduce simbolicamente in maniera<br />
autonoma. Mi piaceva il fatto<br />
del produrre bellezza senza doverla<br />
spiegare con il pensiero o con il linguaggio.<br />
Possiamo definire La riproduzione<br />
dei fiori un disco ottimista in<br />
un periodo in cui essere ottimisti<br />
diventa sempre più difficile?<br />
Non mi piace la parola “ottimista”<br />
perchè penso che l’ottimismo, come<br />
del resto il pessimismo, non esita.<br />
Esiste invece la consapevolezza, l’essere<br />
chiari e sinceri con sè stessi, il<br />
darsi un senso. Il farsi delle domande<br />
per cui spesso non ci sono risposte.<br />
Direi che potrebbe essere definito<br />
“positivo”, più che “ottimista”. Anche<br />
perchè tutte le canzoni del disco,<br />
anche quelle più blu come Sempre<br />
(dedicata a Nick Drake) hanno sempre<br />
un risvolto positivo. Nel caso di<br />
Sempre è l’accordo in maggiore.<br />
Personalmente trovo che nei tuoi<br />
dischi risiedano sempre due anime.<br />
Quella legata ai testi, riconoscibile,<br />
in un certo senso familiare<br />
e fors’anche seriale. Nel senso che<br />
in molti brani ci sono elementi che<br />
ritornano, come ad esempio l’antitesi<br />
tra individuo e mondo, bene<br />
e male, niente e tutto. E quella<br />
legata alle musiche, sempre più<br />
trasversali e aperte alla contaminazione.<br />
Sbaglio se dico che il<br />
mondo di Marco Parente nasce<br />
dal giusto equilibrio tra questo<br />
senso di riconoscibilità e una decisa<br />
apertura a livello musicale?<br />
Mi sembra un’analisi corretta. Le<br />
parole hanno a che fare con il linguaggio,<br />
la musica non si sa. E’ un<br />
linguaggio anch’esso ma molto misterioso.<br />
Io tendo sempre dalla par-<br />
te della musica, perchè credo che sia il suono che conferisce il vero significato<br />
al tutto. Anche alle parole. Per quello scrivo canzoni e non libri. A metterle<br />
nero su bianco, a mio modo di vedere, le parole muoiono. E invece la parola<br />
deve vivere grazie alla voce e aquistare significato dal suono. Nel cantautorato<br />
classico non mi è mai piaciuta la pigrizia del voler giustificare tutto con<br />
delle belle parole. E’ importante che invece, prima di tutto, arrivi la musicalità<br />
delle parole. Con questo ovviamente non voglio dire che il testo in sè non sia<br />
importante.<br />
Un elemento piuttosto interessante de La riproduzione dei fiori è il citazionismo<br />
che emerge da alcuni brani: Sympathy For The Devil degli<br />
Stones che salta fuori nella coda de L’omino patologico, L’Hurricane di<br />
Dylan tra le righe di C’era una stessa volta, i Radiohead suggeriti da La<br />
grande vacanza. In un disco che fa della mescolanza stilistica (non per<br />
forza prevedibile, non certo incoerente) un elemento fondante. C’è una<br />
progettualità dietro o è tutto un divenire non legato a uno schema ben<br />
preciso?<br />
La citazione degli Stones è progettualità, nel senso che la canzone in cui è<br />
inserita parla dell’atto creativo e per me l’atto creativo d’eccellanza nel rock<br />
è quel pezzo degli Stones. Il divertimento che si porta dietro. Poi ci sono anche<br />
citazioni non direttamente connesse con l’ambito musicale. Nel caso de<br />
L’omino patologico la citazione vuole rendere comprensibilie il brano. Vuole<br />
sfogare. É una sorta di esempio di quello di cui parlo nel brano. Le altre citazioni<br />
che hai riportato sono suggestioni e patrimonio di ognuno. Una sorta di<br />
condivisione.<br />
Il tuo primo disco risale al 1998. Cosa è rimasto nel 2011 del Marco Parente<br />
degli esordi?<br />
Non mi guardo mai troppo indietro. Ho capito però che la storia va per cicli.<br />
Cicli sempre più stretti, tra l’altro. In ogni disco che faccio c’è sempre qualcosa<br />
che mi riallaccia a quelli fatti prima. Il modo in cui lo registro, le persone che<br />
frequento. Questo disco credo che abbia molta attinenza proprio con il mio<br />
disco d’esordio, Eppur non basta. Credo che abbia a che vedere con lo stato<br />
di grazia di quel primo disco, un entusiasmo che difficilmente capita due volte<br />
in una carriera. Forse il fatto di essermi fermato così tanto prima di registrare<br />
un disco nuovo ha generato un meccanismo di questo genere. É un po’ una<br />
ripartenza, non con una virgola o con un due punti ma con un bel punto.<br />
Tu, Paolo Benvegnù e Cesare Basile rappresentate tre artisti con una personalità<br />
estetica molto forte. Da un certo punto di vista, slegata dall’attualità<br />
musicale ma forse anche dalla velocità di fruizione che le rivoluzioni<br />
tecnologiche sembrano voler imporre a chi ascolta musica oggi.<br />
Come ti poni nei confronti dei cambiamenti che ci sono stati negli ultimi<br />
anni (mp3, peer to peer, ipod...) ma anche del rapporto tra fans e artista<br />
(web, social network...)?<br />
Io ho sempre accettato di buon grado le innovazioni tecnologiche, anche se<br />
non le ho mai volute prendere in mano in prima persona. Anche perchè le<br />
innovazioni tecnologiche si possono sempre usare in due modi e noi di solito<br />
scegliamo il peggiore: quello che ci porta a impigrire. In generale credo che<br />
sia cresciuta la testa di chi le innovazioni tecnologiche le ha programmate ma<br />
non di chi le usa, anche perchè la tendenza è trattarle come si tratterebbe un<br />
phon. Per me invece quella gocciolina di sudore, quel meccanismo di fatica,<br />
continua a essere una parte importante e necessaria. La tecnologia la uso soprattutto<br />
per velocizzare i tempi in sala di incisione. Per quanto riguarda la<br />
28 29
perdita di identità del supporto, non la trovo negativa. Sono ancora convinto<br />
che se un disco piace a una persona, quella persona lo comprerà fisicamente.<br />
In questo senso, il peer to peer è vantaggioso dal punto di vista del<br />
marketing. Dall’altro lato c’è stata la barbarie dei social network (ma con cui<br />
alla fine dobbiam convivere) in cui nessuno si puo’ più fare i fatti suoi. Devo<br />
dire che cerco di tenermi a una certa distanza da tutto questo, anche se<br />
non faccio l’eremita. Diciamo che collaboro con persone che usano abitualmente<br />
questo tipo di tecnologie e lo faccio per divulgare contenuti. Senza<br />
per questo esserne troppo dipendente.<br />
Pensi che il concetto di “condivisione” nato dalla rete in maniera poco<br />
ortodossa possa adattarsi ad ambiti sociali più pratici portando con sè<br />
elementi positivi?<br />
Diciamo che siamo al limite. La condivisione è positiva per l’arte e per la<br />
musica, ma quando si sfiora il patologico non mi trova più d’accordo. Condividere<br />
un suono è una cosa, condividere la vita personale in maniera eccessiva<br />
è un’altra. Poi il collegamento via internet abbatte molte barriere,<br />
senza dubbio. Non sono bacchettone, in questo senso. Credo che quando<br />
le cose succedono sia una massa a volerle e a farle muovere. E non si possono<br />
fermare. Siamo in un flusso e in quel flusso dobbiamo capire come stare<br />
a galla. Per questo dico che nonostante tutto, non mi sento di muovere una<br />
critica troppo severa a tutto questo.<br />
Pa o l o Be n v e g n ù : il ta l e n t o De l l o st u P o r e<br />
Da dove nasce un disco come Hermann? La storia del manoscritto che<br />
si legge nelle note stampa è l’espediente che sembra o c’è sotto qualcosa<br />
di concreto?<br />
Hermann è un po’ un disco di letteratura e in quanto tale si avvale di espedienti<br />
letterari (come appunto quello del manoscritto). L’idea non era quella<br />
di gettare tranelli quanto ripetere quello che in passato hanno fatto scrittori<br />
come Victor Hugo.<br />
In che senso il disco è “la storia dell’uomo e della sua evoluzione (involuzione)”<br />
?<br />
Il tema è unico: l’uomo che parla dell’uomo. Una volta soddisfatto il bisogno<br />
del cibo l’individuo sposta la sua attenzione sull’armonizzare sè stesso<br />
con il mondo esterno. Ognuno di noi cerca di farlo per stare meglio,<br />
per fuggire dal dolore. E forse anche dal concetto stesso di fuga. Si parla<br />
sempre degli stessi temi dalla notte dei tempi e così sarà finchè avremo la<br />
volontà di porre uno sguardo verso l’esterno.<br />
E’ in questo che Hermann si differenzia dai tuoi dischi precedenti, forse<br />
maggiormente legati a una dimensione personale?<br />
Decisamente. Prima di questo disco non riuscivo ad avere quell’apertura<br />
verso l’esterno perchè non comprendevo neanche me stesso. Adesso, almeno<br />
parzialmente, ci riesco e così ho deciso di spostare il fuoco sull’esterno.<br />
Ho pensato che fosse arrivato il tempo di farlo, anche grazie all’aiuto<br />
degli amici che suonano con me.<br />
Mi pare che Hermann sia molto più diretto rispetto a Le Labbra...<br />
Per certi versi è così. Anche se in realtà Le labbra è più un disco “di pieno<br />
vortice” mentre Hermann gode delle stilizzazioni tipiche del romanzo. E’<br />
affrontato come se fosse narrativa o un film. C’è una parte dedicata al Novecento<br />
che è stilizzata come stilizzato è stato lo stesso Novecento, ma c’è<br />
anche una prima parte che è antica e nella maggior parte dei casi è suonata<br />
in 6/8 o 3/4. Esteticamente Hermann potrebbe essere fuorviante rispetto<br />
a un disco come Le labbra, dove in realtà di estetica ce ne era veramente<br />
poca.<br />
Pochi giorni dopo l’uscita del tuo nuovo disco sono usciti anche quelli<br />
di Marco Parente e Cesare Basile. Magari non avete molto in comune,<br />
le vostre calligrafie sono diverse, eppure sembra unirvi una personalità<br />
intensa, il gusto di scavare in profondità e portare il discorso al limite,<br />
fino a farsi inconfondibile. Non sarà dovuto alla vostra formazione<br />
musicale, al fatto di essere “cresciuti” quando un disco significava molto<br />
più di adesso?<br />
Mi associ a due artisti che stimo moltissimo, artisticamente ma anche a livello<br />
umano. Cesare per tutto il mistero cromosomico che si porta dietro.<br />
La sua terra, il fatto che è un viaggiatore generoso. Marco per la brillantezza<br />
dell’uomo leggero e denso che ha. Io ho il talento del bove, dell’impegno.<br />
Un’uomo che ha l’aratro e continua a tirarlo. Alla fine non è proprio un gran<br />
talento, se ci pensi. Talvolta questo talento si focalizza nella maniera giusta,<br />
altre volte no. Per cui il paragone in questo senso mi onora. Detto questo<br />
io, Cesare e Marco siamo forse ancora uomini del Novecento, veniamo da<br />
un’altra generazione. Siamo gente che dà ancora a un disco la stessa importanza<br />
che darebbe a un libro o a un film. Nella pratica, questo significa<br />
non lesinare in impegno quando viene il momento di incidere e farlo<br />
come se fosse l’ultima cosa che si fa nella vita. Ovviamente questo non vuol<br />
dire che poi i dischi vengano fuori sempre meravigliosi, quantomeno nel<br />
caso di Paolo Benvegnù. Anche se il tempo alla fine è un gran setaccio. Così<br />
come ci sono voluti tanti anni per capire certe cose degli Scisma o un disco<br />
come Piccoli fragilissimi film, ce ne vorranno altrettanti per comprendere<br />
Hermann.<br />
Credi che l’attuale accessibilità dello scibile musicale sul web rappresenti<br />
una risorsa per il musicista del terzo millennio? E come giudichi<br />
l’evoluzione che c’è stata a livello tecnologico?<br />
Non saprei. E’ vero che tecnologicamente lavoriamo per essere sempre più<br />
30 31
veloci ma è anche vero che il ritmo dell’essere umano è sempre quello. Le<br />
innovazioni tecnologiche dovrebbero tenere conto del fatto che noi siamo<br />
sempre uguali e abbiamo sempre gli stessi pensieri (l’amore il controllo, il<br />
possesso, l’indignazione, ecc..). Al progresso tecnologico dovrebbe corrispondere<br />
uno sviluppo dal punto di vista etico, sociale, mentale, che forse<br />
però ancora non c’è. Ovviamente il fatto che si possano fare dischi a un<br />
decimo del prezzo a cui li si faceva una volta è un fatto positivo. Il fatto che<br />
anche un ragazzo che non ha mai fatto musica possa iniziare a suonare grazie<br />
a un microfono e a un computer è positivo. Per il resto, credo che a noi<br />
non servano servizi che ci fanno andare a mille all’ora per fare l’aperitivo,<br />
ma soluzioni per risolvere problemi seri.<br />
Hai scritto canzoni d’amore toccanti. Quanto ti senti vicino, in questo<br />
senso, alla tradizione melodica italiana, tu che comunque hai prestato<br />
brani ad artisti come Giusi Ferreri, Marina Rei, Irene Grandi, Mina?<br />
Il fatto di aver prestato le mie canzoni ad altri non puo’ che rendermi felice.<br />
E’ quasi un miracolo, se ci pensi. Tu sei lì che scrivi la tua musica in un<br />
sottoscala e alla fine arriva una come Mina che ti chiede di cantarla. Del<br />
resto sarebbe un miracolo anche se la cantasse un ragazzo in una qualsiasi<br />
sala prove. Come è un miracolo che tu e io siamo quà a parlare o che io a<br />
quarantasei anni vada ancora in giro a suonare ed abbia ancora delle idee<br />
come uomo e come musicista. Per me è tutto stupore, credimi. Per il resto,<br />
io scrivo canzoni in Italia e le scrivo con quello che sento proprio perchè<br />
vivo qui. Non è tanto un discorso stilistico. Noi italiani abbiamo una complessità<br />
che deriva dal fatto che questo è un Paese colonizzato da sempre<br />
e che nei rari casi di coraggio, ha dovuto usare l’autodeterminazione come<br />
forza personale. Penso quindi che l’autodeterminazione di un Tenco o di un<br />
De Gregori o di un Endrigo alla fine sia in qualche maniera vicina alla mia.<br />
Hai un metodo, o comunque c’è una modalità ricorrente con cui componi<br />
e incidi la tua musica?<br />
Ultimamente l’idea è quella di scrivere la musica e poi di aggiungere le parole.<br />
La cosa bella di questo disco è che alla scrittura hanno partecipato<br />
anche gli altri musicisti, da Guglielmo Ridolfi ad Andrea Franchi. Un allargamento<br />
che è anche una bella deresponsabilizzazione per me. Quello che<br />
ho fatto io è stato formare un contenitore. E in base a quello abbiamo scritto<br />
tutti cercando di scegliere le cose più significative. Cose che andassero<br />
a costituire un disco in qualche modo cronologico, che parlasse dell’individuo<br />
nel tempo. Fino ad arrivare all’ipotesi di un individuo futuro legato magari<br />
a una sobrietà esistenziale lontana dalla glorificazione dell’apparenza<br />
che ci ha caratterizzati fino ad ora. Un’esistenza che non dia per scontata<br />
l’esistenza stessa e il valore dell’altro.<br />
Il rock italiano ha fornito molti epigoni di Marlene Kuntz e Afterhours,<br />
ma si fa fatica a trovare qualcosa di paragonabile agli Scisma. Colpa della<br />
tua ex band, dal linguaggio troppo periodizzato o complesso, oppure<br />
è la nostra scena che non ha saputo - non sa - osare abbastanza?<br />
I Marlene Kuntz e gli Afterhours sono stati qualcosa di davvero importante,<br />
probabilmente più degli Scisma. Scisma che alla fine sono stati un<br />
gruppo che soprattutto agli inizi ha fatto i suoi compromessi e forse non ha<br />
osato fino in fondo, pur cercando di produrre buona musica. Detto questo<br />
credo che per chi suona oggi l’unica maniera per farcela sia proprio osare,<br />
cercando di arrivare ai limiti della propria creatività e della propria immaginazione.<br />
E’ in corso una fioritura di spazi dedicati al rock, soprattutto in determinate<br />
zone (in Emilia, ad esempio). Altrove, invece, pare che regni la<br />
consueta desolazione. Dal tuo punto di vista, com’è suonare dal vivo<br />
in Italia?<br />
Suonare in Italia e bellissimo. E lo è perchè in ogni città percepisci una grande<br />
diversità che è molto legata all’indole delle persone che ci abitano. E’ la<br />
complessità di cui ti parlavo prima. Se suoni a Cuneo o se suoni a Palermo<br />
ti trovi davvero in due situazioni completamente diverse, sia dal punto di<br />
vista tecnico che dal punto di vista della risposta del pubblico. Personalmente<br />
io preferisco i posti in cui riesci a percepire di essere ben voluto, al<br />
di la del fatto strettamente tecnico, forse perchè sono in generale un uomo<br />
che cerca accoglienza e che al tempo stesso spera di riuscire a darne. La<br />
presenza o meno di spazi in cui suonare credo che sia importante anche<br />
per i gruppi giovani, che in questa maniera si sentono motivati a formare<br />
nuove esperienze e ad esprimersi.<br />
32 33
Kode9<br />
—Under the big) Black Sun (of dubstep—<br />
Dr o p ou t<br />
Torna Kode9 su album ed è l'occasione<br />
perfetta per fare il punto<br />
della situazione sui tanti fili intrecciati<br />
dal mastermind Hyperdub.<br />
E sulla sua musica. Lo abbiamo<br />
incontrato.<br />
Testo: Gabriele Marino<br />
Edoardo Bridda<br />
Steve Goodman aka Kode9 è, fuori da ogni retorica, uno dei<br />
personaggi chiave della musica degli ultimi anni. La sua label<br />
Hyperdub il faro di una scena e di un genere che, tra<br />
mille sottocorrenti e sfumature avant, si è imposto come una delle<br />
declinazioni privilegiate - l’altra è il wonky - di una una koiné<br />
elettronica internazionale sempre alla ricerca dell’equilibrio, tra<br />
cristallizzazione del linguaggio e suo rinnovamento. La cosa, per<br />
una volta, vale anche qui da noi: si veda il sorprendente enciclopedismo<br />
appunto wonky/steps di After Silkworm di Planet<br />
Soap.<br />
Di queste convergenze di suoni, e prima ancora di estetiche<br />
ed intenti, avevamo parlato nel nostro maxi-riepilogone sullo<br />
stato delle cose hip hop 2009. Seguendo le principali tappe di<br />
un percorso che, dall’affermazione del genere su scala mondiale,<br />
alla mezza-rivoluzione dell’hip hop strumentale, bianco e wonky<br />
34 35
di metà anni Duemila, ha portato ad una terza generazione di producer a<br />
cui non interessano opposizioni di genere o dicotomie del tipo suonato/<br />
prodotto e campionato/di sintesi, avevamo sottolineato tutta una serie di<br />
contatti, incontri, scambi, intrecci che da allora non hanno fatto che rafforzarsi<br />
e ingrandire il proprio raggio d’influenza e la propria visibilità.<br />
DuB s t e P e Di n t o r n i : 2009-2011<br />
Il nostro discorso su e attorno a Kode9 riparte allora proprio da quel 2009<br />
che è stato l’anno delle celebrazioni per il lustro di vita Hyperdub: con una<br />
compilation ascolto obbligato per tutti e uscite chirurgiche come i singoloni<br />
Black Sun (Kode9) e Wind It Up (di quel Mark Pritchard che poco tempo<br />
prima, su Warp, aveva pubblicato come Harmonic 313 un lavoro fortemente<br />
influenzato dal Dilla elettronico e di quel Om’Mas Keith che è il cuore<br />
club-funk del trio afrofuturista Sa-Ra). 2009 anno dell’affermazione nella<br />
scena delle prime girls Cooly G e Ikonika (l’ottimo Contact, Love, Want,<br />
Hate, trait d’union tra ritmiche steps e suoni wonky, sarebbe uscito a inizio<br />
dell’anno successivo), del debutto lungo dei King Midas Sound di Kevin<br />
Martin (pioniere dubstep a nome The Bug), della joint venture con la Brainfeeder<br />
(tra live alla Redbull Music Academy e contributi su Five Years Of<br />
Hyperdub firmati Samiyam e ovviamente Flying Lotus). Appena fuori da<br />
Hyperdub, altra “relazione pericolosa” e segnale forte di convergenze forse<br />
anche inaspettate, lo split Burial/Four Tet, che declinava i rispettivi specimen<br />
(soulstep e IDM) in salsa housey.<br />
Il 2010 si è aperto in maniera programmatica con Sonic Warfare, denso<br />
saggio - con solide basi nell’intellighenzia post-marxista post-sessantottina<br />
- firmato proprio da mr. Steve Goodman e pubblicato nientemeno che da<br />
MIT Press che indaga appunto la “guerriglia sonica”, e cioè la manipolazione<br />
di ambienti e persone attraverso un uso politico delle frequenze (in contrapposizione<br />
alle espressioni contemporanee - post-techno - dell’afrofuturismo;<br />
che invece, attraverso le frequenze, cercano di tenere unite le persone). Tra i<br />
ringraziamenti del libro: Kevin Martin, Simon Reynolds, Wil Bevan (Burial),<br />
Raz Mesinai (Badawi), la Brainfeeder, la storica radio pirata Rinse, il locale<br />
chiave della scena di East London FWD>>. E si è chiuso con due uscite importanti<br />
e perfettamente complementari nel descrivere le trasformazioni del<br />
catalogo della label, sempre meno interessata a focalizzare un genere o una<br />
tendenza e sempre più attenta a mettere il proprio marchio su singole grandi<br />
personalità, vecchie o nuove che siano, stilisticamente anche molto distanti<br />
tra loro: Terror Danjah, ovvero il modern classic (il più grande produttore grime<br />
secondo Reynolds) che sfoggia - aggiornandolo - il suo enciclopedismo<br />
black, street e dancefloor, e Darkstar, protagonisti dei nuovi venti dubstep<br />
a base di cantabilità pop, riscoperta della voce, appeal indie. Kode9, secco: “Il<br />
suono muta sempre e io sto seguendo la musica che mi interessa”.<br />
In mezzo, lontano da Hyperdub, ma sempre al cuore della scena elettronica<br />
nei suoi fermenti now, le eleganti geometrie di Scuba, i tribalismi di<br />
uno Shackleton mai così sciamanico, l’ampio ventaglio di contaminazioni<br />
bassy della compila Future Bass, l’asciuttissimo wonky di Lukid e quello<br />
glitchato e “suonato” di Dimlite, la rilettura in salsa USA degli steps UK fatta<br />
da Starkey, l’addizione Lotus+Tet di Teebs, le prove tecniche di spacey<br />
ragga di Africa Hitech e, ovviamente, la superfusion dello stesso Flying<br />
Lotus (che ospita il suo fan Thom Yorke) e la riscoperta trip-hop dei Mount<br />
Kimbie, volano ideale per ulteriori evoluzioni del genere e vera e propria<br />
anticipazione delle uscite chiave dell’anno successivo.<br />
Il 2011 che ruota attorno al dubstep è infatti, a più di dieci anni dalla<br />
nascita del genere (prendiamo come riferimenti El-B, Loefah & Co.), l’anno<br />
del post-dusbtep. L’alfiere è ovviamente James Blake, bruciatosi in una<br />
manciata di EP come produttore puro (puntando sempre più verso un freddo<br />
ed elegante camerismo) per dare voce alla sua anima soul nel debutto<br />
omonimo. Nel dubstep post-Burial e quindi post-se-stesso, seguono a ruota<br />
artisti tra loro diversissimi come Magnetic Man (il supergruppo chart<br />
oriented dei veterani Benga e Skream, affiancati da Arthur Smith/Artwork),<br />
Joy Orbison, Ramadanman e Floating Points (tre giovani ancora in attesa<br />
del debutto su lp, ma già nomi di riferimento della scena), quel Jamie<br />
Smith affrancatosi come solo producer dai suoi xx (We’re New Here, per Gil<br />
Scott-Heron) e una vera selva di “super-giovani” il più interessante dei quali,<br />
non fosse altro che per la prematura sponosorizzazione di Gilles Peterson,<br />
è Lewis Gordon aka Koreless.<br />
Attorno al dubstep, alle sue evoluzioni e - termine banale, abusatissimo,<br />
ma qui davvero inevitabile - contaminazioni, ruotano alcune uscite chiave<br />
(a livello di estetica, strategie di posizionamento e di comunicazione, ancora<br />
prima e ancor più che di efficacia artistica) di questi primi mesi 2011.<br />
I Radiohead di The King of Limbs sono la divulgazione indie-blinking dei<br />
suoni laptopistici e sotto sotto dubstep (si pensi al gusto noir e ai detriti<br />
36 37
ambient di Los Angeles) di Flying Lotus; Thom Yorke ha fatto comunella<br />
con Four Tet (fresco di split con un altro nome importante a livello di sintesi<br />
elettrofile come Dan Snaith aka Caribou) e Burial; e quest’ultimo, è<br />
proprio notizia dell’ultima ora, è tornato con un solo work, un 12” pollici di<br />
tre pezzi, dopo 4 anni di quasi completo silenzio. Notare come tutte queste<br />
uscite super-hype corteggino sottilmente quello che sarebbe davvero l’incontro/scontro<br />
del secolo: mettere assieme Burial e Flying Lotus. Come, del<br />
resto, già proprio nel 2009 si era cercato di fare, malinterpretando a tutti i<br />
costi un semplice, per quanto suggestivo, montaggio Burial + Dimlite fatto<br />
da FlyLo e uploadato sul suo Myspace.<br />
Ecco, inutile dire che di questo continuum extra-Reynoldsiano Kode9 è<br />
uno dei protagonisti over e soprattutto under ground. Forse proprio per<br />
questo, coerentemente con una strategia di comunicazione veramente<br />
ninjesca, che costruisce l’hype sotto la cenere, tra mascheramenti, reticenze<br />
e coup de theatre improvvisi, una strategia a ben vedere tutto fuorché<br />
2.0 (ma aspettiamo il lancio - finalmente - di un sito ufficiale Hyperdub che<br />
non si limiti a consigliare l’iscrizione alla mailing list), quando incontriamo<br />
Kode9 e Spaceape qualche ora prima del live al Bronson di Ravenna (19<br />
marzo, per la Hyerpdub Night - ci saranno anche i King Midas Sound - organizzata<br />
dal quarto Transmissions Festival), il discorso non sfiora neppure<br />
di striscio tutto questo buzz, consegnandoci invece un artista interamente<br />
concentrato a spiegare dove sta andando la sua musica: “Quando facciamo<br />
le nostre cose, dobbiamo disinteressarci completamente di tutto quello che<br />
succede intorno”. Si capisce subito che i due non sono solo parte di un pro-<br />
getto musicale, ma sono amici veri, la complicità è forte, ridono e scherzano,<br />
rilassati come due compagni di college.<br />
ko D e 9: u n Pr o f i l o<br />
Scozzese di Glasgow, centro geograficamente lontano dal fermento londinese,<br />
ma con un underground elettronico vitalissimo tra club, etichette e<br />
crew (città da cui provengono infatti anche Rustie, Hudson Mohawke e<br />
Ghost-Simon Williamson, per non dire degli Shamen), classe 1974, il giovane<br />
Steve Goodman si appassiona subito ai ritmi e si mette ad ascoltare<br />
tutto quello che gli capita sotto tiro, reggae, breaks, hip hop, jazz, funk,<br />
house, ma anche l’electro-wave dei concittadini Associates (anni dopo inserirà<br />
la loro Message Oblique Speech in un suo mix). A sedici anni comincia<br />
a fare il dj e una sera, sul dancefloor, arriva per lui improvviso “the most important<br />
musical event of my life”: la folgorazione jungle. “Della jungle non mi<br />
interessano necessariamente i suoni, ma soprattutto l’energia che sprigiona”.<br />
Steve si muove tra Edinburgo (è qui che avviene l’epifania), Warwick (qui<br />
conseguirà un master in filosofia nel 1999) e Coventry, approfondisce l’hardcore,<br />
studia <strong>Tim</strong>baland e l’r’n’b dei primissimi Novanta, prima di trasferirsi<br />
definitivamente a Londra nel 1997. Si immerge nella scena di East London,<br />
fa lo speaker per radio Rinse, tiene set nei locali - compreso il FWD>> - e nel<br />
2001 fonda una webzine specializzata in UK garage, battezzandola Hyperdub.<br />
Come producer, il primo lavoro di rilievo, già a nome Kode9, sono due<br />
pezzi su Tempa (2002) a quattro mani con Ben Garner/Ben III, l’indianeggiante<br />
Fat Larry’s Skank e l’asciutto breakbeat di Tales From The Bass Side. E’<br />
già dubstep, anzi, molto più dubstep di quanto non sarà per lui in seguito.<br />
A fine 2003 Kode decide di trasformare Hyperdub nella label con cui fare<br />
viaggiare la propria musica. La prima uscita, numero di catalogo HYP001, è<br />
una lenta e irreale cover version di Sign O’ the <strong>Tim</strong>es di Prince, Sign Of The<br />
Dub (2004; b-side la minimalista Stalker). Lo stile si è fatto già molto più<br />
personale, Kode comincia ad esplorare le atmosfere dilatate, profonde e<br />
siderali che ne contraddistingueranno il suono in tutte le uscite successive.<br />
Alla voce c’è Daddy Gee, e cioè quello Stephen Samuel Gordon che nel<br />
2005 cambierà nome in Spaceape.<br />
Kode9 è il pigmalione del ragazzo senza nome che si fa chiamare Burial<br />
e che nel 2005 esordisce con un 12” di quattro pezzi, South London<br />
Boroughs (prima uscita Hyperdub di un altro artista), e l’anno successivo<br />
pubblica l’omonimo album di debutto, disco dell’anno per The Wire. Sempre<br />
nel 2006, esce anche Memories of the Future, primo album di Kode9 e<br />
Spaceape. I semi sono gettati. E la raccolta non tarda neppure troppo ad<br />
arrivare, visto che il secondo album di Burial, Untrue, esce già a novembre<br />
2007, diventando in breve tempo un vero caso internazionale (e segnando<br />
di fatto lo sdoganamento del dubstep fuori dai soliti circuiti dei club UK),<br />
anche e soprattutto per il mistero che avvolge il produttore, che riuscirà a<br />
rimanere anonimo fino a metà 2008 (si scoprirà così che William Bevan aveva<br />
frequentato la Elliott School negli stessi anni di Kieran Hebden/Four Tet).<br />
L’ambient sporca e drammatica, i legnosi breakbeat e soprattutto la palpabile<br />
- per quanto fantasmatica - tensione soul delle voci di Burial creano<br />
uno standard che scavalca le dancefloor track e i melmosi pezzi chetaminici<br />
che dominano la scena e fanno di Untrue una pietra miliare del tramonto<br />
dei Duemila. Il “Salinger del dubstep” ritorna nella sua tana e si chiude in un<br />
silenzio quasi completo.<br />
38 39
Kode9 invece, come abbiamo visto, si rimbocca le maniche e svolge il<br />
ruolo di capoccia con uno scrupolo e un’intelligenza che ne spiegano alla<br />
perfezione - assieme all’attività accademica - la produttività piuttosto ridotta<br />
e spalmata su tempi lunghi. Assistente a Warwick già prima di conseguire<br />
il master, dal 2006 in pianta stabile alla University of East London (guarda<br />
un po’...) come “Lecturer in Music Culture” e coordinatore di un programma<br />
di Sonic Culture, specializzato in “Cybernetic Culture, Diasporic futurisms,<br />
Abstract Materialism”, Steve/Kode insegna attulmente materie relative ai<br />
rapporti tra suono e immagine.<br />
af r o f u t u r i s m f o r th e ma s s e s<br />
Non abbiamo aspettato così tanto per stampare il secondo album intenzionalmente.<br />
Semplicemente, ci abbiamo messo molto per realizzarlo. Siamo<br />
stati molto distratti... dalla vita, dal lavoro per l’etichetta. E poi non ci piace<br />
fare le cose di fretta: quando un lavoro è pronto, lo facciamo uscire. Black Sun<br />
è molto diverso da Memories. C’è molta più energia, a livello ritmico e nei testi,<br />
ed è molto più synth-driven; il primo era - come dire - più slow. E’ un lavoro<br />
che si è costruito live dopo live, nel corso degli anni (Black Smoke risale almeno<br />
a due-tre anni fa), provando versioni sempre diverse degli stessi brani, fino a<br />
raggiungere il feel, l’impatto che volevamo. Ci sono tre canzoni propriamente<br />
house e sono tutte sorelle di Black Sun [il singolo 2009].<br />
Space scrive i testi, io le musiche, poi cerchiamo di mettere assieme le due<br />
cose. Dietro Black Sun c’è un concept, ma è nato a posteriori, dopo avere finito<br />
il disco, anche grazie alla grafica della copertina [in stile giappa-Hokusai], dalle<br />
coerenze che abbiamo riscontrato nei testi e nelle musiche e che ci è sembrato<br />
giusto fare emergere. Ironia della sorte - visti i tempi - il concept riguarda un<br />
evento radioattivo che investe la popolazione e la muta geneticamente. L’album<br />
parla di come i diversi gruppi della popolazione rispondono alla cosa. Le liriche<br />
raccontano le loro storie. Black Sun, ad esempio, “parla” dell’eclissi radioattiva.<br />
Nella vostra musica, nel vostro progetto, al di là delle evoluzioni interne<br />
del vostro suono, ci sono sempre due componenti: la voce afrofuturista di<br />
Spaceape e le basi elettroniche di Kode9. Per me l’afrofuturismo è la musica<br />
più interessante venuta fuori negli ultimi 50 anni. E’ elettronica, ma ha radici<br />
organiche. Va oltre le definizioni e gli stereotipi street, roots, hip hop, dubstep,<br />
grime, techno, house. E’ la cosa che in qualche modo riempie il gap tra queste<br />
definizioni e le riunifica tutte. Anche King Midas Sound è un progetto afrofuturista.<br />
Conosciamo Kevin da anni. Spaceape ha lavorato con lui su London<br />
Zoo e in altri progetti [Cult Of The 13th Hour]. Il suo lavoro è sempre stato per<br />
noi fonte di ispirazione. I nostri progetti, per quanto diversi, sono in qualche<br />
modo comparabili. Direi anche che siamo complementari quando ci troviamo<br />
sullo stesso palco. Ed entrambi impariamo e sperimentiamo molto a partire<br />
dai nostri live.<br />
Black Sun parla di “guerriglia sonica”? In senso lato sì. Nel libro ho cercato,<br />
anche attraverso esempi presi dalla politica e da contesti bellici, dei possibili<br />
background per spiegare certi meccanismi della scena bassy, della dance basata<br />
sulle frequenze. Mi interessa capire come le frequenze possono unire o<br />
dividere le persone, ovviamente anche in maniera del tutto inconsapevole, oltre<br />
che manipolatoria. Le diverse sfumature musicali del disco spiegano come<br />
queste persone, di volta in volta, si possono aggregare o si dividono. Tutto è<br />
ritmo: la musica, il metabolismo degli esseri viventi, il moto dei pianeti... il traffico...<br />
i miei ritmi circadiani incasinati.<br />
Prossime uscite Hyperdub in cantiere? Abbiamo appena messo sotto contratto<br />
Hype Williams per un EP. C’è un bel progetto di remix sui King Midas<br />
Sound, sarà un album intero. Poi c’è l’album di Morgan Zarate, con il suo electrosoul,<br />
quello di Cooly G e nuovi pezzi dei Funkysteps e di D.O.K..<br />
Meno sonicamente violento di quello di Martin/King Midas, meno graffiante,<br />
più deep, il live di Kode9 e Spaceape al Bronson conferma le parole del<br />
duo su un album nato nei live e pensato per i live, facendo esplodere il potenziale<br />
dancefloor delle produzioni. Il rappato di Spaceape è ancora più fisico<br />
rispetto al disco, i suoi spoken e il suo lento rapping nutrito di ascolti reggae<br />
si fa più incisivo e allo stesso tempo più cinetico. La gente, insomma, balla, in<br />
un riuscitissimo aggiornamento, in chiave afrofuturista, della logica dei soundsystem<br />
tanto cari a Martin e al prof. Goodman. Con uno spettacolo così e con<br />
la fama post-burialiana che Hyperdub si è guardagnata negli anni, Kode9 può<br />
tranquillamente puntare ad allargare sensibilmente il proprio pubblico di riferimento,<br />
tanto presso l’utenza indie che quella “discotecara”. Senza rinunciare<br />
agli elevati standard qualitativi che finora ha sempre garantito.<br />
40 41
<strong>Tim</strong><br />
Dr o p ou t<br />
L'ultimo album dello schivo canadese<br />
è il più importante lavoro<br />
ambient dai tempi di 'Disintegration<br />
Loops' di William Basinski.<br />
Ne abbiamo approfondito retroscena<br />
e prodromi...<br />
Testo: Antonello Comunale<br />
Edoardo Bridda<br />
HeCker —Cathedral electronic Music—<br />
I don’t want to make a document that’s the master statement of ambient,<br />
or glitch, or whatever else. I’m interested in a hybrid of things, and making<br />
new hybrids, and respecting people who’ve done other hybrids. I see hybrids<br />
where people usually see static forms, like “ambient,” but I find it limiting as<br />
a title.<br />
mus i c a c o m e iBriDazione<br />
Fa un certo effetto vedere il plebiscito di pubblico e critica investire<br />
in pieno una figura che fino ad ora si era conservata nel ristretto circolo<br />
degli affezionati di settore. Quando un profilo elitario e a suo<br />
modo schivo come quello di <strong>Tim</strong> <strong>Hecker</strong> finisce sulla bocca di tutti,<br />
capisci che oltre alla qualità del disco si addensano sul personaggio<br />
i meriti storici di uno che non ha mai voluto far parte di nessun<br />
circolo alla moda. Come sempre in questi casi, si riceve in ritardo il<br />
credito pagato in anni di militante carriera oltranzista.<br />
42 43
E’ dal 2003 che <strong>Tim</strong> <strong>Hecker</strong> è oggetto di forti attenzioni da parte della<br />
stampa specializzata. In quell’anno, il popolare magazine The Wire, sulla<br />
china estrema dell’era glitch, considera il secondo album del sound artist<br />
come un album chiave dell’annata musicale. Radio Amor del resto, è - assieme<br />
ai Rechenzentrum di Directors Cut e al Living Vicariously Through<br />
Burnt Bread di Twerk - l’ultima pubblicazione della Mille Plateaux nella sua<br />
prima (e autentica) incarnazione, etichetta che ha rappresentato, a sua volta,<br />
il meglio in quanto a ambient, noise e psichedelica nell’era del digitale.<br />
Mentre il glitch nella sua accezione d’estetica clicks’n’cut implode, l’ambient<br />
che ne ingloba i detriti, sembra più di una via ma l’autentico paradigma<br />
successivo e se vogliamo la maturazione di un linguaggio che retrocedeva<br />
dall’ondata digitale e nel contempo recuperava l’analogico (il tape<br />
to tape reel) e gli indimenticati trucchi di scuola John Cage. Del resto, nei<br />
due anni precedenti a Radio Amor sugli scaffali dei morenti negozi di dischi<br />
specializzati in elettronica e avant- si posizionavano campali i Disintegration<br />
Loops di William Basinski e Endless Summer di un Fennesz via via<br />
più sintetico e magistrale che forse è il più interessante segno dei tempi. La<br />
ricerca dell’austriaco tanto quanto quella dell’amico londinense Peter Rehberg,<br />
ovvero Pita, è fortemente imperniata su una pasta sonora ancestrale,<br />
mistica, dal sapore storico. Senza tanti giri di parole, nell’era della morte del<br />
tempo, è l’eterno il moloch, il monolite nero, il totem in nome del quale,<br />
salutata la civiltà, ci si avventura nell’ignoto.<br />
I can’t say that naturalism is some over-arching interest of mine at all.<br />
Più che con la natura o la narrativa, <strong>Tim</strong> <strong>Hecker</strong> ha a che fare con l’eterno.<br />
Un flusso di coscienza che si serve della manipolazione di artefatti che<br />
possono essere piano, chitarra, synth o suoni naturali. Fisico e allo stesso<br />
tempo psichico, paragonabile alla sinfonica glitch di Fennesz, o ai field recording<br />
ritrovati del newyorchese, o ai layer d’elettronica su field recording<br />
di Keith Fullerton Whitman, la musica del canadese è un misto di correnti<br />
alternate calde e fredde, presenti ma soprattutto lontane. E’ come sorvolare<br />
un territorio, ha notato qualcuno, oppure assomiglia alle crepe dei fiordi<br />
attraversate dall’oceano. Ma sono osservazioni dall’esterno, dell’ascoltatore.<br />
Abitare una cattedrale di suono rende invece meglio l’idea del requiem<br />
particolare celebrato in Ravedeath, 1972, ovvero l’addio al suono che fu.<br />
Un pianoforte nell’attimo prima del lancio da un edificio è infatti lo scatto<br />
presente nella copertina dell’album, un lavoro che inaspettatamente è il<br />
migliore inciso finora, nonché l’album di ambient noise più convincente<br />
dai tempi di Lisbon di Whitman. Ma non era iniziata così.<br />
I suoi primi passi musicali <strong>Hecker</strong> li muoveva in tutt’altro ambiente.<br />
Sono i primi anni ’90 della minimal techno di Jetone, nome d’arte con cui<br />
il canadese pubblica i primi lavori pensati al laptop e per il laptop. Sono<br />
gli anni di dischi di genere come Autumnumonia e Ultramarin, che non<br />
fosse per la fin troppo facile sapienza ex post, parrebbero già denunciare<br />
tutta la maestria atmosferica del sound artist, anche se si parla pur sempre<br />
di una musica dal pressante e canonico appeal ritmico, del tipo che infatti<br />
non sfigura nel catalogo di etichette di regime come Pitchcadet, Force<br />
Inc e Tigerbeat6. Il gusto per la melodia ficcante e nascosta, per la texture<br />
sonora fumosa e stordente e l’alternarsi tra stasi (apparente) e confusione<br />
(evidente), sono tutte caratteristiche che troviamo già in Haunt Me, Haunt<br />
Me, Do It Again (Substractif, 2001) per una sub label della Alien8 Recordings.<br />
Accantonato per il momento lo pseudonimo di Jetone, <strong>Hecker</strong> firma<br />
senza filtri i venti frammenti d’ambiente che compongono il suo primo e<br />
vero lavoro ambient.<br />
Su venti, solo nove composizioni hanno titolo, ma lo scarto all’udito è<br />
inesistente perché il lavoro è di una coloritura unica seppur assai distante<br />
dall’essere monocorde. Dell’esperienza Jetone vengono qui conservate le<br />
arricciature elettroniche, che agitano continuamente il droning sound del<br />
laptop. Music For Tundra che apre qui le danze, esemplifica al meglio lo<br />
stile dei brani: aperture gotiche di organo, frequenze impazzite al laptop,<br />
sali e scendi emotivo tra lande desolate e frastuoni tuonanti nella biosfera.<br />
Quella di <strong>Hecker</strong> non è certamente ambient per aeroporti, né tanto meno<br />
per sedute new age di yoga, piuttosto si allinea lungo le coordinate elettroacustiche<br />
contemporanee di altri grandi poeti dell’atmosferico digitalizzato,<br />
primi fra tutti Fennesz e Keith Fullerton Whitman.<br />
Il riscontro di Haunt Me, Haunt Me, Do It Again presso la critica specializzata<br />
va dall’entusiastico all’ottimo. <strong>Tim</strong> <strong>Hecker</strong> viene visto come un abilissimo<br />
ingegnere del suono capace di manipolare i sentimenti e l’immaginazione<br />
oltre che le manopole. Il disco successivo corrobora ancora di più<br />
questa fama e stabilisce definitivamente <strong>Hecker</strong> come un nuovo standard<br />
d’eccellenza della musica elettronica contemporanea. Oltre alla proposta<br />
intriga anche l’azzardo d’artista. Dopo il disco di debutto si dà alle stampe<br />
My Love Is Rotten to the Core (Substractif, 2002), un vero e proprio tour de<br />
44 45
force del taglia e cuci, in cui vengono fatti convivere scampoli di interviste,<br />
voci prese chissà dove, e suoni presi da concerti live dei Van Halen, il tutto<br />
per meno di venticinque minuti di fragore digitale.<br />
I don’t think that Walter Benjamin was entirely right about certain aspects of<br />
the “aura.” Aura has shifted into things we can copy.<br />
Il successivo Radio Amor (Mille Plateaux, 2003) è il disco della consacrazione,<br />
non solo del suo nome, ma soprattutto del suo stile. Alleggerita la<br />
prassi ultratecnica dei primi due dischi, il nuovo lavoro trova il fulcro delle<br />
proprie visioni intorno ad un piccolo villaggio da pesca dell’Honduras di cui<br />
fa esperienza <strong>Hecker</strong> stesso. E’ un modo molto sottile e ironico di sottolineare<br />
la pretenziosa e supponente concettualizzazione che sta dietro a tanta<br />
musica elettronica moderna. Far finta che ci sia un concept a guidare l’idea<br />
di un disco senza che poi ci sia davvero niente più di una traccia dentro cui<br />
muovere le proprie visioni. E’ con atteggiamenti come questo che <strong>Hecker</strong> si<br />
allontanerà a lunghe falcate dalla moda imperante di inizio decade, quella<br />
cioè di assemblare lavori certosini di un’elettronica spesso più dedita alla<br />
forma che alla sostanza. Radio Amor segue le tracce lasciate dal marinaio<br />
Jimmy nei perigliosi flutti del mar dei Caraibi, ma è appunto una falsa idea<br />
di concept. Per <strong>Hecker</strong> conta molto di più la suggestione che affascina piuttosto<br />
che lo svolgimento di un poema.<br />
L’afosa atmosfera tropicale si stempera e si riflette nelle mareggiate dronate<br />
di brani come Song Of The Highwire Shrimper, 7000 Miles, (They Call<br />
Me) Jimmy. Il tipico “clashing sound” di <strong>Hecker</strong>, dove le frequenze elettroniche<br />
sembrano collidere l’un l’altra e disegnare nuove geometrie armoniche<br />
si arricchisce qui di riflessi caldi ed evocativi. The Stair Compass vive di vampe<br />
elettroniche alla Fennesz, che bruciano lentamente fatati barocchismi<br />
minimal come nemmeno Colleen. I dieci minuti di Azure Azure potrebbero<br />
essere invece i più avventurosi del suo repertorio, tra voci di capitani persi<br />
nella tormenta e apocalissi atmosferiche per burrascose tempeste di suono<br />
da cui non si esce come prima. Radio Amor eccelle nella prassi visionaria e<br />
trova per il suo autore una cifra stilistica unica e immediatamente riconoscibile.<br />
Un anno più tardi <strong>Hecker</strong> torna sugli scaffali di dischi con un disco nuovo<br />
per Alien8 Recording: Mirages (Alien8 Recording / Wide, 2004). Il canadese<br />
cerca di bissare il colpo di Radio Amor e la press release è suggestiva: “Taking<br />
inspiration from Italian partigiani and the counter-attack of the anti-<br />
Vichyists, <strong>Hecker</strong> has issued a salvo against all tourists of melancholy, from<br />
trustafarian pseudo-leftists to the Ikea nihilists of the bobist rive droite. …<br />
With its motifs of eroticism and torture, militancy, and ecstatic pain, Mirages<br />
also points backwards towards the Viking penchant for fighting and<br />
feasting.” Addirittura un disco che si muove in un contesto politico, come<br />
denuncia di uno modernismo squallido e inconcludente se paragonato agli<br />
“eroi della seconda guerra mondiale e alla loro risolutezza”. Stiamo sempre<br />
li. Una traccia flebile di contorno. E’ la confezione. Dentro il tecnicismo diventa<br />
lussuregiante.<br />
L’iniziale Acephale mostra subito un sound levigato, che rispetto al precedente<br />
Radio Amor graffia maggiormente lambendo territori quasi noise.<br />
Le note di un piano vengono disturbate dal riverbero intermittente del<br />
laptop nella successiva Neither More Nor Less. In definitiva, Mirages è un<br />
lavoro che gioca amabilmente con i due cliché dell’<strong>Hecker</strong> sound: da un<br />
lato gli avventurosi scontri di suono, che, visto anche il romanticismo generale,<br />
assumono fragranze quasi shoegaze, dall’altro l’ambient minimale<br />
disturbata dall’elettronica trattata al pc.<br />
Alla prima categoria appartengono brani come Aerial Silver, The Truth<br />
Of Accountants, Kaito, Balkanize-You. Alla seconda, invece, si iscrivono<br />
Celestina, Counter Attack, Aerial Light-Pollution Orange, Non Mollare. La<br />
splendida Incurably Optimistic che chiude il lavoro, riassume entrambe le<br />
posizioni. Mirages è un disco meno di cuore e più di cervello, ma il risultato<br />
finale è poco meno che ottimo, anche se inferiore a Radio Amor<br />
Nel 2005 <strong>Hecker</strong> dà il suo contributo alla serie Mort Aux Vaches della<br />
Staaplaat, elaborando un unico brano fiume di 40 minuti dove il suono parte<br />
evocativo e minimale, sfocia in un frastuono digitale dai riflessi doom,<br />
ritorna nella calma, si anima di una vaga melodia in lontananza che sciama<br />
nel sottosuolo… insomma un film a occhi aperti di cui non va rivelato il<br />
finale.<br />
First and foremost, I’m a studio musician. My main skill is making studio artifacts.<br />
Arrivati al 2006 i tempi sono ormai maturi perché <strong>Tim</strong> <strong>Hecker</strong> cominci ad<br />
alzare lo sguardo oltre un orizzonte di settore, che comincia oggettivamente<br />
a stargli stretto. Le icone di genere, anni 2000, ovvero Basinski e Fennesz<br />
sono ormai così diventati paradigmatici per un disco che non riescono<br />
a replicare (The Disintegration Loops per il primo, Endless Summer per il<br />
secondo) che la loro stessa carriera diventa un continuo termine di para-<br />
46 47
gone con il passato. <strong>Hecker</strong> può permettersi più di qualche turning point.<br />
La sua non è una sensibilità pop, ma realmente avanguardista, per questo<br />
ha lo spazio e le spalle sufficientemente larghe per affermare che “Fennesz,<br />
nel corso degli anni, si è concentrato su una sensibilità prettamente pop<br />
nei suoi lavori in studio (al contrario il suo approccio live è molto diverso),<br />
come in opposizione ai suoi primi lavori più concreti come Plus Forty Seven<br />
Degrees…”.<br />
Il metodo di <strong>Hecker</strong> di contro è una metodica improvvisazione dettata<br />
da regole interne rigidissime. Descrivendo l’ispirazione che stava dietro al<br />
brano Acephale, il musicista canadese dimostrava di avere uno spirito avventuroso<br />
e soprattutto una base rock che è quella che fa la differenza: “Il<br />
mio processo creativo è di sviluppare una melodia o qualcosa del genere<br />
anche li dove non sembrano esserci gli elementi sufficienti per far nascere<br />
niente. E’ come uno sperimentalismo forzato in termini più pop e goth.<br />
Acéphale è stata sviluppata partendo da un campionamento dei Blur; ci<br />
ho suonato sopra la chitarra e ci ho lavorato sopra fino a quando non ha<br />
preso una vita propria. Ad essere chiari comunque non esiste uno standard<br />
per la composizione. Ogni pezzo ha dietro il proprio fungo sotterraneo che<br />
lavora “.<br />
Il grande turning point arriva quindi con la firma di un contratto con<br />
l’etichetta americana di culto Kranky. Un matrimonio deciso all’inferno e<br />
che produce come primo risultato uno dei migliori dischi del sound artist:<br />
Harmony In Ultraviolet. Il passaggio all’etichetta chicagoana, dopo anni<br />
di laborioso peregrinare di label in label, sembra ai più la dimostrazione<br />
che due rette parallele hanno deciso ad un certo punto di congiungersi.<br />
<strong>Hecker</strong> di contro, rimane come sempre schivo e pragmatico: “E’ difficile<br />
mettersi a pensare all’etichetta giusta per la tua musica, soprattutto perchè<br />
non sono molto addentro alla musica contemporanea, nel senso che non<br />
ho cognizione di cosa ogni label stia facendo. Kranky però è un’etichetta<br />
che ho cercato per un bel po’ e quindi è veramente appagante che ci sia<br />
trovati qui a lavorare insieme”. Il risultato del disco è un <strong>Hecker</strong> che vira<br />
ancora di più sul crinale inaugurato timidamente da Mirages. Un disco che<br />
spiega l’attenzione che il suo autore ha per le geometrie cosmiche, le nebulose<br />
d’ambiente ispide e nervose, gli effetti rumorosi e stordenti. Tutto<br />
il contrario quindi dei canoni classici dell’ambient d’aeroporto e parecchio<br />
più in là in direzione di un’avanguardia elettronica tutta personale. Qui si<br />
cambia anche registro in merito alle durate dei brani, tanto languidamente<br />
estese nei lavori precedenti, quando circoscritte in mini variazioni di pochi<br />
minuti nel presente. Harmony in Blue esemplifica al meglio in nuovo corso<br />
del musicista, mostrando in quattro frammenti, altrettanti modi di piegare<br />
l’elettronica alle fantasie visionarie del suo autore. La sapienza tecnica si è<br />
evoluta al punto di siglare brani masterpiece come Chimeras e Dungeoneering,<br />
che andrebbero studiati nei master di musica elettronica tenuti da<br />
Fred Frith.<br />
Dopo tanta effettistica il successivo An Imaginary Country (2009) sembra<br />
quasi un ritorno sui propri passi, un ripiegarsi su stesso, cercando un<br />
approccio più pastorale e luminoso. <strong>Hecker</strong> pensa all’utopia di Debussy ma<br />
sembra arrivato a un punto morto e la stasi quasi shoegaze di Borderlands<br />
sta lì a dimostrarlo. L’idea di sintesi noise fennesziana è un canto di sirena,<br />
un abbraccio mortale. Il suo è un soundscape tridimensionale (Utropics<br />
/ Paragon Point) che risente evidentemente anche della collaborazione<br />
dell’anno precedente con il connazionale Aidan Baker, Fantasma Parastasie,<br />
ma quello che funziona con quest’ultimo, ovvero un lavorio di fino<br />
verso un’effettistica liquida e molto lieve, non sortisce lo stesso risultato<br />
nelle mani di uno che di contro ha sempre avuto una visione più magniloquente<br />
e wagneriana.<br />
“Ricordo di aver visto le immagini di qualcuno con il volto ricoperto di<br />
sangue in qualche reportage giornalistico su qualche apocalisse rave avvenuta<br />
lo scorso anno. Non so in che modo tutto questo sia entrato nella mia<br />
testa, ma è avvenuto in qualche strano modo”. E’ la microstoria che sta dietro<br />
a Ravedeath, che si pone quindi come il disco migliore del musicista e<br />
capo d’opera di inizio decade. Lavoro che si pone oltre la dialettica digitale<br />
versus analogico dei primi Duemila, lontando dalle short wave estetizzanti<br />
e dalle scene noisey più sub-bassi firmate Mille Plateaux, via dall’IDM più vicina<br />
ai Tangerine Dream, in uno spazio tutto suo dove tutti questi elementi<br />
li ritroviamo con la forza e lo scarto determinanti al superamento. L’altezza<br />
verticale del drone, la stordente potenza dell’organo collegano Satie a Klause<br />
Shultze, la sonata alla cosmica krauta. Un gioco di engineering e produzione.<br />
Presa diretta per l’incisione e successivo lavoro di editing invisibile<br />
che deve parecchio a Ben Frost, l’ultimo signore dei ghiacci in grado di<br />
sottoscrivere un marchio di fabbrica autografo nella recente scena elettronica<br />
post Pan Sonic. E’ lui a prestare idee soniche dal suo disco di debutto<br />
Steel Wound, lui ad ingabbiare la mistica drone del canadese in una spessa<br />
nebbia di layer densi e impenetrabili. Da qui lo scarto dell’organo processato<br />
e il riverbero monastico di Rekjavik che rendono Ravedeath un disco<br />
non solo di sapienza tecnica, ma anche di lirismo umorale e struggimento<br />
malinconico, consegnando il suo autore, finalmente, all’accettazione del<br />
pubblico pop che, non a caso, apprezza ed elogia.<br />
48 49
Recensioni — cd&lp<br />
a red cat in the doghouSe - life under the<br />
chemtrailS (roPeadoPe, ottoBre 2010)<br />
Ge n e r e: b e a t s / f u n k<br />
Il romano Aldo De Sanctis, classe ‘74, polistrumentista e<br />
produttore (di mestiere tecnico del suono), dà seguito<br />
alla prima prova Night On LegHorn (2009) con un buon<br />
album sostanzialmente downtempo (spiccatamente,<br />
l’intro orchestrale, la cadenza reggae e i tocchi etno di<br />
Home Growth; il quasi-rock di Deep Water), con dentro<br />
esercizi funk (il dittico dedicato alla B-movie Funky Star,<br />
che si ricollega a un pezzo del primo disco), dub (la<br />
leggera e dondolante Dub Grown) ed elettronici (l’incedere<br />
minaccioso della spacey Black Moon Rising; le<br />
rarefazioni ambient-noise di Ghost Town e della lunga<br />
conclusiva Debunk This!). Un pezzo su tutti ha la marcia<br />
in più e vale anche da solo l’ascolto del disco: l’iniziale<br />
Citylights (con la sua companion Nightshifting, quasi in<br />
chiusura), sospeso tra dubstep, glitch e Radiohead (le<br />
tastiere).<br />
(6.4/10)<br />
gaBriele marino<br />
aa. vv./geddeS/tom demac - nofitState<br />
(murmur, marzo 2011)<br />
Ge n e r e: d e e p h o u s e<br />
Una compilation doppia di deep che si situa sulla<br />
lunga teoria a basso voltaggio di cassa professata da<br />
Wolf + Lamb, Deniz Kurtel e gli altri DJ che stanno<br />
alimentando con classe, buon gusto e personalità il<br />
nuovo corso dell‘house di questi ultimi mesi. Geddes<br />
è il patron dell‘etichetta murmur e dei parties Mulletover<br />
londinesi. Tom MacDonald è il ragazzo di bottega<br />
che vive sommerso nel suono della label. Il maestro e<br />
l‘apprendista, tanto per intendersi. Un disco a testa per<br />
spaziare in mondi subacquei, visioni calde che non tagliano<br />
il tempo con filtraggi anomali, ma che vivono di<br />
calore e soul.<br />
La selecta di Geddes parte subito in quarta con le positive<br />
vibrations ereditate da Stevie Wonder di Maceo<br />
Plex (Vibe Your Love), per passare poi dentro un tunnel<br />
di vocals blackissime trasudanti clubbismo deep da<br />
tutti i pori. I nomi più cool restano i big: Marco Passarani<br />
(Colliding Bonus Star), la già menzionata Kurtel<br />
(Trust), Seth Troxler (Miles in Aphrika con Lawrence)<br />
e una serie di artisti dell‘etichetta che oltrepassano le<br />
mode e suonano già classici, in particolare James What<br />
e il remix di Glimpse per Lewie Day.<br />
Il secondo disco è lo one man show di Demac: presenta<br />
infatti tutti i singoli di maggior successo dell‘uomo<br />
usciti per la label. La sua proposta esce dal nero e si infatua<br />
di macchine vintage detroitiane: 808 e 909 sono<br />
la base macchinica (Lose That Tape This) per un suono<br />
che cita nelle vocals collezioni di dischi funk, soul e<br />
r‘n‘blues (Idea Without A Name) e che ama forgiarsi con<br />
tecniche di cut-and-paste e citazionismi squadratoanalogici<br />
da club Novanta (Slip Slop Slap).<br />
Un doppio che crea un‘atmosfera calda, piacevole e<br />
sensuale. Due nomi da appuntare nella lista dei VIP dello<br />
spinning. Murmur. Il futuro della deep passa anche<br />
da qui.<br />
(7.3/10)<br />
marco Braggion<br />
aa. vv./uxo/digi g’aleSSio/Planet SoaP/<br />
Smania uagliunS - dolPhyn Surround<br />
(PaSSionjunkieS.it, marzo 2011)<br />
Ge n e r e: b e a t s<br />
Come recitano le note stampa, Dolphyn Surround è la<br />
prima compilation di materiali esclusivi prodotta dal<br />
sito Passion Junkies, dedicato al mondo dei ritmi (con<br />
interessanti podcast) e curato del napoletano Fabio Festa.<br />
Focus su Eric Dolphy, primo di una serie di tributi<br />
a musicisti di culto che hanno influenzato in maniera<br />
diversa il beatmaking, è un memorial barbecue con<br />
dentro molti dei nomi della scena italiana che abbiamo<br />
imparato e stiamo imparando a conoscere.<br />
La scaletta si divide tra brani atmosferici e rarefatti e<br />
track più solide, costruite attorno ad un loop preciso:<br />
lo sketch stomp-hop jazz di Johnny Boy ed Manuele<br />
Atzeni (dalla crew toscana di Digi, OverKnights), il<br />
grime di Kappah, il mystery shuffle di thegodfatherExperience<br />
& Alice, il gioco di accenti su tonalità scure<br />
di Uxo, la folktronica slackerlanguida di Bain Mass,<br />
la batteria immersa in ambient noise di Balbio (in duo<br />
con Robot Kaard su un altro brano), l’ambient di Grovekingsley,<br />
il lick fiatistico con sirene Mantronix di Planet<br />
highlight<br />
Boxcutter - the diSSolve (Planet mu recordS, aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: G l o s t e p<br />
Salvo una personale passione e continuità per lo sci-fi e la robotica firmata Autechre, Barry Lynn è uno<br />
che ha sempre cercato una sintesi tra trend consolidati e proposte innovative (altrui) nei propri lavori,<br />
posizionandosi, nel corso dell‘ultimo lustro, come un barometro privilegiato della vivacità e continua<br />
mutazione dell’UK continuum.<br />
Nel secondo album Glyphic, attraverso un percorso di convergenze parallele al Pinch di Underwater<br />
Dancehall (dello stesso anno, il 2007), esplorava il lato rastafariano dello stepping etnico e dubbato<br />
di scuola Tempa (vedi le reminiscenze Horsepower Productions) senza<br />
farsi mancare certe intuizioni a contorno (post-jazz Miles Davis via Squarepusher<br />
e Skream!); nel successivo Arecibo Message (2009) spaziava qui<br />
e là riprendendo lezioni garage (via Burial di Untrue) ‘ardkore e house (via<br />
Actress) acid (via Luke Vibert) e così via, catalizzandoli in uno spettro analogico<br />
pre-IDM, accarezzando anche sonorità 80s.<br />
Nel 2011 del post-hypnagogic, in pieno recupero di spezie black 70s (funk,<br />
fusion, jazz, Herbie Hancock), nuove e vecchie loungerie, dei Bibio di Mind<br />
Bokeh e dei Toro Y Moi di Underneath The Pine, Caribou e Discodeine,<br />
Lynn si riconferma ancora l’ago della bilancia elettro-brit, consegnando alle stampe forse il suo miglior<br />
lavoro.<br />
The Dissolve oltre a sintetizzare il dubstep e la fu IDM in nuove e convincenti tracce (Factory Setting<br />
e Adele gli splendidi esempi che bazzicano intorno al mondo electro brit tra garage, dubstep, afro,<br />
drum‘n‘bass, ‘ardkore), affonda completamente il colpo nella solarità e nel disimpegno nu disco caraibico<br />
now: da una parte, il funk (Zabriskie Discodegna di Bjørn Torske) dall‘altra il soul (All To Heavy, The<br />
Dissolve e Ufonik, tutte con Brian Greene alla voce), in mezzo, la mano, un solido impasto suonato con<br />
batterie, bassi slap e persino chitarre newagey Settanta (Passerby, Tv Troubles) mescolate a scintillanti<br />
tastiere vintage spaziali.<br />
Il disco è un album a due lune, una chiara e l’altra scura, entrambe focalizzate a dovere. L’irlandese non<br />
è uno che innova, ma incarna l’artigianato che assimila e restituisce con grande capacità ed efficacissima<br />
variazione sul (già) detto. Gli manca ancora tanto così per diventare il Caribou o Four Tet. Noi ci<br />
crediamo.<br />
(7.2/10)<br />
edoardo Bridda<br />
Soap, il loop zappiano di Knobuttons, l’esotismo di<br />
Digi G’Alessio e il mood goodbyeporkpiehat-iano degli<br />
Smania Uagliuns (forse il pezzo più riuscito della raccolta).<br />
Un po’ di fisiologica altalena qualitativa tra i pezzi, ma<br />
iniziativa molto interessante (soprattutto se farà da<br />
apripista per una intera serie) e ulteriore testimonianza<br />
del fermento e - speriamo anche - di una sempre mag-<br />
giore unità d’intenti all’interno della scena.<br />
(6.9/10)<br />
gaBriele marino<br />
adele - 21 (xl, marzo 2011)<br />
Ge n e r e: s o u l w r i t i n G<br />
In un periodo in cui quella cofana irrequieta di Amy Winehouse<br />
non sembra in grado di reggere il peso della<br />
50 51
scena, Joss Stone sembra essersi dimostrata una meteora<br />
durata giusto lo spazio dell’esordio e mentre Duffy<br />
sembra spingere la propria musica verso altri lidi, Adele<br />
sembra avere tutte le carte in regole per prendersi lo<br />
spazio che la sua voce cavernosa e potente da soul singer<br />
si merita.<br />
Dopo un esordio di grande successo commerciale, 19<br />
(numero che indicava anche la giovane età dell’artista),<br />
Adele ha aspettato quasi tre anni per affrontare il sophomore,<br />
tenendosi adeguatamente lontana dai pericoli<br />
che potevano insidiare una carriera ancora tutta da<br />
costruire. Si è ritirata oltre oceano, in questi Stati Uniti<br />
da soul country nei quali tanto affondano le radici della<br />
sua arte (Dusty Springfield, sì, ma anche Wanda Jackson),<br />
e in quel di Malibu, in compagnia di una vecchia<br />
volpe come Rick Rubin, ha messo insieme questo 21.<br />
L’impressione generale è che in un potenziale ancora<br />
tutto da scoprire, le carte per durare ci siano. Il dittico<br />
iniziale del singolo Rolling In The Deep e di Rumors Has<br />
It lascia senza fiato per lo stomp efficace, per la forza<br />
dell’interpretazione, per la cura dei dettagli. La liquida<br />
He Won’t Go sembra superare la Winehouse proprio<br />
sul suo terreno, Take It All è la più classica delle ballate<br />
pianistiche, quelle che resero grande Peggy Lee, ma<br />
anche una buona schiera di cantanti afroamericane<br />
degli anni d’oro del jazz. Ci sono episodi meno riusciti<br />
(Turning Tabels, ad esempio, si salva solo per gli archi, la<br />
cover di Lovesong dei Cure in salsa bossanova convince<br />
fin là), ma dobbiamo scrivere il nome di Adele tra quelli<br />
da seguire nel prossimo futuro.<br />
(7.1/10)<br />
marco BoScolo<br />
adventure - leSSer known (carPark,<br />
aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: s y n t h -p o p<br />
Anche se non ha mai voluto riconoscersi in tale veste,<br />
il primo album di Benny Boeldt (Adventure, 2008) era<br />
di fatto un perfetto esempio del cosiddetto chiptune,<br />
ovvero l’arte di far musica home-made col solo utilizzo<br />
dei suoni prodotti dai primi videogiochi anni ‘90. Nello<br />
stesso anno in cui 4mat, uno dei padrini del genere,<br />
torna con Surrender a ridare lustro e classe all’estetica<br />
nintendo-oriented, Adventure si svincola dalle regole<br />
della chip music approdando in territori più decisamente<br />
(synth)pop. Lesser Known non perde comunque lo<br />
spirito giocoso né una certa nostalgia degli anni passati,<br />
prendendo posto nel percorso evolutivo post-glo-fi<br />
proprio accanto agli ultimi Miami Horror. In altre parole:<br />
l’amore per gli eighties è confermato a viso aperto,<br />
ma l’attitudine lo-fi viene meno in favore di una più<br />
marcata componente dancey. Stavolta però, più che la<br />
lezione di Washed Out e Memory Tapes, ad emergere<br />
è ancora una volta la devozione per i protagonisti degli<br />
‘80, con menzione speciale per New Order (i riconoscibili<br />
loop di synth in Meadows e Open Door), Pet Shop<br />
Boys (l’energy dance di Lights Out e Relax The Mind),<br />
perfino Culture Club (il canto mellifluo di Boy George<br />
ripreso in Smoke And Mirrors). Gli spunti più fantasiosi<br />
si limitano dunque a un paio di brani: Electric Eel, col<br />
suo divertente dialogo tra vocoder e spasmi noise, e<br />
Rio, un vivacissimo gioiellino electro pop su misura per<br />
le vacanze estive. Preso atto delle sue abilità, va detto<br />
che il ragazzo può ancora migliorarsi, maturando un<br />
proprio stile personale. Sufficienza e pacca di incoraggiamento.<br />
(6.3/10)<br />
carlo affatigato<br />
agatha - goatneSS (wallace recordS,<br />
aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: n o i s e -s l u d G e<br />
Ridurre un power-trio elementare ad un duo, fare a<br />
meno della bocca di fuoco per eccellenza delle musiche<br />
rock e rendere il tutto possibilmente più heavy.<br />
Questa la missione non scritta delle due Agatha superstiti,<br />
Pamela a basso e voce e Claudia alla batteria.<br />
Riduzionismo di matrice noise-sludge con armamentario<br />
di effettistica varia e batteria mobile a rendere corposo<br />
un suono che non conosce soste o fa prigionieri:<br />
pesantezza slowcore e slabbrature metal-noise tra un<br />
doom alla Sunn O))) ma più dinamico (AutunnO)))),<br />
uno sludge paludoso alla EyeHateGod e certe efferatezze<br />
sonore del post-hc primi 90s quando flirtava col<br />
metal (Earth Crisis, Snapcase et similia) ma senza fondamentalismo<br />
se si eccettua quello targato diy (Punk<br />
Explained To My Mother). Ad aggiungersi alla proposta<br />
del neo-duo, un notevole senso dell‘umorismo citazionista<br />
e autoironico: titoli come Slayer Vs Morrissey, The<br />
Hard Life Of Last Minute Lyric Writers o Take Care Of My<br />
Carogna dicono di musiciste non solo padrone del versante<br />
strumentale ma anche dotate della sempre più<br />
rara capacità di non prendersi troppo sul serio.<br />
(7/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
alela diane - alela diane & wild divine<br />
(rough trade, aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: f o l k<br />
La parabola di Alela Diane prosegue nel segno di una<br />
pienezza sonora sempre più rivolta al folk-rock della<br />
cuspide tra Sessanta e Settanta. Nel suo rinnovato con-<br />
formismo, la cantautrice di Nevada City riesce comunque<br />
a ritagliarsi una dimensione propria, in un non meglio<br />
definibile punto d’equilibrio tra spirito e carne, tipo<br />
una Sandy Denny resa sanguigna da particelle Janis<br />
Joplin o una Grace Slick redenta Joan Armatrading.<br />
Sembrano quindi accantonati quei riflessi esoterici, la<br />
ricerca delle suggestioni fantasmatiche che l’avevano<br />
inizialmente accomunata al filone prewar-folk assieme<br />
alla concittadina Joanna Newsom.<br />
Sopravvive, certo, nelle nuances di una voce dall’intensità<br />
non comune, capace di esaltarsi nel sound allestito<br />
dalla nuova band, i Wild Divine, ovvero i chitarristi<br />
Tom Menig e Tom Bevitori, rispettivamente padre e<br />
marito di Alela, più il bassista Jonas Haskins ed il batterista<br />
Jason Merculief. Trilli fragranti di mandolino,<br />
tepori d’organo, cartigli di lap-steel, un prodigarsi ora<br />
delicato e ora turgido alla bisogna: è la band complice,<br />
duttile e sensibile di cui Alela aveva bisogno, perciò<br />
non stupisce che il titolo le renda omaggio. Neppure<br />
sorprende, visti i trascorsi, l’ispirazione che sostiene le<br />
tracce in scaletta, ballate che spacciano enfasi asciutta,<br />
calda inquietudine ed elastica risolutezza.<br />
Degne di nota una Suzanne che coglie il punto di fusione<br />
tra il Bob Dylan di Desire e quello di John Wesley<br />
Harding, una Elajah dalla balsamica trepidazione, quella<br />
Heartless Highway che sfarfalla jazzitudine e spersa<br />
acidità. Abbiamo forse perso un’interprete insolita, ne<br />
abbiamo guadagnata una che potrebbe dare una bella<br />
rinfrescata alla tradizione.<br />
(7/10)<br />
Stefano Solventi<br />
aleSSi’S ark - time travel (Bella union,<br />
aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: indie-f o l k<br />
Poco più che ventenne, Alessi Laurant-Marke deve il<br />
suo nome proprio all’omonimo, italianissimo brand di<br />
design. Cresciuta a Londra, debutta per Bella Union, ma<br />
ha alle spalle già una cospicua discografia fatta di EP,<br />
spit e singoli che rendono l’ipotesi di seguirne a ritroso<br />
le tracce operazione per lo meno impegnativa. La fortuna<br />
le arride quando, nemmeno maggiorenne, viene<br />
notata nella giungla My Space e messa sotto contratto<br />
dalla Virgin. Il connubio produce Notes from the Treehouse,<br />
ma qualcosa fa pensare alla giovane cantantautrice<br />
che è meglio rescindere il contratto dopo solo<br />
un disco e accasarsi presso un’etichetta più in linea con<br />
la sua estetica.<br />
Così arriviamo al 2011 e a <strong>Tim</strong>e Travel, con la voce da<br />
gattina di Alessi che mette in fila dodici brani eleganti<br />
e suadenti. Viene in mente Cat Power, ma anche Jo-<br />
hanna Newsom. Di quest’ultima, in particolare, la giovane<br />
londinese sembra possedere la stessa esuberanza<br />
creativa, testimoniata dalla composizione copiosa e<br />
dal fatto che oltre alla musica, si dedichi anche all’arte<br />
illustrata. In questo sguardo al folk al femminile targato<br />
USA, Alessi sforna alcune chicche, come la rivisitazione<br />
Americana della title track, il crescendo scanzonato à<br />
la Feist di The Robot (giù apparsa, insieme a The Bird<br />
Song sull’EP Soul Proprietor, antipasto del disco dello<br />
scorso anno), le ascendenze rock 60s/70s di Must’ve<br />
Grown.<br />
Il risultato complessivo è un lavoro maturo, molto più<br />
di quanto non dica la carta d’identità, per un’autrice<br />
che ha tutte le carte in regola per posizionarsi tra i migliori<br />
prospetti futuri del genere.<br />
(7/10)<br />
marco BoScolo<br />
alex turner - SuBmarine (domino, marzo<br />
2010)<br />
Ge n e r e: m e l l ow b r i t r o c k<br />
Da quando, nel 2008, diede vita ai Last Shadow Puppets<br />
è stato subito chiaro che Alex Turner potesse,<br />
presto o tardi, imboccare la via solista. L’occasione ideale<br />
si è presentata dunque con la colonna sonora del<br />
debutto cinematografico dell’amico Richard Ayoade -<br />
regista di molti videoclip degli Arctic Monkeys - per<br />
cui confezionare i cinque brani di questo EP di debutto.<br />
Dalla beatlesiana Stuck On The Puzzle e al pop midtempo<br />
di Piledriver Waltz fino all’intimismo acustico di Hiding<br />
Tonight e It’s Hard To Get Around The Wind, Turner<br />
dipinge quadri malinconici e trasognati che non si allontanano<br />
troppo dai Monkeys di Secret Door e Cornerstone<br />
(Humbug). Ad emergere però concorrono i testi:<br />
la migliore dimostrazione di una scrittura maturata che<br />
da John Lennon ai Verve porta fino al Turner di oggi,<br />
la cui cifra stilistica è ancora tutta in divenire ma già<br />
poggia su un qualche evanescente eppur solido basamento.<br />
Prima di sbilanciarci bisognerebbe aspettare un album<br />
vero e proprio, ma viste le ottime recensioni ricevute<br />
dal film al Sundance Film Festival - lo hanno definito<br />
addirittura il Trainspotting della propria generazione -<br />
possiamo desumere che Submarine come colonna sonora<br />
possa funzionare, anche se preso a sé ci mostra un<br />
Turner in parte già sentito e abbastanza monotono.<br />
(6/10)<br />
alBerto lePri<br />
52 53
alexander riShaug - Shadow of eventS<br />
(dekorder, marzo 2011)<br />
Ge n e r e: am b i e n t, d r o n e<br />
Poco conosciuto e altrettanto sfuggente, Alexander<br />
Rishaug, è stato tante cose, in primo luogo un sound<br />
artist in proprio, poi un musicista impiegato in vari progetti<br />
impro e noise (ha fatto parte del collettivo ARM<br />
con Arne Borgan e Are Mokkelbost, dal 1996 al 2006,<br />
ha collaborato con Lasse Marhaug, Ole Henrik Moe,<br />
Erik Skodvin e Tape), infine un producer e un remixer.<br />
Guardando alle origini della sua produzione in solitaria<br />
torniamo al 1998, anno cruciale per il clicks’n’cut: in quei<br />
giorni Alexander è un ortodosso produttore di glitch e<br />
microwave music. Quattro anni più tardi, per Smalltown<br />
Supersound, esce il debutto, Panorama, un pout pourri<br />
di tecnologie fritte e saltate nello stile di Oval e lezioni<br />
minimaliste (Terry Riley) applicate all’era digitale (Raster<br />
Noton). Poi, con Possible Landscape per Asphodel, il<br />
tiro s’aggiusta assestandosi sull’ambient di derivazione<br />
glitch. Rishaug polverizza gli errori digitali, contempla la<br />
field music in modalità più campestre e si converte lentamente<br />
al suono maturo degli artisti Mille Plateaux.<br />
E così arriviamo quest’anno a Shadow of Events, terzo<br />
lavoro a suo nome e un passaggio alla chamber drone<br />
pienamente compiuto: il norvegese dipinge caldi<br />
human landscape, quadretti d’elettroacustica folk dai<br />
mood nipponico-umbratili accodandosi così a tante<br />
produzioni di settore ambient-noise dell’ultimo lustro.<br />
Come nei due album precedenti, Rishaug approda su nicchie<br />
sonore oramai esplose dallo sfruttamento di orde di<br />
nerd ed electoheads. La sua proposta non presenta quindi<br />
alcuna novità e neppure brilla per ispirazione o fascino.<br />
(5.5/10)<br />
edoardo Bridda<br />
annie hall - annieS (QuaSi mono, marzo<br />
2011)<br />
Ge n e r e: a c u t e indie-p o p<br />
L‘ultimo anno è stato foriero di novità per questa brillante<br />
formazione bresciana. Innanzitutto l‘amichevole<br />
forfait del bassista Giorgio Marcelli, nella line-up sin<br />
dall‘inizio; poi, la loro Ghosts‘ Legs finita nello spot pubblicitario<br />
di una nota compagnia telefonica. Soddisfazioni<br />
e momenti che hanno lasciato un segno come<br />
l‘essere in giro da un lustro con la mente da “trenta e<br />
qualcosa”. Così che si avverte subito in questo terzo album<br />
che qualcosa è cambiato, che la formula dei dischi<br />
precedenti (all’incirca: una personale sintesi di Eels e<br />
Wilco, Grandaddy ed Elliott Smith) poteva rimanere<br />
valida solo se sottoposta ad aggiustamenti di rotta che<br />
tenessero conto del vissuto.<br />
Parlano allora chiaro un titolo e uno scatto di copertina<br />
che suggeriscono un fare quadrato, ma soprattutto la<br />
sicurezza con cui il quartetto prosegue a sintetizzare<br />
tra loro i modelli di cui sopra nel mentre ne indaga i<br />
rispettivi padri. Da qui una maggiore elettricità, quel<br />
jingle-jangle muscolare alla Big Star che - pur non<br />
adombrando l‘anima acustica: si vedano il country<br />
crepuscolare Merry-Go-Round e la gemma Suitcase, un<br />
Brian Wilson folk-rock - pervade diversi brani (la secca<br />
apertura For You, una Beautiful Mind di ruvida emotività,<br />
la trascinante Place To Hide) e fa bel paio con l‘innesto<br />
di Gabriele Ponticiello, strumentista eclettico e raffinato.<br />
Reazioni che profumano di cambiamento nella<br />
continuità come la produzione arguta di Giovanni<br />
Ferrario e la pienezza raggiunta da scrittura e cantato.<br />
Non da tutti, infatti, la sfoglia chiltoniana Meanigless, con<br />
un refrain splendido per come rende naturale la complessità,<br />
e una commovente Shooting Star da George<br />
Harrison ale prese col dylaniano Oh Mercy (l‘ombra di<br />
Daniel Lanois si stende anche altrove, sullo strumentale<br />
Homestead e su certi toni traslucidi); altrimenti, la sensazionale<br />
articolazione di una Airstrip Zero in continuo<br />
ondeggiare tra luci e ombre e la conclusiva, visionaria<br />
Grand Avenue, sintesi di stile e insieme ponte verso il futuro.<br />
Maturità, ti accogliamo a braccia aperte. E chissà<br />
che qualcuno non presti orecchio anche all‘estero.<br />
(7.3/10)<br />
giancarlo turra<br />
aPeS on taPeS - forePlayS (homework<br />
recordS netlaBel, feBBraio 2011)<br />
Ge n e r e: w o n k y d o w n t e m p o<br />
Ancora ottimi segnali dalla scena. Apes On Tapes è il<br />
duo formato a Bologna nel 2005 da Luca Garuffi aka<br />
Lagàr e Giordano Dini aka Antani, folgorati dall’ascolto<br />
dell’hip hop strumentale di Prefuse 73. Questa è la<br />
loro terza prova dopo un EP (2006) e un album (2008)<br />
sempre su Homework.<br />
Il loro è un trip hop screziato di etno-esotismi (i cuts<br />
di voci in delay che si muovono sinuose fin dall’iniziale<br />
Les e dalla sua naturale prosecuzione Quarter Punder<br />
with Jazz), tagliato con gusto wonky e tocchi spacey.<br />
Senza dimenticare la lezione dilliana (Neat Meat Friend,<br />
Verbal Leprosy), le radici electro (Big Wordz Big Wizard) e<br />
qualche puntata sulla battuta dubstep (smerigliata alla<br />
Dimlite, Not That Ready).<br />
Un disco di raffinata ed evoluta downtempo, perfettamente<br />
inquadrato da un pezzo bello, ed eloquente fin<br />
dal titolo, come Atarassic.<br />
(7.1/10)<br />
gaBriele marino<br />
highlight<br />
cat’S eyeS - cat’S eyeS (downtown, aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: lo u n G e G o t h p o p<br />
“Sapevamo che se ci fossimo riusciti, nessuno sarebbe stato in grado di copiarci” dicono oggi compiaciuti.<br />
E ci mancherebbe! Una band che inizia la propria carriera concertistica a San Pietro (la basilica vaticana,<br />
non una qualche sconosciuta fiera di paese) ha come unico limite le stelle.<br />
Retorica a parte, che Faris Badwan fosse l’anima meno garagistica e più eclettica all’interno del collettivo<br />
Horrors si era capito. Più difficile sarebbe stato immaginare che le derive sarebbero state quello di<br />
un pop cinematico e altamente suggestivo come quello prodotto dai Cat’s Eyes.<br />
Insieme al giovane soprano canadese Rachel Zeffira ha allestito un progetto che si abbevera tanto al<br />
pop dei girl groups, quanto agli score exotici di Piero Umiliani e Bruno Nicolai. Attenzione però a<br />
considerare come marginale il contributo della Zeffira. E’ dalle sue abilità di polistrumentista, nonchè<br />
dai suoi soggiorni italiani (a Verona, infatti, ha perfezionato gli studi lirici) che i Cat’s Eyes traggono<br />
spunto.<br />
Il loro esordio è perciò un disco calato nei 60s più oscuri e bohemien, sia<br />
quando i due si avventurano nel beat kraut della title track, sia quando<br />
forniscono la loro personale interpretazione dei duetti fra la bella e il tenebroso<br />
(più Hazelwood/Sinatra che Gainsbourg/Bardot) sempre virati su<br />
tonalità dark. Trovano infine la loro specificità nel Morricone crepuscolare<br />
di Bandit e Over You, o negli esotismi in Super 8 di Not A Friend.<br />
Piace molto la misuratezza degli arrangiamenti, così come il modo in cui<br />
Rachel dosa la voce calandosi nel ruolo della chanteuse. Il resto lo fa una<br />
produzione che garantisce la giusta patina vintage e un gustoso languore psichedelico.<br />
Badwan e la Zeffira ci tengono a far sapere che i Cat’s Eyes sono una band a tutti gli effetti, per questo<br />
sarà interessante constatare la resa dei brani alla prova del live, quando i due saranno accompagnati da<br />
un vero ensemble di musicisti. Ciò non toglie che il loro sia un progetto decisamente affascinante che<br />
non mancherà di proiettare la propria lunga ombra sul prossimo imminente lavoro degli Horrors.<br />
(7.3/10)<br />
diego Ballani<br />
arBe garBe - arBeit garBeit (cPSr, aPrile<br />
2011)<br />
Ge n e r e: p a t c h a n k a -f r e e<br />
Agropunk freenoise: gli Arbe Garbe abitano un limbo<br />
che è solo loro, fatto di una musica eclettica à la Primus<br />
mixata a una patchanka nomade e multilingue. Quasi<br />
a unire dimensione popolare e concettualità ai confini<br />
con l’avanguardia, in un suono insolitamente bandistico<br />
che macina ottoni, chitarre elettriche, batteria, accordion<br />
e chissà cos’altro.<br />
Se il precedente The Great Prova - pubblicato in comproprietà<br />
con il chitarrista americano Eugene Chadbourne<br />
- era servito a istituzionalizzare agli occhi degli<br />
ascoltatori più smaliziati una band che non sarebbe stato<br />
giusto confinare nel calderone del folk danzereccio<br />
più generalista, questo Arbeit Garbeit sintetizza bene la<br />
contemporaneità del gruppo. Fatta di un suono girovago<br />
ma anche di episodi trasversali e meno prevedibili (Il<br />
volo della Paloma, Une Bugade Di Vint).<br />
E’ in questa veste che li preferiamo, nonostante un giudizio<br />
sul disco complessivamente positivo.<br />
(6.8/10)<br />
faBrizio zamPighi<br />
architecture in helSinki - moment BendS<br />
(modular, aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: in d i e -po p<br />
Furbi gli Architecture In Helsinki a far uscire il nuovo<br />
album alle porte della bella stagione: il suono già tradizionalmente<br />
solare del gruppo tradisce oggi ancora più<br />
voglia d’estate. E’ una delle poche sfumature avvisabili<br />
in una ricetta per lo più immutata dai tempi di quell’In<br />
Case We Die che potremmo definire, se non capitale,<br />
quantomeno importante nel definire il mondo indiepop<br />
nella sua accezione più colorata.<br />
Nessuna svolta, insomma, e del resto sarebbe sciocco<br />
54 55
pretenderne da un gruppo del genere, ma ancora una<br />
manciata di brani divertenti (la corale Yr Go To, con tanto<br />
di campane, o la ballabilissima Escapee) e anche un<br />
po’ di malinconia da tramonto sulla spiaggia (la dolce<br />
W.O.W., la Desert Island che apre il disco in lieve levare).<br />
Nella seconda metà della tracklist l’album, del resto,<br />
mostra il fianco: Denial Style e Everything’s Blue suonano<br />
obiettivamente meno convinte, e come se non bastasse<br />
Sleep Talkin’ gioca col solito synth-pop anni ‘80<br />
con I Know Deep Down a strizzare l’occhio agli Wham.<br />
Per un gruppo che ha puntato tutto sulla centrifuga di<br />
influenze piuttosto che sui rimandi diretti, questo è decisamente<br />
un difetto.<br />
In definitiva Moment Bends è un disco dal fiato corto.<br />
Un peccato dato che quel che c’è di buono funziona<br />
davvero.<br />
(6/10)<br />
Simone madrau<br />
auStin Peralta - endleSS PlanetS<br />
(Brainfeeder, feBBraio 2011)<br />
Ge n e r e: f u s i o n<br />
Giovanissimo astro del piano (un mentore d’eccezione<br />
come Alan Pasqua, due dischi per la Sony/CBS pubblicati<br />
quando aveva appena 16 anni; sul primo suona<br />
Ron Carter), Austin Peralta (1990) rappresenta una<br />
sorta di contraltare USA alla funambolica giapponese<br />
Hiromi Uheara (con la quale peraltro ha collaborato),<br />
come lei con Chick Corea in testa e sulla punta delle<br />
dita. Dopo session per gente del giro nuovo-afrofuturista<br />
come Erykah Badu e Shafiq Husayn (Sa-Ra),<br />
esordisce adesso sulla Brainfeeder di Flying Lotus e<br />
si capisce subito perché. Il ragazzo è cresciuto ascoltando<br />
quella fusion avanzata di cui lo stesso FlyLo si è<br />
nutrito per Cosmogramma e una fusion di quelle che<br />
fa perdere la testa agli hip hop-heads di nuova generazione<br />
- opportunamente immersa in un immaginario<br />
spacey - restituisce.<br />
Chiama l’amico Strangeloop a girare qualche cursore<br />
e premere qualche pulsante lungo la tracklist, ma francamente<br />
l’intervento si sente poco; come pure passa<br />
in secondo piano il cameo della Cinematic Orchestra.<br />
Endless Planets è piuttosto lo showcase jazzistico di<br />
Austin e dei suoi accompagnatori: Zane Musa-sax alto,<br />
Ben Wendel-sax tenore e soprano, Hamilton Pricebasso,<br />
Zach Harmon-batteria. Si sente l’influenza di Hiromi<br />
in certi momenti, per esempio nel bel groove e<br />
nel tema serpentino e accattivante di Capricornus; ma<br />
manca quella freschezza alla fine funk/pop che riscatta<br />
la giapponese dagli onanismi standard nel post-Corea.<br />
In cui invece il biondissimo sguazza.<br />
Austin non ci sembra insomma il visionario fusion di<br />
cui parla FlyLo, ma un impeccabile (il disco è elegante,<br />
suonato da dio, e ci mancherebbe) tecnico armato di<br />
buon gusto. Puro stile e pura forma, l’album manca di<br />
quella incisività che si deve pretendere oggi da chi ha<br />
un pedigree come il suo. Non siamo tra quelli che pensano<br />
che la fusion sia roba vecchia e per vecchi, però<br />
questo qui è proprio un disco conservatore.<br />
(6.4/10)<br />
gaBriele marino<br />
BaBalot - non Sei Più (aiuola, marzo 2011)<br />
Ge n e r e: in d i e, it a l i a n a<br />
Babalot è un piccolo progetto folle, iniziato in gruppo,<br />
con il punkpop lo-fi di Che succede quando uno<br />
muore (2003) e proseguito in seconda battuta in veste<br />
solista dal frontman Sebastiano Pupillo, con il malinconico<br />
e naif Un segno di vita (2005). Babalot, oggi, è di<br />
nuovo una band, e torna per la fida Aiuola dischi - appunto<br />
aiuola felice per il bel pop nostrano - con Non<br />
sei più.<br />
Non si perde occasione, in ognuno di questi otto brani,<br />
di ricordarci che non servono mai grandi mezzi per fare<br />
qualcosa di rilevante e stratificato, con un buon numero<br />
di piani di interpretabilità. Non sei più, infatti, come<br />
del resto gli episodi che lo hanno preceduto, non è solo<br />
pop - autoironico, a tratti noir, glassato di electro da cameretta<br />
- ma nasconde, in una seconda battuta, una<br />
buona dose di analisi folleggiante del nostro presente,<br />
del nostro intimo più onirico, desiderante, spaventato.<br />
Queste canzoni sono cavalcate pop, divise tra folk chitarra<br />
e voce, mood western e punk, a volte minimali,<br />
talvolta in esplosione beatlesiana ma armate sempre e<br />
comunque di intuizioni, anche e soprattutto nei testi,<br />
irresistibili. Non una sola direzione ma mille sguardi:<br />
da quello a Vinicio Capossela in Gattonero a quello,<br />
persistente, all’Alessandro Fiori solista nello splendido<br />
incubo-sogno Andiamo a mare e ancora in Paperino<br />
e Maggio. C’è tutta una nuova direzione cantautorale<br />
di finto nonsense e genio travestito da follia, in questo<br />
senso, il nome di Babalot, insieme a quello di Fiori e a<br />
quello meno incisivo di Dino Fumaretto, è prospettiva<br />
essenziale e pienamente riuscita.<br />
(7.1/10)<br />
giulia cavaliere<br />
highlight<br />
colourmuSic - my _____ iS Pink (memPhiS induStrieS, aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: p o p o b l i q u o<br />
La Colourmusic non è una novità. È l‘output di una coppia di amici che si conoscono dal college e che<br />
metà dei Duemila, ormai, fanno musica ispirandosi a temi cromatici. My ____ is Pink esprime fino in<br />
fondo l‘espressionismo timbrico di cui Ryan Hendrix, Nick Turner e compagni sono capaci.<br />
Conoscevamo la band dai tempi quando apriva per Flaming Lips e British Sea Power qualche anno<br />
fa. E proprio ai primi li accosteremmo per quella che ci sembra la caratteristica<br />
principale di Colourmusic, ovvero l‘approccio: un metodo che ha a<br />
che fare con il recupero non revivalistico, l‘astrazione, la produzione. C‘è<br />
molto Brian Eno che accompagna come meglio può gli U2, in My ____ is<br />
Pink, ma si sentono parecchio anche le corde e le idee tese degli Wire (Jill<br />
& Jack (A Duet)), e, facendo zoom out, una modalità di riapprocciare le cose<br />
del passato che è molto vicino a quel periodo.<br />
Da un lato My ____ is Pink è un disco pienamente post-00, fatto di un uso<br />
dello studio, della stratificazione proprio dei nostri anni, persino di un‘anima<br />
collettiva (We Shall Wish (Use Your Adult Voice)); nel rosa c‘è però anche un tentativo di andare oltre,<br />
passare allo step successivo riabbracciando, riprendendo in mano alcune cose che probabilmente dovremo<br />
riaffrontare nei prossimi anni: abbiamo detto Flaming Lips, ma anche Mercury Rev, e tutto quel<br />
passaggio di inizio anni Novanta e quel tipo di psichedelia che, insieme al pop produttivo Achtung<br />
Baby, la Colourmusic innesta sulla generazione Animal Collective.<br />
Accade perciò che Dolphins & Unicorns sia un‘entità abbastanza strana, una ritmica che ci fa sentire i Novanta<br />
meno intellettuali ma anche un‘obliquità di questi anni, e che ancora una volta gode del lascito<br />
del revival del post-punk quell‘assenza di rettitudine che è anche spirito di astrazione percussiva, acida<br />
e sanguigna nel tempo stesso, nutrita della materia tipica dell‘indie rock: distorsioni di chitarra e basso<br />
affiancate dalle batteria. Un altro esempio: la successione tra The Beast With Two Backs e la lunga The<br />
Little Death (In Five Parts), dove si passa da un esercizio di decomposizione alla 154 a una traccia con<br />
percussività - anche se non poliritmica - alla Mahjongg, con lunga coda di psichedelia cosmica.<br />
Se ci abbiamo visto giusto, il rosa shocking della musica di Hendrix e Turner potrebbe diventare un<br />
precedente nei prossimi anni.<br />
(7.2/10)<br />
gaSPare caliri<br />
Bachi da Pietra/maSSimo volume - SPlit eP<br />
(la temPeSta diSchi, aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: r o c k<br />
Ce lo auspicavamo tempo fa accoppiandoli in un nostro<br />
speciale sull‘uso dell‘italiano nel rock. Poi quella<br />
unione si è materializzata su un palco comune in occasione<br />
del tour di Cattive Abitudini e Quarzo. Ora è la<br />
volta di una appendice discografica, nata proprio durante<br />
quel tour.<br />
Questo split vinilico nasce infatti in accordo con La<br />
Tempesta, il Circolo degli Artisti di Roma e il ravennate<br />
Bronson (dal cui deus ex machina Chris, sembra<br />
sia partita l‘idea) e reitera la collaborazione sfruttando<br />
l‘abusata formula dello split con prestito di canzo-<br />
ne. Sul lato A i bolognesi prendono la vibrante Morse<br />
dall‘ultimo Quarzo e la ingentiliscono smussandone le<br />
asperità “petrose” senza però perdere nulla della drammaticità<br />
originaria. Poi aggiungono un inedito, Un Altro<br />
Domani, memore degli intrecci chitarristici che hanno<br />
rappresentato il marchio di fabbrica dei Massimo Volume<br />
sin dagli esordi.<br />
Dall‘altro lato il duo Dorella/Succi rende il favore con<br />
una Litio, estratta da Cattive Abitudini, resa scheletrica<br />
e nevroticamente rock, tutta spigoli e distorsioni, cui<br />
si aggiunge l‘inedita Stige 11. Vera e propria sorpresa<br />
del lotto, mostra i Bachi Da Pietra saturi e sconvolti,<br />
aggressivi e dilanianti come mai li avevamo ascoltati<br />
prima, in grado di cavalcare un mid-tempo rock incen-<br />
56 57
diario con furore e padronanza. Cosa che ci fa ben sperare<br />
per futuri risvolti.<br />
Una ottima sorpresa che neanche i fan più accaniti si<br />
sarebbero aspettati.<br />
(7/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
Bancale - frontiera (riBéSS recordS,<br />
aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: t a l k i n’ n o i s e<br />
Frontiera è la linea di demarcazione tra l’incantesimo<br />
del vivere e la consapevolezza del ciclo vitale. Forse<br />
l’unico confine reale, perciò rimosso, simbolicamente<br />
dissimulato in un ordito di codici e rituali che ne stemperano<br />
- ne equivocano - il senso. Che pure resta, come<br />
un brontolio ai margini del frastuono. La morte quindi<br />
- evento biologico, cronologico e culturale, ingranaggio<br />
e carburante di vita - è la nota dominante di questo<br />
album di debutto dei Bancale, trio lombardo formato<br />
nel 2006 dal “nostro” Luca Barachetti (voce) e dal chitarrista<br />
Alessandro Rossi, raggiunti poi dal percussionista<br />
Fabrizio Colombi.<br />
Già l’omonimo ep del 2009 ebbe modo di colpirci per<br />
l’intensità dei reading immersi in ordigni noise-blues,<br />
il “metodo” Massimo Volume portato ad un livello di<br />
esasperazione inedito, tra vibrazioni terrigne e visioni<br />
febbrili che semmai scomodavano punti di contatto<br />
coi Bachi Da Pietra. In occasione del presente full<br />
lenght di debutto, quella calligrafia compie un significativo<br />
balzo in avanti, alza la temperatura dell’ossessione<br />
blues fino al delirio controllato del post (echi palpabili<br />
For Carnation) accogliendo turbamenti slow-core<br />
(tipo dei Codeine scorticati) aprendosi poi a suggestive<br />
ancorché livide palpitazioni folk (dalla pregnante<br />
afflizione Will Oldham/Jason Molina).<br />
E’ tangibile il contributo di Xabier Iriondo, che del<br />
disco è produttore artistico: cartigli scabri di chitarra,<br />
elettroniche frastagliate, insomma la tipica calligrafia<br />
disturbante messa al servizio del sound, che arricchisce<br />
senza prevaricare. Tra i dieci episodi in scaletta,<br />
spiccano Megattera col suo ondeggiare tumultuoso,<br />
l’impeto sanguigno di Calolzio, la struggente inquietudine<br />
di Suonatore cielo e la torbida trepidazione della<br />
title-track. Una bella conferma.<br />
(7.2/10)<br />
Stefano Solventi<br />
BaSement freakS - Something freaky<br />
(jalaPeno, feBBraio 2011)<br />
Ge n e r e: d i s c o f u n k<br />
Quando, ad inizio 2010, venne alla luce la hit Disco Life,<br />
era difficile immaginare che il nuovo corso di George<br />
“Basement Freaks” Fotiadis potesse avere una portata<br />
così ampia. L’orientamento nu-funk l’avevamo sì scoperto<br />
nell’esordio di Urban Jungle ma, da allora ad oggi,<br />
lo scarto è notevole: Something Freaky fa finalmente<br />
esplodere le micce groove del talento greco coniugando<br />
classicità e nuove espressioni.<br />
Il punto di partenza è il funk delle origini: James Brown<br />
(già remixato da Fotiadis in Mind Power, un paio d’anni<br />
addietro) e chitarrine frizzanti annesse, ma anche i filmacci<br />
di serie B della blaxploitation anni ‘70, il vocoder<br />
pop, la mutant disco e Prince. Niente che non possa<br />
attecchire con una certa facilità nei nostalgici giorni<br />
d’oggi, tanto più che la mistura si porta dietro tutto ciò<br />
che è intercorso nel frattempo: tra il big beat evoluto a<br />
partire dai Groove Armada più radiofonici (Get Down<br />
Boogie), la nu-disco irriverente di Calvin Harris (Get Ready)<br />
e il p-funk targato DFA sullo sfondo; si aggiungono,<br />
impietosi generosi affondi electro (Makes Me Wanna<br />
Scream), afro-funk da corrida (Ade Bantu in Make<br />
Money) e, perché no, lo stile canoro di un Justin <strong>Tim</strong>berlake<br />
sempre più sdoganato (Something Freaky).<br />
Il troppo stroppia, ma c’è sempre l’eccezione...<br />
(6.8/10)<br />
carlo affatigato<br />
Bill callahan - aPocalyPSe (drag city,<br />
aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: fo l k<br />
Le ultime due prove di Bill Callahan, solari e decisamente<br />
più composte, vedevano l’autore noto come<br />
Smog abbandonare le radici lo-fi che ne avevano fatto<br />
un nome di culto nel decennio precedente: ne risultavano<br />
brani meglio confezionati in cui tuttavia la<br />
maggior pulizia del suono sembrava tenere a freno<br />
estro e ispirazione. Oggi Bill è appena più introverso e<br />
cupo ma non così tanto da giustificare un titolo come<br />
Apocalypse, scelto invece per raccogliere sette nuove<br />
canzoni che di catastrofico hanno nulla e che si fanno<br />
apprezzare per qualità ancor prima che per atmosfere.<br />
Piacerebbe evitare il solito elenco, giudicare invece<br />
il disco nel suo complesso ed elogiarlo per la sua ormai<br />
usuale raffinatezza, ma sarebbe un peccato tacere<br />
dell’incedere dritto e solenne delle chitarre che portano<br />
a trionfo la timbrica inconfondibile del nostro in<br />
Drover, così come non si può non menzionare i singulti<br />
delle stesse in Baby’s Breath: è un dittico di apertura in<br />
cui subito traspare il consueto gran gusto nel pensare<br />
canzoni come fossero suite. I crescendo, gli stacchi, le<br />
accelerazioni improvvise, i cambi di tempo, l’efficacia<br />
di elementi solo apparentemente di contorno qua-<br />
li violino e flauto: tutto è organizzato alla perfezione,<br />
come se la musica fosse la colonna sonora di un film<br />
la cui trama è enunciata nelle liriche, sempre ispiratissime.<br />
A mettere il punto su queste progressioni interviene<br />
dunque il quasi-funk di America!, all’insegna di<br />
un groove pressochè costante ma disturbato da riff di<br />
chitarra che sporcano tutto come nelle migliori pagine<br />
dell’indie-rock anni 90: è l’apice del disco, già ora tra i<br />
brani più eccitanti del 2011.<br />
La seconda metà dell’album è al contrario più pacata<br />
e regala un altro gioiello, Riding For The Feeling, ballata<br />
di rara suggestione emotiva che al solito fa scattare<br />
l’inevitabile paragone tra il nostro e Kurt Wagner dei<br />
Lambchop. Appena inferiori sono invece i nove minuti<br />
della conclusiva One Fine Morning che, lavorando appena<br />
di più sulla melodia, non avrebbe sfigurato fra i<br />
cataloghi di Nick Drake o <strong>Tim</strong> Buckley.<br />
Apocalypse è un’uscita che magari verrà sottovalutata,<br />
complice l’anzianità sulle scene del suo autore in<br />
contrapposizione al sempre più frenetico sbocciare di<br />
gruppi nuovi: non credete agli hype, qui c’è un musicista<br />
che non solo non molla la presa ma si ripresenta in<br />
uno stato di forma invidiabile.<br />
(7.4/10)<br />
Simone madrau<br />
BirdS of PaSSage - without the world<br />
(denovali, aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: d r o n e intimistico<br />
Memorie personali, particolari e sfuggevoli atmosfere,<br />
brevi attimi di una vita, tutto ciò che può contenere l’album<br />
di ricordi che ognuno di noi conserva dentro sé.<br />
Di questa impalpabilità è fatta la musica di Alicia Merz,<br />
la responsabile unica dietro la sigla Birds of Passage:<br />
un diario segreto fatto da collage di ritagli dalla propria<br />
intimità tenuti insieme dall’esilità di atmosfere plumbee<br />
dove soundscape e microdroni richiamano alla<br />
mente voci lontane e spettrali dal passato.<br />
Un lavoro altamente introspettivo, a tal punto da risultare<br />
inestricabile e inesplicabile per chiunque fatta<br />
eccezione per la sua autrice. Senza la maestria necessaria<br />
per creare empatia nell’ascoltatore nella messa in<br />
scena del proprio microcosmo - si prenda ad esempio<br />
l’ultima uscita di casa Six Organs Of Admittance - Without<br />
The World risulta piatto e privo di una carica emotiva,<br />
fallendo proprio là dove avrebbe dovuto colpire.<br />
Invece che suscitare sentimenti ed emozioni produce<br />
un’assenza di esse, uno stato di torpore generalizzato<br />
che si riverbera anche sul giudizio finale.<br />
(5/10)<br />
franceSco aSti<br />
Black devil diSco cluB - circuS (lo<br />
recordingS, aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: d i s c o e l e c t r o<br />
Bernard Fevre chiama a raccolta una serie di nomi di<br />
richiamo: Jon Spencer, Faris Badwan degli Horrors,<br />
Michael Lovett, addirittura Nancy Sinatra e Afrika<br />
Bambaataa. Ma la sua miscela disco, qui pesantemente<br />
virata electro, appare fiacca ed impacciata come non<br />
mai. Non mancano momenti godibili (She Flees The Silence)<br />
o singoli dettagli interessanti, ma in generale,<br />
dall’iniziale Fuzzy Dream (un motivetto infiorettato da<br />
percussioni) alla conclusiva Magnetic Devil (uno stereotipo<br />
portato alla noia), è tutta la stessa marmellata di<br />
sottofondo, trasparente, inoffensiva. Anzi no, a tratti<br />
anche irritante.<br />
(5/10)<br />
gaBriele marino<br />
BleSSed child oPera - fifth (SeahorSe<br />
recordingS, marzo 2011)<br />
Ge n e r e: f o l k-w a v e<br />
Quel che spicca della produzione di Paolo Messere a<br />
nome Blessed Child Opera - perché ormai di progetto<br />
solista si parla, pur con tutta una costellazione di collaboratori<br />
che orbita attorno al padrone di casa - è la<br />
qualità media. Nessun disco che sembri un vezzo gratuito<br />
del musicista-produttore napoletano e tutti a fare<br />
bella mostra di una poetica che lavora da sempre sulle<br />
atmosfere, sui colori, sulla personalità del suono. Fifth<br />
decide che è venuto il momento del folk, con dodici<br />
brani in gran parte acustici contaminati da quella componente<br />
wave analogica e decadente che ormai è un<br />
marchio di fabbrica di Messere. Tra il crooning di Never<br />
To Return On Your Steps e una Falling che ricorda i Tindersticks,<br />
il mood ombroso di Reflection After Nothing<br />
e gli archi di Between Us, la voce e chitarra di Lonely<br />
Friend e gli accenni free di Promised Circle.<br />
Alla fine la cifra stilistica dei Blessed Child Opera è anche<br />
il limite maggiore del progetto, se di limite si può<br />
parlare. Nel senso che da un disco di Paolo Messere<br />
sai quasi sempre cosa aspettarti e alla resa dei conti<br />
quell’eleganza impeccabile che ci trovi dentro fa un po’<br />
la figura del diamante in vetrina: brillante, prezioso, ricercato<br />
ma indirettamente anche autoreferenziale nel<br />
suo involontario ruolo di status symbol.<br />
(6.9/10)<br />
faBrizio zamPighi<br />
58 59
Blow monkeyS (the) - Staring at the Sea<br />
(fod, aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: f o l k s o u l p o p<br />
Tornati sorprendentemente nel 2008 con Devil’s Tavern,<br />
dopo un silenzio durato quasi vent’anni, i Blow<br />
Monkeys ribadiscono oggi il rinnovato estro col settimo<br />
album Staring At the Sea. Val bene ricordare ad uso<br />
dei più giovani che questo quartetto inglese conobbe<br />
qualche anno di celebrità effervescente nella seconda<br />
metà degli Eighties, quando si svincolarono dalla matrice<br />
new wave per prodigarsi in un funk-pop-soul arguto<br />
e satinato piuttosto affine a quello dei coevi Style<br />
Council, sposando infine la causa di una dance tutta<br />
spigoli e raffinatezza che non sopravvisse al sopraggiungere<br />
dei Novanta. Riferiamo della carriera solista<br />
del leader Bruce Robert Howard - meglio noto come<br />
Dr. Robert - giusto per inquadrarne le sempre più<br />
spiccate aperture folk, palpabili in queste undici nuove<br />
tracce, in prevalenza ballate con una certa attitudine<br />
per l’epica accorata di stampo Paul Weller (vedi quel<br />
che accade in Face In The Rock e The Killing Breeze).<br />
I nostalgici di mezza età troveranno motivi per sgranchire<br />
le giunture con Seventh Day e col northern soul<br />
dell’iniziale Steppin’ Down, mentre una One Of Us Is<br />
Lying riesce persino a sprimacciare gradevoli rimembranze<br />
rocksteady. Una malinconica ricercatezza pervade<br />
gli arrangiamenti orchestrali di All Blown Down, la<br />
morbida declinazione flamenco della title track e una<br />
Prayin’ For Rain che addita trepidazioni gospel e country-blues<br />
con solennità persino eccessiva. Fa meglio la<br />
conclusiva A Lasting Joy, che azzecca un ibrido folksoul<br />
con aspersioni cameristiche come potrebbe un -<br />
liberi di stupirvi - <strong>Tim</strong> Hardin in fregola Terry Callier.<br />
L’impressione complessiva gradevole, anche se a ben<br />
vedere non si va oltre una onesta, sentita competenza.<br />
(6.5/10)<br />
Stefano Solventi<br />
Blue van (the) - love Shot (iceBerg<br />
recordS, aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: Ga r a G e p o p<br />
Fa impressione vedere l’assoluto sincronismo con cui<br />
tanti rock act emersi nella prima parte del decennio<br />
scorso, ai tempi in cui NME sbandierava l’assurdo tag di<br />
New Rock Revolution, abbiano assecondato la rivincita<br />
dei synth sulle chitarre, introducendo elementi electro<br />
pop nel proprio sound.<br />
Nel caso del nuovo lavoro dei Blue Van, band danese<br />
che aveva suscitato un certo interesse ai tempi dell’esordio<br />
hard garagistico, la cosa è evidente sin dalle prime<br />
note. Nell’opener Mama’s Boy, i sostenuti accordi sinte-<br />
tici fanno le veci di quella che in altri momenti sarebbe<br />
stata una chitarra ritmica.<br />
E’ pop che usa la sintassi del rock, ma dai connotati inevitabilmente<br />
contraffatti ed edulcorati. Una volta preso<br />
atto di ciò ci si può lasciare andare alla sfacciataggine<br />
glam della title track, ai Led Zeppelin manierati di Hole<br />
In The Ground o al Marc Bolan cromato e sculettante di<br />
Run To The Sun.<br />
Il ritornello killer è sempre dietro l’angolo, talvolta più<br />
sinuoso e sofisticato (è il caso del godibilissimo power<br />
pop di Evil), talaltra di grana decisamente più grossa.<br />
Un sound con mascara e lustrini che punta alle grande<br />
platee, ma si accontenta di finire nella colonna sonora<br />
di qualche telefilm adolescenziale, come già è accaduto<br />
a diversi brani dei loro precedenti lavori.<br />
Si batte piacevolmente il piedino per tutto il tempo<br />
della sua durata, ma ci se ne dimentica alla velocità<br />
della luce una volta che la musica è finita.<br />
(6/10)<br />
diego Ballani<br />
BoB corn - the watermelon dream<br />
(fooltriBe, feBBraio 2011)<br />
Ge n e r e: f o l k<br />
Nel mito del “buon selvaggio” Bob Corn ci ha sempre<br />
sguazzato, col suo folk della porta accanto metafora<br />
barbuta e sorridente di un’epopea instancabile fatta di<br />
mille strade percorse. Un hobo voce e chitarra disperso<br />
nel tempo, lontano dalla comunicazione capillare di<br />
un’epoca aliena e irrispettosa di quella madre terra da<br />
cui invece parte tutta la sua musica. Non possiamo dargli<br />
torto, visti i frutti raccolti fin dagli esordi in termini<br />
di consensi e attestati di stima. Sull’onda emotiva di dischi<br />
che pur non discostandosi molto l’uno dall’altro, di<br />
quella umanità istintiva sono sempre stati una fedele<br />
rappresentazione. Oltre che un prodotto perfettamente<br />
in linea con l’indie lillipuziano (nei mezzi, non nelle<br />
aspirazioni) di casa nostra.<br />
The Watermelon Dream è l’ennesimo tassello del Tiziano<br />
Sgarbi/Bob Corn pensiero: cantore rurale e quasi<br />
drakeiano (You The Rainbow, Call Me My Name ), bluesman<br />
ad libitum (Lost & Found), insospettabile amante<br />
di un gospel solitario e intimo (Love turns around (Don’t<br />
look back)). Impegnato a districarsi da una ragnatela di<br />
fragili equilibri che dosa con cura particolari e accenti,<br />
sottolineando l’estrema sensibilità di un artista da sempre<br />
ripiegato su sé stesso.<br />
(6.8/10)<br />
faBrizio zamPighi<br />
highlight<br />
denniS coffey - denniS coffey (Strut recordS, aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: u l t r a-f u n k<br />
Quando si dice “venie da lontano per arrivare lontano”: Dennis Coffey è una leggenda di Detroit che,<br />
tra i tanti, ha prestato la sua fumigante sei corde ai Funkadelic, ai Temptations della svolta acid-soul e<br />
all‘Edwin Starr di War. Se aggiungete che ricoprì un ruolo chiave nell‘introdurre l‘uso del wah-wah “pesante”<br />
nel soul e nell‘r&b di fine dei ‘60 e che lungo il decennio successivo si<br />
dava alla blaxploitation e alla produzione con Mike Theodore, sapete cosa<br />
attendervi da un suo nuovo disco.<br />
Da un lato, cosmico però tellurico hard-fuzz (ben esemplificato nell‘apertura<br />
di 7th Galaxy come nelle successive Knockabout - roba da Big Chief,<br />
per chi li ricorda - e Space Traveller) straripante della funkitudine di George<br />
Clinton e Jimi Hendrix; dall‘altro, una souledelia robusta e sferzante odorosa<br />
di scenari urbani seventies che dici attualissimi. Nessuna forzatura o<br />
pretesa di attualità, ma competenza in materia e passione che mostrano<br />
uno stile mai invecchiato, che sottolineano la differenza tra datato e databile poggiando salde su ospiti<br />
che ruotano attorno alla “Detroit connection” contemporanea.<br />
Ha così una logica perfettamente compiuta che la stella di casa Stones Throw Mayer Hawthorne si<br />
misuri da campione con il classico dei Parliament All Your Goodies Are Gone e Mick Collins dei Dirtbombs<br />
si unisca a Rachel Nagy (Detroit Cobras) per l‘oscuro martellamento Funkadelic di I Bet You.<br />
Oppure che Fanny Franklin degli Orgone rispolveri la possente Don‘t Knock My Love appartenuta a<br />
Wilson Pickett e Lisa Kekaula dei Bellrays guidi l‘esaltante cavalcata Somebody‘s Been Sleeping. Persino<br />
una nullità come Paolo Nutini convince alle prese con Only Good For Conversation del “culto” Rodriguez:<br />
merito sempre dell‘esperienza e dell‘energia profuse nell‘operazione, della quale beneficiano<br />
anche i Kings Go Forth della ribollente Miss Millie. Come insegna Maestro Clinton, liberate il posteriore<br />
e la mente lo seguirà. A spaccarveli entrambi provvederà questo disco.<br />
(7.5/10)<br />
giancarlo turra<br />
Bodi Bill - what? (SinBuS, aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: el e c t r o, in d i e -ro c k<br />
Al contrario di quanto l’opinabile ragione sociale potrebbe<br />
far credere, i tedeschi Bodi Bill rientrano in<br />
quella schiera di gruppi magari eternamente minori<br />
ma interessanti per il modo in cui padroneggiano e mescolano<br />
le sonorità del loro tempo. Sarebbe facile liquidare<br />
la faccenda dicendo di un perfetto equilibrio tra le<br />
claustrofobie degli Xx e gli ampi respiri dei White Lies:<br />
tale è del resto l’effetto che suscita la Paper in apertura<br />
di questo terzo lavoro. Invece col proseguire dell’ascolto<br />
si esce sempre più dai binari all’inseguimento di un<br />
suono via via meno identificabile, e già con Pyramiding<br />
le orecchie si drizzano davvero: certi echi tenebrosi<br />
fanno pensare a un Burial con gli steroidi ma lungo il<br />
finale le origini kraute dei nostri emergono in pieno,<br />
ed ecco omaggiati insieme tanto i Kraftwerk quanto<br />
i Notwist.<br />
Non è tutto, anzi: benchè l’elettronica rimanga l’ele-<br />
mento chiave del progetto, è quando quest’ultima<br />
diviene comprimaria al pari degli altri strumenti che<br />
il gruppo fa uscire i frutti migliori. Parla chiaro la title<br />
track che non dispiacerebbe a Twin Shadow o ancor<br />
di più l’ottima The Net, che incrocia beats e pianoforte<br />
su una melodia epico-decadente in perfetta continuità<br />
con quelle dei vari David Bowie e Placebo: peccato<br />
solo sentirla scorrere via così veloce, anzichè dilatata<br />
allo stremo come meriterebbe. Il tiro si rialza poi con<br />
i tunnel electro di Hotel, nobilitati da un cameo breve<br />
ma eccellente firmato Fever Ray, e con una Friends che<br />
paga tributo ai Depeche Mode, sfocia in una brillante<br />
coda di synth e lascia posto a una ghost track senza<br />
voce, che chiude le danze anche in senso letterale.<br />
Di What? piacciono le intenzioni, l’approccio ‘intelligente’<br />
alla materia electro, il buon gusto che caratterizza<br />
il progetto, l’innegabile creatività e la voglia di osare.<br />
Purtroppo il gioco del rifuggire la melodia ad effetto<br />
per inseguire l’idea spiazzante non funziona sempre, e<br />
60 61
viceversa il gruppo appare più abile a padroneggiare i<br />
brani con una struttura definita piuttosto che quelli in<br />
cui spariglia le carte. Ma questo influisce poco sul giudizio<br />
finale.<br />
(7.1/10)<br />
Simone madrau<br />
BvduB - triBeS at the temPle of Silence<br />
(home normal, feBBraio 2011)<br />
Ge n e r e: a m b i e n t, t e c h n o -d u b<br />
Se ci sono musicisti che dalla techno passano all‘ambient<br />
senza ritorno - vedi <strong>Tim</strong> <strong>Hecker</strong> - ce ne sono altri<br />
che partono proprio dalle ultime conquiste in fatto<br />
di sintesi ambientali (drone, chamber, shoegaze, neo<br />
classical) per riconsegnarle nuovamente al ritmo.<br />
Lo abbiamo visto con Pantha Du Prince (anche se lì il<br />
discorso era più eclettico e pop) e lo vediamo nell’austero<br />
Brock Van Wey, un americano trapiantato in Cina<br />
non proprio di primo pelo (è un ‘74).<br />
Finora la sua carriera è oscillata tra ambient techno<br />
come discorso d‘ambienti (su Echospace, la sua Quietus<br />
e l‘italiana Glacial Movements) e incursioni in zona dancefloor<br />
a bpm rallentati (per Meanwhile e la blasonata<br />
Kompakt). Dopo il successo di critica di The Art Of Dying<br />
Alone - un album sirena fatto di droni per non droneisti<br />
- il musicista ha deciso d’insistere su quest’ultimi,<br />
proponendosi come una sorta di William Basinski<br />
post-techno, senza tape loop e effetti vintage.<br />
Tribes at the Temple of Silence amplia lo spettro d’indagine<br />
rispetto alla pretenziosa prova precedente, ma i<br />
risultati, anche questa volta, deludono. Mentre Morning<br />
Rituals, unico brano in cassa, pasticcia tra folate<br />
ambient e deep house, The Past Disappears mostra tutti<br />
i limiti del caso: Wey non è Emanuele Errante e né qui<br />
né da altre parti riesce a mixare la matrice drone agli ingredienti<br />
aggiunti all’intingolo - che siano essi soulfull<br />
vocali, shoegaze o etno new age. Una prova fallita.<br />
(4.7/10)<br />
edoardo Bridda<br />
caParezza - il Sogno eretico (univerSal,<br />
marzo 2011)<br />
Ge n e r e: c r o s s o v e r p o p / r a p<br />
Il sogno eretico è forse il più esplicito e “agit-prop” tra i<br />
dischi del riccio capelluto: i testi sono più didascalici, il<br />
rappato meno funambolico, quindi più intellegibile (lui<br />
è al solito bravissimo a costruire le rime). La parte musicale,<br />
con giusto un paio di eccezioni, è colorata ma insipida<br />
come sempre e più che mai. Nessun dorma, dice<br />
Capa, perché il sonno della ragione genera mostri (si vedano<br />
la copertina e l’interno di copertina in stile Char-<br />
les Burns - il fumettista americano, non il personaggio<br />
dei Simpson - opera di Squez) e oggi è sicuramente più<br />
pornografico pensare con la propria testa che sfogliare<br />
le riviste zozze.<br />
Dopo un siparietto un po’ alla Elio, in romanesco, Michele/Capa<br />
se la piglia con il mercato discografico e<br />
con le riviste, con la scena hip hop che lo dissa (non li<br />
cita, ma si riferisce a Fabri Fibra e Bassi Maestro) e con i<br />
social network (Chi se ne frega della musica). Rockettino<br />
hard alla Kashmir, tra una intro in vocoder e un insertino<br />
reggae, contro l’ingenuità di chi non si preoccupa di<br />
verificare le “verità supposte” che gli vengono propinate<br />
dall’alto (Il dito medio di Galileo). Intro alla Chieftains<br />
e riffettini funky/Pink Floyd per parlare di Giordano<br />
Bruno e di altri martiri eretici messi a tacere (Sono il tuo<br />
sogno eretico). In forma di quiz, ecco i controsensi del<br />
sistema Italia (Cose che non capisco); l’Italia della fuga<br />
dei cervelli e con un futuro sempre più arido davanti a<br />
sé protagonista dell’hit single Goodbye Malinconia, con<br />
il bel refrain retroKitsch cantato da Tony Hadley degli<br />
Spandau Ballet.<br />
Rockettino anni Cinquanta per il qualunquismo e i bassistinti<br />
del popolino, messo a paragone con lo stereotipico<br />
mondo disneyano (La marchetta di Popolino). Discopop<br />
da boyband per parlare dell’ecologismo (La fine<br />
di Gaia). Ma non siamo al sicuro neppure dentro casa:<br />
attenzione agli incidenti domestici e ai pericoli anche<br />
psicologici che si annidano tra le quattro mura (House<br />
credibility). Musica hollywoodiana alla Mission Impossible<br />
per il mega-spoilerone intestato a Kevin Spacey (e<br />
ispirato probabilmente a un famoso video che gira sul<br />
Tubo). Divertente, come la successiva tirata anti-Berlusca,<br />
spammatissima su Facebook, che non propone<br />
tanto di legalizzare “la maria” (e parte subito il reggae),<br />
quanto piuttosto di ratificare la già avvenuta legalizzazione<br />
del premier, a cui tutto si perdona e si perdonerà<br />
(Legalize the Premier). Bel riff punk-rock/hard per lo sfogo<br />
di Dio, che si lamenta del tartassamento quotidiano<br />
che subisce dall’uomo (Messa in moto). Mood epico nel<br />
compitino da bravo allievo di Frankie-Hi-Nrg contro i<br />
politici e lo Stato che ci ritroviamo (Non siete Stato voi)<br />
e intro epic metal - e a seguire il solito rockettino caparezziano<br />
- per dire ancora una volta viva la rivoluzione<br />
(ancora Frankie a modello, quello di Sanremo 2008) e<br />
bacchettare una opposizione addormentata incapace<br />
di proporsi come vera alternativa (La ghigliottina).<br />
Un po’ di vera grinta musicale, finalmente, arriva proprio<br />
in chiusura (Ti sorrido mentre affogo): un incalzante<br />
post-hardcore in salsa proggie - con inserti di tastierine<br />
videogame alla Squarepusher - per dire che a Capa non<br />
interessa più di tanto essere capito; lui vuole semplice-<br />
mente dire quello che pensa e continuare per la propria<br />
strada. Noi non ci crediamo ma, viste le premesse,<br />
ci accontentiamo.<br />
(5.6/10)<br />
gaBriele marino<br />
caPillary action - caPSized (natural<br />
Selection, aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: a v a n t -p o p<br />
Non è male la metafora dei vasi comunicanti, che dà il<br />
nome ai Capillary Action. È un buon modo per descrivere<br />
la necessità di equilibrio - costantemente disattesa<br />
e comunque ricercata - tra gli elementi che compongono<br />
chimicamente il sound del quintetto di musicisti<br />
statunitense.<br />
Il principale tassello dell‘identità superficiale espressa<br />
in Capsized, più che la cultura del crossover a tutti i<br />
costi che permeava Fragments e So Embarrassing, è<br />
l‘esecuzione cameristica delle partiture, fuori dal tempo<br />
nel pop, anche se avant. È l‘anima della strumentazione<br />
classica, unicamente acustica, che allestisce colpi di<br />
scena cinematici alla The Prisoner. Ma è solo uno degli<br />
universi dentro cui si muovono i Capillary Action. C‘è la<br />
vocalità eccessiva, che ce li fa immaginare “ambientati”<br />
al Cabaret Voltaire di Zurigo. E poi, come una sorpresa<br />
- ma neanche troppo imprevista - fioccano i poliritmi<br />
tropicali di Feeding Frenzy e Tenderloin, che sono un po‘<br />
una marcia di Odradek - o spiriti maligni - che li accompagnano<br />
sulla cattiva strada.<br />
Tutti mondi che stanno insieme a forza, come una via<br />
di mezzo barocca tra Hella e Parenthetical Girls, via<br />
Dead Science - specialmente per le scelte vocali. Si arriva<br />
a tanto così dalla stucchevolezza, che però - e qui<br />
sta la bravura - Jonathan Pfeffer e soci sventano, grazie<br />
appunto alla comunicazione tra vasi, che dosa i passaggi<br />
e modifica a gran velocità tonalità e umori. Esemplare<br />
la metamorfosi interna alla finale Life of Luxury,<br />
microcosmo che come in un frattale riflette l‘insieme.<br />
In realtà, dietro all‘apparenza si nasconde il precedente<br />
dei Red Crayola di Mayo Thompson (periodo post-<br />
Settanta), che sembra il compositore ex machina delle<br />
musiche. Sarà grazie all‘educazione che ci ha impartito<br />
l‘ex collaboratore dei Pere Ubu che Capsized, da disco<br />
certamente estenuante, faticoso, ci risulta infine avvincente.<br />
Chi ha la passione e tempo per le stranezze si<br />
affezionerà. Chi non ha pazienza, uscirà pazzo.<br />
(7.1/10)<br />
gaSPare caliri<br />
caSa del mirto - 1979 (maShhh!, marzo<br />
2011)<br />
Ge n e r e: G l o -f i d o w n t e m p o<br />
Questione di ghiribizzi mnemonici, mostriciattoli struggenti<br />
usciti dal vaso di Pandora dei ricordi. Cortometraggi<br />
sgranati e sovraesposti, i colori dileguati come<br />
sogni dietro le palpebre. Tu chiamalo, se vuoi, glo-fi.<br />
Nessuna ricetta, semmai una disposizione dell’anima.<br />
Marco Ricci, ad esempio, conduce su tali sentieri<br />
la sua idea chiamata Casa Del Mirto, già sugli scaffali<br />
lo scorso anno con l’apprezzato The Eternal EP, cui fa<br />
seguito oggi l’esordio lungo 1979, dodici fatamorgane<br />
che restituiscono imprinting anni Ottanta (versante<br />
synth-pop, electro-soul e italo disco) inseminato di<br />
suggestioni ambient, chill-out e downtempo. Del tipo:<br />
i Pet Shop Boys opacizzati Boards Of Canada, gli Imagination<br />
sinterizzati Royksopp, Mike Francis glassato<br />
Toro Y Moi, tanto per dire e via discorrendo.<br />
Niente formule, non uno stradario da seguire, solo un<br />
pescare tra palpiti e retaggi, secondo gli stimoli e gli<br />
inneschi. Tra cui distingui omaggi sfacciati quali l’incipit<br />
di Thriller in Fairy Tales For Moonwalkers o inusitate<br />
somiglianze come quella Pain In My Hands che ammicca<br />
(eufemismo) Daydream degli Smashing Pumpkins.<br />
Tanto vale prendere atto, che ad ognuno toccano scorie<br />
di vita imponderabili, e quindi lasciarsi cullare dalla<br />
risacca dance bradipa e pastellata spacey di The Haste<br />
e Killer Haze, dai cromatismi guizzanti di White Chapel,<br />
dall’ipnotica giocheria di The Right Way.<br />
Si segnala la contemporanea uscita (digitale e vinilica)<br />
di 1979 Remixed, che vede calibri sparsi come Populous,<br />
Brothertiger, Luminodisco e Death In Plains<br />
manipolare in varie salse (post-punk, house, ambient,<br />
afro...) il suddetto programmino.<br />
(6.9/10)<br />
Stefano Solventi<br />
caSo - tutti dicono guardiamo avanti (Que<br />
Suerte!, feBBraio 2011)<br />
Ge n e r e: fo l k, po p<br />
Accompagnato da chitarra, armonica e nient’altro, Andrea<br />
Casali, alias Caso, affina in questo secondo lavoro<br />
qualche urgenza punk-rock in favore di un approccio<br />
appena più folk ma non alza il tiro di un Dieci Tracce che<br />
già poneva basi interessanti. Co-prodotto e distribuito<br />
da ben quattro indie-labels (Que Suerte!, Klasproduction,<br />
In Limine, Fiumaio) Tutti Dicono Guardiamo Avanti<br />
si candida come prima e più di prima ad essere il vero<br />
tra palco e realtà, un abbattere steccati tra musicisti e<br />
persone, un proporsi come diario di uno spettatore di<br />
concerti ancor prima di uno che sui palchi ci suona: con<br />
62 63
highlight caSS mccomBS - wit’S end (domino, marzo<br />
2011)<br />
egyPtrixx - BiBle eyeS (night SlugS, marzo 2011)<br />
Ge n e r e: f o l k r o c k<br />
Ge n e r e: uk c o n t i n u u m<br />
Due anni fa Catacombs raffreddò gli entusiasmi di chi<br />
Nel marasma delle etichette di dance UK / wonky / bass o derivativi del continuum sempre più sdoga-<br />
scorgeva in Cass McCombs prospettive importanti in<br />
nato verso il dancefloor, la Night Slugs è una delle next big thing da tenere appuntate sul bloc notes,<br />
chiave pop-rock cantautorale. La fiamma sembrava<br />
allo stesso livello di LuckyMe e delle visioni di Joy Orbison (che prima o poi pubblicherà il suo tanto<br />
smorzata, girava a vuoto attorno a poche idee nean-<br />
atteso esordio). Dopo l‘uscita di una compilation che fa il verso alle storiche Allstars della Tempa (Night<br />
che troppo lucide. Il nuovo lavoro Wit’s End, ahinoi, non<br />
Slugs Allstars Volume 1, uscita qualche mese fa) con nomi di giovani DJ<br />
smentisce quella china discendente, fornendo semmai<br />
come Mosca, L-Vis, Girl Unit, Bok Bok e molti altri nerd dell‘ibridazione<br />
ulteriori motivi di rammarico. Il primo e principale ar-<br />
dance, oggi esce il primo full di uno dei vermi notturni di punta.<br />
riva fin dall’iniziale County Line, punta di diamante del<br />
Il produttore di Toronto David Psutka ci va di stupore e di positività off-ba-<br />
programma e mirabile esempio di equilibrio tra efflulearic.<br />
Egyptrixx riesce a formulare un suono fresco, hi-fi di qualità per balvi<br />
country rock Harry Nilsson, languori obliqui John<br />
lare col sorriso e per una volta si toglie di dosso l‘oscurità di molte derive<br />
Lennon e fatamorgane inquiete Elliott Smith, il tutto<br />
dark del nuum, approdando a una visione futuristico-spacey che defini-<br />
imbevuto di piacevolissimi umori soul e particelle Kinsce<br />
un prima e un dopo senza sbavature, puntando sul lato più techy della<br />
ks depotenziate. Un piccolo grande prodigio che non<br />
questione. La nuova musica dance targata UK può quindi partire da qui,<br />
trova però riscontro nel resto della scaletta, composta<br />
una sensazione che avevamo già sentito con qualche compilation su Soul Jazz e su Fabric, rivisitando<br />
perlopiù da teatrini più dimessi che estatici, all’insegna<br />
i padrini Autechre meno austeri, scompaginando le carte del cut-and-paste e inserendo variazioni sul<br />
di melodie che cincischiano su scale in minore col pi-<br />
tema bbreaking che in pezzi come Liberation Front, Naples e Recital coniugano le anime della minimal<br />
glio smorto di chi non riesce ad azzeccare il giusto gra-<br />
con la melodia e la spazializzazione illuminata. In più, con la bella voce di Trust in Chrysalis Records e in<br />
do di malinconia.<br />
Fuji Cub, c‘è pure qualche puntatina per la sperimentazione in odore di trip-hop stralunato e fumoso.<br />
Ossessioni senza nerbo (Buried Alive), lungaggini in-<br />
Riparte da qui ancora una volta il baraccone del continuum. Una teoria che dopo quasi vent‘anni sta<br />
giustificate (A Knock Upon the Door) ed incantesimi po-<br />
ancora in piedi e che non teme scossoni. Egyptrixx sostiene le colonne della main room. Uno dei nomi<br />
sticci (The Lonely Doll) sono le note storte che il sobrio<br />
su cui puntare per il prossimo futuro.<br />
tepore degli arrangiamenti non è in grado di assolvere.<br />
(7.5/10)<br />
Alla fine ti sembra il fratellino apatico di Ryan Adams o<br />
marco Braggion<br />
- se preferite - un cuginastro depresso di Badly Drawn<br />
Boy. Peccato.<br />
(5.7/10)<br />
Stefano Solventi<br />
le macchinate, gli amici, le storie e tutto il resto. Emozioni<br />
dirette, insomma, con impennate di rilievo già al<br />
volgere della seconda traccia, una Fiato Corto che in<br />
mano a gente più blasonata sarebbe già hit da canzoniere<br />
italiano anni 10.<br />
A fare da cornice per questi quadretti di vita vissuta è<br />
un songwriting dolceamaro e una strenua ricerca di<br />
identificazione con chi può capire, condividere e dunque<br />
cantare a sua volta. Suona disilluso, Andrea, amaro<br />
(‘le frasi migliori che penso le dicono gli altri’, afferma<br />
in Balena Bianca) ma sempre meravigliosamente autoironico<br />
e in qualche misura positivo: quanto basta da<br />
far sorridere il suo ancora piccolo ma affezionato pubblico,<br />
anche quando da ridere non ci sarebbe. Nessuna<br />
sparata universale nell’opera del nostro, al massimo<br />
qualche dichiarazione di indi(e)pendenza, urlata ma<br />
udibile solo fra quelli che se la cantano e se la suonano<br />
(Hopper): lo sfondo è quello messo per inciso più avanti<br />
in Aranciata Amara ovvero la lotta forse ingenua ma<br />
ostinata contro dei mulini a vento chiamati di volta in<br />
volta gestori di locali o vicinato, dove la facile retorica<br />
viene schivata mescolando il punto di vista con l’esperienza<br />
personale.<br />
C’è lo stesso calore dei racconti della sera prima in queste<br />
canzoni, le confidenze di una persona che si racconta<br />
per come è, messe in note con capacità ma pur<br />
sempre esposte da uno che potrebbe essere il nostro<br />
vicino di casa o il nostro migliore amico; è quest’ultima<br />
la miglior qualità di Caso, ciò che crea davvero lo scarto<br />
con certi big names del nuovo cantautorato italiano.<br />
Uno scarto che non è sinonimo di confronto, ma di differenza:<br />
in termini di stile, di percorso e inevitabimente<br />
anche di successo. Se poi i singalong di massa arriveranno,<br />
bene; ora come ora c’è una conferma per quanti<br />
già conoscevano, e un secondo motivo di curiosità per<br />
tutti gli altri.<br />
(7/10)<br />
Simone madrau<br />
citizen fiSh - goodS (alternative<br />
tentacleS, aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: s k a-p u n k<br />
Immaginario e sonorità non possono che essere quelle<br />
care a Jello Biafra e alla sua Alternative Tentacles. Copertina<br />
in modalità collage (alimenti di base ridotti a<br />
merci a simboleggiare trust, friends, beauty, love, truth,<br />
ecc.), booklet in b/n in stile crassiano, sonorità punk virate<br />
verso lo ska, testi arguti e anti-consumismo.<br />
Una vera e propria manna per mr. Eric Reed Boucher,<br />
noto ai più come Jello Biafra, integerrimo nel proseguire<br />
la storia della sua Alternative Tentacles a suon<br />
di true punk e militanza estrema. Questi Citizen Fish<br />
sono dunque allievi ideali, nonostante siano un combo<br />
sulla breccia da anni. provenienti da Bath (UK) e con in<br />
formazione alcuni personaggi dello storico giro inarcopunk<br />
targato Subhumans. Goods, nonostante l‘impegno<br />
del sestetto, rimane ancorato ad un mondo, quello<br />
dello ska-punk, ormai quasi reazionario nel suo rimanere<br />
circoscritto in un perimetro di invariabile ripetiti-<br />
vità. Coinvolgente, ben suonato, arrabbiato il giusto e<br />
divertente con giudizio, ma troppo datato e fermo su<br />
se stesso, al punto che non è più neanche il caso di dire<br />
che sia “just for fun”. Sorry.<br />
(5.5/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
cold cave - cheriSh the light yearS<br />
(matador, aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: sy n t h p o p<br />
Se ve li ricordavate artefici di un synth pop primitivo,<br />
oasi digitale all’interno dell’arcipelago lo-fi newyorkese,<br />
sappiate che questa volta Wesley Eisold ha deciso di<br />
dare una sferzata al proprio algido sound.<br />
Per annunciarlo ha scelto il barbarico grido di The Great<br />
Pan Is Dead: un inferno di chitarre in loop, ritmiche<br />
squadrate, un cantato emotivamente destabilizzante e<br />
tastiere che aprono distese infinite. Un’approccio più<br />
diretto, sicuramente più rock e meno claustrofobico rispetto<br />
al recente passato, che mette definitivamente<br />
da parte l’immagine dei Cold Cave come sperimentatori,<br />
figli di un’era paleo tecnologica.<br />
Non che l’electro wave di brani come Confetti o Icons<br />
Of Summer abbia spostato di molti anni in avanti il loro<br />
revivalismo. E’ come se il progetto fosse approdato<br />
all’alba del technopop. Il 1981 è l’anno di riferimento: il<br />
romanticismo dei New Order e la fisicità degli Human<br />
League, con un Weisold che, indossati i panni del frontman<br />
a tempo pieno, sembra sempre più simile ad una<br />
versione espressionista di Phil Oakey.<br />
Con Pacing The The Church, scorrazzano pericolosamente<br />
nei territori di quella pop wave che ha fatto<br />
la fortuna degli Editors. Ne scampano grazie ad una<br />
produzione ruspante che, seppur lontana dal minimalismo<br />
degli esordi, evita la pomposità di Tom Smith e<br />
compagni.<br />
Cherish The Light Years è l’album che trasforma il progetto<br />
solista di Eisold in una vera e propria band; lo fa<br />
mantenendo la barra dritta verso un pop sintetico naif<br />
ed avvincente, forse meno concettuale e stimolante rispetto<br />
al passato ma, in fin dei conti, decisamente più<br />
godibile.<br />
(7/10)<br />
diego Ballani<br />
colin StetSon - new hiStory warfare<br />
vol.2: judgeS (conStellation recordS,<br />
marzo 2011)<br />
Ge n e r e: i m p r o<br />
Sbarca su Constellation il secondo volume di New History<br />
Warfare di Colin Stetson. Lasciati momentanea-<br />
64 65
highlight cryStal StiltS - in love with oBlivion<br />
(fortuna PoP!, aPrile 2011)<br />
erland and the carnival - nightingale (full time hoBBy, marzo 2011)<br />
Ge n e r e: G l o o m y w a v e<br />
Ge n e r e: p s y c h-f o l k-p o p<br />
Che sia una dichiarazione d‘intenti il titolo del come-<br />
Dire davvero cosa significhi la parola ‘folk’ oggi è un’impresa complessa, forse impossibile. In un genere/<br />
back dei newyorchesi? Non lo sapremo mai, ma di<br />
non genere che prima dell’era pop designava quello che non era musica colta, ma che aveva una matri-<br />
sicuro i quattro Crystal Stilts devono aver fatto tabuce<br />
folklorica, spesso locale e legata alla trasmissione orale, oggi invece troviamo tanto il cantautorato<br />
la rasa di tutti i complimenti ricevuti per la doppietta<br />
delicato di Devendra Banhart, gli spruzzi pop di tutte le band indie-folk<br />
Crystal Stilts / Alight Of Night che un paio di anni addie-<br />
che circolano a tutte le latitudini, il recupero della tradizione come fa, per<br />
tro li scaraventò dall‘anonimato al palco del Primavera<br />
citare qualcuno di casa nostra, Riccardo Tesi. E ci stanno pure gli Erland<br />
Sound senza passare dal via.<br />
and the Carnival, che riescono a recuperare tanto il folk britannico quan-<br />
Non si spiegherebbe altrimenti un disco che, se possito<br />
una psichedelia conturbante e rock, oltre a qualche sfumatura world.<br />
bile, surclassa il già stupefacente esordio lungo, rede-<br />
Già nel primo disco omonimo targato 2010, il gruppo prendeva brandelli<br />
finendolo dall’interno. I quattro smussano lievemente<br />
folk e li aggiornava alla propria sensibilità, fatta di urgenza comunicativa e<br />
le asperità ma senza perdere un grammo in attacco,<br />
una forte personalità. Oggi il discorso si amplia, prendendo ispirazione da<br />
aggiustano il tiro sul versante della scrittura ma non si<br />
testi oscuri, che possono essere tanto articoli di giornale quanto brani di<br />
addolciscono, frullano citazioni e riferimenti con una<br />
romanzi d’inizio Novecento o discorsi politici, in un immaginario che pesca da una fila di nomi lunga<br />
nonchalance invidiabile senza risultare pedissequi o<br />
così: Ennio Morricone, Bert Jansch, Joe Meek, tanto per citarne alcuni.<br />
estremamente citazionisti: in poche parole, mettono<br />
Dietro alla ragione sociale si nascondono il chitarrista e cantante folk Erland Cooper, Simon Tong (The<br />
a segno il punto definitivo. Quello che annienterà le<br />
Verve) e David Nocky (già batterista per il progetto Fireman di Paul McCartney), che si sono incontrati<br />
eventuali ultime resistenze dei critici.<br />
quasi per caso, hanno fatto una jam session e lì, su due piedi, hanno deciso di formare una band, che<br />
Nessuno stravolgimento, sia chiaro. Dentro In Love With<br />
tutto sommato si erano divertiti a suonare insieme. Il sound che esce da questo lavoro è davvero de-<br />
Oblivion troverete sempre garage-rock psichedelico<br />
bitore di quella cultura musicale molto londinese (e in generale proprio britannica 100%) che ha fatto<br />
targato 60s (da Barrett ai Velvet, passando per gemme<br />
scaturire quel supergruppo nel quale ha militato anche lo stesso Tong, ovvero The Good, the Bad &<br />
misconosciute come gli Standells), pop-noise anni ‘80<br />
the Queen, il cui cantante, un certo Damon Albarn, è il proprietario dello studio dove si è registrato<br />
(di qua e di là dall‘oceano, con puntatine nel nuovis-<br />
l’esordio dello scorso anno.<br />
simo mondo), sonorità cavernose e vintage (il mood<br />
L’album è stato registrato nella stiva di un imbarcazione ancorata sulle rive del Tamigi: immaginatevi un<br />
sempre oscuro e apparentemente fuori moda) e lo-fi<br />
sabbah psichedelico moderno in cui convivono le rivisitazioni dei The Coral via Bert Jansch (Map of En-<br />
d‘ordinanza.<br />
glishman), gli accenti doorsiani (This Night, I’m Not Really Here), folk in salsa shoegaze (la titletrack, Em-<br />
A far la differenza, questa volta, sono le canzoni: se<br />
meline), melodie appiccicosamente pop (Springtime). Rispetto al debutto, Nightingale è un’affascinante<br />
Alight Of Night colpiva per immaginario e compattez-<br />
virata verso uno psichedelia oscura e inquietante dai testi colti e gusto tipicamente retro-pop che guarza,<br />
il sophomore stupisce in maturità e screziature. Che<br />
da giù nei sottoscala del teatro inglese. E’ un lavoro terribilmente affascinante. Culto istantaneo.<br />
siano il pop yè-yè super-zuccheroso di Silver Sun, i 60s<br />
(7.4/10)<br />
disorientanti dell‘opener Sycamore Tree o le profondità<br />
marco BoScolo<br />
malate di Alien Rivers, cambia poco. Resta sempre una<br />
certezza: hanno fatto centro, di nuovo.<br />
(7.5/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
mente i compagni della Bell Orchestre e degli Sway<br />
Machinery, presosi una pausa dal lavoro di sessionman<br />
di lusso, il sassofonista/polistrumentista del Michigan<br />
torna a ritagliarsi uno spazio tutto suo.<br />
New History Warfare Vol.2: Judges è un oggetto non<br />
identificato nel cielo della musica contemporanea: un<br />
disco che mischia avanguardia e improvvisazioni cerebrali<br />
con una fisicità materica del suono e una capacità<br />
d‘intrattenere tipiche del rock. Sorprende ancor di più<br />
il fatto che Stetson sia un uomo solo col suo strumento,<br />
in grado di tirar fuori una gamma espressiva vasta e<br />
convincente grazie a capacità tecniche notevoli.<br />
Ricorrendo all’uso della respirazione circolare e di altri<br />
espedienti tecnici (ben 24 differenti posizioni per i mi-<br />
crofoni), Stetson ottiene un linguaggio che passa con<br />
disinvoltura da paesaggi ambient (All Days I’ve Missed<br />
You) a strutture ritmiche spigolose (Red Horse) fino a un<br />
elettronica fatta senza l’uso di loop e macchine, ma con<br />
la forza dei polmoni e la conoscenza dei mezzi espressivi<br />
(Home). A impreziosire il tutto un paio di magistrali<br />
cameo vocali targati Laurie Anderson (A Dream of Water)<br />
e Shara Worden dei My Brightest Diamond.<br />
Sperimentale e ostico, ma sicuramente ammaliante e pieno<br />
di fascino, il secondo capitolo solista di Colin Stetson è<br />
una lotta da affrontare con coraggio, fisicità, accortezza e<br />
astuzia. Un’esperienza intensa e gratificante.<br />
(7.4/10)<br />
franceSco aSti<br />
danielSon - BeSt of glouceSter county<br />
(SoundS familyre, marzo 2011)<br />
Ge n e r e: p s y c h f o l k<br />
L’ultima scorribanda di Daniel Smith col moniker Danielson<br />
risale a ben cinque anni fa. Ships era di quei<br />
dischi che non si dimenticano, non tanto per gli esiti<br />
artistici quanto per quel senso di happening mistico<br />
capace di coagulare attorno all’estro visionario di Mr.<br />
Smith una trentina di musicisti, tra cui ovviamente i<br />
consanguinei della famiglia Danielson ed amici quali<br />
Sufjan Stevens ed Emi Nikolaisen dei Serena Maneesh.<br />
Questi ultimi li ritroviamo anche tra i credits del<br />
nuovo Best of Gloucester County, assieme a new en-<br />
try quali Jens Lekman, Mark Shippy degli US Maple e<br />
Glen Galaxy dei Soul-Junk.<br />
Simile l’entusiasmo effervescente, la ricchezza compulsiva<br />
e la versatilità balzana della proposta, ma il<br />
risultato è sensibilmente diverso, come se la freakeria<br />
folk-pop avesse fatto il nido sul fruttuoso alberello del<br />
power pop (capricciosamente deragliato glam, vedi le<br />
palpitazioni sfrigolanti di But I Don‘t Wanna Sing About<br />
Guitars e Grow Up), sia pure sferzato da folate psych<br />
che non disdegnano siparietti allampanati (la marcetta<br />
in levare di Lil Norge, il vaudeville cabarettistico<br />
di Peolple’s Partay) ed impressionismi sonici (Hovering<br />
Above That Hill). In tale contesto le antiche attitudini riaffiorano<br />
in germogli quali The Day Is A Loaf e Olympic<br />
Portions, non lontani dal luminoso fervore Elephant 6,<br />
di cui il lirismo bucolico di Hosanna In The Forest e You<br />
Sleep Good Now rappresenta il controcanto quieto. Un<br />
delizioso baraccone dalle molte fragranze ed altrettante<br />
idee.<br />
(7.1/10)<br />
Stefano Solventi<br />
dead cat in a Bag - loSt BagS (viceverSa,<br />
marzo 2011)<br />
Ge n e r e: a r t f o l k r o c k<br />
In origine erano un duo folk con spiccata attitudine per<br />
i minimi termini. Col tempo i Dead Cat In A Bag sono diventati<br />
un’accolita di musicisti con le coordinate sperse<br />
da qualche parte tra messico, balcani e certi non luoghi<br />
universali quali bettole fumose ed interni senza sbocco.<br />
Li abbiamo assaggiati alle prese con In The Arms Of<br />
Sleep nel tributo a Mellon Collie And The Infinite Sadness<br />
allestito dalla benemerita 42 Records, e ci erano<br />
sembrati meravigliosamente fuori luogo, un miraggio<br />
sabbioso di cianfrusaglie e peyote. Esordiscono con<br />
questo Lost Bags che in quattrodici tracce pennella<br />
tutto il loro immaginario struggente e sconsolato, un<br />
carosello di teatrini dimessi, deliri tetri e ombre in subbuglio.<br />
Ballate che impastano l’irrequietezza cedevole degli<br />
Howe Gelb, dei Tindersticks, degli Smog (I Can‘t Row<br />
No More, No Lust Left, Wither), sguardi gettati a spazzolare<br />
deserto come dei Calexico ora crespuscolari (Dawn)<br />
e ora ingrugniti (The Stow-Away Song), ipotetiche ibridazioni<br />
tra Xiu-Xiu e Yann Tiersen (The Gipsy Song),<br />
ebbrezza primaria Tom Waits (Old Dog) e Bob Dylan<br />
basico (Wateground Of Your Lips). In mezzo a tutto ciò,<br />
come a mantecare di estro arty, sbocciano fiorellini allucinati<br />
quali il siparietto espressionista di Leapiz o il<br />
talkin’ brumoso della title track. Ad un armamentario<br />
formidabile di strumenti “analogici” (dobro, lap steel,<br />
66 67
anjo, mandolino, bouzouki, vibrafono, organo, violino,<br />
tromba, flicorno, contrabbasso, armonica, melodica,<br />
melodeon, concertina, harmonium, fisarmonica...)<br />
fa da sponda la presenza mai meno che suggestiva di<br />
tastiere e campioni, ambiti narrativi che la voce di Luca<br />
Swanz Andriolo satura di fosca, intima, rauca irrequietezza.<br />
Le ospitate di Massimo Ferrarotto dei Feldmann, Liam<br />
McCahey - vocalist dei disciolti Cousteau - e Cesare<br />
Basile sono un attestato di qualità che non fatichiamo<br />
a sottoscrivere e sottolineare.<br />
(7.4/10)<br />
Stefano Solventi<br />
doormen (the) - the doormen<br />
(autoProdotto, marzo 2011)<br />
Ge n e r e: po s t p u n k<br />
Bella sorpresa quella dei nostrani The Doormen, gruppo<br />
che dice la propria in campo wave rock, con una<br />
personalità ed una autorevolezza che non sapevamo<br />
essere di casa in Italia. E italiani i Doormen li sono per<br />
davvero, tanto da aprire il loro esordio con il brano Italy,<br />
uno schiaffo all’esterofilia che in bocca ad altri sarebbe<br />
suonata indulgente o retorica; loro invece lo ne fanno<br />
un’opener lirica e intensa sul modello dei migliori episodi<br />
dei primi Interpol.<br />
Il paragone con il combo newyorkese, in verità, ritorna<br />
spesso nel corso dell’album, vuoi per lo stile del cantante<br />
Vincenzo Baruzzi, a tratti simile a quello di Paul<br />
Banks, vuoi per la progressione melodica di buona parte<br />
dei brani. Fortunatamente non di mera oleografia è<br />
fatto il loro esordio.<br />
Brani come New Season hanno la loro peculiare cifra<br />
stilistica nelle sferzate garage, in un sound pugnace e<br />
senza posa che non si limita a seguire pedissequamente<br />
gli stilemi post punk, ma fa dell’indole schiettamente<br />
rock il proprio punto di forza.<br />
L’ottimo lavoro chitarristico si fa apprezzare particolarmente<br />
in brani come 24 e Here Comes That Bitch la cui<br />
vena psichedelica e la cui portentosa epicità si riallaccia<br />
a quella degli ingiustamente dimenticati Chameleons.<br />
(6.9/10)<br />
diego Ballani<br />
dorothi vulgar QueStionS - againSt<br />
mySelf (Sun Play, marzo 2011)<br />
Ge n e r e: w a v e r o c k<br />
Tre anni sono passati da L’equilibrio, album d’esordio<br />
che li vide confermare quanto già di buono espresso<br />
nell’ep DVQ. Con Against Myself i toscani Dorothi<br />
Vulgar Questions erano quindi chiamati a ribadire il<br />
carattere e quel bel po’ di talento sul fronte d’un waverock<br />
tosto ma non privo di aperture melodiche, una<br />
creaturina palpitante insomma in differita dagli eighties<br />
ed irrobustitasi a strali psych e grunge. L’imprinting<br />
è appunto wave, con tutto il corollario di asprezza<br />
e obliquità pop che t’immagini sbocciare tra periferie<br />
dimesse ma combattive, poche le magnifiche sorti da<br />
perseguire ma le antenne sempre sintonizzate e l’anima<br />
pure.<br />
Evaso il piglio teso un po’ Killing Joke e un po’ The<br />
Sound con Fight For Yourself, Everything Is Not Forever<br />
e Only One Will Survive, distribuite cupezze e inquietudini<br />
con In Your Bedroom (dei Bauhaus letargici in bagno<br />
acido sixties), la title track e l’iniziale Somewhere<br />
(sussulti Ultravox! in una melma quasi Soundgarden),<br />
ecco il quintetto prestarsi a certo trasporto accorato<br />
tipo i Wire più melodici (Winter Light) o addirittura non<br />
lontano da certi Go-Betweens sintetizzati Notwist<br />
(Keep Away From Me).<br />
Allargare lo spettro e non perdersi, anzi continuare a<br />
sembrare un calderone di energia e buone intenzioni,<br />
è il loro merito principale. Chapeau.<br />
(7/10)<br />
Stefano Solventi<br />
driver&driver - we are the world<br />
(StaatSakt, marzo 2011)<br />
Ge n e r e: ca b a r e t e l e t t r o p u n k<br />
Con il Tubo pieno dei loro video incendiari tra audio<br />
ignobile e riprese epilettiche, un culto studiato ad hoc<br />
è già stato creato, proprio come ai bei vecchi tempi del<br />
situazionismo punk. E’ la premessa ideale a un debutto<br />
intitolato icasticamente We Are The World nel quale<br />
i Driver&Driver, fantomatico duo di Berlino, tentano<br />
di porsi come un ideale punto d‘incontro tra Suicide,<br />
D.A.F. (Deutsch-Amerikanische Freundschaf) e perché<br />
no gli Sparks dai quali ereditano il baffo e un tocco di<br />
kabaret.<br />
Il bello dell’operazione è una formula eccessiva e cafonissima,<br />
indirettamente ironica e maledettamente<br />
banale: immaginatevi gli Art Brut tragicomici di Eddie<br />
Argos in trip elettro punk, oppure la parte maschile e<br />
tedesca degli Stereo Total in un mix di Bloody Beetroots.<br />
Naturale che We Are The World sia una miscela<br />
instabile, uno Sturm und Drang dell‘assurdo tra gag<br />
sfilacciate (Hello, Hello, Back to LA) e attacchi industrial<br />
techno (Der Kleine Ernst), elettrock (quella Kutchen tra<br />
Kraftwerk e autoparodie della lingua tedesca) e rasoiate<br />
oi!<br />
Irresistibili questi due, specie quando calcano i territori<br />
più D.A.F., quando cioè EBM e techno veicolano i teatrini<br />
più corrosivi con Sicherheitsschrankenmann, Kampf<br />
im Kulturkaufhaus e Fluch Nach Vorn, Umtausch a rappresentare<br />
le hit sotterranee da pogo istantaneo e Farmer<br />
In Pajama, l‘anthem cow electro punk del caso. Sul<br />
lato nascosto della faccenda: troviamo infine una serie<br />
di declinazioni avant, da musiche per teatro e balletto<br />
per capirci, che trovano nei Residents degli esordi<br />
(campionati in We Got You Babe) un eccellente dialogo<br />
a distanza (e nel tempo).<br />
Cafone, situazionista, cretino e strafalcione. Il debutto<br />
di Patric Catani & Chris Imler è un autentico spasso.<br />
(7.3/10)<br />
edoardo Bridda<br />
duke garwood - dreamBoatSafari (fire<br />
recordS, marzo 2011)<br />
Ge n e r e: p o s t-b l u e s<br />
Quando pensi al blues e all‘Inghilterra, vengono in<br />
mente i nomi che nei ‘60 rilessero appassionatamente<br />
la tradizione per conservarla e nel contempo rinnovarla.<br />
Fungendo, come nel caso di Alexis Korner e John<br />
Mayall, da sublimi mentori per un‘intera generazione<br />
di talenti che impressero una svolta al rock. Materia<br />
storicizzata che sotto l‘aspetto strettamente stilistico<br />
non vale per questo londinese, giunto al terzo lp e propenso<br />
a restituire delle dodici battute la concezione<br />
“beefheartiana” che ne hanno Tom Waits e i Califone.<br />
Magari gettando nella mistura un interesse per la musica<br />
africana (il ragazzo ha in programma un disco con<br />
i marocchini Master Musicians Of Joujouka ) e tenendosi<br />
vicina l‘ombra di Mark Lanegan (in precedenza<br />
compagni di tour, i due: anche qui è previsto un lavoro<br />
a quattro mani) per muoversi dentro un‘avanguardia<br />
che oggi profuma di classicità. Il risultato persuade e<br />
mostra un artista in progresso, forte di sonorità solide<br />
ed essenziali (Duke fa quasi tutto da solo con il batterista<br />
Paul May) e una penna che attinge sapiente dai<br />
nomi di cui sopra (Summer Gold, Gengis, Jesus Got A<br />
Gun).<br />
Offrendo per il resto cinque minuti di inutile baccano<br />
low-fi, ma soprattutto gustose contaminazioni con Suicide<br />
(Gold Watch), free-jazz (Tapestry On Mars) e una<br />
psichedelia venata di world music (Flames Of Gold, Larry).<br />
In attesa di ulteriori sviluppi, un nome da appuntare<br />
sul taccuino.<br />
(7.1/10)<br />
giancarlo turra<br />
dutch uncleS - cadenza (memPhiS<br />
induStrieS, aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: in d i e, Xtc<br />
Le caratteristiche per farsi notare dalla stampa di settore<br />
questi cinque le hanno tutte. Il <strong>Tim</strong>es li ha recentemente<br />
inseriti negli Ones To Watch descrivendoli<br />
“ragazzi cresciuti alle complesse partiture temporali<br />
degli XTC aggiornate ai Talking Heads e al math-pop”,<br />
il Guardian li ha spottati nella sezione Band Of The Day<br />
chiamando in causa l’ennesima rinascita, questa volta<br />
mancuniana, con Hurts, Everything Everything and<br />
Delphic, Wikipedia chiude in bellezza il negozio di dolci<br />
con riferimenti quali Smiths, King Crimson e Steve<br />
Reich.<br />
Nessuna bugia, i Dutch Uncles usano tempi complessi,<br />
jingle-janglano circolari come Fripp negli 80s, ritmano<br />
secondo serialità prestabilite, ma erano (c’è un omonimo<br />
del 2009 su Tapete) e rimangono una indie band<br />
dalle dubbie capacità melodiche.<br />
Come dei Field Music con canto byrniano edulcorato,<br />
o dei Battles scarburati folk-pop, i cinque sembrano<br />
una bella sportiva uscita di fabbrica ma senza un driver<br />
vero. Il rodaggio è roba da poco ma la personalità<br />
è quello su cui Duncan Wallis deve, in primis, lavorare.<br />
Le sue strofe e ritornelli sono quasi sempre inefficaci e<br />
alla band tutta sembra mancare l’urgenza e l’orgoglio<br />
di cotanto passato chiamato in essere.<br />
Accattivanti e forse qualcosa in più gli zii olandesi ma,<br />
per ora, il loro gioco dura poco.<br />
(6.4/10)<br />
edoardo Bridda<br />
elBow - Build a rocket BoyS! (fiction,<br />
marzo 2011)<br />
Ge n e r e: indie w a v e p r o G<br />
Ho sempre avuto problemi a gestire l’enfasi sconsolata<br />
degli Elbow, con quel sovraccarico emotivo speso<br />
a definire fondali e lineamenti d’una malinconia più<br />
perniciosa che esistenziale, capace di affascinare giusto<br />
finché non inciampa in una spirale di turgida, monocorde<br />
costernazione. Eppure devo concedere loro il<br />
merito d’una coerenza che ha saputo dimostrarsi robusta<br />
e in grado di consolidarsi negli anni. Tanto che oggi<br />
possiamo parlare di un Elbow-sound, una dimensione<br />
espressiva fatta di trasporto, apprensione, una mesta<br />
fierezza che sa fare i conti con la memoria e proiettare<br />
le inquietudini in una prospettiva coinvolgente.<br />
Lontani i tempi in cui potevi scambiarli per una versione<br />
abbacchiata dei Coldplay: il loro indie non insegue<br />
chissà quale grandeur, persegue una comunicatività<br />
intensa e potabile ma allo stesso tempo tenta di sca-<br />
68 69
varsi dentro profondità spacey e vibrazioni oblique, di<br />
rendere tangibili e radianti le irrequietezze e i sussulti<br />
emotivi. Una calligrafia spesso didascalica ma quasi<br />
sempre efficace, non sottile ma onesta. Comunque capace<br />
di tenersi in equilibrio tra modulazioni stilistiche<br />
anche complesse, vedi la naturalezza con cui Jesus Is a<br />
Rochdale Girl bazzica palpitazioni tenui Jim O’Rourke<br />
o quella Lippy Kids che immerge l’acme emotivo dell’album<br />
in una scenografia eterea Brian Eno.<br />
Se la cavano bene quando alzano la temperatura guardando<br />
al pop-prog di stampo Peter Gabriel innervato<br />
di romanticismo wave (With Love, High Ideals, Open<br />
Arms) e non sono affatto male quando spediscono uno<br />
struggimento Smiths tra evanescenze angeliche Sigur<br />
Ros (Open Arms), così come è apprezzabile quel modo<br />
di sclerotizzare gospel ottenendo una strana solennità<br />
apolide (The Birds, The River). Resta però dietro l’angolo<br />
il rischio della litania autoreferenziale (vedi la pur valida<br />
The Night Will Always Win), perché la maturità cambia<br />
molte cose ma la natura, si sa, è un osso duro.<br />
(6.9/10)<br />
Stefano Solventi<br />
emanuele errante/dakota Suite - the<br />
north green down (lidar, marzo 2011)<br />
Ge n e r e: am b i e n t<br />
La collaborazione tra il leader dei Dakota Suite - una<br />
delle più ispirate formazioni della realtà del slow<br />
core britannico di cui segnaliamo Waiting For The Dawn<br />
To Crawl Through And Take Away Your Life per testi e<br />
miniature elettroacustiche - e il compositore italiano<br />
risale già al 2009, precisamente alla rielaborazione<br />
del brano Second Hand Light contenuto in The Night<br />
Just Keeps Coming In, il remix album di The End Of<br />
Trying. A consacrare ulteriormente l‘affinità stilista<br />
tra i due questo The North Green Down, uscito quasi in<br />
contemporanea alla prova solista di Emanuele Errante,<br />
e contenente ottanta minuti di composta malinconia<br />
dedicate alla compianta cognata di Hooson.<br />
Parallelamente a <strong>Tim</strong>e Elapsing Handheld, il napoletano<br />
continua a vestire a puntino gli abiti da ambient<br />
artist, mentre Hooson gli si affianca con notazioni intimiste<br />
per piano e chitarra. Parola d‘ordine è l‘uso<br />
discreto dell‘elettronica, manipolata da Errante come<br />
sempre con incredibile delicatezza ed unita a strumenti<br />
tipicamente acustici. Il tutto confluito nelle radici di<br />
commosse riflessioni a cui ci si avvicina da principio tra<br />
i tasti di The North Green Down e Leegte. Materie palpabili<br />
che, inevitabilmente, restituiscono le sfumature a<br />
modo di un Keith Kenniff nei primi minuti di Famous<br />
Places.<br />
Il resto non è un facile dialogo di cordoglio ma un‘appresa<br />
coscienza d‘assenza, assimilabile ed evidente<br />
nell‘acustica di A Hymn o nel respiro armonico arricchito<br />
dal cello di A Worn Out Life - che rimandano per<br />
affinità, suono narrativo ed esecuzione, ai duetti di un<br />
Francesco Dillon ed Emanuele Torquati. Aliena ma alleata<br />
- rispetto all‘impianto sommesso ma cameristico<br />
di A Loveless Moment, l‘elettronica dell‘ouverture di No<br />
Greater Pain che con i suoni organici di Nobody Is Ever<br />
Safe e i pulviscoli stratificati ed eterei di Wat We Kwijt<br />
Zijn sottolineano il calore delle macchine di Errante.<br />
Oltre alla creatività reciproca e alla fantasia timbrica, a<br />
tenere il filo per questi ottanta minuti di micro sinfonie<br />
è l‘equilibrio tra la poesia sospesa di Hooson e le sostenute<br />
texture di Errante che con i frangenti ambient si<br />
fanno spina dorsale allontanando il progetto da facili<br />
percorsi elettroacustici. Materia e uomini tutt‘altro che<br />
invisibili.<br />
(7/10)<br />
Sara Bracco<br />
eric legnini - the vox (diScograPh, marzo<br />
2011)<br />
Ge n e r e: j a z z s o u l<br />
Agile, sinuoso, urbano, cerebrale, appassionato, dinamico.<br />
Il jazz di Eric Legnini - pianista parigino di origine<br />
belga - respira tradizione in un coté decisamente<br />
contemporaneo e globale, lascia che a sgranare la<br />
pannocchia siano gli umori compositi e coesi della<br />
sua band, gli Afro Jazz Beat (un bassista funk belga,<br />
un chitarrista congolese già al lavoro con Fela Kuti, un<br />
batterista ed un contrabbassista francesi) cui va ad aggiungersi<br />
per metà dei brani la voce calda e flemmatica<br />
della statunitense Krystle Warren.<br />
Il tocco di Legnini possiede una morbidezza guizzante<br />
e sensibile come un Esbjorn Svensson meno pensoso,<br />
sa essere urbano e spirituale, frequenta con disinvoltura<br />
indole latin-tinge, estro afro-beat, sussulti funk e<br />
turgore soul (oltre al piano si presta al Fender Rhodes e<br />
all’Hammond). E’ la sensibilità dorsale di un sound che<br />
cerca le proprie radici nei seventies, cui rimandano le<br />
timbriche frementi e vellutate. Gran bel disco.<br />
(7.2/10)<br />
Stefano Solventi<br />
fareSoldi - caSotto eP (riot maker, marzo<br />
2011)<br />
Ge n e r e: e l e c t r o/d i s c o f u n k y<br />
Ancora EP Faresoldi. Con il solito armamentario di<br />
kitscherie rese con suoni e arrangiamenti sempre impeccabili.<br />
Cinque pezzi per ribadire la via post-Sappia-<br />
highlight<br />
falty dl - you Stand uncertain (Planet mu recordS, aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: re t r o h o u s e, 2 s t e p<br />
Drew Lustman era partito fin troppo cauto con l‘esordio Love Is A Liability, poi però la strada per lui<br />
è stata tutta in salita: prima è arrivato un eppì come The Bravery che testimonivava l’assorbimento<br />
di una lezione fondamentale come quella Luke Vibert-iana; poi una serie<br />
di pubblicazioni per Ramp e Rush Hour, con ancora Luke nel taschino,<br />
evidenziavano un sapiente tocco House in salsa garage (Party), oppure in<br />
downtempo (Meta-Cognist), oppure ancora ispirato ai classici Mr Fingers,<br />
Coco Steel And Lovebomb (la bomba All InThe Place).<br />
In questi ultimi due anni, tra dj set e podcast, Drew si è mosso talmente<br />
bene che arrivato a You Stand Uncertain doveva soltanto metter giù tutto<br />
quello che aveva imparato dal continuum hardcore e restituircelo, intatto,<br />
nella massima espressione groove-step.<br />
Il moniker Falty Dl non è mai stato sinonimo di dubstep producer e neppure<br />
di specialista della sotto nicchia now on (Future Garage o Uk Funk); piuttosto è l’alias di un musicista<br />
elettronico newyorchese follemente innamorato del suono UK, di un ragazzo che non ha mai distinto<br />
tra i cataloghi IDM, d’n’b e quelli più dance.<br />
Nessuna sorpresa se nell’album troviamo vent’anni di step, citazioni early house e rave con un taglio<br />
che parallelamente all‘ultimo Kode9 (anticipato dal suo Endeavour per Planet Mu) lo vede calibrare<br />
smalti black (Gospel Of Opal), sponde soulfull e tocchi etno via Boxcutter (e quindi, indietro, Horsepower<br />
Production).<br />
L‘ondata glo, tagliata da un altro spirito affine come Bibio in senso funk, lo trova dunque sul lato balearico<br />
della faccenda, quella con più affinità rave e jungle: nella splendida Lucky Luciano la citazione a<br />
Pacific State degli 808 State e a A Guy Called Gerald è evidente quanto, in generale, l‘album è da una<br />
parte giocato sulla chill (l‘opener Gospel Of Opal), dall’altra temporalmente sincronizzato tra ambient<br />
house 92 (Voyager) e jungle 93 (The Pacifist).<br />
A contorno, le specialità: post-idm e spezie lounge-jazz (Open Space), 2 step + house (Brazil con Lily MacKenzie),<br />
IDM lato primi Autechre tagliati Actress (You Stand Uncertain), ancora jungle (Eight Eighteen<br />
Ten) e gran finale vibertiano (Waited Patiently).<br />
Per chi ama l’elettronica UK, questo è un album da antologia.<br />
(7.3/10)<br />
edoardo Bridda<br />
mo dove abiti e cioè quella di un act ormai internazionalizzato<br />
che punta a un suono più corposo, tattile,<br />
gommoso. In una parola, da dancefloor. Pasta e Luka<br />
insomma lontani anni luce da canzoni agrodolci come<br />
- la bellissima - Primi baffi.<br />
Cassa Forte mette assieme electro Ottanta e post-fidget,<br />
glo/chill e stomp&go garage; Party Posse ha una<br />
bassline superkunfky slap semplicemente contagiosa,<br />
e ci appiccica sopra una demenziale voce declamatoria;<br />
Volluto è uno stop&go funkyhouse con tocchi<br />
wonky; All You Need Is LOL è un po’ Jim Avignon (un<br />
giorno qualcuno scoprirà/riscoprirà quest’uomo), un<br />
po’ Todd Rundgren, un po’ Toro scanzonato; Sabbiadoro,<br />
dopo una intro con elettroniche alla Xevious, parte<br />
disco superfunky. Le loro specialties.<br />
Stringendo: trascinanti, irresistibili, FS possono anche<br />
andare avanti così all’infinito. Quindi, invece, noi li<br />
aspettiamo con un nuovo album.<br />
(7/10)<br />
gaBriele marino<br />
70 71
federico SQuaSSaBia walkaBout -<br />
SonglineS (Parade, ottoBre 2010)<br />
Ge n e r e: a v a n t -j a z z<br />
Dopo essere cresciuto in quella fucina di talenti che<br />
è Improvvisatore Involontario, Federico Squassabia<br />
approda a Parade - costola sperimentale di Trovarobato<br />
- con questo Songlines. Nella pratica nulla cambia,<br />
nel senso che l’universo del pianista continua ad essere<br />
fatto di una materia flessibile, meditativa, contaminata,<br />
in equilibrio tra jazz, classica e contemporanea.<br />
La formazione è minimale: Nelide Bandello alle percussioni<br />
e Danilo Gallo al basso/contrabbasso, a giocare<br />
con un concetto di viaggio che ambienta ogni<br />
brano in un luogo (fisico o dell’anima) diverso. Con il<br />
groove dispari di The Jellyfish Meal (Amsterdam) e le<br />
ampie aperture di C’era una volta (The Wild Wild West<br />
And Sergio Leone), le aspirazioni atonali di Don Durito<br />
Y Marcos (Mexican Walk & Subcomandante) e i fraseggi<br />
di piano scapicollanti di Una passeggiata ai giardini<br />
pubblici (Bologna) che svelano un’opera stratificata,<br />
obliqua e a suo modo narrativa. Avant-jazz avventuroso<br />
e immaginario, alla stregua delle vie dei canti degli<br />
aborigeni australiani a cui il disco idealmente s’ispira. E<br />
uno Squassabia come al solito a ottimi livelli.<br />
(7.1/10)<br />
faBrizio zamPighi<br />
fratelli calafuria - muSica rovinata<br />
(maSSive artS, aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: e l e t t r o c k<br />
Non cala affatto la furia dei Fratelli Calafuria stando a<br />
quanto si ascolta nell‘opener Pezzo Giallo: 2 minuti e<br />
poco più di furia cieca fatta di ampli al rosso e vocals<br />
in modalità screamo meets nonsense lirico e suburbano.<br />
A ruota, Fare Casino, ovvero l‘electro-rock iper-vitaminizzato<br />
dei dimenticati Death From Above 1979:<br />
stesso frullatone di analogico e digitale e stessa forsennata<br />
corsa a superare ogni possibile limite, messi però<br />
al servizio di un anthem da chiamata alle armi tardoadolescenziale<br />
al grido di “bisogna fare casino!”.<br />
Adrenalina a pacchi e atteggiamento tra l‘amara disillusione<br />
e il sarcastico nei confronti del mondo esterno (in<br />
stretto ordine alfabetico ci fanno sapere i due che i testi<br />
parlano di “amore, cassette, cose complicate, disordine,<br />
disastri, giallo, luoghi comuni, Milano, radio fm”) fanno<br />
di Musica Rovinata uno spietato e folle sguardo lucido/ludico<br />
sull‘attualità. I due fratelli (Andrea Volontè<br />
e Paco Vercelloni) mischiano e stratificano punk, funk,<br />
jazz, noise, no wave, electrock con una predisposizione<br />
collagistica e massimalista che fa il paio con le aperture<br />
melodiche delle vocals, sempre sul filo del calembour<br />
pesante o dello scazzo in modalità ironico-giovanilistico.<br />
Che alla fin fine non si capisce bene se ci facciano o<br />
stiano semplicemente prendendoci tutti per il culo.<br />
Probabilmente la seconda, ma cambia poco: Musica Rovinata<br />
è una centrifuga di rock alto e basso alla maniera<br />
di un Patton sanbabilino o di uno Zappa sboccato e<br />
punkish cresciuto nell‘ovattato e sopravvalutato mondo<br />
del rock fichetto italiano. È tutto eccessivo, tirato ai<br />
massimi livelli, pronto allo strappo, ironico, schizzato e<br />
crudo nella musica dei Calafuria bros. Cosa che ci piace<br />
assai.<br />
(7/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
gatto fritto - gatto fritto (international<br />
feel recordingS, aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: s p a c e n u d i s c o<br />
Gatto Fritto è Ben Williams che già avevamo incontrato<br />
nell‘ottimo 12‘‘ Illuminations con il moniker di Hungry<br />
Ghost, un duo (con Sam Weaver) house declinata nudisco,<br />
che tra i remix illustri portava anche il nome del<br />
re della cosmic Daniele Baldelli.<br />
Ben sta sulla scena da un sacco di anni: nei Novanta si<br />
è fatto le ossa con la techno suonando all‘Analog City<br />
londinese, nei Duemila, tra alterne fortune, ha organizzato<br />
party e cambiato interessi sonici passando da<br />
Detroit a Chicago per poi approdare alla space disco<br />
proveniente dalla Norvegia (Lindstrøm). Nel frattempo,<br />
ha fatto il commesso alla Reckless records (e in un<br />
videostore) e stretto diversi contatti che, a partire dal<br />
2007, si trasformano in release.<br />
Gatto Fritto esordisce quindi nel 2007 per la londinese<br />
Dissident con Invisible College, uno dei brani che ritroviamo<br />
in questo omonimo long playing, emblematica<br />
testimonianza della sua mano: lineari progressioni di<br />
synth cosmici, battuta disco e citazionismi 70s a contorno.<br />
Nel corso degli ultimi quattro anni, rispetto a Lindstrøm<br />
(quasi plagiato in The Hex), Gatto Fritto ha spostato<br />
l‘interesse verso gli 80s sintetici di Com Truise ed ha<br />
aperto pure un’etichetta, la Fritto Morto. Quest‘esordio,<br />
su International Feel Recordings (proprio come Hungry<br />
Ghost) è una raccolta di materiale vecchio e nuovo,<br />
buona space disco e interessante nu. In un momento<br />
di sintesi dance eterodossa come quello attuale (vedi<br />
su altri lidi i Discodeine) la mossa ci sta tutta, anche se<br />
l’approccio è ancora troppo calligrafico. Il meglio, verrà<br />
con l‘esordio lungo del duo...<br />
(7/10)<br />
edoardo Bridda<br />
gentleSS3 - i’ve Buried your ShoeS down<br />
By the garden (wild love, marzo 2011)<br />
Ge n e r e: p o s t-s l o w-f o l k<br />
Quanti frutti insipidi e ammuffiti siano stati colti negli<br />
ultimi anni dall’albero del post-rock e dello slowcore<br />
è cosa tristemente nota. Era ovviamente questione<br />
di attendere la stagione e l’innesto giusti. Come pure<br />
conta il terreno da cui le radici succhiano sostanze ed<br />
energia. E quanto in profondità. Carlo Natoli da Ragusa<br />
- nel curriculum una gavetta da fonico e collaborazioni<br />
in entità quali Albanopower e Tapso II - ha coltivato<br />
bene la propria attitudine organizzando i Gentless3,<br />
quartetto (chitarra baritono, chitarra elettrica, piano<br />
elettrico e batteria) che riarticola l’incedere costernato<br />
di certo post-rock con l’incandescenza dimessa dello<br />
slowcore, puntellando l’emotività con un romanticismo<br />
noir di stampo alt-folk.<br />
Ascolti queste melodie indolenzite ma appassionate,<br />
questo croonerismo sospeso tra selvatica indolenza e<br />
afflizione, ed è come quell’impasto di Slint, Unwound,<br />
Codeine e Black Heart Procession che hai sempre più<br />
o meno consapevolmente desiderato. Il patema fiero<br />
venato di jazz fumoso di On Busting The Sound Barrier,<br />
la gravità risoluta di Comeback From (omeopatie Red<br />
House Painters nel ritornello) e la cinematica apprensione<br />
di Since ‘98 sono l’apice di un programma stringato<br />
(solo sette tracce) ma intenso e credibile.<br />
(7/10)<br />
Stefano Solventi<br />
grailS - deeP PoliticS (temPorary<br />
reSidence, aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: p s y c h p o s t-r o c k<br />
La cosa che spiace di più nell’ascoltare i Grails è il senso<br />
di incompiutezza, un retrogusto amaro dato dalle<br />
grandi possibilità che concretamente non riescono a<br />
realizzarsi in pieno.<br />
Il tentativo di portare avanti le intuizioni dei Neurosis<br />
e degli Isis sposandole con un misto di post-rock, folk e<br />
sonorità psych liquide, rimane infatti soltanto nelle intenzioni.<br />
Una volta messo in pratica infatti sembra più<br />
una forzatura che una evoluzione fluida e omogenea,<br />
sfociando in un manierismo stucchevole (All The Colors<br />
Of The Dark) o in tirate prog abbastanza noiose (Deep<br />
Politics). Ed è un peccato perché i momenti buoni non<br />
mancano, come quando filano via lisci e diretti facendosi<br />
apprezzare per una buona varietà stilistica: il trip-hop<br />
etnico di Corridors Of Power o le folkeggiantiAlmost Grew<br />
My Hair - sicuramente la migliore del lotto - e I Led Three<br />
Lives sono testimonianza di una discreta padronanza di<br />
mezzi e abilità nell‘amalgamare stati d‘animo differenti.<br />
Deep Politics è dunque un lavoro mezzo riuscito nel suo<br />
essere troppo pretenzioso e poco coeso e si fa apprezzare<br />
soprattutto nei pochi momenti in cui i Grails trovano<br />
un punto di equilibrio. Verrebbe da definirlo un<br />
buon primo lavoro che fa ben sperare per il futuro, se<br />
non fosse che sono tutto tranne che una band di novizi.<br />
(6.2/10)<br />
franceSco aSti<br />
green like july - four-legged fortune<br />
(ghoSt recordS, feBBraio 2011)<br />
Ge n e r e: indie, f o l k<br />
Si apre guardando al Bob Dylan di Highway 61 reviseted<br />
questo Four-legged fortune, secondo ottimo lavoro dei<br />
Green like july. Un po’ di Pavia e un po’ di Alessandria,<br />
Andrea Poggio, Nicola Crivelli e Paolo Merlini, hanno<br />
registrato agli ARC studios di Omaha, Nebraska, luogo<br />
centrale nella realizzazione e produzione degli album<br />
dei Bright Eyes e della Saddle Creek tutta. Niente di<br />
più azzeccato, è chiaro, visto che è proprio da un brano<br />
di Fever and mirrors che arriva il nome della band.<br />
Appoggiati, a partire dai demo, da Jake Bellows dei<br />
Neva Dinova e sostenuti, durante la lavorazione, dal<br />
supporto dei fratelli Mogis, i tre ragazzi escono con un<br />
album pieno, denso di riferimenti, citazioni, sguardi,<br />
eppure capace di non risultare mai, pur con una forte<br />
connotazione di genere, la copia di qualcosa di già<br />
noto. Che si sentano, e non poco, Conor Oberst, gli Okkervil<br />
River e una serie di infiniti affondi nella musica<br />
folk più statunitense e antica possibile, è cosa evidente,<br />
tuttavia Four-legged fortune mantiene con forza la<br />
propria originalità. Se nel precedente May This Winter<br />
Freeze My Heart si accusavano infatti i colpi dell’amore<br />
per un certo mood sonoro e vocale, qua il pericolo è<br />
scampato. Testi di forte intimità e ironia che raccontano<br />
un immaginario capace di aderire perfettamente ai<br />
suoni e alla vocalità di Poggio.<br />
Non siamo di fronte a un disco che ne ricalca altri ma<br />
a un lavoro nato, cresciuto e sviluppato nel luogo a lui<br />
più adatto, nel suo spazio più naturale, accanto alle sue<br />
stesse fonti d’ispirazione. Brani come Jackson e, soprattutto,<br />
il piccolo capolavoro A perfect match sono vere e<br />
proprie rarità. Eccellente la cura dei dettagli: una produzione<br />
di alto livello e un artwork di folk art raffinatissimo<br />
e quantomai adatto, nato da un’idea della talentuosissima<br />
illustratrice Olimpia Zagnoli. Bravissimi.<br />
(7.4/10)<br />
giulia cavaliere<br />
72 73
highlight<br />
joSh t. PearSon - laSt of the country gentlemen (mute, aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: p o s t-s o n G w r i t i n G<br />
L‘unico difetto di questo disco è una copertina fuorviante e poco significativa. Nient‘altro. In queste<br />
sette canzoni - mediamente assai lunghe, costruite attorno a silenzi e una chitarra acustica, al violino<br />
dell‘amico Warren Ellis dei Dirty Three e tantissime parole - Pearson ha<br />
inserito un decennio dallo sbando alla salvezza tramite l‘auto-isolamento.<br />
Tanto basterebbe per rispettarlo: per amarlo bisogna scavare negli avvenimenti<br />
precedenti le due notti in uno studio berlinese che ne hanno testimoniato<br />
la genesi. Solo così si può capire come ci si trovi al cospetto di<br />
qualcosa che ha condotto l‘autore fuori da un deserto dell‘anima.<br />
Un tempo leader dei Lift To Experience, il ragazzo faceva in tempo a pubblicare<br />
il cult The Texas-Jerusalem Crossroads e ricevere elogi da John Peel,<br />
dopo di ché il gruppo si sbriciolava a contatto con lo showbiz e per via di<br />
alcune tragedie personali. Josh reagiva con una ricerca di sé nella provincia del Texas, lavorando quel<br />
tanto che bastava a una vita decente, senza smettere di scrivere canzoni nel mentre Lift To Experience<br />
diventavano materia mitica.<br />
Si spostava poi a Berlino e Parigi, andando incontro alla catarsi in alcuni spettacoli dal vivo tenuti senza<br />
un piano preciso. Senza davvero voler tornare sulle scene, piuttosto scrollandosi di dosso il passato<br />
con umiltà e nuovi argomenti. Non fosse stato per il riscontro positivo di alcuni concerti di spalla giustappunto<br />
ai Dirty Three nel 2009, non avremmo mai ascoltato questa ipotesi di Leonard Cohen che<br />
si abbevera alla scuola dei cantautori texani, però consapevole della catatonia di Mark Kozelek e dello<br />
slancio di Micah P. Hinson.<br />
Capace, al posto di un romantico cinismo, di porgere cose commoventi come Honeymoon Is Great, I<br />
Wish You Were Her e il folk dall‘afflato gospel Drive Her Out aprendo il cuore su un piatto d‘argento; di<br />
toccare un vertice sublime in una Country Dumb da Townes Van Zandt in transito dal border al paradiso.<br />
Perché ha compreso che, se qualcosa è onesto e sincero, deve abbandonare il solipsismo e trovare<br />
l‘altrui riscontro. Perché l‘Arte è comunicazione, e benché si tratti di un disco refrattario e scontroso,<br />
basterà un‘ora al giorno per trovare un amico che accomapgni al di là delle miserie di ogni giorno, non<br />
soltanto delle musichette che si dimenticano a una settimana dall‘uscita. Ci vuole coraggio e talento<br />
per questo.<br />
(7.5/10)<br />
giancarlo turra<br />
grey hiStory - all dead StarS (radical<br />
matterS, feBBraio 2011)<br />
Ge n e r e: h a r s h -n o i s e<br />
Riprende il discorso esattamente da dove lo aveva<br />
lasciato con Lucifer Over Disneyland, il duo Gianluca<br />
Becuzzi/Fabio Orsi. All Dead Stars - sempre in cd-r in<br />
cartonato 7” dall‘iconografia potente e politicamente<br />
scorretta - è il gemello diverso dell‘esordio e si nutre<br />
della stessa, infame materia: harsh noise e power electronics<br />
sul versante musicale e immaginario pop-iconoclasta<br />
e humour nerissimo, su quello visivo.<br />
Il declamare icastico di Becuzzi sul tappeto industrial-<br />
noise dell‘opener All Children Are Fascists, il glitch subacqueo<br />
e imputridito di Put Pregnant And Leave Is Very<br />
R‘n‘R, il noise granuloso e ispido delle due parti di Cocaina<br />
Toilettes Tour, l‘ebm malevola in bassa battuta di<br />
Nietzsche Fucks Christ e i droning montanti della conclusiva<br />
Girls Usually Bleed, sono esempi del procedere<br />
musicale estremo del duo.<br />
La chiave di volta per comprendere a fondo il portato<br />
del progetto Grey History risiede però nello humor cattivo<br />
e nerissimo, nella filosofia anti-politically correct,<br />
contro il finto buonismo di fine millennio e l‘incapacità<br />
di prendere posizioni nette che i due sbattono in faccia<br />
all‘ascoltatore con sonorità e immaginario iconografico.<br />
Grey History prende le sue posizioni e di questo<br />
gliene va reso merito.<br />
(7/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
gurun gurun - gurun gurun (home<br />
normal, aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: indietronic a<br />
Gurun Gurun è la creatura poliglotta e transcontinentale<br />
di tre polistrumentisti (Tomas Knoflicek, Jara Tarnovski,<br />
Federsel) che rimbalzano tra l‘est-Europa, l‘Asia<br />
e il Nuovo Continente. Il trio, affiancato da una manciata<br />
di amici musicisti, affida a un disco omonimo un<br />
esordio che ci fa tornare senza interferenze agli anni<br />
dell‘indietronica Morr con qualche picco di ricerca (sui<br />
rumori di fondo) alla The Books.<br />
Sia all‘orecchio che ha attraversato quell‘onda, sia a<br />
quello digiuno, appare evidente l‘eccessivo affidarsi a<br />
una formula-canzone dilatata ma fermamente ancorata<br />
alla melodia eterea della vocalità. Le voci - e i testi<br />
- sono esclusivamente giapponesi (le ospiti più evidenti<br />
in casa Gurun Gurun, ossia Sawako, Moskitoo, Aki<br />
Tomita), il tappeto strumentale un piccolo archivio di<br />
micro-suoni, punteggiato qui da tocchi melodici di chitarra,<br />
là da accenni di ottone (ai fiati sono impegnate le<br />
altre comparse dell‘album). C‘è però troppo miele, facili<br />
emozioni, dentro alle canzoni.<br />
In linea di massima, il sottofondo di piccoli frammenti,<br />
concretismi, residui Books-iani è più originale della media<br />
del genere. L‘ossatura tronica arriva persino in qualche<br />
occasione (Io) a lambire l‘impro elettroacustica, o a<br />
perturbare in maniera non scontata (Kúkó) la trasognata<br />
delicatezza delle melodie vocali, ma non abbastanza<br />
da giustificarne l‘uso senza possibilità di alternativa. È<br />
la pesantezza di un gusto, che si vuole paradossalmente<br />
molto delicato, a fare che questi “eppure” diventino<br />
“nonostante”.<br />
(5/10)<br />
gaSPare caliri<br />
harPS of fuchSia kalmia/dora Bleu - echo<br />
Palace of finitude (three legged cat,<br />
marzo 2011)<br />
Ge n e r e: m i n i m a l-f o l k<br />
L‘ultima manifestazione sonora di Harps Of Fuchsia<br />
Kalmia prima della dismissione della sigla si avvale del<br />
prezioso apporto di Dora Bleu, agitatrice del sottobosco<br />
americano (From Quagmire su tutti) e da qualche<br />
tempo chanteuse dreaming in solitaria. La voce ammaliante<br />
ed evocativa di Dorothy Geller, questo il vero<br />
nome dell‘americana, ben si allinea con le prospettive<br />
sonore architettate da Salvatore Borrelli nella sua ennesima<br />
incarnazione dopo (etre) e Wondrous Horse.<br />
Al primo ascolto identificabili col calderone post weirdfolk<br />
- poiché è da quella macro-area che i due protagonisti<br />
grossomodo provengono - le musiche di Echo<br />
Palace Of Finitude sono invece più eteree e esoteriche<br />
rispetto al canone di genere, caricandosi di una vena<br />
darkish non comune se non volgendo lo sguardo ad<br />
Albione. Spesso accomunabili a paesaggi ambientali di<br />
matrice chamber-folk (la varia strumentazione usata da<br />
Borrelli, in questo caso, aiuta molto), esse sono drammaticamente<br />
e teatralmente accese anche e soprattutto<br />
dalla voce della cantante, finendo con lo sfiorare così<br />
atmosfere orchestrate e minimali alla Amber Asylum<br />
o certo minimal-folk inglese di respiro pienamente bucolico<br />
e acustico.<br />
Animi affini quelli di Harps/Borrelli e Dora/Geller in<br />
grado di far scattare magiche e vibranti interazioni che<br />
fanno di Echo Palace Of Finitude una raccolta lirica e<br />
struggente come un sussurro ancestrale.<br />
(7.2/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
harShcore - Ponytail, PonytaleS (liSca<br />
recordS, aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: eX p e r i m e n t a l<br />
Negli Harshcore di Luca Sicurtà e Tommaso Clerico c‘è<br />
la stessa attrazione ludica nei confronti del rumore che<br />
era tipica dei Throbbing Gristle. Paragone altisonante<br />
ma evidente se si approfondisce l‘ascolto dei mille rivoli<br />
in cui il duo di Biella sparpaglia la propria personale<br />
weltanschauung rumorosa.<br />
Dismessi i panni dei rumoristi incompromissori e legati<br />
all‘industrial da un approccio naif - da cui traeva ispirazione<br />
anche la scelta del moniker - i due elaborano<br />
un caleidoscopio che si muove agile e sboccato tra experimental-sound<br />
(Clusterfuck) ed elettronica weird (le<br />
increspature post-glitch di Divar), dark-ambient deformata<br />
(Neko Case In The Bluegrass o la Ponytail, Ponytales<br />
Pt. 2 impreziosita dalla voce fantasmatica di Madame<br />
P) e industrial-beat spastica (Taping Bones), non disdegnando<br />
squarci da contemporanea meets no-wave (Fable<br />
Cutoff) o loop e ritmi spezzati da hip-hop claudicante<br />
alla Consolidated (U Smilin‘).<br />
C‘è però in questa apparente eterogeneità di forme e<br />
contenuti, una coesione di fondo legata ad un linguaggio<br />
sardonico e pungente, autoironico e grottesco, circense<br />
a tratti nelle movenze, che si avvicina al senso<br />
ultimo dei padri dell‘industrial citati in apertura.<br />
Si obietterà che la nutrita messe di ospiti - To Live And<br />
74 75
Shave In LA, Zeek Sheck, Bologna Violenta, Madame<br />
P, IOIOI e molti altri ancora - possa aver detto la sua<br />
in questo melting-pot stranito e straniante, ma così<br />
facendo non si renderebbe giustizia ai titolari della<br />
sigla. Esperti musicisti, sperimentatori indefessi e mai<br />
domi esploratori di lande sonore periferiche ed entusiasmanti.<br />
(7.2/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
head and the heart (the) - eyeS only (SuB<br />
PoP, aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: a m e r i c a n a<br />
E‘ una felice casualità ad aver riunito quella che, da più<br />
parti, è additata come una delle “sensazioni” dell‘annata.<br />
Correva l‘estate 2009 quando, nei sobborghi di<br />
Seattle, Josiah Johnson e Jonathan Russell mettevano<br />
assieme i propri talenti di songwriter. Entro breve li<br />
raggiungevano il tastierista Kenny Hensle, la cantante<br />
e violinista Charity Rose Thielen e la sezione ritmica di<br />
Tyler Williams (batteria) e Chris Zasche (basso). A inizio<br />
2010 entravano in studio per mettere mano a un disco<br />
dopo averne rodate le composizioni con un‘intensa - e,<br />
stando alle cronache, notevole - attività “live”. Ne stampavano<br />
poche copie da vendere giustappunto ai concerti,<br />
esaurite mentre il cicaleccio si espandeva lungo<br />
la costa Ovest.<br />
Finché, a novembre, la Sub Pop non li metteva sotto<br />
contratto ri-registrando Sounds Like Hallelujah e aggiungendo<br />
un paio di brani più recenti. I quali, come il<br />
resto del programma, posseggono l‘urgenza emozionale<br />
di un Conor Oberst meno verboso e privo dell‘afflato<br />
emo. Che preferisce osservare le radici country e<br />
folk e la loro trasfigurazione lungo i decenni per poi<br />
dire la sua con attitudine sincretica. La scrittura poggia<br />
però più sul pianoforte, su intrecci vocali perfetti e una<br />
tavolozza strumentale ricca ma che valorizza le canzoni<br />
invece di appesantirle.<br />
La penna è di caratura elevata e già matura: complessa<br />
però brillante (i cambi di passo in Honey Come Home, la<br />
festosa, beatlesiana Ghost) oppure di una malinconia<br />
gioiosa (Coeur d‘Alene, la policroma title track); altrove<br />
intrisa di dolcezza crepuscolare (accorate e robuste, Rivers<br />
And Roads e Down In The Valley) e capace di sparigliare<br />
le carte con disinvoltura (Heaven Go Easy On Me:<br />
gli Eagles che, a lezione da The Band, raccolgono per<br />
strada un gusto pop britannico e un finale cameristico;<br />
le venature soul di Lost In My Mind). Materia appassionata<br />
e mai scontata, insomma, bastante a srotolare il<br />
tappeto rosso per accogliere altri “nuovi tradizionalisti”.<br />
Non una contraddizione in termini, casomai il miglior<br />
complimento che ci sentiamo di esprimere.<br />
(7.2/10)<br />
giancarlo turra<br />
holy ghoSt! - holy ghoSt! (dfa, aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: s y n t h p o p 80<br />
Lo spirito santo degli anni Ottanta ritorna ancora una<br />
volta, stavolta incarnato in due ragazzi di Brooklyn, al<br />
secolo Nicholas Millhiser and Alexander Frankel. La DFA<br />
di James Murphy non ha mai celato l‘amore per quella<br />
decade di brillantini e il gruppo di nerd dei synth - che<br />
per noi italo hearts potrebbero essere avvicinati alle<br />
tamarrate intelligenti della Scuola Furano (Riotmaker<br />
come DFA de noantri?) - ha da sempre trovato pane per<br />
i suoi denti nell‘arte del remix nelle stanze hyper-cool<br />
dell‘etichetta che ha alimentato il nu-rave.<br />
Inevitabilmente le riletture andavano di pari passo con<br />
quello che ribolliva nella mente del cantante degli LCD<br />
Soundystem: e quindi pacchi di sonorità patinate à la<br />
Hot Chip prima maniera, Hercules And Love Affair<br />
e Juan MacLean, con cui hanno collaborato in studio<br />
e in tour. Più che creatori, Nick e Alex hanno da sempre<br />
sgobbato come remixers. La raccomandazione di<br />
James li ha portati a toccare punte di hype che i nerd<br />
dei sobborghi di Manhattan sognano: Moby, MGMT,<br />
Phoenix e altri vip del giro giusto nu-disco. Ma oggi,<br />
al debutto, come suonano? Il nerdismo è la loro arma<br />
fondamentale.<br />
Concentrati in un recupero di tastierine, echi e altri FX<br />
di quegli anni suonano come se il tempo non fosse<br />
passato. O meglio, dato che da poco abbiamo capito<br />
che i nonni di quegli anni stanno tornando in massa<br />
per sbancare i botteghini con tonnellate di nostalgia<br />
soporifera (Human League, Duran Duran e OMD, tanto<br />
per citare i più recenti), la domanda nasce spontanea:<br />
che hanno di meglio gli Holy Ghost! dei matusa<br />
incartapecoriti in riciclo continuo? Il tiro, il sorriso nerdy,<br />
la voglia di mettersi in gioco e di far divertire. In una<br />
parola la freschezza necessaria a rivangare un passato<br />
e a scagliarlo nel futuro.<br />
Tra le altre muse ispiratrici obbligatora è la citazione dei<br />
New Order, di cui qualche tempo fa hanno celebrato<br />
la hit Confusion con il singolo I Will Come Back, Giorgio<br />
Moroder (Wait And See), i Depeche Mode (Hold<br />
My Breath) e tornando al presente la Kitsuné (Hold On è<br />
già apparsa in una compilation della maison francese).<br />
Crogiolarsi nel retrofuturismo può essere deleterio, ma<br />
per ora gli Holy Ghost! non hanno ancora saturato le<br />
aspettative. Buon proseguimento.<br />
(7/10)<br />
marco Braggion<br />
howe gelB - alegriaS (fire recordS, marzo<br />
2011)<br />
Ge n e r e: f o l k r o c k<br />
Ideato e pubblicato solo per il mercato spagnolo, questo<br />
Alegrias ha avuto lo scorso anno un successo tale<br />
da meritarsi oggi la distribuzione internazionale. E’ il<br />
caro vecchio Howe stregato dall’atmosfera di Cordoba,<br />
accompagnato da una band flamenca di ascendenze<br />
tzigane (i Band Of Gypsies) e prodotto nientemeno<br />
che da John Parish. Un pugno di tracce nuove ed il resto<br />
del programma (in tutto 13 pezzi) impegnato a rivisitare<br />
il repertorio con la flemma torbida e la malinconia<br />
stropicciata d’un mariachi stanco, ferma restando la<br />
dimensione gelbiana di cui ben sappiamo - amandole<br />
- le malie narcotizzate, la devozione spersa, le visioni<br />
sospese tra fervore e stramberia.<br />
Ebbene sì, ci ritroviamo pur sempre sprofondati nella<br />
stessa poltrona che da Hisser a The Listener passando<br />
da Confluence ci contiene e consola ricordandoci la<br />
struggente finitezza delle cose, il polverizzarsi dei sogni<br />
nel mortaio del disincanto. Messa quindi in conto<br />
una certa inerzia, o se preferite un’ombra di morbida<br />
autoindulgenza, va detto che stiamo parlando di un disco<br />
prezioso, perché in esso l’immaginario desertico di<br />
Gelb si coniuga d’Andalusia riverberando suggestioni<br />
latine meravigliosamente apolidi, come rumbe sciroppose<br />
tra miraggi bossanova, come fremiti gitani strattonati<br />
country-rock.<br />
Particolarmente riuscite le riletture di Cowboy Boots on<br />
Cobble Stone (benedetta dalla chitarra virtuosa di Raimundo<br />
Amador), 4 Doors Maverick e Uneven Light of<br />
Day. Tra le canzoni di nuovo conio, notevole The Ballad<br />
of Lole y Manuel e la breve Lost Like a Boat Full of Rice<br />
con l’accorato rigurgito da pianista “felonious”.<br />
(7.1/10)<br />
Stefano Solventi<br />
human league (the) - credo (wall of<br />
Sound, marzo 2011)<br />
Ge n e r e: s y n t h p o p<br />
L‘ultimo disco della lega umana risale al 2001. E anche<br />
se siamo in pieno revival anni Ottanta (vedi i ritorni di<br />
Orchestral Manoeuvres In The Dark, Duran Duran<br />
e dell‘iconografia di quel decennio nel glo), di dischi<br />
che rifanno solo il passato non se ne sente proprio il<br />
bisogno. All’inizio degli anni zero aveva infatti un certo<br />
senso estetico/politico riportare in primo piano quelle<br />
sonorità synth-based; oggi invece i riciclati entrano nel<br />
meccanismo di vendita e cercano di arraffare (senza alcuna<br />
velleità estetica) fino all’ultimo quattrino, sia dal<br />
pubblico che li adorava trent’anni fa che dalle nuove<br />
leve che assistono stupite ad epifanie impolverate.<br />
Anticipato dal singolo Night People, che ricorda i Depeche<br />
Mode più marziali ed elettronici (periodo Some<br />
Great Reward per intenderci), l‘album è una carrellata di<br />
ricordi pop che Philip Oakey tenta di ringiovanire con<br />
qualche effetto speciale e con l‘aiuto delle sempreverdi<br />
vocals di Susan Ann Sulley e Joanne Catherall.<br />
Il risultato è un memorabilia che non coinvolge, passando<br />
dal synth pop più squadrato e prevedibile (Sky),<br />
al vocoderismo attualizzato now, che però stride con<br />
le tastiere di vent‘anni fa (lo spettro di Cher incombe in<br />
modo imbarazzante sul secondo singolo Never Let Me<br />
Go). Le tensioni da club-dark (Egomaniac, Single Maniac)<br />
e le progressioni à la Moroder (nell‘onesto Electric<br />
Shock) e gli occhiolini al synth pop più glitterato che<br />
mai completano un quadretto da dimenticare.<br />
Fra dieci anni probabilmente uscirà un altro disco degli<br />
HL. Speriamo che nel frattempo si siano stancati di<br />
riproporre le loro fotografie di gioventù, magari considerando<br />
l‘idea di prendere qualche strada nuova, o in<br />
alternativa di ritirarsi a godere di una meritata pensione.<br />
(4/10)<br />
marco Braggion<br />
ignaz Schick/dawid SzczeSny - live in<br />
geneva (zarek, marzo 2011)<br />
Ge n e r e: e l e t t r o a c u s t i c a<br />
Non è la prima volta che i nomi di Ignaz Schick e Dawid<br />
Szczesny si compongono per una pubblicazione<br />
a duo. Successe già con The View Underneath, uscito<br />
per la Non Visual Objects tre anni fa. E anche Live In<br />
Geneva vive dello stesso contrasto tra l‘attitudine ai<br />
suoni/rumori forniti dagli oggetti di Schick, oltranzista<br />
dell‘analogico, e i droni elettronici di Szczesny.<br />
Di fatto, il concerto cui si allude nel titolo non è così<br />
recente da giustificare una sostanziale evoluzione da<br />
quella prima esperienza: testimonia infatti una performance<br />
congiunta del novembre di tre anni fa, avvenuta<br />
appunto a Ginevra, al Cave 12/L’Ecurie. Per di più, al<br />
risultato del live non è stato applicato nessun lavoro di<br />
afterediting. Non ci sono overdubs o tagli; quello che<br />
sentiamo è l‘intero act del duo tedesco/polacco. Eppure<br />
tra Ignaz e Dawid si sente una capacità notevole di<br />
creare con la propria musica lo spazio per quella altrui.<br />
Nei cinque movimenti, l‘elettronica sibila e lascia che il<br />
protagonismo degli oggetti salga (Movement 2), il drone<br />
cerca armonie sostenendosi ai rumori ritmici (Movement<br />
3), il computer allestisce l‘arena cosmica per i<br />
timbri più perforanti (Movement 4).<br />
In realtà Schick è sempre di più un nodo nella rete elet-<br />
76 77
troacustica tedesca, fatto documentato dalla curatela<br />
del Echtzeitmusik Festival 2010. Dove “Echtzeitmusik”<br />
vuol dire real time music, e dunque impro. Ma è la collaborazione,<br />
la co-progettazione, la messa in sintonia<br />
tra i compositori (o improvvisatori) come fossero strumenti<br />
di una meta-composizione a diventare sempre<br />
più la chiave della scena, in Italia come negli angoli di<br />
Kreuzberg. È il metodo odierno di declinazione dell‘eccellenza.<br />
(7.2/10)<br />
gaSPare caliri<br />
inSane warrior (the) - we are the<br />
doorwayS (rj’S electrical connectionS,<br />
marzo 2011)<br />
Ge n e r e: e l e c t r o -f u n k-fic tion<br />
Accantonati per un momento i territori indie-hop del<br />
recente The Colossus, il produttore-musicista dell’Ohio<br />
Rjd2 cambia pelle, e con il moniker The Insane Warrior<br />
mette in scena We Are The Doorways, dieci brani<br />
electro-psych-funk interamente strumentali, ispirati<br />
dalla passione per i film horror-sci-fi in salsa ‘70s. In<br />
pratica?<br />
In pratica il lavoro si muove tra avanzi di new jazz, soprattutto<br />
nel campionario di basi breakbeat-downtempo<br />
che ricordano le produzioni Tru-toughts da Stonephace<br />
ai Belleruche, e synth funkeggianti che spesso<br />
citano i Goblin e odorano di moog, minimoog e vocoder.<br />
Ecco allora, e tra i momenti migliori, il lounge-funk<br />
ispirato di The Water Wheel, oppure Then You Hear A Footstep,<br />
duetto di trombe e tastiere sugli unici barlumi<br />
hip-hop del lotto, e ancora il synth-spacing frenetico di<br />
Whitin The Maze per finire conla ninna nanna tintinnante<br />
di Saint Ignatius Bellse.<br />
Ogni tanto, specie nella seconda metà dell’album, c’è<br />
spazio per qualche sbadiglio quando gli svolazzi psych<br />
esagerano fuori controllo (Trail Of Fire un esempio su<br />
tutti), ma nel complesso l’originalità della proposta di<br />
Rjd2 colpisce nel segno. Rimane un disco di nicchia che<br />
non interesserà a molti, e per certi versi sarà un peccato.<br />
(6.8/10)<br />
Stefano gaz<br />
iroha - iroha (denovali, aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: h e a v y -s h o e G a z e<br />
Muri di feedback, passo cadenzato e rallentato, cantato<br />
sovrastato dal suono degli strumenti, tastiere circolari,<br />
tutti gli stilemi dello shoegaze a cui va aggiunta un’evoluzione<br />
melodica post metal. Questo in sunto ciò che si<br />
può rintracciare nell‘esordio lungo degli Iroha, nuovo<br />
progetto di Andy Swan (Final) approntato con vecchie<br />
glorie del giro post-industrial inglese (Diarmuid Dalton<br />
dei Cable Regime e Dominic Crane già coi Rumblefish).<br />
Insomma, un mix sulla carta interessante di paesaggi<br />
ambientali tra il sogno ristoratore e l’incubo post-atomico,<br />
per molti versi affine alle ultime evoluzioni targate<br />
Justin K. Broadrick (Jesu su tutte) che, non a caso,<br />
nel secondo disco bonus si occupa di un personale mixaggio<br />
dell’intero album.<br />
Lasciando passare l‘utilità di questa ultima operazione,<br />
Iroha è un disco su cui si posano molte riserve. Quando<br />
il gioco ad incastro tra rudi pesantezze da slowness<br />
pos-industriale e celestiali aperture quasi-dreaming<br />
funziona, il risultato è sicuramente coinvolgente come<br />
in Last Day Of Summer, Watercolours o Reminisce, lontane<br />
dall‘essere originali. Molto più spesso però è un<br />
retrogusto troppo evidente di deja-vu che non lascia<br />
mai il segno fino in fondo e si unisce alla sensazione,<br />
nemmeno troppo sbagliata, di ascoltare sempre lo<br />
stesso pezzo.<br />
(6/10)<br />
franceSco aSti<br />
jaruzelSki’S dream - jazz gawronSki<br />
(clean feed, marzo 2011)<br />
Ge n e r e: a v a n t -j a z z<br />
L‘immaginario iconografico di per sé dovrebbe bastare<br />
a rimandare ad una dimensione ludica e a un approccio<br />
non serioso alla materia del jazz. Moniker, titolo dell‘album<br />
e dei 12 pezzi che compongono Jazz Gawronski<br />
sono calembour linguistici tra il surreale e il pastiche<br />
disseminati dal terzetto italiano per suggerire finalità<br />
e attitudine.<br />
Non a caso composto da membri provenienti dai poli<br />
attrattivi più interessanti del (neo)jazz italiano - El Gallo<br />
Rojo e Improvvisatore Involontario - il progetto Jaruzelski’s<br />
Dream è l’esatta somma dei singoli elementi<br />
in gioco: una vulcanica eruzione di follia strumentale,<br />
giocosa attitudine demistificatoria, irregolarità avventurose<br />
e, paradossalmente, coesione interna rese con<br />
leggerezza e (auto)ironia.<br />
Piero Bittolo Bon (sax alto, smartphone) e Stefano Senni<br />
(contrabbasso), entrambi da El Gallo Rojo, insieme<br />
al batterista extraordinaire Francesco Cusa (colonna<br />
portante di Improvvisatore Involontario) inanellano discorsi<br />
di jazz free-form in modalità first take attraversati<br />
da un senso del groove profondo e irresistibile: ritmico<br />
e forsennato, silente e sussurrato, l‘avant-jazz inteso dai<br />
tre è pari alla attitudine iconoclasta e altamente ironica<br />
che li porta a firmare pezzi con titoli come The Mastel-<br />
highlight<br />
kode9/SPaceaPe - Black Sun (hyPerduB recordS, aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: d u b s t e p h o u s e<br />
Il secondo album di Kode9 e Spaceape arriva a cinque anni dall’esordio Memories of the Future<br />
(7.2/10), titolo che più afrofuturista di così si muore e lavoro pre-Untrue che infatti proponeva una visione<br />
dubstep ancora lontana dall’esplosione e - tutto sommato - dalla conseguente<br />
ortodossia Burialiana. Più che dubstep infatti, Memories era propriamente<br />
un dub minimalista e siderale, privo del rullante anticipato così<br />
caratterizzante per il genere. C’era lo spokenragga ipnotico di Spaceape, si<br />
sentivano forti le eredità downtempo, trip hop e - soprattutto - della miscela<br />
noir del primissimo The Bug. Atmosfere notturne e claustrofobiche,<br />
ma anche un suono “intellettuale”, stilizzato, profondo e cremoso, che ne<br />
faceva un disco in qualche modo da sottofondo (9 Samurai a parte).Kode9<br />
ha prodotto poco da allora, ma si è mosso tantissimo all’interno della scena<br />
(basti guardare alla “riforma” del catalogo Hyperdub degli ultimi due anni e alle relazioni intrecciate con<br />
la Brainfeeder lotusiana), tanto che era lecito aspettarsi un disco anche molto attento ai fermenti now<br />
e - passateci il termine osceno - sperimentale. E invece Kode sorprende con un album che continua in<br />
coerenza il suo discorso, iniettando nella miscela originale una bella dose di energetiche suggestioni<br />
tech-house (le stesse attorno a cui ruotava il Dj Kicks uscito a metà 2010), irrobustendo la ritmica e i<br />
cantati, ora più fisici, in un tripudio di synth, controtastierine laser e mini breakbeat (sarà interessante<br />
confrontarlo con l’imminente Africa Hitech). Ne viene fuori un lavoro che, pur elegante e incapace di<br />
nascondere certi tratti anche cerebrali (nelle stilizzate figure break, nelle stratificazioni delle trame tastieristiche),<br />
vuole soprattutto far muovere il sedere in pista.Tolti un intermezzo a base di accordi liquidi<br />
di tastiere fusion (Hole in the SKy, fascinoso ma che andava sviluppato), un semplice esercizio di ritmi<br />
spezzati su tappeto synth (Otherman) e la delusione totale del feat con Flying Lotus (un nulla ambient/<br />
noise-cameristico che mette assieme tastiere da chiesa e crepitii da falò; è la traccia conclusiva), il resto<br />
è tutto materiale di altissima qualità. I tribalismi poliritmici di Black Smoke e Bullet Against Bone, la sospesione<br />
pulsante di Promises, l’assalto street di Am I; ma, soprattutto, il trittico con i feat della vocalist<br />
Cha Cha: la cavalcata deephouse in odor di Cooly G Love Is the Drug (primo singolo), la rarefazione<br />
house tagliata secca da rullante e inserti di tastiere che si muovono come archi sinistri Neon Red Sign,<br />
l’assalto funkysoul trasfigurato street di The Cure. E l’anthemico dittico oldskool tech-house (“potete<br />
sentirlo?”) Black Sun (remix della bomba sganciata nel 2009)/Green Sun (il pezzo migliore del lotto?).<br />
Un secondo lavoro che rifugge il sensazionalismo sonoro e cerca una via personale per mettere assieme,<br />
con stile, testa, atmosfera e dancefloor.<br />
(7.4/10)<br />
gaBriele marino<br />
la Variations, Zibibboniek, The Amazing Kaczinski Twins,<br />
Soulidarnosc.<br />
Vere e proprie gioie per chi ascolta e l‘ennesima dimostrazione<br />
dell‘effervescenza del jazz informale e atipico<br />
che gira da tempo in Italia.<br />
(7.2/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
jim joneS revue (the) - Burning your<br />
houSe down (PiaS, feBBraio 2011)<br />
Ge n e r e: r’n’r<br />
Se nell‘ultima manifestazione sonora (Here To Save<br />
Your Soul - Singles Volume One del 2009) i cinque<br />
Jim Jones Revue garantivano la musica adatta a<br />
smuovere “any house party till the roof falls in”, ora col<br />
comeback vero e proprio la casa la vogliono proprio<br />
dare alle fiamme.<br />
Il bello è che non mentono affatto, a giudicare dal-<br />
78 79
la cover e dall‘alto tasso di pura energia incendiaria<br />
messo in scena.<br />
Il comeback del quintetto capitanato dall‘ex Thee Hypnotics<br />
Jim Jones è un vero e proprio cataclisma che<br />
prende il rock‘n‘roll dei primordi, quello vergato a sangue<br />
dal ribellismo alla Jerry Lee Lewis e dall‘anticonformismo<br />
del secondo Elvis, e lo rovescia dal di dentro.<br />
Chitarre selvagge e un piano posseduto dallo spirito<br />
iconoclasta del killer della Louisiana, accendono la luce<br />
nell‘opener Dishonest John per spegnerla una mezzora<br />
dopo con Stop The People.<br />
In mezzo un florilegio di melodie urlate dalla voce graffiante<br />
del frontman, stomp-rock assassino, riff rubati di<br />
peso al blues del delta e riletti ora in chiave rock, ora<br />
hard, batteria che è un carrarmato e basso-caterpillar<br />
a serrare le fila di un suono che rinverdisce i fasti dei<br />
reietti del garage-rock. Da quelli passati a miglior vita,<br />
Sonics e MC5 su tutti, a quelli che invece hanno fatto<br />
del rock uno stile di vita, vedi alla voce Jon Spencer.<br />
A predominare, in Burning Your House Down, è sempre<br />
la musica del diavolo, ma da un demone del rock come<br />
Jim Jones cos‘altro ci si poteva aspettare?<br />
(6.8/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
julia Stone - the memory machine (PiaS,<br />
aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: 60’s f o l k-p o p<br />
Figlia di musicisti, Julia Stone si è ritagliata con il fratello<br />
Angus un piccolo spazio dalle nostre parti tramite<br />
Big Jet Plane, brano che - estrapolato dal loro secondo<br />
lp Down The Way - ha chissà come goduto di una<br />
certa esposizione radiofonica. Additando il nome a<br />
Giorgio Armani, che del duo sceglieva un altro pezzo<br />
per accompagnare le sue sfilate. Al di là del gossip, la<br />
sostanza restituiva un passabile folk-pop che avrebbe<br />
rimandato l‘ascolto di questo album solista di Julia.<br />
Talento invece più che discreto, la ragazza porge una<br />
manciata di confetti mai melensi con modi da signorina<br />
per bene, con una voce da bambola di porcellana<br />
su fondali di batterie spazzolate e chitarre acustiche, di<br />
pianoforti leggeri e archi svolazzanti.<br />
Fa pensare a una Hope Sandoval che preferisce Claudine<br />
Longet ai Velvet Underground e alla psichedelia<br />
(This Love, la title-track). Altrimenti una Isobel Campbell<br />
rimasta nei Belle & Sebastian e refrattaria alle<br />
avance di Lanegan la frizzante Catastrophe!). Ancora,<br />
una Joanna Newsome metropolitana e pertanto priva<br />
di tentazioni classicheggianti (una Winter Weekend<br />
a metà strada tra Where The Wild Roses Grow e Famous<br />
Blue Raincoat; il notturno incanto jazzato Lights Inside<br />
This Dream; il minuetto Where Does The Love Go?). Arrangiato<br />
con misurata eleganza e forte del traslucido<br />
apice Maybe, The Memory Machine non sfigura vicino<br />
all‘esordio di Anna Calvi e al nuovo capolavoro di P.J.<br />
Harvey. Conquista senza strafare, come una studentessa<br />
straniera - colta, bella, un poco timida - incontrata<br />
per caso a una festa movimentata.<br />
(7.1/10)<br />
giancarlo turra<br />
kilimanjaro darkjazz enSemBle - from<br />
the Stairwell (denovali, aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: cinematic<br />
L’idea che sta alla base dei Kilimanjaro Darkjazz Ensemble<br />
è tutta fuorchè originale. Il collettivo di polistrumentisti<br />
europei (ma di stanza in Olanda) nasce,<br />
infatti, col preciso intento di realizzare colonne sonore<br />
per film mai realizzati, mettendo dalla loro una potente<br />
forza evocativa e una notevole varietà strumentale in<br />
grado di far apparire agli occhi dell’ascoltatore immagini<br />
in movimento. Non è casuale che i due fondatori<br />
Jason Köhnen e Gideon Kiers abbiamo musicato, reinterpretandoli,<br />
capisaldi del cinema muto come il Nosferatu<br />
di Murnau o Metropolis di Lang.<br />
Il loro è un linguaggio fatto di jazz, trip hop, ambient,<br />
post-rock, meno elettronico e più umanizzato rispetto<br />
agli esordi, capace di descrivere scene fortemente<br />
caratterizzate da tinte noir e atmosfere fumose e impalpabili.<br />
Un clima soffuso che, però, crea anche una<br />
sfuggevolezza della musica: non riesce, in definitiva, a<br />
lasciare il segno ma tende a svanire allorché cessano le<br />
immagini da essa evocate. From The Stairwell è un lavoro<br />
compatto e monocromatico, ricco di dettagli che riescono<br />
ad accrescere la qualità dell’ascolto e non farlo<br />
cadere nella mediocrità. Purtroppo però non sufficienti<br />
di per sé a farlo spiccare molto al di sopra.<br />
(6.5/10)<br />
franceSco aSti<br />
killS (the) - Blood PreSSureS (domino,<br />
aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: w a v e p o p<br />
Un bel sospiro e via, avanti col nuovo The Kills. Il quarto<br />
in otto anni, giuro che non ci avrei scommesso. Invece,<br />
rieccoli più civettuoli che mai malgrado s’impegnino<br />
a fare i maudit con la solita imperterrita disperazione.<br />
L’immagine ha poteri cosmetici pressoché illimitati,<br />
ci vuole poco a sembrare figliocci del lato selvaggio<br />
del marciapiede. Il suono invece no, è roba che svela.<br />
Perciò ci son sempre parsi quella fuffa che anche questo<br />
Blood Pressure conferma all’ennesima potenza,<br />
il deprecabile anello di congiunzione tra Royal Trux e<br />
Roxette, la patina new wave spalmata a dissimulare il<br />
piglio piacione.<br />
Ma è un giochino fin troppo scoperto, è tutta una strategia<br />
pop di rinterzo: cos’altro ti dicono la brama costante<br />
di espedienti adesivi, tutti quei trilli acuminati, la<br />
chirurgia di effetti (tremolo, phaser, flanger...), l’intrigo<br />
pervicace dei corettini... Materiale di riporto sulla scorta<br />
del cool d’inizio millennio azzeccato da White Stripes<br />
e Yeah Yeah Yeahs, saltando a pié pari la fase dell’immediatezza<br />
(che tanto si esaurisce subito, come nei casi<br />
sopraccitati). Canzoni che ti solleticano senza neanche<br />
prendersi la briga di disturbare, blues liofilizzati a pulsare<br />
tra marcette acidule, fregole post punk e ghigni<br />
glam(our).<br />
Un autentico carosello dell’insulsaggine di cui VV e Hotel<br />
si stanno rivelando maestri: è giusto rendergliene<br />
merito.<br />
(5/10)<br />
Stefano Solventi<br />
kurt vile - Smoke ring for my halo<br />
(matador, marzo 2011)<br />
Ge n e r e: fo l k<br />
A due anni dall’ultimo Childish Prodigy si riaffaccia sulle<br />
scene Kurt Vile. Smoke Ring For My Halo non cambia<br />
rotta rispetto ai precedenti lavori dell’ex War On Drugs,<br />
ma ne fa nuovamente risaltare le doti creative.<br />
Anche questa volta ci ritroviamo così a tirare in ballo<br />
nomi di paragone piuttosto distanti da quel folk che<br />
pure rimane struttura portante per le sperimentazioni<br />
del nostro: la melodia limpida di Baby’s Arms, ad esempio,<br />
appoggiata su un seducente amalgama di chitarra<br />
acustica, elettronica e psichedelia, giustifica la partecipazione<br />
al prossimo ATP gestito dagli Animal Collective;<br />
mentre On Tour, andatura sommessa ma decisa, è<br />
un numero degno dei vari Go-Betweens e Mojave 3.<br />
Ma ancora di più è opportuno spendere parole su Society<br />
Is My Friend, brano di punta del lavoro intero: da<br />
un lato l’innegabile riconciliazione con l’americana più<br />
epica, dall’altro un connubio di chitarre e synth che crea<br />
veri e propri paradossi temporali, come ad esempio dei<br />
New Order altezza Get Ready coverizzati con enfasi da<br />
stadio dal Bruce Springsteen degli anni 80.<br />
Il resto della tracklist non è altrettanto imprescindibile<br />
ma rimane mediamente gradevole, oltre che più<br />
orecchiabile di quanto potrebbe pensare il neofita. Per<br />
quanto particolare, lo stile di Kurt non rinnega infatti la<br />
melodia ma anzi fa da insolita cornice per quest’ultima.<br />
Il vero contrasto, casomai, è quello tra la cura per gli arrangiamenti<br />
e un songwriting che, per quanto ancora<br />
discreto, sembra aver perso qualche colpo nel corso degli<br />
anni: un difetto che non compromette più di tanto il<br />
disco, ma impedisce di classificare il nostro come autore<br />
di prima grandezza.<br />
(6.7/10)<br />
Simone madrau<br />
london Sinfonietta/micachu & the ShaPeS<br />
- choPPed & Screwed (rough trade, marzo<br />
2011)<br />
Ge n e r e: a c u t e p o p<br />
Arduo per Micachu & The Shapes stupire, dopo questa<br />
collaborazione con l‘ensemble orchestrale London<br />
Sinfonietta. Registrata dal vivo nel maggio londinese di<br />
due stagioni or sono, ispirandosi - chiaro in ciò il titolo<br />
- alla tecnica del chopping and screwing dell‘hip-hop texano<br />
dei Novanta, che consisteva nel dimezzare il tempo<br />
di battuta fino a ottenere un senso di stordimento e<br />
ottundimento. Logico, pensando a un DJ Screw che la<br />
metteva a punto in quel di Houston grazie alla passione<br />
per uno sciroppo contro la tosse che rallenta la percezione<br />
della realtà da parte dei neuroni.<br />
Se a premesse tra loro diverse quanto polo ed equatore<br />
aggiungete gli strumenti auto-costruiti dal trio Mica<br />
Levi/Mark Pell/Raisa Khan per fare tabula rasa in fase<br />
compositiva, il quadro non vi sarà chiaro ed eccolo, il<br />
pregio del lavoro tutto. Una imprevedibilità al riparo<br />
da superbia e approssimazione, ottenuta imponendosi<br />
mezz‘ora di sagace e oppiacea revisione dello stile “onice<br />
e assenzio” appartenuto alla 4AD più aurea. Indovinati<br />
goth-pop cameristici come Not So Sure e Everything<br />
fanno infatti pensare ai This Mortal Coil mai esistiti,<br />
strafatti di codeina e dotati di perverso umorismo.<br />
A seduttori seduti comodamente su una ragnatela d‘archi<br />
e percussioni che al primo ascolto inquieta e, nel<br />
giro di pochi passaggi, avvince come edera (l‘ambient<br />
subacquea Medicine Drank; le movenze scivolose di Unlucky)<br />
anche quando cerca d‘intimorire (Low Dogg: una<br />
Siouxsie alle erbe?). Ragioni d‘essere di un‘opera acuta,<br />
che scompone con un sorriso l‘autocompiacimento di<br />
troppa avanguardia.<br />
(7.2/10)<br />
giancarlo turra<br />
loveS (the) - ...love you (fortuna PoP!,<br />
marzo 2011)<br />
Ge n e r e: indie-p o p<br />
Introdotto da una copertina sinceramente tra le più<br />
brutte circolate negli ultimi anni, l‘epitaffio targato The<br />
Loves è in realtà un godibilissimo disco di indie-pop<br />
meets 60s per il terzo millennio. Il marchio Fortuna Pop!<br />
80 81
aiuta a fissare coordinate e riferimenti generici - tweepop<br />
rumoroso ed eterogeneo come da catalogo - ma il<br />
collettivo inglese ruotante intorno a Simon Love va di<br />
eclettismo poppy come di rado capita.<br />
Tanto che i non meglio precisati musicisti presenti alla<br />
registrazione di questo commiato discografico trasformano<br />
Love You in una summa definitiva del proprio<br />
sentire musicale e un perfetto omaggio ai fan prima<br />
della dipartita ufficiale.<br />
Twee-pop twangy (I Want Love & Affection (Not The<br />
House Of Correction)), garage-bubblegum-pop citazionista<br />
(Bubblegum), blues‘n‘roll velvettiano (King Kong<br />
Blues), il brit-pop spocchioso e liverpooliano (WTF? (Or<br />
How I Realised I‘d Wasted My Life)) clangori spectoriani,<br />
slanci beat e aperture al fifties sound (gli intrecci vocali<br />
di December Boy), offrono una visuale caleidoscopica e<br />
onnivora di una band indubbiamente minore ma non<br />
per questo da dimenticare. Specie in queste giornate<br />
d‘inizio primavera, il sound fresco dei The Loves ha il<br />
suo fascino.<br />
(6.2/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
low - c’mon (SuB PoP, aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: s l o w r o c k<br />
Mai i Low avevano fatto passare quattro anni tra un<br />
album e l’altro, perciò era lecito aspettarsi una discontinuità<br />
di qualche tipo. In effetti, C’mon interrompe<br />
l’espansione prima rockista e quindi pop perseguita<br />
dai precedenti due lavori, recuperando in gran parte<br />
l’antico idioma messo a punto e consolidato nel 2002<br />
con Trust (non a caso si sono recati nello stesso studio<br />
d’incisione, una chiesa sconsacrata conosciuta come<br />
Sacred Heart Studio). Nonostante ciò, riesce a non<br />
sembrare un’operazione nostalgia mirata a compiacere<br />
i fan più stagionati (anche se in parte, ovviamente, lo<br />
è), ottenendo una sorta di status neutro, atemporale.<br />
Quel che affiora nelle dieci nuove tracce è infatti una<br />
nervatura, una pulsazione, un mood che potremmo<br />
definire classico o - se preferite - tradizionale. Una vena<br />
folk-rock di stampo seventies, qualcosa di riconducibile<br />
al lirismo CSN&Y, alla mistica inafferrabile Gram<br />
Parsons o ai Fairport Convention invaghiti d’America.<br />
Una vena che a ben vedere pulsa fin dagli esordi, anche<br />
quando era meno facile avvertirla, sepolta sotto il<br />
tumulto brumoso anni Novanta. In un certo senso, questo<br />
disco chiarisce come i Low siano sempre stati una<br />
band Americana dalla calligrafia intensificata, distorta<br />
e trasfigurata nel/dal caos contemporaneo. Ripensi alle<br />
loro tipiche ballate, liturgie dalla estenuante incandescenza,<br />
per scoprirle perfettamente inserite nel lungo<br />
solco espressivo di chi da generazioni esplora frontiere<br />
emotive, civili e spirituali.<br />
Oggi come e più di ieri: la reiterazione minimale e ossessiva<br />
di Nothing But Heart, il valzer incantato di You<br />
See Everything, la processione onirica di Majesty/Magic,<br />
l’incedere accorato di Witches e la trepidazione assieme<br />
carnale ed eterea di Especially Me sono forse i momenti<br />
migliori di una scaletta più fresca, ispirata e attuale di<br />
quanto potessimo oggettivamente attenderci.<br />
(7.2/10)<br />
Stefano Solventi<br />
luciano maggiore/franceSco “fuzz”<br />
BraSini - chàSm achanèS (Boring<br />
machineS, marzo 2011)<br />
Ge n e r e: d r o n e s<br />
Nell‘ostico panorama droning nazionale e internazionale<br />
si è assistito negli ultimi anni ad una fioritura di<br />
esperimenti e progetti, più o meno intelligibili e tollerabili,<br />
da far sembrare naturale parlare di textures,<br />
droning, elettroacustica e feedback anche in circuiti<br />
meno carbonari di quelli di solito appartenenti a certe<br />
manifestazioni sonore. Non è il caso di Chàsm Achanès,<br />
punto d‘incontro tra due sperimentatori dell‘area bolognese<br />
(quella che si muove tra il Raum e Sant‘Andreadegliamplificatori)<br />
che prende a prestito il titolo<br />
da Parmenide per evidenziare il pozzo senza fondo di<br />
devastante e struggente forza.<br />
Luciano Maggiore e Francesco “fuzz” Brasini, in collaborazione<br />
col tecnico del suono Mattia Dallara, architettano<br />
un lavoro ostico e dall‘alto tasso creativo: un unico<br />
take da 35 e passa minuti, registrato in presa diretta<br />
all‘Officina 49, che difficilmente supererà la soglia dei<br />
più devoti ascoltatori di musica sperimentale.<br />
Ed è un peccato perché gli echi tombali e i riverberi<br />
spettrali dell‘installazione sonoro-architettonica dei<br />
due (chitarre elettriche per Brasini, nastri e dispositivi<br />
elettronici per Maggiore, Dallara a supervisionare l‘ambiente<br />
acustico) si distribuiscono nei fondali oscuri di<br />
drone magmatici e ambientazioni fantasmatiche, con<br />
un ciclico procedere che porta da subito l‘ascoltatore<br />
all‘abbandono al flusso e alla trascendenza. Un ininterrotto<br />
fluire per accumulazione e circolarità che, pur nella<br />
estrema pulizia della produzione, lascia il rammarico<br />
per non aver assistito alla sonorizzazione live. Lasciarsi<br />
avvolgere dalle volute di drones ascendenti sarebbe<br />
stata una esperienza non da poco.<br />
(7.3/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
highlight<br />
mariPoSa - Semmai SemiPlay (trovaroBato, marzo 2011)<br />
Ge n e r e: w a v e p r o G p o p<br />
I Mariposa portano ancora più avanti il discorso avviato con l’omonimo di due anni orsono e finiscono<br />
col rigirare se stessi come calzini, scoprendo il lato reversibile di colori più sgargianti ma ugualmente<br />
insidiosi, distopici, storti. Questo Semmai Semiplay potrebbe passare legittimamente<br />
per il loro definitivo coming out pop, ma in ogni canzone si<br />
nasconde un virus, le melodie sono accattivanti ma infingarde come le alghe<br />
di Wanna Marchi, come un sorriso di Jesus Quintana, come una favola<br />
di Terry Gilliam.Il suono è scoppiettante ma acido, pesca in un immaginario<br />
deliziosamente affollato di retaggi sixties (il beat para-battistiano trasfigurato<br />
glitch di Santa Gina, la filastrocca barocca sbilanciata Canterbury di<br />
Ma solo un lago) così come di wave guizzante e ipercromatica (il synth-rock<br />
radente di Tre Mosse, gli Stranglers fumettistici di Chambre, i Talking Heads<br />
giulivi di Paesaggio indoor).<br />
Tastiere, chitarre, flauti, percussioni, archi: la stratificazione sonora non cede di un millimetro, esaltandosi<br />
in un rinnovato equilibrio tra estro, preziosismi ed asciutta efficacia. E quanto siano bravi a spremere<br />
malsana incongruenza tra il canto pseudo-serafico di Fiori, i testi (ibridati alla bisogna con frasari<br />
inglesi e francesi) e la musica neanche stiamo a ribadirlo: vedi il disimpegnarsi grottesco di Pterodattili<br />
(frullato di Battisti panelliano e Dalla allucinato con guarnizione post-moderna Flaming Lips), la sordidezza<br />
etno-cinematica di Black Baby Hallucination (i Calibro 35 strattonati Pretty Things?), la squinternata<br />
esuberanza di Con grande stile (battente fregola folk-psych) e l’ineffabile trepidazione di Come<br />
un cane (Bruno Lauzi in un soffice sudario electro-folk).<br />
E’ un disco divertente nel senso che ti sbalza dalla consuetudine, ti spettina le coordinate, ti regala dubbi<br />
e pruriti mentali. E’ un disco straordinario.<br />
(7.6/10)<br />
Stefano Solventi<br />
lykke li - wounded rhymeS (ll recordingS,<br />
marzo 2011)<br />
Ge n e r e: po p<br />
Meno suggestioni nordiche nella seconda prova<br />
Wounded Rhymes: una scelta decisa per Lykke Li,<br />
che dopo essersi fatta notare con l’esordio di un paio di<br />
anni fa, Youth Novels, ha scelto per queste nuove registrazioni<br />
di muoversi dalla sua Svezia verso la più calda<br />
Los Angeles. A uno sguardo sommario gli esiti dicono,<br />
se non di un’atmosfera più solare, quantomeno di un<br />
pop ora liberato dal suffisso ‘indie’, di un’opera meno<br />
sommessa in cui la nostra lascia briglia sciolta alla propria<br />
voce e tenta approcci più diretti, urlati, aggressivi.<br />
Partendo da ciò che già sapevamo ecco che l’interazione<br />
tra voce e percussioni, quasi un leit-motiv del<br />
precedente lavoro, si fa più imponente: il beat sopravvive<br />
solo in un episodio comunque brillante quale è I<br />
Follow Rivers, ma il resto sacrifica l’elettronica in favore<br />
di ritmiche suonate. Una partenza come Youth Knows<br />
No Pain sarebbe già indicativa ma nel merito a primeggiare<br />
è sicuramente Get Some, dirompente singolo che<br />
non è sfuggito all’attenzione e alle conseguenti cure di<br />
un remixer di lusso come Beck. Dopodichè la nostra<br />
sceglie di prendersi ulteriori libertà e, con l’aiuto alla<br />
console del Bjorn di Peter Bjorn And John, arricchisce<br />
il disco di sfumature inedite: si ascolti la I Know Pain che<br />
sembra ballad acustica come tante e all’ultimo minuto<br />
lascia posto a una coda dream-pop che semplifica<br />
gli Slowdive più ambientali, o la Unrequited Love che<br />
ipotizza le CocoRosie in salsa gospel; la Rich Kids Blues<br />
che tenta la via di un’epica wave da Horrors ripuliti, o<br />
la Love Out Of Lust che nell’omaggiare quasi plagia Atmosphere<br />
dei Joy Division.<br />
L’idea è quella di un album ad ampio respiro, sospeso<br />
tra echi 80, mainstream ‘intelligente’, (chill)wave e tutta<br />
una serie di riferimenti entro cui la voce della nostra<br />
dovrebbe fare da collante. In questo senso il gioco funziona:<br />
l’ispirazione non sembra costante e si oscilla tra<br />
82 83
alti e bassi ma il disco ha una sua compattezza nonchè<br />
una gradevolezza sufficiente a farsi riascoltare. Semplicemente<br />
manca ancora a Lykke Li una presa netta<br />
di posizione, quel ‘capire cosa vuoi fare da grande’ che<br />
crea lo scarto tra un’artista riconoscibile e possibilmente<br />
influente e una voce nel coro che tra le influenze<br />
altrui si crogiola. Così, anche se quella formula pop a<br />
360° varrebbe sulla carta il confronto con i primi dischi<br />
di Bjork, la personalità per affrontare certi testa a testa<br />
latita ancora: e i termini di paragone più verosimili per<br />
qualità rimangono ora come ora Bat For Lashes o Florence<br />
And The Machine.<br />
(6.7/10)<br />
Simone madrau<br />
marco carola - Play it loud! (minuS<br />
recordS, feBBraio 2011)<br />
Ge n e r e: t e c h h o u s e d e e p<br />
Il ritorno al disco dopo 8 anni vede il DJ napoletano alle<br />
prese con un tribalismo denso di bassi e con una techno<br />
che si scosta dalle sue produzioni più dritte di qualche<br />
tempo fa per incunearsi in una deep da suonare<br />
a volume altissimo. Avvolgente, pensato ovviamente<br />
per il club (magari ibizenco, dato che il nostro suona da<br />
anni nell‘isola, selezionando e mixando all‘Amnesia), il<br />
disco si presenta come un mix continuo e senza tante<br />
sbavature, come è ovvio che sia, dato che è stampato<br />
sulla minus di Richie Hawtin. Bassi da panico, camere<br />
blindatissime, ossessività condita con un savoir faire<br />
che in coda senti avere il DNA mediterraneo.<br />
Senza tagli nordici, il suono di Marco è una visione calda<br />
e pompante, mai barocca, un cono di luce strobo<br />
che non finisce di pompare casse, rullanti, shaker e tutte<br />
le altre diavolerie ritmiche obbligatorie per approdare<br />
in pista. Nessun vocalismo, se non per qualche cut<br />
qui e là: il monolite che ci offre il ragazzo è un prendere<br />
o lasciare. A dispetto di tutto quello che sta succedendo<br />
nell‘house, sempre più virata verso la coolness, qui<br />
si parla un dialetto antico, fatto di spostamenti lievissimi<br />
dal quattro, tagli trasversali applicati sulla pelle, tatuaggi<br />
indelebili per serate al fulmicotone che starebbero<br />
bene nei set di Plastikman, Loco Dice o Ricardo<br />
Villalobos, sezioni mutanti in loop definitivi.<br />
Con questa bombetta Carola mette in discussione tutto<br />
un mondo che si specchia su se stesso e torna a parlare<br />
di realness, cose che senti nei DJ set di Tania Vulcano,<br />
Onur Ozer e pochi altri intriganti nomi provenienti dalla<br />
comunità balearica. Deeppissimo nelle soluzioni, magmatico<br />
nello stile, senza equivoci di sorta sul risultato:<br />
una tavolozza spalmata sui denti e sulla pancia tutta<br />
da ballare, ovviamente col sorriso. Coniugare l‘anima<br />
squadrata della mitteleuropa con il sanguigno balearico<br />
non è da tutti. Marco ce la fa alla grande. Seguitelo<br />
e alzate il volume.<br />
(7.2/10)<br />
marco Braggion<br />
marta Sui tuBi - carne con gli occhi<br />
(venuS, marzo 2011)<br />
Ge n e r e: a r t f o l k r o c k<br />
Quarto album in otto anni, un processo di espansione<br />
nella continuità che coinvolge anche - di conseguenza?<br />
- l’organico, dal momento che l’ex-duo è oggi un<br />
quintetto, considerato l’ingresso in pianta stabile del<br />
violoncellista Mattia Boschi. Un acquisto che determina<br />
ulteriore ispessimento della trama, indirizzata verso<br />
una ricchezza carica di tensione, una gravità che pesca<br />
nell’imprinting del folk mediterraneo per poi andare ad<br />
incendiarsi rock (quella specie di grunge a spine staccate<br />
disposto a vampe e sfuriate psych). L’innesco è il<br />
solito, ovvero il concitato dinamismo che intercorre tra<br />
la chitarra ipercinetica di Carmelo ed il canto ventrale<br />
di Giovanni, quel loro fare disanima a sangue caldo<br />
dello stare al mondo, dell’essere pervicacemente umani<br />
tra i rapporti di forza tragicomici della società degli<br />
uomini.<br />
Virtuosismi complementari corroborati da un senso<br />
vivo della performance e un utilizzo delle liriche sempre<br />
in bilico tra la sagacia e la rivelazione. Le dodici tracce<br />
di questo Carne con gli occhi - prodotto dall’esperto<br />
Tommaso Colliva - non deludono, ribadendo l’ispirazione<br />
che ha sostenuto i lavori precedenti, prediligendo<br />
una più diffusa intensità alle tipiche scorribande genialoidi<br />
(che pure non mancano, vedi il cabaret psicotico<br />
di Camerieri ed il facinoroso carosello di Muratury). Sarà<br />
la maturità, sarà che hanno voglia di fare sul serio e di<br />
farsi prendere sul serio più di quanto non sia finora<br />
accaduto, probabilmente a causa di una calligrafia sì<br />
insolita, originale ed esuberante, ma a gioco lungo il<br />
laccio che ti fa cavalcare in cerchio.<br />
Gli echi folk-studio di Cromatica, l’enumerazione filosofeggiante<br />
di Di vino, l’art-folk animoso de Il traditore,<br />
l’impeto furibondo di Al guinzaglio e gli aromi palpitanti<br />
di Coincidenze sono gli episodi più riusciti di una<br />
scaletta che sembra voler allentare la cavezza. E magari<br />
- chissà - saltare il recinto.<br />
(7/10)<br />
Stefano Solventi<br />
matt and kim - SidewalkS (PiaS, novemBre<br />
2010)<br />
Ge n e r e: in d i e -po p<br />
E’ una brusca discesa quella imboccata dagli ultimi<br />
Matt And Kim. Un potenziale di produzione, di pulizia<br />
e ricerca del suono e in generale di ‘forma’ come quello<br />
dispiegato per questo Sidewalks (in regia c’è Ben Allen,<br />
già visto con P. Diddy, Gnarls Barkley e gli ultimi Animal<br />
Collective) suona come un vero spreco se paragonato<br />
all’assenza pressochè totale di brani un minimo<br />
rilevanti. Non solo: manca in toto anche quell’aspetto,<br />
così comune ai progetti indie-pop più leggeri, che consiste<br />
di ritornelli non memorabili ma memorizzabili:<br />
facilmente canticchiabili, insomma; e coinvolgenti, se<br />
non sulla lunga distanza, almeno nell’immediato.<br />
I Matt And Kim del terzo disco fanno venire in mente<br />
un improbabile supergruppo formato dai B52’s più<br />
caciaroni che prendono in voce un Joey Ramone e<br />
cercano di aggiornare la lezione del pop di allora. Peccato<br />
che quegli storici nomi avessero piena coscienza<br />
di cosa fosse una melodia, avendone scritte nella loro<br />
carriera di micidiali; e, se è vero che non si pretende<br />
di raggiungere gli stessi livelli, pure sembra lecito<br />
chiedere qualcosa di più al duo newyorchese. Perchè<br />
si può fare sicuramente meglio di una Good For Great,<br />
davvero insipida, o della stessa Northeast, ballata che<br />
vorrebbe proporsi come l’asso nella manica del disco e<br />
invece non regala sussulto alcuno. Quel poco di buono<br />
si trova in un’intro come Block After Block e in una chiusura<br />
discreta come Ice Melts. Il problema sta nel mezzo:<br />
non bastano i cori Ramones di AM / FM Sound, non basta<br />
la marcetta di Cameras, non basta qualche synth in<br />
più del solito e qualche accenno di hip hop a salvare<br />
l’ascoltatore dalla monotonia.<br />
(5/10)<br />
Simone madrau<br />
matthewdavid - outmind (Brainfeeder,<br />
aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: p s y c h a m b i e n t<br />
Matthew McQueen aka Matthewdavid, giovane pupillo<br />
Dublab/Brainfeeder (e fondatore dalla label Leaving<br />
Records), arriva al debutto su long dopo la solita trafila:<br />
talentscoutizzato da FlyLo, mini, collaborazioni, podcast.<br />
Undici frammenti brevi e una traccia conclusiva<br />
lunga quasi sette minuti che sono la migliore (perché<br />
peggiore) dimostrazione di come l’estetica lotusiana<br />
sia da maneggiare con la massima cautela.<br />
Qui è proprio tutta la stessa roba, una ambient a falde<br />
larghe sporcata a botte di laptop e glitch, un’orgia di<br />
stratificazioni polverose e sfrigolanti che si rigirano su<br />
stesse senza portare da nessuna parte, nebbie di voci<br />
lontane che si avviluppano attorno alle suggestioni<br />
now del glo (l’abbastanza superdrogata International).<br />
Quando c’è un ritmo che timido prende corpo è una<br />
via di mezzo tra un wonky diluito e scassato e altrettanto<br />
diluiti ed estemporanei breakbeat. Nel migliore dei<br />
casi non si va oltre l’epigonismo lotusiano (lo sfarfallare<br />
siderale di Like You Mean It; la nebulizzazione di un motivetto<br />
facile facile in Cucumber-Lime).<br />
Lo definiscono “post-psychedelic” e “sound collage artist”,<br />
ma a noi, ora come ora, per definirlo pare più calzante<br />
il termine incolore.<br />
(4.5/10)<br />
gaBriele marino<br />
mauve - the night all cricketS died (face<br />
like a frog, aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: indie n o i s e<br />
Tre anni dopo il buonissimo esordio lungo Kitchen<br />
Love, i Mauve da Verbania ci concedono il sophomore.<br />
Va detto subito che non delude questo The Night<br />
All Crickets Died, anzi conferma in pieno la grinta<br />
agile e intensa del loro indie rock, modellato a partire<br />
da spasmi wave, particelle shoegaze e turbe noise.<br />
Piace la disinvoltura con cui producono urgenza ad un<br />
tempo lieve e nervosa, capace di tumulto adrenalinico<br />
e rarefazioni fiabesche: Grasshopper In Your Hands<br />
ipotizza gli Interpol tra perturbazioni Primal Scream,<br />
Ludovico stempera subbuglio Arcade Fire e putiferio<br />
Sonic Youth, Decay ed Hang_Over - vuoi anche per la<br />
voce della batterista Elda Belfanti - giocano con palpiti<br />
e rarefazioni un po’ Scisma e un po’ Grimoon, Black<br />
Dogs è un frutto colto da qualche parte tra i Pixies più<br />
imbronciati ed i Verdena meno facinorosi.<br />
Canzoni che prediligono la ricercatezza all’impatto, ma<br />
che pure impattano con energia insidiosa, vedi le due<br />
parti di The Solitude Of The Ship, apertura e chiusura di<br />
programma dalle nuances psichedeliche e spacey. Un<br />
buon ritorno.<br />
(7/10)<br />
Stefano Solventi<br />
mazeS - a thouSand heyS (fat cat, aPrile<br />
2011)<br />
Ge n e r e: l o -f i p o p<br />
Un tuffo al cuore, non ci sarebbe neanche bisogno di<br />
aggiungere altro. Soprattutto se, come il sottoscritto,<br />
siete cresciuti studiando le traiettorie sbilenche dei Pavement<br />
come l‘abbecedario.<br />
Dei Mazes, peraltro, avevamo già parlato esattamente<br />
un anno fa, in occasione dello speciale sul DIY britanni-<br />
84 85
highlight<br />
mirrorS - lightS and offeringS (Skint, marzo 2011)<br />
Ge n e r e: s y n t h p o p<br />
Ehi, che succede? Che il pop britannico ne abbia avuto abbastanza di lasciarsi calpestare dall‘infame<br />
tacco colonizzatore dell‘indie yankee (o yankee-oriented, stile Mumford & Sons) e stia finalmente rialzando<br />
la testa? Cerchiamo un po‘ di capire come siamo arrivati a questo punto. Non che l‘output sia<br />
mai venuto meno: l‘industria in UK non ha mai subito la benché minima flessione, in barba alla crisi. È<br />
una questione di qualità: fatti salvi l‘hype pitchforkiano di band in stile xx o<br />
These New Puritans da un lato e la rivoluzione dubstep dall‘altro, sembra<br />
che negli ultimi due o tre anni Albione non sia stata in grado di tenere il<br />
passo, o meglio di regalare realtà genuinamente brit che potessero dar vita<br />
a una nuova stagione pop come si deve. Foals? Ma per piacere. White Lies?<br />
Sì, ma dipende dalla vostra età. E sinceramente, i barocchismi prog-oriented<br />
di Everything Everything o degli ultimi Klaxons sono roba un tantino<br />
spinta per essere considerati puramente pop. In sostanza, dopo gli Arctic<br />
Monkeys, niente. Quindi, che succede?<br />
Succede che a inizio 2011 ti escono a distanza ravvicinata un paio dischi<br />
che suonano come due sonori schiaffoni, brusco ma necessario risveglio dopo una stagione di - pur relativo<br />
- torpore pop. Detto che i Chapel Club di Palace sono una delle cose più belle accadute dai tempi<br />
di (riempite pure voi lo spazio), questi Mirrors da Brighton hanno chiaramente intenzione di riscrivere<br />
la storia del britpop anni ‘10 a suon di cari, vecchi synth. Come dite? Gli Hurts? No, un po‘ troppo mainstream.<br />
Piuttosto, l‘anno scorso non c‘erano stati quei Delphic che, benché più sbilanciati sul versante<br />
New Order, erano già sull‘ottima strada? Verissimo, peccato che ce ne siamo accorti giusto in quattro.<br />
Tempi forse non ancora maturi per capire che qualcosa si stava muovendo: perché sotto l‘assodato<br />
ammodernamento di sonorità eighties si muove tutta un‘onda fatta di grandi canzoni. Erano quelle a<br />
latitare, e quindi eccole finalmente emergere per annunciare la nuova alba del pop inglese. Beh, se si<br />
ha un debole per OMD (non a caso mentori del gruppo dai loro primi passi), gli Ultravox più romantici,<br />
i Depeche Mode di Speak & Spell (Searching In The Wilderness sembra proprio sfornata da Vince Clarke)<br />
e - ovvio! - Kraftwerk è certo più facile innamorarsi all‘istante di quattro ragazzi che sin dalla copertina<br />
ammiccano con ironia all‘eleganza teutonica di Trans Europe Express, riprendendo peraltro nelle primissime<br />
battute del disco l‘infinita spirale di Europe Endless (o magari di Baba O‘Riley, quando non di Terry<br />
Riley stesso).<br />
Ma è altrettanto certo che Fear Of Drowning ha quell‘incedere da anthem che fa grande un singolo<br />
(esattamente come Surfacing dei sunnominati Chapel Club), e lo stesso dicasi per Somewhere Strange,<br />
Into The Heart, Ways To An End, Hide And Seek. Come da onorevole tradizione sintetica c‘è sì da ballare e<br />
da godere di melodie istantanee e architetture solide ed intelligenti, ma nel nostro caso c‘è soprattutto<br />
da gustare di un songwriting e di un canto che poco ha dell‘algido declamare del synthpop originario<br />
e più del crooning accorato di un, mettiamo, Billy MacKenzie (Write Through The Night, Something On<br />
Your Mind) quando non - per avvicinarci ai nostri tempi - di Win Butler, la cui ecumenicità è l‘obiettivo<br />
finale. 2011: the year britpop broke. Again.<br />
(7.5/10)<br />
antonio Puglia<br />
co, anche se l’esordio sulla lunga distanza mostra una<br />
capacità di scrittura che all‘epoca potevamo solo auspicare.<br />
Riepilogando: John Cooper e compagni (la cui cittadinanza<br />
è divisa fra Londra e Manchester) sono artefici<br />
di un pop fieramente lo-fi che guarda ai Novanta con<br />
una abbondante dose di carattere (se non di originalità).<br />
Bastano un paio di pezzi pubblicati sul loro blog<br />
per consegnarli all’attenzione delle minuscole etichette<br />
dell‘underground londinese, nella fattispecie della<br />
Italian Beach Babes che li fa uscire come singolo.<br />
Di quei due brani, uno si fa notare per il titolo curioso<br />
(Painting Of Tupac Shakur), l‘altro (Bowie Knives) fra testi<br />
nonsense e un andamento caracollante, rilegge in chiave<br />
glam la slackness di tanti anti eroi dei 90s. Insomma,<br />
una delizia. Tanto che una Bowie Knives appena più<br />
composta costituisce l’ombelico concettuale del loro<br />
primo album; un disco che guarda all‘America scazzata<br />
di Sebadoh e Pavement, ma lo fa con una sensibilità<br />
tutta britannica.<br />
Bastano i primi accordi dell‘opener Go-Betweens per<br />
svelarne il segreto: schitarrata college rock (circa primi<br />
REM), distorsione calda alla Dinosaur Jr. e tonnellate<br />
di glassa melodica che solo gli inglesi quando fanno<br />
il verso agli americani riescono a produrre. Dopo due<br />
minuti è tutto finito. La successiva Surf & Turf è un po‘<br />
più didascalica nel seguire i precetti di Lou Barlow ma<br />
non meno azzeccata nella melodia. Cenetaph e Boxing<br />
Clever tornano a parlare il linguaggio di Bowie con lo<br />
slang di Steven Malkmus.<br />
Alla fine (sorpresa!) i tredici frammenti si gustano tutto<br />
d‘un fiato senza skippare niente, neppure i ventisette<br />
secondi dell‘haiku Eva. Se non è un esordio coi fiocchi,<br />
questo!<br />
(7.3/10)<br />
diego Ballani<br />
moritz von oSwald/vladiSlav delay/max<br />
loderBauer - moritz von oSwald trio<br />
- horizontal StructureS (honeSt jon’S<br />
recordS, marzo 2011)<br />
Ge n e r e: a m b i e n t, j a z z, e t n o<br />
Pensavamo che i tre del Moritz Von Oswald di Vertical<br />
Ascent e del Live In New York avessero inaugurato un<br />
side project di lusso più che qualcosa di concreto e<br />
continuativo. Eppure nulla, per il momento, vieta loro<br />
di sfornare dischi tanto frequentemente quanto i cugini<br />
jazzisti, unendo esplorazione e affiatamento.<br />
Horizontal Structures viene pubblicato ancora una volta<br />
dalla Honest Jon‘s di Damon Albarn ed è un lavoro<br />
che innanzitutto risponde al mancato effetto sorpresa<br />
attraverso il due elementi preziosi nell’economia del<br />
sophomore: la chitarra blues psych silenziata di Paul<br />
St Hilaire (aka Tikiman) apre magnifici ponti con l‘estetica<br />
bucolico new agey dell‘accoppiata David Gilmour<br />
e Orb di Metallic Spheres (Structure 1), mentre il double<br />
bass di Marc Muellbauer (del giro ECM) introduce<br />
chiaroscuri post-wave à la Bill Laswell perfettamente<br />
amalgamati nell‘ossatura ambient dub voluta da<br />
Oswald, personaggio, ahinoi, sempre più evanescente<br />
e auto confinato al missaggio e ai delay.<br />
Altra caratteristica interessante - e la si nota in Structure<br />
2 - è l‘esplorazione ancor più consapevole ed accurata<br />
di quella terra di mezzo tra il sempre fondamentale My<br />
Life In The Bush Of Ghosts di Brian Eno e David Byrne<br />
e i quartomondismi del proverbiale Jon Hassell, a<br />
cui s‘uniscono il giro post-punk del basso e una chitarra<br />
fusion balearica sullo sfondo.<br />
L‘incursione funky spezzata della Structure 3 - con un<br />
essenziale Louderbauer al synth dub/reggae - rileva<br />
qualche pericolo di autoreferenzialità che ritroviamo<br />
pure nella successiva suite di 20 minuti (Structure<br />
4), metà techno-dub metà kosmische tedesca con le<br />
percussioni di Ripatti (non più in 4/4) e il funk acustico<br />
dell‘ottimo Muellbauer. La quinta traccia, disponibile<br />
nella sola versione in download, affonda ancor di più<br />
nell‘esotico/esoterico dei 70s fino a perdersi nel mare<br />
di Java.<br />
Un più che discreto seguito con almeno due momenti<br />
ottimi a inizio scaletta (Structure 1 e Structure 2) e della<br />
buona qualità nelle restanti tracce. È evidente: sono<br />
stati i contributi degli ospiti ha dare linfa e sfumature<br />
fondamentali a un lavoro che avrebbe potuto immaginarsi<br />
più ardito, a partire dall’autorappresentazione di<br />
sé come ensemble aperto e non più come trio. Moritz,<br />
del resto, assomiglia sempre più al Miles Davis deus<br />
ex machina dei Settanta (Cobblestone Jazz prendete<br />
pure appunti). Se l’esordio era in verticale, perché<br />
esplodeva della carica intrisa di novità, questo seguito<br />
è in orizzontale: una meditazione rilassata ma pienamente<br />
cosciente su cosa sia l’elettronica now. E non è<br />
poco.<br />
(7.2/10)<br />
edoardo Bridda<br />
morning telefilm - o time (caneBagnato,<br />
novemBre 2010)<br />
Ge n e r e: eX p e r i m e n t a l, indie<br />
Emanuele Gatti è una figura decisamente centrale nella<br />
piccola scena indipendente pavese. Già con Emily<br />
plays e News for Lulu, consolida, con questo O <strong>Tim</strong>e, il<br />
suo progetto solista Morning telefilm.<br />
L’idea di fondo pare essere un progetto pop che non si<br />
forza però di rispondere a certi dettami di omogeneità<br />
tra i pezzi. Si comincia con un omaggio ai primi Arcade<br />
fire con la splendida Billion billiards per poi recuperare<br />
un sound tutto acustico in Something within me e<br />
abbandonarsi a ricordi glitch in The meaning of these<br />
scarps o Provers and sobs.<br />
La realtà è che la forza di un album come questo è<br />
quella di riuscire a raccogliere brani non troppo annodati<br />
alla tradizione: O <strong>Tim</strong>e scivola da sé in zone nuove,<br />
86 87
inesplorate, talvolta avvolte da sonorità rarefatte, antiche,<br />
e in altri casi, quasi anarchiche, futiristiche. Se Wax<br />
è malinconia e Morganology, unico brano in italiano,<br />
sembra d’ironia d’amore, una più classicheggiante e<br />
l’altra più sperimentale, in ambedue sentiamo ugualmente<br />
forte la cifra stilistica di questa band.<br />
Un lavoro solido, insomma, a dimostrare un’originalità<br />
di raro spessore.<br />
(7/10)<br />
giulia cavaliere<br />
moStly other PeoPle do the killing - the<br />
coimBra concert (clean feed, marzo 2011)<br />
Ge n e r e: j a z z<br />
Se qualcuno avesse bisogno di fare un ripasso tutto di<br />
un fiato della storia del jazz, dando, al contempo, uno<br />
sguardo al futuro del genere, The Coimbra Concert sarebbe<br />
senz’altro il disco più indicato.<br />
I Mostly Other People Do The Killing sfornano, infatti,<br />
un doppio live che è un enciclopedia jazz messa in un<br />
frullatore e poi rincollata con maestria pezzo per pezzo,<br />
senza rispettare affatto l’ordine iniziale.<br />
Fatta d’improvvisazioni anarchiche tenute sotto pieno<br />
controllo, la musica del quartetto è una metastasi benigna<br />
nel corpo del jazz: ne prende le cellule e le ricombina<br />
in forme cangianti e mai banali. Merito del bassista<br />
Moppa Elliott (già con Puttin’ On The Ritz), i cui temi<br />
portanti vengono presi dagli altri tre componenti - Peter<br />
Evans alla tromba, Kevin Shea (Talibam!) alla batteria<br />
e Jon Irabagon al sax - e dissezionati con irruenza,<br />
sventrandone la struttura in mille pezzi. L’abilità maggiore<br />
dei quattro risiede però nella capacità ricombinatoria<br />
tra le parti, a volte anche in maniera oppositiva,<br />
che dona loro una nuova luce: le melodie conflagrano<br />
ma trovano sempre la strada per rimettersi sui binari<br />
iniziali.<br />
Con una particolare e mai irrispettosa irriverenza, un<br />
notevole gusto per la parodia (ricorda qualcosa la copertina?)<br />
e un’energia invidiabile, i MOPDtK riescono<br />
nel miracolo di far risultare estremamente divertenti e<br />
godibili tutti i 100 minuti e oltre che compongono The<br />
Coimbra Concert. Se pensavate che il jazz fosse noioso,<br />
forse è bene che facciate un salto da queste parti.<br />
(7.2/10)<br />
franceSco aSti<br />
mount fuji doomjazz corPoration -<br />
anthroPomorPhic (denovali, marzo 2011)<br />
Ge n e r e: i m p r o -d r o n e -j a z z<br />
È una strana creatura questo terzo lavoro dei Mount<br />
Fuji Doomjazz Corporation, alter ego live-impro del<br />
Kilimanjaro Darkjazz Ensemble. È un magma scuro<br />
che si sparge lento lungo gli albori dell’umanità, a ripescare<br />
radici sonore ancora naturali per trasformarle in<br />
un suono umano, in un elemento antropomorfo.<br />
Questo unico, lungo flusso in 4 atti - registrato dal vivo<br />
nel corso di tre diversi concerti tra Utrecht, Breslavia<br />
e Mosca - è un qualcosa di sconosciuto, nascosto in<br />
penombra in una parte non ben definita della storia<br />
dell’uomo. Qualcosa di atavico e irrazionale risvegliato<br />
dai lunghi droni e dall’ambientazione dark provenienti<br />
dalle sorgenti sonore. Al contempo, però, è moderno e<br />
ragionato come il trombone jazz di Hilary Jeffrey o le<br />
note provenienti dal violino di Sarah Anderson.<br />
Anthropomorphic sta in un territorio all’incrocio tra<br />
ambient, jazz, elettronica, doom: impossibile darne<br />
un resoconto preciso. Per spiegarlo si può accostare ai<br />
passaggi più oscuri dei Supersilent, o rappresentarlo<br />
attraverso le immagini di David Lynch; certo è che<br />
l’unico modo per capirlo è abbandonarsi ad esso.<br />
(7/10)<br />
franceSco aSti<br />
mountain goatS - all eternalS deck<br />
(tomlaB de, aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: f o l k r o c k<br />
Album numero tredici, se abbiamo fatto bene i conti,<br />
per il trio californiano - ma attualmente domiciliato in<br />
North Carolina - dei Mountain Goats. Senza contare le<br />
cassette e gli EP che il buon John Darnielle - l’uomo che<br />
tira le fila del progetto - iniziò a sfornare giusto venti<br />
anni fa. Ogni volta tocca spendere le stesse parole, la<br />
stessa stupefatta ammirazione per una calligrafia che<br />
sa essere tesa, lirica, toccante, contemporanea senza<br />
inventare nulla, limitandosi cioè a spacciare alt-folk irrequieto,<br />
ballate frementi, lo-fi facinoroso e accorato<br />
retrogusto indie-rock.<br />
C’è come un fuoco che brucia nel petto di Darnielle ed<br />
il suo principale merito è saperlo impacchettare in un<br />
flusso di versi febbrili, visionari, indocili, espettorati con<br />
la penetrante concitazione d’un Mike Scott, d’un Robyn<br />
Hitchcock, d’uno Springsteen giovane. E ancora:<br />
a momenti ti sembra un Daniel Johnston con gli ingranaggi<br />
(ancora) a posto, un Mark Everett senza nevrastenia,<br />
un Dan Bejar stradaiolo, un Gordon Gano<br />
indolenzito. E’ insomma l’outsider della porta accanto,<br />
così lontano così vicino dal nostro quieto vivere, un altro<br />
ordine di percezioni e sensibilità oltre quel pianerottolo<br />
socchiuso.<br />
La chitarra, una batteria decisa ma frugale, tocchi di piano<br />
e tastiere discrete, giusto un soffio d’archi: questi i<br />
pochi ingredienti di siparieti intensi come la palpitante<br />
highlight<br />
PainS of Being Pure at heart - Belong (fortuna PoP!, aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: d r e a m-p o p<br />
Bisogna ammetterlo. C‘era una grossissima attesa per questo comeback e l‘attesa,<br />
per una volta, viene pienamente ripagata. Belong propone il quartetto<br />
newyorchese al suo zenith, in grado di mostrare maturità e consapevolezza<br />
non solo dei propri mezzi ma anche del ruolo ormai assegnato al progetto<br />
Pains Of Being Pure At Heart nell‘universo musicale odierno.<br />
I quattro non si smuovono di un centimetro, ma la loro formula - rodata a dovere<br />
sui palchi di mezzo mondo e raffinata per mano di Flood (alla produzione)<br />
e Alan Moulder (al missaggio) - è semplicemente perfetta per equilibrio<br />
e cognizione. Belong offre twee-pop rumoroso e dreaming ai suoi massimi livelli, saturo, dolciastro,<br />
melodico e godibilissimo sia nei momenti più “irruenti” (The Body, Girl Of 1000 Dreams, Heart In Your Heartbreak),<br />
sia in quelli più tipicamente shoegazing e delicati (Anne With An E, Strange) e inanella gemme<br />
su gemme in grado di passare in heavy rotation nelle discoteche alternative così come rimanere intrappolate<br />
negli i-pod di un seguito sempre più nutrito e - perché no? - intergenerazionale.<br />
Scozia e Inghilterra, 80s e 90s, college-rock e Velvet, Nuova Zelanda e C-86, Smiths e fratelli Reid, Washington<br />
fine ‘80 e Williamsburg d‘oggi. Nel sophomore dei quattro si mescola tutto in un andirivieni<br />
spazio-temporale che cattura dal primo ascolto e annienta le (eventuali) ultime difese. Un grande centro.<br />
(7.5/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
Damn These Vampires, le trasognate Age Of Kings e Outer<br />
Scorpion Squadron, la mesta Sourdoire Valley Song, le<br />
trafelate Estate Sale Sign e Prowl Great Cain. Il momento<br />
più insolito coincide con quella High Hawk Season che<br />
affida la solenne trepidazione ad un coro “barbershop”,<br />
con effetto straniante e confortevole ad un tempo. Ennesimo<br />
bel disco di un grande songwriter.<br />
(7.2/10)<br />
Stefano Solventi<br />
muShy - faded heart (manneQuin recordS,<br />
aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: d r e a m i n G c o l d-w a v e<br />
Mushy, ovvero l‘ennesimo gioiello gelosamente custodito<br />
dal sottobosco italiano. Non una novità vera e propria<br />
l‘esordio lungo della sigla dietro cui si nasconde<br />
Valentina F., responsabile in solitaria di Mushy e personaggio<br />
noto nell‘ambiente musicale non solo italiano.<br />
Le apparizioni live (una su tutte, il PRE fest con Current<br />
93 ed altri), le manifestazioni via tapes e cd-r (per Cold<br />
Current, Three Legged Cat, ecc) o le collaborazioni con<br />
nomi hype come Mater Suspiria Vision - senza contare<br />
il talento grafico messo a disposizione delle release<br />
Mannequin - stanno lì a dimostrarlo.<br />
L‘appena uscito Faded Heart, però, chiarisce molto,<br />
mostrando il perché di tanto interesse. Moderna chanteuse<br />
romantica e struggente, non lontana da certe sopravvalutate<br />
moaning stars (vedi alla voce Zola Jesus),<br />
si muove leggiadra e sognante su una architettura sonora<br />
fatta di tappeti di synth, loops di drum-machines<br />
analogiche, effettistica povera varia e una fluttuante<br />
e droning chitarra acustica a quattro corde. Strumentazione<br />
minimale per costruire landscapes spettrali<br />
e glaciali atmosfere reminiscenti in egual misura di<br />
Dead Can Dance e Cocteau Twins, minimal cold-wave<br />
e esoterismo folkish e visionario made in Albione, impreziosito<br />
dalla heavenly voice dell‘artista romana. Calibrata<br />
su toni malinconici e evocativi, emotivamente<br />
chiaroscura e drammatizzata è in grado di trascinare<br />
l‘ascoltatore in un deliquio onirico segnando la cifra<br />
stilistica più evidente di Faded Heart. Oltre ad essere il<br />
vero scarto che separa la nostra da altre frequentatrici<br />
di lande simili. Ottimo esordio.<br />
(7.3/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
88 89
noah and the whale - laSt night on earth<br />
(mercury, marzo 2011)<br />
Ge n e r e: r o c k/f o l k<br />
Terzo disco per una delle band infilate in quel calderone<br />
giornalistico che è andato sotto il nome di nu-folk,<br />
qualsiasi cosa abbia mai voluto dire mettere insieme il<br />
pop/folk/rock raffinato di Noah and The Whale con le<br />
nostalgie Seventies di Mumford & Sons. D’altra parte,<br />
soprattutto in ambito anglosassone, ci sono ancora<br />
delle riviste patinate da riempire di etichette e finti<br />
scandali. Per cui, forse, un senso tutto questo ce l’ha.<br />
Last Night On Earth arriva dopo First Days of Spring e<br />
l’esordio di qualche anno prima. Siamo di fronte a una<br />
band che con il terzo album vuole affrancarsi anche da<br />
queste etichette e tracciare la propria strada nel music<br />
business. Ci provano prendendo il materiale dei primi<br />
due dischi, quello che affondava le radici nel folk britannico,<br />
e lo tingono di world (Life Is Life, L.I.F.E.G.O.E.S.O.N.),<br />
di sentimenti americani in pieno stile Bruce Springsteen<br />
(Paradise Star, Give It All Back). Le melodie sono quasi<br />
sempre appiccicose e nel suo complesso Last Night<br />
On Earth è un disco piacevole, che troverà spazio in<br />
un airplay non strettamente legato al mondo indie. La<br />
pecca è che provare a battere nuove vie compositive<br />
ti riesce reinterpretando del gospel in chiave moderna<br />
(Old Joy), ma altre volte si scivola nell’imitazione dei<br />
Coldplay (Waiting For My Chance To Come).<br />
Un disco che conferma la buona vena melodica del<br />
gruppo di Fink e soci e che è anche un tentativo apprezzabile<br />
di non riscaldare sempre la stessa minestra.<br />
Ci sono cadute, anche se non così gravi, ma c’è sostanza<br />
sufficiente per costruire un futuro, con un sound che<br />
ha preso al suo interno i sintetizzatori e guarda tanto<br />
alle cose di casa propria (il Brit folk, Brian Eno), quanto<br />
dall’altra parte dell’oceano (il già citato Springsteen,<br />
ma anche alla vena melanconica di certo cantautorato<br />
americano).<br />
(6.5/10)<br />
marco BoScolo<br />
n_SamBo - Sofà elettrico (Snowdonia,<br />
feBBraio 2011)<br />
Ge n e r e: el e c t r o p s y c h<br />
Tra rock sintetico, astrazioni psych, sogni androidi<br />
kraut e brume pastorali folk, il livornese N_sambo confeziona<br />
un disco di debutto prontamente intercettato<br />
da Snowdonia, che lo divulga col consueto spirito refrattario<br />
a mode e consuetudini. Questo Sofà Elettrico<br />
è in effetti album che sfugge alla trama di flussi e<br />
riflussi contemporanei, deliziosamente fuori dai tempi,<br />
abitato da visioni espanse in una combinazione pecu-<br />
liarissima che gli consente di bazzicare electro-house<br />
contagiata etno (Tre), ambient-pop digitale à la Boards<br />
Of Canada (Edizione straordinaria), deliri radenti Syd<br />
Barrett (Zappaterra) e ballate caliginose col petto pieno<br />
di nostalgia (Drake).<br />
Molto sintetizzatore, chitarre, percussioni, effetti e campionamenti,<br />
ma anche flauti, organo, piano e tromba a<br />
comporre un puzzle sonoro sì artefatto però insospettabilmente<br />
organico, come visioni colte ancora calde<br />
da un immaginario senza preclusioni, si tratti di catturare<br />
nel retino le rarefatte geografie Jean Michel Jarre<br />
(Sofà) o sgranare irrequietezze synth-rock vagamente<br />
Cansei De Ser Sexy (Novembre). Notevole.<br />
(7.1/10)<br />
Stefano Solventi<br />
orcheStre Poly-rythmo - cotonou cluB<br />
(Strut recordS, marzo 2011)<br />
Ge n e r e: a f r i c a n a<br />
Senza tema di smentite “la più grande band del Benin”.<br />
Oppure, come si prefissano i diretti interessati, l‘onnipotente.<br />
Giustificata guasconeria a parte, a contare è il<br />
ritorno discografico dell‘Orchestre Poly-Rythmo dopo<br />
più di vent‘anni sotto forma di un festoso biglietto da<br />
visita destinato all‘Europa. Responsabile una Strut che,<br />
seria come d‘abitudine, accoglie questi arzilli vecchietti<br />
dopo un anno di concerti prestigiosi e il recente ripescaggio<br />
da parte di etichette come Soundway e Analog<br />
Africa di brani di un repertorio ampissimo. Cose di una<br />
fedeltà stereofonica non elevata ma artisticamente esaltanti,<br />
che mostravano un ensemble partito nel ‘64 come<br />
Groupe Meloclem e giunto alla definitiva ragione sociale<br />
quattro primavere più tardi. Che nel decennio 69-79<br />
segnalava un talento capace di spaziare da ritmi vodoun<br />
al funk tramite la salsa e l‘afro-beat, vantando collaborazioni<br />
con Manu Dibango e le lodi di Fela Kuti.<br />
Era nondimeno grazie all‘interessamento della giornalista<br />
transalpina Elodie Maillot che se ne scopriva la<br />
grandezza: persasi dentro i loro album, si recava a intervistarli<br />
e fungeva da supporto alla preparazione di<br />
questo lavoro che, registrato a Parigi con calde tonalità<br />
analogiche avvalendosi di ospiti “influenti” (Angelique<br />
Kidjo per il rutilare di Gbeti Madjro; Nick Mc Carty dei<br />
Franz Ferdinand per la sensazionale afro-disco secondo<br />
i Talking Heads Lion Is Burning) alterna - senza cali<br />
qualitativi - episodi del passato a materiale di più fresca<br />
composizione. Echi caraibici e screziature soul, fiati pingui<br />
ma squillanti, un guizzare di chitarre tra tribalismi e<br />
arguzie da cui non vorresti mai separarti.<br />
(7.3/10)<br />
giancarlo turra<br />
highlight<br />
r.e.m. - collaPSe into now (warner muSic grouP, marzo 2011)<br />
Ge n e r e: p o p r o c k<br />
Se con questo album i R.E.M. avessero voluto compiacere se stessi e lo sterminato esercito di fans -<br />
non necessariamente in quest’ordine - direi che ci sarebbero riusciti in pieno. Di più: col quindicesimo<br />
album in carriera, affidato all’ormai sodale Jacknife Lee, hanno eretto un monumento al proprio fare<br />
musica, un tour pressoché completo nel loro repertorio, opportunamente profuso e dissimulato nelle<br />
dodici tracce in scaletta. Come se avessero semplicemente preso atto della preponderanza del passato,<br />
accettandolo come strada percorribile in chiave futura. Non a caso si propone come un disco circolare,<br />
o se preferite il loro tardivo ma non (ancora) senile perfect circle. Ballate struggenti ed assalti entusiastici<br />
si alternano tanto più prevedibili quanto più sostanzialmente riusciti, in virtù del mestiere e di quel<br />
certo ingrediente magico altrimenti definibile fattore umano.<br />
Prendi il valzer mesto e accorato di Oh My Heart, con la fisarmonica struggente<br />
e le naunce gospel apolidi, oppure quella Every Day Is Yours To Win che<br />
ammicca la sdolcinatezza onirica di Love Is All Around e Find The River: ci vanno<br />
spudoratamente di pilota automatico, eppure l’azzeccano con un’efficacia<br />
disarmante, come i lavori di bottega degli artisti rinascimentali. Viene da dire:<br />
artigianato d’alto profilo. Considerazioni simili per All The Best, col suo saturare<br />
gli spazi d’impeto accattivante e caramelloso, ovvero come ti riciclo a<br />
dovere glam, hardcore e college rock per compensare una certa pedanteria<br />
melodica. Casomai metteteci pure quello scherzetto di Mine Smell Like Honey, tutto ruvidità intenerita<br />
altezza New Adventures In Hi-Fi, e ancora il divertissement a fuoco alto di Alligator Aviator Autopilot<br />
Antimatter, con l’espediente azzannaclassifica di Peaches nei cori.<br />
Altri segnali inequivocabili: Uberlin che celebra una possibile via di mezzo tra l’era Automatic For The<br />
People e quella Around The Sun; It Happened Today intenta a riprocessare con aria festosa una mischia<br />
Shaking Through e Half A World Away, con Eddie Vedder partecipazione omeopatica tra i cori del ritornello;<br />
la conclusiva Blue che incede come una processione pari pari Country Feedback, il talkin effettato<br />
di Stipe contrapposto all’intervento ieratico di Patti Smith prima di andare a spegnersi riesumando le<br />
pennate squillanti e stoppose dell’iniziale Discoverer, innescando così la suddetta circolarità che è forse<br />
il senso profondo del tutto. Praticamente in ogni episodio avverti la presenza assieme confortante e<br />
fastidiosa dell’auto-clonazione, andazzo cui sfuggono per la sbrigliata agilità indie-wave la breve That<br />
Someone Is You - tipo dei Go-Betweens anfetaminizzati - e una Walk It Back dall’incedere claudicante<br />
non lontano dal teatrino amarognolo Wilco. Non è tutto, ma più o meno ci siamo.<br />
Collapse Into Now è episodio ridondante nella lunga carriera dei R.E.M., caparbiamente ispirato e<br />
prodotto con una cura ai limiti della leziosità. Ed è anche - malgrado gli anni implacabili, la fama debordante,<br />
i dollari a vagonate - una bella dimostrazione di persistenza nella dimensione entusiastica del<br />
pop-rock. Ci sarebbe quel retrogusto stantio, ok, ma è sensazione quasi trascurabile.<br />
(6.3/10)<br />
Stefano Solventi<br />
ovo - cor cordium (SuPernatural cat<br />
recordS, aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: s l u d G e/d o o m<br />
Quella degli Ovo è una parabola musicale ormai nota a<br />
chiunque si occupi di musica in Italia. Storia di musica<br />
e di vita, fatta di impegno, dedizione e passione, svisceratasi<br />
in centinaia e più concerti, collaborazioni ad ogni<br />
latitudine, dischi d‘ogni formato per le etichette più<br />
oltranziste del pianeta e progetti collaterali eccitanti<br />
quanto il gruppo madre stesso. Con una identità sonora<br />
talmente evidente e fattasi classica che verrebbe<br />
quasi da identificare gli OvO con se stessi e nulla più.<br />
L‘ascolto di Cor Cordium - la nuova prova dell‘accoppiata<br />
Pedretti/Dorella, questa volta targata Supernatural-<br />
Cat - sposta ancor di più il limite sonoro del progetto,<br />
suggerendoci uno slittamento di significato: quella del<br />
90 91
duo è etimologicamente musica doom. Non limitata,<br />
cioè, a ripetere musicalmente i pesanti e lenti cliché<br />
del genere estremo (seppur mischiato con avant-noise,<br />
sludge, experimental e altro ancora), quanto a rimandare<br />
ad un immaginario da colonna sonora del giorno<br />
del giudizio.<br />
Cor Cordium è infatti un turbinio di emozioni estreme<br />
da fine-vita, una sonorizzazione del trapasso, un deliquio<br />
di sofferenza e dolore mentre colonne di fumo e<br />
cumuli di macerie fanno da scenografia ad un laico, infernale<br />
e maledetto doomsday. Di una lentezza esacerbante<br />
o ritmicamente accese, dalle vocals possedute o<br />
dalle corde maltrattate, le dieci canzoni di Cor Cordium<br />
sprizzano malessere e sofferenza da ogni poro.<br />
Non è un caso che l‘album sia ispirato dalla figura di<br />
Percy Shelley, maledetto e sfortunato protagonista di<br />
un personale inferno in Terra.<br />
(7.4/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
Panda Bear - tomBoy (Paw trackS, aPrile<br />
2011)<br />
Ge n e r e: p o p<br />
È un campione dell‘arrangiamento d‘effetto, Panda<br />
Bear. Conosce le nostre orecchie e sa su cosa puntare,<br />
come allestire una forma canzone per appagarle. Del<br />
resto - per quanto si possa discutere della qualità in<br />
senso assoluto della produzione - agli Animal Collective<br />
non si può certo negare di aver costruito un gusto,<br />
oltre che stilemi, appassionati, qualche detrattore e<br />
una carovana di band tese all‘emulazione o a cogliere i<br />
frutti del collettivo. Un po’ come successe per i Talking<br />
Heads, se ci pensiamo.<br />
Tomboy - a partire dalla title-track - è un condensato di<br />
polpa Collective: crea melodie semplici e la sa amplificare<br />
con layer di ambiente stratificati. Person Pitch stupiva<br />
i più per la sperimentazione di studio. In Tomboy<br />
c’è invece un gusto del montaggio che ha l‘obiettivo<br />
della semplicità, della messa a fuoco dello strumento.<br />
Ne perde la psichedelia e l’obliquità dell‘insieme, ma<br />
ne esce in chiaro tutta la personalità per le masse di<br />
Panda. A partire dalla voce, ovviamente, specchio mai<br />
quanto per Noah dell‘anima, fino alla pratica musicale<br />
della ripetizione (Slow Motion), quasi mantrica, dentro<br />
a canzoni che non sono né più né meno che loro stesse.<br />
Prendiamo Last Night At The Jetty: si gioca con i livelli<br />
sovrapposti della voce, un coro interno che riempie lo<br />
spazio tra le pareti, ma senza che il sound ne esca ostico.<br />
Potremmo anzi dire che questo è pop che trascende<br />
le scene (e i Beach Boys), che ha una classicità pal-<br />
pabile, dove Lennox si propone come il Phil Spector<br />
del passaggio tra anni Zero e anni Dieci. È lo studio che<br />
fa la differenza (Scheherazade), finendo con il colmare<br />
brillantemente anche alcune scelte meno felici (Friendship<br />
Bracelet). Si coglie la serenità con cui Panda ha lavorato<br />
nel suo studio di Lisbona, costruendo Tomboy.<br />
Ma, fuori dalla biografia personale, ci sentiamo un percorso<br />
che parte da Brian Eno, e che si manifesta nelle<br />
note infinite di tastiera (Drone), trasposte dall‘ambient<br />
alla classifica ormai post-indie dell‘orsetto.<br />
Tutti personaggi che hanno spostato l‘asticella del<br />
benchmark nella storia della musica. È inutile nascondersi<br />
a cosa punti Lennox. A fissare un nuovo standard<br />
della classicità indie-pop odierna, del cantautorato che<br />
si annida in essa, dello studio che vale (concetto ormai<br />
antichissimo) che vale più di una seicorde. La sfida con<br />
Avey Tare - e con tanti altri - è apertissima, e i più punteranno<br />
i propri soldi scommettendo sull‘orso con l‘occhio<br />
cerchiato.<br />
(7.2/10)<br />
gaSPare caliri<br />
Peter Bjorn and john - gimme Some<br />
(cooking vinyl uk, marzo 2011)<br />
Ge n e r e: po p<br />
Un gruppo che è anche un insieme di teste pensanti<br />
distinte e attive su diversi fronti quello di Peter Bjorn e<br />
John da Stoccolma. Per dire, Bjorn Yttling si è dedicato<br />
alla produzione artistica di numerosi colleghi svedesi<br />
tra cui Lykke Li, mentre Peter Mòren si è già aperto una<br />
strada in solo con The Last Tycoon (del 2008). Del resto,<br />
la formazione, che con il presente lavoro arriva alla sesta<br />
prova in studio, non ha mai perseguito un modello<br />
o un’idea di progetto artistico vincolante: il popolare<br />
Writer‘s Block (quello con il singolo Young Folks, per<br />
capirci) era fatto della più riconoscibile pasta indiepop,<br />
il successivo Seaside Rock pasturava uno scuro<br />
instrumental folk, mentre il precedente Living thing<br />
(del 2009) proiettava i tre su varie direzioni tra le quali<br />
il binario wave tropicalista che tanto andava di moda<br />
qualche anno fa.<br />
Gimme Some è l‘album rock, o per meglio dire power<br />
pop, quello che da un lato risposa il cosidetto mainstream<br />
e dall‘altro i soliti Beatles ma nell‘accezione dei<br />
primi XTC (le anfetamine Mod di Black Book) o il più<br />
ampio paradigma indie per il grande pubblico promulgato<br />
dai R.E.M. elettrici (Tomorrow Has To Wait).<br />
Infine, c‘è tanto e di tutto dell‘immaginario pop in queste<br />
compresse canzoni in media di tre minuti, dagli<br />
ovvi Sixties (Eyes, Dig A Little Deeper), fino al glam (Second<br />
Chance, (Don’t Left Them) Cool Off), dal punk-rock<br />
highlight<br />
Sean rowe - magic (anti-, marzo 2011)<br />
Ge n e r e: f o l k-r o c k-b l u e s<br />
Il ragazzo viene da Albany, stato di New York, e ha cominciato a calcare i palchi con la sua chitarra all’età<br />
di tredici anni. Nella sua saccoccia tutte le strade senza fine dell’America, i monti Appalacchi, le lumberjack<br />
dei boscaioli, le camicie a quadri della working class che si ritrova in un diner, il whisky a buon<br />
mercato, Henri David Thoureau e tutto il suo succhiare il midollo della vita. Il ragazzo scrive canzoni<br />
che sono storie, perché la musica è la sua vita, è la Vita. Incide un po’ di canzoni, magari direttamente<br />
nello stanzone sopra il ristorante di famiglia, in solitudine, baciato in fronte dal sole al crepuscolo, mentre<br />
i fantasmi di tutte le persone di cui parla si affollano nella mente, si insinuano tra le note, prendono<br />
consistenza. La sua voce baritonale ha un timbro particolare, pieno e caldo, capace di dare vita alle<br />
parole che canta. Ma ancora nessuno se n’è accorto. Che importa: si suona e canta per il gusto di farlo,<br />
per la musica stessa. Il ragazzo ha questo pugno di canzoni pronte e levigate, custodite gelosamente<br />
da chi le ha incontrate, e solo dopo un limbo nel sottobosco USA, un’etichetta vera, di quelle che hanno<br />
ancora i talent scout con le orecchie aperte, gli dà una pacca sulla spalla e gli dice: “Ehi, pubblicheremo<br />
la tua roba”. Il ragazzo, con un sorriso timido, si fa accogliere da quelle ali protettive e ce lo ritroviamo<br />
nello stereo. Quello che accade dentro a Magic è un continuo dialogo tra Sean Rowe, questo il nome<br />
del newyorkese con la voce che ti stende, e una serie di padri nobili della musica che sta all’incrocio tra<br />
il country, il folk e il blues: la storia stessa della musica americana. Ci si ritrova<br />
tutti, da Bruce Springsteen a Steve Earle passando per Gil Scott-Heron e<br />
scia blues a seguire. Partecipano al simposio anche alcuni ospiti venuti da<br />
lontano, a cominciare da quell’irlandese testa calda di Van Morrison, quel<br />
signore di Leonard Cohen e quel satanasso di Nick Cave. A stendersi come<br />
un tappeto sotto alle storie di Rowe la chitarra (perché capita che il ragazzo<br />
sappia anche suonare, oltre che cantare e scrivere) e molti altri strumenti (violoncello,<br />
xilofono, pianoforte, sintetizzatore, percussioni) spesso usati solo<br />
per dare senso a piccoli dettagli e rendere così grandi le canzoni. Il ragazzo adesso non sta più<br />
dentro a una foto sbiadita in bianco e nero. Oggi il ragazzo ha preso la chitarra, se l’è messa in spalla e si<br />
è messo in viaggio. Ha salutato gli amici/maestri e ha le spalle abbastanza larghe per mostrarsi a tutto<br />
il mondo. Certo, ha ancora bisogno che qualcuno gli dia qualche consiglio, che qualcuno di tanto in<br />
tanto gli metta una mano sulla spalla. Ma quando attacca una qualsiasi delle dieci canzoni che qui ha<br />
voluto contenere, riesce a parlare direttamente al cuore di chi lo ascolta. Questa è la sua grande capacità:<br />
saper veicolare emozioni, e non vergognarsene, anzi trarne la forza per inchiodarti alla sedia. Non<br />
è forse tutto quello che cerchiamo nella musica?<br />
(7.6/10)<br />
marco BoScolo<br />
(Breaker Breaker) al wave pop (la chitarra e basso primi<br />
U2 di May Seem Macabre). Il tutto infiocchettato senza<br />
fronzoli e grossi hit, con un gusto solare e positivo di<br />
lungo corso, dolcezze e anfetamine al passino. Onestamente<br />
pop rock. Bravi.<br />
(7/10)<br />
edoardo Bridda<br />
PoiSucevamachenille -<br />
PoiSucevamachenille (outline recordS,<br />
agoSto 2010)<br />
Ge n e r e: w e i r d (-f o l k)<br />
Il pescarese Ezio Piermattei esordisce con uno studio<br />
solo project che farà la gioia degli appassionati di musiche<br />
weird. Poisucevamachenille (nome costruito secondo<br />
la regola delle parole-valigia di Lewis Carroll), 31<br />
minuti senza soluzione di continuità, comincia infatti<br />
92 93
highlight<br />
SongS for ulan - the gloBe haS SPun and we’re all gone (Stout muSic, aPrile<br />
2011)<br />
Ge n e r e: f o l k b l u e s r o c k<br />
Cinque anni sono tarscorsi da You Must Stay Out, un lustro pieno per covare le dieci tracce che compongono<br />
The Globe Has Spun And We’re All Gone, album lungo numero tre per Songs For Ulan,<br />
moniker dietro cui agisce Pietro De Cristofaro, napoletano classe ‘70. Alla produzione troviamo ancora<br />
Cesare Basile, ed è una presenza pregnante, tanto quanto è palpabile la premeditazione, la densa brusca<br />
raffinatezza portata in dote da tutto il tempo speso a far nascere, crescere,<br />
irrobustire e smerigliare queste canzoni. Ognuna un episodio vivo, intenso,<br />
particolare. Dall’arrendevole risolutezza Jeff Buckley di Like TV all’asprezza<br />
terrigna di Hook (prossima alla PJ Harvey più basale), il folk blues di De Cristofaro<br />
possiede la fisionomia cruda e penetrante di chi mette in gioco sentimenti<br />
reali, assolvendo ogni tetraggine con la vibrazione insopprimibile della<br />
tenerezza, lasciando sempre aperto uno spiraglio tra fatalismo e speranza.<br />
Ai blues ingrugniti e sordidelli di stampo Mark Lanegan (What Good Can Tell)<br />
e al tumulto velenoso Nick Cave (From The Borders) rispondono quindi diafane processioni Black Heart<br />
Procession alleviate da un incanto dolciastro Devendra Banhart (la stupenda The Bed), narcosi<br />
livide e iridescenti come un sogno trip-hop di Howe Gelb (You Only Love) e valzer enigmatici come<br />
ambasce dEUS tra peregrinazioni Calexico (She’s A Ghost). Corde scorticate e incandescenti, fremiti di<br />
contrabbasso, fisarmonica e xilofono alla bisogna, organi che pennellano sfondi noir, il drumming sospeso<br />
tra pulsazione frugale ed astrazione cinematica, sobri ma cruciali interventi sintetici (come nella<br />
spettrale acidità di A Promise e nel rigurgito Sparklehorse di The New World): questi gli elementi di un<br />
ordito su cui la voce ricama melodie indolenzite ma tenaci, vulnerabili e irrequiete.<br />
In chiusura, la morbida rilettura della If It Be Your Will di Leonard Cohen - col sabbioso controcanto di<br />
Dave Muldoon - sigilla alla perfezione il programma. Nel suo genere, uno dei più convincenti dischi<br />
italiani degli ultimi anni.<br />
(7.8/10)<br />
Stefano Solventi<br />
un po’ alla Third Ear Band, con percussioncine e archi<br />
che stridono maltrattati. Costruisce poi, sopra una<br />
pulsazione percussiva di base (ma è tutto il disco ad<br />
essere fortemente percussivo), una serie di alternanze<br />
e di stratificazioni: un vociare tra Magma, free-folk e<br />
giapponeserie psych-prog; zoppicanti e giocosi siparietti<br />
di un minuto o poco più (un oboe, un carillon); filastrocche<br />
bucolico-lisergiche. Attorno ai 14:00: reset. E<br />
si riprende con una canzone praticamente power-pop<br />
(eredità dell’esperienza nei Levis Hostel?), tutta piano,<br />
chitarra ed effetti (e che se ci fosse la batteria potrebbe<br />
anche essere dei Dandy Warhols). Il crescendo del pezzo<br />
non si risolve, ma diventa una giostrina da luna park<br />
che non sarebbe dispiaciuta al Todd Rundgren glam e<br />
smanettone. Si continua così, cazzeggio avant in grande<br />
spolvero, fino al minuto 26:00, quando inizia il gran<br />
finale: incedere sinistro e atmosfera inquietante, con<br />
un occhio - anzi un bulbo - ai cari vecchi Residents. Un<br />
lavoro che si posiziona, come ammette lo stesso Ezio,<br />
in un ambito “un tantinello inflazionato”, ma costruito<br />
con cognizione e gusto del divertimento.<br />
(6.8/10)<br />
gaBriele marino<br />
ProfeSSor - madneSS (naive, aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: r e G G a e<br />
Lodevole il presupposto a monte del progetto solista<br />
di Harrison Stafford, cantante di quei Groundation<br />
che intanto ingannano l‘attesa del prossimo disco con<br />
la stuzzicante raccolta The Gathering Of The Elders. Da<br />
anni trapiantato nella madrepatria del reggae e accettato<br />
dalla comunità col soprannome di “Professor”,<br />
l‘uomo si recava in visita nei “territori occupati” tra Israele<br />
e Palestina, affrontando la spinosa questione dal<br />
punto di vista palestinese incurante del seguito che la<br />
sua band ha a Tel Aviv. Accompagnato da un‘attivista<br />
francese, trascorreva dieci giorni tra Hebron, Ramallah<br />
e Nablus confrontandosi con la gente.<br />
La sera, rifletteva canticchiando motivi dentro il telefonino<br />
e, tornato a St. Ann‘s Bay, vergava otto brani<br />
registrati in una settimana assieme a sodali del calibro<br />
di Leroy “Horsemouth” Wallace e Flabba Holt e invitando<br />
a cantare, tra gli altri, U-Roy e Ashanti Roy dei<br />
Congos. Occupandosi inoltre di produzione e mixaggio,<br />
infine affidando a un amico californiano le riuscite<br />
“dub version” che integrano la scaletta. La quale non risente<br />
dei rischi insiti in simili operazioni, come l‘eccesso<br />
di enfasi e il populismo che spesso affossano vena<br />
melodica e comunicatività.<br />
Non in questo gesto di profondo rispetto, dove - nonostante<br />
titoli potenzialmente didascalici come Intifada<br />
e East Jerusalem - il “messaggio” è articolato con partecipazione<br />
e disinvoltura e senza prevaricare il “mezzo”,<br />
cioè il reggae d‘impronta roots anni ‘70 - classico ma<br />
dotato di personalità - proposto con il gruppo madre.<br />
E, quel che più conta, persuadendo come di rado fuori<br />
dai confini giamaicani.<br />
(7/10)<br />
giancarlo turra<br />
QuakerS and mormonS - evolvotron (la<br />
valigetta, aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: h i p h o p p o p<br />
Maolo e Mancho, con l’assistenza di Rico (Uochi Toki),<br />
in libera uscita dai My Awesome Mixtape per mettere<br />
a fuoco le pulsioni più hip hop che animano la band.<br />
In un mezzo-delirio di proclami filosofico-linguistico-esistenziali<br />
tra il serio e il faceto. Su basi con ritmi<br />
impostati da batterie e percussioni legnose e campioni<br />
- molto discreti - che più che vintage si direbbero<br />
proprio oldie, si sviluppano i motivetti a presa rapida<br />
che abbiamo imparato a conscere coi MAM, con quella<br />
prosodia, quelle cadenze immediatamente riconoscibili,<br />
scandite, filastroccose, super-americane nel senso<br />
del power-pop delle college band. Virate su toni scuri,<br />
come impongono nome, liner notes e immagini promozionali<br />
che strizzano l’occhio ai Sunn O))). Brani molto<br />
simili tra loro, non fosse altro che per il rappato declamatorio<br />
di Maolo, sempre tutto uguale; ma la ricetta<br />
funziona sorprendentemente bene, merito di un profilo<br />
produttivo asciutto e variegato, tra arrangiamenti<br />
azzeccati, ammiccamenti elettronici, campioni-trovate<br />
e incisività (hip) pop.<br />
Dancing In The Mud è un uptempo Tom Waits-iano<br />
(percussioni tribali, fiati pomposi, chitarra stonata) cantato<br />
in maniera quasi espressionista ed espressionista<br />
è l’ispitazione della lullabesca Moldova, che campiona<br />
la colonna sonora pianistica del Nosferatu di Murnau<br />
(e tornano qui come da menù MAM certe influenze<br />
cross/emo, nell’inciso con voce femminile alla Linkin<br />
Park). C’è una chitarra spagnoleggiante e un motivetto<br />
pop ma come farebbero pop gli gnometti del bosco in<br />
Down Is Up e questa atmosfera un po’ da fiaba malata<br />
torna anche in The Prose. Altri elementi (imp)ortanti,<br />
un’ispirazione di sapore soul (Speechless Sentence) che<br />
in alcuni casi diventa proprio gospel (il singolo New<br />
York Town) o si vaporizza in puro mood epico (i supertimpani<br />
e l’inciso corale di Background, Foreground; la<br />
lenta Louder Than Bombs contro la guerra). E coloriture<br />
elettroniche che da una parte strizzano molto bene<br />
l’occhio alla nowness internazionale (wonky/glochill;<br />
Bog) e dall’altra appaiono pretestuosamente noize (Taste<br />
Of Poland).<br />
(6.7/10)<br />
gaBriele marino<br />
raz meSinai - Badawi - the axiom eP (the<br />
agriculture recordS, feBBraio 2011)<br />
Ge n e r e: d o o m d u b a m b i e n t<br />
Dall’acerbo, avventuroso esordio in coppia con il dj<br />
John Ward a nome Sub Dub (1993; tra i protagonisti<br />
della scena soundscape/”illbient” di metà anni Novanta),<br />
al debutto come Badawi e alle sperimentazioni<br />
insistite su un dub etnico, percussivo, collagistico e iterativo<br />
(Bedouin Soundclash, 1996), fino ai dischi elettroacustici/classico-contemporanei<br />
pubblicati su Tzadik<br />
(che cercano di mettere assieme folk del Medio Oriente<br />
e contemporanea europea), il lungo - 18 dischi finora -<br />
percorso di Raz Mesinai (Gerusalemme, 1973) si è fatto<br />
sempre più complesso, ma anche meno dispersivo,<br />
più affinato, focalizzato.<br />
Axiom ne sintetizza la visione dubstep, riuscendo<br />
nell’impresa di proporre una - chiamiamola così - “ambient<br />
da dopo-bomba”, sporca e noise (tra radici electro,<br />
nuovo camerismo e desolazione dubstep; Demdike<br />
Stare, Vex’d, Richard A. Ingram), che non sia<br />
pensata esclusivamente per gli audiofili o gli esoteristi<br />
specializzati e che metta di nuovo sul tavolo l’elemento<br />
pulsazione.<br />
Questi cinque pezzi (più due remix della title track a<br />
opera di Andy Stott e Vaccine, in chiave deep) parlano<br />
con gli echi del dub e si nutrono di un’ossatura techno<br />
superminimale, dipingendo scenari urbani da contatore<br />
Geiger, tutti polveri sottili, sirene e radar. E trovando<br />
nella traccia conclusiva, Anlan 7, la loro massima<br />
espressione, squassata da bordate dubnoise.<br />
(7.3/10)<br />
gaBriele marino<br />
94 95
ingo deathStarr - colour triP (cluB ac30,<br />
marzo 2011)<br />
Ge n e r e: ps y c h o p o p<br />
C’è shoegaze e shoegaze. C’è chi si limita a sfoggiare un<br />
pò di effettistica dream pop per dare smalto a brani altrimenti<br />
incolore, e chi, come i Ringo Deathstarr, scolpisce<br />
melodie da blocchi di rumore grezzo. Che poi il<br />
risultato sia simile a quello dei My Bloody Valentine è<br />
solo un elemento che gioca a loro favore. Non così strano,<br />
peraltro, visto che Kevin Shields e compagni hanno<br />
codificato una maieutica del pop rumoroso che i texani,<br />
non fanno che seguire diligentemente.<br />
Certo, è impossbile ascoltare Imagine Hearts, la traccia<br />
che apre il disco, e non pensare a qualche outtake da<br />
Loveless. Con quelle melodie che sembrano provenire<br />
da una pellicola Super 8 in procinto di liquefarsi, la voce<br />
della bella Alex Gehrin che si fa strada fra la glassa noise<br />
e che ricorda una Bilinda Butcher appena più sveglia.<br />
Poi però, dalla seconda traccia, il loro pop prende corpo<br />
e sostanza. Siamo dalle parti dei Jesus And Mary<br />
Chain più urgenti, con una melodia 60s sciorinata a colpi<br />
di fuzz che si insinua e dimostra quanto il loro non sia<br />
solo un lavoro di pedaliere.<br />
Colour Trip è un grande omaggio allo psycho pop britannico<br />
degli anni 80, al punto che per ogni brano è<br />
possibile individuare con una certa oggettività la band<br />
shoegaze-C86 di riferimento (i Talulah Gosh per So<br />
High, i Lush nella successiva Two Girls, gli Slowdive per<br />
Kaleidoscope e si potrebbe proseguire).<br />
Colour Trip, d’altro canto, è anche un ottimo album di<br />
pop tout-court, con canzoni che si farebbero apprezzare<br />
anche senza la loro soffice corazza di feedback e distorsioni.<br />
Sembra banale, ma sta tutta qui la differenza<br />
con il 90% del pop psichedelico odierno.<br />
(7/10)<br />
diego Ballani<br />
SandwitcheS - mrS joneS cookie (emPty<br />
cellar, marzo 2011)<br />
Ge n e r e: indie-c o u n t r y -f o l k<br />
Secondo album per i The Sandwitches, trio di San Francisco<br />
composto da Grace Cooper Heidi Alexander e<br />
Roxy Brodeur, che debutta su Empty cellar con un disco<br />
programmatico fin dal titolo, Mrs Jones Cookies.<br />
Da copione quindi eccoci proiettati in un country-folk<br />
al femminile che non si misura solo con i cliché indie<br />
alla Cat Power (comunque sempre presente come in<br />
Joe says), ma cerca di allargare il respiro a una tradizione<br />
americana tout-court, tanto nel pop delle Shangri-Las<br />
da cui riciclano l’uso massiccio di coretti-sixties e un onnipresente<br />
cantato a più voci, quanto nei lavori di Roky<br />
Erickson. Ad uscirne è un disco di “canzoni” nella stessa<br />
accezione che potrebbe darne un dizionario, giocato<br />
su atmosfere contrapposte: Summer of love, My heart<br />
does swell e Lightfoot sono il lato country e sereno, ma<br />
ci sono anche le sferzate rock di Black Rider con più di<br />
una reminiscenza di Pj Harvey, o il lancinante mantra<br />
blues di Heviest head in the west; e volendo continuare<br />
la lista non può mancare all’appello la ballata struggente,<br />
Miracle me, con un arrangiamento equilibratissimo<br />
nel dosare strumenti e voce, prima di giungere al finale<br />
retrò e malinconico di Heavy times che sembra mimare<br />
una crisi esistenziale di Buddy Holly.<br />
Insomma il rischio di rimanere invischiati nel limbo grigiastro<br />
dell’indie folkettino era alto (e si annusava anche<br />
dall’artwork di copertina...), invece i The Sandwitches<br />
vincono la partita nel modo più semplice possibile: con<br />
una manciata di canzoni ben scritte, che scaldano e avvolgono.<br />
Non si chiede di più ai grandi, non vedo perché<br />
farlo con loro.<br />
(7.3/10)<br />
Stefano gaz<br />
Seun kuti - from africa with fury: riSe<br />
(BecauSe, aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: a f r i c a n a<br />
Si fa sempre fatica a parlare dei “figli d‘arte”, del loro<br />
cognome ingombrante che finisce per creare speranze<br />
esagerate e in sostanza ingiuste. Considerazioni che in<br />
questo caso non è possibile accantonare, perché se ti<br />
chiami Seun Anikulapo Kuti e ti metti a capo di quei<br />
Egypt 80 già a suo tempo capeggiati da babbo Fela, i<br />
casi sono due: 1) sei un incosciente; 2) sai benissimo il<br />
significato di quanto stai facendo. E hai fegato, ragazzo<br />
mio, oltre a un talento che non è solo questione di DNA.<br />
Già il tuo debutto del 2008 Many Things era un bel sentire<br />
e portare avanti messaggio ed eredità di chi sai tu.<br />
Oggi, From Africa With Fury: Rise racconta che stai cercando<br />
una tua possibile identità guardandoti indietro,<br />
come chiunque oggi fa.<br />
Ci piace che di là dal vetro si siano alternati in tanti e tra<br />
costoro Brian Eno e tuo fratello Seun; ci piace l‘energia<br />
che trasuda da sei brani e il lasciarci tirare il fiato nella<br />
sublime, tesa ipnosi Rise; ci piacciono gli impasti vocali,<br />
le scorribande fiatistiche guidate dall‘alto sax di Lekan<br />
Animashaun, lo stratificato rutilare ritmico. Perché ci<br />
fanno sentire a casa e, sì, ricordano l‘afrobeat ma pure<br />
i Talking Heads, e allora come la mettiamo? Così: che<br />
non sei un Jeff Buckley, ma nemmeno un Jacob Dylan;<br />
che sei bravo, ed è questo che conta.<br />
(7/10)<br />
giancarlo turra<br />
Slug gutS - howlin’ gang (Sacred BoneS,<br />
feBBraio 2011)<br />
Ge n e r e: bl u e s po s t pu n k<br />
Ancora una volta l‘Australia segna un punto a suo favore<br />
sullo scacchiere internazionale del (post)punk. Dopo<br />
UV Race e Deaf Wish ecco una nuova formazione in<br />
grado di superare i patri confini tanto da firmare per la<br />
famigerata label newyorkese. Come molti altri gruppi<br />
del Nuovissimo Continente, anche gli Slug Guts fanno<br />
man bassa della tradizione locale di Birthday Party e<br />
Lubricated Goat e c‘è poco da fare quando i riferimenti<br />
sono così chiari ed inequivocabili: prendere o lasciare.<br />
Dopo il primo Down On The Meat (su Stained Circles),<br />
Howlin’ Gang torna ad insistere su territori minati da<br />
Telecaster pericolose come rasoi arrugginiti, percussionismo<br />
isterico vagamento jazzato, cantato posseduto,<br />
baritonale e ossessivo. Tredici pezzi rudi e crudi, totalmente<br />
devoti a ricreare quel mood cimiteriale tipico del<br />
blues-punk degli anni d‘oro. E se quando parte Howlin’<br />
viene da chiedersi se per caso non si stia ascoltando i<br />
Chrome Cranks, beh siamo sicuri che gli Slug Guts<br />
prenderebbero questo dubbio come il più grande dei<br />
complimenti.<br />
(7/10)<br />
andrea naPoli<br />
Sonic youth - Simon werner a diSParu (Syr,<br />
aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: s o u n d t r a c k<br />
Il numero 9 della collana Perspectives Musicales che la<br />
gioventù sonica affida alla personale label SYR è assai<br />
distante dai precedenti. Meno sperimentale e avanguardistico<br />
rispetto alle altre uscite, Simon Werner A<br />
Disparu è la colonna sonora dell‘omonimo film del francese<br />
Fabrice Gobert e fotografa la band nel suo mood<br />
attuale, proprio come era successo anni fa per Made In<br />
Usa (e in maniera misura per Demonlover, del 2002).<br />
Se all‘epoca la gioventù sonica ben si rispecchiava in<br />
quella soundtrack del 1986 scoppiettante e frantumata,<br />
Simon Werner A Disparu si adagia sui Sonic Youth più<br />
ectoplasmici e (tra)sognanti, estatici e sospesi. Quelli<br />
dell‘ultimo periodo, per capirsi: meno irruenti ed esplosivi<br />
(eccettuati un paio di episodi, tra cui Chez Yves e la<br />
daydreamiana Alice Et Simon) ma altrettanto disturbanti<br />
e insidiosi. La formula a tre chitarre utilizzata dal quartetto<br />
(l‘ex-membro Jim O‘ Rourke è presente al basso<br />
solo nella fluviale Theme D‘Alice) incide sul risultato finale,<br />
spostando ancor di più l‘ago della bilancia sulle<br />
stratificazioni e sui dialoghi chitarristici (Theme De Laetitia,<br />
Escapades), ma non mancano momenti più rarefatti<br />
(Dans Les Bois/M. Rabier)e addirittura inconsueti duetti<br />
Ranaldo-Moore al piano (Les Anges Au Piano).<br />
Considerato che il film dovrebbe essere un noir, le elucubrazioni<br />
tra sogno e realtà, psych e rumore inscenate<br />
dai quattro dovrebbero ben sposarsi con le atmosfere<br />
filmiche. Per ora non possiamo che accontentarci di<br />
una delle migliori prove fornite dai SY da qualche anno<br />
a questa parte.<br />
(7/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
SQuadra omega - SQuadra omega (holidayS<br />
recordS, dicemBre 2010)<br />
Ge n e r e: k r a u t/p s y c h n o i s e<br />
L‘esordio della Squadra Omega, tanto atteso, per chi ha<br />
visto il gruppo in azione dal vivo, o ne conosce i componenti,<br />
vive di una questione di taglio dentro a un flusso,<br />
di sartoria che separa i pezzi dal tessuto e dà loro vita<br />
autonoma.<br />
Supergruppo è una formula che non spiega del tutto<br />
quello che accade, anche se all‘apparenza ha una buona<br />
pertinenza giornalistica. Come tenere insieme - criticamente<br />
- schegge del post-With Love, e di Mojomatics,<br />
Movie Star Junkies, Apoteosi del Mistero e Be Maledetto<br />
Now, senza ricorrere a questa formula un po‘ demodé,<br />
ma sempre fascinosa? Una via è possibile, serve passare<br />
dal risultato più che dalle premesse, tener presente<br />
l‘amicizia e le esperienze precedenti di Andrea Giotto e<br />
compari ma ritrovarla solo nell‘esito musicale.<br />
Squadra Omega non è un criterio di composizione, ma<br />
un modo di stare insieme sul palco e in studio, di articolare<br />
un‘empatia. E tale stato d‘animo congiunto non<br />
può che diventare, se messa in musica, una interminabile<br />
jam session. Ciò che comunica il self-titled, primo<br />
long playing (con 7” in aggiunta al 33 giri) firmato dai<br />
trevigiani, è questo: e il fatto che l‘output suoni spesso<br />
krauto e free-jazz crea legami fenomenologici interessanti,<br />
che ricorda le comunità (o comuni) hippy dei<br />
tedeschi di fine Sessanta e le ricollega a un gruppo di<br />
persone nell‘odierno Veneto, che si coagulano attorno<br />
all‘aggregatore musicale, all‘ascolto e all‘esecuzione in<br />
free form di una materia che le prove e i concerti perfezionano,<br />
fino ad arrivare su LP.<br />
Il sound di Squadra Omega è krauto come può esserlo<br />
una musica che mantiene caratteri della cosmica (l‘acida<br />
suite di Murder in the Mountains) eppure conserva<br />
una sua rudezza. Motorizzata in memoria dei Neu!,<br />
evidentemente, ma con un linguaggio e uno sguardo<br />
odierno (la doppia batteria post-nineties di The Mistery<br />
of the Deep Blue Sea). La Squadra Omega è sicuramente<br />
una creatura meta-, che si prende la briga di risuonare<br />
tanta musica nota e di riprodurne l‘enunciazione, di<br />
96 97
i-enunciarla, rimetterla in pasto a chi già la conosce (i<br />
musicisti stessi, anzitutto). Il prodotto è quasi apocalittico,<br />
nell‘ambiguità funzionale che porta i membri della<br />
band a vestire una tunica e tingersi la faccia di nero prima<br />
dei live. Tattica e strategia. Più che un supergruppo,<br />
siamo di fronte una squadra, senza allenatore, con la<br />
regia affidata a un metodo - free form - che procede per<br />
sintonia tra i componenti. È detto tutto.<br />
(7.2/10)<br />
gaSPare caliri<br />
Steve mackay - SometimeS like thiS i talk<br />
(Polyglot, marzo 2011)<br />
Ge n e r e: j a z z r o c k<br />
Instancabile, febbrile, cazzone, capace di aspro lirismo<br />
e anarchica intensità, Steve Mackay è un sassofonista,<br />
anzi - per i rockettari impenitenti - QUEL sassofonista<br />
che sta fra i credits di Fun House, il formidabile secondo<br />
album degli Stooges. Tanto folgorante quel capitolo<br />
da mettere in ombra tutte le succesive voci curricolari,<br />
che pure sono disparate, annoverando collaborazioni<br />
con Jello Biafra, Violent Femmes, Dirtbombs e persino<br />
i nostrani Zu. Il qui presente Sometimes Like This<br />
I Talk - terzo album a suo nome - ci offre uno spaccato<br />
della propensione ad allestire combo più o meno (Radon<br />
Ensemble, Carnal Kitchen...) estemporanei per<br />
sbrigliare l’estro in bilico tra ipotesi free, rockaccio inacidito<br />
e cavalcate visionarie.<br />
Nelle tredici tracce in scaletta, tutte registrate live,<br />
Mackay compare da solo, in duo, terzetto, quartetto e<br />
via andare fino al nonetto (tra Mingus e l’hard rock) di<br />
Song For Baghdad. Un vero e proprio calderone di musicisti<br />
tra i quali ricorrono più spesso di altri i nomi del<br />
polistrumentista giramondo Kamilsky e del vecchio<br />
bucaniere della quattro corde Mike Watt. Peregrinazioni<br />
sordide e pensose (la splendida The Prisoner), motorismi<br />
psichici (gli Stereolab scorticati di Lament For The<br />
Leaving Of The Isle Of Lewis), rumbe erratiche (Lost In The<br />
Fog), boogie caciaroni (Dead Chevys), cabaret beffardi<br />
(Stradivarius’ Cat) ed esotismi elusivi (Rue Interdit d’Afficher),<br />
sono lo spettacolo d’arte varia di questo scellerato<br />
dinosauro che non ha perso il gusto di azzardare.<br />
(7.2/10)<br />
Stefano Solventi<br />
Steve wynn - wynn PlayS dylan (interBang<br />
recordS, marzo 2011)<br />
Ge n e r e: a l t c o u n t r y r o c k<br />
Deve essere stata davvero una bella serata, quel 13 agosto<br />
2009 all’Hana-Bi di Ravenna, quando Steve Wynn ed<br />
un manipolo di amici/colleghi (il sodale Chris Cacavas<br />
all’organo, la violinista Vicki Brown, la batterista nonché<br />
compagna Linda Pitman, il bassista Rigo Righetti<br />
ed il chitarrista Antonio Gramentieri) misero in piedi<br />
un tributo all’incommensurabile Bob Dylan. Mi chiedo:<br />
come si può, in pieno ventunesimo secolo, suonare<br />
ancora Dylan in maniera tanto convinta e convincente?<br />
Una possibile risposta ce la offre lo stesso Wynn nel<br />
bel documentario realizzato da Alessandro Quadretti,<br />
venti minuti di interviste ai protagonisti del concerto in<br />
questione, organizzatori compresi, scaricabile dal sito<br />
dell’etichetta grazie ad un codice fornito al momento<br />
dell’acquisto.<br />
L’ineffabile Steve, sollecitato a proposito dell’ars musicandi<br />
di Sua Bobbità, sostiene che uno dei principali e<br />
inossidabili motivi di fascino risiede nella capacità di<br />
escogitare testi e melodie con implicazioni molto profonde,<br />
per poi suonarle come se non gliene fregasse un<br />
cazzo. Con entusiasmo sgarbato, espettornado il cuore<br />
con tutti i graffi e la sporcizia del caso. Perché appunto<br />
la vita che t’ispira non è cosa - per così dire - edulcorata.<br />
Anzi, è una formidabile bastarda, quintali di veleno e<br />
immondizia per ogni grammo di bellezza. E questo, più<br />
o meno, spiega perché le nove tracce di questo Wynn<br />
Plays Dylan suonano tanto vive. Al punto che - rischiando<br />
la bestemmia - hai quasi la sensazione di non averle<br />
mai sentite accendersi con tale intensità.<br />
Sentitevi la travolgente Gotta Serve Somebody, una Isis<br />
satura d’irrequietezza o una deliziosamente infervorata<br />
Just Like A Woman. E che dire di quella The Groom’s<br />
Still Waiting At The Altar - dal controverso Shot Of Love<br />
- scudisciata di febbrile acidità contry blues? Alla fine<br />
l’episodio meno convincente è la conclusiva Knocking<br />
On Heaven’s Door, che vede gradito ospite Mr. Robyn<br />
Hitchcock nientemeno: difficile evitare il retrogusto<br />
didascalico con un pezzo tanto metabolizzato nell’immaginario<br />
collettivo, e a poco serve il piglio altrettanto<br />
genuino. Peso specifico altissimo in ogni caso per un<br />
disco che, mentre ribadisce doverosa devozione per il<br />
Bardo di Duluth, sottolinea la grandezza dell’ex sindacalista<br />
onirico.<br />
(7.5/10)<br />
Stefano Solventi<br />
StrokeS (the) - angleS (rough trade,<br />
marzo 2011)<br />
Ge n e r e: p o p -r o c k<br />
Angles arriva dieci anni dopo quel fulminante esordio<br />
che fu Is This It e a cinque anni di distanza dall’ultima<br />
prova della band, il moscissimo First Impressions Of<br />
Earth. Sarebbe anche troppo facile allora liquidare la<br />
faccenda come un goffo tentativo di tornare in pista<br />
highlight<br />
tu fawning - heartS on hold (city Slang, marzo 2011)<br />
Ge n e r e: a r t-r o c k<br />
Se riuscite ad immaginare una sorta di dark mood cameristico alla Black Heart Procession con teatrali<br />
voce male-female spesso in falsetto e paesaggi ritmici che rimandano anche al trip-hop, non siete lontani<br />
dai Tu Fawning.<br />
Collettivo avant-rock da Portland composto da Joe Haege (31Knots, Menomena) e Corrina Repp, più<br />
i neo-arrivati polistrumentisti Toussaint Perrault e Liza Rietz, i Tu Fawning sono una bella sorpresa per<br />
chi ami trasversalmente la teatralità meno cabarettistica di Tom Waits, certe aperture cameristiche<br />
sempre d‘ambito “rock” (alla Rachel‘s, ma senza l‘afflato post- ), tappeti ritmici da art-rockers in scia<br />
Williamsburgh e echi di atmosfere mitteleuropee (s‘aggira lontano, come un padre spirituale, lo spettro<br />
di Kurt Weill). Il tutto sempre condito da una spessa coltre di dark mood,<br />
variazioni arty su schema-canzone e strutture di base e un interessantissimo<br />
lavoro percussivo tra digitale e umano.<br />
Dal lavoro certosino dei quattro esce un album umorale, non ordinario, mai<br />
lineare; fatto di spigoli dolci, curve a gomito e splendide canzoni in cui l‘incessante<br />
ricerca e sperimentazione su mood, atmosfere e suoni si stratifica<br />
creando gemme multistrato. In questo senso, aiuta la capacità strumentale<br />
dei quattro, abili polistrumentisti in grado di variare e scambiarsi un quantitativo<br />
infinito di strumenti tra i più vari - dai fiati al piano, dal violino all‘organo oltre al quadrilatero rock<br />
per antonomasia - che contribuiscono alla eterogeneità della proposta. Con almeno due o tre capolavori<br />
(l‘ipnotica Multiply A House, Sad Story, la portisheadina I Know You Now) e un livello medio molto al<br />
di sopra della normalità, Hearts On Hold è l‘esordio che molti gruppi hanno solo sognato. Di diritto nella<br />
top-ten annuale.<br />
(7.5/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
con la scusa di mettersi in gioco. Ma altrettanto sbagliato.<br />
Perché qui gli Strokes si impegnano davvero, ci<br />
credono, provano sul serio a smarcarsi da se stessi (pur<br />
mantenendo fortissima la cifra della loro riconoscibilità;<br />
la voce di Casablancas, le chitarrine sgrattuggine<br />
ma in fondo pulite) e a maturare come gruppo creativo<br />
(con quello che infatti è il più collettivo dei loro album;<br />
Hammond Jr. e Fraiture forti delle rispettive esperienze<br />
solistiche). Una strada quasi obbligata per una band<br />
che, salvo un momento di ispirazione speciale, non poteva<br />
più limitarsi a riproporre la fotocopia del proprio<br />
suono e dei propri modi. Sommariamente meno rock<br />
e più pop, meno essenziale e più sfaccettato, il disco<br />
mette in scena un (impossibile) ritorno alla spontaneità<br />
che fu, nutrendosi però di suggestioni diverse: richiami<br />
all’elettro-pop Ottanta più melodico (sui quali era tutto<br />
costruito il Casablancas solista); strizzatine d’occhio<br />
al folk e alla psichedelia; tentativi di inspessimento del<br />
suono che orecchiano certo glam-prog enfatico alla<br />
Muse (vero punto debole di tutta l’operazione).<br />
I ragazzi riescono bene allora quando miscelano orecchiabilità<br />
immediata (l’opener Machu Pichu, reggaettino<br />
Ottanta nelle strofe e inciso strumentale che guarda<br />
a mondi latin tra Babe Ruth e Santa Esmeralda) e<br />
pop-rock con abiti casual (lo scanzonato uptempo del<br />
singolo Under Cover Of Darkness; la diafana ballad per<br />
“amanti moderni” Life Is Simple). Sono divertenti quando<br />
affondano nella naivete New Romantics (Two Kinds<br />
of Happiness, Games), giocano a sperimentare come<br />
possono (Call Me Back, intro con chitarrina quasi bossanova<br />
e finale lennoniano con valzerino deformato)<br />
o dicono di credere ancora nel R’n’R (il quadretto oldie<br />
soft-rollingstoniano Gratisfaction). Annoiano invece a<br />
morte quando si autoplagiano (il riempitivo firmato Valensi<br />
Taken For A Fool) e si fanno letteralmente odiare<br />
quando cercano di proporsi scuri e minacciosi - risultando<br />
invece solo monocromi e monotoni - andando<br />
giù di arpeggini, giri di basso e ritmiche pestate che<br />
imitano Muse e simili (la claustrofobica You’re So Right,<br />
annunciato secondo singolo; la schifosa - ci passate il<br />
98 99
tecnicismo? - Metabolism).<br />
Siamo i primi a non amare quelle recensioni che concludono<br />
paternalisticamente con un “Non gli si può davvero<br />
chiedere di più”: ma è proprio questo il nostro caso.<br />
(5.9/10)<br />
gaBriele marino<br />
SuBSonica - eden (emi, marzo 2011)<br />
Ge n e r e: s y n t h -r o c k<br />
Sesto disco per la band torinese ovviamente superatteso<br />
dai fan e perché no, anche dalla critica. I Subsonica<br />
restano, infatti, una delle band 90s più longeve nel panorama<br />
italico, e il lavoro precedente (L’eclissi) riusciva<br />
a coniugare rock e dance, proponendo qualche buona<br />
riflessione intimista che si accostava - mutatis mutandis<br />
- alla maturità over 30 degli Amari di Scimmie d’amore.<br />
Mixato da Mauro Pagani (tanto per non sbagliare), il<br />
nuovo disco, che segue una consolidata prassi di piccole<br />
rivoluzioni arrangiative, oscilla tra la collezione di singoli<br />
pronti per la radio e un vago leit motif sul paradiso<br />
perduto. Gli stessi Subsonica hanno dichiarato di avere<br />
avuto idee diverse all’inizio della lavorazione del disco.<br />
Le anime e le vocazioni del gruppo si sentono tutte: la<br />
vocalità melodiosa di Boosta, il quattro dritto di Samuel<br />
(che milita anche nei Motel Connection), il dubstep di<br />
Ninja e Max e l’indie di Vicio.<br />
Tra affondi nel drum’n’bass (Il diluvio), esperimenti autoironici<br />
di composizione collettiva (il testo del veloce<br />
electro-punk di Benzina Ogoshi è stato scritto assieme<br />
ai fan sul sito della band e ha per ritornello la frase “Non<br />
siete riusciti a bissare Microchip emozionale”), innocue<br />
prese di posizione contro il sistema finanziario (Prodotto<br />
Interno Lurido), il singolone marchio di fabbrica in midtempo<br />
(Istrice) e il sorprendente featuring retrò Ottanta<br />
dei Righeira (La funzione), il disco si assesta però su un<br />
livello medio che non esplode nè affonda.<br />
La professionalità non si discute, ma per il futuro, oltre<br />
che a rileggere e remiscelare il passato (vedi la presenza<br />
dell’anima reggae in più punti), sarebbe opportuno<br />
pensare a costruire una seconda parte di carriera più in<br />
linea con l’età media del gruppo, per non declamare un<br />
giovanilismo fuori tempo massimo. Per adesso, lasciamo<br />
che si divertano e facciano divertire i fan.<br />
(6/10)<br />
marco Braggion<br />
tBa (natalie Beridze) - forgetfulneSS<br />
(monika enterPriSe de, marzo 2011)<br />
Ge n e r e: el e c t r o p o p<br />
I tempi di Annulé sono lontani. Dal misto di pop e strappi<br />
avant di quello splendido lavoro, troviamo oggi Na-<br />
talie Beridze alle prese con un umbratile e insapore<br />
deutsch pop minimale solo sporadicamente piroettato<br />
sul fortunato mix di trip-hop, cyber e minimal techno<br />
che l‘aveva resa un caso nel 2005.<br />
Se Laurie Anderson e AGF rimangono le muse ispiratrici,<br />
TBA tenta la strada del confidenziale d‘autore. I fine<br />
‘80 brit di Tanita Tikaram e le umbratilità dream in coda<br />
al dream dei ‘90 sono i nuovi riferimenti ma a mancare<br />
sono purtroppo gli elementi fondanti del discorso, forza<br />
e ispirazione.<br />
Forgetfulness scorre lento e scialbo, fallendo sia nei<br />
momenti più intimisti sia in quelli ritmati e pop (The<br />
Face We Choose To Miss). E‘ un lavoro che tenta di evidenziare<br />
un mood personale professando invece solo<br />
un post-twee per trentenni depresse, nascoste dietro a<br />
un dito arty.<br />
(4.5/10)<br />
edoardo Bridda<br />
thank you - golden worry (thrill jockey,<br />
gennaio 2011)<br />
Ge n e r e: a v a n t r o c k<br />
Terrible Two era riuscito a decostruire il proprio universo<br />
di riferimento, e di fatto aveva fatto dei Thank You<br />
da subito un punto di riferimento per altre band e i critici.<br />
Le staffilate erano rese oblique da toni inaspettati<br />
di tastiera. Gli ingredienti non sono cambiati in Golden<br />
Worry. Ci sono le note vintage dei tasti bianconeri, le<br />
escursioni delle chitarre, il drumming costante. Manca<br />
- e questo non sempre lo si riesce a spiegare - la quadratura<br />
del cerchio magistralmente palpabile nell‘album<br />
precedente.<br />
La Thrill Jockey ci parla di loro come di coloro che meglio<br />
rappresentano l‘ambiente di Baltimore. In effetti si<br />
sente anche lo spirito (e non solo in Birth Reunion) di un<br />
altro protagonista della scena locale, il pluriapprezzato<br />
Dan Deacon. Non si riesce però a creare quello scarto<br />
che esca dall‘avant per essere di forza trascendente, o<br />
semplicemente per perforare le barriere di genere musicale.<br />
Il pubblico di Golden Worry è ancora quello del postmath<br />
e avant massimalista. La batteria è tra i responsabili<br />
della “normalizzazione”. Più per la facilità di essere<br />
incasellata in uno stile che per le qualità - indiscusse - di<br />
Emmanuel Nicolaidis, che anzi già all‘indomani di Terrible<br />
Two venne in aiuto di Jeffrey McGrath e Michael<br />
Bouyoucas (compagno di band nei More Dogs) e fece<br />
le veci del transfugo e neo-berlinese Elke Wardlaw.<br />
Né si può negare che i tre sappiano trascinare e mantenere<br />
una qualità elevatissima dell‘output (magistrale e<br />
ancora piena di inventiva la chiusura di Pathetic Magic,<br />
l‘apertura immediatamente successiva di Continental<br />
Divide, con un urlo di battaglia soffiato al flauto, eppoi<br />
tutto lo sviuppo del brano). Manca solo il guizzo e la<br />
capacità di sintesi. Che si traduceva in una maestria di<br />
costruire e gestire al meglio un thrilling. Quella tensione<br />
che oggi è un brillante “saper fare”.<br />
(6.7/10)<br />
gaSPare caliri<br />
timeS new viking - dancer eQuired (wichita<br />
recordingS, aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: s l a c k e r-G a z e<br />
<strong>Tim</strong>es New Viking, ovvero c‘era una volta lo shitgaze. A<br />
dimostrazione di come certe sigle e definizioni abbiano<br />
vita breve, ecco Dancer Equired. Le quattordici gemme<br />
per mezzora di musica del comeback del quartetto<br />
dell‘Ohio spostano ancora di un passo il baricentro delle<br />
musiche di Adam Elliott, Beth Murphy, Jared Phillips<br />
e Dustin White. Sempre meno rovinate e rovinose, più<br />
inclini alla forma canzone ripulita, virano verso paesaggi<br />
a tratti da americana o tradizionalmente indie-rock a<br />
stelle e strisce.<br />
Merito della riduzione dello shit- di cui parlavamo in<br />
apertura, quell‘insozzare le melodie che era insieme il<br />
tratto caratteristico e la necessaria virtù di tutta l‘ondata<br />
che dai Psychedelic Horseshit arrivava agli Eat Skull<br />
passando per una serie sterminata di bands. Ciò che<br />
resta è una indolenza tipicamente americana mista<br />
allo scazzo tardo-adolescenziale che sembra la cifra stilistica<br />
predominante in molti gruppi rock attuali. Quel<br />
rotondo autocompiacimento nell‘ammirare la propria<br />
sconclusionatezza e nel sentirsi pieni nell‘autodefinizione<br />
di “romantic nihilism”. Della serie, prendete pezzi<br />
come Ways To Go o Want To Exist e ditemi che non ci<br />
sono Pavement et similia dentro.<br />
Un passo deciso, quello compiuto dalla band di Columbus.<br />
Oltre ciò che erano i TNV fino a Born Again Revisited<br />
e verso quel qualcosa che ci auspicammo trovassero.<br />
Che sia nato lo slackergaze?<br />
(7/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
tormenta - la ligne ÂPre (africantaPe,<br />
feBBraio 2011)<br />
Ge n e r e: m a t h -n o i s e<br />
Una insana passione per lame e coltelli e un nome che è<br />
tutto un programma. Si presenta così l‘ennesima band<br />
alla conquista del mondo in nome della scena mathnoise<br />
strumentale francese: chitarre affilate come le<br />
lame dei coltelli distribuiti copiosamente nell‘artwork e<br />
una tempesta di suoni strumentali a ipotizzare un incro-<br />
cio tra Melvins e Hella. Dei primi riprendono stazza del<br />
suono, incedere pachidermico e svisate metal-oriented;<br />
dei secondi strutture mobili, florilegio strutturale e<br />
drumming da ossessione in cattività.<br />
Vertiginosi e circolari, tesi e vibranti, Vincent Beysselance<br />
(batteria, cello, basso), Jeff Grimal (chitarra, basso) e<br />
Esteban Rodiére (chitarra, basso) si infilano alla grande<br />
nella recente tradizione math d‘oltralpe - da Chevreuil<br />
a Passe Montagne, Marvin, Papaye, partendo da quegli<br />
Cheval De Frise dove alla chitarra agiva proprio Beysselance<br />
- fatta di energiche e originali aperture, momenti<br />
di pausa pneumatica ed esplosioni strumentali fragorose.<br />
Tutto in questo esordio si sviluppa sempre in nome<br />
di elaborate architetture mathy e di un suono che spesso<br />
e volentieri sconfina su territori metallosi: l‘iniziale<br />
Pagan (stop‘n‘go, scale vertiginose, cambi di ritmo da<br />
forsennati) o L‘Arche Interne, con quello spessore di chitarra<br />
che farebbe invidia a molti lungocriniti axemen,<br />
sono paradigmatiche di un suono possente e, per quel<br />
che consente il genere, piuttosto instabile e creativo.<br />
(6.9/10)<br />
Stefano Pifferi<br />
trent reznor/atticuS roSS - the Social<br />
network (the null corPoration,<br />
SettemBre 2010)<br />
Ge n e r e: e l e c t r o, a m b i e n t<br />
Con questa colonna sonora del premiato - ma non<br />
premiatissimo - film di David Fincher su Mark Zuckerberg<br />
e sulla nascita di Facebook, Trent Reznor corona<br />
la propria ventennale carriera con un Golden Globe e<br />
un Oscar. E’ una consacrazione che sviluppa in maniera<br />
assolutamente coerente il percorso iniziato con i Nine<br />
Inch Nails, e cioè la solita storia: da fenomeno di culto<br />
a fenomeno e basta.<br />
Il disco, firmato a quattro mani con l’ormai fido Atticus<br />
Ross (produttore inglese cointestatario con Reznor e<br />
la moglie Mariqueen Maandig degli How To Destroy<br />
Angels; ha iniziato la carriera al fianco di Barry Adamson),<br />
ha due anime che sono le facce della stessa medaglia:<br />
una ambient pianistica, romantica, e una electro<br />
ondosa, iterativa, ora dark, ora solare, che pesca - ovviamente<br />
- dai Kraftwerk fino all’electro-pop dei Depeche<br />
Mode. A un estremo troviamo quindi Sakamoto<br />
(la conclusiva Soft Trees Break the Fall) e all’altro tastiere<br />
kraut psych (Complication With Optimistic Outcome) che<br />
hanno più di un punto di contatto con il Tron dei Daft<br />
Punk. Il concetto di sviluppo è relativo (siamo in un disco<br />
post-minimal e post-electro, che per giunta è una<br />
colonna sonora), in una suite chiaroscurale dove contano<br />
invece le oscillazioni della materia e il dosaggio di in-<br />
100 101
highlight<br />
tune-yardS - whokill (4ad, aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: p o p<br />
Un talento puro, Merrill Garbus, a.k.a. tUnE-yArDs. Lo era e lo rimane. Questa è la sostanziale conferma<br />
di Whokill, secondo album della montrealina oggi residente a Oakland, California. Un cambio di contesto<br />
e di everyday life che non può che riflettersi nella musica di colei che aveva fatto della “focolare”<br />
della stanzetta e della quotidianità un catalizzatore di musica con l‘anima e<br />
col sorriso.<br />
Primo risultato: il banjo è appoggiato al muro, e al suo posto compaiono<br />
l‘elettricità delle chitarre e una nuova aggressività tutta positiva che mordicchia<br />
l‘ascoltatore coi denti più affilati, ma giocosi di un gatto urbanizzato.<br />
Ma anche con una musica che è diventata ancor più black dell‘esordio, forse<br />
per il contrasto maggiormente tangibile tra il calore della voce di Merrill e il<br />
controllo dell‘output strumentale.<br />
Il collante è come spesso avviene una percussività trascinante e certosina<br />
(Gangsta), già tratto potenziale di Bird-Brains. Esiste però anche un metodo con cui perseguirla, una<br />
focalizzazione precisa, che sfonda in Whokill. C‘è, dietro alle canzoni, una grande coesione costruttiva,<br />
che non finisce mai di stupire nella Garbus, ma anche l‘altra principale variazione di contesto rispetto<br />
a due anni fa: il lavoro in studio. Oggi Merrill ha uno studio professionale - che peraltro la 4AD non ha<br />
mancato di documentare, con video di Tune- all‘opera su microfoni e tracce - e un ingegnere che la segue,<br />
Eli Crews. Gli spunti di progressione minimalista di Bird-Brains possono quindi diventare ciò che<br />
sono oggi, costrutti di produzione che non perdono una virgola - almeno nella prima parte dell‘album<br />
- di efficacia, anzi ci rapiscono al primissimo ascolto.<br />
Nell‘innesto tra le nuove dinamiche urbane e quelle produttive Merrill tesse un filo sotto al testo. Non<br />
solo le chitarre sostituiscono il banjo, ma a tratti si fanno quasi atonali (Es-so), escono i riff di fiati da<br />
Contorsion-isti (My Country) e in generale un sottotesto di riferimenti alla NYC mutante (Killa), che si<br />
alternano alla trasognata rassegnazione dei pezzi sottovoce (Wooly Wooly Gong). E sono solo due dei<br />
mondi possibili, analizzati scientificamente e di testa, oltre che di cuore. In questo sta la scommessa<br />
che puntiamo su Merrill: è il potenziale di sovrapporre la ricerca e il lavoro che sta sotto alle canzoni al<br />
talento su cui contiamo e continueremo a contare.<br />
(7.4/10)<br />
gaSPare caliri<br />
gredienti sempre diversi per insaporire la comune base<br />
di partenza: l’acqua versata di 3:14 Every Night, il riffone<br />
elettrorock di Carbon Prevails, la parossistica versione<br />
de Nell’altro del re della montagna, la cavalcata percussiva<br />
di Magnetic, lo scandire metronomico con il piano in<br />
controtempo di Almost Home.<br />
Un ottimo bignamino di electro atmosferica e un ottimo<br />
prodotto, costruito per piacere ai fan del post-NIN<br />
ma anche alle platee hollywoodiane tra smoking e pellicce.<br />
(7.2/10)<br />
gaBriele marino<br />
vaccineS (the) - what did you exPect from<br />
the vaccineS (columBia recordS, marzo<br />
2011)<br />
Ge n e r e: b r i t p o p ‘10<br />
Ci pensate? Si sono formati appena nove mesi fa, i Vaccines,<br />
e oggi debuttano al quarto posto in classifica.<br />
Cose dell‘altro mondo - quel mondo aldilà della Manica,<br />
dove i dischi si vendono ancora, i concerti sono affollati<br />
e frequenti, le riviste di settore sono lette (e persino tenute<br />
in considerazione, incredibile). Un piccolo miracolo<br />
anche di questi tempi, a ben vedere, se pensiamo che<br />
proposte omologhe e non meno valide come Chapel<br />
Club e Mirrors hanno avuto riscontri inferiori di pubblico<br />
e critica (il culto, si sa, è altra faccenda). Questi quattro<br />
ragazzi di Londra hanno dalla loro un‘immediatezza<br />
e un impatto che non sono sfuggiti né alla Columbia né<br />
a quelli della BBC, che sulla spinta di un solo singolo li<br />
hanno prontamente segnalati come “il” nome del 2011.<br />
Ad ascoltare quel singolo, Wreckin‘ Bar (Ra Ra Ra), viene<br />
proprio da dargli ragione: un minuto e ventidue (!) di<br />
Ramones / Phil Spector in salsa garage-shoegaze, con<br />
un canto a voce piena che niente ha a che vedere con<br />
le declinazioni wave a cui l‘indie albionico - e non - ci<br />
ha sin troppo assuefatti. Questo perché il frontman, Justin<br />
Young, fino all‘altroieri era un cantautore new-folk<br />
e si faceva chiamare Jay Jay Pistolet. Approccio da songwriter<br />
dunque (un po‘ alla Billy Bragg, alla lontana),<br />
ed è questo che fa davvero la differenza e rinvigorisce<br />
il carattere di un progetto che altrimenti si reggerebbe<br />
esclusivamente su un paio di intuizioni molto efficaci,<br />
certo, ma destinate inevitabilmente a soffrire la lunga<br />
distanza.<br />
Cosa che in parte avviene perché What Did You Expect<br />
From The Vaccines, pur veloce e digeribile nella sua<br />
mezzoretta di durata, vive di alti e bassi: ci piacciono<br />
molto le schegge adolescenziali punk-pop come Norgaard<br />
(occhio alla storia sulla modella diciassettenne<br />
svedese) If You Wanna e Wolf Pack, così come le chitarre<br />
rumorose che guardano all‘America di Blow It Up; un po‘<br />
meno certe vocazioni innodiche alla Glasvegas (e che<br />
un fulmine ci colga se nella ballata All In White non fa<br />
capolino Chris Martin). La formula alterna le coordinate<br />
sopraccitate, in un potenzialmente infinito gioco di rimandi<br />
che però riconduce a un‘identità assolutamente<br />
riconoscibile. È certo un bene. E le canzoni? Sulla base<br />
della hit indie Post Break-Up Sex (gli Interpol fronteggiati<br />
da John Grant su parole di Jarvis Cocker?) e dei bei<br />
lentoni Wetsuit e Family Friend (hidden track compresa),<br />
non possiamo che constatare che c‘è trippa per gatti, e<br />
il meglio può (deve!) ancora venire. Non ci stracciamo le<br />
vesti, no - ci limitiamo a stappare una bottiglia di buon<br />
vino per i bei segnali che continuano a provenire dal<br />
Regno in questo primo scorcio di anni ‘10.<br />
(7/10)<br />
antonio Puglia<br />
valentina gravili - la Balena nel tamigi<br />
(autoProdotto, aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: p o p d’a u t o r e<br />
A dieci anni dal premio Ciampi vinto per il miglior disco<br />
d’esordio con Alle ragazze nulla succede a caso, torna<br />
Valentina Gravili, portando in dote la consueta leggerezza.<br />
Un piede nella tradizione popolare e uno in un<br />
cantautorato pop immediato e poetico, oltre le facili<br />
analogie - i rimandi a Cristina Donà e Carmen Consoli<br />
ci sono ma quasi non si vedono - e verso una formula<br />
sempre più riconoscibile. Merito di una scrittura puntuale<br />
ma anche dell’ottimo lavoro di Max Baldassarre,<br />
Silvio Trisciuzzi e dell’ex Lula/Lotus Amerigo Verardi.<br />
Fondamentali in sede di produzione artistica nell’arricchire<br />
il materiale con una gamma di colori che aggiorna<br />
il “melodico” della Gravili donandogli naturalezza e<br />
personalità.<br />
Synth, chitarre elettriche, percussioni, certi fondali stratificati<br />
ai confini con la psichedelia (La malafede), dei<br />
Baustelle declinati in salsa Sufjan Stevens (La balena<br />
nel Tamigi): la Gravili rimane sempre in bilico tra serietà<br />
e atmosfere giocose, un po’ come faceva con le parole<br />
quel Gianni Rodari che viene in mente leggendo l’insolito<br />
titolo del disco (ripreso invece da un fatto realmente<br />
accaduto). Fuori dai giri “giusti” ma alla fine capace<br />
di mettere l’anima in un disco che conferma la statura<br />
artistica di una musicista sensibile e trasparente.<br />
(7.1/10)<br />
faBrizio zamPighi<br />
van der graaf generator - a grounding in<br />
numBerS (eSoteric, marzo 2011)<br />
Ge n e r e: p r o G<br />
Diamo un po’ di numeri: sei anni dopo l’inattesa reunion,<br />
tre dal discreto predecessore Trisector, arriva l’album<br />
numero dodici per l’accolita Van Der Graaf Generator,<br />
ridotta a trio ma pur sempre di membri originali (il leader<br />
Peter Hammill, il bassista e organista Hugh Banton<br />
ed il batterista Guy Evans). Inoltre, la data di uscita del<br />
disco (il 14 marzo) non è affatto casuale, essendo stata<br />
scelta per riferirsi alle prime tre cifre della costante π<br />
(pi greco, per gli amici). C’è poi il titolo, A Grounding<br />
In Numbers, e ci sono tracce in scaletta intitolate Mathematics<br />
e 5533. Ok, stiamo scherzando, ma neanche<br />
troppo, perché coi vecchi progster il lambiccato è una<br />
norma, ne costituisce la poetica profonda e l’effervescenza<br />
superficiale.<br />
Da sempre campioni nel conciliare questi due livelli<br />
dell’espressione, i VDGG ci propongono oggi un lavoro<br />
sì complesso ma accomodante, all’insegna del lirismo<br />
perentorio di Hammill (l’intatta prestanza della voce<br />
ha un che di prodigioso) e d’un piglio rockista turgido<br />
ancorché arzigogolato di sincopi, ruggiti acidi, bordoni<br />
cosmici, spasmi preterintenzionali e gorghi misterici.<br />
Non stupisce certo il dominio gagliardo di timbri e dinamiche,<br />
la ricchezza essenziale degli arrangiamenti (non<br />
l’avrei detto, ma l’assenza dei fiati di David Jackson non<br />
rappresenta affatto un handicap). Sorprende semmai<br />
l’ostinazione entusiastica di un verbo tanto obsoleto,<br />
che fa sembrare freschi pezzi come Mr. Sands, Bunsho,<br />
Medusa o Highly Strung, altrettante gradevoli ucronie<br />
102 103
per chi non ha mai perdonato alla Storia la disfatta delle<br />
traiettorie progressive.<br />
Un buon disco per appassionati del genere: banale<br />
uscirne così, ma vero.<br />
(6.9/10)<br />
Stefano Solventi<br />
vickerS (the) - fine for now (foolica,<br />
marzo 2011)<br />
Ge n e r e: b r i t-r o c k<br />
La bandiera inglese stampata sui boxer ritratti in copertina<br />
qualcosa vorrà pur dire. Nessuna sorpresa, dunque,<br />
se questo Fine For Now ribadisce che i Vickers sono uno<br />
dei gruppi più brit della scena nostrana e non aggiunge<br />
quasi nulla a quanto già sapevamo. Del resto su certe<br />
forme di fedeltà al modello inglese formazioni come gli<br />
A Toys Orchestra hanno costruito una carriera - pur con<br />
le evidenti differenze di stile - e sarebbe ingiusto penalizzare<br />
i Nostri per aver seguito la lezione alla lettera.<br />
Anche perché il terzo disco dei Vickers - l’ultimo era<br />
l’Ep Sofa Sessions - rassicura e conferma. In primis che<br />
la fiducia che avevamo concesso alla band ai tempi di<br />
Keep Clear era ben riposta e poi che il praticantato delle<br />
nostre band all’estero passa soprattutto per produzioni<br />
come questa. Tanto che in Fine For Now mettono<br />
lo zampino figure di primo piano come Steve Orchard<br />
(Paul McCartney, Pulp, U2) e John Astley (Stereophonics),<br />
per un suono cristallino che cita i Libertines e spara<br />
fuori piccole gemme pop come Chem Dream.<br />
Va bene così per ora, ci comunica la band. Noi sottoscriviamo,<br />
in attesa di un eventuale cambio di rotta che potrebbe<br />
regalare ottimi spunti di riflessione.<br />
(6.9/10)<br />
faBrizio zamPighi<br />
walter Beltrami - ParoxySmal PoStural<br />
vertigo (auand, maggio 2011)<br />
Ge n e r e: j a z z r o c k<br />
Tra i chitarristi emergenti più apprezzati in ambito jazz,<br />
Walter Beltrami vanta già tre dischi a suo nome prima<br />
del presente Paroxysmal Postural Vertigo, titolo che<br />
si riferisce ad una patologia di cui ha sofferto realmente<br />
nel periodo che lo ha visto comporre nove delle dieci<br />
tracce in scaletta (essendo Unexpected Visit frutto improvvisato,<br />
non lontano dalle astrazioni del Wayne<br />
Shorter più sperimentale). La vertigine è quindi l’elemento<br />
chimico che fa precipitare i pezzi tra groove<br />
funk-rock serrati (Seamont’s Manoeuvre) e tensioni quasi<br />
art-wave (BPPV), concedendosi tregua pensosa con le<br />
suggestioni misteriche di What Is (minimalismo atmosferico,<br />
ipnotiche reiterazioni, struggimenti incrociati di<br />
chitarra, sax e violoncello) e la malinconia cinematica<br />
di You See.<br />
Giusto ricondurre al leader anche i meriti della band,<br />
un quintetto che annovera tra gli altri un ispiratissimo<br />
Francesco Bearzatti (al sax tenore e clarinetto) ed un<br />
sontuoso Vincent Courtois al violoncello. Detto che<br />
Lilienthal è l’episodio più intrigante con le sue convulsioni<br />
mingusiane e le scaramucce free, occorre riferire<br />
di una #2 che azzarda curiosa ibridazione tra incalzante<br />
riff hard ed un mesto binario sax-cello solcato di vampe<br />
portentose, costrutto un po’ forzato però alla resa dei<br />
conti efficacissimo. Disco godibile con picchi di superbo<br />
lirismo.<br />
(7.2/10)<br />
Stefano Solventi<br />
yelle - Safari diSco cluB (downtown,<br />
marzo 2011)<br />
Ge n e r e: po p, da n c e<br />
Julie Budet, in arte Yelle, è una pop singer francese salita<br />
alla ribalta in patria grazie a MySpace e poi atterrata<br />
anche all’estero quattro anni fa con l’esordio Pop Up.<br />
Questo secondo Safari Disco Club perfeziona e impreziosisce<br />
la formula dell’esordio con una produzione più<br />
imponente e una propensione netta verso l’electropop:<br />
un territorio in cui la voce della nostra si muove con sicurezza,<br />
donando un po’ di colore al fantasma di una<br />
Vanessa Paradis e impartendo più di una lezione alla<br />
meteora Alizèe.<br />
Difficile comunque immaginare che i fasti commerciali<br />
possano essere i medesimi: troppo di genere la proposta,<br />
troppo poco incisivi i brani per abbordare le classifiche,<br />
troppo poco personale lei per un mainstream<br />
sempre più a caccia di icone riconoscibili. E anche guardando<br />
al lavoro in sè, non siamo di fronte a qualcosa per<br />
cui rimanere a bocca aperta: Safari Disco Club è niente<br />
più e niente meno di ciò che il titolo dichiara, ovvero<br />
un treno dance-pop che procede a velocità costante<br />
dall’inizio alla fine. Nessun cambio di atmosfera anche<br />
vago, niente che risollevi l’ascoltatore dalla monotonia<br />
che si fa gradualmente largo traccia dopo traccia. Fatto<br />
salvo il singolo Que Veux Tu non si incontra in tutto<br />
l’album un solo vero guizzo, nè in senso strettamente<br />
musicale nè in senso qualitativo.<br />
E’ un peccato: anche perchè, prestando bene orecchio,<br />
si capisce che c’è comunque un lavoro notevole dietro<br />
a questi brani, frutto di una buona conoscenza di tutto<br />
ciò che va dal primo synth pop degli anni 80 al revival<br />
electro degli anni 00. Mancando però il coinvolgimento<br />
emotivo ecco che l’unico contesto funzionale diventa<br />
quello di un dancefloor, magari dei più frivoli: allora sì<br />
che episodi come Unillusion o Comme Un Enfant troverebbero<br />
facile spazio, magari tra un brano di Goldfrapp<br />
e uno di Ladyhawke.<br />
(5.2/10)<br />
Simone madrau<br />
young kniveS - ornamentS from the Silver<br />
arcade (gadzook, aPrile 2011)<br />
Ge n e r e: in d i e r o c k<br />
Next Big Thing nel 2006 con l’esordio Voices of Animals<br />
and Men (nominato Mercury) e rappresentanti dell‘indie<br />
più genuino nel sophomore Superabundance, gli<br />
Young Knives sono stati dei tardivi nerd dell’angular.<br />
Non hanno mai avuto nulla da invidiare a Wombats e<br />
altri fenomeni mid-2000, ma senza un leader che che<br />
ne catalizzasse l’immaginario (vedi per dire Eddie Argos<br />
degli Art Brut) e le giuste tempistiche, rischiavano seriamente<br />
d’implodere con gli stessi noughties.<br />
Il nuovo, Ornaments From The Silver Arcade, terzo disco<br />
prodotto da Nick Launay (già al lavoro con Arcade Fire,<br />
Nick Cave e molti altri) è dunque un banco di prova<br />
molto importante per il terzetto: pena la retrocessione,<br />
o peggio, lo scioglimento.<br />
In tempi di wave e sintetiche spinte, gli YK scelgono coraggiosamente<br />
di rimanere dentro ai binari del guitar<br />
pop concedendosi alla contemporaneità con giusto<br />
qualche tocco elettronico (senza gli archi della prova<br />
precedente) e regalandoci una manciata di pop ottimamente<br />
confezionato.<br />
L’agrodolce Sister Frideswide, i momenti power pop<br />
(Glass House), le marcette sarcastiche (Love My Name),<br />
i tocchi wave (Everything falls into place), le complicazioni<br />
(Vision Of Rag con cambi tempo, siparietti, cori e<br />
controcanti) e persino le incursioni in territori Muse-y<br />
(Storm Clouds) formano un caleidoscopio di grande pop<br />
britannico, di quello che non cerca clamori ma va dritto<br />
al cuore della faccenda. Per chi ama la qualità nella musica<br />
inglese prima di tutto, un gran bell’album.<br />
(7.2/10)<br />
edoardo Bridda<br />
zaBriSky - fortune iS alwayS hiding<br />
(Shyrec recordS, marzo 2011)<br />
Ge n e r e: r o c k<br />
Gli Zabrisky mostrano una cifra stilistica popular e condivisa<br />
analoga a quella dei Gurubanana di Giovanni<br />
Ferrario (qui presente nel ruolo di produttore) e Andrea<br />
Fusari, sospesa com’è tra un citazionismo marcato e la<br />
capacità di rimanere sul pezzo senza ammiccamenti<br />
gratuiti. Tanto che quello che a una qualsiasi altra formazione<br />
non perdoneresti, il fatto cioè di apparire fin<br />
troppo didascalica nell’opera di rielaborazione del proprio<br />
scibile rock, negli Zabrisky ha tutto l’aspetto del<br />
punto centrale del discorso. La base affettiva da cui partire<br />
per rendere credibile un suono altrimenti fin troppo<br />
identificabile.<br />
E’ così che nel disco convivono i Jesus & Mary Chains<br />
di Summer Is Always Grey e i Beatles di Calling Home,<br />
i Libertines di Getting Better So Far e i Byrds di Stone<br />
Inside, i Dandy Warhol di Good Company e i R.E.M. di<br />
Better <strong>Tim</strong>es. Compressi in brani da due minuti e mezzo,<br />
proiettati in un simposio di chitarre jingle-jangle e<br />
irresistibili armonie vocali, nobilitati da una psichedelia<br />
decodificabile e tutto sommato rassicurante. La vera<br />
differenza in questo caso la fa la scrittura, non la ricerca<br />
forzata di un linguaggio che magari non ti apparterrebbe<br />
nemmeno. Quella si, perfettamente a fuoco nel suo<br />
dinamismo nomade e folgorante.<br />
(7.1/10)<br />
faBrizio zamPighi<br />
zzolcheStra - zzolcheStra (Parade,<br />
novemBre 2010)<br />
Ge n e r e: j a z z-r o c k<br />
Di orchestra a tutto tondo si tratta, con tanto di sezione<br />
fiati (sax tenore, cornetta e baritono), vibrafono, basso,<br />
batteria, theremin, piano, violoncello, chitarra. Costruita<br />
attorno al responsabile del progetto Alberto Danielli,<br />
docente di biologia evoluzionistica qui nelle vesti di un<br />
direttore dei lavori creativo e capace.<br />
Elementi dei Mariposa (Enzo Cimino, Valerio Canè)<br />
si mescolano a musicisti di diversa estrazione (Alberto<br />
Polese, Andrea Rigatti, Elena Maestrini, Giovanni<br />
Gonano, Massimiliano Gollini, Antonio Sodano,<br />
Paolo Bottacin, Gianbattista Tornielli) per dar vita a<br />
una misticanza di linguaggi: quelli “classici” di Archie<br />
Shepp, Charles Mingus e del Liberation Music Orchestra<br />
di Charlie Haden, ma anche quelli di un rock-blues<br />
contaminato (le chitarre elettriche di Seicinque, le dodici<br />
battute al vibrafono di Alblues) e di un funk rielaborato<br />
in tono orchestrale (Romeo).<br />
Bella la familiarità che riesce a trasmettere il disco, lontana<br />
dai virtuosismi fini a sè stessi e tesa verso una coralità<br />
di sostanza e assolutamente convincente.<br />
(7.2/10)<br />
faBrizio zamPighi<br />
104 105
Gimme Some<br />
Inches #15<br />
Nuovo mese, nuovi giri di vinile grandi e piccoli, con sconfinamenti<br />
anche sul terreno del cd-r. Mi Ami, Lettera 22, Big’n, Lost<br />
Tribe, Welles, Guinea Pig e chi più ne ha più ne me metta.<br />
I tempi d’oro del noise-rock a stelle<br />
e strisce sembrano sul punto di<br />
ritornare. Quanto si tratti di mero<br />
revival à la page o genuina rinascita<br />
di un suono viscerale e claustrofobico,<br />
figlio dei tempi caliginosi e<br />
grami, lo dirà la storia. Per ora accontentiamoci<br />
della musica. Del<br />
10” ep dei Big’n, Spare The Horses,<br />
ad esempio. Pubblicato molti<br />
anni dopo la dipartita della band e<br />
come “unfinished business” grazie<br />
all’appoggio di una sempre più vinilica<br />
AfricanTape – a breve vedranno<br />
la luce il 12” Bon Sauvage dei<br />
Ned, due ep gemelli targati Oxes<br />
il 7” degli svizzeri Honey For Petzi<br />
– il vinile vede distribuiti quattro<br />
pezzi tra lato a e lato b. Tra avvitamenti<br />
da blues deformato (Assholes<br />
& Elbows) e tribalismo spastico<br />
(Long Pig) reminiscente Butthole<br />
Surfers, stop’n’go killer, vocals al vetriolo<br />
e bassi pachidermici (Like A<br />
Killer), il trio chicagoano mostra di<br />
non essere mero comprimario sulla<br />
scena noise-post di fine millennio.<br />
Ottimo anche l’album di b-sides e<br />
rarità Dying Breed da poco uscito<br />
sempre per la label di Julien Fernandez.<br />
Chi invece sembra allontanarsi<br />
dal chitarrismo isterico e postpunk<br />
degli esordi sono i nostri<br />
cari Mi Ami. Perduto per strada<br />
un pezzo (il bassista Jacob Long) e<br />
non si sa se sostituito o meno, l’ex<br />
trio losangelino sembra essere influenzato<br />
sempre più dalle svisate<br />
techno-vintage del suo leader Daniel<br />
Martin-McCormick, già passato<br />
per queste pagine col suo progetto<br />
Ital. Se i 12” Cut Men e Techno mostravano<br />
il fascino per l’elettronica,<br />
ora Dolphins, un quattro pezzi targato<br />
Thrill Jockey, vira decisamente<br />
verso l’elctro con un concentrato di<br />
“dystopian refraction of left-field<br />
new age, lush soundscapes and Italo<br />
daydreams” che a noi, amanti del<br />
suono nevrotico e convulsamente<br />
rock degli esordi lasciano un po’ di<br />
amaro in bocca.<br />
Saltando a piè paro da un sup-<br />
porto ad un altro, segnaliamo la<br />
meritoria operazione targata Bloody<br />
Sound Fucktory. L’etichetta<br />
marchigiana non paga di immettere<br />
sul mercato dischi sempre più<br />
focalizzati sul concetto di rumore<br />
rock, inaugura una nuova serie.<br />
“Ectoplasmi” è dedicata a dischi<br />
maledetti, perduti, dimenticati o<br />
mai usciti ma meritori di menzione.<br />
Prime uscite, i prime-movers Guinea<br />
Pig col noise-rock alieno di 2,<br />
e due solo-projects: Welles, sigla<br />
che nasconde Massimo Audia (Tutelo,<br />
Satantango) e Mr. Whore aka<br />
Francesco Villotta. In mezzora i Guinea<br />
Pig mostrano di essere stati un<br />
combo seminale per il rumore di<br />
quelle zone, a furia di noise mai irruento,<br />
cosmico, alienato, ossessivo<br />
e inclassificabile. Menzione d’onore<br />
per la sguaiata XXX e la sboccata<br />
In The Court Of The Burger King. A<br />
ruota Mr. Whore con la sua paranoia<br />
per chitarra acustica. Un Alfabeto<br />
è sgembo e irrituale, enigmatico<br />
ed evanescente (blues)rock non<br />
convenzionale, ma anche un po’<br />
acerbo nel songwriting. A chiudere<br />
il progetto di modernariato rock di<br />
Massimo Audia, aka Welles, il cui<br />
Radical Shit è un caleidoscopio di<br />
follie rock-oriented da cameretta.<br />
Electro e rock, stranezze zappiane<br />
e memorabilia post-moderna scritta<br />
con gusto e classe, ma anche<br />
con tanta autoironia. Dei tre, forse<br />
quello che meriterebbe maggiore<br />
visibilità. Siamo anche sicuri però<br />
che è quello a cui importa meno.<br />
Nella nostra eterna azione<br />
di setaccio dei fondali più luridi<br />
dell’underground virtuale ci siamo<br />
imbattuti in una delle scoperte più<br />
gustose di questo mese: i Lost Tribe<br />
di Richmond. Formati da membri<br />
di gruppi crust a stelle&strisce<br />
come SSR, Syndrome e Aghast, i<br />
ragazzi in nero della Virginia hanno<br />
già da qualche mese rilasciato una<br />
cassetta autoprodotta, sfuggitaci di<br />
primo acchito ma oggi saldamente<br />
nelle nostre mani. The Dawn vomita<br />
cinque pezzi di pesante caratura<br />
dark-punk, intrecciando incubi<br />
in perfetto equilibrio tra T.S.O.L.,<br />
Christian Death e i primissimi Killing<br />
Joke, tra tensione hardcore e<br />
macabro lirismo goth. Un debutto<br />
sorprendente, una band da seguire.<br />
Tornando alla nostra safe european<br />
home troviamo ad attenderci<br />
Kim Larsen e il nuovo singolo di Of<br />
The Wand And The Moon. Shine<br />
Black Algiz consta di due pezzi inediti<br />
che introducono The Lone Descent,<br />
il prossimo album del danese,<br />
sul quale però non figureranno.<br />
Il primo una preghiera sommessa,<br />
il secondo una ballata contagiosa.<br />
Come è logico attendersi dalle<br />
pubblicazioni di area brown&grey,<br />
grande cura del packaging con il 7”<br />
in edizione picture e la copertina<br />
con incisione dorata a sbalzo. Più di<br />
così…<br />
Nei patri confini invece ci da il<br />
bentornato una pioggia di rumore<br />
targata Second Sleep e A Dear Girl<br />
Called Wendy, label dedite al noise<br />
più intransigente, rispettivamente<br />
da Vittorio Veneto e Milano. La prima<br />
ha appena licenziato una nuova<br />
infornata che comprende tapes<br />
per gli svedesi Negative, duo in<br />
stile CCCC con l’immancabile Dan<br />
Johansson di Sewer Election e Ättestupa,<br />
e i danesi Alleypisser provenienti<br />
dal giro della Posh Isolation e<br />
artefici di due foschi episodi a base<br />
di organo e tape loops, e un 12<br />
pollici one-sided a nome Endless<br />
Sea, uno dei vari progetti con cui<br />
Matteo Castro, tenutario della stessa<br />
etichetta, si diletta in assalti di<br />
elettronica arrugginita, condita da<br />
scarti concreti e sporcizia industriale.<br />
Dei Lettera22, duo che coinvolge<br />
il sopra citato Matteo e il sodale<br />
Riccardo Mazza, si occupa invece A<br />
Dear Girl Called Wendy, che proprio<br />
in questi giorni rilascia True Form,<br />
LP introdotto dal distintivo artwork<br />
a collage divelto e contenente due<br />
lunghe tracce per immancabili feedback,<br />
clangori, overload, stridori,<br />
frastuoni e tutto il necessario per<br />
farsi male alle orecchie. Un modo<br />
appropriato per salutare l’arrivo<br />
della bella stagione.<br />
Stefano Pifferi<br />
106 107
Re-Boot #14<br />
è deliziosamente schizofrenico questo inizio primavera. E’ un ribollire<br />
di stili e umori. Il nostro consueto setaccio mensile tra le<br />
emergenze italiche.<br />
Nati da una costola degli Ojm – il<br />
link tra le due formazioni è Alessandro<br />
Tedesco – Glincolti sono<br />
un quartetto chitarra elettrica,<br />
batteria, synth e basso. Pochi dubbi<br />
in merito al genere proposto:<br />
jazz-prog-rock-blues strumentale<br />
con qualche velleità psichedelica<br />
rubata ai Quicksilver Messenger<br />
Service e a Jimi Hendrix (Ferma<br />
un momento). La grafica del disco<br />
contestualizza il gruppo come un<br />
figlioccio de Il banco del mutuo<br />
soccorso o degli Osanna, ma in<br />
realtà il suono di Visti e imprevisti<br />
(6.9/10, Go Down Records) stà più<br />
dalle parti dei King Crimson (Fili<br />
scoperti). Aggiornati grazie a una<br />
nervatura funk che finisce per personalizzare<br />
il tutto nella giusta maniera<br />
e senza suonare stucchevole.<br />
Cantautorato al femminile di<br />
scuola americana per Giulia Millanta.<br />
I Novanta di Ani Di Franco<br />
(Right Between The Eyes) sublimati<br />
da un folk trasversale che dialoga<br />
col jazz (Dropping Down), omaggia<br />
Jeff Buckley (The Tunnels Of My<br />
Brain), suona un blues pop che sarebbe<br />
piaciuto anche ai Beatles (A<br />
Long Dark Road). Spregiudicatezza<br />
di chi è sicura dei propri mezzi ma<br />
anche arrangiamenti ben calibrati<br />
(organo, violino, sax, chitarre, basso<br />
e batteria la strumentazione) fanno<br />
di Dropping Down (6.7/10, Ugly<br />
Cat) un disco con molte potenzialità<br />
e pochi difetti. Tra questi ultimi,<br />
una rilettura di Paranoid dei Black<br />
Sabbath a cui forse manca il coraggio<br />
di osare fino in fondo.<br />
Suggestioni soffici di chitarra<br />
acustica e sospiri, per il primo lavoro<br />
di Ed, A Quick Goodbye (autoprodotto;<br />
6,4/10). Quattordici<br />
brani, in devoto omaggio a Ellioth<br />
Smith, Beatles, Bright Eyes e tutto<br />
quel sound vellutato di un cantautorato<br />
appeso fra malinconico e sognante.<br />
Tuttavia, a riuscire meglio<br />
in questo esordio sono gli innesti<br />
più duri e decisi di chitarra elettrica<br />
Un mese di ascolti<br />
emergenti italiani<br />
o organo hammond, suonati con<br />
tipico appiglio Sixties, sempre sul<br />
pezzo, mai fuori le righe. Consigliato<br />
a tutti i malinconici, i nostalgici<br />
o semplicemente a chi ha voglia di<br />
tuffarsi in un clima retrò, chiudere<br />
gli occhi e lasciarsi andare.<br />
Nuovissimo e freschissimo il<br />
secondo Ep degli Antenna Trash,<br />
dal titolo Ded Comes For Ded (autoprodotto,<br />
7.0/10). Il quartetto<br />
veronese propone una manciata<br />
di canzoni dall’attitudine electropunk<br />
e dai rigurgiti da dance floor.<br />
Fra synth con derive psichedeliche<br />
e vortici di distorsioni frizzanti, tengono<br />
alto il nome del nu rave, personalizzandolo<br />
con uno stile per<br />
nulla scontato che a tratti si accosta<br />
alla new wave più godibile. Dall’asse<br />
Depeche Mode-Editors vengono<br />
fuori i brani più accattivanti, con<br />
delle contorsioni vocali che, pur se<br />
oscure e profonde, non rinunciano<br />
alla melodia. Da tener d’occhio.<br />
Ecco a voi un duo smoderatamente<br />
orgoglioso di annunciare il<br />
proprio esordio. Parliamo dei Farewell<br />
To Heart And Home ovvero<br />
Diego Boboli e Una, entrambi po-<br />
listrumentisti, il secondo alle prese<br />
pure col canto, e del loro The Domestic<br />
EP (autoproduzione, 6.9/10),<br />
quattro tracce che escogitano indie<br />
romantico e ombroso, smaccatamente<br />
british ma disposto a suggestioni<br />
mitteleuropee. Immaginatevi<br />
un ibrido tra Jens Lekman, i dimenticati<br />
Venus e Patrick Wolf, e più o<br />
meno ci siamo. Volendo allargare e<br />
zoomare all’indietro, possiamo rilevare<br />
echi Depeche Mode, Smiths e<br />
Scott Walker, tanto per abbozzare<br />
una mappa di tutto rispetto. Molto<br />
curati gli arrangiamenti, interpretazioni<br />
intense senza strafare, manca<br />
forse un po’ di adrenalina e qualche<br />
goccia di sangue. Ma è un signor<br />
biglietto da visita.<br />
Trio a gestione familiare quello<br />
dei The Perris, due fratelli - i cantanti<br />
e chitarristi Amedeo e Nicola - più<br />
la bassista Simona (coniugata ad<br />
uno dei suddetti). Reggio Emilia è<br />
la base di questa cospirazione indie<br />
wave in corso da una decade sotto<br />
diverse incarnazioni e finalmente<br />
sfociata nell’esordio Hic Sunt Leones<br />
(Youthless Fanzine Rec, 6.7/10),<br />
cinque tracce a base di chitarre in-<br />
grugnite, tastiera e drum machine,<br />
le melodie tra il suadente, l’arguto<br />
e il morboso, mischia di suggestioni<br />
Blur, Afghan Whigs, New<br />
Order, dEUS. Disinvolti nella cura<br />
del dettaglio così come della sporcizia<br />
dell’impatto, devono semmai<br />
lavorare sull’intensità che l’ascolto<br />
passa come un’effervescenza gradevole<br />
ma effimera. Li attendiamo<br />
con curiosità sulla prova lunga.<br />
Pochissime note biografiche accompagnano<br />
Le donne per bene<br />
distruggono il mondo, EP a firma<br />
Teatro Musicato Cosciente pubblicato<br />
dalla net-label ViVeriVive<br />
(7.1/10). Sotto la sigla TMC troviamo<br />
il cantautore Sergio Dal Cin,<br />
provenienza Vittorio Veneto, Treviso.<br />
Nel mini di 5 pezzi , Dal Cin rivede<br />
la forma canzone cantautorale,<br />
ibridandola con una veste musicale<br />
punkeggiante e testi graffianti e ironici.<br />
CCCP i referenti che emergono<br />
maggiormente, il tutto realizzato<br />
in forma acida e una verve ispirativa<br />
molto buona. Presupposti che<br />
fanno ben sperare per un proseguimento<br />
fervido. È uscito intanto<br />
anche un album a nome TMC di cui<br />
sicuramente diremo in seguito.<br />
Malo è un progetto cantautorale<br />
tosco-romano basato a Roma;<br />
il quartetto così denominato si<br />
presenta con un EP (autoprodotto,<br />
6.9/10), Il bene e il malo contenente<br />
sei canzoni. Tanto songwriting<br />
oriented che riprende le ultime<br />
wave di casa nostra, si veda Dente,<br />
Le luci della centrale elettrica ma<br />
anche i classici, a partire da Tiromancino<br />
fino ai Diaframma. Una<br />
buona vena melodica e compositiva<br />
rendono questo mini piacevole<br />
all’ascolto e foriero di ulteriori sviluppi.<br />
Bene.<br />
faBrizio zamPighi, tereSa greco,<br />
Stefano Solventi, nino ciglio<br />
108 109
China underground#5<br />
Breve storia degli sviluppi, dagli anni Novanta a oggi, di uno dei<br />
generi che maggiormente infiammano la scena musicale cinese...<br />
Se l’apertura cinese al mondo esterno<br />
ampiamente promossa da Deng<br />
Xiaoping dal 1978 fosse cominciata<br />
un decennio prima, è probabile<br />
che la scena musicale asiatica come<br />
la conosciamo oggi si sarebbe sviluppata<br />
in maniera radicalmente<br />
diversa. Soprattutto per quanto riguarda<br />
quelle frange più estreme<br />
del caleidoscopio post rock and roll,<br />
che generalmente prendono le macronomenclature<br />
di metal, punk e<br />
alternative, funzionando invariabilmente<br />
da definizioni ombrello per<br />
contenere decine e decine di sottogeneri,<br />
sottoculture e stili musicali.<br />
Queste definizioni hanno da tempo<br />
raggiunto una chiara demarcazione<br />
nel mondo musicale occidentale,<br />
mentre creano ancora confusione<br />
nell’identificazione delle relative<br />
trasposizioni asiatiche.<br />
Soprattutto in Cina, nazione così<br />
vasta e dal recente passato storico<br />
complesso e rapidamente in evoluzione,<br />
lo sviluppo e il consolida-<br />
mento di stili musicali alternativi e<br />
relative sottoculture è stato segnato<br />
da una storia curiosa, rapida come<br />
la definizione della società post-maoista<br />
e decisamente spiazzante. Il<br />
punk rock ha specialmente infettato<br />
la Cina con la sua anima ubriaca,<br />
putrida e purtroppo anche filtrata<br />
dai commercialismi a stelle e strisce,<br />
creando un fenomeno musicale e<br />
culturale che trova correntemente<br />
la sua massima espressione artistica<br />
tra i fumi grigi della macrocapitale<br />
Pechino e i locali del quartiere studentesco<br />
di Wudakou.<br />
Pu n k , ci n a e il su o<br />
P e r c h é<br />
La domanda spontanea che viene<br />
all’ascoltatore medio osservando<br />
i corpi sudati di questi dediti perfomers<br />
cinesi è di chiedersi perché<br />
in Cina il punk ha trovato così tanti<br />
fedeli tra i giovani. La prima considerazione<br />
viene da una differenza<br />
storica: se la tradizione punk occi-<br />
China PUNK!<br />
Brain Failure, Carsick Cars,<br />
Hang on the Box<br />
dentale viene da un trentennio di<br />
storia della musica rock che è passato<br />
dalla concezione e trasformazione<br />
del rock and roll da “musica del<br />
diavolo” ad accettatissimo strumento<br />
economico di etichette discografiche<br />
nei floridi e complicati anni ’70<br />
(post blues, post cultura hippy, post<br />
eccessi di morrisoniana memoria,<br />
coltelli di Hell’s Angels che scintillano<br />
ad Altamont, Rolling Stones, cocaina,<br />
Black Sabbath e iniziazione<br />
del metal), la nascita di una cultura<br />
punk in Asia e in Cina arriva solo di<br />
seconda mano, importata, trapiantata.<br />
Senza un supporto storico e<br />
culturale pronto a difendere le proprie<br />
differenze.<br />
Nei primi anni ‘90, le idee con cui<br />
i musicisti cinesi si confrontavano<br />
venivano prevalentemente dal mercato<br />
nero di CD e cassette piratate,<br />
fortemente saturo di classici rock<br />
and roll o heavy metal americani.<br />
Con il cambio di direzione del mainstream<br />
americano e l’arrivo in scena<br />
del grunge (essenzialmente i Nirvana),<br />
il materiale che lentamente<br />
permetteva ai cinesi di conoscere<br />
la cultura occidentale e abituarsi<br />
ai suoi nuovi modelli cambiò rotta<br />
verso la semplicità e l’immediatezza<br />
di quel suono grunge pesantemente<br />
influenzato dal garage degli anni<br />
‘60 e dal punk. Entro la fine del 1995,<br />
i Nirvana avevano raggiunto uno<br />
status di successo asiatico di ledzeppeliniana<br />
memoria, e costituivano<br />
la prima fonte di ispirazione per<br />
centinaia di band underground.<br />
Dopo il grunge, la nuova evoluzione<br />
della musica alternativa<br />
americana fu la rinascita del punk,<br />
quello di matrice più commerciale;<br />
di conseguenza, il mercato nero<br />
musicale cinese cominciò a riempirsi<br />
di Green Day, Fugazi, Sex<br />
Pistols, Ramones, Rancid, NOFX<br />
e purtroppo anche di artisti decisamente<br />
poco punk come i Blink 182.<br />
Se il punk in Cina sembrava molto<br />
infantile, troppo ancorato ai classici<br />
settantasettini, e a volte privo di<br />
quella personalità tutta asiatica che<br />
gli avrebbe dato dei caratteri più<br />
definiti, il motivo sono queste prime<br />
influenze. Parlando di punk, in occidente<br />
si distingue ampiamente tra<br />
un mainstream blasonato e criticato<br />
e una forte scena underground, che<br />
è il motore di definizione delle mode<br />
e dell’autenticità del movimento. Al<br />
contrario, pare che in Cina il punk<br />
sia nato ricalcando a carbone gli stili<br />
e le suggestioni di gruppi famosi legati<br />
al punk americano e inglese più<br />
mediatico, senza potere andare più<br />
a fondo e capire le radici e il senso<br />
del movimento.<br />
pr i m i fu o c h i De l l a<br />
r i v o l t a : Pe c h i n o br u c i a<br />
In America e in Europa, la musica<br />
punk e hardcore nasce e si sviluppa<br />
in un underground dominato da<br />
pubblicazioni indipendenti, concerti<br />
in centri sociali e club, circoli di persone<br />
che definiscono il movimento<br />
e la sua direzione. Di conseguenza,<br />
quella stessa influenza underground<br />
che fatica a entrare in contesti ben<br />
Underbaby<br />
più liberali di quelli asiatici (in Europa,<br />
ad esempio), in Cina ci arriva<br />
solo quando qualcuno ce la porta:<br />
lo sviluppo del punk cinese ha dunque<br />
sperimentato la partecipazione<br />
chiave della musica punk istituzionalizzata,<br />
che dal mainstream occidentale<br />
veniva piratata e venduta<br />
sulle bancarelle pechinesi; d’altro<br />
canto si è poi esposto all’ondata di<br />
stranieri che, chi per studiare il cinese,<br />
chi per insegnare l’Inglese, chi<br />
per lavorare, arrivavano in una Cina<br />
dai confini fisici e mentali sempre<br />
più aperti e curiosi verso “l’ignoto<br />
straniero”. Pechino, come da copione,<br />
fu la prima città cinese ad essere<br />
aperta e quindi “invasa” da queste<br />
idee rivoluzionarie.<br />
Indicativa della doppia tendenza<br />
è la nascita della prima scena punk<br />
pechinese nel 1995: Underbaby,<br />
la prima vera ‘punk’ band spilloni e<br />
creste, e Catcher in the Rye, la prima<br />
pop-punk band. Pur distinguendo<br />
un background culturale e ideologico,<br />
il suono delle due band era<br />
totalmente antitetico, un po’ come<br />
tra i Sex Pistols e Blondie: marci,<br />
veloci e rancidi i primi, melodici,<br />
poppeggianti e a cappella i secondi.<br />
Anche la scelta di un nome di pari<br />
passo preso dal classico romanzo di<br />
formazione postmoderno america-<br />
no di J.D. Salinger la dice lunga sulle<br />
influenze, e pare sia stata suggerita<br />
da un professore straniero di lingua<br />
inglese.<br />
Nel 1997, Pechino è pronta per<br />
una nuova generazione di punk<br />
che si raduna ai concerti del celeberrimo<br />
Scream Club: non solo<br />
ormai le influenze si sono fatte più<br />
variegate e più storicamente accurate,<br />
pescando anche dal calderone<br />
dell’hardcore di metà anni ’80 (band<br />
americane come Fugazi, Operation<br />
Ivy, Misfits, NOFX, Bad Brains etc.),<br />
ma anche l’età dei fans si abbassa di<br />
molto, includendo ragazzini dai 16<br />
anni in su, a differenza della prima<br />
ondata di punk, che aveva generalmente<br />
scoperto questa nuova cultura<br />
alternativa nei 20 anni avanzati. È<br />
da questa generazione che nascono<br />
le band più significative del movimento:<br />
Brain Failure, 69, Reflector<br />
e Anarchy Boys. Una compilation<br />
con queste quattro band testimonia<br />
la prima vera uscita discografica del<br />
punk cinese, il doppio CD album rilasciato<br />
da Jing Wen Records e rapidamente<br />
esaurito. Ed è appunto in<br />
questi anni e soprattutto nel 1998, a<br />
seguito dell’arrivo e del successo di<br />
band come Qiutian de chongzi (Autumn<br />
Bug) e Niuqu de jiqi (Twisted<br />
Machine) –le prime ad usare costu-<br />
110 111
mi di scena ed effetti speciali di Marylin<br />
Mansoniana memoria- che la<br />
stampa straniera si interessa al punk<br />
cinese e Pechino diventa un esempio<br />
di libertà culturale e musicale,<br />
attirando musicisti, fans e studenti<br />
da tutte le parti della Cina.<br />
Questo è il periodo in cui, stando<br />
alle parole di David O’Dell, studente<br />
di Cinese texano e uno dei “laowai”<br />
(stranieri) chiave nell’ambito dello<br />
sviluppo e informazione della scena<br />
punk cinese, band e concerti abbondano,<br />
e non è raro poter scegliere<br />
tra una quindicina di band che suonano<br />
in tre o quattro locali diversi<br />
nella stessa serata. Un fermento<br />
incredibile, una scheggia impazzita<br />
che si è guadagnata l’attenzione<br />
della stampa internazionale in vari<br />
paesi, tra cui celeberrimi reportage<br />
su Newsweek, <strong>Tim</strong>e Magazine, CNN<br />
e MTV. La miccia del punk era accesa,<br />
e la bomba pronta a esplodere.<br />
Ma proprio con l’arrivo del nuovo<br />
millennio, l’atmosfera cambia: Pechino<br />
è satura di musicisti e pronta<br />
a scrollarsi di dosso il passato per<br />
lanciarsi nel nuovo. Il punk cinese,<br />
quasi spodestato, non vuole morire<br />
e decide invece di prendersi una vacanza<br />
al sole, infettando tutto quel-<br />
lo che trova sul suo cammino.<br />
Joyside<br />
hol i d a y s in th e su n :<br />
migrazione pu n k a Su D<br />
D e l l e nu v o l e<br />
Per due anni, la scena musicale pechinese<br />
si destabilizza e si sposta. Il<br />
clima cittadino del nuovo millennio<br />
è inquinato da troppe band e competizione,<br />
ma prima di soccombere<br />
si cercano altri territori. La scelta<br />
ricade sullo Yunnan, meravigliosa<br />
provincia meridionale incastonata<br />
tra la cultura tibetana e quella<br />
del Sud-est asiatico, ricca di luoghi<br />
idilliaci dove i turisti stranieri si fermano<br />
rapiti; lì la vita costa meno, la<br />
marijuana cresce selvatica e viene<br />
venduta per pochissimi yuan. Insediandosi<br />
nei caffè di Dali e Lijiang, i<br />
punk pechinesi iniziano a suonare e<br />
a influenzare centinaia di altri giovani<br />
cinesi che fino ad allora non<br />
avevano mai potuto venire a contatto<br />
con queste forme di ribellione<br />
musicale. Nel frattempo, in una Pechino<br />
scremata di punk, una nuova<br />
scena rap metal –influenzata dal<br />
nuovo giro di vite del mainstream<br />
americano chiamato Korn- si insidia<br />
creando distinzioni e mutando la<br />
direzione dei locali cosiddetti punk,<br />
che perlomeno apprezzavano il<br />
fatto che queste nuove rock band<br />
fossero più edulcorate, non lanciassero<br />
bottiglie di birra sul pubblico<br />
e suonassero in maniera molto più<br />
commerciale e “controllabile”.<br />
Quando nel 2000-2001 gli spiantati<br />
punk pechinesi, finiti soldi e sogni<br />
di successo yunnanesi ritornarono<br />
a Pechino, l’inevitabile cambio<br />
di tendenze modificò nuovamente<br />
la scena. Rabbia, creste e stivali<br />
erano stati lentamente sostituiti<br />
da barbette emo e chitarre a sette<br />
corde –probabile retaggio culturale<br />
del post esilio nello Yunnan-, lasciando<br />
la prima violenza punk da<br />
parte, e condividendo palchi, ideologie<br />
e serate con gli altrimenti inconciliabili<br />
rap metallari. Nel giro di<br />
pochi anni, quello che in occidente<br />
è successo nel corso di tre decenni,<br />
in Cina ha preso la superstrada temporale<br />
e si è modificato così rapidamente<br />
da lasciare un vuoto, e cambiare<br />
faccia.<br />
10 a n n i in c o r s i a Di<br />
s o r P a s s o...<br />
Concludere un’introduzione alla<br />
storia rocambolesca del punk cinese<br />
è un po’ come prendere alcune<br />
centinaia di dischi fondamentali<br />
scelti tra le varie decine di sottogeneri<br />
del rock e del metal degli ultimi<br />
trent’anni, metterli in un frullatore<br />
e lasciare tritare per alcuni minuti.<br />
Il risultato è distillato in tanti nomi<br />
di band che hanno rappresentato<br />
le prime imitazioni cinesi di gruppi<br />
occidentali più famosi, senza mai dimenticare<br />
le “caratteristiche cinesi”.<br />
Le spille e le creste colorate rimangono,<br />
ma altri generi si consolidano:<br />
i ragazzi cinesi iniziano a portare<br />
canottiere bianche da rockabilly<br />
e a sfoggiare grossi tatuaggi sulle<br />
braccia, le ragazze punk esibiscono<br />
minigonne da urlo e calze a rete<br />
bucate (e anche i primi tatuaggi), i<br />
più malinconici si crogiolano nelle<br />
nuove correnti emo rock e vestono<br />
come intellettuali alternativi pescati<br />
da un incubo rimbaudiano.<br />
L’epicentro della scena rimane sempre<br />
Pechino, ma anche la vibrante<br />
Shanghai –più propensa alla disco<br />
e a trance acide- per non parlare<br />
della progressista Wuhan, dello studentato<br />
di Tianjin, della balneare<br />
Qingdao e della fumeggiante Dali,<br />
tra le tante. I locali sono decine, se<br />
non centinaia. Il punk, seppure non<br />
sulla cresta dell’onda e nascosto agli<br />
occhi meno attenti, è una scena ormai<br />
fervente.<br />
La corsia di sorpasso temporale<br />
cinese ha creato molte band interessanti<br />
che è doveroso citare: i Joyside,<br />
gli Hedgehog e i Carsick Cars,<br />
ovvero i tre punti saldi della pechino<br />
punk post Yunnan, gruppi che sono<br />
stati anche in grado di affrontare<br />
tour europei e americani, portando<br />
la “giallo punk mania” all’infuori dei<br />
confini della Repubblica popolare.<br />
Le Hang on the Box, uno dei primi<br />
gruppi punk tutti al femminile, ispirati<br />
dalle correnti Riot Grrrl americane<br />
care a Kathleen Hanna e alle sue<br />
Bikini Kill, nonché autrici di uno<br />
scordato punk da tre accordi e voce<br />
da bambina lisergica. Gli Angry Jerks<br />
da Nanjing, nati nel 2000 come<br />
hardcore band e ad oggi trasformatisi<br />
nella prima e unica psychobilly<br />
band cinese, con tanto di bassista<br />
donna in qipao e autoreggenti da<br />
pin-up dei ‘50, pettinature ingellate<br />
alla Elvis Presley, e dadi e fiamme<br />
tatuati sulle spalle.<br />
È interessante considerare come<br />
grazie al sempre maggior numero<br />
di ingressi di stranieri in Cina e<br />
all’incremento delle opportunità<br />
che i ragazzi cinesi hanno di studiare<br />
nei paesi occidentali, il punk<br />
cinese abbia fatto passi da gigante,<br />
segnato da un notevole riflusso di<br />
idee e proposte musicali oramai a<br />
dieci anni esatti dal ritorno dei punk<br />
a Pechino. Le influenze rimangono<br />
straniere, ma i punk e gli alternativi<br />
cinesi hanno grinta da vendere e<br />
qualcosa da insegnare anche ai modelli<br />
occidentali a cui si sono ispirati:<br />
la passione. Una grande, rinomata<br />
passione che ormai ha consolidato<br />
la propria versione rossa a stelle<br />
gialle del punk rock, e che non si<br />
trova più in quei modelli occidenta-<br />
li. Il futuro? Ancora tutto da scrivere,<br />
ma a questi ritmi, non sarebbe stupefacente<br />
trovarsi di fronte a una<br />
vera e propria rivoluzione musicale<br />
nel corso dei prossimi cinque o dieci<br />
anni. Punk a caratteri cinesi? Se il<br />
ritmo della corsa rimane costante, la<br />
risposta è sicuramente sì. Preparatevi<br />
ad aggiungere nuovi classici dagli<br />
occhi a mandorla tra i vostri prossimi<br />
acquisti musicali.<br />
*Marco Ferrarese ha suonato per<br />
10 anni nei The Nerds Rock Inferno,<br />
una delle poche punk rock bands<br />
italiane capaci di infiammare i palchi<br />
di Europa e Stati Uniti. Dal 2007,<br />
incuriosito dall’Asia, si trasferisce in<br />
oriente. Ha vissuto in Europa, Cina,<br />
Stati Uniti ed Australia, e viaggiato<br />
in circa 40 paesi. Al momento vive,<br />
scrive e lavora a Penang, Malesia. Il<br />
suo sito è www.monkeyrockworld.<br />
com. China Files è un’agenzia di<br />
stampa di base a Pechino composta<br />
da giornalisti, videomaker, fotoreporter<br />
e sinologi di diverse nazionalità.<br />
www.china-files.com.<br />
marco ferrareSe<br />
Carsick Cars<br />
112 113
Rearview Mirror<br />
—speciale L’acid folk dei Pearls Before Swine è stato uno dei principali<br />
fenomeni cult emersi dai sixties; figlio della psichedelia<br />
acustica ma solo per vaghe generalità, il progetto<br />
ha attinto quasi esclusivamente alla polimorfica<br />
personalità del suo autore e cantante, quel Tom Rapp<br />
dal pronunciato sigmatismo che oggi può bearsi al raccolto<br />
di una semina neppure tanto prolifica dalla quale<br />
è derivata però, con l’aiuto del tempo, una nutrita<br />
Pearls Before<br />
Swine<br />
Gotico folk,<br />
sgranando le perle dell’underground<br />
Il folk esoterico a nome Pearls Before Swine, il country parnassiano<br />
negli Anni ‘70 e il ritiro dalle scene, ad alimentare le<br />
ipotesi più stravaganti; Tom Rapp si racconta e la magia torna<br />
a brillare.<br />
Testo: Filippo Bordignon<br />
schiera di estimatori intenzionati a proseguire il discorso<br />
artistico dei Pbs, nella speranza di superarlo.<br />
Tanti gli artisti che ne hanno riconosciuto la grandezza:<br />
dal regista Julien Temple allo scrittore Thomas<br />
Pynchon (leggere per credere il Vizio di forma), passando<br />
per il chitarrista del Patty Smith Group Lenny<br />
Kaye, Julian Cope, Genesis P-Orridge, Cul de Sac e<br />
Ivo Watts-Russell che rese tributo a Rapp con una cover<br />
di The Jeweller nel secondo imperdibile episodio<br />
della trilogia dark-pop dei This Mortal Coil, Filigree &<br />
Shadow.<br />
Conosciuta quasi esclusivamente per i primi due album<br />
di fine Anni ’60, la carriera artistica di Rapp è proseguita<br />
con una manciata di lavori ammantati da un<br />
delicato torpore bucolico, degna evoluzione umanista<br />
dei celebrati One Nation Underground e Balaklava.<br />
Il nuovo millennio, con la rinascita dalle ceneri dello<br />
psych-indie-freak folk grazie a personaggi estrosi quali<br />
Devendra Banhart e Joanna Newsom, ha decretato<br />
giocoforza un’occasione di rispolvero per la storia del<br />
buon Tom, qui raccontata grazie allo studio della discografia<br />
e con il contributo diretto del compositore<br />
statunitense.<br />
Inizieremo dunque, citando niente meno che Gesù<br />
Cristo nel Vangelo secondo Matteo (Capitolo 7, Versetto<br />
6):<br />
“Non date ciò che è santo ai cani, né gettate le vostre<br />
perle davanti ai porci, affinché non le calpestino coi loro<br />
piedi e voltandosi non vi sbranino”.<br />
Con un pizzico di grandiosità, ma sopratutto in virtù<br />
di quello humour che in pochi sapranno intravedere<br />
nelle opere lì a venire, il giovane Thomas Dale Rapp<br />
(classe 1947) conia il nome della sua band, adducendo<br />
la previsione di una carriera alla mercé di un pubblico<br />
poco riconoscente. Nativo del North Dakota (Bottineau)<br />
ma trasferitosi ancora ragazzino coi genitori insegnanti<br />
nel Minnesota (siamo sempre al confine col Canada<br />
dell’amato Leonard Cohen), egli dimostra ‘orecchio’<br />
fin dalla tenera età, imparando i rudimenti di ukulele e<br />
chitarra e ‘componendo’ il primo pezzo a sei anni (una<br />
ballata su un cowboy prossimo alla morte, secondo il<br />
suo vago ricordo). Leggenda vuole che a un concorso<br />
per nuovi talenti la terza posizione fosse tributata pro-<br />
prio a Rapp, mentre un imberbe ‘Bobby Zimmerman<br />
da Hibbing’ (non ancora battezzatosi Dylan) si fermò al<br />
quinto posto. Gli spostamenti dei Rapp però non sono<br />
finiti: sarà la volta della Pennsylvania e dunque dell’assolata<br />
Melbourne in Florida, dove il nostro compie gli<br />
studi superiori e, insieme ad alcuni compagni di scuola,<br />
dà vita alla prima e unica formazione stabile dei Pearls<br />
Before Swine, nel 1965.<br />
L’ascolto dell’album omonimo dei Fugs, prodotto<br />
per la oggi leggendaria Esp Disk (promotrice di icone<br />
jazz quali Albert Ayler, Patty Waters e Sun Ra), suggerisce<br />
alla band di spedire un demo all’ufficio newyorkese<br />
dell’etichetta, chiedendole senza troppi giri di parole<br />
di metterla sotto contratto. Possiamo immaginare<br />
dunque la sopresa dei ragazzi, ricevuta la richiesta di<br />
recarsi nella Big Apple per registrare il loro esordio.<br />
Per arrivare alla lunghezza delle due facciate, Tom &<br />
Co. terminano di elaborare la tracklist durante il viaggio<br />
in aereo; One Nation Underground (Esp Disk, 1967) verrà<br />
registrato in soli quattro giorni, ottenendo un isperato<br />
successo di vendita (200.000 copie) che ai nostri frutterà<br />
– come da tradizione underground – ricompensi economici<br />
quasi nulli. In apertura, la delicata Another <strong>Tim</strong>e ripercorre<br />
l’episodio di un incidente nel quale Rapp venne<br />
sbalzato fuori dall’auto di cui era passeggero (una Austin<br />
Healy Sprite cabriolet, a essere precisi), cavandosela solo<br />
con un taglio al sopracciglio. Sotto un profilo musicale,<br />
il brano è manifesto di uno stile che, pur attingendo ai<br />
manierismi del proprio decennio, si colloca in un limbo<br />
di autentica unicità, grazie al timbro impalpabile della<br />
voce di Rapp e alla scelta della strumentazione (con<br />
stranianti incursioni di vibrafono, clavicembalo, celesta e<br />
clavioline). Se Playmate scimmiotta la cantilena del Dylan<br />
Blonde On Blonde e I Shall Not Care non si distacca<br />
di molto dallo psychedelic rock del tempo, numeri quali<br />
Morning Song e Regions of May, suonate con la rassegnazione<br />
di un’anima pronta al distacco dal corpo, danno<br />
la misura di una sensibilità cresciuta e sviluppatasi nei<br />
territori crepuscolari di un intimismo universale. Ballad<br />
To An Amber Lady proietta l’ascoltatore in un’altra epoca,<br />
merito del polistrumentista Roger Crissinger, qui<br />
responsabile di un testo di struggente malinconia tardo<br />
romantica: “Madama dell’Ambra/ sedeva al clavicembalo<br />
di velluto vestita/ nella stanza delle meraviglie orientali/<br />
fissando la veranda fiorita/ ammantata com’era di seta<br />
e tristezze// Rebecca singhiozzava tormentandosi all’arpa/<br />
Leila invece, si donava a uno sconosciuto/ nei campi<br />
riarsi da un sole cinereo”. La chiusa è affidata alla spettrale<br />
The Surrealist Waltz, abbandono mortale in formato<br />
pop e gemma esoterica d’indescrivibile efficacia.<br />
Balaklava (Esp Disk, ’68) affina le migliori intui-<br />
114 115
zioni dell’esordio, palesando il proprio mood a partire<br />
dalla copertina, dettaglio dal Trionfo della morte del<br />
pittore fiammingo Pieter Bruegel. Concept incentrato<br />
sull’orrore della guerra, Balaklava è raccolta di incisioni<br />
toccanti e sapientemente arrangiate, perfetta dalla<br />
prima all’ultima traccia. L’incipit con Translucent Carriages<br />
(il brano più richiesto dell’intero repertorio) proietta<br />
in una dimensione atemporale, persa tra i fumi<br />
dei sixties e il post-battaglia del 1854, a Balaclava, durante<br />
la guerra di Crimea, salvo risvegliare l’ascoltatore<br />
nel paradiso maomettano di Images Of April, animato<br />
da cinguettii ed echi di pifferi fiabeschi. Persa la formazione<br />
originale (salvo il banjo di Wayne Harley) lo stupore<br />
estatico di Rapp prosegue tra leggiadri clangori<br />
percussivi e archi arrangiati con elegante emotività in I<br />
Saw The World e Lepers And Roses. Pure non mancano<br />
episodi di arrendevole semplicità, come la spoglia dolcezza<br />
cantautorale There Was A Man e il sentito tributo<br />
a Cohen con una delle migliori versioni dell’arcinota<br />
Suzanne. Guardian Angels, unico picco di stravaganza,<br />
consiste nella riproduzione di un gracchiante 78 giri<br />
del 1929, sul quale è intonata una torch song di ironico<br />
patetismo. Il congedo, Ring Thung, vestirà i panni<br />
della morte violenta, con l’incedere trascinato di una<br />
pastoia medievale interrotta da un vorticoso giochetto<br />
di nastri.<br />
L’entusiasmo della critica specializzata spinge Rapp<br />
a tentare un contratto con la Reprise, nella speranza di<br />
allargare il proprio bacino di ascoltatori al di fuori degli<br />
States. Ma il Cristo inquietante ritratto dal nostro Giovanni<br />
Bellini nella copertina di These Things Too (Reprise,<br />
’69) paga lo scotto di un parziale distaccamento<br />
col nuovo repertorio del gruppo (ridotto praticamente<br />
ai soli Harley, un tale Jim Fairs, Rapp e la neo-sposa<br />
Elisabeth ai cori). Album di transizione verso liriche<br />
dall’approccio più narrativo e un’apparente standardizzazione<br />
del songwriting, These Things Too flirta qua e<br />
là con blues e country, pervenendo a miniature come<br />
dal pennello di un Townes Van Zandt parnassiano; oltre<br />
a una maggiore qualità esecutiva, l’opera si spoglia<br />
degli orpelli già di maniera dei lavori trascorsi, concedendo<br />
soavi tenerezze (Look Into Her Eyes, Man In the<br />
Tree, Wizard Of Is) e una spontaneità ‘back to roots’ che<br />
non sarebbe dispiaciuta alla Band di Music From Big<br />
Pink (I’m Going To The City).<br />
Trasferitosi per alcuni mesi con la moglie in una pittoresca<br />
cittadina dei Paesi Bassi, il cantautore trova ispirazione<br />
per del nuovo materiale, che incide in soli tre<br />
giorni al suo ritorno negli States, utilizzando sessionmen<br />
di Nashville e una piccola orchestra d’archi e legni.<br />
The Use Of Ashes (Reprise, ‘70) dimostra un’ulteriore<br />
maturazione compositiva, elargendo alcuni dei migliori<br />
numeri a catalogo (The Jeweller, God Save The Child,<br />
Riegal) e ispirando al paroliere Bernie Taupin il soggetto<br />
per uno dei suoi capolavori indiscussi in coppia<br />
con Elton John (Rocket Man). Il successivo City Of Gold<br />
(Reprise, ’71) rischia, sotto un profilo stilistico, una pericolosa<br />
overdose di Americana, imitando il Dylan svagato<br />
in Nashville Skyline e coverizzando Judy Collins,<br />
Jaques Brel e il solito Cohen.<br />
…Beautiful Lies You Could Live In (Reprise, ’71),<br />
inspiegabilmente, risale la china di un estro insabbiato<br />
con una manciata di irrinunciabili malinconie, su<br />
tutte quella Snow Queen circondata di gabbiani che le<br />
intimano cripticamente “Nella nostra cecità, dobbiamo<br />
pur sfiorarci tra noi”. Ma vanno anche investigate,<br />
con tutta calma, le eteree esecuzioni di Island Lady (…<br />
Signora dell’isola, a volte dio si manifesta, e se anche<br />
fossero solo menzogne, ti prometto bugie meravigliose<br />
con cui poter vivere”), Butterlies, Freedom e l’acquerello<br />
tracciato appositamente per la voce di Elisabeth,<br />
Epitaph.<br />
Il non autorizzato Familiar Songs (‘72) a nome Tom<br />
Rapp, raccoglie canzoni già note ai fan rubate da una<br />
session particolarmente riuscita e sancisce l’abbandono<br />
definitivo dalla Reprise. I tentativi solisti Stardancer<br />
(Blue Thumb, ’72) e Sunforest (Blue Thumb, ’73) sono<br />
testimonianze di un pop-rock vagamente psichedelico<br />
e ormai fuori tempo massimo, pur contenendo alcune<br />
tracce di pregevole fattura (For The Dead In Space,<br />
Stardancer, Blind River). La seconda metà dei seventies,<br />
archiviata la Guerra in Vietnam e con essa lo spirito vitale<br />
che animò la controcultura, suggerisce a Rapp un<br />
drastrico abbandono dello showbiz (qualcuno lo avvisterà,<br />
a torto, in Italia, nelle vesti di becchino). La realtà<br />
è ovviamente più prosaica: egli riprende gli studi laureandosi<br />
in economia, si separa da Elisabeth e sceglie<br />
la strada dell’avvocatura, raccontata nell’intervista a<br />
seguire.<br />
La re-entry, nei nineties, avviene un po’ per volta:<br />
prima con la partecipazione in sordina all’esordio del<br />
Terrastock festival nel 1997 a Providence, poi con la<br />
progressiva ripubblicazione dell’intero catalogo, integrato<br />
da compilation trascurabili, ‘tribute’ di insospettata<br />
validità artistica (i tre volumi For The Dead In Space,<br />
Secret Eye, ’97), raccolte di demo e inediti (il doppio<br />
The Wizard Of Is, Water, 2003) e un live particolarmente<br />
ispirato del ‘71 (Live Pearls, Wild Cat 2008) . C’è spazio<br />
persino per un nuovo capitolo da studio a proprio<br />
nome, prodotto dagli ex Galaxy 500 Damon Krukowski<br />
e Naomi Yang: A Journal Of The Plague Year (Woronzow,<br />
’99) ripropone tali e quali profumi e sapori dei<br />
sixties, passando inosservato nei 10 minuti dell’acid<br />
Dylan Shoebox Symphony ma toccando i vertici emozionali<br />
dei lavori più noti nell’immediatezza acustica<br />
di The Swimmer e Silver Apples II (dedicata all’amico<br />
Simeon Coxe, col quale il nostro condivise il palco nel<br />
rientro al Terrastock festival del ‘97).<br />
Letta nella sua interezza, l’avventura creativa di<br />
Tom Rapp è situata in quella nicchia del mercato discografico<br />
popolata da outsider che al business musicale<br />
finiscono per preferire la straordinarietà di una vita<br />
‘ordinaria’. Per tirare le somme di tanto valore artistico,<br />
chiuderemo citando il Borges dei Frammenti di un<br />
Vangelo apocrifo:<br />
“Da’ quel ch’è santo ai cani, getta le tue perle ai porci;<br />
quel che importa è dare”.<br />
l’i n t e r v i s t a<br />
Tom, iniziamo dalla tua ultima fatica da studio: cosa<br />
ti inorgoglisce di A Journal Of The Plague Year?<br />
È stato un piacere lavorare fianco a fianco con Damon<br />
e Naomi, i quali avevano appena inaugurato il loro studio<br />
di registrazione a Cambridge, nel Massachussets.<br />
L’album rappresenta la loro prima produzione ufficiale.<br />
Mi sono limitato ad affidargli alcuni brani che tenevo<br />
nel cassetto dal 1973. Eppoi devo evidenziare l’ottimo<br />
lavoro di Adrian Shaw e l’ospitata di Nick Saloman, rispettivamente<br />
bassista e compositore nell’indie rock<br />
band Bevis Frond. Tutta bella gente.<br />
A Journal Of … è da considerarsi il tuo album conclusivo<br />
o c’è dell’altro?<br />
Sto lavoricchiando coi The Late Cord per il loro nuovo<br />
album. Ho alcune canzoni da parte e di tanto in tanto<br />
mi piglia la tentazione di lavorarci su e registrarle. Chissà…<br />
E ora il passato. Togliamoci subito il pensiero: che<br />
ricordi delle registrazioni di Balaklava?<br />
Eh, ci è voluto un anno per realizzarlo. Avevamo composto<br />
arrangiamenti diversi per quasi ogni canzone.<br />
116 117
Fu solo dopo Balaklava che provai la marijuana (e a<br />
quel punto sì che aspiravo alla grande!). Il precedente<br />
One Nation Underground, a esempio, al contrario di<br />
quanto ipotizzò la critica, fu registrato in un’atmosfera<br />
assolutamente sobria e ‘pulita’. Diciamo che mi sentivo<br />
psichedelico ancor prima di venire a contatto con qualsivoglia<br />
tipo di droga. C’è quel pensiero di Abbie Hoffman<br />
secondo il quale chi abbia ricordi degli Anni ’60<br />
vuol dire che non li ha vissuti veramente. Da parte mia<br />
rammento il profondo stato di trance, assolutamente<br />
naturale, in cui precipitai appena terminata di incidere<br />
la mia versione di Suzanne.<br />
La critica sembra concorde nel tributarti onori quasi<br />
esclusivamente per i tuoi primi due album; non<br />
trovi seccante questo atteggiamento, il quale pone<br />
in ombra lavori successivi, tipo The Use Of Ashes?<br />
I lavori che preferisco, oltre a One Nation Underground<br />
e Balaklava sono appunto The Use of Ashes ma anche<br />
Stardancer. Forse, a influenzare il mio giudizio sono le<br />
condizioni in cui ricordo che sono stati realizzati e il fatto<br />
che ci siamo divertiti un sacco per inciderli. Questi<br />
quattro titoli hanno toccato il cuore a un sacco di persone.<br />
Pensa che nei Paesi Bassi c’è perfino un gruppo<br />
che si chiama The Use Of Ashes e sono pure bravi.<br />
Dalle copertine dei tuoi album traspare una predilezione<br />
per l’arte medievale e, più generalmente,<br />
per un’estetica grottesca…<br />
Beh, ho sempre adorato Hieronymus Bosch e Bruegel<br />
il Vecchio ma, al contempo, la mia estetica abbraccia<br />
anche la cinematografia horror Anni ’30 della Universal<br />
(e allora vai di film come Frankenstein, Dracula, La<br />
mummia, L’uomo lupo) così come certe pellicole dei<br />
’50-’60 prodotte dall’inglese Hammer Film. E poi mi<br />
hanno sempre affascinato film come Il mastino dei<br />
Baskervilles (consiglio la versione del ’39 con Basil Rathbone<br />
nella parte di Holmes) e il Macbeth di Orson<br />
Welles. Una delle prime canzoni che ho composto da<br />
bambino si intitolava “Sherlock Holmes e le tre streghe”;<br />
non ricordo come faceva ma mi pare fosse un<br />
pezzo particolarmente complicato.<br />
E nella letteratura, cosa ti ha segnato?<br />
Non ho dubbi: leggetevi The hollow men di Thomas<br />
S. Eliot.<br />
Eccezion fatta per la prosa di Burroughs e la poesia<br />
di Ginsberg non trovi che la letteratura beat sia tra<br />
i fenomeni culturali più sopravvalutati del ventesimo<br />
secolo?<br />
Adoro Ginsberg e Burroughs ma non scordiamoci Kerouac!<br />
Ancor oggi assaporo la bellezza di Mexico city<br />
blues; senti che meraviglia questo estratto dalla strofa<br />
211:<br />
“La ruota della carne tremante - il concepimento - gira<br />
nel vuoto catapultando esseri umani, porci, tartarughe,<br />
rane, insetti, pulci (...) orribili innominabili pidocchi<br />
d’avvoltoi (...) tutto l’infinito concepimento di esseri<br />
viventi (...) Vorrei essere libero/ da quell’incatenante<br />
ruota di carne/ e salvo, in un cielo morto”.<br />
Sfortunatamente la loro poetica si è prestata a facili<br />
manierismi ma il fulcro della letteratura beat riesce<br />
a fondere l’aspetto estatico con il rigore di un testo<br />
obiettivamente ben scritto. Oggi leggo molto volentieri<br />
David Tibet e un poeta canadese poco conosciuto<br />
ma che mi sento di consigliare, tale Marc Creamore.<br />
Chi è il giudice più importante: l’artista o il pubblico?<br />
Crei sempre per te stesso e, contemporaneamente, per<br />
quell’ascoltatore di cui non sai nulla se non il fatto che<br />
è davvero interessato a capire ciò che hai scritto e, talvolta,<br />
ha bisogno di essere confortato dalla tua musica.<br />
Non sai quante persone mi hanno riferito che la mia<br />
musica li ha aiutati a desistere da pensieri suicidi. Pensa<br />
che durante la seconda edizione del Terrastock festival,<br />
a Londra, mi sono trovato davanti un fan con il viso interamente<br />
ricoperto di bende. Disse che stava morendo<br />
di cancro e mi chiedeva il permesso per mettere di<br />
sottofondo un brano dei Pbs al suo funerale. Due mesi<br />
dopo se n’è andato. Che dire? Cose del genere sono<br />
talmente commoventi! Ti fanno capire che ciò che hai<br />
fatto nella tua vita ha avuto un senso, un ruolo importante<br />
in quella degli altri. Molto semplicemente, realizzi<br />
che sì, sei riuscito a entrare in contatto con qualcuno<br />
e ad aiutarlo.<br />
Uno dei tuoi pezzi più recenti, The Swimmer, è dedi-<br />
cata a Cobain: te ne frega davvero dei Nirvana o hai<br />
solo omaggiato un giovane artista morto prematuramente?<br />
La morte di Kurt Cobain e tutta la questione concernente<br />
il suicidio hanno suscitato in me una reazione<br />
che si è poi tradotta in The Swimmer. Credo davvero<br />
che la sua perdita, oltre a essere un fatto obiettivamente<br />
triste, abbia significato per noi la privazione di un<br />
talento che poteva dare ancora molto in termini musicali.<br />
E oggi? Qualche nome di rilievo tra le nuove leve<br />
dello psych folk, gente come Devendra Banhart?<br />
Ascolto molto volentieri gli album in duo dei miei amici<br />
Damon & Naomi. Poi vediamo: Black Forest/Black<br />
Sea, Dave Pearce, Kitchen Cynics (cioè Alan Davidson),<br />
Prydwyn e gruppo annesso, <strong>Tim</strong>othy Renner<br />
e i suoi tanti progetti paralleli, i giapponesi Ghost,<br />
Alastair Galbraith, Spacious Mind. Fanno tutti bella<br />
roba.<br />
Nel 1997 il tuo ritorno ufficiale ‘on stage’ dopo più<br />
di vent’anni d’assenza…<br />
Tutto grazie a Phil McMullen, editore della rivista Ptolemaic<br />
Terrascope. È stato il primo a venirmi a cercare,<br />
agli inizi degli Anni ’90. A quanto pare la maggior parte<br />
di quelli che apprezzavano i Pbs erano convinti che<br />
fossi morto e sepolto. Ha insistito affinché partecipassi<br />
alla prima edizione del festival indie organizzato dalla<br />
rivista, a Providence. Visto che anche mio figlio David<br />
avrebbe suonato lì coi suoi Shy Camp mi sono fatto<br />
forza e ho accettato. Solo che non avevo più toccato<br />
una chitarra da un sacco di tempo ed è stato necessario<br />
esercitarsi, esercitarsi, esercitarsi. Ho dovuto dannarmi<br />
a ritrovare gli accordi delle mie stesse canzoni,<br />
non ricordavo neanche le parole. Eppoi non avevo più i<br />
calli sui polpastrelli perciò le dita mi sanguinavano alla<br />
grande. Molto fico comunque.<br />
La formazione originale dei Pbs non sembrava particolarmente<br />
interessata a suonare dal vivo…<br />
Poi però esibirsi nei primi Anni ’70 sì rivelò un’esperienza<br />
affascinante: ho conosciuto gente come John<br />
Lennon, <strong>Tim</strong> Hardin, Jerry Garcia dei Grateful Dead<br />
e diviso il palco con mostri sacri quali Odetta, Chuck<br />
Berry e i Pink Floyd. Cosa potevo chiedere di più a<br />
quel punto? Il rovescio della medaglia era che avvertivo<br />
una pressione costante e di soldi ne giravano assai<br />
pochi perciò talvolta c’era davvero poco per cui stare<br />
allegri.<br />
Quanto successo può tollerare un uomo prima di<br />
perdere contatto con la realtà?<br />
È una questione, quella della ‘fama’, che tratto in un<br />
brano ancora inedito, dal titolo Every Change Is A Re-<br />
lease. Sono assolutamente felice della mia vita e della<br />
piega che ha preso in questo momento. Sono in armonia<br />
con le persone che mi circondano, con il sobrio stile<br />
di vita che conduco. Se un giorno dovessi rimuginare<br />
rispetto alle occasioni sprecate o ai progetti naufragati<br />
beh, mi basterebbe pensare che se la mia vita fosse<br />
andata diversamente, con buona probabilità ora non<br />
sarei appagato come sono.<br />
Arriviamo ai giorni nostri: “Chi controlla il passato<br />
controlla il futuro: chi controlla il presente controlla<br />
il passato”. C’è del vero?<br />
George Orwell ci vedeva giusto il più delle volte. La<br />
questione oggi è che una piccola percentuale della<br />
popolazione si è accaparrata la maggior parte delle<br />
risorse disponibili; inoltre la disparità di guadagno tra<br />
le diverse classi sociali non fa che aumentare, senza<br />
controllo. Stati Uniti e Inghilterra stanno facendo del<br />
loro meglio per vanificare anni e anni di lotte per ottenere<br />
un livello minimo di benessere sociale. Citando la<br />
Genesi, Capitolo 4, Versetto 9: “Sono forse il custode di<br />
mio fratello?”, la risposta del partito repubblicano è un<br />
secco: “Cavolo, no!”.<br />
Qual è il tuo bilancio dopo tre anni di presidenza<br />
Obama?<br />
Obama è troppo cauto quando fronteggia repubblicani<br />
e teabaggers. Ma dico io: visto che non gli piacerai<br />
mai a prescindere (non so se te l’ho detto che Obama è<br />
nero…) perché non prenderli a calci sul culo e passare<br />
ad altro?<br />
Qual è il pericolo più imminente che stiamo correndo?<br />
L’ambiente e la salvaguardia del pianeta, sono le que-<br />
118 119
stioni principe. Negli States la fazione di destra se ne<br />
frega del riscaldamento globale: vorrebbero farci credere<br />
si tratti di inutili allarmismi. E vorrebbero pure che<br />
credessimo alla loro buonafede in questa convinzione…<br />
Blowin’ In The Wind t’ha convinto a diventare cantautore;<br />
il Dylan di oggi, quello di Modern <strong>Tim</strong>es o<br />
Together through Life, lo trovi ancora efficace?<br />
Un atteggiamento ingeneroso, il tuo. È come dire: ok,<br />
Dylan ha inventato la ruota ma poi che ha fatto? Quando<br />
l’ho incontrato si è dimostrato una persona gentile<br />
e generosa, completamente avvolta dalla propria travolgente<br />
creatività. Amerò tutto quello che vorrà ancora<br />
donarci per il resto della sua vita, che mi auguro duri<br />
almeno un centinaio d’anni.<br />
Allora è Dylan la tua influenza principale?<br />
Mettiamola così: lui ha inventato l’alfabeto che noi<br />
tutti abbiamo adoperato. Però l’autore che più mi ha<br />
influenzato è Leonard Cohen. La sua poetica mescola<br />
sapientemente Amor Sacro e Amor Profano. Sai, ero un<br />
ragazzino cattolico al tempo, perciò conoscevo bene<br />
queste due forze in eterna collisione. Quel genere di<br />
tensione si è trovata uno spazio all’interno di molte mie<br />
canzoni.<br />
Che hai fatto negli Anni ’80?<br />
Nel 1979 mi sono reiscritto a scuola pur avendo trovato<br />
un lavoro a tempo pieno: fino al 1982 credo di aver dormito<br />
per una media di cinque ore a notte. Nell’84, conseguita<br />
una laurea presso la University of Pennsylvania<br />
Law School, decisi di restare a Filadelfia, per esercitare<br />
a tutela dei diritti civili e contro quelle leggi che ci<br />
discriminano in merito alla razza, l’età, l’orientamento<br />
sessuale ecc.. Ho lavorato in una piccola società gestita<br />
da un uomo straordinario, Alan Epstein, una persona<br />
che si è battuta davvero contro le ingiustizie del governo,<br />
a tutela di vedove e bambini. Un paio dei nostri casi<br />
si sono spinti fino alla Corte Suprema. So che sembra la<br />
trama di un film ma ricordo che avevamo questo caso<br />
entusiasmante di un giovane e brillante avvocato, silurato<br />
per aver contratto l’Hiv. Poco prima che la giuria<br />
rientrasse in aula per esprimere il verdetto la grande<br />
società che l’aveva licenziato patteggiò un’importante<br />
somma di denaro. Soddisfazioni. Trasferitomi in Florida<br />
nel 2001 lavorai per alcuni anni nell’ufficio legale della<br />
contea in cui stavo.<br />
Sei ancora operativo come avvocato civilista?<br />
Mi sono ritirato nel 2008 e adesso vivo sulla costa est<br />
della Florida con Lynn, mia moglie da venticinque anni,<br />
e con Atticus e Lucy, due cani assolutamente indisciplinati.<br />
Ti prego di specificare che sono raggiungibile<br />
all’indirizzo email pbswine@aol.com. Beh, chiaro: astenersi<br />
stalker psicotici con tendenze assassine!<br />
Keats azzardava: “Se la poesia non vi arriva con la<br />
naturalezza della foglia sull’albero è meglio che<br />
non nasca nemmeno”. Mai avuto un blocco creativo?<br />
Le canzoni sono solite sgorgarmi fuori con una certa<br />
scioltezza; notizie che leggo sui quotidiani o fatti di cui<br />
vengo a conoscenza o che mi toccano riesco a tramu-<br />
tarli facilmente in canzoni. Riegal l’ho scritta dopo aver<br />
letto nell’International Herald Tribune del ritrovamento<br />
di una nave da guerra tedesca affondata nel 1944<br />
dagli inglesi, circostanza che causò la morte dei 400<br />
prigionieri in essa detenuti. Ho acceso il registratore<br />
incidendo tutto, parole in rima e musica, in cinque minuti.<br />
Il processo è stato talmente immediato che ho dovuto<br />
riascoltare il nastro per trascrivere gli accordi che<br />
avevo suonato. Chiaramente anche la location aiuta:<br />
nel mio caso aver abitato, per alcuni mesi del 1969, in<br />
una casetta circondata di rose con vista sul un lago meraviglioso<br />
popolato dai cigni (e con un bunker nazista<br />
a pochi metri, aggiungerei) sai… vorrei poter scrivere<br />
più musica in quelle stesse condizioni…<br />
Qualche inciampo musicale che non ti perdoni?<br />
“Non, je ne regrette rien”.<br />
Sei credente, in qualche modo?<br />
Non proprio. Credo piuttosto che gente come Martin<br />
Luter King abbia rappresentato la mano salvifica di<br />
dio, una possibilità concreta per aggiustare le nostre<br />
diatribe terrene. Scelgo, giorno dopo giorno, di credere<br />
nella giustizia e nell’amore.<br />
Cos’è allora, la religione?<br />
Una speranza tutta umana in merito a qualcosa che<br />
sta al di là di noi e che utilizziamo come infrastruttura<br />
per raggranellare un po’ di speranza nei giorni difficili.<br />
Qualcuno ha detto meglio di me che dio, per ‘funzionare’,<br />
non deve necessariamente esistere.<br />
Senti questa di Confucio: “L’uomo che commette un<br />
errore e non tenta di porvi rimedio commette un altro<br />
errore”…<br />
Sì ma certi errori sono irreparabili e tentare di correggerli<br />
sarebbe uno sbaglio ulteriore. Questa l’ha detta,<br />
sempre Confucio, un anno dopo della tua!<br />
Qual è l’aspetto più straordinario dell’essere un artista?<br />
Ti risponderei col verso di una canzone: “Money for<br />
nothin’ and chicks for free” (“Soldi facili e pupe a volontà”)…<br />
no aspetta, questo è di un altro autore. Credo<br />
che gli artisti e tutti quelli implicati in ogni genere di<br />
attività creativa siano immersi costantemente in un lavorio<br />
di rielaborazione della realtà che poi propongono<br />
agli altri, affinché la percezione di ciò che li circonda<br />
divenga più nitida e consapevole.<br />
120 121
CAMPI MAGNETICI #3<br />
Lucio Battisti Stereolab<br />
coSa Succederà alla ragazza (columBia recordS,<br />
ottoBre 1992)<br />
Correva il 1992 quando vide la luce Cosa succederà<br />
alla ragazza, quarto titolo per il connubio sconcertante<br />
tra Pasquale Panella, paroliere, ed un sempre più eclissato<br />
Lucio Battisti. I tre lavori precedenti sembravano<br />
obbedire ad una strategia di negazione, uno spostare il<br />
confine di ciò che è assodato, normale. Il contrario del<br />
tipico smarrimento dell’ispirazione, del banale appassire,<br />
dello spegnersi crepuscolare nel pulviscolo fiacco<br />
di polvere di stelle. Tutt’altro: c’è una determinazione<br />
lucidissima nell’ultimo Battisti. Una convinzione premeditata.<br />
Affidarsi a Panella fu il colpo di genio, l’aggiustamento<br />
di rotta dopo i buoni ma non eccelsi risultati<br />
ottenuti con Velezia (ovvero sua moglie Grazia Letizia<br />
Veronese) in E già (1982). Rispetto al lirismo straordinariamente<br />
potabile di Mogol, Panella rappresenta una<br />
sorta di algido dark side, fautore di disanime cubiste,<br />
di simbologie algoritmiche e scambi di senso incrociati<br />
che pure mettono nel mirino - mutatis mutandis - la<br />
vita emotiva, le turbe sentimentali ed il rapporto tra individuo<br />
e società.<br />
Giochi di parole che guadagnano il senso alla fine<br />
del labirinto, rivelando l’insensatezza perniciosa del<br />
formulario quotidiano. Un percorso che andava coperto<br />
con flemma da analista, con calcolo da laboratorio,<br />
da cui lo sconcertante disin-canto dell’interpretazione,<br />
perché il canto non è più libero se non nella dimensione<br />
distaccata di un punto d’osservazione intangibile. Il<br />
Battisti panelliano compie una necessaria confutazione<br />
di sé e (quindi) di tanto rassicurante codice melodico,<br />
introducendo nel salottino del pop-rock italiano un<br />
veleno alieno. Ok, certo, nessuna invenzione: nulla che<br />
post-punk e new wave non avessero già ampiamente<br />
sperimentato. E che pure il nostro Paese non aveva metabolizzato<br />
in una concreta dimensione/diffusione popolare.<br />
Di nuovo, è possibile stabilire un parallelo con<br />
quanto fatto da Lucio nei sessanta, quando aveva innestato<br />
l’RnB a pieno titolo nell’immaginario collettivo.<br />
Il metodo di lavoro avviato con Don Giovanni<br />
(1986) - prima le musiche, poi i testi - fu ribaltato con<br />
L’apparenza (1988) e La sposa occidentale (1990), riverberando<br />
nella sublime freddezza delle musiche. Nel<br />
successivo CSAR il processo creativo sembra raggiungere<br />
un punto di equilibrio superiore (meglio di come<br />
farà due anni più tardi il pur notevole canto del cigno<br />
Hegel): malgrado la netta accentuazione ritmica - in<br />
chiave funky dance con qualche tentazione techno:<br />
produce Andy Duncan, già Pet Shop Boys, Frankie<br />
Goes To Hollywood e New Order - le melodie tornano<br />
a gonfiare il petto, sembra cioè che Battisti abbia stabilito<br />
una padronanza nuova anzi rinnovata. Si prenda<br />
Ecco i negozi - il rap finto mansueto delle strofe come<br />
trampolino per il setoso trasporto del ritornello - o l’allusiva<br />
gaiezza di La metro eccetera, oppure l’incalzante<br />
palpitazione di Cosa farà di nuovo.<br />
Ed è proprio questo stare sul pezzo con la tensione<br />
delle grandi occasioni a rendere possibile episodi quali<br />
Così gli dei sarebbero (saturo di affabili insidie ed emblematiche<br />
esegesi) o la straordinaria title-track, tirata<br />
d’allegorie sinistre, livide reiterazioni e sferzanti simbolismi.<br />
Canzoni che non smettono di germinare sensi<br />
rispetto ai propri tempi e che pure messi in prospettiva<br />
non scherzano affatto, continuando a ghignare il loro<br />
sberleffo pungente. Appostatissime nell’aria.<br />
Stefano Solventi<br />
classic album rev<br />
tranSient random-noiSe BurStS with announcementS<br />
(elektra, novemBre 1993)<br />
L’incontro fatale avvenne sul finire degli Eighties. Lui,<br />
<strong>Tim</strong> Gane, polistrumentista inglese appassionato di<br />
kraut rock e wave sperimentale. Lei, Laetitia Sadier, vocalist<br />
francese col pallino della chanson sbilanciata pop.<br />
L’intesa operò il miracolo, attivando forze incognite che<br />
frutteranno una sintesi sconcertante. A quel punto la<br />
coppia si espanse in sestetto, ché altrimenti non sarebbe<br />
stato possibile dare vita ad un costrutto sonoro a<br />
base di stratificazioni magmatiche d’organi (Farfisa e<br />
Vox) e sintetizzatori (Moog), di chitarre e percussioni.<br />
Si era ormai nei Novanta, girava qualcosa nell’aria, una<br />
forte spinta a ridefinire sostanza e finalità del rock. Il<br />
post-rock non fu, ovviamente, un genere, ma un sentimento<br />
generazionale che esigeva porre in discussione<br />
le consuetudini e i rituali fin nel profondo.<br />
Da par loro, gli Stereolab colsero nell’aria il bisogno<br />
di riorganizzare l’esperienza di composizione e ascolto: le<br />
canzoni come sezioni di flussi sonori, la reiterazione come<br />
dimensione dell’esperienza emotiva, l’improvvisazione<br />
come variazione organica del ciclo meccanico, il timbro<br />
analogico della strumentazione vintage come segno<br />
esoterico prima che stilistico, quasi che nella sporcizia<br />
delle vibrazioni armoniche, nella ruvidità delle distorsioni<br />
pre-digitali, si celasse una sublime mostruosità, il rifiuto<br />
programmatico dell’ottimizzazione indotta dalle logiche<br />
industriali. Quanto alla componente melodica, anziché<br />
annullare il canto come usarono compagini-cardine quali<br />
Slint, GY!BE e Tortoise, gli Stereolab optarono per una<br />
sua ricollocazione e - in un certo senso - reinvenzione,<br />
immergendo la melodia in una zuppa acida formalmente<br />
ostile ma sorprendentemente fertile.<br />
Se al centro del progetto sembra esserci il tentativo<br />
di aggiornare i raga lisergici dei sixties rispetto ai codici<br />
dei neo-fricchettoni della rave-generation (un po’<br />
come similmente/diversamente avevano fatto i Primal<br />
Scream nel ‘91 con l’epocale Screamadelica), si trattava<br />
in ogni caso di sottrarsi al logoro schematismo<br />
della forma canzone per accogliere ed enfatizzare le<br />
capacità evocative - o genuinamente psichedeliche -<br />
del rock: per far questo guardarono principalmente al<br />
kraut di Can e Faust, alla contro-psichedelia dei Velvet<br />
Underground, al minimalismo estatico di Steve Reich,<br />
alle congetture soniche di Jesus & Mary Chain e My<br />
Bloody Valentine, alle allucinazioni atmosferiche<br />
dei Cocteau Twins, al massimalismo fiabesco dei Mercury<br />
Rev, ovunque insomma fossero stati edificati<br />
“altrove” musicali nei quali si esaltassero le possibilità<br />
ammalianti - e totalizzanti - del suono.<br />
L’entusiasmo suscitato dall’esordio Peng! (Too Pure,<br />
1992) non tardò a suscitare gli interessi della Elektra che<br />
pose il marchio al secondo lavoro lungo Transient Random-Noise<br />
Bursts With Announcements, già apice artistico<br />
della band. Tra le linee melodiche pigre e dolciastre<br />
(cantate da una Sadier flemmatica, quasi algida, sorta di<br />
nipotina sintetica di Nico), gli stridori siderali delle tastiere,<br />
le pulsazioni battenti ed i clangori scomposti delle corde<br />
si innesca una compenetrazione ipnotica, suadente,<br />
penetrante e tentacolare. E’ pop come somma di esperienze<br />
pop, la rumorosità come sfondo inevitabile, tumulto<br />
percettivo, sovraccarico di sensazioni auditive attorno<br />
alla ramificazione tenue ma tenace della melodia. Fu così<br />
che, in un certo senso, il post-rock partorì l’iper-pop. Con<br />
fantasmatiche guarnizioni più o meno riconoscibili: l’evidente<br />
parafrasi NEU!della suite Jenny Ondioline, l’indolente<br />
impudenza Modern Lovers in I’m Going Out Of My<br />
Way, l’estro anarcoide Red Crayola via Suicide in Analogue<br />
Rock, omeopatie George Harrison - un cui sample<br />
era presente nella versione originale, poi tolto per evitare<br />
noie legali - in Pack Yr Romantic Mind, sordidezza Royal<br />
Trux in Golden Ball, e via discorrendo.<br />
La targa di retro-futurismo è simpatica e attagliata ma<br />
rischia di prestarsi all’equivoco: val bene sottolineare che<br />
la musica degli Stereolab rappresentò puntualmente le<br />
pulsioni profonde del proprio tempo, alba di un’epoca<br />
che vedrà rimettere totalmente in gioco lo scibile rock alla<br />
stregua di un repertorio accessibile, disponibile e simultaneo<br />
secondo i nuovi codici imposti dall’avvento del web.<br />
Stefano Solventi<br />
122 123
sentireascoltare.com