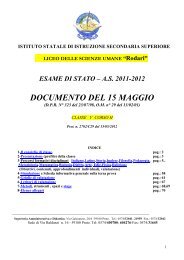esame di stato - ISISS Cicognini Rodari
esame di stato - ISISS Cicognini Rodari
esame di stato - ISISS Cicognini Rodari
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE<br />
LICEO CLASSICO “<strong>Cicognini</strong>”<br />
ESAME DI STATO – A.S. 2010-2011<br />
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO<br />
(D.P.R. N° 323 del 23/07/98, O.M. n° 29 del 13/02/01)<br />
CLASSE III CORSO B<br />
INDICE<br />
1-Il consiglio <strong>di</strong> classe, pag.: 2<br />
2-Presentazione Percorso formativo della classe pag.: 3 - 4<br />
3-Percorsi formativi <strong>di</strong>sciplinari Italiano,Latino, Greco, Storia,Inglese,Filosofia,<br />
Matematica, Fisica, Scienze, Arte, Educ.Fisica,Religione<br />
(Obiettivi, contenuti, approfon<strong>di</strong>menti in<strong>di</strong>viduali, valutazione)<br />
pag.:<br />
5 - 34<br />
4-Simulazione e Scheda informativa generale sulla terza prova pag.: 35<br />
5-Griglie <strong>di</strong> valutazione pag.: 42<br />
6-I criteri <strong>di</strong> valutazione pag.: 48<br />
7-Meto<strong>di</strong>, strumenti , spazi pag.: 49<br />
8-Elenco allegati pag.: 50<br />
__________________________________________________________________________<br />
Segreteria Amministrativa e Didattica: Via Galcianese, 20/4 -59100 Prato. Tel.: 0574/32041; 21959 -Fax.: 0574/32042<br />
Sede <strong>di</strong> Via Baldanzi n. 16 - 59100 Prato. Tel: 0574/400780; 604276-Fax: 0574/31645<br />
1
1. Consiglio <strong>di</strong> Classe <br />
Dirigente Scolastico Mario Di Carlo<br />
Italiano Stefano Sacconi<br />
Latino Floria Cresci<br />
Greco Floria Cresci<br />
Storia Giovanni Spena<br />
Lingua Inglese Eugenia Gervasi<br />
Filosofia Maurizio Sarti<br />
Matematica Margherita Meoli<br />
Fisica Chiara Mastrantonio<br />
Scienze Giuseppe Meucci<br />
Storia dell’Arte Antonello Nave<br />
Educazione Fisica Giovanni Biagiotti<br />
Religione Paolo Drago<br />
Elenco dei docenti del triennio<br />
Firma<br />
MATERIE I LICEO II LICEO III LICEO<br />
ITALIANO CMaccacciniS Sacconi Stefano Sacconi Stefano Sacconi<br />
LATINO Floria Cresci Floria Cresci Floria Cresci<br />
GRECO Floria Cresci Floria Cresci Floria Cresci<br />
MATEMATICA Margherita Meoli Margherita Meoli Margherita Meoli<br />
FISICA MichelangeloManetta Chiara Mastrantonio<br />
STORIA Giovanni Spena Giovanni Spena Giovanni Spena<br />
FILOSOFIA Umberto Papeschi Maurizio Sarti Maurizio Sarti<br />
INGLESE Eugenia Gervasi Eugenia Gervasi Eugenia Gervasi<br />
SCIENZE Giuseppe Meucci Giuseppe Meucci Giuseppe Meucci<br />
STO. DELL’ARTE Antonello Nave Antonello Nave Antonello Nave<br />
ED. FISICA Giovanni Biagiotti Giovanni Biagiotti Giovanni Biagiotti<br />
RELIGIONE Paolo Drago Paolo Drago Paolo Drago<br />
2
2. Profilo della classe <br />
La classe I B dell’a. s. 2008 – 2009 si costituisce da due quinte Ginnasio, la V B (venti alunni) e la<br />
V A ( sei alunne), da qui alle spalle due percorsi paralleli <strong>di</strong>stinti dei due gruppi costituenti la Prima<br />
Liceo, ma anche la consistente composizione attorno la componente originaria V B. Accanto a tal<br />
dato va subito dopo segnalato un secondo tratto inerente al percorso ginnasiale: sia la IV e V A, sia<br />
la IV e V B hanno avuto una configurazione della classe variabile nei due anni scolastici (tanto in<br />
IV e V A, quanto in IV e V B si sono succeduti ritiri, non ammissioni ad anno scolastico succesivo,<br />
nuovi iserimenti nel collettivo classe); la variazione nel corso dei due anni ginnasiali ha riguardato<br />
anche gli insegnanti: un numero significativo <strong>di</strong> docenti <strong>di</strong> <strong>di</strong>scipline <strong>di</strong>stinte si sono succeduti nei<br />
due anni ginnasiali, tale il cambio delle figure <strong>di</strong> insegnanti da incidere sia sulla continuità <strong>di</strong>dattica<br />
sia sull’orientarsi degli alunni alla acquisizione <strong>di</strong> capacità precipue da far maturare nelle singole<br />
<strong>di</strong>scipline. E tuttavia le classi coinvolte hanno saputo far fronte alle con<strong>di</strong>zioni non favorevoli<br />
creando un ambiente armonico e collaborativo, chiunque nei subentri o per altra circostanza ha<br />
avuto bisogno <strong>di</strong> sostegno ed aiuto l’ha costantemente trovato.<br />
La classe IB una volta costituitasi con le storie dei due gruppi originari, storie succintamente<br />
riprese, ha avuto un percorso meno agitato rispetto ai due anni ginnasiali: sia dal lato della<br />
configurazione della classe, sia dal lato dei docenti: il prof Umberto Papeschi tiene cattedra <strong>di</strong><br />
Filosofia il primo anno del triennio liceale poi a lui subentra per i due anni successivi il prof<br />
Maurizio Sarti, il prof <strong>di</strong> Italiano Carlo Maccaccini in I B, sulla fine del primo quadrimestre, lascia<br />
la classe per usufruire <strong>di</strong> Borsa <strong>di</strong> ricerca per Dottorato, il prof <strong>di</strong> Fisica Michelangelo Manetta<br />
svolge attività in classe il secondo anno del triennio liceale, nel terzo anno a lui subentra la prof.ssa<br />
Chiara Mastrantonio. Variazioni minime, ripeto, a fronte delle quali la classe non ha risentito <strong>di</strong><br />
particolari contraccolpi avendo messo in campo il suo atteggiamento responsabile <strong>di</strong> sempre, la sua<br />
<strong>di</strong>sponbilità ad accogliere le in<strong>di</strong>cazioni degli insegnanti, la sua partecipazione interessata alle<br />
lezioni e alle iniziative organizzate dalla scuola, l’impegno e la determinazione a darsi e conseguire<br />
rinnovati obiettivi.<br />
Il profilo della classe è dunque alto, su <strong>di</strong> esso è bene ulteriormente indugiare. Nei tre anni liceali, a<br />
fronte della sperimentazione in Arte, in Lingua e Cultura inglese ed in Matematica, la classe ha<br />
con<strong>di</strong>viso l’opzione della sperimentazione: in inglese lo scorso anno tutti gli alunni hanno richiesto<br />
la preparazione all’<strong>esame</strong> FCE dell’Università <strong>di</strong> Cambridge; in matematica, con alle spalle<br />
l’esperienza della sperimentazione, la classe quest’anno ha partecipato ai ‘Giochi <strong>di</strong> Archimede’<br />
organizzati dall’UMI (Unione Matematica Italiana), inoltre un gruppo <strong>di</strong> alunni ha messo in gioco<br />
le capacità maturate nei giochi Mon<strong>di</strong>ali o ‘Kangourou’. Altrettanto attivo interesse la classe ha<br />
testimoniato nella partecipazione, lungo il presente ultimo anno del triennio, sia nei Certamina<br />
nazionali <strong>di</strong> Latino, sia nelle uscite integrative in Scienze, sia nelle uscite per visite a Musei (e qui<br />
ricordo anche la partecipazione della classe a due lezioni tenute dall’ex alunno del <strong>Cicognini</strong><br />
Leonardo Anatrini su musica ed arti figurative negli anni delleAvanguar<strong>di</strong>e), sia nel viaggio <strong>di</strong> due<br />
alunne sul treno della Memoria verso Auschwitz. Da ultimo un cenno va fatto al viaggio <strong>di</strong><br />
istruzione in Grecia che ha consentito agli alunni <strong>di</strong> visitare luoghi e siti storico culturali già<br />
incontrati nei programmi scolastici e che gli alunni hanno valutato quale una esperienza intensa e <strong>di</strong><br />
profondo impatto su <strong>di</strong> loro.<br />
Il Consiglio <strong>di</strong> classe non solo ha stimolato il molto investimento curriculare ed extracurriculare<br />
della classe, ma anche l’ha orientato ed in<strong>di</strong>rizzato alla maturazione <strong>di</strong> un complessivo pensiero<br />
critico. Tale tensione <strong>di</strong>dattica del Consiglio <strong>di</strong> classe è stata esplicitata anche nell’azione <strong>di</strong><br />
recupero od assorbimento <strong>di</strong> alcune <strong>di</strong>fficoltà, <strong>di</strong> pochi, in alcune <strong>di</strong>scipline, ciò attraverso le<br />
opzioni del recupero in itinere, del corso <strong>di</strong> recupero o infine dello sportello. Dal Consiglio <strong>di</strong><br />
Classe inoltre è stata tenuta costante la medesima <strong>di</strong>rezione della bussola nelle tre simulazioni <strong>di</strong><br />
Terza Prova (tipologia B – tipologia A – tipologia B)<br />
La cooperazione tra insegnanti ed alunni è stata piena ne ha tratto vantaggio il ren<strong>di</strong>mento dei<br />
<strong>di</strong>scenti che è me<strong>di</strong>amente buono. Per gli specifici risultati conseguiti nelle varie <strong>di</strong>scipline si<br />
rimanda ai giu<strong>di</strong>zi contenuti nelle relazioni dei singoli docenti.<br />
3
4<br />
Da ultimo si segnala che l’Istituto <strong>Cicognini</strong> – <strong>Rodari</strong> me<strong>di</strong>ante la propria struttura e connessioni<br />
esterne ha provveduto a dare informazioni alla classe circa attività <strong>di</strong> orientamento sul territorio in<br />
<strong>di</strong>rezione delle successive opzioni universitarie degli alunni, quest’ultimi ne hanno sottolineato<br />
l’utilità nella prospettiva delle loro successive scelte formative.<br />
1 Ban<strong>di</strong>ni Massimiliano<br />
2 Berti Carlotta<br />
3 Biagini Martina<br />
4 Calò Gioia<br />
5 Cantini Eleonora<br />
6 Cascone Aurora<br />
7 Fioravanti Giulia<br />
8 Fornaciari Chiara<br />
9 Gargiani Clau<strong>di</strong>a<br />
10 Gelli Elisa<br />
11 Gori Arianna<br />
12 Guida Simone<br />
13 La Vigna Giovanni<br />
14 Livi Francesca<br />
15 Mannucci Serena<br />
16 Marchese Andrea<br />
17 Marini Letizia<br />
18 Nassa Ilaria<br />
19 Pancani Valentina<br />
20 Rosati Matilde<br />
21 Sanesi Virginia<br />
21 Santi Maria<br />
23 Toccafon<strong>di</strong> Alice<br />
24<br />
25<br />
Elenco Studenti
3. 1. Percorso formativo <strong>di</strong> Italiano <br />
DOCENTE Prof Stefano Sacconi<br />
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE:<br />
Percorsi formativi <strong>di</strong>sciplinari<br />
La classe è risultata positiva, sia per quanto riguarda l’attenzione e l’impegno, che il profitto<br />
conseguito.<br />
Naturalmente bisogna <strong>di</strong>stinguere al suo interno gli alunni che hanno maggiormente contribuito a<br />
questo ren<strong>di</strong>mento, nel quadro <strong>di</strong> un proficuo <strong>di</strong>alogo educativo. Permangono alcune <strong>di</strong>fficoltà,<br />
presenti soprattutto nell’esposizione delle prove scritte.<br />
In<strong>di</strong>cazioni metodologiche:<br />
a tale proposito, anche in questo anno scolastico, ho utilizzato tre tipologie presenti nell’Esame <strong>di</strong><br />
<strong>stato</strong>, prima prova scritta: tip.A, analisi <strong>di</strong> un testo in prosa o in poesia; tip.B, saggio breve o<br />
articolo <strong>di</strong> giornale; tip.D, tema <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne generale. Per quanto riguarda le prove orali, ho dato<br />
spazio ad eventuali approfon<strong>di</strong>menti personali che permettessero una migliore comprensione <strong>di</strong><br />
alcuni brani o autori della letteratura italiana ed europea.<br />
Programmi:<br />
− A. Manzoni: la vita, le opere, la conversione. La Pentecoste, dagli Inni sacri; Il cinque maggio,<br />
dalle O<strong>di</strong> civili. La morte <strong>di</strong> Ermengarda, dall’Adelchi (coro dell’atto IV). I promessi sposi: la<br />
conclusione del romanzo.<br />
− G. Leopar<strong>di</strong>: la vita, le opere, il pensiero (letture dallo Zibaldone). Analisi <strong>di</strong> alcuni Canti:<br />
L’infinito, La sera del dì <strong>di</strong> festa, ad Angelo Mai, a Silvia, le Ricordanze, La quiete dopo la<br />
tempesta, Il sabato del villaggio, il Canto notturno, Il passero solitario, A se stesso, La ginestra.<br />
Le operette morali: <strong>di</strong>alogo della Natura e <strong>di</strong> un Islandese.<br />
− L’età postunitaria: la Scapigliatura e G. Carducci (I<strong>di</strong>llio maremmano, da Rime nuove; Alla<br />
stazione in una mattina d’autunno, da O<strong>di</strong> barbare)<br />
− G. Verga: la vita e le opere. Le prefazioni: da Eva, da L’amante <strong>di</strong> Gramigna, da I malavoglia. I<br />
racconti veristi: Fantasticheria e Rosso Malpelo, da Vita dei campi. Il ciclo dei vinti e la<br />
conclusione dei Malavoglia. Le novelle rusticane: la Roba. La morte <strong>di</strong> mastro don Gesualdo.<br />
− Il decadentismo e i suoi caratteri. G. d’Annunzio: la vita “inimitabile”. L’estetismo e la sua<br />
crisi: una fantasia “in bianco maggiore”, da Il piacere. Le lau<strong>di</strong>: Ferrara, da Elettra; la Sera<br />
fiesolana e la Pioggia nel pineto, da Alcyone.<br />
− G. Pascoli: la vita e le opere. Una poetica decadente, da Il fanciullino. Letture da Myricae: X<br />
Agosto, L’assiuolo; dai Poemetti: l’Aquilone; dai Canti <strong>di</strong> Castelvecchio: Il gelsomino notturno.<br />
− Futuristi e crepuscolari: G. Gozzano, la signorina Felicita.<br />
− I. Svevo: la vita e i suoi romanzi. La profezia <strong>di</strong> un’apocalisse cosmica, da La coscienza <strong>di</strong><br />
Zeno.<br />
− L. Pirandello: la vita, le opere, la visione del mondo. Il treno ha fischiato, dalle Novelle per un<br />
anno. La “lanterninosofia”, da Il fu Mattia Pascal. Nessun nome, da Uno nessuno centomila. la<br />
rappresentazione teatrale tra<strong>di</strong>sce il personaggio, da Sei personaggi in cerca d’autore.<br />
− L’ermetismo.<br />
5
6<br />
− E. Montale: la vita e le opere. Letture da Ossi <strong>di</strong> seppia: I limoni, Non chiederci la parola,<br />
Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male <strong>di</strong> vivere ho incontrato. La casa dei doganieri, da Le<br />
occasioni; La primavera hitleriana, da La bufera.<br />
− Para<strong>di</strong>so dantesco: lettura e analisi dei canti I-III-VI-VIII-XI-XV-XVII-XXI-XXIII-XXXIII.<br />
3. 2. Percorso formativo <strong>di</strong> Latino e Greco
DOCENTE: Floria Cresci<br />
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE<br />
Seguo la classe, derivante dalla fusione <strong>di</strong> due quinte ginnasio,caratterizzate da un percorso<br />
ginnasiale <strong>di</strong> avvicendamenti <strong>di</strong> docenti per il latino e greco, in ambedue le <strong>di</strong>scipline dall’inizio del<br />
triennio.<br />
Gli studenti hanno da subito mostrato interesse per le <strong>di</strong>scipline, <strong>di</strong>sponibilità allo stu<strong>di</strong>o e<br />
partecipazione all’attività <strong>di</strong>dattica, così che si è recuperato quel <strong>di</strong>sagio inevitabilmente avvertito<br />
per l’avvicendamento <strong>di</strong> insegnanti vissuto tra quarta e quinta ginnasio e si sono verificate le<br />
con<strong>di</strong>zioni perché la classe fosse in grado <strong>di</strong> misurarsi con i testi degli autori oggetto <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o,<br />
secondo quanto prevedono i programmi ministeriali.<br />
A tal proposito si nota che, mentre l’autonomia nello stu<strong>di</strong>o storico-letterario risulta per tutti<br />
apprezzabile, per alcuni studenti – nonostante l’impegno con cui hanno cercato <strong>di</strong> colmare le lacune<br />
pregresse <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne morfo-sintattico – persistono evidenti fragilità nella preparazione linguistica e<br />
nella competenza della traduzione. Diversi alunni possiedono in modo adeguato gli strumenti <strong>di</strong><br />
analisi e comprensione dei testi e alcuni mostrano capacità <strong>di</strong> efficace rielaborazione autonoma del<br />
testo in lingua, conseguendo risultati ottimi ed eccellenti.<br />
Per quanto riguarda lo svolgimento dei programmi, nonostante un certo rallentamento<br />
all’inizio d’anno ( tra settembre ed ottobre) dovuto all’avvicendamento <strong>di</strong> due docenti chiamate a<br />
sostituirmi durante un’assenza per motivi <strong>di</strong> salute, essi hanno, poi, proceduto con regolarità. ho<br />
incentrato il lavoro sull’analisi linguistica e contenutistica dei testi tradotti e commentati e la<br />
cresciuta maturità degli studenti, la consapevolezza dell’<strong>esame</strong> <strong>di</strong> steto, il desiderio – per molti – <strong>di</strong><br />
affrontarlo al meglio delle proprie possibilità hanno motivato il lavoro del gruppo-classe.<br />
Segnalo:<br />
1) la partecipazione attiva e entusiasta al viaggio d’istruzione in Grecia, dal 6 al 12 marzo 2011, che<br />
è <strong>stato</strong> vissuto con curiosità intellettuale e verifica in loco <strong>di</strong> tanti stu<strong>di</strong> scolastici e al quale ha<br />
partecipato tutta la classe tranne 2 alunne. L’itinerario prescelto ha portato gli allievi a visitare<br />
Atene, l’istmo <strong>di</strong> Corinto, l’Argolide - con Epidauro, Tirinto e Micene - e, infine, attraverso<br />
l’Arca<strong>di</strong>a, Olimpia nell’Elide. Particolare attenzione è stata riservata alla visita dei teatri e degli<br />
odeia presenti nei vari siti in relazione al programma <strong>di</strong> letteratura greca svolto.<br />
2) la partecipazione dei seguenti allievi a Certamina nazionali <strong>di</strong> latino:<br />
Eleonora Cantini e Chiara Fornaciari (9° Certamen Varronianum Reatinum).<br />
Giulia Fioravanti XXI Certamen Ciceronianum Arpinas.<br />
3) la partecipazione della classe a tre conferenze <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>mento: prof. M. Labate, I bersagli<br />
della satira ( 15 <strong>di</strong>cembre 2010); Prof.ssa M.-P- Pieri Tandoi, Letture Noventesche della Germania<br />
<strong>di</strong> Tacito ( 30 aprile 2011); prof.ssa P. Bray, La donna a Roma ( 23 maggio 2011)<br />
OBIETTIVI E METODOLOGIE<br />
Gli obiettivi <strong>di</strong>sciplinari che hanno sostenuto la mia azione <strong>di</strong>dattica sono stati <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne linguistico<br />
e <strong>di</strong> tipo storico-letterario:<br />
I) Obiettivi linguistici:<br />
a) comprensione, interpretazione e traduzione <strong>di</strong> un testo <strong>di</strong> autore attraverso accurata analisi<br />
morfo-sintattica , corretta in<strong>di</strong>viduazione del significato lessicale e appropriata resa italiana.<br />
b) capacità <strong>di</strong> giustificazione della propria traduzione.<br />
L’esercizio <strong>di</strong> traduzione è <strong>stato</strong> svolto, in piccola parte, sui brani assegnati nei precedenti esami <strong>di</strong><br />
<strong>stato</strong>; si sono analizzati e letti testi <strong>di</strong> autori del programma <strong>di</strong> III liceo e, in particolare per latino,<br />
7
8<br />
data la seconda prova scritta all’<strong>esame</strong>, ci si è esercitati su brani <strong>di</strong> storici, <strong>di</strong> oratori,<strong>di</strong> filosofi e <strong>di</strong><br />
prosatori <strong>di</strong> età classica e imperiale.<br />
II) Obiettivi storico-letterari:<br />
α) conoscenza della storia della letteratura per generi e per autori con capacità <strong>di</strong><br />
contestualizzazione storico-letteraria <strong>di</strong> ogni autore.<br />
β) capacità <strong>di</strong> analizzare, interpretare e considerare testi d’autore nel loro specifico linguisticoletterario.<br />
χ) capacità <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare collegamenti fra autori latini e greci per evidenziare permanenze,<br />
variazioni e scarti nelle rispettive culture e capacità <strong>di</strong> confrontare aspetti e momenti del<br />
mondo classico con la modernità.<br />
Al fine <strong>di</strong> conseguire gli obiettivi storico-letterari che mi sono prefissata ho attivato:<br />
a) stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong>acronico della storia letteraria, con opportuno utilizzo dei testi antologici in<br />
traduzione, con richiami fra letteratura greca e letteratura latina e con eventuali riprese dai<br />
programmi <strong>di</strong> I e II liceo.<br />
b) ricostruzione del quadro dei fatti storico-culturali significativi.<br />
c) nel caso dei testi in lingua: lettura – metrica ove prevista –, analisi linguistica, stilistica e<br />
contenutistica dei passi scelti con inquadramento storico-letterario dei vari autori<br />
CONTENUTI E TEMPI DELLE PROGRAMMAZIONI DI GRECO E DI LATINO<br />
Lo svolgimento dei programmi ha, in genere, rispettato i contenuti e i tempi fissati all’inizio<br />
dell’anno scolastico nell’incontro <strong>di</strong> area, pur con inevitabile intensificazione dei ritmi soprattutto<br />
nella parte finale dell’anno, in ragione della mia assenza iniziale.<br />
GRECO: la comme<strong>di</strong>a (per questa classe partendo da Aristofane, che non era <strong>stato</strong> affrontato in II<br />
liceo), la letteratura <strong>di</strong> età ellenistica ed imperiale, 400 versi circa della trage<strong>di</strong>a e 26 paragrafi<br />
dell’orazione. Per le in<strong>di</strong>cazioni esatte si rinvia agli allegati programmi.<br />
Al 15 Maggio le ore <strong>di</strong> lezione svolte sono state 80 (42 nel I quadrimestre, 38 nel II).<br />
LATINO: la letteratura <strong>di</strong> età imperiale <strong>di</strong> I e II sec.d.C.; Orazio (4 satire, 9 o<strong>di</strong> e 2 epistole); Seneca<br />
(11 capitoli); Tacito (11 capitoli). Per le in<strong>di</strong>cazioni esatte si rinvia agli allegati programmi.<br />
Al 15 Maggio le ore <strong>di</strong> lezione svolte sono state 88 (47 nel I quadrimestre, 41 nel II).<br />
Gli argomenti ancora non svolti sono contrassegnati con *.<br />
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE (LATINO E GRECO)<br />
Ho effettuato tre compiti scritti per greco a quadrimestre, tre compiti nel I quadrimestre e quattro<br />
nel II per latino e almeno due colloqui orali, ripartiti sulle varie unità <strong>di</strong>dattiche. Per latino, ho<br />
svolto una verifica scritta <strong>di</strong> letteratura e traduzione nel I quadrimestre su Orazio ( sulla base della<br />
tipologia B prevista per la terza prova d’<strong>esame</strong>). Lo stesso per greco, materia per la quale si è<br />
effettuata una verifica scritta <strong>di</strong> letteratura e traduzione (l’orazione <strong>di</strong> Lisia) nel I quadrimestre,alla<br />
quale si aggiungono le tre simulazioni <strong>di</strong> terza prova d’<strong>esame</strong> (due <strong>di</strong> tipologia B, una <strong>di</strong> tipologia<br />
A) condotte nel II quadrimestre.<br />
Per i criteri <strong>di</strong> valutazione e le tabelle tassonomiche, si rinvia al POF <strong>di</strong> Istituto, nel quale è presente<br />
anche la griglia per la valutazione delle prove scritte, mo<strong>di</strong>ficata da quest’anno.<br />
PROGRAMMA DI LATINO
TESTI ADOTTATI<br />
G.B. Conte - E. Pianezzola, Storia e testi della letteratura latina, vol 3 (L’età imperiale), Le Monnier<br />
Novae Voces- Orazio, a cura <strong>di</strong> M. Gori, Ed. scol. B. Mondatori<br />
Seneca, De brevitate vitae, a cura <strong>di</strong> R. Gazich, C. Signorelli E<strong>di</strong>tore<br />
Neropolis, La Roma <strong>di</strong> Nerone negli Annales <strong>di</strong> Tacito, a cura <strong>di</strong> A. Roncoroni, Signorelli Scuola<br />
F. MONTANARI- A.BARABINO- N. MARINI, Lintres. Versioni latine per il biennio, Loescher<br />
A) Letteratura<br />
(con lettura in traduzione, analisi e commento dei brani riportati sull’antologia)<br />
• ORAZIO. Vita e opere. Le Satire: breve storia del genere letterario; aggressività e critica dei costumi.<br />
Le O<strong>di</strong>: struttura, modelli e temi. Le Epistole (tra<strong>di</strong>zione dell’epistola poetica). Orazio e la poesia. Orazio e<br />
Mecenate<br />
Per le letture in lingua e in traduzione, si veda sotto AUTORI.<br />
Parte I: L’ETA’ IMPERIALE DA TIBERIO AI FLAVI: inquadramento storico e culturale.<br />
• SENECA IL VECCHIO e le declamazioni. Lettura antologica in traduzione: La prima argomentazione<br />
(suas.1.1), L’amore in catene (contr.1.6.1-2), (Conte-Pianezzola vol.3, p. 40 s.e p. 42 s.)<br />
• SENECA. Vita ed opere. I Dialogi (struttura, contenuti e cronologia) e la saggezza stoica. Il De<br />
Clementia e i rapporti con il potere. La Consolatio come genere letterario. La pratica quoti<strong>di</strong>ana della<br />
filosofia: le Epistulae ad Lucilium (il genere letterario). Le trage<strong>di</strong>e. L’Apokolokyntosis.<br />
Per le letture in lingua e in traduzione, si veda sotto AUTORI.<br />
• LUCANO*. Vita e opere. Struttura e contenuto del Bellum Civile. Lucano e Virgilio: la <strong>di</strong>struzione dei<br />
miti augustei. L’elogio <strong>di</strong> Nerone. I personaggi del poema (Conte-Pianezzola vol.3, pp.141-149) Lettura<br />
antologica in traduzione: Proemio, Phars. I, 1-32; Che cos’è il saggio, Phars.2.380-391; L’inantesimo <strong>di</strong><br />
Erittone, Phars. 6, 654-718 (Conte-Pianezzola vol.3, pp.150-153; p.161; pp. 166-169).<br />
• PETRONIO*. L’autore e il Satyricon. Titolo e genere letterario. Rapporti con la satira menippea, con il<br />
romanzo greco, con la fabula milesia. Trama ed ambientazione. La lingua. Il realismo. Lettura antologica in<br />
traduzione: Dibattito sulla decadenza dell’oratoria (Sat. 1-4); Coena Trimalchionis: Presentazione <strong>di</strong> T. (Sat.<br />
26.7-28.9), La Troiae Halosis (Sat. 89), La novella della matrona <strong>di</strong> Efeso (Sat. 110.6-113.2), (Conte-<br />
Pianezzola vol.3, pp.201-203; pp.216-219; pp.221-224).<br />
• LA SATIRA SOTTO IL PRINCIPATO:<br />
PERSIO. Vita ed opere. Il programma satirico e i rapporti con il pubblico. Lettura antologica in traduzione:<br />
Choliambi 1-14 (Conte-Pianezzola vol.3, pp.250-252)<br />
• GIOVENALE. Vita ed opere. Temi delle satire. L’in<strong>di</strong>gnatio. Lettura antologica in traduzione: Satira 6<br />
(vv. 136-160; vv.231-241; vv.268-285; vv.434-456) (Conte-Pianezzola vol.3, pp.263-266)<br />
PLINIO IL VECCHIO e il sapere specialistico.<br />
• MARZIALE . Vita ed opere. L’epigramma come poesia realistica; precedenti letterari, struttura e temi.<br />
(Conte-Pianezzola vol.3, pp.331-334). Lettura antologica in traduzione: Gli epigrammi biografici:<br />
Epigrammata 10, 96 (Nostalgia <strong>di</strong> Bilbilis); 10.103 (Desiderio <strong>di</strong> tornare); 10, 104 (Preparativi per il viaggio<br />
in Spagna). Dichiarazioni <strong>di</strong> poetica: 10,4 (La scelta del genere); 4,49 (Che cosa non è un epigramma). Gli<br />
epigrammi satirici: 1,30; 1,84; 3,26; 4.41; 8.79 (Conte-Pianezzola vol.3, p.334 s., p.340 s.,p.343, p. 345,<br />
pp.346-348).<br />
• QUINTILIANO . Vita ed opere. Corruzione dell’eloquenza Il programma educativo <strong>di</strong> Q. L’oratore e il<br />
principe (Conte-Pianezzola vol.3, pp.357-360). Lettura antologica in traduzione: Alcuni principi pedagogici<br />
(Inst. orat. 1.1.20-29); I primi passi nell’istruzione (Inst. orat.1,2.18-28); Il buon maestro (Inst. orat.2,2, 4-<br />
13); Confutazione del carattere ambiguo della retorica (Inst. Orat.2.17.30-36); Elegia, satira, giambo, lirica<br />
(Inst. Orat.10.1.93-96) (Conte-Pianezzola vol.3, pp.362-367,p.368 s.)<br />
II parte : L’ETÀ IMPERIALE, II SECOLO. Inquadramento storico e culturale.<br />
• PLINIO IL GIOVANE*. Vita ed opere. Plinio e Traiano; Plinio e la società del suo tempo (Conte-<br />
Pianezzola vol.3, pp.376-378). Lettura antologica in traduzione: Epist.3.16 (Una grande figura<br />
femminile:Arria); Epist.3.21 (Plinio ricorda Marziale) (Conte-Pianezzola vol.3, pp.389-392)<br />
• TACITO. Vita ed opere. Le cause della decadenza dell’oratoria: il Dialogus de oratoribus. L’Agricola:<br />
caratteristiche dell’opera. La Germania: virtù dei barbari e corruzione dei Romani. Historiae ed Annales:<br />
9
10<br />
struttura, contenuti, la concezione storiografica <strong>di</strong> Tacito. Lingua e stile (Conte-Pianezzola vol.3, pp.399-<br />
410)<br />
Per le letture in lingua e in traduzione, si veda sotto AUTORI.<br />
B) Gli autori<br />
ORAZIO<br />
• SATIRE. In lingua con lettura metrica: I,1 Est modus in rebus; I.5 Diario <strong>di</strong> viaggio; I.9 Il seccatore;<br />
II.6 Hoc erat in votis.<br />
• ODI. In lingua : I.1 A ciascuno il proprio sogno(p.19);I.37 Ora bisogna bere (p.45);L’amore in<br />
Orazio:I.5 Naufrago d’amore(p.28 ), I.11 Leuconoe (p.41), I.23 Il cervo e la tigre(p.44); II.5 Lalage bella<br />
immatura, II.8, Barine,ammaliatrice pericolosa, I.8 Ly<strong>di</strong>a,seduttrice fatale, IV.13 Lyce bellezza sfiorita (in<br />
fotocopia)<br />
• EPISTOLE (in fotocopia);I.11 Carpe <strong>di</strong>em : I.4 Un porcellino del gregge <strong>di</strong> Epicuro.<br />
SENECA<br />
• IN TRADUZIONE :<br />
- Il prosatore moralista – Felicità e piacere (de vita beata, 5), Il saggio e il tempo (de brev. 8), Vita<br />
contemplativa e attiva ( de otio, 5.8-6.5), Un caso limite (de ira,3.14) (Conte-Pianezzola vol.3, pp.63-65,<br />
p.72)<br />
- Consolationes : - ad Marciam ,12 (Il possesso del passato consola), ibidem,24.5 (Dopo la morte), (Conte-<br />
Pianezzola vol.3, p.69 s.)<br />
- ad Polyb.12 (Elogio <strong>di</strong> Clau<strong>di</strong>o), (Conte-Pianezzola vol.3, p.70 s.)<br />
- ad Helv. matr.20 (Gli stu<strong>di</strong> del saggio), (Conte-Pianezzola vol.3, p.71 s.)<br />
- Epist. Ad Luc.1, Impiego del tempo (Conte-Pianezzola vol.3, p.77 s.)<br />
Ibidem, 47.1-13, Come trattare gli schiavi (Conte-Pianezzola vol.3, pp.84-87 )<br />
- Trage<strong>di</strong>e : Mono<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Tieste (Thy.920-969) (Conte-Pianezzola vol.3, pp.100-103)<br />
Amore, incesto, ironia tragica ( Phaedr. 589-671) (Conte-Pianezzola vol.3, pp.103-106)<br />
- Apokolokyntosis : 1- 4.1 (L’esor<strong>di</strong>o), 4.2-3 (Morte <strong>di</strong> Clau<strong>di</strong>o), 5 (Prologo…in cielo) (Conte-Pianezzola<br />
vol.3, pp.106-110)<br />
• IN LINGUA:<br />
De brevitate vitae,capp. 1-5, 7-10,14-15*.<br />
TACITO<br />
• IN TRADUZIONE :<br />
- Dialogus de oratoribus, 35 (Le scuole <strong>di</strong> retorica oggi) (Conte-Pianezzola vol.3, p.412 s.)<br />
- Agricola,3 (Il principato e la libertà); ibidem, 46 (La consolatio finale) (Conte-Pianezzola<br />
vol.3, p.417,p.419 s.)<br />
- Historiae,1.1 (Il proemio); ibidem 1.2 (Il quadro drammatico degli avvenimenti) (Conte-<br />
Pianezzola vol.3, p.422 s.)<br />
- Annales,1.1 (L’obiettività dello storico) (Conte-Pianezzola vol.3, p.433 s.)<br />
• IN LINGUA:<br />
Ann.XIII. 4-5 (Programma <strong>di</strong> governo); XIII.50-51 (Il progetto riformista); XIII.45-46* (Entra in scena<br />
Poppea); XV, 62-64 (La morte <strong>di</strong> Seneca); XVI 18-19* (La fine <strong>di</strong> Petronio).
PROGRAMMA DI GRECO<br />
TESTI ADOTTATI<br />
G. Guidorizzi, Il mondo letterario greco, L’età classica (vol.2 * e **); Dall’età ellenistica all’età cristiana<br />
(vol. 3 * e **), Einau<strong>di</strong> scuola<br />
Lisia, Per Eufileto, a cura <strong>di</strong> A.Roncoroni, Signorelli<br />
Sofocle, Antigone, a cura <strong>di</strong> V. Citti - C. Casali – M. Gubellini – A. Pennesi, Zanichelli<br />
R. Rossi, L’or<strong>di</strong>ne delle parole, Cappelli E<strong>di</strong>tore<br />
A) Letteratura<br />
• LA SECONDA META’ DEL V SECOLO - IL IV SECOLO: inquadramento storico-culturale.<br />
• LA COMMEDIA: le origini, i caratteri della comme<strong>di</strong>a attica. Perio<strong>di</strong>zzazione, struttura. La struttura<br />
architettonica del teatro greco. La comme<strong>di</strong>a antica. ARISTOFANE: la vita, le caratteristiche dell’opera, la<br />
tecnica drammaturgica, le principali comme<strong>di</strong>e (Acarnesi, Cavalieri, Nuvole, Uccelli, Lisistrata, Rane) Il<br />
coro nella comme<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Aristofane. (Guidorizzi 2*, pp. 369-403) Lettura integrale <strong>di</strong> Lisistrata .<br />
• L’ ELLENISMO. Quadro storico politico e culturale: dall’età dei Diadochi all’imperialismo romano. La<br />
koiné <strong>di</strong>alektos. Il ruolo dell’intellettuale: una nuova idea <strong>di</strong> letteratura. La cultura greca <strong>di</strong> età ellenistica. I<br />
centri principali ellenistici: Alessandria d’Egitto. (Guidorizzi 3*, pp. 3-7)<br />
• LA COMMEDIA NUOVA: dalla comme<strong>di</strong>a <strong>di</strong> mezzo a quella nuova (crisi della polis ed evoluzione della<br />
comme<strong>di</strong>a). Il teatro comico nel secolo IV. L’evoluzione della tecnica drammaturgica. MENANDRO: la vita e le<br />
opere. Le prime comme<strong>di</strong>e e quelle della maturità. La rappresentazione dei caratteri. (Guidorizzi 3*, pp. 13-<br />
31). Lettura integrale <strong>di</strong> Dyskolos e La ragazza <strong>di</strong> Samo.<br />
• CALLIMACO: Vita e opere. Gli Aitia, gli Inni, gli Epigrammi. Letture antologiche in traduzione: Aitia:<br />
Prologo contro i Telchini, Acontio e Ci<strong>di</strong>ppe; Inno a Demetra e Per i lavacri <strong>di</strong> Pallade (vv. 53-142);<br />
Giambo IV ; Epigrammi (Antologia Palatina XII, 43, 73; VII, 525). (Guidorizzi 3*, pp. 79-136)<br />
• TEOCRITO*: Vita ed opere. Letture antologiche in traduzione: I<strong>di</strong>llio VII (Le Talisie) ; Epillio XIII<br />
(Ila); Mimi II (L’incantatrice), XV (Le Siracusane). (Guidorizzi 3*, pp. 139-191)<br />
• APOLLONIO RODIO*: Vita ed opere. Letture in traduzione da Le Argonautiche: Ila rapito dalle ninfe, I,<br />
1207-1272; Il passaggio delle rupi Simplega<strong>di</strong>, II, 549-606; Eros giocatore <strong>di</strong> da<strong>di</strong> e tiratore d’arco, III,<br />
111-160; 275-290; L’angoscia <strong>di</strong> Medea innamorata III, 744-824; L’uccisione <strong>di</strong> Apsirto, IV, vv. 445-491.<br />
(Guidorizzi 3*, pp. 205-247)<br />
• L’EPIGRAMMA. Origine <strong>di</strong> una forma poetica, caratteristiche e sviluppo letterario. L’Antologia<br />
Planudea e l’Antologia Palatina. Caratteristiche dell’Antologia Palatina. Letture antologiche in traduzione:<br />
LEONIDA DI TARANTO (Antologia Palatina VII,715; VI,302; VII,472; VII,455;). NOSSIDE (Antologia Palatina,<br />
VII,718; V,170; VI,265). ANITE DI TEGEA (Antologia Palatina VI, 312; VII, 202, 190; Antologia<br />
Planudea 228) MELEAGRO DI GADARA (Antologia Palatina, Proemio La ghirlanda vv. 1-24 e 57-8; VII, 417; V,<br />
171; V, 151-152; V, 179). (Guidorizzi 3*, pp. 283-325)<br />
• LA STORIOGRAFIA ELLENISTICA*: inquadramento generale; gli storici <strong>di</strong> Alessandro. (Guidorizzi 3*, pp.<br />
361-363)<br />
• POLIBIO*: Vita ed opere. Letture antologiche in traduzione: La teoria delle forme <strong>di</strong> governo (VI, 3-5;<br />
7-9); Scipione e Polibio (XXXII, 9-11 e 16) (Guidorizzi 3*, pp. 373-378, 400-406, 413-416).<br />
• L’ETA’IMPERIALE *: Roma imperiale e mondo greco. (Guidorizzi 3**, pp. 501-4)<br />
• PLUTARCO E LA BIOGRAFIA*: Vita ed opere. Letture antologiche in traduzione: La vita <strong>di</strong> Antonio: Vizi e<br />
virtù <strong>di</strong> Antonio (9; 25-9); Moralia, La luna è abitabile in Il volto della luna( Mor.938c – 940). (Guidorizzi<br />
3**, pp. 531-591 passim)<br />
• CARATTERI DEL GENERE ROMANZESCO *(Guidorizzi 3**, pp.661-666).<br />
B) Autori<br />
L’ORATORIA, LISIA<br />
• PER EUFILETO, - In lingua: exor<strong>di</strong>um, propositio,narratio capp.1 - 26 (lettura, analisi e traduzione). In<br />
traduzione: lettura <strong>di</strong> tutte le altre parti dell’orazione.<br />
• LA TRAGEDIA, SOFOCLE<br />
ANTIGONE -<br />
11
12<br />
In lingua con lettura metrica: Prologo, vv.1-99; Primo episo<strong>di</strong>o vv. 162-331; Primo stasimo vv. 332-383<br />
(lettura proso<strong>di</strong>ca, analisi e traduzione); Secondo Episo<strong>di</strong>o vv.441-560.<br />
In traduzione: lettura <strong>di</strong> tutte le altre parti della trage<strong>di</strong>a.<br />
3 3 Percorso formativo <strong>di</strong> STORIA <br />
DOCENTE: Giovanni Spena<br />
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE<br />
Ho preso la classe III B nel primo anno del triennio superiore, ciò ha fatto sì che essa abbia<br />
usufruito della continuità <strong>di</strong>dattica in Storia lungo l’intero triennio. Altro dato da richiamare, in<br />
avvio <strong>di</strong> presentazione, è quello della sua composizione iniziale: 22 alunni provengono dalla V B e<br />
4 alunne provengono dalla V A ma i due gruppi da subito si amalgamarono abbastanza bene. Nel<br />
triennio <strong>di</strong> corso su questo collettivo <strong>di</strong> partenza vi sono stati nuovi inserimenti e nuove uscite:<br />
nel secondo quadrimestre del primo anno una alunna si ritira, poi ad avvio del secondo anno sono<br />
in 24 (essendoci <strong>stato</strong> ai primi del primo quadrimestre il ritiro <strong>di</strong> altra alunna) e a fine del medesimo<br />
secondo anno sono in 23 (essendoci stata nello scrutinio finale <strong>di</strong> giugno la non ammissione a classe<br />
successiva <strong>di</strong> una alunna), infine ad inizio del terzo anno entra nel collettivo classe una nuova<br />
alunna che nel corso del secondo quadrimestre si ritira. Ai dati precedenti in<strong>di</strong>cati va affiancato un<br />
terzo altro dato: la classe, nei tre anni <strong>di</strong> corso ha saputo positivamente far fronte ai limitati arrivi ed<br />
alle poche uscite in<strong>di</strong>cate sia per la fusione e coesione iniziale sopra richiamata, sia per la<br />
<strong>di</strong>sponibilità a cooperare per la riuscita scolastica <strong>di</strong> tutti, a sostenere e aiutare ove qualcuno<br />
palesasse nei subentri qualche <strong>di</strong>fficoltà.<br />
La classe ha dunque lavorato con costante impegno e profitto lungo il triennio sì da raggiungere<br />
esito molto sod<strong>di</strong>sfacente a conclusione del percorso, <strong>di</strong> certo ciò configura dato primo nel<br />
ren<strong>di</strong>mento della classe. Sento doveroso subito soggiungere che le capacità conseguite nella classe<br />
sono sì <strong>di</strong>versificate ma ciascuno ha lavorato con costanza e continuità nel perseguire la propria.<br />
FINALITA’ ED OBIETTIVI<br />
Nei tre anni costantemente ho proposto loro una composita attività <strong>di</strong> classe essendo previsti<br />
momenti <strong>di</strong> mia spiegazione, momenti <strong>di</strong> chiarificazione ad interruzione della spiegazione in<br />
svolgimento e momenti <strong>di</strong> confronto od interlocuzione nel tempo della loro rielaborazione in corso<br />
ante verifica frontale. Tale composita attività <strong>di</strong> classe ha avuto come fine il favorire presso i<br />
<strong>di</strong>scenti la riflessione rielaborante e come scopo il far maturare un pensiero critico non solo quale<br />
tratto scolastico ma anche quale aspetto del loro personale e consapevole definirsi. Il fine e lo scopo<br />
in<strong>di</strong>cati sono stati perseguiti attraverso costante esercizio <strong>di</strong> analisi intrerpretante degli eventi<br />
storici, attraverso il far maturare la capacità <strong>di</strong> cogliere il senso storico degli eventi in <strong>esame</strong> nei<br />
<strong>di</strong>stinti piani (socio- economico, politico – istituzionale, culturale – delle mentalità), il definire, in<br />
sintesi, una loro autonoma considerazione a fronte degli svolgimenti nella storia.<br />
METODOLOGIE<br />
Tutta l’attività <strong>di</strong> classe si è svolta a partire dalla mia richiesta <strong>di</strong> inferenza a strumenti <strong>di</strong> analisi<br />
favorenti l’interpretazione degli eventi. Tra gli strumenti interpretanti qui ricordo oltre la<br />
<strong>di</strong>slocazione <strong>di</strong> piano o <strong>di</strong> ambito <strong>di</strong> un dato evento anche la sua variabile configurazione negli<br />
sviluppi e svolgimenti, nonché le connessioni tra eventi nei tempi multipli (nell’adesso, nel me<strong>di</strong>o<br />
tempo, nei tempi lunghi). Qui un cenno va anche fatto all’attenzione prestata alla esposizione
argomentativa or<strong>di</strong>nata ed efficace, correlata alla capacità riflessiva effettivamente maturata.<br />
VERIFICHE<br />
Le verifiche per lo più sono state due a quadrimestre per ciascuno alunno, ma per i <strong>di</strong>scenti in<br />
momentanea <strong>di</strong>fficoltà sono state <strong>di</strong> numero superiore, me<strong>di</strong>amente tre. La griglia <strong>di</strong> valutazione è<br />
stata quella inserita nel POF<br />
PROFITTO CONSEGUITO<br />
Nel tempo ciascun alunno ha conseguito propria capacità e competenza <strong>di</strong> riflessione sugli eventi<br />
storici, me<strong>di</strong>amente nel collettivo classe è più che <strong>di</strong>screta. Più in dettaglio a conclusione del<br />
triennio una parte significativa degli alunni perviene a capacità semplice definita e consolidata, un<br />
numero ampio <strong>di</strong> loro perviene ad articolata e duttile capacità ed infine una restante parte più<br />
limitata perviene a capacità accurata e densa.<br />
PROGRAMMA DI STORIA<br />
Unità <strong>di</strong>dattica 1<br />
La lunga transizione dal decennio settanta del XIX secolo al 1914: aspetti economici (la modalità<br />
del produrre nella seconda rivoluzione industriale – il for<strong>di</strong>smo ed il taylorismo – lo scambio<br />
mercantile e l’attività finanziaria raccordati alla nuova modalità del produrre) – aspetti sociali (la<br />
stratificazione sociale – i nuovi ceti me<strong>di</strong> – la società <strong>di</strong> massa – il sindacalismo al tempo della<br />
società <strong>di</strong> massa) - aspetti politici lato interno (la forma partito agente nella società <strong>di</strong> massa e<br />
nella ridefinita statualità) – aspetti politici lato esterno (il Congresso <strong>di</strong> Berlino del 1878 e<br />
successivamente la formazione <strong>di</strong> blocchi politico <strong>di</strong>plomatici contrapposti; la Conferenza <strong>di</strong><br />
Berlino del novembre 1894 – febbraio 1885 e la proiezione coloniale europea fuori d’Europa) –<br />
aspetti istituzionali (la nuova statualità misurantesi con la ine<strong>di</strong>ta stratificazione sociale ed<br />
introducente il sistema <strong>di</strong> protezione sociale).<br />
Unità <strong>di</strong>dattica 2<br />
Il quadro politico europeo dal decennio settanta del XIX secolo al 1914. Lato interno: svolgimenti<br />
politici in Inghilterra, Francia, Germania, Austria, Russia, Italia. Il quadro politico extraeuropeo<br />
sulla fine del XIX secolo, lato interno: gli USA dalla guerra civile all’intervento nella Prima Guerra<br />
Mon<strong>di</strong>ale, il Giappone dal decollo industriale e dal ripristino del Mikado ai primi del 1900.<br />
Unità <strong>di</strong>dattica 3<br />
Il quadro politico europeo dal decennio settanta del XIX secolo al 1914: il passaggio dal sistema <strong>di</strong><br />
equilibrio (ultima espressione il Congresso <strong>di</strong> Berlino del 1878) al sistema dei blocchi contrapposti<br />
(Triplice Alleanza – Triplice Intesa); i sistemi coloniali europei <strong>di</strong> Inghilterra, Francia, Germania,<br />
Italia (quadro riassuntivo), gli Usa in proiezione nell’America Latina (la Dottrina Monroe ridefinita<br />
nel 1903, alle spalle la Prima Conferenza Panamericana 1889, quadro complessivo) e nel Pacifico<br />
(la gestione <strong>di</strong>retta del canale <strong>di</strong> Panama dal 1903, alle spalle la base <strong>di</strong> Pearl Harbor 1887, quadro<br />
complessivo).<br />
Unità <strong>di</strong>dattica 4<br />
La prima guerra mon<strong>di</strong>ale: le ragioni del conflitto, gli svolgimenti militari, i trattati <strong>di</strong>plomatici che<br />
la chiudono, le inquietu<strong>di</strong>ni che lascia persistenti, i revanscismi che prendono forma.<br />
Unità <strong>di</strong>dattica 5<br />
13
14<br />
Il primo dopoguerra: il quadro economico sociale tra il 1919 ed il 1929; la crisi del 1929 negli<br />
aspetti che la spiegano, nella propagazione degli effetti in Europa, in USA, in Giappone; la<br />
<strong>di</strong>fferenziata riorganizzazione dell’economico nel decennio trenta. Il primo dopoguerra: il quadro<br />
delle linee <strong>di</strong> politica estera tra il 1925 (il Trattato <strong>di</strong> Locarno) ed il 1935 (la Conferenza <strong>di</strong> Stresa)<br />
Unità <strong>di</strong>dattica 6<br />
Svolgimenti politici in Inghilterra e Francia tra decennio venti e trenta; svolgimenti politici in USA<br />
e Giappone tra decennio venti e trenta. La Germania nel tempo della Repubblica <strong>di</strong> Weimar. la<br />
Rivoluzione in Russia, la fondazione dell’URSS, l’avvio <strong>di</strong> realizzazione del modello staliniano <strong>di</strong><br />
socialità e <strong>stato</strong>, l’avvio dell’economia <strong>di</strong> piano.<br />
Inoltre i Gulag aspetto intrinseco dell’economia <strong>di</strong> piano e del comunismo staliniano in<br />
realizzazione (quadro complessivo). Tra il 1919 ed il 1933 l’avvio del confronto tra i fascismi (in<br />
Italia dal 1922, in Germania dal 1933, in Austria dal 1938) e le democrazie liberali; in tal contesto<br />
riferimenti (complessivi) ai governi autoritari dell’Est Europa e l’attrattiva nazismo per alcuni <strong>di</strong><br />
essi (per l’Ungheria dal 1939, per la Romania dal 1940, per la Bulgaria dal 1940)<br />
unità <strong>di</strong>dattica 7<br />
Il fascismo afermantesi in Spagna e Portogallo (quadro riassuntivo). La fondazione del Regno <strong>di</strong><br />
Jugoslavia, svolgimenti politici lato interno (quadro riassuntivo). Svolgimenti politici in Cina ed<br />
In<strong>di</strong>a (quadro riassuntivo)<br />
Unità <strong>di</strong>dattica 8<br />
Le ragioni della seconda guerra mon<strong>di</strong>ale: nuove relazioni politico <strong>di</strong>plomatiche in Europa dal 36,<br />
le relazioni <strong>di</strong>plomatiche tra Germania, Italia, Giappone dal 36; l’isolazionismo degli Usa dal<br />
decennio venti al 41; l’aggressiva proiezione esterna del Giappone dal 31 e poi dal 37 l’avvio della<br />
guerra in Asia; svolgimenti del conflitto bellico in Europa, Africa, Asia tra il 39 ed il 45; le<br />
Resistenze, i Collaborazionismi (tra quest’ulimi la RSI), il Regno del Sud in Italia; la Deportazione<br />
ebraica in Europa (gli apporti preminenti della Germania nazista, gli apporti in subor<strong>di</strong>ne della<br />
collaborante RSI – i Campi <strong>di</strong> concentramento) susseguentemente all’introduzione <strong>di</strong> legislazioni<br />
razziali (le Leggi <strong>di</strong> Norimberga 1935 per la Germania, la legislazione razziale del 1938 per l’Italia ,<br />
quadro riassuntivo).<br />
Unità <strong>di</strong>dattica 9<br />
La progettazione del dopoguerra: incontro al largo <strong>di</strong> Terranova tra Roosewelt e Churchill<br />
dell’agosto 41, la sigla della Carta Atlantica; la Conferenza <strong>di</strong> Casablanca tra Roosewelt e Churchill<br />
del gennaio 43; la Conferenza <strong>di</strong> Theran tra Roosewelt, Churchill, Stalin del novembre 43; il<br />
colloquio a Mosca tra Roosewelt e Stalin dell’ottobre 44; la Conferenza <strong>di</strong> Yalta tra Roosewelt,<br />
Churchill, Stalin del febbraio 45; la Conferenza <strong>di</strong> Postdam tra Truman, Stalin, Churchill (Attlee);<br />
la Conferenza <strong>di</strong> Pace a Parigi tra l’aprile 46 ed il febbraio 47.<br />
Unità <strong>di</strong>dattica 10<br />
La contestualità economico sociale del secondo novecento: il Welfare State connotati e precipuità<br />
per tratti complessivi<br />
Le relazioni internazionali tra il 1947 ed il 1980 (decennio): la guerra fredda (strategia del<br />
contenimento – strategia della contraffensiva – la <strong>di</strong>fficile coesistenza); dalla Conferenza <strong>di</strong><br />
Bandung (1955) al Movimento dei non allineati; la decolonizzazione (quadro complessivo)<br />
Unità <strong>di</strong>dattica 11<br />
In Europa i quadri economici tra il 1945 e la fine degli anni ottanta. In Europa i quadri politico<br />
<strong>di</strong>plomatici tra la Conferenza <strong>di</strong> pace <strong>di</strong> Parigi (25 aprile – 17 luglio 1946) ed il 1989 – 1991. In<br />
Europa svolgimenti politici interni a singoli paesi tra il 1945 ed il 1980 (decennio): Gran Bretagna,<br />
Francia, Repubblica Federale Tedesca, Repubblica Democratica Tedesca, Italia (a partire dalla<br />
ricostituzione della democrazia con l’Assemblea Costituente e la Costituzione), l’URSS. Fuori
15<br />
dell’Europa: gli Usa, il Giappone, e poi per tratti riassuntivi l’In<strong>di</strong>a e la Cina. Quadro riassuntivo<br />
dei fascismi persistenti per qualche tempo (in Spagna, in Portogallo, in Grecia). Quadro riassuntivo<br />
inerente alle Repubbliche Socialiste dell’Est Europa.<br />
Si segnala che alla data del 6 maggio l’unità 11 è avviata (relativamente a quadri economici, quadri<br />
politico <strong>di</strong>plomatici, ad Usa 1945 – decennio 1980, a URSS 1945 – decennio 1980). Gli altri temi<br />
in<strong>di</strong>cati si ritiene poterli affrontare nel tempo <strong>di</strong> fine quadrimestre.<br />
Il manuale adottato è ‘Leggere la storia. Profilo, documenti, storiografia’vol 3A e 3B, <strong>di</strong> Marco<br />
Manzoni, Francesca Occhipinti, Fabio Cereda, Rita Innocenti, Einau<strong>di</strong> Scuola. Sono stati utilizzati<br />
anche miei suppporti aggiuntivi al fine <strong>di</strong> sopperire a frammentarietà e non sufficiente<br />
problematizzazione del manuale in<strong>di</strong>cato
3.4 Percorso formativo <strong>di</strong> Filosofia ñ<br />
DOCENTE Prof. Maurizio Sarti<br />
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE<br />
La classe, da me conosciuta in seconda Liceo, ha subito rivelato <strong>di</strong> possedere capacità logiche ed<br />
espositive adeguate nonché un buon metodo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o. In molti elementi è presente anche una buona<br />
attitu<strong>di</strong>ne alla problematizzazione e alla riflessione critica tanto che la lezione si è sempre svolta<br />
sviluppando gli spunti <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>mento suscitati dalle frequenti domande e osservazioni degli<br />
alunni. Lo svolgimento dei programmi, data la buona risposta nel rispettare le scadenze e la<br />
ricettività alle spiegazioni, è <strong>stato</strong> spe<strong>di</strong>to e lineare e ha sempre rispettato i tempi progettati<br />
lasciando anzi ampio spazio, specie nel secondo anno del triennio liceale, ad approfon<strong>di</strong>menti<br />
tematici proposti dal testo nelle rubriche “Problemi” e “Dibattiti”. Il metodo utilizzato è <strong>stato</strong><br />
quello della lezione frontale, sempre interattiva, a partire dal contenuto del manuale che è <strong>stato</strong><br />
seguito rigorosamente. Prevalentemente la lezione è consistita nella spiegazione minuziosa e nel<br />
commento-ampliamento dei paragrafi del testo in adozione. Per questo, nella presentazione del<br />
programma svolto, si sono titolati i vari argomenti con il titolo dei capitoli dello stesso: gli alunni<br />
conoscono gli argomenti sulla base del taglio, del linguaggio, della <strong>di</strong>sposizione propri del manuale.<br />
Il lavoro si è svolto in un clima sempre positivo perché la classe è stata collaborativa in maniera<br />
encomiabile, con<strong>di</strong>videndo con responsabile partecipazione le proposte <strong>di</strong>dattiche. Nel corso del<br />
presente anno si sono svolte in compresenza con l’insegnante <strong>di</strong> Greco due lezioni <strong>di</strong><br />
approfon<strong>di</strong>mento, una sulla interpretazione della grecità in Nietzsche e una seconda sulla lettura<br />
hegeliana della figura <strong>di</strong> Antigone. Gli alunni hanno mostrato in buona maggioranza interesse e<br />
anche passione per la <strong>di</strong>sciplina e gli argomenti affrontati.<br />
Come emergerà dalla lettura del programma, non tutti gli aspetti degli autori sono stati affrontati. In<br />
particolare non sono stati trattati i momenti della logica hegeliana e l’analisi marxiana<br />
dell’economia capitalistica con le connesse teoria del plusvalore e del saggio <strong>di</strong> profitto.<br />
PROGRAMMA DI FILOSOFIA<br />
LE FILOSOFIE DELL’ETA’ ROMANTICA<br />
Contesto storico e temi della sensibilità romantica<br />
L’idealismo soggettivo <strong>di</strong> Fiche (lettura “Idealismo e dogmatismo”)<br />
La filosofia della natura e dell’arte in Schelling<br />
HEGEL<br />
Ragione, realtà, storia<br />
L’assoluto e la <strong>di</strong>alettica<br />
Il percorso verso la filosofia: l’impianto generale della Fenomenologia dello Spirito<br />
Il signore, il servo e il lavoro: la <strong>di</strong>alettica dell’autocoscienza (lettura “Signoria e servitù”)<br />
L’interpretazione hegeliana della Antigone <strong>di</strong> Sofocle<br />
Il sistema (lettura “La <strong>di</strong>alettica”)<br />
Il soggetto umano e i rapporti giuri<strong>di</strong>ci e morali<br />
Le istituzioni etiche (letture “Lo <strong>stato</strong>, la volontà generale e la rivoluzione” “Ciò che è reale<br />
e ciò che è razionale”)<br />
Guerra e pace: la storia del mondo<br />
Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia<br />
SCHOPENHAUER<br />
La filosofia del pessimismo<br />
L’enigma della volontà<br />
Le vie della liberazione<br />
16
KIERKEGAARD<br />
Parlare al singolo nella massa anonima<br />
Vita estetica e vita etica<br />
La <strong>di</strong>alettica dell’esistenza e la fede (lettura “Abramo, l’etica e la fede”)<br />
FEUERBACH<br />
La critica a Hegel<br />
L’origine dell’alienazione religiosa<br />
MARX<br />
Filosofia ed emancipazione umana (lettura “Lavoro e alienazione”)<br />
Il materialismo storico e il destino del capitalismo<br />
IL POSITIVISMO<br />
I caratteri generali<br />
Filosofia positiva e riforma sociale in Comte (lettura “La legge dei tre sta<strong>di</strong>”)<br />
Mill: empirismo e liberalismo (lettura “Contro il conformismo”)<br />
La teoria dell’evoluzione: Lamarck e Darwin<br />
NIETZSCHE<br />
Il senso tragico del mondo<br />
Il prospettivismo e la concezione della storia (lettura “Utilità e danno della storia”)<br />
Il periodo illuministico<br />
Superuomo ed eterno ritorno (letture “Le tre metamorfosi” “La visione e l’enigma”)<br />
La critica della morale e della religione (lettura “I due tipi <strong>di</strong> morale”)<br />
LE FILOSOFIE DELLA CRISI<br />
La crisi della cultura europea tra Ottocento e Novecento<br />
La crisi dei fondamenti della matematica: la soluzione <strong>di</strong> Frege e l’antinomia <strong>di</strong> Russell<br />
FREUD<br />
La scoperta dell’inconscio<br />
La metapsicologia (lettura “La seconda topica”)<br />
La terapia psicoanalitica<br />
L’ETICA<br />
Etica e metaetica<br />
Etica descrittiva e normativa<br />
Universalismo e relativismo etico<br />
L’origine dell’obbligo morale: teoria del comando <strong>di</strong>vino, naturalismo, cognitivismo<br />
razionalistico e intuizionistico, non-cognitivismo<br />
Etiche deontologiche e consequenzialistiche<br />
La bioetica<br />
BERGSON<br />
Durata e memoria<br />
L’evoluzione creatrice<br />
LA TEOLOGIA NEL ‘900<br />
Neotomismo e Personalismo<br />
La Teologia protestante: Barth e Bonhoeffer<br />
Testo in adozione: Cioffi-Luppi-Vigorelli-Zanette, Agorà, B. Mondadori, vol. 3<br />
17
3.5 Percorso formativo <strong>di</strong> Lingua Inglese ñ<br />
DOCENTE: Prof.ssa Eugenia Gervasi<br />
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE<br />
Insegno in questa classe da cinque anni e ho avuto quin<strong>di</strong> modo <strong>di</strong> conoscere ed apprezzare le varie<br />
personalità degli alunni, <strong>di</strong> aiutare i singoli a comprendere e sviluppare le proprie capacità sia<br />
umane che cognitive, <strong>di</strong> accompagnarli nell’acquisizione <strong>di</strong> conoscenze e competenze.<br />
La caratteristica specifica <strong>di</strong> questa classe mi sembra la riservatezza: sono sempre stati interessati<br />
alla lingua straniera, <strong>di</strong>sponibili ad affrontare tutti i tipi <strong>di</strong> lavoro proposti, ma spesso timi<strong>di</strong> e<br />
schivi. Anche il gruppo <strong>di</strong> sei alunne che si è inserito in prima liceo, senza peraltro incontrare<br />
alcuna <strong>di</strong>fficoltà, sembra con<strong>di</strong>videre questa peculiarità, pur lavorando sempre con impegno e<br />
buona partecipazione.<br />
Nel corso degli anni hanno acquisito sicurezza, hanno sviluppato autonomia nel metodo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o<br />
della lingua e, a vari livelli, anche <strong>di</strong>screte capacità critiche nell’analisi testuale e nel fare<br />
collegamenti tra correnti letterarie, autori e <strong>di</strong>scipline <strong>di</strong>verse.<br />
Per quanto riguarda più specificatamente le conoscenze linguistiche, devo sottolineare non solo<br />
l’impegno generale, ma una vera e propria determinazione, da parte della maggioranza, a<br />
raggiungere livelli alti <strong>di</strong> conoscenza: lo scorso anno tutta la classe ha richiesto la preparazione<br />
all’<strong>esame</strong> FCE dell’università <strong>di</strong> Cambridge e quelli <strong>di</strong> loro, quattor<strong>di</strong>ci su ventitré, che poi hanno<br />
effettivamente sostenuto l’<strong>esame</strong> hanno tutti ottenuto risultati positivi.<br />
Lo stu<strong>di</strong>o della letteratura è <strong>stato</strong> affrontato con serietà e interesse anche se inizialmente il lavoro<br />
sui testi risultava talvolta ostico. Poiché ritengo che la capacità <strong>di</strong> comprensione non solo del<br />
parlato, ma <strong>di</strong> vari tipi <strong>di</strong> scrittura sia fondamentale anche per il loro futuro, abbiamo lavorato molto<br />
in questa <strong>di</strong>rezione ed in particolare, per la terza prova, in accordo col consiglio <strong>di</strong> classe e con gli<br />
alunni stessi, si è utilizzata la modalità specifica prevista per la lingua straniera (esercizi <strong>di</strong><br />
comprensione e produzione su un brano <strong>di</strong> circa ottanta parole).<br />
Obiettivi conseguiti<br />
Conoscenze:<br />
Nell’ambito della lingua inglese le conoscenze acquisite sono sia linguistiche sia letterarie, in tutti<br />
gli alunni il livello <strong>di</strong> padronanza delle strutture linguistiche è migliorato ed i contenuti letterari<br />
sono stati largamente acquisiti, non mancano livelli eccellenti.<br />
Competenze<br />
Le competenze me<strong>di</strong>amente acquisite dalla classe sono me<strong>di</strong>o alte: tutti gli alunni sono in grado <strong>di</strong><br />
comprendere le idee principali <strong>di</strong> testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, <strong>di</strong><br />
comprendere il parlato, <strong>di</strong> interagire in modo efficace con parlanti nativi, <strong>di</strong> produrre testi personali.<br />
La gran maggioranza <strong>di</strong> loro ha raggiunto il livello autonomo B2 (avanzato o in<strong>di</strong>pendente) secondo<br />
la definizione presente nel Quadro comune europeo <strong>di</strong> riferimento.<br />
Capacità.<br />
Si è cercato <strong>di</strong> sviluppare capacità critiche e <strong>di</strong> sintesi, capacità <strong>di</strong> collegamento tra <strong>di</strong>scipline<br />
<strong>di</strong>verse, capacità <strong>di</strong> lavoro autonomo. Tutti gli alunni hanno fatto notevoli progressi complessivi,<br />
molti <strong>di</strong> loro hanno raggiunto un buon livello <strong>di</strong> autonomia, sono capaci <strong>di</strong> affrontare e risolvere<br />
problemi linguistici, letterari, interpretativi, alcuni sono in grado anche <strong>di</strong> produrre materiale<br />
originale.<br />
Meto<strong>di</strong><br />
Le modalità <strong>di</strong> svolgimento delle lezioni sono state varie:<br />
18
19<br />
Molte lezioni sono state, anche per questione <strong>di</strong> tempo, frontali, ma la classe è sempre stata<br />
stimolata a seguire in modo attivo, ponendo domande collettive o in<strong>di</strong>viduali, sollecitando<br />
paralleli con la letteratura italiana, non dando subito le risposte, ma ascoltando prima le<br />
opinioni dei ragazzi.<br />
Alcune lezioni hanno privilegiato la lettura guidata ed il lavoro sul testo, in modo che gli<br />
alunni potessero apprendere la metodologia e nello stesso tempo misurarsi con se stessi e<br />
confrontare le proprie idee con quelle degli altri.<br />
Alcuni lavori sono stati svolti in coppia in classe per favorire la collaborazione e lo scambio<br />
<strong>di</strong> idee.<br />
Si è cercato <strong>di</strong> svolgere il programma in modo parallelo a quello delle altre <strong>di</strong>scipline,<br />
cercando <strong>di</strong> evidenziare i collegamenti con la Storia dell’Arte, la Letteratura Italiana, la<br />
Storia e la Filosofia, per favorire approfon<strong>di</strong>menti inter<strong>di</strong>sciplinari nel lavoro dei singoli.<br />
Tempi<br />
I tempi per lo svolgimento del programma hanno rispettato in linea <strong>di</strong> massima quelli previsti,<br />
anche se si è cercato <strong>di</strong> lavorare molto in classe, coinvolgendo tutti e verificando via via quanto<br />
appreso e rielaborato dai singoli, dando ampio spazio alle verifiche formative, più che a quelle<br />
sommative, per tenere sempre viva la partecipazione e seguire i processi <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento in<br />
itinere.<br />
Attrezzature<br />
Sono stati usati i libri <strong>di</strong> testo in adozione, fotocopie, videoregistrazioni, internet.<br />
Verifiche<br />
Le verifiche sono state <strong>di</strong>versificate:<br />
Colloqui orali su temi letterari, in cui si è dato importanza alla capacità <strong>di</strong> comunicare<br />
in lingua e al contenuto esposto, poi alla correttezza formale, all’adeguatezza del<br />
registro, alla pronuncia, all’intonazione.<br />
Letture in classe <strong>di</strong> brani scelti per saggiare la comprensione del testo, l’utilizzazione<br />
delle tecniche <strong>di</strong> lettura stu<strong>di</strong>ate, le capacità interpretative e creative,l’accuratezza della<br />
pronuncia<br />
Lavori in coppia per saggiare anche le capacità <strong>di</strong> interagire in lingua con i compagni<br />
Esercitazioni scritte con una serie <strong>di</strong> quesiti chiusi e/o aperti sugli argomenti stu<strong>di</strong>ati, in<br />
cui è dato maggior valore alle conoscenze specifiche ed alle capacità <strong>di</strong> sintesi che non<br />
all’accuratezza formale.<br />
Compiti in classe, durante i quali gli alunni non hanno mai fatto uso del <strong>di</strong>zionario, e<br />
che, sono stati sempre preparati in modo tale da saggiare sia la comprensione <strong>di</strong> un<br />
testo , che le capacità <strong>di</strong> rielaborazione personale e <strong>di</strong> produzione.
Valutazione delle verifiche<br />
Per la valutazione delle verifiche <strong>di</strong> Inglese sono stati adottati i descrittori inseriti nel POF<br />
Programma <strong>di</strong> lingua inglese 2010-2011<br />
Modulo Argomenti Testi Meto<strong>di</strong><br />
L’età augustea e la<br />
nascita del<br />
romanzo moderno<br />
Preromanticismo<br />
Reason and common sense –<br />
Lavori <strong>di</strong> gruppo su<br />
1) Daniel Defoe: vita e opere,<br />
Robinson Crusoe<br />
2) H. Fiel<strong>di</strong>ng : vita e opera,<br />
Tom Jones<br />
3) S. Richardson:vita e opera,<br />
Pamela<br />
4) Laurence Sterne : vita e<br />
opere, The Life and Opinions<br />
of Tristram Shandy<br />
The Age of Reason vs<br />
Preromanticism (poesia, poetic<br />
<strong>di</strong>ction, imitazione….)<br />
Nuovo concetto <strong>di</strong> natura dal<br />
landscape gardening, al sublime in<br />
natura <strong>di</strong> Turner e Constable<br />
Cenni al Grand Tour<br />
Il Sublime:<br />
E.Burke : definizione del ‘bello’<br />
e del ‘sublime’in natura, sua<br />
influenza in letteratura ed in<br />
pittura<br />
Il romanzo gotico<br />
T. Gray. Vita ed opere, elementi<br />
classici e preromantici<br />
dell’elegia, parallelo con<br />
Foscolo…<br />
Strumenti <strong>di</strong> analisi <strong>di</strong> un testo<br />
poetico (figure retoriche, rima, ritmo,<br />
assonanza, allitterazione,<br />
connotazione denotazione, tono.)<br />
W. Blake: vita e opere, valore<br />
dell’immaginazione e<br />
dell’infanzia nelle sue poesie…<br />
Origine dell’aggettivo ‘romantic’ e<br />
sua evoluzione dal ‘romance’ all’uso<br />
fattone da Rousseau e Coleridge fino<br />
alla fine dell’ottocento<br />
Tematiche fondamentali del<br />
Romanticismo riguardanti<br />
l’immaginazione, il poeta, la lingua,<br />
Libro <strong>di</strong> testo: Lit and Lab,<br />
vol. 1: From the Origins to<br />
the Augustan Age<br />
pp.194/197, 200<br />
1) pp.218/224<br />
2) pp.210/213<br />
3) pp.206/209<br />
4) pp.214/217<br />
Libro <strong>di</strong> testo: Only<br />
Connect…:<br />
.Module D: pp.10/13, 17,<br />
20/26, 30/31, 36/40.<br />
Module L (looking into<br />
Art): 39,43,<br />
71,73,75,77,7953,55<br />
Lettura ed analisi dei<br />
seguenti testi:<br />
‘On the Sublime’ tratto da<br />
‘A Philosophical Enquiry’<br />
Elegy written in a Country<br />
Churchyard <strong>di</strong> T. Gray,<br />
parallelo con <strong>di</strong>versi versi<br />
dei Sepolcri <strong>di</strong> U. Foscolo<br />
London,The Tiger, The<br />
Lamb, ( pp.32-33)<strong>di</strong><br />
W.Blake<br />
Libro <strong>di</strong> testo ‘Only<br />
Connect’ della Zanichelli<br />
Module D. 82-89, 101-<br />
108, 145, 148 ,194<br />
Lettura ed analisi dei<br />
seguenti testi:<br />
‘Poetry and<br />
Lavori <strong>di</strong><br />
gruppo:<br />
lettura dei<br />
romanzi<br />
durante il<br />
periodo estivo,<br />
esposizione<br />
alla classe del<br />
lavoro <strong>di</strong> ogni<br />
singolo<br />
gruppo, lettura<br />
dei brani<br />
antologici dei<br />
singoli autori<br />
Lezioni<br />
frontali<br />
Analisi<br />
testuale<br />
Lavori in<br />
coppia<br />
Tests <strong>di</strong><br />
verifica scritti<br />
ed orali<br />
Analisi <strong>di</strong><br />
alcuni <strong>di</strong>pinti<br />
dell’epoca per<br />
evidenziare il<br />
cambiamento<br />
nel modo <strong>di</strong><br />
rappresentare<br />
l’uomo e la<br />
natura<br />
Lezioni<br />
frontali<br />
Esercizi <strong>di</strong><br />
skimming in<br />
coppia<br />
Analisi<br />
testuale<br />
20
Romanticismo<br />
Età Vittoriana<br />
Il Novecento<br />
il ‘subject-matter’, la natura, il<br />
processo creativo, l’in<strong>di</strong>vidualismo,<br />
l’esotismo, il soprannaturale, la<br />
melanconia....<br />
Vita ed opere dei seguenti poeti:<br />
W.Wordsworth,<br />
S Coleridge,<br />
J. Keats<br />
Paragone <strong>di</strong> Wordsworth e<br />
Coleridge con i pittori Turner e<br />
Constable<br />
Introduzione storica alla società<br />
dell’epoca: con<strong>di</strong>zione delle <strong>di</strong>verse<br />
classi sociali, tipici valori vittoriani<br />
(famiglia, religione, lavoro,…),<br />
evoluzione della con<strong>di</strong>zione della<br />
donna, lotte politiche…..<br />
C. Dickens: vita, opere,<br />
caratterizzazione dei<br />
personaggi,,aspetti sociali delle<br />
maggiori opere, realismo e<br />
simbolismo, ironia, tecniche<br />
narrative…<br />
Estetismo:<br />
O. Wilde: vita ed opere, sua<br />
teoria dell’arte (bellezza,<br />
moralità, impersonalità, autonomia<br />
del fruitore…), figura del<br />
dandy, tema della femme fatale,<br />
simbolismo,<br />
Crisi del mondo vittoriano:breve<br />
<strong>esame</strong> delle cause della crisi <strong>di</strong> valori,<br />
influenza delle scoperte nel campo<br />
della psicoanalisi, dell’antropologia,<br />
della fisica…,<br />
Modernismo<br />
Ricapitolazione delle varie tecniche<br />
imagination’ dalla<br />
‘Biographia Literaria’<br />
<strong>di</strong> Coleridge<br />
‘A certain colouring of<br />
imagination’dalla<br />
prefazione alle ‘Lyrical<br />
Ballads’<br />
‘The Rainbow’,<br />
Composed upon<br />
Westminster Bridge,,<br />
‘Daffo<strong>di</strong>ls’ <strong>di</strong> W.<br />
Wordsworth ,D86-87<br />
‘Ode on a Grecian Urn’<br />
<strong>di</strong> J.Keats<br />
versi 1-62/ <strong>di</strong>’The<br />
Rime of the Ancient<br />
Mariner’ <strong>di</strong> S.<br />
Coleridge<br />
Libro <strong>di</strong> testo ‘Only<br />
Connect’:<br />
Module E: .2,3,10-11, 14-<br />
15, 48, 58-60, 139-140,<br />
145- 149-153,<br />
Module L: p.93, 95, 125,<br />
Lettura ed analisi dei<br />
seguenti testi:<br />
‘London’ da Bleak<br />
House <strong>di</strong> C. Dickens e<br />
parallelo con ‘London’<br />
<strong>di</strong> Blake, First Day of<br />
School da D.<br />
Copperfield<br />
Lettura <strong>di</strong> ‘Deceits, Tea<br />
and Muffins’ da ‘The<br />
Importance of being<br />
Earnesrt’,<strong>di</strong> O. Wilde,<br />
Prefazione a ‘The<br />
Picture of D. Gray’<br />
(fotocopia)<br />
Dorian’s death da ‘The<br />
Picture of D. Gray’<br />
Versi scelti da<br />
‘Salomè’ ( 2<br />
fotocopie)<br />
Libro <strong>di</strong> testo ‘Only<br />
Connect’ Module :.F. 20-<br />
23, 59-60, F65-67, 71,146-<br />
149, 157-159, 162, 166-<br />
167,G102-106,<br />
Analisi <strong>di</strong><br />
alcune<br />
tematiche<br />
romantiche in<br />
alcuni <strong>di</strong>pinti<br />
dell’epoca<br />
Lezioni<br />
frontali<br />
Lavori in<br />
coppia<br />
Analisi<br />
testuale<br />
Tests strutturati<br />
Stu<strong>di</strong>o autonomo<br />
a casa<br />
con verifica<br />
successiva<br />
Visione del<br />
video <strong>di</strong> The<br />
Importance of<br />
being Earnest<br />
Lezioni<br />
frontali<br />
Analisi<br />
testuale<br />
Tests orali e<br />
21
Argomenti da<br />
svolgere dopo il<br />
15-05-11<br />
narrative esaminate nel corso del<br />
triennio in relazione alla nascita e lo<br />
sviluppo del romanzo moderno<br />
J. Joyce : vita,opere, concezione<br />
dell’artista (craftsman) e della<br />
impersonalità dell’opera d’arte,<br />
formazione religiosa, rapporto<br />
con l’Irlanda, realismo e<br />
simbolismo nelle sue opere,<br />
concetto <strong>di</strong> epifania, paralisi.(<br />
‘Dubliners’<br />
‘A Portrait of the Artist as a<br />
Young Man’ : ‘Bildungsroman’,<br />
simbologia del nome del<br />
protagonista, tecnica narrativa,<br />
utilizzazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi registri…<br />
‘Ulysses’: considerazioni <strong>di</strong><br />
Joyce sull’opera stessa, schema<br />
Linati, ‘metodo mitico’, antieroe,<br />
realismo e simbolismo, tecniche<br />
narrative, religione<br />
Il Teatro dell’Assurdo<br />
S.Beckett: vita e opere, tematiche<br />
fondamentali. Waiting for Godot<br />
Lettura ed analisi dei<br />
seguenti testi:<br />
Dubliners:<br />
‘Eveline’racconto<br />
complete in fotocopia,<br />
She was fast asleep:<br />
ultima parte <strong>di</strong> ‘The<br />
Dead’<br />
A Portrait of the Artist<br />
as a Young Man:prime<br />
due pagine del primo<br />
capitolo (fotocopia) e<br />
citazione dal quarto<br />
capitolo (He Was<br />
alone…in fotocopia)<br />
Ulysses: monologo finale<br />
<strong>di</strong> Molly (fotocopia)<br />
Monologo <strong>di</strong><br />
Lucky(fotocopia), ultimi<br />
<strong>di</strong>aloghi dell’opera<br />
T.S.Eliot T.S. Eliot:’’Tra<strong>di</strong>tion<br />
and In<strong>di</strong>vidual<br />
Talent’(fotocopia)<br />
The Waste Land: The<br />
Burial of the Dead,<br />
What the Thunder said)<br />
scritti<br />
22
3.6 Percorso formativo <strong>di</strong> Scienze <br />
DOCENTE: Prof. Giuseppe Meucci<br />
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE<br />
Ho cominciato il lavoro con la classe dall’inizio del triennio, classe apprezzabile per correttezza nei<br />
rapporti, <strong>di</strong>sponibilità all’appren<strong>di</strong>mento e interesse per i <strong>di</strong>versi temi affrontati nell’ambito della<br />
<strong>di</strong>sciplina. Durante questi tre anni il lavoro si è sviluppato in un clima <strong>di</strong> sereno <strong>di</strong>battito, che ha<br />
permesso <strong>di</strong> mettere a frutto le positive qualità presenti nella generalità degli allievi, sia quanto a<br />
capacità <strong>di</strong> ragionamento ed elaborazione delle conoscenze, che a consapevolezza dei propri doveri.<br />
Si sono registrati quin<strong>di</strong> molti vali<strong>di</strong> risultati, anche ottimi, mentre qualche situazione <strong>di</strong> profitto<br />
incerto appare in via <strong>di</strong> risoluzione. Interessi significativi si sono concretizzati in varie forme,<br />
soprattutto nella partecipazione a corsi <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> chimica istituiti dalla Scuola: ciò ha<br />
riguardato in particolare gli studenti Ban<strong>di</strong>ni, Biagini, Cascone, Pancani durante il secondo anno <strong>di</strong><br />
Liceo; Ban<strong>di</strong>ni e Calò negli ultimi mesi del 2010.<br />
FINALITA’<br />
La programmazione <strong>di</strong> questo ultimo anno <strong>di</strong> corso è stata impostata sulla base delle in<strong>di</strong>cazioni<br />
ministeriali (che comprendono una gamma <strong>di</strong> tematiche notoriamente ampia), ma anche<br />
dell’esigenza <strong>di</strong> far capire come le varie conoscenze sono state acquisite e, più in generale, <strong>di</strong><br />
chiarire per quanto possibile il significato della parola “scienza”. Per questa ragione si è in<strong>di</strong>viduato<br />
il tema dell’astronomia come il più adatto sul quale impostare il lavoro <strong>di</strong> tutto l’anno. La scelta<br />
viene compiuta – ormai da anni – <strong>di</strong> comune accordo con i Colleghi <strong>di</strong> Storia e Filosofia, nella<br />
convinzione che proprio la scienza del cielo possa più <strong>di</strong> altre fornire occasioni <strong>di</strong> riflessione<br />
storico-epistemologica, oltre a coinvolgere emotivamente con la bellezza dei fenomeni e, infine,<br />
con la portata degli interrogativi che è in grado <strong>di</strong> suscitare.<br />
Principali finalità del corso sono quin<strong>di</strong> far capire e apprezzare alcuni aspetti dei fenomeni celesti e,<br />
più in generale, approfon<strong>di</strong>re la conoscenza del pensiero scientifico. Ciò avviene ripercorrendo<br />
alcuni passaggi – ad esempio, dal cielo degli antichi alla rivoluzione copernicana – che, proprio in<br />
questo campo, ne hanno segnato l’evoluzione.<br />
OBIETTIVI<br />
Agli obiettivi generali del Consiglio <strong>di</strong> Classe si aggiungono i seguenti, propri della <strong>di</strong>sciplina:<br />
Competenze:<br />
Descrivere i vari fenomeni in modo corretto e or<strong>di</strong>nato, utilizzando la necessaria terminologia<br />
specifica<br />
Fare uso appropriato <strong>di</strong> semplici formule per schematizzare i principi enunciati (comunque<br />
privilegiati gli aspetti qualitativi rispetto a quelli quantitativi)<br />
Interpretare tabelle, schemi e <strong>di</strong>agrammi<br />
Capacità:<br />
In<strong>di</strong>viduare collegamenti spazio-temporali e <strong>di</strong> causa-effetto<br />
Cercare <strong>di</strong> formulare ipotesi corrette riguardo ai fenomeni descritti<br />
Applicare le conoscenze ai vari contesti proposti<br />
METODI E STRUMENTI<br />
La lezione viene generalmente concepita come <strong>di</strong>scussione del tema, che <strong>di</strong> volta in volta viene<br />
affrontato, nei suoi <strong>di</strong>versi aspetti. E’ importante che tale lavoro coinvolga tutta la classe e perciò si<br />
assegnano da stu<strong>di</strong>are le corrispondenti parti del libro <strong>di</strong> testo prima della lezione, si fanno frequenti<br />
23
24<br />
riferimenti a casi concreti, si analizzano i vari problemi che si possono porre, si incoraggiano e<br />
valorizzano le osservazioni e i contributi personali degli studenti e si fanno loro domande <strong>di</strong>rette.<br />
Per quanto è possibile, compatibilmente con il rispetto dei tempi e degli obiettivi, nello svolgere la<br />
lezione si cerca <strong>di</strong> andare incontro alle esigenze <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento della classe. Si fa ricorso a<br />
esercizi applicativi per quei contenuti che lo richiedono, a qualche osservazione all’aperto e a visite<br />
a strutture esterne alla Scuola. Si svolgono attività <strong>di</strong> recupero in itinere.<br />
Il periodo settembre-novembre è <strong>stato</strong> de<strong>di</strong>cato ai temi dell’osservazione del cielo a occhio nudo e<br />
dello sviluppo dell’astronomia e del pensiero scientifico dall’antichità a Galilei. Il primo tema ha<br />
avuto come riferimento una <strong>di</strong>spensa preparata allo scopo dal Docente, con riferimento alle possibili<br />
osservazioni realizzabili nei <strong>di</strong>versi momenti del giorno e dell’anno. Il secondo tema è <strong>stato</strong><br />
affrontato attraverso l’approfon<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> contenuti già affrontati in Filosofia nel secondo anno <strong>di</strong><br />
liceo, attività già ampiamente sperimentata nelle classi terminali degli anni precedenti, grazie alla<br />
collaborazione dei Colleghi <strong>di</strong> Storia e Filosofia. Per questa parte del lavoro si è fatto riferimento al<br />
testo <strong>di</strong> Filosofia <strong>di</strong> seconda liceo (Cioffi, Luppi, Vigorelli, Zanette, Bianchi, O’Brien, Agorà, Vol.1<br />
e 2, Ed. Scolastiche Bruno Mondadori), oltre che al libro <strong>di</strong> Alberto Righini (Galileo, tra Scienza,<br />
Fede e Politica, E<strong>di</strong>trice Compositori, Bologna, 2008) che gli studenti lessero durante l’anno<br />
precedente, prima <strong>di</strong> un incontro a scuola con l’autore.<br />
Il libro <strong>di</strong> testo adottato è: Neviani – Pignocchino Feyles, Pianeta Tre, SEI, Torino.<br />
VERIFICHE E VALUTAZIONE<br />
Primo quadrimestre:<br />
due questionari scritti (ciascuno <strong>di</strong> venti domande a scelta multipla)<br />
almeno una verifica orale, due in tutti quei casi che lo richiedono.<br />
Secondo quadrimestre:<br />
un questionario scritto a domande aperte<br />
almeno una verifica orale, due in tutti quei casi che lo richiedono.<br />
Svolte anche tre simulazioni <strong>di</strong> terza prova scritta, comprendenti questa <strong>di</strong>sciplina.<br />
Per la valutazione si fa riferimento alla griglia relativa alla <strong>di</strong>sciplina, allegata al P.O.F.<br />
VISITE DIDATTICHE E ALTRE INIZIATIVE<br />
Visita al Museo Galileo <strong>di</strong> Firenze<br />
Lezione al planetario dei Musei Scientifici Fiorentini<br />
Lezione notturna all’osservatorio Astrofisico <strong>di</strong> Arcetri<br />
PROGRAMMA (i numeri fra parentesi in<strong>di</strong>cano le pagine del testo)<br />
1. L’OSSERVAZIONE DEL CIELO A OCCHIO NUDO (<strong>di</strong>spensa a cura dello scrivente)<br />
L’osservazione del cielo; concetti generali <strong>di</strong> orizzonte e <strong>di</strong> sfera celeste. Moto apparente <strong>di</strong>urno del<br />
sole e cambiamenti durante le stagioni. Moto apparente notturno delle stelle e cambiamenti durante<br />
le stagioni. Movimenti apparenti del sole lungo l’eclittica e dei pianeti: stazioni e retrogradazioni.<br />
2. L’ASTRONOMIA DALL’ANTICHITA’ ALLA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA<br />
Dal Vol. 1 del testo <strong>di</strong> Filosofia citato, Sez. 3. La filosofia nel mondo ellenistico-romano:<br />
Lezione: Cosmo. Quale modello per il mondo? Volta celeste, costellazioni, moto annuale del Sole,<br />
della Luna e dei pianeti. Oriente e Grecia: cosmologie naturalistiche, cosmologia pitagorica, Platone<br />
e gli astri erranti, Eudosso e le sfere omocentriche. Aristotele e la “fisicizzazione” del modello<br />
eudossiano; la cosmologia come “esercizio spirituale”; astronomia alessandrina. Modelli a deferente<br />
e epiciclo; modello eliocentrico <strong>di</strong> Aristarco <strong>di</strong> Samo; sistema aristotelico-tolemaico. (342-347)<br />
Dal Vol. 2 dello stesso testo <strong>di</strong> Filosofia, Sez. 10. La filosofia del rinascimento:<br />
Lezione: La rivoluzione copernicana. La rivoluzione astronomica. I moti dei pianeti (72). Critiche<br />
rinascimentali alla tra<strong>di</strong>zione aristotelico-tolemaica. La teoria eliocentrica copernicana (73). Le
25<br />
critiche fisiche e teologiche all’eliocentrismo (74). Tycho Brahe: un compromesso tra vecchio e<br />
nuovo (75). Keplero. Metafisica platonica e copernicanesimo (75). Le tre leggi <strong>di</strong> Keplero ((76-77).<br />
Lezione: Il cosmo è finito o infinito? Argomentazioni a sostegno delle due <strong>di</strong>verse visioni del<br />
mondo nella storia della scienza (103-107).<br />
Lezione: La scienza moderna. Il cannocchiale e la rivoluzione scientifica . I principali fattori della<br />
rivoluzione scientifica (112). Rinascimento e rivoluzione scientifica. Le medesime leggi governano<br />
cielo e Terra (113). La ricerca <strong>di</strong> un nuovo metodo. La scienza moderna: un sapere aperto e<br />
progressivo (114). L’integrazione tra scienza e tecnica (115).<br />
Lezione: Galilei. L’autonomia della scienza. Le osservazioni astronomiche (126). La critica della<br />
visione tra<strong>di</strong>zionale del mondo. Vita e opere <strong>di</strong> Galilei (127). Bibbia e ricerca scientifica: la<br />
condanna del copernicanesimo (128). Una nuova fisica, celeste e terrestre (128).<br />
Lezione: Il gran naviglio. Brano tratto dal Dialogo sopra i due massimi sistemi (138-139).<br />
3. COORDINATE ASTRONOMICHE, OSSERVAZIONE TELESCOPICA E<br />
SPETTROSCOPIA<br />
Stu<strong>di</strong>o dei corpi celesti (2). Posizione della Terra nell’Universo (2). La sfera celeste e le<br />
costellazioni (4). Gli elementi <strong>di</strong> riferimento sulla sfera celeste (5). L’orizzonte (6). Coor<strong>di</strong>nate<br />
astronomiche altazimutali ed equatoriali (7). La luce messaggera dell’Universo (10). Gli strumenti<br />
per osservare il cielo (11). La spettroscopia: spettri <strong>di</strong> emissione continui e <strong>di</strong>scontinui, spettri <strong>di</strong><br />
assorbimento (11-12).<br />
4. LE STELLE E LA LORO EVOLUZIONE<br />
Distanza delle stelle: metodo della parallasse (16). Le unità <strong>di</strong> misura delle <strong>di</strong>stanze in astronomia:<br />
parsec, unità astronomica, anno luce (17). Luminosità delle stelle e classi <strong>di</strong> magnitu<strong>di</strong>ne (18).<br />
Colore e temperatura delle stelle (19). Analisi spettrale della luce delle stelle (20). L’effetto Doppler<br />
e gli spettri delle stelle (21). Il volume e la massa delle stelle (22). Il <strong>di</strong>agramma <strong>di</strong> Herzsprung-<br />
Russel (24). Le forze che agiscono nelle stelle (25). La nascita delle stelle (26). Le stelle della<br />
sequenza principale (27). Le reazioni termonucleari nelle stelle <strong>di</strong> sequenza principale, con<br />
particolare riferimento al ciclo protone-protone (28). Dalla sequenza principale alle giganti rosse<br />
(28). La “morte” <strong>di</strong> una stella: nane bianche, stelle <strong>di</strong> neutroni e buchi neri (30). Le novae (31). Le<br />
pulsar (32). Le stelle mo<strong>di</strong>ficano la composizione dell’Universo (33).<br />
5. LE GALASSIE E L’UNIVERSO<br />
Le galassie nell’Universo (38). La classificazione delle galassie (40). Le galassie in movimento<br />
(42). La nostra galassia: la Via Lattea (43). Il red shift delle galassie, la legge <strong>di</strong> Hubble e la<br />
scoperta dell’espansione dell’Universo (44). Le ipotesi cosmologiche: modelli dello <strong>stato</strong><br />
stazionario e del big bang (46-47). Le prove a favore del big bang (48). Le possibili evoluzioni<br />
dell’Universo (49).<br />
6. IL SISTEMA SOLARE<br />
Corpi in movimento uniti dalla forza <strong>di</strong> gravità (53). L’origine del sistema solare (54). La stella Sole<br />
(55). La struttura del Sole (55). L’attività del Sole (58). I pianeti e i loro movimenti: le leggi <strong>di</strong><br />
Keplero (59). Le spiegazioni delle leggi <strong>di</strong> Keplero, secondo Newton (60). Le caratteristichefisico –<br />
chimiche dei pianeti terrestri e gioviani (61: aspetti generali). Gli altri corpi del sistema solare:<br />
asteroi<strong>di</strong>, comete, meteore e meteoriti (68).<br />
7. LE CARATTERISTICHE DEL PIANETA TERRA<br />
La Terra: un pianeta unico nel sistema solare (74). L’interno della Terra è caldo e non è omogeneo<br />
(75). La Terra: un pianeta in continua evoluzione (75). La forma della Terra e la sua scoperta (76-<br />
77). La forza <strong>di</strong> gravità sulla Terra (78). La rappresentazione della forma della Terra: ellissoide e<br />
geoide (78). Il calcolo <strong>di</strong> Eratostene e la misura della circonferenza terrestre (79). Il reticolato<br />
geografico (80).
8. I MOVIMENTI DELLA TERRA<br />
Introduzione (85). Il movimento <strong>di</strong> rotazione (86). Le conseguenze della rotazione: alternarsi del dì<br />
e della notte; apparente moto <strong>di</strong>urno della sfera celeste; forza centrifuga e variazioni della gravità;<br />
forza <strong>di</strong> Coriolis (86).<br />
Contenuti da svolgere dopo il 15 Maggio:<br />
Prove della rotazione: esperienze <strong>di</strong> Guglielmini e Foucault (88).<br />
Il movimento <strong>di</strong> rivoluzione (89). Le conseguenze della rivoluzione terrestre: giorno solare e giorno<br />
sidereo, movimento apparente del Sole sullo sfondo dello zo<strong>di</strong>aco (89). Le stagioni astronomiche<br />
(91). Le zone astronomiche del globo terrestre (94). I moti secondari della Terra (95).<br />
9. MISURE DI SPAZIO E TEMPO<br />
L’osservazione del cielo. Orientarsi sulla Terra: la ricerca dei punti car<strong>di</strong>nali (100). La misura dl<br />
tempo: la durata del giorno (103). L’ora vera, il tempo civile e i fusi orari (103). La durata dell’anno<br />
civile e il calendario (105).<br />
26
3.7 Percorso formativo <strong>di</strong> Matematica<br />
DOCENTE: Prof. ssa Margherita Meoli<br />
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE<br />
L’insegnante <strong>di</strong> matematica conosce tutti gli alunni della classe fin dalla quarta ginnasio ed ha<br />
potuto accompagnarli in tutto il corso <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>. La continuità <strong>di</strong>dattica ha consentito <strong>di</strong> instaurare un<br />
buon rapporto tra alunni e insegnante e ha permesso <strong>di</strong> seguire i progressi ottenuti dai singoli allievi<br />
nella <strong>di</strong>sciplina. Per quanto riguarda l’impegno, la classe ha sempre partecipato all’attività <strong>di</strong>dattica<br />
anche se, a volte, ha avuto bisogno <strong>di</strong> opportune stimolazioni da parte del docente. E’ sempre stata<br />
<strong>di</strong>sponibile al lavoro in aula e <strong>di</strong> gruppo e, nella maggior parte dei casi, piuttosto puntuale nello<br />
svolgere i compiti assegnati a casa. Ha collaborato inoltre, durante le attività <strong>di</strong> recupero, ad aiutare<br />
i compagni in <strong>di</strong>fficoltà. C’è però da far presente che, sebbene la maggior parte degli alunni<br />
presentasse una <strong>di</strong>screta preparazione <strong>di</strong> base, non sono mancate le <strong>di</strong>fficoltà nello stu<strong>di</strong>o degli<br />
argomenti trattati durante quest’ultimo anno scolastico che hanno rallentato il regolare svolgimento<br />
del programma. Spesso ci si è dovuti soffermare, per consentire a tutti l’assimilazione dei concetti<br />
precedenti, prima <strong>di</strong> introdurre nuove nozioni. Durante le lezioni si è cercato <strong>di</strong> coinvolgere il più<br />
possibile gli allievi, con interventi sia durante le spiegazioni della teoria, sia durante lo svolgimento<br />
degli esercizi proposti alla lavagna. Anche se vi sono alcuni alunni che presentano <strong>di</strong>fficoltà e<br />
insicurezze nell’utilizzare autonomamente tecniche e procedure <strong>di</strong> calcolo per risolvere semplici<br />
esercizi, a causa <strong>di</strong> un inadeguato metodo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o, piuttosto <strong>di</strong>scontinuo e superficiale, la classe si<br />
presenta piuttosto omogenea e il livello <strong>di</strong> preparazione è <strong>di</strong>screto.<br />
PROGRAMMA<br />
Insiemi numerici. Funzioni<br />
Insiemi numerici. Insiemi numerici e insiemi <strong>di</strong> punti. Intervalli. Intorno. Insiemi numerici limitati e<br />
illimitati. Considerazioni intuitive sul massimo e sul minimo <strong>di</strong> un insieme numerico. Estremo<br />
superiore ed inferiore <strong>di</strong> un insieme numerico. Punti <strong>di</strong> accumulazione. Funzioni: definizioni e<br />
terminologia. Funzioni numeriche e funzioni matematiche. Osservazioni sull’ espressione analitica<br />
<strong>di</strong> una funzione. Grafico <strong>di</strong> una funzione. Funzioni pari e funzioni <strong>di</strong>spari. Funzioni iniettive,<br />
suriettive, biunivoche. Funzioni inverse. Funzioni composte. Funzioni perio<strong>di</strong>che. Funzioni<br />
crescenti e decrescenti in un intervallo. Funzioni monotòne. Funzioni limitate. Massimi e minimi<br />
assoluti. Classificazione delle funzioni<br />
matematiche. Determinazione del dominio <strong>di</strong> una funzione y = f(x). Grafico <strong>di</strong> y = |f(x)|.<br />
Limite e continuità delle funzioni<br />
Introduzione. Limite finito <strong>di</strong> una funzione per x che tende a un valore finito. Limite destro e limite<br />
sinistro. Osservazione. Limite finito <strong>di</strong> una funzione per x che tende all’infinito. Casi particolari.<br />
Asintoti orizzontali. Limite infinito <strong>di</strong> una funzione per x che tende a un valore finito. Casi<br />
particolari. Asintoti verticali. Limite infinito <strong>di</strong> una funzione per x che tende all’infinito. Casi<br />
particolari. Osservazioni sulle definizioni <strong>di</strong> limite. Teoremi generali sui limiti. Conseguenze<br />
imme<strong>di</strong>ate delle definizioni <strong>di</strong> limite. Teoremi del confronto. Funzioni continue e calcolo dei limiti.<br />
27
Continuità delle funzioni elementari. Calcolo dei limiti delle funzioni continue.<br />
L’ algebra dei limiti e delle funzioni continue<br />
Teoremi sul calcolo dei limiti. Limite della somma algebrica <strong>di</strong> funzioni. Somma e <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong><br />
funzioni continue. Limite del prodotto <strong>di</strong> due funzioni. Prodotto <strong>di</strong> funzioni continue. Continuità<br />
delle funzioni razionali intere. Continuità <strong>di</strong> senx e cosx. Limite del reciproco <strong>di</strong> una funzione.<br />
Limite del quoziente <strong>di</strong> due funzioni. Quoziente <strong>di</strong> funzioni continue. Continuità delle funzioni tgx<br />
e cotgx. Continuità del valore assoluto <strong>di</strong> una funzione. Limite e continuità della ra<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> una<br />
funzione. Limiti delle funzioni razionali. Funzioni razionali intere. Limiti delle funzioni razionali<br />
fratte per x che tende a c, con c finito. Limiti delle funzioni razionali fratte per x che tende a<br />
infinito. Continuità delle funzioni inverse. Limiti delle funzioni composte. Cambiamento <strong>di</strong><br />
variabile. Continuità delle funzioni composte <strong>di</strong> funzioni continue. Limiti notevoli. Forme<br />
indeterminate. Infinitesimi e loro confronto. Scrittura fuori del segno <strong>di</strong> limite. Infiniti e loro<br />
confronto.<br />
Funzioni continue<br />
Discontinuità delle funzioni. Osservazione. Proprietà delle funzioni continue.<br />
Zeri <strong>di</strong> una funzione. Grafico probabile <strong>di</strong> una funzione.<br />
Derivata <strong>di</strong> una funzione.<br />
Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate. Rapporto incrementale. Significato geometrico<br />
del rapporto incrementale. Derivata. Significato geometrico della derivata. Punti stazionari.<br />
Interpretazione geometrica <strong>di</strong> alcuni casi <strong>di</strong> non derivabilità. Continuità delle funzioni derivabili.<br />
Derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata <strong>di</strong> una funzione <strong>di</strong> funzione.<br />
*Derivate <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne superiore al primo. *Differenziale <strong>di</strong> una funzione. *Significato geometrico del<br />
<strong>di</strong>fferenziale. *Regola <strong>di</strong> De L’Hôpital. *Applicazioni del concetto <strong>di</strong> derivata in fisica.<br />
Libro <strong>di</strong> testo:<br />
Titolo: “Lineamenti <strong>di</strong> matematica” Vol. 5<br />
Autori: Dodero - Baroncini - Manfre<strong>di</strong><br />
Ed.: Ghisetti e corvi<br />
ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI SVOLTE DALLA CLASSE<br />
Una parte della classe ha partecipato ai “Giochi <strong>di</strong> Archimede”, gara nazionale <strong>di</strong> matematica cui la<br />
scuola ha aderito, organizzata dall’UMI (Unione Matematica Italiana) e valida per la prima<br />
selezione alle Olimpia<strong>di</strong> della Matematica.<br />
Un gruppo ha altresì aderito ai giochi mon<strong>di</strong>ali denominati “Kangourou della matematica”, che<br />
ormai da <strong>di</strong>versi anni la scuola propone a tutte le classi.<br />
NOTE:<br />
28
29<br />
- Gli argomenti contrassegnati con il simbolo “ * ”, sono quelli che in data o<strong>di</strong>erna sono ancora da<br />
trattare<br />
3. 8 Percorso formativo <strong>di</strong> Fisica <br />
DOCENTE Prof. ssa Chiara Mastrantonio<br />
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE<br />
La classe ha intrapreso lo stu<strong>di</strong>o del secondo anno <strong>di</strong> fisica, accostandosi ad essa con interesse e<br />
curiosità. Subentrata ad un collega, nel primo periodo ho cercato <strong>di</strong> rivedere con gli alunni gli<br />
argomenti più importanti del programma dello scorso anno e <strong>di</strong> consolidare eventuali concetti<br />
lacunosi.<br />
Da subito ho potuto constatare nel gruppo molta <strong>di</strong>sponibilità alla collaborazione e altrettanta<br />
serietà nello stu<strong>di</strong>o a casa: sempre sistematici e regolari, gli alunni hanno costruito gradatamente<br />
una conoscenza sod<strong>di</strong>sfacente dei vari argomenti e più volte il loro impegno ha potuto compensare<br />
la <strong>di</strong>fficoltà a ricordare con precisione gli argomenti pregressi, ad interpretare correttamente quelli<br />
attuali o a risolvere autonomamente gli esercizi assegnati.<br />
Il processo <strong>di</strong>dattico è <strong>stato</strong> armonioso e piuttosto <strong>di</strong>namico.<br />
Gli obiettivi <strong>di</strong>dattici prefissati sono stati raggiunti in modo omogeneo da tutta la classe, che<br />
evidenzia una buona conoscenza dei contenuti, una <strong>di</strong>screta capacità <strong>di</strong> interpretare la materia e<br />
comunicarla con il linguaggio specifico, sufficiente capacità <strong>di</strong> analisi e sintesi, anche a scopo<br />
applicativo.<br />
OBIETTIVI<br />
Conoscenza: - dei contenuti specifici<br />
- delle regole convenzionali<br />
- <strong>di</strong> classificazioni, categorie e criteri<br />
- dei principi e delle leggi fisiche.<br />
Comprensione : - saper leggere ed interpretare un testo scritto che illustra un concetto fisico<br />
- saper leggere ed interpretare grafici, formule e tabelle<br />
- essere in grado <strong>di</strong> comprendere le informazioni semplici, complesse e<br />
tematiche.<br />
Comunicazione - saper utilizzare la terminologia specifica in modo corretto, preciso e<br />
personale.<br />
- saper illustrare i concetti appresi attraverso l’uso <strong>di</strong> formule, grafici e tabelle<br />
- saper esporre il proprio pensiero con linearità e pertinenza argomentativa.<br />
Applicazione: - saper risolvere in modo autonomo semplici esercizi applicativi<br />
- saper applicare a contesti <strong>di</strong> varia natura le leggi stu<strong>di</strong>ate.<br />
Analisi: - saper cogliere eventuali relazioni esistenti tra le varie grandezze fisiche<br />
- saper esaminare semplici esperienze <strong>di</strong> vita quoti<strong>di</strong>ana e <strong>di</strong> laboratorio,<br />
applicando i principi stu<strong>di</strong>ati.
Sintesi: - saper mettere in luce eventuali collegamenti concettuali<br />
a) nell’ambito della fisica<br />
b) nell’ambito delle <strong>di</strong>scipline affini.<br />
METODOLOGIA<br />
La metodologia applicata è stata estremamente semplice e lineare: la lezione, normalmente condotta<br />
in modo frontale, qualche volta con l’ausilio <strong>di</strong> materiale <strong>di</strong>dattico presente in laboratorio, ha<br />
comunque tenuto in grande considerazione il <strong>di</strong>alogo con la classe, in modo tale da valorizzarne<br />
potenzialità e conoscenze e in<strong>di</strong>viduarne eventuali carenze da colmare.<br />
Alcune lezioni sono state de<strong>di</strong>cate al necessario ripasso <strong>di</strong> argomenti affrontati in seconda, anche se<br />
<strong>di</strong> norma tali elementi risultavano acquisiti in modo adeguato.<br />
Il testo adottato è <strong>stato</strong> seguito con molta regolarità perché potesse essere valido supporto allo<br />
stu<strong>di</strong>o in<strong>di</strong>viduale e sostegno nel consolidamento delle abilità tecniche ed espressive necessarie per<br />
interpretare ed illustrare concetti scientifici.<br />
Le teorie enunciate sono state spiegate ricorrendo a numerosi esempi tratti dalla vita concreta e<br />
rappresentate attraverso gli strumenti matematici adeguati, <strong>di</strong> cui si è analizzato il significato<br />
attraverso l’interpretazione <strong>di</strong> vari fenomeni.<br />
Gli esercizi proposti sono stati meramente applicativi delle formule notevoli, contenti <strong>di</strong>fficoltà<br />
minime, allo scopo semplicemente <strong>di</strong> consolidare le nozioni acquisite nello stu<strong>di</strong>o della teoria.<br />
La verifica è stata attuata attraverso due prove scritte e colloqui orali.<br />
PROGRAMMA<br />
TERMODINAMICA<br />
Termologia<br />
Termoscopi e termometri<br />
Dilatazione termica lineare<br />
Dilatazione termica dei soli<strong>di</strong>, dei liqui<strong>di</strong> e dei gas.<br />
I gas perfetti<br />
La legge <strong>di</strong> Boyle<br />
Prima e seconda legge <strong>di</strong> Gay Lussac<br />
La temperatura assoluta<br />
L’equazione <strong>di</strong> <strong>stato</strong> dei gas perfetti<br />
Teoria cinetica dei gas<br />
Energia interna del gas<br />
Interpretazione microscopica della pressione esercitata da un gas<br />
Significato della temperatura assoluta<br />
Il calore e i cambiamenti <strong>di</strong> <strong>stato</strong><br />
La natura del calore<br />
Capacità termica e calore specifico<br />
Calorimetro e caloria<br />
Propagazione del calore (convezione, conduzione e irraggiamento)<br />
Fusione e soli<strong>di</strong>ficazione<br />
30
Vaporizzazione e la condensazione<br />
Temperatura critica e <strong>di</strong>agramma <strong>di</strong> fase<br />
I principi della termo<strong>di</strong>namica<br />
Il lavoro meccanico compiuto da un sistema termo<strong>di</strong>namico<br />
Il primo principio della termo<strong>di</strong>namica<br />
Applicazioni del primo principio a particolari trasformazioni termo<strong>di</strong>namiche<br />
La macchina termica<br />
Il secondo principio della termo<strong>di</strong>namica: enunciati <strong>di</strong> Kelvin e Clausius<br />
Il ren<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> una macchina termica, trasformazioni reversibili e irreversibili<br />
Il teorema <strong>di</strong> Carnot<br />
Il ciclo <strong>di</strong> Carnot<br />
Il motore dell’automobile<br />
Il frigorifero<br />
Le variazioni <strong>di</strong> entropia<br />
Secondo principio dal punto <strong>di</strong> vista molecolare.<br />
ELETTROLOGIA<br />
ELETTROMAGNETISMO<br />
Elettrostatica<br />
Fenomeni <strong>di</strong> elettrizzazione (strofinio, contatto, induzione)<br />
La carica elettrica<br />
La legge <strong>di</strong> Coulomb (nel vuoto e nella materia)<br />
I conduttori e gli isolanti<br />
Il campo elettrico: concetto e vettore<br />
Le linee <strong>di</strong> campo<br />
Il flusso <strong>di</strong> un campo vettoriale attraverso una superficie<br />
Il teorema <strong>di</strong> Gauss per il campo elettrico<br />
L’energia potenziale elettrica<br />
Il potenziale elettrico<br />
Il potenziale <strong>di</strong> una carica puntiforme<br />
Le superfici equipotenziali<br />
Relazione tra campo elettrico e potenziale<br />
La circuitazione del campo elettrostatico<br />
La <strong>di</strong>stribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico<br />
Il campo elettrico e il potenziale <strong>di</strong> un conduttore in equilibrio elettrostatico<br />
Capacità <strong>di</strong> un conduttore<br />
Il condensatore e la sua capacità<br />
Esperienza <strong>di</strong> Rutherford<br />
Modello atomico <strong>di</strong> Bohr<br />
Energia <strong>di</strong> legame <strong>di</strong> un elettrone in un atomo<br />
Elettro<strong>di</strong>namica<br />
La corrente elettrica continua<br />
I generatori <strong>di</strong> tensione<br />
Il circuito elettrico<br />
Leggi <strong>di</strong> Ohm<br />
Le leggi <strong>di</strong> Kirchoff<br />
I conduttori ohmici in serie e in parallelo<br />
31
32<br />
L’energia e la potenza elettrica<br />
Particolari effetti della corrente nei conduttori metallici (effetto Joule, effetto termoionico,<br />
effetto fotoelettrico, effetto Volta)<br />
L’elettrolisi, le scariche elettriche nei gas, raggi cato<strong>di</strong>ci.<br />
MAGNETISMO*<br />
Fenomeni magnetici fondamentali<br />
I magneti<br />
Le linee del campo magnetico<br />
Confronto tra campo elettrico e campo magnetico<br />
Esperienze <strong>di</strong> Oersted, Faraday, Ampere<br />
L’origine del campo magnetico<br />
L’intensità del campo magnetico<br />
La forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente<br />
Il campo magnetico <strong>di</strong> un filo rettilineo percorso da corrente<br />
Il campo magnetico <strong>di</strong> una spira<br />
Il campo magnetico <strong>di</strong> un solenoide<br />
La forza <strong>di</strong> Lorentz<br />
Il flusso del campo magnetico<br />
La circuitazione del campo magnetico<br />
L’induzione elettromagnetica<br />
Le correnti indotte<br />
La legge <strong>di</strong> Faraday-Neumann<br />
La legge <strong>di</strong> Lenz<br />
Equazioni <strong>di</strong> Maxwell e spettro elettromagnetico<br />
Libro <strong>di</strong> testo in adozione<br />
Ugo Amal<strong>di</strong> – “Corso <strong>di</strong> fisica”, Vol. 2 – Ed. Zanichelli<br />
*<br />
Attualmente gli argomenti successivi alla voce evidenziata con il simbolo (*) sono ancora da<br />
spiegare.
3. 9 Percorso formativo <strong>di</strong> Storia dell’Arte <br />
DOCENTE Prof.Antonello Nave<br />
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE<br />
Obiettivi <strong>di</strong>sciplinari:<br />
Conoscenza delle caratteristiche generali dei movimenti esaminati e dell’apporto dei principali<br />
esponenti.<br />
- Competenze: lettura dell’opera d’arte dal punto <strong>di</strong> vista iconografico e iconologico e<br />
stilistico-formale; riconoscimento delle funzioni linguistiche <strong>di</strong> un’opera d’arte contemporanea; uso<br />
<strong>di</strong> un linguaggio lessicalmente e concettualmente corretto e articolato.<br />
- Capacità: confronti tra autori ed opere e collegamenti in senso <strong>di</strong>acronico e sincronico,<br />
anche con agganci tematici ad altre <strong>di</strong>scipline.<br />
Verifiche:<br />
- Verifica sommativa (su ampia porzione <strong>di</strong> programma svolto).<br />
- Verifiche formative nel corso stesso delle lezioni, sia frontali che interattive o multime<strong>di</strong>ali.<br />
- Simulazioni <strong>di</strong> terza prova scritta (tipologia B).<br />
Metodologia:<br />
- Lezione frontale (per premesse metodologiche, introduzioni storiografiche, nuclei<br />
concettuali).<br />
- Lezione interattiva, soprattutto per analisi guidate dell’opera d’arte, nei suoi connotati<br />
stilistico-formali.<br />
- Lezione multime<strong>di</strong>ale (<strong>di</strong>apositive, immagini tratte dal web), soprattutto per<br />
l’approfon<strong>di</strong>mento su autori <strong>di</strong> particolare rilevanza o in preparazione della visita guidata.<br />
Testi in adozione:<br />
33
34<br />
- P. ADORNO-A. MASTRANGELO, Dell’arte e degli artisti, vol. 3, Messina-Firenze, D’Anna, 2001<br />
[in<strong>di</strong>cato più sotto come A]<br />
- AA.VV., I luoghi dell’arte. Storia, opere, percorsi, vol. 6, Milano, Electa-Bruno Mondadori,<br />
Contenuti:<br />
2003 [in<strong>di</strong>cato più sotto come B e già in uso in IV ginnasiale]<br />
N° Unità <strong>di</strong>dattica<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
Il linguaggio neoclassico:<br />
Illuminismo, educazione e “risorgimento” delle arti (A pp. 146-147)<br />
Visione del film <strong>di</strong> F. Truffaut, Il ragazzo selvaggio (1969)<br />
David (A pp. 158-161)<br />
Canova (A pp. 153-157)<br />
Tra due secoli:<br />
Goya (A pp. 163-167). Visione del film <strong>di</strong> M. Forman, L’ultimo inquisitore. Goya’s Gost<br />
(2006)<br />
- Friedrich (A pp. 184-187)<br />
Eclettismo: Vala<strong>di</strong>er al Pincio. Il Caffè Pedrocchi <strong>di</strong> Jappelli (A pp. 152 e 178)<br />
Pittura d’età romantica:<br />
- Géricault (A pp. 191-193).<br />
- Delacroix. (A pp. 194-195)<br />
- Romanticismo italiano (A pp. 198-201): Nazareni e Puristi. Hayez, Bezzuoli e Ussi<br />
Arte inglese (A pp. 188-189):<br />
- Füssli<br />
- Blake<br />
- Constable<br />
- Turner<br />
- Preraffaelliti. Arts and Crafts<br />
Dal realismo al naturalismo.<br />
- Courbet (A pp. 204-205)<br />
- Macchiaioli (A pp. 288-301)<br />
- Manet e gli Impressionisti (A pp. 212-218; 221-235)<br />
6 Le Avanguar<strong>di</strong>e storiche:<br />
- Matisse (B pp. 95-99)<br />
- Die Brücke (B pp. 100-102)<br />
- Picasso e Braque (B pp. 103-107; 110-114; 116-117; 221-224)<br />
- Boccioni e il Futurismo (B pp. 120-125; 129)<br />
- Astrattismi *<br />
* Argomento ancora da svolgere.
Kan<strong>di</strong>nskij (B pp. 131-135)<br />
Maleviĉ (B pp. 138-139)<br />
Mondrian (B pp. 136-137; 196-197)<br />
- Dada e Surrealismo * (B pp. 148-150; 210-215)<br />
Visita guidata alla Galleria d’Arte Moderna <strong>di</strong> Palazzo Pitti (9 <strong>di</strong>cembre 2010)<br />
Due lezioni multi<strong>di</strong>sciplinari sui rapporti tra musica e arti figurative negli anni delle Avanguar<strong>di</strong>e<br />
storiche, a cura dell’ex-studente Leonardo Anatrini (2 e 12 maggio 2011)<br />
Breve giu<strong>di</strong>zio sulla classe:<br />
A conferma <strong>di</strong> quanto registrato nell’intero quinquennio trascorso insieme, il giu<strong>di</strong>zio sulla classe è<br />
<strong>stato</strong> indubbiamente positivo anche nel corso <strong>di</strong> questo ultimo anno scolastico.<br />
La partecipazione al <strong>di</strong>alogo educativo è stata costante, con <strong>di</strong>ffuso interesse per i contenuti<br />
<strong>di</strong>sciplinari. Profitto tra più che <strong>di</strong>screto e ottimo. Comportamento sempre corretto.<br />
* Argomento ancora da svolgere.<br />
35
3. 10 Percorso formativo <strong>di</strong> Educazione fisica <br />
DOCENTE: Prof. Giovanni Biagiotti<br />
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE<br />
Sono titolare della cattedra <strong>di</strong> Educazione Fisica in questa classe dall’inizio del triennio.<br />
Sono convinto che durante questi tre anni sia <strong>stato</strong> svolto un lavoro sod<strong>di</strong>sfacente soprattutto per<br />
quanto riguarda le competenze conseguite al termine del corso dagli studenti in relazione al livello<br />
<strong>di</strong> partenza.<br />
Livello <strong>di</strong> partenza che presentava una classe decisamente eterogenea sia dal punto <strong>di</strong> vista delle<br />
qualità motorie sia dal punto <strong>di</strong> vista delle motivazioni e dell’impegno<br />
OBIETTIVI<br />
Gli obiettivi previsti dalla programmazione annuale sono stati generalmente raggiunti. Partendo<br />
però, come accennato sopra, da <strong>di</strong>fferenti livelli <strong>di</strong> capacità, anche il livello delle competenze<br />
raggiunto, è risultato <strong>di</strong>versificato.<br />
I risultati conseguiti in termini <strong>di</strong> miglioramento <strong>di</strong> capacità, conoscenze e competenze, possono<br />
essere comunque definiti sod<strong>di</strong>sfacenti.<br />
METODOLOGIE<br />
La strategia per il conseguimento degli obiettivi prefissati, mi ha impegnato su un duplice fronte:<br />
1. Motivare chi aveva minor interesse verso le attività motorie in genere e verso quelle sportive in<br />
particolare, facendo leva soprattutto sull'importanza della ricaduta positiva <strong>di</strong> queste in termine<br />
<strong>di</strong> benessere psico-fisico.<br />
2. Offrire altri strumenti a chi, essendo decisamente motivato, aveva <strong>di</strong>mostrato esigenze <strong>di</strong>verse<br />
ed era interessato ad approfon<strong>di</strong>menti più consistenti.<br />
Il programma è <strong>stato</strong> perciò <strong>di</strong>versificato e personalizzato secondo le reali necessità. L'attività svolta<br />
si è basata prevalentemente su meto<strong>di</strong> induttivi che favoriscono la scoperta personale, la fantasia, la<br />
creatività. Abbastanza varia l'impostazione della lezione con momenti frontali affiancati ad altri<br />
interattivi, con esercitazioni <strong>di</strong> gruppo e con fasi della lezione in cui gli alunni stessi organizzavano<br />
la propria attività.<br />
CRITERI DI VALUTAZIONE<br />
La particolare natura della materia fa sì che il miglioramento capacità motorie degli allievi risenta<br />
molto più delle attitu<strong>di</strong>ni innate e dei precedenti appren<strong>di</strong>menti motori e sportivi, che non degli<br />
insegnamenti impartiti nella scuola secondaria <strong>di</strong> secondo grado.<br />
Mi è sembrato pertanto opportuno, nella valutazione finale, più che dei risultati assoluti conseguiti,<br />
tenere in maggior considerazione, l'impegno, l'entusiasmo con cui si affrontavano situazioni nuove<br />
e <strong>di</strong>verse, il comportamento tenuto durante lo svolgimento della lezione e il livello <strong>di</strong><br />
collaborazione raggiunto con l'insegnante e con i compagni.<br />
Per quanto riguarda le valutazioni, sono stati adottati i criteri docimologici inseriti nel Piano<br />
dell’Offerta Formativa della Scuola.<br />
36
CONCLUSIONI<br />
La classe ha concluso l'anno scolastico con uno standard <strong>di</strong> preparazione eterogeneo. Si passa da<br />
valutazioni che vanno dal buono all’eccellente e in alcuni casi all’ottimo.<br />
Alcuni alunni avrebbero potuto raggiungere risultati superiori se l'impegno fosse <strong>stato</strong> costante, altri<br />
invece proprio grazie alla costanza, sono riusciti a ottenere risultati decisamente gratificanti.<br />
Il clima è sempre <strong>stato</strong> improntato alla correttezza e al rispetto, la partecipazione attiva e l’impegno<br />
appropriato.<br />
37
3. 11 Percorso formativo <strong>di</strong> Religione (facoltativo) <br />
DOCENTE: Prof. Paolo Drago<br />
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE<br />
Quest’anno scolastico si sono avvalsi dell’IRC 20 alunni su 22.<br />
Nel quadro delle finalità <strong>di</strong> una scuola formativa e critica, l’IRC ha privilegiato contenuti e<br />
<strong>di</strong>dattica, in cui l’alunno fosse protagonista attivo, attraverso un approccio approfon<strong>di</strong>to sia<br />
culturale che umano al fatto religioso.<br />
Tutti gli studenti ha avuto nei confronti della <strong>di</strong>sciplina e dei suoi contenuti un atteggiamento <strong>di</strong><br />
interesse, un approccio positivo, un comportamento corretto e costruttivo.<br />
Conoscenze e capacità<br />
Quasi tutti gli alunni hanno valorizzato appieno l’opportunità <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>re temi che<br />
permettevano anche collegamenti multi<strong>di</strong>sciplinari e approfon<strong>di</strong>menti personali. Gli argomenti sono<br />
stati talvolta affrontati in modo marginale, quin<strong>di</strong> poco incisivo, spesso sorvolati. Per l’esiguo<br />
numero <strong>di</strong> ore <strong>di</strong> lezione ho avuto <strong>di</strong>fficoltà a dare continuità e <strong>di</strong> conseguenza approfon<strong>di</strong>re temi <strong>di</strong><br />
interesse.<br />
Contenuti<br />
Come previsto dal piano annuale <strong>di</strong> lavoro, oltre a tematiche e linguaggi più specificatamente<br />
religiosi, è stata de<strong>di</strong>cata una mirata attenzione alla <strong>di</strong>mensione ed alla problematica esistenziale e<br />
religiosa degli studenti.. Ciò ha contribuito talvolta ad attualizzare e a rendere positivamente vivace<br />
l’ora <strong>di</strong> lezione, con un <strong>di</strong>alogo-confronto aperto ed equilibrato.<br />
Valutazione<br />
In genere hanno saputo rielaborare ed approfon<strong>di</strong>re in modo personale i contenuti, <strong>di</strong>mostrando<br />
un <strong>di</strong>screto senso critico. Alcuni alunni hanno <strong>di</strong>mostrato buona conoscenza <strong>di</strong> base dei contenuti<br />
<strong>di</strong>sciplinari. Complessivamente il ren<strong>di</strong>mento risulta buono.<br />
Le valutazioni si sono svolte in itinere, nell’ambito del normale <strong>di</strong>alogo educativo.<br />
Metodologie attuate<br />
Brevi lezioni frontali; lettura/visione/ascolto, spiegazione e commento dei vari materiali.<br />
UNITA' DIDATTICHE<br />
1. Credere oggi:<br />
2. - crisi <strong>di</strong> fede: infinito <strong>di</strong> Dio o infinito dell'uomo?<br />
3. - Il bisogno <strong>di</strong> Dio.<br />
4. - l'in<strong>di</strong>fferenza: anoressia dell'anima.<br />
5. Bibbia e vita:<br />
− - Bibbia: libro sconosciuto. Perchè conoscerla?<br />
− - Introduzione: il testo, la tra<strong>di</strong>zione, le traduzioni<br />
− - Temi biblici universali:<br />
- “Dov'è tuo fratello?” (Caino e Abele): la violenza<br />
- la ricchezza della <strong>di</strong>versità (torre <strong>di</strong> Babele)<br />
- l'uomo in viaggio (Abramo e … Ulisse)<br />
- Gesù e il Cristianesimo: il dubbio e la fede. Il paradosso cristiano.<br />
3. Cristianesimo ed Europa:<br />
- San Paolo: l’annuncio cristiano ai gentili;<br />
− - le culture che hanno fatto l'Europa: Atene, Gerusalemme, Roma<br />
− - l'impronta cristiana nel tempo e nello spazio.<br />
- Il monachesimo<br />
4. Etica della solidarietà:<br />
38
− - l'amore del prossimo un hobby?<br />
− - Storia cristiana della carità; carità e giustizia;<br />
5. I <strong>di</strong>ritti dell'uomo nel magistero cattolico:<br />
- il pensiero sociale della Chiesa: beni, sviluppo, solidarietà, conflitti …<br />
NB: Parte degli argomenti della Unità 5 sono da sviluppare entro il 12 giugno.<br />
TESTO: Sergio Bocchini, Religione e Religioni, Triennio, EDB Bologna 2003<br />
39
4. Simulazione terza prova. <br />
SCHEDA INFORMATIVA GENERALE SULLA PROGRAMMAZIONE DELLA<br />
TERZA PROVA<br />
Il Consiglio <strong>di</strong> Classe della III B, in accordo con gli altri Consigli <strong>di</strong> Classe ha scelto <strong>di</strong> far<br />
sostenere agli alunni tre simulazioni <strong>di</strong> terza prova: una con la TIPOLOGIA A e due con la<br />
TIPOLOGIA B . Questa tipologia si è <strong>di</strong>mostrata come la più adatta per raggiungere le finalità<br />
della prova stessa, cioè garantire un accertamento pluri<strong>di</strong>sciplinare sulla conoscenza delle materie<br />
dell’ultimo anno <strong>di</strong> corso.<br />
Le prove si sono svolte:<br />
Il 28/02/2011, TIPOLOGIA B, <strong>di</strong>scipline coinvolte: GRECO, FISICA, SCIENZE, INGLESE,<br />
FILOSOFIA<br />
Il 30/03/2011, TIPOLOGIA A, <strong>di</strong>scipline coinvolte: GRECO, MATEMATICA, SCIENZE,<br />
INGLESE, STORIA<br />
Il 28/04/2011, TIPOLOGIA B, <strong>di</strong>scipline coinvolte GRECO, MATEMATICA, SCIENZE,<br />
INGLESE, STORIA<br />
Seguono i testi delle tre prove.<br />
40
PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA data 28/02/2011<br />
GRECO<br />
1)Delinea le <strong>di</strong>fferenze fra la drammaturgia <strong>di</strong> Aristofane e quella <strong>di</strong> Menandro.<br />
2)Illustra la concezione retorica <strong>di</strong> Isocrate, a partire dal brano del Panegirico allegato<br />
ISOCRATE.Paneg.47-50 (soprattutto 47exc.-49)<br />
[47]Scoperta la nostra città fu veramente la cultura dell’intelletto e l’amore del sapere, che <strong>di</strong> ciò<br />
che abbiamo detto fu la vera causa, e che ci ha educati all’azione e ci ha resi civili e umani gli uni<br />
verso gli altri, ed ha <strong>di</strong>stinte le sventure causate dall’ ignoranza da quelle cagionate dalla necessità<br />
della sorte apprendendoci ad evitare le une e a sopportare con magnanimo cuore le altre E fu<br />
appunto la nostra città che <strong>di</strong>ede origine all’arte della parola, alla quale tutti ambiscono e tutti tra<br />
quelli che la posseggono invi<strong>di</strong>ano.[48] Ben sapeva la nostra città che questo solo è il nostro<br />
privilegio, rispetto a tutti gli animali, e che questo pregio ci rende in tutto superiori Per <strong>di</strong> più essa<br />
scorgeva che in ogni altra attività così incerto è l’esito che chi più vale e più sa spesso fallisce,<br />
mentre gli inetti hanno successo; ma nell’arte della bella ed artistica parola nulla è dato agli inetti;<br />
ma solo è conquista <strong>di</strong> anime accorte e sagge.<br />
41
[49] E ben scorgeva ancora la nostra città che per tale arte massimamente fra loro <strong>di</strong>fferiscono i<br />
valenti ingegni e gli inetti, ed oltre a ciò, che coloro i quali sin dalla fanciullezza sono educati<br />
liberalmente non si <strong>di</strong>stinguono dagli altri per coraggio o ricchezza o simili pregi, ma<br />
massimamente per il valore che appare dai loro <strong>di</strong>scorsi; e questo è il più chiaro e sicuro suggello<br />
dell’educazione e della cultura <strong>di</strong> ciascuno; e per <strong>di</strong> più,coloro che sono eccellenti nell’arte della<br />
parola <strong>di</strong>vengono nelle loro città potenti e ovunque gloriosi.[50] E la nostra città supera tanto gli<br />
altri uomini per cultura e per l’ingegno e per l’ arte della parola che i suoi <strong>di</strong>scepoli sono <strong>di</strong>ventati<br />
maestri agli atri ; ed ha fatto sì che il nome <strong>di</strong> Greci non paresse più il nome <strong>di</strong> una razza, ma<br />
dell’intelligenza e della cultura stessa; e che piuttosto si chiamano Greci quelli che partecipano della<br />
nostra cultura che coloro ché hanno comune con l’origin<br />
FILOSOFIA<br />
1) Si spieghi il significato del concetto <strong>di</strong> trasvalutazione dei valori in Nietzsche<br />
2) Si illustrino i caratteri della società positiva delineata da Comte<br />
SCIENZE<br />
1) Spiega che cos’è l’effetto Doppler e quali informazioni se ne possano ottenere riguardo ad un<br />
dato corpo celeste<br />
2) Esponi gli aspetti principali del fenomeno delle pulsar e spiega la causa delle loro pulsazioni<br />
INGLESE<br />
To speak truly, few adult persons can see nature. Most persons do not see the sun. The sun<br />
illuminates only the eye of the man, but shines into the eye and the heart of the child. The lover of<br />
nature is he who has retained the spirit of infancy even into the era of manhood. In the presence<br />
of nature, a wild delight runs through the man, in spite of real sorrows. Stan<strong>di</strong>ng on the bare<br />
ground, all mean egotism vanishes. I am nothing, I see all.<br />
From Ralph Waldo Emerson, Nature, 1836<br />
1) Read the passage above and write true or false next to the following statements.<br />
Many people are blind<br />
The child is not illuminated by the sun<br />
Adults who are fond of nature still experience childhood feelings<br />
People who suffer can’t find enjoyment in nature<br />
Nature makes men less selfish<br />
42<br />
T F
43<br />
2) Summarize the passage above and, at the same time, you can either say if your<br />
experience of nature is comparable to Emerson’s or show any similarities with W.<br />
Wordsworth’s opinions on childhood and nature.<br />
STORIA DELL’ARTE<br />
stilistica :<br />
P.A. Renoir, Bal au Moulin de la Galette, 1876. Analisi<br />
Silvestro Lega, Il pergolato, 1868. Analisi stilistica
SECONDA ESERCITAZIONE TERZA PROVA data 30/03/2011<br />
GRECO<br />
Definisci, attraverso opportuni esempi, il rapporto <strong>di</strong> Callimaco con la tra<strong>di</strong>zione<br />
poetica precedente.<br />
STORIA<br />
Prendendo in <strong>esame</strong>, sottoponendo ad interpretazione l’evento storico New Deal negli Stati Uniti<br />
del Presidente F. D. Roosewelt si in<strong>di</strong>duino due o massimo tre tratti, due o tre decisioni politiche<br />
aprenti a processi, a vostro avviso, particolarmente rilevanti, incisivamente trasmettenti il senso <strong>di</strong><br />
tale evento<br />
FILOSOFIA<br />
1) Freud scrive: “Dove era l’ES deve subentrare l’IO”. Qual è il significato <strong>di</strong> questa affermazione ?<br />
Si può ipotizzare un legame con il motto nietzschiano “Divieni ciò che sei” ? Nella risposta traccia<br />
unconfronto più generale fra l’analisi freu<strong>di</strong>ana dell’IO e l’idea nietzschiana <strong>di</strong> soggetto<br />
SCIENZE<br />
Tra le costellazioni, le più note sono quelle dello zo<strong>di</strong>aco. Descrivi la loro posizione sulla sfera<br />
celeste e spiega la relazione che esiste con l’apparente moto annuo del Sole<br />
44
INGLESE<br />
1) Find out which words in the text above have the following meaning:<br />
A picture printed from a cut piece of metal<br />
The state of being away from other people<br />
A small enclosed area behind a house<br />
Wearing clothes that are old and torn<br />
To seem similar<br />
Unfamiliar, surprising<br />
2) What features is ‘the sense of a claustrophobic world’ due to? Fill in the blanks below<br />
a) example: the houses extend in a row<br />
b)_____________________________<br />
c)_____________________________<br />
d)_____________________________<br />
3) What kind of life do you think people used to live in the slums? Say which writers Doré’s<br />
London reminds you of and why. (not more than 8 lines)<br />
TERZA ESERCITAZIONE TERZA PROVA data 28/04/2011<br />
GRECO<br />
1) Descrivi la forma metrica dell’epigramma e evidenzia i contenuti e le tematiche<br />
che sono trattate dalle varie scuole epigrammatiche alessandrine.<br />
45
2) Illustra il rapporto che intercorre tra Antologia Palatina e Antologia Planudea .<br />
STORIA<br />
1) si ricostruisca lo status <strong>di</strong> potenza del Giappone, in contesto <strong>di</strong> mon<strong>di</strong>alizzazione, lo si faccia<br />
in<strong>di</strong>viduando nitidamente, all’altezza del XIX secolo – primi del XX secolo, le principali<br />
caratteristiche proprie della nuova potenza emergente<br />
2) Si ricostruisca lo status <strong>di</strong> potenza del Giappone in contesto <strong>di</strong> mon<strong>di</strong>alizzazione stabilizzatosi<br />
nel decennio trenta del XX secolo, lo si faccia in<strong>di</strong>viduando nitidamente, all’altezza 1937 – 1941, le<br />
principali e specifiche funzioni dalla potenza Giappone assegnatesi.<br />
SCIENZE<br />
1) Spiega che cosa sono e come si ottengano la declinazione e l’ascensione retta <strong>di</strong> un astro<br />
2)Reazione nucleare che avviene nelle stelle <strong>di</strong> sequenza principale: a) quali con<strong>di</strong>zioni sono<br />
necessarie ? b) nuclei che reagiscono e nuclei che si formano; c) cosa accade alla massa ?<br />
STORIA DELL’ARTE<br />
Die Brücke: definizione e caratteri.<br />
linguaggio.<br />
INGLESE<br />
P. Picasso, Les Demoiselles d’Avignon (1907). L’inizio <strong>di</strong> un nuovo<br />
Crime is a plague on our cities, infecting communities with fear. Solutions to urban crime are independent of<br />
whether the issue is characterized as a virus or a wild animal, right? Wrong. Asked to solve one city’s crime<br />
problem, participants in a Stanford University study tended to propose social reforms (era<strong>di</strong>cate poverty,<br />
improve education) when crime was described as a virus. But when crime was described as a wild animal,<br />
they tended to propose harsher enforcement policies (jail criminals, enact tougher laws). Both stu<strong>di</strong>es reveal<br />
the hidden power of metaphor to influence how we view the world.<br />
1) find words in the passages above which have similar meanings to the following words<br />
Very infectious <strong>di</strong>sease<br />
problem<br />
46
More severe<br />
To imprison<br />
To pass laws<br />
2) Read the passage above and write true or false next to the following statements<br />
T F<br />
Nowadays all people who live in cities are afraid of criminal acts<br />
You can refer to criminality as a virus or a wild animal<br />
Solutions to the problem of criminality seemed independent from the way it was<br />
portrayed<br />
Two stu<strong>di</strong>es on one city’s crime problem have shown that solutions to urban crime do<br />
not depend on how you call it.<br />
3) Write about the importance of metaphors or similes in real life ( as proved in the passage above) and<br />
in literature (quote from one of the texts you recently read at school).<br />
47
GRIGLIE DI VALUTAZIONE <br />
Prima prova scritta: Italiano<br />
TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO<br />
9-10 8 7 6 5 < 4<br />
Comprensione Efficace ed Esauriente e Sod<strong>di</strong>sfacente Sufficiente ma Trattazione Incompleta e<br />
complessiva esauriente. approfon<strong>di</strong>ta<br />
talvolta superficiale molto<br />
Approfon<strong>di</strong>ta<br />
superficiale Sono presenti superficiale<br />
e funzionale<br />
Poco<br />
approfon<strong>di</strong>ta e<br />
con qualche<br />
errore<br />
lacune<br />
Analisi del testo Efficace ed Esauriente e Sod<strong>di</strong>sfacente Sufficiente ma Trattazione Incompleta e<br />
esauriente approfon<strong>di</strong>ta<br />
talvolta superficiale molto<br />
Approfon<strong>di</strong>ta<br />
superficiale Sono presenti superficiale<br />
e funzionale<br />
Poco<br />
approfon<strong>di</strong>ta e<br />
con qualche<br />
errore<br />
lacune<br />
Approfon<strong>di</strong>menti Efficaci<br />
Esaurienti Sod<strong>di</strong>sfacente Sufficiente ma Trattazione Incompleta e<br />
esaurienti e<br />
talvolta superficiale molto<br />
personali<br />
superficiale Sono presenti superficiale<br />
Poco<br />
approfon<strong>di</strong>ta e<br />
con qualche<br />
errore<br />
lacune<br />
Struttura del Esposizione Esposizione Esposizione Esposizione Esposizione Esposizione<br />
<strong>di</strong>scorso chiara, corretta e or<strong>di</strong>nata e corretta adeguata con talvolta poco <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nata con molto<br />
48
Elaborazione<br />
personale<br />
coesa. qualche<br />
scorrettezza<br />
Argomentazione<br />
ricca e articolata<br />
con contributi<br />
personali<br />
nell’interpretazio<br />
ne<br />
Argomentazione<br />
adeguata con<br />
alcuni contributi<br />
personali<br />
Argomentazione<br />
adeguata, ma<br />
non sempre<br />
articolata<br />
TIPOLOGIA B – SAGGIO BREVE /ARTICOLO DI GIORNALE<br />
Aderenza alla<br />
consegna<br />
Aderenza alla<br />
traccia<br />
Argomentazione<br />
ed elaborazione<br />
Struttura del<br />
<strong>di</strong>scorso<br />
or<strong>di</strong>nata, ma<br />
coerente. Sono<br />
presenti alcuni<br />
errori<br />
Argomentazione<br />
schematica,<br />
sono quasi del<br />
tutto assenti i<br />
contributi<br />
personali<br />
frequenti errori<br />
(sintattici,<br />
ortografici)<br />
Argomentazione<br />
molto<br />
schematica e<br />
senza contributi<br />
personali<br />
9-10 8 7 6 5 < 4<br />
Completa Nel complesso<br />
completa<br />
Completa Nel complesso<br />
completa<br />
Efficaci,<br />
Articolata con<br />
esaurienti e una tesi ben<br />
articolate, con riconoscibile e<br />
una tesi ben con contributi<br />
definita e sono<br />
presenti apporti<br />
personali<br />
personali<br />
Esposizione Esposizione<br />
chiara, corretta e<br />
coesa.<br />
or<strong>di</strong>nata e corretta<br />
Quasi completa Sufficiente Superficiale/<br />
parziale<br />
Quasi completa Sufficiente Superficiale/<br />
parziale<br />
Nel complesso Sufficiente Non sempre<br />
articolate; la tesi l’ articolazione, articolata bene.<br />
sostenuta è solo ma le tesi La tesi sostenuta<br />
superficialmente sostenuta non è è solo appena<br />
riconoscibile sempre<br />
riconoscibile<br />
accennata<br />
Esposizione<br />
adeguata con<br />
qualche<br />
scorrettezza<br />
Esposizione<br />
talvolta poco<br />
or<strong>di</strong>nata, ma<br />
coerente. Sono<br />
presenti alcuni<br />
errori<br />
Esposizione<br />
<strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nata con<br />
frequenti errori<br />
(sintattici,<br />
ortografici)<br />
TIPOLOGIA C TEMA DI ORDINE STORICO<br />
9-10 8 7 6 5 < 4<br />
Aderenza alla<br />
traccia<br />
Documentazion<br />
e storica<br />
Argomentazione<br />
ed elaborazione<br />
Struttura del<br />
<strong>di</strong>scorso<br />
Completa Nel complesso<br />
completa<br />
Ampia e Esauriente e<br />
articolata articolata<br />
Efficaci,<br />
esaurienti e<br />
articolate, con<br />
apporti personali<br />
Esposizione<br />
chiara, corretta e<br />
coesa.<br />
Articolata e con<br />
alcuni contributi<br />
personali<br />
Esposizione<br />
or<strong>di</strong>nata e corretta<br />
Quasi completa Sufficiente Superficiale/<br />
parziale<br />
Quasi completa Sufficiente Superficiale/<br />
incompleta<br />
Nel complesso<br />
articolate e<br />
adeguate<br />
Esposizione<br />
adeguata con<br />
qualche<br />
scorrettezza<br />
Sufficiente<br />
ma articolata<br />
in modo<br />
schemativo<br />
Esposizione<br />
talvolta poco<br />
or<strong>di</strong>nata, ma<br />
coerente. Sono<br />
presenti alcuni<br />
errori<br />
Articolata in<br />
modo piuttosto<br />
superficiale<br />
Esposizione<br />
<strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nata con<br />
frequenti errori<br />
(sintattici,<br />
ortografici)<br />
<strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nata,<br />
incoerente e<br />
con molti errori<br />
Argomentazione<br />
non adeguata<br />
Non aderente<br />
Fuori tema<br />
La tesi non è<br />
espressa<br />
Esposizione<br />
molto<br />
<strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nata,<br />
incoerente e<br />
con molti errori<br />
Fuori tema<br />
Molto<br />
imprecisa/molto<br />
limitata/<br />
scorretta<br />
49<br />
Inadeguate/<br />
Appena<br />
accennate<br />
Esposizione<br />
molto<br />
<strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nata,<br />
incoerente e<br />
con molti errori
TIPOLOGIA D – TEMA DI ORDINE GENERALE<br />
Aderenza alla<br />
traccia<br />
Argomentazione<br />
ed elaborazione<br />
Struttura del<br />
<strong>di</strong>scorso<br />
9-10 8 7 6 5 < 4<br />
Completa Nel complesso<br />
completa<br />
Efficaci,<br />
Articolata e con<br />
esaurienti e alcuni contributi<br />
articolate, con<br />
apporti personali<br />
personali<br />
Esposizione Esposizione<br />
chiara, corretta e<br />
coesa.<br />
or<strong>di</strong>nata e corretta<br />
Quasi completa Sufficiente Superficiale/<br />
parziale<br />
Nel complesso Sufficiente Articolata in<br />
articolate e ma articolata modo piuttosto<br />
adeguate in modo<br />
schemativo<br />
superficiale<br />
Esposizione Esposizione Esposizione<br />
adeguata con talvolta poco <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nata con<br />
qualche or<strong>di</strong>nata, ma frequenti errori<br />
scorrettezza coerente. Sono (sintattici,<br />
presenti alcuni<br />
errori<br />
ortografici)<br />
50<br />
Fuori tema<br />
Inadeguate/<br />
Appena<br />
accennate<br />
Esposizione<br />
molto<br />
<strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nata,<br />
incoerente e<br />
con molti errori
Seconda prova scritta: Latino<br />
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE LATINO E GRECO<br />
A) Tabella punteggi (approvata il 9/12/2010)<br />
In<strong>di</strong>catore Punteggi Giu<strong>di</strong>zio<br />
Comprensione globale<br />
del contenuto del brano<br />
Corretta in<strong>di</strong>viduazione<br />
e analisi delle strutture<br />
morfosintattiche del<br />
testo<br />
Corretta in<strong>di</strong>viduazione<br />
delle voci del lessico e<br />
dei significati più<br />
pertinenti al contesto;<br />
proprietà linguistica e<br />
efficacia espressiva<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
Completamente insufficiente con<br />
omissioni<br />
Gravemente insufficiente<br />
Insufficiente<br />
Me<strong>di</strong>ocre<br />
Sufficiente<br />
Discreto<br />
Buono<br />
Ottimo<br />
Eccellente<br />
Completamente insufficiente con<br />
omissioni<br />
Gravemente insufficiente<br />
Insufficiente<br />
Me<strong>di</strong>ocre<br />
Sufficiente<br />
Discreto<br />
Buono<br />
Ottimo<br />
Eccellente<br />
Completamente insufficiente con<br />
omissioni<br />
Gravemente insufficiente<br />
Insufficiente<br />
Me<strong>di</strong>ocre<br />
Sufficiente<br />
Discreto<br />
Buono<br />
Ottimo<br />
Eccellente<br />
51
Tabella B: fasce <strong>di</strong> valutazione<br />
Comprensione del brano Conoscenze<br />
Completamente<br />
insufficiente<br />
Comprensione<br />
completamente<br />
insufficiente per<br />
frainten<strong>di</strong>menti morfosintattici<br />
numerosi e<br />
molto gravi e/o viziata<br />
da lacune molto estese<br />
Gravemente insufficiente Comprensione<br />
gravemente insufficiente<br />
per errori morfo-sintattici<br />
e lessicali molto gravi e<br />
numerosi e/o lacune<br />
estese<br />
insufficiente Comprensione<br />
insufficiente per errori<br />
morfo-sintattici e<br />
lessicali numerosi e gravi<br />
e/o lacune <strong>di</strong> una certa<br />
estensione<br />
Me<strong>di</strong>ocre Comprensione me<strong>di</strong>ocre<br />
per errori morfo-sintattici<br />
e lessicali e/o lacune od<br />
omissioni<br />
sufficiente Comprensione sufficiente<br />
ma parzialmente inficiata<br />
da errori morfo-sintattici<br />
e lessicali e/o lacune o<br />
omissioni<br />
<strong>di</strong>screto Comprensione <strong>di</strong>screta<br />
ma in parte inficiata da<br />
alcuni errori morfosintattici<br />
e lessicali e/o<br />
omissioni non gravi<br />
buono Comprensione buona, pur<br />
con qualche errore<br />
morfologico e lessicale<br />
ed eventuali rare<br />
omissioni <strong>di</strong> singoli<br />
termini secondari<br />
ottimo Interpretazione completa<br />
ed accurata del senso del<br />
brano in tutte le sue<br />
problematiche pur con<br />
imperfezioni lessicali non<br />
rilevanti<br />
eccellente Interpretazione completa<br />
ed approfon<strong>di</strong>ta del senso<br />
del brano in tutte le sue<br />
problematiche e in tutti i<br />
suoi livelli espressivi<br />
morfosintattiche<br />
Conoscenze<br />
morfosintattiche talmente<br />
incomplete e lacunose da<br />
non consentire la<br />
traduzione <strong>di</strong> ampi passi<br />
del brano<br />
Conoscenze largamente<br />
incomplete e lacunose<br />
che non consentono per<br />
estesi passi una corretta<br />
interpretazione della<br />
morfosintassi anche <strong>di</strong><br />
frasi semplici<br />
Conoscenze incomplete<br />
che pregiu<strong>di</strong>cano in vari<br />
punti l’analisi<br />
morfosintattica del brano<br />
Conoscenze superficiali e<br />
approssimative in ambito<br />
morfologico e sintattico<br />
che non consentono una<br />
corretta interpretazione<br />
delle frasi più complesse<br />
Pur in presenza <strong>di</strong> errori<br />
l’elaborato rivela una<br />
sufficiente conoscenza<br />
degli elementi<br />
fondamentali della<br />
morfologia e della<br />
sintassi<br />
Discrete conoscenze degli<br />
elementi fondamentali<br />
della morfologia e della<br />
sintassi, pur in presenza<br />
<strong>di</strong> alcuni errori non gravi<br />
Buone conoscenze <strong>di</strong><br />
morfologia e sintassi<br />
sostanzialmente corretta<br />
Ottima padronanza delle<br />
regole morfologiche e<br />
sintattiche con irrilevanti<br />
imperfezioni<br />
Conoscenze eccellenti e<br />
approfon<strong>di</strong>te in ambito<br />
morfologico e sintattico<br />
Correttezza e proprietà<br />
linguistica<br />
resa linguistica assai<br />
scorretta e numerosi e gravi<br />
frainten<strong>di</strong>menti lessicali<br />
Resa linguistica scorretta con<br />
numerosi frainten<strong>di</strong>menti<br />
lessicali<br />
Resa linguistica<br />
approssimativa con numerosi<br />
errori lessicali<br />
Resa linguistica me<strong>di</strong>ocre<br />
con <strong>di</strong>ffusi errori lessicali<br />
Resa linguistica<br />
sufficientemente corretta, pur<br />
con taluni errori lessicali<br />
Resa linguistica<br />
sostanzialmente corretta pur<br />
con scelte lessicali non<br />
sempre adeguate<br />
Resa linguistica espressa in<br />
forma lineare e pertinente pur<br />
con irrilevanti imperfezioni<br />
Resa ottima e fluida del<br />
registro linguistico del brano<br />
Resa eccellente ed<br />
estremamente fluida del<br />
registro linguistico del brano<br />
che personalizza il testo<br />
proposto<br />
52
Terza prova scritta<br />
INDICATORI PUNTEGGIO<br />
MASSIMO<br />
Comprensione<br />
della domanda e<br />
aderenza alle<br />
3<br />
specifiche<br />
richieste<br />
Padronanza dei<br />
contenuti e<br />
capacità <strong>di</strong><br />
rielaborazione<br />
critica<br />
Capacità <strong>di</strong><br />
organizzare il<br />
testo:<br />
esposizione<br />
precisa, qualità <strong>di</strong><br />
analisi e <strong>di</strong><br />
sintesi, capacità<br />
<strong>di</strong><br />
argomentazione<br />
Competenza<br />
espressiva:<br />
proprietà<br />
lessicale, uso <strong>di</strong><br />
terminologie e<br />
rappresentazioni<br />
specifiche<br />
Voto totale attribuito alla prova<br />
con arrotondamento<br />
6<br />
3<br />
3<br />
LIVELLO<br />
VALUTAZIONE<br />
(--) grav. insuff.<br />
(-) insuff.<br />
(=) sufficiente<br />
(+) buono<br />
(++) ottimo<br />
(--) grav. insuff.<br />
(-) insuff.<br />
(=) sufficiente<br />
(+) buono<br />
(++) ottimo<br />
(--) grav. insuff.<br />
(-) insuff.<br />
(=) sufficiente<br />
(+) buono<br />
(++) ottimo<br />
(--) grav. insuff.<br />
(-) insuff.<br />
(=) sufficiente<br />
(+) buono<br />
(++) ottimo<br />
…..…../15<br />
PUNTEGGIO<br />
1<br />
1,5<br />
2<br />
2,5<br />
3<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
1<br />
1,5<br />
2<br />
2,5<br />
3<br />
1<br />
1,5<br />
2<br />
2,5<br />
3<br />
subtotale<br />
53
Griglie utilizzate per le terze prove <strong>di</strong> lingua inglese<br />
Prova del 28-02-11<br />
in<strong>di</strong>catori punteggio<br />
Comprensione<br />
Produzione:<br />
ogni risposta chiusa esatta vale<br />
un punto<br />
5<br />
Aderenza alle richieste<br />
specifiche e completezza delle<br />
informazioni<br />
6<br />
Competenza linguistica:<br />
proprietà lessicale, correttezza<br />
morfositattica e ortografica<br />
2<br />
Organizzazione del<br />
testo,originalità<br />
2<br />
15 punteggio totale<br />
Prova del 30-03-11<br />
in<strong>di</strong>catori punteggio<br />
Comprensione<br />
Produzione:<br />
ogni risposta chiusa esatta vale<br />
un punto<br />
9<br />
Aderenza alle richieste<br />
specifiche e completezza delle<br />
informazioni<br />
2<br />
Competenza linguistica:<br />
proprietà lessicale, correttezza<br />
morfositattica e ortografica<br />
2<br />
Organizzazione del<br />
testo,originalità<br />
2<br />
15 punteggio totale<br />
Prova del 28-04-11<br />
in<strong>di</strong>catori punteggio<br />
Comprensione<br />
Produzione:<br />
ogni risposta chiusa esatta vale<br />
un punto<br />
9<br />
Aderenza alle richieste<br />
specifiche, adeguatezza delle<br />
informazioni, organizzazione<br />
del testo<br />
3<br />
Competenza linguistica:<br />
proprietà lessicale, correttezza<br />
morfositattica e ortografica<br />
3<br />
15 punteggio totale<br />
54
6. CRITERI DI VALUTAZIONE <br />
SCOPO DELLE VERIFICHE:<br />
La verifica ha lo scopo <strong>di</strong>:<br />
• Assumere informazioni sul processo <strong>di</strong> insegnamento/appren<strong>di</strong>mento in corso per orientarlo o mo<strong>di</strong>ficarlo per<br />
favorire il raggiungimento degli obiettivi <strong>di</strong>dattici<br />
• Controllare durante lo svolgimento dell’attività <strong>di</strong>dattica l’adeguatezza dei meto<strong>di</strong>, delle tecniche e degli<br />
strumenti utilizzati al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici<br />
• Accertare il raggiungimento degli obiettivi <strong>di</strong>dattici prefissati<br />
• Classificare gli studenti<br />
L’attività formativa viene programmata in modo da chiarire obiettivi, contenuti, tempi, meto<strong>di</strong>, criteri <strong>di</strong> valutazione,<br />
modalità <strong>di</strong> recupero.<br />
CRITERI DI VALUTAZIONE:<br />
Il Collegio dei Docenti, valutando anche l’importanza delle norme relative allo svolgimento degli Esami <strong>di</strong> Stato, ritiene<br />
che vada utilizzata tutta la scala della misurazione e della valutazione in decimi, anche al fine <strong>di</strong> valorizzare il merito e<br />
l’impegno.<br />
MISURAZIONE:<br />
La seguente griglia <strong>di</strong> valutazione tiene in considerazione le competenze relative alle conoscenze acquisite, qualità<br />
dell’esposizione, comprensione, capacità <strong>di</strong> applicazione delle nozioni apprese.<br />
VOTI 1-3: - nessuna o scarsissima conoscenza degli argomenti proposti;<br />
- assenza <strong>di</strong> comprensione della relazione tra i concetti;<br />
- incapacità <strong>di</strong> applicare i concetti;<br />
- gravi errori e confusione nella comunicazione scritta e orale;<br />
VOTO 4: - carente e frammentaria conoscenza degli argomenti significativi e <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> esposizione;<br />
- comprensione limitata delle attività proposte;<br />
- <strong>di</strong>fficoltà evidente nell’applicazione dei concetti;<br />
VOTO 5: - conoscenza superficiale degli argomenti ed esposizione non fluida e con errori grammaticali;<br />
- comprensione parziale delle relazioni tra i concetti superficialmente appresi;<br />
- incertezza e limitata autonomia nell’applicazione <strong>di</strong> concetti superficialmente appresi;<br />
VOTO 6: - conoscenza sostanziale degli aspetti più significativi degli argomenti fondamentali;<br />
- esposizione sostanzialmente or<strong>di</strong>nata, pur con qualche inesattezza sintattica ed ortografica;<br />
- capacità <strong>di</strong> cogliere gli aspetti essenziali delle relazioni;<br />
- applicazione limitata, ma corretta, dei concetti;<br />
VOTO 7: - conoscenza dei contenuti significativi ed esposizione chiara e sostanzialmente corretta;<br />
- capacità <strong>di</strong> cogliere le principali relazioni;<br />
- applicazione corretta dei concetti;<br />
VOTO 8: - conoscenza approfon<strong>di</strong>ta dei contenuti ed esposizione corretta, chiara e con accenti personali;<br />
- capacità <strong>di</strong> cogliere le relazioni;<br />
- applicazione corretta dei concetti;<br />
VOTO 9: - capacità <strong>di</strong> padroneggiare argomenti e <strong>di</strong> organizzare le conoscenze esponendole in modo<br />
corretto, sapendo fare gli opportuni collegamenti inter<strong>di</strong>sciplinari, utilizzando correttamente i<br />
linguaggi specifici;<br />
VOTO 10: - capacità <strong>di</strong> padroneggiare tutti gli argomenti e <strong>di</strong> organizzare le conoscenze in modo<br />
personale, esponendole in modo corretto, sapendo costruire gli opportuni collegamenti;<br />
55
7-METODI, STRUMENTI, SPAZI: <br />
MODALITA’ DIDATTICHE:<br />
Disciplina: Lezioni<br />
Lezioni Attività <strong>di</strong> Attività <strong>di</strong> Attività<br />
frontali: <strong>di</strong>alogate: gruppo: recupero: pratiche:<br />
ITALIANO X x x<br />
LATINO X x x<br />
GRECO X x<br />
STORIA X x<br />
FILOSOFIA X x<br />
MATEMATICA X x x x x<br />
FISICA X x x<br />
SCIENZE X x x x<br />
INGLESE X x x x<br />
ST. ARTE X x x<br />
ED. FISICA X x<br />
RELIGIONE X x<br />
STRUMENTI USATI:<br />
Disciplina: Libro <strong>di</strong><br />
Altri Registratore tv Lavagna<br />
testo: testi: o cassette luminosa:<br />
ITALIANO x x<br />
LATINO x x<br />
GRECO x x<br />
STORIA x x<br />
FILOSOFIA x x<br />
MATEMATICA x<br />
FISICA x x<br />
SCIENZE x x<br />
INGLESE x x x x<br />
ST. ARTE x<br />
ED. FISICA x<br />
RELIGIONE x<br />
SPAZI:<br />
Disciplina: Aula<br />
classe:<br />
Laboratorio<br />
informatica:<br />
Laboratorio<br />
multime<strong>di</strong>ale<br />
:<br />
Strumenti<br />
multime<strong>di</strong>ali:<br />
Attività<br />
extrascolastiche:<br />
Palestra: Altro:<br />
ITALIANO x<br />
LATINO x<br />
GRECO x<br />
STORIA x<br />
FILOSOFIA x<br />
MATEMATICA x<br />
FISICA x<br />
SCIENZE x x<br />
INGLESE x x<br />
ST. ARTE x<br />
ED. FISICA x<br />
RELIGIONE x<br />
56<br />
Altro:
8-ALLEGATI <br />
1) RELAZIONI DEI DOCENTI E PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE<br />
2) ORIGINALI DELLE ESERCITAZIONI DELLA TERZA PROVA<br />
57