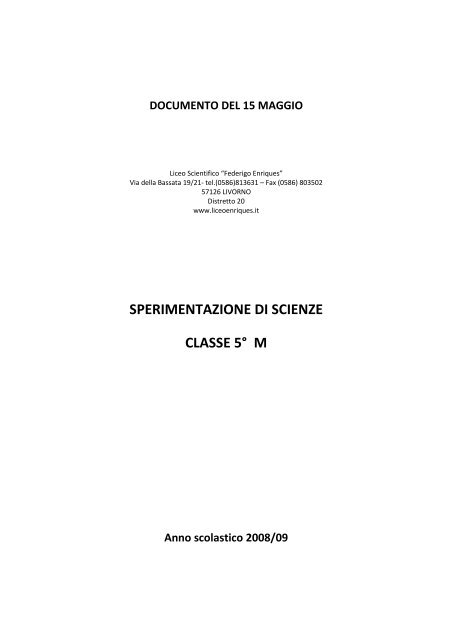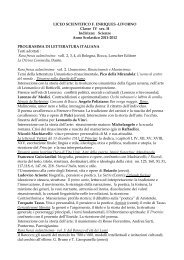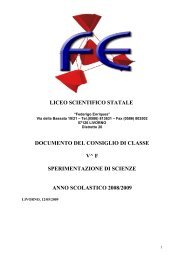documento del 15 maggio - Liceo Scientifico Federigo Enriques ...
documento del 15 maggio - Liceo Scientifico Federigo Enriques ...
documento del 15 maggio - Liceo Scientifico Federigo Enriques ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
DOCUMENTO DEL <strong>15</strong> MAGGIO<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Scientifico</strong> “<strong>Federigo</strong> <strong>Enriques</strong>”<br />
Via <strong>del</strong>la Bassata 19/21- tel.(0586)813631 – Fax (0586) 803502<br />
57126 LIVORNO<br />
Distretto 20<br />
www.liceoenriques.it<br />
SPERIMENTAZIONE DI SCIENZE<br />
CLASSE 5° M<br />
Anno scolastico 2008/09
INDICE <strong>del</strong> DOCUMENTO<br />
Caratteristiche <strong>del</strong> piano di studi <strong>del</strong>la Sperimentazione Di Scienze pag. 3<br />
Composizione <strong>del</strong> Consiglio di Classe pag. 3<br />
Sez. 1: presentazione <strong>del</strong>la Classe:<br />
- elenco dei candidati pag. 4<br />
- storia e profilo <strong>del</strong>la Classe pag. 5<br />
Sez. 2: attività <strong>del</strong> Consiglio di Classe: pag. 6<br />
- obiettivi generali pag. 7<br />
- obiettivi specifici cognitivi e formativi pag. 7<br />
- metodi, mezzi e strumenti, verifiche ,valutazione, pag. 8<br />
- attività di recupero, attività integrative ed extracurricolari pag. 9<br />
Sez. 3: ambiti disciplinari: pag. 10<br />
- Italiano pag. 11<br />
- Latino pag. 17<br />
- Inglese pag. 20<br />
- Matematica pag. 24<br />
- Fisica pag. 26<br />
- Storia pag. 28<br />
- Filosofia pag. 30<br />
- Scienze pag. 33<br />
- Disegno e Storia <strong>del</strong>l’Arte pag. 38<br />
- Educazione fisica pag. 45<br />
- Religione pag. 47<br />
Sez. 4: allegati: pag. 49<br />
- griglie di valutazione italiano pag. 50-52<br />
- griglia di valutazione matematica pag. 53<br />
- griglia di valutazione terza prova pag. 54<br />
- griglie di valutazione educazione fisica pag. 55-56<br />
- griglia di valutazione di inglese pag 57<br />
- simulaz. 3a prova pag. 58<br />
- Scienze pag. 59<br />
- Storia pag. 60<br />
- Inglese pag. 61<br />
- Storia <strong>del</strong>l’arte pag. 62<br />
2
CARATTERISTICHE DEL CORSO DI SPERIMENTAZIONE DI SCIENZE<br />
La Sperimentazione di Scienze, già in atto da diversi anni nell'Istituto, prevede il potenziamento<br />
<strong>del</strong>le ore di questa disciplina che sono tre nella prima classe, quattro nella seconda, terza e quarta,<br />
tre nella quinta.<br />
OBIETTIVI GENERALI:<br />
conoscere la Natura, i suoi fenomeni e le leggi che governano il mondo vivente e non vivente<br />
prendere coscienza <strong>del</strong>la situazione <strong>del</strong> pianeta e <strong>del</strong> ruolo <strong>del</strong>l’uomo all’interno <strong>del</strong>la Natura<br />
acquisire una mentalità scientifica<br />
sviluppare la passione per lo studio <strong>del</strong>le Scienze <strong>del</strong>la Natura<br />
STRUMENTI :<br />
laboratori adeguatamente attrezzati con strumenti e apparecchiature scientifiche<br />
audiovisivi, biblioteca specifica<br />
uso <strong>del</strong> computer<br />
telescopio<br />
Caratterizzazione: l’attività sperimentale connota quest’indirizzo. L’insegnamento <strong>del</strong>le Scienze<br />
prevede, oltre all’insegnamento teorico, una frequente attività di Laboratorio, condotta sotto la<br />
guida degli insegnanti e degli assistenti. Con una serie di esperienze programmate, attraverso un<br />
percorso logico-deduttivo, i ragazzi verificano o ricavano, dal caso particolare, leggi e<br />
comportamenti più generali dei fenomeni naturali.<br />
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5a C<br />
COGNOME E NOME<br />
LUPERI LAURA<br />
CATANORCHI VIOLA<br />
MATERIA /h. settiman. FUNZIONE ALL’ESAME DI<br />
STATO<br />
RELIGIONE h.1<br />
ITALIANO/LATINO h.4+3 COMMISSARIO<br />
Fiorillo Veronica INGLESE h.4 COMMISSARIO<br />
SONETTI CATIA<br />
MALACARNE ENRICO<br />
Bolognesi Antonella<br />
Pieraccini Stefano<br />
STORIA/FILOSOFIA h.3+3 COMMISSARIO<br />
MATEMATICA/FISICA h.3+3<br />
SCIENZE h.3<br />
DISEGNO/ST. ARTE h.2<br />
3
Isolani Monica<br />
EDUCAZIONE FISICA h 2<br />
SEZ.1:ELENCO E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE<br />
ELENCO DEI CANDIDATI<br />
1 – ANGIOLI ENRICO<br />
2 – ATZENI ROBERTO<br />
3 – BARONTINI LEONARDO<br />
4 – CALACI ANNA RITA<br />
5 – CASSANO ALICE<br />
6 –DINI MICHELE<br />
7 –FERRETTI GIULIA<br />
8 –FORNASARI RICCARDO<br />
9 – FRACCARI ANDREA<br />
10 –FRANCESCHI ANNA<br />
11–GABRINI ALESSANDRA<br />
12–GORI MICHELE<br />
13–LOTTI NICCOLO’<br />
14–MAINARDI DANIELE<br />
<strong>15</strong>– MANEO GIULIA<br />
16– MARINAI SIMONE<br />
17– OROFINO JACOPO<br />
18 – PARLAGRECO ALESSANDRO<br />
19 – RISTORI MATTEO<br />
20 – SAMBALDI ANTONIO<br />
21 – SANTINI SIMONE<br />
4
22 – VALENTI PAOLO<br />
STORIA DELLA CLASSE<br />
La classe V M, formata attualmente da 22 studenti,e è il risultato di un lento assestamento legato<br />
a due elementi: da una parte un progressivo miglioramento dei rapporti interni e dall’altra un<br />
intervento selettivo <strong>del</strong> Consiglio di Classe nello scorso anno<br />
Durante questo anno scolastico i docenti hanno potuto constatare come il miglior clima interno<br />
abbia facilitato sia l’apprendimento sia l’espressione da parte degli alunni più fragili che nella<br />
situazione precedente non riuscivano ad emergere.<br />
Diverse materie non hanno avuto , nel triennio, la continuità didattica auspicabile per un buon<br />
apprendimento. Gli insegnanti di matematica e fisica, storia e filosofia, disegno e storia <strong>del</strong>l’arte<br />
sono cambiati in quarta ,mentre il docente di italiano e latino in questo anno.<br />
Una situazione particolare si è verificata per inglese in quanto il titolare ha lasciato la classe<br />
all’inizio <strong>del</strong>l’anno sostituito da una insegnante che ha rinunciato alla cattedra alla fine <strong>del</strong> primo<br />
periodo, l’insegnante attuale ha cominciato a lavorare con la classe solo da gennaio.<br />
PROFILO DELLA CLASSE<br />
Il clima nella classe, durante questo anno scolastico, ha permesso a ciascun insegnante di svolgere<br />
con serenità il programma prefissato.<br />
Gli alunni hanno mostrato un impegno e un interesse soddisfacenti verso tutte le discipline,<br />
adattandosi anche alle metodologie didattiche proposte loro dai nuovi docenti che si sono<br />
avvicendati.<br />
Nella classe si nota un gruppo di alunni dotati di buone capacità e seriamente impegnati nello<br />
studio che hanno raggiunto risultati molto buoni, migliorando progressivamente le proprie abilità<br />
e competenze, un secondo gruppo più numeroso a cui si possono ascrivere alunni generalmente<br />
volenterosi, che presentano qualche lacuna nella preparazione di base ma lavorano per colmarle,<br />
conseguendo nel complesso risultati positivi; infine un gruppo più ristretto di alunni che<br />
incontrano difficoltà nello studio di alcune discipline, nelle quali presentano lacune che non hanno<br />
colmato.<br />
5
SEZ .2: ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO DI CLASSE<br />
6
OBIETTIVI GENERALI MEDIAMENTE RAGGIUNTI DALLA CLASSE<br />
Nell’arco <strong>del</strong> triennio, la classe 5° M, in base al carattere essenzialmente formativo proprio<br />
<strong>del</strong>l’indirizzo di studi liceali frequentato, è stata orientata a perseguire i seguenti obiettivi generali,<br />
che a questa data possono ritenersi mediamente raggiunti:<br />
Approfondire, attraverso lo studio e la cultura, i valori fondamentali di una società libera e<br />
democratica (consapevolezza <strong>del</strong>le diversità come patrimonio cui attingere in modo aperto e<br />
disponibile);<br />
Acquisire capacità di relazione, attraverso lo star bene con gli altri e con se stessi (libera<br />
espressione <strong>del</strong>le proprie idee nel rispetto di quelle altrui; educazione alla parola e all’ascolto;<br />
rispetto <strong>del</strong>le regole <strong>del</strong>la socializzazione nei diversi spazi <strong>del</strong>le attività curricolari - aula, laboratori,<br />
palestra -; rispetto degli altri, di se stessi e <strong>del</strong>le cose);<br />
Acquisire una cultura aperta ed omogenea, alla quale concorrano tutte le discipline previste dal<br />
curricolo;<br />
Acquisire un’abitudine alla lettura critica personale, che vada oltre l’ambito <strong>del</strong> lavoro scolastico;<br />
Sviluppare capacità di riflessione e di critica, volte alla autonoma problematizzazione non solo<br />
degli argomenti di studio, ma anche <strong>del</strong>la realtà contemporanea;<br />
Acquisire un metodo di lavoro rigoroso e sistematico, che consenta di proseguire gli studi con<br />
strumenti adeguati e/o inserirsi proficuamente nel mondo <strong>del</strong> lavoro;<br />
Apprendere i linguaggi specifici <strong>del</strong>le singole discipline; sviluppare le abilità inerenti alle singole<br />
discipline; potenziare attitudini e interessi individuali;<br />
Acquisire conoscenze e competenze, che, unite alle capacità personali, promuovano la crescita<br />
<strong>del</strong>la persona.<br />
Obiettivi specifici mediamente raggiunti – Conoscenze – Metodi –Mezzi e<br />
Strumenti – Verifiche – Valutazione<br />
In merito alle voci in oggetto, la classe 5° M ha operato secondo le indicazioni che emergono in<br />
modo specifico dalla documentazione relativa alle singole discipline di seguito allegata (l’ordine<br />
segue la scansione tradizionalmente indicata nelle “pagelle” di valutazione). In sintesi, si tenga<br />
presente quanto segue:<br />
OBIETTIVI SPECIFICI COGNITIVI E FORMATIVI<br />
Per queste voci, si fa riferimento ai contenuti e alle indicazioni <strong>del</strong>la documentazione <strong>del</strong>le singole<br />
discipline di seguito riportata. Si ricorda che alcuni allievi <strong>del</strong>la classe 5a M, mossi da interessi e<br />
attitudini personali, hanno saputo elaborare, in modo autonomo, percorsi di tipo multidisciplinare<br />
(da ricondursi, va da sé, entro l’ambito <strong>del</strong>le loro competenze e capacità).<br />
Metodi<br />
La classe 5° M ha utilizzato complessivamente le seguenti metodologie:<br />
lezione frontale con interventi e dibattiti – lavori di gruppo – relazioni – ricerche – “problem<br />
solving” - visioni di filmati e diapositive - approfondimenti personali – analisi <strong>del</strong> testo - analisi<br />
7
degli aspetti di un problema e discussione –lettura <strong>del</strong>l ìimmagine- risoluzione di problemi -<br />
esercitazioni e prove pratiche – lavori in classe e lavori a casa –<br />
Si sottolinea che per tutte le discipline, per abituare gli studenti alla capacità di dialogo e<br />
all’efficacia <strong>del</strong>la sintesi, è stata privilegiata la discussione critica in classe, focalizzata su singoli<br />
contenuti o aperta a contesti di riferimento più ampio. In questo ambito gli allievi sono stati<br />
sollecitati anche a promuovere un difficile, ma proficuo processo di autovalutazione.<br />
Mezzi e Strumenti<br />
La classe 5° M ha impiegato essenzialmente i seguenti mezzi e strumenti:<br />
libri di testo, di lettura e consultazione – uso <strong>del</strong> dizionario - uso dei laboratori [lingue, scienze,<br />
fisica, informatica] – sussidi audiovisivi – materiale su supporto magnetico – siti Internet – Idei di<br />
recupero e di approfondimento – partecipazione volontaria a: conferenze, seminari e corsi<br />
d’approfondimento organizzati dalla scuola o da enti esterni – progetti di classe e di fascia-classi -<br />
visite guidate a musei, mostre, località – studio <strong>del</strong>l’ambiente – attività sportiva – attività di<br />
orientamento.<br />
VERIFICHE<br />
La classe 5° M ha adottato essenzialmente i seguenti tipi di verifica:<br />
temi argomentativi di carattere letterario, storico e di attualità – scritti di produzione propria –<br />
riassunti – brevi commenti a un testo dato – analisi <strong>del</strong> testo letterario (di prosa e di poesia) –<br />
traduzione e commento di testi in latino - analisi e commento di testi in lingua inglese - questionari<br />
– esercizi – problemi –lettura ed analisi di opere artistiche singole o poste in confronto-<br />
esercitazioni pratiche – test motori - esposizione orale dei contenuti appresi – colloqui individuali e<br />
colloqui che hanno visto coinvolta l’intera classe – relazioni -rielaborazione personale e<br />
collegamento di concetti e dati.<br />
Per quanto attiene in particolare ai questionari, la classe 5° M si è <strong>maggio</strong>rmente esercitata nei<br />
questionari a trattazione sintetica di argomenti, secondo indicazioni che ne hanno precisato<br />
estensione <strong>del</strong>la risposta (di media min.6 – max. 20 righe o numero di parole precisato) e tempo di<br />
esecuzione (di preferenza 2 - 3 ore). Talvolta, ma non per tutte le discipline, sono stati<br />
somministrati anche questionari a risposta singola e test a risposta multipla, verso i quali la classe<br />
5° M non ha potuto pertanto conseguire abilità e competenze adeguate.<br />
Nella sezione allegati è accluso il testo di simulazione <strong>del</strong>la 3a prova somministrato alla classe<br />
durante il mese di <strong>maggio</strong>. Sono altresì accluse le griglie di valutazione utilizzate per le prove<br />
scritte disciplinari (prova d’italiano e prova di matematica) e multidisciplinari (simulazione 3a<br />
prova) <strong>del</strong>la classe.<br />
VALUTAZIONE<br />
Accanto a verifiche di tipo sommativo (di norma 3/4 per quadrimestre per ogni disciplina, tra<br />
prove orali e prove scritte), la classe 5° M ha adottato in modo privilegiato verifiche di tipo<br />
formativo, che hanno permesso di valutare in itinere ogni progresso interno all’itinerario didattico,<br />
in riferimento al livello di partenza di ogni singolo allievo. In tal modo ciascun alunno è stato<br />
valutato nel suo percorso formativo- educativo, in relazione alle sue specifiche conoscenze,<br />
competenze e capacità, anche parzialmente evidenziate.<br />
8
Per la classificazione degli obiettivi e dei livelli, cui il consiglio di classe ha fatto riferimento per<br />
l’espressione <strong>del</strong>la valutazione in numeri decimali, si ritengono fondamentali i seguenti criteri di<br />
valutazione:<br />
pertinenza a quanto richiesto.<br />
conoscenza dei contenuti.<br />
correttezza e chiarezza espositiva.<br />
padronanza dei linguaggi specifici, propri di ciascuna disciplina.<br />
capacità di analisi e di sintesi.<br />
capacità di collegamento e di rielaborazione personale.<br />
eventuale capacità di collegamenti pluridisciplinari e/o apporti personali.<br />
Per la definizione <strong>del</strong> voto, l’alunno ha visto privilegiato il patrimonio di conoscenze da lui<br />
posseduto, unito alla qualità <strong>del</strong>le competenze acquisite, inserite in un quadro di impegno,<br />
partecipazione e progresso rispetto ai livelli di partenza, e <strong>del</strong>le capacità personali evidenziate nel<br />
curricolo.<br />
ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO<br />
Durante il corso <strong>del</strong>l’anno sono stati attivati corsi integrativi e sportelli (recupero, sostegno e/o<br />
approfondimento) per le discipline di inglese, scienze, matematica, fisica,storia e filosofia.<br />
Sono state inoltre promosse dalla scuola attività e incontri di orientamento universitario.<br />
ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI<br />
- Visita al Salone <strong>del</strong>l’Orientamento <strong>del</strong>l’Università di Pisa<br />
- Visita guidata al Planetario di Livorno<br />
- Partecipazione alle Olimpiadi <strong>del</strong>la Matematica, alle gare interne di Fisica e Kangarou.<br />
-Cacciuccata matematica<br />
- Visita al Sacrario <strong>del</strong>le vittime di S. Anna di Stazzema ( Progetto 25 Aprile)<br />
-Gruppo sportivo<br />
9
SEZ. 3 : AMBITI DISCIPLINARI<br />
10
ITALIANO<br />
Docente : Catanorchi Viola<br />
Conoscenze<br />
Per le conoscenze si fa riferimento al programma allegato.<br />
Competenze<br />
0 Esprimersi in modo chiaro e corretto ed usare un registro linguistico adeguato al tipo di<br />
comunicazione,sia allo scritto che all’orale.<br />
1 Saper produrre testi scritti di varie tipologie (espositivo, argomentativo, di analisi).<br />
2 Saper riconoscere gli aspetti formali <strong>del</strong> testo: registri linguistici, figure retoriche,tecniche narrative,<br />
scelte linguistiche.<br />
3 Saper analizzare la struttura di un testo e individuarne le tematiche.<br />
4 Saper inquadrare un testo nel suo contesto storico-letterario.<br />
5 Saper confrontare testi di uno stesso autore o di autori diversi.<br />
6 Saper formulare riflessioni e giudizi autonomi sui testi proposti.<br />
Metodi<br />
• Lezione frontale<br />
• Analisi di testi con la partecipazione attiva dei ragazzi<br />
• Discussione in classe degli elaborati<br />
• Discussione di approfondimento su argomenti di letteratura e di attualità<br />
• Libri di testo<br />
• Libri di narrativa<br />
• Letture critiche<br />
• Fotocopie<br />
• Appunti <strong>del</strong>le lezioni<br />
• Dizionari<br />
• Audiovisivi<br />
0 Elaborati di analisi <strong>del</strong> testo<br />
1 Saggi brevi<br />
2 Temi di attualità<br />
3 Questionari a trattazione sintetica<br />
4 Verifiche orali<br />
Mezzi e strumenti<br />
Verifiche<br />
Criteri di valutazione<br />
Nelle prove scritte si è tenuto conto dei seguenti indicatori:<br />
1.Conoscenza <strong>del</strong>l’argomento<br />
2.Organizzazione e coerenza <strong>del</strong>l’elaborato /competenza degli strumenti d’analisi<br />
3.Correttezza formale<br />
4.Apporti critici personali<br />
Per la corrispondenza fra gli indicatori, il punteggio assegnato e il voto finale , v. griglia in allegato.<br />
11
Per le verifiche orali la valutazione ha tenuto conto <strong>del</strong>le conoscenze, <strong>del</strong>la capacità di sintesi, di analisi e di<br />
collegamento tra gli argomenti, <strong>del</strong> modo di esprimersi.<br />
Programma di Italiano<br />
Testi in adozione:<br />
Luperini-Cataldi, La scrittura e l’interpretazione, Palumbo editore, 2005, edizione rossa, volume II<br />
(3° tomo) volume III in 3 tomi.<br />
Il Romanticismo<br />
Definizione e caratteri <strong>del</strong> Romanticismo; l'immaginario romantico; temi e caratteri <strong>del</strong><br />
Romanticismo italiano; la battaglia fra "classici" e romantici in Italia<br />
Giacomo Leopardi<br />
La vita; il sistema filosofico; la poetica <strong>del</strong> vago e indefinito; la teoria <strong>del</strong> piacere; il rapporto con il<br />
Romanticismo;gli idilli; le "Operette morali"; i canti pisano-recanatesi; la terza fase <strong>del</strong>la poesia<br />
leopardiana; il messaggio conclusivo <strong>del</strong>la "Ginestra"<br />
Testi analizzati<br />
dallo Zibaldone La teoria <strong>del</strong> piacere<br />
La poetica <strong>del</strong>la rimembranza<br />
dalle Operette morali Dialogo <strong>del</strong>la Natura e di un Islandese<br />
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere<br />
Dialogo di un folletto e di uno gnomo<br />
dai Canti L'infinito<br />
La sera <strong>del</strong> dì di festa<br />
A Silvia<br />
Il sabato <strong>del</strong> villaggio<br />
Canto notturno di un pastore errante <strong>del</strong>l'Asia<br />
A se stesso<br />
La ginestra (1-<strong>15</strong>7, 297-317)<br />
Il romanzo <strong>del</strong>l'Ottocento<br />
Caratteri e diffusione <strong>del</strong> genere romanzesco in Europa; ritardo e difficoltà <strong>del</strong>la sua affermazione nel<br />
nostro paese; il romanzo storico: la sua definizione, le sue caratteristiche, la sua storia<br />
Alessandro Manzoni<br />
La vita e le opere; gli scritti di poetica; la genesi dei Promessi sposi e le fasi <strong>del</strong>la sua elaborazione; il<br />
tempo <strong>del</strong>la storia e quello <strong>del</strong> racconto; il sistema dei personaggi; il narratore; l'ideologia religiosa<br />
Testi analizzati<br />
dagli scritti di poetica La lettera a Chauvet<br />
La lettera al d'Azeglio<br />
dai Promessi sposi Don Abbondio e i bravi<br />
Padre Cristoforo e il fratello <strong>del</strong>l'ucciso<br />
La conclusione <strong>del</strong> romanzo<br />
12
Il Naturalismo<br />
Poetiche e contenuti; i fondamenti teorici; caratteri generali <strong>del</strong> Positivismo; il determinismo; i<br />
mo<strong>del</strong>li letterari: il romanzo realista di Flaubert; la tecnica <strong>del</strong>l'impersonalità; l'atteggiamento<br />
ideologico progressista<br />
Testi analizzati Emile Zola: La prefazione ai "Rougon Macquart"<br />
Lo scrittore come operaio <strong>del</strong> progresso<br />
sociale<br />
Il verismo italiano<br />
Poetiche e contenuti; il rapporto con il naturalismo francese<br />
Giovanni Verga<br />
La vita e le opere; la poetica e la tecnica narrativa; la regressione; lo straniamento; l'ideologia<br />
verghiana; il ciclo dei Vinti; I Malavoglia: il titolo e la composizione; il tempo <strong>del</strong>la storia, la struttura e<br />
la vicenda; il sistema dei personaggi; la lingua, lo stile, il punto di vista; il motivo <strong>del</strong>l'esclusione e<br />
quello <strong>del</strong>la rinuncia; Mastro-don Gesualdo<br />
Testi analizzati<br />
dagli scritti di poetica Dedicatoria a Salvatore Farina<br />
Lettera a Salvatore Paolo Verdura<br />
La prefazione a "Eva"<br />
da "Vita dei campi" Rosso Malpelo<br />
La lupa<br />
da "Novelle rusticane" La roba<br />
Libertà<br />
Lettura integrale dei Malavoglia<br />
Testi analizzati La prefazione<br />
Mena, compare Alfio e le stelle che ammiccavano forti<br />
L'inizio dei Malavoglia<br />
La tempesta sui tetti <strong>del</strong> paese<br />
Un esempio di sintassi<br />
L'addio di 'Ntoni<br />
da Mastro-don Gesualdo Il pesco non s'innesta all'ulivo<br />
La Scapigliatura<br />
Caratteri generali<br />
Il decadentismo<br />
L'origine <strong>del</strong> termine; la poetica; la visione <strong>del</strong> mondo; la figura <strong>del</strong>l'artista: la perdita <strong>del</strong>l'aureola; il<br />
poeta veggente; il simbolismo; l'analogia e la sinestesia<br />
Testi analizzati<br />
C. Bau<strong>del</strong>aire Corrispondenze<br />
13
L'albatro<br />
Giovanni Pascoli<br />
Vita e opere; l'ideologia politica; la poetica <strong>del</strong> Fanciullino; i temi di Myricae e Canti di Castelvecchio; il<br />
simbolismo impressionistico; le soluzioni formali;<br />
Testi analizzati X agosto,<br />
Lavandare<br />
Temporale<br />
L'assiuolo<br />
Novembre<br />
Il Gelsomino notturno<br />
Il fanciullino<br />
La grande proletaria si è mossa<br />
Gabriele D’Annunzio<br />
Vita e opere; l'estetismo; il superomismo; il panismo; Il piacere: caratteri generali<br />
Testa anlizzati<br />
Da Alcyone: La sera fiesolana<br />
La pioggia nel pineto<br />
Da Il Piacere Andrea Sperelli<br />
La conclusione <strong>del</strong> romanzo<br />
Il romanzo <strong>del</strong> Novecento<br />
Le scienze fisiche, psicologiche, le tendenze filosofiche <strong>del</strong> Novecento; la dissoluzione <strong>del</strong>le forme<br />
tradizionali, la creazione di una nuova struttura narrativa, l'elaborazione di nuovi temi<br />
Italo Svevo<br />
La vita; la cultura e la poetica; caratteri dei romanzi sveviani; vicenda temi e soluzioni formali; i primi<br />
romanzi: Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno come opera aperta; la vicenda; la psicoanalisi;<br />
principio di piacere e principio di realtà; l'io narrante e l'io narrato; il tempo narrativo; l'inattendibilità<br />
di Zeno narratore; il concetto di malattia e di salute; il significato <strong>del</strong>la conclusione <strong>del</strong> romanzo<br />
Lettura integrale de La Coscienza di Zeno<br />
Testi analizzati<br />
da Una vita Le ali <strong>del</strong> gabbiano<br />
da Senilita L'inizio <strong>del</strong> romanzo<br />
L'ultimo appuntamento con Angiolina<br />
da La coscienza La morte <strong>del</strong> padre<br />
Il matrimonio di Zeno<br />
Zeno e il suo antagonista<br />
La vita è una malattia<br />
Le avanguardie <strong>del</strong> primo Novecento<br />
Caratteristiche generali<br />
14
I Crepuscolari<br />
La definizione; contenuti e forme; la figura <strong>del</strong> poeta; la "vergogna" <strong>del</strong>la poesia; l'atteggiamento<br />
ironico di Gozzano; la poetica <strong>del</strong>lo choc e <strong>del</strong>lo straniamento<br />
Testi analizzati Guido Gozzano La Signorina Felicita<br />
Il Futurismo<br />
I manifesti di Marinetti e la storia <strong>del</strong> movimento<br />
Testi analizzati Il Manifesto <strong>del</strong> Futurismo<br />
Manifesto tecnico <strong>del</strong>la letteratura futurista<br />
Luigi Piran<strong>del</strong>lo<br />
La vita e le opere; la visione <strong>del</strong> mondo e la poetica; il relativismo filosofico e la poetica<br />
<strong>del</strong>l'umorismo; la "forma" e la "vita"; la vicenda, i personaggi, i temi principali e l'ideologia <strong>del</strong> Fu<br />
Mattia Pascal; caratteristiche generali <strong>del</strong> teatro di Piran<strong>del</strong>lo<br />
Testi analizzati La forma e la vita<br />
La differenza fra umorismo e comicità<br />
da Novelle per un anno Il treno ha fischiato<br />
da Il fu Mattia Pascal Lo strappo nel cielo di carta<br />
L'ultima pagina <strong>del</strong> romanzo<br />
Lettura integrale di Così è (se vi pare)<br />
Giuseppe Ungaretti<br />
La vita; la formazione; la poetica; "L'Allegria": i temi, il titolo, il valore <strong>del</strong>la parola, lo stile e la metrica<br />
Testi analizzati da L'Allegria Allegria di naufragi<br />
Veglia<br />
I fiumi,<br />
San Martino <strong>del</strong> Carso,<br />
Soldati<br />
Mattina<br />
Il porto sepolto<br />
Commiato<br />
L’Ermetismo<br />
I caratteri <strong>del</strong>l’Ermetismo<br />
Umberto Saba<br />
La vita, la formazione, la poetica; Il canzoniere;<br />
Testi analizzati Città vecchia<br />
Trieste<br />
La capra<br />
Ulisse<br />
<strong>15</strong>
Eugenio Montale<br />
La vita e le opere; le varie fasi <strong>del</strong>la produzione poetica; la poetica; il correlativo oggettivo; la figura<br />
femminile; Ossi di seppia<br />
Testi analizzati Da Ossi di seppia Meriggiare pallido e assorto<br />
Non chiederci la parola<br />
Spesso il male di vivere ho incontrato<br />
Felicità raggiunta<br />
Da Le occasioni La casa dei doganieri<br />
Lettura e contestualizzazione di tre romanzi <strong>del</strong>la seconda metà <strong>del</strong> Novecento<br />
Beppe Fenoglio Una questione privata<br />
Giuseppe Tomasi di Lampedusa Il Gattopardo<br />
Italo Calvino Il barone rampante<br />
16
Per le conoscenze si rimanda al programma allegato.<br />
LATINO<br />
DOCENTE: CATANORCHI VIOLA<br />
Conoscenze<br />
Competenze<br />
0 Saper individuare la struttura <strong>del</strong> periodo, suddividendolo in proposizioni e facendo la costruzione<br />
dei singoli enunciati.<br />
1 Saper commentare un testo e inquadrarlo nel contesto storico-letterario.<br />
2 Saper riconoscere le peculiarità di alcuni generi letterari e le loro caratteristiche evolutive.<br />
3 Saper riconoscere le più importanti figure retoriche e i diversi registri linguistici<br />
4 Saper riconoscere le caratteristiche stilistiche degli autori studiati.<br />
Metodi<br />
• Lezione frontale<br />
• Lettura di testi di autore in lingua originale ,con analisi <strong>del</strong> testo e traduzione.<br />
• Lettura di testi di autore in italiano con osservazione su testo latino a fronte.<br />
• Lettura di testi direttamente in italiano.<br />
Libri di testo, fotocopie, dizionario.<br />
Mezzi e strumenti<br />
Verifiche<br />
Analisi e contestualizzazione di testi noti di autori oggetto di studio, questionari di Storia <strong>del</strong>la Letteratura<br />
Verifiche orali.<br />
Criteri di valutazione<br />
Gli elaborati sono stati valutati in base alla tipologia e alle abilità richieste di volta in volta.<br />
17
Testi in adozione:<br />
Pagliani-Alosi, Alla scoperta dei classici, Petrini<br />
Programma di Latino<br />
Lucrezio<br />
La vita ; il De rerum natura: impianto generale; temi poetici e contenuti dottrinali; l'epicureismo e<br />
la figura di Epicuro; Dei e religio; i principi fondamentali <strong>del</strong>la fisica; lo stile;<br />
Dal De rerum natura L’inno a Venere<br />
Il trionfo di Epicuro<br />
Il proemio <strong>del</strong> secondo libro (in traduzione)<br />
La "madre" natura<br />
Cicerone<br />
Vita e opere; l'epistolario; le orazioni; le opere sull'oratoria; il pensiero politico; il pensiero<br />
filosofico; il Somnium Scipionis; lo stile<br />
Testi analizzati De natura deorum II, 62<br />
De legibus II, <strong>15</strong> (in traduzione)<br />
Tusculanae disputationes I, 47 (in traduzione)<br />
Dal Somnium Chi si prodiga per la patria otterrà la vita eterna<br />
Compare a Scipione l’ombra <strong>del</strong> padre Emilio Paolo<br />
La missione <strong>del</strong>l’uomo sulla terra<br />
La visione <strong>del</strong>la terra dalla Via Lattea<br />
Seneca<br />
La vita e le opere; i rapporti di Seneca con il potere; il pensiero filosofico; la figura <strong>del</strong> sapiente; il<br />
concetto di deus internus; il tema <strong>del</strong> tempo; il tema <strong>del</strong>l'otium; ,lo stile<br />
Testi analizzati Deus intus est (in traduzione)<br />
False lamentele (De brev. I, 1-3)<br />
Epistulae ad Lucilium 1<br />
L'impegno civile <strong>del</strong> sapiente ( De otio 3, 2-5; 4, 1-<br />
2; 6, 4-5)<br />
Tacito<br />
Vita e opere; fonti, mo<strong>del</strong>li, tecniche <strong>del</strong>lo storiografo; la riflessione sul principato; lo stile<br />
Testi analizzati Dagli Annales Il ritratto di Petronio (in traduzione)<br />
La seduttrice<br />
Le arti subdole di Poppea<br />
18
La scelta <strong>del</strong> piano <strong>del</strong>ittuoso<br />
Un <strong>del</strong>itto imperfetto<br />
Nerone salvato da un liberto<br />
La tragedia si conclude<br />
Petronio<br />
Il mistero <strong>del</strong> Satyricon e il problema <strong>del</strong>l'identificazione <strong>del</strong>l'autore; i mo<strong>del</strong>li e la tecnica narrativa<br />
<strong>del</strong> romanzo; i protagonisti e la vicenda; il mondo <strong>del</strong> Satyricon; la lingua<br />
Testi analizzati Il discorso di Ermerote<br />
Una brutta figura di Encolpio<br />
La tomba di Trimalcione<br />
La novella <strong>del</strong>la matrona di Efeso (in traduzione)<br />
19
LINGUA E LETTERATURA INGLESE<br />
Docente:Fiorillo Veronica<br />
Finalità<br />
• Favorire il processo di acquisizione <strong>del</strong>la competenza comunicativa <strong>del</strong>la lingua in situazioni reali<br />
utilizzando il lessico e le strutture morfo-sintattiche in modo adeguato.<br />
• Contribuire allo sviluppo <strong>del</strong>le facoltà espressive, logiche e critiche.<br />
Obiettivi<br />
Al termine degli studi gli studenti dovranno aver acquisito le seguenti competenze comunicativo-relazionali:<br />
• Comprendere e produrre messaggi orali legati al contesto e alla situazione comunicativa.<br />
• Produrre messaggi orali di tipo descrittivo- narrativo<br />
• Comprendere e rispondere per scritto a quesiti formulati su brevi testi attinenti all’indirizzo di<br />
studio<br />
• Comprendere e analizzare testi letterari dei vari generi<br />
Metodologia didattica<br />
Il lavoro è stato indirizzato principalmente a fornire agli studenti gli strumenti necessari per giungere ad<br />
una comprensione ed analisi di testi di attualità e letterari, per questi ultimi prescindendo dallo studio<br />
sistematico e cronologico <strong>del</strong>la letteratura.<br />
Nell’ambito dei testi letterari esaminati in classe gli studenti possiedono le seguenti competenze:<br />
• comprendere il testo e riformularlo<br />
• riconoscere le tematiche fondamentali<br />
• analizzare il testo avvalendosi degli strumenti specifici<br />
L’approccio ai testi letterari è avvenuto tramite l’utilizzo di questionari che hanno permesso di analizzare:<br />
• i personaggi<br />
• il narratore e il punto di vista<br />
• l’ambiente spaziale e temporale<br />
• il linguaggio<br />
• i temi<br />
20
Strumenti di verifica<br />
La verifica <strong>del</strong>la competenza orale è avvenuta attraverso colloqui o conversazioni in classe il cui scopo era<br />
quello di accertare la competenza comunicativa e la conoscenza dei contenuti relativi ai testi letterari<br />
proposti<br />
Le prove scritte sono state proposte in modo da verificare le capacità di comprensione di un testo autentico<br />
(pubblicazioni e articoli di giornali) e la capacità di rielaborarne i contenuti<br />
Criteri di valutazione<br />
I parametri di valutazione <strong>del</strong>le prove orali sono stati soprattutto la capacità di comprensione, la<br />
conoscenza dei contenuti e l’efficacia comunicativa.<br />
Nella valutazione <strong>del</strong>le prove scritte, si è privilegiato la verifica <strong>del</strong>la comprensione <strong>del</strong> testo piuttosto che<br />
l’accertamento <strong>del</strong>la correttezza morfo-sintattica. La classificazione è avvenuta in base ad un punteggio<br />
precedentemente stabilito.<br />
Sia allo scritto che all’orale, la metodologia invalsa nella scuola, che prevede un approccio di tipo<br />
comunicativo all’insegnamento <strong>del</strong>la lingua straniera, ha naturalmente comportato una tolleranza verso<br />
inesattezze di carattere morfo-sintattico ed ha consentito l’attribuzione <strong>del</strong> punteggio massimo anche in<br />
presenza di errori che non interferiscono con il passaggio <strong>del</strong>la comunicazione.<br />
Tempi <strong>del</strong> percorso didattico<br />
Seguendo le linee programmatiche e le indicazioni metodologiche concordate in sede di coordinamento<br />
disciplinare, i testi letterari sono stati affrontati con una scansione media di due settimane.<br />
Contemporaneamente sono stati presentati documenti autentici tratti soprattutto da quotidiani e riviste<br />
relative ai temi specifici <strong>del</strong>l’ indirizzo.<br />
L’ultima parte <strong>del</strong>l’anno è stata dedicata al ripasso, alla preparazione <strong>del</strong>la prova orale, <strong>del</strong>la terza prova e a<br />
eventuali approfondimenti.<br />
21
Da Opportunities:<br />
Traveller’s Tale<br />
The Ballad of Jesse James<br />
Fear of Flying<br />
Getting around Britain<br />
Australia<br />
The Third Man<br />
Da Lit & Lab:<br />
PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE<br />
Women<br />
Tess of the D’ Urbervilles, Alec and Tess, T. Hardy<br />
To the Lighthouse, Mrs, Ramsay, V. Woolf<br />
Mrs. Dalloway, Clarissa and Septimus, V. Woolf<br />
Dubliners, Eveline - the Dead: she was fast Asleep, J. Joyce<br />
Ulysses, Molly’s monologue, J. Joyce<br />
The Hours, 2002, S. Daldry, novel by M. Cunningham<br />
Utopian/dystopian novels<br />
1984, The big brother is watching you, G. Orwell<br />
The Lord of the Flies, W. Golding<br />
The Brave New World, A. Huxley<br />
War<br />
War poets:<br />
The Soldier, R. Brooke<br />
Dulce et Decorum est, W. Owen<br />
Futility, W. Owen<br />
A letter from the Trenches,W. Owen<br />
Refugee Blues, W.H. Auden<br />
The Vignette, E. Hemingway<br />
Nagasaki, A. C. Mathews<br />
Thermonuclear War: the Death Wish of Mankind, B. Russel<br />
No Man’s Land, D. Danovic, 2001<br />
Before September Ends, Greenday<br />
Masters of Wars, Bob Dylan<br />
Theatre<br />
The Theatre of the Absurd: Waiting for Godot, S. Beckett<br />
The Theatre of Anger: Look back in Anger, J. Osborne<br />
The voyage<br />
Heart of darkness, J. Conrad<br />
22
On the road, Route 66, J. Kerouac<br />
Apocalypse now, F. F. Coppola, 1979<br />
Easy Rider, D. Hopper, 1969<br />
The double<br />
Frankenstein, M. Shelley<br />
The convergence of the twain, W. H. Auden<br />
The picture of Dorian Gray, I would give my soul, Dorian’s death, O. Wilde<br />
LIBRI DI TESTO : Opportunities, Harris, Mower, Sikorzynska, Longman<br />
Lit & Lab, Spiazzi-Tavella, Zanichelli<br />
23
1. Vedi programma<br />
MATEMATICA<br />
Docente: Malacarne Enrico<br />
Conoscenze<br />
Competenze<br />
1. Esaminare e correlare le conoscenze e i dati<br />
2. Costruire un algoritmo risolutivo<br />
3. Usare un linguaggio specifico adeguato alla disciplina in oggetto<br />
1. Soluzione di semplici problemi<br />
2. Rispondere a quesiti orali e scritti<br />
Capacità<br />
Metodi<br />
1. Lezione frontale<br />
2. Analisi degli aspetti di un problema teorico ed eventuale rappresentazione grafica<br />
3. Discussione in classe degli argomenti trattati<br />
1. Libro di testo<br />
2. Appunti preparati dal docente<br />
Mezzi e strumenti<br />
Verifiche<br />
1. Soluzione di semplici problemi<br />
2. Questionari<br />
3. Esposizione orale dei contenuti acquisiti<br />
4. Colloqui individuali e colloqui in cui viene coinvolta l’intera classe<br />
5. Rielaborazione e collegamento dei contenuti <strong>del</strong> programma<br />
Valutazione<br />
I criteri di valutazione hanno teso ad evidenziare le conoscenze, le competenze e le capacità di ciascun<br />
alunno sia in assoluto sia in relazione al progresso compiuto, all’interno <strong>del</strong>l’itinerario didattico, rispetto al<br />
livello di partenza. Gli elementi essenziali che hanno contribuito alla valutazione globale sono:<br />
1. Capacità di analisi e di sintesi<br />
2. Correttezza nell’esposizione e nel calcolo<br />
3. Uso appropriato <strong>del</strong> linguaggio specifico <strong>del</strong>la disciplina<br />
4. Capacità di rielaborazione personale<br />
24
PROGRAMMA MATEMATICA<br />
Calcolo combinatorio: disposizioni semplici o con ripetizione, permutazioni semplici<br />
o con ripetizione, combinazioni semplici, coefficienti binomiali, formula <strong>del</strong> binomio<br />
di Newton, formula di Stifel (con dimostrazione), principio di induzione.<br />
Elementi di topologia <strong>del</strong>la retta reale, funzioni: dominio, proprietà, grafico, funzioni<br />
composte.<br />
Il limite di una funzione, verifica di un limite, teoremi sui limiti: unicità <strong>del</strong> limite<br />
(con dimostrazione), permanenza <strong>del</strong> segno (con dimostrazione), teorema <strong>del</strong> confronto<br />
o dei carabinieri (con dimostrazione).<br />
Funzioni continue, calcolo dei limiti, operazioni sui limiti, limite <strong>del</strong>la somma di due<br />
funzioni (con dimostrazione), forme indeterminate, limiti notevoli; infiniti, infinitesimi<br />
e loro confronto; asintoti verticali, orizzontali, obliqui.<br />
Derivata di una funzione, derivate fondamentali, teoremi sul calcolo <strong>del</strong>le derivate,<br />
derivata <strong>del</strong>la somma di due funzioni (con dimostrazione), derivata <strong>del</strong>la funzione inversa<br />
(con dimostrazione), retta tangente al grafico di una funzione.<br />
Teoremi <strong>del</strong> calcolo differenziale, teorema di Rolle (con dimostrazione), teorema di<br />
Lagrange o <strong>del</strong> valor medio (con dimostrazione), teorema di Cauchy, regola di De<br />
L’Hospital.<br />
Massimi, minimi, flessi, convessità, concavità.<br />
Studio di una funzione e relativo grafico.<br />
Integrale indefinito, calcolo di integrali, integrazione per sostituzione, integrazione<br />
per parti.<br />
Integrale definito, teorema <strong>del</strong>la media (con dimostrazione), funzione integrale, teorema<br />
fondamentale <strong>del</strong> calcolo integrale, calcolo dei volumi dei solidi di rotazione,<br />
risoluzione di problemi vari.<br />
Testo adottato: Bergamini, Trifone, Barozzi, Corso base blu di matematica,<br />
Volume 5, Ed. Zanichelli<br />
25
Conoscenze<br />
2. Vedi programma<br />
Competenze<br />
FISICA<br />
Docente: Malacarne Enrico<br />
Obiettivi raggiunti<br />
4. Esaminare e correlare le conoscenze e le informazioni<br />
5. Analizzare ed interpretare un fenomeno fisico nella sua globalità e nel contesto specifico<br />
6. Usare un linguaggio specifico adeguato alla disciplina in oggetto<br />
Capacità<br />
3. Soluzione di semplici problemi<br />
4. Rispondere a quesiti orali e scritti<br />
Metodi<br />
4. Lezione frontale<br />
5. Analisi degli aspetti di un problema teorico o affrontato in laboratorio<br />
6. Discussione in classe degli argomenti trattati<br />
3. Libro di testo<br />
4. Appunti preparati dal docente<br />
5. Uso <strong>del</strong> laboratorio<br />
Mezzi e strumenti<br />
Verifiche<br />
6. Soluzione di semplici problemi (prevalentemente nel periodo ottobre-marzo)<br />
7. Questionari<br />
8. Esposizione orale dei contenuti acquisiti<br />
9. Colloqui individuali e colloqui in cui viene coinvolta l’intera classe<br />
10. Rielaborazione e collegamento dei contenuti <strong>del</strong> programma<br />
Valutazione<br />
I criteri di valutazione hanno teso ad evidenziare le conoscenze, le competenze e le capacità di ciascun<br />
alunno sia in assoluto sia in relazione al progresso compiuto, all’interno <strong>del</strong>l’itinerario didattico, rispetto al<br />
livello di partenza. Gli elementi essenziali che hanno contribuito alla valutazione globale sono:<br />
5. Capacità di analisi e di sintesi<br />
6. Correttezza nell’esposizione e nel calcolo<br />
7. Uso appropriato <strong>del</strong> linguaggio specifico <strong>del</strong>la disciplina<br />
8. Capacità di rielaborazione personale.<br />
26
PROGRAMMA DI FISICA<br />
Forze elettriche e campi elettrici. Legge di Coulomb, campo elettrico, legge di Gauss,<br />
campi elettrici per alcune distribuzioni di cariche.<br />
Potenziale elettrico. Energia potenziale elettrica, differenza di potenziale, condensatori,<br />
dielettrici, condensatori in serie o in parallelo.<br />
Circuiti in corrente continua. Corrente elettrica, prima e seconda legge di Ohm, potenza<br />
e effetto Joule, principi di Kirchhoff per i nodi e per le maglie, resistori in serie<br />
o in parallelo.<br />
Magnetismo. Campo magnetico, campo magnetico generato da una corrente elettrica,<br />
forza agente su una corrente immersa in un campo magnetico, forza di Lorentz, moto<br />
di una carica in un campo magnetico, selettore di velocità, spettrometro di massa, ciclotrone,<br />
effetto Hall, forze tra correnti parallele, spira circolare, solenoide, momento<br />
magnetico di una spira o di una bobina.<br />
Induzione elettromagnetica. Forza elettromotrice (f.e.m.) indotta, flusso <strong>del</strong> campo<br />
magnetico, legge di Faraday-Neumann-Lenz, mutua induzione, autoinduzione, circuiti<br />
RL, f.e.m. di movimento, generatori di corrente alternata, motori elettrici, trasformatori.<br />
Cenni sulle Equazioni di Maxwell.<br />
Laboratorio: esperienze qualitative di elettrostatica, legge di Coulomb, condensatori,<br />
multimetro e circuiti elettrici, differenza di potenziale mediante calorimetro, prima<br />
legge di Ohm (conduttori ohmici e non ohmici), scarica di un condensatore, forza su<br />
un conduttore percorso da corrente, solenoidi, determinazione di e/m con gli anelli o<br />
bobine di Helmholtz, f.e.m. indotta, trasformatori.<br />
Testo adottato: Bueche, Jerde, Bonzini, Corso di fisica, Volume 3, Ed. ETAS<br />
27
STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA<br />
Docente: Sonetti Catia<br />
Obiettivi raggiunti<br />
Conoscenze<br />
Gli alunni hanno acquisito la conoscenza degli aspetti fondamentali dei processi storici elencati alla voce<br />
"Contenuti".<br />
Competenze e capacità<br />
saper esporre i dati appresi<br />
saper descrivere le linee generali di sviluppo dei processi storici<br />
saper analizzare le cause e le conseguenze di processi ed episodi storici studiati<br />
saper descrivere e confrontare istituzioni, tendenze e processi storici<br />
saper definire concetti storiografici<br />
saper analizzare e valutare criticamente tesi storiografiche<br />
saper utilizzare il linguaggio specifico <strong>del</strong>la disciplina<br />
Strumenti<br />
Gli strumenti utilizzati sono stati:<br />
a) i libri di testo adottati: R.Marchese “Piani e percorsi <strong>del</strong>la storia” vol.3 Minerva Italica;<br />
R. Amato “Leggere la Costituzione” Simone<br />
b) materiali integrativi fotocopiati<br />
c) lettura integrale di un testo a scelta tra due proposti (vedi modulo)<br />
d) visione filmati<br />
Metodi<br />
Il lavoro didattico è stato suddiviso in moduli, ognuno dei quali articolato in lezioni frontali, risposte alle<br />
domande di chiarimento, discussioni guidate, letture di approfondimento, verifiche formative ed una<br />
verifica sommativa finale (orale o scritta).<br />
Modalità di verifica e criteri di valutazione<br />
Le verifiche sono servite ad accertare l'apprendimento <strong>del</strong>le conoscenze e il conseguimento <strong>del</strong>le<br />
competenze prima elencate, anche in vista di eventuali modifiche al percorso preventivato.<br />
Le verifiche sono avvenute mediante interrogazioni orali e prove scritte di diverso genere (semistrutturate,<br />
quesiti a risposta singola, trattazioni brevi).<br />
E’ stata inoltre proposta ,a partire dalle vacanze estive precedenti, la lettura (a volte facoltativa, a volte<br />
obbligatoria) di alcuni testi completi. Le verifiche svolte su queste letture sono state inserite tra le altre<br />
valutazioni se effettuate da tutta la classe, oppure valutate per la definizione <strong>del</strong> risultato finale di<br />
quell’alunno nel caso di prove facoltative.<br />
La valutazione <strong>del</strong>le verifiche è avvenuta tenendo conto dei seguenti parametri: 1) conoscenza<br />
<strong>del</strong>l'argomento; 2) uso <strong>del</strong> linguaggio specifico; 3) struttura logica.<br />
28
PROGRAMMA DI STORIA<br />
MODULO 1<br />
Il nuovo secolo: nuova organizzazione <strong>del</strong> lavoro (taylorismo e fordismo); la società di<br />
massa; integrazione politica e sociale <strong>del</strong>le masse<br />
L’età giolittiana<br />
La prima guerra mondiale<br />
L’oriente: Giappone e Cina<br />
MODULO 2<br />
La crisi <strong>del</strong>lo zarismo e la rivoluzione russa. L’URSS da Lenin a Stalin.<br />
I trattati di pace. L’Europa <strong>del</strong> primo dopoguerra.<br />
Il dopoguerra in Italia fino alla “marcia su Roma”.<br />
La crisi <strong>del</strong> ’29. Il “new deal” roosveltiano.<br />
L’Italia fascista: l’instaurazione <strong>del</strong>la dittatura; la politica estera.<br />
Il nazismo in Germania: costruzione <strong>del</strong> terzo Reich, politica estera di Hitler fino al ‘39.<br />
La diffusione <strong>del</strong> fascismo in Europa. La guerra di Spagna.<br />
MODULO 3:<br />
Lettura <strong>del</strong> libro:<br />
P. Levi, I sommersi e i salvati<br />
MODULO 4:<br />
Verso la guerra. IL caso tedesco e quello italiano.<br />
La costituzione di Weimar e l’articolo 48. Confronto con la Costituzione italiana.<br />
La seconda guerra mondiale.<br />
La Resistenza in Italia ed in Europa.<br />
La Shoah.<br />
MODULO 5:<br />
Gli organismi sovranazionali, l’Onu, la CECA, il MEC, L’Europa unita.<br />
Il secondo dopoguerra nel mondo. L’inizio <strong>del</strong>la “guerra fredda” e le sue fasi (a grandi<br />
linee, attraverso avvenimenti e parole chiave) fino alla caduta <strong>del</strong> muro di Berlino.<br />
Politica ed economia nell’Italia <strong>del</strong> dopoguerra: la Costituzione repubblicana, gli anni<br />
<strong>del</strong> centrismo, il “miracolo” economico, i governi di “centro-sinistra”.<br />
La Cina dalla fine <strong>del</strong>l’impero all’epoca maoista (a grandi linee).<br />
MODULO 6:<br />
Educazione civica:<br />
la Magistratura, la Corte Costituzionale, gli Enti Locali ed i loro<br />
organi.<br />
La decolonizzazione: fattori e modalità nei diversi continenti (approfondimento degli<br />
avvenimenti di Algeria e Indocina); i problemi <strong>del</strong>lo sviluppo nel Terzo Mondo non<br />
allineato ( il neocolonialismo); problemi irrisolti (la questione palestinese).<br />
La contestazione giovanile <strong>del</strong> 1968 in Italia e nel mondo.<br />
L’ America latina tra populismo e dittature (a grandi linee).<br />
L’Europa dopo la caduta <strong>del</strong> Muro: la riunificazione <strong>del</strong>la Germania, la disgregazione<br />
<strong>del</strong>la Iugoslavia, le nuove tappe <strong>del</strong>l’integrazione europea.<br />
L'Italia dal 1969 al nuovo millennio attraverso alcune parole chiave: autunno caldo,<br />
strategia <strong>del</strong>la tensione, brigatismo, compromesso storico, governo di solidarietà<br />
nazionale, pentapartito, democrazia imperfetta/regime bloccato/bipolarismo,<br />
tangentopoli, prima repubblica.<br />
29
FILOSOFIA<br />
Docente: Sonetti Catia<br />
Obiettivi specifici<br />
• saper enunciare le tesi fondamentali di una teoria filosofica<br />
• saper definire un concetto filosofico<br />
• saper contestualizzare storicamente, in rapporto all'evoluzione storica <strong>del</strong> dibattito<br />
filosofico, gli autori conosciuti<br />
• saper confrontare concezioni filosofiche diverse<br />
• saper ragionare sulle premesse e sulle conseguenze logiche di una teoria filosofica<br />
• saper utilizzare il linguaggio specifico <strong>del</strong>la disciplina<br />
Si allega programma dettagliato.<br />
Contenuti<br />
Metodi<br />
Il lavoro didattico è stato suddiviso in moduli, ognuno dei quali articolato in lezioni frontali, risposte alle<br />
domande di chiarimento, discussioni guidate, letture di approfondimento, verifiche formative ed una<br />
verifica sommativa finale (orale o scritta).<br />
Strumenti<br />
Gli strumenti utilizzati sono stati:<br />
a) il libro di testo adottato: N. Abbagnano - G. Fornero "Figure <strong>del</strong>la filosofia" voll.B, C, D<br />
b) materiali integrativi fotocopiati<br />
Modalità di verifica e criteri di valutazione<br />
Le verifiche sono servite ad accertare l'apprendimento <strong>del</strong>le conoscenze e il conseguimento <strong>del</strong>le<br />
competenze prima elencate, anche in vista di eventuali modifiche al percorso preventivato.<br />
Le verifiche sono avvenute mediante interrogazioni ed esposizioni orali e prove scritte di diverso genere<br />
(semistrutturate, quesiti a risposta singola, trattazioni brevi).<br />
La valutazione <strong>del</strong>le verifiche è avvenuta tenendo conto dei seguenti parametri: 1) conoscenza<br />
<strong>del</strong>l'argomento; 2) uso <strong>del</strong> linguaggio specifico; 3) struttura logica<br />
30
PROGRAMMA DI FILOSOFIA<br />
MODULO 1<br />
L’idealismo tedesco<br />
FICHTE: l’idealismo etico<br />
I tre principi <strong>del</strong>la “Dottrina <strong>del</strong>la scienza”<br />
“Scelta” tra dogmatismo e idealismo<br />
“Primato” <strong>del</strong>la ragion pratica<br />
Cenni alla filosofia politica<br />
HEGEL: l’idealismo logico<br />
Significato di realtà, filosofia e ragione dialettica per H.<br />
La dialettica: significato ed articolazione.<br />
La “Fenomenologia <strong>del</strong>lo Spirito”: le figure (servo/padrone, coscienza infelice).<br />
Idea, Natura e Spirito: l’articolazione triadica <strong>del</strong> sistema hegeliano.<br />
Logica e Filosofia <strong>del</strong>la natura (a grandi linee).<br />
La Filosofia <strong>del</strong>lo Spirito: Spirito Soggettivo (cenni), Spirito Oggettivo (la triade che culmina con<br />
l’eticità: teoria <strong>del</strong>lo stato e filosofia <strong>del</strong>la storia), Spirito Assoluto (il punto di arrivo <strong>del</strong> processo<br />
dialettico)<br />
MODULO 2<br />
Destra e sinistra hegeliana: il concetto di alienazione in Feuerbach<br />
MARX<br />
La critica a Hegel e a Feuerbach.<br />
Il materialismo storico.<br />
Lettura integrale <strong>del</strong> Manifesto<br />
”Il Capitale”: critica all’economia politica borghese (merce, lavoro, plus-valore)<br />
Le fasi <strong>del</strong>la società futura.<br />
MODULO 3<br />
Il Positivismo nelle sue linee generali (in rapporto all’Illuminismo e al Romanticismo)<br />
SCHOPENHAUER<br />
Il mondo <strong>del</strong>la rappresentazione come “velo di Maya”<br />
Il mondo noumenico come “volontà di vivere”<br />
Il pessimismo<br />
Le vie di liberazione dal dolore<br />
NIETZSCHE<br />
Apollineo e dionisiaco<br />
Il metodo genealogico e la filosofia <strong>del</strong> mattino<br />
La morte di Dio. Critica <strong>del</strong>la metafisica e <strong>del</strong>la morale.<br />
L’Ubermensch: eterno ritorno, nichilismo, volontà di potenza<br />
MODULO 4<br />
Esistenza, inconscio, coscienza.<br />
31
KIERKEGAARD<br />
L’esistenza e il singolo<br />
Gli stadi <strong>del</strong>l’esistenza<br />
Angoscia, disperazione e fede<br />
FREUD<br />
La realtà <strong>del</strong>l’inconscio (le topiche) ed i modi per accedere ad esso (i sogni)<br />
La teoria <strong>del</strong>la sessualità ed il complesso di Edipo<br />
Il disagio <strong>del</strong>la civiltà<br />
BERGSON<br />
I dati <strong>del</strong>la coscienza: il tempo<br />
La metafisica: intelligenza e intuizione<br />
L’evoluzione creatrice<br />
Società aperte e società chiuse<br />
MODULO 6<br />
MAX WEBER<br />
Rapporto tra capitalismo ed etica protestante<br />
Sviluppo <strong>del</strong>l’analisi <strong>del</strong>la società con particolare riguardo all’etica <strong>del</strong>la convinzione ed etica<br />
<strong>del</strong>la responsabilità<br />
Il discorso sul Leader carismatico.<br />
MODULO 7<br />
L’importanza <strong>del</strong> pensiero scientifico nell’evoluzione <strong>del</strong>la filosofia<br />
Il caso DARWIN<br />
L’evoluzionismo di SPENCER<br />
MODULO 8<br />
Gli sviluppi <strong>del</strong> marxismo<br />
Il marxismo sovietico.<br />
LUKACS e il tema <strong>del</strong>l’ideologia<br />
GRAMSCI. Il concetto di egemonia. Il “moderno principe”.<br />
La scuola di Francoforte<br />
HORKHEIMER,<br />
Critica alla famiglia e alla società<br />
Dialettica <strong>del</strong>l’illuminismo.ADORNO<br />
BENJAMIN<br />
MODULO 9<br />
Due filosofe a confronto.<br />
S. WEIL<br />
Condizione operaia<br />
Scelta mistica<br />
H. ARENTD<br />
L’analisi <strong>del</strong> totalitarismo<br />
La “banalità <strong>del</strong> male”<br />
32
Conoscenza<br />
Astronomia descrittiva<br />
Il sistema solare<br />
Evoluzione stellare, le galassie e teorie cosmologiche<br />
Classificazione e genesi <strong>del</strong>le rocce<br />
Mo<strong>del</strong>lo <strong>del</strong>l’interno <strong>del</strong>la Terra e mezzi di indagine<br />
Teoria generale <strong>del</strong>la tettonica a zolle<br />
SCIENZE NATURALI<br />
Docente: Antonella Bolognesi<br />
Obiettivi specifici raggiunti<br />
Competenze<br />
Comprendere l’interdipendenza tra la vita e la materia<br />
Comprendere il ruolo che l’uomo deve svolgere nel mantenere l’equilibrio cosmico<br />
Uso appropriato <strong>del</strong>la terminologia scientifica<br />
Capacità<br />
Verifica <strong>del</strong> ragionamento logico su base ipotetica<br />
Inserire ogni argomento in un insieme interdisciplinare logicamente collegato, con riferimenti<br />
multidisciplinari.<br />
- lezioni frontali;<br />
- approfondimenti personali;<br />
- uso di audiovisivi;<br />
- uso di riviste specializzate;<br />
Metodi di insegnamento<br />
L’osservazione dei fenomeni è servita come punto di partenza per la comprensione <strong>del</strong> procedimento<br />
logico-deduttivo <strong>del</strong>la metodologia scientifica di ricerca e a sostenere la metodica deduttiva <strong>del</strong>lo studio “<br />
tradizionale “ <strong>del</strong>le Scienze naturali.<br />
Strumenti di lavoro<br />
L’approccio teorico alla materia proposto dal testo, è stato accompagnato da :<br />
osservazione di campioni di rocce,<br />
osservazione al telescopio di: pianeti, stelle,sole<br />
visite guidate al Planetario di Livorno, teoriche di geologia. Lo studio teorico è stato comunque integrato,<br />
per quanto è possibile, da alcuni audiovisivi i quali, oltre a illustrare e approfondire la trattazione dei vari<br />
argomenti, ha permesso agli alunni di verificare almeno indirettamente il senso <strong>del</strong>la esperienza empirica<br />
come base fondamentale <strong>del</strong> metodo induttivo di ricerca e ha fatto loro conoscere il grado di tecnologia<br />
raggiunto dalla ricerca scientifica attuale.<br />
33
Discussioni di approfondimento.<br />
Strumenti per la verifica formativa<br />
Strumenti per la verifica sommativa<br />
- Verifiche orali con esposizione di temi e argomenti di ordine generale<br />
- Verifiche scritte mediante test oggettivi di valutazione ( trattazione di tematiche, esercizi, risposte brevi,<br />
test a scelta multipla)<br />
Numero di verifiche sommative<br />
Sono state fatte almeno due verifiche scritte e una orale per quadrimestre.<br />
Criteri di valutazione<br />
La valutazione <strong>del</strong>le prove sia orali che scritte si è basata sui seguenti elementi:<br />
- pertinenza <strong>del</strong>le risposte;<br />
- conoscenza dei contenuti;<br />
- completezza <strong>del</strong>le risposte;<br />
- capacità di rielaborazione dei contenuti;<br />
- uso corretto <strong>del</strong> linguaggi<br />
34
L’UNIVERSO LONTANO<br />
Unità di misura: U.A, A.L, Parsec.<br />
PROGRAMMA DI SCIENZE<br />
Oltre il Sistema Solare: le stelle<br />
•la sfera celeste: orizzonte, zenit e nadir, meridiani e paralleli celesti, eclittica, punto gamma<br />
e omega.<br />
•coordinate celesti: h e azimut, declinazione ed ascensione retta<br />
•caratteristiche e proprietà <strong>del</strong>le stelle (classi spettrali, magnitudine assoluta ed apparente,<br />
temperatura e colore <strong>del</strong>le stelle, stelle doppie e sistemi multipli, stelle variabili, movimenti,<br />
costellazioni<br />
•nebulose luminose ed oscure.<br />
I corpi celesti nascono e muoiono<br />
Reazioni di fusione termonucleare<br />
Diagramma di Hertzsprung-Russel<br />
Evoluzione di una stella: sua formazione e condizione di esistenza (buchi neri, novae, supernovae,<br />
quasars, nebulose, stelle a neutroni, pulsar)<br />
Le galassie<br />
Natura e forma <strong>del</strong>le galassie<br />
Distribuzione <strong>del</strong>le galassie nello spazio quasars<br />
Ipotesi sulla genesi <strong>del</strong>l’ Universo:<br />
Legge di Hubble<br />
Teoria <strong>del</strong>lo stato stazionario; Teoria <strong>del</strong> big bang<br />
Futuro <strong>del</strong>l’Universo<br />
IL SISTEMA SOLARE<br />
Il Sole<br />
Caratteristiche generali<br />
Interno <strong>del</strong> Sole e sua composizione<br />
Atmosfera solare e fenomeni caratteristici: vento solare e aurore polari<br />
Teoria geocentrica e eliocentrica le leggi di Keplero<br />
La legge di gravitazione universale di Newton<br />
Asteroidi<br />
Comete<br />
Meteoriti e meteore<br />
35
IL PIANETA TERRA<br />
La forma e le dimensioni <strong>del</strong>la Terra<br />
Il reticolato geografico<br />
I MOVIMENTI DELLA TERRA<br />
• movimento di rotazione: prove e conseguenze (esp. di Guglielmini, esp. di Foucault, legge<br />
di Ferrel e forza di Coriolis)<br />
• movimento di rivoluzione: prove e conseguenze (aberrazione <strong>del</strong>la luce)<br />
• zone astronomiche<br />
• moti terrestri più lenti (precessione, nutazione)<br />
LA LUNA<br />
Caratteri fisici <strong>del</strong>la Luna<br />
I movimenti <strong>del</strong>la Luna: rotazione, rivoluzione, epicicloide, regressione <strong>del</strong>la linea dei nodi<br />
Fasi lunari ed eclissi<br />
Mese sinodico e ciclo di Metone.<br />
L’ORIENTAMENTO E LA MISURA DEL TEMPO<br />
L’orientamento.<br />
Determinazione <strong>del</strong>le coordinate geografiche.<br />
Le unità di misura <strong>del</strong> tempo.<br />
Il tempo vero, il tempo civile e i fusi orari, linea <strong>del</strong> cambiamento di data.<br />
I MATERIALI DELLA CROSTA TERRESTRE: LE ROCCE<br />
Lo studio <strong>del</strong>le rocce e dei minerali: i silicati<br />
ROCCE IGNEE: origine dei magmi, rocce intrusive ed effusive, rocce acide, basiche e intermedie,<br />
principali famiglie.<br />
ROCCE SEDIMENTARIE: il processo sedimentario; rocce detritiche, chimiche, organogene<br />
ROCCE METAMORFICHE: vari tipi di metamorfismo con esempi più significativi<br />
Ciclo litogenetico.<br />
LA DINAMICA DELLA LITOSFERA<br />
L interno <strong>del</strong>la terra: crosta; mantello; nucleo.<br />
Flusso termico e temperatura all’interno <strong>del</strong>la terra<br />
Il campo magnetico terrestre: origine <strong>del</strong> campo, inversioni e paleomagnetismo, le anomalie<br />
magnetiche<br />
La struttura <strong>del</strong>la crosta: crosta oceanica e continentale<br />
L’espansione dei fondi oceanici: dorsali oceaniche, fosse abissali, meccanismo <strong>del</strong>l’espansione,la<br />
“prova indipendente”<br />
La tettonica <strong>del</strong>le placche: dinamica e classificazione <strong>del</strong>le zolle (margini, faglie, fosse abissali, archi<br />
insulari)<br />
I processi orogenetici<br />
Celle convettive e punti caldi<br />
36
I FENOMENI VULCANICI<br />
Cos’è un vulcano<br />
Gli edifici vulcanici<br />
Prodotti <strong>del</strong>l‘attività vulcanica<br />
Vulcanesimo effusivo ed esplosivo<br />
Distribuzione geografica dei vulcani<br />
I FENOMENI SISMICI<br />
Natura ed origine dei terremoti<br />
Propagazione e registrazione <strong>del</strong>le onde sismiche<br />
Magnitudo ed intensità<br />
Effetti <strong>del</strong> terremoto<br />
Distribuzione dei terremoti e tettonica <strong>del</strong>le placche<br />
Terremoti ed interno <strong>del</strong>la terra<br />
Libro di testo: I. Neviani “Geografia generale” SEI<br />
37
Conoscenze<br />
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE<br />
Docente: Pieraccini Stefano<br />
Obiettivi disciplinari<br />
• Conoscere le caratteristiche fondamentali di singoli autori e periodi artistici.<br />
Competenze<br />
• Saper inquadrare storicamente le opere d’arte proposte, in seguito al riconoscimento di peculiari<br />
caratteristiche<br />
• Sviluppare una capacità di “lettura” critica <strong>del</strong>l’opera d’arte, realizzando opportuni collegamenti<br />
con la cultura coeva al periodo di produzione <strong>del</strong>l’opera stessa<br />
• Saper operare il confronto fra autori differenti all’interno di ambiti culturali uguali e/o differenti<br />
• Comprendere ed utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica <strong>del</strong>la disciplina<br />
• Nel disegno, elaborazione e applicazione autonoma dei metodi proiettivi studiati nel corso degli<br />
anni passati e capacità di impostazione di un elaborato a mano libera cercando di evidenziare<br />
inclinazioni personali<br />
Metodologie didattiche<br />
• Agli studenti sono state illustrate le finalità e gli obiettivi disciplinari, i contenuti <strong>del</strong>la<br />
programmazione, le scadenze <strong>del</strong>le prove di verifica e le relative griglie di valutazione<br />
• L’intervento <strong>del</strong>l’insegnante si è sviluppato partendo dal generale al particolare, dalla concretezza<br />
all’astrazione, dall’analisi alla sintesi, cercando di indurre negli allievi lo stesso procedimento<br />
applicativo.<br />
• Indispensabili si sono dimostrati alcuni momenti di stimolo e di addestramento all’attività<br />
percettiva come premessa necessaria alle operazioni mentali di attenzione, osservazione,<br />
memorizzazione, analisi, sintesi, oltre che alla stessa creatività.<br />
• Le lezioni ex cattedra sono state condotte avvalendosi <strong>del</strong>la videoproiezione di presentazioni su<br />
PowerPoint onde consentire una lettura <strong>del</strong>l’opera su immagini di grande dimensione e, per quanto<br />
possibile, affiancate da proiezioni di filmati su cassette VHS o DVD<br />
• Al termine di ogni fase di lavoro si è cercato di effettuare una verifica che funzionasse come<br />
momento riepilogativo e di eventuale chiarimento oltre che per la misurazione <strong>del</strong>lo studio<br />
condotto dagli studenti.<br />
38
Strumenti<br />
• Libro di testo:: Itinerari nell’Arte. Ed. Zanichelli<br />
• Schede riepilogative con immagini di alcune fra le opere non presenti sul libro di testo, fotocopie<br />
integrative di altri testi.<br />
• CD con dispense <strong>del</strong>l’insegnante<br />
Verifiche e valutazioni<br />
Durante l’anno scolastico sono state effettuate due verifiche nel primo periodo e tre nel secondo, sia in<br />
forma orale che scritta al fine di valutare insieme alle conoscenze dei singoli allievi la loro capacità<br />
espressiva e l’uso <strong>del</strong> linguaggio specifico.<br />
La valutazione <strong>del</strong>le verifiche scritte e orali è avvenuta mediante l’utilizzo di griglie opportunamente<br />
predisposte in seno al Dipartimento, che si allegano a detto <strong>documento</strong> .<br />
In particolare, ai fini <strong>del</strong>la valutazione finale, si terrà conto anche <strong>del</strong>l’attenzione, <strong>del</strong>l’impegno e dei<br />
progressi conseguiti rispetto ai livelli di partenza oltre agli obiettivi minimi da raggiungere al termine <strong>del</strong><br />
corso di studi:<br />
Capacità di lettura analitica di alcune produzioni artistiche più significative<br />
Capacità di orientamento nella produzione artistica <strong>del</strong>l’intero arco temporale previsto.<br />
Capacità di contestualizzazione <strong>del</strong>l’opera e relativa individuazione <strong>del</strong>le influenze storico-culturali<br />
<strong>del</strong> periodo di appartenenza<br />
Capacità di espressione orale corretta e articolata dei contenuti disciplinari mediante l’uso <strong>del</strong>la<br />
terminologia specifica<br />
Per quanto possibile, capacità di analisi e critica personali, anche in relazione alle inclinazioni<br />
evidenziate da ciascuno studente.<br />
39
PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE<br />
L’OTTOCENTO<br />
IL NEOCLASSICISMO<br />
Antonio Canova “La bellezza ideale ”<br />
Amore e Psiche; Ebe; Paolina Borghese<br />
Jacques- Louis David “La pittura epico-celebrativa”<br />
Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat<br />
INQUIETUDINI PREROMANTICHE<br />
Francisco Goya<br />
3 <strong>maggio</strong> 1808 (La fucilazione); La famiglia di Carlo IV<br />
IL ROMANTICISMO<br />
Il Romanticismo in Germania<br />
Friedrich:<br />
Il naufragio <strong>del</strong>la Speranza; Viandante sul mare di nebbia<br />
Il “Sublime” e “Pittoresco” nella pittura romantica inglese<br />
Fussli:<br />
Incubo notturno<br />
W. Blake:<br />
Paolo e Francesca<br />
John Constable:<br />
Nuvole<br />
William Turner<br />
Vapore durante una tempesta in mare<br />
La pittura romantica in Francia<br />
Thèodore Gericault:<br />
Ufficiale dei cacciatori a cavallo;La zattera <strong>del</strong>la “Medusa”;<br />
E. Delacroix:<br />
La Libertà che guida il popolo<br />
La Scuola di Barbizon<br />
Camille Corot:<br />
Il Tevere a Castel Sant’Angelo; Marietta a Roma<br />
Il romanticismo storico in Italia<br />
Francesco Hayez<br />
Il bacio<br />
40
IL REALISMO:<br />
Gustave Courbet:<br />
Le bagnanti; Seppellimento a Ornans;Gli spaccapietre; Bounjour Monsieur Courbet;<br />
Demoiselles au bord de la Seine<br />
Honoré Daumier :<br />
A Napoli ;Lo scompartimento di terza classe ; Nous voulons Barabba<br />
Jean-Francois Millet:<br />
L’Angelus<br />
I MACCHIAIOLI<br />
Giovanni Fattori:<br />
Soldati francesi <strong>del</strong> ’59; La Rotonda di Palmieri; Il riposo.<br />
Silvestro Lega:<br />
La visita; Il pergolato<br />
Telemaco Signorini:<br />
La sala <strong>del</strong>le agitate al S.Bonifazio di Firenze<br />
L’IMPRESSIONISMO<br />
Eduard Manet:<br />
Le Dejeuner sur l’herbe; Olympia; Il bar alle Folies-Bergère<br />
Claude Monet :<br />
La Grenouillière ; Impressione : il levar <strong>del</strong> sole ; La cattedrale di Rouen ; vedute di<br />
Venezia ; Londra, il Parlamento ; Lo stagno <strong>del</strong>le ninfèe<br />
Pierre Auguste Renoir:<br />
La Grenouilliere; Bal au Moulin de la Galette; Bagnante bionda; Giovanetta; Pagliaccio<br />
rosso; Donna con cappello di paglia.<br />
Edgar Degas:<br />
Fantini davanti alle tribune; La prova; L’assenzio; Donna che si spugna nella tinozza.<br />
Paul Cezanne:<br />
La casa <strong>del</strong>l’impiccato; Autoritratto; I giocatori di carte; Donna con caffettiera; Bagnanti; La<br />
montagna Sainte-Victoire<br />
IL POSTIMPRESSIONISMO<br />
Il Pointillisme: George Seurat:<br />
Una domenica pomeriggio all’isola <strong>del</strong>la Grande Jatte<br />
Paul Gauguin:<br />
Il Cristo gianno; Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?<br />
Vincent Van Gogh:<br />
I mangiatori di patate; Autoritratto 1887; La piana <strong>del</strong>la Crau, presso Arles; Notte stellata;<br />
La chiesa di Auvers; Il campo di grano con volo di corvi<br />
Henri de Toulouse-Lautrec:<br />
La Toilette; Ballo al Moulin Rouge; Manifesto di Jane Avril al Jardin de Paris.<br />
41
IL SIMBOLISMO<br />
Odilon Redon :<br />
Il fiore <strong>del</strong>la palude ; Sognando vidi nel cielo una visione di mistero<br />
IL DIVISIONISMO<br />
Giovanni Segantini:<br />
Le due madri<br />
Giuseppe Pellizza da Volpedo:<br />
Il quarto stato<br />
L’ARCHITETTURA NELLA SECONDA META’ DELL’800:<br />
L’architettura degli ingegneri; l’Eclettismo; l’urbanistica:<br />
La torre Eiffel; La Mole Antonelliana: La Galleria Vittorio Emanuele II a Milano.<br />
L’Opera di Parigi; Palazzo di Giustizia a Roma; Il Vittoriano<br />
ART NOUVEAU:<br />
Architettura:<br />
Antonio Gaudì:<br />
Casa Milà; Parco Guell; Sagrada Familia<br />
Pittura:<br />
Gustav Klint:<br />
Giuditta; Il bacio.<br />
IL NOVECENTO<br />
L’ESPRESSIONISMO<br />
L’Espressionismo francese: i Fauves<br />
Henri Matisse: la pittura tra colore e decorazione<br />
Ritratto con la riga verde; La danza<br />
Maurice de Vlaminck:<br />
La ballerina <strong>del</strong> Rat mort<br />
André Derain:<br />
Donna in camicia<br />
L’Espressionismo tedesco<br />
Precedenti <strong>del</strong>l’espressionismo tedesco:<br />
James Ensor: il visionarismo pre-espressionista<br />
Entrata di Cristo a Bruxelles<br />
Eduard Munch:l’angoscia <strong>del</strong>l’esistenza come tema centrale <strong>del</strong>l’arte<br />
Il grido<br />
Die Brucke (Il Ponte)<br />
Kirchner<br />
Marcella; Busto di donna nudo con cappello<br />
42
L’espressionismo in Austria<br />
Egon Schiele:<br />
Autoritratto con le dita aperte; Donna distesa con vestito giallo<br />
IL CUBISMO:<br />
Pablo Picasso:<br />
Poveri in riva al mare (Periodo blu)<br />
I giocolieri (Periodo rosa)<br />
Les demoiselles d’Avignon (Periodo proto-cubista)<br />
Ritratto di Amboise Vollard (Periodo <strong>del</strong> cubismo analitico)<br />
I musicanti (Periodo <strong>del</strong> cubismo sintetico e <strong>del</strong> collage)<br />
Guernica<br />
L’ASTRATTISMO<br />
Der Blaue Reiter (Il cavaliere azzurro)<br />
Vasiliij Kandinskij:<br />
Cenni al testo: Punto, Linea, Superficie<br />
Composizione 1924; Le punte <strong>del</strong>l’arco<br />
Franz Marc:<br />
I grandi cavalli azzurri; Forme in combattimento<br />
De Stijl o Neoplasticismo:<br />
Piet Mondrian:<br />
L’albero rosso; L’albero argentato; Melo in fiore, Composizione con rosso, giallo, blu<br />
LA SCUOLA DI PARIGI<br />
Marc Chagall:<br />
Parigi alla finestra; La passeggiata<br />
Amedeo Modigliani.<br />
Margherita seduta; Testa di Jeanne Hebuterne; Nudo sdraiato a braccia aperte<br />
Maurice Utrillo<br />
Impasse Cottin; A’ la belle Gabrielle<br />
N.B. I seguenti argomenti saranno oggetto di studio nei giorni successivi alla presentazione di<br />
questo <strong>documento</strong><br />
DADAISMO<br />
Il Dadaismo a Zurigo<br />
Hans Arp:<br />
Ritratto di Tristan Tzara<br />
Il Dadaismo in America<br />
Marcel Duchamps e il ready-made (oggetto già fatto)<br />
Ruota di bicicletta; Fontana; La Gioconda coi baffi<br />
43
Il dadaismo berlinese: dada come rivolta politica<br />
IL FUTURISMO<br />
Umberto Boccioni:<br />
Stati d’animo: quelli che vanno; Stati d’animo: quelli che restano; Stati d’animo: gli addii<br />
Forme uniche <strong>del</strong>la continuità nello spazio<br />
Carlo Carrà:<br />
Il cavaliere rosso<br />
Giacomo Balla:<br />
Dinamismo di un cane al guinzaglio; Le mani <strong>del</strong> violinista<br />
Antonio di Sant’Elia e l’architettura futurista<br />
Casamento con ascensori.....<br />
..<br />
L’ARCHITETTURA DEL NOVECENTO:<br />
Il Bauhaus.<br />
Walter Gropius:<br />
Mies Van der Rohe:<br />
Monumento a Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg; Grattacielo Seagram Building a New York<br />
Il razionalismo in Francia<br />
Le Corbusier:<br />
Villa Savoye; Cappella di Notre Dame du Haut; il modulor<br />
L’architettura organica negli Stati Uniti<br />
Wrigt :<br />
Casa sulla cascata; Museo Salomon Guggenheim a New York<br />
44
EDUCAZIONE FISICA<br />
Docente: Isolani Monica<br />
Obiettivi disciplinari<br />
Conoscenze:<br />
Conoscere un riscaldamento motorio generale e specifico.<br />
Conoscere la tecnica esecutiva dei test motori: Funicella 30”, Velocità 30 mt, Lancio <strong>del</strong>la<br />
Palla Medica 3kg.<br />
Conoscere i fondamentali individuali e di squadra <strong>del</strong>la pallavolo in maniera approfondita<br />
e in maniera più approssimativa <strong>del</strong>la pallacanestro .<br />
Conoscere le ossa e i muscoli e la loro funzionalità.<br />
Conoscere l’apparato cardio-circolatorio e quello respiratorio in funzione <strong>del</strong>l’attività<br />
fisica e sportiva.<br />
Conoscere il regolamento tecnico <strong>del</strong>la pallavolo ,<strong>del</strong> calcetto e <strong>del</strong>la pallacanestro<br />
( Regole più importanti).<br />
Conoscere i quattro stili <strong>del</strong>l’attività <strong>del</strong> nuoto.<br />
Conoscere le attività che si svolgono nel campo di atletica.<br />
Conoscere i principali traumi e il primo pronto soccorso<br />
<br />
Competenze:<br />
Eseguire un riscaldamento generale.<br />
Svolgere una partita di pallavolo con le regole di gioco.<br />
Svolgere una partita di pallacanestro con regole semplificate.<br />
Svolgere una partita di calcetto con le regole di gioco.<br />
Adattare le conoscenze teoriche all’attività pratica.<br />
Metodi e mezzi<br />
Lezioni frontali. Lavoro di gruppo. Lavoro in circuito. Gesti tecnici in forma globale. Tutti gli<br />
attrezzi <strong>del</strong>la palestra. Computer per la standardizzazione dei test motori. Appunti e libro<br />
di testo.<br />
Verifiche<br />
Prove pratiche con i test motori: Funicella 30 sec., Lancio dorsale palla medica kg.3,<br />
Velocità 30 Mt.<br />
Interrogazione orale sugli argomenti teorici.<br />
Impegno, partecipazione e comportamento.<br />
Criteri per la valutazione<br />
Griglia fornita dal programma <strong>del</strong> CONI “Osservatorio <strong>del</strong>le Capacità Motorie“ per i test<br />
motori.<br />
. La valutazione finale scaturisce dalla media <strong>del</strong>le valutazioni nei singoli test motori,<br />
nell’attività sportiva, nella prova orale, nell’impegno e nella partecipazione.<br />
45
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA<br />
Preparazione generale: esercizi di preatletica generale, esercizi individuali a carico<br />
naturale, esercizi a coppie in forma attiva e in forma passiva.<br />
Preparazione specifica ai test motori (Funicella 30”, Velocità 30 mt, Lancio <strong>del</strong>la<br />
Palla Medica 3kg). Fondamentali individuali <strong>del</strong>la pallavolo (palleggio, bagher, battuta,<br />
schiacciata, muro), svolgimento di partite e tornei con le regole di gioco.<br />
Fondamentali individuali <strong>del</strong>la pallacanestro : esecuzione individuale e a coppie<br />
degli stessi, svolgimento di partite semplificate.<br />
L’apparato locomotore: suddivisione in scheletrico e muscolare.<br />
Classificazione <strong>del</strong>le ossa e loro nomenclatura.<br />
Classificazione <strong>del</strong>le articolazioni .<br />
Classificazione dei muscoli e loro nomenclatura.<br />
La contrazione muscolare: meccanismi che regolano la contrazione.<br />
Meccanismo anaerobico alattacido, meccanismo anaerobico lattacido e<br />
meccanismo aerobico.<br />
L’apparato cardio-circolatorio: piccola e grande circolazione <strong>del</strong> sangue con<br />
conoscenza <strong>del</strong>a composizione <strong>del</strong>lo stesso.<br />
L’apparato respiratorio : sua funzionalità e conoscenza <strong>del</strong>le sue parti.<br />
Conoscenza <strong>del</strong> regolamento <strong>del</strong>la pallavolo e <strong>del</strong>la pallacanestro<br />
Regole principali <strong>del</strong> calcetto.<br />
Tecnica <strong>del</strong> crawl,<strong>del</strong> dorso ,<strong>del</strong>la farfalla e <strong>del</strong>la rana nello sport <strong>del</strong> nuoto<br />
Il primo soccorso<br />
46
RELIGIONE<br />
Docente: Laura Luperi<br />
Obiettivi specifici<br />
Nel corso di questo anno scolastico sono stati mediamente raggiunti i seguenti obiettivi:<br />
• La conoscenza dei tratti essenziali <strong>del</strong>la morale cristiana in relazione alle<br />
problematiche emergenti.<br />
• Una <strong>maggio</strong>re comprensione e rispetto <strong>del</strong>le diverse posizioni che le persone<br />
assumono in materia etica e religiosa.<br />
• La conoscenza <strong>del</strong>le caratteristiche e finalità dei sistemi conoscitivi <strong>del</strong>la scienza e<br />
<strong>del</strong>la fede.<br />
• Comprensione <strong>del</strong> superamento <strong>del</strong> dogmatismo scientifico e necessità di una<br />
collaborazione tra scienza e fede.<br />
• Individuazione <strong>del</strong>la necessità di un codice morale anche all'interno <strong>del</strong>la ricerca<br />
scientifica e tecnologico.<br />
• Conoscere l’atteggiamento <strong>del</strong>la Chiesa di fronte al nazionalismo e al totalitarismo e di fronte alle<br />
guerre mondiali.<br />
• Una <strong>maggio</strong>re cultura <strong>del</strong>la legalità.<br />
Metodi<br />
A seconda degli obiettivi da raggiungere sono state adottate le seguenti metodologie:<br />
• Una linea di ricerca per problemi a prevalente soggetto etico<br />
• Una linea storico-culturale che prevede lezioni frontali e lezioni dialogate<br />
• Una linea antropologico-esperenziale che parte dai dubbi e dagli interrogativi di<br />
fondo degli studenti, con conseguente confronto e discussione<br />
Mezzi e strumenti<br />
L'insegnante si è avvalsa oltre che <strong>del</strong> libro di testo, di strumenti audiovisivi, di riviste e periodici, di articoli<br />
di giornale e di quant'altro utile allo svolgimento <strong>del</strong>le lezioni.<br />
Verifiche orali <strong>del</strong>le tematiche affrontate.<br />
Verifiche<br />
Criteri di valutazione<br />
Gli alunni sono stati valutati oltre che sulla base <strong>del</strong>le conoscenze acquisite, sulla base <strong>del</strong>l'interesse, <strong>del</strong>la<br />
partecipazione attiva al dialogo educativo, sulla capacità di confrontarsi criticamente e di rielaborare i<br />
contenuti appresi.<br />
47
PROGRAMMA DI RELIGIONE<br />
• La Bioetica ed i suoi diversi ambiti;, la pena di morte, l’eutanasia, l’accanimento<br />
terapeutico e le cure palliative. Il testamento biologico.<br />
• Il dialogo interculturale, la lotta al razzismo alla xenofobia all’antisemitismo e<br />
all’intolleranza. Nel 70° anniversario <strong>del</strong>la firma <strong>del</strong>le leggi razziali a San Rossore lettura e<br />
commento <strong>del</strong> “ Manifesto degli scienziati antirazzisti 2008”.<br />
• Antigiudaismo e antisemitismo; il dolore e la memoria <strong>del</strong>la Shoah; La Chiesa di fronte al<br />
nazionalismo e al totalitarismo; Il silenzio di PioXII.<br />
• Educazione alla legalità: contro le mafie, un impegno per la giustizia. Breve storia <strong>del</strong>la<br />
mafia. La storia <strong>del</strong> giovane rivoluzionario Beppino Impastato nella Sicilia degli anni 70.<br />
L’impegno di Don Luigi Ciotti e di LIBERA per contrastare la mafia. La storia di don Pino<br />
Puglisi nel quartiere di Brancaccio a Palermo.<br />
48
SEZIONE 4: ALLEGATI<br />
49
GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO<br />
TIPOLOGIA A (analisi <strong>del</strong> testo)<br />
MEDIA (A+B+C+D+)/4= /10<br />
MEDIA (A+B+C+D+)/4= /<strong>15</strong><br />
CANDIDATO/A ________________________________<br />
50
GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO<br />
TIPOLOGIA B (saggio breve e articolo di giornale)<br />
MEDIA (A+B+C+D+)/4= /10<br />
MEDIA (A+B+C+D+)/4= /<strong>15</strong><br />
CANDIDATO/A ________________________________<br />
51
GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO<br />
TIPOLOGIA C e D (Tema storico e di attualità)<br />
MEDIA (A+B+C+D+)/4= /10<br />
MEDIA (A+B+C+D+)/4= /<strong>15</strong><br />
CANDIDATO/A ________________________________<br />
52
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER GLI ELABORATI DI MATEMATICA<br />
la scala si basa su una valutazione sintetica che tiene conto dei seguenti indicatori:<br />
- uso di conoscenze e competenze per soddisfare la richiesta. (5 punti).<br />
- correttezza <strong>del</strong> calcolo. (3 punti).<br />
- correttezza nell’uso <strong>del</strong> linguaggio, chiarezza nell’esposizione, nella giustificazioni dei<br />
passaggi, nella parte grafica (2 punti).<br />
1 La richiesta non ha alcun esito.<br />
2 Alcune conoscenze, mostrate in modo errato e non coerenti con la richiesta.<br />
3 Alcune conoscenze e/o competenze, pur corrette ma non coerenti con la richiesta.<br />
4 Conoscenze e competenze tendenti a soddisfare la richiesta <strong>del</strong> problema o <strong>del</strong>la domanda posta, non<br />
raggiunto per mancanza di altre competenze o capacità di calcolo, di chiarezza nella successione logica.<br />
5 Conoscenze e competenze coerenti con la richiesta, usate in forma non corretta (lo studente mostra di<br />
sapere quali competenze usare, ma non riesce a determinare con sufficiente correttezza la successione<br />
logica <strong>del</strong> procedimento)<br />
6 Lo studente raggiunge l'obiettivo anche se il procedimento adottato presenta imprecisioni e lievi errori<br />
di calcolo.<br />
7 Lo studente raggiunge l'obiettivo mostrando una discreta padronanza, nonostante la presenza di<br />
qualche lieve errore.<br />
8 La richiesta è stata soddisfatta nonostante lievi imperfezioni.<br />
9 La richiesta è stata soddisfatta correttamente. L’esposizione (sia scritta che orale ) è fatta con proprietà<br />
di linguaggio.<br />
10 La richiesta è stata soddisfatta correttamente, in modo ricco e pienamente soddisfacente sia nelle<br />
spiegazioni dei vari passaggi, sia nell’eventuale trattazione grafica.<br />
il voto <strong>del</strong>la prova è determinato assegnando un peso percentuale p al problema ed un peso q<br />
= 100 – p ai quesiti, si moltiplicano i punti <strong>del</strong> problema per p e la somma dei punti dei quesiti<br />
per q/5<br />
Si sommano quindi i punteggi pesati e si considera sufficiente una prova che superi la metà <strong>del</strong> punteggio massimo.<br />
Viene utilizzata la seguente tabella (adattata alla valutazione in quindicesimi per l’esame; in classe è stata usata<br />
usando la somma, divisa per 100 e approssimata per eccesso, ottenendo il risultato in decimi)<br />
p.p.= 100 1/<strong>15</strong><br />
100< p.p. ≤ <strong>15</strong>0 2/<strong>15</strong><br />
<strong>15</strong>0< p.p. ≤ 200 3/<strong>15</strong><br />
200< p.p. ≤ 250 4/<strong>15</strong><br />
250< p.p. ≤ 300 5/<strong>15</strong><br />
300< p.p. ≤ 350 6/<strong>15</strong><br />
350< p.p. ≤ 400 7/<strong>15</strong><br />
400< p.p. ≤ 450 8/<strong>15</strong><br />
450< p.p. ≤ 500 9/<strong>15</strong><br />
500< p.p. ≤ 583 10/<strong>15</strong><br />
583< p.p. ≤ 666 11/<strong>15</strong><br />
666< p.p .≤ 750 12/<strong>15</strong><br />
750< p.p. ≤ 833 13/<strong>15</strong><br />
833< p.p. ≤ 916 14/<strong>15</strong><br />
916< p.p. ≤ 1000 <strong>15</strong>/<strong>15</strong><br />
53
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA<br />
Tipologia A : n° 4 quesiti a trattazione sintetica ( max. 20 righe ciascuno)<br />
Conoscenza dei<br />
contenuti Punti<br />
Ottima 7/<strong>15</strong><br />
Buona 6/<strong>15</strong><br />
Adeguata 5/<strong>15</strong><br />
Sufficiente 4/<strong>15</strong><br />
Inadeguata 3/<strong>15</strong><br />
Gravem. lacunosa 2/<strong>15</strong><br />
Nulla<br />
Pertinenza alla<br />
traccia<br />
1/<strong>15</strong><br />
Articolata 4/<strong>15</strong><br />
Adeguata 3/<strong>15</strong><br />
Inadeguata 2/<strong>15</strong><br />
Assente<br />
Correttezza e<br />
proprietà lessicale<br />
1/<strong>15</strong><br />
Appropriata 4/<strong>15</strong><br />
Accettabile 3/<strong>15</strong><br />
Inadeguata 2/<strong>15</strong><br />
Inaccettabile 1/<strong>15</strong><br />
TOTALE<br />
Risultato finale= media aritmetica dei totali parziali = ……………<br />
Griglia di valutazione test motorio: Palla Medica 3Kg<br />
54
Griglia di valutazione test motorio: Velocità 30mt<br />
Griglia di valutazione test motorio: Salti con la corda 30”<br />
55
ADEGUATEZZA<br />
DELLA PRODUZIONE<br />
(rispetto <strong>del</strong>la consegna<br />
e numero di parole)<br />
COMPETENZA<br />
COMUNICATIVA<br />
(organizzazione logica,<br />
coerenza, coesione e<br />
stile)<br />
COMPETENZA<br />
LINGUISTICA<br />
Osservazioni ed Annotazioni particolari:<br />
PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA<br />
Trattazione sintetica di argomenti<br />
Griglia di valutazione<br />
1 il contenuto sviluppa la tematica proposta in modo non pertinente<br />
alla traccia e/o incompleto (non in tutte le sue parti). Non si procede alla verifica<br />
<strong>del</strong>le voci successive.<br />
2 il contenuto sviluppa la tematica proposta in modo parziale<br />
3 il contenuto sviluppa la tematica proposta nelle sue linee essenziali<br />
4 il contenuto sviluppa la tematica proposta in modo esauriente.<br />
5 Il contenuto sviluppa la tematica proposta in modo ampio e personale<br />
1 la trattazione manca di chiarezza e ordine nell’esposizione <strong>del</strong>le idee, per<br />
cui la produzione risulta di difficile comprensione / registro inadeguato.<br />
2 la trattazione non manca di coesione e coerenza, nonostante risenta di qualche<br />
carenza nella organizzazione ed esposizione <strong>del</strong>le idee/ registro non sempre<br />
adeguato.<br />
3 la trattazione rispetta, nell’insieme, i principi <strong>del</strong>la logica, coesione e coerenza,<br />
registro complessivamente adeguato e forma scorrevole.<br />
Correttezza morfo-sintattica / Ortografia<br />
1 numerose e gravi errori nell’uso <strong>del</strong>le strutture grammaticali e<br />
sintattiche e degli esponenti funzionali e/o frequenti / gravi errori<br />
ortografici.<br />
2 numerosi errori nell’uso <strong>del</strong>le strutture grammaticali e sintattiche e<br />
degli esponenti funzionali e/o errori ortografici pregiudicano talvolta<br />
l’efficacia <strong>del</strong>la comunicazione.<br />
3 alcuni errori nell’uso <strong>del</strong>le strutture grammaticali e sintattiche e degli<br />
esponenti funzionali / errori ortografici che non pregiudicano seriamente<br />
l’efficacia <strong>del</strong>la comunicazione.<br />
4 uso complessivamente appropriato <strong>del</strong>le strutture grammaticali, sintattiche e<br />
funzionali: la presenza di eventuali inesattezze non è rilevante.<br />
Adeguatezza lessicale:<br />
1 lessico elementare e ripetitivo, non sempre adeguato all’argomento.<br />
2 lessico non molto ampio e/o non sempre <strong>del</strong> tutto corretto,presenza di<br />
ambiguità.<br />
3 lessico globalmente corretto ed appropriato.<br />
__________________________________________________________________________________________________<br />
__________________________________________________________________________________________________<br />
_______________________________________________<br />
Punteggio _________________________<br />
57<br />
5<br />
3<br />
4<br />
3
SIMULAZIONE TERZA PROVA<br />
58
Scienze Candidato……………………………….<br />
Dopo aver caratterizzato il sole come stella descrivi la nascita, l’evoluzione e la sua probabile<br />
morte.<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
……………………………………………………………………………………………………………………………….<br />
59
Storia Candidato……………………………….<br />
Spiega l’importanza per la storia italiana, <strong>del</strong>le elezioni <strong>del</strong> 18 Aprile 1948 inserendole in un<br />
contesto internazionale.<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
……………………………………………………………………………………………………………………………….<br />
60
Disegno e Storia <strong>del</strong>l’Arte Candidato………………………………….<br />
“La poetica <strong>del</strong>l’Impressionismo ha come tema centrale la resa <strong>del</strong>la realtà attraverso la luce e il colore”.<br />
Sviluppa questo concetto parlando <strong>del</strong>la nascita di questo movimento artistico, dei principali esponenti, <strong>del</strong>le<br />
caratteristiche pittoriche anche attraverso l’analisi <strong>del</strong>l’opera “Lo stagno <strong>del</strong>le ninfèe” di Claude Monet.<br />
C. Monet: Lo stagno <strong>del</strong>le ninfèe<br />
(1899); olio su tela; cm 89x93,5<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
……………………………………………………………………………………………………………………………….<br />
61
Lingua inglese Name:………………………….<br />
Time present and time past<br />
Are both perhaps present in time future<br />
And time future contained in time past<br />
(from Four quartet by T.S. Eliot)<br />
In the literary production of the 20 th century one of the leit motivs is the human mind and its working.<br />
Mind is seen as a container which opens and interacts with the experiences the character is living in a coexistence of<br />
past, present and future.<br />
Write about the works which witness such a theme.<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
……………………………………………………………………………………………………………………………….<br />
62
ADEGUATEZZA<br />
DELLA PRODUZIONE<br />
(rispetto <strong>del</strong>la consegna<br />
e numero di parole)<br />
COMPETENZA<br />
COMUNICATIVA<br />
(organizzazione logica,<br />
coerenza, coesione e<br />
stile)<br />
COMPETENZA<br />
LINGUISTICA<br />
Osservazioni ed Annotazioni particolari:<br />
PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA<br />
Trattazione sintetica di argomenti<br />
Griglia di valutazione<br />
1 il contenuto sviluppa la tematica proposta in modo non pertinente<br />
alla traccia e/o incompleto (non in tutte le sue parti). Non si procede alla verifica<br />
<strong>del</strong>le voci successive.<br />
2 il contenuto sviluppa la tematica proposta in modo parziale<br />
3 il contenuto sviluppa la tematica proposta nelle sue linee essenziali<br />
4 il contenuto sviluppa la tematica proposta in modo esauriente.<br />
5 Il contenuto sviluppa la tematica proposta in modo ampio e personale<br />
1 la trattazione manca di chiarezza e ordine nell’esposizione <strong>del</strong>le idee, per<br />
cui la produzione risulta di difficile comprensione / registro inadeguato.<br />
2 la trattazione non manca di coesione e coerenza, nonostante risenta di qualche<br />
carenza nella organizzazione ed esposizione <strong>del</strong>le idee/ registro non sempre<br />
adeguato.<br />
3 la trattazione rispetta, nell’insieme, i principi <strong>del</strong>la logica, coesione e coerenza,<br />
registro complessivamente adeguato e forma scorrevole.<br />
Correttezza morfo-sintattica / Ortografia<br />
1 numerose e gravi errori nell’uso <strong>del</strong>le strutture grammaticali e<br />
sintattiche e degli esponenti funzionali e/o frequenti / gravi errori<br />
ortografici.<br />
2 numerosi errori nell’uso <strong>del</strong>le strutture grammaticali e sintattiche e<br />
degli esponenti funzionali e/o errori ortografici pregiudicano talvolta<br />
l’efficacia <strong>del</strong>la comunicazione.<br />
3 alcuni errori nell’uso <strong>del</strong>le strutture grammaticali e sintattiche e degli<br />
esponenti funzionali / errori ortografici che non pregiudicano seriamente<br />
l’efficacia <strong>del</strong>la comunicazione.<br />
4 uso complessivamente appropriato <strong>del</strong>le strutture grammaticali, sintattiche e<br />
funzionali: la presenza di eventuali inesattezze non è rilevante.<br />
Adeguatezza lessicale:<br />
1 lessico elementare e ripetitivo, non sempre adeguato all’argomento.<br />
2 lessico non molto ampio e/o non sempre <strong>del</strong> tutto corretto,presenza di<br />
ambiguità.<br />
3 lessico globalmente corretto ed appropriato.<br />
__________________________________________________________________________________________________<br />
__________________________________________________________________________________________________<br />
_______________________________________________<br />
Punteggio _________________________<br />
63<br />
5<br />
3<br />
4<br />
3