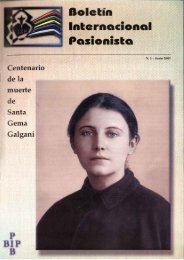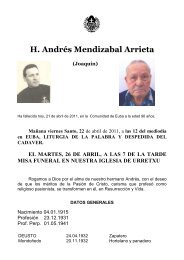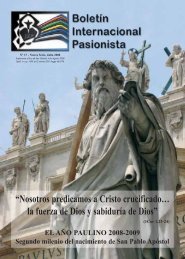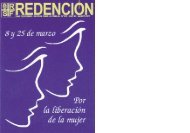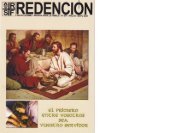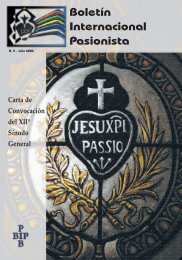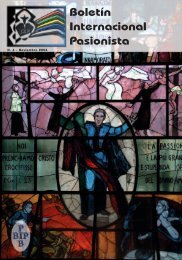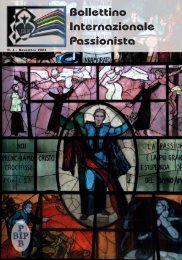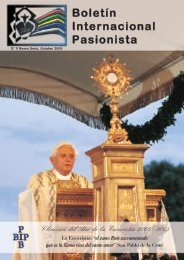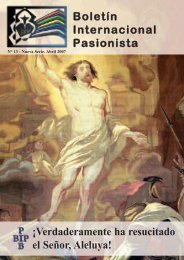Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
LA<br />
Rivista trimestrale di cultura e spiritualità della <strong>Passio</strong>ne a cura<br />
dei <strong>Passio</strong>nisti italiani e della Cattedra Gloria Crucis della<br />
Pontificia Università Lateranense<br />
SAPIENZA<br />
della<br />
CROCE<br />
ANNO XXV - N. 3<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
EDITORIALE<br />
Newman, lo sviluppo della Dottrina cristiana<br />
e il Concilio Vaticano II<br />
di ADOLFO LIPPI C. P.<br />
SACRA SCRITTURA e TEOLOGIA<br />
Pasqua d’Israele e Pasqua di Gesù<br />
Alcuni elementi in relazione all’Eucaristia<br />
di MAURIZIO BUIONI C.P.<br />
I fondamenti staurologici di un’etica sociale cristiana.<br />
Quale etica sociale discende dalla Teologia della Croce?<br />
di ADOLFO LIPPI C.P.<br />
La forza evangelizzatrice della parola<br />
di SUOR ANGELA MARIA LUPO C.P.<br />
PASTORALE e SPIRITUALITÀ<br />
Max Josef Metzger.<br />
E infranse tutte le catene, senza far rumore<br />
“La parola di Dio non si lega con le catene”<br />
di NICO DE MICO<br />
Il Beato Bernardo Maria Silvestrelli<br />
e San Gabriele dell’Addolorata<br />
di GIOVANNI DI GIANNATALE<br />
SALVEZZA E CULTURE<br />
Dante nel Sancta Sanctorum lateranense?<br />
Una ipotesi non tanto fantasiosa<br />
di MARIO CEMPANARI<br />
XIV Biennale di Arte Sacra di S. Gabriele<br />
di TITO AMODEI<br />
Mistero e misteri della memoria<br />
di ELISABETTA VALGIUSTI<br />
RECENSIONI<br />
267-272<br />
273-294<br />
295-311<br />
313-329<br />
331-348<br />
349-364<br />
365-382<br />
383-389<br />
391-396<br />
397-400<br />
Direttore responsabile<br />
Adolfo Lippi c. p.<br />
Direttore amministrativo<br />
Vincenzo Fabri c. p.<br />
Cattedra Gloria Crucis<br />
Comitato scientifico<br />
Fernando Taccone c. p. - Piero Coda<br />
Antonio Livi - Denis Biju-Duval<br />
Adolfo Lippi c. p. - Gianni Sgreva c. p.<br />
A. Maria Lupo c. p.<br />
Segretari di redazione<br />
Carlo Baldini c. p. - Gianni Sgreva c. p.<br />
A. Maria Lupo c. p. - Franco Nicolò<br />
Lucia Ulivi<br />
Collaboratori<br />
Tito Amodei - Max Anselmi - Carlo Baldini<br />
Vincenzo Battaglia - Luigi Borriello<br />
Maurizio Buioni - Giuseppe Comparelli<br />
Massimo Pasqualato - G. Marco Salvati<br />
Salvatore Spera - Flavio Toniolo<br />
Gianni Trumello - Tito Zecca<br />
Redazione:<br />
La Sapienza della Croce<br />
Piazza SS. Giovanni e Paolo, 13<br />
00184 Roma<br />
Tel. (06)77.27.14.74<br />
Fax 700.80.12<br />
e-mail: sapienzadellacroce@ tiscali.it<br />
http./www.passionisti.it<br />
Abbonamento annuale<br />
Italia € 20,00, Estero $ 30<br />
Fuori Europa (via aerea) $ 38<br />
Singolo numero € 5,00<br />
C.C.P. CIPI n. 50192004 - Roma<br />
Finito di stampare ottobre 2010<br />
Stampa:<br />
Editoriale Eco srl - San Gabriele (Te)<br />
Progetto grafico: Filomena Di Camillo<br />
Impaginazione: Florideo D’Ignazio<br />
ISSN 1120-7825<br />
Autorizzazione del tribunale di Roma n. 512/85, del 13 novembre 1985 - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento<br />
Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2 e 3, Teramo Aut. N. 123/2009
di ADOLFO LIPPI C.P.<br />
1. L’opera Lo sviluppo<br />
della Dottrina cristiana<br />
The Development of <strong>Christi</strong>an<br />
Doctrine è certamente una delle<br />
opere più belle di Newman 1 . Scritta<br />
nella solitudine di Littlemore, dove il leader<br />
del Movimento di Oxford, ridotto al<br />
silenzio dalla Chiesa anglicana dopo la<br />
pubblicazione del celebre Tract 90, viveva<br />
con i più cari amici una vita da monaco,<br />
essa è al tempo stesso l’espressione dell’illuminazione<br />
che avveniva nella sua<br />
coscienza ed un ottimo trattato di ecclesiologia.<br />
E non solo, ma possiamo riscontrare<br />
in essa anche un’opportuna ricerca di<br />
ermeneutica teologica e di ermeneutica in genere.<br />
NEWMAN,<br />
LO SVILUPPO<br />
DELLA<br />
DOTTRINA<br />
CRISTIANA E IL<br />
CONCILIO<br />
VATICANO II<br />
Come ecclesiologia anticipa il Concilio Vaticano II 2 . Come opera<br />
di pensiero indica la metodologia generale secondo la quale muoversi<br />
in un’epoca che smarrirà la strada verso la definizione e la<br />
comunicazione della Verità. E’ importante che ci rendiamo conto<br />
che non è soltanto una magistrale difesa della Chiesa cattolica di<br />
fronte alle accuse degli anglicani e dei protestanti in genere, non è<br />
1 Faccio riferimento nelle citazioni alla traduzione di A. Prandi, edita a cura<br />
di L. Obertello, Lo sviluppo della Dottrina cristiana, Jaca Book, Milano, 2003.<br />
2 Scriveva J. Guitton: “Il Vaticano II è tutto Newman. Paolo VI, che presiedeva<br />
quel Concilio, me lo diceva. Pensava che Newman si trovasse al centro<br />
invisibile del Vaticano II” (Il Cristo nella mia vita, Paoline, Cinisello B., 1988,<br />
170).<br />
editoriale<br />
Newman, lo sviluppo<br />
della Dottrina<br />
cristiana e il Concilio<br />
Vaticano II<br />
267-272<br />
editoriale<br />
267
editoriale<br />
ADOLFO LIPPI C.P.<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
editoriale<br />
268<br />
soltanto un’esposizione fedele e spassionata del cammino che ha<br />
condotto la sua propria coscienza a sentirsi in obbligo di passare alla<br />
Chiesa cattolica. No, Newman è andato oltre tutto questo, portando<br />
alla luce la radice della vitalità del cristianesimo cattolico, la sua<br />
natura vitale e conseguentemente dinamica, evolutiva, la crescita<br />
come dimostrazione della vita. Facendo questo egli indica la strada<br />
per risolvere il problema – oggi attualissimo – del rapporto fra ermeneutica<br />
della rottura ed ermeneutica del rinnovamento nella continuità,<br />
delle quali si discute a proposito dell’interpretazione da dare<br />
al Concilio Vaticano II.<br />
Negativamente, Newman viene a dire che non esiste una Chiesa<br />
statica, immobile nei suoi dogmi, che sia sempre identica a se stessa<br />
non soltanto nel suo essere profondo, ma anche nelle sue formulazioni<br />
dottrinarie, spirituali ed etiche. Certamente la Chiesa è sempre<br />
identica a se stessa nel suo essere profondo, ma lo è nel modo<br />
stesso in cui un adulto è identico al bambino che è stato. E’ identico<br />
e diverso, identico e sviluppato. Non solo, ma neanche la stessa rivelazione<br />
scritturistica, secondo Newman, si può considerare statica.<br />
Tutto è dinamico e in sviluppo nel popolo di Dio e nella Chiesa, perché<br />
tutto è vivo. La Chiesa è un organismo vivente. I paragoni che<br />
più spesso ricorrono nella Scrittura sono quelli di realtà viventi: il<br />
seme, la forza vitale interiore, il lievito 3 . Un principio che aveva<br />
affascinato Newman fin dalla sua gioventù era “La crescita è la sola<br />
dimostrazione della vita” 4 .<br />
Soltanto Teilhard de Chardin, un secolo dopo, sarà in grado di<br />
riconoscere questa caratteristica fondamentale della Rivelazione<br />
ebraico-cristiana e della vita della Chiesa 5 , come parte di una concezione<br />
generale della realtà in sviluppo. Vien fatto di pensare, tuttavia,<br />
che proprio nell’anno in cui Newman componeva la sua opera,<br />
un altro inglese stendeva un ampio abbozzo inedito della teoria che<br />
esporrà nella sua opera L’origine delle specie. Era Darwin, il quale<br />
3 Cf Lo sviluppo della Dottrina cristiana, cit., 104.<br />
4 Apologia pro vita sua, Milano, 1982, 24.<br />
5 Per Teilhard l’evoluzione non è riducibile al vecchio trasformismo darwiniano,<br />
non è qualcosa che riguarda esclusivamente le scienze naturali, ma la<br />
realtà come tale, compresa la religione e la fede. Cf ad es. Il fenomeno umano,<br />
Mondadori, Milano, 1973, 291-292: “Una teoria, un sistema l’evoluzione...?<br />
Assolutamente no. Essa è molto di più: è una condizione generale alla quale<br />
devono conformarsi e soddisfare ormai tutte le teorie, tutte le ipotesi e tutti i sistemi,<br />
se vogliono essere pensabili e veri” (292).
non si è mai sognato di contrapporre evoluzione a creazione come<br />
fanno molti suoi seguaci poco intelligenti. E’ chiaro che Newman<br />
non dice ciò che diceva Darwin o dirà Teilhard, anzitutto perché loro<br />
si muovono su un terreno diverso al suo. Ma si potrebbe dire che<br />
Newman ha fatto per la teologia e per il pensiero in genere un’operazione<br />
analoga a quella che loro hanno fatto per la scienza. “Qui<br />
sulla terra - scrive - vivere è cambiare e la perfezione è il risultato<br />
di molte trasformazioni” 6 .<br />
Poiché lo sviluppo della Rivelazione e dell’opera della Grazia<br />
nell’uomo è analogo alla sviluppo della vita nel cosmo, lo sviluppo<br />
non può avvenire per sradicamento, ma piuttosto per un più forte<br />
radicamento. Newman distingue e discerne chiaramente le trasformazioni<br />
che sono sviluppo da quelle che sono corruzione. Il cattolicesimo<br />
moderno sorge da quello del Medio Evo e questo da quello<br />
di Nicea 7 . Non c’è vero sviluppo se non nella Chiesa Cattolica 8 .<br />
Corruzioni e sradicamenti ci sono stati altrove e hanno rotto la<br />
continuità.<br />
I modernisti si appellarono a Newman come ad un loro precursore<br />
9 , ma il più grande loro avversario – San Pio X - fu abbastanza<br />
lucido e teologicamente informato per non cadere nella loro trappola<br />
e difese Newman. Un altro uomo santo che riconobbe immediatamente,<br />
nonostante l’originalità dell’impostazione newmaniana e la<br />
sua sottigliezza argomentativa, l’ortodossia e il valore teologico del<br />
trattato del Newman, fu il beato Domenico della Madre di Dio.<br />
Passato alla Chiesa cattolica, Newman si trovò in mano il suo trattato<br />
frettolosamente concluso, ma non pubblicato e si pose il problema<br />
dell’approvazione ecclesiastica per la pubblicazione. Sarebbe<br />
stato apprezzato positivamente o sospettato di eresia? Si rallegrò<br />
molto per il fatto che Domenico lo apprezzasse immediatamente e<br />
con entusiasmo. Così ne scriveva a James Hope: “Una persona già<br />
6 Lo sviluppo della Dottrina cristiana, cit., 75. Vedi anche G. Velocci,<br />
Incontrando Newman, Jaca Book, Milano, 2009, 97; Newman J. H., Lettera al<br />
Duca di Norfolk. Coscienza e libertà, Paoline, Milano, 1999, 44 ss.<br />
7 Cf Lo sviluppo della Dottrina cristiana, cit., 124.<br />
8 Cf ivi, 122.<br />
9 Cf A. Prandi, Introduzione all’edizione italiana, in Newman J. H., Lo sviluppo<br />
della Dottrina cristiana, cit., 27 ss: “Di fatto l’età modernistica è una di<br />
quelle in cui si è avuta una copiosa letteratura newmaniana, ma è anche quella<br />
in cui la distorsione del pensiero di Newman è stata ad un tempo più grave<br />
e più sottile” (27).<br />
editoriale<br />
Newman, lo sviluppo<br />
della Dottrina<br />
cristiana e il Concilio<br />
Vaticano II<br />
267-272<br />
editoriale<br />
269
editoriale<br />
ADOLFO LIPPI C.P.<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
editoriale<br />
270<br />
incline al favore, ma che è anche un perspicace, buono e profondo<br />
teologo, il P. Domenico, si compiace moltissimo di essa” 10 .<br />
La cattedra Gloria Crucis dell’Università Lateranense ha organizzato<br />
un Seminario di studio dal titolo: Il Beato Domenico Barberi<br />
passionista nell’itinerario di conversione del Card. John Henry<br />
Newman. Torneremo su questo interessante rapporto nei prossimi<br />
numeri della rivista.<br />
2. La beatificazione<br />
di Newman<br />
e il Concilio Vaticano II<br />
Il 19 settembre, presso<br />
Birmingham, Papa<br />
Benedetto XVI<br />
proclamerà Newman<br />
beato. E’ una grande<br />
gioia per tutti coloro<br />
che lo hanno amato e lo amano. Lo stesso papa è tra loro e ne ha da<br />
sempre studiato il pensiero. La figura e il pensiero di Newman,<br />
come lui stesso prevedeva, sono andati crescendo specialmente<br />
dopo la sua morte. Come già rilevato, si può senz’altro affermare<br />
che il Concilio Vaticano II si muove fondamentalmente nella linea<br />
tracciata da Newman. Per poco che riflettiamo, riconosciamo gli<br />
sviluppi - che ad alcuni sembrano più contraddizioni che sviluppi -<br />
fra le posizioni assunte dal Magistero riguardo ai diritti dell’uomo al<br />
tempo della Rivoluzione francese, o riguardo alle moderne libertà<br />
specialmente di religione e di culto al tempo di Pio IX e le dichiarazioni<br />
contenute nei testi del Concilio Vaticano II.<br />
E’ proprio il limpido concetto di sviluppo che Newman aveva,<br />
che apre la strada per capire la continuità vitale che c’è fra queste<br />
prese di posizione. Lui stesso difese le prese di posizione dei papi<br />
indicandone il modo di leggerle, cioè prospettando un’ermeneutica<br />
sempre correlata alla vitalità di una Chiesa in sviluppo. Basterebbe<br />
pensare a quel capolavoro di teologia, di ecclesiologia, di teologia<br />
della storia ed anche di ermeneutica filosofica che è la Lettera al<br />
Duca di Norfolk. Queste difese non erano certamente per lui<br />
accomodamenti escogitati allo scopo di fare un’apologetica a tutti i<br />
costi, posizione che sarebbe stata pericolosissima in quanto avrebbe<br />
aperto la strada al relativismo, col quale si può provare tutto e il<br />
10 “A prepossessed person, but a shrewd and a good and a deep divine,<br />
Father Dominic, is very much pleased with it” (Letters, XI, 76).
contrario di tutto. Il relativismo era la posizione più lontana, anzi<br />
quella del tutto contraria al pensiero di Newman, quella che combatté<br />
sempre con tutte le forze riscontrandola nelle posizioni liberali di<br />
allora. Il Biglietto Speech, letto in occasione della sua elevazione al<br />
cardinalato nel 1879, è estremamente chiaro su questo e presenta in<br />
anticipo una lucida analisi del processo di secolarizzazione già<br />
allora in atto in Inghilterra e ancora in atto in tutto l’Occidente. E’ più<br />
facile che fosse qualche ultramontanista a tentare un’apologetica a<br />
tutti i costi.<br />
Newman si muove sempre nella lucidità di una posizione vitale<br />
che è equidistante dalla paralisi dell’immobilismo come dalle rotture<br />
e dallo sradicamento delle Riforme e delle Rivoluzioni violente.<br />
Egli mostra le trasformazioni verificatesi da sempre nella Chiesa<br />
come segno di vitalità: le chiama sviluppi vitali e le distingue da<br />
altre trasformazioni che si sono rivelate corruzioni e così apre al<br />
pensiero teologico che è approdato al Concilio Vaticano II. Chi può<br />
dire, peraltro, che la nostra coscienza, sensibilità e responsabilità<br />
verso problemi come il colonialismo, il patriottismo e il nazionalismo,<br />
la pena di morte, la guerra, il trattamento degli animali, sia la<br />
stessa che prevaleva nella cultura dei tempi di Newman o anche soltanto<br />
qualche decennio prima del Vaticano II?<br />
L’intera esistenza del Newman ci viene ora proposta come un<br />
insegnamento, che è (come è sempre la Sacra Scrittura) al tempo<br />
stesso esortazione ed ammonimento. Esortazione: I Concili sono le<br />
più grande profezie che risuonano nella storia della Chiesa. Sono<br />
profezie anzitutto per il tempo in cui risuonano e poi per sempre.<br />
Tale fu il Concilio Tridentino, sempre difeso dal Newman. Che ne<br />
sarebbe della Chiesa della modernità senza il Tridentino? Ma è fin<br />
troppo evidente che per molto tempo ci fu nella Chiesa cattolica chi<br />
rimpiangeva e si bloccava nella precedente struttura mentale e pratica.<br />
Erano strutture di pensiero e strutture etiche, categorie mentali<br />
cui si era accostumati. La Chiesa era così, la Chiesa dei principi e<br />
dei vescovi-principi, dei nobili e dei cadetti dei nobili che diventavano<br />
ecclesiastici, dei privilegi acquisiti che pesavano sulla pastorale,<br />
delle controversie e delle guerre di religione, e così via. Quelle<br />
strutture fornivano alla Chiesa i mezzi di sostentamento e di mantenimento<br />
di tutto ciò che era stato acquisito precedentemente.<br />
Sembrava cosa buona. La Riforma Tridentina – o la Controriforma,<br />
se si preferisce chiamarla così – era cosa nuova: dove sarebbe<br />
approdata? Non era di facile attuazione. Lo stesso Francesco di<br />
editoriale<br />
Newman, lo sviluppo<br />
della Dottrina<br />
cristiana e il Concilio<br />
Vaticano II<br />
267-272<br />
editoriale<br />
271
editoriale<br />
ADOLFO LIPPI C.P.<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
editoriale<br />
272<br />
Sales desiderò tanto istituire un seminario ed ebbe amare delusioni.<br />
Si poteva mollare il vecchio che c’era - che era collaudato da secoli<br />
- per gettarsi nell’avventura del nuovo?<br />
E’ chiaro che anche il Concilio Vaticano I ha rappresentato un<br />
momento profetico di vitale importanza per la Chiesa. La crescita<br />
organica della Chiesa lo esigeva. Lo esigeva la necessità di allontanare<br />
pericoli che ne avrebbero distrutto la compagine e l’identità.<br />
Alla luce di quanto accadde dopo il Concilio Tridentino e dopo il<br />
Concilio Vaticano I, va letto ciò che accade oggi, dopo il Concilio<br />
Vaticano II. Alla luce delle difficoltà incontrate dai santi che attuarono<br />
i precedenti Concili si possono valutare le difficoltà che si<br />
incontrano oggi per il Vaticano II. Ricordando le incomprensioni<br />
patite da Newman possiamo comprendere quelle che si patiscono<br />
oggi. Ma alla luce della sua dottrina si può comprendere quanto la<br />
dottrina e la prassi promosse dal Concilio Vaticano II siano necessarie<br />
per il nostro tempo. Ben coscienti che questa stessa dottrina e la<br />
prassi finora attuata non possono considerarsi di nuovo realtà statiche,<br />
immutabili, alla stregua delle ideologie che tanti disastri hanno<br />
prodotto nel recente passato. L’ispirazione profonda del Vaticano II<br />
deve forse essere ancora interiorizzata dalla Comunità cristiana e,<br />
soprattutto, verificata nell’esperienza, di fronte alle sfide sempre<br />
nuove che essa si trova ad affrontare. I tesori più grandi sono ancora<br />
da svelare. L’ermeneutica della rottura prevalse comprensibilmente<br />
all’inizio, ma non è necessariamente l’unica. Lo sviluppo di<br />
ciò che Newman chiamava un’idea viva resta anche oggi l’attitudine<br />
nella quale collocarci per servire al Regno di Dio, cioè alla Vita.
di MAURIZIO BUIONI C.P.<br />
La ricerca delle radici ebraiche della fede cristiana è un tema dei<br />
più attuali dell’odierna teologia. L’egualitarismo illuminista che tutto<br />
appiattiva ci aveva impedito di percepire il modo con cui la salvezza<br />
di Dio è arrivata al mondo<br />
mediante una Chiesa sorta<br />
dalla rivelazione ebraica e nel-<br />
l’ambito della cultura ebraica.<br />
L’autore di questo articolo vi ritorna<br />
per quello che riguarda<br />
la Pasqua e l’Eucaristia, con un<br />
accurato studio sulle fonti.<br />
Il «patrimonio comune»<br />
liturgico<br />
PASQUA<br />
D’ISRAELE<br />
E PASQUA<br />
DI GESÙ<br />
Alcuni elementi in<br />
relazione all’Eucaristia<br />
Il 28 ottobre 2005 ricorre<br />
il 40° anniversario<br />
dalla promulgazione<br />
della Dichiarazione<br />
Nostra Aetate del<br />
Concilio Vaticano II, sulle relazioni della Chiesa con le religioni noncristiane.<br />
Il paragrafo 4 esordiva con le seguenti parole: «Scrutando<br />
attentamente il mistero della chiesa, questo sacro sinodo non ha dimenticato<br />
il vincolo con cui il popolo del Nuovo Testamento è spiritualmente<br />
legato con la stirpe di Abramo». Più avanti si rimarcava il<br />
grande «patrimonio spirituale comune» tra cristiani ed ebrei.<br />
Giovanni Paolo II ha fatto grandi passi nella direzione del<br />
rinnovamento conciliare. In un discorso del 6 marzo 1982, egli ha ribadito<br />
l’importanza di quel considerevole patrimonio, aggiungendo<br />
che «farne l’inventario in se stesso, tenendo però anche conto della<br />
fede e della vita religiosa del popolo ebraico, così come esse sono<br />
professate e vissute ancora adesso, può aiutare a comprendere<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
Pasqua d’Israele<br />
e Pasqua di Gesù<br />
273-294<br />
teologia<br />
273
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
MAURIZIO BUIONI C.P.<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
teologia<br />
274<br />
meglio alcuni aspetti della vita della Chiesa» 1 . Subito dopo il Papa ha<br />
aggiunto: «E’ il caso della liturgia...». Tale affermazione rappresenta<br />
un’importante passo in avanti: se la ricerca storica circa l’Ebraismo<br />
all’epoca del Secondo Tempio è di fondamentale importanza per la<br />
comprensione del NT, della vita e della liturgia della Chiesa Primitiva,<br />
non va trascurata la conoscenza della fede ebraica così come essa<br />
è vissuta al presente.<br />
Il 13 aprile 1986 Giovanni Paolo II ha detto nella Sinagoga di Roma<br />
che la realtà ebraica «non ci è estrinseca, ma in un certo qual modo<br />
è intrinseca alla nostra religione» 2 . Nello stesso anno, la Commissione<br />
per le relazioni religiose con l’Ebraismo ha pubblicato un documento<br />
intitolato Sussidi per una corretta presentazione degli Ebrei<br />
e dell’Ebraismo nella predicazione e nella catechesi della Chiesa<br />
Cattolica. Il quinto capitolo è dedicato alla liturgia e in particolare il<br />
paragrafo 24 al nostro tema della Pasqua:<br />
I cristiani e gli ebrei celebrano la Pasqua: Pasqua della storia, protesa<br />
verso l’avvenire, per gli ebrei; Pasqua realizzata nella morte e resurrezione<br />
di Cristo, per i cristiani, anche se ancora in attesa della<br />
consumazione definitiva. E’ ancora il «memoriale» che ci viene dalla<br />
tradizione ebraica con un contenuto specifico, diverso in ciascun<br />
caso. Esiste dunque, dall’una e dall’altra parte, un dinamismo parallelo:<br />
per i cristiani, esso dà un senso alla celebrazione eucaristica<br />
(Cf.,. Antifona O sacrum convivium), celebrazione pasquale e, in<br />
quanto tale, attualizzazione del passato, vissuto nell’attesa «della sua<br />
venuta» (1Cor 11,26) 3 .<br />
Non è nostro intento nel presente articolo affrontare la questione<br />
se e in quale forma Gesù abbia celebrato il Seder (Rituale della<br />
cena) Pasquale durante la sua Ultima Cena. In ogni caso, non si può<br />
dubitare almeno del fatto che Gesù abbia celebrato la sua Ultima Cena<br />
nel contesto della Pasqua Ebraica e che abbia dato all’istituzione<br />
1 Cf., anche i Sussidi per una corretta presentazione degli Ebrei e<br />
dell’Ebraismo nella predicazione e nella catechesi della Chiesa Cattolica, 24<br />
Giugno 1986, I,2; CCC 1096.<br />
2 Quanto quest’affermazione sia tenuta in conto della Chiesa è visibile<br />
anche concretamente, perché la Commissione per le relazioni religiose con<br />
l’ebraismo è un organismo che si trova all’interno del Segretariato per l’Unità<br />
dei Cristiani.<br />
3 Cf., anche CCC 1096
dell’Eucaristia un netto significato pasquale. Pertanto, non è solo legittimo,<br />
ma anche doveroso collocare l’Eucaristia nella cornice della<br />
Cena Pasquale ebraica 4 . Così, ad esempio, si afferma in un recente<br />
articolo sul tema:<br />
Indipendentemente dalla questione storica, per la comprensione dell’eucaristia<br />
non si può prescindere dalla cornice storico-salvifica della<br />
Pasqua ebraica. E su questo si vedono d’accordo tutti gli evangelisti;<br />
il sacrificio della croce costituisce il compimento di quello che<br />
prefigurava l’immolazione dell’agnello, mentre l’ultima cena di Gesù<br />
si configura come il pasto della nuova Pasqua 5 .<br />
Ogni rinnovamento non può prescindere da un ritorno alle fonti.<br />
Anche il rinnovamento liturgico dell’Eucaristia, Pasqua di Gesù e Pasqua<br />
della Chiesa, non può prescindere da un ritorno alle fonti. Ora,<br />
il ritorno alle fonti cristiane non può prescindere da un ritorno alle<br />
fonti ebraiche. Il rinnovamento dell’Eucaristia passa quindi anche attraverso<br />
il ritorno alle fonti ebraiche, un cammino che, per quanto<br />
possa sembrare strano, è ancora lungo 6 .<br />
Il NT e la liturgia della Chiesa primitiva rimangono un enigma per<br />
chi ignori non solo l’AT, ma anche il culto e la liturgia ebraica, essendo<br />
la liturgia Parola celebrata, fatta carne, resa attuale e viva nell’oggi<br />
4 Così, ad es., in Lc 22,14: «Quando fu l’ora, prese posto a tavola e gli<br />
apostoli con lui, e disse: “Ho desiderato ardentemente di mangiare questa<br />
Pasqua con voi, prima della mia passione»; Cf., anche Mt 26,18-19. Afferma<br />
giustamente J.K. HOWARD, «Passover and Eucharist in the Fourth Gospel», SJT<br />
20/3 (1967), pp. 329-330: «It is clearly outside our province to argue whether<br />
the Last Supper was a genuine Passover meal or not, but whichever view of the<br />
matter is taken, we cannot escape that obvious Paschal signification which Jesus<br />
gave to the bread and the wine» (cors. nostro).<br />
5 L.D. CHRUPCAŁA, «Fate questo in memoria di me», SBFLA 53 (2003), p. 141.<br />
6 Così nota A. DI BERARDINO, «Tendenze attuali negli studi patristici», in<br />
Complementi interdisciplinari di Patrologia, (ed. A. Quacquarelli) (Roma<br />
1989), pp. 38-39: «Lo schema del fecondo programma del “ritorno alle fonti”,<br />
che in larga misura ha condizionato e stimolato gli studi sul protocristianesimo,<br />
ha provocato un’uscita dagli steccati degli studi svolti prevalentemente in ambito<br />
latino e greco, indirizzandosi anche verso il cristianesimo delle aree orientali<br />
di altro retroterra linguistico: siriaco, copto, armeno, ecc. Tuttavia, tra le fonti,<br />
questo programma non ha incluso il giudaismo; si tratta perciò di un ritorno alle<br />
fonti incompiuto e imperfetto» (cors. nostro).<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
Pasqua d’Israele<br />
e Pasqua di Gesù<br />
273-294<br />
teologia<br />
275
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
MAURIZIO BUIONI C.P.<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
teologia<br />
276<br />
del credente 7 . E nel contesto della conoscenza dell’AT, è di grande<br />
importanza anche quella della sua interpretazione orale ebraica, perché<br />
la Scrittura ai tempi di Gesù non era un testo «nudo», ma era già<br />
rivestita di tutti gli «ornamenti» delle interpretazioni della Torah orale 8 .<br />
Per illuminare la liturgia cristiana, in particolare quella della Chiesa<br />
primitiva, è necessaria la conoscenza della liturgia ebraica 9 .<br />
Fatte queste premesse, nel presente articolo intendiamo approfondire<br />
alcuni elementi antichi della liturgia della Pasqua ebraica<br />
in relazione alla Pasqua cristiana, per vedere come essi possano<br />
illuminare la teologia e la prassi del Sacramento dell’Eucaristia.<br />
Pasqua: passaggio di Dio<br />
e «passaggio» dell’uomo<br />
La Scrittura dà<br />
un’etimologi del<br />
termine Pasqua:<br />
durante Pesah il Signore<br />
«è passato» o, più<br />
letteralmente, «ha zoppicato», «è saltato» (Pasah) sopra le case degli<br />
Israeliti, ovvero è passato oltre e non li ha colpiti come ha fatto<br />
con i loro nemici, ma il suo passaggio ha costituito per essi la liberazione<br />
(Es 12,27; Cf., 12,13.23) 10 . Filone Alessandrino ha accentuato<br />
il fatto che la Pasqua non è solo il passaggio di Dio, ma anche quello<br />
del popolo attraverso il Mar Rosso. Egli ha interpretato la Pasqua<br />
7 Cf., S. LYONNET, Il Nuovo Testamento alla luce dell’Antico. VII Settimana<br />
Biblica del Clero Napoli, Luglio 1968, Studi biblici pastorali 3, Brescia 1972,<br />
p. 16.<br />
8 R. LE DÉAUT, «Targum», Dictionnaire de la Bible - Supplément XIII (Paris<br />
2002), p. 271.<br />
9 Come giustamente ha affermato L. BOUYER, Eucaristia. Teologia e<br />
Spiritualità della Preghiera Eucaristica (Torino 1969), 23: «Immaginare che la<br />
liturgia cristiana sia nata come da una specie di generazione spontanea, senza<br />
né padre né madre come Melchisedech, o attribuirle gratuitamente qualche<br />
paternità putativa che dimenticasse definitivamente la percezione della sua<br />
autentica genealogia, equivarrebbe a ridurre, fin dall’inizio, tutte le ricostruzioni<br />
a una impalcatura di controsensi più o meno intelligente, più o meno ingegnosa».<br />
Cf., anche R. LE DÉAUT, Liturgie Juive et Nouveau Testament. Roma<br />
1965, pp. 12-16.<br />
10 Quest’interpretazione era diffusa all’epoca del Secondo Tempio e in<br />
seguito, come testimonia la traduzione di Aquila (hyperbasis) e m.Pes 10,5:<br />
Cf., R. CANTALAMESSA, La Pasqua della nostra salvezza, Torino 1971, pp. 30.
come un esodo spirituale dalle passioni, dal proprio io e dalla<br />
prigione del proprio corpo: si tratta di un «passaggio» tutto<br />
spirituale, un’entrata nella luce e nella vita nuova 11 .<br />
Nella tradizione ebraica, la Pasqua è la festa primaverile di nascita<br />
del mondo, la festa della prima creazione, ma nello stesso tempo<br />
quella della nuova creazione: l’uomo è chiamato a un esodo spirituale,<br />
a divenire nuova creatura. «Pesah» significa pertanto passaggio<br />
dalla schiavitù alla libertà, dalle tenebre alla luce, dall’angoscia del<br />
peccato (in ebraico micräyîm,«Egitto», contiene in sé la parola<br />
cäräh, «angoscia») alla gioia della nuova creazione. Pasqua è<br />
anzitutto il passaggio di Dio, passaggio che ha il potere di far<br />
passare il popolo, di metterlo in cammino, di collocarlo in un nuovo<br />
dinamismo, di aprirgli la possibilità di un ex-odòs, di un «cammino<br />
fuori», insieme alla speranza di nuovi orizzonti inattesi e imprevedibili.<br />
La Pasqua ha in sé un dinamismo infinito, perché è il memoriale<br />
del passaggio di Dio, la cui potenza dinamica è, per l’appunto,<br />
infinita. Pasqua è quindi passaggio di Dio e passaggio del popolo<br />
e dell’uomo: vero «ebreo» è colui che «passa oltre» con Dio<br />
(`ibrî «ebreo», evoca la radice `br «passare oltre»), che compie<br />
l’esodo dal proprio Egitto, lasciandosi trascinare dalla forza<br />
divina liberatrice, che è pura forza motrice e iniziativa gratuita. Ciò<br />
è ben espresso da un passo della Mishnà, ripreso nell’Haggadah di<br />
Pasqua:<br />
Per questo noi abbiamo il dovere di ringraziare, di cantare, di lodare,<br />
di glorificare, di esaltare, di celebrare e di benedire colui che ha<br />
fatto, per i nostri Padri e per noi, tutti questi miracoli. Ci ha condotti<br />
dalla schiavitù alla libertà, dall’angoscia alla gioia, dal lutto alla festa,<br />
dalle tenebre alla luce, dalla schiavitù alla libertà. Cantiamo in<br />
suo onore, Alleluia 12 .<br />
Questo brano ha un forte carattere liturgico, come testimonia l’uso<br />
della prima persona singolare e l’invito alla lode. La redazione della<br />
Mishnà risale al II° sec. d.C. Sappiamo però che la liturgia è conservatrice<br />
per natura, per cui è probabile che tale passo sia una reliquia<br />
liturgica assai più antica.<br />
11 Cf., Filone, Spec. leg. II, 145-147; De Migr. 25.14 ; Quaest. in Ex. I,4.<br />
12 m.Pes 10,5<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
Pasqua d’Israele<br />
e Pasqua di Gesù<br />
273-294<br />
teologia<br />
277
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
MAURIZIO BUIONI C.P.<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
teologia<br />
278<br />
Melitone da Sardi riprende questo canto liturgico nella sua Omelia<br />
Pasquale e ne mostra il mirabile compimento in Gesù Cristo 13 :<br />
«Egli è colui che ci ha fatto passare dalla schiavitù alla libertà, dalle tenebre<br />
alla luce, dalla morte alla vita, dalla tirannide al regno eterno» 14 .<br />
La Pasqua cristiana è il passaggio di Gesù da questo mondo al Padre<br />
(Gv 13,1). In questo passaggio, l’uomo è coinvolto, anzi trasformato.<br />
La sua situazione esistenziale cambia radicalmente e le porte<br />
del cielo sono aperte per lui.<br />
L’immolazione dell’Agnello<br />
e l’Aqedà (legatura) d’Isacco<br />
L’immolazione<br />
dell’Agnello era<br />
di eccezionale<br />
importanza nella Pasqua<br />
ai tempi di Gesù.<br />
Nella tradizione orale ebraica, e in particolare in quella targumica,<br />
l’agnello è paragonato a Isacco. Il Targum Neofiti mette in bocca di<br />
Abramo queste parole: «Dio provvederà l’agnello per l’olocausto,<br />
altrimenti sarai tu l’agnello dell’olocausto» 15 . E subito dopo, Isacco<br />
chiede al padre: «Abbà! Legami bene, non sia che io non recalcitri<br />
e sia reso vano il tuo sacrificio» 16 . Secondo la tradizione ebraica,<br />
Abramo sacrifica Isacco nel monte del futuro Tempio di Gerusalemme,<br />
il giorno 14 di Nisan. Questa tradizione risale almeno a un secolo<br />
prima di Cristo, perché si trova nel Libro dei Giubilei secondo cui il sacrificio<br />
d’Isacco è avvenuto durante la Pasqua, in Sion 17 : «La legatura<br />
d’Isacco è il primo sacrificio pasquale» 18 . Isacco è così un simbolo dell’agnello<br />
pasquale che si doveva scegliere bene 19 , portare nel Tempio<br />
13 Per un confronto tra l’Haggadà di Pasqua e l’Omelia Pasquale di<br />
Melitone, Cf., F. MANNS, La prière d’Israël à l’heure de Jésus, in SBFAnalecta<br />
27, Jerusalem 1986, pp. 200-206.<br />
14 Cf., Perì Páscha 68. Cf., anche 1Pt 2,9-10.<br />
15 TgNGn 22,8.<br />
16 TgNGn 22,10; Cf., anche la versione di TgJ.<br />
17 Cf., Jub 17-18; 49,15.<br />
18 Cf., F. MANNS, L’Évangile de Jean à la lumière du judaïsme in<br />
SBFAnalecta 33, Jerusalem 1991, p. 425.<br />
19 Per rendersi conto della minuziosa scelta di un oggetto della festa, basti<br />
notare come gli ebrei ortodossi scelgano l’ethrog (cedro) all’inizio della festa di<br />
Sukkot. Con quanta maggior cura si sarà esaminato l’agnello, che doveva essere<br />
senza alcuna macchia (Es 12,5)! Es 12,3 prescrive che l’agnello si dovesse<br />
scegliere quattro giorni prima, perché si avesse il tempo di esaminarlo bene:<br />
Cf., il commento di Rashi ad loc.
perché fosse legato e immolato 20 . L’agnello pasquale, pertanto, era già<br />
personificato all’epoca di Gesù.<br />
L’agnello doveva essere Tämîm, «integro» e senza macchia<br />
(Es 12,5). Ora, questo termine è usato nell’AT sia per le vittime sacrificali,<br />
che devono essere perfette e immacolate 21 , come anche per<br />
l’uomo giusto e innocente 22 . La particolare perfezione dell’agnello<br />
era dovuta al fatto che è un animale mite e non recalcitra né si<br />
ribella dinanzi all’uccisore. Secondo la tradizione ebraica, Isacco<br />
aveva trentasette anni nel momento del suo sacrificio.<br />
La perfezione d’Isacco è dovuta all’intenzione del suo cuore e<br />
alla sua offerta, totalmente libera, alla passione. Abramo e Isacco si<br />
avviavano al monte del Tempio con «cuore perfetto» 23 . La tradizione<br />
dell’offerta libera d’Isacco era diffusa all’epoca del Secondo Tempio,<br />
come testimonia anche Giuseppe Flavio 24 . Questa tradizione è<br />
passata ai primi cristiani. Clemente scrive nella sua lettera ai<br />
Corinzi: «Isacco, conoscendo il futuro, con fiducia si fece volentieri<br />
condurre al sacrificio» 25 .<br />
L’immolazione dell’agnello avveniva nel Tempio, «tra le due sere»<br />
(come prescrive letteralmente Es 12,6) e il sangue dell’agnello<br />
era asperso sull’altare. Nell’immolazione dell’agnello ogni israelita<br />
era chiamato a sentirsi come Abramo e come Isacco (perché ciò che<br />
avveniva nei Padri era un segno per i figli). Ma non solo. Filone sottolinea<br />
che ogni ebreo nel giorno di Pasqua è elevato alla dignità di<br />
sacerdote 26 . Ogni ebreo è al tempo stesso Abramo e sacerdote: egli<br />
doveva immolare la vittima di propria mano 27 . Si tratta di un popolo<br />
20 m.Tam 4,1 spiega in modo minuzioso in che modo si dovesse legare l’agnello<br />
dell’offerta quotidiana (Tamid) e in che modo si dovesse immolarlo.<br />
21 Cf., ad es. Lv 1,3.10; 3,1.6; 4,3.23; 5,15.18.25; 22,19.21; 23,12; Nm<br />
6,14.<br />
22 Cf., ad es. Gn 6,9; 17,1; Dt 18,13; 2Sam 22,24.26<br />
23 TgNGn 22,6.8; Cf., TgJGn 22,8. L’aggettivo che traduciamo «perfetto»<br />
è l’aggettivo aramaico šälîm, che traduce l’ebraico Tämîm del TM, usato per<br />
indicare l’integrità della vittima sacrificale. Si tratta quindi di un cuore integro,<br />
nel senso che è adatto e bene accetto per il sacrificio.<br />
24 Gius. Flavio, Ant. Jud. 1,232.<br />
25 Clemente Alessandrino, Ad Cor. 31,3. Sul legame tra Pasqua e Isacco e<br />
la tipologia del suo sacrificio nella letteratura antica ebraica e nella prima letteratura<br />
cristiana, Cf., la sintesi di J. DANIÉLOU, Sacramentum futuri. Études sur<br />
les origines de la typologie biblique, Études de théologie historique,<br />
Paris 1950, pp. 97-111.<br />
26 Filone, De Spec. Leg. II, 146.<br />
27 Filone, De Vita Mosis II, 224 ; Cf., anche m.Pes 5,6.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
Pasqua d’Israele<br />
e Pasqua di Gesù<br />
273-294<br />
teologia<br />
279
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
MAURIZIO BUIONI C.P.<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
teologia<br />
280<br />
sacerdotale, che partecipa attivamente alla liturgia. Secondo Giovanni,<br />
Gesù è il Nuovo Isacco e il Nuovo Agnello Pasquale. Egli è<br />
l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo (Gv 1,29.36). Abramo<br />
ha visto il suo giorno e se ne rallegrò (Gv 9,56), il che vuol dire<br />
che è il Nuovo Isacco. Egli è legato nel giardino (Gv 18,12) e portato<br />
al processo, esaminato come un agnello. Gesù è portato al sacrificio,<br />
nell’ora in cui si cominciava ad immolare l’agnello nel Tempio<br />
(Gv 19,14). Quando, sulla croce, ebbe sete gli porsero un ramo di issopo<br />
28 con una spugna imbevuta d’aceto: poiché l’issopo non si addiceva<br />
ad un tale uso, si deve pensare che l’evangelista faccia un’altra<br />
allusione all’agnello pasquale, perché l’aspersione degli stipiti e<br />
dell’architrave delle porte con il sangue dell’agnello, secondo Es<br />
12,22, si faceva tramite l’issopo. Infine, come quell’agnello, a Gesù<br />
crocifisso non fu spezzato alcun osso (Gv 19,33.36). Per alcuni, questo<br />
è anche un chiaro riferimento al giusto sofferente descritto in<br />
Sal 34,21 29 . Qui, l’agnello è accostato al giusto sofferente: anche<br />
in Is 53,7 il servo di YHWH è paragonato a un «agnello condotto<br />
al macello», perché dinanzi alle umiliazioni «non aprì la sua<br />
bocca» 30 . Isacco, agnello, giusto-Servo sofferente: queste figure<br />
potevano essere legate già all’epoca del Secondo Tempio 31 . Così ha<br />
scritto A. Díez Macho: «i circoli teologici ebraici del I Sec.<br />
dell’era cristiana associarono Aqedá, Servo di Yahveh e sacrificio<br />
dell’agnello pasquale» 32 .<br />
La Chiesa Primitiva ha sottolineato che le figure sopra menzionate<br />
si sono compiute in Gesù Cristo. L’omelia pasquale di<br />
Melitone da Sardi dichiara che Gesù «è stato immolato come un<br />
agnello ed è risuscitato come Dio» 33 . Egli ha compiuto ciò che<br />
28 Purtroppo, la traduzione CEI non riporta questo termine così importante<br />
ed evocativo.<br />
29 Cf., M.L. RIGATO, «Gesù “l’Agnello di Dio”, Colui che toglie il peccato del<br />
mondo” (Gv 1,29), nell’immaginario cultuale giovanneo. Secondo Giovanni Gesù<br />
muore il 13 Nisan (Gv 18,28/19,14.31-37)», Atti del VII Simposio di Efeso su S.<br />
Giovanni Apostolo (ed. L. PADOVESE) (Roma 1999), pp. 110.<br />
30 Cf., anche Ger 11,19.<br />
31 Cf., A. DEL AGUA PÉREZ, El método midrásico y la exégesis del Nuevo<br />
Testamento Biblioteca Midrásica, vol. 4, Valencia 1985, pp. 142-143.<br />
32 A. DÍEZ MACHO, «Targum y Nuevo Testamento», Mélanges Eugènes<br />
Tisserant, I, Ecriture sainte - Ancient orient, Studi e Testi 231, Città del Vaticano<br />
1964, p. 162.<br />
33 Perì Páscha 1.
simboleggiava l’immolazione, la morte e il sangue dell’agnello 34 .<br />
Egli ricorda inoltre che «Gesù fu legato in Isacco», testimoniando in<br />
tal modo che la tradizione dell’Aqedà d’Isacco era importante anche<br />
per i cristiani 35 .<br />
Il Sangue dell’Agnello,<br />
il Sangue della<br />
Nuova Alleanza e il Memoriale<br />
Il sangue dell’agnello<br />
pasquale aveva<br />
una funzione fondamentale.<br />
Era un ´ot, un<br />
«segno» (Es 12,13), e<br />
uno zikkärôn, «un me-<br />
moriale» (Es 12,14). Il sangue dell’agnello negli stipiti (mezûzôt) delle<br />
porte aveva salvato Israele (Es 12,7.22). Il Libro dell’Apocalisse rimarca<br />
l’importanza del sangue dell’Agnello che è Cristo, che lava gli eletti,<br />
rendendo bianche le loro vesti, e li salva (Ap 7,14; 12,11).<br />
Si celebrava la Pasqua di generazione in generazione, con una notte<br />
di veglia in onore del Signore (Es 12,42) in cui il memoriale del sangue<br />
dell’Agnello e il memoriale della liberazione erano centrali. Il termine<br />
zikkärôn è spiegato da R. Gamaliel, un rabbino del I° sec. d.C.:<br />
In ogni generazione, ognuno deve considerarsi come se egli stesso<br />
fosse uscito dall’Egitto, perché il Santo, benedetto Egli sia, non<br />
liberò solo i nostri padri, ma con loro liberò anche noi 36<br />
«Zikkärôn» non significa però primariamente che l’uomo ricorda,<br />
ma che Dio stesso si ricorda della sua alleanza, a favore del suo<br />
popolo 37 . La festa di Pasqua, in quanto memoriale, è «una rappresentazione<br />
sacramentale» che rende attuale il passato ed è tesa all’avvenire<br />
e al compimento futuro 38 .<br />
34 Cf., Perì Páscha 44.60.<br />
35 Cf., Perì Páscha 59.<br />
36 m.Pes 10,4<br />
37 Cf., R. LE DÉAUT, «Pâque juive et Pâque chrétienne», Bible et vie<br />
chrétienne 62 (1965) 16; egli cita in proposito b.Ber 49a: «Benedetto sei tu,<br />
Signore nostro Dio...che hai donato al tuo popolo Israele questi giorni di festa<br />
per la gioia e in memoriale». Il «ricordo» da parte di Dio è un tòpos della<br />
tradizione biblica e rabbinica e si ritrova anche nel NT (Cf., Lc 1,72).<br />
38 Cf., R. LE DÉAUT, «Pâque juive et Pâque chrétienne», 20; E. TESTA, «Influssi<br />
giudeo-cristiani nella liturgia eucaristica della chiesa primitiva», Studia<br />
Hierosolymitana, II, Studi esegetici, in SBF Collectio Maior 23, Jerusalem 1976,<br />
pp. 202-204.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
Pasqua d’Israele<br />
e Pasqua di Gesù<br />
273-294<br />
teologia<br />
281
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
MAURIZIO BUIONI C.P.<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
teologia<br />
282<br />
Abbiamo già parlato dell’identificazione tra agnello pasquale e<br />
Isacco. Ora, nella tradizione ebraica c’è un legame tra il sangue dell’agnello<br />
pasquale e l’offerta che Isacco ha fatto del suo sangue: secondo<br />
la Mekhilta de-Rabbi Ishmael, per citare solo un esempio, il<br />
sangue che Dio vede negli stipiti delle porte non è altro che il sangue<br />
dell’Aqedà d’Isacco 39 . Anche il sangue d’Isacco è un memoriale 40 . Per<br />
la tradizione targumica poi, il sangue negli stipiti delle porte non è solo<br />
quello dell’agnello, ma anche quello della circoncisione e si rimarca che<br />
questo sangue gode di uno speciale merito, che Dio tiene in considerazione<br />
per la salvezza d’Israele 41 . Ora, nella tradizione, vi è un ulteriore<br />
legame tra il sacrificio di Isacco e la circoncisione: il sangue d’Isacco<br />
ha un grande merito e valore, perché la sua è un’offerta volontaria a Dio<br />
non di un solo membro, ma di tutte le sue membra 42 .<br />
Nel Targum, Abramo chiede a Dio: «Quando i suoi figli saranno<br />
nell’ora dell’angoscia, ricordati dell’Aqedà d’Isacco loro padre e ascolta<br />
la voce delle loro suppliche, ascoltali e liberali da ogni tribolazione»<br />
43 . L’Aqedà d’Isacco è un memoriale: grazie al merito d’Isacco e<br />
al fatto che Dio si ricorderà di tale merito, la salvezza si farà attuale<br />
per Israele, specialmente nella fatidica «ora» dell’angoscia 44 . La Pasqua<br />
è quindi un memoriale della liberazione dall’Egitto, dell’Aqedà<br />
d’Isacco e della sua liberazione, del sangue dell’agnello e del sangue<br />
d’Isacco, che hanno un grande potere espiatorio 45 .<br />
A questo punto, si deve rimarcare che tutte le realtà sopra menzionate,<br />
Aqedà d’Isacco, circoncisione, sangue della vittima hanno una<br />
stretta relazione con l’alleanza 46 . Nella Pasqua, il ricordo dell’allean-<br />
39 MekhShem 12,13.<br />
40 Cf., Tg1Cr 21,15.<br />
41 Cf., TgJEs 12,13.<br />
42 Cf., TgJGn 22,1. Sul legame tra sangue dell’agnello, sangue d’Isacco,<br />
sangue della circoncisione e morte di Cristo, Cf., l’ottima sintesi in M. REMAUD,<br />
Vangelo e tradizione rabbinica, Collana Studi biblici, 47, Bologna 2005, pp.<br />
119-135.<br />
43 TgNGn 22,14. Cf., anche la versione di TgJ e del TgFramm. (ms. 110).<br />
44 La tradizione ebraica è piena di riferimenti al merito d’Isacco e della sua<br />
Aqedà: Cf., ad es. TgCt 1,13; 2,17; TgMi 7,20; TgEst 5,1. Cf., M. REMAUD, À<br />
cause des pères – Le “Mérite des Pères” dans la tradition juive, Collection de<br />
la Revue des Études Juives 22, Paris-Louvain 1997, pp. 149-171.<br />
45 R. LE DÉAUT, «Pâque juive et Pâque chrétienne», 23.<br />
46 Secondo TgNLv 26,42 Dio ha fatto un’alleanza con Isacco sul Monte<br />
Moria.
za di Dio con il suo popolo è fondamentale. Durante la Cena, Gesù<br />
ha dato un nuovo significato al calice pasquale del vino, dicendo che<br />
in realtà quel vino era il «suo sangue dell’Alleanza versato per molti,<br />
in remissione dei peccati» (Mt 26,28; Cf., Mc 14,24), «la Nuova<br />
Alleanza, nel suo sangue» (Lc 22,20; Cf., 1Cor 11,25). Egli si riferiva<br />
al sangue dell’agnello, così importante nel rituale descritto in Esodo,<br />
ma certamente anche al «sangue dell’Alleanza» di cui si parla in<br />
Es 24, 8. Qui, Mosè asperge il popolo con il sangue dei sacrifici di<br />
comunione, dicendo: «Ecco il sangue dell’Alleanza» 47 .<br />
La preparazione della Pasqua<br />
e il pane azzimo<br />
La preparazione<br />
del banchetto<br />
pasquale era<br />
molto importante. La<br />
casa e il luogo del ban-<br />
chetto dovevano essere ben preparati e avere la bellezza e la dignità<br />
del Tempio 48 . Anche nel NT si rimarca l’importanza di questa preparazione:<br />
si parla di una sala grande e addobbata, con i tappeti, all’interno<br />
della città (Mc 14,12-16; Lc 22,7-13; Cf., Mt 26,17-19), perché<br />
l’agnello pasquale andava mangiato all’interno di Gerusalemme 49 .<br />
Una parte importante della preparazione era l’immersione nella<br />
mikwà (bagno di purificazione): si doveva mangiare la pasqua in<br />
stato di purità, come emerge anche da Gv 13,10.<br />
La ricerca e l’eliminazione del lievito, del Hämec, era un momento<br />
fondamentale di tale preparazione, già in Es 12,15 50 . Che tale ricerca<br />
era importante nel I° sec. d.C. lo testimonia S. Paolo: «Togliete<br />
via il lievito vecchio, per essere pasta nuova, poiché siete azzimi.<br />
E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato! Celebriamo dunque<br />
la festa non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia e perversità,<br />
ma con azzimi di sincerità e di verità» (1Cor 5,6-7). Togliere il<br />
lievito significava entrare nella festa, nella novità della Pasqua. La<br />
Pasqua è una vita nuova: non si può celebrare con il lievito vecchio<br />
47 E’ interessante notare che per Eb 9,19 anche quest’aspersione, proprio<br />
come quella di Es 12,22, veniva fatta con l’issòpo.<br />
48 Filone, De Spec. Leg., II, 148.<br />
49 Cf., m.Pes 7,9; BerR 5,2; 7,8; SifBem 69.<br />
50 Quanto tale prescrizione fosse importante nel III° sec. a.C. è testimoniato<br />
dal Papiro di Elefantina.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
Pasqua d’Israele<br />
e Pasqua di Gesù<br />
273-294<br />
teologia<br />
283
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
MAURIZIO BUIONI C.P.<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
teologia<br />
284<br />
e ciò è legato alla disposizione interiore e all’intenzione del cuore.<br />
La ricerca del lievito non è nell’ebraismo un precetto legalistico e stupido.<br />
Se si è disposti a ricercare il lievito vecchio e ad eliminarlo, si<br />
manifesta la serietà della Kawwanäh, vale a dire dell’intenzione decisa<br />
del proprio cuore di celebrare la festa in verità. Il «culto nella verità»<br />
è un motivo importante nell’ebraismo del I° sec d.C 51 .<br />
La Pasqua, come<br />
e più di ogni festa<br />
ebraica, è legata<br />
alla trasmissione<br />
della fede ai figli. Ciò risale alla Scrittura. Il rito stimola le domande<br />
dei figli: «Che cos’è per voi questo rito?» (Es 12,26). Nell’Haggadah<br />
di Pasqua attuale, questa domanda è espressa così: «Che cosa<br />
c’è di diverso questa notte, da tutte le altre notti?». I padri devono rispondere<br />
a partire dalla Scrittura, facendo memoriale, ovvero attualizzando<br />
la storia di salvezza: « È il sacrificio della Pasqua del Signore,<br />
che passò oltre le case dei figli d’Israele in Egitto, quando colpì<br />
l’Egitto e salvò le nostre case» (Es 12,27). Da qui partiva il racconto<br />
dei memoriali di salvezza operati dal Signore, in cui ciascuno si sentiva<br />
coinvolto in modo attivo, come protagonista. Questo racconto<br />
porta ancora oggi alla gratitudine e al canto del Dayyènu. In questa<br />
cornice, si può collocare il dialogo riportato da Giovanni tra Gesù e<br />
i suoi discepoli (13,36-16), che, come i figli, hanno difficoltà a capire<br />
e vanno istruiti con dolcezza e pazienza52 Il Banchetto Pasquale<br />
.<br />
Nel banchetto pasquale tre cibi erano fondamentali, già secondo<br />
Es 12,8: l’agnello (Pesah), gli azzimi (maccäh) e le erbe amare<br />
(märor). Una tradizione contenuta nella Mishnà, che risale a Rabbi<br />
Gamaliele (I° sec. d.C.) ci fornisce la spiegazione di questi tre cibi.<br />
51 Cf., D.MUÑOZ LEÓN, «Adoración en espíritu y verdad: aportación targúmica<br />
a la intelligencia de Jn 4,23-24» in Homenaje a Juan Prado . Miscelanea<br />
de estudios biblicos y hebraicos (edd.) J. PRADO-L. ALVAREZ VERDES-E.J. ALONSO<br />
HERNANDEZ, Madrid 1975, pp. 389-403.<br />
52 Simon Pietro domanda a Gesù: «Signore, dove vai?» (Gv 13,36);<br />
Tommaso gli domanda: «Come possiamo conoscere la via?» (Gv 14,6); Filippo<br />
gli dice: «Signore, mostraci il Padre e ci basta» (Gv 14,8) e ciò introduce un<br />
dialogo con il Maestro; Giuda domanda: «Signore, com’è accaduto che devi<br />
manifestarti a noi e non al mondo?» (Gv 14,22).
Non c’è ragione di non ritenere che questa spiegazione non fosse quella<br />
comune ai tempi di Gesù, perché è l’interpretazione più spontanea<br />
e legata alla Scrittura. Perché l’agnello? Perché Dio ha risparmiato le<br />
case dei Padri in Egitto. Perché il pane azzimo? Perché i Padri sono<br />
stati liberati dall’Egitto. Perché le erbe amare? Perché gli Egiziani<br />
hanno resa amara la vita dei Padri in Egitto 53 .<br />
Dopo il primo calice di vino, e la sua benedizione, cominciava l’intinzione<br />
di alcuni cibi, prima che fossero portati i pani azzimi 54 . Per chi<br />
conosce gli usi semitici, l’intinzione è un gesto di condivisione concreta<br />
del cibo e di comunione conviviale. Nella Pasqua di Gesù, quest’aspetto<br />
conviviale non ha niente di ambiguo: Gesù ha sperimentato che tra<br />
coloro a cui aveva offerto totale comunione vi poteva essere uno che lo<br />
tradisse e lo consegnasse alla morte. La Pasqua di Gesù è così amore totale<br />
al nemico, amore nella dimensione della croce.<br />
In seguito, venivano portati i pani azzimi. Secondo l’Haggadah di<br />
Pasqua, il pane azzimo simboleggia «il pane dell’afflizione», che i Padri<br />
hanno mangiato in Egitto. L’espressione aramaica si può tradurre però<br />
«Pane afflitto». Qui il pane è personificato: il pane è paragonato alla<br />
persona anche in 1Cor 5,7 55 .<br />
Durante il banchetto era obbligatorio bere vino. La tradizione di quest’obbligo<br />
è precedente alla nascita di Cristo, com’è testimoniato dal Libro<br />
dei Giubilei 56 . Secondo la Mishnà, anche il povero ha diritto alle<br />
quattro coppe di vino 57 . Doveva essere vino rosso: le prescrizioni che<br />
abbiamo in proposito sono posteriori a Gesù, ma si può intuire (anche<br />
dalla relazione tra vino e sangue) che era così anche al suo tempo 58 .<br />
L’obbligo di bere vino è un simbolo chiaro: chi celebra la Pasqua non<br />
può essere nella tristezza, ma deve partecipare alla gioia della libertà.<br />
Uno schiavo non beve vino. Il vino simboleggia la festa e la libertà,<br />
che ciascuno deve sperimentare nel banchetto pasquale.<br />
53 Cf., m.Pes 10,5. La tradizione delle erbe amare è ripresa da Melitone da<br />
Sardi, Perì Páscha, 93, ma qui l’amarezza è riferita alla passione di Cristo.<br />
54 Ciò è testimoniato da m.Pes 10,2.<br />
55 Cf., D.B. CARMICHAEL, «David Daube on the Eucharist and the Passover<br />
Seder», JSNT 42 (1991), 49. D. Daube ha collocato però l’istituzione<br />
dell’Eucarestia nel contesto del misterioso afikoman del Seder Pasquale: Cf.,<br />
pp. 45-67.<br />
56 Cf., Jub 46,6.9.<br />
57 Cf., m.Pes 10,1.<br />
58 Cf., le fonti citate in J. JEREMIAS, Le parole dell’ultima cena, Biblioteca di<br />
cultura religiosa, 23, Brescia 1973, p. 58.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
Pasqua d’Israele<br />
e Pasqua di Gesù<br />
273-294<br />
teologia<br />
285
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
MAURIZIO BUIONI C.P.<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
teologia<br />
286<br />
Un altro simbolo importante di libertà era il fatto di mangiare<br />
distesi e appoggiati sul gomito, testimoniato dalla Mishnà: anche<br />
Gesù e i suoi discepoli hanno celebrato la Pasqua distesi (Mc 14,18;<br />
Mt 26,20; Lc 22,14; Gv 13,12.28), il discepolo che Gesù amava era<br />
«disteso» (anakeímenos) nel seno di Gesù (Gv 13,23) e così si<br />
spiega meglio il suo gesto di reclinarsi sul petto di Gesù, descritto<br />
in Gv 13,25 59 .<br />
Il Targum Neofiti contiene il famoso poema delle Quattro Notti, le<br />
cui tradizioni erano conosciute all’epoca del Secondo Tempio. In esso<br />
si trova una densa interpretazione teologica della Pasqua 60 . La prima notte<br />
è quella della creazione: si tratta di una notte in cui la Parola di Dio<br />
fu la luce. La Pasqua è una notte piena di luce. Sul legame tra Pasqua e<br />
luce, occorre notare che la festa coincide con la luna piena dell’equinozio<br />
di primavera, che la schiavitù è interpretata già nella Bibbia come<br />
tenebra e la liberazione come luce 61 . La seconda notte è quella della<br />
rivelazione di Dio ad Abramo: si ricorda l’Aqedà d’Isacco. La terza<br />
notte è quella dell’Esodo: Dio appare mostrando che il suo figlio primogenito<br />
è Israele. Circa la quarta notte si dice:<br />
La quarta notte il mondo arriverà alla sua fine per essere dissolto;<br />
i gioghi di ferro saranno spezzati e le generazioni perverse saranno<br />
annientate. Mosè salirà dal mezzo del deserto e il Re Messia verrà<br />
dall’alto. Uno camminerà alla testa del gregge e l’altro camminerà<br />
alla testa del gregge e la sua Parola camminerà fra i due. Io e loro<br />
cammineremo insieme. E’ la notte di Pasqua per la liberazione di<br />
tutte le generazioni d’Israele 62 .<br />
59 Cf., m.Pes 10,1.<br />
60 Lo studio approfondito del poema delle quattro notti e delle sue tradizioni<br />
si trova nella nota opera di R. LE DÉAUT, La Nuit Pascale. Essai sur la signification<br />
de la Pâque juive à partir du Targum d’Exode XII,42, in AnBib 22, Roma<br />
1963.<br />
61 Così TgIs 9,1 interpreta il versetto in chiave pasquale: «Il popolo, la casa<br />
d’Israele, che camminava in Egitto come nelle tenebre, è uscito per<br />
contemplare una grande luce».<br />
62 TgNEs 12,42. Sull’interpretazione messianica di questo versetto, Cf., l’ottimo<br />
studio di M. PÉREZ FERNÁNDEZ, Tradiciones mesiánicas en el Targum<br />
Palestinense. Éstudios exegéticos, (Institución San Jerónimo 12) (Valencia-<br />
Jerusalén, 1981), pp. 173-209.
Nel Talmud si trova il medesimo legame tra creazione, esodo e<br />
nuova creazione: il trattato Rosh Ha-Shanà afferma che in Nisan<br />
avvenne la creazione del mondo e la liberazione dall’Egitto e che in<br />
Nisan sarebbe avvenuta la liberazione futura; così conclude questo<br />
testo: «E’ in Nisan che essi furono liberati, è in Nisan che lo saranno<br />
ancora» 63 .<br />
La notte pasquale era la notte dell’attesa del Messia, una notte piena<br />
di significato escatologico 64 : in questa notte si sono concentrate<br />
tutte le speranze di salvezza e di liberazione 65 . I salmi di Hallel, che<br />
erano parte della liturgia domestica della Pasqua, sono salmi densi di<br />
riferimenti messianici.<br />
La tradizione ebraica della venuta del Cristo nella notte di Pasqua<br />
è conosciuta da S. Girolamo:<br />
Una tradizione ebraica dice che Cristo verrà a mezzanotte, come al<br />
tempo dell’Egitto, quando si celebrò la Pasqua e venne l’angelo<br />
sterminatore e il Signore passò sopra le case e gli stipiti delle nostre<br />
fronti furono consacrati con il sangue dell’Agnello 66 .<br />
63 b.RHsh 11a. Notiamo che R. Yehoshua, a cui il detto qui contenuto è attribuito,<br />
è della fine del I° sec. d.C. Quest’idea doveva essere diffusa tra gli zeloti<br />
e questo spiega la paura di ribellioni durante la festa di Pasqua.<br />
64 Così recita TgLam 2,22: «Tu chiamerai il tuo popolo alla libertà, la casa<br />
d’Israele, per mezzo del Messia, allo stesso modo in cui hai fatto per mezzo di<br />
Mosè e Aronne, nel giorno di Pasqua». Che la notte di Pasqua avesse un forte<br />
significato escatologico già al tempo di Gesù, è testimoniato anche da Ger<br />
38,8 (LXX): qui si aggiunge al TM che la salvezza e il raduno del popolo dall’esilio<br />
avverrà en eort fasek («nella festa di Pasqua»).<br />
65 Anche nel libro di Ester, la liberazione avviene la notte di Pasqua: in TgEst<br />
5,14 e 6,1 si sottolinea l’importanza della notte. Nel NT, Pietro è liberato dal<br />
carcere durante la notte di Pasqua (At 12,1-18).<br />
66 Girolamo, In Matth. IV,25,6. Per questa ragione, continua S. Girolamo,<br />
non è lecito che la Veglia Pasquale finisca prima di mezzanotte. Che tale tradizione<br />
fosse forte tra i primi cristiani, specialmente quelli proveniente dall’ebraismo,<br />
è testimoniato da un manoscritto dell’IX° secolo che riporta una tradizione<br />
che risalirebbe addirittura al Vangelo degli Ebrei, uno dei più antichi vangeli<br />
apocrifi (II° sec. d.C.); è stato merito di R. CANTALAMESSA, La Pasqua della<br />
nostra salvezza, pp. 209-210, aver destato per la prima volta l’attenzione sull’interesse<br />
di questo testo. La tradizione era già presente in Lattanzio, Div. instit.<br />
VII, 19,3.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
Pasqua d’Israele<br />
e Pasqua di Gesù<br />
273-294<br />
teologia<br />
287
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
MAURIZIO BUIONI C.P.<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
teologia<br />
288<br />
Brevi cenni di sintesi<br />
teologica: Pasqua ed Eucaristia<br />
Tentiamo ora di<br />
trarre alcune<br />
conclusioni in<br />
relazione all’Eucaristia.<br />
Qui ci soffermiamo so-<br />
lo su alcuni elementi della Pasqua ebraica, per mostrare il loro compimento<br />
nella Pasqua cristiana e nell’Eucaristia, come paradigma.<br />
Siamo consapevoli di non aver trattato altri elementi fondamentali,<br />
come la frazione del pane, per citare solo un esempio.<br />
Anzitutto, si deve riconoscere che è impossibile comprendere numerosi<br />
elementi dei Vangeli, del NT e della liturgia cristiana, senza<br />
conoscere la liturgia e le feste ebraiche. Afferma R. Le Déaut:<br />
Sarebbe impoverire in modo particolare il significato delle feste cristiane<br />
il non rimetterle nella così ricca cornice della tradizione ebraica,<br />
dove esse sono nate. La liturgia del tempio e quella della sinagoga<br />
possono essere considerate come la culla della nuova religione 67 .<br />
Occorre però sottolineare qui non solo la continuità, ma anche il<br />
compimento avvenuto nella liturgia cristiana, compimento che implica<br />
anche una discontinuità, o meglio un certo «superamento» 68 e ciò<br />
vale anche per la festa di Pasqua:<br />
Celebrando l’ultima Cena con i suoi Apostoli durante un banchetto<br />
pasquale, Gesù ha dato alla pasqua ebraica il suo significato<br />
definitivo. Infatti, la nuova Pasqua, il passaggio di Gesù al Padre<br />
attraverso la sua Morte e la sua Risurrezione, è anticipata<br />
nella Cena e celebrata nell’Eucaristia, che porta a compimento la<br />
pasqua ebraica e anticipa la pasqua finale della chiesa nella gloria<br />
del Regno 69 .<br />
67 Cf., R. LE DÉAUT, Liturgie juive et Nouveau Testament: le témoignage des<br />
versions araméennes, Scripta Pontificii Instituti Biblici, 115, Rome 1965, p. 18.<br />
68 Come ha sottolineato la Pontificia Commissione Biblica nel suo<br />
documento Il popolo ebraico e le sue sacre scritture nella Bibbia cristiana (Città<br />
del Vaticano 2001) II,21, non si dovrebbe mai dimenticare questo<br />
elemento del superamento, per un’equilibrata teologia del compimento, secondo<br />
il principio di Ambrogio Autpert: non solum impletur, verum etiam transcenditur<br />
(Cf., n. 39).<br />
69 CCC 1340.
Benedetto XVI ha affermato esplicitamente che Gesù ha celebrato<br />
la cena pasquale e ha seguito i riti d’Israele. Egli ha voluto tuttavia<br />
sottolineare nel contempo la novità della Nuova Alleanza nel sangue<br />
di Cristo:<br />
Insieme con i discepoli Egli celebrò la cena pasquale d’Israele, il<br />
memoriale dell’azione liberatrice di Dio che aveva guidato Israele<br />
dalla schiavitù alla libertà. Gesù segue i riti d’Israele. Recita sul<br />
pane la preghiera di lode e di benedizione. Poi però avviene una<br />
cosa nuova. Egli ringrazia Dio non soltanto per le grandi opere del<br />
passato; lo ringrazia per la propria esaltazione che si realizzerà<br />
mediante la Croce e la Risurrezione, parlando ai discepoli anche<br />
con parole che contengono la somma della Legge e dei Profeti:<br />
“Questo è il mio Corpo dato in sacrificio per voi. Questo calice è la<br />
Nuova Alleanza nel mio Sangue” 70 .<br />
Ogni domenica, il cristiano celebra la Pasqua. Questo era chiaro<br />
per i primi cristiani. Eusebio di Cesarea afferma: «I seguaci di Mosè<br />
immolavano l’agnello pasquale una sola volta l’anno, il 14 del primo<br />
mese, a sera. Noi, invece, uomini del Nuovo Testamento, celebrando<br />
la nostra Pasqua tutte le domeniche, ci saziamo in continuazione del<br />
Corpo del Salvatore e comunichiamo in continuazione al Sangue dell’agnello<br />
(...). Perciò ogni settimana noi celebriamo la nostra Pasqua» 71 .<br />
Ma anche ogni celebrazione dell’Eucaristia è celebrazione della<br />
Pasqua, come asserisce decisamente (e polemicamente) S. Giovanni<br />
Crisostomo: «La Pasqua si celebra tre volte la settimana, talvolta<br />
anche quattro, o piuttosto ogni volta che lo vogliamo. La Pasqua<br />
infatti non consiste nel digiuno, ma nell’oblazione e nel sacrificio che<br />
si realizza in ogni sinassi» 72 .<br />
Se è vero che la celebrazione dell’Eucaristia è celebrazione della<br />
Pasqua, gli elementi teologici antichi e fondamentali della Pasqua<br />
Ebraica, sopra delineati, possono illuminare alcuni aspetti della<br />
teologia dell’Eucaristia. Ciò che si predica della Pasqua si può<br />
predicare dell’Eucaristia.<br />
70 Omelia durante la S. Messa a Colonia, in occasione della XX Giornata<br />
Mondiale della Gioventù, 21/08/2005.<br />
71 De solemnitate paschali, 7.<br />
72 Adv. Iudaeos, III,4.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
Pasqua d’Israele<br />
e Pasqua di Gesù<br />
273-294<br />
teologia<br />
289
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
MAURIZIO BUIONI C.P.<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
teologia<br />
290<br />
L’Eucaristia, in quanto Pasqua, è un passaggio di Dio, che fa passare<br />
l’uomo dalla schiavitù alla libertà, dalla morte alla vita, da questo<br />
mondo al Regno. Questo implica l’importanza di sottolineare<br />
l’aspetto dinamico dell’Eucaristia, come i Vescovi hanno fatto recentemente:<br />
«Nella celebrazione dell’Eucaristia Gesù, sostanzialmente<br />
presente, ci introduce tramite il Suo Spirito nella pasqua: passiamo<br />
dalla morte alla vita, dalla schiavitù alla libertà, dalla tristezza alla<br />
gioia. La celebrazione dell’Eucaristia rafforza in noi questo dinamismo<br />
pasquale e consolida la nostra identità» (cors. nostro) 73 .<br />
L’Eucaristia, in quanto Pasqua, implica in sé il concetto di<br />
sacrificio. La categoria del sacrificio va vista però nel contesto del<br />
compimento da parte di Gesù Cristo delle realtà anticotestamentarie,<br />
sopra delineate: Gesù è il Vero Agnello Pasquale, il Nuovo Isacco,<br />
il giusto-Servo sofferente. Egli ha il potere di liberare l’uomo dal<br />
peccato, grazie alla sua libera offerta di sé e al suo sangue, che è un<br />
memoriale di salvezza. L’offerta libera e volontaria di Cristo sulla<br />
Croce, la sua non resistenza al male, il suo compiere il Servo di YHWH<br />
di Is 53 indicano che egli è l’Uomo Nuovo del Sermone della<br />
Montagna, l’Uomo della Pasqua che ha travalicato l’impossibilità di<br />
amare: la sua donazione, il suo sacrificio è già Resurrezione e ci<br />
rende partecipi di questa. E’ così possibile per il cristiano, grazie<br />
alla potenza dinamica dell’Eucaristia, il cambiamento di vita. Così<br />
hanno affermato recentemente i vescovi:<br />
Nel contesto della cena rituale ebraica, che concentra nel memoriale<br />
l’evento passato della liberazione dall’Egitto, la sua rilevanza<br />
presente e la promessa futura, Gesù inserisce il dono totale di Sé.<br />
Il vero Agnello immolato si è sacrificato una volta per tutte nel<br />
mistero pasquale ed è in grado di liberare per sempre l’uomo dal<br />
peccato e dalle tenebre della morte 74 .<br />
Il concetto di sacrificio non va inteso pertanto come un concetto<br />
statico, ma come parte del Mistero Pasquale: l’Eucaristia rende presente<br />
e attuale il Sacrificio che Cristo ha offerto al Padre sulla croce,<br />
la sua totale auto-donazione, e in questo senso è un memoriale e non<br />
solo una memoria. Dio «si ricorda» del Nuovo Isacco e del Vero<br />
73 Propositio n°3, XI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi,<br />
23/10/05.<br />
74 Propositio n°3, XI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi,<br />
23/10/05.
Agnello, possiamo essere totalmente liberi e rinnovati, entrare nella<br />
festa. Abbiamo visto come nell’immolazione dell’agnello, durante la<br />
Pasqua, ogni israelita era sacerdote. La Chiesa è veramente un<br />
popolo sacerdotale (Cf., 1Pt 2,5.9; Ap 1,6; 5,10; 20,6), chiamato<br />
alla partecipazione attiva, pur nel rispetto del ruolo insostituibile del<br />
sacerdozio ministeriale.<br />
L’Eucaristia, in quanto Pasqua, è un memoriale di salvezza, la<br />
B e räkäh di tutte le B e räkôt, un solenne canto di esultanza per gli<br />
interventi di salvezza che Dio ha operato nella storia, in primo luogo<br />
dell’Esodo di Cristo, che è il suo Mistero Pasquale: la Pasqua è un<br />
canto alla Resurrezione di Cristo. La Liturgia della Parola è questa<br />
proclamazione della salvezza operata, che è resa attuale e viva<br />
nell’oggi concreto dell’assemblea. Se è vero che, per il cristiano,<br />
l’Esodo si è compiuto nel Mistero Pasquale di Cristo, «fare<br />
memoriale» significa che in Cristo si fa attuale per lui la libertà<br />
dalla schiavitù: in modo sacramentale, egli passa con Cristo da<br />
questo mondo al Regno dei Cieli.<br />
Nell’Eucaristia, come nella Pasqua, si fa memoriale degli eventi<br />
di salvezza, facendo risuonare la Parola ascoltata. La Parola dovrebbe<br />
trovare la sua eco nella vita concreta del Popolo di Dio, di modo<br />
che ciascun membro si possa sentire parte attiva della storia di<br />
salvezza che Dio continua ad operare e possa dare gloria a Dio.<br />
Nell’Eucaristia, come nella Pasqua, è fondamentale la trasmissione<br />
di fede ai figli, che si domandano: «Perché questo rito?». Ciò<br />
deve dare l’occasione ai genitori di testimoniare che la Parola<br />
ascoltata si è fatta carne nella loro vita e si farà carne, se accolta, di<br />
generazione in generazione.<br />
Nell’Eucaristia, in quanto Pasqua, la preparazione spirituale e<br />
materiale è molto importante. Ogni celebrazione è pasquale: ciò si<br />
deve riflettere nella bellezza degli spazi liturgici e nella preparazione<br />
materiale e spirituale. La Chiesa deve risplendere, anche<br />
esteriormente, della bellezza della Pasqua e della bellezza di Cristo.<br />
Ogni Eucaristia è un banchetto pasquale e ciò significa che ogni<br />
Eucaristia è una festa. Questo suo essenziale carattere festivo,<br />
proveniente dal suo carattere pasquale, deve sempre essere evidente,<br />
sebbene nel rispetto della diversità dei tempi liturgici, come ad<br />
esempio la Quaresima 75 . Il vino è un simbolo della festa: è un<br />
75 Occorre notare che in Quaresima il carattere festivo di alcuni segni è<br />
diminuito solo in ragione della Pasqua, perché questa sfolgori con più forza,<br />
anche nei segni concreti, come Festa delle feste e Solennità delle solennità.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
Pasqua d’Israele<br />
e Pasqua di Gesù<br />
273-294<br />
teologia<br />
291
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
MAURIZIO BUIONI C.P.<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
teologia<br />
292<br />
peccato che dopo aver ascoltato il comando di Cristo: «Prendetene e<br />
bevetene tutti», l’assemblea non possa comunicare al Sangue di<br />
Cristo e si perda così il segno visibile della festa nella celebrazione.<br />
Per di più, il fatto che si usi spesso e volentieri il vino bianco sminuisce<br />
(non nella sostanza ovviamente, ma di sicuro nella visibilità del<br />
segno!) la forza delle parole d’istituzione: «Questo è il mio sangue».<br />
Ogni Eucaristia, in quanto Pasqua, è entrare nel riposo messianico,<br />
unirsi alla Liturgia Celeste, pregustare il Cielo. Nell’Eucaristia si<br />
sperimenta la vera libertà dalla schiavitù del peccato, si è come<br />
«distesi» con Cristo, che passa a servirci, e al cui seno, come il<br />
discepolo che Gesù amava, possiamo accostarci. Nel banchetto<br />
Pasquale sperimentiamo l’intimità conviviale con il Messia: «Ecco,<br />
sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la<br />
porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me» (Ap 3,20).<br />
Tale unione con Cristo nel banchetto pasquale è un’anticipazione<br />
della vita eterna.<br />
Ogni Eucaristia, in quanto Pasqua, è densa di attesa escatologica<br />
e messianica. Si annuncia la morte del Signore finché egli venga<br />
(1Cor 11,26), gridando: «Maranathà! Vieni Signore Gesù» (1Cor<br />
16,22; Ap 22,20).<br />
L’Eucaristia, com’era celebrata nella Chiesa primitiva, ha affascinato<br />
un rabbino capo di Roma, che in un giorno di Yom Kippur<br />
riconobbe in Gesù il Messia. Egli, grazie al suo contatto vivo con<br />
l’ebraismo, poteva comprendere bene tutta la forza pasquale insita<br />
nell’Eucaristia:<br />
Rimasi, per così dire, incatenato alla Dottrina Apostolica sull’Eucaristia<br />
per anni. Rubacchio ancora oggi ogni tanto un pò di tempo a<br />
me stesso, anche se talvolta mi piego sotto il peso dei lavori, pur di<br />
ritornare alla Didachè, al capitolo sull’Eucaristia 76 .<br />
76 E. ZOLLI, Prima dell’alba, Cinisello Balsamo 2004 2 , p. 189.
ISRAEL’S PASCH AND JESUS’ PASCH<br />
ENG<br />
A few points regarding the Eucharist<br />
By Maurizio Buioni C.P.<br />
Research into the Hebrew roots of our <strong>Christi</strong>an faith is a hot theme<br />
in today’s theology. Illuminist egalitarianism which sought to level<br />
everything impeded our being able to perceive the manner in which<br />
God’s salvation entered the world through a Church which arose<br />
from Hebrew revelation and within the ambience of Hebrew culture.<br />
The author of this article takes us back to the theme of the Pasch and<br />
the Eucharist, with a precise study of the fonts.<br />
ESP<br />
PASCUA DE ISRAEL Y PASCUA DE JESÚS.<br />
Algunos elementos en relación con la Eucaristía.<br />
De Maurizio Buioni C.P.<br />
La investigación de las raíces hebreas de la fe cristiana es un tema<br />
de los más actuales de la Teología hodierna. El igualitarismo iluminista<br />
que todo lo aplanaba nos había impedido percibir el modo<br />
con el que la salvación de Dios ha llegado al mundo mediante una<br />
Iglesia nacida de la revelación hebrea y en el ámbito de la cultura<br />
hebrea. El autor de este artículo nos hace volver hacia aquello que<br />
relaciona la Pascua y la Eucaristía, mediante un meticuloso estudio<br />
de las fuentes.<br />
DAS PASCHA ISRAELS UND DAS PASCHA JESU<br />
GER<br />
Einige Aspekte zur Eucharistie<br />
von Maurizio Buioni C.P.<br />
Die Erforschung der hebräischen Wurzeln des christlichen Glaubens<br />
ist eines der aktuellsten Themen in der modernen Theologie. Die<br />
alles einebnende Wirkung des Egalitarismus der Aufklärung haben<br />
uns daran gehindert, wahrzunehmen, in welcher Art und Weise das<br />
Heil Gottes in die Welt gekommen ist; nämlich durch eine Kirche,<br />
die aus der hebräischen Kultur mit ihren Offenbarungsinhalten<br />
hervorgegangen ist. Gestützt auf ein fundiertes Quellenstudium<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
Pasqua d’Israele<br />
e Pasqua di Gesù<br />
273-294<br />
teologia<br />
293
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
MAURIZIO BUIONI C.P.<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
teologia<br />
294<br />
trägt der Autor für das Studium von Pascha und Eucharistie diesem<br />
Hintergrund Rechnung.<br />
PASCHA IZRAELA I PASCHA JEZUSA.<br />
Wybrane zagadnienia w odniesieniu do Eucharystii<br />
Maurizio Buioni C.P.<br />
POL<br />
Poszukiwanie żydowskich korzeni wiary chrześcijańskiej jest<br />
jednym z bardziej aktualnych tematów teologii współczesnej.<br />
Egalitaryzm oświeceniowy, który wszystko spłaszczał, przeszkodził<br />
nam w zrozumieniu sposobu, w jaki zbawienie Boże przyszło na<br />
świat poprzez Kościół, który powstał dzięki żydowskiemu<br />
objawieniu i w kręgu żydowskiej kultury. Autor tego artykułu<br />
powraca do tematów, które dotyczą Paschy i Eucharystii, opierając<br />
się na dokładnej analizie źródeł.
di ADOLFO LIPPI C. P.<br />
Almeno fino al Concilio Vaticano II non si osava fondare la<br />
Morale sociale sulla carità. Si pensava che l’etica sociale<br />
dovesse fondarsi sulla giustizia<br />
nei rapporti di scambio.<br />
La Bibbia propone di fatto un’etica<br />
sociale fondata sul dono, resa<br />
possibile da un atteggiamento<br />
kenotico che si basa sulla teologia<br />
della Croce.<br />
E’ pensabile un fondamento di<br />
questo genere per l’etica nell’attuale<br />
società secolarizzata?<br />
L’articolo fa riferimento ad alcuni<br />
autori che di fatto hanno dichiarata<br />
possibile ed anche urgente<br />
questa fondazione e soprattutto al<br />
pensiero sociale di Benedetto XVI.<br />
1. Bibbia e Sociologia:<br />
qualche parola fondante<br />
I FONDAMENTI<br />
STAUROLOGICI<br />
DI UN’ETICA<br />
SOCIALE<br />
CRISTIANA<br />
Quale etica sociale<br />
discende dalla<br />
Teologia della Croce?<br />
Il capitolo ventesimo<br />
di Matteo ci<br />
presenta un quadretto<br />
pittoresco. Due<br />
dei discepoli più vicini<br />
a Gesù, gli apostoli, mandano avanti la loro mamma per strappare al<br />
Maestro una concessione che può essere molto importante per il loro<br />
futuro: dì che questi miei figli siedano uno alla tua destra e l’altro alla<br />
tua sinistra nel tuo Regno. Sedere alla destra e alla sinistra di un re o<br />
di un personaggio molto importante era un’immagine-simbolo<br />
immediatamente comprensibile nelle culture orientali. Significava<br />
condividere il potere di quel re o personaggio. Tanto è vero che gli<br />
altri discepoli capiscono a volo il senso del tentativo fatto dai due<br />
fratelli: lo vedono come un tentativo di garantirsi il potere a<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
I fondamenti<br />
staurologici<br />
di un’etica<br />
sociale cristiana<br />
295-311<br />
teologia<br />
295
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
ADOLFO LIPPI C.P.<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
teologia<br />
296<br />
loro danno, di diventare i primi nel nuovo Regno che stavano<br />
aspettando.<br />
Gesù avrebbe potuto inquietarsi per l’ottusità che gli apostoli<br />
manifestano in questi litigi, nonostante i lunghi anni di insegnamento<br />
e immediatamente dopo una sua predizione della <strong>Passio</strong>ne. Invece<br />
instaura con i due fratelli un dialogo il cui senso sarà capito forse<br />
soltanto molto tempo dopo, un dialogo nel quale si ha l’impressione<br />
che alle parole che vengono dette, quali il bere il mio calice, ognuno<br />
dia un senso differente. Poi Gesù chiama tutti i discepoli e fa una<br />
lezione che si può considerare fondante per la sociologia e per l’etica<br />
sociale cristiana. Egli contrappone due impostazioni sociologiche:<br />
quella delle genti, dei goyim, e quella del popolo di Dio, soprattutto<br />
dei suoi discepoli. La sociologia dei gentili è fondata sul diritto<br />
del più forte al quale i deboli debbono necessariamente piegarsi.<br />
La sociologia di Gesù è fondata sull’abbassamento per cui chi è più<br />
forte si mette a servizio, come è logico che sia perché la Vita si<br />
espanda e come, soprattutto, è logico per il fondamento che Lui stesso,<br />
il Figlio di Dio, dà a tale comportamento: il Figlio dell’Uomo è<br />
venuto per servire e non per essere servito, è venuto per dare la vita<br />
(cf Mt 20, 20-28). E’ chiaro qui che la sociologia cristiana deve essere<br />
fondata sul servizio incondizionato e gratuito ed anche che il fondamento<br />
definitivo del servizio, come della stessa concezione cristiana<br />
dei rapporti sociali, è la Croce.<br />
Se ci rimanesse qualche dubbio su questa impostazione sociologica<br />
evangelica, il capitolo venticinquesimo, sempre di Matteo, è lì<br />
per dissiparlo. In una maniera assolutamente inusitata, Gesù si<br />
immedesima con i fratelli più piccoli, enumerando alcuni paradigmi<br />
di indigenza ben presenti nella Bibbia ebraica, soprattutto nei profeti:<br />
ero affamato, assetato, nudo, malato, forestiero, prigioniero… Tra<br />
queste categorie è presente anche quella dei carcerati, che normalmente<br />
sono ritenuti responsabili del loro stato, non sono ritenuti<br />
degli innocenti che sono stati soltanto sfortunati, come, magari, i<br />
malati. Come vi siete comportati con i fratelli più piccoli, con gli<br />
ultimi della società in cui vivete, vi siete comportati con me: questo<br />
è il giudizio dei singoli, dei gruppi, della stessa umanità (cf Mt 25,<br />
25-40). Qui la carità non è una qualunque benevolenza: essa è orientata,<br />
orientata verso il basso. Se aiutate coloro da cui sperate avere<br />
una ricompensa, che merito ne avete? (cf Mt 5, 45-48). La carità è<br />
gratuità, la gratuità fonda la morale sociale, la sociologia.<br />
Rapportare questo insegnamento con la dottrina della kenosi
espressa in Fil 2 non è arbitrario: il fratello più grande che si china<br />
sul più piccolo attua in sé la kenosi del Signore e realizza, non in<br />
maniera devozionistica o fantastica, ma in maniera reale ed etica, la<br />
conformazione a Cristo della quale Paolo parla diverse volte (cf ad<br />
es. Rom 8, 29). Ci si configura a Cristo quando si rovescia l’atteggiamento<br />
di base dell’uomo che tende a elevarsi sopra gli altri<br />
seguendo la catechesi del serpente: sarete come Dio, arbitri del bene<br />
e del male; e si assume quell’atteggiamento che porta ad abbassarsi<br />
per amore. Aimer c’est s’abaisser, diceva con profonda sapienza<br />
Santa Teresa di Lisieux, dottore della Chiesa.<br />
C’è un’impressionante coerenza fra tutti gli insegnamenti del<br />
Nuovo Testamento (e, implicitamente, dell’Antico) e fra gli insegnamenti<br />
e i fatti, come rileva il celebre paragrafo 2 della Dei Verbum.<br />
Se si cerca quale può essere il punto matematico in cui tutti gli<br />
insegnamenti e i fatti convergono, dobbiamo dire che esso è la<br />
Croce. La Croce è servizio e regno, è gloria e nascondimento (Deus<br />
absconditus revelatus di Lutero), è amore e legge, è obbedienza e<br />
libertà, la libertà del dono, la libertà, cioè la possibilità di amare, è<br />
kenosi e ricchezza.<br />
2. I tentativi di andare oltre la<br />
correttezza nello scambio nella<br />
dottrina sociale cristiana<br />
Da queste brevissime<br />
riflessioni<br />
biblico-teologiche<br />
risulta chiaro che<br />
l’agire sociale cristiano<br />
procede dalla teologia<br />
della Croce e da essa riceve la sua identità che lo differenzia da ogni<br />
altra etica sociale. Questa persuasione, però, entra in crisi se ci si<br />
confronta con il modo di esporre l’etica sociale cristiana, soprattutto<br />
nei manuali. A scopo di chiarezza accenno qui alla posizione tradizionale<br />
o classica, dove per tradizionale non intendo la posizione<br />
dei Padri della Chiesa o dei grandi pensatori cristiani, ma piuttosto<br />
la sistemazione di quel pensiero in manuali e trattati di facile comprensione<br />
e uso. La fondamentale distinzione fra natura e soprannatura,<br />
pensata, si potrebbe dire cartesianamente, con idee chiare e<br />
distinte, si estendeva all’etica come distinzione fra giustizia e carità,<br />
fra precetti e consigli, fra leggi obbligatorie e ideali di vita cristiana.<br />
La condivisione dell’etica cristiana con ogni uomo di buona volontà<br />
si collocava ovviamente a livello di natura 1 . Da una filosofia<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
I fondamenti<br />
staurologici<br />
di un’etica<br />
sociale cristiana<br />
295-311<br />
teologia<br />
297
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
ADOLFO LIPPI C.P.<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
teologia<br />
298<br />
perenne condivisibile da tutti gli uomini e da una theologia naturalis<br />
o rationalis o philosophica discendeva deduttivamente un’etica<br />
della giustizia e del diritto, dell’eguaglianza e della correttezza, del<br />
dovere e dell’obbedienza alle leggi e alle autorità costituite. Per il di<br />
più della fede, per la rivelazione come per la carità gratuita, si poteva<br />
chiedere ai non cristiani apprezzamento, forse ammirazione, ma<br />
non condivisione.<br />
I tentativi di destrutturare questo schema rigido e comodo, ma<br />
non corrispondente al pensiero dei Padri e dei grandi pensatori, che<br />
furono fatti da uomini come Blondel e De Lubac – si ricordino le<br />
celebri opere L’action e Surnaturel – erano considerati pericolosi.<br />
Oggi sembra che siano piuttosto pensatori non cristiani, ma esenti<br />
dalla contaminazione illuminista, a riproporre il problema dei rapporti<br />
fra religioni e società laica 2 .<br />
L’impostazione evangelica dell’etica sociale cristiana cominciò<br />
col Concilio. Ma già negli anni ’50 si era proposto di porre l’insegnamento<br />
evangelico sulla carità a fondamento della morale cristiana<br />
in genere, non lasciando più la trattazione della dottrina della<br />
carità come amore gratuito all’ascetica o alla mistica o facendone, al<br />
massimo, un capitolo particolare della Morale. Il Concilio Vaticano<br />
II, pur non offrendo una trattazione specifica sul fondamento della<br />
Morale, optava chiaramente per ricondurre la Morale cristiana al suo<br />
fondamento che è Cristo e alla carità come suo insegnamento<br />
primario 3 . E’ diventata dottrina comune, da allora l’idea che tutta<br />
la Morale cristiana debba far capo alla carità, come sua forma<br />
perfetta, che lo stesso Decalogo, come detto nel Catechismo della<br />
Chiesa cattolica, debba essere “interpretato alla luce di questo duplice<br />
ed unico comandamento della carità, pienezza della Legge” 4 .<br />
Il catechismo trova la conferma più chiara di questa asserzione in<br />
1 Cf ad es. L. Lorenzetti, La Morale nella storia, EDB, Bologna 2009, 702:<br />
“Fino a un tempo abbastanza recente, la dottrina sociale della Chiesa era considerata<br />
parte integrante dell’etica naturale, che elaborava principi e norme<br />
morali argomentando ex lege naturali e rientrava nelle competenze del magistero<br />
ecclesiale in quanto competente sulla legge naturale che, alla luce della<br />
rivelazione, trovava maggiore conoscenza, perfezionamento e completamento”<br />
(Ristampa di un articolo del 1989).<br />
2 Rimando, per questo, al mio recente editoriale su La Sapienza della<br />
Croce, dal titolo: Esiste e come si sostiene un’etica sociale laica? (Sap Cr XXV,<br />
2010, 3-8).<br />
3 Cf L. Lorenzetti, op. cit., 25.<br />
4 CCC 2055.
Rom 13, 9-10, ma poteva appellarsi a molti altri passi e, soprattutto,<br />
al senso generale della Bibbia in genere e del Nuovo Testamento<br />
in specie.<br />
Colpisce il fatto che nello stesso schema preparatorio del<br />
Concilio in tema di Morale si escludesse la carità come fondamento<br />
della Morale in quanto poteva dare adito a verbalismo, sentimentalismo,<br />
abbandono dei precetti 5 . Sottinteso è che neanche i precetti si<br />
sostengano da soli e che tutto sia sostenuto dalla sanzione, cioè che<br />
tutto si debba fondare sulla paura dei castighi. La Morale sociale<br />
rinuncerebbe così ad appellarsi all’interiorità ed assumerebbe come<br />
fondamento il principio del diritto romano della legge e della sanzione.<br />
Tuttavia, le obiezioni contro una Morale dell’Amore (ricordiamo<br />
la civiltà dell’Amore della quale parlava Paolo VI), possono<br />
avere qualcosa di valido, se questa non viene presentata bene secondo<br />
gli insegnamenti del Nuovo Testamento preso nel suo insieme.<br />
Basta dire che la Morale cristiana è una Morale dell’Amore o bisognerebbe<br />
precisare che l’Amore implica la kenosi, il servizio e il<br />
sacrificio, come rilevava la piccola Teresa? Nella cultura dominante<br />
è diffuso un certo buonismo che viene spesso confuso con la Morale<br />
Cristiana. Questa, però, non è una Morale buonista e meno ancora<br />
una Morale permissiva o rigorista. Non ci si può rifugiare in queste<br />
evasioni. Il testo di Mt 20, 20-28, fondante per la Sociologia cristiana,<br />
parla esplicitamente di kenosi e di servizio, non solo di Amore,<br />
che potrebbe effettivamente essere vago, generico, non veramente<br />
trasformante.<br />
3. I rapporti sociali all’interno<br />
della Comunità dei credenti<br />
La contrapposizione<br />
che Mt 20,<br />
20-28 stabilisce<br />
fra sociologia delle<br />
genti, dei gojim, e<br />
sociologia dei discepoli non sembra una proposta che questi debbano<br />
fare immediatamente al mondo. Sembra piuttosto un insegnamento<br />
teso a regolare i rapporti dei discepoli fra loro. I rapporti debbono<br />
essere kenotici, il servizio va dall’alto al basso, è orientato in<br />
senso discendente, non è generico o vago. A questo proposito si<br />
5 Riferito da L. Lorenzetti, op. cit., 24-25, senza rimando alla fonte.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
I fondamenti<br />
staurologici<br />
di un’etica<br />
sociale cristiana<br />
295-311<br />
teologia<br />
299
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
ADOLFO LIPPI C.P.<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
teologia<br />
300<br />
potrebbero porre due domande, una riguardante la società cristiana<br />
al suo interno e l’altra la dottrina sociale che la Chiesa intende offrire<br />
a tutta l’umanità per il suo stesso bene.<br />
La prima domanda è: si è coscienti nel mondo cristiano che la<br />
sociologia cristiana è radicalmente differente ed anche opposta a<br />
quella non cristiana? Si è decisi a promuoverla? Oppure ci si contenta<br />
di una correttezza negli scambi, si rinuncia all’etica della<br />
gratuità? I rapporti all’interno delle comunità dei credenti, ad<br />
esempio in una comunità religiosa o nella comunità presbiterale<br />
di una diocesi, sono veramente fondati sugli insegnamenti del<br />
vangelo, oppure ci si contenta di rapporti eticamente corretti?<br />
Non mi sentirei di rispondere che dappertutto o prevalentemente<br />
ci si fermi all’etica dello scambio, ma mi sembra che a volte lo si<br />
faccia e lo si teorizzi, magari non avendone piena coscienza.<br />
Mi domando se alcune comunità si reggano sull’etica evangelica<br />
oppure su grandi abilità diplomatiche che producono equilibri di<br />
peccato, cioè equilibri di persone non guarite interiormente e<br />
quindi ancora fondamentalmente egocentriche, incapaci di aprirsi<br />
veramente all’altro e all’etica del dono gratuito.<br />
Riprendendo il discorso fatto sopra, mi domando se ci si renda<br />
sempre conto che l’etica cristiana è per natura sua kenotica, o la<br />
si percepisce invece come vagamente sentimentale, secondo quel<br />
certo buonismo diffuso dalla e nella cultura dominante, di cui<br />
parlavo sopra.<br />
4. La proposta che la Morale<br />
cristiana fa all’etica sociale<br />
La seconda domanda<br />
riguarda più<br />
propriamente l’etica<br />
sociale in quanto tale:<br />
pur avendo pazienza<br />
nell’attendere o nel pretendere da tutti un comportamento corrispondente<br />
alla concezione sociologica cristiana, si è coscienti che<br />
l’attesa paziente e piena di speranza non significa scendere a<br />
compromesso con un’etica sociale non evangelica? Si è coscienti, in<br />
particolare, della nuova domanda o della nuova sfida che l’evolversi<br />
e l’ampliarsi del problema sociale pongono alla Chiesa, pena il<br />
rischio di un degrado della coesistenza o addirittura dell’autodistruzione<br />
dell’umanità?
Se si aderisce all’idea che un’etica sociale possa essere condivisa<br />
soltanto sulla base della ragione e della legge naturale, queste domande<br />
potrebbero sembrare pie considerazioni o, al massimo, riflessioni<br />
da fare verso l’interno della Comunità ecclesiale a scopo edificante e<br />
verso l’esterno a scopo apologetico, per ottenere una stima sempre<br />
più grande per un’etica autenticamente evangelica. Se, però, le confrontiamo<br />
con proposte analoghe fatte al di fuori della Chiesa da pensatori<br />
del nostro tempo, ci chiediamo se non siamo noi ad essere poco<br />
coraggiosi nel proporre il punto di vista cristiano sulla convivenza<br />
umana. Propongo qui una riflessione sull’impostazione dell’etica<br />
sociale che si può ricavare dal pensiero di Lévinas e Derrida.<br />
5. Breve excursus sul pensiero<br />
di Lévinas e Derrida<br />
Di Lévinas mi<br />
colpì anzitutto<br />
quanto lui proponeva<br />
a proposito dell’intuizionefondamen-<br />
tale da cui sorge l’atteggiamento etico e l’etica in quanto tale:<br />
“L’intuizione fondamentale della moralità consiste forse nell’avvertire<br />
che io non sono l’eguale di altri, e ciò in senso stretto come<br />
segue: mi vedo obbligato nei confronti di altri e per conseguenza<br />
sono infinitamente più esigente con me stesso che rispetto agli<br />
altri. ‘Più sono giusto e più severamente sarò giudicato’, dice un testo<br />
talmudico.<br />
Donde deriva che non esiste coscienza morale che non sia<br />
coscienza di questa posizione originale, che non sia coscienza di elezione.<br />
La reciprocità è una struttura fondata su un’ineguaglianza originaria.<br />
Perché l’uguaglianza possa fare il suo ingresso nel mondo,<br />
bisogna che gli esseri possano esigere da sé più di quanto esigano<br />
dagli altri, che si sentano responsabili della sorte dell’umanità e che<br />
si pongano, in questo senso, in disparte rispetto all’umanità” 6 .<br />
Quest’impostazione, oltre ad essere storicamente veritiera, giacché<br />
i progressi dell’etica sociale non sono venuti da teorie, ma da<br />
uomini che si sono sentiti interpellati personalmente ad andare oltre<br />
la mentalità dello scambio, richiama la persuasione basilare di<br />
Lévinas secondo la quale un’impostazione biblica – ed è di essa che<br />
6 Difficile libertà, Jaca Book, Milano, 2004, 39.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
I fondamenti<br />
staurologici<br />
di un’etica<br />
sociale cristiana<br />
295-311<br />
teologia<br />
301
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
ADOLFO LIPPI C.P.<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
teologia<br />
302<br />
si ha bisogno – non può sopraelevarsi su un’impostazione pagana o<br />
semplicemente filosofica. Possiamo trovare qui un’analogia col<br />
rifiuto della fondazione razionale della teologia, propria della theologia<br />
crucis di Lutero 7 . Detto in termini cristiani, per Lévinas un’etica<br />
autenticamente umana può sorgere soltanto dal sentirsi scelti e<br />
chiamati ad una responsabilità, non generica, legale o egualitaria,<br />
ma personale, gratuita e insostituibile. E’, con ciò, fede in un intervento<br />
di Dio in me, vocazione, missione, obbedienza incondizionata.<br />
Sappiamo tutti, poi, dove conduce questa riflessione di Lévinas:<br />
conduce alla filosofia dell’alterità che mi costituisce in quanto io<br />
non sono io senza l‘altro: l’altro nel Medesimo che apre all’assolutamente<br />
Altro. Conduce all’etica della sostituzione e all’accettare di<br />
essere ostaggio designato per un sacrificio senza riserve. La coscienza<br />
della chiamata personale fonda un’etica ben più efficace di quella<br />
che può essere fondata su un’ontologia generale (fosse pure<br />
un’ontoteologia) o anche, in modo autonomo dalla speculazione teoretica,<br />
su un imperativo categorico.<br />
E’ chiaro che ciò che concretamente ha generato nell’umanità<br />
una coscienza assai condivisa di dover andare incontro a tutti senza<br />
eccezione, è stata l’iniziativa gratuita di chi ha sentito che valeva la<br />
pena consumare la vita per questo. Basterebbe pensare alle opere di<br />
misericordia e di sostegno dei disgraziati che hanno generato nella<br />
società la coscienza di dover provvedere, di non potersi tirare indietro.<br />
Derrida, con le riflessioni sull’ospitalità e l’accoglienza, aggiunge<br />
alle riflessioni di Lévinas una concreta incarnazione nell’attualità<br />
della nostra società multiculturale, con i problemi quotidiani che<br />
essa ci pone. L’etica di Derrida, intorno alla quale sono stati organizzati<br />
incontri in vari centri culturali, è chiamata significativamente<br />
etica del dono 8 . Già in questa parola c’è tutto un contenuto che ci<br />
interpella in quanto cristiani. Alterità, dono, sostituzione sono vocaboli<br />
che, oltre ad evitare la banalizzazione alla quale sono andate<br />
soggette parole come carità e amore, aggiungono ad esse i concetti<br />
di uscita da sé, espropriazione, sacrificio.<br />
7 Rimando per questo al mio articolo riassuntivo del pensiero di Lutero sulla<br />
theologia crucis: A. Lippi, Lutero e la Theologia crucis. In Christo Crucifixo est<br />
vera theologia, in Sap Cr X (1995), 339-357.<br />
8 Cf ad es. L’étique du don. Jaques Derrida et la pensée du don, Métailié-<br />
Transition, Paris 1992: G. Coccolini, L’etica come ospitalità in Jaques Derrida,<br />
in Rivista di teologia morale, 129 (2001), 77-85.
Derrida considerava Totalità e Infinito di Lévinas un immenso<br />
trattato sull’ospitalità, una parola che diviene sempre più centrale<br />
nel suo pensiero. L’ospitalità implica un’accoglienza incondizionata,<br />
il far sentire l’altro a casa propria, non preso dentro una proprietà<br />
che resta sempre mia e nella quale io resto padrone.<br />
Approfondendo la vicinanza e l’antinomia fra legge dell’ospitalità per<br />
cui l’altro deve essere accolto incondizionatamente senza domandargli<br />
né reciprocità né il suo nome 9 e le norme sulle quali si regola di fatto<br />
l’ospitalità, Derrida si interroga sul rapporto fra diritto e giustizia.<br />
Poiché quest’ultima è sempre al di là del diritto, lo trascende sempre,<br />
“l’ospitalità giusta rompe con l’ospitalità di diritto; non che la condanni<br />
o vi si opponga, può anzi metterla e tenerla in un moto incessante di<br />
progresso; ma è tanto stranamente diversa dall’altra, quanto la giustizia<br />
è diversa dal diritto al quale tuttavia è così vicina” 10 .<br />
Invito a riflettere su quell’espressione di Derrida secondo la<br />
quale l’ospitalità giusta può mantenere l’ospitalità di diritto “in un<br />
moto incessante di progresso”. La concreta storia dell’ospitalità –<br />
dice Derrida - sarà sempre “una perversione sempre possibile della<br />
Legge dell’ospitalità (che può sembrare incondizionata) e delle<br />
leggi che la limitano e la condizionano iscrivendola in un diritto” 11 .<br />
Allargando la riflessione alla giustizia in quanto tale, Derrida dice<br />
che essere giusti, allora, è non essere mai abbastanza giusti e tuttavia<br />
trovarsi nella condizione di sentire che la giustizia preme per non<br />
essere rimandata, urge anche se non è mai presente 12 . La politica in<br />
quanto tale – si noti bene, non una politica in quanto aperta alla religiosità<br />
istituzionale – è chiamata ad aprirsi all’altro, quasi in un<br />
estremo gesto messianico. Nell’attesa dell’altro uomo, dell’uomo<br />
come altro (e nell’altro) che viene, si dà forse quella porta attraverso<br />
cui, soltanto, può entrare il Messia 13 .<br />
Accenno appena ad un pensatore vivente che ha portato alle<br />
estreme conseguenze questo discorso, Jean-Luc Marion, per il quale<br />
la filosofia prima è filosofia della donazione. Egli tiene conto sia<br />
9 Cf J. Derrida, Sull’ospitalità, Baldini & Castoldi, Milano 2000, 53.<br />
10 Ivi, 53.<br />
11 J. Derrida, Cosmopoliti di tutti i paesi, ancora uno sforzo!, Cronopio,<br />
Napoli 1997, 27.<br />
12 J. Derrida, “Diritto alla giustizia”, in G. Vattimo e J. Derrida (a cura),<br />
Diritto, giustizia, interpretazione, Laterza, Bari 1988, 20.<br />
13 Cf J. Derrida, Ecografie della televisione, Cortina, Milano 1997, 14.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
I fondamenti<br />
staurologici<br />
di un’etica<br />
sociale cristiana<br />
295-311<br />
teologia<br />
303
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
ADOLFO LIPPI C.P.<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
teologia<br />
304<br />
della gegebenheit della fenomenologia husserliana, tutta derivante<br />
dalla donazione 14 , sia delle ricerche di antropologia culturale di<br />
Marcel Mauss, come della riflessione di Jean-Luc Nancy sull’essere<br />
singolare plurale e la comunità e tiene conto soprattutto, ovviamente,<br />
del pensiero di Lévinas e di Derrida, i quali si sono influenzati<br />
vicendevolmente. L’uomo si scopre attributario di una donazione<br />
che non conosce e della quale non si può appropriare. Il soggettivismo<br />
dominatore e accaparratore del pensiero occidentale moderno<br />
viene rovesciato, soprattutto sulla base, credo, dei rilievi di<br />
Lévinas sulla passività che ci costituisce fondamentalmente.<br />
L’attributario “supera la spontaneità dell’Io penso nella ricettività<br />
dell’Io sono affetto dall’effetto dell’evento, e ricevendosi esso stesso<br />
come un ente donato si libera dalla sussistenza di un sostrato, in<br />
breve dalla soggettività del soggetto” 15 .<br />
Questi discorsi possono sembrare utopici solo se si rimane pigramente<br />
attaccati alle strutture astratte delle teorie giuridiche e sociologiche.<br />
Se si riflette, per esempio, a come si sono sviluppate le<br />
leggi dell’assistenza sociale negli stati più sviluppati, si vede che<br />
questo è avvenuto con la maturazione di una sensibilità condivisa<br />
dalla maggioranza delle coscienze 16 . Prendiamo il caso particolare<br />
dell’assistenza sanitaria: prima che esistesse la legge, si sono andate<br />
sviluppando, da secoli, una serie di iniziative volontarie che sono<br />
arrivate a creare strutture il più delle volte piccole, microstrutture,<br />
ma a volte anche grandi e imponenti, fino a che ci si è domandati<br />
perché non garantire per legge un’assistenza offerta a tutti, che è<br />
quanto dire assumere collettivamente in quanto società l’onere<br />
dell’assistenza sanitaria. A questo punto il trascurare la sofferenza<br />
di qualcuno è apparso cinismo. E’ un caso di maturazione della<br />
coscienza sul tema della giustizia. Se ne potrebbero citare molti<br />
altri.<br />
14 Cf S. Currò, Il dono e l’altro. In dialogo con Derrida, Lévinas e Marion,<br />
Las Roma 2005, 80.<br />
15 J-L. Marion, Dato che. Saggio per una fenomenologia della donazione,<br />
SEI, Torino,2001, 319-320. Cf S. Currò, Il dono e l’altro. In dialogo con<br />
Derrida, Lévinas e Marion, cap. IV: In principio la donazione, 73-116.<br />
16 Benedetto XVI, nell’enciclica Deus caritas est, attribuisce alla presenza del<br />
cristianesimo come tale la crescita dell’impegno sociale a favore degli esseri<br />
più deboli e ricorda come la riforma del paganesimo voluta da Giuliano<br />
l’Apostata, risentiva di questa presenza.
6. Religioni positive ed etica<br />
sociale: sono due campi<br />
da tenere distinti?<br />
Un’altra situazione<br />
culturale del<br />
nostro tempo,<br />
da tenere presente, riguarda<br />
la reciproca inte-<br />
grazione fra religioni ed etica sociale, cui ho già accennato. Essa è<br />
ben diversa da quella rinascimentale e più ancora illuminista nella<br />
quale il problema era piuttosto quello dell’autonomia della ragione<br />
rispetto a una fede che appariva invasiva. Parto dal riferimento a una<br />
ricerca sociologica di Jürgen Habermas. Muovendo da una domanda<br />
di Böckenforde, Habermas si domanda se l’etica sociale non stia ancora<br />
beneficiando inconsciamente di convinzioni condivise sulla base<br />
di fedi o tradizioni culturali, mantenute per inerzia, pur illudendo<br />
le masse di essere guidate unicamente da un’etica laica e puramente<br />
razionale. Che cosa accadrà quando, per il processo di secolarizzazione<br />
e di sradicamento in atto, queste tradizioni verranno a perdere<br />
il loro influsso sociale? Habermas non nasconde di essere personalmente<br />
persuaso del valore positivo delle religioni per sostenere<br />
l’etica sociale, nella linea di Hegel 17 . Le fonti della normatività e<br />
della solidarietà non dovrebbero essere abbandonate a cuor leggero:<br />
“E’ nell’interesse dello Stato costituzionale trattare con riguardo tutte le<br />
fonti culturali da cui si alimentano la consapevolezza normativa e la solidarietà<br />
dei cittadini” 18 . Su questa linea egli propone che nella società<br />
post-secolare venga modificata riflessivamente sia la coscienza religiosa<br />
che quella laica nei loro rapporti e in rapporto al bene comune.<br />
Come detto sopra, i nostri manuali ci avevano abituato a categorizzazioni<br />
rigide, con la distinzione fra precetti e consigli evangelici,<br />
fra la giustizia dovuta distinta dalla carità gratuita, l’etica razionale<br />
o filosofica distinta dalla morale rivelata o soprannaturale. Oggi<br />
l’ipotesi che la laicità o la pura razionalità non siano in grado di fondare<br />
un’etica sociale non è più così assurda, vista anche la fuga<br />
verso le religioni degli uomini e delle donne del nostro tempo. Al di<br />
fuori del mondo cristiano l’interferenza della religione sull’etica<br />
civile è ancora superiore: norme di natura strettamente religiosa<br />
(tipo sharia) sono state accolte nella legislazione civile non soltanto<br />
in Iran, ma anche in Israele.<br />
17 Cf J. Habermas, Tra scienza e fede, Laterza, Bari 2005, XI.<br />
18 Id. ibid., 15-16.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
I fondamenti<br />
staurologici<br />
di un’etica<br />
sociale cristiana<br />
295-311<br />
teologia<br />
305
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
ADOLFO LIPPI C.P.<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
teologia<br />
306<br />
I richiami a pensatori quali Lévinas e Derrida non rappresentano<br />
un invito seppure implicito a prendere ispirazione da loro, ma piuttosto<br />
un invito a prendere atto che esistono proposte molto coraggiose,<br />
nella linea della Parola rivelata, fatte senza paura al mondo occidentale<br />
che si presenta come secolarizzato e geloso della propria<br />
secolarizzazione. Credo che sia contemporanea all’indagine sociologica<br />
di Habermas la presa di coscienza dei moralisti cattolici dell’identità<br />
evangelica e non semplicemente filosofica dell’etica<br />
sociale cristiana, e quello che è stato chiamato il passaggio dell’etica<br />
sociale dei cattolici dalla filosofia alla teologia 19 . Da parte sua<br />
Benedetto XVI afferma con la sua solita lucidità che “lo Stato non è<br />
di per sé fonte di verità né di morale”. Conseguentemente lo Stato<br />
deve disporsi ad accogliere da ‘fuori’ di sé il patrimonio di conoscenza<br />
e di verità da cui non può prescindere. Le religioni convergono<br />
su un consenso di fondo riguardo a ciò che è bene e “la fede<br />
cristiana ha dato prova di sé come creatrice di cultura religiosa universale<br />
e razionale in sommo grado” 20 .<br />
Questi rilievi mi<br />
7. Il pensiero di Benedetto XVI introducono alle<br />
riflessioni conclusive<br />
di questo studio, nelle quali farò riferimento al pensiero di<br />
Joseph Ratzinger-Benedetto XVI. La terza domanda, che qui possiamo<br />
porci, è la seguente: Fino a che punto è possibile, perseguendo un’etica<br />
sociale condivisa con tutti gli uomini, offrire la nostra riflessione<br />
secondo cui un’etica del dono, un’etica che si potrebbe chiamare kenotica,<br />
non soltanto rappresenta qualcosa di meglio di una qualsiasi etica<br />
di scambio, ma sembra essere oggi la condizione della sopravvivenza<br />
dell’umanità e del cosmo? Un’etica kenotica si oppone a un’etica del<br />
possesso, dell’accaparramento: è pensabile che noi cristiani possiamo<br />
proporre all’umanità che un’etica della kenosi, dell’abbassamento<br />
accettato per realizzare il dono, venga a sostituire un’etica del possesso<br />
e del riempimento, dove ci si apre all’altro soltanto nella misura in<br />
cui questo può favorire i propri programmi di autopromozione e di<br />
accumulazione?<br />
19 Cf L. Lorenzetti, La Morale nella storia, cit., 699.<br />
20 Cf L’elogio della coscienza. La verità interroga il cuore, Cantagalli, Siena,<br />
2009, 71-74.
Leggendo le encicliche di Benedetto XVI, mi sembra chiaro che<br />
questa concezione neotestamentaria viene proposta all’umanità<br />
come soluzione dei problemi che la tormentano fino a minacciarne,<br />
oggi, la distruzione. Mi pare che il papa eviti di fare del concetto di<br />
dono un’ideologia, come forse potrebbe accadere sulla base delle<br />
dottrine accennate sopra. Egli si esprime ripetutamente contro la<br />
riduzione a ideologia di intenzionalità per sé valide. Si può riscontrare<br />
questo, ad esempio, nell’affermare che compito dello Stato è<br />
anzitutto il perseguimento della giustizia con la difesa dei diritti di<br />
ognuno e l’equa distribuzione dei beni 21 .<br />
Egli però non si ferma qui. Già nella sua prima enciclica Deus<br />
caritas est, riflettendo sul rapporto fra giustizia e carità e assegnando<br />
allo stato il compito di amministrare la giustizia, dichiara che la<br />
fede “è una forza purificatrice per la ragione stessa” e spiega a lungo<br />
questo principio (n. 28). Al di là dell’etica naturale c’è l’amore, del<br />
quale l’uomo ha un assoluto bisogno, in quanto non vive di solo<br />
pane. “Chi vuole sbarazzarsi dell’amore si dispone a sbarazzarsi<br />
dell’uomo in quanto uomo” (n. 28). Lo stato perciò deve necessariamente<br />
essere affiancato dalle forze sociali che operano in vista delle<br />
necessità di ogni uomo e soprattutto dalla Chiesa: “Non uno Stato<br />
che regoli e domini tutto è ciò che ci occorre, ma invece uno Stato<br />
che generosamente riconosca e sostenga, nella linea del principio di<br />
sussidiarietà, le iniziative che sorgono dalle diverse forze sociali e<br />
uniscono spontaneità e vicinanza agli uomini bisognosi di aiuto.<br />
La Chiesa è una di queste forze vive: in essa pulsa la dinamica<br />
dell’amore suscitato dallo Spirito di Cristo” (n. 28).<br />
L’enciclica sociale Caritas in veritate si riallaccia a Paolo VI per<br />
affermare che “il Vangelo è elemento fondamentale di sviluppo,<br />
perché in esso Cristo, rivelando il mistero del Padre e del suo amore,<br />
svela anche pienamente l’uomo all’uomo (GS 22)” (n. 18): Nel<br />
numero seguente (19), i due papi convergono nel rilevare la centralità<br />
della carità, che, se anche può essere compresa dall’uomo, non<br />
può essere realizzata se non con un dono di Dio.<br />
Non sarebbe difficile proseguire questa ricerca, ma non ne abbiamo<br />
lo spazio. Concludo con un passo di un vecchio libro di Joseph<br />
Ratzinger, che resta sempre fondamentale per il suo pensiero ed<br />
anche come conclusione del discorso che stiamo facendo:<br />
21 Cf ad es. Deus caritas est, 26.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
I fondamenti<br />
staurologici<br />
di un’etica<br />
sociale cristiana<br />
295-311<br />
teologia<br />
307
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
ADOLFO LIPPI C.P.<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
teologia<br />
308<br />
“Quando sarò innalzato da terra, trarrò a me tutti gli uomini (Gv<br />
12, 32). Questa frase intende spiegare la morte di Gesù in croce; e<br />
in questo modo, poiché la croce costituisce il centro della teologia<br />
giovannea, essa esprime la direzione verso cui l’intero vangelo<br />
vuole orientare. L’avvenimento della crocifissione vi appare come<br />
un processo di apertura, in cui le disperse monadi umane vengono<br />
riunite nell’abbraccio di Gesù Cristo, nell’immenso spazio delle sue<br />
braccia spalancate, per giungere in questa unificazione al loro traguardo,<br />
alla mèta finale dell’umanità. Se però le cose stanno così,<br />
allora Cristo, in quanto uomo venturo, non è l’uomo per sé, bensì<br />
essenzialmente l’uomo per gli altri; egli è l’uomo del futuro proprio<br />
in quanto uomo totalmente aperto. L’uomo per sé, che vuole pensare<br />
solo a sé, è allora l’uomo del passato, che dobbiamo lasciarci alle<br />
spalle per andare avanti. In altri termini, ciò significa che il futuro<br />
dell’uomo sta nell’ essere per… Nell’immagine del fianco squarciato<br />
culmina per Giovanni non solo la scena della croce, ma l’intera<br />
vicenda storica di Gesù. Adesso, infatti, dopo il colpo di lancia che<br />
mette fine alla sua vita terrena, la sua esistenza è completamente<br />
aperta; egli è interamente ‘per’, ora egli non è veramente più un singolo,<br />
ma è ‘Adamo’, dal cui fianco viene formata Eva, vale a dire<br />
un’umanità nuova” 22 .<br />
Chiunque segua le<br />
Conclusione migliori ricerche<br />
nel campo del<br />
pensiero riflesso, della<br />
stessa letteratura e delle arti, riconoscerà facilmente qui una consonanza,<br />
che indica l’attualità del discorso programmatico del papa.<br />
L’apertura all’altro, che si è espressa anzitutto nella croce di Gesù,<br />
nelle sue braccia aperte e nel suo cuore squarciato, senza scendere ad<br />
espressioni polemiche, relega in un passato antistorico certe posizioni<br />
di pensiero nelle quali l’uomo appare tutto ripiegato su se stesso, sui<br />
propri veri o presunti diritti, infantilmente piagnucolando perché<br />
qualcuno gli contesta il diritto a certe soddisfazioni. E’ come quando il<br />
cristianesimo apparve chiaramente all’orizzonte della cultura classica:<br />
22 Ratzinger J, Introduzione al cristianesimo, Queriniana, Brescia 2005,<br />
230.
si capiva che la storia camminava nella direzione che esso indicava,<br />
nonostante le nostalgie. C’è una responsabilità enorme davanti alla<br />
Chiesa, condivisa da tutte le persone che si pongono con serietà il problema<br />
delle sorti dell’umanità e della stessa creazione: portare l’uomo<br />
a gioire della carità, a gioire nell’ essere-per, perché c’è più felicità nel<br />
dare che nel trattenere (cf At 20, 35). E’ una responsabilità che farebbe<br />
paura se, per la fede, non sapessimo di essere sostenuti con la forza<br />
dello Spirito da Colui che è all’origine del nostro essere e da Colui che<br />
il Creatore ha mandato per comunicarci questo Dono.<br />
STAUROLOGICAL FOUNDATIONS OF CHRISTIAN<br />
ENG<br />
SOCIAL ETHICS<br />
Which are the social ethics which derive from the theology of the<br />
Cross?<br />
By Adolfo Lippi, C.P.<br />
At least until the 2 nd Vatican Council no one dared base social<br />
Morality on charity. It was thought that social ethics should be<br />
founded strictly on justice as in an exchange. Yet Scripture does propose<br />
a social ethic founded on the idea of gift which allows for a<br />
kenotic approach based on the theology of the Cross. Is a foundation<br />
for ethics of this kind possible in today’s secularized society?<br />
This article contains references to a number of authors who in fact<br />
have declared that such a foundation is both possible and urgent,<br />
especially when we examine the social thoughts of Benedict XVI.<br />
LOS FUNDAMENTOS ESTAUROLÓGICOS DE UNA<br />
ESP<br />
ÉTICA SOCIAL CRISTIANA. ¿Cuál es la ética social<br />
que proviene de la Teología de la Cruz?<br />
De Adolfo Lippi C.P.<br />
Por lo menos hasta el Concilio Vaticano II no se atrevían a fundamentar<br />
la Moral social sobre la caridad. Se pensaba que la ética<br />
social tendría que fundamentarse sobre la justicia en las relaciones<br />
de intercambio. La Biblia propone de hecho una ética social funda-<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
I fondamenti<br />
staurologici<br />
di un’etica<br />
sociale cristiana<br />
295-311<br />
teologia<br />
309
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
ADOLFO LIPPI C.P.<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
teologia<br />
310<br />
mentada sobre la donación, que se hace posible desde un comportamiento<br />
kenótico que se basa en la Teología de la Cruz. ¿Es posible<br />
pensar en un fundamento de este género para la ética en la<br />
actual sociedad secularizada? El artículo hace referencia a algunos<br />
autores que de hecho han declarado que es posible y también urgente<br />
esta fundamentación y sobre todo atendiendo al concepto de lo<br />
social de Benedicto XVI.<br />
DIE KREUZESTHEOLOGISCHEN FUNDAMENTE<br />
GER<br />
EINER CHRISTLICHEN SOZIALETHIK<br />
Welche Art der Sozialethik entstammt der Theologie des<br />
Kreuzes?<br />
von Adolfo Lippi C.P.<br />
Zumindest bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil wagte man es<br />
kaum, die Sozialmoral auf die christliche Nächstenliebe aufzubauen.<br />
Man war davon überzeugt, dass die Sozialethik, was die menschlichen<br />
Austauschbeziehungen anbelangt, die Gerechtigkeit als<br />
Fundament haben müsse. Tatsächlich zeigt uns die Heilige Schrift<br />
eine sozialethische Haltung, die auf dem Prinzip des Schenkens und<br />
der Hingabe beruht. Ein solches ergibt sich aus einer kenotischen,<br />
sich entäußernden Grundhaltung, wie sie in der Theologie des<br />
Kreuzes deutlich wird. Ist ein derartiges Fundament als ethische<br />
Grundlage für unsere säkularisierte Gesellschaft denkbar? Der<br />
Artikel benennt einige Autoren, die diese Auffassung vertreten, und<br />
sie für dringend nötig halten. Besonderes Augenmerk wurde auf die<br />
diesbezüglichen Überlegungen von Benedikt XVI. gelegt.<br />
STAUROLOGICZNE PODSTAWY CHRZEŚCIJAŃ-<br />
SKIEJ ETYKI SPOŁECZNEJ. JAKA ETYKA SPO-<br />
ŁECZNA WYWODZI SIĘ Z TEOLOGII KRZYŻA?<br />
Adolfo Lippi C.P.<br />
POL<br />
Przynajmniej do Soboru Watykańskiego II nikt nie ośmielał się<br />
opierać społecznej teologii moralnej na miłości. Uważano, że etyka<br />
społeczna powinna opierać się na sprawiedliwości w wymianie
dóbr. Biblia jednak proponuje etykę społeczną opartą na darze,<br />
która jest możliwa dzięki postawie kenotycznej opartej na teologii<br />
krzyża. Czy podstawa tego rodzaju jest możliwa dla współczesnej<br />
etyki społecznej w społeczeństwie zsekularyzowanym? Artykuł<br />
nawiązuje do autorów, którzy faktycznie uznali ją za możliwą oraz<br />
pilnie potrzebną, przede wszystkim do myśli społecznej Benedykta<br />
XVI.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
I fondamenti<br />
staurologici<br />
di un’etica<br />
sociale cristiana<br />
295-311<br />
teologia<br />
311
di ANGELA MARIA LUPO C.P.<br />
La riflessione della Lupo mostra chiaramente l’originalità, anzi<br />
l’unicità del rapporto fra Dio e l’uomo<br />
che la Bibbia ebraico-cristiana<br />
propone, un rapporto che si qua-<br />
lifica come il parlare del Dio all’uomo<br />
e il colloquiare dell’uomo<br />
con Dio. Con un’attenta analisi di<br />
numerosi passaggi dell’Antico e<br />
del Nuovo Testamento, l’articolo<br />
mostra poi le caratteristiche di questo<br />
colloquio, non riducibile a nulla<br />
di magico o fantastico, ma coinvolgente<br />
esistenzialmente l’intera vita del discepolo e la stessa<br />
immagine che l’uomo si forma di Dio.<br />
A conclusione l’autrice rileva che la scena storica che si presenta<br />
oggi ai nostri occhi esige una nuova evangelizzazione della<br />
Parola.<br />
La parola di Dio è<br />
l’energia stessa di<br />
Premessa Dio che opera<br />
nella storia umana e che<br />
non cessa di correre da<br />
una parte all’altra della terra per realizzare ciò che essa contiene. Per<br />
L’Antico e Nuovo Israele, la Bibbia non solo contiene la parola di<br />
Dio, quella parola che Dio a più riprese e in più modi aveva indirizzato<br />
agli uomini mediante i suoi messaggeri, ma essa stessa è Parola<br />
di Dio. È significativo che, come leggiamo nei libri dell’Antico Testamento,<br />
il rapporto tra Dio e l’uomo avvenga mediante la parola:<br />
“Il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla<br />
con un suo amico” (Es 33,11).<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
LA FORZA<br />
EVANGELIZZATRICE<br />
DELLA PAROLA<br />
La forza<br />
evangelizzatrice<br />
della parola<br />
313-329<br />
teologia<br />
313
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
ANGELA MARIA LUPO<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
teologia<br />
314<br />
Presentando Jahvè come un Dio che comunica mediante la parola,<br />
l’AT si contrappone a tutti i tipi di rapporti naturalistici fra la divinità<br />
e i seguaci delle religioni cananee dell’ambito circostante: l’incontro<br />
con Jahvè non avviene attraverso la fertilità dei campi o la fecondità<br />
del bestiame, né attraverso i rapporti sessuali, ma si realizza<br />
attraverso la sua parola 1 .<br />
La Parola per eccellenza di Dio, l’ultima e definitiva Parola è Gesù<br />
Cristo, la sua Persona, la sua missione condotta secondo il disegno<br />
del Padre che culmina nella Pasqua ed avrà il suo compimento<br />
quando Gesù consegnerà il Regno al Padre 2 . Al servizio dell’unica<br />
parola di Dio, le parole dell’uomo sono assunte come parola di Dio<br />
che risuonano nella predicazione profetica e apostolica. La parola di<br />
Dio, infatti, non resta bloccata nello scritto, ma continua la sua corsa<br />
nella predicazione e nelle tante altre forme di servizio di evangelizzazione,<br />
per cui la predicazione è parola di Dio comunicata dal Dio<br />
vivo a persone vive in Gesù Cristo tramite la Chiesa.<br />
Sarebbe interessante seguire la corsa della parola di Dio nella Chiesa<br />
lungo questi duemila anni di storia; si mostrerebbe una continuità<br />
di presenza, molteplicità di forme e di qualità secondo l’evoluzione<br />
storica e culturale, momenti di decadenza e di forte ripresa come quella<br />
del dopo Vaticano II 3 .<br />
L’evangelizzazione serve a farci capire che Dio parla a noi oggi<br />
nella Scrittura; non c’è bisogno di ritornare ad un «allora» in cui la<br />
parola storicamente fu scritta. L’evangelizzazione mi mette oggi in<br />
contatto con Cristo, cosicché oggi Cristo per me è partorito; oggi Cristo<br />
vive ed opera; oggi muore e ritorna al Padre; oggi viene dato lo<br />
Spirito Santo.<br />
Questo è possibile perché la parola di Dio nella Scrittura è panstorica,<br />
trascende la storia e tutta la storia deve esplicitarne il senso.<br />
Così Gregorio Magno poteva dire: «Cos’è la Scrittura, se non una<br />
lettera di Dio Onnipotente alla sua creatura? Dedicati, dunque, allo<br />
studio, ti prego; medita ogni giorno le parole del tuo Creatore:<br />
1 Il termine tecnico per eccellenza con cui l’AT indica la Parola è dabar<br />
(usato 1500 volte circa); il verbo che ne deriva, dibber, è usato quasi altrettanto<br />
spesso. Il costrutto dabar Jahvé, Parola del Signore, compare 241 volte, per<br />
lo più negli scritti profetici di Ger ed Ez.<br />
2 Cf. 1Cor 15,24.<br />
3 Cf. C. BISSOLI, “Va’ e annunzia” (Mc 5,19). Manuale di catechesi biblica,<br />
Torino 2006.
impara a conoscere il cuore di Dio nelle parole di Dio (disce cor<br />
Dei in Verbis Dei)» 4 .<br />
Un autore medievale, Goffredo d’Admont, prolunga questa riflessione<br />
in senso cristologico, prendendo come punto di partenza la descrizione<br />
giovannea del discepolo che Gesù amava, reclinato durante<br />
la cena sul petto di Gesù (cf. Gv 13,25):<br />
Il petto di Gesù è la Sacra Scrittura. Coloro che amano<br />
Dio e vogliono imitare Gesù devono sforzarsi di conoscere<br />
la Sacra Scrittura con il solo scopo di giungere ad una<br />
maggiore conoscenza di Dio, cioè per scoprire in essa il<br />
cuore di Dio, il sentire di Dio 5 .<br />
Dalla Sacra Scrittura si risale infatti alla conoscenza interiore di<br />
Gesù, al «petto» di Gesù e dal petto di Gesù, al cuore di Dio! In definitiva,<br />
occorre annunciare la parola alla luce dello Spirito che l’ha<br />
ispirata, perché solo in tal modo il lettore si eleva dalla storia al mistero<br />
di Cristo. Celebre è la formula di Ugo di S. Vittore: «Omnis<br />
Scriptura divina unus liber est, et ille liber unus Christus est» 6 .<br />
Richiamiamo un principio caro a S. Gregorio: «Divina eloquia<br />
cum legentibus crescit» 7 : quanto più si cresce nell’abbandono alla<br />
parola, tanto più la parola si abbandona a noi, cosicché si arriva a fare<br />
l’esperienza di Paolo: “Vivo, ma non io, la Parola vive in me”<br />
(cf. Gal 2,20); ormai io mi sono talmente lasciato possedere dalla<br />
Parola, che è la Parola stessa a guidarmi.<br />
Il Dio biblico è un<br />
Dio che parla: la Pa-<br />
1. In ascolto di Dio che parla rola è in Dio, la Parola<br />
è Dio (cf. Gv 1,1)<br />
e l’incontro con Lui<br />
avviene attraverso la parola: “Dio vi parlò in mezzo al fuoco: voce di<br />
parole voi ascoltavate, nessuna immagine vedevate, solo una voce”<br />
(Dt 4,12). Dio si presenta come “una voce di parole”, una voce<br />
entrata in scena agli inizi della creazione che squarcia il silenzio del<br />
4 S. GREGORIO MAGNO, Registro delle lettere, V, 46.<br />
5 Cf. I. GARGANO, “Per un ascolto ‘spirituale’ delle Scritture secondo il<br />
pensiero dei Padri della Chiesa”, PSV 1(1980), 197-200.<br />
6 UGO DA SAN VITTORE, L’arca di Noè, II, 8.<br />
7 S. GREGORIO MAGNO, Omelie su Ezechiele, I, 7.8.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
La forza<br />
evangelizzatrice<br />
della parola<br />
313-329<br />
teologia<br />
315
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
ANGELA MARIA LUPO<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
teologia<br />
316<br />
nulla. L’incontro tra Dio e l’uomo mediato dalla parola richiede lo<br />
sviluppo dell’interiorità e della libertà dell’uomo e si configura come<br />
comunione, come relazione 8 . Il Dio che parla è il Dio che si comunica<br />
e ciò significa che la parola di Dio dice tutto ciò che di Dio<br />
si possa dire mediante la parola; il Dio che parla è il Dio che si rivela,<br />
che risponde all’anelito proprio del cuore umano ed è presenza che<br />
si dona in Cristo Gesù, Parola fatta carne.<br />
Inoltre, il Dio che si rivela con la Parola è il Dio che si apre alla<br />
parola umana, che la attende e la desidera, cioè che si apre all’uomo<br />
e alla sua libertà. Il quadro al cui interno avviene il dialogo Dio-uomo<br />
è l’alleanza. Parlando, Dio esce dal suo nascondimento 9 e pone<br />
liberamente se stesso quale presenza personale che trascende la natura<br />
e chiede relazione all’uomo. Pregando l’uomo risponde liberamente<br />
al piegarsi di Dio verso di lui e assume la responsabilità della<br />
sua esistenza davanti a Dio.<br />
Innumerevoli passi della Scrittura presentano Dio in atto di parlare<br />
agli uomini e di trasmettere le sue parole mediante i suoi messaggeri.<br />
Scrive Tertulliano:<br />
Perché potessimo accostare con maggiore pienezza e intensità<br />
Dio stesso, le sue disposizioni e volontà, egli aggiunse gli<br />
strumenti della letteratura, per chi voglia ricercare Dio e<br />
cercandolo trovarlo, e trovatolo credere in lui, e credendo<br />
servirlo … La predicazione dei profeti e i miracoli che facevano<br />
per provare la divinità rimangono nei tesori letterari, che<br />
ormai non sono più occulti 10 .<br />
Il testo letterario è per noi uno strumento indispensabile per giungere<br />
a Dio, e per poter comprendere meglio la natura e la funzione di<br />
questo strumento occorre studiare la natura della realtà del linguaggio.<br />
Ricordiamo che ci sono tre accezioni fondamentali di dabar, “parola”<br />
e per comprenderli partiamo dai risultati della linguistica analitica<br />
che distingue tre dimensioni nell’atto del linguaggio 11 :<br />
la locuzione, che è l’atto globale del dire, del parlare concreto;<br />
l’illocuzione, indica quella particolare funzione linguistica che si<br />
realizza nell’atto della locuzione: affermare, negare, interrogare,<br />
rispondere;<br />
8 Cf. E. BIANCHI, «Parola di Dio, Parola a Dio», PSV 58 (2008) 202.<br />
9 Cf. Is 45,15.<br />
10 TERTULLIANO, Apologeticum 18,19, PL I, 337.<br />
11 Cf. B. MALMBERG, Les nouvelles tendances de la linguistique, Paris<br />
1968; A. MARTINET, Elementi di linguistica generale, Bari 1966.
la perlocuzione o performazione significa l’effetto reale prodotto<br />
dall’atto linguistico: insegnare, consolare, incoraggiare, condannare,<br />
promettere, obbligare.<br />
In maniera analogica possiamo dire che dabar indica:<br />
l’atto stesso di parlare, sarebbe il momento della locuzione;<br />
il contenuto poetico o il significato della parola;<br />
in terzo luogo significa la cosa stessa nominata dalla parola; nella<br />
disposizione degli eventi, dabar è l’evento in sé.<br />
Così quando leggiamo che «la Parola di Jahvé fu rivolta a x», si<br />
può parafrasare la formula dicendo che «la Parola di Jahvé si fece<br />
realtà in x». Infatti, per lo stretto legame che c’è tra dabar e ruah,<br />
“soffio”, “spirito”, la parola è attiva, efficace, creatrice, chiama all’esistenza<br />
12 .<br />
Nell’AT la parola di Dio stabilisce un rapporto di comunione tra<br />
Dio e il suo popolo attraverso strumenti di comunicazione particolari<br />
che sono:<br />
I sogni: Dio parla nei sogni a Giacobbe (Gen 20,3.6), a Giuseppe<br />
(Gen 28,12), a Salomone (1Re 3,5-15). Anche nei libri di Daniele e<br />
Zaccaria il sogno è ammesso come veicolo della parola di Dio.<br />
Dio parla attraverso i sacerdoti; gli strumenti sacerdotali per conoscere<br />
la volontà divina sono chiamati ‘urîm e tummîm: il sacerdote<br />
li custodiva nell’efod (borsa o pettorale). Non si sa se tali strumenti<br />
indicassero rispettivamente assenso o dissenso, oppure se recassero<br />
incisi segni o lettere dell’alfabeto.<br />
I profeti: per Dt 18,8-20 essi sono i soli veicoli autorizzati della parola<br />
di Dio. Quando nel post-esilio ci sarà la cessazione della profezia, quello<br />
non sarà un fenomeno di «silenzio di Dio», ma un momento di transizione<br />
dalla parola di Dio parlata alla parola di Dio scritta.<br />
Nella letteratura sapienziale dabar non compare con il significato<br />
di Parola di Dio, ma il suo posto è stato preso dal termine sofìa.<br />
La rivelazione di Dio per mezzo di parole umane, che è in definitiva<br />
una discesa di Dio a livello degli uomini, fu denominata dai<br />
Padri greci symkatàbasis, che i latini tradussero con condescendentia:<br />
cioè tenendo conto della nostra debolezza, Dio utilizza un<br />
linguaggio umano per farsi intendere e portarci alla salvezza 13 .<br />
12 Cf. C. WESTERMANN, Teologia dell’Antico Testamento, Brescia 1983, 21.<br />
13 R. GÖGLER, Zur Theologie des biblischen Wortes bei Origenes, Düsseldorf<br />
1963, 307.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
La forza<br />
evangelizzatrice<br />
della parola<br />
313-329<br />
teologia<br />
317
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
ANGELA MARIA LUPO<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
teologia<br />
318<br />
Come leggiamo in DV 12: «Dio ha parlato nella sacra Scrittura<br />
per mezzo di uomini e alla maniera umana», per cui la storia della<br />
Bibbia è storia della parola di Dio agli uomini; l’AT e il NT altro non<br />
fanno che descriverci l’itinerario della parola di Dio.<br />
Se Dio è il Dio che parla, il credente è essenzialmente colui che<br />
ascolta: “È l’udito il primo cordone ombelicale comunicativo della<br />
nostra esistenza; grazie all’udito ci separiamo dalla fusione indistinta<br />
con la carne del mondo e insieme ci teniamo pur sempre agganciati<br />
ad essa” 14 .<br />
L’ascolto è il luogo per eccellenza di purificazione e conversione<br />
delle immagini che l’uomo si crea di Dio, dunque di purificazione ed<br />
evangelizzazione della conoscenza del Signore. L’ascolto scava in<br />
noi uno spazio per l’Altro, interiorizza in noi la sua Parola e la sua<br />
presenza e ci fa vivere in comunione con Lui. Solo ponendosi in ascolto<br />
il credente lascia che il Signore sia il Signore: “Parla, Signore, che<br />
il tuo servo ti ascolta” (1Sam 3,9).<br />
La Scrittura stessa ci rivela che l’organo dell’ascolto, più che<br />
l’orecchio, è il cuore (1Re 3,9), cioè la totalità della persona e che<br />
la stessa parola divina può divenire idolo quando l’uomo cerca di<br />
catturarla e vuole impadronirsene 15 .<br />
1.1 L’azione della Parola<br />
Ci chiediamo quali aspetti e funzioni l’AT attribuisce alla Parola<br />
di Dio 16 :<br />
La parola è creatrice di comunione: è mediante la parola che Dio<br />
stabilisce la sua alleanza con il popolo.<br />
È strumento di comunicazione: sono infatti frequenti le formule<br />
del messaggero «Così dice il Signore…», «Oracolo del Signore».<br />
La parola ha la funzione di esortare, di ammonire, non solo nei<br />
14 C. SINI, Il gioco del silenzio, Milano 2006, 72.<br />
15 M. BUBER, Begegnungen, Stuttgart 1961, 46: “Bisogna riconoscere che<br />
gli uomini e le generazioni umane tendono a fraintendere Dio. L’uomo è fatto<br />
in modo che può, ma non deve necessariamente, comprendere ciò che Dio gli<br />
dice. Dio non lascia l’uomo creato in balia delle sue sofferenze e delle sue<br />
paure. Gli offre l’assistenza della sua parola, gli dice la sua parola. Ma l’uomo<br />
non presta orecchio attento e fedele a ciò che gli viene detto; mescola già<br />
al momento dell’ascolto comandamento celeste e norma terrena. A questo dato<br />
di fatto non si sottraggono neppure le sacre Scritture, neppure la Bibbia”.<br />
16 Cf. V. MANNUCCI, Bibbia come Parola di Dio. Introduzione generale<br />
alla Sacra Scrittura, Brescia 1981, 18ss.
profeti, ma anche negli scritti sapienziali. La parola è strumento<br />
esecutivo di Jahvé: essa infatti porta a compimento la volontà<br />
divina, in quanto fa agire gli angeli (Sl 103,20); crea il mondo<br />
(Sl 33,6). La storia non solo di Israele, ma di tutti i popoli, è sottoposta<br />
al giudizio e all’azione della parola di Dio: «Guai a voi, abitanti<br />
della zona marina, nazione dei Cretei! Ecco la parola del Signore<br />
contro di voi …» (Sof 2,5).<br />
Tale nozione attiva, dinamica della parola, ha la sua espressione più<br />
solenne nel racconto sacerdotale della creazione (Gen 1,1-2,4a) con i<br />
vari «Dio disse»: la parola non appare come qualcosa che è separato da<br />
Dio, ma è ricondotta alla sua iniziativa: egli crea parlando 17 .<br />
Il pensiero della permanenza fruttifera della parola ispira il difficile<br />
passo di Dt 30,11-14: il comandamento di Dio non è eccessivo<br />
né inaccessibile, non è in cielo né al di là del mare, anzi «La parola<br />
ti è molto vicina: è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la<br />
metta in pratica». La menzione della bocca e del cuore rendono l’idea<br />
dell’accessibilità della parola, che tutti sono in grado di capire e<br />
ripetere, facendola propria in vista della sua applicazione nella<br />
concretezza dell’esistenza.<br />
Così la Parola di Dio passa dallo stadio di parola contingente, legata<br />
ad una situazione specifica, allo stadio di parola fissata nella tradizione,<br />
poi scritta, alla quale far riferimento in tutte le circostanze. All’inizio si<br />
dà il titolo di dabar a raccolte sempre più ampie di esortazioni di Jahvé<br />
(es. Decalogo; raccolte di parole profetiche) e alla fine si arriva alla nozione<br />
che tutta la Scrittura di Israele è Parola di Dio.<br />
Nel NT Gesù è il Logos, la Parola eterna che si fa carne. Attraverso<br />
le cose dette, ma anche con tutta la sua attività, egli manifesta ed attua la<br />
salvezza. Gesù è la Parola di Dio che vive in mezzo a noi e dice parole<br />
che si distinguono per la loro autorevolezza e per la loro efficacia: con la<br />
parola scaccia gli spiriti immondi, opera guarigioni …<br />
Gesù ricorda l’importanza della parola ai suoi discepoli: «In base<br />
alle tue parole sarai giustificato, in base alle tue parole sarai<br />
condannato» (Mt 12,37). Perciò, nel giorno del giudizio gli uomini<br />
dovranno rendere conto delle loro parole (Mt 12,36), poiché la<br />
parola non è ritenuta una cosa estemporanea e fuggevole, alla quale<br />
17 E. SCHILLEBEECKS, Rivelazione e teologia, Roma 1966, 46: “L’ebraico<br />
non fa distinzione tra la parola e colui che la pronuncia. Parlare è un modo di<br />
essere della persona stessa. La potenza della parola è quella stessa della<br />
persona che la pronuncia”.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
La forza<br />
evangelizzatrice<br />
della parola<br />
313-329<br />
teologia<br />
319
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
ANGELA MARIA LUPO<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
teologia<br />
320<br />
non andrebbe attribuita alcuna importanza; al contrario essa è l’espressione<br />
della realtà interiore dell’uomo: «L’uomo buono trae fuori il<br />
bene dal prezioso tesoro del suo cuore; l’uomo cattivo, invece, dal<br />
suo cattivo tesoro trae fuori il male. Con la bocca, infatti, si esprime<br />
tutto ciò che si ha nel cuore» (Lc 6,45).<br />
Negli Atti degli Apostoli il termine logos designa per lo più la<br />
predicazione cristiana; nelle lettere paoline ci sono pochi riferimenti<br />
al termine, anche perché Paolo invece del termine logos ama usare<br />
altri sostantivi o espressioni equivalenti:<br />
Vangelo, lieta notizia. 1Cor 15,3-5 è il più antico sommario del<br />
kerigma apostolico che è presentato così: «Vi richiamo, fratelli,<br />
il vangelo che vi ho annunciato …» in 1Cor 9,19 egli riassume<br />
la sua attività apostolica: «Guai a me se non predicassi il<br />
vangelo!». Egli ha la coscienza di essere stato consacrato, appartato,<br />
separato per il Vangelo di Dio (cf. Rm 1,1).<br />
Predicazione: akoè, termine che sottolinea, nella predicazione,<br />
il momento del suo ascolto, non solo fisico ma anche sottomesso<br />
e obbediente. Importante è il testo di 1Ts 2,13: «Ricevendo<br />
dalla nostra voce la parola di Dio (gr: la parola della predicazione<br />
di Dio), l’avete accolta non come parola di uomini, ma<br />
come è realmente, come parola di Dio, la quale è potenza in voi<br />
che credete».<br />
Testimonianza: martyrion, e in 1Cor 1,6 la testimonianza di Cristo<br />
è la predicazione del Vangelo fatta da Paolo.<br />
1.2 L’efficacia della Parola<br />
Mentre nel caso di Gesù l’efficacia della sua parola risultava dalla<br />
descrizione dei suoi effetti, nelle lettere l’efficacia risulta in modo<br />
più teorico: dalla loro enunciazione; attraverso la parola la verità di<br />
Dio raggiunge gli ascoltatori.<br />
Il fine che Paolo si propone con la sua insistenza sulla parola è di<br />
portare i suoi ascoltatori ad accogliere l’annuncio del Vangelo e ad<br />
interiorizzarlo fino ad esserne trasformati. In questo modo la parola<br />
di Dio rinnova il miracolo della creazione di Gen 1. Con Cristo, infatti,<br />
si compie la «nuova creazione» (2Cor 5,17), perciò in Col 3,16<br />
si può augurare: «La parola del Cristo abiti in voi con tutta la sua<br />
ricchezza».<br />
Anche in Giovanni, come nei Vangeli sinottici, è grazie alla Parola<br />
che si perviene alla fede ed anzi si sottolinea che bisogna rimanere<br />
nella parola per arrivare alla pienezza della verità e della libertà.
Nella Lettera agli Ebrei il prologo indica la centralità della parola:<br />
«Dio, che nel tempo antico aveva parlato ai padri nei profeti, in una successione<br />
e varietà di modi, in questa fine dei tempi ha parlato a noi nel<br />
Figlio» (Eb 1,1-2a). Tutto lo scritto non è una lettera, ma un trattato religioso<br />
che mira a presentare Gesù Cristo come la Parola definitiva di<br />
Dio, superiore alle precedenti. Una digressione sulla parola si trova alla<br />
fine del cap. 4, che è un vero e proprio inno a due strofe sulla parola:<br />
12 Vivente, infatti, è la Parola di Dio e attiva,<br />
più tagliente di ogni spada a doppio taglio,<br />
penetrante fino alla saldatura d’anima e spirito,<br />
di giunture e midolla: discernente disposizioni e pensieri del cuore.<br />
13 Non c’è creatura che non sia manifesta davanti a lui.<br />
Anzi tutto è nudo e messo allo scoperto<br />
davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere (4,12-13).<br />
La parola è intesa dall’autore come qualcosa di inaudito che Dio<br />
manifesta in modo certo e vincolante nel contesto dell’ascolto e<br />
dell’obbedienza. Secondo il v. 12, la parola di Dio è ciò che Dio in<br />
persona pronuncia e le cui caratteristiche gli sono conformi. Come<br />
Lui, anch’essa è viva e tende quindi a portare alla vita; è efficace,<br />
provoca cioè l’efficacia di cui parla e può essere fonte di salvezza o<br />
di perdizione. La parola, inoltre, è l’arma più affilata che possa<br />
colpire l’uomo: quando trapassa divide ciò che vi è di più intimo,<br />
stretto e segreto. Essa giudica i sentimenti, quindi può mettere allo<br />
scoperto anche ciò che vi è di più segreto.<br />
Avendo Dio creato l’uomo con la parola, con la parola lo<br />
richiama di continuo alla sua origine creaturale di cui è chiamato a<br />
rendere conto senza potersi giustificare, perché dinanzi a Lui ogni<br />
cosa è “messa allo scoperto” e quindi ognuno deve dare una risposta<br />
adeguata alla parola 18 .<br />
Nel NT la Scrittura fa riferimento a ciò che dissero i profeti o<br />
altri autori biblici; ci sono molte citazioni per mostrare che Cristo è<br />
lo sbocco di quello che fu detto prima di Lui. Possiamo dire che la<br />
storia della Bibbia è storia della Parola di Dio agli uomini. L’AT e il<br />
NT non fanno altro che descriverci l’itinerario della Parola di Dio.<br />
In nessun luogo della Bibbia noi incontriamo la Parola di Dio<br />
direttamente se non in Gesù di Nazareth: la parola donata tramite<br />
vari messaggeri si fa carne in Gesù.<br />
18 Cf. A. STROBEL, La lettera agli Ebrei, Brescia 1997, 72-73.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
La forza<br />
evangelizzatrice<br />
della parola<br />
313-329<br />
teologia<br />
321
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
ANGELA MARIA LUPO<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
teologia<br />
322<br />
1.3 Le strade della Parola<br />
La parola di Dio personificata “esce” dalla sua casa, dal Tempio e<br />
si avvia per le vie del mondo: “Da Sion uscirà la Legge e da Gerusalemme<br />
la parola del Signore” (Is 2,3). Questo è possibile perché la<br />
parola di Dio è innanzitutto un avvenimento in cui Dio stesso si rivela<br />
e quindi come tale è rivelante: racchiude dei significati ed implica<br />
un orientamento verso la verità e la conoscenza. Ma essa è anche appello,<br />
chiamata, invito.<br />
Oggi, più che nel passato, la parola è penetrata nella molteplicità<br />
delle culture e viene espressa secondo i loro linguaggi, le loro concezioni,<br />
simboli e tradizioni religiose. Come aveva detto Giovanni Paolo<br />
II all’episcopato del Kenya durante il suo viaggio in Africa nel<br />
1980: “L’inculturazione (…) sarà realmente un riflesso dell’Incarnazione<br />
del Verbo, quando una cultura, trasformata e rigenerata dal Vangelo,<br />
produce dalla sua propria Tradizione espressioni originali di vita,<br />
di celebrazione, di pensiero cristiano” 19 . Prima di poter diventare Scrittura,<br />
la Parola è passata attraverso orecchi, occhi e mani di uomini.<br />
Tutti i membri delle varie comunità sono responsabili del progresso<br />
o del regresso della conoscenza della parola che è stata loro annunziata,<br />
ridonandola in maniera appropriata. La parola, infatti, appare<br />
come un elemento essenziale dell’incarnazione della persona in<br />
questo mondo. Essa è la realtà umana quale si manifesta esprimendosi:<br />
è un modo di essere uomo 20 .<br />
La parola, in quanto fenomeno umano, costituisce il luogo e lo<br />
strumento per la mediazione tra l’uomo e la cultura, e costituisce inoltre<br />
il mezzo dell’incontro tra la persona e il suo simile. La parola è<br />
una forza operante, riempita dello Spirito ed aperta all’avvenire. Essa<br />
è all’opera nella storia e appare in dialogo: un incontro a faccia a<br />
faccia tra Dio e l’uomo. Spazio esistenziale imprescindibile di mediazione<br />
della parola è la vita concreta del singolo fedele: la testimonianza<br />
della sua esistenza che annuncia la bellezza e la possibilità di<br />
attuazione del Vangelo è, più di ogni altro discorso, efficace forza di<br />
attrazione alla santità. In tale contesto anche il dialogo interpersonale<br />
diventa strumento di evangelizzazione attraverso le sue molteplici<br />
forme, quella del discorso, del consiglio, dell’indicazione, del suggerimento,<br />
dell’esortazione.<br />
19 Cf., Giovanni Paolo II in terra d’Africa, (Magistero 6), 12.<br />
20 G. GUSDORF, Filosofia del linguaggio, Roma 1970, 14: “Venire al<br />
mondo significa prendere la parola”.
La parola nuova<br />
che compie il<br />
presente e apre il<br />
futuro è la parola di Ge-<br />
sù, in cui si manifestano la vicinanza e l’immediatezza dell’azione di<br />
Dio. La sua parola non è solo un “atto linguistico” e non solo perché<br />
essa corrisponde alle sue “azioni” in parte storicamente verificabili, ma<br />
soprattutto perché essa si rivela nell’ultima “azione” umana possibile:<br />
nella sua morte 21 .<br />
La morte di Gesù è da intendere come la cessazione della Parola<br />
e al tempo stesso come una realtà estremamente eloquente; in quell’evento<br />
“il parlare denso di significato di Gesù rivela la sua densità<br />
di significato” 22 . La Parola fattasi carne vuole mostrare l’agire di Dio<br />
che conduce gli uomini alla liberazione da ogni forma di oppressione<br />
tramite la remissione dei peccati, la guarigione dei malati, l’espulsione<br />
dei demoni. Tuttavia non di rado Gesù rimprovera i suoi<br />
apostoli perché non comprendono la sua parola: “Se non comprenderete<br />
questa parabola, come potrete capire tutte le altre parabole?”<br />
(Mc 4,13) e poco più oltre leggiamo: “Essi non comprendevano<br />
queste parole e avevano timore di chiedergli spiegazioni” (Mc 9,32).<br />
2.1 La potente debolezza della Parola della Croce<br />
L’apostolo Paolo, di fronte ai partiti che dividevano la comunità cristiana<br />
di Corinto, presenta con grande incisività la debolezza–fortezza<br />
della sua predicazione, del Vangelo della Croce da lui annunziato:<br />
Cristo, infatti, non mi ha mandato a battezzare, ma a predicare<br />
il vangelo; non però con un discorso sapiente, perché non<br />
venga resa vana la croce di Cristo. La parola della croce, infatti,<br />
è stoltezza per quelli che vanno in perdizione, ma per quelli<br />
che si salvano, per noi, è potenza di Dio (1Cor 1,17-18).<br />
Paolo è colui che, prima di ogni altro, sottolinea l’aspetto sconcertante<br />
dell’agire di Dio che ha voluto salvare l’uomo attraverso la<br />
parola della croce di Cristo, simbolo di ogni debolezza, di ogni<br />
sconfitta, di ogni sofferenza. La parola, come Cristo e come la croce,<br />
è insieme “debole” e “forte”: è giudicata “stoltezza” da chi va in perdizione,<br />
ma è attraverso questa parola che arriva la salvezza a tutti.<br />
21 Cf. W. TRILLING, L’annuncio di Gesù, (Studi Biblici 74), Brescia 1986,<br />
120.<br />
22 Ibid.<br />
2. La parola incompresa<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
La forza<br />
evangelizzatrice<br />
della parola<br />
313-329<br />
teologia<br />
323
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
ANGELA MARIA LUPO<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
teologia<br />
324<br />
Paolo annunzia alla comunità di Corinto che a loro manca la fortezza<br />
umana, ma tale deficit non ha impedito che Dio li chiamasse e<br />
che, con strumenti umanamente poco adatti, confondesse i sapienti e<br />
i forti, annientando “le cose che sono, perché nessun uomo possa<br />
gloriarsi davanti a Dio” (1Cor 1,29). La parola è forte quando è<br />
debole, è parola di Dio quando è simultaneamente parola di uomini.<br />
Ma di quale debolezza si tratta?<br />
Sia in 1Cor 1,18–2,5 che in 2Cor 12,7-10 si possono riscontrare<br />
una serie di ossimori che riguardano il rapporto fortezza-debolezza,<br />
usati da Paolo per esprimere un concetto che egli ritiene di fondamentale<br />
importanza. Paolo mette in contrapposizione la debolezza forte<br />
di Dio e la fortezza debole dell’uomo. Da una parte, infatti, la croce<br />
di Cristo, il vangelo della croce, la chiamata di Dio e la predicazione<br />
di Paolo esprimono la debolezza degli strumenti di cui Dio si serve,<br />
ma è una debolezza forte, perché attraverso di essa arriviamo a Cristo.<br />
Dall’altra parte a tale forte debolezza si contrappone la “fortezza<br />
debole” dell’uomo, cioè la fortezza basata sulle prove convincenti<br />
della logica e quindi si tratta di una fortezza che è solo apparente<br />
perché impedisce di giungere a Cristo 23 .<br />
La fede è il luogo dove la parola della croce di Cristo non viene<br />
vanificata, ma viene riconosciuta ed accolta come Vangelo 24 ; quando<br />
seguendo Cristo, il Vangelo diventa vita, è Cristo che riprende vita,<br />
continuando la sua missione di rivelazione e di salvezza e così la parola<br />
si riveste nuovamente di “carne” 25 .<br />
3. L’evangelizzazione della<br />
parola nel Vangelo di Luca<br />
Consultando una<br />
concordanza del<br />
NT si rileva che<br />
il verbo greco euanghelízesthai<br />
nell’ambito dei<br />
quattro Vangeli ricorre una sola volta in Mt (11,5), mai in Mc e 10<br />
23 Cf. D. DOZZI, “La Bibbia ha un Autore e degli autori. Parola di Dio in<br />
parola umana”, PSV 58 (2008), 72ss.<br />
24 P. RICOEUR, Exégèse et herméneutique, Paris 1971, 294: “La verità di<br />
fede è un cammino da seguire”.<br />
25 H. DE LUBAC, L’Ecriture dans la Tradition, Paris 1966, 35: «La parola di Dio,<br />
parola viva ed efficace, non ottiene il suo compimento reale e il suo pieno significato<br />
se non nella trasformazione che essa opera in colui che la riceve ».
volte in Lc. Lc lo usa altre 15 volte negli Atti degli Apostoli. Per il<br />
resto del NT il verbo ricorre 21 volte nelle lettere di Paolo, 2 volte in<br />
Ebrei, tre volte nella 1Pt e 2 volte nell’Ap 26 .<br />
Nel brano programmatico del Vangelo di Luca (4,16-30), che<br />
caratterizza l’inizio della predicazione pubblica di Gesù nella sinagoga<br />
di Nazaret, è citata la profezia di Is 61,1-2 che Gesù applica a<br />
sé, segnalando che il suo ministero di evangelizzazione consiste<br />
nell’annunziare un messaggio che è “lieto” perché permette la<br />
liberazione dai mali che affliggono l’umanità e perché è destinato<br />
a capovolgere la situazione dei poveri di Jahvé.<br />
L’opera di evangelizzazione, secondo Luca, caratterizza sia la<br />
missione di Gesù che quella dei suoi discepoli. Tra i passi che<br />
riguardano Gesù merita particolare attenzione Lc 4,43 perché, nel<br />
contesto del capitolo quarto del Vangelo, presenta l’evangelizzazione<br />
come essenza e scopo della missione di Gesù: “Anche alle<br />
altre città bisogna che io evangelizzi il Regno di Dio, perché per<br />
questo sono stato mandato”.<br />
L’altro soggetto del verbo “evangelizzare” sono i discepoli. In Lc<br />
9,6 di essi si dice che “uscendo passavano di villaggio in villaggio<br />
evangelizzando e curando dappertutto”: appare che come l’opera<br />
evangelizzatrice di Gesù, anche quella del discepoli tende a tradursi<br />
in gesti terapeutici.<br />
Soprattutto negli Atti degli Apostoli emerge che l’opera di<br />
evangelizzazione non è compito esclusivo di alcuni, ma è dovere di<br />
tutti coloro che sono stati illuminati e rigenerati dalla Parola. In ogni<br />
caso, l’unica persona oggetto dell’evangelizzazione è Gesù nella<br />
totalità del suo mistero ed è proprio la persona di Gesù che attua a<br />
rende lieto l’annuncio, perché è lui la forza liberatrice del “lieto<br />
messaggio”, non solo dei mali di natura fisica, ma soprattutto attua<br />
la liberazione dagli idoli 27 e da ogni forma di suggestione 28 .<br />
26 Cf. W.F. MOULTON – A.S. GEDEN – H.K. MOULTON, Concordance to<br />
the Greek Testament, Edinburgh 1986.<br />
27 Cf. At 14,15.<br />
28 Cf. R. FABRIS (ed.), La Parola di Dio cresceva (At 12,24), Bologna 1998,<br />
311ss.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
La forza<br />
evangelizzatrice<br />
della parola<br />
313-329<br />
teologia<br />
325
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
ANGELA MARIA LUPO<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
teologia<br />
326<br />
4. Rimanere nella Parola<br />
Nel capitolo 8<br />
del Vangelo di<br />
Giovanni, la<br />
diatriba di Gesù con i<br />
giudei gli permette di rivelare la sua intima relazione con il Padre:<br />
Gesù dice di sé che ascolta la parola del Padre e la custodisce perché egli<br />
conosce il Padre (8,55) e allo stesso modo al discepolo viene chiesto di<br />
custodire la parola di Gesù (cf. 8,51.52): “Gesù custodisce la parola perché<br />
conosce il Padre, i discepoli rimanendo nella parola e custodendola<br />
potranno conoscere progressivamente la verità ed essere liberi” 29 .<br />
Chi “custodisce la parola non vedrà la morte in eterno” (8,51), perché<br />
l’accoglienza della rivelazione permette di passare, già ora nella<br />
vita presente, dalla morte alla vita. L’identità del discepolo è quindi<br />
definita dalla custodia della parola, segno dell’amore che ha verso<br />
Gesù e che determina un movimento d’amore del Padre verso il discepolo,<br />
perché al “rimanere” del discepolo nella parola (cf. 8,32),<br />
corrisponde la “dimora” fatta dal Padre e dal Figlio in lui 30 .<br />
La custodia della parola non indica quindi un atteggiamento meramente<br />
intellettuale, 31 ma implica una relazione di comunione intratrinitaria<br />
e si traduce con il vivere il comandamento dell’amore, che<br />
è il contenuto essenziale della parola. Il comandamento dell’amore<br />
vicendevole, infatti, radicato nella custodia della parola, diviene un<br />
vero e proprio mandato missionario; esso dipende dalla custodia della<br />
parola e fa trasparire, nell’intreccio delle relazioni tra i credenti,<br />
l’amore trinitario che alberga nel cuore dei discepoli 32 .<br />
La custodia della parola è quindi una vera e propria attività interiore<br />
che implica la memoria attualizzante, la riflessione e il discernimento.<br />
La vita del credente è lentamente plasmata da ciò che lui<br />
29 M. MARINO, Custodire la Parola. Il verbo THPEIN nell’Apocalisse alla<br />
luce della tradizione giovannea, Bologna 2003, 169.<br />
30 Cf. U. WILCKENS, Il Vangelo secondo Giovanni, Brescia 2002, 197.<br />
31 P. BOVATI, Il libro del Deuteronomio (1–11), Roma 1994, 93-94: “Il verbo<br />
ebraico shamar che è tradotto con ‘osservare’ i comandamenti, significa<br />
propriamente custodire, mantenere, conservare. Ed è Dio che manifesta il suo<br />
amore ‘mantenendo’ il giuramento fatto ai padri e ‘conservando’ la sua benevolenza<br />
per mille generazioni. A patto che Israele resti in questa storia e<br />
accetti di mantenere il suo impegno che è ‘osservare’ in modo perseverante e<br />
fedele tutti gli ordini del Signore”.<br />
32 A. HUMBERT, “L’observance des commandaments dans les ècrits<br />
Johanniques” StMor 1 (1963), 187-219.
custodisce: ciò che fa o dice esprime ciò che è divenuto parte di se<br />
stesso e quindi la custodia della rivelazione permette al credente di<br />
divenire, lui stesso rivelazione vivente 33 .<br />
Dalla custodia dipende dunque la capacità della testimonianza ed<br />
è anche capacità di prendere una legittima distanza dagli eventi della<br />
cronaca per assumere lucidamente il punto di vista di Dio e valutare<br />
autenticamente le vicende umane, al di là delle apparenze.<br />
La scena storica<br />
Conclusione che si presenta<br />
oggi davanti ai<br />
nostri occhi, nella sua<br />
estrema complessità, esige una nuova evangelizzazione della Parola.<br />
Essa potrà incontrare, più che nel passato, varie forme di resistenza<br />
che richiedono nuove forme di martirio, cioè di resistenza al “sistema<br />
mondano”. La realtà sociale, la politica e l’economia dovrebbero<br />
essere abitati dai credenti e “combattuti” dal di dentro.<br />
La Parola può continuare a svolgere il suo impegno volto alla liberazione<br />
dalle molteplici forme di schiavitù che opprimono l’uomo<br />
in forme diverse. Ai singoli e alle comunità è affidato il delicato compito<br />
di tradurre operativamente la parola di salvezza denunciando le<br />
varie situazioni che negano concretamente i valori umani e cercando<br />
di inserire i valori evangelici nei circuiti delle strutture socio-politiche<br />
dove si decide il destino di interi popoli.<br />
La parola di Dio deve aiutare a leggere profondamente la realtà<br />
sociale, al di là delle apparenze; per tale motivo si deve mettere un<br />
grande impegno per offrire alle comunità cristiane momenti intensi<br />
di esperienza di fede e di preghiera che sappiano riconciliare il rapporto<br />
della trascendenza con la responsabilità del mondo.<br />
In un tempo, qual è il nostro, in cui l’agire assume un’importanza<br />
del tutto privilegiata, con il rischio di scambiare l’efficacia con l’efficienza,<br />
è quanto mai attuale richiamare l’attenzione sull’attività interiore<br />
dell’ascolto, interiorizzazione e custodia della parola: ascoltare<br />
e custodire per testimoniare. La testimonianza è il fine ultimo<br />
dell’ascolto e della custodia della rivelazione, ed è quindi su di essa<br />
che bisogna verificarsi.<br />
33 Cf. R.E. BROWN, Giovanni, Assisi 1979, I, 472ss.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
La forza<br />
evangelizzatrice<br />
della parola<br />
313-329<br />
teologia<br />
327
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
ANGELA MARIA LUPO<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
teologia<br />
328<br />
Mi piace concludere citando il Maggid di Mesritsch che dice:<br />
Ogni serratura ha la chiave adatta che la apre. Ma ci sono dei ladri<br />
forti che sanno aprire senza chiave: sforzano la serratura. Così ogni<br />
segreto del mondo si può aprire con la particolare meditazione adatta.<br />
Ma Dio ama il ladro che sforza la serratura: costui è l’uomo che<br />
si rompe il cuore per Dio 34 .<br />
THE EVANGELIZING POWER OF THE WORD<br />
By Sister Angela Maria Lupo, c.p.<br />
Lupo’s reflections clearly show the originality, even the uniqueness<br />
of God’s speaking to man and man’s talking with God proposed by<br />
the Hebrew-<strong>Christi</strong>an Bible. Carefully analyzing numerous passages<br />
of both the Old and the New Testaments, the article shows us<br />
the characteristics of this dialogue, something which cannot be<br />
reduced to magic or fantasy, involving as it does the entire life of the<br />
disciple and the very image which man forms of God. In concluding,<br />
the author stresses that the historical scene placed before our eyes<br />
today demands a new evangelization of the Word.<br />
LA FUERZA EVANGELIZADORA DE LA PALABRA<br />
De Sor Angela María Lupo CP.<br />
ENG<br />
ESP<br />
La reflexión de la autora Lupo muestra claramente la originalidad,<br />
e incluso la unicidad de la relación entre Dios y el hombre que la<br />
Biblia Hebraico-cristiana propone, una relación que se califica<br />
como la comunicación de Dios al hombre y el coloquio del hombre<br />
con Dios. Con un análisis esmerado de los numerosos pasajes del<br />
Antiguo y Nuevo Testamento, el artículo muestra asimismo las<br />
características de este diálogo, no reducible a nada mágico o fantástico,<br />
sino que envuelve existencialmente la vida completa del<br />
discípulo y la misma imagen que el hombre se hace de Dios. Como<br />
34 Citato da P. STEFANI, Introduzione all’ebraismo, Brescia 1995, 339.
conclusión la autora pone de relieve que la escena histórica que se<br />
presenta hoy a nuestros ojos exige una nueva evangelización de la<br />
Palabra.<br />
DIE EVANGELISIERENDE KRAFT DES WORTES<br />
GER<br />
GOTTES<br />
von Sr. Angela Maria Lupo CP<br />
Die Erwägungen von Lupo machen die Originalität und<br />
Einzigartigkeit der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen in<br />
der hebräisch-christlichen Bibel deutlich - eine Beziehung, in der<br />
Gott zum Menschen spricht, und der Mensch in einen Dialog mit<br />
Gott eintritt. In einer sorgfältigen Analyse zahlreicher Schriftstellen<br />
aus dem Alten und Neuen Testament werden im vorliegenden Artikel<br />
die charakteristischen Eigenschaften dieses Dialoges aufgezeigt. In<br />
ihm kann nichts Magisches oder Fantastisches gefunden werden,<br />
wenngleich dieser Dialog das ganze Leben des Jüngers existentiell<br />
in Anspruch nimmt und das Bild bestimmt, das der Betroffene sich<br />
von Gott macht. Die Autorin kommt zum Ergebnis, dass die biblischhistorische<br />
Szenerie, wie wir sie heute vor Augen haben, eine<br />
Neuevangelisierung des Wortes notwendig macht.<br />
POL<br />
EWANGELIZACYJNA MOC SŁOWA<br />
S. Angela Maria Lupo CP<br />
Refleksja s. Lupo wyraźnie pokazuje oryginalność a nawet wyjątkowość<br />
relacji Bóg-człowiek, którą zawiera Biblia hebrajsko-chrzeiścijańska;<br />
relacji którą można określić jako mowę Boga skierowaną<br />
do człowieka i rozmowę człowieka z Bogiem. Poprzez skrupulatną<br />
analizę licznych fragmentów Starego i Nowego Testamentu artykuł<br />
ukazuje cechy tej rozmowy, której nie da się sprowadzić do magii<br />
czy wyobraźni, bo jest czymś, co angażuje całe życie ucznia na<br />
poziomie egzystencjalnym oraz określa sposób, w jaki człowiek pojmuje<br />
Boga. W zakończeniu autorka podkreśla, że sytuacja historyczna,<br />
z którą mamy do czynienia, wymaga nowej ewangelizacji Słowa.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
La forza<br />
evangelizzatrice<br />
della parola<br />
313-329<br />
teologia<br />
329
di NICO DE MICO<br />
Prima parte<br />
Profonda meditazione sulla vicenda<br />
di Max Joseph Metzger sul<br />
quale la nostra rivista ha già riflettuto<br />
con un articolo di Lubomir<br />
Zac (Sap Cr XXIV-2009, 53-83).<br />
Ciò che l’autore scopre nel martire<br />
è confermato dai testi delle<br />
Lettere che egli riporta prevalentemente<br />
nelle note in calce. Qui<br />
la <strong>Passio</strong>ne vissuta da Metzger è<br />
quanto di più lontano c’è dall’intimismo,<br />
vede con chiarezza<br />
quanto il male assoluto è lontano<br />
dall’Amore della <strong>Passio</strong>ne,<br />
non ammette compromessi. E tuttavia<br />
vive in conformità a Cristo<br />
tutti i passaggi di sofferenza del-<br />
la fragilità umana che l’autore evidenzia specialmente nella<br />
seconda parte dell’articolo.<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
Max Josef 1<br />
Metzger1<br />
E infranse tutte<br />
le catene,<br />
senza far rumore<br />
“La parola di Dio non si<br />
lega con le catene” 2<br />
1 M. J. Metzger (1887-1944), sacerdote cattolico tedesco, già trattenuto<br />
nelle prigioni naziste per la prima volta dal 23 al 26 gennaio 1934 e per la<br />
seconda dal 9 novembre al 4 dicembre 1939, viene arrestato dalla Gestapo<br />
per la terza volta, e in tale circostanza con esito fatale, il 29 giugno 1943. A<br />
ricordarne il sacrificio e la testimonianza di fede, si è cercato di ricostruirne la<br />
dolorosa, ultima esperienza carceraria, sulla base esclusiva delle lettere da lui<br />
scritte durante tale tragica prigionia, che si protrasse fino al 17 aprile 1944,<br />
giorno della sua morte per decapitazione. Le Lettere cui nel presente lavoro si<br />
fa riferimento, sono pubblicate, in traduzione italiana, in Max Josef Metzger, La<br />
mia vita per la pace, a cura di L. Zak, Cinisello Balsamo, 2008.<br />
2 2 Tm 2,9. Viva ed efficace è la parola di Dio (Eb 4,12), che è salvezza<br />
(At 13,26), forza divina (1 Cor 1,18), verità (Ef 1,13), vita (At 5,20) liberazione<br />
(Gc 1,21), e che corre, secondo la missione affidata da Gesù ai suoi discepoli<br />
(Mt 28,19), della quale sono resi esecutori tutti i fedeli (Gc 1,22).<br />
E infranse<br />
tutte le catene,<br />
senza far rumore<br />
331-348<br />
spiritualità<br />
331
pastorale e<br />
spiritualità<br />
NICO DE MICO<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
spiritualità<br />
332<br />
In un penitenziario di estrema durezza, reclusorio di un’umanità<br />
disprezzata, disconosciuta e inascoltata, plaga dolorosa di isolamento<br />
e segregazione in cui è assai facile che la lucidità sconfini<br />
nella follia e nella disperazione, tra un numero rimasto sconosciuto<br />
di detenuti, tanti, anonimi, Max Josef Metzger sperimenta e sopporta<br />
gli apici dell’inflessibilità e della spietatezza umane, spoglie di<br />
ogni brivido di pietà. Perché, in certi contesti, la pietà è una forma<br />
di cedimento e il cedimento può risultare rischioso; perché la sensibilità<br />
è disposizione a risentire di emozioni, sentimenti e affetti e la<br />
raggiungibilità può scalfire l’indifferenza e il distacco; perché la clemenza<br />
è inclinazione all’indulgenza e al perdono e la compartecipazione<br />
può diventare pericolosa debolezza.<br />
Più volte imprigionato nelle carceri naziste, e più volte confinato,<br />
dunque, in un’atmosfera di sospensione surreale dove la morte<br />
resta di continuo prorogata per un po’ e dove il quotidiano è una<br />
straziante testimonianza del dramma di un’esistenza in cui vivono e<br />
convivono, tra mille squilibri, spossanti sensi di incompiutezza e<br />
impotenza e ardenti aneliti di spazio e di infinito, il sacerdote cattolico<br />
conosce e patisce i travagli di un’epoca storica in cui, mentre il<br />
potere umano dà prova della sua vigorosità e della sua forza, ma<br />
anche della sua stoltezza e della sua follia, si disperde e si consuma<br />
la vita martoriata di tanti uomini.<br />
Sullo sfondo, infatti, non inerti comparse, ma attori vivi e doloranti,<br />
troppi prigionieri si muovono rassegnati, sottomessi e privi di<br />
energia, schiacciati dal peso dell’ingiustizia che li fa martiri innocenti:<br />
individui orfani e soli, i quali, vittime del loro tempo, paradossalmente<br />
sembrano non appartenere al tempo; e sono comunque lì,<br />
a dare, nell’attesa di impossibili ritorni e improbabili svolte, il senso<br />
del tempo e di ciò che succede in esso 3 ; emblematicamente sospesi,<br />
3 “Eravamo sette uomini che in una cella del Tribunale (di Giustizia del<br />
Popolo) attendevamo il processo. [...] Seguendo l’ordine, ognuno tornava dal<br />
processo con le mani incatenate, segno questo della condanna a morte. [...] È<br />
sempre un nuovo colpo al cuore quando si vedono portare alla ghigliottina i<br />
compagni venuti qui insieme a noi, senza sapere per quanto tempo ancora si<br />
potrà sfuggire alla loro sorte ”: Lettera del 14 novembre 1943.<br />
4 Già fondatore, con W. Impekoven, detto fratel Gottwills, della Società missionaria<br />
della Croce Bianca (1919), successivamente denominata Societas<br />
<strong>Christi</strong> Regis, Metzger costituisce, tra la fine del 1938 e l’inizio del 1939, la<br />
Fraternità interconfessionale Una Sancta, nella prospettiva di creare terreno fertile<br />
per un autentico, reciproco e costruttivo ritrovarsi, in Cristo, dei fratelli divi
a farsi portavoce e codificazione di ideologie e comportamenti<br />
umani ben identificabili e contestualizzabili, ma anche di principi<br />
teorici per tutti e ovunque valevoli.<br />
È il 29 giugno del 1943 quando, con presumibile fraudolento<br />
concorso della svedese Dagmar Imgart, che considera fedele membro<br />
della Fraternità Una Sancta da lui fondata 4 e suo collaborativo<br />
corriere, ma che è, in realtà, un’agente in incognito della Gestapo,<br />
Metzger viene per la terza e ultima volta arrestato dalla polizia<br />
segreta tedesca, con l’accusa di tradimento e di sovversione.<br />
Ha appena consegnato nelle mani della donna, perché lo faccia<br />
pervenire clandestinamente in Svezia, un proprio compromettente<br />
Memorandum, nel quale, sostenendo l’imminenza della disfatta dei<br />
Tedeschi, auspica la presenza di una Germania democratica e libera<br />
dal nazional-socialismo all’interno di una Federazione degli Stati<br />
d’Europa, concepita come forza capace di pacificare e unificare i<br />
popoli, sulla base di un impegno di tutti per il bene comune 5 .<br />
si e irrigiditi nelle proprie posizioni. Consapevole del disorientamento e delle<br />
inquietudini di tanti credenti, sia cattolici sia protestanti, egli propone una<br />
Chiesa sentita come comunità di fede, di speranza e di carità, mistero di comunione<br />
che coinvolge, radunandolo, tutto il popolo di Dio e che si costituisce<br />
passo passo, con il concorso di tutti. Egli sa che realizza l’umiltà nel proprio<br />
vissuto chi, lasciandosi pervadere dalla grazia di Dio (Rm 12,3), s’impegna<br />
fino in fondo perché ci sia l’unità nella comunità (Fil 2,1-4), rifiutando di porsi<br />
al di sopra degli altri (Rm 12,16). Ma il richiamo all’unificazione e alla compattezza<br />
oltre ogni differenza viene percepito dal potere come implicito appello<br />
all’opposizione e alla congiura e pertanto l’Una Sancta, come pure altre istituzioni<br />
ecumeniche, vengono da esso qualificate come forze nemiche e perciò<br />
perseguibili. Va tenuto ben presente che l’armonia di diverse fedi contrasta con<br />
la visione di Hitler, già in nuce nel Mein Kampf, di una Chiesa nazionale tedesca,<br />
espressione e strumento dello Stato e della razza superiore.<br />
5 Il sacerdote cattolico profonde da sempre un impegno indefesso nell’aprire<br />
le menti e i cuori all’idea di un’unione pacifica dei popoli, quale condizione<br />
imprescindibile per liberare dall’infelicità e dal male. Si è appena usciti dal I<br />
conflitto mondiale, quando scrive: “Deve rinascere una nuova Europa che,<br />
diversamente da quella vecchia, non avrà più ambizione di espandere il potere,<br />
ingrandire il territorio e cose simili. Un’Europa, che metterà insieme i popoli<br />
racchiudendo in una grande unione pacifica gli interessi comuni e l’impegno<br />
di tutti nella soluzione dei comuni problemi... Quest’unione degli Stati d’Europa<br />
verrà, dovrà venire, perché se non la forgeranno insieme la comprensione e gli<br />
ideali, essa sarà saldata dall’egoismo e dalla paura”: M.J. Metzger, Das neue<br />
Europa, in Die neue Zeit I (1918), n. 10, p. 69.<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
E infranse<br />
tutte le catene,<br />
senza far rumore<br />
331-348<br />
spiritualità<br />
333
pastorale e<br />
spiritualità<br />
NICO DE MICO<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
spiritualità<br />
334<br />
È quanto basta per farlo giudicare un traditore e un sobillatore<br />
meritevole di morte 6 : inizia da qui il calvario che lo condurrà alla<br />
morte per decapitazione mediante la macchina della ghigliottina,<br />
che il potere ha pensato, e con zelo utilizza, come strumento di<br />
repressione e di dissuasione.<br />
6 Vi si legge: «La “Nordlandia” (“Stati Uniti del Nord”) è un’unione di Stati<br />
liberi a governo democratico (Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca,<br />
Islanda). Ogni Stato libero è autonomo, nel quadro della costituzione della<br />
“Nordlandia”, quanto alle questioni di politica interna, agli affari culturali e<br />
sociali e all’amministrazione. La politica estera viene condotta congiuntamente<br />
ed è riservata alla guida dell’unione di Stati. La politica sia interna che estera<br />
della “Nordlandia” è definita costituzionalmente come autentica politica di<br />
pace fondata sul rispetto del diritto morale eterno, sul riconoscimento e la tutela<br />
dello stesso diritto fondamentale per tutti i cittadini, su una politica sociale<br />
progressista ( certezza del lavoro, del guadagno e delle possibilità di vita per<br />
tutti; nazionalizzazione di tutte le miniere, di tutte le centrali elettriche, delle ferrovie,<br />
come pure delle grandi proprietà di campi, boschi e laghi; una politica<br />
fiscale sociale con la tutela dei più deboli) e su una politica equa delle nazionalità<br />
e delle razze (autogestione dei consigli nazionali, per esempio per quanto<br />
riguarda i fondi pubblici per la scuola. La politica di pace estera riconosce<br />
e rispetta nella maniera più ampia il diritto alla vita dei popoli stranieri e<br />
appoggia, ovvero compie volontariamente il disarmo (fatta eccezione per un<br />
corpo di polizia destinato al mantenimento dell’ordine interno) a favore di un<br />
esercito transnazionale, posto al servizio di un organo degli “Stati Uniti<br />
d’Europa” al di sopra delle parti, il quale si fa carico di tutelare una pace giusta<br />
tra gli Stati. A ogni cittadino della Nordlandia vengono garantite costituzionalmente<br />
l’inviolabilità della dignità personale e della certezza del diritto, la<br />
libertà di coscienza, di lingua e di cultura, come pure di religione, la libertà di<br />
opinione e infine la libertà alla proprietà personale e all’uso della proprietà nell’ambito<br />
dei limiti stabiliti dal bene comune e definiti giuridicamente in modo<br />
chiaro. Tutti i cittadini della Nordlandia che, in modo provato, sono corresponsabili<br />
della rovina nazionale e della violenza sul loro popolo, come pure tutti<br />
coloro che sono condannati per crimini comuni, sono esclusi per vent’anni da<br />
tutti i diritti di cittadino (diritto di voto, diritto di ricoprire cariche pubbliche).<br />
Fino all’accertamento, ossia alla prova della loro affidabilità caratteriale e costituzionale,<br />
questa correità viene presupposta per tutti i funzionari dei partiti antinazionali<br />
e antisociali e delle loro organizzazioni militari di autodifesa.<br />
L’elenco popolare tenuto a tale riguardo è pubblico. Fino alla ratifica della costituzione<br />
definitiva mediante votazione popolare libera, il potere legislativo della<br />
Nordlandia viene esercitato dal parlamento del popolo. Questo è costituito da<br />
rappresentanti prominenti di tutti i ceti, come pure da personaggi eminenti degli<br />
enti intellettuali, culturali, religiosi, scelti la prima volta dall’ordine della pace<br />
della Nordlandia. Detto ordine comprende personaggi di tutti i gruppi statali e<br />
degli ex partiti, che si sono distinti nel sostenere i principi morali, sociali e politici<br />
della nuova politica di pace davanti al loro popolo e al mondo, soprattutto<br />
se a causa delle loro convinzioni e della loro posizione hanno dovuto subire<br />
svantaggi personali dal sistema precedente. Questo programma politico viene<br />
redatto per il caso in cui a conclusione della guerra scoppi una rivoluzione che<br />
non consenta più di mantenere la continuità del diritto»: cf. Max Josef Metzger,<br />
op. cit., pp. 260-262.
Condannato a morte a Berlino il 14 ottobre 1943, nel corso di un<br />
processo fittizio in cui vede miseramente crollare tutte le speranze,<br />
che in esso aveva riposto, di poter provare la sua distanza da fini<br />
politici, la purezza dei suoi intendimenti cristiani, l’amore autentico<br />
per la sua terra e la sincera, fraterna preoccupazione per un eventuale<br />
destino di dolore del popolo tedesco sopraffatto 7 , passerà sei lunghi<br />
mesi, venticinque interminabili settimane, nel braccio della<br />
morte di Braandenburg-Görden, in attesa dell’esecuzione della<br />
quale ignorerà, fino all’ultimo, il giorno e l’ora 8 .<br />
Così il potere ufficiale, colpendone il leader, pensa di arginare<br />
l’espandersi e l’articolarsi di quella Fraternità Una Sancta, dallo<br />
stesso istituita, che da tempo guarda con preoccupazione e che giudica<br />
irriducibilmente avversa al partito nazionalsocialista e alla sua<br />
ideologia unificatrice 9 .<br />
7 “Sarei dovuto comparire in giudizio alle 11. Di fatto, però, erano già la tre<br />
e mezzo del pomeriggio quando fui condotto davanti ai magistrati. Il tempo di<br />
attesa fu un’autentica prova di nervi. Tuttavia ero abbastanza calmo e concentrato.<br />
Quando [alcuni giorni prima] ricevetti il verbale d’imputazione, che era<br />
redatto in modo pacato e pertinente, avevo ancora speranza in un processo che<br />
avesse un po’ a che fare con il vero significato del termine. Ma poi, quando<br />
venne l’avvocato e mi disse che l’udienza avrebbe avuto luogo tra un paio di<br />
giorni, compresi che il dado era ormai tratto. [...] Già il momento introduttivo<br />
dell’udienza, però, mi tolse ogni dubbio: colà si amministrava la “giustizia” non<br />
per far valere il “diritto”, ma per impressionare il popolo con un processo spettacolare.<br />
Allora compresi chiaramente che ogni umana speranza era vana.<br />
Nondimeno mi sentii in dovere di fare tutto quello che era nelle mie forze, al fine<br />
di mettere in luce – di fronte, per così dire, alla storia – la verità vera, anche se<br />
in quel consesso essa non veniva riconosciuta”: Lettera del 14 novembre 1943.<br />
8 Il processo che condanna a morte Metzger come “infame traditore del<br />
popolo” si svolge a Berlino il 14 ottobre 1943. Ne è giudice spietato Roland<br />
Freisler, sotto la cui presidenza (1942-1944) la storia registra più di 5000 pronunce<br />
di sentenza di morte. “Esattamente un mese fa mi trovavo dinanzi al<br />
Tribunale di Giustizia del Popolo. [...] Quando udii il verdetto di condanna a<br />
morte fui colto da un senso di fiero disprezzo. Sentivo che il fatto di essere giudicato<br />
“disonorevole” da un simile tribunale non rappresentava una vergogna,<br />
ma un onore. Dovetti dominarmi per non dare maggior risalto all’espressione<br />
del volto, come comunque feci. In nessuna maniera mi sentivo colpito dal giudizio.<br />
[...] Quando alla sera entrai nella mia cella mi inginocchiai, ringraziando<br />
Dio di avermi inserito in questo modo nella sequela di Cristo, e Lo pregai<br />
affinché conservasse il mio coraggio fino alla fine”: Lettera del 14 novembre<br />
1943<br />
9 La pubblicazione, nel 1925, del Mein Kampf di Hitler, rende più intensa<br />
e radicale, in Metzger, l’esigenza di richiamare alla difesa di ideali comunitari<br />
di unità e pace, contro l’idea di un nuovo mondo unificato, come prodotto di<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
E infranse<br />
tutte le catene,<br />
senza far rumore<br />
331-348<br />
spiritualità<br />
335
pastorale e<br />
spiritualità<br />
NICO DE MICO<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
spiritualità<br />
336<br />
Metzger aderisce senza riserve alle spaccature dell’umana esistenza<br />
10 : cosciente di essere ormai tagliato fuori dal mondo e di non<br />
poter più prendere il largo, costretto ad ammainare le vele e a prendere<br />
atto dell’invalicabilità delle mura carcerarie, drammaticamente<br />
consapevole della sconfitta fatale, non retrocede, né si chiude in se<br />
stesso, né perde il contatto con la realtà: un saldo, lucido razionalismo<br />
che non gli consente di filosofeggiare sulla fortuna o sfortuna,<br />
o di moraleggiare per distribuire arrogantemente biasimi e sentenze,<br />
gli conserva, intatta, la capacità di guardare in prospettiva e di pensare<br />
in comunione 11 . Uomo di parola e della parola, non si erge<br />
superbo e sprezzante e non punta l’indice contro le devianze del<br />
potere, riconfermandosi, invece, sacerdote di amore, di compassione<br />
e di comprensione 12 . Intride così la sua sofferenza di significati<br />
gruppi di individui ben circoscritti e selezionati. Demarcando con l’ideologia<br />
nazista una differenziazione inconciliabile, il sacerdote cattolico, fin dall’inizio<br />
e sempre più incisivamente con l’Una Sancta, ribadisce l’uguaglianza delle<br />
razze e dei popoli contro il principio della superiorità della razza ariana, il<br />
valore della fratellanza e della solidarietà contro ogni forma di intolleranza e<br />
di intransigenza, l’efficacia salvifica della fede e delle virtù cristiane contro ogni<br />
ideale di freddezza e di forza; soprattutto logora il mito della personalità e del<br />
Führer onnipotente e invincibile, esortando a riconoscere nel Risorto il vero<br />
unico salvatore.<br />
10 “Quanto a me, visto come stanno le cose, dovreste fare i conti con il fatto<br />
che sarò assente più a lungo. Ma anche questo avrà un senso nei piani di Dio”:<br />
Lettera dell’8 luglio 1943. “Quanto a me posso dire che, date le circostanze,<br />
sto bene. Sapermi adattare facilmente a tutto è stata sempre la mia grazia speciale<br />
... e così, anche se non sono al settimo cielo, sono comunque silenziosamente<br />
pronto e contento”: Lettera del 21agosto 1943. “Sono fiducioso che Dio<br />
volgerà tutto al bene per me, per voi e anche per il nostro popolo”: Lettera del<br />
14 gennaio 1944.<br />
11 “Anche se esternamente sono tagliato fuori del mondo e non sono in<br />
grado di compiere alcunché di efficace, partecipo con tutto il cuore alle pene<br />
e alle sofferenze di ciascuno di voi”: Lettera del 19 agosto 1943. “Anche se<br />
nella cella si è proprio tagliati fuori da tutto il mondo, è sufficiente vedere come<br />
gli aerei [nemici] si dirigono sempre sopra Brandenburg per farsi un’idea di ciò<br />
che sta succedendo a Berlino! Naturalmente sono molto preoccupato, ma cosa<br />
posso fare se non raccomandarvi tutti sempre di nuovo alla protezione<br />
dell’Altissimo? Con Lui mi sento anch’io tranquillo, nella pace”: Lettera del 19<br />
agosto 1943. “Pur essendo segregato dal mondo partecipo con cuore febbrile<br />
a tutto ciò che succede, non ultimo al destino del nostro popolo” Lettera del 13<br />
gennaio 1944.<br />
12 “Se potete, mandate al parroco [della prigione] un po’ di immaginette,<br />
sul cui retro sia possibile scrivere un pensiero. In fondo io rimango un curatore<br />
d’anime e non posso dimenticare i poveri compagni di sventura, che attraverso<br />
la diffusione di pensieri ricevono aiuto”: Lettera del 14 febbraio 1944.
econditi e la fa tribolazione sostitutiva, sofferta in sequela di Cristo;<br />
la fa sorgente redentiva di speranza e di fidente attesa; la rende,<br />
riscoprendola compagna della vita e della storia degli uomini, mistero<br />
di consolazione e liberazione 13 .<br />
Nel dolore in cui vive imprigionato e mortificato, che è uguale in<br />
chiunque lo viva e ha un’unica natura, che serba, inconfondibile e<br />
immutabile, la sua pungente intonazione, riconosce l’eco antica di<br />
tutti i dolori, che si accaniscono, caparbi, a offendere i corpi e a lacerare<br />
gli animi. E il suo sconforto si sublima in ardente e accorata<br />
preghiera, per sé e per gli altri 14 .<br />
Da fervido ministro di Dio, Metzger sa che le persecuzioni appartengono<br />
alla storia del cristianesimo 15 ; che, come Gesù, anche i suoi<br />
discepoli, e quindi la Chiesa e i suoi membri, saranno continuamente<br />
soggetti a vessazioni e angherie 16 ; che i cristiani devono aspettarsi<br />
di essere calunniati 17 , di patire tribolazioni 18 , di ispirare odio e<br />
disprezzo 19 .<br />
13 Anche quando la sua angoscia di prigioniero, espandendosi e incontrandosi<br />
con quella di tanti altri reclusi, stringe la gola con un morso più stretto,<br />
Metzger conforta: “Chi è preso dall’angoscia della morte più di noi, a cui la<br />
vita è già negata? Davvero non c’è nessuna ‘speranza’ per noi? È vero che non<br />
ci è ancora stata tolta ogni umana speranza nella ‘grazia’. La speranza della<br />
nostra fede, è di gran lunga più salda e sicura: abbiamo una vita che non può<br />
esserci tolta se rimaniamo in Cristo. Questa ‘vita eterna’ della quale il Signore<br />
parla continuamente, non è solo una promessa per l’‘aldilà’, ma ci è già data<br />
come qualcosa di attuale (Gv 6,47.54; Ef 2,6; Col 3,1ss.), solo che non può<br />
essere toccata con mano, poiché è una vita nascosta dello spirito. Non per questo,<br />
però, è meno vera: è una partecipazione misteriosa alla vita di Cristo iniziata<br />
con la ‘rinascita’ per mezzo del santo battesimo: Riflessione, senza data.<br />
14 “... a tutti noi non rimane altro che metterci nelle mani di Dio. Egli libererà<br />
i prigionieri alla Sua ora. Prego incessantemente per tutti voi e so che anche<br />
voi pregate per me”: Berlino, 8 Luglio 1943. “Pregando Dio ci incontriamo tutti<br />
i giorni, sperimentando, nonostante la separazione esterna, una comunione più<br />
profonda. Preghiamo tutti per comprendere a fondo la santa volontà di Dio e<br />
per essere perfettamente disponibili alla sua attuazione. Tale sentimento ci unisce<br />
a Colui che possiamo chiamare ‘Abbà’ e che ci rende partecipi del Suo<br />
Spirito, tanto che la nostra preghiera viene sempre realmente esaudita”: Lettera<br />
ai fratelli, 18 agosto 1943.<br />
15 Cf. Lc 21,12; 2 Tm 3,11<br />
16 Cf. Mt 10,23; At 8,1<br />
17 Cf. At 19,9; 1 Pt 2,12<br />
18 Cf. 1 Pt 4,12<br />
19 Cf. Gv 15,19; Mt 10,22<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
E infranse<br />
tutte le catene,<br />
senza far rumore<br />
331-348<br />
spiritualità<br />
337
pastorale e<br />
spiritualità<br />
NICO DE MICO<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
spiritualità<br />
338<br />
Ma sa anche che la durezza delle prove serve alla salvezza 20 ; che<br />
i perseguitati, gli oppressi, i piccoli, sperimentano da sempre, in<br />
modo speciale, l’aiuto divino 21 ; che non mancherà il sostegno di Dio<br />
a chi versa in condizione di bisogno 22 , purché abbia in Lui incondizionata<br />
fiducia. E sa, ancora, che Dio ama ogni singolo uomo 23 e lo<br />
incoraggia con le sue parole 24 , facendosi, per tutti, fonte di consolazione<br />
25 .<br />
Soprattutto, Metzger sa che, per aspirare al Regno celeste e sperare<br />
di ricongiungersi finalmente al Padre dopo il faticoso peregrinare<br />
dell’esistenza terrena, bisogna non salire in alto, ma scendere<br />
in basso: come ha fatto Gesù che, incarnandosi, si è calato nell’uomo,<br />
facendone propri i limiti e le colpe 26 ; che, avvicinandosi ai poveri,<br />
ai malati, agli emarginati, agli oppressi e ai peccatori, è sceso tra<br />
i più miseri, a comprenderne i bisogni e le speranze; che, offrendosi<br />
al sacrificio estremo in spirito di abnegazione e di offerta, è sprofondato<br />
nella morte infamante e disonorata della croce 27 , a riscattare<br />
e riconciliare gli uomini 28 . Egli legge nella discesa progressiva del<br />
20 Cf. Mt 5,4.11<br />
21 Cf. Gdt 9,11; Gdc 7,1 ss.; Dt 8,17s.<br />
22 Cf. Gb 5,11; Is 66,2<br />
23 Cf. Gv 3,16; 10,11; 13, 1.34, 15,9; 16,27<br />
24 Cf. Gs 1,5-9; Ger 15,16.20<br />
25 Cf. Is 51,12; 2 Cor 1,3 Metzger sperimenta, in carcere, la possibilità<br />
umana di trovare rigenerante consolazione attraverso la parola di Dio diventata<br />
conoscibile per mezzo di Gesù (Gv 1,14.18) e presente nelle Sacre Scritture<br />
che, di per se stesse consolazione (Rm 15,4), sono altresì causa della fede che<br />
è, a sua volta, consolazione (Rm 1,12; 1 Ts 3,7; Eb 6,8).<br />
26 “E l’esser salito che vuol dire, se non che era disceso nelle parti inferiori<br />
della terra? Quegli che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra dei cieli<br />
tutti, per portare a compimento ogni cosa”: Ef 4, 9-10. Profondo conoscitore<br />
della Bibbia, il sacerdote cattolico si rifugia nella sapienza del Figlio di Dio,<br />
che, incarnandosi, ha ricondotto l’umanità al Padre annientando in essa ogni<br />
inimicizia (Ef 2,16) e che, nella gloria della risurrezione, l’ha rischiarata della<br />
luce pura e immacolata dello Spirito.<br />
27 Fil 2,8: “Umiliò se stesso, fattosi obbediente fino alla morte, e alla morte<br />
di croce”. Il cristiano sa che la crocifissione di Gesù ha significato non solo il<br />
patimento fisico, ma anche l’umiliazione morale di un fallimento totale, essendo<br />
allora esecranda punizione riservata agli schiavi e ai non romani.<br />
28 L’evento di Cristo non viene presentato nel NT come una delle azioni salvifiche<br />
di Dio, ma come il loro apice. Cf. Eb 2,16: “Giacché non certo ad angeli<br />
Egli viene in aiuto, ma viene in aiuto al seme d’Abramo”; Gv 12,32: “Io,<br />
quando sarò sollevato da terra, attirerò tutti a me”.
Cristo, discesa che si è fatta scala verso l’alto, tutta la grandezza del<br />
Suo mistero; e nella croce vede la scaturigine della gloria del Figlio<br />
di Dio fatto uomo, che a essa assurge non attraverso la forza, il prestigio,<br />
l’autorità o la ricchezza, ma attraverso l’amore come dono<br />
incondizionato di sé, l’esperienza dell’abbandono e della spoliazione<br />
e la kenosi come svuotamento della propria divinità, esproprio,<br />
cioè, di se stesso, in una prossimità totale agli uomini, perché agli<br />
ultimi degli uomini 29 .<br />
Così, con quello spirito di autentica umiltà che richiede disponibilità<br />
al servizio 30 e che non si risolve nel disprezzo o nella disistima<br />
di se stessi, ma nell’assunzione della propria realtà di fronte a<br />
29 Si evince, dalle lettere, che la croce di Cristo è presenza costante nel pensiero<br />
del recluso: “ Rivolgo il mio sguardo alla tua santa Croce, mio Redentore<br />
e Salvatore! Tu hai patito la morte, ma essa non ti ha sconfitto. Il terzo giorno<br />
sei risuscitato vittorioso dai morti, come ‘primizia di quelli che dormono’ (1 Cor<br />
15,20). Sì, tu stesso lo avevi detto: “Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede<br />
in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno...”<br />
(Gv 11,25). Perciò ne sono sicuro: la morte non sarà nemmeno per me<br />
la fine; essa è piuttosto una porta verso la vita che Dio ha preparato per quelli<br />
che lo amano (Lettera del 26 novembre 1943). “Attualmente sto attraversando<br />
un periodo un po’ difficile, del quale non posso dire molto. In fondo la croce è<br />
propria del discepolo del Crocefisso” (Brandenburg-Görden 16 dicembre<br />
1943). “Ci ha redenti sulla croce, riscattando per noi la salvezza ed aprendoci<br />
la porta del cielo. È risorto come “primizia di coloro che si sono addormentati”.<br />
Trasfigurato nel suo corpo glorioso, coperto di ferite, è salito al Cielo, assumendo<br />
alla destra del Padre il trono che gli appartiene. È sempre davanti al<br />
Padre come nostro avvocato e intercessore (Eb 7,25; 1Gv 2,1) e gli mostra le<br />
Sue ferite gloriose, che sono per noi garanzia di vita” (Riflessione, senza data).<br />
30 Cf. Mc 9,35; Lc 9, 48. Ministro di Dio e servitore della Sua parola per<br />
vocazione, in autentico spirito di servizio rivolto al Padre e ai fratelli, e in tutte<br />
le circostanze della vita, quelle semplici e ordinarie, ma anche in quelle assolutamente<br />
rischiose, Metzger ha impegnato il suo pensiero e le sue opere nella<br />
ricerca della pace e della giustizia, dando prova di un amore dimentico di sé<br />
e disposto a far sacrificio anche della propria vita. “Ho cercato piuttosto di<br />
comprendere sempre le particolari esigenze di ogni singolo partito politico, giustificandole<br />
nella prospettiva di una maggiore sintesi. Con ciò mi sono fatto<br />
ogni volta sia amici che nemici appartenenti trasversalmente a tutte le ideologie<br />
e a tutti gli schieramenti politici. Dato che la verità e la giustizia – da cristiano<br />
e sacerdote, essendo tale con anima e corpo, potrei parlare anche del<br />
‘Regno di Dio’ – sono per me di primario interesse, ho cercato di crearmi, per<br />
quanto lo permettevano la mia esperienza e conoscenza, sempre una mia opinione,<br />
difendendola da tutte le parti con coscienza, senza guardare se ciò mi<br />
procurava dei vantaggi o meno. Non ho mai aspirato a fare carriera, né sono<br />
andato a caccia di alte cariche. Ho rinunciato radicalmente ai soldi e ai piaceri<br />
– non ho nessuna entrata fissa, mi astengo dalla carne, dall’alcool e dal fumo<br />
– per servire, libero da tutto, con migliori forze, il popolo al quale mi sono sentito<br />
e mi sento completamente unito” (Lettera 30 luglio 1943).<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
E infranse<br />
tutte le catene,<br />
senza far rumore<br />
331-348<br />
spiritualità<br />
339
pastorale e<br />
spiritualità<br />
NICO DE MICO<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
spiritualità<br />
340<br />
Dio e agli uomini, in concreta sequela del Maestro, accetta docile la<br />
prova del carcere che la vita gli riserva e risponde a Dio in sincerità<br />
e libertà, facendo della sua adesione una forma di responsabilità,<br />
corresponsabilità e partecipazione in e con Cristo, con il sostegno<br />
dello Spirito divino 31 ; e sollecita innanzitutto se stesso a ritrovare le<br />
sorgenti, a discernere gli argini e a individuare i confini, a<br />
distinguere gli approdi e gli abissi, a bloccare gli esodi e a definire<br />
precisi punti di riferimento: a conoscersi, cioè, nel profondo<br />
e crescere nello spirito, ricercando quelle verità germinanti<br />
sentimenti di giustizia e di libertà, che il Padre ha stampato nel<br />
cuore degli uomini 32 . Alla ricerca di tali verità richiama, dunque,<br />
e coinvolge, il suo pensiero, la sua volontà e le sue aspirazioni,<br />
in un percorso di amore e di fiducia, di preghiera e di libertà, di<br />
superamento del piccolo e del mediocre, di rifiuto del compromesso<br />
e delle mezze misure e anche di comprensione dei limiti,<br />
dell’imperfezione, dei condizionamenti e delle ombre della<br />
natura umana debole e peccatrice: contro ogni falsa sicurezza<br />
terrena costruita sulla ‘sabbia’, ormeggia le sue certezze all’ancora<br />
della Parola divina, che non si lega con le catene 33 ed è inamovibile<br />
roccia 34 . Vittima che si rifiuta di essere vittima, che non si<br />
31 “Comunque si evolverà la mia vita, nella morte della carne ‘per essere<br />
con Cristo’ – anzi, una parte di me desidera proprio essere ‘dissolta e stare con<br />
Cristo’ – oppure nel continuare a vivere, destinato per il futuro a nuovi compiti<br />
o ad adempiere meglio quelli antichi, tutto sarà stabilito da Dio e quindi per me<br />
sarà il bene. Quante volte, pregando, ho ripetuto le parole che prima di me ha<br />
pronunciato il Signore: padre, se è possibile fa’ che questo calice passi da me,<br />
però non la mia, ma la tua volontà sia fatta”. Adorando e attuando questa<br />
santa volontà del Signore, io voglio vivere e morire. Amen”: Brandenburg,<br />
prima domenica di Avvento 1943.<br />
32 Eb 10,16: “Questa è infatti l’alleanza che io stipulerò con loro dopo quei<br />
giorni, dice il Signore: io porrò le mie leggi nei loro cuori e le imprimerò nella<br />
loro mente, e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità”.<br />
33 Cf. 2 Tm 2,9<br />
34 In una lettera indirizzata alla sorella Gertrudis, Metzger scrive: «Per il<br />
Nuovo Anno, nella notte di san Silvestro, ho pensato questo per me e per voi:<br />
“Così comincio nel nome di Dio / l’anno che porterà la sentenza./ Già in anticipo<br />
dico il mio Amen / a ciò che scaturirà dal Tuo consiglio./ Ciò che è bene,<br />
ciò che è male per me – per tutti! / – Tu l’hai nascosto alla nostra stoltezza. /<br />
In ogni caso, però, è una benedizione / ciò che la Tua sapienza ha concepito<br />
per noi. / Così scrivi Tu il calendario / per noi che siamo sotto la Tua protezione!<br />
/ Soltanto lasciaci rimanere nella Tua grazia! / ciò che Tu, Padre, ci mandi,<br />
è buono”. Nel nome di Dio! In Lui, grazie al cielo, continuo a essere di buon<br />
umore. Sono fiducioso che Dio volgerà tutto al bene per me, per voi e anche<br />
per il nostro popolo. Sento quanto è buono con me il Signore, che mi dona ogni<br />
sorta di consolazione e incoraggiamento»: Lettera del 13 gennaio 1944.
autocommisera, che combatte strenuamente per la sopravvivenza,<br />
che crede fermamente nella possibilità di incontrare Dio come<br />
amico e Cristo come fratello, Metzger fa del suo cuore un luogo<br />
d’incontro e tenta di dare un senso al tempo che scorre inesorabile,<br />
di tingere l’incolore dei muri grigi, di animare il silenzio, di scaldare<br />
in qualche modo le albe desolate e fredde e di medicare la piaga,<br />
che si prospetta cancerosa, inferta alla sua dignità di uomo 35 .<br />
In carcere, da prigioniero e con le mani incatenate, sempre e<br />
comunque, tanto e di tutto, in sintonia con il Vangelo e nella certezza<br />
che Dio, in ogni circostanza della vita, assiste e protegge, egli<br />
scrive. E ci lascia pagine straordinarie che danno vita ai sentimenti<br />
più profondi, alle emozioni più coinvolgenti, a parole sussurrate per<br />
avvicinare e condividere. Sono pagine vibranti, calde nei toni,<br />
modulate negli accenti, aderenti al sentire e al parlare semplici e<br />
concreti, incise con limpida chiarezza, infuse di preziose intuizioni 36<br />
e di accezioni profetiche 37 . In una realtà in cui l’isolamento è<br />
35 “Come vi avevo già detto, ora sono in una cella comune. Nonostante la<br />
grande varietà degli abitanti, siamo una comunità molto ordinata. Si ha almeno<br />
la possibilità di uno svago. Certo, tutto ciò diventa assai pesante per uno<br />
che per la prima volta si trova in una tale situazione di vita in comune. Eppure<br />
anch’essa avrà un senso. In questi giorni ho riflettuto molto sullo Spirito Santo<br />
[...]. La Scrittura lo chiama pneuma, che significa soffio, alito o vento. Esso è il<br />
caldo alito di vita che promana dall’interiorità di Dio, perciò si può identificare<br />
anche con un amore che scorre. Secondo il salmista, questo alito vitale di<br />
Dio riempie tutto. In Lui, nel Suo amore, viviamo e ci muoviamo. Per mezzo di<br />
Lui siamo uniti tra di noi. Sì, anche il nostro respiro di vita proviene da Lui. In<br />
Lui noi ci incontriamo”: Berlino, 8 luglio 1943.<br />
36 “Cristo, il Signore, ci ha posto davanti agli occhi questa verità confortante<br />
e al tempo stesso angosciosa: la morte non colpisce ciò che abbiamo di più<br />
profondo, ciò che ci appartiene. Infatti, il nostro ‘Io’ continua ad esistere al di<br />
là della morte fisica”. [...] ‘La vita non è il più alto dei beni...’, ecco una<br />
parola profondamente umana del poeta! Forse è proprio questo che costituisce<br />
l’uomo: il poter pensare in questo modo. L’animale resta attaccato al suo<br />
naturale istinto di sopravvivenza. All’infuori di questo, non conosce ‘valori’ per<br />
cui valga la pena di sacrificare la vita, valori nei quali in talune circostanze si<br />
fonda proprio la più grande dignità. In sostanza, le parole del poeta sono vere,<br />
ma lo sono unicamente sulla base della fede cristiana. Per il cristiano l’anima’<br />
e la ‘coscienza’ sono i valori più alti, superiori perfino ai valori più grandi del<br />
mondo fuggevole”: Riflessione, senza data.<br />
37 “Il fatto è che, in una guerra condotta con una ferocia come la nostra,<br />
il raggiungimento della consapevolezza dell’inutilità del proseguimento dei<br />
combattimenti viene impedito da forti resistenze di natura psicologica: il fanati-<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
E infranse<br />
tutte le catene,<br />
senza far rumore<br />
331-348<br />
spiritualità<br />
341
pastorale e<br />
spiritualità<br />
NICO DE MICO<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
spiritualità<br />
342<br />
desolante abbandono e il silenzio è rifiuto del dialogo, dissenso<br />
ideologico e chiaro allontanamento da chi, detenuto, non appare<br />
degno di risposta, riscoprendone il valore, il recluso fa della solitudine<br />
e del vuoto di rumore di vita occasioni speciali per ritrovarsi e<br />
ritrovare 38 : stupiscono, dei suoi scritti, non tanto – o non solo – la<br />
profondità e il fascino dei contenuti, quanto la virtù di restituirne<br />
l’autore nella sua immagine più vera e la forza con cui costringono<br />
a pensare e meditare.<br />
Innanzitutto rinveniamo in essi l’uomo che, se prima, come<br />
incredulo di fronte agli eventi che lo travolgono, sotto la piena delle<br />
emozioni, dei ricordi, dei sentimenti, delle aspettative e dell’esigenza<br />
inutilmente urlata di vita e di operatività, chiede ragione a Dio del<br />
dolore innocente, vano, ingiusto e ingiustificabile, poi si arrende al<br />
co desiderio di vincere, che disprezza qualsiasi voce di opposizione; la paura<br />
di subire, in caso di sconfitta, le umiliazioni della propria persona, ossia la<br />
paura di una sanguinosa e personale vendetta che ora, più che mai, minaccia<br />
quelli che fanno parte della struttura portante dello Stato sconfitto, fanno diminuire<br />
l’autocritica e la possibilità di un’oggettiva valutazione della situazione; e<br />
ciò si verifica in particolare in quelle persone che, per via della loro forza fisica<br />
e della loro fanatica risoluzione, vedono nell’attuazione di un attacco e nell’imporsi<br />
sugli altri il loro compito, anche se esso verrebbe considerato, da chi<br />
sta fuori, un impegno non risolutivo. [...] La sorte del popolo tedesco è completamente<br />
nelle mani del Führer. È lui ad esserne responsabile”: Lettera del 23<br />
luglio 1943. “Le mie perplessità di fronte alla politica del Terzo Reich erano inizialmente<br />
di natura etica, a causa del mio radicale rifiuto del primato della<br />
forza sul diritto. Tuttavia, esse avevano alla base anche una realistica percezione<br />
politica, e cioè che, nel caso di un nuovo conflitto mondiale, la Germania si<br />
sarebbe fatto nemico il mondo intero e avrebbe causato la mobilitazione contro<br />
di sé delle immense risorse militari del resto del mondo. Temevo che dopo<br />
alcuni possibili successi dell’iniziale attacco, tale concentrazione delle forze<br />
avrebbe dato inizio ad uno sviluppo simile a quello del 1917/18”: Lettera del<br />
30 luglio 1943.<br />
38 “Nonostante la solitudine, che naturalmente sento, non conosco la noia.<br />
Studio, leggo e scrivo, compongo musica e poesie, anche se non posso mettere<br />
tutto su carta. [...] Le mie sensazioni spesso trovano espressione in qualche<br />
poesia. Naturalmente sono per lo più pensieri religiosi ad ispirarmi. Così ora<br />
ho terminato di scrivere la terza Messa tedesca per il popolo”: Lettera del 13<br />
gennaio 1943. “Con l’anima vivo davvero in un altro mondo dal quale,<br />
proprio nella solitudine, molte forze e pensieri mi vengono incontro. Anche le<br />
poesie, di cui vi posso rendere un po’ partecipi, provengono di là. So che siete<br />
contenti, quando vi lascio guardare un po’ dentro il mio cuore”: Lettera del<br />
13 gennaio 1943.
mistero, all’insondabilità e all’insita giustizia della volontà divina 39 .<br />
E riflettendo, forse, che non sono gli anni di vita che contano, ma la<br />
vita dei propri anni, dissipa le tenebre del suo presente, stempera<br />
derive e contraddizioni, dosa i pieni e i vuoti, dilata gli spazi e le<br />
prospettive, rinviene possibilità e simmetrie, canta l’amore come<br />
forza vincente: e, ancora, a mantenere vecchi contatti e a crearne di<br />
nuovi, scrive, dimostrando che una vita rivolta solo a se stessi si<br />
restringe e si limita, dedicata agli altri, si dilata e si espande.<br />
Scrive lettere, poesie, memorie, messe cantate, saggi; scrive<br />
riconfermando, in tutta la loro rilevanza e dirompenza, quelle idee<br />
personali che, riflettendo un rovesciamento radicale dell’ideologia<br />
al tempo propagandata, lo hanno reso fortemente sospetto e ne<br />
hanno fatto un sorvegliato speciale.<br />
Metzger percepisce fin dall’inizio la presenza di Hitler sulla scena<br />
politica come foriera di sventure e di afflizione, se, trascorsi appena<br />
pochi giorni dalla sua nomina a cancelliere del Reich (30 gennaio<br />
1933), può affermare con decisione: “Ieri sera abbiamo ascoltato<br />
Hitler alla radio. Sono state superate le mie peggiori previsioni. Si<br />
tratta di un vero e proprio isterico, malato di mente, o di un bruto del<br />
peggior genere. [...] Guardo al futuro della Germania con molto pessimismo.<br />
Anche quando nelle elezioni non raggiungerà la maggioranza,<br />
Hitler è palesemente deciso a non lasciarsi più strappare dalle<br />
mani il potere e a fare un colpo di stato” 40 . E, allertando chiunque<br />
39 “È vero che ho vissuto alcune settimane difficili. Conoscete la mia vivacità,<br />
il mio dinamismo e il mio amore per la libertà. È naturale che la costrizione<br />
di dover permanere in un ambiente diametralmente opposto crei in me, malgrado<br />
tutta la buona volontà, delle tensioni. Tuttavia ho superato ogni cosa e cerco<br />
di esercitare l’obbedienza del Signore (Fil 2,8)”: Lettera del 27 gennaio 1944<br />
(riscritta il 14 febbraio 1944). “Nella notte di Natale sarò con voi vicino al presepe,<br />
purtroppo lo sarò solo nello spirito, in quanto non ho nessuna speranza,<br />
neppure per quel giorno, di poter assistere alla santa messa. Ma può essere che<br />
alla fine questa gioia natalizia ci verrà concessa? Altrimenti mi dovrò proprio<br />
arrendere alla santa volontà del Signore, che mi colpisce duramente, ma che<br />
comunque adoro rendendo grazie”. (Brandenburg-Görden 16 dicembre 1943).<br />
40 Lettera privata dell’11 febbraio 1933, conservata nell’Archivio di<br />
Meitingen. I timori di Metzger sono fondati. Il 27 febbraio 1933, a meno di un<br />
mese dalla nomina di Hitler a cancelliere (30 gennaio 1933) e ad appena una<br />
settimana di distanza dalle elezioni fissate per il 5 marzo, l’incendio che<br />
distrugge la sede del Reichstag e del quale vengono accusati i comunisti, offre<br />
ai nazisti il pretesto per inauditi atti di violenza, che creano un disarmante<br />
clima di terrore. Migliaia di oppositori, reali o presunti, vengono eliminati. Il 30<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
E infranse<br />
tutte le catene,<br />
senza far rumore<br />
331-348<br />
spiritualità<br />
343
pastorale e<br />
spiritualità<br />
NICO DE MICO<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
spiritualità<br />
344<br />
voglia intendere, quando già voci contrarie vengono assolutamente<br />
respinte e combattute e ogni opposizione al regime è stroncata con il<br />
sostegno di un solido consenso di massa e di un capillare controllo<br />
poliziesco, con inquietudine e fermezza ammonisce il popolo tedesco<br />
a non illudersi di un’illusoria, fallace potenza della propria<br />
patria. Sperimenta come l’esaltazione ideologica del nazismo, l’odio<br />
razziale e la vendetta politica esercitata con disumana crudeltà, alimentando<br />
un inimmaginabile potenziale di aggressività e di furia<br />
distruttiva, abbiano sprofondato la Germania nella spaventosa spirale<br />
dei rastrellamenti, delle carcerazioni e degli assassini collettivi 41 ;<br />
e preannuncia la deriva di una politica che, sicuramente perdente per<br />
le sconsiderate decisioni di un pugno di uomini rosi dalla sete di<br />
potenza e di dominio, condurrà allo sterminio di tante, troppe<br />
incolpevoli e sconosciute vittime destinate a rimanere per sempre<br />
anonime, quasi la loro esistenza sia di nessun conto 42 .<br />
giugno 1934, nella famosa “notte dei lunghi coltelli”, mentre Hitler, succeduto<br />
a Hindenburg, è, da poco, anche presidente della Repubblica, le SA, formazioni<br />
paramilitari del partito nazista, fondate nel 1921 e guidate, dal 1930, da<br />
E. Röhm, mal tollerate per il loro spirito di autonomia, vengono massacrate con<br />
il loro comandante e sostituite con le più temibili SS, costituite nel 1925 e<br />
comandate dal 1929 da H. Himmler. Rese responsabili anche dei campi di concentramento,<br />
esse saranno il braccio armato del regime e lo strumento primo<br />
della sua realizzazione. A partire dal 1937, quando il progetto espansionistico,<br />
motivato dalla necessità di concretizzare il diritto della razza germanica a<br />
uno spazio più vitale rispetto a quello degli altri popoli, diventa ormai la priorità<br />
del programma hitleriano, le iniziative del Führer, sulla base di un unilaterale<br />
disconoscimento dei trattati di pace e di un loro progressivo smantellamento,<br />
si rivolgono tutte a provocare e suscitare sentimenti di risentimento e di guerra.<br />
41 Mentre cataste di libri bruciano, opere d’arte si sfregiano e un’aperta<br />
campagna anticulturale preannuncia rischi gravissimi anche per gli intellettuali,<br />
molti illustri esponenti della cultura del tempo, tra questi Albert Einstein, Thomas<br />
Mann, Walter Gropius, Bertolt Brecht vanno in esilio; gli Ebrei, prima privati<br />
della cittadinanza, successivamente esclusi da ogni pubblica attività, infine<br />
fatti oggetto di una violenza crescente, vengono in ultimo destinati alla soppressione;<br />
le forze armate si ristrutturano, preparandosi alla guerra; la radio, la<br />
pubblicità, il cinema, parate militari e manifestazioni di folla, esaltano il sentimento<br />
nazionalistico, eccitando gli animi.<br />
42 Nel disegno nazista di dare un ‘nuovo ordine’ al mondo rientrano lo sfruttamento<br />
dei deboli; l’assoggettamento dei vinti; l’appropriazione forzata di<br />
materie prime e strumenti utili ai bisogni economici e bellici della Germania;<br />
l’asservimento culturale; il conformismo ideologico e il tragico stermino di Ebrei,<br />
di comunisti e di gruppi etnici considerati inferiori. Sono anni dolorosi di rovine<br />
e di stragi che vedono vittime inermi e straziate le popolazioni civili.
Sullo sfondo sciagurato del II conflitto mondiale, che tanto<br />
impietosamente insanguina lo scacchiere europeo e in cui appaiono<br />
scardinati e ribaltati tutti gli equilibri tra le potenze del vecchio continente,<br />
Metzger grida il rifiuto della guerra come il male più assurdo,<br />
più lacerante e disgregante, quello che intossica gli animi e avviluppa<br />
fino all’annientamento totale 43 . E ad evitare il versamento di<br />
tanto sangue innocente, insistentemente esorta a nuovi itinerari e a<br />
diverse risoluzioni, proponendo il più fecondo sogno di una<br />
Germania unita 44 . Avendo compreso i segni del tempo e temendone<br />
43 “L’esperienza del conflitto mondiale ha suscitato in me la convinzione che<br />
ciò che veramente serve al mio popolo, e anche all’intera umanità, è soltanto<br />
una tollerante e lungimirante politica della pace. L’irritante esperienza del crollo<br />
finale della Germania aveva confermato il mio profondo convincimento<br />
secondo il quale si può dire che qualcosa è giusto politicamente solo quando<br />
lo è anche eticamente. Subito nella primavera del 1917, risiedendo allora in<br />
Austria, avevo pubblicato un Programma internazionale della pace, che godeva<br />
di un’ampia accoglienza; un Programma elogiato espressamente, nel giugno<br />
del 1917 e successivamente durante un’udienza privata, dal papa<br />
Benedetto XV, e che venne accolto con entusiasmo anche dall’attuale papa,<br />
allora nunzio a Monaco, quando gliene parlai personalmente nel 1917. (...) Il<br />
mio atteggiamento, sempre più critico nei confronti del partito nazional-socialista<br />
tedesco dei lavoratori, poggiava sulla convinzione che la sua politica estera,<br />
che per principio non considerava il diritto proprio degli altri Stati, non poteva<br />
che provocare un nuovo conflitto mondiale. Dal 1936 ne sono rimasto certo.<br />
Avevo considerato una disgrazia il fatto che la repressione di ogni tipo di libera<br />
espressione e di ogni legittima opposizione non lasciava, a questo riguardo,<br />
nessuno spazio all’esercizio di una responsabilità critica di cui, a mio avviso,<br />
necessita anche un regime autoritario affinché non si lasci sfuggire quei basilari<br />
punti di vista dalla cui presenza o assenza dipendono o la prosperità o i travagli<br />
del popolo”: Lettera del 30 luglio 1943.<br />
44 “Dopo aver capito che non avevo più nessuna possibilità di far qualcosa<br />
per fermare la guerra – tanto più se una mia partecipazione alle eventuali azioni<br />
contro il legittimo governo non veniva presa in considerazione a causa dei<br />
motivi religiosi – ero convinto, così credevo, di dovermi rassegnare, attendendo<br />
passivamente lo scatenarsi, prima o poi, di una ineluttabile catastrofe. (...).<br />
Questi pensieri si consolidavano in me, concretizzandosi nella stesura di uno<br />
schizzo” – è il Memorandum che gli vale l’arresto – “in cui proponevo l’idea<br />
di una Costituzione tedesca, concepita come unica via d’uscita nel tentativo di<br />
salvaguardare il libero governo del popolo nel caso di un collasso provocato<br />
dalla sconfitta.. per mantenere velato il senso dello schizzo, ero ricorso all’idea<br />
– proposta, in termini simili, già precedentemente – di una Federazione degli<br />
Stati nordici. In quanto parte della ‘Nordlandia’, la ‘Germania’ sarebbe dovuta<br />
essere costituita dai grandi distretti tedeschi i quali, continuando ad essere<br />
amministrati autonomamente, sarebbero dovuti appartenere a un unico Stato<br />
federale. Il sistema federalista mi pareva non soltanto quello più rispondente<br />
alla lunga storia tedesca, ma anche la migliore possibilità di come prevenire e,<br />
eventualmente, contrastare la logica della spartizione adottata dalle forze nemiche”:<br />
Lettera del 30 luglio 1943.<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
E infranse<br />
tutte le catene,<br />
senza far rumore<br />
331-348<br />
spiritualità<br />
345
pastorale e<br />
spiritualità<br />
NICO DE MICO<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
spiritualità<br />
346<br />
i prevedibili, funesti sviluppi, denuncia i rischi di un agire temerario<br />
e pericoloso e suggerisce rimedi atti a evitare assurde sofferenze<br />
dei probabili vinti, facendo balenare la possibilità di tempi<br />
migliori. Ma il contesto è sordo e non ci sono cuori o orecchi che<br />
lo vogliano ascoltare 45 .<br />
(continua)<br />
MAX JOSEF METZGER SHATTERS EVERY CHAIN<br />
WITHOUT THE SLIGHTEST NOISE<br />
“The Word of God cannot be chained.”<br />
By Nico De Mico<br />
1 st part.<br />
ENG<br />
This is a profound meditation on the thought of Max Joseph<br />
Metzger, on which our journal has reflected in an article by<br />
Lubomir Zac (Sap. Cr. XXIV – 2009). That which the author has<br />
discovered in the martyr is confirmed by the texts of the Letters<br />
45 “Avevo tentato, nell’autunno del 1941, di scrivere al Führer, per fargli<br />
presente e spiegare che la guerra sarebbe divenuta una vicenda ormai senza<br />
speranza e che, a causa di ciò, l’ultimo atto di responsabilità nei confronti del<br />
popolo avrebbe richiesto da lui il sacrificio della rinuncia al potere per liberare<br />
la via verso la pace in quanto il suo governo, data la situazione, non sarebbe<br />
stato in grado di giungere ad una pacifica soluzione. Volevo fargli capire<br />
la grandezza di un simile gesto di altruismo fatto nell’interesse del popolo,<br />
gesto che sarebbe entrato nella storia, tanto più se si fosse pubblicamente<br />
ammesso che la politica del potere e del sacro egoismo era divenuta fatalmente<br />
una falsa via da abbandonare a favore di una nuova politica di pace. Sì, in<br />
fin dei conti è nella prontezza a sacrificare il proprio “io” per amore del popolo<br />
che si rivela la genuinità di ogni sentimento nazionale. Intanto la lettera, così<br />
come l’avevo concepita, rappresentava solo un tentativo di esternare i pensieri<br />
che provocavano in me una forte agitazione. Non sono un illuso privo di senso<br />
della realtà e perciò, in quel periodo – era l’autunno del 1941 –, sapevo bene<br />
che non era venuto ancora il momento per sperare che una simile lettera<br />
avrebbe portato a qualche risultato, senza considerare, poi, il fatto di non aver<br />
intravisto nessuna possibilità di come farla arrivare nelle mani del Führer”:<br />
Lettera del 22 luglio 1943.
which he mentions in the footnotes. Here the passion suffered by<br />
Metzger is as distant as possible from any over-concern for himself;<br />
he clearly sees just how far absolute evil is from the Love shown in<br />
the <strong>Passio</strong>n. On this he admits no half-way thoughts. What is more,<br />
he lives in conformity with Christ through every kind of suffering<br />
due to our frail humanity, something the authors stresses in the second<br />
part of the article.<br />
MAX JOSEF METZGER ROMPIÓ TODAS LAS<br />
ESP<br />
CADENAS, SIN HACER RUIDO.<br />
“La palabra de Dios no está atada con cadenas”.<br />
Nico De Mico<br />
Primera parte:<br />
Profunda meditación sobre la peripecia de Max Joseph Metzger;<br />
sobre ella nuestra revista ya ha reflexionado con un artículo de<br />
Lubomir Zac (Sap Cf XXIV-2009, 53-83). Lo que el autor descubre<br />
en el mártir está confirmado por textos de las Cartas que él recoge<br />
preferentemente en las notas a pie de página. Aquí la Pasión vivida<br />
por Metzger está muy lejana del intimismo, él ve con claridad cuanto<br />
dista el mal absoluto del Amor de la Pasión, no admite compromisos.<br />
Y todavía vive en conformidad con Cristo todos los pasajes<br />
de sufrimiento de la fragilidad humana que el autor pone en evidencia<br />
especialmente en la segunda parte del artículo.<br />
MAX JOSEF METZGER SPRENGT STILL UND<br />
GER<br />
LEISE ALLE FESSELN<br />
“Das Wort Gottes fesselt man nicht mit Ketten”<br />
von Nico De Mico<br />
Teil 1<br />
Es handelt sich hier um eine tiefgehende Betrachtung zu Max<br />
Joseph Metzger, über den Lubomir Zac schon früher in unserer<br />
Zeitschrift (Sap Cr XXIV-2009, 53-83) geschrieben hat. Die<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
E infranse<br />
tutte le catene,<br />
senza far rumore<br />
331-348<br />
spiritualità<br />
347
pastorale e<br />
spiritualità<br />
NICO DE MICO<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
spiritualità<br />
348<br />
Aussagen des Autors über den Märtyrer werden durch Passagen aus<br />
seinen Briefen bestätigt, die überwiegend in den Fußnoten wiedergegeben<br />
werden. Dort wird deutlich, dass die <strong>Passio</strong>n Metzgers in<br />
keiner Weise intimistisch (nicht für andere bestimmt) verstanden<br />
werden kann. Er sieht ganz klar, dass das Böse und die Liebe der<br />
<strong>Passio</strong>n völlig entgegen gesetzte Wirklichkeiten sind, die keinen<br />
Kompromiss zulassen. Und so durchleidet er die Phasen seiner<br />
<strong>Passio</strong>n und der menschlichen Gebrechlichkeit in einem<br />
Gleichgestaltetwerden mit Christus. Dies hebt der Autor besonders<br />
im zweiten Teil des Artikels hervor.<br />
MAX JOSEPH METZGER POZRYWAŁ WSZYSTKIE<br />
ŁAŃCUCHY NIE CZYNIĄC HAŁASU<br />
„Słowa Bożego nie można związać łańcuchami”<br />
Nico De Mico<br />
Część pierwsza<br />
POL<br />
Głęboka medytacja nad przeżyciami Maxa Josepha Metzgera, któremu<br />
nasze czasopismo poświęciło już artykuł Lubomira Zaca (Sap<br />
Cr 29[2009], s. 53-83). To, co autor dostrzega w postaci męczennika,<br />
opiera się na tekstach Listów, cytowanych przeważnie w przypisach.<br />
Tutaj Pasja przeżyta przez Metzgera daleka jest od skupienia<br />
się na sobie, opiera się na świadomości, jak zło absolutne jest odległe<br />
od miłości cechującej Pasję, nie dopuszcza kompromisów.<br />
Przeżywa, upodabniając się do Chrystusa wszystkie aspekty cierpienia<br />
związanego z ludzką kruchością, które autor ukazuje zwłaszcza<br />
w drugiej części artykułu.
di GIOVANNI DI GIANNATALE<br />
In un profilo biografico del beato Bernardo, l’illustre biblista Ireneo<br />
Pontremolesi scriveva: “Degno compagno del B. Gabriele<br />
dell’Addolorata, ebbe con lui comune la virtù… Faccia Dio, ripetiamo<br />
con ardente desiderio, che un giorno non lontano possa<br />
avere comuni col suo Beato Compagno gli onori degli altari”.<br />
Questo è ora avvenuto. L’autore<br />
dell’articolo esamina alcuni rapporti<br />
spirituali fra i due santi con-<br />
fratelli.<br />
Se il Beato Bernardo Silvestrelli non<br />
si fosse dimesso dalla carica di<br />
Preposito Generale nel 1889 e al suo<br />
posto non fosse stato eletto il P. Francesco<br />
Saverio dell’Addolorata 1 , molto sicuramente<br />
l’ascesa di Gabriele agli onori degli<br />
IL BEATO<br />
BERNARDO<br />
MARIA<br />
SILVESTRELLI<br />
E SAN GABRIELE<br />
DELL’ADDOLORATA<br />
1 Il B. Bernardo Maria di Gesù (Cesare Silvestrelli: 1831-1911) fu Preposito<br />
generale della Congregazione dei <strong>Passio</strong>nisti nei seguenti periodi: 1878-1889;<br />
1893-1907. Il Papa il 7/07/1907 aveva accolto la richiesta di rinuncia<br />
all’ufficio di Generale da parte del Silvestrelli, ottenendo che però conservasse<br />
il titolo di Generale ad honorem. Nell’occasione il B. Bernardo avrebbe detto,<br />
scherzosamente, di essere «un generale senza soldati». Dopo le dimissioni<br />
rassegnate il 2/01/1889, la Congregazione fu guidata fino al Capitolo Generale<br />
dell’8-15/05/1890 dal Vice-generale P. Francesco Saverio dell’Addolorata<br />
(Mattia del Principe: 1832-1893), che fu eletto generale nel predetto Capitolo,<br />
governando fino al 22/09/1892, allorché dovette rinunciare per sopraggiunta<br />
grave malattia. Gli successe il Vice-generale P. Giovanni di Gesù (Testa)<br />
fino al capitolo Generale del 3-09/05/1893, quando fu rieletto il B. Bernardo.<br />
Si vd. P.F. Giorgini, La Congregazione della <strong>Passio</strong>ne di Gesù, sguardo storico<br />
della spiritualità, organizzazione, sviluppo, Curia generale dei <strong>Passio</strong>nisti,<br />
Roma, 2006, pp. 193-198, e anche, dello stesso autore, Bernardo Maria Silvestrelli,<br />
Edizioni CIPI, Roma, 1988, pp. 73-151. Si vd anche la profonda analisi<br />
del P.C.A. Naselli C.P., P. Bernardo Maria di Gesù, Silvestrelli (1831-1911),<br />
l’uomo della libertà e della speranza, tip. “Eco” S. Gabriele, 1972, pp. 1-18.<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
Il beato Bernardo Maria<br />
Silvestrelli e san Gabriele<br />
dell’Addolorata<br />
349-364<br />
spiritualità<br />
349
pastorale e<br />
spiritualità<br />
GIOVANNI DI GIANNATALE<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
spiritualità<br />
350<br />
altari sarebbe stata più lenta di quanto si pensi e, forse, nella peggiore<br />
delle ipotesi, la causa non sarebbe stata ancora aperta. Il P. Silvestrelli,<br />
in sintonia con il P. Norberto Cassinelli e con il sentire comune<br />
della Congregazione, efficacemente espresso dal P. Domenico Bàrberi,<br />
riteneva che i passionisti dovevano aspirare a farsi veri santi e<br />
non ad essere canonizzati, essendo sufficiente che fosse stato santificato<br />
dalla Chiesa il fondatore, San Paolo della Croce. Il P. Domenico<br />
aveva dichiarato: “Noi dobbiamo farci santi… davanti a Dio, il<br />
ché è più facile che diventarlo davanti agli uomini” 2 . La provvidenza<br />
volle che la linea del P. Bernardo fosse felicemente disattesa dal<br />
P. Francesco Saverio che, sollecitato dal cardinale L. M. Parocchi,<br />
decretò la ripresa delle cause “dormienti” dei servi di Dio P. Domenico<br />
Bàrberi e P. Vincenzo Maria Strambi e l’introduzione di tre nuove<br />
cause 3 . Il nuovo Generale, a sorpresa, decise di introdurre anche<br />
la causa di Gabriele dell’Addolorata, che, per ultimo nell’ordine di<br />
successione, fu il primo ad essere beatificato (1908) e canonizzato<br />
(1920) rispetto agli altri religiosi, in quanto lo Strambi è stato beatificato<br />
nel 1925 e canonizzato nel 1950, il Barberi è stato beatificato<br />
2 Cfr. P.F. dell’Addolorata, Vita del P. Domenico della Madre di Dio, Roma<br />
1963, p. 461. Sull’adesione a tale linea del P. Bernardo e del P. Norberto, si<br />
vd. il P. F. D’Anastasio, p. 289 e si vd. anche il P. F. Giorgini C.P., Bernardo Maria<br />
Silvestrelli, op.cit., p. 210.<br />
3 Il P. Francesco Saverio dell’Addolorata introdusse la causa di canonizzazione<br />
del P. Lorenzo di San Francesco Saverio (Lorenzo Salvi: 1782-1856), fr.<br />
Giacomo di S. Luigi (Giacomo Gianiel: 1714-1750) e di confr. Gabriele<br />
dell’Addolorata (Francesco Possenti: 1838-1862). Diede nuovo impulso alle<br />
cause del P. Vincenzo Maria di S. Paolo (Strambi:1745-1824), vescovo di<br />
Macerata e Tolentino (1801-1823), introdotta nel 1824, e del P. Domenico<br />
della Madre di Dio (Bàrberi: 1792-1849), introdotta nel 1863. Si vd. G. Di<br />
Giannatale, San Gabriele dell’Addolorata – l’iter processuale, in «Piccola<br />
opera Charitas – notizie», n. 23, 2008, pp. 61-64. Sull’intervento del card.<br />
Lucido Maria Parocchi (1833-1903), originario di Mantova, vescovo di<br />
Albano, vicario dell’Urbe e nel contempo Prefetto della Congregazione dei Riti,<br />
si vd. P.F. D’Anastasio C.P., Gabriele e le vie di Dio, in San Gabriele<br />
dell’Addolorata e il suo tempo, Ed. Eco, S. Gabriele dell’Addolorata, 1983,<br />
pp. 290-291. Il P. D’Anastasio ascrive un ruolo “provvidenziale” al P. Francesco<br />
Saverio, pure ex compagno di noviziato e di studentato di Gabriele, denominato<br />
con felice e indovinata metafora, «pedina di ricambio». Altrettanto decisivo<br />
per l’avvio dell’iter processuale di Gabriele fu il Parocchi, che nel 1892,<br />
avuto il sentore dei primi miracoli di Gabriele, fu l’artefice del «processo di<br />
Albano» per la deposizione del B. Silvestrelli, allora residente nel Ritiro di<br />
Nettuno nella provincia della Presentazione.
nel 1963, Lorenzo Salvi è stato beatificato nel 1989 e le altre cause<br />
sono ancora in corso 4 . Nonostante la decisione generalizia fosse<br />
contraria ai suoi intendimenti, il B. Bernardo, a partire dal terzo mandato,<br />
che iniziò nel 1893, seguì tutto l’iter processuale, attraverso<br />
l’oculata postulazione del P. Germano di Santo Stanislao (Vincenzo<br />
Ruòppolo, 1850-1909).<br />
Ciò che stupisce è l’assenza del B. Bernardo dalla cerimonia di<br />
beatificazione di Gabriele il 31 maggio del 1908. Vi erano tutti i capitolari,<br />
compreso il P. Norberto; mancava solo Bernardo. Perché?<br />
Nulla traspare dai documenti. I biografi riportano solo la risposta<br />
data da Bernardo ad alcuni studenti dello Studio teologico internazionale,<br />
da lui stesso istituito nel Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo, i<br />
quali lo esortavano a partecipare alla cerimonia. Il B. Bernardo<br />
disse agli studenti, in procinto di recarsi a S. Pietro, che preferiva<br />
restare in orazione nel Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo, invitandoli a<br />
pregare il novello Beato per lui. Non partecipò neppure alla speciale<br />
udienza concessa dal Papa ai capitolari. Quale poteva essere il motivo<br />
di questa assenza? Indifferenza per la cerimonia di canonizzazione<br />
di religiosi passionisti (fosse anche il proprio compagno di noviziato),<br />
in coerenza con la convinzione che la Congregazione non avesse<br />
bisogno di santi canonizzati, ma solo di santi al cospetto di Dio?<br />
Se è vero che non mutò convinzione, si deve riconoscere tuttavia che<br />
nel corso del suo lungo generalato, che coincide con i processi<br />
relativi alla beatificazione di Gabriele (dal 9 maggio 1893 al 7 luglio<br />
1907), fece di tutto per favorirne lo sviluppo e la conclusione,<br />
incoraggiando il P. Germano. Nella testimonianza resa nel Processo<br />
Addizionale Ordinario di Albano (1892; sess. II), il B. Bernardo<br />
ebbe a dichiarare: “Ho devozione speciale verso questo servo di Dio<br />
e desidero la di lui beatificazione a gloria di Dio e della Chiesa”. E’<br />
da evidenziare anche quanto il B. Bernardo dichiarò in una lettera del<br />
12 giugno 1894, allorché, trovandosi nel ritiro di Isola del Gran<br />
Sasso per alcuni giorni, tra la fine di maggio e la prima metà di<br />
giugno, al termine di una serie di visite canoniche nella provincia di<br />
Maria Santissima della Pietà, poté ammirare e venerare la tomba di<br />
Gabriele. Egli, nel dirsi commosso per le “cose sorprendenti” che si<br />
udivano e si verificavano per intercessione di Gabriele, ritenne che<br />
bastavano i prodigi e i miracoli fino allora operati dal servo di Dio a<br />
4 Si vd. P.F. D’Anastasio C.P., op. cit., pp. 288-289.<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
Il beato Bernardo Maria<br />
Silvestrelli e san Gabriele<br />
dell’Addolorata<br />
349-364<br />
spiritualità<br />
351
pastorale e<br />
spiritualità<br />
GIOVANNI DI GIANNATALE<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
spiritualità<br />
352<br />
determinare l’immediata approvazione della Congregazione dei<br />
Santi ai fini della beatificazione: “Sono giunto al termine del mio<br />
pellegrinaggio ed ho avuto subito occasione di restare commosso<br />
delle cose senza dubbio sorprendenti che qui si vedono e si sentono.<br />
Credo che se i componenti della sacra Congregazione dei riti<br />
fossero qui per una settimana, darebbero subito il loro voto ‘de tuto’<br />
per acclamationem” 5 .<br />
A ciò si aggiunga che intorno al 1879 aveva fatto eseguire un<br />
ritratto di Gabriele per la Cappella degli studenti della Scala Santa,<br />
affinché ne seguissero l’esempio 6 . L’assenza dalla cerimonia di<br />
5 Per la lettera si vd. Fonti storico-biografiche di S. Gabriele dell’Addolorata,<br />
a c. del P.N. Cavatassi C.P. e del P. F. Giorgini, C.P., Ed. “Eco”, S. Gabriele<br />
dell’Addolorata, 1963, p. 364. Il passo citato è riportato dal P.F. D’Anastasio<br />
C.P., L’evento San Gabriele dell’Addolorata: 1893-1896, v. II, Tip. Edigrafital,<br />
Teramo, 1987, pp. 563-564. Il P.E. Malacarne C.P. , op. cit., a p. 305, riferisce<br />
una singolare decisione del B. Bernardo, che, per evitare, soprattutto durante<br />
i giorni feriali, che si violasse il silenzio, imposto dalla regola alla comunità<br />
passionista, per favorire l’orazione e la meditazione, “vietò” a Gabriele di operare<br />
prodigi e miracoli in chiesa sulla sua tomba: «La prima volta che il padre<br />
Bernardo nel 1894 si recò in Isola, proibì al taumaturgo Gabriele<br />
dell’Addolorata di fare miracoli nella Chiesa del Convento. Lo stesso padre<br />
Bernardo confidò tal cosa al sacerdote che ne somministra la notizia. Ed<br />
aggiunse di averlo fatto perché i miracoli toglievano il raccoglimento dei religiosi».<br />
Sembra che il vecchio compagno abbia “ubbidito” al suo Superiore,<br />
almeno per qualche anno. Così scrive la Platea del 1902: «E’ vero che dei<br />
miracoli straordinari più non si verificano presso alla tomba, ma molti ottengono<br />
grazie non lievi prima di venire ovvero dopo tornati alle loro case. Ed è<br />
comune avviso che il venerabile Gabriele operi così per assecondare, anche<br />
dopo morte, la volontà dei superiori e lo spirito dell’Istituto che a mantenere la<br />
regolare osservanza richiede che non si faccia straordinario richiamo di forestieri<br />
alla chiesa, massime nei giorni feriali» (vol. II, p. 85 bis). E’ da rilevare<br />
che il B. Bernardo mostrò vivo interesse per la riuscita del processo di beatificazione<br />
di Gabriele, diramando circolari alle province passioniste nelle seguenti<br />
occasioni, perché fosse esposto il SS. Sacramento e celebrata una Solenne<br />
messa “in terzo” per invocare l’assistenza dello Spirito Santo sui Padri che, riuniti<br />
nella Congregazione, dovevano decidere sull’eroicità delle virtù del<br />
Venerabile: 29/07/1902, in occasione della Congregazione antipreparatoria;<br />
il 28/06/1904, in occasione della Congregazione preparatoria; il<br />
3/05/1905, in occasione della Congregazione generale “coram<br />
Sanctissimo”, presieduta dal Papa, per la dichiarazione dell’eroicità delle virtù<br />
(Si vd. Archivio del Convento di S. Gabriele dell’Addolorata, Platea, v. II, ff. 85<br />
r, 85 v, 86 r, 8 v).<br />
6 Sulla testimonianza processuale, si vd. Fonti storico-biografiche di S.<br />
Gabriele dell’Addolorata, a c. di P. N. Cavatassi C.P. e F. Giorgini C.P., ed.
eatificazione è dovuta molto probabilmente, come sostiene il<br />
P. F. Giorgini C.P., alla naturale riluttanza per gli onori e i complimenti,<br />
dai quali, secondo la regola del Fondatore, i passionisti<br />
dovevano rifuggire ordinariamente, vivendo nel più assoluto spirito<br />
di orazione, meditazione e solitudine. Scrive, in merito, lo stesso<br />
Giorgini: “Il 31 maggio i capitolari, pieni di gratitudine a Dio,<br />
partecipavano in S. Pietro alla liturgia in cui veniva proclamato<br />
beato Gabriele dell’Addolorata. Vi era presente il P. Norberto<br />
Cassinelli ed altri che l’avevano conosciuto. Bernardo, per fuggire<br />
onori e complimenti, preferì rendere grazie a Dio e parlare col suo<br />
indimenticabile compagno, rimanendo in orazione nel ritiro dei<br />
SS. Giovanni e Paolo” 7 .<br />
Eco, S. Gabriele dell’Addolorata, 1969, p. 334. Il quadro era stato commissionato<br />
all’artista romano Grandi in collaborazione con il P. Norberto di S. Maria.<br />
La cappella era interna all’ala del Ritiro (II piano), che ospitava lo Studentato<br />
teologico internazionale, fondato dal P. Bernardo nel 1878 e rinnovato nel<br />
1905, allorché stabilì che vi fossero mandati due religiosi di ciascuna provincia<br />
(si vd. P. F. Giorgini C.P., op. cit., pp. 165 e 183).<br />
7 Cfr. op. cit., p. 155. Sulle ragioni della mancata partecipazione del B.<br />
Bernardo alla cerimonia di beatificazione, si vd. anche quanto scrive il P. Ireneo<br />
di S. Giovanni Evangelista, P. Bernardo Maria Silvestelli di Gesù, Tipografia<br />
Agostiniana, Roma 1931: «Mancava solo il P. Bernardo, il compagno, l’amico<br />
del beato Gabriele, che più di tutti esultava della gloria di lui […], ma di feste<br />
esteriori, di distinzione e onori non voleva saperne; si contentò di raccomandarsi<br />
agli studenti che andavano a S. Pietro, che pregassero per lui il Beato confratello»<br />
(p. 90). Le stesse motivazioni sono addotte da P. L. Baldella, Beato<br />
Bernardo Maria Silvestrelli, S. Gabriele Edizioni, 2008, p. 34 e da Pierluigi Di<br />
Eugenio C.P., Sotto la croce appassionatamente, Ed. Eco, 1997, p. 86. E’ da<br />
rimarcare, tuttavia, che il 14/05/1905, nonostante rifuggisse dagli onori, preferendo<br />
vivere “nascosto”, schivo e umile qual era, partecipò nella Sede<br />
Apostolica alla cerimonia di promulgazione del decreto pontificio sulle virtù<br />
eroiche del Servo di Dio Gabriele dell’Addolorata. La Platea o Cronaca<br />
del Ritiro della Concezione presso Isola del Gran Sasso narra che il Papa,<br />
S. Pio X, alla presenza del Preposito generale, Bernardo Maria di Gesù, del<br />
nuovo procuratore generale P. Luigi di S. Francesco di Paola in rappresentanza<br />
del P. Germano, nominato Visitatore apostolico della Diocesi di Firenze, e<br />
di porporati e prelati della Corte Romana, «lesse il decreto definitivo delle virtù<br />
esercitate in grado eroico dal nostro Venerabile Servo di Dio […] il medesimo<br />
Sommo Pontefice fece voto che presto Iddio si degnasse confermare la<br />
sentenza apostolica con ben provati miracoli, onde si potesse procedere alla<br />
beatificazione di un giovanetto» (Archivio del Convento di S. Gabriele<br />
dell’Addolorata, Platea, v. II, f. 85 bis).<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
Il beato Bernardo Maria<br />
Silvestrelli e san Gabriele<br />
dell’Addolorata<br />
349-364<br />
spiritualità<br />
353
pastorale e<br />
spiritualità<br />
GIOVANNI DI GIANNATALE<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
spiritualità<br />
354<br />
2. La testimonianza del<br />
beato Bernardo su Gabriele<br />
Il B. Bernardo fu<br />
largo di lodi e di<br />
sincera ammirazione<br />
per Gabriele, come<br />
si evince dalla vita<br />
dello stesso Gabriele che egli traccia nelle Biografie edificanti di<br />
alcuni chierici passionisti 8 . In essa evidenzia lo stato di perfezione<br />
spirituale che l’”angelico giovane” aveva raggiunto nel compiere<br />
tutti gli atti dell’osservanza prescritti dalla Regola, enucleando il<br />
principio che l’assoluta fedeltà alla Regola costituisce di per sé<br />
motivo di santità. Nei Cenni biografici di alcuni religiosi <strong>Passio</strong>nisti<br />
che professarono l’Istituto nel suo primo periodo di 50 anni 9 , il<br />
B. Bernardo aveva dichiarato quanto segue: “Quindi quel religioso<br />
dovrà chiamarsi perfetto che ha atteso con incessante premura e con<br />
fedele esattezza ad osservare tutte le prescrizioni della sua Regola;<br />
siccome quelle che esprimono per lui la volontà SS.ma di Dio, e gli<br />
sono state date dal medesimo come mezzo di santificarsi”. Questo<br />
concetto è il “cuore” della biografia di Gabriele, che è poi il testo<br />
della deposizione canonica resa il 2/02/1892 nella sessione II del Processo<br />
Addizionale Ordinario di Albano, e confermato nel Processo<br />
Apostolico Aprutino il 31/03/1897 durante la sessione 47 a10 .<br />
Infatti il B. Bernardo, dopo aver dichiarato di sentire “devozione<br />
speciale verso questo servo di Dio”, nel cap. III riprende questo concetto,<br />
ponendolo come il criterio principe con cui è possibile, a suo<br />
avviso, discernere lo stato di perfezione spirituale di un religioso: “Il<br />
miglior mezzo per conoscere la corrispondenza di un’anima alla vocazione<br />
religiosa è quello di osservare il modo col quale essa ne adempie<br />
le obbligazioni” 11 . Passando a verificare questa “corrispondenza”,<br />
o coerenza di Gabriele, il B. Bernardo la connota con la sua assoluta<br />
e incondizionata “ubbidienza” (considerata la “virtù fondamentale<br />
nella vita religiosa”), alla volontà del suo “Superiore” (cioè del<br />
Direttore, P. Norberto) e con la perfetta e totale osservanza della “Regola”<br />
passionista, al punto da non trascurare nessuna prescrizione,<br />
neppure quella più minuta: “Tutte le più minute pratiche che trovò<br />
8 Furono stampate a Roma per l’editore Tip. Guerra e Mirri nel 1885 (pp. 149).<br />
9 Furono stampate a Roma per l’editore Tip. Guerra e Mirri nel 1886 (pp. 380).<br />
10 Si vd. Fonti storico-biografiche di S. Gabriele dell’Addolorata, op. cit., p. 333.<br />
11 Si vd. ibidem, p. 345.
designate nella regola, tutte egli riguardò come espressione della volontà<br />
di Dio, e perciò si studiò di conformarvisi nella maniera più perfetta” 12 .<br />
In un altro passaggio della sua testimonianza, il B. Bernardo ascrive il<br />
rapido avanzamento compiuto da Gabriele durante il noviziato, nel conseguire<br />
sempre più il maggiore “spirituale profitto”, all’esatta osservanza<br />
della Regola e alla sollecitudine con cui giornalmente la “santificava”:<br />
“Seppe peraltro il generoso giovane compensarvi assai bene, perché oltre<br />
all’esatta osservanza di tutte le prescrizioni della regola, ad ogni momento<br />
ed in ogni sua opera, benché indifferente, egli era attentissimo non solo<br />
a santificarla colle più belle intenzioni, ma ad accompagnarla ancora<br />
con un sacrificio di qualche penalità” 13 .<br />
Oltre all’osservanza della Regola, il B. Bernardo evidenzia un<br />
altro elemento fondamentale, che aveva contribuito ad elevare<br />
Gabriele alla perfezione: la devozione alla Vergine Addolorata. Così<br />
scrive nel cap. V dello stesso profilo: “Ma la devozione del nostro<br />
Confratel Gabriele divampò in modo straordinario verso Maria<br />
Santissima; e ben si può dire che questa fu l’origine, la vita, l’anima,<br />
il tutto della perfezione cui giunse” 14 . E così specifica nella<br />
deposizione orale del Processo apostolico aprutino: “Credo che<br />
questa devozione sia stata l’origine e la fonte, da cui ebbe tutta la<br />
grazia che ottenne dal cielo” 15 .<br />
3. Il Beato Bernardo compagno<br />
di noviziato di san Gabriele<br />
Le testimonianze<br />
del B. Bernardo<br />
attingono tutte dal<br />
periodo del noviziato nel<br />
Ritiro di Morrovalle, do-<br />
ve entrò il 1/04/1856, vestendo l’abito il 27/04/1856 e assumendo il<br />
nome di Confr. Bernardo Maria di Gesù 16 . Ripeteva la “prova”, come<br />
sacerdote, perché dopo essere entrato nella Congregazione dei<br />
<strong>Passio</strong>nisti, presso il Ritiro del Monte Argentario il 25/03/1854, e aver<br />
vestito l’abito il 7/04/1854 (all’età di 22 anni), assumendo il nome di<br />
12 Si vd. ibidem, p. 346.<br />
13 Si vd. ibidem, p. 346.<br />
14 Si vd. ibidem, pp. 349-350.<br />
15 Si vd. ibidem, p. 356.<br />
16 Si vd. P. F. Giorgini, op. cit., pp. 43-49.<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
Il beato Bernardo Maria<br />
Silvestrelli e san Gabriele<br />
dell’Addolorata<br />
349-364<br />
spiritualità<br />
355
pastorale e<br />
spiritualità<br />
GIOVANNI DI GIANNATALE<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
spiritualità<br />
356<br />
Luigi del Cuore di Maria, non aveva concluso per ragioni di salute il<br />
noviziato, che lasciò il 3/05/1854 17 . Gli fu concesso il permesso di restare<br />
come ospite nel Ritiro della Presentazione di Maria SS.ma dal<br />
Preposito Generale, P. Antonio di S. Giacomo (Testa, 1787-1862), per<br />
poter proseguire gli studi in vista del sacerdozio. Dopo il corso di<br />
teologia, tenuto dal P. Pacifico di S. Giuseppe, Bernardo, che si era<br />
trasferito temporaneamente nel Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo a<br />
Roma il 31/06/1855, fu poi ordinato dal Mons. Giuseppe Molajoni<br />
C.P., già Vescovo in Bulgaria, alla Presentazione prima diacono il<br />
22/11/1855 e poi presbitero il 22/12/1855. Nel periodo successivo all’ordinazione<br />
sacerdotale, dimorò sempre, ut hospes, nel Ritiro della<br />
Presentazione. Dunque Bernardo, già sacerdote, e all’età di 24 anni,<br />
incontrò e conobbe Gabriele all’atto del suo ingresso nel Ritiro<br />
di Morrovalle, che ebbe luogo il 10/09/1856 18 . I compagni di noviziato<br />
con Gabriele erano dieci ed ebbero come maestro il P. Raffaele<br />
di S. Antonio (Antonio Ricci, 1812-1879) e come vicemaestro il<br />
P. Norberto di S. Maria (Domenico Cassinelli, 1829-1911) 19 . Non<br />
abbiamo documenti che possano farci conoscere le relazioni intercorse<br />
tra i due connovizi. Occorre affidarci alle testimonianze di<br />
Bernardo. La prima riguarda l’impressione ricevuta alla vista del<br />
giovane Possenti. Bernardo, maturo, forte dell’esperienza religiosa<br />
17 Nel noviziato del Ritiro di S. Giuseppe del Monte Argentario ebbe come<br />
maestro Bartolomeo di S. Gabriele. Le cause dell’abbandono del noviziato<br />
sono attribuite alla debilitazione fisica da un lato e dall’altro ad esaurimento<br />
nervoso. Così scrive il P.F. Giorgini C.P.: «Si era in prima Quaresima. Egli si<br />
scalza andando solo con i sandali in un ambiente non riscaldato, interrompe il<br />
sonno a mezzanotte per alzarsi a pregare […] I piedi gli si raffreddano e non<br />
riesce sempre a riprendere sonno dopo l’ora e mezza di preghiera notturna. Il<br />
digiuno era rigido, al mattino non si prendeva nulla fino al magro pranzo verso<br />
le ore 11,30. Alla sera un piatto di erbe o legumi con una sardina o un pezzetto<br />
di formaggio. Le forze vengono meno e l’assale la tristezza e la noia»<br />
(p. 39). Prese il sopravvento la “malinconia”, che indicava allora uno stato di<br />
affaticamento psichico, che dava luogo a fissazione e perdita di interesse e di<br />
motivazioni. Il P. L. Baldella, op. cit., p. 14, riporta l’epressione che caratterizza<br />
lo stato psicologico di Bernardo: «Il tutto l’era di noia per essere troppo<br />
dominato dalla malinconia».<br />
18 Si vd. G. Di Giannatale, La formazione di Gabriele dell’Addolorata: dal<br />
noviziato alla teologia (1856-1862), in San Gabriele e il suo tempo, IV San<br />
Gabriele edizione, 2009, pp. 251-269.<br />
19 Si vd. l’approfondito studio del P. E. Annibali C.P. apparso nell’Eco di<br />
S. Gabriele dell’Addolorata, n. 18, 26/X/1981, pp. 2-4.
e sacerdotale, restò originariamente perplesso, quando si trovò davanti<br />
un ragazzo galante, raffinato e ben vestito, che gli insinuò subito<br />
il dubbio sulla sua riuscita in una Congregazione, come quella<br />
passionista, che si caratterizzava per l’austerità e per la rigidità della<br />
Regola, domandandosi interiormente: “Riuscirà questo damerino?” 20 .<br />
Allorché Gabriele, vestito il 21/09/1856, gli fu assegnato come<br />
compagno dal Padre Maestro, Bernardo, col passar del tempo, dovette<br />
ricredersi 21 , e, sulla base dei fatti narrati nella deposizione, sciolse<br />
radicalmente il dubbio iniziale, affermando: “Questo damerino<br />
20 Si riporta quanto scrive il P. E. Malacarne C.P., Il Servo di Dio Bernardo<br />
di Maria Gesù – memorie edificanti, Unione Tipografica Nazzarena, Spoleto,<br />
1920, p. 4: «Il P. Bernardo, come egli confidenzialmente manifesta poi, nel<br />
vedere quel giovane di aspetto signorile, disse in cuor suo: che riuscita farà<br />
costui? Reggerà alla vita austera della Congregazione?».<br />
21 Il P. Bernardo nelle deposizioni del Processo addizionale di Albano<br />
dichiarò così: «Ho conosciuto di persona il confr. Gabriele della Vergine<br />
Addolorata come mio compagno di noviziato nel Ritiro di Morrovalle». (Fonti,<br />
op. cit., pp. 333-334). Sull’assegnazione di Gabriele come compagno a<br />
Bernardo si vd. l’art. Bernardo Maria Silvestrelli, nel sito www.passionisti.piet.it<br />
p. 2/4. In una lettera del 28/03/1895 del P. Norberto di S. Maria (Domenico<br />
Cassinelli: 1829-1911) al P. Germano di S. Stanislao (Salvatore Ruòppolo:<br />
1850-1909) emergono alcune considerazioni critiche del B. Bernardo sull’eccessivo<br />
fervore della devozione mariana di Gabriele nel periodo in cui gli fu<br />
compagno nel noviziato di Morrovalle, parlando di “fanatismo devozionale<br />
“ed usando anche altre espressioni negative. Tali considerazioni ed espressioni<br />
erano state riferite al P. Norberto dal P. Germano, che, come postulatore, ne<br />
chiedeva spiegazioni. A mio avviso esse rispecchiano lo stato d’animo del<br />
B. Bernardo nel periodo del noviziato, nell’ambito del quale vanno circoscritte<br />
e contestualizzate, quando anche il P. Francesco Saverio dell’Addolorata diede<br />
a Gabriele del «bizzoccone», come riferisce il P. F. Pozzi nella sua biografia<br />
(si vd. per tale riferimento e per la citata lettera del P. Norberto il P. F.<br />
D’Anastasio, S. Gabriele dell’Addolorata in 100 anni di ricerche [1892-1992],<br />
Ed. Eco, S. Gabriele dell’Addolorata, 1993, pp. 429-432) e non contraddicono<br />
la stima e l’ammirazione del B. Bernardo per Gabriele. Gli è che il B.<br />
Bernardo aveva una devozione diversa, più distaccata, di tipo “stoico”, per<br />
usare un’espressione del P. Norberto. Pertanto certi atteggiamenti di concitazione<br />
e di enfasi spirituale non erano consoni al suo sentire, come si può<br />
intravedere in un passo della deposizione canonica, in cui narra che, mentre<br />
accompagnava Gabriele nel passeggio, questi «quasi uscito fuori di sé, si<br />
attirava l’attenzione di tutti, tutti soffocava col suo parlare concitato, enfatico,<br />
espressivo, e che sempre si aggirava sul dovere che si aveva di unirsi a Maria<br />
SS.ma». Il B. Bernardo riteneva che l’intensità con cui visse la devozione alla<br />
Vergine dolente fu «uno dei motivi che alterarono ben presto la sua sanità»<br />
(Fonti storico-biografiche di S. Gabriele, op. cit., pp.336-337).<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
Il beato Bernardo Maria<br />
Silvestrelli e san Gabriele<br />
dell’Addolorata<br />
349-364<br />
spiritualità<br />
357
pastorale e<br />
spiritualità<br />
GIOVANNI DI GIANNATALE<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
spiritualità<br />
358<br />
passerà davanti a tutti” 22 . Con tale espressione presentì la futura<br />
beatificazione del suo compagno. L’intesa tra i due fu così intensa<br />
e profonda, che Gabriele, insieme con il suo vicemaestro, fu<br />
testimone della professione perpetua dei voti, che Bernardo emise il<br />
28 aprile del 1857 23 .<br />
Che cosa si siano detti e confidati i due confratelli, non è stato consegnato<br />
ai documenti. Neppure un cenno su Bernardo nelle lettere di<br />
Gabriele. Molto probabilmente, come novizio anziano, Bernardo ebbe<br />
il compito di avviare il più giovane compagno alle usanze e alle<br />
consuetudini passioniste, e anche di esserne l’interlocutore privilegiato<br />
nelle orazioni e nelle sacre meditazioni stabilite dal Maestro 24 .<br />
Subito dopo la professione religiosa, Bernardo lasciò il noviziato, partendo<br />
alla volta del Ritiro di Recanati, dove fece parte del gruppo degli<br />
studenti teologi, che ebbero come lettore e direttore il P. Salviano<br />
di S. Luigi (Luigi Masolini, 1819-1896). Qui Bernardo restò fino al<br />
settembre del 1861, completando la sua formazione con lo studio della<br />
“sacra eloquenza” 25 . Sappiamo che da Recanati si recò a Morrovalle<br />
nell’ottobre del 1857 e, forse ancora nel corso del 1858, rivedendo<br />
Gabriele 26 , che vi era rimasto, dopo la professione religiosa,<br />
per attendere la professione degli altri suoi compagni, seguendo il<br />
22 Questa espressione è riportata dal P. Pierluigi Di Eugenio C.P., op. cit.,<br />
p. 81.<br />
23 Vd. P. F. Giorgini C.P., op. cit., p. 55. Al P. Bartolomeo di S. Gabriele,<br />
che era stato il suo primo maestro di noviziato all’Argentario, così scrisse il P.<br />
Norberto, essendogli state chieste informazioni sulla riuscita di Bernardo: «Il P.<br />
Bernardo va sempre di bene in meglio e pare più che abbia mutato natura: è<br />
riuscito gioviale quanto mai». Aggiunge che «andava innanzi a tutti nell’esercizio<br />
della virtù, non escluso Gabriele dell’Addolorata».<br />
24 Il P. E. Malacarne C.P. affidandosi alle testimonianze del P. Norberto e di<br />
fr. Silvestro di S. Paolo della Croce (Giovanni Polidori: 1836-1923), descrive<br />
così la relazione tra i due connnovizi: «Il P. Norberto e un connovizio del Santo,<br />
l’ultimo Superstite dei compagni, fratel Silvestro, asseriscono che il P. Bernardo<br />
e il confratel Gabriele furono sempre un cuor solo ed un’anima sola, quasi due<br />
novelli Davide e Gionata. Il P. Bernardo poi per aggiungere esca al fuoco di<br />
Gabriele soleva cavare dalle Sacre Scritture i passi più belli e acconci, glieli<br />
offriva da leggere e meditare a fine giorno» (p. 38).<br />
25 Si vd. P. F. Giorgini C.P., op. cit., p. 56.<br />
26 Si vd. P. F. Giorgini C.P., op cit., p. 56: «Nel mese di ottobre 1857, allora<br />
mese di vacanze della scuola, gli studenti andarono a Morrovalle per fraternizzare<br />
con i novizi e così Bernardo ebbe occasione di rivedere formatori e<br />
compagni».
corso di latinità insieme con gli altri neo-professi 27 . Risulta che Bernardo<br />
potè rivedere Gabriele, insieme con gli altri sei compagni, che,<br />
guidati dal P. Norberto, loro direttore e lettore, il 4/07/1859 si fermarono<br />
nel Ritiro di Recanati, per riposare 28 , mentre erano in viaggio<br />
verso il Ritiro di Isola di Penne, dove dovevano completare il corso<br />
di filosofia, avviato a Pievetorina, e compiere il triennio di teologia.<br />
Fu questa l’ultima volta in cui Bernardo vide Gabriele. Ne apprese la<br />
morte, avvenuta nel Ritiro di Isola il 27/02/1862, mentre si trovava<br />
nel Ritiro di Morrovalle, dove era stato trasferito nell’ottobre del<br />
1861 come lettore degli studenti di teologia, non essendovi più accolti<br />
i novizi 29 .<br />
Gabriele, il vecchio e indimenticabile compagno di noviziato gli<br />
apparve in una visione, così narrata da Bernardo. Nel 1893, dovendosi<br />
procedere all’elezione del Preposito generale, che doveva<br />
succedere al P. Francesco Saverio, malato, Bernardo, per evitare di<br />
essere rieletto, decise di non partecipare al Capitolo generale,<br />
recandosi al Ritiro di Nettuno. Mentre iniziava il viaggio, gli apparve<br />
Gabriele, che gli ordinò di partecipare al Capitolo. Bernardo si indirizzò<br />
a Roma, partecipando al Capitolo. Fu eletto Preposito Generale<br />
al primo scrutinio. A differenza delle precedenti elezioni, in cui aveva<br />
protestato, ritenendosi inadatto a governare, questa volta Bernardo<br />
accettò l’ufficio senza opporre difficoltà, suscitando la meraviglia di tutti.<br />
Nessuno sapeva che l’artefice di tale esemplare spirito di ubbidienza<br />
e di sacrifico era stato Gabriele, destinato da lì a poco alla beatificazione.<br />
Bernardo narrò l’antefatto ai suoi confratelli alcuni anni dopo, dichiarando<br />
affettuosamente e profeticamente: “Questo ragazzo me l’ha<br />
fatta grossa, ma io lo raggiungerò” 30 . Non si sbagliò, perché il 16 ottobre<br />
1988 è stato proclamato Beato da Giovanni Paolo II.<br />
27 Si Vd. G. Di Giannatale, La formazione di Gabriele dell’Addolorata dal<br />
noviziato alla teologia (1856-1862), op. cit., p. 258.<br />
28 Si vd. P. E. Annibali C.P., La venuta di S. Gabriele in Abruzzo: caso o<br />
Provvidenza?, in S. Gabriele dell’Addolorata e il suo tempo, ed. Eco, S.<br />
Gabriele dell’Addolorata, Teramo, 1983, p. 178. Si vd. anche P. F. Giorgini<br />
C.P., op. cit., pp. 56-57.<br />
29 Si vd. P. F. Giorgini C.P., op. cit., p. 57, che dipende dal citato studio del<br />
P. Annibali: «Il P. Bernardo si trasferì a Morrovalle con i suoi studenti per far<br />
posto a Recanati agli studenti di Pievetorina, già sacerdoti, che vi compiono<br />
l’anno di sacra eloquenza».<br />
30 Il P. Ireneo, op cit., scrive che i PP. Norberto, Salviano di S. Luigi e<br />
Sebastiano del Cuore di Maria «attestarono di aver udito dal P. Bernardo stes-<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
Il beato Bernardo Maria<br />
Silvestrelli e san Gabriele<br />
dell’Addolorata<br />
349-364<br />
spiritualità<br />
359
pastorale e<br />
spiritualità<br />
GIOVANNI DI GIANNATALE<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
spiritualità<br />
360<br />
4. La devozione mariana del<br />
B. Bernardo e di S.Gabriele<br />
Il B. Bernardo e S.<br />
Gabriele ebbero in<br />
comune la devozione<br />
per la Vergine<br />
Addolorata e la medi-<br />
tazione-memoria della <strong>Passio</strong>ne di Gesù Crocifisso. Entrambi derivarono<br />
la devozione mariana dalla comune matrice formativa, che<br />
furono, nel noviziato, il P. Raffaele di S. Antonio e il P. Norberto di<br />
S. Maria. Il primo leggeva e commentava il “secondo decalogo”, composto<br />
dal P. Bernardo Spinelli (suo ex maestro di noviziato), in cui ai<br />
nn. 8 e 10 si delineava il ruolo della devozione mariana per un passionista<br />
31 . Maria è presentata come la mediatrice delle grazie e, pertanto,<br />
l’artefice della salvezza, come madre del Redentore, che ha sofferto<br />
insieme al Figlio ai piedi della Croce, diventando per questo<br />
“corredentrice” dell’umanità. Il “Regolamento dei novizi”, che Gabriele<br />
e Bernardo leggevano sotto la guida del Maestro, invitava i giovani<br />
passionisti non solo a recitare “tre ave Maria ai dolori sofferti<br />
dalla Vergine Santissima ai piedi della Croce”, ma anche a collegare<br />
la riflessione sulle pene della Vergine Addolorata con la meditazione<br />
sulla <strong>Passio</strong>ne di Gesù Cristo. Su questo punto Bernardo e Gabriele<br />
avevano come guida ispiratrice il P. Norberto, che nella Mariologia<br />
riporta un brano di Tommaso da Kempis che raccomanda di riceve-<br />
so, che venendo da Nettuno a Roma gli era apparso S. Gabriele, e in nome di<br />
Dio gli aveva ingiunto di recarsi al Capitolo, essendo volontà di Dio che ripigliasse<br />
il governo della Congregazione». Diceva il Servo di Dio, nel parlare<br />
bonario:”Quel bardascio ne ha fatto una grossa, una grossa” (p. 64). Lo stesso<br />
narra il P. Serafino dell’Addolorata, Il Servo di Dio B. Bernardo Maria di<br />
Gesù, Tipografia A. Macione e Pisani, Isola del Liri, 1940, 2^ ed., 1940, p.<br />
58 (riporta, come il P. Ireneo, la parola dialettale “bardascio”). Il P. E.<br />
Malacarne, op. cit., riporta la testimonianza del P. Norberto di S. Maria, secondo<br />
cui Gabriele gli apparve più volte: «Appena trapelò qualche cosa sull’apparizione<br />
del 1893 altrove accennata; tuttavia il P. Norberto di S. Maria dichiarò<br />
che il Santo è apparso più volte al Servo di Dio» (p. 177). L’espressione «ma<br />
io lo raggiungerò», attribuita a Bernardo, è riportata dall’articolo apparso nel<br />
“sito” della provincia di Maria SS.ma della Pietà, citato sopra, p. 4/4.<br />
31 Il secondo decalogo dello Spinelli era denominato Modo facilissimo per<br />
stare con Dio. Ciascuno dei due decaloghi era preceduto e seguito da un epilogo.<br />
I lavori dello Spinelli erano pervenuti nel Ritiro di Morrovalle qualche<br />
mese prima che vi entrassero il P. Bernardo e S. Gabriele. Si vd., per tale aspetto,<br />
il P.F. D’Anastasio C.P., S. Gabriele dell’Addolorata in 100 anni di ricerche<br />
[1892-1992], Ed. Eco, S. Gabriele dell’Addolorata, 1993, pp. 360-365 e ora
e “con Maria Gesù”, di abitare “con Maria e Gesù”, e di restare con<br />
Maria “sotto la Croce di Gesù” 32 . In un altro passo il P. Norberto chiarisce<br />
che “Maria fu commartire di Gesù, perché fu partecipe e compagna<br />
dei tormenti, del dolore e della morte di Gesù Cristo (…) onde<br />
la sua anima dicesi crocifissa insieme con Gesù Cristo”, citando<br />
l’abate Guerrico, autore dei Sermones Assumptionis 33 .<br />
Tenendo conto di questo quadro di riferimento, vediamo le consonanze<br />
esistenti tra Bernardo e Gabriele. Entrambi affidano il loro<br />
pensiero a due opere, che trovano la loro genesi e la loro ispirazione<br />
nell’ambito del noviziato. Bernardo iniziò il Mariologium 34 , che è<br />
una raccolta di brani e di sentenze dei Padri della Chiesa e di scrittori<br />
ecclesiastici, ad imitazione della Mariologia norbertiana. San Gabriele<br />
– secondo L. Baldella – compone il “Simbolo mariano”, la<br />
cui ultima redazione N. Cavatassi ritiene eseguita nel Ritiro di Isola<br />
dopo il 1859 35 . Bernardo afferma che per il passionista Maria deve<br />
essere Superiora e Madre, dalla quale deve essere guidato per conformarsi<br />
totalmente ed effettivamente a Cristo Crocifisso. Commentando<br />
le parole espresse da Gesù in Gv 14,6, sulla necessità della sua<br />
mediazione per andare al Padre: Nessuno va al padre, se non per mio<br />
mezzo, egli è sicuro che “possiamo tenere per certo che il mezzo più<br />
spedito e sicuro per andare a Gesù Cristo è Maria SS.ma, è da<br />
mettersi sulle tracce di Lei, riguardandola come via e guida...<br />
Fissando lo sguardo su Maria Addolorata, lo fissiamo in pari tempo<br />
su Gesù appassionato 36 .<br />
32 Si vd. Mariologia, n. 319.<br />
33 Si vd. Mariologia, n. 27.<br />
34 Sul Mariologium si vd. P.F. Giorgini C.P., op. cit., pp. 207-210, e P.L.<br />
Baldella C.P., op. cit., pp. 56-57. Il manoscritto recita che il Mariologuim è stato<br />
«per sua devozione» trascritto da «servo dei servi della Vergine Madre di Dio».<br />
E’ diviso in sette sezioni, in cui Bernardo «medita la grandezza e la bellezza<br />
morale di Maria, la sua dignità per la missione sublime che Dio le ha affidato,<br />
la sua disponibilità assoluta alla volontà divina, la sua incessante opera materna<br />
verso gli uomini e le donne di tutti i tempi perché conoscano ed amino il<br />
Salvatore» (P.F. Giorgini C.P., p. 207).<br />
35 Si vd. Il P.N. Cavatassi C.P., Il simbolo mariano di S. Gabriele<br />
dell’Addolorata, in «S. Gabriele dell’Addolorata e il suo tempo», II, Ed. Eco,<br />
1986, pp. 105-109.<br />
36 Cfr. P.F. Giorgini C.P., op.cit., pp. 208-209, che cita i Trattenimenti spirituali,<br />
Roma 1886, pp. 314.<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
Il beato Bernardo Maria<br />
Silvestrelli e san Gabriele<br />
dell’Addolorata<br />
349-364<br />
spiritualità<br />
361
pastorale e<br />
spiritualità<br />
GIOVANNI DI GIANNATALE<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
spiritualità<br />
362<br />
Non diversamente concepisce la Vergine San Gabriele che, rispetto<br />
a Bernardo, vi aggiungeva un più intenso affetto spirituale, come<br />
attesta il P. Valentino di S. Giuseppe (Costantino Perrucci, 1858 –<br />
1901) in una deposizione canonica, dichiarando che spesso Gabriele<br />
interrompeva i suoi compagni mentre stavano conversando, sommergendoli<br />
“col suo parlare concitato, enfatico, espressivo, e che sempre<br />
si aggirava sul dovere che aveva da unirsi a Maria SS.ma nel piangere<br />
la passione di Gesù Cristo” 37 . Il Santo - come attesta il P. Francesco<br />
Saverio - durante la sua “penosa malattia” mostrò sempre<br />
“speciale devozione nel parlare dei dolori del Redentore e della Madonna<br />
SS.ma” 38 . Come abbiamo rilevato in un nostro saggio 39 ,<br />
Gabriele nella relazione binaria tra i dolori di Maria e la <strong>Passio</strong>ne<br />
del Figlio, fondò la sua devozione mariana che, pur sorgendo<br />
dall’esperienza gesuitica, si connota delle caratteristiche proprie<br />
della spiritualità passionista. Questo nesso speculare tra la meditazione<br />
sui dolori di Maria e quella sulla contemporanea <strong>Passio</strong>ne del<br />
Cristo, è stato mirabilmente descritto da Bernardo nella deposizione<br />
del Processo Apostolico Aprutino in cui dichiara che Gabriele<br />
“applicato a meditare la <strong>Passio</strong>ne SS. di Gesù Cristo qui si fermò<br />
tutto di proposito”, riconoscendo “subito che questa <strong>Passio</strong>ne<br />
riflettevasi tutta come in uno specchio nel cuore amatissimo di<br />
Maria SS.ma” 40 .<br />
E’ evidente in questo atteggiamento di San Gabriele il riflesso del<br />
suggestivo passo norbertiano che considera tra i “flagelli” che<br />
affliggevano e percuotevano il corpo di Gesù Crocifisso “gli stessi<br />
che trafiggevano il cuore e l’anima di Maria” 41 . Passo dal quale<br />
dipende anche l’atteggiamento mariano di Bernardo. Il comune<br />
sentire di Bernardo e Gabriele è suggellato dal ruolo determinante<br />
che la Vergine ha avuto nell’origine e nello sviluppo della loro<br />
vocazione religiosa 42 . Gabriele il 22 agosto 1856 ricevette dalla<br />
37 Cfr. Fonti storico-biografiche di S. Gabriele dell’Addolorata, op. cit., pp.<br />
400-401.<br />
38 Cfr. op. cit., p. 368.<br />
39 Cfr. G. Di Giannatale, La spiritualità di S. Gabriele dell’Addolorata, in<br />
«Piccola opera Charitas», n. 3, sett/dic. 2008, pp. 51-53.<br />
40 Cfr. Fonti storico-biografiche di S. Gabriele dell’Addolorata, op. cit.,<br />
pp. 336-337.<br />
41 Cfr. Mariologia in P. F. D’Anastasio C.P., S. Gabriele dell’Addolorata e la<br />
spiritualità mariana, op. cit., p. 58.
Vergine a Spoleto l’invito a lasciare il mondo e a farsi religioso.<br />
Il 6 settembre partì alla volta del noviziato di Morrovalle, dove<br />
iniziò il suo cammino verso la santità. Bernardo nel corso del<br />
noviziato fu beneficato dall’apparizione della Vergine dalla tela<br />
denominata della Santa Speranza, che poi fece trasferire nel Ritiro<br />
di Sant’Angelo in Pontano. Sembra che la Madonna lo abbia<br />
confermato nella sua vocazione passionista, cosa che, secondo<br />
alcuni biografi, aveva fatto anche San Paolo della Croce, che gli era<br />
apparso nel Ritiro dell’Argentario, quando interruppe il noviziato 43 .<br />
BLESSES BERNARD MARY SILVESTRELLI AND ST.<br />
ENG<br />
GABRIEL OF THE SORROWFUL MOTHER<br />
By Giovanni Di Giannatale<br />
In a biographical outline of Blesses Bernard Mary, the distinguished<br />
Bible scholar Ireneo Pontremolesi wrote: “A worthy companion<br />
of Blessed Gabriel of the Sorrowful Mother, they shared a<br />
common virtue... Let us repeat often with burning desire, that one<br />
day in the not too distant future, he may come to share with his<br />
Blessed companion the honour of the altar.” This has now come to<br />
pass. The author of this article examines some of the mutual spiritual<br />
relationship between the two confrères.<br />
42 Sulla relazione, tra la Vergine e la vocazione religiosa di S. Gabriele<br />
si vd. il P. A. M. Artola Arbiza C.P., L’esperienza mistica di S. Gabriele<br />
dell’Addolorata in S. Gabriele e il suo tempo, IV, S. Gabriele Edizioni, 2009,<br />
pp. 137-152. Si vd. anche alcune osservazioni sulla “locuzione interiore” del<br />
22/08/1856 G. Di Giannatale, Alle origini della vocazione religiosa di S.<br />
Gabriele dell’Addolorata, in corso di stampa ne “La Sapienza della Croce” di<br />
aprile-giugno 2010.<br />
43 Si vd. P. L. Baldella C.P., op. cit., p. 60 sull’apparizione della Madonna<br />
e di S. Paolo della Croce.<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
Il beato Bernardo Maria<br />
Silvestrelli e san Gabriele<br />
dell’Addolorata<br />
349-364<br />
spiritualità<br />
363
pastorale e<br />
spiritualità<br />
GIOVANNI DI GIANNATALE<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
spiritualità<br />
364<br />
EL BEATO BERNARDO MARÍA SILVESTRELLI Y<br />
SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA<br />
De Giovanni Di Giannatale<br />
En un perfil biográfico del Beato Bernardo, el ilustre biblista Ireneo<br />
Pontremolesi escribía: “Digno compañero del B. Gabriel de la<br />
Dolorosa, tuvo con él de común la virtud… Que Dios haga, repitamos<br />
con ardiente deseo, que un día no lejano pueda tener común<br />
con su Beato compañero los honores de los altares”. Esto ha sucedido<br />
ahora. El autor del artículo examina algunos contactos espirituales<br />
entre los dos santos cohermanos.<br />
DER SELIGE BERNHARD MARIA SILVESTRELLI<br />
UND DER HEILIGE GABRIEL VON DER SCHMERZ-<br />
HAFTEN MUTTER GOTTES<br />
von Giovanni Di Giannatale<br />
Der bekannte Bibelwissenschaftler Ireneo Pontremolesi schrieb in<br />
einer biographischen Abhandlung über den Seligen Bernhard:<br />
„Dieser würdige Kamerad des Seligen Gabriel teilte mit ihm die<br />
Tugenden … Möge Gott - was wir mit glühendem Verlangen wiederholen<br />
– schenken, dass er an einem nicht allzu fernen Tage mit seinem<br />
seligen Kameraden auch die Ehre der Altäre teilen kann.“ Dies<br />
ist nun Wirklichkeit. Der Autor untersucht in diesem Artikel einige<br />
geistliche Verbindungen zwischen diesen beiden heiligen Brüdern.<br />
BŁOGOSŁAWIONY BERNARD MARIA<br />
SILVESTRELLI I ŚWIĘTY GABRIEL OD MATKI<br />
BOŻEJ BOLESNEJ<br />
Giovanni Di Giannatale<br />
ESP<br />
GER<br />
POL<br />
W biografii bł. Bernarda znany biblista Ireneo Pontremolesi napisał:<br />
“Godny towarzysz bł. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej miał<br />
cnoty podobne do niego. Oby Bóg sprawił, powtórzmy to z wielką<br />
gorliwością, że pewnego dnia w nieodległej przyszłości będzie<br />
podobnie jak błogosławiony towarzysz, cieszył się chwałą ołtarzy”.<br />
Teraz ma to miejsce. Autor artykułu zajął się tylko wybranymi związkami<br />
duchowymi między dwoma świętymi współbraćmi.
di MARIO CEMPANARI<br />
La ricerca condotta dall’autore di questo articolo, che muove<br />
da alcuni passi dell’Inferno di<br />
Dante, ci immerge in un periodo<br />
vivace e drammatico della Storia<br />
della Chiesa. L’autore ce la presenta<br />
utilizzando apporti vari a lui noti<br />
per l’ampia ricerca condotta sulla<br />
storia del Sancta Sanctorum Lateranense.<br />
Domanda provocatoria<br />
DANTE NEL<br />
SANCTA<br />
SANCTORUM<br />
LATERANENSE?<br />
Una ipotesi non tanto<br />
fantasiosa<br />
La domanda curiosa, ed anche provocatoria per il lettore, di cui,<br />
in quattro e quattrotto vorrebbe conoscere con certezza la risposta,<br />
non è così semplice o scontata. Da quali documenti o testimonianze<br />
si può ricavare la presenza del divino poeta in quella celebre<br />
cappella palatina riservata ai pontefici lateranensi. La risposta alla<br />
domanda, dunque, che non è del tutto frutto di pura fantasia, può essere<br />
data per una gradazione di certezze che va da elementi storicamente<br />
sicuri, ad altri meno certi, fino a quelli opinabili. Mai però del tutto fantasiosi.<br />
Si tratta, infatti, di partire da un commento letterale e contestuale<br />
del celebre canto XIX dell’Inferno, in cui Dante si incontra con il<br />
papa che edificò e restaurò ab imis fundamentis la collassata cappella<br />
papale palatina a motivo del terremoto del 1277. E’ papa Niccolò<br />
III Orsini (1277-1280).<br />
A proposito, poi, del canto citato, non è una esagerazione quando<br />
si asserisce che è un piccolo capolavoro a sé stante, nel grande capolavoro<br />
della Commedia, se è vero, com’è vero, che tutti i canti danteschi<br />
sono geniali capolavori. Ma il XIX canto ha una sua peculiare originalità,<br />
come constateremo meglio nello sviluppo di queste pagine.<br />
salvezza<br />
e<br />
culture<br />
Dante nel<br />
Sancta Sanctorum<br />
lateranense?<br />
365-382<br />
culture<br />
365
salvezza e<br />
culture<br />
MARIO CEMPANARI<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
culture<br />
366<br />
E per partire da una nota che caratterizza in generale tutto il canto,<br />
va osservato il tono estremamente scenico e personale del canto,<br />
che, da un lato, è dato dal personalissimo “mio bel San Giovanni”,<br />
luogo familiare per il poeta, battezzato appunto in quel battistero di<br />
Firenze nel 1265 e rievocato nel lirico canto XXV, 1-9 del Paradiso<br />
ed in cui, forse durante il bimestre del suo priorato nel 1300, aveva<br />
disposto l’effrazione di un pozzetto del fonte battesimale per evitare<br />
che un tale, incastratovisi dentro a testa in giù, soffocasse. “E questo<br />
– afferma a questo punto il poeta con frase allusiva assai ellittica –<br />
fia suggel ch’ogn’uomo sganni”, per dire che il caso è archiviato, per<br />
stroncare tutte le chiacchiere nate pro o contro il suo provvedimento;<br />
ma poi si trovano delle analogie con la pena che soffrono i condannati<br />
in questa terza bolgia: infoibati con la testa in giù. Pena che<br />
caratterizza la posizione di questi dannati.<br />
Ma, si accennava, il canto ha il tono estremamente scenico contenendo<br />
i due estremi del canto – dell’inizio e della fine – in un siparietto<br />
ecclesiastico, in cui Dante-personaggio tiene la ribalta, fino ad<br />
esibirsi, nel finale in un monologo furente e iroso; e Dante-poeta rincara<br />
nel monologo ira e sarcasmo con inesorabile dosaggio di nuova<br />
ira e sarcasmo. Insomma, in questo canto Dante “fa la parte del presentatore<br />
di varietà che espone la cronaca all’irrisione della platea<br />
ammiccando al senso comune e con tecniche da presentatore di varietà<br />
espone la stessa cronaca al ludibrio dei millenni, riscontrandola<br />
con la verità delle Sacre Scritture”.<br />
Alla ribalta del piccolo siparietto – non tanto piccolo poi trattandosi<br />
degli ampi e tristi spazi della terza bolgia dell’ottavo girone di<br />
Malebolge – compaiono cinque principali figure: due in secondo e<br />
tre in primo piano, quest’ultime di tutto rispetto, trattandosi di tre pontefici,<br />
che, dei sei pontefici dell’inferno dantesco, sono qui riuniti per<br />
la stessa colpa di simonia, perché praticavano la compravendita di<br />
beni spirituali e di uffici ecclesiastici, procurando alla Chiesa, sposa<br />
di Cristo, di essere ingravidata dallo Spirito maligno, e così costringere<br />
Dio ad avere figli adulterini e a diseredare i legittimi, direbbe il<br />
Pietro di Dante.<br />
Il peccato grave è detto di “simonia”, perché, com’è noto, deriva<br />
dal passaggio degli Atti degli Apostoli 8, 9-24, dove si narra che un<br />
tal Simone mago, convertitosi al cristianesimo, prese il battesimo e<br />
avendo veduto che Pietro e Giovanni infondevano lo Spirito Santo ai<br />
battezzati con l’imposizione delle mani, Simone offrì ai due apostoli<br />
una certa somma di denaro affinché gli conferissero quella facoltà
pentecostale. Ma Pietro gli rispose: “Il tuo denaro sia con te in<br />
perdizione, visto che hai pensato di procurarti il dono di Dio con il<br />
denaro”. Da Simone, dunque, il sostantivo simonia e l’aggettivo simoniaco,<br />
che Gregorio Magno per la prima volta affibbiò a chiunque<br />
si faceva pagare l’ordinazione dei sacerdoti; e che in seguito si estese<br />
a chiunque praticasse la compravendita dei beni spirituali e degli<br />
uffici ecclesiastici.<br />
Sembrerà strano, ma proprio a tre grandi papi, successori di Gregorio<br />
Magno, che conoscevano bene la condanna di S. Pietro e l’applicazione<br />
del termine simonia da parte di papa Gregorio ai venditori<br />
di beni spirituali ed ecclesiastici, Dante attribuisce l’infamante<br />
sostantivo. E tra tanti condannati per simonia della terza bolgia nell’ottavo<br />
cerchio di Malebolge (canto XVIII), il poeta, in questo canto<br />
XIX, si sofferma a parlare e nomina solo tre papi: Niccolò III (1277-<br />
1280), al secolo Giovanni Giacomo Orsini, Clemente V (1305-1314),<br />
al secolo Bertrand de Got, e Bonifacio VIII (1294-1303), al secolo<br />
Benedetto Caetani.<br />
A questo punto, si profila logicamente la domanda provocatoria:<br />
perché mai il cattolico guelfo bianco Dante, di sei papi che condanna<br />
all’inferno (in ordine alfabetico sono Anastasio II [496-498], Bonifacio<br />
VIII [1294-1303], Celestino V [1294], Clemente V [1305-<br />
1314], Giovanni XXII [955-964], Niccolò III [1277-1280]), tre li pone<br />
tutti insieme in questa bolgia, piantati a testa in giù come un palo<br />
nella stessa buca? Atto, questo, riservato nella Commedia ai papi simoniaci,<br />
noto nella pratica della giustizia fiorentina col termine di<br />
“propaggine”. Le risposte a quella interrogazione possono essere<br />
molteplici, e vanno considerate attentamente, prima che passiamo al<br />
caso specifico di Niccolò III, messo tra i dannati dal poeta.<br />
Anche se Dante<br />
da Ugo Foscolo<br />
Dante, il Papato e i Papi<br />
fu chiamato il<br />
“ghibellin fuggiasco”, il<br />
nostro poeta non appartenne<br />
mai a quella fazione antipapale, né fu mai contrario al papato<br />
per principio e prende sempre le adeguate distanze da irriverenti o<br />
ereticali posizioni nei confronti del papato: egli mantenne sempre<br />
“la reverenza per le somme chiavi”, come afferma chiaramente al v.<br />
101 di questo canto XIX e che fa dire da Bonifacio VIII a Virgilio che<br />
salvezza<br />
e<br />
culture<br />
Dante nel<br />
Sancta Sanctorum<br />
lateranense?<br />
365-382<br />
culture<br />
367
salvezza e<br />
culture<br />
MARIO CEMPANARI<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
culture<br />
368<br />
accompagna Dante nella bolgia di Malebolge: “Lo ciel poss’io serrare<br />
e disserrare, / come tu sai” (Inf. XXVII, 103-4). Sicuramente,<br />
tuttavia, dal suo punto di vista non sempre errato o fazioso, Dante fu<br />
severo critico delle azioni e dei comportamenti politici, mantenendo<br />
la sua indipendenza di giudizio su persone ed avvenimenti politicoamministrativi<br />
dello Stato della Chiesa. Per esprimermi in modo<br />
icastico, direi che Dante sa distinguere il “Sovrano” dal “Pontefice”<br />
e sa cogliere le “due anime in un corpo” del capo della Chiesa:<br />
l’anima della “persona particolare” del papa, dall’anima del “successore<br />
di Pietro”.<br />
Questo aspetto della posizione dantesca si avverte specialmente nella<br />
difesa di Bonifacio VIII, al quale non perdona mai alcune sue azioni<br />
politiche, quando condanna poi fortemente l’oltraggio che Guillaume<br />
de Nogaret e Giacomo Sciarra Colonna fecero al papa nel palazzo<br />
pontificio con il cosiddetto “schiaffo di Anagni” (vedi Purgatorio<br />
XX, 85-90), insultando gravemente non tanto Benedetto Caetani,<br />
quanto il Romano Pontefice, Vicario di Cristo, Papa Bonifacio.<br />
Per afferrare, tuttavia, “la reverenza” che Dante ha del papato<br />
dobbiamo riandare alla mentalità e alla cultura cattolica largamente<br />
diffusa nel secolo XIII, sia fra i rappresentanti più autorevoli della<br />
cultura, sia nella grande massa del popolo.<br />
E’ bene, infatti, ricordare che nonostante tutto, nella società e<br />
nel secolo XIII si viveva in un’età intrisa di sentimento religioso e<br />
pervasa da un specie di “febbre di Dio”.<br />
E’ pur vero che “Gioacchino da Fiore aveva dominato tutta l’età<br />
che corre dal ‘200 al ‘300 e le influenze del suo pensiero sono evidenti<br />
nei maggiori rappresentanti della spiritualità dell’epoca, da Dante,<br />
che visse la tragedia della sua vita, sognando l’avvento del Veltro;<br />
a Cola di Rienzo, nella cui vicenda la fiamma dell’aspettativa escatologica<br />
doveva dare gli ultimi bagliori; dalle travolgenti processioni<br />
dei flagellanti, che percorrevano litaniando tutte le contrade<br />
d’Italia, agli spirituali, che videro il loro effimero trionfo con l’elezione<br />
di Celestino V; ai fraticelli, che innestarono le aspettative del<br />
gioachimismo sul grande tronco del francescanesimo, sorto agli<br />
inizi del secolo XIII ed affermatosi nel paesaggio sconvolto della<br />
religiosità medievale”.<br />
In questo clima, affocato di passioni e di contrasti religiosi, di aspettative<br />
messianiche e chiliastiche, di aspirazioni francescane alla pace<br />
e al perdono, viene celebrato il grande giubileo del Trecento, indetto<br />
proprio dall’avversario giurato di Dante, Papa Bonifacio VIII.
Il poeta-teologo Dante, da credente e rispettoso delle “somme chiavi”,<br />
non poteva mancare al grande richiamo del grande perdono giubilare<br />
e da buon pellegrino, insieme alle migliaia che giungevano da<br />
ogni angolo d’Europa, si mette in cammino nel lungo ed estenuante<br />
viaggio verso Roma per lucrare l’indulgenza plenaria. Come tutti gli<br />
altri “romei”, anche lui, giunto sul Monte Mario o in vista della Città<br />
Eterna, avrà ricordato o ripetuto il famoso inno d’ammirazione e<br />
di gioia:<br />
O Roma nobilis, orbis et domina,<br />
Cunctarum urbium excellentissima,<br />
Roseo martyrum sanguine rubea,<br />
Alba et virginum liliis candida,<br />
Salutem dicimus tibi per omnia<br />
Te benedicimus: salve per saecula.<br />
Del resto, questi sentimenti del poeta-pellegrino appaiono dai<br />
versi che egli avrebbe stilato proprio per celebrare l’evento giubilare,<br />
quando nei vv. 103-108 del XXXI canto del Paradiso scrive con<br />
commozione:<br />
Qual’è colui che forse di Croazia<br />
Viene a veder la Veronica nostra,<br />
Che per l’antica fama non si sazia,<br />
Ma dice nel pensier, finché si mostra:<br />
Signor mio, Gesù Cristo, Dio verace<br />
Or fu sì fatta la sembianza vostra ?<br />
Mentre poco prima, nello stesso canto ai vv. 31-36, il poeta-romeo<br />
resta ammirato dei monumenti di Roma e della splendida dimora dei<br />
papi lateranensi quando, nelle vesti di un barbaro, di fronte all’antico<br />
Patriarchio lateranense, che superava in fasto ogni altra cosa al<br />
mondo, può esclamare, pur nel trapasso “al divino da l’umano, / a<br />
l’etterno dal tempo” del cielo Empireo:<br />
Se i barbari...<br />
Veggendo Roma e l’ardua sua opra,<br />
Stupefaciensi , quando Laterano<br />
A le cose mortali andò di sopra...<br />
Ma la prova provata della venuta di Dante a Roma durante l’Anno<br />
Santo del 1300 in veste di “romeo”, portando per distintivo, come<br />
tutti i “romei”, le insegne della chiavi papali incrociate sul mantello,<br />
secondo la lettura di molti dantisti, viene data dal poeta-pellegrino<br />
con i versi 28-33 del XVIII canto dell’Inferno, che recita:<br />
salvezza<br />
e<br />
culture<br />
Dante nel<br />
Sancta Sanctorum<br />
lateranense?<br />
365-382<br />
culture<br />
369
salvezza e<br />
culture<br />
MARIO CEMPANARI<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
culture<br />
370<br />
Come i Roman per l’essercito molto,<br />
l’anno del giubileo, su per lo ponte<br />
hanno a passar la gente modo colto<br />
che dal’un lato tutti hanno la fronte<br />
verso ‘l castello e vanno a Santo Pietro,<br />
dal’altra sponda vanno verso ‘l monte...<br />
Da questi versi sembrerebbe che Dante abbia osservato personalmente<br />
il curioso fenomeno della grande turba di pellegrini che vanno<br />
e vengono dalla basilica di S. Pietro, attraverso Ponte Sant’Angelo,<br />
in un duplice schieramento: da un lato tutti hanno la fronte o la<br />
faccia verso Castel Sant’Angelo e verso S. Pietro, mentre dall’altro<br />
lato, nel flusso verso il monte, tutti hanno la faccia verso il Monte<br />
Giordano, su cui troneggiava all’epoca la rocca degli Orsini e oggi<br />
sale in via di Panìco.<br />
Se questa prima visita di Dante può essere messa in dubbio, non<br />
lo è l’altra che egli fece per doveri di ufficio, quando in qualità di<br />
Priore di Firenze, nell’autunno del 1300, venne mandato alla corte<br />
di Roma di Bonifacio VIII per trattare con quel papa la posizione del<br />
partito guelfo dei bianchi nei confronti delle disposizioni teocratiche<br />
di papa Bonifacio a riguardo del governo della città. Infatti, è tradizione<br />
che nei giorni in cui Dante trattò con la Curia papale gli affari<br />
per i quali era stato mandato a Roma, egli fu ospite del palazzo degli<br />
Anguillara in Trastevere, oggi conosciuto come “Casa di Dante”<br />
e sede della Società di studi danteschi. In questo tempo, dunque, il<br />
poeta e politico Dante ebbe modo di conoscere la Curia romana e<br />
forse lo stesso pontefice. Certamente, però, ebbe modo di visitare il<br />
palazzo del Laterano, allora sede ufficiale dei papi, dove si svolgevano<br />
gli incontri ufficiali delle varie delegazioni di regnanti, di città<br />
e di ambasciatori che trattavano affari di Stato con la Santa Sede.<br />
Questa costatazione è assai importante ai fini della nostra ricerca,<br />
come vedremo in seguito.<br />
Ma un altro elemento di natura squisitamente politica dobbiamo<br />
prendere in considerazione, che, per una sorta di eterogenesi dei fini,<br />
ci fa conoscere il pensiero di Dante circa il valore e la stima che egli<br />
ebbe del papato. Anche se egli condivideva molti aspetti degli<br />
spirituali e della tradizione francescana, tesa al rinnovamento della<br />
Chiesa in senso spirituale, contro la corruzione morale e l’attaccamento<br />
al potere temporale allora dominanti e di alcuni eretici del<br />
suo tempo che insistevano sulla stessa direzione, deprecando inoltre<br />
la prevalenza nella gerarchia ecclesiastica, a partire dai papi, con
metodi e conduzione giurisdizionalistici della Chiesa, affatto pastorali,<br />
e per risolvere i gravi problemi dei rapporti tra Chiesa e Impero,<br />
Dante tuttavia si dissocia da questi indirizzi ereticali o radicali, escogitando<br />
una originale ed insolita teoria dei “due soli”. Nel torno di<br />
tempo in cui siamo e più esattamente nel periodo che Dante scriveva<br />
il trattato Monarchia, probabilmente scritto durante il tempo della<br />
redazione del Paradiso e comunque durante gli ultimi anni del<br />
poeta, si dibatteva vivacemente il problema del documento pseudo<br />
costantiniano, ritenuto all’epoca di Dante autentico, ed entrato nelle<br />
raccolte dei canoni che precedono il Decretum di Graziano,<br />
della legittimità della “donatio Constantini” e della conseguente<br />
“translatio Imperii”, secondo cui Costantino avrebbe donato al<br />
papato, nella persona di papa Silvestro I (314-335), la città di Roma<br />
con l’”occidentale regnum” a beneficio della Chiesa e dei poveri.<br />
I papi, in seguito, avrebbero fatto la “translatio imperii a Graecis<br />
in Germanos”, dando così inizio all’impero carolingio e alla discrezionalità<br />
della Chiesa di designare l’imperatore o di deporlo in base<br />
alla fedeltà verso la Chiesa stessa ed il papato.<br />
Nelle accese controversie che si vennero creando tra scrittori ecclesiastici<br />
e canonisti sostenitori dell’autenticità della donatio, con i<br />
contestatori o assertori della falsità del documento costantiniano, come<br />
i riformatori religiosi catari, valdesi, seguaci di Gioacchino da<br />
Fiore, si venne profilando la teoria di Marsilio da Padova (1280 ca.-<br />
1343), secondo il quale, nel testo fortemente polemico e decisamente<br />
antipapale “Defensor pacis”, pubblicato nel 1324, e nell’altro “Tractatus<br />
de translatione imperii”, una delle principali cause dei disordini<br />
e delle guerre contemporanee provengono dal papato. Marsilio,<br />
poi, formula una propria teoria del potere imperale, appoggiandosi<br />
alla tesi della Politica di Aristotele, affermando la preminenza del potere<br />
imperiale e dell’impero non solo indipendente dalla Chiesa, ma<br />
che lo stesso potere della Chiesa è soggetto al potere dell’impero e<br />
dell’imperatore. L’impero sarebbe come il sole che ha luce propria e<br />
da questa ne verrebbe illuminata la Chiesa per luce riflessa.<br />
Ad una posizione diametralmente opposta si colloca la teoria<br />
teocratica di Tolomeo da Lucca (al secolo Bartolomeo Fiadoni, 1236<br />
ca.- 1327), discepolo di S. Tommaso d’Aquino, di cui porta a termine<br />
l’incompiuto trattato De regimine principum. Il domenicano fra’<br />
Tolomeo, già priore di S. Maria Novella in Firenze, poi vescovo di<br />
Torcello, porta alle estreme conseguenze la dottrina affermata da<br />
Innocenzo IV (1243-1254), secondo il quale nel papa risiede la<br />
salvezza<br />
e<br />
culture<br />
Dante nel<br />
Sancta Sanctorum<br />
lateranense?<br />
365-382<br />
culture<br />
371
salvezza e<br />
culture<br />
MARIO CEMPANARI<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
culture<br />
372<br />
pienezza dell’autorità imperiale, anzi la “plenitudo potestatis” sia<br />
spirituale che temporale. Tolomeo scriveva il suo trattato quando<br />
Albrecht I d’Asburgo, detto Alberto Tedesco era candidato alla<br />
corona imperiale e mentre si svolgevano laboriose trattative tra il<br />
nuovo imperatore eletto e Bonifacio VIII, che si conducevano a<br />
Rieti nell’estate del 1298. In quest’occasione il fiero pontefice, che<br />
conosceva bene la dottrina dei canonisti, avrebbe detto - stando a<br />
quanto riferisce nella sua Cronaca Francesco Pipino e riportato dal<br />
Muratori - mentre era assiso sul soglio pontificio, la tiara sul capo<br />
con in cima al triregno d’oro una splendida pietra preziosa detta<br />
“il diadema di Costantino” e nella destra non solo le chiavi di<br />
S. Pietro, ma anche la spada, rivolto agli inviati di Alberto Tedesco:<br />
“Numquid ego sum pontifex ? Nonne ista est cathedra Petri ?<br />
Nonne possum Imperii iura tutari? Ego sum Caesar; ego sum<br />
Imperator”! Comunque sia - della veridicità di questo episodio -<br />
Tolomeo da Lucca teorizza la “plenitudo potestatis” del pontefice,<br />
facendo del papato l’unico sole nella cui orbita come satellite ruota<br />
l’imperatore e l’impero.<br />
Non mi soffermo su quanto argomenta Dante nel suo Monarchia<br />
per negare le due posizioni estreme sulla potestà papale, che direttamente<br />
o indirettamente poggiavano sul falso documento della<br />
“donatio”, ma la posizione del poeta-politico in materia si equidistanzia<br />
dalle due citate teorie. Egli, con grande acutezza, nel suo citato<br />
trattato, discute l’immagine biblica usata dai canonisti dei “duo<br />
luminaria magna” che Dio pose nel firmamento, facendo sua una<br />
dottrina astrologica assai diffusa allora, si sforza di dare valore alla<br />
similitudine della luce autonoma del sole e di quella riflessa della<br />
luna, osservando che anche la luna ha una propria e fievole luce<br />
diversa da quella del sole, ed avrà altresì una sua propria influenza.<br />
Ed arguisce che, nella sfera del potere, vi sono due soli, risplendenti<br />
ciascuno di luce propria. Siffatta insolita similitudine dovette essere<br />
suggerita allo spirito di Dante da quanto Aristotele, nel terzo libro<br />
delle Meteore, scriveva intorno ai fenomeni di perielio e da quanto<br />
ne riferivano i suoi commentatori, specialmente Alberto Magno, in<br />
un’opera più volte ricordata dall’Alighieri. E forse uno di questi<br />
fenomeni del perielio avrebbero potuto colpire l’animo del poeta,<br />
attento osservatore dei fatti della natura.<br />
Da quanto detto, dunque, appare chiaro quale fosse la considerazione<br />
in cui Dante teneva il potere papale ed i papi all’interno<br />
dell’ordinamento spirituale della Chiesa universale.
Ci resta da vedere, invece, ciò che il poeta pensa dei singoli<br />
pontefici e del loro comportamento etico-politico, se alcuni di loro li<br />
condanna inesorabilmente alla pena eterna.<br />
Il primo di tre papi simoniaci che Dante incontra in Malebolge è<br />
Niccolò III Orsini, che non indica con il suo nome pontificio, ma<br />
semplicemente alludendo al nome del suo casato quando afferma che<br />
fu “figliuol de l’orsa”: negli atti pubblici registrato in latino con de<br />
filiis Ursae. Forse papa Orsini è anche il primo papa che Dante<br />
incontra all’Inferno, almeno se non si ritiene che il poeta voglia<br />
alludere al rinunciatario papa Celestino V, quando parla del singolare<br />
personaggio “che fece per viltade il gran rifiuto” (Inf. III, 59).<br />
Ma chi era realmente l’uomo Niccolò III, al secolo Giangaetano<br />
Orsini? Appartenente al lignaggio romano, tanto potente quanto<br />
ramificato, degli Orsini, che aveva già dato al papato Celestino III<br />
(1191-1198), era figlio di Matteo Orsini detto Rosso e di Perna<br />
Gaetani, appartenente alla famiglia dei duchi di Gaeta. Matteo s’era<br />
messo in luce come uno dei capi del partito guelfo di Roma, oltre che<br />
come amico di Francesco d’Assisi, il quale, stando ad una tradizione,<br />
avrebbe predetto il pontificato per il piccolo Giangaetano. Nel<br />
1241 Matteo venne nominato segretario di Roma, mentre suo figlio<br />
Giovanni Gaetano nel 1244 venne creato da Innocenzo IV cardinale<br />
diacono di S. Niccolò in Carcere tulliano e seguì il papa a Lione. Sotto<br />
Alessandro IV (1254-1261), rafforzò la sua posizione di cardinale<br />
disinteressato, vivendo del proprio patrimonio, dedito allo studio e<br />
alla repressione delle eresie, come incaricato dell’ufficio di grande<br />
inquisitore, e divenendo protettore dell’Ordine dei Francescani.<br />
Il “cursus honorum” di Giangaetano andò sempre aggiungendo altri<br />
prestigiosi incarichi, anche di carattere diplomatico e politico, sapendo<br />
sempre imporsi abilmente come uomo dei compromessi: né troppo<br />
angioino, né eccessivamente guelfo. Nel 1276 era il cardinale più<br />
anziano e a lui si dovette l’elezione di papa Giovanni XXI (1276-1277),<br />
portoghese, papa che non era abbastanza politico da farsi dominare dal<br />
cardinale Orsini. Un simbolo della potenza regionale ramificata degli<br />
Orsini fu il fatto che, quando nel 1277 Giovanni venne eletto papa<br />
nel conclave tenutosi a Viterbo, il podestà della città era suo nipote<br />
Orso Orsini.<br />
Per essere giusti e a voler dire tutta la verità senza pregiudizi o passioni<br />
politiche di parte, né dando troppo ascolto al poco attendibile o<br />
tendenzioso cronista fiorentino del secolo XIII Giovanni Villani,<br />
bisogna riconoscere che i tempi del pontificato di Niccolò III erano<br />
salvezza<br />
e<br />
culture<br />
Dante nel<br />
Sancta Sanctorum<br />
lateranense?<br />
365-382<br />
culture<br />
373
salvezza e<br />
culture<br />
MARIO CEMPANARI<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
culture<br />
374<br />
difficili per molti problemi politici intricati e contrastanti che implicavano<br />
la compagine dell’impero germanico di Rodolfo di Asburgo,<br />
i rapporti con Carlo d’Angiò e gli Angioini e con il regno d’Aragona,<br />
oltre che con lo Stato della Chiesa, di cui mi sembra fuori luogo<br />
parlare in questa sede. Ma certamente nella valutazione politica di<br />
Dante fu estremamente grave il disegno di papa Orsini, che, stando<br />
almeno a quanto afferma Tolomeo da Lucca nella sua Historia<br />
Ecclesiastica nova scritta intorno al 1317, avrebbe avuto intenzione<br />
di suddividere l’impero in quattro parti: il regno di Germania, divenuto<br />
ereditario, sarebbe passato a Rodolfo; il regno di Arles sarebbe<br />
stato dato agli Angioini; l’ex regno d’Italia sarebbe stato smembrato<br />
in due nuovi regni: Toscana e Lombardia, che avrebbe assegnato ai<br />
suoi nipoti. Comunque sia di questo irrealizzato progetto, è certo che<br />
papa Niccolò si avvalse moltissimo dell’aiuto politico dei suoi<br />
nipoti cardinali Latino Frangipane Malabranca e Bertoldo Orsini, che<br />
favorì a sua volta concedendo loro benefici e possedimenti terrieri ed<br />
almeno sette castelli della Tuscia meridionale o del viterbese. Per questo<br />
papa Orsini si guadagnò il triste primato di essere additato come<br />
l’iniziatore del nepotismo papale ed accusato dal cronista Giovanni<br />
Villani che lo indica “de’ primi, o primo papa, nella cui corte s’usasse<br />
palese simonia per gli suoi parenti”. Tanto che a poca distanza<br />
dalla morte, il papa veniva raffigurato in caricature nell’atto di<br />
nutrire con oro e monete piccoli orsi che si arrampicavano sulle sue<br />
ginocchia. E questa è la grave colpa per la quale Dante lo mette tra<br />
i dannati nel girone dei simoniaci.<br />
Ma la figura reale di Niccolò III va ridimensionata in senso positivo<br />
per quanto operò di bene nel governo della Chiesa e di Roma<br />
in particolare. Egli infatti va considerato come il vero fondatore della<br />
residenza papale e dei Giardini Vaticani, da lui preferiti al vecchio<br />
palazzo lateranense. Inoltre a sue spese, come abbiamo accennato,<br />
fece restaurare o meglio ricostruire dalle fondamenta la collassata<br />
cappella papale del Sancta Sanctorum, portata a termine nel giro di<br />
due anni circa.<br />
A questo riguardo, possiamo mettere in evidenza lo stridente contrasto<br />
esistente tra la valutazione etico-politica del poeta Dante che<br />
mette Niccolò III all’inferno tra i simoniaci e la valutazione poeticopittorica<br />
che ne fa il pittore, il cosiddetto “Maestro del Sancta Sanctorum”<br />
(ma forse si tratta del grande affreschista e mosaicista Pietro<br />
Cavallini), che in uno smagliante riquadro degli affreschi all’interno<br />
della cappella palatina privata dei papi Sancti Laurentii de pa
latio ad Lateranum (poi detta Sancta Sanctorum), in uno splendido<br />
ritratto di papa Niccolò, dai lineamenti signorili, vestito coi solenni<br />
abiti pontificali, offre al Salvatore, nella rituale proskynesis, il modellino<br />
della cappella da lui restaurata, assistito dagli apostoli Pietro<br />
e Paolo, in piedi, come testimoni di un atto solenne. Se Dante mette<br />
tra i dannati papa Orsini a ludibrio dei secoli, il Maestro del Sancta<br />
Sanctorum esalta lo stesso papa Orsini all’ammirazione dei posteri.<br />
Non è da escludere<br />
che Dante abbia<br />
messo all’inferno<br />
Niccolò III per una<br />
valutazione politica dell’operato<br />
del pontefice, in quanto lo ritiene, sì, colpevole di simonia,<br />
ma perché questo causa lo smembramento dell’impero, come abbiamo<br />
visto. E per Dante l’unità dell’impero è qualcosa come strappare<br />
in pezzi la tunica inconsutile di Cristo. D’altra parte, sappiamo a quali<br />
brutte conseguenze può portare l’odio o la faziosità politica che onnubila<br />
non solo il buon senso comune, ma talvolta anche il giudizio<br />
critico degli storici.<br />
C’è ancora da fare un’altra considerazione sulla valutazione dantesca<br />
circa papa Niccolò. Il poeta si può considerare contemporaneo dei<br />
tre papi messi all’inferno per simonia e specialmente di papa Bonifacio<br />
e di Clemente V, dei quali conobbe i principali atti politici - e non quando<br />
erano ancora viventi - mentre di papa Niccolò ebbe certamente notizia,<br />
da uomo di grande cultura storica e politica, leggendo le cronache<br />
del tempo, specialmente quella del fiorentino Giovanni Villani, che per<br />
lo meno è tendenziosa nei confronti di papa Orsini.<br />
Ad ogni modo, andiamo a leggere quello che lo stesso Dante ci<br />
dice di papa Niccolò e dalle sue parole comprenderemo le ragioni della<br />
sua terribile sentenza di dannazione.<br />
Ecco il testo che ci interessa:<br />
Dante e Niccolò III Orsini<br />
“O qual che se’ che ‘l di su tien di sotto,<br />
anima trista come pal commessa”,<br />
comincia’ io a dir, “se puoi, fa motto”.<br />
Io stava come ‘l frate che confessa<br />
lo perfido assessin, che, poi ch’è fitto,<br />
richiama lui per che la morte cessa.<br />
salvezza<br />
e<br />
culture<br />
Dante nel<br />
Sancta Sanctorum<br />
lateranense?<br />
365-382<br />
culture<br />
375
salvezza e<br />
culture<br />
MARIO CEMPANARI<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
culture<br />
376<br />
Ed el gridò: “Se’ tu già costì ritto,<br />
se’ tu già costì ritto, Bonifazio?<br />
Di parecchi anni mi mentì lo scritto.<br />
Se’ tu sì tosto di quell’aver sazio<br />
per lo qual non temesti tòrre a ‘nganno<br />
la bella donna, e poi di farne strazio?”<br />
Tal mi fec’io, quai son color che stanno,<br />
per non intender ciò ch’è lor risposto,<br />
quasi scornati, e risponder non sanno.<br />
Allor Virgilio disse: “Dilli tosto:<br />
Non son colui, non son colui che credi”;<br />
e io rispuosi come a me fu imposto.<br />
Per che lo spirto tutti storse i piedi;<br />
poi, sospirando e con voce di pianto,<br />
mi disse: “Dunque che a me richiedi ?<br />
Se di saper ch’i’ sia ti cal cotanto,<br />
che tu abbi però la ripa corsa,<br />
sappi ch’i’ fui vestito del gran manto;<br />
e veramente fui figliuol de l’orsa,<br />
cupido sì per avanzar gli orsatti,<br />
che sù l’avere, e qui me misi in borsa.<br />
Di sotto al capo mio son gli altri tratti<br />
che precedetter me simoneggiando,<br />
per le fessure de la pietra piatti.<br />
Là giù cascherò io altressì quando<br />
verrà colui ch’i’ credea che tu fossi,<br />
allor ch’ i’ feci ‘l sùbito dimando.<br />
Ma più è ‘l tempo già che i piè mi cossi<br />
e ch’ io son stato così sottosopra,<br />
ch’el non starà piantato coi piè rossi:
ché dopo lui verrà di più laida opra,<br />
di ver’ ponente, un pastor sanza legge,<br />
tal che convien che lui e me ricopra.<br />
Nuovo Jasòn sarà, di cui si legge<br />
ne’ Maccabei; e come a quel fu molle<br />
suo re, così fia lui chi Francia regge”.<br />
(Inf. XIX, 46-87)<br />
Ho voluto riportare il lungo brano del canto, perché costituisce<br />
il cuore del canto stesso e anche per comprendere il linguaggio di<br />
persona colta, che sa usare l’allegoria o il confronto con personaggi<br />
ed episodi biblici, al quale Dante mette in bocca il lungo monologo<br />
e la delineazione della sua colpa simoniaca. Altra nota importante da<br />
sottolineare è il fatto che sia il pellegrino Dante che papa Niccolò,<br />
eccetto che per papa Bonifacio, non fanno mai esplicitamente nomi<br />
di papi, se non per allusioni al casato cui appartengono. La seconda<br />
parte del canto, invece, è una forte e vibrata rampogna contro<br />
l’avarizia e l’arricchimento di certi papi “ne la vita lieta”, culminante<br />
nella celebre terzina:<br />
Ahi, Costantin, di quanto mal fu matre,<br />
non la tua conversion, ma quella dote<br />
che da te prese il primo ricco patre!<br />
(Inf. XIX, 115-117)<br />
Da colto ed informato uomo politico, Dante non poteva ignorare<br />
chi era stato papa Orsini, almeno nei suoi tre anni di pontificato e<br />
quale la sua azione moderata nelle contese politiche dei regnanti del<br />
tempo. Quando papa Niccolò regnava, Dante era poco più che un ragazzo:<br />
contava infatti 14 anni circa e soltanto nel 1300, anno in cui<br />
egli fa il viaggio nei regni dell’oltre tomba, egli aveva 36 anni. Era<br />
dunque un uomo maturo, di vasta cultura, scrittore e poeta assai<br />
noto (la Vita Nuova la scrive dal 1292-1293 e le Rime dal 1292<br />
agli anni dell’esilio), di navigata esperienza politica. Non era certo<br />
mancante di forte acume critico e di indipendente giudizio. Tuttavia<br />
non si sottrasse agli influssi negativi di certa cronaca del tempo,<br />
quale fu quella, ad esempio, di Giovanni Villani.<br />
Di contro alla sentenza inappellabile di condanna di Dante nei<br />
confronti di papa Niccolò, conviene spezzare una lancia in difesa<br />
salvezza<br />
e<br />
culture<br />
Dante nel<br />
Sancta Sanctorum<br />
lateranense?<br />
365-382<br />
culture<br />
377
salvezza e<br />
culture<br />
MARIO CEMPANARI<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
culture<br />
378<br />
dell’Orsini. La storiografia moderna e contemporanea sulla figura di<br />
questo pontefice ha dato ampio spazio, forse troppo, al programma<br />
e all’attività politica di Niccolò, alimentando un topos ormai di<br />
maniera che lo vuole anticipatore e fautore del nepotismo rinascimentale<br />
e della simonia più sfacciata. Altre volte, invece, egli è stato<br />
esaltato per l’energica azione di sganciamento dalla subalternanza di<br />
Roma e dagli Stati della Chiesa all’egemonia francese e imperiale<br />
germanica. Un’altra non scarsa parte della storiografia ha messo in<br />
luce il mecenatismo e la febbrile attività edilizia del pontefice, che,<br />
nel breve tempo di tre anni, ha lasciato, qualitativamente, opere di<br />
alto valore artistico, sempre tenute in grande considerazione da<br />
posteri e studiosi.<br />
Le attività o la specifica funzione di questo papa non sufficientemente<br />
prese in considerazione, o solo marginalmente studiate dalla<br />
ristretta cerchia degli specialisti del settore, sono quelle esercitate nella<br />
liturgia e nel riordinamento amministrativo disciplinare, che, di riflesso,<br />
ebbero il loro peso negli eventi sociali e politici di un secolo<br />
quale il Duecento. Il dotto pontefice, infatti, era anche un esperto amministratore<br />
ed un amante della liturgia. Questo è l’aspetto che più<br />
preme sottolineare di questo pontefice, restauratore del Sancta Sanctorum,<br />
dove i pontefici celebravano in base ad antichi cerimoniali,<br />
solenni riti liturgici di Curia e le quotidiane salmodie.<br />
Va ricordato in particolare, a merito di papa Orsini, il fatto che egli<br />
fu il primo papa ad adottare il cosiddetto anulus piscatorius come aureo<br />
sigillo o timbro dei suoi atti ufficiali, in cui era inciso un giovane<br />
imberbe pescatore che tiene la canna e lenza da pesca, cui è preso<br />
all’amo un pesce. Inoltre, va rilevato che negli affreschi o nelle varie<br />
opere musive o bronzee contenute all’interno della cappella palatina<br />
non v’è traccia dell’esaltazione della famiglia Orsini, come invece<br />
si vorrebbe far credere da una certa storiografia che ritiene papa<br />
Niccolò dominato e innamorato dei suoi “orsatti”.<br />
In questo contesto, anche se non si può assolvere del tutto<br />
papa Orsini dal suo peccato, potrebbe essere mandato a scontarlo in<br />
qualche balza del Purgatorio!
Papa Nicolò e il “grande manto”<br />
del Sancta Sanctorum<br />
Tirando le fila di<br />
quanto siamo venuti<br />
dicendo in<br />
queste pagine, siamo arrivati<br />
al punto di dover<br />
dare la risposta alla domanda provocatoria da cui siamo partiti. Evidentemente<br />
dobbiamo tornare a parlare del problema se Dante abbia<br />
visitato e visto dal di dentro la cappella papale palatina, con i relativi<br />
affreschi del Magister del Sancta Sanctorum, che in quel torno di<br />
tempo erano stati da poco ultimati ed erano ancora, possiamo dire,<br />
freschi di calce.<br />
Intanto il periodo in cui Dante fu a Roma, nel 1300, non presenta<br />
difficoltà per la nostra ipotesi. In quel periodo, Dante visitò con<br />
ogni probabilità anche il palazzo lateranense, allora sede ufficiale dei<br />
papi, dove erano ricevute le ambascerie o avvenivano i contatti<br />
ufficiali della Santa Sede per motivi di Stato. Dante, se non incontrò<br />
di persona il suo odiato nemico papa Bonifacio, certamente fu a<br />
contatto con qualche esponente della Curia pontificia per trattare gli<br />
affari di cui era stato incaricato dalla Repubblica di Firenze e in<br />
particolare la posizione del partito dei guelfi bianchi nei confronti del<br />
papa. Entrò dunque all’interno del Patriarchio e non è da escludere<br />
che fosse introdotto anche nella cappella palatina riservata al<br />
pontefice, dove appunto si trovava (e si trova tuttora) il bellissimo<br />
riquadro di papa Niccolò in prosckynesis, che offre al Salvatore il<br />
modellino della cappella restaurata, come sopra abbiamo descritto.<br />
Ma il dipinto va ancora illustrato più nel dettaglio.<br />
Mentre nel riquadro destro della parete orientale o est che<br />
sovrasta l’altare si vede Cristo in trono che accetta con la destra il<br />
dono della cappella e con la sinistra regge una croce astile dorata, tra<br />
due angeli protesi verso gli angoli superiori del riquadro, alla sinistra<br />
nella stessa parete, separato da una monofora, si ammira un altro<br />
riquadro, che contiene in una equilibrata distribuzione di spazi e di<br />
figure, che solo un grande maestro sa fare, papa Niccolò vestito<br />
solennemente dei suoi abiti pontificali: sulla testa porta la tiara con<br />
duplice corona d’oro, da cui scende a destra e sinistra l’infula, sulla<br />
cuspide della tiara è collocato un diadema color rubino, alle mani che<br />
reggono il modellino porta dei guanti bianchi con al centro il suo<br />
stemma papale, mentre le mani dei due apostoli Pietro e Paolo sono<br />
nude; il volto del papa è ben modellato e si direbbe che è un<br />
vero e proprio ritratto di un uomo dai lineamenti distinti, signorili<br />
salvezza<br />
e<br />
culture<br />
Dante nel<br />
Sancta Sanctorum<br />
lateranense?<br />
365-382<br />
culture<br />
379
salvezza e<br />
culture<br />
MARIO CEMPANARI<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
culture<br />
380<br />
(era soprannominato, infatti, “il composto”), che ha superato i 60 anni,<br />
con un bell’incarnato roseo, gli occhi chiari, il naso e la bocca ben<br />
modellati; è vestito di un lungo camice bianco, con orlo delle maniche<br />
e del fondo del camice ornate da una banda color marrone; sulle<br />
spalle porta il tradizionale pallio; ai piedi calza delle pantofole di<br />
colore rosso. Ma ciò che più impressiona è il “grande manto” rosso,<br />
che copre tutta la persona. E’ questo, insieme al volto di papa Orsini,<br />
che fa più colpo nel visitatore e che caratterizza la sua figura. Nella<br />
simbologia pontificia, mentre il pallio indica la “pienezza del<br />
potere” nella dimensione ecclesiale e la tiara in quella temporale, il<br />
grande manto rosso - sempre nel simbolismo pontificio - significa il<br />
martirio di Cristo, fondamento cristico della funzione pontificia e di<br />
Colui che per noi rese rosso il suo indumento. I cerimoniali del XIII<br />
secolo segnalavano il colore rosso del manto con cui l’arcidiacono o<br />
il priore dei diaconi, nella cappella palatina, ammantava il neoeletto<br />
pontefice subito dopo l’elezione investendolo del pieno potere<br />
papale, spirituale e temporale.<br />
Se Dante vide questo affresco non poté non rimanere impressionato<br />
dal manto che copriva papa Orsini e non poteva non menzionarlo<br />
quando lo vide povero dannato scalpitante nel suo inferno. E il simbolismo<br />
del “gran manto” scarlatto pontificio doveva doppiamente<br />
bruciare sulle spalle del simoniaco pontefice. Il “gran manto”, dunque,<br />
è messo in risalto da Dante per indicare non solo il gravissimo<br />
peccato di simonia, ma la compromissione dell’altissima carica istituzionale<br />
del pontefice che utilizzò la potenza o potestà spirituale e<br />
finanziaria pontificia per arricchire i suoi parenti “orsatti”, e, contro<br />
il suo scopo istituzionale, defraudando quelle ricchezze destinate ai<br />
poveri e a vantaggio della Chiesa stessa.<br />
Così, in una certa misura, anche in questo caso si realizza la legge<br />
dantesca del contrappasso: il “gran manto”, che simboleggia la pienezza<br />
del potere papale ed investe Niccolò III della suprema dignità<br />
ed onore pontificio, diventa per lui il tormento e il dolore che lo<br />
copre per i secoli nella buca dei dannati simoniaci “piantato coi<br />
piè rossi”.<br />
Le amare e dolenti parole del pontefice-simoniaco Orsini, trovano<br />
il controcanto del poeta-pellegrino Alighieri in una forte e vibrata<br />
rampogna nella chiusura del XIX canto, a suggello del contrappasso.
DANTE IN THE LATERAN SANCTA SANTORUM?<br />
ENG<br />
A not so wishful thinking hypothesis.<br />
By Mario Campanari.<br />
The research undertaken by the author of this article, who moves<br />
just a few steps behind “Dante’s Hell,” immerses us into a lively and<br />
dramatic period of the history of the Church. The author presents it<br />
to us in a using the contributions of a number of people known to<br />
him through the ample research they have conducted into the history<br />
of Lateran “Sancta Santorum.”<br />
DANTE, ¿EN EL SANCTA SANCTORUM LATERA-<br />
ESP<br />
NENSE?<br />
Una hipótesis no demasiado fantástica.<br />
De Mario Cempanari.<br />
La investigación llevada a cabo por el autor de este artículo, que se<br />
mueve por algunos pasos del Infierno de Dante, nos sumerge en un<br />
período vivo y dramático de la historia de la Iglesia. El autor nos lo<br />
presenta utilizando diversas aportaciones que él conoce de primera<br />
mano por la amplia investigación que ha realizado en torno a la<br />
historia del Sancta Sanctorum Lateranense.<br />
DANTE IM SANCTA SANCTORUM LATERANENSE?<br />
GER<br />
Eine nicht unbedingt fantastische Hypothese<br />
von Mario Cempanari<br />
Die Analyse, die der Autor in diesem Artikel durchführt, nimmt ihren<br />
Ausgang bei einigen Stellen aus Dantes Inferno und führt uns in<br />
einen sehr ereignisreichen und dramatischen Abschnitt der<br />
Kirchengeschichte. Er beschreibt diesen durch verschiedene<br />
Beiträge, die ihm durch die umfassende Erforschung der Geschichte<br />
des Sancta Sanctorum Lateranense zugänglich geworden sind.<br />
salvezza<br />
e<br />
culture<br />
Dante nel<br />
Sancta Sanctorum<br />
lateranense?<br />
365-382<br />
culture<br />
381
salvezza e<br />
culture<br />
MARIO CEMPANARI<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
culture<br />
382<br />
DANTE W SANCTA SANCTORUM NA LATERANIE?<br />
Hipoteza dość prawdopodobna.<br />
Mario Cempanari<br />
POL<br />
Badania przeprowadzone przez autora tego artykułu, które opierają<br />
się na fragmentach z “Piekła” Dantego, wyłania się żywy i dramatyczny<br />
obraz dziejów Kościoła. Autor ukazuje go posługując się<br />
danymi, do których dotarł dzięki szeroko zakrojonym badaniom nad<br />
historią Sancta Sanctorum Lateranense.
di TITO AMODEI<br />
Si ritiene questa quattordicesima Biennale di arte sacra di<br />
S.Gabriele come una vittoria conseguita sulle molte difficoltà<br />
che si frapponevano al futuro di questa straordinaria istituzione.<br />
Le difficoltà sono state superate grazie agli sforzi fatti dalle<br />
autorità della Congregazione dei<br />
<strong>Passio</strong>nisti e la collaborazione dei<br />
critici e dei tanti appassionati del<br />
non facile problema del sacro<br />
che si faccia coinvolgere dall’arte<br />
contemporanea.<br />
L’autore di queste note si concede<br />
delle riflessioni che tendono a<br />
dare un contributo di corretta<br />
lettura di quanto sta accadendo in<br />
questo settore.<br />
QUATTORDICESIMA<br />
BIENNALE<br />
DI ARTE SACRA<br />
DI S. GABRIELE<br />
ono davvero tante quattordici Biennali di arte sacra<br />
in Italia. Se questa manifestazione sull’arte sacra ha<br />
raggiunto una quota così alta vuol dire pure qualcosa.<br />
Quattordici, per sé non è una cifra eccessivamente<br />
alta; è alta però se consideriamo il tema che a<br />
questi numeri viene abbinato. Vuol significare, vuol<br />
dire che non é vero che, nella cultura ufficiale, il<br />
sacro debba necessariamente essere messo all’angolo. Quando<br />
questo è accaduto una non ardua sociologia ce lo spiega abbondantemente.<br />
Riducendone le cause a due principali fattori: il percorso<br />
spesso estremo della ricerca artistica dell’ultimo secolo e la disinvolta<br />
opzione per il deprimente kitsch per la copertura del fabbisogno<br />
liturgico. L’edizione di questa Biennale era fortemente in<br />
forse perché nel giro di circa due anni sono state recise le radici, o<br />
meglio, i motori che l’avevano fondata, sostenuta ed allargata e cioè<br />
salvezza<br />
e<br />
culture<br />
Quattordicesima<br />
biennale di arte sacra<br />
di S.Gabriele<br />
383-389<br />
culture<br />
383
salvezza e<br />
culture<br />
TITO AMODEI<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
culture<br />
384<br />
LUIGI ONTANI, San Paolo folgorato fortunato d’apres Caravaggio, 2008,<br />
fotografia su carta, Ø cm 90<br />
il p. Adriano di Bonaventura, passionista e il salesiano Don Carlo<br />
Chenis, poi vescovo di Tarquinia/Civitavecchia. La tenacia e l’energia<br />
del p. Adriano, in questi quasi trent’anni ne hanno fronteggiato<br />
tutti gli urti immaginabili: pratici, economici e soprattutto ideologici.<br />
Dentro e fuori il proprio ambiente, sfidando resistenze culturali e<br />
l’inerzia delle istituzioni.<br />
Ma che avesse ragione e che avesse visto giusto stanno queste quattordici<br />
edizioni della Biennale a testimoniarlo.<br />
Ancora un altro grande merito gli va riconosciuto, quello di aver<br />
sempre affidato la conduzione delle varie edizioni della Biennale a<br />
curatori di accertata competenza. Non di rado ai massimi del settore<br />
e ai quali non ha mai chiesto attestati di ortodossia.
Infine volle l’appoggio culturale, la competenza e l’entusiasmo del<br />
salesiano Carlo Chenis (1994), in seguito vescovo di Tarquinia<br />
Civitavecchia, deceduto prematuramente il 19 marzo 2010.<br />
Dopo una simile mutilazione e con sempre i più ridotti aiuti economici<br />
non essersi fermati e aver coraggiosamente voluta un’altra<br />
edizione della Biennale, ha del miracoloso.<br />
Va dato atto al coraggio dei superiori religiosi, ma non si può<br />
non sottolineare la tenacia ammirevole e gli sforzi quasi miracolosi<br />
del giovane Giuseppe Bacci (da anni assistente del p. Adriano),<br />
il quale oltre a farsi carico dell’organizzazione della Biennale<br />
come prodotto culturale, non risparmia fatiche per il peso di metterla<br />
in piedi.<br />
E’ stata sua anche la cura del magnifico catalogo, nel quale tutte<br />
le opere di tutti gli artisti sono riprodotte. Al quale catalogo non ha<br />
fatto mancare una preziosa messa a punto delle ragioni che supportano<br />
l’attuale Biennale che si farebbe garante delle altre a venire.<br />
L’edizione di questa biennale si presenta con un’altra coraggiosa<br />
iniziativa: ha convocato ben quindici curatori richiamando più di una<br />
delle edizioni passate e tra questi dei critici che hanno segnato la storia<br />
di questi ultimi cinquanta anni.<br />
Una formula, questa, di mettere a confronto critici di diverso e, a<br />
volte, opposto indirizzo doveva dare un panorama il più possibile<br />
completo della vigente temperie culturale nel settore dell’arte.<br />
Dalla parte della direzione della Biennale è stato compiuto un<br />
gesto di rispetto delle diverse competenze e da quella dei curatori un<br />
attestato di reciproca stima.<br />
Ma oltre tutte queste considerazioni dobbiamo dedurre, in maniera<br />
compiaciuta, che il tema sacro, nelle cultura, non è bandito, non<br />
è scaricato o escluso dalla cultura viva e vigente. Può ancora interessare<br />
e coinvolgere la cultura, anche la più avanzata; se il sacro,<br />
quello vero, è sempre presente nei comportamenti umani.<br />
Come hanno risposto gli artisti convocati da tali critici?<br />
Il tema di questa quattordicesima edizione, tema suggerito da<br />
Chenis, sono le Beatitudini.<br />
Tema molto intrigante e, ovviamente, spiritualmente altissimo.<br />
Ma un tema senza racconto; un tema che deve essere dentro e che è<br />
quasi impossibile narrare. Per cui il titolo apposto alle opere presentate<br />
può apparire o appare pretestuoso.<br />
Pochi hanno raccontato (magari anche figurativamente) qualcosa<br />
che atteneva al tema. La maggior parte hanno coraggiosamente pre-<br />
salvezza<br />
e<br />
culture<br />
Quattordicesima<br />
biennale di arte sacra<br />
di S.Gabriele<br />
383-389<br />
culture<br />
385
salvezza e<br />
culture<br />
TITO AMODEI<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
culture<br />
386<br />
sentato il proprio lavoro, la propria ricerca, il proprio linguaggio al<br />
quale poi hanno apposto uno dei titoli del tema.<br />
Una convergenza strana: il tema non si prestava ad essere sceneggiato<br />
e l’artista coerente deve e vuole proporre il proprio linguaggio.<br />
Qui una riflessione sul binomio arte e sacro si impone.<br />
La lunga storia dell’impiego dell’arte nella Chiesa e, se vogliamo,<br />
della promozione della fede attraverso l’arte è stata sempre<br />
vissuta sul racconto illustrato o sulla verità di fede riproposta<br />
per allegorie, simboli sempre rintracciabili in “figure” prese dall’immaginario<br />
disponibile nella cultura vigente. Per cui il fedele, ma<br />
soprattutto la gerarchia, avevano elevato a strumento esplicativo la<br />
ricostruzione, la traduzione dei concetti dottrinali in stereotipi i<br />
quali, a lungo andare, identificavano la dottrina con la sua visibilità,<br />
nel racconto e la mimesi.<br />
In questa Biennale, come in genere anche nelle precedenti, il<br />
racconto, la rappresentazione non ci poteva essere quando si tiene<br />
conto del percorso linguistico dell’arte di oggi. Gli artisti presentano<br />
il loro quadro, la loro scultura e si industriano a farli combaciare,<br />
nei titoli, al tema dato. Ma quei quadri, quelle sculture, giudicati<br />
col metro della cultura tradizionale della Chiesa, dei fedeli, o del<br />
concetto stesso del sacro acquisito non sa a chi riferirli, a quale<br />
mistero del proprio credo attribuirli.<br />
Qualcosa di analogo è accaduto nella recezione dei nuovi<br />
Lezionari apprestati dalla CEI. La Cei ha avuto il grande merito di<br />
coinvolgere artisti anche celebratissimi per rendere quella edizione<br />
veramente aggiornata, immessa nel circuito della cultura più viva.<br />
Ovvio che la qualità dei singoli interventi non sempre è sostenuta.<br />
Ma a fronte delle illustrazioni convenzionali dei libri liturgici del<br />
passato/l’operazione è da considerare encomiabile.<br />
Torniamo alla Biennale di S. Gabriele. L’interrogativo potrebbe<br />
essere il seguente. Se il linguaggio espressivo corrente è quello della<br />
cultura più viva, se questo linguaggio è prima di tutto una autentica<br />
manifestazione del vissuto contemporaneo e viene ritenuto da quelli<br />
che lo esprimono come una confessione sacrale, si devono fare<br />
degli sforzi per sintonizzarsi con loro per riceverne il messaggio e<br />
per non essere tagliati fuori da un sacro davvero vivo che ci viene<br />
proposto dalle sentinelle attente della spiritualità da cui siamo tutti<br />
permeati. Altrimenti il rischio che si corre è il pericoloso divorzio<br />
dalla vita più viva.<br />
Se gli artisti non hanno voluto mentire dobbiamo riconoscere che
nelle loro opere hanno confessato il loro sentire sacro, il loro essere<br />
sacri. E che il sacro di oggi non si racconta più con formule obsolete.<br />
Anzi che il sacro oggi dobbiamo scorgerlo nelle forme da loro<br />
espresse. Quelle superfici delle loro tele, quelle forme delle loro<br />
sculture più che raccontare il sacro come illustrazione di un articolo<br />
di fede dicono prima di tutto del sacro che è dentro ciascuno di noi.<br />
Il racconto esplicito ne potrebbe sminuire o frastornare l’immediata<br />
trasmissione di quello che veramente sono.<br />
Se si vuole dare una proiezione esterna artistica questa va inseguita<br />
maggiormente nel gesto e materia che devono precedere la<br />
narrazione o la mimesi. Impresa ardua perché tutta l’arte sacra è<br />
bloccata dalla secolare convivenza col racconto e l’illustrazione.<br />
Si deve convenire che l’opera d’arte scaturisce da un ascolto,<br />
spesso ignoto e inesplorato dallo stesso artista. Egli potrà anche<br />
imporsi il tema e attenersi ad uno stile sul quale ha orientato il suo<br />
linguaggio espressivo, ma a quel linguaggio non risponderà mai il<br />
risultato che si prefigge: gli sfuggirà la connessione tra l’emozione<br />
di partenza (e di contenuto) e i risultati linguistici. Cosi l’artista è<br />
costretto a leggere il suo prodotto spostando l’attenzione dal piano<br />
razionale a quello emotivo e poetico. Se ne deduce che molta dell’arte<br />
contemporanea ha tutti i requisiti per accostarsi al sacro, ma<br />
richiede al fruitore la disponibilità a fare buona lettura dei suoi<br />
linguaggi evitando di confrontarli con quelli del passato perché quel<br />
passato non ci appartiene più. Un passato grandioso, un passato<br />
della memoria. Ma vita la viviamo oggi.<br />
Il contributo dei critici curatori è consistito prima di tutto nella<br />
scelta degli artisti ritenuti capaci di testimoniare nelle loro opere, il<br />
sacro, oggi. Ma più di uno ha dato anche qualche contributo di idee<br />
o ha suggerito delle proposte operative.<br />
Ritengo utile l’indicazione di Calvesi il quale sostiene che l’arte<br />
sacra debba risposarsi con l’architettura delle chiese per ritrovare la<br />
sua casa e diventare organica al culto.<br />
Giorgio di Genova torna sul suo antico convincimento che solo<br />
l’aniconico sarebbe il vero linguaggio del sacro.<br />
E chiudiamo sottolineando l’entusiasmo di Giuseppe Billi per il<br />
Saulo caduto da cavallo, estrapolato dal Caravaggio di S. Maria del<br />
Popolo in Roma da Luigi Ontani, che si sostituisce al Santo nella<br />
foto che pubblichiamo ad illustrazione di queste riflessioni.<br />
salvezza<br />
e<br />
culture<br />
Quattordicesima<br />
biennale di arte sacra<br />
di S.Gabriele<br />
383-389<br />
culture<br />
387
salvezza e<br />
culture<br />
TITO AMODEI<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
culture<br />
388<br />
THE 14 TH BIENNIAL OF SACRED ART AT THE<br />
SHRINE OF ST. GABRIEL<br />
By Tito Amodei, C.P.<br />
This fourteenth Biennial of Sacred Art at St. Gabriel’s is considered<br />
a victory obtained over so many difficulties which seemed to be<br />
threatening the future of this extraordinary institution. Such<br />
difficulties were overcome thanks to the efforts of the authorities of<br />
the <strong>Passio</strong>nist Congregation together with the collaboration of art<br />
critics and a great many enthusiasts of the none too easy problem<br />
of the sacred in contemporary art.<br />
The author of this note has granted us some reflections which<br />
tend to provide a contribution for the correct reading of all that is<br />
transpiring in this sector.<br />
DÉCIMOCUARTA BIENAL DE ARTE SAGRADO DE<br />
SAN GABRIEL.<br />
De Tito Amodei.<br />
Se considera esta décimocuarta Bienal de arte sagrado de San<br />
Gabriel como una victoria conseguida superando las muchas<br />
dificultades que se sobreponían al futuro de esta extraordinaria<br />
institución. Las dificultades fueron superadas gracias a los<br />
esfuerzos hechos por las autoridades de la Congregación de los<br />
Pasionistas y a la colaboración de los críticos y de tantos apasionados<br />
que están interesados en el problema nada fácil de que lo sagrado<br />
esté vinculado al arte contemporáneo. El autor de estas notas<br />
propone unas reflexiones que tienden a ofrecer una contribución de<br />
lectura correcta de cuanto está sucediendo en este sector.<br />
VIERZEHNTE BIENNALE DER ARTE SACRA DI<br />
SAN GABRIELE<br />
von Tito Amodei<br />
ENG<br />
ESP<br />
GER<br />
Diese vierzehnte Biennale der Arte Sacra di San Gabriele kann als<br />
Sieg über die vielen Hindernisse gelten, die der Zukunft dieser so
herausragenden Institution im Wege standen. Dank des<br />
Engagements der Kongregationsleitung der <strong>Passio</strong>nisten sowie der<br />
Mitarbeit von Kritikern und vielen Liebhabern der Biennale konnten<br />
die Schwierigkeiten überwunden werden, die mit dem nicht einfachen<br />
Vorhaben verbunden sind, die zeitgenössische Kunst für das<br />
Heilige zu öffnen.<br />
Der Autor will mit seinen Überlegungen einen Beitrag zu einem besseren<br />
Verständnis dafür leisten, was sich in diesem Kulturbereich<br />
ereignet.<br />
CZTERNASTE BIENNALE SZTUKI SAKRALNEJ W<br />
POL<br />
S. GABRIELE<br />
Tito Amodei<br />
Można uznać to czternaste Biennale sztuki sakralnej w S. Gabriele<br />
za zwycięstwo nad wieloma przeciwnościami, które zagroziły przyszłości<br />
tej wspaniałej instytucji. Trudności zostały przezwyciężone<br />
dzięki wysiłkom władz Zgromadzenia Pasjonistów i współpracy<br />
krytyków oraz wielu osób zafascynowanych niełatwym problemem<br />
sacrum, które wkracza na teren sztuki współczesnej.<br />
Autor tych spostrzeżeń snuje refleksję, która ma na celu ułatwienie<br />
poprawnej lektury wydarzeń na tym polu.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
Quattordicesima<br />
biennale di arte sacra<br />
di S.Gabriele<br />
383-389<br />
culture<br />
389
di ELISABETTA VALGIUSTI<br />
Il premio Oscar per il film straniero 2010 è andato al film<br />
argentino El secreto de sus ojos, del regista di origini italiane<br />
Juan Josè Campanella. E’ un riconoscimento adeguato a un<br />
film di grande qualità che porta sullo schermo una storia drammatica<br />
in cui vengono rappresentati il valore dei sentimenti e<br />
l’importanza dell’esperienza<br />
umana attraverso la memoria. Il<br />
film ha caratteristiche che non si<br />
trovano nel panorama odierno<br />
cinematografico, popolato da<br />
figure più o meno virtuali in storie<br />
da favola o da incubo.<br />
MISTERO<br />
E MISTERI<br />
DELLA<br />
MEMORIA<br />
l segreto dei suoi occhi (El secreto de sus ojos) è il film del<br />
regista argentino Juan José Campanella con un cast di ottimi<br />
attori come Ricardo Darín, Soledad Villamil, Guillermo Francella,<br />
José Luis Gioia, Pablo Rago. E’ un film sulla memoria<br />
di un uomo, memoria dei fatti cruciali della sua vita, degli<br />
avvenimenti o dell’avvenimento che pensa lo abbiano<br />
spinto a prendere una direzione piuttosto che un’altra. Una<br />
memoria che l’uomo mette in discussione, elabora, affronta, ottenendo<br />
una qualche liberazione, un possibile superamento degli errori,<br />
la ricerca di una verità, cercando l’occasione di riscattarsi da quanto<br />
rimasto insoluto e riprendersi quanto mancato.<br />
Benjamin Esposito, interpretato dall’ottimo Ricardo Darin, è un<br />
investigatore del tribunale ormai in pensione che sente la necessità<br />
di scrivere un romanzo ispirandosi a un caso giudiziario di cui si era<br />
occupato.<br />
Il corpo della vicenda si svolge a Buenos Aires nei primi anni ’70,<br />
quando cominciano i primi cambiamenti che porteranno alla dittatura<br />
militare. Nell’ufficio di un odioso giudice del tribunale, lavora<br />
salvezza<br />
e<br />
culture<br />
Mistero e misteri<br />
della memoria<br />
391-396<br />
culture<br />
391
salvezza e<br />
culture<br />
ELISABETTA VALGIUSTI<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
culture<br />
392<br />
Esposito con il collega e<br />
amico Pablo Sandoval.<br />
Giunge a dirigere l’ufficio<br />
la splendida e serissima<br />
Irene di cui Esposito<br />
si innamora profondamente<br />
senza trovare mai<br />
il coraggio di dichiararsi.<br />
Un giorno Esposito, per la<br />
defezione di un collega<br />
scansafatiche della sezione<br />
omicidi competente,<br />
viene costretto ad occuparsi<br />
del caso Morales.<br />
Giunto sulla scena del<br />
delitto, Esposito trova<br />
una giovanissima donna,<br />
Liliana, che è stata violen-<br />
tata e poi assassinata brutalmente.<br />
Il corpo sfigurato della giovane è riverso in maniera scomposta<br />
per terra, i suoi occhi sono rimasti aperti. Esposito fissa quegli occhi<br />
e non li dimenticherà più. Inoltre, viene profondamente colpito<br />
dal dolore dell’inconsolabile Ricardo Morales, il giovane marito di<br />
Liliana. L’indagine è aperta e il collega scansafatiche della sezione<br />
omicidi fa arrestare e confessare a suon di botte due muratori che<br />
lavoravano nei pressi della casa di Liliana. Esposito riesce a farli<br />
liberare denunciando il collega che viene punito e spostato in altra<br />
sede e inimicandosi il giudice per cui lavora che non ha nessun interesse<br />
a risolvere il caso e vuole solo chiuderlo. Esposito e Sandoval<br />
continuano a cercare l’assassino, hanno dei sospetti su un compagno<br />
di scuola di Liliana ma non riescono a trovarlo. I due si espongono<br />
nell’indagine e sono scoperti dal giudice che non li caccia via a<br />
patto che il caso venga archiviato.<br />
Ma Esposito non demorde. Grazie alla sua intuizione e a un’ idea<br />
di Sandoval riesce ad acciuffare l’assassino allo stadio, fra la folla<br />
dei tifosi. L’interrogatorio dell’indagato Isidoro viene condotto con<br />
abilità da Irene che lo provoca con astuti commenti fino a scatenare<br />
la sua reazione. Isidoro aggredisce Irene e la colpisce mentre<br />
confessa il suo delitto a gran voce. Il caso è chiuso.<br />
Ricardo, il marito di Liliana, nel frattempo aveva cercato l’assas
sino in vari modi. Il suo desiderio<br />
di giustizia si placa,<br />
visto che a Isidoro sarà sicuramente<br />
inflitto l’ergastolo.<br />
Ma le cose non vanno<br />
così.<br />
Isidoro sarà ben presto liberato<br />
e armato dai servizi<br />
segreti. La vicenda assume<br />
contorni tristissimi come i<br />
fatti avvenuti in Argentina in quegli anni. Il buon Sandoval viene assassinato<br />
al posto di Esposito che viene costretto a cambiare sede allontanandosi<br />
definitivamente da Irene.<br />
Sono passati più di vent’anni quando Esposito comincia a scrivere<br />
il romanzo e rivede Irene che è sposata con figli. La donna non è<br />
felice ed ama ancora Esposito. Il romanzo che l’uomo sta scrivendo<br />
ha a che fare con la memoria, la memoria di un assassinio, di<br />
un’indagine interrotta, di una giustizia negata, ma anche di un amore<br />
rimasto sospeso. In effetti, il caso viene riaffrontato e si scoprono<br />
come sono andate a finire le cose. E’ una scoperta inaspettata con un<br />
pesante sapore giustizialista ma umanamente comprensibile.<br />
Allo stesso tempo, essere arrivato al fondo della vicenda è una<br />
novità importante per Esposito che trova finalmente la forza per<br />
dichiarare il suo amore a Irene.<br />
La storia del film è tratta dal romanzo di Eduardo Sacheri, che ha<br />
collaborato alla sceneggiatura insieme al regista Campanella, che è<br />
anche autore del montaggio. L’abilità del regista sta nel saper<br />
cambiare diversi registri, dal noir alla commedia amorosa al thriller,<br />
senza intaccare l’ efficacia del racconto e la credibilità dei personaggi<br />
e dando grande vitalità alla vicenda.<br />
La splendida recitazione e gli ottimi dialoghi danno al film una<br />
grande carica di umanità e di realismo. Gli attori sono tutti interessantissimi<br />
e perfettamente calati in personaggi originali e credibilissimi.<br />
La fotografia di Felix Monti ha toni cupi e caldi che rafforzano<br />
l’ insidia e il mistero. Le musiche originali sono di Federico Jusid ed<br />
Emilio Kauderer. I costumi sono di Cecilia Monti.<br />
Il regista Campanella ha affermato che nel film gli interessava occuparsi<br />
di una storia comune, della storia di un uomo che ti cammina<br />
accanto, che ti potrebbe capitare di fissare negli occhi e di conoscere<br />
i segreti della sua vita. In particolare, il regista ha dichiarato:<br />
salvezza<br />
e<br />
culture<br />
Mistero e misteri<br />
della memoria<br />
391-396<br />
culture<br />
393
salvezza e<br />
culture<br />
ELISABETTA VALGIUSTI<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
culture<br />
394<br />
“Un vecchio che mangia da solo. E’ stata questa immagine a catturarmi<br />
e, alla fine, a farmi prendere in considerazione il romanzo. Non<br />
il crimine. O la suspense. O il genere. Il vecchio che mangia da solo.<br />
Come fa una persona a ritrovarsi sola nella vita? Quel vecchio si chiede<br />
come è finito a mangiare solo in un bar senza nessuno accanto?<br />
Lo si può ignorare, dimenticare o nascondere per un po’, ma il passato<br />
finisce per ripresentarsi.” Le parole del regista suonano scontate<br />
ma rivelano in parte il segreto del suo film e del suo successo: mostrare<br />
il realismo della vita con i misteri che la vita contiene. Per questo,<br />
il film ha un sapore antico come quello di storie conosciute che<br />
non si dimenticano. Dall’altra parte, la riflessione del film sui misteri<br />
insiti nella realtà rimane in una dimensione tutta umana senza grandi<br />
slanci. Nella storia di Esposito la memoria elabora sentimenti e<br />
fatti seguendo un comprensibile desiderio di felicità, giustizia, verità,<br />
ma senza andare oltre o senza andare nel profondo di tale memoria,<br />
limitando così l’approccio alla conoscenza del mistero e impoverendo<br />
i risultati della ricerca umana.<br />
“Ecco quanto ho spaziato nella mia memoria alla tua ricerca,<br />
Signore; e fuori di questa non ti ho trovato. Nulla, di ciò che di te ho<br />
trovato dal giorno in cui ti conobbi, non fu un ricordo; perché dal<br />
giorno in cui ti conobbi, non ti dimenticai. Dove ho trovato la verità,<br />
là ho trovato il mio Dio, la Verità persona; e non ho dimenticato<br />
la Verità dal giorno in cui la conobbi. Perciò dal giorno in cui ti<br />
conobbi, dimori nella mia memoria, e là ti trovo ogni volta che ti<br />
ricordo e mi delizio di te. È questa la mia santa delizia, dono della<br />
tua misericordia, che ebbe riguardo per la mia povertà” 1 .<br />
1 S. Agostino, Le Confessioni, 1024, 24, 35 (www.clerus.org/bibliaclerusonline/it/btt.htm).
ENG<br />
MYSTERY AND THE MYSTERIES OF MEMORY<br />
By Elisabetta Valgiusti<br />
The 2010 Oscar prize for a foreign film was awarded to the<br />
Argentine film “El Secreto de tus Ojos” (‘The Secret of your Eyes’)<br />
directed by Juan José Campanella, born in Italy. The Oscar was a<br />
fitting recognition of a high quality film which takes to the screen a<br />
dramatic story which presents the value of feelings and the importance<br />
of human experience through memory. This film has characteristics<br />
which are not found in today’s movie production, populated<br />
by more or less virtual figures in fairy tales and horror films.<br />
ESP<br />
MISTERIO Y MISTERIOS DE LA MEMORIA<br />
De Elisabetta Valgiusti<br />
El premio Oscar a la película extranjera del año 2010 se ha concedido<br />
a la película argentina “El secreto de sus ojos”, del Director,<br />
de origen italiano, Juan José Campanella. Es un reconocimiento<br />
adecuado a una película de gran calidad que lleva a la pantalla una<br />
historia dramática en la que se representan el valor de los sentimientos<br />
y la importancia de la experiencia humana a través de la<br />
memoria. La película tiene características que no se encuentran en<br />
el panorama cinematográfico actual, plagado de figuras más o<br />
menos virtuales en historias de fábula o de pesadilla.<br />
GER<br />
GEHEIMNIS UND GEHEIMNISSE IM GEDÄCHTNIS<br />
di Elisabetta Valgiusti<br />
Den Oskar für den besten ausländischen Film erhielt 2010 der<br />
argentinische Beitrag El secreto de sus ojos (Das Geheimnis ihrer<br />
Augen) des Regisseurs italienischer Abstammung Juan-Josè<br />
Campanella. Hier fand ein Film mit großer Qualität Anerkennung,<br />
der eine dramatische Geschichte ins Bild bringt, in der die<br />
Bedeutung der Gefühle und die Wichtigkeit der menschlichen<br />
Erfahrung durch das Gedächtnis gezeigt wird.<br />
salvezza<br />
e<br />
culture<br />
Mistero e misteri<br />
della memoria<br />
391-396<br />
culture<br />
395
salvezza e<br />
culture<br />
ELISABETTA VALGIUSTI<br />
SapCr XXV<br />
LUGLIO-SETTEMBRE 2010<br />
culture<br />
396<br />
MISTERIUM I TAJEMNICE PAMIĘCI<br />
Elisabetta Valgiusti<br />
POL<br />
Oscar dla filmu zagranicznego w 2010 został przyznany argentyńskiemu<br />
filmowi “El secreto de sus ojos”, w reżyserii Juana Josè<br />
Campanelli, z pochodzenia Włocha. Jest to wyraz uznania, który<br />
należał się wybitnemu filmowi przedstawiającemu na ekranie dramatyczną<br />
historię, która opowiada o znaczeniu uczuć i ludzkiego<br />
doświadczenia pamięci. Film ma cechy, które trudno znaleźć we<br />
współczesnym kinie zaludnionym przez postaci mniej lub bardziej<br />
wirtualne wplątane w baśniowo-koszmarne historie.
FONDAZIONE BRUNO KESSLER<br />
SCIENZE RELIGIOSE,<br />
Annali di<br />
Studi religiosi 10/2009,<br />
EDB, Bologna 2009,<br />
cm 17x24,<br />
pp 339,<br />
€ 26,00<br />
Gradito e doveroso<br />
omaggio<br />
alla pubblicazione<br />
che taglia il traguardo<br />
del primo decennale<br />
e al Direttore<br />
Antonio Autiero, docente<br />
di teologia morale<br />
a Muenster. Insieme<br />
ad altri due alunni<br />
di Johann Baptist<br />
Metz, festeggia il<br />
Maestro che nel 2008 ha compiuto ottant’anni. Un focus su alcuni nodi<br />
del suo pensiero: l’intreccio tra la sua biografia e le opzioni teologiche,<br />
l’ancoraggio biblico e la portata emancipatoria, politica, del suo<br />
disegno teologico. Autiero sottolinea lo spostamento di accento dal<br />
primato del peccato a quello della sofferenza dell’uomo: “Con tale<br />
spostamento il tema della sofferenza acquista un valore di ermeneutica<br />
dell’esistenza: interpreta la conditio humana e fa appello alla sensibilità<br />
radicale di rispetto per la sofferenza, soprattutto della sofferenza<br />
dell’altro”. Una teologia che per pensare e nominare autenticamente Dio<br />
deve farsi fondamentalmente teodicea: interrogazione e tentativo di<br />
risposta sulla sofferenza individuale e collettiva che getta nuova luce sul<br />
peccato nella sua realtà meta-individuale e meta-attuale (si pensi a<br />
P. Schonenberg e alla TdL). Di qui l’appello alla responsabilità etica<br />
estesa e condivisa, un ethos mondiale che richiama il Projekt Weltethos<br />
di Hans Küng con l’appello: “Non c’è pace tra i popoli se non c’è pace<br />
tra le religioni” (discussione su morale autonoma ed etica della fede in<br />
A. Auer, J. Fuchs e F. Boeckle). L’autorità morale mondiale è individuata<br />
da Metz in coloro che soffrono: tribunale di giudizio ma anche<br />
sorgente di risposte, criterio di verifica di fronte alle forme sedimentate<br />
della religione e, dunque, l’esigenza di un movimento ecumenico<br />
tra le religioni.<br />
Quanto al rischio della fine dell’umanesimo (cfr P. Sloterdejk), dove<br />
anche l’etica rischia di essere travolta dal dilagare della tecnica,<br />
ancora una volta, il primato della sofferenza e dell’autorità morale<br />
che i vulnerabili rappresentano, sono una chance di carattere antropologico:<br />
liberano “energie di pensiero e di prassi di trasformazione<br />
che rendono la tecnica non più erosiva dell’etica, ma la fanno<br />
ancora immaginare come arte di servizio e al servizio dell’umano…<br />
recensioni<br />
recensioni<br />
397
ecensioni<br />
recensioni<br />
398<br />
siamo all’inizio di un nuovo umanesimo”. In conclusione: “La postulazione<br />
di un primato della sofferenza non è prigioniera di visioni<br />
nichiliste, ma è ancora a suo modo aperta alla trascendenza e<br />
all’implorazione di un Dio capace di salvare”. Ci siamo soffermati<br />
su questo intervento introduttorio per il prezioso inquadramento nel<br />
dibattito teologico ed ecclesiale della vicenda biografico-teologica di<br />
Metz, che riprende e rifonde un suo discorso in occasione dell’assegnazione<br />
del Premio teologico delle settimane universitarie di<br />
Salisburgo (2007): “Con il volto rivolto verso il mondo’. Una notizia<br />
teologico-biografica”. L’omaggio iniziale al “maestro e amico Karl<br />
Rahner” (proprio in questi mesi ancora una volta oggetto di discussioni)<br />
non è d’occasione: la “svolta antropologica” del maestro,<br />
nella sua fecondità e problematicità, è alla base della “teologia politica”.<br />
La teologia va insieme con la biografia e i mondi del percorso<br />
biografico sono quelli della seconda guerra mondiale, della Shoah<br />
(“fare teologia dopo Auschwitz”) e della Chiesa universale con il<br />
Vaticano II e il passaggio da una visione dogmatico-intenzionale a<br />
una reale-empirica: “Nel mondo della Chiesa universale c’è una storia<br />
sociale di dolore, il dolore della povertà, dell’oppressione e della<br />
miseria”. Si aggiunga, all’interno della globalizzazione, il pluralismo<br />
dei mondi religiosi e culturali, con inevitabili sviamenti (Habermas)<br />
e patologie (Ratzinger). Contro una interpretazione sbilanciata e<br />
riduttiva, l’affermazione: “Per lo sfondo neotestamentario della<br />
compassione è importante che lo sguardo messianico di Gesù si sia<br />
rivolto in primo luogo non al peccato, ma alla sofferenza degli altri”,<br />
non è meno problematico e ideologico. E’ proprio il peccato che<br />
impedisce una “passione per Dio come compassionevole essere<br />
coinvolti, una autentica “mistica della compassione”. Erich Zenger,<br />
con “ ‘Sarò come colui che sarò’. La provocazione del discorso<br />
biblico su Dio”, ritiene di poter fondare biblicamente l’idea della<br />
accentuazione della sofferenza, nel NT, rispetto al peccato e<br />
Paul Suess, baldanzoso, con “Teologia politica e teologia della<br />
liberazione. Omaggio del discepolo al suo maestro”, conclude:<br />
“La narratività dell’America Latina è il figlio più caro della teologia<br />
di Metz”.<br />
A questi “Dialoghi”, seguono le sezioni dei “Nodi”, delle “Fonti”<br />
e alcuni contributi del seminario: “Gender, sessualità e religione”,<br />
uno dei progetti di ricerca in corso presso il Centro.<br />
Salvatore Spera
G. DI GIANNATALE,<br />
Lo studio teologico dei <strong>Passio</strong>nisti<br />
di San Gabriele dell’Addolorata,<br />
San Gabriele Edizioni,<br />
2010,<br />
pp. 294<br />
Tra i saggi finora<br />
pubblicati<br />
sulla storia dei<br />
<strong>Passio</strong>nisti, il lavoro<br />
del prof. Giovanni Di<br />
Giannatale (presentato<br />
il 27 maggio 2010<br />
nel Centro di spiritualità<br />
di S. Gabriele<br />
dell’Addolorata dal<br />
P. Ciro Benedettini C.P., Vice Direttore della Sala Stampa Vaticana,<br />
nell’ambito dell’Assemblea provinciale PIET) rappresenta un contributo<br />
esemplare, che analizza rigorosamente l’evoluzione storica<br />
della formazione filosofico-teologica dei giovani chierici passionisti<br />
avviati all’ordinazione sacerdotale e ne ricostruisce un quadro<br />
quanto mai esaustivo sia sotto il profilo pedagogico-spirituale che<br />
sotto quello socio-religioso.<br />
Emerge dall’intero studio una filosofia di vita dei religiosi<br />
passionisti che si sintetizza in questi termini: essere contemplativi<br />
nell’azione.<br />
Lo studentato di Isola del Gran Sasso (1847-1969) fu destinato a<br />
prosperare sia per il buon auspicio della vivificante e santa presenza<br />
del giovane Gabriele dell’Addolorata, il quale vi frequentò il corso<br />
di filosofia e di teologia dal 1859 al 1862, anno della sua prematura<br />
scomparsa, sia per le condizioni formative e didattiche, costantemente<br />
assolte dai Padri Lettori.<br />
Lo studio del prof. Di Giannatale non trascura di ricordare i<br />
momenti difficili dello studentato durante le soppressioni governative<br />
post-unitarie che, contrariamente ai fini delle leggi liberali,<br />
non fecero altro che diffondere ulteriormente lo spirito passionista,<br />
attraverso la diaspora dei padri predicatori anche nel Sud Italia.<br />
Caso eccelso fu quello dei 24 <strong>Passio</strong>nisti che nel 1866 da Isola del<br />
Gran Sasso vennero esiliati in Puglia, dove fondarono il primo ritiro<br />
della Regione a Manduria (Ta).<br />
Ma il clima anticlericale non scoraggiò i padri che tornarono<br />
qualche decennio dopo a completare l’opera che, come un disegno<br />
divino, è giunta sino a noi. Il testo contiene uno studio preciso<br />
e sostanzioso sulle discipline dello studentato, accorpato, poi,<br />
alle Pontificie Università romane, ed analizza i programmi didatticoformativi<br />
della formazione degli studenti.<br />
recensioni<br />
recensioni<br />
399
ecensioni<br />
recensioni<br />
400<br />
Il prof. Di Gianntale si avvale rigorosamente di numerosi documenti<br />
d’archivio comprovanti che nello studentato isolano nulla era<br />
lasciato al caso e tutto veniva pianificato seguendo la sostanza della<br />
vita vocazionale-sacramentale del messaggio paulocruciano; indicativa<br />
è l’introduzione, sulla scia del rinnovamento liturgico-pastorale<br />
e spirituale richiesto dal Concilio Vaticano II, di alcune discipline,<br />
come l’inglese, la lingua ebraica, la sacra liturgia. Il prof. Di Giannatale,<br />
nell’ambito dell’Appendice documentaria (che consta di 8<br />
copiose sezioni: pp.181-260), ricostruisce minutamente la serie dei<br />
lettori e degli studenti dal 1899 (quando lo studentato fu riattivato)<br />
al 1969 (quando fu soppresso), fornendo di ciascuno dettagliate<br />
informazioni, comprese quelle relative ai vari movimenti interni, tra<br />
uno studentato e l’altro, alle date di professione e di ordinazione<br />
presbiterale, nonchè di dimissione, ove ricorrenti, e fornendo dei<br />
principali e più autorevoli lettori, oltre alle materie insegnate, anche<br />
utili notizie mirate ad inquadrarne sinteticamente il “profilo”<br />
intellettuale, culturale e spirituale. Importante è l’analisi della<br />
biblioteca dello studentato, creata e aggiornata con grande fatica<br />
personale anche da alcuni Lettori, e la minuziosa descrizione dei<br />
Convegni di spiritualità passionista, veri meeting di rinnovazione<br />
socio-religiosa, per dare una storia degna del proprio passato alla<br />
Congregazione e aprire all’evoluzione dei tempi.<br />
Lo studio del prof. Di Giannatale, ricco, ben documentato e stilisticamente<br />
limpido, risulta un valido tributo storico alla Provincia della<br />
Pietà, che si aggiunge agli altri numerosi saggi passionistici che<br />
l’Autore ha già pubblicato (come, fondamentale, quello sulla<br />
fondazione del ritiro dei <strong>Passio</strong>nisti di Isola e sulla formazione di<br />
S. Gabriele, apparsi negli Atti del IV Colloquio su San Gabriele e il suo<br />
tempo, 2009, pp. 87-109 e 251-269) e che sta per pubblicare. Questo<br />
studio risulta un omaggio alla spiritualità passionista e un valido<br />
tributo storico dedicato alla Provincia della Pietà. Per questo l’attuale<br />
Superiore provinciale, P. Piergiorgio Bartoli, ha voluto scriverne personalmente<br />
la Prefazione.<br />
Olga Sarcinella
PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE<br />
CATTEDRA GLORIA CRUCIS<br />
PRODUZIONE SCIENTIFICA<br />
DELLA CATTEDRA GLORIA CRUCIS<br />
AA.VV. Memoria <strong>Passio</strong>nis in Stanislas Breton, Edizioni<br />
Staurós, S. Gabriele Teramo, 2004.<br />
PIERO CODA Le sette Parole di Cristo in Croce, Edizioni<br />
Staurós, S. Gabriele Teramo, ottobre 2004.<br />
LUIS DIEZ MERINO, CP Il Figlio dell’Uomo nel Vangelo della <strong>Passio</strong>ne,<br />
Edizioni Staurós, S. Gabriele Teramo, ottobre<br />
2004.<br />
MARIO COLLU, CP Il Logos della Croce centro e fonte del Vangelo,<br />
Edizioni Staurós, S. Gabriele Teramo, novembre<br />
2004.<br />
TITO DI STEFANO, CP Croce e libertà, Edizioni Staurós, S. Gabriele<br />
Teramo, dicembre 2004.<br />
CARLO CHENIS, SDB Croce e arte, Edizioni Staurós, S. Gabriele<br />
Teramo, gennaio 2004.<br />
ANGELA MARIA LUPO, CP La Croce di Cristo segno definitivo<br />
FERNANDO TACCONE, CP (ed.)<br />
dell’Alleanza tra Dio e l’Uomo, Edizioni<br />
Staurós, S. Gabriele Teramo, febbraio 2004.<br />
Quale volto di Dio rivela il Crocifisso?, Edizioni<br />
OCD, Roma Morena, 2006.<br />
FERNANDO TACCONE, CP (ed.) La visione del Dio invisibile nel volto del<br />
Crocifisso, Edizioni OCD, Roma Morena, 2008.<br />
FERNANDO TACCONE, CP (ed.) Stima di sé e kenosi, Edizioni OCD, Roma<br />
Morena, 2008.<br />
FERNANDO TACCONE, CP (ed.) Croce e identità cristiana di Dio nei primi secoli,<br />
Edizioni OCD, Roma Morena, 2009.<br />
L’attività scientifica della Cattedra Gloria Crucis è fruibile nel sito www.passiochristi.org<br />
alla voce Cattedra Gloria Crucis.<br />
La rivista La Sapienza della Croce è anch’essa fruibile nello stesso sito alla voce<br />
Sapienza della Croce.