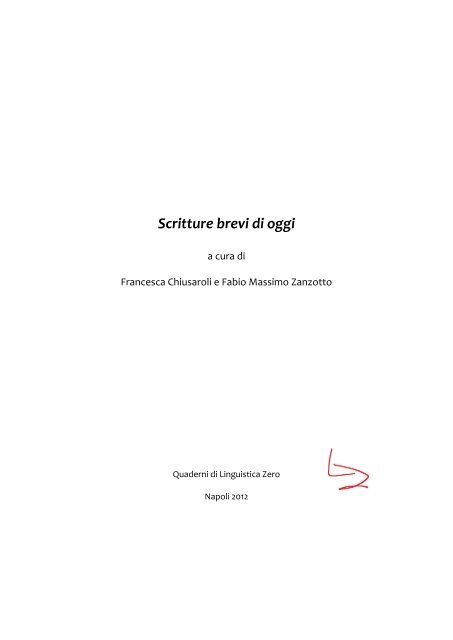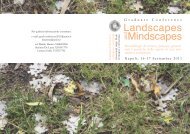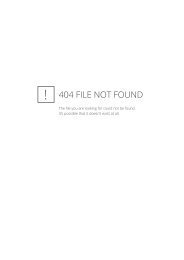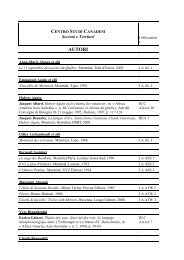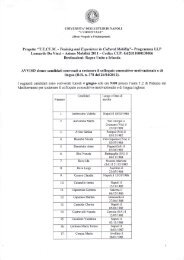You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong> <strong>di</strong> <strong>oggi</strong><br />
a cura <strong>di</strong><br />
Francesca Chiusaroli e Fabio Massimo Zanzotto<br />
Quaderni <strong>di</strong> Linguistica Zero<br />
Napoli 2012
<strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong> <strong>di</strong> <strong>oggi</strong>, a cura <strong>di</strong> Francesca Chiusaroli e Fabio Massimo<br />
Zanzotto<br />
Quaderni <strong>di</strong> Linguistica Zero, numero 1<br />
Napoli, 2012<br />
ISBN: 978-‐88-‐6719-‐017-‐1<br />
Linguistica Zero, Rivista del Dottorato in Teoria delle lingue e del linguaggio<br />
dell’Università degli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Napoli “L’Orientale”<br />
Direttore: Domenico Silvestri<br />
Redazione: Domenico Silvestri, Cristina Vallini, Rossella Bonito Oliva,<br />
Alberto Manco.<br />
In<strong>di</strong>rizzo: Università degli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Napoli “L’Orientale”, Dipartimento <strong>di</strong><br />
Stu<strong>di</strong> Letterari, Linguistici e Comparati, via Duomo 319 -‐ 80138 Napoli.<br />
ISSN: 2038-‐8675<br />
e-‐mail: lz@unior.it<br />
web: www.lz.unior.it<br />
La presente pubblicazione è stata preventivamente sottoposta a revisione esterna da parte<br />
della redazione <strong>di</strong> Linguistica Zero, ricevendo giu<strong>di</strong>zio positivo.<br />
Copyright © Università degli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Napoli “L’Orientale”<br />
I <strong>di</strong>ritti degli autori sono regolati dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive mo<strong>di</strong>fiche e<br />
dalle relative <strong>di</strong>sposizioni comunitarie, oltre che dal Titolo IX del Libro Quinto del Co<strong>di</strong>ce<br />
Civile. Si fa inoltre riferimento al quadro normativo relativo alle pubblicazioni scientifiche<br />
open access.
Sommario<br />
Premessa, Francesca Chiusaroli e Fabio Massimo Zanzotto 3<br />
<strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong> <strong>oggi</strong>: tra convenzione e sistema, Francesca Chiusaroli 4<br />
Microantroponimi del XXI secolo, Enzo Caffarelli 45<br />
<strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong> e nuove tecnologie <strong>di</strong>gitali: un nuovo percorso verso<br />
l’appren<strong>di</strong>mento e la creatività, Andrea Granelli 69<br />
Le interiezioni tra scritto e parlato, Francesca M. Dovetto 90<br />
Sigle e acronimi: <strong>di</strong>mensione grafica e statuto lessicale, Lucia <strong>di</strong> Pace<br />
e Rossella Pannain 108<br />
Simboli e scrittura delle sperimentazioni scientifiche: la chimica,<br />
Roberto Reali 129<br />
Un caso <strong>di</strong> tendenza alla <strong>brevi</strong>tà sintattica nell’italiano contemporaneo,<br />
Sergio Marroni 147<br />
La traduzione delle sigle e degli acronimi dallo spagnolo all’italiano. Un<br />
problema <strong>di</strong> interpretazione linguistica e culturale, Matteo Lefèvre 173<br />
Forme e mo<strong>di</strong> delle scritture <strong>brevi</strong> <strong>di</strong> <strong>oggi</strong>, Felicia Logozzo 192<br />
Language evolution in social me<strong>di</strong>a: a preliminary study, Fabio Massimo<br />
Zanzotto & Marco Pennacchiotti 208
Premessa<br />
La riflessione iniziata con i workshop “<strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong>” – 1° workshop:<br />
Roma Tor Vergata, 22 febbraio 2011; 2° workshop: Roma Tor Vergata e<br />
Società Geografica Italiana, 12-‐‑13 aprile 2011; 3° workshop: Roma Tor<br />
Vergata, 16-‐‑17-‐‑18 maggio 2011 (https://sites.google.com/site/scritture<strong>brevi</strong>/)<br />
– conosce ora nuova circostanza <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>mento con la presente<br />
pubblicazione, che costituisce il primo numero <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> tre quaderni<br />
monografici <strong>di</strong> Linguistica Zero de<strong>di</strong>cati ancora a questo tema.<br />
Si troveranno, in queste se<strong>di</strong>, gli scritti dei Maestri e dei Colleghi che<br />
sono stati relatori e nostri interlocutori nell’organizzazione degli incontri<br />
seminariali. Desideriamo ringraziarli per avere accolto anche questo<br />
secondo invito a prendere parte alla nostra ricerca comune. Ringraziamo<br />
anche i Colleghi che, pur relatori, non hanno potuto, solo per impe<strong>di</strong>menti<br />
<strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pratico, consegnare i loro contributi.<br />
Come abbiamo ripetuto ad ogni incontro, nostra intenzione era che il<br />
tema si sviluppasse, a partire dall’etichetta da noi proposta, secondo le<br />
specifiche competenze e i “punti <strong>di</strong> vista”, e che le <strong>di</strong>verse prospettive<br />
emerse confluissero componendo un comune quadro <strong>di</strong> insieme. In<br />
particolare ci interessava evidenziare la <strong>di</strong>mensione multi<strong>di</strong>sciplinare come<br />
potenziamento dell’indagine, a partire dalle aree della linguistica e<br />
dell’ingegneria informatica, <strong>di</strong> rispettiva pertinenza dei promotori<br />
dell’iniziativa. Come abbiamo verificato nel corso degli incontri, e come<br />
<strong>di</strong>mostrano le redazioni scritte, tutte le aspettative si sono ampiamente<br />
compiute.<br />
Con sincera sod<strong>di</strong>sfazione possiamo dunque ora licenziare questo<br />
primo quaderno de<strong>di</strong>cato alle “scritture <strong>brevi</strong> <strong>di</strong> <strong>oggi</strong>”, non senza però aver<br />
ringraziato la rivista Linguistica Zero e in particolare il Direttore, il Prof.<br />
Domenico Silvestri, il quale non ci ha mai fatto mancare il Suo sostegno,<br />
fino ad offrirci generosamente lo spazio e<strong>di</strong>toriale. La Sua competenza e il<br />
Suo prestigio, così come la <strong>di</strong>sponibilità dei membri della Redazione, ci<br />
rendono onorati <strong>di</strong> poter usufruire <strong>di</strong> questa sede <strong>di</strong> pubblicazione.<br />
28 agosto 2012<br />
Francesca Chiusaroli e Fabio Massimo Zanzotto
Abstract<br />
<strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong> <strong>oggi</strong>:<br />
tra convenzione e sistema<br />
Francesca Chiusaroli<br />
L’espressione “scritture <strong>brevi</strong> <strong>oggi</strong>” è intesa a definire forme grafiche sintetiche<br />
introdotte negli ultimi decenni nella scrittura della cosiddetta comunicazione<br />
me<strong>di</strong>ata dal computer (CMC). Ab<strong>brevi</strong>azioni e acronimi, segni e simboli, ricorrenti<br />
in e-‐‑mail, sms, chat, instant messaging, sono solitamente considerati una singolarità<br />
delle giovani generazioni, o spesso ritenuti errori grafici illogici ed incongruenti;<br />
tuttavia una loro analisi funzionale nella catena e nel sistema, insieme a un<br />
confronto fra sistemi grafici in sincronia e in <strong>di</strong>acronia, mostrano la coesistenza <strong>di</strong><br />
tipi universali e un equilibrio permanente tra forme gergali o i<strong>di</strong>oletti e norma<br />
ideale, agli scopi della pragmatica della comunicazione nel dominio della rete.<br />
Parole chiave: scritture <strong>brevi</strong>, lingua <strong>di</strong> internet, socio-‐‑pragmatica della<br />
comunicazione scritta, storia e tipologia della scrittura<br />
The notion of "ʺshort writings today"ʺ refers here to synthetic graphic forms<br />
introduced in recent decades in the writing of the so-‐‑called Computer-‐‑Me<strong>di</strong>ated<br />
Communication (CMC). Ab<strong>brevi</strong>ations and acronyms, signs and symbols,<br />
occurring in e-‐‑mails, sms, chats, instant messaging, are usually considered as an<br />
od<strong>di</strong>ty of the younger generations, illogical and incongruent writing mistakes,<br />
wherever a functional analysis in language chain and system, together with a<br />
comparison between writing systems in <strong>di</strong>achrony and synchrony, show the<br />
coexistence of universal typologies and a permanent balance between slang, i<strong>di</strong>olect<br />
and the ideal norm, relevant to the main purposes of the pragmatics of<br />
communication in the web domain.<br />
Keywords: short writings, language of the Internet, sociopragmatics of written<br />
communication, history and typology of writing<br />
1. Oggetto della ricerca<br />
La nozione <strong>di</strong> “scritture <strong>brevi</strong> <strong>oggi</strong>” definisce in questa sede formazioni<br />
grafiche a marca sintetica introdotte negli ultimi decenni nella scrittura
F. Chiusaroli 5<br />
dalla cosiddetta Computer-‐‑Me<strong>di</strong>ated Communication (CMC), che è<br />
l’interscambio comunicativo a <strong>di</strong>stanza promosso dall’uso delle moderne<br />
tecnologie informatiche.<br />
Costituiscono oggetto precipuo della presente ricerca le ab<strong>brevi</strong>azioni e<br />
le forme accorciative nella comunicazione scritta in uso soprattutto da parte<br />
<strong>di</strong> utenti delle giovani generazioni in messaggi e-‐‑mail, sms, chat, instant<br />
messaging, questi elencati secondo l’or<strong>di</strong>ne crescente della presenza<br />
quantitativa delle forme nei tipi testuali.<br />
Si tratta <strong>di</strong> una manifestazione originata nel gergo giovanile, ben nota<br />
agli utenti della rete e, con valenza negativa, ai detrattori degli effetti<br />
dell’era <strong>di</strong>gitale sulla lingua <strong>di</strong> <strong>oggi</strong>.<br />
Come riflette David Crystal (2008), non vi è attualmente argomento che<br />
susciti maggiore “moral panic”, o più intensa contrarietà, ed opposizione,<br />
tra la popolazione adulta, che la serie delle accorciature grafiche utilizzate<br />
per lo più dai giovani nella tipica scrittura per sms, ciò che in italiano si<br />
chiama “il messaggiare” e in inglese va sotto il nome <strong>di</strong> texting.<br />
Nel 2007, in un articolo <strong>di</strong> giornale, I h8 txt msgs: How texting is wrecking<br />
our language (http://www.dailymail.co.uk/news/article-‐‑483511/I-‐‑h8-‐‑txt-‐‑msgs-‐‑How-‐‑<br />
texting-‐‑wrecking-‐‑language.html), John Humphrys definiva i texters come<br />
the SMS vandals who are doing to our language what Genghis Khan <strong>di</strong>d to his<br />
neighbours 800 years ago. They are destroying it: pillaging our punctuation;<br />
savaging our sentences; raping our vocabulary. And they must be stopped. This, I<br />
grant you, is a tall order. The texters have many more arrows in their quiver than<br />
we who defend the old way. Ri<strong>di</strong>cule is one of them. “What! You don'ʹt text. What<br />
century are you living in then, granddad? Need me to sharpen your quill pen for<br />
you?”<br />
La <strong>di</strong>ffidenza non è priva <strong>di</strong> motivazioni.<br />
Famosa è ormai la pagina <strong>di</strong> Yahoo answers che riporta un naturale<br />
scambio <strong>di</strong> informazioni su tale<br />
Nino Biperio o Bixio, nato a Genova, il 2 ottobre 1821, e morto all’Isola <strong>di</strong> Sumatra il<br />
16 <strong>di</strong>cembre 1873, militare e politico italiano, oltreché un personaggio-‐‑chiave del<br />
Risorgimento…<br />
http://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080201051946AAsyWnP<br />
Tra le spiegazioni della identificazione “Biperio/Bixio” vi è la notizia,<br />
riportata da Giampaolo Pansa (Viva Nino Biperio, “L’Espresso”, Bestiario
6<br />
<strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong> <strong>oggi</strong>: tra convenzione e sistema<br />
dell’1 settembre 2006), <strong>di</strong> una studentessa universitaria ripresa all’esame <strong>di</strong><br />
Storia del Risorgimento:<br />
“Chi è questo Biperio?” domanda, stupito, il docente. Poi si scopre che si tratta <strong>di</strong><br />
Nino Bixio: la ragazza era convinta che la “x” significasse “per”. La <strong>di</strong>fesa: “Sì,<br />
scusi, ci deve essere stato qualche problema nella trascrizione degli appunti.”<br />
Su reali apprensioni si fonda la preoccupazione degli intellettuali per le<br />
con<strong>di</strong>zioni della o<strong>di</strong>erna civiltà virtuale (Simone 2000 e 2012; Carr 2011) e<br />
per gli effetti sull’educazione delle giovani generazioni. Tra le elencate<br />
“calamità” Umberto Eco denuncia la pratica del messaggiare:<br />
Penso che Michel Serres sia la mente filosofica più fine che esista <strong>oggi</strong> in Francia, e<br />
come ogni buon filosofo sa piegarsi anche a riflettere sull'ʹattualità. Spudoratamente<br />
uso (tranne qualche commento personale) un suo bellissimo articolo uscito su "ʺLe<br />
Monde"ʺ del 6-‐‑7 marzo ultimo scorso, dove ci ricorda cose che, per i più giovani dei<br />
miei lettori, riguardano i loro figli, e per noi più anziani i nostri nipoti.<br />
Tanto per cominciare, questi figli o nipoti non hanno mai visto un maiale, una<br />
vacca, una gallina […]. I nuovi esseri umani non sono più abituati a vivere nella<br />
natura e conoscono solo la città […].<br />
Si tratta <strong>di</strong> una delle più gran<strong>di</strong> rivoluzioni antropologiche dopo il neolitico. Questi<br />
ragazzi abitano un mondo superpopolato, la loro speranza <strong>di</strong> vita è ormai vicina<br />
agli ottant'ʹanni e, a causa della longevità <strong>di</strong> padri e nonni, se hanno speranza <strong>di</strong><br />
ere<strong>di</strong>tare qualcosa non sarà più a trent'ʹanni, ma alle soglie della loro vecchiaia […].<br />
Sono stati formati dai me<strong>di</strong>a concepiti da adulti che hanno ridotto a sette secon<strong>di</strong> la<br />
permanenza <strong>di</strong> una immagine, e a quin<strong>di</strong>ci secon<strong>di</strong> i tempi <strong>di</strong> risposta alle domande<br />
[…]. Sono educati dalla pubblicità che esagera in ab<strong>brevi</strong>azioni e parole straniere<br />
che fanno perdere il senso della lingua natale, non hanno più coscienza del sistema<br />
metrico decimale dato che gli si promettono premi secondo le miglia, la scuola non<br />
è più il luogo dell'ʹappren<strong>di</strong>mento e, ormai abituati al computer, questi ragazzi<br />
vivono buona parte della loro vita nel virtuale. Lo scrivere col solo <strong>di</strong>to in<strong>di</strong>ce<br />
anziché con la mano intera "ʺnon eccita più gli stessi neuroni o le stesse zone<br />
corticali"ʺ (e infine sono totalmente "ʺmultitasking"ʺ). Noi vivevamo in uno spazio<br />
metrico percepibile ed essi vivono in uno spazio irreale dove vicinanze e<br />
lontananze non fanno più alcuna <strong>di</strong>fferenza.<br />
Umberto Eco, Una generazione <strong>di</strong> alieni, “L’Espresso”, 18 marzo 2011<br />
http://espresso.repubblica.it/dettaglio/una-‐‑generazione-‐‑<strong>di</strong>-‐‑alieni/2147183<br />
La consuetu<strong>di</strong>ne è tanto denigrata quanto vincente. Il riconoscimento<br />
della necessità <strong>di</strong> controlli ed interventi dell’autorità sulla corretta<br />
collocazione dei linguaggi nei giusti contesti non può sottrarci dalla
F. Chiusaroli 7<br />
considerazione della fortuna del fenomeno e, come qui vedremo, delle sue<br />
potenzialità. Ovvero, non sembra più possibile negare i vantaggi <strong>di</strong> una<br />
forma <strong>di</strong> comunicazione con la quale la società si confronta, anche suo<br />
malgrado, e persino si arricchisce:<br />
Molti sono scandalizzati, <strong>di</strong>cono che questo è un nuovo Me<strong>di</strong>oevo, quello<br />
dell’ortografia, ma, stranamente, gli stu<strong>di</strong>osi della lingua, proprio i puristi più<br />
rigi<strong>di</strong>, guardano con favore e curiosità al fenomeno. Certo, è una sintassi un po’<br />
sconcertante. Facciamo qualche esempio?<br />
Ieri pom sn andata dal dottore cn mamy x mia sorella poi mi ha kiamato vale e sn andata ai<br />
giar<strong>di</strong>…..lì ho incontrato fabry e david ke sn scesi x prendere i gelati…… e ancora Dopo<br />
abbiamo incontrato vlad ke m ha detto ke l’ex piskella sa k noi stiamo insieme!!!!!……<br />
Ostrogoto? Ma no, se si fa un po’ <strong>di</strong> attenzione si capisce tutto: sono solo artifici per scrivere<br />
più velocemente, e in modo colorito. Ecco che allora tutto si ab<strong>brevi</strong>a, le vocali dove è<br />
possibile scompaiono, la x “vince” sul per, la k sostituisce il ch, i punti esclamativi e<br />
quelli interrogativi vengono usati come nei fumetti, e si aggiungono le faccine, i<br />
cosiddetti emoticons, costruite combinando punti, trattini, parentesi che servono ad<br />
esprimere le emozioni: ò.ò, confusione, @_@, perplessità. :-‐‑( , tristezza, :-‐‑S,<br />
confusione o paura. I simboli sono tanti e in continua evoluzione.<br />
Curiosamente sono proprio gli esperti della lingua italiana, Accademia della Crusca<br />
compresa, a guardare con grande interesse a questa nuova lingua che a parer loro<br />
per la prima volta nella storia del nostro Paese, è un italiano scritto <strong>di</strong> massa. Una<br />
seconda conquista dopo quella dell’italiano parlato <strong>di</strong> massa, <strong>di</strong>venuto tale solo<br />
dopo l’avvento della televisione.<br />
Franca Porciani, La rivincita della X e della K, “Corriere della Sera”, 26 maggio 2012<br />
http://27esimaora.corriere.it/articolo/la-rivincita-della-x-e-della-k/<br />
Si tratta, come si vede, <strong>di</strong> una modalità espressiva grafica rinnovata, che<br />
ha in qualche misura annullato la <strong>di</strong>stinzione dei concetti <strong>di</strong> variabilità<br />
<strong>di</strong>amesica tra<strong>di</strong>zionalmente intesa, quale era nella classica <strong>di</strong>cotomia scritto<br />
vs parlato (Halliday 1992), introducendo nuove e <strong>di</strong>verse categorie per la<br />
scrittura che riproduce la voce (già in Ong 1970 e 1986; Goody 1989;<br />
Cardona 1990 [1985]) e l’interazione faccia a faccia annullando <strong>di</strong>stanze<br />
fisiche <strong>di</strong> ingenti quantità <strong>di</strong> chilometri e azzerando la lungaggine dei<br />
tempi <strong>di</strong> trasferimento dei messaggi (il cosiddetto lag), che è il presupposto<br />
in<strong>di</strong>spensabile nella nuova società dell’informazione (Orletti 2004;<br />
Fiorentino 2007).<br />
Ma <strong>di</strong> che cosa stiamo parlando?
8<br />
2. Dall’sms a Twitter<br />
<strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong> <strong>oggi</strong>: tra convenzione e sistema<br />
La storia <strong>di</strong>gitale attesta che il primo sms fu inviato il 3 <strong>di</strong>cembre 1992<br />
da un computer ad un cellulare sulla rete GSM Vodafone inglese e il testo<br />
del messaggio era il breve "ʺMERRY CHRISTMAS"ʺ, un augurio natalizio<br />
lievemente anticipato, scritto tutto in caratteri maiuscoli. Il primo sms da<br />
cellulare a cellulare invece risulta inviato all'ʹinizio del 1993 da uno stagista<br />
della Nokia, il finlandese Riku Pihkonen.<br />
Tecnicamente il messaggino (cosiddetto) ha un’estensione fissa <strong>di</strong> 140<br />
byte. Questa misura si traduce, in pratica, nella possibilità <strong>di</strong> usare 160<br />
caratteri <strong>di</strong> testo (a 7 bit) per comporre una unità-‐‑messaggio. Costo<br />
contenuto, imme<strong>di</strong>atezza, velocità, efficienza ed efficacia, praticità e<br />
versatilità del canale, la compatibilità per l’invio ad ogni apparecchio<br />
in<strong>di</strong>pendentemente dal gestore del destinatario -‐‑ sono riconosciuti come i<br />
maggiori punti <strong>di</strong> forza, elementi che hanno decretato l'ʹeccezionale<br />
successo degli SMS. Dalla fine degli anni 'ʹ90, soprattutto in seguito alla<br />
<strong>di</strong>ffusione dei telefoni cellulari tra le fasce <strong>di</strong> utenti delle giovani<br />
generazioni, i 160 caratteri dei messaggini sono <strong>di</strong>ventati uno dei mezzi più<br />
usati per tenersi in contatto:<br />
Meglio scrivere che parlare. Per la prima volta da quando sono stati introdotti i<br />
telefonini, in Gran Bretagna cala il numero delle chiamate ma aumenta quello dei<br />
messaggini. Il totale delle telefonate fatte con i cellulari è <strong>di</strong>minuito dell’1,1 per<br />
cento nel 2011, mentre la quantità <strong>di</strong> sms inviati è cresciuta del 16,6 per cento. In<br />
me<strong>di</strong>a, lo scorso anno ogni possessore <strong>di</strong> un cellulare ha trasmesso 200 messaggini<br />
al mese; nel 2006 ne venivano inviati me<strong>di</strong>amente soltanto 60 a persona.<br />
Le cifre annunciate dall’annuale Communications Market Report dell’Ofcom,<br />
l’agenzia che regolamenta il settore delle comunicazioni nel Regno Unito,<br />
confermano una tendenza che era già evidente, qui e in altri paesi: la gente<br />
preferisce comunicare per iscritto piuttosto che a voce. Vari i motivi, secondo gli<br />
esperti del ramo: i messaggini costano <strong>di</strong> meno, si possono rileggere ovvero “scripta<br />
manent” come sapevano già gli antichi Romani, e per molti, specie tra i più giovani,<br />
permettono una forma <strong>di</strong> <strong>di</strong>alogo più concisa e moderna.<br />
Ma il boom o meglio il ritorno della comunicazione scritta non si limita ai<br />
messaggini. Sempre più spesso si comunica attraverso i social network, come<br />
Facebook o Twitter, piuttosto che con un sms o con una e-‐‑mail. Anche perché,<br />
sempre secondo i dati dell’Ofcom, <strong>oggi</strong> due terzi dei consumatori britannici hanno<br />
uno “smartphone”, un telefonino “intelligente” ovvero in grado <strong>di</strong> navigare sul<br />
web e dunque <strong>di</strong> collegarsi ai social network (o a Skype, l’altro nuovo mezzo per<br />
comunicare, verbalmente e perfino visualmente, gratis oltretutto). E l’11 per cento
F. Chiusaroli 9<br />
dei citta<strong>di</strong>ni del Regno Unito ha un tablet, percentuale destinata a raddoppiare <strong>di</strong><br />
anno in anno secondo le previsioni, un altro mezzo <strong>di</strong> comunicazione mobile, che<br />
contribuisce al rilancio della parola scritta. Quando fu inventato il telefono, e ancora<br />
<strong>di</strong> più quando è arrivato il telefonino, si pensava che la comunicazione verbale<br />
avrebbe mandato in pensione la forma scritta. E invece non è così, potrebbe<br />
ad<strong>di</strong>rittura accadere il contrario. Perché “verba volant”, mentre un testo rimane con<br />
noi quanto vogliamo.<br />
Enrico Franceschini, Regno Unito, “scrivi non parlare”. Calano le chiamate, aumentano<br />
gli sms, “La Repubblica”, 18 luglio 2012.<br />
http://www.repubblica.it/economia/2012/07/18/news/regno_unito_scrivi_non_parla<br />
re_calano_le_chiamate_aumentano_gli_sms-‐‑39263324/<br />
Tali risultano le con<strong>di</strong>zioni per la nascita delle “scritture <strong>brevi</strong>” <strong>di</strong> <strong>oggi</strong>.<br />
Il collegamento tra il numero massimo dei caratteri e la spesa ha<br />
implicato sin da subito l’elaborazione <strong>di</strong> tecniche <strong>di</strong> risparmio che agiscono<br />
intaccando le regole della grafia standard allo scopo primario <strong>di</strong><br />
risparmiare, pur salvaguardando la corretta comunicazione.<br />
I ragazzi, particolarmente gli adolescenti, hanno limitate risorse<br />
economiche e debole grado <strong>di</strong> assoggettamento alla norma linguistica, o<br />
meglio certamente sono capaci <strong>di</strong> sfruttare al massimo la libertà concessa<br />
dall’appartenenza al gruppo al <strong>di</strong> fuori degli ambienti “regolati” e<br />
normativi. La scuola e anche, in minor misura, la famiglia, richiedono un<br />
comportamento linguistico appropriato, ma, dove non vi è controllo da<br />
parte dell’autorità superiore, fantasia e creatività <strong>di</strong>ventano motori efficaci<br />
dell’innovazione (Stefinlongo 2002; Pistolesi 2005a).<br />
Insieme alla tipica adesione alle regole del gruppo (che in termini<br />
sociolinguistici costituisce la base per lo sviluppo e per il mantenimento<br />
delle varietà gergali), il costo legato alla lunghezza del messaggio, ma<br />
anche le ristrette <strong>di</strong>mensioni materiali del supporto, la minuscola tastiera e<br />
il piccolo schermo del cellulare, la posizione fisica solitamente “in<br />
movimento” dello scrivente, hanno creato le con<strong>di</strong>zioni per la nascita <strong>di</strong><br />
forme <strong>di</strong> scrittura ab<strong>brevi</strong>ata.<br />
Ma si può affermare che la lingua dell’sms, pur moderna e nuova, sia<br />
già sopravvissuta a molte rivoluzioni <strong>di</strong>gitali, conservandosi, ad esempio,<br />
nel corso della pur frequente e rapida sostituzione <strong>di</strong> modelli <strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivi<br />
telefonici aggiornati secondo le nuove tecnologie (Crystal 2001).
10<br />
<strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong> <strong>oggi</strong>: tra convenzione e sistema<br />
La spe<strong>di</strong>tezza garantita dal sistema <strong>di</strong> scrittura pre<strong>di</strong>ttivo, o T9 (<strong>oggi</strong><br />
<strong>di</strong>sponibile in oltre settanta lingue), non ha messo in crisi le ab<strong>brevi</strong>azioni,<br />
poiché è appurato che al giovane scrivente interessano la <strong>brevi</strong>tà e il<br />
risparmio, più che la velocità della <strong>di</strong>gitazione. La possibilità <strong>di</strong> ampliare il<br />
vocabolario memorizzato integrando nuove forme consente la prassi <strong>di</strong><br />
inserire parole ab<strong>brevi</strong>ate nella memoria pre<strong>di</strong>sposta. Giovani utenti del T9<br />
sono raramente <strong>di</strong>sposti a rinunciare a = “non”; parimenti l’uso, per<br />
altro non nuovo, del valore fonetico dei segni aritmetici (+, -‐‑, x) non è mai<br />
stato soppiantato dalla scrittura “normale”, estesa, “più, meno, per”.<br />
Recentemente infine, le nuove tastiere QWERTY, con un tasto per ogni<br />
lettera, hanno rinver<strong>di</strong>to i fasti della scrittura breve, a tutto svantaggio del<br />
non economico T9.<br />
Ancora, è segnale del valore insieme sociale ed economico del sistema il<br />
fatto che la pratica della scrittura ab<strong>brevi</strong>ata sia stata trasferita <strong>di</strong> peso nella<br />
conversazione scritta via chat, a partire dalle forme adottate dalle reti<br />
sociali, come <strong>oggi</strong> Twitter (dal 2006), che per altro segue ed impone le<br />
limitazioni dell’sms, ammettendo messaggi <strong>di</strong> massimo 140 caratteri, ma la<br />
consuetu<strong>di</strong>ne risulta nella pratica adottata da tutti i sistemi <strong>di</strong><br />
messaggistica istantanea, come Windows Live Messenger e finalmente nel<br />
social network più popolare, Facebook (dal 2004).<br />
Internet Relay Chat (in sigla IRC) è il nome del programma messo a<br />
punto dal finlandese Jarkko Oikarinen nel 1988, data convenzionale che<br />
inaugura la concezione dello scambio sincrono multiutente. Nella storia<br />
della rete, questa data costituisce un punto <strong>di</strong> svolta poiché fino a quel<br />
momento la comunicazione in forma scritta si limitava ai soli sistemi<br />
asincroni (e-‐‑mail, newsgroups).<br />
La <strong>di</strong>fferenza che <strong>oggi</strong> intercorre tra forme comunicative asincrone e<br />
sincrone incide fortemente sulle manifestazioni concrete delle modalità<br />
scrittorie implicate (Bazzanella 2002 e 2003; Pistolesi 2003).<br />
Nata nel 1971, la posta elettronica (e-‐‑mail) ha rapidamente rivoluzionato<br />
il modo <strong>di</strong> comunicare (Baron 1998), ponendosi come me<strong>di</strong>um scritto<br />
veloce ed imme<strong>di</strong>ato rispetto al tra<strong>di</strong>zionale messaggio epistolare, ma <strong>oggi</strong>,<br />
dopo quarant’anni, l’imme<strong>di</strong>atezza inizialmente garantita ha perso<br />
consistenza <strong>di</strong> fronte alle nuove forme della comunicazione per chat, che<br />
tale “primitiva” velocità hanno <strong>di</strong> gran lunga superato, proponendo mo<strong>di</strong><br />
<strong>di</strong> interrelazione comunicativa istantanea che costituiscono l’espressione<br />
tangibile <strong>di</strong> uno scambio faccia a faccia e la riproduzione in forma scritta<br />
dello stile parlato:
F. Chiusaroli 11<br />
Signs you’re an old fogey: You still watch movies on a VCR, listen to vinyl records<br />
and shoot photos on film.<br />
And you enjoy using e-‐‑mail.<br />
Young people, of course, much prefer online chats and text messages. These have<br />
been on the rise for years but are now threatening to eclipse e-‐‑mail, much as they<br />
have already superseded phone calls.<br />
Major Internet companies like Facebook are respon<strong>di</strong>ng with message services that<br />
are focused on imme<strong>di</strong>ate gratification.<br />
The problem with e-‐‑mail, young people say, is that it involves a boringly long<br />
process of signing into an account, typing out a subject line and then sen<strong>di</strong>ng a<br />
message that might not be received or answered for hours. And sign-‐‑offs like<br />
“sincerely” — seriously?<br />
Matt Richtell, E-‐‑mail use gets an instant makeover, “The New York Times”, 20<br />
December, 2010.<br />
http://www.nytimes.com/2010/12/21/technology/21email.html?_r=1<br />
Facebook, Twitter, chat, Skype, perfino l'ʹimmarcescibile sms sono più imme<strong>di</strong>ati,<br />
informali, gratificanti. L'ʹe-‐‑mail obbliga a un minimo <strong>di</strong> preparazione: un account <strong>di</strong><br />
posta, un destinatario con un in<strong>di</strong>rizzo, magari qualcosa nel «subject» (argomento).<br />
Bisogna aspettare che il destinatario risponda: e non sempre lo fa. Occorre evitare<br />
gli errori <strong>di</strong> ortografia, e magari fingere <strong>di</strong> essere educati. Nessuno, in Italia, chiude<br />
una email con «In attesa <strong>di</strong> favorevole riscontro», se non ha assunto sostanze molto<br />
forti. Ma un saluto prima della firma lo usano tutti.<br />
È questa sovrastruttura che i ragazzi trovano pesante, in America come in Italia, a<br />
Londra come a Pechino. Una email non può -‐‑ o non dovrebbe -‐‑ contenere solo «:-‐‑<br />
O», per spiegare che il mittente è sorpreso. Facebook, per esempio, s'ʹè accorta che la<br />
riga del «subject» (l'ʹargomento) resta spesso vuota (al massimo qualcuno batte hi!<br />
oppure ehi!). Così ha deciso <strong>di</strong> eliminarla insieme a cc (copia) e bcc (copia nascosta).<br />
FB non è un paese per vecchi; l'ʹemail sì. Yahoo e Hotmail -‐‑ celeberrimi siti <strong>di</strong> posta<br />
elettronica -‐‑ hanno perso il 16% dei visitatori in un anno; solo Gmail, prodotto <strong>di</strong><br />
casa Google, è cresciuta del 10%. […]<br />
La chiocciolina (@) è una specie in via <strong>di</strong> estinzione?<br />
Probabilmente sì. Poco male: l'ʹemail ha avuto una vita intensa. Intensa -‐‑ basta<br />
vedere gli auguri seriali da cui veniamo inondati in queste ore -‐‑ ma breve. Quin<strong>di</strong>ci<br />
anni, <strong>di</strong>ciamo. L'ʹimpatto sociale inizia nel 1995. L'ʹemail è come le ragazze della<br />
televisione: c'ʹè sempre una più giovane in agguato.<br />
Le lettere <strong>di</strong> carta hanno resistito meglio: cinquanta secoli?<br />
Qualcuno ancora ne manda, anche se l'ʹabitu<strong>di</strong>ne è ristretta ormai a tre categorie <strong>di</strong><br />
persone: molto romantici, molto anziani, molto eccentrici. Accadrà presto anche agli<br />
utenti <strong>di</strong> posta elettronica. «Ti mando una email» sembra il titolo <strong>di</strong> una comme<strong>di</strong>a<br />
romantica all'ʹamericana, <strong>di</strong> quelle dove si baciano a <strong>di</strong>eci minuti dalla fine e tutti<br />
applaudono. Vederla fa sempre piacere, ma la vita funziona in altro modo.
12<br />
<strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong> <strong>oggi</strong>: tra convenzione e sistema<br />
Beppe Severgnini, Il declino della “chiocciola”. Email snobbate dai ragazzi, “Corriere<br />
della Sera”, 22 Dicembre 2010.<br />
http://www.corriere.it/cronache/10_<strong>di</strong>cembre_22/declino-‐‑della-‐‑chiocciola-‐‑Email-‐‑<br />
snobbate-‐‑dai-‐‑ragazzi-‐‑beppe-‐‑severgnini_e7942c7a-‐‑0d98-‐‑11e0-‐‑8558-‐‑<br />
00144f02aabc.shtml<br />
Sostituendo, innanzi tutto per motivazioni pratiche ed economiche, la<br />
comunicazione scritta cartacea, l’e-‐‑mail ha infine soppiantato la lettera<br />
persino nelle occasioni ufficiali, acquisendo (ad esempio con l’introduzione<br />
del valore legale della firma <strong>di</strong>gitale) prerogativa anche pubblica e legale.<br />
Ciò ha comportato uno slittamento delle potenzialità e delle funzioni della<br />
scrittura per e-‐‑mail, con conseguente relativa attribuzione al nuovo mezzo<br />
delle caratteristiche ere<strong>di</strong>tate dalla comunicazione scritta tra<strong>di</strong>zionale -‐‑ alto<br />
controllo dell’espressione e dello stile, verifica della correttezza formale e<br />
grafica, <strong>di</strong>latazione dello spazio fisico e temporale tra l’emittente e il<br />
destinatario, eliminazione dei fenomeni <strong>di</strong> personalizzazione o<br />
spontaneismi -‐‑ conservando pertanto i vantaggi della scrittura ed<br />
eliminandone la principale insufficienza, che era sostanzialmente nella<br />
lunghezza dei tempi <strong>di</strong> consegna del messaggio (Cho 2010).<br />
Tali specializzazioni progressive dei tipi testuali <strong>di</strong>gitali, intervenute nel<br />
giro <strong>di</strong> pochi anni, hanno determinato, <strong>di</strong> fatto, la proliferazione <strong>di</strong> una<br />
variegata gamma <strong>di</strong> scritture della rete, che non possono più essere<br />
valutate come fenomeno singolo ed unitario, bensì piuttosto come una<br />
sorta <strong>di</strong> <strong>di</strong>asistema complesso, <strong>di</strong> pari passo con l’ampliarsi dell’universo<br />
<strong>di</strong>gitale (Stefinlongo 2004; Bonomi 2010; Pilloni 2011; Tavosanis 2011).<br />
Nell’ideale continuum tra la <strong>di</strong>mensione della scrittura e il parlato, la<br />
scrittura per chat o l’instant messaging possono essere riguardati come una<br />
significativa via interme<strong>di</strong>a e, data l’o<strong>di</strong>erna <strong>di</strong>ffusione globale dei social<br />
network, non può essere trascurato l’impatto universale sulle forme e sulla<br />
lingua (Baron 2000; Frehner 2008).<br />
3. Per una grammatica delle scritture <strong>brevi</strong><br />
Nella considerazione, asseverata dalla pragmatica, della competenza<br />
comunicativa come somma <strong>di</strong> micro-‐‑competenze relative ai contesti d’uso,<br />
è evidente che la <strong>di</strong>fferenziazione delle con<strong>di</strong>zioni dello scambio<br />
comunicativo abilitata dalla comunicazione sincrona rispetto a quella<br />
asincrona richiede, da parte degli utenti, l’adeguamento ai relativi registri,
F. Chiusaroli 13<br />
l’acquisizione <strong>di</strong> un linguaggio collettivo, in pratica l’adesione a un canone<br />
(socio-‐‑)linguistico con<strong>di</strong>viso (Herring 1996 e 2012a; Bazzanella 2005a).<br />
La comunità degli scriventi, in sé virtuale, risulta essere particolarmente<br />
esigente quanto alle regole che determinano il riconoscimento e l’inclusione<br />
dei suoi affiliati.<br />
Secondo i parametri della socio-‐‑pragmatica della comunicazione,<br />
l’espressione del singolo è piuttosto determinata dalla personale esigenza<br />
<strong>di</strong> consenso e <strong>di</strong> approvazione e l’identificazione all’interno del gruppo<br />
risulta prevalente rispetto all’originalità e alla in<strong>di</strong>vidualità, o alla sostanza<br />
stessa della comunicazione.<br />
Parlare, ovvero scrivere “come gli altri”, appare presupposto<br />
imprescin<strong>di</strong>bile non solo per la comprensione, ma per la stessa<br />
trasmissione del messaggio. Ogni buon utente della rete sa che scrivere e-‐‑<br />
mail è <strong>di</strong>verso dal partecipare validamente e in maniera propria all’attività<br />
<strong>di</strong> un chatgroup, lì dove proprio l’adesione alle consuetu<strong>di</strong>ni linguistiche del<br />
gruppo determina, a priori, l’attribuzione del ruolo <strong>di</strong> parlante virtuale<br />
(Adkins&Brashers 1995).<br />
Tra le forme che consentono il riconoscimento dell’utente nella<br />
comunità “social” vi è senz’altro la scrittura (poiché scritta è concretamente<br />
la modalità <strong>di</strong> manifestazione dell’utente) e, all’interno <strong>di</strong> essa,<br />
particolarmente pertinenti appaiono le forme delle scritture <strong>brevi</strong>, le quali<br />
assommano, alla preliminare urgenza della velocità e della concisione,<br />
annesse prioritariamente alla comunicazione <strong>di</strong>gitale, l’esigenza sociologica<br />
dell’accre<strong>di</strong>tamento al gruppo quale appena sopra illustrata.<br />
Si giustifica a partire da tali premesse la <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> pratiche grafiche<br />
con<strong>di</strong>vise, che per lo più utilizzano la modalità ab<strong>brevi</strong>ativa come segnale<br />
<strong>di</strong>stintivo gergale (Lorenzetti&Schirru 2006), ma all’interno della comunità<br />
coesa ne sperimentano le possibilità espressive allo scopo della<br />
comunicazione più efficace.<br />
Alla luce delle nostre premesse, forme <strong>brevi</strong> saranno infrequenti, quasi<br />
inappropriate, alla comunicazione via e-‐‑mail, mentre risulteranno<br />
pressoché obbligate all’interno della conversazione per chat.<br />
Il carattere vincolante è tanto più evidente lì dove la scrittura ab<strong>brevi</strong>ata<br />
compare senza remore <strong>di</strong> contravvenzione dello standard in scambi non<br />
solo tra utenti intimi o familiari, ma anche fra corrispondenti<br />
reciprocamente sconosciuti, per i quali l’espressione non sorvegliata e il<br />
tratto amichevole costituiscono gli effetti, oltre che le cause, dell’approccio<br />
comunicativo e grafico spontaneo.
14<br />
<strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong> <strong>oggi</strong>: tra convenzione e sistema<br />
Il concetto <strong>di</strong> convenzione si ristruttura all’interno della nuova <strong>di</strong>namica<br />
comunicativa, fino a determinare la costituzione <strong>di</strong> repertori con<strong>di</strong>visi la<br />
cui competenza, da parte degli utenti, con<strong>di</strong>ziona evidentemente il<br />
processo <strong>di</strong> trasmissione e <strong>di</strong> ricezione del messaggio.<br />
Prova della rilevanza del principio della convenzione interna al gruppo<br />
è la <strong>di</strong>ffusione, in rete, <strong>di</strong> <strong>di</strong>zionari <strong>di</strong> ab<strong>brevi</strong>azioni in uso nelle chat, liste<br />
<strong>di</strong> acronimi <strong>di</strong>sponibili per tutti gli utenti (Crystal 2004), o, se anche non<br />
utilizzati, comunque compresi, deco<strong>di</strong>ficati ed acquisiti, repertori che<br />
attestano il grado <strong>di</strong> standar<strong>di</strong>zzazione delle forme e soprattutto il livello <strong>di</strong><br />
normalizzazione della pratica delle scritture ab<strong>brevi</strong>ate all’interno della<br />
comunicazione <strong>di</strong>gitale (Lo Cascio 2007).<br />
Ma, nonostante ciò, è la stessa proliferazione dei <strong>di</strong>zionari, come pure la<br />
convivenza, al loro interno, <strong>di</strong> forme grafiche non univoche o uniformi,<br />
l’esistenza, inoltre, <strong>di</strong> più varianti per una parola, nonché la presenza non<br />
rara <strong>di</strong> forme omografiche, a dover indurre necessariamente a una<br />
riflessione sui principi che paiono regolare la prassi ab<strong>brevi</strong>ativa, in<br />
considerazione della <strong>di</strong>fformità delle produzioni.<br />
Per rifarci intanto solo ai lessici delle chat – che costituiscono qui<br />
oggetto dell’indagine e nostro punto <strong>di</strong> partenza – la recensione dei testi<br />
non sempre supporta l’idea che gli utenti aderiscano a una convenzione.<br />
La selezione e l’analisi <strong>di</strong> una conversazione a lungo termine su Twitter<br />
(in questa sede contributo Logozzo) fa rilevare, contestualmente, nello<br />
stesso utente, l’impiego della forma ab<strong>brevi</strong>ata, o estesa, o spesso<br />
variamente ab<strong>brevi</strong>ata, <strong>di</strong> una stessa parola.<br />
Piuttosto da tali analisi specifiche deriva come l’esame e la<br />
classificazione delle forme annunci l’adesione non già a lessici<br />
standar<strong>di</strong>zzati, quanto invece a ciò che vorremmo definire una sorta <strong>di</strong><br />
“grammatica” o “sistema <strong>di</strong> regole” rispondenti a criteri <strong>di</strong> funzionalità<br />
relativa alla <strong>di</strong>mensione della “<strong>brevi</strong>tà” (Dardano&De Roberto&Frenguelli<br />
2008; Held&Schwarze 2011; Chiusaroli&Zanzotto in stampa).<br />
4. Per una storia delle scritture <strong>brevi</strong><br />
A tale scopo apparirà utile inquadrare i tipi <strong>di</strong> scritture <strong>brevi</strong> del web<br />
all’interno <strong>di</strong> una più vasta considerazione delle fenomenologie, per<br />
procedere a una loro considerazione sincronica, in senso tipologico, ma<br />
anche <strong>di</strong>acronica, istituendo confronti con sistemi grafici e ab<strong>brevi</strong>ativi<br />
contemporanei o succedentisi, storicamente sperimentati.
F. Chiusaroli 15<br />
Come è noto, al <strong>di</strong> là delle specifiche casistiche, la storia della scrittura<br />
ha proceduto nel corso del tempo a una progressiva ristrutturazione del<br />
proprio impianto, nel perseguimento del principio della linearità del<br />
significante, ovvero fonetico/fonologico, pertanto abbandonando forme<br />
grafiche iniziali, come quelle ricostruite per le fasi<br />
pittografiche/ideografiche/logografiche, stilizzando, astrattizzando e infine<br />
specializzando man mano i <strong>di</strong>segni, trasformandoli in segni istituiti e<br />
convenzionali espressioni <strong>di</strong> valenze sillabiche e fonetiche, perdendo infine<br />
ogni relazione <strong>di</strong>retta e “naturale” coi referenti (Cardona 1981; Cardona<br />
1986a).<br />
Così come, tuttavia, i sistemi grafici storici hanno <strong>di</strong> fatto conservato<br />
elementi dei precedenti sta<strong>di</strong>, configurandosi come sommatoria <strong>di</strong> meto<strong>di</strong><br />
grafici mistiformi (Valeri 2000), anche la pratica del texting mostra <strong>di</strong><br />
recuperare tale somma <strong>di</strong> varietà utilizzandone le singole realizzazioni<br />
all’occorrenza all’interno del medesimo linguaggio/<strong>di</strong>scorso.<br />
Si tratta, ovvero, <strong>di</strong> verificare, nelle scritture <strong>brevi</strong> <strong>di</strong> <strong>oggi</strong>, la<br />
permanenza e la convivenza <strong>di</strong> forme grafiche appartenenti non più o non<br />
soltanto ai principi della tra<strong>di</strong>zione alfabetica, bensì a <strong>di</strong>verse tipologie<br />
(Pulgram 1976; Frutiger 1996), semasiografiche o glottografiche,<br />
rispondenti alle plurime esigenze rese funzionali per la scrittura del<br />
messaggio <strong>di</strong>gitale <strong>di</strong> testo.<br />
Contro la <strong>di</strong>ffidenza e l’ostilità <strong>di</strong>ffuse nei confronti <strong>di</strong> pratiche<br />
attribuite con biasimo ai gerghi giovanili, andrà inoltre osservato come<br />
analoghi principi costitutivi possano essere riscontrati nei sistemi delle<br />
ab<strong>brevi</strong>ature che, nonostante la storica supremazia del modello alfabetico<br />
(Martin 1990; Harris 1998; Harris 2003), convivono in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong>afasiche<br />
nelle grafie specialistiche (in questa sede Reali), come, dall’età antica, la<br />
paleografia, la <strong>di</strong>plomatica e l’epigrafia, oppure nei sistemi tachigrafici e<br />
stenografici (Battelli 1939; Paoli 1891 e 1987; Bischoff 1992; Cencetti 1997).<br />
In tali ambiti il principio della convenzione si associa, integrandosi,<br />
all’esigenza funzionalista, dando luogo spesso a <strong>di</strong>zionari in cui convivono<br />
forme incongruenti, <strong>di</strong>somogenee, irregolari (Cappelli 1990), la cui<br />
legittimità è innanzi tutto salvaguardata dal prestigio della fonte, ma anche<br />
dai meccanismi pratici che asseverano il funzionamento del sistema.<br />
In chiave sincronica, la comparazione interlinguistica fa altresì osservare<br />
la ricorrenza <strong>di</strong> meccanismi ab<strong>brevi</strong>ativi in parte specifici, ma in parte<br />
anche comuni alle <strong>di</strong>verse lingue, precipuamente collegati vuoi al <strong>di</strong>verso<br />
carattere tipologico delle lingue o alla efficacia fonologica della loro norma
16<br />
<strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong> <strong>oggi</strong>: tra convenzione e sistema<br />
grafica standard, vuoi alla finalità dell’atto comunicativo, oltre che<br />
all’adesione a stili convenzionali. Se la scrittura può essere attività<br />
universale dell’uomo (Cardona 1990 [1986b]), certamente generali<br />
appaiono i meccanismi che regolano le pratiche dell’accorciatura grafica.<br />
Alcuni semplici confronti interlinguistici ci mostrano l’applicazione <strong>di</strong><br />
tecniche ripetute e assimilabili – ciò che in questa sede chiameremo<br />
“regole”.<br />
5. Tipi e regole<br />
5.1 Grafie fonologiche<br />
Risponde a necessità <strong>di</strong> <strong>brevi</strong>tà, velocità, sintesi, eliminazione della<br />
ridondanza, la rappresentazione grafica della parola sulla base della<br />
riproduzione della pronuncia, replicando in tal modo, con perfetta<br />
corrispondenza, alla richiesta mimesi col parlato e con la <strong>di</strong>mensione orale<br />
del messaggio. La pratica riduce al minimo la lunghezza grafica,<br />
recuperando la corrispondenza biunivoca suono/segno che è il presupposto<br />
originario, ideale, successivamente perduto, del sistema alfabetico.<br />
Ecco dunque l’adozione dei caratteri -‐‑ lettere/numeri/simboli -‐‑ per<br />
sostituire sequenze foniche e parole (Crystal 2001):<br />
inglese:<br />
= “be”<br />
= “see”<br />
= “are”<br />
= “you”<br />
= “why”<br />
= “for/fore”<br />
= “to/too”<br />
= “-‐‑ate”<br />
inglese:<br />
“to be or not to be”<br />
= “see you”<br />
italiano:
= “perché”<br />
= “che fai?”<br />
= “ci sei?”<br />
F. Chiusaroli 17<br />
Lo storico grado <strong>di</strong> allontanamento della grafia inglese dalla<br />
<strong>di</strong>mensione fonologica -‐‑ rispetto al tratto altamente fonetico della scrittura<br />
dell’italiano -‐‑ può darci spiegazione della speciale fortuna della pratica del<br />
texting per l’inglese (Baron 2000) e della grande abbondanza dei fenomeni<br />
in tale lingua, ma anche giustifica la varietà e la pluralità degli esiti, o la<br />
non univocità delle opzioni negli scriventi.<br />
Per l’italiano, al numero minore delle soluzioni fanno da contraltare la<br />
saldezza e la costante occorrenza <strong>di</strong> alcuni esiti, fissi e pressoché<br />
standar<strong>di</strong>zzati, al limite dell’automatismo, come l’uso della lettera per<br />
sostituire il poco economico “ch”, <strong>di</strong>lagante oltre i limiti dell’impiego<br />
gergale. Per altro, è ben noto già nella scrittura dei writers degli anni ’70<br />
l’impiego <strong>di</strong> nei graffiti e nelle scritte murali -‐‑ una lettera che è,<br />
all’origine, visiva manifestazione dell’anima giovanile della protesta<br />
sessantottina, della sua ispirazione anarchica e sovranazionale, espressiva,<br />
anche nella sonorità espressa dal fono occlusivo sordo, dei sentimenti della<br />
rabbia e del <strong>di</strong>sprezzo delle regole <strong>di</strong>chiarati dai movimenti punk e rock<br />
(entrambi nomi con ).<br />
Ancora per l’italiano, è guidata dal principio fonologico l’adozione dei<br />
segni matematici per “più, meno, per”, che si trova all’origine del<br />
grossolano “Bixio/Biperio”, ma la cui esistenza può essere rintracciata nella<br />
grafia giovanile degli “appunti” già da prima dell’avvento dei cellulari.<br />
Costituisce una pratica comune a varie lingue l’impiego dei numerali<br />
arabi per la loro valenza fonetica (it. = “sei”; ingl. = “for”), adozione<br />
generale che, nel caso specifico, attesta la non universalità della lettura dei<br />
segni e piuttosto la loro <strong>di</strong>retta relazione con il sistema linguistico dato e<br />
con la corretta competenza <strong>di</strong> esso.<br />
Il medesimo richiamo alla <strong>di</strong>mensione linguistica <strong>di</strong> riferimento è alla<br />
base della appropriata e “relativa” decifrazione <strong>di</strong> forme <strong>brevi</strong> come ,<br />
che vale “ci” per un utente <strong>di</strong> lingua italiana e “see” (o anche “sea”) per un<br />
parlante/scrivente inglese.<br />
5.2 Grafie consonantiche
18<br />
<strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong> <strong>oggi</strong>: tra convenzione e sistema<br />
Tipiche forme ab<strong>brevi</strong>ative risultano dalla consuetu<strong>di</strong>ne della<br />
soppressione <strong>di</strong> elementi dal corpo grafico della parola:<br />
= “thanks”<br />
= “domani, <strong>oggi</strong>, vedo/vado, non, sono,<br />
grazie”<br />
= “<strong>oggi</strong> non vado”<br />
Il denunciato <strong>di</strong>sorientamento dell’utente non esperto <strong>di</strong> fronte a nuclei<br />
totalmente composti <strong>di</strong> consonanti può essere attribuibile a scarsità <strong>di</strong><br />
consapevolezza metalinguistica, ma più presumibilmente sarà da<br />
addebitare a posizioni <strong>di</strong> pregiu<strong>di</strong>zio, lì dove intuitivamente appare<br />
operazione abbastanza imme<strong>di</strong>ata ed istintiva ricostruire il senso <strong>di</strong> una<br />
parola derivandolo dalla struttura consonantica (non solo grafica).<br />
A tale riguardo ricor<strong>di</strong>amo che risiede fra i fondamentali presupposti<br />
della teoria dell’informazione l’idea che, nelle parole, la qualità informativa<br />
sia massimamente veicolata dalle consonanti piuttosto che dalle vocali<br />
(Barr 1976). Numerosi ed acclarati sono i casi <strong>di</strong> esperimenti volti a<br />
asseverare il <strong>di</strong>verso grado <strong>di</strong> <strong>di</strong>pendenza della intelligibilità <strong>di</strong> un<br />
messaggio scritto dalla presenza dei caratteri che richiamano certe<br />
componenti sonore e non altre, così che è <strong>di</strong>mostrato come si possa<br />
decifrare senza errori un testo scritto senza, o con poche, vocali<br />
(Lee&Rayner&Pollatsek 2001). Allo stesso modo l’assuefazione<br />
all’esperienza della <strong>di</strong>mensione scritta della lingua, acquisita con la cultura<br />
della scolarizzazione cui sin da bambini siamo sottoposti, determina<br />
l’acquisizione <strong>di</strong> una percezione “gestaltica”, non sempre reale, della forma<br />
scritta, che ci consente <strong>di</strong> leggere correttamente parole contenenti errori <strong>di</strong><br />
stampa o refusi tipografici (Cardona 1981).<br />
In termini <strong>di</strong> confronto storico, sarà inoltre da ricondurre alla medesima<br />
prospettiva la scelta, operata nelle fasi dello sviluppo dei primi sistemi<br />
grafici alfabetici, <strong>di</strong> istituire apparati solo consonantici, quali sono<br />
testimoniati dalle antiche scritture semitiche, fenicio, arabo, ebraico. Mentre<br />
non si dà tra<strong>di</strong>zione alfabetica che attesti la notazione <strong>di</strong> sole vocali, risulta<br />
tra le tipologie ab<strong>brevi</strong>ative della tra<strong>di</strong>zione paleografica la trascrizione <strong>di</strong><br />
parole composte dalle componenti solamente consonantica (<br />
“Dominus”; “sanctus”) o solamente vocalica ( “anima”).
5.3. Grafie tronche<br />
F. Chiusaroli 19<br />
Entrano nel novero dei proce<strong>di</strong>menti ab<strong>brevi</strong>ativi ad ampia <strong>di</strong>ffusione le<br />
tecniche <strong>di</strong> apocope, troncamento ed elisione, eliminazioni <strong>di</strong> “porzioni”<br />
della parola che appaiono ininfluenti rispetto alla salvaguar<strong>di</strong>a del<br />
principio informativo:<br />
= “andare/an<strong>di</strong>amo/andate”<br />
= “compleanno”<br />
La particolare varietà degli esiti riferiti dai <strong>di</strong>zionari delle ab<strong>brevi</strong>azioni<br />
della rete è spesso dovuta alle polimorfiche possibilità <strong>di</strong> lettura <strong>di</strong> forme<br />
grafiche che costituiscono i lessemi delle parole, alle quali l’elemento<br />
morfologico o desinenziale viene sottratto in quanto giu<strong>di</strong>cato facilmente<br />
ricostruibile dal corpo sintattico della frase. Tale proce<strong>di</strong>mento appare<br />
particolarmente fecondo, produttivo e ricorrente nel caso <strong>di</strong> lingue a<br />
componente morfologica flessiva, lì dove la parte semantica e quella<br />
grammaticale sono facilmente <strong>di</strong>stinguibili e risultano dotate <strong>di</strong> valore<br />
informativo reciprocamente non equivalente.<br />
Significativamente, moltissime equivalenze, con casi <strong>di</strong> plurivoche<br />
letture, si trovano della pratica del troncamento delle desinenze nella<br />
paleografia latina: “nomen”, “<strong>di</strong>xit, “fecerunt”,<br />
“accepit/acceperunt” (Battelli 1939).<br />
5.4. Scriptio continua<br />
Frequente è la soppressione delle separazioni grafiche tra le parole,<br />
proce<strong>di</strong>mento in uso anche nella lingua standard e che appare storicamente<br />
alla base <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficazioni indotte sulla lingua dalle caratteristiche della<br />
scrittura del parlato. Certe perplessità, registrate dai <strong>di</strong>zionari della lingua<br />
italiana (http://www.accademiadellacrusca.it/faq/faq_risp.php?id=4026&<br />
ctg_id=93), circa la corretta scrittura <strong>di</strong> alcune locuzioni avverbiali o<br />
preposizionali, conducono non raramente all’accoglimento, nello standard,<br />
della duplice opzione, unita o <strong>di</strong>sgiunta, dell’espressione, esplicito segnale<br />
del carattere del tutto convenzionale dell’isolamento dell’unità “parola”<br />
scritta nella scrittura alfabetica.<br />
Analogamente attestate nella sincronia e nella <strong>di</strong>acronia dell’italiano<br />
sono formazioni riproducenti esiti fonetici <strong>di</strong> processi legati al continuum
20<br />
<strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong> <strong>oggi</strong>: tra convenzione e sistema<br />
tipico della catena fonica (sui con<strong>di</strong>zionamenti tra scritto e orale<br />
nell’italiano cfr. almeno Serianni 2003 e Trifone 2007):<br />
= <br />
= <br />
= <br />
= <br />
= <br />
= <br />
= <br />
= <br />
= <br />
o processi <strong>di</strong> assimilazione per coarticolazione:<br />
= <br />
= <br />
= <br />
= <br />
= <br />
= <br />
http://ebookpdf.files.wordpress.com/2008/10/come-‐‑si-‐‑scrive-‐‑prontuario.pdf<br />
Già variamente attestate nella scrittura epigrafica e paleografica (con le<br />
connesse derivanti problematiche <strong>di</strong> deco<strong>di</strong>fica e <strong>di</strong>sambiguazione), la<br />
legatura e la scriptio continua, insieme alla assenza/omissione della<br />
punteggiatura, risultano sicuri proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> risparmio anche nell’sms e<br />
nelle chat, in cui è prevalente la pratica della eliminazione <strong>di</strong> segni <strong>di</strong><br />
interpunzione o spaziature non significativi o giu<strong>di</strong>cati irrilevanti per la<br />
comprensione, determinando grafie sintetiche dal pertinente effetto<br />
fonetico (esempio: = “c’è”).
5.5. Acronimie<br />
F. Chiusaroli 21<br />
Principio produttivo tra i meccanismi ab<strong>brevi</strong>ativi più comuni è la<br />
contrazione acronimica o inizialismo, agente attivissimo nella formazione<br />
delle parole e delle frasi nella lingua della rete come nel lessico comune<br />
(Calvet 1980; in questa sede Di Pace&Pannain e, con riferimento alla<br />
traduzione, Lefèvre).<br />
L’uso <strong>di</strong> ab<strong>brevi</strong>are per singulam litteram (cfr. Valerio Probo, De litteris<br />
singularibus), anziché scrivere per esteso alcune parole, risulta praticamente<br />
coevo, o almeno poco meno antico della scrittura alfabetica stessa, ed è<br />
legato, oltre che alle con<strong>di</strong>zioni degli impieghi epigrafici e manoscritti,<br />
all’alta frequenza d’uso delle parole, così usuali da rendere ridondante la<br />
versione estesa delle forme: “Senatus Populusque Romanus”,<br />
“ab Urbe con<strong>di</strong>ta” (Cencetti 1997).<br />
Sono frutto della fortuna garantita dalla scrittura della rete -‐‑ il<br />
cosiddetto netspeak -‐‑ alcuni neologismi ora acquisiti ufficialmente nella<br />
norma grafica e linguistica, secondo le consuete trafile <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffusione e<br />
integrazione delle forme speciali o gergali nella lingua comune (in questa<br />
sede Marroni), fino al loro inserimento nei <strong>di</strong>zionari dello standard.<br />
Il termine sms è acronimo dell'ʹinglese Short Message Service ed è ad<br />
esempio comunemente usato per in<strong>di</strong>care un “breve messaggio <strong>di</strong> testo” (il<br />
“messaggino”) inviato da un telefono cellulare ad un altro. Il termine<br />
corretto sarebbe SM (Short Message), ma ormai è invalso l'ʹuso <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care il<br />
singolo messaggio col nome del servizio, quin<strong>di</strong> utilizzando sms con valore<br />
sostantivale (“inviare un sms”, “<strong>di</strong>gitare un sms”). Evidentemente per<br />
analogia con sms si è imposta successivamente la forma mms, acronimo <strong>di</strong><br />
Multime<strong>di</strong>a Messaging Service, che vale “messaggio multime<strong>di</strong>ale”.<br />
Derivante dallo stesso contesto, T9 nasce come acronimo <strong>di</strong> Text on 9<br />
(keys), nome del relativo software, inventato da Tegic Communication,<br />
mentre ora vale “Dizionario T9”.<br />
Il successo della forma (breve) e-‐‑mail (da electronic mail) può essere posto<br />
alla base dell’acquisizione del prefisso e-‐‑ come formante per nomi <strong>di</strong><br />
prodotti collegati concettualmente alla posta elettronica, come e-‐‑commerce,<br />
e-‐‑business, e-‐‑bay, e-‐‑book, progressivamente acquisiti come prestiti<br />
nell’italiano, con interessanti formazioni paronomastiche, quali ad esempio<br />
il termine e-‐‑mule, per cui la resa senza trattino separatore (comune anche<br />
per le voci precedenti) emule configura felicemente l’idea della<br />
“riproduzione”, fatalmente “non autorizzata”, <strong>di</strong> cui il logo dell’asinello
22<br />
<strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong> <strong>oggi</strong>: tra convenzione e sistema<br />
(mule) può rendere concretamente l’immagine. L’attivazione <strong>di</strong> analogo<br />
proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> scomposizione e ricomposizione <strong>di</strong> pezzi <strong>brevi</strong> della<br />
parola si riconosce nella costituzione e imme<strong>di</strong>ata fortuna <strong>di</strong> una<br />
formazione come g-‐‑mail, che riproduce il concetto <strong>di</strong> e-‐‑mail<br />
specializzandolo sull’iniziale del più famoso motore <strong>di</strong> ricerca dalla<br />
contrazione del più lungo Google mail (dal 4 luglio 2005).<br />
Ad <strong>oggi</strong> una delle più fortunate trafile per una formazione breve appare<br />
rappresentata dal gruppo <strong>di</strong> parole dell’universo Apple, lì dove la prima<br />
formazione i-‐‑Mac (i-‐‑ equivale a Internet ed è poi il pronome I, espressione<br />
felicissima della tendenza alla personificazione e personalizzazione tipiche<br />
della tra<strong>di</strong>zione Apple: ricor<strong>di</strong>amo che nel 1998 il primo modello si<br />
presentò da solo grazie a un programma <strong>di</strong> sintesi vocale Hallo, I’m<br />
McIntosh) ha guidato la costruzione della serie dei nomi dei <strong>di</strong>spositivi i-‐‑<br />
Pod (Pod dalla navicella del film <strong>di</strong> Kubrick 2001: O<strong>di</strong>ssea nello spazio), i-‐‑<br />
Phone, i-‐‑Pad (Pad è la tavoletta dell’amanuense), i prodotti i-‐‑Book<br />
(omofonico ma più fortunato <strong>di</strong> e-‐‑book) e i-‐‑Tunes, <strong>oggi</strong> manifestazioni <strong>di</strong><br />
un vero e proprio stile <strong>di</strong> vita -‐‑ i-‐‑Life – dentro l’universo Mac.<br />
La correlazione che si instaura tra la notorietà e l’uso comporta la<br />
convenzionalizzazione <strong>di</strong> forme grafiche spontanee e la loro <strong>di</strong>ffusione al<br />
<strong>di</strong> là dei confini nazionali originari. La sequenza a due lettere è oramai<br />
Facebook per tutto il mondo, e la forma breve è realizzata dalle iniziali degli<br />
elementi del composto.<br />
Gli effetti, anche in questo caso, vanno oltre la creatività dello scrivente,<br />
fino a con<strong>di</strong>zionare la strutturazione dei sistemi pre<strong>di</strong>ttivi nel trattamento<br />
automatico del linguaggio naturale, come nei <strong>di</strong>zionari intuitivi o nel<br />
motore <strong>di</strong> ricerca.<br />
Le nuove funzioni <strong>di</strong> Google come “Instant” e “Suggest”<br />
(http://www.google.it/instant/;<br />
http://www.google.it/support/websearch/bin/answer.py?answer=106230) si<br />
basano sulla pre-‐‑selezione e la proposta dei risultati della ricerca partendo<br />
dalla <strong>di</strong>gitazione degli elementi ritenuti più informativi nella frase (Herring<br />
2012b), ad esempio privilegiando le consonanti rispetto alle vocali, i<br />
morfemi lessicali rispetto a quelli grammaticali, i sostantivi e i verbi<br />
rispetto alle preposizioni e alle congiunzioni, o attraverso la deduzione del<br />
risultato dalle prime lettere della parola ricercata ( > Facebook). E si tratta,<br />
come si vede, <strong>di</strong> un effetto con valenza ideologica indotto dalla pratica<br />
delle scritture <strong>brevi</strong> (Shirky 2010).
F. Chiusaroli 23<br />
Entra nel novero dei proce<strong>di</strong>menti acronimici il notissimo “ti<br />
voglio bene”, acclimatato nella scrittura giovanile e conseguentemente<br />
declinato in forme più lunghe, anche con commistioni multilingui, un<br />
fenomeno che, tra l’altro, mette in rilievo la motivazione lu<strong>di</strong>ca, <strong>di</strong> gioco<br />
con la lingua (Crystal 1998), che provoca tipici allungamenti “ridondanti”<br />
delle scritture <strong>brevi</strong>:<br />
“ti voglio tanto bene, ti voglio tantissimo bene”<br />
“ti voglio un casino <strong>di</strong> bene e oltre forever”<br />
La <strong>di</strong>mensione globalizzante indotta dal fenomeno della rete si<br />
riconosce nella <strong>di</strong>ffusione, in italiano, della forma contratta LOL, acronimo<br />
<strong>di</strong> “loughing out loud” o “lough out loud”, espressione enfatica della risata<br />
fragorosa, e della forma OMG, ab<strong>brevi</strong>azione convenzionalizzata<br />
dell’esclamazione “Oh my God!”, entrambi ben <strong>di</strong>ffusi nella messaggistica<br />
istantanea come sequenza grafica compatta, con effetti semantici in qualche<br />
modo riconducibili al caso della composizione delle formazioni<br />
onomatopeiche attestate nella lingua dei fumetti e in particolare nelle<br />
traduzioni dalla lingua inglese dei testi fumettistici della tra<strong>di</strong>zione<br />
<strong>di</strong>sneyana (Pietrini 2007; in questa sede Dovetto).<br />
5.6. <strong>Scritture</strong> a effetto<br />
Si classifica nel novero delle espressioni <strong>di</strong>gitali giovanili la pratica <strong>di</strong><br />
alterazione della struttura grafica standard della parola tramite<br />
sostituzione <strong>di</strong> lettere con caratteri alternativi. Le corrispondenze sono in<br />
tali casi istituite attraverso lo sfruttamento <strong>di</strong> certe analogie visive o anche<br />
in ragione <strong>di</strong> suggestioni ed evocazioni a marca esterofila (anglofila) o<br />
comunque per il richiamo internazionalizzante.<br />
Costituisce occasione importante <strong>di</strong> manifestazione identitaria dello<br />
scrivente l’ideazione del nickname (ora nick), che graficamente rappresenta<br />
una sorta <strong>di</strong> passaporto della personalità, una sintetica rivelazione del sé-‐‑<br />
<strong>di</strong>gitale che precede o accompagna, siglandola, ogni comunicazione (in<br />
questa sede Caffarelli). L’esigenza, talora imposta dal sistema, <strong>di</strong> evitare<br />
omonimie o omografie, determina la creazione <strong>di</strong> stringhe nominali<br />
autografe ottenute combinando lettere e numeri, come le lettere del nome,<br />
o del nomignolo (nome breve), e i numeri della data <strong>di</strong> nascita. Nei casi,<br />
parimenti frequenti, <strong>di</strong> “nomi in co<strong>di</strong>ce” o “nomi d’arte” si assiste
24<br />
<strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong> <strong>oggi</strong>: tra convenzione e sistema<br />
all’applicazione <strong>di</strong> caratteri sostitutivi che garantiscono l’originalità senza<br />
mettere a repentaglio la corretta lettura: per il principio della analogia<br />
visiva si creano associazioni <strong>di</strong> segni come = “A”; = “E”, da cui, ad<br />
esempio, originano formazioni <strong>di</strong> nick come o<br />
.<br />
Entrano nella medesima tipologia le sostituzioni <strong>di</strong> parti della parola<br />
(evidentemente avvertite come non fondamentali) che uniscono le<br />
potenzialità evocative e la pressione ab<strong>brevi</strong>ativa, quale è l’impiego<br />
sperequativo della in = “compleanno”, = “Camilla”,<br />
raddoppiata, triplicata, senza motivazione razionale:<br />
= “bellissimo”<br />
= “benissimo”<br />
perchè la x al posto delle 2 esse? boo<br />
Ciao!<br />
Vabè capisco magari perchè scriverlo "ʺxke"ʺ bene o male un senso ce l'ʹha (x
F. Chiusaroli 25<br />
Alla sostanziale specializzazione della punteggiatura per scopi lu<strong>di</strong>ci ed<br />
espressivi corrisponde l’impiego non ortodosso dei segni paragrafematici<br />
nelle scritture <strong>brevi</strong>. Nel messaggio e-‐‑mail è ancora attestato un certo grado<br />
<strong>di</strong> adesione alle norme corrette – alternanza <strong>di</strong> punto/virgola,<br />
maiuscole/minuscole, uso dell’accapo – ma il livello <strong>di</strong> accuratezza è<br />
relativo al ruolo dello scrivente e alla <strong>di</strong>mensione comunicativa <strong>di</strong>afasica;<br />
nelle conversazioni per chat l’identificazione pressoché totale col parlato e<br />
la forte pressione del ritmo comunicativo determinano per lo più la<br />
soppressione <strong>di</strong> ogni atto <strong>di</strong> <strong>di</strong>gitazione che possa alterare il processo della<br />
scrittura continua senza determinare effetti informativi.<br />
5.8. Pittogrammi e ideografie<br />
Non potrà essere omesso, anzi è caratteristica fondamentale della<br />
scrittura che ci interessa, l’impiego dei cosiddetti emoticons, inglese smileys,<br />
per noi anche faccine (Crystal 2004).<br />
Realizzati in modalità pittografica, inizialmente ricavati componendo<br />
figure <strong>di</strong> “sguar<strong>di</strong>” attraverso segni <strong>di</strong> punteggiatura (da guardare con la<br />
testa chinata a sinistra), sopperiscono quasi senza necessità <strong>di</strong><br />
interme<strong>di</strong>azione al vuoto intonativo che è la più rilevante fra le<br />
insufficienze pragmatiche della comunicazione scritta (Dresner&Herring<br />
2010):<br />
:-‐‑) felicità<br />
:-‐‑( tristezza<br />
:-‐‑D risata<br />
:-‐‑P linguaccia<br />
Tali segni hanno tra l’altro conosciuto una propria evoluzione in termini<br />
<strong>di</strong> <strong>brevi</strong>tà, essendo stati presto soppressi i tratti evidentemente avvertiti<br />
come non necessari:<br />
:) :( :D :P<br />
Gli smileys ccompagnano dunque l’espressione scritta, esplicitando<br />
l’umore del mittente o la modulazione del messaggio, ma ad<strong>di</strong>rittura<br />
possono felicemente sostituire la scrittura, lì dove la faccina sorridente può<br />
ad esempio rimpiazzare il sì! scritto, più efficacemente della opaca parola,
26<br />
<strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong> <strong>oggi</strong>: tra convenzione e sistema<br />
l’icona mostrando senz’altro il massimo potenziale in termini <strong>di</strong><br />
rappresentatività e <strong>di</strong> espressività.<br />
Elementi della medesima tipizzazione, come gli smileys dotati <strong>di</strong> grande<br />
efficacia comunicativa <strong>di</strong>retta, ideale connubio tra <strong>brevi</strong>tà ed effetto, i<br />
simboli, <strong>di</strong>segnini e forme, si sono in pochi anni moltiplicati,<br />
particolarmente nei linguaggi delle chat, in un certo senso riportando la<br />
scrittura alla propria origine. Fra tutti è certamente sovrano (e nato ben<br />
prima dell’sms) il cuore, che universalmente vale love/amore.<br />
La costruzione iconica del cuore con i due segni
F. Chiusaroli 27<br />
L’altissima occorrenza <strong>di</strong> tali figure ideografiche, <strong>di</strong>sseminate lungo il<br />
corso <strong>di</strong> ogni conversazione in chatgroup, manifesta il particolare<br />
ren<strong>di</strong>mento funzionale della scrittura breve: la collocazione regolare del<br />
simbolo in chiusura della frase <strong>di</strong>gitata, o, come spesso avviene, la<br />
presenza dell’icona quale unico elemento del rigo a scopo <strong>di</strong> commento o<br />
<strong>di</strong> replica, denotano l’importanza annessa all’espressione <strong>di</strong> stati d’animo,<br />
emozioni, reazioni istintive, rispetto alla sostanza del messaggio. La<br />
frequenza appare spesso correlata alle comuni necessità del turn taking e<br />
del floor taking, secondo i meccanismi rilevati dall’analisi conversazionale,<br />
in questo caso nelle particolari con<strong>di</strong>zioni della interazione sincrona a<br />
<strong>di</strong>stanza (Bazzanella 2005b e 2005c; Pistolesi 2005b).<br />
6. Le varianti: grammatica, sintassi, convenzione e sistema<br />
Le possibili, molteplici letture <strong>di</strong> una stessa forma mettono in campo<br />
ulteriori questioni importanti, che sono, oltre al dato della convenzione,<br />
l’ambiguità, la correttezza, i tempi. Si osservino gli esempi:<br />
“vedo una casa”<br />
“vado a casa”<br />
Se può essere “vedo” e “vado”, sarà la catena sintattica a far<br />
decidere per la corretta interpretazione; ovvero saussurianamente, le<br />
relazioni para<strong>di</strong>gmatiche e sintagmatiche daranno luogo a processi <strong>di</strong><br />
combinazione e selezione, privilegiando le forme <strong>brevi</strong> prevalentemente, se<br />
non in assoluto, nei casi in cui esse non determinino letture ambigue od<br />
oscure (Chiusaroli 2012).<br />
Osservando la questione dalla parte dello scrivente, la velocità imposta<br />
dalla pressione della catena e del sistema costituirà un limite naturale agli<br />
esiti regolari, determinando piuttosto produzioni grafiche apparentemente<br />
contrad<strong>di</strong>ttorie, quali scritture incongruenti, ma anche automatismi. Il<br />
dubbio <strong>di</strong> poter non essere bene interpretati, o fraintesi, potrà farci optare<br />
per la forma considerata più popolare, oppure per la forma estesa anziché<br />
ab<strong>brevi</strong>ata, ed ecco il margine <strong>di</strong> elasticità consentito dai linguaggi non<br />
stabilizzati (Bazzanella&Baracco 2003) (ricor<strong>di</strong>amo che anche nella<br />
stenografia classica le ab<strong>brevi</strong>azioni sono fisse e facoltative; Giulietti 1968).<br />
Come nelle lingue l’economia è principio <strong>di</strong> valutazione posteriore, ma<br />
non pre<strong>di</strong>ttivo, dei fenomeni, ed è principio relativo e non assoluto
28<br />
<strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong> <strong>oggi</strong>: tra convenzione e sistema<br />
(Martinet 1966 e 1984), così nelle scritture <strong>brevi</strong> l’economia non è<br />
incon<strong>di</strong>zionata, lì dove un eccesso <strong>di</strong> economia può mandare in crisi il<br />
principio della comprensibilità, ciò che sarà <strong>di</strong> nuovo, ed altamente,<br />
antieconomico (Chiari 2002).<br />
Secondo la premessa enunciata, la norma grafica dovrà dunque essere<br />
subor<strong>di</strong>nata alle <strong>di</strong>namiche della pragmatica comunicativa; tuttavia lo<br />
stesso principio normativo risulterà ugualmente attivo, operando, ancora<br />
per motivi <strong>di</strong> economicità, nel senso <strong>di</strong> favorire un contenimento effettivo<br />
delle spinte centrifughe indotte dalle varianti isolate ed estemporanee<br />
(Herring 2012b).<br />
Entra pertanto nella nostra prospettiva la funzione della scrittura<br />
normata, per la quale non soltanto vale il grande potente principio<br />
sociolinguistico del prestigio e del gruppo dei pari (si scrive come scrivono<br />
tutti, si scrive come scrivono i migliori), ma lo stesso canone dell’economia<br />
comporta l’adeguamento <strong>di</strong> necessità a regole più o meno con<strong>di</strong>visibili, e<br />
dunque spinge verso la convenzione. Soltanto con un buono sforzo <strong>di</strong><br />
cooperazione la lettera può essere letta come “grazie”, mentre ha<br />
maggiori possibilità <strong>di</strong> essere correttamente recepito. La <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong><br />
, già favorita dalla positiva valenza del gruppo consonantico, è per lo<br />
stesso motivo facilmente promossa al rango <strong>di</strong> ab<strong>brevi</strong>azione “ufficiale”<br />
(convenzionale).<br />
È giusto osservare passivamente il <strong>di</strong>lagare <strong>di</strong> queste forme nella<br />
comunicazione <strong>di</strong> <strong>oggi</strong>?<br />
7. Fortuna e ideologia<br />
Per placare le <strong>di</strong>ffuse inquietu<strong>di</strong>ni andrà detto – e questo potrebbe<br />
andare a svantaggio del nostro <strong>di</strong>scorso – che, al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> fenomeni isolati,<br />
l’uso delle ab<strong>brevi</strong>azioni nei messaggi raramente travalica i confini del<br />
contesto rappresentato dalla rete. Ogni ragazzo sa quando sia il caso o<br />
meno <strong>di</strong> utilizzarle; ognuno sa che non si scrive nei compiti a scuola, o<br />
comunque la formazione scolastica istituisce presto il corretto <strong>di</strong>scrimen<br />
degli usi e delle competenze. Le ab<strong>brevi</strong>azioni elencate nei relativi<br />
<strong>di</strong>zionari on line in alcuni casi appartengono già alla lingua dell’uso, altre<br />
volte sono forme isolate, che spesso compaiono in un’unica occorrenza, non<br />
reiterate neppure dallo stesso utente. Si tratta pertanto <strong>di</strong> fenomeni creativi<br />
spontanei che non intaccano la fissità della norma.
F. Chiusaroli 29<br />
Ma non potrà essere <strong>di</strong>sconosciuta la spen<strong>di</strong>bilità delle scritture <strong>brevi</strong> e<br />
la loro <strong>di</strong>lagante <strong>di</strong>ffusione nei settori comunicativi della nuova società<br />
globale (Van Dijk 2002; Granelli 2006 e in questa sede; Granelli&Sarno<br />
2007; De Kerckhove 2008).<br />
Si sa che tvb <strong>oggi</strong> è la marca <strong>di</strong> un succo <strong>di</strong> frutta, gli smileys fanno<br />
capolino nei manifesti pubblicitari. Non sorprende insomma la recettività<br />
<strong>di</strong> tali forme da parte del linguaggio creativo dei me<strong>di</strong>a, per l’efficacia, la<br />
sintesi, l’appeal sulle generazioni giovani.<br />
Effetto positivo della potenza della rete è stato l’allargamento della<br />
mutua comprensibilità, vuoi nei termini della <strong>di</strong>ffusione ad ampio spettro<br />
<strong>di</strong> quella specie <strong>di</strong> lingua universale che è l’inglese <strong>di</strong> internet, ma vuoi<br />
anche, per la varietà e la contrad<strong>di</strong>ttorietà che è tipica delle cose umane,<br />
ovvero vive, per le forme <strong>di</strong> un nuovo e positivo multilinguismo (anche<br />
come rivitalizzazione dei <strong>di</strong>aletti), essendoci un posto per tutti nelle infinite<br />
pagine del libro virtuale.<br />
Ma qui è l’occasione per considerare, fra gli esiti positivi della<br />
globalizzazione, la scrittura breve, che ha, fra i suoi pregi, quello <strong>di</strong> unire<br />
tutte le lingue, in lungo e in largo, passate e presenti, in quanto è pratica<br />
universale dell’uomo, riscontrata in tutte le epoche, l’ab<strong>brevi</strong>azione (alla<br />
ricerca delle leggi “generali” delle ab<strong>brevi</strong>ature latine, ad esempio,<br />
Schiaparelli 1926 e Battelli 1939).<br />
Il carattere imperioso delle scritture nazionali tende a confinare le<br />
costruzioni ab<strong>brevi</strong>ate nell’alveo <strong>di</strong> settori specialistici, ma non raramente<br />
si assiste al collocamento delle forme nel sistema, inizialmente occasionale<br />
e imprevisto, ma successivamente stabilizzato (come sms).<br />
Per ciò che riguarda la lingua comune, i vocabolari registrano molte<br />
parole che sono forme <strong>di</strong> scritture <strong>brevi</strong>, alcune ben note e particolarmente<br />
fortunate (si pensi alla <strong>di</strong>ffusione mon<strong>di</strong>ale <strong>di</strong> OK, su cui Metcalf 2010),<br />
entrate nell’uso or<strong>di</strong>nario e <strong>di</strong>ventate parole. Proce<strong>di</strong>menti come<br />
sincretismi, aplologie, formazioni macedonia e acronimie sono<br />
continuamente in atto nella lingua, e nella <strong>di</strong>acronia linguistica si<br />
osservano ripetuti movimenti “a fisarmonica”, che restringono (e poi anche<br />
allungano) le forme dando vita a nuovo lessico: TV, WC, VIP, UFO, NATO,<br />
brunch, smog,…<br />
L’origine <strong>di</strong> tali formazioni è molto spesso nella <strong>di</strong>mensione <strong>di</strong>amesica<br />
della scrittura: si tratta, ovvero, <strong>di</strong> accorciamenti grafici che vengono letti.
30<br />
<strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong> <strong>oggi</strong>: tra convenzione e sistema<br />
È del marzo 2011 la notizia dell’inserimento del simbolo del cuore -‐‑ ♥ -<br />
nell’autorevole sede dell’Oxford English <strong>di</strong>ctionary, e si tratta del primo<br />
carattere non alfabetico ad avere accesso ufficiale nel tempio sacro della<br />
lingua inglese. La novità, accolta con molta sorpresa e con la preve<strong>di</strong>bile<br />
contrarietà, non può lasciarci in<strong>di</strong>fferenti, poiché è il segnale <strong>di</strong> una<br />
evidente, ed inevitabile, rivoluzione in atto:<br />
Don’t look now, but I think my old English grammar teacher is doing somersaults<br />
in her grave: No less an authority than the Oxford English Dictionary has declared<br />
“OMG” a word, along with two other popular 3-‐‑letter ab<strong>brevi</strong>ations, “LOL” and<br />
“FYI.”<br />
Language purists may scoff at the new ad<strong>di</strong>tions or even consider them a sure sign<br />
of the decline of Western civilization. However, in it’s latest update, the OED notes<br />
that both OMG and LOL have jumped out of the confines of electronic screens and<br />
are now “found outside of electronic contexts, however; in print, and even in<br />
spoken use…The intention is usually to signal an informal, gossipy mode of<br />
expression, and perhaps parody the level of unreflective enthusiasm or<br />
overstatement that can sometimes appear in online <strong>di</strong>scourse, while at the same<br />
time marking oneself as an ‘insider’ au fait with the forms of expression associated<br />
with the latest technology.”<br />
C. Mikojajczyk, It’s official: OMG is now a word, March 28, 2011<br />
http://www.k-‐‑international.com/blog/its-‐‑official-‐‑omg-‐‑is-‐‑now-‐‑a-‐‑word/<br />
Significativamente si registra contemporaneamente l’acquisizione, nella<br />
stessa prestigiosa sede, della sigla LOL e <strong>di</strong> OMG, <strong>di</strong> cui sopra abbiamo<br />
identificato l’ascendente extranazionale sulle lingue a partire dall’inglese<br />
(Crystal 2003 e qui Zanzotto&Pennacchiotti).<br />
8. Una conclusione<br />
Ma al <strong>di</strong> là delle peculiari fortune e dei successi – che pure decretano la<br />
rilevanza <strong>di</strong> queste specie -‐‑ è qui l’occasione per l’osservazione e l’analisi<br />
delle fenomenologie, in quanto regolari e non irrazionali appaiono le<br />
tecniche e le strutture delle grafie sintetiche <strong>di</strong> tutti i tempi.<br />
La dominanza del principio dell’economia temporale quale<br />
denominatore comune riconosciuto nella definizione delle “scritture<br />
veloci” storicamente ricorrenti (Giulietti 1968) -‐‑ dalle notae tironianae alle<br />
notae iuris attestate dall’epoca ciceroniana, dalle siglae (ab<strong>brevi</strong>azione <strong>di</strong><br />
singulae litterae) della tra<strong>di</strong>zione epigrafica alle ab<strong>brevi</strong>azioni dei nomina<br />
sacra dell’ambito religioso, dalla tachigrafia sillabica (dal VI secolo) alla
F. Chiusaroli 31<br />
stenografia moderna – può essere riconsiderata in un’ottica integrale <strong>di</strong><br />
storia della scrittura, ovvero inquadrando lo stesso concetto <strong>di</strong> “tempo”<br />
della scrittura come la ragione occasionale, lì dove la “<strong>brevi</strong>tà”, in senso<br />
spazio-‐‑temporale, costituisce causa/effetto permanente, risultato delle<br />
pratiche grafiche ab<strong>brevi</strong>ative riscontrate ad ogni epoca e non soltanto nei<br />
contesti specialistici.<br />
Da tali premesse motivazionali si deducono le forme, che esibiscono<br />
parametri <strong>di</strong>stintivi e tratti peculiari tali da comporre una logica<br />
sommatoria e non tanto un inventario normativo.<br />
Mentre le lingue e le scritture sono tante e <strong>di</strong>verse, appare proponibile<br />
non solo elencare, ma anche classificare le ab<strong>brevi</strong>azioni, riconoscere<br />
principi mentali alla base della pratica dell’accorciamento, ammettere<br />
l’esistenza <strong>di</strong> tipologie in analogia con i tipi o gli universali linguistici,<br />
ovvero redatte sulla base delle stesse qualità tipologiche intrinseche alle<br />
lingue.<br />
Benché siano profonde e complesse le problematiche relative all’origine<br />
della scrittura, appare indubitabile che la particolare natura dei supporti e<br />
degli strumenti che accolgono le prime forme <strong>di</strong> rappresentazione grafica<br />
del pensiero e del linguaggio (Leroi-‐‑Gourhan 1977; Cardona 1990 [1978];<br />
Silvestri 1996) non può non avere con<strong>di</strong>zionato la raffigurazione sintetica,<br />
dunque breve, delle realizzazioni <strong>di</strong> graffiti e pitture su rocce, “immagini<br />
senza parole” (Bocchi&Ceruti 2002) che sono funzionalmente adeguate alla<br />
maggiore economia della comunicazione (Cardona 1986a).<br />
Analogamente, la riconosciuta circostanza <strong>di</strong> intrecci e convivenze tra<br />
sistemi semasiografici e glottografici, o tra sistemi logografici e alfabetici,<br />
la tesi della convivenza <strong>di</strong> forme che ha sostituito la visione ”progressista”<br />
dell’alfabeto come risultato finale e perfetto dell’evoluzione della scrittura<br />
nella storia, comportano la necessità <strong>di</strong> confrontarsi con le tipologie delle<br />
scritture, evitando un’interpretazione rigidamente meccanicistica del<br />
rapporto tra segno e nozione, ma non<strong>di</strong>meno riconoscendo l’azione <strong>di</strong> un<br />
principio pragmatico che punta alla massima efficacia funzionale delle<br />
soluzioni primariamente in senso economico, <strong>di</strong> risparmio. La per<strong>di</strong>ta, nelle<br />
fasi temporali soprattutto moderne, ad esempio successive all’introduzione<br />
della stampa, della corrispondenza esatta delle lettere coi suoni, non può<br />
impe<strong>di</strong>re <strong>di</strong> riconoscere la ricerca <strong>di</strong> tale ideale coerenza all’origine della<br />
stipulata corrispondenza: ricerca che per altro è ulteriormente provata nei<br />
casi <strong>di</strong> ricostruzione a ritroso della derivazione <strong>di</strong> caratteri alfabetici da<br />
quelli logografici/ideografici, provando un continuo equilibrio, a scopo
32<br />
<strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong> <strong>oggi</strong>: tra convenzione e sistema<br />
funzionale ed economico, tra gli estremi <strong>di</strong> economia e ridondanza, e tra le<br />
tendenze <strong>di</strong> arbitrarietà, motivazione e convenzione (Silvestri 2009 e in<br />
stampa), che sono caratteristiche precipue delle lingue, prima (e oltre) che<br />
delle scritture.<br />
Non appaiono casuali, ma seguono un principio logico (psico-‐‑logico,<br />
morfo-‐‑logico) e comune, le pratiche <strong>di</strong> recisione <strong>di</strong> elementi desinenziali<br />
osservabili nei sistemi ab<strong>brevi</strong>ativi dell’sms come nelle ab<strong>brevi</strong>ature<br />
paleografiche introdotte dall’antico copista.<br />
L’amanuense me<strong>di</strong>oevale, che trascorreva la propria esistenza a scrivere<br />
e a copiare dentro le pareti dello scriptorium monastico, non aveva certo<br />
problemi <strong>di</strong> fretta, o almeno la sua vita non è paragonabile alla o<strong>di</strong>erna<br />
con<strong>di</strong>zione multitasking, ma il supporto per la scrittura richiedeva quanto<br />
meno attenzione a evitare ogni spreco inutile <strong>di</strong> materiale. Ed ecco la ricca<br />
serie delle convenzioni grafiche della paleografia greca e latina.<br />
Analogie si rintracciano, come visto, nelle più antiche scritture<br />
epigrafiche, le quali riportano serie convenzionali <strong>di</strong> ab<strong>brevi</strong>azioni fatte <strong>di</strong><br />
soppressione <strong>di</strong> elementi, troncature ed elisioni, <strong>di</strong>segni e simboli, che<br />
possono essere incongruenti, ma mai illogici.<br />
Si collega alle notae tironianae e alla tachigrafia dell’epoca <strong>di</strong> Cicerone la<br />
moderna stenografia, che, attraverso un alfabeto molto semplice, e<br />
attraverso regole ab<strong>brevi</strong>ative delle scritture or<strong>di</strong>narie, costruisce segni<br />
<strong>brevi</strong>ssimi, che possono essere tracciati con un solo tratto <strong>di</strong> penna,<br />
operazione che richiede un tempo che è pari ad un quinto rispetto ai<br />
caratteri or<strong>di</strong>nari.<br />
La stessa tra<strong>di</strong>zione stenografica si collega storicamente, ma ancor più<br />
ideologicamente, a certi progetti <strong>di</strong> lingue universali dell’epoca empirista,<br />
fondati sull’invenzione <strong>di</strong> caratteri sintetici ideografici “perfetti” (Poli 2012;<br />
Chiusaroli 1998), ovvero rappresentanti, nella figura scritta, i tratti<br />
essenziali degli elementi del reale pensato, i costituenti, privi <strong>di</strong><br />
ridondanze, risultanti della operazione concettuale della reductio dei dati<br />
alle nozioni prime, al <strong>di</strong> fuori della me<strong>di</strong>azione, giu<strong>di</strong>cata fallace, della<br />
lingua e dell’alfabeto (Chiusaroli 2001). Gli stessi progetti costituiscono un<br />
punto <strong>di</strong> riferimento culturale per la fondazione della teoresi della ars<br />
combinatoria e della leibniziana characteristica universalis (Rossi 1983; Eco<br />
1993) nella speculazione moderna, dove la riconduzione della lingua a<br />
schema logico, algebrico e aritmetico (Rossi 1971; 1989; Burkhardt 1987) è<br />
in seguito <strong>di</strong>venuta prototipo per la costituzione dei modelli matematici
F. Chiusaroli 33<br />
posti alla base dei programmi per il trattamento automatico delle lingue<br />
naturali.<br />
Dalla scrittura a mano alla macchina, ricor<strong>di</strong>amo che lo schema Qwerty,<br />
brevettato per le macchine da scrivere nel 1864, aveva fra i suoi scopi<br />
l’accelerazione della scrittura tramite l’ab<strong>brevi</strong>azione dei tempi e dei<br />
passaggi nei movimenti. Tale obiettivo veniva perseguito attraverso la<br />
collocazione dei tasti su basi ergonomiche, peculiarmente separando le<br />
lettere maggiormente utilizzate (in inglese) in modo tale che le mani dello<br />
scrivente non si intrecciassero nel corso della battitura, anzi in modo tale<br />
che, mentre una mano si posizionava, l'ʹaltra mano colpisse il tasto, nel<br />
rispetto delle sequenze grafiche maggiormente ricorrenti.<br />
E poi entrano in campo le molte analogie con i sistemi grafici <strong>di</strong> tutti i<br />
tempi. Ovvero, la classificazione secondo la trafila<br />
-‐‑ <strong>di</strong>segno – pittogramma – ideogramma – logogramma – sillabogramma<br />
– carattere alfabetico<br />
trova speciale occasione <strong>di</strong> sintesi nelle scritture <strong>brevi</strong> non istituzionalizzate<br />
o non generalizzate, dove elementi <strong>di</strong> ogni sistema o <strong>di</strong> ogni sta<strong>di</strong>o sono<br />
adottati sulla base del principio <strong>di</strong> minimo sforzo e massimo ren<strong>di</strong>mento,<br />
istituendo una convivenza delle forme che supera le barriere spazio e<br />
tempo.<br />
Il confronto, in sincronia e in <strong>di</strong>acronia, sugli scriventi, i destinatari, i<br />
supporti e gli strumenti, i contesti, fa notare specificità e <strong>di</strong>fferenze, ma<br />
forse in maggior misura mette in luce affinità e somiglianze, in una pratica<br />
umana che riunisce tecnica e cultura, ideologia e creatività, regola e libertà.<br />
Francesca Chiusaroli<br />
chiusaroli@lettere.uniroma2.it<br />
francesca.chiusaroli@gmail.com
34<br />
Bibliografia<br />
<strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong> <strong>oggi</strong>: tra convenzione e sistema<br />
Adkins&Brashers 1995<br />
Adkins Mark, Brashers Dale E., “The power of language in computer-‐‑<br />
me<strong>di</strong>ated groups”, Management Communication Quarterly 8 (3), 289-‐‑<br />
322.<br />
Baron 1998<br />
Baron Naomi S., “Letters by phone or speech by other means: the<br />
linguistics of email”, Language and Communication 18/2, 133-‐‑170.<br />
Baron 2000<br />
Baron Naomi S., Alphabet to email: how written English evolved and where<br />
it’s hea<strong>di</strong>ng, London, Routledge.<br />
Barr 1976<br />
Barr James, “Rea<strong>di</strong>ng a script without vowels”, in W. Haas (ed. by),<br />
Writing without letters, Manchester, Manchester University Press, 71-‐‑100.<br />
Battelli 1939<br />
Battelli Giulio, Lezioni <strong>di</strong> paleografia, II ed., Città del Vaticano, Pontificia<br />
Scuola Vaticana <strong>di</strong> Paleografia e Diplomatica.<br />
Bazzanella 2002<br />
Bazzanella Carla, Le facce del parlare. Un approccio pragmatico all'ʹitaliano<br />
parlato, ristampa dell’ed. 1994, Firenze-‐‑Roma, La Nuova Italia.<br />
Bazzanella 2003<br />
Bazzanella Carla, “Nuove forme <strong>di</strong> comunicazione a <strong>di</strong>stanza,<br />
restrizioni contestuali e segnali <strong>di</strong>scorsivi”, in N. Maraschio, T. P<strong>oggi</strong><br />
Salani (a cura <strong>di</strong>), Italia linguistica anno Mille -‐‑ Italia linguistica anno<br />
Duemila, XXXIV Congresso della SLI, Firenze 2000, Bulzoni, Roma, 403-‐‑<br />
415.<br />
Bazzanella 2005a<br />
Bazzanella Carla, Linguistica e pragmatica del linguaggio, Roma-‐‑Bari,<br />
Laterza.
F. Chiusaroli 35<br />
Bazzanella 2005b<br />
Bazzanella Carla, “Parlato <strong>di</strong>alogico e contesti <strong>di</strong> interazione”, in K.<br />
Hölker, C. Maaβ (a cura <strong>di</strong>), Aspetti dell'ʹitaliano parlato, Münster-‐‑<br />
Hamburg-‐‑London, LIT-‐‑Verlag, 1-‐‑22.<br />
Bazzanella 2005c<br />
Bazzanella Carla, “Tratti prototipici del parlato e nuove tecnologie”, in<br />
E. Burr (a cura <strong>di</strong>), Tra<strong>di</strong>zione ed innovazione, Atti SILFI, Duisburg 2000,<br />
Firenze, Cesati, 427-‐‑441.<br />
Bazzanella&Baracco 2003<br />
Bazzanella Carla, Baracco Alberto, “Misunderstan<strong>di</strong>ng in IRC (Internet<br />
Relay Chat)”, in M. Bon<strong>di</strong>, S. Stati (a cura <strong>di</strong>), Dialogue analysis 2000, Atti<br />
IADA, Bologna 2000, Tübingen, Niemeyer, 119-‐‑131.<br />
Bischoff 1992<br />
Bischoff Bernhard, Paleografia latina: antichità e me<strong>di</strong>oevo, trad. it. Padova,<br />
Antenore.<br />
Bocchi&Ceruti 2002<br />
Bocchi Gianluca, Ceruti Mauro (a cura <strong>di</strong>), Origini della scrittura, Milano,<br />
Bruno Mondadori.<br />
Bonomi 2010<br />
Bonomi Ilaria, “Tendenze linguistiche dell’italiano in rete”, Informatica<br />
Umanistica 3, 17-‐‑29.<br />
Burkhardt 1987<br />
Burkhardt Hans, “The Leibnizian ‘characteristica universalis’ as link<br />
between grammar and logic”, in D. Buzzetti, M. Ferriani (ed. by),<br />
Speculative grammar, universal grammar, and philosophical analysis of<br />
language, Amsterdam – Philadelphia, John Benjamins, 43-‐‑63.<br />
Calvet 1980<br />
Calvet Louis-Jean, Les sigles, Paris, Presses Universitaires de France.<br />
Cappelli 1990<br />
Cappelli Adriano, Dizionario <strong>di</strong> ab<strong>brevi</strong>ature latine ed italiane, Milano,<br />
Hoepli 1929; rist. anast.
36<br />
<strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong> <strong>oggi</strong>: tra convenzione e sistema<br />
Cardona 1981<br />
Cardona Giorgio Raimondo, Antropologia della scrittura, Torino,<br />
Loescher.<br />
Cardona 1986a<br />
Cardona Giorgio Raimondo, Storia universale della scrittura, Milano,<br />
Mondadori.<br />
Cardona 1990<br />
Cardona Giorgio Raimondo, I linguaggi del sapere, a cura <strong>di</strong> C. Bologna,<br />
Roma-‐‑Bari, Laterza (Parte seconda: “Antropologia della scrittura”: “Per<br />
una teoria integrata della scrittura” [1978]; “I percorsi della scrittura.<br />
Aspetti conoscitivi <strong>di</strong> uno strumento <strong>di</strong> comunicazione” [1985]; “La<br />
scrittura: un’attività universale?” [1986b]).<br />
Carr 2011<br />
Carr Nicholas, Internet ci rende stupi<strong>di</strong>? Come la rete sta cambiando il nostro<br />
cervello, trad. it. Milano, Cortina.<br />
Cencetti 1997<br />
Cencetti Giorgio, Lineamenti <strong>di</strong> storia della scrittura latina. Dalle lezioni <strong>di</strong><br />
paleografia, Bologna, a.a. 1953-‐‑1954; rist. a cura <strong>di</strong> G. Guerrini Ferri,<br />
Bologna, Pàtron.<br />
Chiari 2002<br />
Chiari Isabella, Ridondanza e linguaggio. Un principio costitutivo delle<br />
lingue, Roma, Carocci.<br />
Chiusaroli 1998<br />
Chiusaroli Francesca, Categorie <strong>di</strong> pensiero e categorie <strong>di</strong> lingua. L’i<strong>di</strong>oma<br />
filosofico <strong>di</strong> John Wilkins, numero monografico dei “Quaderni linguistici e<br />
filologici dell’Università <strong>di</strong> Macerata” 10.<br />
Chiusaroli 2001<br />
Chiusaroli Francesca, “Una trafila secentesca <strong>di</strong> reductio”, in V. Orioles<br />
(a cura <strong>di</strong>), Dal ‘para<strong>di</strong>gma’ alla parola. Riflessioni sul metalinguaggio della
F. Chiusaroli 37<br />
linguistica, Atti del Convegno, U<strong>di</strong>ne -‐‑ Gorizia, 10-‐‑11 febbraio 1999,<br />
Roma, Il Calamo, 33-‐‑51.<br />
Chiusaroli&Zanzotto (in stampa)<br />
Chiusaroli Francesca, Zanzotto Fabio Massimo (a cura <strong>di</strong>) (in stampa),<br />
<strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong> <strong>di</strong> <strong>oggi</strong>; <strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong> nella storia delle scritture; <strong>Scritture</strong><br />
<strong>brevi</strong> nelle lingue, Quaderni monografici <strong>di</strong> Linguistica Zero, con<br />
contributi dei relatori ai workshop <strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong>: 1° workshop, Roma Tor<br />
Vergata, 22 febbraio 2011; 2° workshop, Roma Tor Vergata -‐‑ Società<br />
Geografica Italiana, 12-‐‑13 aprile 2011; 3° workshop, Roma Tor Vergata,<br />
16-‐‑17-‐‑18 maggio 2011 (https://sites.google.com/site/scritture<strong>brevi</strong>/).<br />
Chiusaroli 2012<br />
Chiusaroli Francesca, Relazioni para<strong>di</strong>gmatiche e sintagmatiche nella<br />
costruzione del segno: la creazione del lessico della rete, Relazione presentata<br />
al XIII Colloque International de Psychomécanique du Langage, Naples,<br />
20-‐‑21-‐‑22 juin 2012 (in stampa).<br />
Cho 2010<br />
Thomas Cho, “Linguistic features of electronic mail in the workplace: a<br />
comparison with memoranda”, Language@Internet 7 (http://nbn-‐‑<br />
resolving.de/urn:nbn:de:0009-‐‑7-‐‑27287).<br />
Crystal 1998<br />
Crystal David, Language play, London, Penguin Books.<br />
Crystal 2001<br />
Crystal David, Language and the Internet, Cambridge, Cambridge<br />
University Press.<br />
Crystal 2003<br />
Crystal David, English as a global language, II ed., Cambridge University<br />
Press.<br />
Crystal 2004<br />
Crystal David, A glossary of netspeak and textspeak, E<strong>di</strong>nburgh, E<strong>di</strong>nburgh<br />
University Press.
38<br />
<strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong> <strong>oggi</strong>: tra convenzione e sistema<br />
Crystal 2008<br />
Crystal David, Txtng. The Gr8 Db8, Oxford, Oxford University Press.<br />
Dardano&De Roberto&Frenguelli 2008<br />
Dardano Maurizio, De Roberto Elsa, Frenguelli Gianluca (a cura <strong>di</strong>),<br />
Testi <strong>brevi</strong>, Atti del convegno internazionale <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>, Università Roma<br />
Tre, 8-‐‑10 giugno 2006, Roma, Aracne.<br />
De Kerckhove 2008<br />
De Kerckhove Derrick, Dall’alfabeto a internet. L’homme “littéré”:<br />
alfabetizzazione, cultura, tecnologia, trad. it. Milano-‐‑U<strong>di</strong>ne, Mimesis.<br />
Dresner&Herring 2010<br />
Dresner Eli, Herring Susan C., “Functions of the non-‐‑verbal in CMC:<br />
emoticons and illocutionary force”, Communication Theory 20, 249-‐‑268.<br />
Eco 1993<br />
Eco Umberto, La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea, Roma –<br />
Bari, Laterza, 1993.<br />
Fiorentino 2007<br />
Fiorentino Giuliana, “Nuova scrittura e me<strong>di</strong>a: le metamorfosi della<br />
scrittura”, in Ead. (a cura <strong>di</strong>), Scrittura e società. Storia, cultura, professioni,<br />
Roma, Aracne, 175-‐‑207.<br />
Frehner 2008<br />
Frehner Carmen, Email – SMS – MMS: the linguistic creativity of<br />
asynchronous <strong>di</strong>scourse in the new me<strong>di</strong>a age, Bern, Peter Lang.<br />
Frutiger 1996<br />
Frutiger Adrian, Segni e simboli, trad. it. Viterbo, Nuovi Equilibri.<br />
Giulietti 1968<br />
Giulietti Francesco, Storia delle scritture veloci. Dall’antichità ad <strong>oggi</strong>,<br />
Firenze, Giunti-‐‑Barbera.<br />
Goody 1989<br />
Goody Jack, Il suono e i segni, trad. it. Milano, Il Saggiatore.
F. Chiusaroli 39<br />
Granelli 2006<br />
Granelli Andrea, Il Sé <strong>di</strong>gitale. Identità, memoria, relazioni nell’era della rete,<br />
Milano, Guerini e associati.<br />
Granelli&Sarno 2007<br />
Granelli Andrea, Sarno Lucio, Immagini e linguaggi del <strong>di</strong>gitale. Le nuove<br />
frontiere della mente, Milano, Il Sole 24 Ore.<br />
Halliday 1992<br />
Halliday Michael Alexander K., Lingua parlata e lingua scritta, trad. it.<br />
Firenze, La Nuova Italia.<br />
Harris 1998<br />
Harris Roy, L’origine della scrittura, trad. it. Viterbo, Nuovi Equilibri.<br />
Harris 2003<br />
Harris Roy, La tirannia dell’alfabeto. Ripensare la scrittura, trad. it. Viterbo,<br />
Nuovi Equilibri.<br />
Held&Schwarze 2011<br />
Held Gudrun, Schwarze Sabine (hrsg. v.), Testi <strong>brevi</strong>. Teoria e pratica della<br />
testualità nell'ʹera multime<strong>di</strong>ale, Frankfurt am Main, Lang (cfr. in<br />
particolare i contributi <strong>di</strong> Sabine Schwarze: “Brevità e «testo breve» -‐‑<br />
stimoli interpretativi in chiave della linguistica testuale”; Gudrun Held:<br />
“Il «testo breve»: condensazione multimodale nella comunicazione <strong>di</strong><br />
massa. Riflessioni in chiave della linguistica dei me<strong>di</strong>a”; Giulio Lughi:<br />
“Non solo breve. Frammentazione e ricomposizione nella testualità dei<br />
nuovi me<strong>di</strong>a”; Massimo Arcangeli: “Il testo breve nell'ʹera <strong>di</strong>gitale.<br />
Teoria e applicazioni”; Elena Pistolesi: “Frammenti <strong>di</strong> un <strong>di</strong>scorso<br />
or<strong>di</strong>nario. Contributo all'ʹanalisi pragmatica degli SMS”; Giuliana<br />
Fiorentino: “Brevità e microcontenuti nei blog”).<br />
Herring 1996<br />
Herring Susan C. (ed. by), Computer-‐‑Me<strong>di</strong>ated Communication: linguistic,<br />
social and cross-‐‑cultural perspectives, Amsterdam: John Benjamins.
40<br />
<strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong> <strong>oggi</strong>: tra convenzione e sistema<br />
Herring 2012a<br />
Herring Susan C. (in press, 2012), “Grammar and electronic<br />
communication”, in C. Chapelle (ed. by), Encyclope<strong>di</strong>a of applied<br />
linguistics, Hoboken, NJ, Wiley-‐‑Blackwell, Prepublication version:<br />
http://ella.slis.in<strong>di</strong>ana.edu/~herring/e-‐‑grammar.2011.pdf<br />
Herring 2012b<br />
Herring Susan C. (in press, 2012), “Relevance in computer-‐‑me<strong>di</strong>ated<br />
conversation”, in S. C. Herring, D. Stein, & T. Virtanen (Eds.), Handbook<br />
of pragmatics of computer-‐‑me<strong>di</strong>ated communication, Berlin, Mouton.<br />
Prepublication version:<br />
http://ella.slis.ind iana.edu/~herring/relevance.pdf<br />
Lee&Rayner&Pollatsek 2001<br />
Lee Hye-‐‑Won, Rayner Keith, Pollatsek Alexander, “The relative<br />
contribution of consonants and vowels to word identification during<br />
rea<strong>di</strong>ng”, Journal of Memory and Language 44/2, 189-‐‑205.<br />
Leroi-‐‑Gourhan 1977<br />
Leroi-‐‑Gourhan André, Il gesto e la parola. I. Tecnica e linguaggio. II. La<br />
memoria e i ritmi, trad. it. Torino, Einau<strong>di</strong>.<br />
Lo Cascio 2007<br />
Lo Cascio Vincenzo (a cura <strong>di</strong>), Parole in rete. Teorie e appren<strong>di</strong>mento<br />
nell’era <strong>di</strong>gitale, Torino, UTET.<br />
Lorenzetti&Schirru 2006<br />
Lorenzetti Luca, Schirru Giancarlo, “La lingua italiana nei nuovi mezzi<br />
<strong>di</strong> comunicazione: SMS, posta elettronica e Internet”, in S. Gensini (a<br />
cura <strong>di</strong>), Fare comunicazione. Teoria ed esercizi, Roma, Carocci, 71-‐‑98.<br />
Martin 1990<br />
Martin Henry-‐‑Jean, Storia e potere della scrittura, trad. it. Roma-‐‑Bari,<br />
Laterza.<br />
Martinet 1966<br />
Martinet André, Elementi <strong>di</strong> linguistica generale, trad. it. Roma-‐‑Bari,<br />
Laterza.
F. Chiusaroli 41<br />
Martinet 1984<br />
Martinet André, La considerazione funzionale del linguaggio, trad. it. [1965],<br />
Bologna, il Mulino.<br />
Metcalf 2010<br />
Metcalf Allan, Ok. The improbable story of America’s greatest word, Oxford,<br />
Oxford University Press.<br />
Ong 1970<br />
Ong Walter, La presenza della parola, trad. it. Bologna, il Mulino.<br />
Ong 1986<br />
Ong Walter, Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, trad. it. Bologna,<br />
il Mulino.<br />
Orletti 2004<br />
Orletti Franca (a cura <strong>di</strong>), Scrittura e nuovi me<strong>di</strong>a, Roma, Carocci.<br />
Paoli 1891<br />
Paoli Cesare, Le ab<strong>brevi</strong>ature nella paleografia latina del Me<strong>di</strong>o Evo: saggio<br />
meto<strong>di</strong>co-‐‑pratico, Firenze, Tip. dei Successori Le Monnier, 1891; rist.<br />
anast. Nabu Press 2012.<br />
Paoli 1987<br />
Paoli Cesare, Diplomatica, Nuova ed. aggiornata da G. C. Bascapè, 1942,<br />
Sansoni, Firenze; rist. anast. Firenze, Le Lettere.<br />
Pietrini 2007<br />
Daniela Pietrini, Parola <strong>di</strong> Papero. Storia e tecniche della lingua dei fumetti<br />
Disney, Firenze, Cesati.<br />
Pilloni 2011<br />
Pilloni Silvia, “Digita come parli”, Informatica Umanistica 5, 79-‐‑92.<br />
Pistolesi 2003
42<br />
<strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong> <strong>oggi</strong>: tra convenzione e sistema<br />
Pistolesi Elena, “L’italiano nella rete”, in N. Maraschio, T. P<strong>oggi</strong> Salani<br />
(a cura <strong>di</strong>), Italia linguistica anno Mille -‐‑ Italia linguistica anno Duemila,<br />
XXXIV Congresso della SLI, Firenze 2000, Bulzoni, Roma, 431-‐‑447.<br />
Pistolesi 2005a<br />
Pistolesi Elena, Il parlar spe<strong>di</strong>to. L’italiano <strong>di</strong> chat, e-‐‑mail e SMS, Padova,<br />
Esedra.<br />
Pistolesi 2005b<br />
Pistolesi Elena, “La simulazione del parlato nello scambio <strong>di</strong>alogico<br />
delle chat”, in E. Burr (a cura <strong>di</strong>), Tra<strong>di</strong>zione ed innovazione, Atti SILFI,<br />
Duisburg 2000), Firenze, Cesati, 471-‐‑483.<br />
Poli 2012<br />
Poli Diego, “La scrittura del cinese come chiave interpretativa<br />
dell'ʹuniversale nell'ʹadattamento <strong>di</strong> Matteo Ricci e nella speculazione in<br />
Occidente”, in F. Mignini (a cura <strong>di</strong>), Humanitas. Attualità <strong>di</strong> Matteo Ricci.<br />
Testi, fortuna, interpretazioni, Macerata, Quodlibet, 103-‐‑148.<br />
Pulgram 1976<br />
Pulgram Ernst, “The typologies of writing-‐‑systems”, in W. Haas (ed by),<br />
Writing without letters, Manchester, Manchester University Press, 1-‐‑28.<br />
Rossi 1971<br />
Rossi Paolo, I filosofi e le macchine, 1400-‐‑1700, nuova ed., Milano,<br />
Feltrinelli.<br />
Rossi 1983<br />
Rossi Paolo, Clavis universalis. Arti della memoria e logica combinatoria da<br />
Lullo a Leibniz, II ed., Bologna, il Mulino.<br />
Rossi 1989<br />
Rossi Paolo, La scienza e la filosofia dei moderni. Aspetti della rivoluzione<br />
scientifica, Torino, Bollati Boringhieri.<br />
Schiaparelli 1926<br />
Schiaparelli Luigi, Avviamento allo stu<strong>di</strong>o delle ab<strong>brevi</strong>ature latine nel<br />
me<strong>di</strong>oevo, Firenze, Olschki.
Serianni 2003<br />
Serianni Luca, Italiani scritti, Bologna, il Mulino.<br />
F. Chiusaroli 43<br />
Shirky 2010<br />
Shirky Clay, Surplus cognitivo. Creatività e generosità nell’era <strong>di</strong>gitale, trad.<br />
it. Torino, Co<strong>di</strong>ce e<strong>di</strong>zioni.<br />
Silvestri 1996<br />
Silvestri Domenico, “Testi e contesti. Genesi e forma della testualità tra<br />
preistoria e protostoria linguistica del mondo antico”, in C. Consani, F.<br />
Motta (a cura <strong>di</strong>), Lezioni <strong>di</strong> linguistica, Università degli stu<strong>di</strong> "ʺG.<br />
D'ʹAnnunzio"ʺ Chieti, Istituto <strong>di</strong> Scienze del Linguaggio e della<br />
Comunicazione, Facoltà <strong>di</strong> Lingue e Letterature straniere, Pescara,<br />
Libreria dell'ʹUniversità e<strong>di</strong>trice, 69-‐‑132.<br />
Silvestri 2009<br />
Silvestri Domenico, “Genesi e forme della linearità nelle scritture<br />
arcaiche dello spazio indome<strong>di</strong>terraneo”, in M. Mancini, B. Turchetta (a<br />
cura <strong>di</strong>), Scrittura e scritture: le figure della lingua, Atti del XXIX Convegno<br />
della Società Italiana <strong>di</strong> Glottologia, Viterbo 28-‐‑30 ottobre 2004, Roma, Il<br />
Calamo, 81-‐‑113.<br />
Silvestri (in stampa)<br />
Silvestri Domenico, “Primissime forme <strong>di</strong> scritture <strong>brevi</strong>: dai<br />
pittogrammi “metonimici” protosumerici alle complementazioni<br />
fonetiche ittite”, contributo dalla relazione presentata a <strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong>, 2°<br />
workshop, Roma Tor Vergata, 12-‐‑13 aprile 2011. Ora in stampa in F.<br />
Chiusaroli, F.M. Zanzotto (a cura <strong>di</strong>), <strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong> nella storia delle<br />
scritture, Quaderno monografico <strong>di</strong> Linguistica Zero.<br />
Simone 2000<br />
Simone Raffaele, La terza fase. Forme <strong>di</strong> sapere che stiamo perdendo, Roma-‐‑<br />
Bari, Laterza.<br />
Simone 2012<br />
Simone Raffaele, Presi nella rete. La mente ai tempi del web, Milano,<br />
Garzanti.
44<br />
<strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong> <strong>oggi</strong>: tra convenzione e sistema<br />
Stefinlongo 2002<br />
Stefinlongo Antonella, I giovani e la scrittura: attitu<strong>di</strong>ni, bisogni,<br />
competenze <strong>di</strong> scrittura delle nuove generazioni, Roma, Aracne.<br />
Stefinlongo 2004<br />
Stefinlongo Antonella. Scrivo come parlo/penso. Caratteri della scrittura<br />
giovanile <strong>di</strong> fine millennio, in M. Cecchini (a cura <strong>di</strong>), Fare, conoscere,<br />
parlare. Abilità linguistiche, capacità operative e processi <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento,<br />
Atti del X Convegno Nazionale Giscel, Ischia porto-‐‑Napoli 23-‐‑24-‐‑25<br />
marzo 2000, Milano, FrancoAngeli, 294-‐‑303.<br />
Tavosanis 2011<br />
Tavosanis Mirko, L’italiano del web, Roma, Carocci.<br />
Trifone 2007<br />
Trifone Pietro, Malalingua. L’italiano scorretto da Dante a <strong>oggi</strong>, Bologna, il<br />
Mulino.<br />
Valeri 2000<br />
Valeri Vincenzo, La scrittura, Roma, Carocci.<br />
Van Dijk 2002<br />
Van Dijk Jan, Sociologia dei nuovi me<strong>di</strong>a, trad. it. Bologna, il Mulino.
Abstract<br />
Microantroponimi del XXI secolo<br />
Enzo Caffarelli<br />
La storia dell’onomastica <strong>di</strong>mostra numerosi esempi <strong>di</strong> accorciamento <strong>di</strong> nomi o<br />
<strong>di</strong> ricorso a forme <strong>brevi</strong>, con <strong>di</strong>fferenze <strong>di</strong>acroniche, <strong>di</strong>atopiche, <strong>di</strong>afasiche e<br />
<strong>di</strong>amesiche. Nel Me<strong>di</strong>oevo e anche in tempi moderni, sia pure con modalità<br />
<strong>di</strong>fferenti, è l’usura del linguaggio orale a creare ipocoristici e nomi comunque<br />
raccorciati; numerosi cognomi nascono da aferesi, sincopi e apocopi <strong>di</strong> patronimici<br />
e <strong>di</strong> soprannomi. Ai giorni nostri è possibile verificare l’accorciamento dei nomi<br />
propri anche in <strong>di</strong>fferenti àmbiti, come la segnaletica stradale o la crematonimia, e i<br />
nomi dei prodotti commerciali in genere, nei quali si celano spesso poche sillabe del<br />
cognome-‐‑marchio aziendale. Nella lingua <strong>di</strong> Internet la scelta dei nicknames sembra<br />
invece non tanto favorire la <strong>brevi</strong>tà quanto la condensazione in un’unica stringa <strong>di</strong><br />
più informazioni, non esclusivamente onomastiche, sulla persona.<br />
Parole chiave: accorciamento del nome, antroponimo, cognome, imposizione<br />
del nome, marchionimo, nome personale, onomastica, pseudonimo, soprannome<br />
The history of onomastics offers many examples of shortening of names or<br />
employment of short forms, with <strong>di</strong>fferences regar<strong>di</strong>ng times, places, situations and<br />
me<strong>di</strong>a. In the Middle Ages and in modern times, albeit in <strong>di</strong>fferent ways, the<br />
wearing effects of time in oral language facilitates the short name formation. Many<br />
surnames originate from apheresis, syncope and cuttings of family names and<br />
nicknames. Nowadays it is possible to observe the shortening of proper names in<br />
<strong>di</strong>fferent spheres, such as road signs or crematonimia, and the names of commercial<br />
products in general, in which few syllables of the name-‐‑brand are often hidden. In<br />
the language of the Internet the choice of nicknames seems not to encourage<br />
<strong>brevi</strong>ty, but rather it expresses the condensation, into a single string, of most<br />
information about the person.<br />
Keywords: anthroponym, brand name, namegiving, nickname, onomastics,<br />
personal name, pseudonym, shortening of name, surname<br />
Nella primavera 2004, il quoti<strong>di</strong>ano «Metro» pubblicava nella rubrica<br />
“Nome x Nome” la seguente notizia, intitolata “La nuova legge sui
46<br />
Microantroponimi del XXI secolo<br />
cognomi”: «Ormai pronta per l’approvazione in Parlamento, la nuova<br />
legge sui cognomi presenta come maggiore novità quella che prevede che i<br />
cognomi non potranno essere più lunghi <strong>di</strong> due sillabe (e <strong>di</strong> otto lettere). La<br />
decisione è stata presa in vista del risparmio <strong>di</strong> testi in ogni atto burocratico<br />
e in particolare per sveltire le procedure <strong>di</strong> informatizzazione e in Internet.<br />
Entro il 1º aprile 2005, a un anno da <strong>oggi</strong>, tutti i cognomi più lunghi<br />
verranno tagliati dalle anagrafi e limitati a due sillabe a scelta del citta<strong>di</strong>no.<br />
Un signor Scognamiglio, per es., si chiamerà in futuro soltanto Scogna o<br />
soltanto Miglio, Pappalardo dovrà optare per Pappa o per Lardo, anche il<br />
comunissimo Esposito potrà scegliere tra Espo e Sito. I Lombar<strong>di</strong> e<br />
Lombardo saranno conguagliati in Lomba (o in Bar<strong>di</strong>). I Brambilla si<br />
chiameranno Brambi, i Fumagalli Fuma, i Cattaneo Catta. Dalla norma<br />
saranno esentate, finché in carica, le più alte autorità dello stato: non<br />
avremo dunque, per il momento, nessun Berlus».<br />
Un professore della Facoltà <strong>di</strong> Scienze politiche della “Sapienza” <strong>di</strong><br />
Roma scrisse all’autore della nota che, dopo aver letto della decisione,<br />
infuriato, aveva cambiato il contenuto della lezione che avrebbe dovuto<br />
tenere quel giorno in aula, impostandola sulle prevaricazioni della politica<br />
più bieca e stupida sui citta<strong>di</strong>ni, oltre che sulla per<strong>di</strong>ta del patrimonio<br />
onomastico che la nuova sciocca norma avrebbe comportato. Intanto il<br />
forum in rete dello IAGI, l’Istituto per l’Aral<strong>di</strong>ca e la Genealogia Italiano, si<br />
riempiva <strong>di</strong> proteste; la <strong>di</strong>scussione, ancora <strong>oggi</strong> leggibile in rete<br />
all’in<strong>di</strong>rizzo prese il via dalle parole scandalizzate<br />
<strong>di</strong> Michele Tuccimei <strong>di</strong> Sezze: «Con questa ri<strong>di</strong>cola legge perderemo tutti<br />
un patrimonio storico-‐‑personale-‐‑familiare che, per molti, dura inalterato da<br />
secoli e secoli. Mi domando che fine faranno i cognomi storici. Mi domando<br />
con che riguardo della Costituzione, <strong>di</strong> cui il <strong>di</strong>ritto al nome è uno fra gli<br />
inviolabili, si pensa <strong>di</strong> emanare una legge del genere senza il consenso dei<br />
citta<strong>di</strong>ni. Mi domando a cosa serviranno dunque i cognomi, visto che lo<br />
scopo per cui sorsero fu quello <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinguere le varie gens... in questo<br />
modo altro che confusione, molti cognomi “accorciati” sarebbero uguali ad<br />
altri, i rischi delle omonimie aumenterebbero vertiginosamente! Il<br />
problema <strong>di</strong> fondo è che tutto questo verrà fatto per “risparmiare” sulla<br />
burocrazia. Ecco a cosa siamo giunti. Viva la libertà!».<br />
Finché... uno degli studenti non fece notare a quel professore – e un<br />
altro appassionato <strong>di</strong> aral<strong>di</strong>ca e genealogia a quel nobile signore – che,<br />
essendo il primo <strong>di</strong> aprile, avrebbe potuto trattarsi <strong>di</strong> uno scherzo.
E. Caffarelli 47<br />
E che scherzo giornalistico fu posso testimoniarlo senza ombra <strong>di</strong><br />
dubbio, essendo stato io l’autore della notizia nella rubrica quoti<strong>di</strong>ana che<br />
curavo all’epoca per il quoti<strong>di</strong>ano «Metro». Ma la cre<strong>di</strong>bilità del contenuto,<br />
tale da convincere persone d’elevata cultura (fui redarguito severamente<br />
dal <strong>di</strong>rettore del giornale, che non avevo preventivamente informato), oltre<br />
che a confermare la scarsa fiducia degli italiani nella classe politica e<br />
dunque la cre<strong>di</strong>bilità <strong>di</strong> leggi particolarmente sciocche 1, <strong>di</strong>mostrava il fatto<br />
che l’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> ciascuno <strong>di</strong> noi non è più così semplice come<br />
quando si richiedeva: “mi <strong>di</strong>ca nome e cognome”.<br />
Rita Caprini, nel suo bel saggio I nomi propri, annotava, allarmata, come<br />
la progressiva desemantizzazione dei nomi propri in Occidente (<strong>di</strong>fferente<br />
è – s’intende – la situazione presso le civiltà in<strong>di</strong>gene sparse nei vari<br />
continenti, dove il nome ha ancora un suo significato trasparente, viene<br />
imposto con funzioni specifiche e non per mera eufonia o moda, a maggior<br />
ragione nelle culture prive – o quasi – <strong>di</strong> scrittura) possa condurre a una<br />
trasformazione del nome in qualcosa <strong>di</strong> puramente astratto e meccanico,<br />
come il co<strong>di</strong>ce fiscale, e allora sì, privo <strong>di</strong> qualsiasi senso, fungibile ossia<br />
interscambiabile, ecc. (Caprini 2001). In effetti tutti noi siamo già una sigla<br />
alfanumerica <strong>di</strong> 15 elementi e ciò che rimane del nome e del cognome sono<br />
sei lettere: com’è noto, le prime tre consonanti del cognome, e la prima, la<br />
terza e la quarta consonante del nome, salvo conguagliare con le prime<br />
vocali i cognomi poveri <strong>di</strong> consonanti. CHSFNC è il nome “fiscale” della<br />
collega Francesca Chiusaroli, come BRLSLV è quello del nostro penultimo<br />
capo del governo e NPLGRG quello del presidente della Repubblica o<br />
TTTFNC quello del più popolare calciatore romano.<br />
Ma c’è solo il fisco, c’è solo l’informatizzazione dei co<strong>di</strong>ci, l’ABI CAB e<br />
l’IBAN a profilare all’orizzone una rivoluzione onimica? E, soprattutto,<br />
stiamo andando davvero verso una riduzione del corpo delle voci<br />
onimiche, verso quella che ho provvisoriamente chiamato, nel titolo del<br />
mio contributo, i microantroponimi del XXI secolo?<br />
1 Pesce d’aprile... ma appuriamo con certezza, – scriveva un altro frequentatore del forum<br />
IAGI – e poi ci rideremo sopra tutti insieme!» – insomma, lo spavento era stato davvero<br />
grande.
48<br />
1. Accorciamenti orali me<strong>di</strong>evali<br />
Microantroponimi del XXI secolo<br />
In realtà, l’accorciamento del nome personale è un fenomeno che si è<br />
ripetuto più volte nella storia e, volendo limitarci all’esempio più<br />
significativo in Italia, <strong>di</strong> cui ancora <strong>oggi</strong> sono evidenti gli effetti nel<br />
repertorio cognominale, portiamoci nel Me<strong>di</strong>oevo, in particolare nei<br />
perio<strong>di</strong> e nelle aree per le quali siamo meglio documentati, come la Toscana<br />
dalla fine del XII alla metà del XV secolo.<br />
Ebbene, qui, ma non solo, i documenti testimoniano <strong>di</strong> quel fenomeno<br />
tipico dell’oralità che è l’usura del nome proprio, dell’antroponimo che,<br />
impiegato spesso in funzione vocativa, viene ad essere via via accorciato<br />
per como<strong>di</strong>tà del parlante. Cadono perlopiù la prima sillaba o tutte le<br />
sillabe prima <strong>di</strong> quella tonica o scompare l’intero corpo fonico compreso tra<br />
una consonante iniziale e la vocale tonica (quasi mai, invece, osserviamo<br />
fenomeni <strong>di</strong> apocope); e, <strong>di</strong> questi ipocoristici aferetici, conserviamo<br />
memoria negli o<strong>di</strong>erni cognomi: Fé, per Bonafe(de), Lippi da Filippo, Buti da<br />
Benvenuti, Vegni da Bentivegni, Fano da Alfano (non da Stefano, data la<br />
posizione dell’accento); salvo dover constatare che tanti nomi che hanno<br />
“perduto la testa” hanno però “acquistato la coda”, per usare un’immagine<br />
dello stu<strong>di</strong>oso ticinese Ottavio Lurati, e cioè sono cresciuti a destra con uno<br />
o più suffissi, oltre a mostrare a volte un fenomeno <strong>di</strong> assimilazione<br />
consonantica regressiva: il tipo Pippi da Filippo, Peppe da Giuseppe, Cencio da<br />
Vincencio o da Lorencio (varianti popolari <strong>di</strong> Lorenzo e Vincenzo), Totti da<br />
Bertotto o altro prenome in -‐‑to + -‐‑otto, ma anche da Angelotto, Cecchi e<br />
Checchi da Francesco; con i tanti nomi <strong>di</strong> famiglia Bini, Cini, Dini, Fini, Ghini,<br />
Lini, Mini, Nini, Pini, Tini, ecc. con rispettivi alterati, che possono<br />
<strong>di</strong>scendere da qualsiasi nome personale in -‐‑bo, -‐‑co, -‐‑do, -‐‑fo, -‐‑go, -‐‑lo, -‐‑mo,<br />
-‐‑ni/no, -‐‑po, -‐‑to...; fino a incontrare cognomi tri-‐‑ e quadrisillabi della cui<br />
ra<strong>di</strong>ce iniziale non resta – se pure – che la consonante tematica: Golinelli da<br />
Ugo (+ -‐‑olo, -‐‑ino, -‐‑ello), Pinarello da Filippo, Bucciarelli e Muccinelli da Jacobo e<br />
da Giacomo e così via (cfr. Caffarelli&Marcato 2008 s.vv.).<br />
Il patrimonio cognominale italiano, nel suo insieme ma soprattutto per<br />
quell’ampia frazione che deriva da nomi personali, è dunque il frutto <strong>di</strong><br />
due vettori opposti, sul piano fonetico e su quello pragmatico: da un altro<br />
la riduzione del corpo fonico per usura, dall’altro la suffissazione per<br />
motivi affettivi ma, soprattutto in epoca me<strong>di</strong>evale, con funzione <strong>di</strong>stintiva<br />
all’interno della medesima famiglia. Peraltro anche cognomi derivanti da<br />
soprannomi composti (per es. verbo più nome) hanno conservato solo uno
E. Caffarelli 49<br />
degli elementi grammaticali originali: i tipi Mangia, Caccia, Acconcia o Denti,<br />
Lardo e Guida potrebbero essersi formati per apocope <strong>di</strong> un Mangiapane, <strong>di</strong><br />
un Cacciavillani e <strong>di</strong> un Acconciagioco, o per aferesi <strong>di</strong> un Ficcadenti, <strong>di</strong> un<br />
Pappalardo o <strong>di</strong> un Cacciaguida.<br />
2. I cognomi italiani più <strong>brevi</strong><br />
I cognomi più <strong>brevi</strong> del repertorio italiano sono monosillabi: una<br />
consonante e una vocale; nascono generalmente da voci <strong>di</strong>alettali<br />
settentrionali, come Bo per ‘bove’, Cè forse dal soprannome degli abitanti<br />
della Val Camonica, Co e forse Go e Gho per ‘capo’, Fé da un accorciamento<br />
<strong>di</strong> Bonafe(de), Fo per ‘faggio’, Mo per ‘Mado’ nome personale, Mu sardo per<br />
‘bue’ o ‘mulo’, Re ‘rivo’ o da rex; oppure derivano da toponimi identici,<br />
quali Rho presso Milano anche senza “h”, probabilmente Po, ecc. Alcuni,<br />
tipici del Salento, parrebbero le lettere dell’alfabeto greco, come Mi e My (a<br />
meno che non si debba pensare al greco mys ‘topo’), e se ne può anche<br />
supporre un’imposizione d’ufficio in funzione enumerativo-‐‑classificatoria,<br />
per esempio nel caso <strong>di</strong> trovatelli. Ma <strong>di</strong> monosillabi con tre o più lettere è<br />
pieno il repertorio, specie nelle regioni settentrionali dove si sono<br />
conservate forme locali non toscanizzate, con la caduta dell’ultima vocale<br />
se <strong>di</strong>versa da -‐‑a: Alt, Ba, Bé, Bet, Bon, Bot, Dan, Din, Don, Col, Fa, Ge, Lot, Me,<br />
Men, Not, Pan, Pat, Pin, Poz, Rà, Riz, Ros, Zan, Zen, Zin, ecc.; e può trattarsi<br />
anche <strong>di</strong> cognomi poligenetici, come Cau, in Sardegna dalla voce locale per<br />
‘cavità’ (o per ‘gabbiano’) e in Friuli da un originale nome Nicolau.<br />
Che cosa possiamo <strong>di</strong>re dei cognomi del XXI secolo in Italia? I nomi <strong>di</strong><br />
famiglia italiani sono ormai fissati stabilmente, gli ultimi all’indomani<br />
dell’Unità d’Italia con la creazione delle anagrafi in tutti i comuni. Si tratta<br />
<strong>di</strong> un repertorio vastissimo, e tra i tipi più frequenti troviamo molti<br />
cognomi bisillabi – 19 sui primi 50 e i due che si contendono il primato,<br />
Rossi e Russo – e trisillabi (con in testa Ferrari, Romani e Colombo); tra i primi<br />
100 appena 11 sono quadrisillabi (Esposito, Martinelli, De Angelis e Pellegrini<br />
i più numerosi); il primo pentasillabo è appena in 159ª posizione:<br />
Napolitano (cfr. Caffarelli 2004b).<br />
Andrà aggiunto che, come vedremo e com’è ovvio per i prenomi, anche<br />
i cognomi nel linguaggio orale e nello scritto informale (compreso il<br />
linguaggio giornalistico) possono essere accorciati; tale accorciamento può<br />
seguire regole e abitu<strong>di</strong>ni tipiche <strong>di</strong> una certa area linguistico-‐‑<strong>di</strong>alettofona
50<br />
Microantroponimi del XXI secolo<br />
oppure trovare un motivo semplicemente nella necessità <strong>di</strong> rendere più<br />
semplice e rapido il parlato o ingombrare meno spazio nei titoli dei<br />
giornali: per fare qualche esempio, Franco Ballerini, il compianto ciclista e<br />
commissario tecnico della nazionale italiana <strong>di</strong> ciclismo, era toscanamente<br />
detto il Bàllero; l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è per molti più<br />
semplicemente il Berlusca; il calciatore svedese <strong>di</strong> origini bosniaco-‐‑croate<br />
Zlatan Ibrahimovic, è chiamato nelle telecronache Ibra; il cognome del<br />
giovane allenatore dell’Inter Andrea Stramaccioni è semplificato in Strama 2.<br />
Ma dobbiamo ormai considerare anche i nomi <strong>di</strong> famiglia degli stranieri<br />
<strong>di</strong> recente immigrazione, quasi 4 milioni <strong>di</strong> persone e già al 2011-‐‑2012 con<br />
cognomi in testa alle classifiche, in particolare nella gran<strong>di</strong> città del Nord e<br />
per le nazionalità il cui repertorio onomastico è più concentrato (cfr. Sestito<br />
2011 e 2012). Così a Brescia e in alcuni comuni non capoluoghi <strong>di</strong> provincia<br />
dell’Italia settentrionale il primatista assoluto è l’indopakistano Singh, che<br />
ha superato Ferrari, Rossi e gli altri tipici cognomi del Nord d’Italia; a<br />
Milano il 2º è il cinese Hu, inferiore al solo Rossi e ben superiore a Colombo,<br />
Ferrari, Bianchi, Villa e Brambilla, e nel capoluogo lombardo i cognomi cinesi<br />
tra i primi 10 sono 3, con Chen e Zhou, mentre tra i primi 100 sono ben 12,<br />
con anche Wang, Wu, Lin, Zhang, Liu, Zhao, Li, Zhu e Zheng nell’or<strong>di</strong>ne: tutti<br />
monosillabi, insomma, e tutti con centinaia <strong>di</strong> portatori; a questi si<br />
aggiungano altri cinesi ad alta <strong>di</strong>ffusione, quali Xu, Ye, Khan, Huang, Jin,<br />
Jiang, Cheng, Dai, Diong, Xie, ecc.<br />
Tra i cognomi arabi più frequenti nel nostro Paese, si vedano i bisillabi<br />
Ahmed, Hassan, Ali, Akter, Rahman, Khalil, Islam, Ud<strong>di</strong>n, Begum, fino a Md,<br />
che è accorciamento estremo, accettato delle anagrafi italiane, per<br />
Mohammed. I cognomi subsahariani più numerosi in Italia sono i senegalesi<br />
o del golfo <strong>di</strong> Guinea Diop, N<strong>di</strong>aye, Fall, Niang, Dieng, Gueye, Diallo, Diouf;<br />
l’altro indopakistano frequentissimo, con Singh che è solo maschile, è il<br />
corrispondente femminile Kaur; anche nel repertorio romeno,<br />
abbondantissimo a Torino, a Roma e altrove, primeggiano mono-‐‑ e<br />
bisillabi, come Pop, Popa, Rusu, Radu, Stan, Lupu, Lazar, Timis, Serban, ecc.; il<br />
primo cognome albanese per frequenza è Hoxha; tra i primissimi filippini e<br />
latino-‐‑americano emergono Reyes, Santos, Perez, Sanchez, Lopez; e un solo<br />
2 Inutile arricchire la lista con una miriade <strong>di</strong> esempi: sia sufficiente per ciascuno <strong>di</strong> noi<br />
ricordare i giorni della scuola e i compagni o i professori dai cognomi che venivano<br />
regolarmente accorciati (o storpiati).
E. Caffarelli 51<br />
cognome lungo si va imponendo in Italia, nel Nord e nel Sud, come frutto<br />
delle migrazioni da Sri Lanka: Warnakulasuriya (cfr. Caffarelli 2012a).<br />
3. Il repertorio dei prenomi e gli accorciamenti innovativi<br />
Veniamo invece ai prenomi. Computando i primi 100 nomi femminili<br />
imposti nel 2004, risultavano 26 bisillabi, 56 trisillabi, 18 quadri-‐‑ o<br />
pentasillabi, per una me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> 2,93 sillabe per nome; tra i maschi, 33<br />
bisillabi (da notare 11 stranieri non adattati, da Christian a Thomas, da Kevin<br />
a Daniel, da Michael a Omar, da Gabriel a Denis...), 56 trisillabi e 11 quadri-‐‑ o<br />
pentasillabi, con una me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> 2,80 sillabe per nome. E al <strong>di</strong> sotto del rango<br />
100, s’incontrano Brian, Jan, Max e altri bisillabi (cfr. Caffarelli 2004a e<br />
2009).<br />
Un confronto con il 1876 e con il 1951, limitatamente alla città <strong>di</strong> Roma<br />
(cfr. Caffarelli 1996): la me<strong>di</strong>a nel rilevamento ottocentesco era <strong>di</strong> 2,99<br />
sillabe me<strong>di</strong>e per i nomi femminili (con 12 composti tra i primi 100) e <strong>di</strong><br />
3,07 per i maschili; all’inizio della seconda metà del Novecento risultava <strong>di</strong><br />
3,27 e <strong>di</strong> 2,84 rispettivamente. Ricapitolando in <strong>di</strong>acronia: femminili 2,99 ><br />
3,27 > 2,93; maschili 3,07 > 2,84 > 2,80.<br />
Abbiamo dunque nel XXI secolo nomi più “<strong>brevi</strong>” nel repertorio<br />
italiano? Prenomi <strong>di</strong> appena due lettere – e comunque bisillabi – sono Ea,<br />
Eo, Ia (<strong>di</strong> cui origine e significato restano piuttosto incerti e che sono stati<br />
portati ciascuno da una manciata <strong>di</strong> italiani nel XX secolo); vari<br />
monosillabici che però hanno una provenienza straniera, come Max (cfr.<br />
Rossebastiano&Papa 2005), sono già o esclusivamente del Novecento. La<br />
novità del XXI secolo (ovviamente avviatasi negli ultimi decenni del<br />
precedente) è, anche nel campo dei nomi personali, proprio la presenza <strong>di</strong><br />
tipi non italiani, entrati nel repertorio italiano o comunque presenti nelle<br />
nostre città, che stanno accorciando la lunghezza me<strong>di</strong>a delle nostre catene<br />
onimiche. Dobbiamo, però, <strong>di</strong>stinguere: perché i prenomi “corti” d’origine<br />
allotri, appartengono anche e talvolta soprattutto agli italiani; per esempio<br />
Nicole ha soppiantato Nicoletta o sono soprattutto italiani i tanti bambini <strong>di</strong><br />
nome Christian, Nicholas, Gabriel, Samuel, ecc.). Andrà anche detto che i<br />
nomi primatisti, almeno in campo femminile, dalla fine dell’Ottocento al<br />
primo decennio del XXI secolo, sono formati da cinque solo lettere<br />
(ancorché in due casi trisillabi): Maria, Giulia e Sofia, in or<strong>di</strong>ne cronologico;<br />
e che tra i più frequenti prenomi imposti alle nuove nate secondo l’Istat<br />
(anno 2010, ultimo <strong>di</strong>sponibile alla primavera 2012, cfr.
52<br />
Microantroponimi del XXI secolo<br />
www.istat.it/it/archivio/38402) tra i primi 30 femminili risultano 12 bisillabi<br />
(in or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> frequenza, Giulia, Sara, Giorgia, Chiara, Emma, Anna, Giada,<br />
Gaia, Greta, Viola, Asia e Marta), 17 trisillabi e un solo quadrisillabo, peraltro<br />
in forte <strong>di</strong>scesa (Federica) 3.<br />
In genere, anche le forme <strong>di</strong> prenomi, ridotti al solo suffisso, come Ina o<br />
Uccio, sono propri più dell’oralità che della scrittura (e quasi assenti dai<br />
documenti ufficiali); tuttavia, nel registro familiare dello scritto, in <strong>di</strong>afasia,<br />
è ben possibile trovarli attestati in lettere o anche messaggi telematici. I<br />
nomi monosillabici inglesi sono invece anche anagrafici e comunque assai<br />
più usati nei testi scritti: basti pensare al confronto tra la forma italiana<br />
piena (o quasi) e a quella americana: Giovanni/Gianni > John, Giuseppe > Joe,<br />
Giacomo > James 4 e alla quasi infinita serie monosillabica che si produce con<br />
qualsiasi iniziale: Al, Ann, Ben, Beth, Bill, Bob, Brad, Brooke, Bud, Butch,<br />
Charles, Chuck, Clive, Dan, Dave, Dean, Deb, Dick, Don, Ed, Frank, Fred, Gal,<br />
Gene, Hugh, Ian, Jane, Jay, Jim, Kate, Ken, Lee, Mae, Mark, Mike, Ned, Neil,<br />
Nick, Paul, Pete, Phil, Ray, Rick, Rob, Rose, Sal, Sean, Sid, Steve, Ted, Tim, Todd,<br />
Tom, Van, Vic, Walt, Will, Zack, Zed, ecc.<br />
Nella lingua italiana si sono comunque <strong>di</strong>ffusi negli ultimi anni alcune<br />
tipologie innovative <strong>di</strong> accorciamenti:<br />
• apocopi anziché aferesi e non monosillabi tronchi (Cri, Fra, Gio, Cla,<br />
Pa, ecc.): ve<strong>di</strong> il caso <strong>di</strong> Ale, <strong>di</strong> provenienza settentrionale, per<br />
Alessandro/Alessandra e poi Alessio/Alessia, dove in passato prevaleva<br />
l’ipocoristico mozzato a sinistra, ossia Sandro/Sandra; è comunque<br />
frequentissimo, nell’oralità come nelle scritture <strong>brevi</strong> (messaggi <strong>di</strong> posta<br />
elettronica, sms, ecc.), il ricorso alle sole prime sillabe <strong>di</strong> un nome tri-‐‑ o<br />
quadrisillabico: Bea[trice], Cate[rina], Ceci[lia], Dani[ela/e], Emi[lia],<br />
Fede[rica/o], Leti[zia], Ludo[vica/o], Manu[ela/e], Simo[na/e], Vale[ntina/o],<br />
ecc.;<br />
• nuove forme fungibili in relazione anche a nomi <strong>di</strong> moda, per es. Lele<br />
(con l’assimilazione consonantica regressiva che ricor<strong>di</strong>amo dall’epoca<br />
3 In parallelo, tra i primi 30 nomi maschili, i bisillabi sono soltanto 6 (Luca, Marco, Christian e<br />
Cristian, Diego e Pietro); figurano tuttavia alcuni trisillabi (Andrea, Matteo e Mattia) e<br />
quadrisillabi composti <strong>di</strong> poche lettere (Samuele, Edoardo).<br />
4 E Jack con beneficio d’inventario: perché c’è chi sostiene che si tratti invece <strong>di</strong> un ipocoristico<br />
<strong>di</strong> Joseph o <strong>di</strong> altri nomi ancora.
E. Caffarelli 53<br />
me<strong>di</strong>evale) per tutti i nomi ebraici in -‐‑ele; Chica per Federica (anche qui con<br />
il medesimo processo fonetico) e inoltre per Cristina, Francesca ecc.;<br />
• la riduzione drastica delle forme suffissate con -‐‑ino/-‐‑a e con -‐‑etto/-‐‑etta –<br />
anche i suffissi, è peraltro <strong>di</strong>mostrato, vivono i loro periodo <strong>di</strong> moda – e<br />
dunque il passaggio <strong>di</strong> testimone, per esempio, tra Simonetta e Simona o la<br />
scomparsa <strong>di</strong> voci quali Paolina o Luigina o Enrichetta in favore delle<br />
corrispondenti forme base, per non <strong>di</strong>re del tramonto <strong>di</strong> Andreina e simili in<br />
favore <strong>di</strong> Andrea anche femminile. Ma quest’ultimo aspetto<br />
dell’antroponimia, in particolare femminile, presenta il suo rovescio della<br />
medaglia. Una sensibile preferenza per le forme base ha riportato in auge i<br />
nomi pieni a scapito anche <strong>di</strong> forme più <strong>brevi</strong>, per esempio ipocoristici del<br />
tipo Gina/-‐‑o, Lina/-‐‑o, Nina/-‐‑o, Rina/-‐‑o, Tina/-‐‑o, ecc. che, se sopravvivono<br />
nell’oralità, sono quasi scomparse nelle scritture anagrafiche e ufficiali.<br />
4. L’orientamento dei parlanti<br />
Al proposito può cogliersi anche in alcune affermazioni (cercando in<br />
rete) un orientamento favorevole non tanto ai nomi lunghi in sé, quanto ai<br />
nomi pieni, parallelamente al timore per accorciamenti e ipocoristici vari<br />
che potrebbero risultare sgra<strong>di</strong>ti. Riporto alcuni frammenti <strong>di</strong> un forum<br />
datato 20.12.2009 (); il messaggio<br />
che ha originato la <strong>di</strong>scussione s’intitola “Rachele o alessia” e riguarda il<br />
nome da imporre a una bambina:<br />
VANILLA 73: «[...] mi <strong>di</strong>cono che Rachele è pesante, che la prenderanno in giro, che<br />
ab<strong>brevi</strong>ato sarà... Rache=Racchia che sarà tormentata dai primi giorni <strong>di</strong> scuola. Ma<br />
<strong>di</strong>co io non è mica Genoveffa o ancora più strani».<br />
VERITAS56: «[...] Rachele lo trovo decisamente bruttarello, senza contare che mi<br />
richiama l’aggettivo “rachitico” oppure il sostantivo “chela” e mi dà quin<strong>di</strong><br />
un’impressione negativa».<br />
PATTY042: «[...] ho una bimba che si chiama Hilary. Quado doveva nascere anch’io<br />
volevo mettere Rachele o Rebecca. Ma una mia vicina insegnante in una scuola<br />
me<strong>di</strong>a me lo sconsigliò <strong>di</strong>cendomi che questi nomi erano molto storpiati tra i<br />
ragazzi [...]».<br />
IRIDELLA84: «Rachele mi sa <strong>di</strong> vecchia...».
54<br />
Microantroponimi del XXI secolo<br />
LYLAMAI: «[...] Rachele non ha bei <strong>di</strong>minutivi ve<strong>di</strong> Rachi, Rache. Non riesco a<br />
farmelo piacere».<br />
LILMUFFIN: «[...] un nome <strong>di</strong> origine ebraica ed ha il significato <strong>di</strong> “mite” è in<strong>di</strong>cato<br />
per persone del segno del saggittario ed è legato al numero 2... si <strong>di</strong>ce che sia attenta<br />
alla cura <strong>di</strong> se, è competitiva e mira in alto (e se mi permettete un commento<br />
personale è un nome nobile e veramente bello!!!».<br />
Dunque in questo breve scambio <strong>di</strong> opinioni emergono le principali<br />
motivazioni legate alla scelta del nome: l’eufonia, la moda, il significato...<br />
ma anche il pericolo delle storpiature e dei <strong>di</strong>minutivi. Non tutti<br />
ragioneranno in modo così articolato, ma certo il nome “breve” rappresenta<br />
per alcuni un rischio che è meglio evitare <strong>di</strong> correre. Per darne conferma,<br />
cito un altro frammento <strong>di</strong> forum dallo stesso sito (“Nino e ab<strong>brevi</strong>azioni<br />
nomi” il messaggio <strong>di</strong> partenza, datato 22.11.2005), rimarcando che, per<br />
quanto si tratti <strong>di</strong> osservazioni metalinguistiche, anzi metaonomastiche, è<br />
pur sempre “scrittura”:<br />
PETRA186: «Il nome NINO, come vi piace? Ci sono molti bambini dalle vostre parti<br />
chiamati così? Una curiosità: sapreste suggerirmi un’altra ab<strong>brevi</strong>azione per<br />
Lorenzo che il solito Enzo? [...] I nomi Jacopo e Stefano, invece, che forma familiare<br />
carina vi viene in mente?».<br />
MARIAPIA89: «NINO alle mie parti è quasi sempre il <strong>di</strong>minutivo <strong>di</strong> GAETANO, ma<br />
ci sono anche SEBASTIANO (mio padre si chiama così e viene chiamato Nino) e<br />
ANTONIO. Per LORENZO non mi piace nè Enzo e nè Renzo, preferisco Iori anche<br />
se mi sà troppo <strong>di</strong> femminile! Per quanto riguarda STEFANO mi piace Stè, mentre<br />
JACOPO è bellissimo così comè e non riesco a trovare un <strong>di</strong>minutivo».<br />
VIVIAH: «[...] Il bimbo <strong>di</strong> una coppia <strong>di</strong> conoscenti lo chiamano Nino, lui si chiama<br />
Antonino e ha anche altri 2 nomi. Conosco un signore anziano <strong>di</strong> nome Nicola che<br />
per viene chiamato Nino... Lorenzo penso che si possa ab<strong>brevi</strong>are solo con Lore,<br />
Lory o Enzo (ma un nome così bello come Lorenzo non si può rovinare con Enzo o<br />
Renzo). Anche a me piace molto Jacopo, anch’io ho pensato a come si potrebbe<br />
ab<strong>brevi</strong>are: Jaco, Jachy, c’è chi mi ha detto Pino=Jacopino ma è tremendo! O chi mi<br />
ha suggerito Chino... Stefano può <strong>di</strong>ventare Nino=Stefanino, Ste, Stefy, Stefa, Fano<br />
(bleah)».<br />
MARSHALL66: «[...] mi pare <strong>di</strong> capire che non sei italiana (forse tedesca, o?) <strong>di</strong>co così<br />
perché mi sembra che ormai in Italia i nomi ab<strong>brevi</strong>ati <strong>di</strong> questo tipo siano in<br />
<strong>di</strong>suso, [e ci metto anche Gino/a Rino/a Lino/a Dino/a Pino/a Tino/a Mino/a, a<br />
<strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> 50 anni fa], mentre in Germania mi dà l’idea che siano ancora
E. Caffarelli 55<br />
utilizzati, forse perché visti come esotici... a me personalmente sanno proprio <strong>di</strong><br />
vecchio e <strong>di</strong> sciatto, anche se effettivamente sono semplici e imme<strong>di</strong>ati [...]».<br />
In questa <strong>di</strong>scussione si dà dunque per scontato che i nomi ufficiali<br />
debbano poi essere ab<strong>brevi</strong>ati e pare che la scelta possa essere orientata, se<br />
non determinata, non tanto dalla bellezza e piacevolezza del nome pieno,<br />
quanto dal suo o dai suoi ipocoristici. Solo se il nome base è bellissimo,<br />
allora bisogna rinunciare al <strong>di</strong>minutivo: e pare quasi un prezzo da pagare a<br />
quella bellezza. L’ultimo intervento riportato avverte come ormai estranei<br />
all’onomastica italiano i bisillabi in -‐‑ino, considerandoli invece propri <strong>di</strong><br />
altri domini linguistici. Il che, peraltro, è parzialmente vero. Ma trovo un<br />
altro scambio <strong>di</strong> parere interessante a partire dal messaggio “Nomi bimba e<br />
ab<strong>brevi</strong>azioni” (novembre 2005):<br />
NICOVONPOZZAR: «[...] Io personalmente adoro i <strong>di</strong>minutivi: mia figlia si chiama<br />
Caterina e viene chiamata: Cate, Cat, Cater, Ina, Kitty, Ketty, Catine!! [...]<br />
Caterinuccia [...], Inuccia, Inetta, Kit, a seconda dell’interlocutore e dell’umore del<br />
suddetto. Lei non ha MAI battuto ciglio, si volta sempre a qualsiasi nomignolo e<br />
non ha mai detto “che brutto”. Aggiungo che insegno e ho esattamente 147 alunni,<br />
se non ci fossero i <strong>di</strong>minutivi impazzirei con la selva <strong>di</strong> Niccol[ò], Nicola, Nicholas,<br />
Nicolas, Nicole, Nicol, Nicoletta, Tomas, Thomas, Tommaso, Riccardo, Michele,<br />
Andrea (maschio e femmina) eccetera eccetera. Sopravvivo chiamando tutti Vic,<br />
Nic, Ric, Tim, Rom, Camy, Meggu e avanti».<br />
MARIAPIA89: «Ho 2 amiche che si chiamano Angelica [...] qualche volta le chiamo<br />
per cognome ma è brutto e allora una la chiamato Gegy (<strong>di</strong>minutivo inventato da<br />
me) e l’altra Angy o Angè. Le altre le chiamo TANIA (da Gaetana [...], ELY o E (da<br />
Elena), FRA (da Francesca), SIMO o Etta (da Simonetta), ANNA (da Annalisa),<br />
DANY (da Daniela). [...] Benedetta (Benny): si ma anche Bene; Bia (significa “vita”...<br />
è pratico: non si ha nemmeno il bisogno <strong>di</strong> ab<strong>brevi</strong>are!): già cortissimo. Ludovica<br />
(Vicky; Lulù): Lulù o Ludo; Fabiola (Fabi): sì ma anche Fà».<br />
TITTI163: «Mia figlia Ludovica viene chiamata ludo... mio figlio andrea.. andry.. si<br />
sono importanti le ab<strong>brevi</strong>azioni.. io ab<strong>brevi</strong>o tutto i nomi... quando ludo la chiama<br />
vica [...] non mi piace».<br />
A parte l’orgoglio per la passiva accettazione da parte della figlia dello<br />
“scempio” onimico <strong>di</strong> Caterina, della prima madre colpisce la percezione <strong>di</strong><br />
una forte omonimia sul piano dei nomi ufficiali e della funzione del<br />
“<strong>di</strong>minutivo” in chiave <strong>di</strong>stintiva: colpisce anche perché un nome più<br />
lungo dovrebbe avere più probabilità <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinguersi; infatti l’insegnante<br />
non specifica come si rivolge ai vari Niccol[ò], Nicola, Nicholas, Nicolas,
56<br />
Microantroponimi del XXI secolo<br />
Nicole, Nicol, Nicoletta..., dando per scontato che non potrà orientarsi sul<br />
tipo “Tim” e “Ric”, perché finirebbe per omologare metà classe<br />
all’ipocoristico “Nic”.<br />
La seconda interlocutrice spiega le strategie poste in essere per<br />
<strong>di</strong>ffenziare le amiche omonime, esprime un parere su una serie <strong>di</strong> nomi da<br />
accorciare, proposti dal primo messaggio e qui omessi, consiglia <strong>di</strong><br />
estendere la sua tecnica <strong>di</strong> apocope dopo la prima sillaba (v. Fabiola ridotto<br />
a Fà) e, complessivamente, pare talmente impegnata a in<strong>di</strong>viduare le<br />
riduzioni eufoniche e funzionali che bene<strong>di</strong>ce il nome Bia in quanto, così<br />
corto <strong>di</strong> suo, non le imporrebbe sforzo alcuno.<br />
Anche la terza partecipante al forum ab<strong>brevi</strong>a i nomi, ma sottolinea che<br />
c’è modo e modo <strong>di</strong> accorciare: la figlia Ludovica è regolarmente Ludo, guai<br />
a chiamarla Vica. Si noti anche la scelta razionale e non spontanea del nome<br />
breve, del tutto opposta a quanto accadeva in passato, quando gli<br />
ipocoristici e i fenomeni <strong>di</strong> caduta sillabica <strong>di</strong>pendevano dall’uso e pertanto<br />
si basavano, come visto, sulla conservazione della vocale tonica; ora i<br />
prenomi vengono frammentati e se ne sceglie una porzione, quella più<br />
eufonica, che piace <strong>di</strong> più. Si veda un successivo intervento:<br />
HAWIKA: «Ludovica (Vicky; Lulù) piuttosto Luvi ma lulù no!!!. Fabiola (Fabi) meglio<br />
così che ab<strong>brevi</strong>ato in Lola (conosco una ragazza che si presenta così».<br />
Poche le voci in controtendenza:<br />
viva800: «No, per carità... Pensare già ad un’ab<strong>brevi</strong>azione per un nome è una cosa<br />
in sè che proprio non mi piace. Nomi bellissimi vengono storpiati in nomignoli<br />
ri<strong>di</strong>coli quasi fossero dei nick... proprio brutto! Io ho chiamato mio figlio Gianni... se<br />
tornassi in<strong>di</strong>etro [...] ci penserei forse un attimo... ma sento intorno a me tanti<br />
Giovanni ab<strong>brevi</strong>ati in Gianni che mi fa una rabbia incredbilie... Così come<br />
Alessandro (il mio vicino 25enne) “Aleeeeeeeee”; Leonardo “Leooooooooooo”...<br />
persino Bernardo <strong>di</strong> più <strong>di</strong> 40 anni “Dadoooooooo” come fosse un frugoletto <strong>di</strong><br />
pochi mesi. No, guarda... se uno deve partire già con il presupposto <strong>di</strong> scovare<br />
anche un <strong>di</strong>minutivo... meglio Ugo, Ivo, Ada, Eva, Ebe... almeno nessuno li<br />
massacrerà mai».<br />
E in quest’ultima opinione emerge la netta <strong>di</strong>stinzione tra il nome<br />
anagrafico, che tale dovrebbe restare nell’uso, e il nick che avrebbe la<br />
connotazione del ‘ri<strong>di</strong>colo’, mentre la forma accorciata risulterebbe propria<br />
soltanto della prima infanzia. La soluzione parrebbe essere la prevenzione,
E. Caffarelli 57<br />
optando per un bisillabo magari <strong>di</strong> tre lettere: e poiché l’eventuale<br />
alterazione (suffissazione) non preoccupa, sembra palesarsi la concezione<br />
secondo la quale la questione si gioca non tanto sul rapporto<br />
lunghezza/<strong>brevi</strong>tà, quanto sulla <strong>di</strong>cotomia ufficialità/manipolazione:<br />
insomma, il nome “intoccabile” nella sua forma base.<br />
5. Un confronto oltralpe<br />
Se <strong>di</strong>amo uno sguardo alla Francia, ve<strong>di</strong>amo che i prenomi più portati<br />
dalla popolazione nel suo complesso risultano <strong>oggi</strong>, frutto ovviamente <strong>di</strong><br />
stratificazioni cronologiche, Michel, Pierre e Jean in campo maschile, con<br />
tipi, tra i primi 50, <strong>di</strong> una certa consistenza fonetica, quali Philippe, Bernard,<br />
Christophe, Fréderic, Sébastien, Alexandre, Dominique, Guillaume e i doppi Jean-‐‑<br />
Pierre e Jean-‐‑Claude. In campo femminile: Monique, Nathalie, Catherine,<br />
Françoise e Isabelle e tra i primi 50 anche Jacqueline, Jeannine, Christine,<br />
Sandrine, Christiane, Stéphanie, Véronique, Dominique, Madeleine, Carolina,<br />
Geneviève e i doppi Anne-‐‑Marie e Marie-‐‑Thérèse (cfr. Besnard&Desplanques<br />
2004).<br />
Si notino i trisillabi e i quadrisillabi, non così frequenti nella lingua<br />
francese, e i composti che hanno avuto oltralpe maggiore fortuna che in<br />
Italia. Li si confronti con i nomi imposti con maggiore frequenza nei primi<br />
anni del XXI secolo; maschi: Lucas, Théo, Thomas, Hugo, Enzo, Quentin,<br />
Maxime, Mathis, Louis, Tom tra i primi 20; femmine: Léa, Manon, Chloé,<br />
Emma, Sarah, Clara, Inés, Camille, Lucie, Julie, Lisa, Laura, Éva, Jade sempre tra<br />
i primi 20. Non c’è dubbio, pertanto, che in Francia ci si stia orientando<br />
verso prenomi più <strong>brevi</strong> che nel passato; naturalmente per avere valore<br />
statistico i confronti dovrebbero essere ampliati a un numero superiore <strong>di</strong><br />
ranghi e includere vari altri domini linguistici,. Ma ciò non rientra nei<br />
compiti e nei limiti <strong>di</strong> questa comunicazione. Tuttavia, come semplice<br />
in<strong>di</strong>catori, possono offrirci materia su cui riflettere.<br />
6. Le altre se<strong>di</strong> dell’onomastica breve<br />
Quali sono altre se<strong>di</strong> “onomastiche” nelle quali si riflette l’urgenza della<br />
comunicazione, i tempi <strong>brevi</strong> richiesti dalle nuove tecnologie, i ritmi<br />
frenetici del tempo che viviamo? Ve<strong>di</strong>amone rapidamente un campionario<br />
<strong>di</strong> altri luoghi.
58<br />
Microantroponimi del XXI secolo<br />
Odonimia e dunque insegne stradali: sono ben conosciute quelle<br />
insegne rettangolari a fondo bianco e bordo blu, minimali nelle <strong>di</strong>mensioni,<br />
con il determinato, ossia la tipologia dell’area scritta in caratteri<br />
microscopici, e il nome dell’area su una sola riga in caratteri rigidamente<br />
minuscoli; è anche noto che i Paesi dell’Unione Europea sono stati costretti<br />
ad adattarsi a una normativa comunitaria, tesa, nelle intenzioni dei<br />
promotori, a uniformare e a rendere più chiara l’informazione stradale. In<br />
realtà la sede <strong>di</strong> scrittura è talmente limitata che i prenomi <strong>di</strong> alcuni<br />
de<strong>di</strong>catari sono sovente ridotti all’iniziale puntata: ciò accresce la<br />
confusione tra omonimi (le nostre città sono piene <strong>di</strong> strade e piazze<br />
de<strong>di</strong>cate a due o più persone con lo stesso cognome, oppure a personaggi il<br />
cui cognome coincide con un toponimo a sua volta ricordato in altra area...)<br />
e, inoltre, rende alcuni insegne curiose, per non <strong>di</strong>re ri<strong>di</strong>cole: come le<br />
numerose “Via D. Alighieri” o, peggio “Via Alighieri D.” che incontriamo<br />
nelle nostre città.<br />
Crematonimi e in particolare prodotti commerciali: da un lato i marchi –<br />
qui s’intendono quelli composti dai cognomi dei fondatori/proprietari delle<br />
aziende – tendono ad essere compressi in un acronimo: ma non è vezzo<br />
moderno; se pren<strong>di</strong>amo le aziende motoristiche a partire dagli ultimi anni<br />
dell’Ottocento e primo Novecento e ne confrontiamo le ragioni sociali con<br />
le industrie o<strong>di</strong>erne, incontriamo un numero elevatissimo <strong>di</strong> sigle: da ABC<br />
(Anonima Brevetti Chiribiri) a VALT (Vetturette Automobili Leggere<br />
Torino), passando per AM, ASA, ATS, BBC, BN, CABI, CAR, CEVA, CIP.<br />
CMN, DRB, EIA, FAIT, FAS, FATS, FIAM, FLAG, FOD, FRAM, FTA, LUX,<br />
MBP, MRR, OM, OMT, OSCA, SABA, SACA, SALM SAOM, SCA, SIATA,<br />
SIC, SILVA, SIMS, SIVE, SMB, SMIN, STAR, SVAN, e solo per citare alcune<br />
aziende nate in Italia tra fine Ottocento e primo Novecento.<br />
Nei nomi dei prodotti alimentari troviamo invece marchi<br />
deantroponimici ab<strong>brevi</strong>ati, ossia i nomi aziendali (per lo più cognomi e<br />
toponimi) ridotti a un paio <strong>di</strong> sillabe e più spesso a una soltanto, una marca<br />
<strong>di</strong>stintiva combinata con altri elementi portatori ciascuno <strong>di</strong><br />
un’informazione. Ecco alcuni esempi: il marchio <strong>di</strong> salumi Beretta entra<br />
parzialmente nel würstel Wüber e negli alterati Wüberone e Wüberini; inoltre:<br />
i composti Biralungo e Birasnack (Biraghi); i crackers salati GranPavesi<br />
(Pavesi); Sanciok, metà cacao e metà biscotto (Sanson). Un ricco campione è<br />
fornito dal marchio Doria: sfruttando il lessico, la casa produce i crackers<br />
salati Doriano, i biscotti agli agrumi Doriflor, i frollini Doricrem e gli snack
E. Caffarelli 59<br />
salati Doribar. Anche marchi stranieri, ma ben noti in Italia, si trovano<br />
variamente combinati nei nomi dei prodotti: dal cognome svizzero Nestlè<br />
sono nati Nescafè, Nespresso (caffè in capsule – si noti l’incrocio), Nestea,<br />
Nesquik, Nescau, Neslac e Nespray, Nestum e Nestogen, con Nes-‐‑ sorta <strong>di</strong><br />
prefissoide aziendale. Analogamente il marchio multinazionale Danone si<br />
ritrova parzialmente in Danacol, Danette, Danito, Danaos (con vitamina D<br />
per rinforzare le ossa). Un altro popolarissimo marchio è McDonald, che<br />
applica la sua marca morfologica <strong>di</strong> appartenenza, il M(a)c <strong>di</strong> molti nomi <strong>di</strong><br />
famiglia scozzesi, ancora a guisa <strong>di</strong> prefissoide alla lista detta McMenu e<br />
dunque ai prodotti McToast, McChicken, BigMac, McRoyal Deluxe, McItaly<br />
Vivace-‐‑Adagio, McWrap Caesar, Cripsy McBacon, McNuggets, ecc.<br />
Un settore che possiamo accogliere come esemplificativo della tendenza<br />
<strong>di</strong> ridurre al minimo il cognome aziendale ma <strong>di</strong> inserirlo nelle<br />
denominazioni propri prodotti è quello farmaceutico. Basta qui una<br />
manciata <strong>di</strong> esempi sui tanti possibili: Sandoz in San<strong>di</strong>mmun,<br />
Sandoglobulina, Sandomigran; Bayer in Bayolin, Baypen, Baypress,<br />
Glucobay, Metbay; Roche in Roaccutan, Rocefin, Roferon, Roipnol; Menarini<br />
in Menaderm, Menalgon, Menorest, Azolmen, Climen, Dolmen, Miocamen,<br />
Neocytamen; Malesci in Aminomal, Diffumal, Paidomal; Gentili in Genalen,<br />
Genaprost, Gentipress, Montegen; Bracco in Tebraxin; Bruschettini in<br />
Brumeti<strong>di</strong>na e Bruxicam; Dr. Falk in Salofalk e Ursofalk; Formenti in<br />
Forgenac; Lampugnani in Lampocef, Lampoflex, Lampomandol; Molteni in<br />
Mepivamol e Molcain; ecc.<br />
Infine un cenno alla crescente riduzione <strong>di</strong> marchi complessi alla parola<br />
chiave; è il caso degli istituti <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to, nel linguaggio giornalistico sempre<br />
più spesso ridotti al toponimo che in<strong>di</strong>ca l’appartenenza della banca: Lo<strong>di</strong>,<br />
Mantova o Novara stanno rispettivamente per Banca Popolare <strong>di</strong> Lo<strong>di</strong>, Banca<br />
Popolare <strong>di</strong> Mantova e Banca Popolare <strong>di</strong> Novara. Lo stesso capita per le<br />
squadre sportive (ad eccezione del calcio), dove si tende a citare il solo<br />
toponimo omettendo l’articolo, un’eventuale suffissazione corrispondente<br />
all’aggettivo etnico e sovente il nome dello sponsor: così è facile leggere<br />
“Siena batte Roma” nel basket o “Trento si arrende a Macerata nella corsa<br />
scudetto” nella pallavolo, mentre i nomi ufficiali delle contendenti<br />
risultano rispettivamente Itas Diatec Trentino e Lube Banca Marche Macerata.
60<br />
7. Pseudonimi e nomi d’arte<br />
Microantroponimi del XXI secolo<br />
Un’altra area privilegiata del nome breve è la firma pseudonimica o il<br />
nome d’arte. Tuttavia non è semplice cogliere in questo àmbito un<br />
cambiamento d’abitu<strong>di</strong>ne o, secondo la nostra iniziale ipotesi, una<br />
tendenza più sviluppata negli ultimi anni verso l’accorciamento dei nomi.<br />
La verifica si può cercare tra gli scrittori, i giornalisti, i vignettisti, gli<br />
attori, i registi cinematografici, i cantanti. Ma, tra casi abbastanza isolati,<br />
come Totò e Macario attori, Trilussa poeta, Steno regista, posso sottolineare<br />
solo alcuni repertori più consistenti:<br />
• firme <strong>di</strong> vignettisti: in genere limitate al solo cognome (Altan, Bucchi,<br />
Forattini, Giannelli, Krancic, Manetta, Staino, Vincino, ecc.) o al solo prenome<br />
(Vauro), talvolta con una sigla acronimica o pseudotale (BDA – Bruno<br />
D’Alfonso – oltre allo storico Sto – Sergio Tofano –, e non sempre con<br />
risparmio grafico: Elle Kappa) o con uno pseudonimo (Quino);<br />
• cantanti: limitatamente al panorama italiano: Adamo, Al Bano, Alice,<br />
Arisa, Drupi, Dolcenera, Elisa, Giorgia, Fiorello, Fiordaliso, Garbo, Jovanotti,<br />
Mango, Michele, Mietta, Milva, Mina, Morgan, Nada, Neffa, Nek, Povia, Pupo,<br />
Raf, Ron, Scialpi, Siria, Spagna, Tosca, Ugolino, Zucchero; si noti come si tratti<br />
per lo più <strong>di</strong> prenomi – alcuni d’arte – o <strong>di</strong> soprannomi e talvolta <strong>di</strong><br />
cognomi (Adamo, Fiorello, Scialpi, Spagna, ecc.);<br />
• coppie o trii <strong>di</strong> artisti, in particolare comici; qui la scelta si giustifica<br />
sia con la tra<strong>di</strong>zione cinematografica <strong>di</strong> coppie quali Stanlio & Ollio o Gianni<br />
e Pinotto, sia con la necessità <strong>di</strong> non appesantire la propria firma artistica<br />
con tutti i prenomi e tutti i cognomi: Totò e Peppino, Billi e Riva, Ric e Gian,<br />
Cochi e Renato, Franco e Ciccio, Gaspare e Zuzzurro, Gigi e Andrea, fin ai più<br />
recenti Ficarra e Picone, Luca e Paolo, Aldo Giovanni e Giacomo, Ale e Franz;<br />
• tra i personaggi dello spettacolo si possono comunque in<strong>di</strong>viduare<br />
vari nomi d’arte più <strong>brevi</strong> <strong>di</strong> quelli anagrafici: ne sono palese testimonianza<br />
i cognomi reali accorciati, sul palco, per apocope: Giorgio Gaber da<br />
Gaberscik, Charles Aznavour da Aznavourian, Jenifer Aniston da<br />
Anistonapoulos, Ringo Starr da Starkey; per aferesi: Orietta Berti da
E. Caffarelli 61<br />
Galimberti; per sincope: Ombretta Colli da Comelli, Clau<strong>di</strong>a Mori da Moroni,<br />
ecc. 5<br />
Per chi conosce tali nomi, appare evidente che si tratta <strong>di</strong> tra<strong>di</strong>zioni<br />
pseudonimiche o ellittiche che si continuano nel tempo, senza che emerga<br />
negli ultimi anni un orientamento più <strong>di</strong>ffuso verso scritture onimiche<br />
<strong>brevi</strong>, che tuttavia persistono nei nuovi personaggi.<br />
Antroponimi <strong>brevi</strong> nella lingua <strong>di</strong> Internet<br />
Fin qui gli antroponimi del registro ufficiale, quelli anagrafici.<br />
Tralasciando l’uso orale che non rientra negli interessi <strong>di</strong> questo gruppo <strong>di</strong><br />
stu<strong>di</strong>o, <strong>di</strong>amo però un rapido sguardo al registro non ufficiale, alle scritture<br />
“colloquiali”, in particolare a quelle della lingua “trasmessa” <strong>di</strong> Internet 6,<br />
per il motivo della grande <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> messaggi e dunque <strong>di</strong> “firme” in<br />
rete e per la massima accessibilità da parte del ricercatore 7.<br />
Ho concentrato l’attenzione sui cosiddetti nicknames, per verificare, sia<br />
pure con campioni necessariamente ridotti e dunque in grado <strong>di</strong> fornire<br />
informazioni qualitative e solo in parte quantitativa, ma certo non <strong>di</strong> valore<br />
statistico, quale sia il livello <strong>di</strong> “accorciamento” della propria catena<br />
onimica in rete e quale sia lo status prevalente del cosiddetto nickname 8.<br />
5 Lino Banfi racconta che fu Totò, incontrato sul palco del Sistina nel 1965, a suggerirgli <strong>di</strong><br />
cambiare il primo nome d’arte, Lino Zaga da Pasquale Zagaria: «Cambialo. I cognomi ab<strong>brevi</strong>ati<br />
portano sfortuna».<br />
6 Termine che mi pare <strong>di</strong> poter applicare anche qui, sulla scia della definizione <strong>di</strong> Francesco<br />
Sabatini inizialmente in relazione con teatro, cinema, testi musicali e televisione, anche agli<br />
strumenti dell’informatica e della telematica.<br />
7 Chi ha stu<strong>di</strong>ato repertori <strong>di</strong> messaggeria telefonica ha senz’altro incontrato e già trattato<br />
anche <strong>di</strong> nomi propri e <strong>di</strong> firme – così come anche quanti si sono occupati della lingua <strong>di</strong><br />
internet hanno citato l’argomento del nome proprio: ho per questo provato a ritagliarmi alcuni<br />
aspetti molto specifici, che spero possano risultare d’un qualche interesse.<br />
8 Avrei voluto stu<strong>di</strong>are anche un ampio campione <strong>di</strong> account <strong>di</strong> posta elettronica ma non vi era<br />
il tempo né lo spazio: del resto il nickname usato in rete talvolta è spesso strutturato in modo<br />
simile se si tratta <strong>di</strong> bambini e ragazzi o <strong>di</strong> chi usa la posta elettronica per comunicazioni non<br />
formali e non professionali; in quest’ultimo caso, sappiamo bene che prevale l’uso del solo<br />
cognome o del cognome accompagnato dal nome, o dall’iniziale del nome, puntata o no, ma<br />
comunque equivale, se non a una firma completa, per es. alle citazioni bibliografiche <strong>di</strong> un<br />
articolo scientifico dove, con rare eccezioni, gli autori e i curatori vengono segnalati con il<br />
cognome e la sola iniziale del prenome.
62<br />
Microantroponimi del XXI secolo<br />
Ho condotto due <strong>brevi</strong> ricerche in particolare. La prima legata ai<br />
nickname alfanumerici (cfr. Caffarelli 2012b). Non si tratta <strong>di</strong> una novità:<br />
almeno da quarant’anni, a mia memoria, soprattutto i giovani sono soliti<br />
firmarsi – ricordo le lettere inviate al settimanale per il quale ho scritto tra il<br />
1969 e il 1985, «Ciao 2001» – con il nome <strong>di</strong> battesimo, o uno pseudonimo,<br />
accompagnato dalla data <strong>di</strong> nascita (perlopiù limitatamente alle ultime due<br />
cifre). È esperienza comune, <strong>di</strong> chi frequenti il web, che tale prassi si sia<br />
continuata e, anzi, nettamente intensificata. Un àmbito antroponimico<br />
particolare nel quale è ben presente l’elemento numerico è costituito dalle<br />
firme parapseudonimiche, quelle cioè che svelano soltanto in parte<br />
l’identità personale e che negli ultimi decenni ha trovato un enorme<br />
sviluppo nella rete telematica, dunque nei cosiddetti nickname <strong>di</strong> Internet,<br />
negli in<strong>di</strong>rizzi <strong>di</strong> posta elettronica e nelle denominazioni dei siti web.<br />
Ho potuto calcolare, cercando con il motore Google la formula N+data,<br />
per es. Giulia99, e tornando in<strong>di</strong>etro calando il numero fino a Giulia20, un<br />
altissimo numero <strong>di</strong> occorrenze 9; e, a conferma <strong>di</strong> quanto avevo ipotizzato<br />
– partendo dal presupposto con<strong>di</strong>visibile che i giovani usano scrivere in<br />
rete più degli adulti e questi più degli anziani – ho riscontrato che il<br />
numero delle occorrenze decresce con il crescere dell’età, ma poi torna a<br />
salire perché, evidentemente, ci sono casi in cui i giovani (intendo i<br />
bambini, gli adolescenti e i giovani adulti) usano come cifre della propria<br />
firma alfanumerica non l’anno <strong>di</strong> nascita, ma la propria età: l’abbondanza<br />
<strong>di</strong> Giulia30 o Giulia20, insomma, più che far pensare a un folto gruppo <strong>di</strong><br />
signore ottantenni e novantenni intente ad animare forum, raccontarsi nei<br />
blog e scambiarsi foto e messaggi nei social network, a ventenni e trentenni,<br />
appunto.<br />
La formula più <strong>di</strong>ffusa, nell’utilizzo <strong>di</strong> un numerale, è come si <strong>di</strong>ceva<br />
quella costituita dal prenome associato all’anno <strong>di</strong> nascita, espresso con<br />
quattro cifre o, più sovente, con le due ultime soltanto. Prendendo uno dei<br />
prenomi femminili imposti con maggiore frequenza in Italia negli ultimi 30<br />
anni – Sara – e limitando la ricerca <strong>di</strong> pagine web, attraverso il motore<br />
Google, a quelle in lingua italiana, si ottengono frequenze elevatissime <strong>di</strong><br />
occorrenze del tipo Sara+numerale. Si va dalle 144.000 occorrenze <strong>di</strong> Sara88<br />
e dalle 27.200 <strong>di</strong> Sara82 a valori comunque superiori a 10.000 per ogni<br />
9 Quando si <strong>di</strong>ce altissimo s’intende però il numero apparente <strong>di</strong> pagine: che vanno ridotte,<br />
secondo i casi, e comunque se superano il migliaio, dall’80 al 90%.
E. Caffarelli 63<br />
numero compreso tra 80 e 99 e maggiori <strong>di</strong> 5.000 per vari altri numeri<br />
compresi tra 11 e 79 10. Risultati simili possono registrarsi con altri prenomi,<br />
tanto femminili quanto maschili.<br />
Il numerale legato al nome <strong>di</strong> persona segnala perlopiù la data <strong>di</strong><br />
nascita del portatore. Oltre che sull’esperienza e sull’intuito, la spiegazione<br />
si basa su un fattore probabilistico <strong>di</strong> assoluta evidenza: tenuto conto che il<br />
prenome Sara ha notevolmente accresciuto la sua <strong>di</strong>ffusione in Italia nelle<br />
ultime generazioni e che i luoghi telematici dove appaiono le firme (i<br />
nickname o soprannomi) sono frequentate in misura maggiore dai giovani<br />
che dagli adulti e dagli anziani, ci aspetteremmo grossomodo una frequenza<br />
superiore dei numeri corrispondenti agli anni <strong>di</strong> nascita compresi tra il<br />
1975 e il 1999 e valori descrescenti via via che le cifre più basse in<strong>di</strong>cano<br />
una maggiore età della persona; ciò che i dati rilevati nella ricerca con il<br />
motore Google confermano pienamente; la risalita della curva con i numeri<br />
inferiori a 30 può infatti giustificarsi se li si considera, come detto sopra,<br />
non più rappresentazione dell’anno <strong>di</strong> nascita, bensì dell’età del portatore.<br />
Un ulteriore in<strong>di</strong>zio favorevole all’ipotesi è dato dalla serie <strong>di</strong> valori<br />
in<strong>di</strong>viduati per le formule a quattro cifre, il tipo Sara1999; ebbene, anche in<br />
questo caso i valori massimi si riferiscono agli anni 80 e 90, e in<br />
corrispondenza dei numeri compresi tra 1910 e 1960 le presenze sono<br />
minime e in genere fallaci, proprio come ci si aspetterebbe.<br />
L’utilizzo della combinazione prenome+anno <strong>di</strong> nascita (o anno d’età) è<br />
la spia <strong>di</strong> un interessante aspetto psicologico, che qui si lascia<br />
evidentemente al vaglio degli specialisti in materia: nel biglietto da visita<br />
rappresentato dalla firma/nickname il riferimento all’età parrebbe più<br />
importante del cognome, della città <strong>di</strong> residenza o <strong>di</strong> qualsiasi altra<br />
appartenenza e segno <strong>di</strong>stintivo. Sarebbe interessante stabilire in quale<br />
misura ciò è dovuto alla sinteticità del numero rispetto a in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> tipo<br />
<strong>di</strong>verso. In ogni caso il fenomeno costituisce motivo <strong>di</strong> me<strong>di</strong>tazione per<br />
quanti, stu<strong>di</strong>osi <strong>di</strong> onomastica in testa, paventano legittimamente che in un<br />
futuro non troppo lontano prenomi e cognomi possano essere sostituiti in<br />
parte o in toto da sequenze alfanumeriche <strong>di</strong>stintive, come quelle del co<strong>di</strong>ce<br />
fiscale.<br />
10 Sondaggi effettuati tra il febbraio e il settembre 2011.
64<br />
Microantroponimi del XXI secolo<br />
La <strong>di</strong>ffusione delle firme/nickname con un componente numerale è<br />
documentabile in àmbiti ancor più specifici. Nell’esempio del Fantacalcio e<br />
<strong>di</strong> analoghi concorsi <strong>di</strong> previsioni <strong>di</strong> risultati calcistici, da un’analisi<br />
cursoria dei nomi dei partecipanti riportati in www.fantamagic.it 11 risulta<br />
che circa il 10% degli pseudonomi in<strong>di</strong>cati sono caratterizzati da un<br />
numero. Varia è la tipologia: si va dal tipico abbinamento prenome+anno <strong>di</strong><br />
nascita (presumibile), come toni73, con possibile riferimento anche a un<br />
figlio (alessia06, Sofia2000), a nomi <strong>di</strong> squadre <strong>di</strong> calcio variamente<br />
interpretabili (Lazio74 che ricorda l’anno del primo scudetto vinto dalla<br />
società calcistica romana, reggina77, Stella rossa24, Napoli Soccer 2008,<br />
Rosanero79, 11 bianconeri, ecc.) o anche <strong>di</strong> calciatori (Huntelaar92).<br />
La seconda ricerca effettuata è <strong>di</strong> tipo qualitativo. Ho scelto un sito<br />
molto frequentato, e ho in<strong>di</strong>viduato due campi<br />
nei quali mi pareva <strong>di</strong> poter ipotizzare, da un lato, un interesse particolare<br />
per l’onomastica, ossia le donne che <strong>di</strong>scutono <strong>di</strong> quale nome dare ai propri<br />
bambini in arrivo o comunque <strong>di</strong> quali siano i nomi più belli, ecc. 12; e,<br />
dall’altro lato, un probabile <strong>di</strong>sinteresse per i nomi, e per nomi troppi<br />
sofisticati o articolati, perché i temi erano i più vari e in nessun modo legati<br />
a un interesse per i nomi 13.<br />
Ho dunque raccolto oltre 660 nicknames <strong>di</strong>fferenti usati nell’uno e<br />
nell’altro àmbito, riscontrando, in termini generali, le caratteristiche<br />
seguenti del repertorio:<br />
• non ho rilevato una <strong>di</strong>fferenza significativa tra l’uno e l’altro forum<br />
quanto all’aspetto formale, composizione, uso <strong>di</strong> nomi reali o del tutto<br />
11 Consultato nel marzo 2010.<br />
12 Il campione <strong>di</strong> nickname è tratto da forum su gravidanza, in particolare “nomi” (gennaio<br />
2007) “il nostro nome” (ottobre 2009), “il nome più bello è” (luglio 2010), “origine-‐‑etimologia-‐‑<br />
nomi”, “sondaggi nomi stranieri” (luglio 2008), “mi consigliate questi nomi?” (gennaio 2008),<br />
“fra questi quali preferite” (maggio 2010), “emergenza nome” (giugno 2010) e altri compresi<br />
tra l’inizio del 2007 e la primavera 2010 (tenendo conto che una stessa persona può cambiare il<br />
suo nickname a seconda <strong>di</strong> dove si trova e che talvolta è portata a usare davvero la prima<br />
parola che gli viene in mente; alcune firme, tuttavia, si ritrovano a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> anni).<br />
13 Il campione <strong>di</strong> nickname è tratto da forum che presso il sito http://forum.chatta.it/ sono così<br />
intitolati: “i problemi giovanili”, “politica”, “fatti del giorno”, “chiavi moderni”, “auto<br />
mania”, “motociclisti”, “mercatino <strong>di</strong> chatta”, “over 40”, “si parla <strong>di</strong>...”, “mondo <strong>di</strong>versamente<br />
abile”, “amore e <strong>di</strong>ntorni”, “salute e benessere”, “moda e trend”, ecc.) relativi al maggio 2011<br />
(con qualche messaggio del precedente aprile). Ancora una volta non andrà <strong>di</strong>menticato che i<br />
nick non sono univoci per la stessa persona, ma cambiano spesso.
E. Caffarelli 65<br />
fantasiosi, ecc. dei nicknames; tale omogeneità relativa concerne anche la<br />
quantità delle lettere e dei numeri utilizzati in me<strong>di</strong>a per ciascun nick: 9,44<br />
per il gruppo degli internauti interessati all’onomastica e 9,78 per il<br />
secondo campione (me<strong>di</strong>a complessiva: 9,61);<br />
• tali nicks presentano spesso caratteristiche alfanumeriche, ed è assai<br />
probabile che i numeri, come detto sopra, corrispondano all’età o all’anno<br />
<strong>di</strong> nascita, ma molte volte non è così: talvolta somigliano a un co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />
avviamento postale (dada20091, fede86307), a un numero telefonico senza<br />
prefisso (elena220173); sono posti in genere a destra rispetto al testo<br />
alfabetico, ma non mancano casi <strong>di</strong> collocazione in testa (79marlene,<br />
89matilde, 10.enzo, 1977giorgio, ecc.) o al centro (agnese89ct, iris78balla,<br />
tata81as) o in più posizioni (19m80); capita che le cifre siano più numerose<br />
delle lettere (ale021270);<br />
• la fantasia viene espressa attraverso nomignoli d’ogni genere ma<br />
spesso consiste piuttosto nel richiamo a un personaggio per esempio dei<br />
cartoni animati o dei fumetti o delle fiabe – apemaya3, bamby2512,<br />
fatinatrilly, kandykandy, wileecoyote, ecc. – o <strong>di</strong> altre opere letterarie e<br />
cinematografiche, reali o fittizi (scarlettoharakf, jamesdean88, ecc.);<br />
• spicca l’uso <strong>di</strong> forme anglofile o <strong>di</strong> anglicismi grafici, come il ricorso<br />
alle “y”, alle “k” e alle “x”: alessya84, carolyne70, costy77, debby545, kiara397 e<br />
kiaretta62, mikela170 e mikela1983, ecc.;<br />
• si nota una vivace tendenza al vezzeggiativo, una scelta <strong>di</strong> tenerezza e<br />
dolcezza e anche autoironia (bignettina, bollicina1976, cerbiatto29, cipollinad,<br />
coccinella, coccola77, coriandolina73, cucciola018, dolcefragola, dulcineadolce,<br />
flybutter, fogliolina9, gemellina 300, musetto, piccola2009, scorpioncina.84,<br />
spennacchiotto, tigrottina1988, ecc.), in cui oltre al suffisso (ve<strong>di</strong> emanueluccia<br />
– nessun accorciamento, anzi!) acquistano valore voci <strong>di</strong> lessico come<br />
amore, oro, aurora, stella e astri... (aleamoredoro, amore1979, animeovunque,<br />
astrablu, aurora925, auroraluna82 e aurorazzurra, dolcesogno29,<br />
fioredellasperanza, giornienuvole, honey81, ilsogn.atore, incantoarmonioso,<br />
innoallanotte, lareginadeivampiri, lucingalleria, luna<strong>di</strong>mandorle, magnoliafiorita,<br />
neraperla, ombranera 84, ortensia76, pratoazzurro, primulagialla, rimmel71,<br />
stellalpina22, stellaluce3, unicornonero, unpoco<strong>di</strong>zucchero, ecc. – alcuni riferibili<br />
forse, dato anche il contesto, al rapporto con il proprio figlio/figlia – e si<br />
nota inoltre, detto dal linguistica e non dallo psicologo, e dunque con
66<br />
Microantroponimi del XXI secolo<br />
ampio beneficio d’inventario, l’incertezza del proprio carattere e del<br />
proprio status o anche il livello <strong>di</strong> autostima: ve<strong>di</strong> badhorse e cavallopazzo,<br />
beauty83, bimbaconfusa1, <strong>di</strong>amondsforever, dolcebono90, inutilicertezze,<br />
laragazzadeisogni78, kleopatraelegance, kreativa72, merycrazy, nonmifermo,<br />
pazzascatenata64, pestiferaa, psicoparallela, psychoclau<strong>di</strong>a, redeisogni, restomuta,<br />
sadlilly, solitario0000, sparoa0, supremo.imperatore, tipoideale, xsolarissima89,<br />
1000.risorse, ecc.;<br />
• si vedano inoltre alcuni casi <strong>di</strong> duplicazione o <strong>di</strong> allitterazione: arakiki,<br />
bisibina 81, chichi985, eheheheheheh, kitukitu, la<strong>di</strong><strong>di</strong>l, luanaluna1888, martattak,<br />
pazzimpazza, tittititti78, o anche <strong>di</strong> quasi onomatopea (linguaggio infantile<br />
basato su ripetizioni consonantiche – s’intende, occlusive – e vocaliche:<br />
bubi28 e bubi86, ecc.);<br />
• in rari casi il nick prende in prestito la terminologia della rete e la<br />
deforma: blogo, ecc.<br />
Infine, il tema centrale della <strong>brevi</strong>tà: qui essa riguarda soprattutto la<br />
condensazione <strong>di</strong> più informazioni in una rapida stringa univerbata; non è<br />
tanto il nome-‐‑soprannome-‐‑pseudonimo che si accorcia (esistono come visto<br />
nickname composti piuttosto lunghi), quanto i dati multipli che vengono<br />
aggregati insieme, come l’età, il co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> avviamento postale, il numero <strong>di</strong><br />
telefono. Anzi, quelle che nei forum, nei social network ecc. sono chiamate<br />
“firme” in realtà sono scritture tutt’altro che <strong>brevi</strong> 14.<br />
Sappiamo che molti nicknames sono ideati dalle persone che un<br />
in<strong>di</strong>viduo frequenta (come del resto il soprannome nella vita reale) e che la<br />
stessa persona può usare più nicks se appartiene a più “gruppi sociali”, in<br />
genere offre in<strong>di</strong>cazioni sul sesso delle persone, sull’immagine che ha <strong>di</strong> sé,<br />
sulle aspirazioni e ambizioni, sugli interessi sociali e culturali, su simpatie e<br />
affiliazioni. Più che <strong>di</strong> nickname sarebbe il caso <strong>di</strong> usare il termine net name,<br />
14 Tanto che i webmaster spesso si lamentano, con inviti e moniti del genere che segue<br />
(): «Regola n. 10 – Non tenere firme lunghe. Le firme<br />
troppo lunghe non facilizzano per nulla la visualizzazione del foum! Meglio avere firme corte<br />
e semplici, tutto sarà più or<strong>di</strong>nato, provare per credere!». Un altro esempio in<br />
: «Solitamente accettiamo firme corte (non più <strong>di</strong> tre righe) e la cosa mi ha<br />
fatto storcere un pò il naso, questa è comunque la mia opinione e anche se non è contro il<br />
nostro regolamento».
E. Caffarelli 67<br />
il “nome nella rete”, un iperonimo che va poi declinandosi nei vari nicks e<br />
nella varie formule che ciascuna persona può utilizzare.<br />
Il campione qui raccolto può essere letto comunque in una chiave<br />
interpretativa importante, e cioè come tendenza verso un futuro nel quale<br />
potrebbe sempre più ampliarsi il <strong>di</strong>vario, nella denominazione degli<br />
in<strong>di</strong>vidui, tra il nome ufficiale da una parte, soggetto a co<strong>di</strong>ficazioni<br />
alfanumeriche e chissà a quali altri protocolli info-‐‑telematici <strong>di</strong> cui il co<strong>di</strong>ce<br />
fiscale e il co<strong>di</strong>ce IBAN sono soltanto i primi assaggi, e il nome non ufficiale<br />
dall’altra, sempre meno co<strong>di</strong>ficato e sempre più libero da vincoli e<br />
tra<strong>di</strong>zionali, rinnovabile nello spazio e nel tempo e auto-‐‑imposto. A questa<br />
interpretazione sembrerebbe però opporsi la gran mole <strong>di</strong> formule<br />
alfanumeriche e quelle prive <strong>di</strong> significato (in apparenza o con quasi<br />
certezza) che compongono il repertorio qui presentato.<br />
Bibliografia<br />
Enzo Caffarelli<br />
ecafrion@tin.it<br />
Besnard&Desplanques 2004<br />
Besnard Joséphine, Desplanques Guy, La cote des prénoms en 2005, Paris,<br />
Balland.<br />
Caffarelli 1996<br />
Caffarelli Enzo, L’onomastica personale nella città <strong>di</strong> Roma dalla fine del<br />
secolo XIX ad <strong>oggi</strong>. Per una nuova prospettivi <strong>di</strong> sociografia e cronografia<br />
antroponimica, Tübingen, Niemeyer.<br />
Caffarelli 2004a<br />
Caffarelli Enzo, “Frequenze onomastiche. I prenomi italiani nel XX<br />
secolo”, Rivista Italiana <strong>di</strong> Onomastica 7/1, 291-‐‑354.<br />
Caffarelli 2004b<br />
Caffarelli Enzo, “Frequenze onomastiche. Aspetti demografici e<br />
tipologici dei cognomi in Italia e in due regioni campione: Sardegna e<br />
Sicilia”, Rivista Italiana <strong>di</strong> Onomastica 7/2, 663-‐‑726.
68<br />
Microantroponimi del XXI secolo<br />
Caffarelli 2009<br />
Caffarelli Enzo, “Frequenze onomastiche. I prenomi in Italia nel XXI<br />
secolo. Un’analisi dei dati ISTAT (anno 2004)” (prima parte), Rivista<br />
Italiana <strong>di</strong> Onomastica 15/2, 659-‐‑759.<br />
Caffarelli 2012a<br />
Caffarelli Enzo, “A Torino vince Russo cognome del Sud”, ANCI Rivista<br />
55/1, 11-‐‑31.<br />
Caffarelli 2012b<br />
Caffarelli Enzo, “L’elemento numerale nell’onimia e nell’onomastica<br />
italiana”, in P. Poccetti (a cura <strong>di</strong>), Symmikta Arithmetika. La lingua dà i<br />
numeri, Roma, Il Calamo, 13-‐‑127.<br />
Caffarelli&Marcato 2008<br />
Caffarelli Enzo, Marcato Carla, I cognomi in Italia. Dizionario storico ed<br />
etimologico. Torino, UTET, 2 voll.<br />
Caprini 2001<br />
Caprini Rita, Nomi propri, Alessandria, E<strong>di</strong>zioni dell’Orso.<br />
Rossebastiano&Papa 2005<br />
Rossebastiano Alda, Papa Elena, I nomi <strong>di</strong> persona in Italia. Dizionario<br />
storico ed etimologico, Torino, UTET, 2 voll.<br />
Sestito 2011<br />
Sestito Francesco, “Frequenze onomastiche. Variazioni e stabilità nel<br />
repertorio cognominale italiano del 2011: un’analisi dei dati forniti<br />
dall’ANCI per 26 capoluoghi <strong>di</strong> provincia”, Rivista Italiana <strong>di</strong><br />
Onomastica 17/2, 857-‐‑891.<br />
Sestito 2012<br />
Sestito Francesco, “Frequenze onomastiche. Variazioni e stabilità nel<br />
repertorio cognominale italiano del 2011: un’analisi dei dati forniti<br />
dall’ANCI per 50 capoluoghi <strong>di</strong> provincia (continuazione e fine)”,<br />
Rivista Italiana <strong>di</strong> Onomastica 18/1, 337-‐‑370.
Abstract<br />
<strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong> e nuove tecnologie <strong>di</strong>gitali: un nuovo percorso<br />
verso l’appren<strong>di</strong>mento e la creatività<br />
Andrea Granelli<br />
Le forme <strong>brevi</strong> – per risparmiare tempo, energie cognitive, materiali pregiati o<br />
spazio <strong>di</strong> archiviazione – hanno sempre accompagnato l’uomo -‐‑ assumendo – nelle<br />
varie fasi storiche – forme e modalità <strong>di</strong>fferenti. La rivoluzione <strong>di</strong>gitale -‐‑ unità a una<br />
crescente mancanza “cronica” <strong>di</strong> tempo – ha dato però un contributo alla loro<br />
<strong>di</strong>ffusione introducendo non solo nuovi strumenti (chat, SMS, tweet, …) ma anche<br />
nuove forme linguistiche o ad<strong>di</strong>rittura schemi <strong>di</strong> relazione innovativi (ad es. con il<br />
vibracall del telefonino). Forse una delle sue novità è il “ritorno” delle immagini,<br />
spesso forme <strong>di</strong> autentica <strong>brevi</strong>tà informativa, e il loro contributo – quando<br />
integrate con il testo – può essere significativo nei processi creativi e nel supportare<br />
l’appren<strong>di</strong>mento. Ma la rivoluzione <strong>di</strong>gitale ha anche dai lati negativi – <strong>di</strong> cui tra<br />
l’altro poco si parla – che vanno però messi in luce e tenuti in grande<br />
considerazione per evitare un cattivo utilizzo e una potenziale neutralizzazione dei<br />
benefici.<br />
Parole chiave: <strong>brevi</strong>tà, appren<strong>di</strong>mento, <strong>di</strong>gitale, innovazione, cattivo utilizzo<br />
The short forms – to save time, energy, material and storage space – have always<br />
been part of men’s life, taking – from time to time – <strong>di</strong>fferent shapes. The <strong>di</strong>gital<br />
revolution – together with an increasing and chronic shortage of time – has<br />
significantly contributed to their adoption and <strong>di</strong>ssemination, by not only<br />
introducing new tools (chat, SMS, tweet, …) but also new linguistic mechanisms or<br />
even innovative ways to relate to each other (e.g. with the so called vibracoll feature<br />
of the mobile phone). Maybe one of the novelty is the recurrence of images – often<br />
representation of truly compressed information – and their contribution, when<br />
associated with the text, can be significant in creativity and in supporting the<br />
learning process. But the <strong>di</strong>gital revolution has also a dark side – not particularly<br />
analyzed and <strong>di</strong>scussed, as a rule – which should be more investigated and taken<br />
into consideration to avoid misuse.<br />
Keywords: conciseness, learning, <strong>di</strong>gital, innovation, misuse
70<br />
Un (breve) elogio della <strong>brevi</strong>tà<br />
<strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong> e nuove tecnologie <strong>di</strong>gitali<br />
Ci vuole una grande abilità a racchiudere tutto in poco spazio<br />
(Seneca, Lettere a Lucilio)<br />
Con i tempi che corrono, la <strong>brevi</strong>tà è il solo segno <strong>di</strong> rispetto apprezzato dal<br />
pubblico (Stendhal)<br />
L'ʹuomo ha sempre cercato <strong>di</strong> non sprecare le proprie energie. Appena<br />
una attività <strong>di</strong>ventava ripetitiva, nasceva automaticamente la riflessione su<br />
come farla con minor sforzo. Questa tensione umana venne<br />
concettualizzata agli inizi del ventesimo secolo dal fisico Ernst Mach come<br />
“principio <strong>di</strong> economia”: il compito primario del sapere scientifico è quello<br />
<strong>di</strong> esporre il più completamente possibile i fatti col minore impiego <strong>di</strong><br />
pensieri e quin<strong>di</strong> le connessioni più importanti sono quelle più semplici,<br />
rapide e controllabili, che richiedono dunque meno sforzo. Questo<br />
minimalismo rappresentativo non si applica solo alla scienza ma anche<br />
all’arte. In un libro recente – La visione dall'ʹinterno. Arte e cervello, Bollati<br />
Boringhier – Semir Zeki parte dall ‘ipotesi che il nostro cervello debba<br />
estrarre informazioni sugli aspetti essenziali e costanti del nostro universo<br />
visivo (gli invarianti) a partire da una grande messe <strong>di</strong> dati in continuo<br />
cambiamento. Secondo l’autore, stu<strong>di</strong>ando l’arte – soprattutto quella<br />
moderna che tende alla semplificazione – «si scopre una somiglianza tra<br />
ciò che ha prodotto, o almeno ha posto in evidenza, e le caratteristiche del<br />
campo recettivo delle singole cellule nelle <strong>di</strong>verse aree nel cervello».<br />
Questa “economicità” sottende naturalmente il concetto <strong>di</strong> <strong>brevi</strong>tà, <strong>di</strong><br />
essenzialità. Anzi, come <strong>di</strong>sse una volta Bartezzaghi, «il vero problema non<br />
sta nella <strong>di</strong>mensione ma nella tensione, non nel corto ma nel teso».<br />
Certamente la <strong>brevi</strong>tà è stata una delle risposte dell'ʹuomo ad alcuni<br />
vincoli della natura. Alcuni erano legati allo sforzo fisico. Quando si vuole<br />
scrivere sulla pietra o sul marmo, o su qualche altro materiale <strong>di</strong>fficile da<br />
incidere, la concisione s'ʹimpone. Nasce così una scrittura lapidaria (o<br />
scrittura <strong>di</strong> pietra) che spesso cela dentro <strong>di</strong> sé un carattere <strong>di</strong> sacralità<br />
oracolare. George Perros (pseudonimo del critico Georges Poulot) arriverà<br />
ad<strong>di</strong>rittura ad affermare – richiamando le origini delle forme <strong>brevi</strong> – che<br />
«l'ʹaforisma è un sasso». Ma le forme <strong>brevi</strong> più interessanti erano legate alla<br />
minimizzazione dello sforzo <strong>di</strong> ricordare. L'ʹaforisma è, storicamente, un<br />
proce<strong>di</strong>mento mnemonico utilizzato in campo scientifico e soprattutto
A. Granelli 71<br />
me<strong>di</strong>co in quanto condensa l'ʹessenziale <strong>di</strong> una materia con l'ʹestrema<br />
concisione che facilita una buona memorizzazione. Primi nel genere, gli<br />
aforismi <strong>di</strong> Ippocrate sono una raccolta <strong>di</strong> quattrocento massime <strong>di</strong><br />
me<strong>di</strong>cina generale, <strong>di</strong>visa in otto parti riguardanti le <strong>di</strong>ete. Questi aforismi<br />
hanno inaugurato la tra<strong>di</strong>zione dell'ʹaforisma me<strong>di</strong>co e scientifico,<br />
tra<strong>di</strong>zione giunta fino ai nostri giorni.<br />
Ma la <strong>brevi</strong>tà non veniva usata solo per ricordare; spesso doveva<br />
stupire. Le frasi paradossali (ad esempio «vietato vietare») e gli slogan<br />
politici sono stati usati per la loro forza persuasiva e i gran<strong>di</strong> retori hanno<br />
co<strong>di</strong>ficato in maniera sistematica questa arte.<br />
La <strong>brevi</strong>tà non si ferma alla letteratura; ad esempio anche la musica ne è<br />
stata contagiata. Tra le forme <strong>brevi</strong> musicali più note non si possono non<br />
menzionare l'ʹincipit della sinfonia n.5 <strong>di</strong> Beethoven, o il miniaturismo<br />
pianistico tipico del romanticismo. Ad esempio i prelu<strong>di</strong> n.3 in SOL<br />
maggiore e n.22 in SOL minore <strong>di</strong> Chopin hanno entrambi una durata<br />
inferiore al minuto. Per avvicinarsi al nostro tempo come non ricordare le<br />
famose “due note” <strong>di</strong> So What <strong>di</strong> Miles Davis o i “quadri musicali” <strong>di</strong><br />
Stravinskij.<br />
Nell’era moderna, la <strong>brevi</strong>tà è apparsa sotto <strong>di</strong>verse spoglie.<br />
L’architettura è stato teatro <strong>di</strong> molte riflessioni sia <strong>di</strong> tipo estetico che<br />
funzionale. Sul lato estetico la battaglia <strong>di</strong> Mies Van der Rohe («Less is<br />
more») sulle inutilità del decorativismo riassume secondo molti lo spirito<br />
più autentico della modernità. Anche dal punto <strong>di</strong> vista funzionale molti<br />
architetti si sono cimentati nella creazione <strong>di</strong> spazi essenziali per ospitare<br />
masse crescenti <strong>di</strong> abitanti senza nel contempo snaturare l’ambiente.<br />
Probabilmente l’Unitè d’abitation <strong>di</strong> Le Corbusier può essere considerata la<br />
capofila <strong>di</strong> questa riflessione architettonica sulla concisione spaziale.<br />
Anche la psicoanalisi si è confrontata con la <strong>brevi</strong>tà. Ad esempio il<br />
meccanismo della condensazione utilizzato nei sogni tende a imprimere<br />
tramite un solo elemento più elementi connessi tra loro come per esempio<br />
rappresentando due in<strong>di</strong>vidui me<strong>di</strong>ante un unico tratto o tramite<br />
un’assonanza tra i loro nomi. Il contenuto manifesto del sogno contiene<br />
infatti sempre ab<strong>brevi</strong>azioni rispetto a quello latente. La condensazione è<br />
quin<strong>di</strong> un compromesso che il sogno attua tra contenuto latente e censura<br />
per eludere ed allo stesso tempo “accontentare” la censura stessa e per
72<br />
<strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong> e nuove tecnologie <strong>di</strong>gitali<br />
risparmiare il più possibile energia psichica illustrando simultaneamente<br />
vari contenuti. Un’applicazione del principio <strong>di</strong> Mach.<br />
Un’altra realtà interessante è il mondo dei fumetti e dei cartoni animati.<br />
Opere come Sim City <strong>di</strong> Frank Miller o La Linea <strong>di</strong> Cavandoli (resa celebre<br />
quando utilizzata per pubblicizzare Lagostina) sono esempi <strong>di</strong> scrittura<br />
minimalista, capaci <strong>di</strong> restituire una straor<strong>di</strong>naria ricchezza informativa e<br />
narrativa.<br />
Perfino il teatro – tra<strong>di</strong>zionalmente non associato alla <strong>brevi</strong>tà – ne è<br />
stato contagiato. Una delle più ra<strong>di</strong>cali innovazioni futuriste nel teatro fu il<br />
cosiddetto Teatro futurista sintetico. La sua chiave era la concisione:<br />
affermava Marinetti «è stupido scrivere cento pagine dove ne basterebbe<br />
una». Su questo concetto ha giocato – portandolo all’estremo – Achille<br />
Campanile con le sue 87 trage<strong>di</strong>e in due battute, scenette teatrali<br />
effettivamente in due battute basate sul 'ʹnonsense'ʹ e sul paradosso.<br />
Ma il vero responsabile <strong>di</strong> questo autentico <strong>di</strong>lagare della <strong>brevi</strong>tà è<br />
probabilmente la rivoluzione <strong>di</strong>gitale. Innanzitutto le più recenti tecnologie<br />
informatiche e <strong>di</strong> comunicazione hanno riunificato in maniera naturale, con<br />
il loro esperanto <strong>di</strong>gitale fatto <strong>di</strong> zeri e <strong>di</strong> uni e con il concetto operativo <strong>di</strong><br />
informazione, la misura dello spazio e del tempo. Un messaggio è breve<br />
perché richiede poco tempo per essere trasmesso o ascoltato ma anche<br />
perché presuppone poco spazio per essere archiviato. Le due misure sono<br />
assolutamente correlate. Pertanto ogni riflessione sulla <strong>brevi</strong>tà <strong>di</strong>gitale<br />
unifica spazio e tempo.<br />
Dobbiamo però sempre tenere presente la preoccupazione <strong>di</strong> Tomàs<br />
Maldonado: «il riduzionismo stenografico della messaggistica elettronica<br />
non è una maggiore concisione del pensiero, neppure uno stile espositivo<br />
più limpido e sobrio, ma soltanto un depauperamento dei contenuti<br />
referenziali».<br />
La mutazione delle forme scritte nel nuovo “paesaggio <strong>di</strong>gitale”<br />
Le lettere sono simboli che trasformano la materia in spirito (Alphonse de<br />
Lamartine)<br />
Scrivere è <strong>di</strong>ventato inutile, a meno che non si scriva indecifrabilmente<br />
(Ennio Flaiano)
A. Granelli 73<br />
Oggi tutti scrivono e nessuno legge, tutti parlano e nessuno ascolta (Mario Perniola)<br />
Affrontare il tema della mutazione del linguaggio grazie alla nuove<br />
tecnologie <strong>di</strong>gitali per comprenderne cause, implicazioni e <strong>di</strong>rezioni ci<br />
porterebbe molto lontano. Il linguaggio può toccare – anzi “tocca” –<br />
moltissimi ambiti e non solo la letteratura e la comunicazione. Alcuni<br />
fugaci esempi.<br />
Per Lacan l'ʹinconscio è strutturato come un linguaggio e il motto <strong>di</strong><br />
spirito è il para<strong>di</strong>gma della formazione dell'ʹinconscio (in quanto puro<br />
fenomeno del linguaggio); inoltre i principali processi che presiedono alla<br />
formazione dell'ʹinconscio sono metafora e metonimia.<br />
Il linguaggio è anche una cura. Tra i tanti che se ne sono occupati, viene<br />
in mente Flaubert che, in una lettera, afferma che «scrivere è tessere una<br />
rete che ci tiene sospesi sull’abisso del nulla, per questo può essere<br />
un’attività salvifica».<br />
Il recente Clue Train Manifesto afferma infine che «i nuovi mercati sono<br />
innanzitutto luoghi <strong>di</strong> conversazione e il compito delle imprese che<br />
vogliono esserci e <strong>di</strong> conversare con i consumatori».<br />
Questi <strong>brevi</strong> flash (aforismi appunto …) vogliono solo suggerire la<br />
portata delle potenziali trasformazioni legate alla <strong>di</strong>ffusione delle<br />
tecnologie <strong>di</strong>gitale e alla loro applicazione meto<strong>di</strong>ca al nostro modo <strong>di</strong><br />
rappresentare e comunicare e a una crescente pulsione verso la <strong>brevi</strong>tà. La<br />
mia riflessione – che parte da questo contesto – vuole invece concentrarsi<br />
su un paio aspetti specifici che stanno emergendo nelle forme <strong>brevi</strong> <strong>di</strong>gitali:<br />
la compressione linguistica che nasce nei canali <strong>di</strong>gitali e la punteggiatura<br />
emozionale.<br />
Quando la rappresentazione <strong>di</strong> un concetto, <strong>di</strong> una espressione, <strong>di</strong> un<br />
sentimento ha un costo significativo (legato al materiale utilizzato, al tempo<br />
<strong>di</strong>sponibile, alla <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> utilizzare il materiale come me<strong>di</strong>um, alla<br />
scomo<strong>di</strong>tà del luogo in cui si “scrive”, …), si tende ad optare per una<br />
rappresentazione che sottolinei gli aspetti rilevanti. Se osserviamo i giovani<br />
che comunicano con gli SMS, abbiamo l’impressione che il loro tempo sia la<br />
risorsa scarsa; essi tendono infatti a battere velocissimamente e – oltre a<br />
impiegare frasi fatte o concetti già espressi – utilizzano espressioni<br />
concentrate, dove il superfluo scompare. Questa comportamento viene
74<br />
<strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong> e nuove tecnologie <strong>di</strong>gitali<br />
anche rafforzato dal ricevente, che – come il trasmittente – tende ad avere<br />
poco tempo e ad essere bombardato da informazioni e che quin<strong>di</strong> si<br />
spazientisce a dover leggere cose “inutili”. A ben osservare, vi è una forte<br />
similitu<strong>di</strong>ne fra i nuovi linguaggi compressi utilizzati negli SMS e nelle<br />
Chat e il linguaggio epigrafico latino. Entrambi i linguaggi sono infatti<br />
vincolati ad uno spazio limitato (la <strong>di</strong>mensione dell’epigrafe per i latini, la<br />
lunghezza del SMS) e devono far risparmiare il più possibile (il costo degli<br />
“scalpellini” epigrafisti per i latini, il tempo personale o i costi <strong>di</strong><br />
trasmissione nel caso attuale).<br />
TECNICA DI LINGUAGGIO<br />
RAPPRESENTAZOINE DELLA RETE<br />
uso delle iniziali <strong>di</strong> parole<br />
o espressioni molto usate<br />
ab<strong>brevi</strong>azioni <strong>di</strong><br />
espressioni “rituali”<br />
creazione <strong>di</strong> "ʺnuovi<br />
alfabeti"ʺ usando la<br />
<strong>di</strong>mensione fonica della<br />
lettera<br />
giochi <strong>di</strong> parole con le<br />
ab<strong>brevi</strong>azioni<br />
IMHO (In My<br />
Humble Opinion)<br />
WYSIWYG (What<br />
You See Is What You<br />
Get)<br />
4U (For You) B4<br />
U (Before<br />
You); f2f(face-‐‑to-‐‑<br />
face); CUL83 (See You<br />
Later)<br />
LINGUAGGIO EPIGRAFICO<br />
V (Vir), D.M. (Dis<br />
Manibus); DSPF (De Sua Pecunia<br />
Fecit)<br />
CEBQ (Cineres Eius Bene<br />
Quiescant);QDERFPDERIC (Quid<br />
De Ea Re Fieri Placeret, De Ea Re<br />
Ita Censuerunt)<br />
VII V (Septemvir)<br />
TOCOTOX (TOo<br />
DOM (Deo Optimo Maximo)<br />
COmplicated TO<br />
SPQR (Senatus Populusque<br />
eXplain); NIMBY (Not<br />
Romanus)<br />
in my back yard)<br />
Inoltre i latini iniziavano le loro lettere con SVBE (Si Vale Bene Est) e<br />
questa composizione è molto simile alla tipica “chiusura” delle
A. Granelli 75<br />
comunicazioni <strong>di</strong>gitali TTYL (Talk To You Later). Per tanto una forma<br />
espressiva che sembrava una cifra della modernità <strong>di</strong>gitale altro non è che<br />
l’applicazione all’ambiente <strong>di</strong>gitale <strong>di</strong> un metodo “antico”.<br />
Un’altra novità dei linguaggi <strong>di</strong>gitali è la creazione degli emoticon,<br />
marcatori emozionali che aiutano sia a definire il contesto della<br />
comunicazione (serio o ironico, ...) sia a veicolare specifiche emozioni<br />
(stupore, <strong>di</strong>sappunto, ...). Anche in questo caso, non si tratta <strong>di</strong> una<br />
assoluta novità, ma consente <strong>di</strong> mantenere anche in “assenza” quelle<br />
preziose informazioni extra-‐‑linguistiche.<br />
È curioso notare che gli emoticon – nati come esperanto universale del<br />
villaggio globale –si sono però dovuti rapidamente piegare alle regole<br />
culturali. In Giappone – per esempio – è considerata maleducazione per<br />
una donna (sor)ridere con la bocca aperta. Per tanto la Netiquette nipponica<br />
ha creato due <strong>di</strong>versi emoticon che esprimono la felicità a secondo che<br />
venga utilizzato da un maschio (^_^) o da una (^.^). Quello femminile<br />
suggerisce infatti, sostituendo il trattino con il puntino, la bocca chiusa ….<br />
Le capacità espressive degli SMS possono andare molto oltre. Ad<br />
esempio in un interessante libro scritto da due psicologi – SMS.<br />
Straor<strong>di</strong>naria fortuna <strong>di</strong> un uso improprio del telefono – vengono osservati<br />
meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> comunicazione molto creativi legati non solo alle caratteristiche<br />
del telefonino ma anche agli schemi <strong>di</strong> pricing proposti dagli operatori <strong>di</strong><br />
telefonia. Ad esempio Se il ricevente usa il vibracall, l'ʹavviso si traduce in<br />
un fremito che, se si ha il cellulare addosso, tocca qualche parte del corpo e<br />
può persino sembrare una carezza, creando una sensazione analoga al<br />
profumo aggiunto – nei secoli passati – dalle donne innamorate nelle<br />
lettere scritte per i loro amanti. Inoltre spesso i giovani si augurano la<br />
buona notte con un semplice squillo a cui non segue la chiamata. Questa<br />
comunicazione – resa possibile dall’identificativo del chiamante che appare<br />
sul <strong>di</strong>splay del telefonino anche se la telefonata non è completata – è<br />
interessante perché non costa nulla in quanto l’addebito inizia solo quando<br />
si risponde.<br />
Va anche ricordato che il linguaggio può <strong>di</strong>ventare strumento per la<br />
costruzione identitaria e per segnare l’appartenenza a una comunità, anzi a<br />
una neo-‐‑tribù come <strong>di</strong>rebbe Michel Maffesoli. Il caso più interessante è<br />
probabilmente il fenomeno francese del Verlan, una forma criptica <strong>di</strong> argot
76<br />
<strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong> e nuove tecnologie <strong>di</strong>gitali<br />
usata dai giovani dove le sillabe e certe parole (generalmente le<br />
<strong>di</strong>sillabiche) vengono invertite foneticamente. La stessa parola Verlan<br />
deriva dall’inversione della parola envers. La sua origine è attribuita a<br />
Auguste Le Breton nel 1953, ma è <strong>di</strong>ventata <strong>di</strong> uso generale attorno al 1970.<br />
È molto utilizzato nei sobborghi dagli arabi e dai “black” (in Verlan “beurs”<br />
e “keblas”) come co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> riconoscimento. Alcuni esempi entrati nel<br />
linguaggio comune sono meuf (femme), téci (cité), géman (manger), vétrou<br />
(trouvé).<br />
La paura della tecnica<br />
Usa le tecnologie prima che loro usino te (detto cyberpunk)<br />
La tecnologia crea innovazione ma -‐‑ contemporaneamente -‐‑ anche rischi e<br />
catastrofi: inventando la barca, l’uomo ha inventato il naufragio, e scoprendo<br />
il fuoco ha assunto il rischio <strong>di</strong> provocare incen<strong>di</strong> mortali (Paul Virilio)<br />
L’oblio non è meno creativo della memoria (Jorge Luis Borges)<br />
Queste trasformazioni in atto rese possibili dalle tecnologie <strong>di</strong>gitali<br />
hanno però anche un lato oscuro e per questo motivo generano paura e<br />
inquietu<strong>di</strong>ne. Questo fenomeno ha sempre accompagnato l’innovazione<br />
tecnologica; ogni grande mutazione guidata dalla tecnica ha infatti sempre<br />
suscitato paure nell’uomo per il cambiamento dello status quo. Alle volte<br />
se ne suggeriscono gli aspetti problematici come nelle riflessioni del Fedro<br />
<strong>di</strong> Platone: «[…] fidandosi dello scritto richiameranno le cose alla mente<br />
non più dall’interno <strong>di</strong> se stessi, ma dal <strong>di</strong> fuori, attraverso segni estranei ..<br />
la cosa strana delle cose scritte ... sembra che ti parlino come se fossero<br />
intelligenti, eppure se chie<strong>di</strong> loro qualcosa su ciò che ti <strong>di</strong>cono, per<br />
desiderio che ti istruiscano <strong>di</strong> più, continuano a ripetere sempre la stessa<br />
cosa» (Platone). Altre volte una vera e propria paura che genera riflessioni<br />
strumentali che talvolta <strong>di</strong>ventano stereotipi.<br />
Ad esempio durante la rivoluzione della lettura avviata nel Settecento<br />
con la <strong>di</strong>ffusione dei romanzi, si <strong>di</strong>batteva sugli effetti moralmente benefici<br />
o psichicamente <strong>di</strong>sastrosi della cattura del lettore da parte della finzione.<br />
Lo storico della cultura Roger Chartier, riporta nel suo Inscrivere e cancellare.<br />
Cultura scritta e letteratura tracce <strong>di</strong> questo <strong>di</strong>battito: «Nel XVIII secolo il<br />
<strong>di</strong>scorso si trasferisce all’ambito me<strong>di</strong>co e costruisce una patologia<br />
dell’eccesso <strong>di</strong> lettura, considerata una malattia in<strong>di</strong>viduale o un'ʹepidemia
A. Granelli 77<br />
collettiva. La lettura senza controllo è ritenuta pericolosa perché unisce<br />
l’immobilità del corpo e l’eccitazione dell’immaginazione, provocando così<br />
i mali peggiori: ostruzione dello stomaco e dell’intestino, <strong>di</strong>sturbi ai nervi,<br />
spossamento fisico ... l’esercizio solitario della lettura porta allo sviamento<br />
dell'ʹimmaginazione, al rifiuto della realtà, alla preferenza accordata alle<br />
chimere. Ne deriva una vicinanza tra eccesso della lettura e masturbazione,<br />
perché entrambe le pratiche provocano gli stessi sintomi: pallore,<br />
inquietu<strong>di</strong>ne, prostrazione».<br />
D’altra parte la letteratura è piena <strong>di</strong> passi celebri che parlano della<br />
pericolosità della lettura: ad esempio l’episo<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Paolo e Francesca nella<br />
Divina Comme<strong>di</strong>a («galeotto fu ‘l libro e chi lo scrisse»), le fasi finali del<br />
Don Chisciotte («per il molto leggere gli si prosciugò il cervello in modo<br />
che venne a perdere il giu<strong>di</strong>zio», che svolge la consonanza verbale <strong>di</strong><br />
lectura y locura), la vita <strong>di</strong> Madame Bovary, …<br />
Non si tratta naturalmente <strong>di</strong> criminalizzare le tecnologie, ma solo <strong>di</strong><br />
ricordarsi della presenza “naturale” <strong>di</strong> questi timori ancestrali, <strong>di</strong> questi<br />
anticorpi dell’innovazione, quando si analizzano le mo<strong>di</strong>fiche indotte –<br />
soprattutto sugli adolescenti – dalle nuove tecnologie <strong>di</strong>gitali sui processi<br />
<strong>di</strong> ricordo, appren<strong>di</strong>mento, con<strong>di</strong>visione, ….<br />
È d’altra parte noto che ogni eccesso crea sempre squilibri, e che la<br />
mutazione in sé indotta dalle tecnologie – che comporta sempre sia il<br />
potenziamento <strong>di</strong> alcune facoltà (ad es. il multitasking o la velocità delle<br />
<strong>di</strong>ta) sia il (complementare) depotenziamento <strong>di</strong> altre (ad es. la memoria) –<br />
non deve essere vista per definizione come negativa (ma neanche positiva).<br />
Il tema non è quin<strong>di</strong> se è giusto (o pericoloso) che la tecnica mo<strong>di</strong>fichi<br />
l’uomo quanto piuttosto separare le buone dalle cattive pratiche e orientare<br />
il percorso delle nuove tecnologie verso processi <strong>di</strong> rafforzamento della<br />
<strong>di</strong>mensione integrale della persona, e non solo <strong>di</strong> alcune sue funzionalità:<br />
la questione tende dunque ad essere <strong>di</strong> natura squisitamente antropologica.<br />
Scrive infatti Benedetto XVI nell’enciclica Caritas in veritate:<br />
«Dall’ideologia tecnocratica, particolarmente ra<strong>di</strong>cata <strong>oggi</strong>, Paolo VI aveva<br />
già messo in guar<strong>di</strong>a, consapevole del grande pericolo <strong>di</strong> affidare l’intero<br />
processo dello sviluppo alla sola tecnica, perchè in tal modo rimarrebbe<br />
senza orientamento. La tecnica, presa in se stessa, è ambivalente. Se da un<br />
lato, <strong>oggi</strong>, vi è chi propende ad affidarle interamente detto processo <strong>di</strong>
78<br />
<strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong> e nuove tecnologie <strong>di</strong>gitali<br />
sviluppo, dall’altro si assiste all’insorgenza <strong>di</strong> ideologie che negano in toto<br />
l’utilità stessa dello sviluppo, ritenuto ra<strong>di</strong>calmente antiumano e portatore<br />
solo <strong>di</strong> degradazione». Ma questa attenzione antropologia sui rischi della<br />
tecnica che pone la Chiesa non è anti-‐‑moderna. Sempre nella stessa<br />
enciclica il papa afferma infatti che «L’idea <strong>di</strong> un mondo senza sviluppo<br />
esprime sfiducia nell’uomo e in Dio».<br />
Per cogliere il meglio delle tecnologie (<strong>di</strong>gitali) e la loro straor<strong>di</strong>naria<br />
potenzialità trasformativa, bisogna dunque aprire gli occhi anche sui lati<br />
oscuri <strong>di</strong> tali tecnologie e incominciare a contrastare fattivamente gli aspetti<br />
negativi legati all’informazione <strong>di</strong>gitale, e in particolare l’informazione<br />
eccessiva, l’”inquinamento <strong>di</strong>gitale” e la frammentazione della conoscenza.<br />
La Biblioteca <strong>di</strong> Alessandria conservava probabilmente 700.000 rotoli <strong>di</strong><br />
papiro e pergamena – tutto il sapere del mondo occidentale antico. La<br />
Biblioteca nazionale francese ha invece oltre 400 chilometri <strong>di</strong> scaffali. Alla<br />
sua inaugurazione – nel 1997 – erano già presenti 10 milioni <strong>di</strong> volumi,<br />
350.000 perio<strong>di</strong>ci, 76.000 microfilm, … Questa moltiplicazione delle<br />
informazioni sta <strong>di</strong>ffondendo sia l’anoressia informativa sia il suo<br />
speculare – l’obesità. In entrambi i casi il crescente proliferare<br />
dell’informazione riduce la capacità dell’uomo <strong>di</strong> assimilare in maniera<br />
sana nuova conoscenza spingendo i giovani a riempirsi in maniera<br />
ossessiva <strong>di</strong> informazioni “non nutrienti”. Come ha osservato Joshua<br />
Lederberg – riattualizzano un bellissimo verso <strong>di</strong> Coleridge («Acqua, acqua<br />
dovunque e neppure una goccia da bere») – «<strong>oggi</strong> vi è un <strong>di</strong>luvio <strong>di</strong><br />
informazioni generali e una siccità <strong>di</strong> informazioni specifiche». A ciò si<br />
aggiunge lo “sporco <strong>di</strong>gitale”: le tracce che lasciamo sulla rete tendono<br />
progressivamente a <strong>di</strong>ventare indelebili. I motori <strong>di</strong> ricerca registrano tutto,<br />
ma non esiste un processo con<strong>di</strong>viso che toglie dalle liste dei motori le<br />
informazioni non più atten<strong>di</strong>bili o invecchiate. Questo bombardamento<br />
informativo unito al progressivo inquinamento <strong>di</strong>gitale ha indebolito il<br />
sistema immunitario della società rispetto alla “cattiva” informazione.<br />
Siamo quin<strong>di</strong> vittime <strong>di</strong> una sorta <strong>di</strong> AIDS (Anti-‐‑Information Deficiency<br />
Syndrome), per usare l’espressione coniata da Giuseppe Longo. Non si<br />
trovano più orientamenti, prescrizioni e regole <strong>di</strong> selezione nella tra<strong>di</strong>zione<br />
o nella vita istituzionale e si innesca un circolo vizioso squisitamente<br />
tecnico che ci trasforma in massa facilmente suggestionabile e in<strong>di</strong>rizzabile.
A. Granelli 79<br />
Anche la frammentazione dei saperi – in essere da molto tempo ma<br />
rafforzata dalle tecnologie <strong>di</strong>gitali – può <strong>di</strong>ventare preoccupante. Il <strong>di</strong>gitale,<br />
infatti, aumenta questa <strong>di</strong>mensione problematica in quanto il processo<br />
stesso <strong>di</strong> <strong>di</strong>gitalizzazione genera frammenti isolati (le singole foto, le<br />
singole pagine <strong>di</strong> un documento, i record dei database, …). Andranno<br />
quin<strong>di</strong> stu<strong>di</strong>ate specifiche modalità per riconsolidare la progressiva<br />
frammentazione dei nostri saperi in unità dotate <strong>di</strong> senso, ricostruendo le<br />
nuove narrazioni <strong>di</strong>gitali. Sarà infatti sempre più importante la<br />
(ri)composizione dei frammenti <strong>di</strong>gitali – soprattutto quelli che<br />
provengono dagli archivi (storici, politici, culturali, televisivi, …) in unità<br />
<strong>di</strong> senso narrabili, comprensibili e “intriganti” per le future generazioni. Il<br />
cinema ha <strong>di</strong>mostrato una capacità strutturale <strong>di</strong> dare senso/continuità<br />
(grazie al montaggio) ai frammenti/fotogrammi. Non è la semplice<br />
<strong>di</strong>gitalizzazione degli archivi che li salverà dall’oblio. È la narrazione che<br />
seleziona i fatti (e quin<strong>di</strong> contrasta quell’approccio alla storia che richiede<br />
<strong>di</strong> conservare tutto, <strong>oggi</strong> realisticamente non più applicabile) e li “salva” in<br />
flussi narrativi. Come ha osservato Gaston Bachelard, «si conserva solo ciò<br />
che é stato drammatizzato dal linguaggio». Solo così si assicurerà un futuro<br />
alle nostre memorie (<strong>di</strong>gitali e non), proteggendo – tra l’altro – la nostra<br />
identità.<br />
Si devono inoltre utilizzare con molta attenzione e maturità le<br />
cosiddette “sirene” <strong>di</strong> Internet (Wikipe<strong>di</strong>a, i motori <strong>di</strong> ricerca e i social<br />
networking) che da sole non risolvono le carenze in<strong>di</strong>viduali e non si<br />
possono sostituire al processo <strong>di</strong> assorbimento personale della conoscenza,<br />
unica garanzia per un reale arricchimento culturale ed emotivo<br />
dell’in<strong>di</strong>viduo. Inoltre con la loro “pretesa autoriale” possono innescare<br />
meccanismi pericolosi. Ad esempio anche strumenti apparentemente<br />
democratici come l’enciclope<strong>di</strong>a online Wikipe<strong>di</strong>a vanno usati con grande<br />
cautela. Il fatto che persone autorevoli come Eco suggeriscano <strong>di</strong> usarla<br />
come fonte “naturale” per vedere ad esempio la definizione <strong>di</strong> un termine<br />
controverso, in quanto la considerano «ottima e documentatissima<br />
enciclope<strong>di</strong>a on line» può <strong>di</strong>ventare problematico. Le criticità sono oramai<br />
note: dati sbagliati, azioni manipolative o <strong>di</strong> controinformazione e<br />
soprattutto il fatto che con Wikipe<strong>di</strong>a prevale la “verificabilità” sulla verità,<br />
lo strumento sul fine.<br />
I motori <strong>di</strong> ricerca, invece, alimentano un altro falso mito: grazie a loro<br />
tutto ciò che è presente su Internet si trova; ma ciò non è vero. Basta fare
80<br />
<strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong> e nuove tecnologie <strong>di</strong>gitali<br />
una ricerca inserendo una parola me<strong>di</strong>amente frequente e il motore <strong>di</strong><br />
ricerca in<strong>di</strong>viduerà con tutta probabilità <strong>di</strong>verse centinaia <strong>di</strong> migliaia <strong>di</strong><br />
files che “trattano” dell’argomento (per la verità che contengono la parola).<br />
Ora gli utenti tendono a consultare al massimo la prima ventina <strong>di</strong><br />
documenti in<strong>di</strong>cati dalla lista. Esiste quin<strong>di</strong> una deperibilità intrinseca del<br />
dato su Internet (se recuperabile solo con i motori <strong>di</strong> ricerca):<br />
l’informazione, man mano che invecchia, perde priorità ed è sempre più<br />
<strong>di</strong>fficilmente recuperabile.<br />
Infine il social networking è certamente un’area molto promettente che<br />
può dare corpo al “potere della rete”. Da sola però non basta: se i singoli<br />
contributi sono modesti, anche il contributo collettivo è modesto: <strong>di</strong>cono<br />
infatti gli informatici «garbage in, garbage out». Questi ambienti possono<br />
essere straor<strong>di</strong>nari moltiplicatori <strong>di</strong> valore, enzimi capaci <strong>di</strong> accelerare le<br />
buone “reazioni creative”, ma pericolosi se la materia prima non è <strong>di</strong><br />
qualità.<br />
Il ritorno delle immagini<br />
Non vi possono essere parole senza immagini (Aristotele)<br />
Quando mi prende la paura, invento un'ʹimmagine (Goethe)<br />
L’immagine può essere vista come una forma <strong>di</strong> <strong>brevi</strong>tà e sicuramente la<br />
<strong>di</strong>ffusione della larga banda e dei terminali (e software collegati) per<br />
vedere e manipolare immagini a filmati in alta definizione ha riportato al<br />
centro l’importanza delle immagini creando consuetu<strong>di</strong>ni che – in qualche<br />
modo – evocano ad<strong>di</strong>rittura l’era pre-‐‑alfabetica, dove le immagini erano<br />
l’unica forma non orale per co<strong>di</strong>ficare e con<strong>di</strong>videre i saperi collettivi.<br />
Oggi la sfida è dunque stu<strong>di</strong>are modalità efficaci per utilizzare il potere<br />
evocativo, narrativo e creativo delle immagini.<br />
È utile ricordare che l’immagine – rispetto al testo – aumenta il<br />
potenziale espressivo e <strong>di</strong>ventano possibili letture “multiple”. Infatti:<br />
un testo ha un inizio, una fine e un percorso obbligato <strong>di</strong> lettura;<br />
un’immagine no. Inoltre l’immagine può essere ingannevole;
A. Granelli 81<br />
al contrario delle parole, le immagini visive posseggono una capacità <strong>di</strong><br />
estensione verbale quasi infinita, in quanto l'ʹosservatore deve<br />
trasformarsi a sua volta in narratore;<br />
l’alfabeto visivo possiede anche un valore emozionale; ad esempio<br />
Kan<strong>di</strong>nsky era solito <strong>di</strong>re: «la linea orizzontale è fredda e quella<br />
verticale è calda»;<br />
l’analisi delle immagini può consentire una comprensione del<br />
profondo <strong>di</strong> chi le ha create;<br />
i colori veicolano anche un messaggio subliminare, come intuito per<br />
esempio da Goethe nella sua Teoria dei colori o applicato dalla Disney<br />
nel film Dick Tracy, dove per esempio il giallo rappresentava il colore<br />
dei buoni.<br />
Molti spunti su come utilizzare le immagini per potenziare i processi <strong>di</strong><br />
comprensione, ricordo, creatività vengono dal passato. Non solo quando la<br />
cultura era pre-‐‑alfabetica – e l’immagine era lo strumento principe per la<br />
co<strong>di</strong>fica e trasmissione <strong>di</strong> messaggi e saperi – ma anche quando<br />
l’analfabetismo era ancora molto <strong>di</strong>ffuso (si pensi ad esempio<br />
all’importanza della Biblia Pauperum) per trasferire al volgo i dettami della<br />
Chiesa cattolica.<br />
Oggi purtroppo l’anoressia culturale (che alcuni chiamano<br />
l’analfabetismo <strong>di</strong> ritorno) non è stata debellata, anzi; ed è purtroppo<br />
ancora in agguato una vera e propria carestia culturale. Per questo alcuni<br />
approcci “per analfabeti” non hanno perso la loro rilevanza ed efficacia. Il<br />
linguista Tullio De Mauro ha infatti osservato: «se pren<strong>di</strong>amo come buono<br />
quel 40% circa <strong>di</strong> italiani che <strong>di</strong>ce <strong>di</strong> navigare su internet, la percentuale <strong>di</strong><br />
chi usa il web si <strong>di</strong>mostra paradossalmente <strong>di</strong> gran lunga superiore a chi<br />
legge libri e comunque a chi più in generale sa orientarsi in una società<br />
contemporanea. Uno stu<strong>di</strong>o severo ma proprio per questo interessante <strong>di</strong><br />
alcuni anni … ha messo in luce che solo un italiano su cinque –<br />
praticamente il 20% della popolazione – possieda gli strumenti minimi<br />
in<strong>di</strong>spensabili <strong>di</strong> lettura, scrittura e calcolo …7 italiani su 10 con età<br />
compresa tra i 15 e i 65 anni sono tagliati fuori dai benefici dell'ʹeconomia<br />
della conoscenza».
82<br />
<strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong> e nuove tecnologie <strong>di</strong>gitali<br />
Tornando alle fonti da utilizzare per provare a immaginare l’utilizzo<br />
delle immagini nell’era <strong>di</strong>gitale, anche le sperimentazioni delle<br />
avanguar<strong>di</strong>e ci possono dare in<strong>di</strong>cazioni sull’uso che ne verrà fatto poi dal<br />
grande pubblico.<br />
Pensiamo ad esempio agli alfabeti visivi inventati da gran<strong>di</strong> artisti<br />
(Serafini, Daumier, …) che hanno anticipato l’uso dei caratteri grafici degli<br />
adolescenti nelle chat o le infinite variazioni con cui la parola Google viene<br />
rappresentata quando si chiama il famoso motore <strong>di</strong> ricerca.<br />
Oppure come l’uso visivo dei caratteri e del loro posizionamento<br />
“grafico” sul foglio <strong>di</strong> carta fatti sono stati autentici anticipatori della<br />
cosiddetta Ascii Art.<br />
Le cosiddette parole in libertà, dette anche parolibere, inventate dai<br />
Futuristi. Alcune delle più famose (ad esempio Serata in onore <strong>di</strong> Yvonne <strong>di</strong><br />
Cangiullo o Dune <strong>di</strong> Marinetti) vennero pubblicate sulla rivista fiorentina<br />
Lacerba. In esse il significato continua a predominare sulla lettera. Gli<br />
effetti tipografici sono in<strong>di</strong>cazioni per una gesticolazione declamatoria. Essi<br />
sottolineano ed enfatizzano una sequenza ancora tutta verbale. Un<br />
approccio più estetico a questa volontà <strong>di</strong> trasformare le frasi in pittura si<br />
trova nei, Calligrammes, prodotti da Guillaume Apollinaire nel 1918. Anche<br />
in questo caso le poesie si <strong>di</strong>namizzano e il valore dei versi non sta solo in<br />
ciò che illustrano ma anche come riempiono lo spazio della pagina.<br />
Apollinaire <strong>di</strong>ceva a proposito dei suoi calligrammi: «bisogna che la nostra<br />
intelligenza si abitui a comprendere in modo sintetico-‐‑ideogrammatico<br />
piuttosto che in modo analitico-‐‑<strong>di</strong>scorsivo».<br />
La domanda che si pone è allora: come le immagini intese come forme<br />
compresse <strong>di</strong> conoscenza possano – nella “<strong>di</strong>gisfera” – contribuire<br />
fattivamente al processo <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento ei meccanismi <strong>di</strong> ricordo e <strong>di</strong><br />
stimolo necessari per avviare i meccanismi della creatività.<br />
Apprendere e creare nell’era della Rete<br />
I confini del mio linguaggio sono i confini del mio mondo (Ludwig<br />
Wittgenstein)<br />
L'ʹimmagine ha bisogno della nostra esperienza per destarsi (Elias Canetti)
A. Granelli 83<br />
La crescita in varietà e complessità <strong>di</strong> tecnologie e sistemi, la maggiore<br />
profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> conoscenza del consumatore richiesta per progettare prodotti<br />
e servizi <strong>di</strong> successo, la <strong>di</strong>ffusa instabilità dei modelli organizzativi<br />
prevalenti e delle regole per avere successo e soprattutto la crescente<br />
impreve<strong>di</strong>bilità dei fenomeni e dei comportamenti collettivi fa si che il<br />
sapere apprendere e tenersi al passo con i tempi è <strong>di</strong>ventato <strong>oggi</strong> un<br />
imperativo categorico. Il successo <strong>di</strong> un manager <strong>di</strong>pende sempre <strong>di</strong> più<br />
non tanto da quello che sa già, quanto dall’intensità, dalla rapi<strong>di</strong>tà e<br />
dall’efficacia con cui riesce ad imparare: deve essere quin<strong>di</strong> in grado <strong>di</strong><br />
giocare un ruolo attivo nel costruire e gestire lo sviluppo dei propri saperi.<br />
Nonostante ciò la stragrande maggioranza delle persone non sa più<br />
imparare. Per questo motivo la Declaration on learning promulgata nel 1988<br />
dal Learning Declaration Group ha sancito a chiare lettere che la capacità <strong>di</strong><br />
“imparare a imparare” e <strong>di</strong> padroneggiare il processo <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento è<br />
la conoscenza critica del prossimo secolo.<br />
Dobbiamo trasformarci da immagazzinatori <strong>di</strong> fatti in protagonisti <strong>di</strong><br />
indagini e <strong>di</strong> <strong>di</strong>scussioni e cioè passare dalla conoscenza-‐‑racconto alla<br />
conoscenza-‐‑problema. Per questi motivi il metodo (e il “contenitore” dove<br />
si deposita e si organizza la conoscenza appresa) è quasi più importante del<br />
contenuto. Il processo <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento (e il relativo processo <strong>di</strong> raccolta<br />
della conoscenza) deve essere pertanto costruito in funzione <strong>di</strong> come noi<br />
assorbiamo e riutilizziamo la conoscenza e non solo puntando ad una<br />
facilitazione della produzione dei contenuti. Dobbiamo ridurre l’attenzione<br />
quasi esclusiva verso la tecnologia e il suo (spesso solo apparente) potere<br />
taumaturgico e lavorare maggiormente sulle metodologie <strong>di</strong><br />
appren<strong>di</strong>mento e sui processi reali <strong>di</strong> assorbimento e riutilizzo del sapere<br />
che ci viene proposto. La vera missione <strong>di</strong> chi vuole facilitare<br />
l’appren<strong>di</strong>mento è quin<strong>di</strong> «invitare al significato», per usare una felice<br />
espressione <strong>di</strong> George Steiner.<br />
In un era caratterizzata dalle immagini, va però recuperato il rapporto<br />
con la parola scritta, unendo la forma alfabetica al potere delle immagini<br />
con l’obiettivo <strong>di</strong> creare una nuova sintesi compositiva che unisca –<br />
oltretutto – intelletto ed emozioni.<br />
La potenza del linguaggio è spesso <strong>di</strong>menticata. Come affermava<br />
Gorgia il sofista, «la parola è un gran dominatore, che con piccolissimo<br />
corpo e invisibilissimo, <strong>di</strong>vinissime cose sa compiere; riesce infatti e a
84<br />
<strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong> e nuove tecnologie <strong>di</strong>gitali<br />
calmare la paura, e a eliminare il dolore, e a suscitare la gioia, e ad<br />
aumentare la pietà». Inoltre lo scrivere ha un ruolo fondamentale<br />
nell’apprendere. Osserva infatti Lothar Baier, autorevole scrittore e critico<br />
letterario tedesco, che «la scrittura non può procedere al ritmo del pensiero<br />
e quin<strong>di</strong> non può rifletterne il corso, ha una velocità sua propria. Il<br />
rallentamento che ne deriva non si limita a frenare il pensiero, ma anzi lo<br />
mo<strong>di</strong>fica e lo arricchisce, concedendogli il tempo <strong>di</strong> assorbire, durante il<br />
percorso, obiezioni e argomentazioni contrarie».<br />
Servono nuovi schemi e nuovi format per supportare l’autentico<br />
appren<strong>di</strong>mento, il cui scopo non è tanto archiviare ma consentire <strong>di</strong><br />
recuperare in maniera creativa quanto immagazzinato. Recuperare con<br />
accostamenti coraggiosi suggerimenti inaspettati, creare dei varchi nella<br />
nostra memoria poiché – come notava Ungaretti – l’idea creativa (come la<br />
parola poetica) «scaturisce dall'ʹabisso».<br />
Per questo va utilizzato anche il potere delle emozioni, che richiede<br />
strumenti narrativi <strong>di</strong>versi e spesso vede l’immagine come forma <strong>di</strong><br />
rappresentazione naturale. Come ha osservato Salvatore Natoli in E<strong>di</strong>po e<br />
Giobbe, «il dolore – al pari <strong>di</strong> tutte le esperienze estreme (come anche la<br />
felicità) – lacera il linguaggio, si colloca sempre al <strong>di</strong> sotto o al <strong>di</strong> sopra <strong>di</strong><br />
esso» e il processo creativo – quando è ra<strong>di</strong>cale – è una esperienza estrema.<br />
La sfida è organizzare il non conosciuto e suggerire nuove correlazioni:<br />
«Dimmi come cerchi e ti <strong>di</strong>rò cosa cerchi» scrisse Wittgenstein nelle sue<br />
Osservazioni filosofiche, ribadendo l’importanza degli strumenti <strong>di</strong> ricerca (e<br />
mettendoci implicitamente in guar<strong>di</strong>a anche sul loro potere con<strong>di</strong>zionante<br />
…).<br />
Le immagini spesso innescano il processo creativo. Einstein affermava<br />
che la maggior parte delle sue idee nascevano con l'ʹaiuto <strong>di</strong> immagini<br />
mentali, ancora prima che attraverso un qualche tipo <strong>di</strong> teorizzazione<br />
verbale o matematica. Anche Italo Calvino ne era convinto: «Quando ho<br />
cominciato a scrivere storie fantastiche non mi ponevo ancora problemi<br />
teorici; l’unica cosa <strong>di</strong> cui ero sicuro era che all’origine d’ogni mio racconto<br />
c’era un’immagine visuale […] Appena l’immagine è <strong>di</strong>ventata abbastanza<br />
netta nella mia mente, mi metto a svilupparla in una storia, o meglio, sono<br />
le immagini stesse che sviluppano le loro potenzialità implicite, il racconto<br />
che esse portano dentro <strong>di</strong> sé».
A. Granelli 85<br />
Si possono a questo punto ipotizzare tre possibili <strong>di</strong>rezioni verso cui<br />
dovrebbe orientarsi l’appren<strong>di</strong>mento me<strong>di</strong>ato (e facilitato) dagli strumenti<br />
<strong>di</strong>gitali.<br />
Archiviare (classificando) le informazioni in maniera efficiente e<br />
facilmente ritrovabile/riutilizzabile<br />
Per il grande regista Konstantin Stanislavskij, nel teatro, le parole del<br />
testo si traducono creativamente in immagini interiori che hanno la doppia<br />
funzione <strong>di</strong> far ricordare il testo e <strong>di</strong> tradurlo in immagini corporee vive ed<br />
efficaci; una vera e propria fisiognomica teatrale, dove le caratteristiche<br />
fisiche e le qualità morali e psicologiche si traducono imme<strong>di</strong>atamente le<br />
une nelle altre. Il poter – grazie alle tecnologie <strong>di</strong>gitali <strong>di</strong> nuova<br />
generazione – archiviare immagini, ricercarle in funzione <strong>di</strong> particolari o<br />
colori oppure usare schemi <strong>di</strong> archiviazione che si basano sul potere delle<br />
immagini (si pensi ai cosiddetti “luoghi della memoria”) è <strong>oggi</strong> non solo<br />
possibile ma è una grande occasione.<br />
Un caso molto interessante <strong>di</strong> classificazione della conoscenza è quella<br />
concepita da Aby Warburg, il grande mecenate fondatore della omonima<br />
scuola, per aiutare nella creazione <strong>di</strong> intuizioni e <strong>di</strong> «comprensioni<br />
inter<strong>di</strong>sciplinari»: la cosiddetta Biblioteca per le scienze della cultura. Tale<br />
biblioteca era organizzata secondo il criterio personale della «legge del<br />
buon vicinato», che non <strong>di</strong>sponeva i libri in sequenze alfabetiche o<br />
cronologiche, ma li accostava – «come tessere <strong>di</strong> un mosaico <strong>di</strong> cui aveva<br />
ben chiaro in mente il <strong>di</strong>segno» in base agli ambiti culturali, tematici, ai<br />
significati intrinseci, e ne mo<strong>di</strong>ficava continuamente l’or<strong>di</strong>ne con la crescita<br />
della collezione e lo sviluppo delle ricerche. L’obiettivo <strong>di</strong> questa biblioteca<br />
era strumentale a una specifica convinzione che Warburg nutriva<br />
relativamente al ruolo della memoria. Straor<strong>di</strong>nario – anticipatore dei temi<br />
<strong>di</strong> cui stiamo <strong>di</strong>scutendo e naturalmente collegato alla sua idea <strong>di</strong><br />
Biblioteca – fu anche il suo «atlante della memoria» (Mnemosyne: serie <strong>di</strong><br />
immagini per l’analisi della funzione svolta dai valori espressivi stabiliti<br />
dall’antichità nella rappresentazione della vita in movimento nell’arte europea del<br />
Rinascimento), un’opera «aperta», composta da circa sessanta tavole a loro<br />
volta composte da collage <strong>di</strong> circa millecinquecento tra foto e immagini.<br />
Warburg usava queste tavole per illustrare le proprie conferenze.<br />
Osservano Kurt W. Forster e Katia Mazzucco in Introduzione ad Aby<br />
Warburg e all’atlante della memoria, che «il meccanismo <strong>di</strong> smontaggio e <strong>di</strong> ri-‐‑
86<br />
<strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong> e nuove tecnologie <strong>di</strong>gitali<br />
assemblaggio dei materiali presenti nelle tavole <strong>di</strong> Mnemosyne, consente <strong>di</strong><br />
staccare e ritagliare, letteralmente, i soggetti della ricerca dal contesto<br />
originale non per snaturarli o, peggio, banalizzarli e fraintendere la loro<br />
qualità ed essenza ma per valorizzarli in termini nuovi».<br />
Facilitare la con<strong>di</strong>visione del non co<strong>di</strong>ficato e del non strutturato per<br />
potenziare il processo creativo.<br />
Il processo creativo ha bisogno <strong>di</strong> instabilità, <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenze <strong>di</strong> potenziale,<br />
si nutre <strong>di</strong> (bio)<strong>di</strong>versità, <strong>di</strong> suggestioni, <strong>di</strong> tracce; per questo motivo le<br />
immagini, i frammenti <strong>di</strong> conoscenza il “non ancora co<strong>di</strong>ficato” sono<br />
essenziali nell’innescare i processi <strong>di</strong> ricordo e <strong>di</strong> creatività. La possibilità –<br />
grazie alle nuove tecnologie <strong>di</strong>gitali – <strong>di</strong> co<strong>di</strong>ficare non solo numeri, testi<br />
strutture definite, ma anche immagini, ambienti immersivi, frammenti<br />
vocali, e schemi, connessioni, ipertesti, … apre spazi straor<strong>di</strong>nari al<br />
processo <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento. La sfida è <strong>di</strong> far convivere i due “mon<strong>di</strong>” – la<br />
struttura e il <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ne, l’emozione e la regola – facilitando le occasioni <strong>di</strong><br />
sintesi che aprono la via all’intuizione e alla creatività e soprattutto<br />
consentendo una con<strong>di</strong>visione <strong>di</strong>ffusa con altri per allargare il processo<br />
creativo e quin<strong>di</strong> la sua creatività. La Rete è un grande strumento <strong>di</strong><br />
con<strong>di</strong>visione, ma non basta creare i social network. Bisogna creare<br />
meccanismi per la con<strong>di</strong>visione non solo dei saperi ma anche delle<br />
emozioni per facilitare la generazione <strong>di</strong> stimoli creativi. Le emozioni<br />
portano all’azione, mentre la ragione porta solo a trarre delle conclusioni.<br />
Come <strong>di</strong>ce Manfred Kets de Vries dell’Insead: «un grammo <strong>di</strong> emozione<br />
può essere più efficace che una tonnellata <strong>di</strong> fatti».<br />
Costruire ambienti effettivamente centrati sull’appren<strong>di</strong>mento e non sul<br />
semplice scambio <strong>di</strong> contenuti culturali o se<strong>di</strong>centi educativi. In questo<br />
contesto i “siti personali” – spazi web associati a singoli in<strong>di</strong>vidui e pensati<br />
per essere contenitori <strong>di</strong> conoscenza ed elementi <strong>di</strong> racconto della propria<br />
identità – saranno un elemento chiave. Essi sono un pezzo <strong>di</strong> noi stessi<br />
sulla rete; sono un vero e proprio “sé <strong>di</strong>gitale”, elemento centrale nella<br />
nuova topologia della mente originatasi dall’interazione dell’uomo con le<br />
tecnologie <strong>di</strong>gitali (ve<strong>di</strong> Granelli 2006).<br />
La possibilità <strong>di</strong> archiviare toglie quella <strong>di</strong>mensione transitoria tipica<br />
delle prime forme <strong>di</strong> comunicazione elettronica e consente <strong>di</strong> memorizzare,<br />
ri-‐‑utilizzare, e ri-‐‑adattare l’informazione aprendo nuovi spazi espressivi.
A. Granelli 87<br />
Ma deve esistere un luogo personale <strong>di</strong> archiviazione, strumento<br />
conoscitivo, che consente <strong>di</strong> realizzare una vera e propria memoria estesa, a<br />
complemento e integrazione della memoria fisiologica. L’esistenza <strong>di</strong><br />
questo sito personale sta progressivamente forzando nuovi comportamenti:<br />
la sostanziale <strong>di</strong>fferenza dell’avere il sito su un sito Internet e non su un<br />
personal computer è legata alla accessibilità: se il sito è su Internet si accede<br />
da ovunque; se è sul computer <strong>di</strong> casa, si accede solo da casa – e quin<strong>di</strong> non<br />
è <strong>di</strong>sponibile in tutti i momenti in cui potrebbe essere utile – e inoltre<br />
nessun altro può accedervi, rimanendo una monade inaccessibile.<br />
Bibliografia<br />
Andrea Granelli<br />
andrea.granelli@kanso.it<br />
Baier 2004<br />
Baier Lothar, Non c'ʹè tempo! Diciotto tesi sull'ʹaccelerazione, trad. it. Torino,<br />
Bollati Boringhieri.<br />
Benedetto XVI, Caritas in Veritate. Enciclica sociale, 2009.<br />
Campanile 2009<br />
Campanile Achille, 87 trage<strong>di</strong>e in due battute, Milano, Rizzoli.<br />
Chartier 2006<br />
Chartier Roger, Inscrivere e cancellare. Cultura scritta e letteratura, trad. it.<br />
Roma-‐‑Bari, Laterza.<br />
Del Corno&Mansi 2002<br />
Del Corno Franco, Mansi Gianluigi, SMS. Straor<strong>di</strong>naria fortuna <strong>di</strong> un uso<br />
improprio del telefono, Milano, Cortina.<br />
Eco 2004<br />
Eco Umberto, Il politicamente corretto che <strong>di</strong>vide destra e sinistra, la<br />
Repubblica, 6 novembre 2004.
88<br />
<strong>Scritture</strong> <strong>brevi</strong> e nuove tecnologie <strong>di</strong>gitali<br />
Forster&Mazzucco 2002<br />
Forster Kurt, Mazzucco Katia, Introduzione ad Aby Warburg e all’atlante<br />
della memoria, Milano, Bruno Mondadori.<br />
Granelli 2006<br />
Granelli Andrea, Il Sé <strong>di</strong>gitale. Identità, memoria, relazioni nell'ʹera della rete,<br />
Miano, Guerini e associati.<br />
Kan<strong>di</strong>nsky 1983<br />
Kan<strong>di</strong>nsky Wassily, Punto, linea, superficie. Contributo all'ʹanalisi degli<br />
elementi pittorici, trad. it. Milano, Adelphi.<br />
Learning Declaration Group, Declaration on learning,<br />
www.mwls.co.uk/learndec.htm, 1988.<br />
Levine&Locke 1999<br />
Levine Rick, Locke Cristopher, The Cluetrain manifesto, Cambridge (Ma),<br />
Perseus Publishing.<br />
Longo 2001<br />
Longo Giuseppe O., Homo technologicus, Roma, Meltemi.<br />
Maffesoli 2004<br />
Maffesoli Michel, Il tempo delle tribù. Il declino dell’in<strong>di</strong>vidualismo nelle<br />
società postmoderne, Milano, Guerini Stu<strong>di</strong>o.<br />
Maldonado 2005<br />
Maldonado Tomás, Memoria e conoscenza. Sulle sorti del sapere nella<br />
prospettiva <strong>di</strong>gitale, Milano, Feltrinelli.<br />
Natoli 2008<br />
Natoli Salvatore, E<strong>di</strong>po e Giobbe. Contrad<strong>di</strong>zione e paradosso, Brescia,<br />
Morcelliana.<br />
Platone, Fedro, in Opere complete, a cura <strong>di</strong> G. Giannantoni, Roma-‐‑Bari,<br />
Laterza, 1971.
A. Granelli 89<br />
Troncon 2008<br />
Troncon Renato (a cura <strong>di</strong>), La teoria dei colori <strong>di</strong> Goethe, Milano, Il<br />
Saggiatore.<br />
Zeki 2003<br />
Zeki Semir, La visione dall'ʹinterno. Arte e cervello, trad. it. Torino, Bollati<br />
Boringhieri.
Abstract<br />
Le interiezioni tra scritto e parlato<br />
Francesca M. Dovetto<br />
Tra le forme <strong>di</strong> economia linguistica vanno incluse anche le interiezioni, forme<br />
lessicali <strong>brevi</strong> ma olofrastiche, molto frequenti nel parlato, anche se non rare nello<br />
scritto. Si tratta <strong>di</strong> una categoria normalmente collocata ai margini tra oralità e<br />
scrittura, particolarmente frequente nel linguaggio fumettistico.<br />
In questa sede si presentano alcuni risultati relativi all'ʹanalisi delle interiezioni<br />
tratte da un corpus costituito da fumetti Disney, e in particolare dalle storie del<br />
Topolino.<br />
Parole chiave: interiezione, onomatopea, ideofono, parlato, scritto, fumetto<br />
Among the forms of linguistic economy we also find interjections, short<br />
holophrastic phrases which are very frequent in speech, though also not rare in<br />
writing. This is a category usually located on the edge between speech and writing,<br />
particularly frequent in the language of comics.<br />
Here we present some results from the analysis of interjections drawn from a corpus<br />
consisting of Disney comics, especially those involving Mickey Mouse from the<br />
Italian publication Topolino.<br />
Keywords: interjection, onomatopoeia, ideophone, speech, writing, comics<br />
Shorter and more abrupt forms are more appropriate to certain states of<br />
mind, longer ones to others [Jespersen 1925, 403]<br />
Eh salgo un momento in camera e c ve<strong>di</strong>amo (sono pressoke'ʹ morto...)<br />
[sms 24.2.2011, c.vo mio]<br />
1. Introduzione<br />
Tra le forme <strong>di</strong> economia linguistica «o meglio, psicologica» Spitzer<br />
include anche le interiezioni (1922/2007, 236-‐‑237; cfr. anche 229), forme<br />
lessicali <strong>brevi</strong> ma olofrastiche, costituite per lo più da monosillabi o<br />
bisillabi e molto frequenti nel parlato, anche se non rare nello scritto. Si
F. M. Dovetto 91<br />
tratta <strong>di</strong> una categoria normalmente collocata ai margini tra oralità e<br />
scrittura con tendenza prevalente, anche se non esclusiva, per la funzione<br />
linguistica emotiva (P<strong>oggi</strong> 1981; 1995).<br />
Il fenomeno della 'ʹab<strong>brevi</strong>azione del linguaggio esterno'ʹ è noto in<br />
letteratura. Vygotskij (1934/1998, 365-‐‑368), ad esempio, ne traccia le<br />
caratteristiche ricorrendo ad esempi celebri, come la silenziosa<br />
<strong>di</strong>chiarazione d'ʹamore <strong>di</strong> Levin a Kitty nell'ʹAnna Karenina <strong>di</strong> Tolstoj (ivi,<br />
366-‐‑367) o l'ʹattesa alla fermata del tram (ivi, 365) che Gambarara (1999, 103)<br />
riprende con queste parole:<br />
Ad esempio, stiamo aspettando l'ʹautobus con un amico. Il primo che lo scorge<br />
arrivare <strong>di</strong>rà all'ʹaltro semplicemente "ʺEccolo"ʺ. Non occorre che <strong>di</strong>ca <strong>di</strong> più. Può<br />
anche <strong>di</strong>re "ʺAttento!"ʺ, o "ʺEhi!"ʺ o puntare l'ʹin<strong>di</strong>ce verso l'ʹautobus, o sollevare le<br />
sopracciglia <strong>di</strong> colpo, se l'ʹamico lo sta guardando in faccia. [...] Vygotskij usa il<br />
passo <strong>di</strong> Anna Karenina e l'ʹesempio dell'ʹautobus per mostrare l'ʹ"ʺab<strong>brevi</strong>azione"ʺ che<br />
il linguaggio verbale può permettersi dove si ha coincidenza nel linguaggio<br />
interiore degli interlocutori, cioè negli usi non verbali del linguaggio verbale.<br />
Nell'ʹesempio l'ʹehi! <strong>di</strong> chi attende alla fermata rappresenta un caso, tra i<br />
tanti possibili, <strong>di</strong> <strong>brevi</strong>tà; l'ʹaltro esempio <strong>di</strong> ab<strong>brevi</strong>azione linguistica<br />
attraverso l'ʹimpiego <strong>di</strong> enunciati cosiddetti «per allusione» (Vygotskij<br />
1934/1998, 367) è la <strong>di</strong>chiarazione d'ʹamore <strong>di</strong> Nikolaj Levin, composta<br />
tracciando col gesso sul tavolo da gioco le sole iniziali <strong>di</strong> parole che<br />
rappresentano intere frasi, quelle alle quali è affidata la <strong>di</strong>chiarazione<br />
stessa. Si tratta, in entrambi i casi, della tendenza al «linguaggio ab<strong>brevi</strong>ato,<br />
a mezza parola» che costituisce «più la regola che l'ʹeccezione» nello<br />
scambio verbale, laddove però quest'ʹultimo avvenga «tra persone che<br />
vivono in un contatto psicologico assai grande» (ivi).<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista formale, le interiezioni costituiscono un insieme <strong>di</strong><br />
elementi lessicali «debolmente inquadrati o non inquadrati nel sistema<br />
della lingua» (De Mauro 2008, 153); esse infatti si riconoscono non soltanto<br />
per la loro <strong>brevi</strong>tà, ma anche per una certa estraneità all'ʹapparato<br />
fonematico e morfologico-‐‑derivazionale delle lingue 1, come è facilmente<br />
evidente nella loro rappresentazione nei sistemi ortografici abituali che può<br />
1 È questo il caso delle cosiddette interiezioni vere e proprie ; restano esclusi invece, da questo<br />
insieme, tutti gli altri elementi lessicali appartenenti alla lingua, tutti comunque<br />
potenzialmente utilizzabili in modo interiettivo (cfr. De Mauro 2008, 152-‐‑155).
92<br />
Le interiezioni tra scritto e parlato<br />
<strong>di</strong>scostarsi dalle norme delle specifiche lingue utilizzando anche suoni<br />
estranei al repertorio fonologico della lingua nella quale vengono prodotte.<br />
In generale, data anche la loro collocazione marginale rispetto<br />
all'ʹapparato formale della lingua, le interiezioni non sono state stu<strong>di</strong>ate<br />
quanto le altre parti del <strong>di</strong>scorso, ma <strong>di</strong> quell'ʹapparato fanno comunque<br />
parte e, come segnala De Mauro (ivi, 158) «non tenerne conto è un errore».<br />
E infatti, benché la loro «precisazione sia del tutto implicita e si affi<strong>di</strong>, per il<br />
produttore e per i riceventi, alla evidenza del rapporto con la situazione <strong>di</strong><br />
enunciazione» (ivi), esse rientrano a pieno <strong>di</strong>ritto in quel materiale che il<br />
plurisemiotico locutore umano si trova innanzi al momento della<br />
produzione come della comprensione del percetto e contribuiscono<br />
pertanto attivamente alla costruzione del senso (ivi, 154-‐‑155).<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista dell'ʹanalisi fonetica le interiezioni 'ʹvere e proprie'ʹ<br />
(come, ad esempio, i segnali d'ʹassenso eh, ah, o <strong>di</strong> esitazione ehm, mhmh etc.)<br />
vengono attribuite alla macroclasse delle <strong>di</strong>sfluenze o esitazioni<br />
comprendente fenomeni <strong>di</strong>versi e <strong>di</strong>fferenziati, come pause piene o vuote,<br />
ripetizioni, false partenze etc. (cfr. Pettorino&Giannini 2004, 2), tutti<br />
fenomeni che occorrono più frequentemente nel parlato informale e che<br />
presentano in genere una notevole variabilità i<strong>di</strong>osincratica (tanto per<br />
frequenza, quanto per durata), anche in funzione degli stili <strong>di</strong> parlato.<br />
Benché la collocazione delle interiezioni nella struttura degli enunciati<br />
<strong>di</strong>penda anche dalla loro funzione (emotiva, fàtica o referenziale), sono<br />
presenti per lo più nelle forme <strong>di</strong> apertura (con funzione tanto emotiva<br />
quanto, soprattutto, fàtica), ma si ritrovano frequentemente anche in<br />
posizione interna agli enunciati, sia come pausa emotiva tra l'ʹespressione <strong>di</strong><br />
contenuti referenziali, sia come prelu<strong>di</strong>o a un contenuto emotivo espresso<br />
internamente all'ʹenunciato, sia con mera funzione relazionale, e quin<strong>di</strong><br />
come veri e propri marcatori <strong>di</strong>scorsivi.<br />
L'ʹistintività e imme<strong>di</strong>atezza tipica <strong>di</strong> questi <strong>brevi</strong> elementi lessicali ha<br />
portato ad attribuire loro, in mo<strong>di</strong> forse un po'ʹ riduttivi, una certa<br />
'ʹsommarietà cognitiva'ʹ (P<strong>oggi</strong> 1995, 411), anche a causa della loro frequente<br />
ambiguità. Alcuni <strong>di</strong> essi infatti possono esprimere sia sorpresa, sia dolore,<br />
sia altra, <strong>di</strong>versa emozione, <strong>di</strong>sambiguata nel parlato per mezzo<br />
dell’intonazione e nello scritto affidata invece al co-‐‑testo, ma anche al<br />
contesto, che assumono così un ruolo fondamentale per la corretta
F. M. Dovetto 93<br />
trasmissione del contenuto emotivo e, ovviamente, anche <strong>di</strong> quello<br />
referenziale. Anche la punteggiatura, nel testo scritto, <strong>di</strong>venta elemento<br />
funzionale alla risoluzione dell'ʹambiguità degli elementi interiettivi, come<br />
mostra esemplarmente il copione <strong>di</strong> Uomo e galantuomo <strong>di</strong> Eduardo de<br />
Filippo nella esilarante <strong>di</strong>stinzione tra il no esclamativo, interrogativo e<br />
conclusivo.<br />
Nello scambio <strong>di</strong> battute qui sotto riportate, tratte, con qualche libera<br />
improvvisazione, dalla comme<strong>di</strong>a edoar<strong>di</strong>ana, il protagonista, capocomico,<br />
si rivolge al suggeritore e alle due attrici della compagnia facendo<br />
riferimento alla redazione scritta del copione e tentando <strong>di</strong> spiegare loro la<br />
<strong>di</strong>fferenza tra i tre no interiettivi: il primo, che porta dopo <strong>di</strong> sé il punto<br />
esclamativo (a manic'ʹ 'ʹe martiell'ʹ), il secondo, seguito dal punto<br />
interrogativo (a manic'ʹ 'ʹe 'ʹmbrell'ʹ) e l'ʹultimo dal punto fermo ('ʹa pallina) 2.<br />
Queste le parole del capocomico:<br />
NO! NOOO...? NO. Tre no, tre intonazioni <strong>di</strong>verse.<br />
NO! ... a manic'ʹ 'ʹe martiell; NOOO...? ... a manica 'ʹe mbrell; NO.<br />
punto... pallina<br />
e, a proposito del «No.» interiettivo-‐‑conclusivo, aggiunge:<br />
Quando hai fatto la pallina non si può più andare avanti, è finita<br />
Come è evidente anche dall'ʹesempio sopra riportato, l'ʹimme<strong>di</strong>atezza<br />
espressiva delle interiezioni fa sì che siano utilizzate nello scritto per lo più<br />
in quei generi in cui quest'ʹultimo tende a imitare il parlato, e quin<strong>di</strong><br />
principalmente in testi teatrali o in <strong>di</strong>aloghi inseriti nelle narrazioni, oppure<br />
in produzioni scritte tipicamente informali come lettere etc. Le interiezioni<br />
sono molto frequenti anche nelle scritture dei nuovi me<strong>di</strong>a: chat, sms etc.<br />
Interamente affidato al contesto situazionale, invece, è quella parte <strong>di</strong><br />
contenuto proposizionale delle interiezioni che precisa «l'ʹevento del mondo<br />
implicato da quello stato mentale» (P<strong>oggi</strong> 1995, 405). Nella parafrasi<br />
articolata dell'ʹinteriezione questo viene espresso infatti da un elemento<br />
2 La citazione è tratta da una recente reinterpretazione della comme<strong>di</strong>a edoar<strong>di</strong>ana sotto la<br />
regia <strong>di</strong> Armando Pugliese; lo scambio <strong>di</strong> battute è recitato da Francesco Paolantoni<br />
(capocomico), Tonino Taiuti (suggeritore), Antonella Stefanucci (Viola) e la prima attrice<br />
Patrizia Spinosi (Florance).
94<br />
Le interiezioni tra scritto e parlato<br />
deittico, come ad esempio aha!, che potremmo parafrasare con: 'ʹquesto lo<br />
sapevo bene!'ʹ dove questo si riferisce, evidentemente, a un fatto noto, o<br />
perché menzionato in precedenza, o perché comunque recuperabile dal<br />
contesto.<br />
Il valore illocutivo dell'ʹinteriezione infine, che permette <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinguere<br />
tra un'ʹinteriezione <strong>di</strong> tipo espositivo, esercitivo o richiestivo <strong>di</strong> azione o <strong>di</strong><br />
domanda e comportativo, nello scritto è ancora una volta affidato al co-‐‑<br />
testo e, per lo più, alla punteggiatura.<br />
In questa sede si presentano alcuni risultati relativi all'ʹanalisi delle<br />
interiezioni tratte da un corpus costituito da fumetti Disney, e in particolare<br />
tratto dalle storie <strong>di</strong> Topolino, selezionate in un arco <strong>di</strong> tempo che va dal<br />
1930 (e in particolare dal n. 1 <strong>di</strong> quell'ʹanno) al n. 2811 del 2009 3.<br />
La scelta <strong>di</strong> selezionare e analizzare le interiezioni presenti in un<br />
fumetto e, in particolare, in un fumetto comico e sofisticato come il<br />
Topolino, si fonda sulla consapevolezza dell'ʹincidenza e del ruolo <strong>di</strong> questi<br />
<strong>brevi</strong> elementi lessicali nel linguaggio fumettistico, dove infatti abbondano<br />
insieme a imprecazioni, intercalari, allocutivi, vocativi e segnali <strong>di</strong>scorsivi<br />
in genere, veicolando spesso contenuti fondamentali alla narrazione e<br />
comprensione della storia, come il Topolino mostra esemplarmente.<br />
Come ha scritto Rodari, il fumetto va considerato come una sorta <strong>di</strong><br />
stenografia, a partire dalla quale il lettore è in grado poi <strong>di</strong> risalire al testo,<br />
non perdendo <strong>di</strong> vista i suoni in<strong>di</strong>cati nelle apposite nuvolette, anzi<br />
afferrandone le sfumature («uno "ʺsquash"ʺ non è uno "ʺscreek"ʺ») e<br />
in<strong>di</strong>viduandone la causa. Nei fumetti infatti l'ʹazione, descritta per salti e<br />
frammenti, è spesso rappresentata sotto forma <strong>di</strong> pura sonorità<br />
(interiettiva), spesso responsabile anche dei caratteri dei personaggi per lo<br />
più mostrati in azione. Ai 'ʹrumori'ʹ tra<strong>di</strong>zionali, inoltre, si aggiungono<br />
spesso, sia nei fumetti comici, sia in quelli più sofisticati, nuove invenzioni<br />
3 Il corpus comprende in particolare ca. 6 storie per annata (60 per decennio), selezionate tra le<br />
sole storie del personaggio <strong>di</strong> Topolino e per un arco <strong>di</strong> tempo compreso tra il 1930 e il 2009,<br />
per un totale <strong>di</strong> quasi 80 annate e quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> più <strong>di</strong> 400 storie. Il corpus è stato raccolto da Anna<br />
Mancini (tesi <strong>di</strong> laurea <strong>di</strong> vecchio or<strong>di</strong>namento in Lettere moderne, L'ʹonomatopea nel<br />
«Topolino», relatore F.M. Dovetto, Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Napoli Federico II, a.a. 2009-‐‑2010).<br />
In precedenza due altri corpora sono stati de<strong>di</strong>cati alla lingua del Topolino: l uno (Mioni 1992) è<br />
basato sullo spoglio dell intero n. 1867 (1991); l altro (Pietrini 2008) comprende 90 storie, ca. 15<br />
per decennio, selezionate in un arco <strong>di</strong> tempo tra il 1954 e il 2006.
F. M. Dovetto 95<br />
(sonore) che il lettore deve poter decifrare. L'ʹintero corso della storia va<br />
perciò ricostruito sfruttando, insieme al <strong>di</strong>segno, le <strong>di</strong>dascalie, i <strong>di</strong>aloghi, i<br />
colori e, soprattutto, anche i rumori, combinando poi il tutto assegnandogli<br />
un senso (Rodari 1997, 153-‐‑155).<br />
Le interiezioni selezionate dal corpus costituito dalle storie del Topolino<br />
riguardano essenzialmente le cosiddette 'ʹemozioni primarie'ʹ.<br />
In generale le emozioni, secondo stu<strong>di</strong> recenti <strong>di</strong> psicologia delle<br />
emozioni, psicologia cognitiva, neurofisiologia e psicofisiologia, sono<br />
considerate strutture psicologiche complesse comprendenti aspetti<br />
cognitivi, fisiologici, espressivo-‐‑motori, motivazionali e soggettivi relativi<br />
al vissuto dello stato affettivo (Anolli&Ciceri 1992, 167). Le emozioni<br />
inoltre svolgono una fondamentale e costante funzione comunicativa, in<br />
quanto costituiscono un in<strong>di</strong>catore utile alla valutazione delle risposte<br />
regolative dell'ʹorganismo all'ʹambiente.<br />
L'ʹemozione è dunque un evento che può essere definito multisistemico,<br />
relativo infatti a più piani, come quello dell'ʹelaborazione cognitiva, dei<br />
comportamenti motori e delle risposte fisiologiche, oltre al piano dei<br />
resoconti verbali dell'ʹesperienza soggettiva (cfr. Vallone 2005-‐‑2006 [2007],<br />
23-‐‑33).<br />
Benché siano sono state proposte teorie delle emozioni non <strong>di</strong>screte, ma<br />
componenziali o <strong>di</strong>mensionali, che interpretano la variabilità emozionale<br />
come la manifestazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi gra<strong>di</strong> <strong>di</strong> intensità collocabili lungo un<br />
continuum (a partire da Wundt), l'ʹapproccio darwiniano ed evoluzionista<br />
allo stu<strong>di</strong>o delle emozioni, che ritiene queste ultime innate e universali, le<br />
sud<strong>di</strong>vide in emozioni primarie (basic emotions, come la paura, la gioia o<br />
l'ʹira) e secondarie o complesse derivanti dalla <strong>di</strong>versa combinazione delle<br />
emozioni primarie (ad es. l'ʹansia sarebbe costituita dalla paura combinata<br />
con la vergogna e l'ʹangoscia). Negli anni Settanta Tomkins ha proposto una<br />
classificazione <strong>di</strong> otto emozioni fondamentali (sorpresa, interesse, gioia, ira,<br />
paura, <strong>di</strong>sgusto, vergogna, angoscia), ridotte a sei da Ekman (sorpresa, felicità,<br />
ira, paura, <strong>di</strong>sgusto, tristezza) e infine a cinque negli anni Ottanta da Johnson-‐‑<br />
Laird e Oatley che hanno elaborato una classificazione basata<br />
essenzialmente sulle parole che usiamo per parlare delle emozioni stesse<br />
(felicità, ira, paura, <strong>di</strong>sgusto, tristezza).
96<br />
Le interiezioni tra scritto e parlato<br />
Più recentemente è emersa una prospettiva ulteriore, che supera tanto il<br />
riduzionismo strutturalista quanto il relativismo culturale e il<br />
costruzionismo sociale e che concilia, allo stesso tempo, i punti <strong>di</strong> vista<br />
strutturalista e funzionalista: quest'ʹultima teoria tende a considerare i<br />
processi emotivi come universali e comunque <strong>di</strong>stinti, pur non negando<br />
l’influsso delle componenti culturali e sociali.<br />
Per necessità metodologiche nell'ʹin<strong>di</strong>viduazione e selezione delle<br />
emozioni nel fumetto si è preferito far riferimento alle teorie categoriali e<br />
non <strong>di</strong>mensionali, e in particolare alla tassonomia <strong>di</strong> Ekman che considera<br />
tra le emozioni primarie anche la sopresa, una delle emozioni<br />
maggiormente presenti nel testo fumettistico.<br />
2. L'ʹanalisi<br />
Come è noto, Topolino debutta in America dapprima nel 1928 con un<br />
cortometraggio e quin<strong>di</strong> come protagonista dei fumetti nel 1930. In Italia<br />
Topolino arriva sulle pagine dell'ʹIllustrazione del popolo (supplemento della<br />
Gazzetta del popolo) nel 1930; <strong>di</strong>viene poi pubblicazione autonoma con<br />
l'ʹe<strong>di</strong>tore Nerbini verso la fine del 1932 e, successivamente, con la casa<br />
e<strong>di</strong>trice Mondadori, a cui verrà ceduto nel 1935.<br />
La necessità <strong>di</strong> creare le storie <strong>di</strong>rettamente in Italia, avvertita già sotto il<br />
regime fascista a causa della censura a cui furono sottoposti i modelli<br />
americani 4, si fece urgente a guerra finita. A partire dagli anni Cinquanta si<br />
sviluppò così una scuola fiorente <strong>di</strong> autori italiani del Topolino, i quali non<br />
traducevano più le storie americane, ma le producevano essi stessi e<br />
<strong>di</strong>rettamente in lingua italiana, con evidenti ripercussioni sulle storie e sul<br />
linguaggio del fumetto (Barbieri 2009, 48-‐‑49).<br />
Non è un caso pertanto che la voce che designa lo sbattere della porta,<br />
tra<strong>di</strong>zionalmente rappresentata anche nel fumetto italiano con<br />
l'ʹonomatopea slam (dall'ʹinglese to slam 'ʹsbattere, chiudere violentemente'ʹ),<br />
venga sostituita dagli autori italiani con sbatt, troncamento da sbattere, o che<br />
l'ʹonomatopea relativa allo squillo del telefono resa con ring (dall'ʹingl. to<br />
4 Durante la seconda guerra mon<strong>di</strong>ale non vennero e<strong>di</strong>tati i protagonisti americani e anche<br />
Topolino venne sostituito nel 1942 da Tuffolino, un ragazzino con le sue stesse caratteristiche<br />
creato da Federico Pedrocchi e Pier Lorenzo De Vita.
F. M. Dovetto 97<br />
ring 'ʹsuonare, squillare'ʹ) venga presto sostituita dall'ʹonomatopea romanza<br />
drin, successivamente incrociata con ring in dring 5.<br />
La storia lessicale <strong>di</strong> queste forme <strong>brevi</strong> riflette inoltre la storia degli<br />
oggetti concreti, che mutano col mutare dei tempi e delle tecnologie, in una<br />
sorta <strong>di</strong> percorso sul modello Wörter und Sachen, come mostra ad esempio<br />
la variabilità della forma linguistica rappresentativa del suono del clacson<br />
che riflette la varietà anche tecnologica dell'ʹoggetto. A questo proposito le<br />
forme registrate nel corpus sono infatti <strong>di</strong> tre <strong>di</strong>versi tipi lessicali: la forma<br />
pot pot con le varianti poo pooo, poot, potti, pee pee, peet; la forma tweet<br />
(dall'ʹingl. to tweet 'ʹcinguettare'ʹ, voce <strong>di</strong> origine imitativa), con la variante<br />
twoot; infine, verso la fine degli anni Novanta, si aggiunge anche la forma<br />
beep, con la variante bee (dall'ʹingl. to beep 'ʹfare beep'ʹ).<br />
I suoni rappresentati dalle tre onomatopee nella loro varietà rendono<br />
bene le <strong>di</strong>verse tipologie <strong>di</strong> segnalatori acustici per autovetture, tutti<br />
comunemente denominati clacson, dal nome della <strong>di</strong>tta produttrice del<br />
primo segnalatore acustico elettrico (Klaxon), brevettato agli inizi del<br />
Novecento. L'ʹoggetto, messo in commercio dapprima dalla <strong>di</strong>tta Klaxon, è<br />
costituito da un <strong>di</strong>aframma metallico azionato da una camma dentata<br />
messa in moto da un motore elettrico che produce un rumore reso<br />
onomatopeicamente con la voce ca-‐‑uu-‐‑ga oppure ha-‐‑uu-‐‑ha 6.<br />
Precedentemente venivano utilizzate altre tipologie <strong>di</strong> segnalatori acustici,<br />
come ad esempio le campane, o come le sirene, pompe centrifughe ad aria<br />
compressa che potevano regolare la velocità, e quin<strong>di</strong> il sibilo prodotto,<br />
grazie a un sistema <strong>di</strong> valvole. Il caratteristico suono delle sirene,<br />
riprodotto nei fumetti come eeeee, ueee, uhueee, venne però presto limitato,<br />
per ovvi motivi, ai soli mezzi <strong>di</strong> soccorso, così come avviene anche nelle<br />
storie del Topolino, dove il suono della sirena annuncia l'ʹarrivo dei<br />
pompieri o della polizia. Altro <strong>di</strong>spositivo acustico per autovetture, molto<br />
<strong>di</strong>ffuso prima e dopo l'ʹinvenzione <strong>di</strong> quello elettrico, è infine la tromba, che<br />
può utilizzare <strong>di</strong>verse fonti <strong>di</strong> energia (aria, gas <strong>di</strong> scarico, vapore, forza<br />
muscolare etc.) e produrre quin<strong>di</strong> anche suoni <strong>di</strong>versi, profon<strong>di</strong> e<br />
5 Sulle onomatopee nel fumetto, cfr., più estesamente, Dovetto (2012).<br />
6 La pubblicità dei primi clacson sottolineava come il nuovo strumento acustico emettesse «un<br />
suono del tutto nuovo, dal carattere molto allarmante, paragonabile ad un or<strong>di</strong>ne a cui si<br />
obbe<strong>di</strong>sce d impulso» (, 21.2.2011).
98<br />
Le interiezioni tra scritto e parlato<br />
prolungati (pooooo), gravi e potenti (pot, potti) 7, ma anche stridenti come<br />
fischi (tweet), fino a intere melo<strong>di</strong>e 8.<br />
Per quanto riguarda invece le interiezioni che esprimono funzione<br />
emotiva (sorpresa, felicità, ira, paura, <strong>di</strong>sgusto, tristezza) nel corpus raccolto<br />
ricorrono tutte abbastanza frequentemente, benché le emozioni primarie<br />
con più alta occorrenza siano, sin dalle primissime storie del Topolino,<br />
sorpresa e ira, per la loro particolare consonanza con i contenuti comici<br />
delle storie narrate nel fumetto. Queste ultime presentano tra l'ʹaltro anche<br />
la maggior ricchezza <strong>di</strong> forme, sia per neoformazioni, sia per numero <strong>di</strong><br />
varianti rispetto a ciascuna forma base, come mostra ad esempio la<br />
ricorrenza <strong>di</strong> forme derivate come ulp, da gulp, o urgle e sgurgle, da gurgle.<br />
Tra le neoformazioni ricorrono invece anche delle pseudopolirematiche,<br />
come ad esempio urk acc grr, forma interiettiva che rende un'ʹira<br />
particolarmente intensa attraverso un'ʹintera sequenza <strong>di</strong> elementi sonori<br />
<strong>di</strong>versi tra loro e descrittivi dell'ʹevento còlto nella sua ricchezza emotiva.<br />
Complessivamente l'ʹespressione interiettiva della sorpresa nel corpus<br />
conta più <strong>di</strong> 170 forme e varianti (tra cui eh?/eh!/ehi, gasp, gawrssh, glab,<br />
glom, gnaf, gosh, guap, gulp, iuf, oh, sgurgle, sob, sput, squeak, toh, uh?/uh!,<br />
uuuhuack, ulp, urgh, urgle, whew etc.), la maggior parte delle quali è <strong>di</strong><br />
origine anglosassone e ripropone o un'ʹinteriezione vera e propria (come<br />
gosh 9, whew), o il derivato da una forma inglese verbale o nominale, come<br />
gasp per il 'ʹrespiro affannoso'ʹ da to gasp o sigh per il 'ʹsospiro'ʹ da to sigh.<br />
Molto spesso la base inglese è a sua volta <strong>di</strong> origine onomatopeica (così per<br />
sob, voce identificativa del 'ʹsinghiozzo'ʹ o per gulp, voce imitativa del<br />
7 A questo proposito è interessante osservare che dal punto <strong>di</strong> vista acustico i suoni cosiddetti<br />
gravi corrispondono, fra i suoni vocalici, alle vocali posteriori, e fra i suoni consonantici, alle<br />
consonanti ariticolate nelle regioni periferiche come le labiali e le velari (cfr. Dovetto 2000,<br />
283). Inoltre, nella scala (relativa) <strong>di</strong> forza, le occlusive sorde rappresentano i segmenti <strong>di</strong><br />
massima forza (e minima sonorità), mentre la geminazione costituisce un fenomeno <strong>di</strong><br />
rafforzamento.<br />
8 In questo caso l oggetto corrisponde a una pompa elettropneumatica. Sempre nei primi<br />
decenni del Novecento si <strong>di</strong>ffuse in Italia anche un clacson elettrico denominato "ʺtenore<br />
elettrico"ʺ il cui suono, assai più gradevole, veniva pubblicizzato con questa parole: «è pure<br />
gra<strong>di</strong>to ai passanti come un benefattore inapprezzabile. Esso li avverte cortesemente,<br />
gentilmente, senza spaventarli. Nessuna protesta, nessuna espressione avversa si ha<br />
udendolo; nessuno sbalzo <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nato, né cadute pericolose sull orlo dei marciapie<strong>di</strong>. Il<br />
passante, avvisato a tempo debito, si scosta con calma (, 21.2.2011).<br />
9 Cfr. OED (1989 2, s.v.): «Mincing pronunc. of GOD».
F. M. Dovetto 99<br />
rumore che si fa deglutendo a vuoto). Non mancano tuttavia le comuni<br />
forme interiettive tra<strong>di</strong>zionalmente presenti nel lessico italiano, come eh!,<br />
oh!, toh!, uuuh! etc. Queste ultime, riccamente presenti nei primi anni, nel<br />
corso del tempo vengono affiancate da altre forme, rappresentazione <strong>di</strong><br />
rumori <strong>di</strong>versi (come gasp!, gawrsh!, gnaf! 10, guap!, ulp!) che arricchiscono il<br />
corpus colorandolo connotativamente.<br />
L'ʹampio subcorpus delle forme interiettive per la sorpresa viene<br />
incrementato anche negli ultimi anni, quando si aggiungono le<br />
onomatopee glab e sgurgle (forse da to gurgle 'ʹgorgogliare'ʹ) e qualche glom.<br />
Quest'ʹultima forma, probabilmente derivata dall'ʹinglese to gloom 'ʹoscurarsi;<br />
aver l'ʹaria scontenta; essere triste, depresso'ʹ 11, è particolarmente<br />
interessante per la sua versatilità e polisemicità. Nel corpus in<strong>di</strong>ca infatti<br />
stati emotivi <strong>di</strong>versi, come preoccupazione e senso <strong>di</strong> tristezza sconfinante<br />
in agitazione, sconforto, <strong>di</strong>sperazione e paura fino al pianto, ma può<br />
designare anche l'ʹeffetto sonoro <strong>di</strong> eventi fisici come lo schiocco delle<br />
labbra 12, il deglutire e l'ʹazione del mordere o mangiare 13.<br />
L'ʹira, anche attenuata nelle forme del nervosismo e dell'ʹagitazione che<br />
esprime <strong>di</strong>sappunto, è anch'ʹessa riccamente presente nel corpus sin dagli<br />
anni Trenta con forme per lo più con antecedente inglese. Rispetto alla<br />
sorpresa questa emozione presenta tuttavia un più scarso numero <strong>di</strong> 'ʹtipi'ʹ;<br />
infatti, tranne poche eccezioni, viene resa quasi sempre con grrr 14 (sin dal<br />
1932), o con groan, che in<strong>di</strong>ca il gemere, il mormorio <strong>di</strong> <strong>di</strong>sapprovazione, e<br />
con argh, espressione <strong>di</strong> <strong>di</strong>sgusto o irritazione. Più recentemente ricorrono<br />
altre forme come sgrunt e grunf, umf e snort, identificative <strong>di</strong> forme d'ʹira<br />
attenuate.<br />
10 L onomatopea gnaf trova in italiano un antecedente lessicale nella forma interiettiva gnaffe,<br />
attestata dal XIV secolo, ma con significato asseverativo ( in fede mia, sicuramente ), la cui<br />
origine è romanza, probabilmente esito <strong>di</strong> una pronuncia veloce e trascurata del sintagma mia<br />
fé (cfr. Nocentini 2010, s.v.). In italiano la forma apofonica gniffe gnaffe, identificativa del<br />
rumore dello schiaffo, viene utilizzata anche in riferimento a uno smacco ricevuto (cfr. le<br />
parole con cui G.B. Marino descrive nel febbraio 1609 l attentato del Murtola: «voleva darmi<br />
un gniffe gnaffe e appendermi <strong>di</strong>etro i tricchi tracchi», Borzelli&Nicolini 1911, 68-‐‑69).<br />
11 Cfr. anche la forma aggettivale correlata glum tetro, accigliato, depresso, triste . A proposito<br />
<strong>di</strong> gloom, glum cfr. anche Jespersen (1925, 401).<br />
12 Si tratta tuttavia <strong>di</strong> un bacio dato alla terra da Topolino appena uscito dall acqua.<br />
13 Più <strong>di</strong>fficile il collegamento con la forma colloquiale americana glom ghermire, afferrare .<br />
14 Le sole varianti sono costituite dalla <strong>di</strong>versa iterazione della vibrante, oltre a una forma<br />
pseudoprefissata che presenta un occlusiva sorda anteposta alla base grr: pgrr.
100<br />
Le interiezioni tra scritto e parlato<br />
La minore ricchezza <strong>di</strong> forme per la paura trova invece motivazione<br />
nella più facile rappresentazione <strong>di</strong> questa emozione nel fumetto attraverso<br />
azioni in qualche modo ad essa collegate, come il battere dei denti (rattle<br />
rattle) o il tremito del corpo (brr). Ciò costituisce per altro certamente un<br />
freno alla creatività degli autori che, per la rappresentazione dello stato<br />
della mente del parlante rispetto a questa emozione, si limitano per lo più<br />
all'ʹimpiego delle forme della tra<strong>di</strong>zione classica (ehm, oh oh, uhm).<br />
Scarsissima è infatti la ricorrenza <strong>di</strong> altre forme, tra cui si possono però<br />
menzionare almeno glom e grumf.<br />
Tre sono invece le onomatopee che rendono nel corpus il <strong>di</strong>sgusto: puah 15<br />
(1951 e 1994), <strong>di</strong> orgine romanza, pfuì (1951), derivata dal tedesco, e infine<br />
argh (1997); mentre la tristezza occorre per lo più nelle forme inglesi, ma<br />
ricorrenti pure in italiano, sigh e sob, oltre al polisemico glom. Anche nel<br />
caso della tristezza va segnalata la presenza nel corpus <strong>di</strong> interiezioni che<br />
esprimono gra<strong>di</strong> <strong>di</strong>versi della stessa emozione, tendenti a denotare forme<br />
del <strong>di</strong>spiacere via via rafforzate fino a confondersi con manifestazioni d'ʹira,<br />
per quanto attenuata (sgrunt), e/o <strong>di</strong> <strong>di</strong>sperazione (glom, groan).<br />
Poco presenti, infine, le interiezioni che esprimono felicità. È possibile<br />
tuttavia che ciò trovi motivazione anche nella scarsa riconoscibilità <strong>di</strong><br />
questa emozione. Da numerosi lavori <strong>di</strong> fonetica sperimentale de<strong>di</strong>cati al<br />
riconoscimento delle emozioni emerge infatti che la gioia, unica emozione<br />
positiva tra le emozioni primarie, rappresenta in realtà un'ʹemozione <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>fficile identificazione e deco<strong>di</strong>fica nelle sue manifestazioni sonore. Più in<br />
particolare questi stu<strong>di</strong> evidenziano la generale tendenza da parte dei<br />
parlanti a riconoscere più facilmente le emozioni negative (e in particolare<br />
tristezza e rabbia) rispetto a quelle positive (cfr., tra gli altri, Scherer 1981 e<br />
Bezooyen 1984; cfr. anche Vallone 2005-‐‑2006 [2007], 64-‐‑66) 16.<br />
15 Questa interiezione, che si fonda su una onomatopea romanza (cfr. fr. pouah, <strong>di</strong> origine<br />
imitativa), è attestata in italiano dal 1882.<br />
16 In altri corpora ricorrono le seguenti forme: yippee! yu-‐‑uuh! e la forma italianizzata uao!<br />
(Mioni 1992, 89; Pietrini 2008, 170). Più spesso la felicità viene espressa, piuttosto che per<br />
mezzo <strong>di</strong> interiezioni vere e proprie, tramite i lessemi dell italiano viva, evviva, urrà etc., ossia<br />
col ricorso alle cosiddette interiezioni derivate , la cui origine è rintracciabile in voci del lessico<br />
del linguaggio articolato (P<strong>oggi</strong> 1995, 412-‐‑413).
3. Conclusioni<br />
F. M. Dovetto 101<br />
Questa rassegna, per quanto sommaria, consente <strong>di</strong> mettere in evidenza<br />
alcune caratteristiche comuni alle interiezioni presenti nel fumetto, utili per<br />
l'ʹidentificazione della categoria anche in relazione ad altre tipologie <strong>di</strong><br />
lessemi <strong>brevi</strong> come, ad esempio, gli ideofoni con cui le interiezioni sono<br />
spesso confuse 17.<br />
Innanzitutto va evidenziato come né la <strong>brevi</strong>tà fonica <strong>di</strong> questi lessemi,<br />
né l'ʹinevitabile approssimazione con cui essi riproducono i suoni esistenti<br />
in natura, ostacolino l'ʹattribuzione <strong>di</strong> senso, «poiché la situazione, la<br />
prontezza dell'ʹascoltatore e la mimica apportano un importante<br />
contributo» alla deco<strong>di</strong>fica dell'ʹevento linguistico designato (Spitzer<br />
1922/2007, 236). D'ʹaltra parte, proprio l'ʹespressività e la creatività che<br />
contrad<strong>di</strong>stinguono queste forme, ne hanno favorito l'ʹimpiego nel<br />
linguaggio fumettistico, caratterizzato da una struttura interna «a<br />
ridondanza ridotta» che tuttavia non pregiu<strong>di</strong>ca la deco<strong>di</strong>fica del<br />
messaggio o della sequenza visiva e comunicativa facilitata piuttosto<br />
dall'ʹovvietà del messaggio trasmesso (Eco 1964, 148-‐‑149 n).<br />
Per quanto riguarda invece la <strong>di</strong>stinzione tra interiezioni e ideofoni,<br />
l'ʹorigine onomatopeica <strong>di</strong> parte delle interiezioni ha certamente contribuito<br />
alla confusione delle prime con i secon<strong>di</strong>, tutti invece <strong>di</strong> origine<br />
onomatopeica (Mioni 1992, 88). Alla macroclasse lessicale delle<br />
onomatopee appartengono infatti tutti gli ideofoni, ma solo parte delle<br />
interiezioni, oltre ovviamente ai lessemi che hanno perso nel tempo la loro<br />
natura iconica <strong>di</strong>ventando in sincronia arbitrari 18, nonché alle voci che, non<br />
essendo onomatopeiche in origine, lo sono però <strong>di</strong>ventate nella sensibilità<br />
dei parlanti nel corso del tempo 19. Secondo Mioni (1992) i confini tra<br />
ideofoni e interiezioni sarebbero perciò assegnabili piuttosto al rispettivo<br />
contenuto semantico, esprimendo, i primi, «l'ʹintenzione puramente<br />
17 A questo proposito cfr., più <strong>di</strong>ffusamente, Dovetto (2012).<br />
18 Cfr. ad es., vagito, derivato dal verbo vagire apparentemente non onomatopeico, ma che in<br />
realtà trae origine da una onomatopea morfologizzata già in latino, vagīre [wagire] fare uà<br />
(Zamboni 1979, 165).<br />
19 Tale è, ad esempio, l it. strappare, derivato dal got. *strappōn tendere fortemente , che è alla<br />
base dell onomatopea strap, identificativa del rumore <strong>di</strong> un tessuto che si lacera, e quin<strong>di</strong> dello<br />
strappo.
102<br />
Le interiezioni tra scritto e parlato<br />
descrittiva del parlante» 20, le seconde invece una funzione<br />
«emotiva/conativa/fàtica» (ivi, 87) nella quale si manifesterebbe il loro<br />
valore fondamentalmente illocutivo. Questa <strong>di</strong>stinzione lascia tuttavia<br />
alcune zone d'ʹombra, soprattutto in quanto non considera che anche le<br />
interiezioni possono avere, e <strong>di</strong> fatto spesso hanno, un ruolo narrativo e<br />
quin<strong>di</strong> una funzione referenziale. Gli ideofoni, d'ʹaltra parte, possono<br />
assumere una funzione emotiva/conativa/fàtica preservando il loro ruolo<br />
narrativo, come appare chiaramente dal linguaggio giovanile il cui lessico è<br />
così permeabile a tutti gli usi iconici della sostanza fonica (ad es. è molto<br />
frequente tra i più giovani l'ʹuso <strong>di</strong> sgrunt olofrastico, narrativo con<br />
funzione emotiva, che designa genericamente <strong>di</strong>sappunto e da cui deriva<br />
tra l'ʹaltro il recente conio della voce verbale sgrunteggiare, descrittivo <strong>di</strong> uno<br />
stato d'ʹanimo; cfr. Pietrini 2008, 173) 21.<br />
Le caratteristiche evidenziate non sembrano quin<strong>di</strong> sufficienti a<br />
tracciare chiari e netti confini tra le due tipologie <strong>di</strong> lessemi che<br />
con<strong>di</strong>vidono comunque un <strong>di</strong>screto numero <strong>di</strong> particolarità formali, come<br />
la semplicità morfologica per mancanza <strong>di</strong> affissi, anche se a volte<br />
presentano reduplicazione (ad es., eh! eh!; glu glu) e, più spesso, variazione<br />
della vocale (tic tac), oltre alla scarsa aderenza alle regole fonotattiche della<br />
lingua e all'ʹuso tendenzialmente olofrastico.<br />
A tanta incertezza classificatoria, che tende a volte ad<strong>di</strong>rittura a fondere<br />
una categoria nell'ʹaltra (cfr. da ultimo Pietrini 2008, 169-‐‑170), si oppone<br />
d'ʹaltra parte la chiara percezione dei parlanti che evidentemente assegnano<br />
questi stessi lessemi a una rigorosa tassonomia 22 la cui semantica, niente<br />
affatto ambigua (ovviamente in contesto), ha fatto pensare anche ad una<br />
sorta <strong>di</strong> universalità dei relativi significati 23. Nel fumetto in particolare, tutti<br />
gli elementi sopra citati (onomatopee, ideofoni, interiezioni, rumori) si<br />
20 In Mioni (1990, 258) si accenna, tuttavia, anche alla funzione emotiva, oltre che descrittiva,<br />
degli ideofoni, definiti come «elementi tutti descrittivi, che solo contestualmente possono<br />
talvolta assumere una qualche forza illocutiva particolare» (ivi, 262). Diversamente Catricalà<br />
(2000, 21, con ulteriore bibliografia) considera gli ideofoni suoni che servono a in<strong>di</strong>care stati<br />
d animo.<br />
21 Sulle incertezze della <strong>di</strong>stinzione tra ideofoni e interiezioni cfr. anche Pietrini (2008, 169-‐‑<br />
170).<br />
22 Eco (1964, 146), ad esempio, fa cenno a una «tabella dei rumori, piuttosto rigorosa».<br />
23 Nelle lingue al mondo sussistono in<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> alcune ampie corrispondenze tra suono e<br />
significato; non mancano tuttavia anche numerosi esempi contrari (cfr. Crystal 1987/1993, 175).
F. M. Dovetto 103<br />
accompagnano, <strong>di</strong> norma, anche a una iconografia a sua volta portatrice <strong>di</strong><br />
significato, anch'ʹesso tendente all'ʹuniversalità 24.<br />
L'ʹintera macroclasse, ma soprattutto la sottoclasse delle interiezioni, è<br />
infine caratterizzata sia da una notevole variabilità sul piano del<br />
significante, che trova la sua motivazione nella scarsa standar<strong>di</strong>zzazione<br />
grafica delle forme impiegate, sia, sul piano del significato, da ambiguità<br />
semantica e polisemicità. Analogamente al linguaggio interno descritto da<br />
Vygotskij, caratterizzato da <strong>brevi</strong>tà del significante e «pre<strong>di</strong>catività<br />
assoluta», queste forme <strong>brevi</strong> trasmettono il contesto psicologico interno<br />
del locutore e la percezione imme<strong>di</strong>ata della situazione attraverso la<br />
tendenza all'ʹab<strong>brevi</strong>azione. Si tratta infatti <strong>di</strong> segni il cui «significante che è<br />
istintivo [...] o è un espe<strong>di</strong>ente occasionale, sfrutta allora, per essere<br />
interpretato, aspetti in<strong>di</strong>cali o iconici» (Gambarara 1999, 105). Ed è proprio<br />
in questi termini che ritroviamo, tra l'ʹaltro, gli elementi interiettivi in altre<br />
produzioni letterarie, anche molto <strong>di</strong>stanti dalla comicità, come dalla<br />
contemporaneità 25. In tutti i casi si tratta della trasmissione <strong>di</strong> «una<br />
funzione verbale del tutto particolare e originale per struttura e modalità <strong>di</strong><br />
funzionamento» alla quale questi elementi olofrastici, <strong>brevi</strong>, mostrano<br />
chiaramente <strong>di</strong> appartenere con le loro proprietà enigmatiche, come<br />
ab<strong>brevi</strong>azioni, cortocircuiti ed economie, attraverso il processo, che essi<br />
attuano, <strong>di</strong> «volatilizzazione del linguaggio nel pensiero» (Vygotskij<br />
1934/1998, 347) 26.<br />
Francesca M. Dovetto<br />
dovetto@unina.it<br />
24 Verda (1990, 58) fa riferimento, a questo proposito, alle interpunzioni metaforiche e alle<br />
particolarità della grafia in genere.<br />
25 Su occorrenza e ruolo delle interiezioni in <strong>di</strong>verse tipologie <strong>di</strong> testi, scritti e parlati, cfr.<br />
Dovetto (2010).<br />
26 All estremo <strong>di</strong> questo processo si situano le forme dell endofasia o linguaggio interiore a cui<br />
Vygotskij ha de<strong>di</strong>cato le sue riflessioni. Come sottolinea Bergounioux (2010), raramente la<br />
riflessione sul linguaggio si è soffermata sul linguaggio interiore, ad eccezione degli stu<strong>di</strong><br />
sulle produzioni linguistiche da parte <strong>di</strong> pazienti afasici o nevrotici, piuttosto «ramenant la<br />
question du <strong>di</strong>scours à celle de la parole, l exercise de la parole aux fonctions de la langue et<br />
les fonctions de la langue à l exercise d une pensée sans phonologie» (ivi, 20).
104<br />
Bibliografia<br />
Le interiezioni tra scritto e parlato<br />
Anolli&Ciceri 1992<br />
Anolli Luigi, Ciceri Rita, La voce delle emozioni. Verso una semiosi della<br />
comunicazione vocale non-‐‑verbale delle emozioni, Milano, FrancoAngeli.<br />
Barbieri 2009<br />
Barbieri Daniele, Breve storia della letteratura a fumetti, Roma, Carocci.<br />
Bergounioux 2010<br />
Bergounioux Gabriel, “Les trois sources de la théorie de l'ʹendophasie”,<br />
in M. De Palo, L. Formigari (éd. par), Sciences du language et psychologie à<br />
la charnière des 19e et 20e siècle, H.E.L., 32/2, 37-‐‑92.<br />
Borzelli&Nicolini 1911<br />
Borzelli Angelo, Nicolini Fausto (a cura <strong>di</strong>), G.B. Marino. Epistolario<br />
seguito da altre lettere del Seicento, vol. I, Bari, Laterza.<br />
Bezooyen 1984<br />
Bezooyen Renee van, Characteristics and recognizability of vocal expressions<br />
of emotion, Dordrecht, Foris Pubblication.<br />
Catricalà 2000<br />
Catricalà Maria, “Dall'ʹitaliano bisbigliato a quello urlato: come si ascolta<br />
il fumetto”, in M. Catricalà, G. Marrone (a cura <strong>di</strong>), Come parla il fumetto<br />
e la multime<strong>di</strong>alità, Roma, Comic Art Publishing, 21-‐‑26.<br />
Crystal 1987/1993<br />
Crystal David, The Cambridge encyclope<strong>di</strong>a of language, Cambridge,<br />
Cambridge University Press; ed. it. a cura <strong>di</strong> P. M. Bertinetto,<br />
Enciclope<strong>di</strong>a Cambridge delle scienze del linguaggio, Bologna, Zanichelli,<br />
1993 (da cui si cita).<br />
De Mauro 2008<br />
De Mauro Tullio, Lezioni <strong>di</strong> linguistica teorica, Roma-‐‑Bari, Laterza.
F. M. Dovetto 105<br />
Dovetto 2000<br />
Dovetto Francesca M., “Terminologia ‘calda’ e terminologia ‘fredda’:<br />
alcune caratteristiche della costituzione del lessico italiano della<br />
fonetica”, in C. Vallini (a cura <strong>di</strong>), Le parole per le parole. I logonimi nelle<br />
lingue e nel metalinguaggio, Atti del Convegno, Napoli, Istituto<br />
Universitario Orientale, 18-‐‑20 <strong>di</strong>cembre 1997, Roma, Il Calamo, 279-‐‑300.<br />
Dovetto 2010<br />
Dovetto Francesca M., “Interiezioni e neutralità semantica”, in M.<br />
Pettorino, A. Giannini, F.M. Dovetto (a cura <strong>di</strong>), La comunicazione parlata<br />
3. Atti del congresso internazionale, (Napoli, 23-‐‑25 febbraio 2009), Napoli,<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Napoli L'ʹOrientale, vol. I, 363-‐‑381.<br />
Dovetto 2012<br />
Dovetto Francesca M., “Onomatopee in <strong>di</strong>acronia nel fumetto”, in A.<br />
Manco (a cura <strong>di</strong>), Comunicazione e ambiente. Orientare le risorse, Aiutare a<br />
capire, Stimolare ad agire, Ispirare il cambiamento, Napoli, Università degli<br />
Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Napoli L’Orientale, 201-‐‑211.<br />
Eco 1964<br />
Eco Umberto, Apocalittici e integrati. Comunicazioni <strong>di</strong> massa e teorie della<br />
cultura <strong>di</strong> massa, Milano, Bompiani, I ed. "ʺSaggi Tascabili”, 1993.<br />
Gambarara 1999<br />
Gambarara Daniele, “Dai segni alle linee. La semiosi tra natura e<br />
cultura”, in S. Gensini (a cura <strong>di</strong>), Manuale della comunicazione, Roma,<br />
Carocci, 91-‐‑117.<br />
Jespersen 1925<br />
Jespersen Otto, Language: its nature, development and origin, New York,<br />
Henry Holt and Company.<br />
Mioni 1990<br />
Mioni Alberto, “Fece splash e, glu glu, affondò. L'ʹideofono come parte<br />
del <strong>di</strong>scorso”, in M. Berretta, P. Molinelli, A. Valentini (a cura <strong>di</strong>),<br />
Parallela 4. Morfologia, Atti del V° incontro italo-‐‑austriaco della Società <strong>di</strong><br />
Linguistica Italiana, Bergamo 2-‐‑4 ottobre 1989, Tübingen, Narr, 255-‐‑267.
106<br />
Le interiezioni tra scritto e parlato<br />
Mioni 1992<br />
Mioni Alberto, “Uao!, Clap, cap! Ideòfoni e interiezioni nel mondo dei<br />
fumetti”, in E. Banfi, A.A. Sobrero (a cura <strong>di</strong>), Il linguaggio giovanile degli<br />
anni Novanta. Regole, invenzioni, gioco, Bari, Laterza, 85-‐‑96.<br />
Nocentini 2010<br />
Nocentini Alberto, l'ʹEtimologico. Vocabolario della lingua italiana,<br />
Firenze/Milano, Le Monnier.<br />
OED 1989 2<br />
OED, The Oxford English <strong>di</strong>ctionary, Second e<strong>di</strong>tion prepared by John A.<br />
Simpson, Edmund S.C. Weiner, Oxford, Clarendon Press.<br />
Pettorino&Giannini 2004<br />
Pettorino Massimo, Giannini Antonella, Progetti AVIP e API – Unità <strong>di</strong><br />
ricerca dell’Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Napoli L’Orientale, in F. Albano Leoni,<br />
F. Cutugno, M. Pettorino, M. Savy (a cura <strong>di</strong>), Il parlato italiano, Atti del<br />
Convegno nazionale <strong>di</strong> Napoli 13-‐‑15 febbraio 2003, CD ROM, Napoli,<br />
D’Auria.<br />
Pietrini 2008<br />
Pietrini Daniela, Parola <strong>di</strong> papero. Storia e tecniche della lingua dei fumetti<br />
Disney, Firenze, Cesati.<br />
P<strong>oggi</strong> 1981<br />
P<strong>oggi</strong> Isabella, Le interiezioni: stu<strong>di</strong>o del linguaggio e analisi della mente,<br />
Milano, Boringhieri.<br />
P<strong>oggi</strong> 1995<br />
P<strong>oggi</strong> Isabella, “Le interiezioni”, in L. Renzi, G. Salvi, A. Car<strong>di</strong>naletti (a<br />
cura <strong>di</strong>), Grande Grammatica italiana <strong>di</strong> consultazione, vol. III, Tipi <strong>di</strong> frase<br />
deissi, formazione delle parole, Bologna, il Mulino, 405-‐‑425.<br />
Rodari 1997<br />
Rodari Gianni, Grammatica della fantasia. Introduzione all'ʹarte <strong>di</strong> inventare<br />
storie, S. Dorligo della Valle (Trieste), Einau<strong>di</strong> Ragazzi.<br />
Scherer 1981
F. M. Dovetto 107<br />
Scherer Klaus R., “Speech and emotional states”, in J. Darby (ed. by),<br />
Speech Evaluation in Psychiatry, New York, Grune and Stratton, 189-‐‑220.<br />
Spitzer 1922/2007<br />
Spitzer Leo, Italienische Umgangssprache, Bonn-‐‑Leipzig, Schroeder; trad.<br />
it. Lingua italiana del <strong>di</strong>alogo, Milano, il Saggiatore, 2007 (da cui si cita).<br />
Vallone 2005-‐‑2006 [ma 2007]<br />
Vallone Marianna, L'ʹespressione fonica delle emozioni, Tesi <strong>di</strong> Dottorato in<br />
Filologia moderna, XVIII ciclo (tutore F. Albano Leoni, co-‐‑tutore F.M.<br />
Dovetto), Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Napoli Federico II.<br />
Verda 1990<br />
Verda Sandra, “La parola a Topolino”, Italiano & Oltre 5/2, 53-‐‑59.<br />
Vygotskij 1934/1998<br />
Vygotskij Lev S., Myšlenie i reč'ʹ. Psichologičeskie issledovanija, Moskva-‐‑<br />
Leningrad, Gosudarstvennoe Social'ʹno-‐‑Ekonomičeskoe Izdatel'ʹstvo;<br />
trad. it. Pensiero e linguaggio. Ricerche psicologiche, Roma-‐‑Bari, Laterza,<br />
1998 (da cui si cita).<br />
Zamboni 1979<br />
Zamboni Alberto, L’etimologia, Bologna, Zanichelli.
Abstract<br />
Sigle e acronimi: <strong>di</strong>mensione grafica e statuto lessicale<br />
Lucia <strong>di</strong> Pace e Rossella Pannain<br />
Tra i <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> formazione per riduzione, dei quali è proposta una<br />
classificazione basata su un insieme <strong>di</strong> parametri, anche grafici, e sulle interazioni<br />
tra questi, le sigle/acronimi presentano una fenomenologia ricca e variata, e <strong>di</strong><br />
particolare interesse anche in virtù delle sovrapposizioni con altre categorie, quali le<br />
ab<strong>brevi</strong>azioni o le parole macedonia. Il tratto che caratterizza in modo forte la<br />
fenomenologia delle sigle è quello della lessicalizzazione, che risulta essere<br />
l’inevitabile deriva nel passaggio dalla <strong>di</strong>mensione scritta a quella propriamente<br />
linguistica. In questo lavoro vengono portate numerose evidenze che testimoniano<br />
<strong>di</strong> questo passaggio a partire da in<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> natura grafica fino ad altri <strong>di</strong> natura<br />
fonica, morfosintattica e semantica. Infine, le sigle/acronimi sono il risultato <strong>di</strong> un<br />
processo <strong>di</strong> formazione delle parole su base non morfologica, nel quale si manifesta<br />
in maniera saliente il <strong>di</strong>namismo nel rapporto lingua-‐‑scrittura.<br />
Parole chiave: sigle/acronimi, riduzione, formazione delle parole, lessicalizzazione,<br />
scrittura<br />
The study, primarily focused on acronyms and initialisms, first of all addresses the<br />
issue of definition and classification of <strong>di</strong>fferent types of non-‐‑morphological word<br />
formation processes by reduction. The proposed classification, which takes<br />
previous most relevant taxonomies into account, is aimed at highlighting, among<br />
other classificatory parameters, those which reveal the complex interaction of<br />
graphic vs. (spoken-‐‑)linguistic factors in the genesis of formations by reduction. In<br />
fact, initialisms and acronyms represent the one area within reduction in which the<br />
dynamic interaction of spoken and written language can best be appreciated.<br />
Moreover the category of initialisms and acronyms, which includes cases of partial<br />
overlap with other types of formation by reduction, <strong>di</strong>splays a particularly rich,<br />
varied and productive phenomenology. Finally, a salient feature of this category is<br />
its tendency towards lexicalization, entailing a transfer from the graphic to the<br />
spoken <strong>di</strong>mension, which in turn implies formal mo<strong>di</strong>fications also affecting the<br />
initial graphic co<strong>di</strong>ng of the forms. In the study, indexes of lexicalization are<br />
identified and analyzed at the graphic, phonetic, morphosyntactic and semantic<br />
level.<br />
Keywords: acronyms/initialisms, reduction, word formation, lexicalization, writing
1. Aspetti definitori e terminologici<br />
L. <strong>di</strong> Pace e R. Pannain 109<br />
Le sigle e gli acronimi sono entità linguistiche che rientrano nella vasta<br />
area della “riduzione” 1, nella quale è possibile collocare <strong>di</strong>verse altre<br />
manifestazioni: ab<strong>brevi</strong>azioni, simboli, accorciamenti e parole macedonia 2.<br />
La definizione e classificazione <strong>di</strong> tali <strong>di</strong>verse entità, con i rispettivi tratti,<br />
comuni e i<strong>di</strong>osincratici, sono caratterizzate, in letteratura, da un elevato<br />
grado <strong>di</strong> incertezza, cui corrisponde una notevole approssimazione<br />
terminologica.<br />
Non si intende in questa sede affrontare la questione, che meriterebbe<br />
uno stu<strong>di</strong>o de<strong>di</strong>cato, ma, in fase introduttiva, non si può tralasciare del<br />
tutto qualche accenno a questo aspetto. L’incertezza definitoria e<br />
terminologica è estesa e trasversale ed è infatti ravvisabile su molteplici<br />
livelli: a) tra le <strong>di</strong>verse comunità <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>osi; b) tra le <strong>di</strong>verse scuole <strong>di</strong><br />
pensiero all’interno <strong>di</strong> una stessa tra<strong>di</strong>zione linguistica; c) in uno stesso<br />
autore.<br />
Che non esista con<strong>di</strong>visione tra le <strong>di</strong>verse tra<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> linguisti lo si<br />
rileva quando si constata che l’insieme delle entità sopra menzionate viene,<br />
<strong>di</strong> volta in volta, segmentato in modo <strong>di</strong>fferente: mentre, per portare<br />
un’esemplificazione, la maggior parte degli stu<strong>di</strong>osi italiani in<strong>di</strong>vidua<br />
l’ampia categoria delle sigle (che solo alcuni <strong>di</strong>stinguono dagli acronimi),<br />
nella letteratura in lingua inglese troviamo prevalentemente acronyms (ad<br />
es. in Kreidler 2000), accanto ad ulteriori categorie come gli<br />
initialisms/alphabetisms (Bauer 1983, Crystal 2006). Nella tra<strong>di</strong>zione italiana<br />
una sigla è tanto quella pronunciata come parola, come è il caso ad es. <strong>di</strong><br />
FIAT (solo questo sarebbe un acronym), quanto quella pronunciata lettera<br />
per lettera, come è il caso <strong>di</strong> CGIL (un initialism o alphabetism per gli inglesi).<br />
Alcuni, infine (ad es. Fandrych 2008), definiscono acronyms solo le sigle con<br />
pronuncia ortoepica, opponendole non agli initialisms ma alle ab<strong>brevi</strong>ations,<br />
pronunciate lettera per lettera, altri ancora usano ab<strong>brevi</strong>ation come<br />
sinonimo <strong>di</strong> acronym (Dressler 1987, Bussmann 1996). Tutto ciò, come è<br />
evidente, comporta peraltro grosse <strong>di</strong>fficoltà nello stabilire equivalenze<br />
traduttive. Andando oltre il confronto tra l’inglese e l’italiano, troviamo ad<br />
1 Dressler (1987, 105-‐‑107), facendo riferimento a Mayerthaler (1981, 110), colloca questa<br />
fenomenologia nella categoria della morfologia sottrattiva, che egli pone all’estremo inferiore<br />
<strong>di</strong> un continuum <strong>di</strong> naturalezza nei processi morfologici.<br />
2 Su questi <strong>di</strong>versi fenomeni si è sviluppata una ricca letteratura, in particolare concernente la<br />
lingua inglese che manifesta una marcata tendenza in questa <strong>di</strong>rezione.
110<br />
Sigle e acronimi: <strong>di</strong>mensione grafica e statuto lessicale<br />
es. che in tedesco il termine Abkürzung viene utilizzato per in<strong>di</strong>care sia ciò<br />
che gli inglesi definiscono acronyms, sia ciò che noi definiamo ab<strong>brevi</strong>azioni.<br />
Ma l’oscillazione terminologica non si ferma al riscontro<br />
interlinguistico; si rileva, come anticipato, anche all’interno della stessa<br />
comunità linguistica. Nella tra<strong>di</strong>zione italiana è affermato l’uso <strong>di</strong> sigla<br />
(Thornton 2004), mentre acronimo è considerato nella maggior parte dei casi<br />
una sorta <strong>di</strong> sinonimo 3, sia nei <strong>di</strong>zionari della lingua italiana (Devoto-‐‑Oli,<br />
Zingarelli, DISC, Gabrielli), sia nei <strong>di</strong>zionari <strong>di</strong> linguistica (ad es. in<br />
Beccaria 1996). Tuttavia, si segnala che alcuni, come De Mauro (2003),<br />
appaiono <strong>di</strong>stinguere tra acronimo e sigla, attribuendo solo al primo lo<br />
statuto <strong>di</strong> parola e rispecchiando, in questo senso, la <strong>di</strong>stinzione presente in<br />
lingua inglese tra acronyms e initialisms:<br />
acronimo s.m. TS. ling. [1950; comp. <strong>di</strong> acro– e –onimo] nome costituito da una o più<br />
lettere iniziali <strong>di</strong> altre parole (per es. radar, dall'ʹingl. ra<strong>di</strong>o detection and ranging)<br />
sigla s.f. AD. [av. 1750; dal lat. tardo sǐgla pl., forse forma contratta <strong>di</strong> singula sott.<br />
signa "ʺ(segni) singoli"ʺ] 1 la lettera o le lettere iniziali <strong>di</strong> una o più parole usate<br />
convenzionalmente come ab<strong>brevi</strong>azione al posto della denominazione per esteso:<br />
ACI è la s. dell'ʹAutomobile Club d'ʹItalia<br />
Sembrerebbe dunque chiara la contrapposizione tra un nome e un “non<br />
nome” (la lettera o le lettere …); eppure, a conferma ulteriore<br />
dell’incertezza definitoria, leggiamo che lo stesso <strong>di</strong>zionario, altrove,<br />
considera le sigle come nomi:<br />
Sono state considerate sigle tutte quelle ab<strong>brevi</strong>azioni che vengono comunemente<br />
usate come nomi propri preceduti dall’articolo (De Mauro 2003, Introduzione xxxix).<br />
Inoltre, nel GRADIT emerge chiaramente come solo alcune sigle<br />
vengano trattate come nomi, comportando ad esempio l’in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong><br />
tratti morfologici, a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> altre, pur sempre sigle, che sembrano<br />
sottrarsi a tali con<strong>di</strong>zioni. Si veda la contrapposizione nel trattamento <strong>di</strong><br />
due sigle, entrambe pronunciate lettera per lettera, entrambe prestiti<br />
dall’inglese, ma solo la seconda definita come “sostantivo”:<br />
3 Talora, un sinonimo dotto, ad es. nel <strong>di</strong>zionario Treccani alla voce acronimo si legge: “è<br />
comunem. detto sigla, rispetto a cui ha sign. più ristretto…” . Paradossalmente, negli ultimi<br />
anni, si è verificata una <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> “acronimo” nell’uso comune, non specialistico.
L. <strong>di</strong> Pace e R. Pannain 111<br />
FBI sigla ES. ingl. Federal Bureau of Investigation, ufficio federale investigativo, nome<br />
del corpo <strong>di</strong> polizia federale degli Stati Uniti.<br />
DNA s.m.inv. TS biochim. [1970; propr. sigla dell'ʹingl. Deoxyribo Nucleic Acid "ʺacido<br />
desossiribonucleico"ʺ]<br />
Questo insieme <strong>di</strong> considerazioni fa sì che in questo lavoro non si<br />
porranno in opposizione i termini acronimo e sigla, che verranno <strong>di</strong> fatto<br />
considerati in modo congiunto, sebbene dei due verrà prevalentemente<br />
usato il secondo, <strong>di</strong> fatto più <strong>di</strong>ffuso.<br />
Infine, si può segnalare ancora l’incertezza nell’estensione della<br />
categoria “acronimo”, che riflette probabilmente la complessiva sfumatezza<br />
della fenomenologia, la quale presenta zone <strong>di</strong> sovrapposizione (López Rúa<br />
2006, 675) anche, ad es., tra ab<strong>brevi</strong>azioni e sigle, ab<strong>brevi</strong>azioni e<br />
accorciamenti, sigle e accorciamenti 4.<br />
Se, dunque, nel vocabolario TRECCANI, al lemma acronimo si registra<br />
un’ampia sovrapposizione con il termine sigla, desta sorpresa che, in<br />
chiusura, la categoria venga allargata ad includere forme che sono<br />
chiaramente “parole macedonia”:<br />
per estensione si chiamano acronimi anche i nomi formati con le sillabe estreme <strong>di</strong><br />
due parole, come per es. motel, formata da mo(to-‐‑) e (ho)tel.<br />
2. Possibile classificazione<br />
Le problematiche terminologiche e definitorie appena esaminate,<br />
spingono a tentare una classificazione dei fenomeni <strong>di</strong> riduzione che,<br />
tenendo conto <strong>di</strong> precedenti tassonomie 5, miri, nell’esame dei parametri e<br />
delle loro sinergie, ad assegnare il giusto rilievo all’interazione tra la<br />
<strong>di</strong>mensione grafica e quella orale.<br />
I parametri ritenuti pertinenti sono i seguenti:<br />
a) forma piena sottostante costituita da una vs. più parole;<br />
b) origine nella <strong>di</strong>mensione scritta vs. orale;<br />
4 Su questo aspetto si veda più avanti il par. 2.1.<br />
5 Resta fondamentale il pionieristico lavoro <strong>di</strong> Algeo 1975, cui fa riferimento ad esempio<br />
Thornton 2004. Si veda anche López Rúa 2006.
112<br />
c) uso scritto vs. orale;<br />
Sigle e acronimi: <strong>di</strong>mensione grafica e statuto lessicale<br />
d) sistematicità vs. marginalità/assenza della puntazione;<br />
e) uso <strong>di</strong> maiuscole vs. minuscole nella grafia della forma ridotta;<br />
f) modalità <strong>di</strong> lettura (lettera per lettera, come forma <strong>di</strong> parola, tramite<br />
la forma piena sottostante);<br />
g) grado <strong>di</strong> riduzione del materiale fonico/grafico della forma piena<br />
sottostante.<br />
Sulla base della combinazione e interazione <strong>di</strong> questi parametri è<br />
possibile raccogliere e classificare la varietà dei fenomeni <strong>di</strong> riduzione in<br />
quattro categorie fondamentali:<br />
1. Ab<strong>brevi</strong>azioni. Le ab<strong>brevi</strong>azioni rimandano ad una forma sottostante<br />
che è tendenzialmente costituita da una sola parola; si originano nella<br />
<strong>di</strong>mensione scritta, nella quale tendono a rimanere confinate nell’uso. La<br />
con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> forma scritta è confermata, da un lato, dall’in<strong>di</strong>ce grafico<br />
costituito dalla presenza e persistenza della puntazione, dall’altro, dal fatto<br />
che nella lettura si tende a sostituire l’ab<strong>brevi</strong>azione con la forma piena<br />
sottostante (come nel caso <strong>di</strong> Sig./sig. letto come /siɲ’ɲore/. Il grado <strong>di</strong><br />
riduzione della forma piena oscilla dal grado massimo, che risulta nella<br />
conservazione della sola iniziale <strong>di</strong> parola6, a riduzioni minori come nel<br />
caso, ad esempio, <strong>di</strong> pagina ab<strong>brevi</strong>ato come: p./pg./pag. In quest’ultimo<br />
caso, è interessante notare come, nel plurale, pp./pagg., l’incremento dato<br />
dal raddoppiamento grafico <strong>di</strong> natura iconica non vada a recuperare<br />
ulteriore materiale dalla forma estesa sottostante. Nelle ab<strong>brevi</strong>azioni,<br />
prevale l’uso del carattere minuscolo tranne nei casi in cui la forma<br />
sottostante sia per convenzione scritta con la maiuscola come per es. S.<br />
Antonio per Sant’Antonio.<br />
2. Sigle e/o acronimi. Le sigle rimandano ad una forma sottostante<br />
costituita da più parole (PD da Partito Democratico) o da parola complessa le<br />
6 I simboli, come quelli chimici e matematici, possono essere considerati un caso estremo <strong>di</strong><br />
ab<strong>brevi</strong>azioni. Infatti, come queste, non vengono letti mai come tali, ma rimandano sempre<br />
alla forma estesa; questa con<strong>di</strong>zione è particolarmente evidente nei casi in cui il simbolo non<br />
ha alcuna affinità con la forma pronunciata, come accade ad esempio per il simbolo K che sta<br />
per “potassio” (dal nome latino kalium).
L. <strong>di</strong> Pace e R. Pannain 113<br />
cui componenti vengono riconosciute come entità autonome (TV per<br />
televisione). Si originano nella <strong>di</strong>mensione scritta, ma possono acquisire<br />
ampia <strong>di</strong>ffusione nel parlato; la puntazione non è sistematica, né lo è l’uso<br />
delle maiuscole (I.N.P.S. / INPS / Inps) e la tendenza è comunque, nel<br />
tempo, verso la per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> entrambe le marche grafiche (S.p.A. → spa). Si<br />
riscontra tutto il ventaglio delle possibili modalità <strong>di</strong> lettura: pronuncia<br />
lettera per lettera (Idv , Italia dei valori), come forma <strong>di</strong> parola (USA/Usa), o,<br />
molto più raramente, tramite la forma piena sottostante (IC da Inter City,<br />
pronunciato sempre come /inter'ʹsiti/), modalità tipica delle ab<strong>brevi</strong>azioni.<br />
Inoltre, vi sono casi in cui si rileva un’alternanza tra le prime due modalità<br />
<strong>di</strong> pronuncia, come nel caso <strong>di</strong> Aids, letto tuttora anche come /aid<strong>di</strong>'ʹɛsse/.<br />
Per quanto concerne il grado <strong>di</strong> riduzione rispetto alla forma piena<br />
sottostante, esso è tendenzialmente massimo: viene conservata solo<br />
l’iniziale delle singole componenti7. Non è rara l’omissione <strong>di</strong> alcune<br />
parole, funzionali (CNEL per Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro;<br />
IsIAO , Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente), ma non solo (I.S.M.E.O.<br />
/IsMEO con la cancellazione anche della seconda parola piena del<br />
sintagma: Istituto Italiano per il Me<strong>di</strong>o e l’Estremo Oriente). Peraltro, gli ultimi<br />
due esempi mostrano, nella prima parola del sintagma, un grado <strong>di</strong><br />
riduzione minore.<br />
3. Accorciamenti. Partono da un’unica parola, si originano nel parlato,<br />
ma possono essere trasferiti nello scritto (tipicamente in registri<br />
caratterizzati da un grado ridotto <strong>di</strong> formalità). La nascita nella <strong>di</strong>mensione<br />
orale comporta la sistematica mancanza <strong>di</strong> puntazione, mentre la<br />
provenienza da un’unica parola determina l’assenza del ricorso all’uso<br />
della marca grafica rappresentata dalla maiuscola. La riduzione può<br />
ricalcare la segmentazione morfologica e quin<strong>di</strong> lasciare come residuo un<br />
intero morfema (es. moto da motocicletta), oppure risultare in un’entità che<br />
non corrisponde ad un’effettiva componente morfologica della forma <strong>di</strong><br />
base (es. bici da bicicletta).<br />
4. Parole macedonia. Come nel caso delle sigle, prendono le mosse da<br />
un sintagma sottostante, che però in questo caso è prototipicamente<br />
costituito da solo due parole piene. Si originano nello scritto, ma possono<br />
essere accolte nel parlato, anche al <strong>di</strong> fuori dell’eventuale ambito settoriale<br />
in cui nascono, come ad es. polfer (Polizia Ferroviaria). Sono assenti tanto la<br />
7 Tranne nel caso delle cosiddette sigle sillabiche, su cui si veda più avanti.
114<br />
Sigle e acronimi: <strong>di</strong>mensione grafica e statuto lessicale<br />
puntazione quanto l’impiego <strong>di</strong> maiuscole, segnalatori del processo <strong>di</strong><br />
riduzione, il che in<strong>di</strong>zia la volontà <strong>di</strong> creare un’unica parola. In italiano il<br />
processo è molto meno produttivo che in inglese, lingua da cui sono giunte<br />
come prestito parole come motel e smog che, infatti, vengono generalmente<br />
percepite dai parlanti italiani come forme compatte. Il processo <strong>di</strong><br />
riduzione, che ha risultati quantitativamente e qualitativamente variabili<br />
(potendo anche lasciare intatta una delle componenti, es. Federconsorzi), è<br />
comunque contenuto; questo tratto, con tutta probabilità, riflette un’istanza<br />
<strong>di</strong> preservazione della riconoscibilità delle componenti.<br />
2.1. Sfumatezza e sovrapposizione della fenomenologia<br />
La classificazione appena proposta, più che identificare categorie dai<br />
confini netti, vuole segnalare quelli che, si ritiene, costituiscano i quattro<br />
fondamentali poli <strong>di</strong> gravitazione <strong>di</strong> una fenomenologia che si presenta,<br />
anche, come continua e sfumata. Infatti, non rari sono i casi <strong>di</strong> forme ridotte<br />
che si collocano in una zona <strong>di</strong> sovrapposizione tra due delle categorie<br />
sopra in<strong>di</strong>viduate.<br />
Ad esempio, tra le ab<strong>brevi</strong>azioni, <strong>di</strong> cui sopra si è sottolineata<br />
l’appartenenza esclusiva alla <strong>di</strong>mensione scritta, figura un elemento, <strong>di</strong> uso<br />
piuttosto frequente, Prof./prof., cui corrisponde nella categoria degli<br />
accorciamenti, quin<strong>di</strong> con statuto primariamente orale, una forma<br />
colloquiale/giovanile anch’essa <strong>di</strong> uso relativamente frequente, prof, anche<br />
al femminile, la prof 8. Le due forme si manifestano in <strong>di</strong>mensioni e registri<br />
<strong>di</strong>stinti; tuttavia è verosimile che il risultato dell’istanza grafica<br />
dell’ab<strong>brevi</strong>azione abbia innescato, o per lo meno rinforzato, il processo <strong>di</strong><br />
accorciamento che ha portato alla creazione dell’elemento appartenente al<br />
parlato.<br />
Una sovrapposizione tra la categoria delle ab<strong>brevi</strong>azioni e quella delle<br />
sigle si riscontra nel caso dell’elemento IC, che, come le ab<strong>brevi</strong>azioni,<br />
viene pronunciato esclusivamente tramite la forma piena sottostante<br />
/inter'ʹsiti/, ma con<strong>di</strong>vide con le sigle l’origine da una forma complessa, la<br />
marca grafica della maiuscola per l’iniziale <strong>di</strong> ogni parola del sintagma<br />
sottostante e l’assenza della puntazione.<br />
8 Cfr. Thornton 2004, 565.
L. <strong>di</strong> Pace e R. Pannain 115<br />
Si segnalano, inoltre, forme miste che, pur manifestando tratti tipici<br />
delle sigle, mostrano aspetti che potrebbero farle rientrare nelle ulteriori<br />
categorie degli accorciamenti e delle parole macedonia. Ad esempio, Udeur<br />
(Unione dei democratici europei) che è, per la parte iniziale, collocabile nella<br />
categoria delle sigle (in cui per lo più confluiscono le forme ridotte dei<br />
nomi <strong>di</strong> partiti politici), manifesta nella seconda metà un processo <strong>di</strong><br />
accorciamento, -‐‑eur. Particolarmente problematica è la classificazione <strong>di</strong><br />
forme come Ascom (Associazione Commercianti), in cui la parzialità della<br />
riduzione concerne entrambi i lessemi sottostanti, ponendo la forma al<br />
confine tra sigle e parole macedonia. Graffi&Scalise (2002, 153) la<br />
classificano tra le “sigle sillabiche”, mentre collocano polfer tra le parole<br />
macedonia. In ogni caso quella <strong>di</strong> “sigla sillabica” è una sotto-‐‑<br />
categorizzazione insi<strong>di</strong>osa e non da tutti con<strong>di</strong>visa, <strong>di</strong> frequente applicata a<br />
forme in cui «appaiono porzioni <strong>di</strong> parole base maggiori <strong>di</strong> una lettera ma<br />
minori o maggiori <strong>di</strong> una sillaba» (Thornton 2004, 560).<br />
L’incertezza classificatoria, su cui ci si è già soffermati, emerge anche<br />
nella problematicità della collocazione <strong>di</strong> una forma come palasport (palazzo<br />
dello sport) che Thornton (2004, 561) inserisce nella categoria degli<br />
accorciamenti, laddove sarebbe forse più opportuno ricondurla a quella<br />
delle parole macedonia.<br />
La parziale sovrapposizione delle categorie si riscontra anche in alcuni<br />
usi metalinguistici. È il caso delle sigle usate dai generativisti, che possono<br />
essere lette anche nella modalità tipica delle ab<strong>brevi</strong>azioni, come<br />
<strong>di</strong>mostrato dall’oscillazione nell’uso dell’articolo. La cosa è tanto più<br />
sorprendente dal momento che le <strong>di</strong>verse occorrenze si registrano in uno<br />
stesso autore a breve <strong>di</strong>stanza:<br />
“Occupiamoci ora dell’altro oggetto sintattico contenuto in (79), il SN quell’uomo”<br />
(Graffi 2008, 75)<br />
“come complementi dei nomi e degli aggettivi in frasi corrispondenti a (12) e (13) si<br />
avrebbero degli SN, non degli SP» (ibidem, 81).<br />
Nella prima occorrenza la selezione dell’articolo in<strong>di</strong>zia una pronuncia<br />
per esteso, mentre, nella seconda, evidenzia una pronuncia come sigla<br />
/'ʹɛsse 'ʹɛnne/.
116<br />
Sigle e acronimi: <strong>di</strong>mensione grafica e statuto lessicale<br />
Infine, ad ulteriore conferma della sfumatezza delle categorie della<br />
riduzione si può menzionare il caso <strong>di</strong> tbc/TBC che è propriamente<br />
un’ab<strong>brevi</strong>azione del termine tubercolosi, ma viene percepito come sigla,<br />
circostanza che ha, tra l’altro, determinato l’impiego delle maiuscole. In De<br />
Mauro (2003) l’elemento è classificato, appunto, come sigla:<br />
tbc /tibbit'ʹtʃi/ s.m. e f.inv. CO, TS med., vet. [1961; propr. sigla <strong>di</strong><br />
tubercolosi] 1 s.f.inv. BU tubercolosi 2 s.m. e f.inv. malato <strong>di</strong><br />
tubercolosi, tubercolotico.<br />
TBC /tibbit'ʹtʃi/ s.m. e f.inv., var. → tbc.<br />
3. Focalizzazione su sigle e/o acronimi<br />
In questo contributo l’attenzione verrà focalizzata sulla fenomenologia<br />
relativa alle sigle: è proprio nel caso <strong>di</strong> queste entità che si può meglio<br />
cogliere il rapporto <strong>di</strong>namico tra scrittura e lingua. Le sigle si originano<br />
come fenomeno grafico in base alla duplice istanza <strong>di</strong> creare una forma, da<br />
una parte, economica, dall’altra, maggiormente capace <strong>di</strong> attrarre<br />
l’attenzione del lettore, attraverso la marcatezza delle maiuscole e della<br />
puntazione (non a caso, le sigle hanno un elevato grado <strong>di</strong> occorrenza nei<br />
titoli <strong>di</strong> articoli giornalistici). Successivamente, queste entità, proprio in<br />
virtù della loro salienza e della <strong>di</strong>mensione ridotta rispetto a quella del<br />
sintagma sottostante -‐‑ quin<strong>di</strong> già più vicina a quella <strong>di</strong> una “parola”-‐‑<br />
vanno a riversarsi nel parlato, dando l’avvio ad un processo <strong>di</strong> integrazione<br />
nel lessico della lingua, cui segue un rientro nella <strong>di</strong>mensione grafica in<br />
una veste mo<strong>di</strong>ficata che registra gli effetti <strong>di</strong> tale processo. Questo<br />
complesso <strong>di</strong>namismo bi-‐‑<strong>di</strong>rezionale non si manifesta, ad avviso <strong>di</strong> chi<br />
scrive, nelle altre tipologie della riduzione.<br />
Un’ulteriore motivazione a concentrarsi sulle sigle è costituita dal fatto<br />
che esse emergono da forme piene molto articolate, cosa che non avviene<br />
negli altri casi <strong>di</strong> riduzione, neppure in quello delle parole macedonia, cui<br />
sottostanno in genere non più <strong>di</strong> due parole. La complessità delle forme<br />
piene ha come risvolto una complessità e anche una varianza nella<br />
fenomenologia <strong>di</strong> questo tipo <strong>di</strong> riduzione.
L. <strong>di</strong> Pace e R. Pannain 117<br />
Infine, la creazione <strong>di</strong> sigle è senz’altro un processo particolarmente<br />
produttivo, andando a costituire una non trascurabile risorsa per la<br />
formazione <strong>di</strong> nuove parole.<br />
3.1. Tendenza alla lessicalizzazione<br />
Una fase cruciale nel complesso <strong>di</strong>namismo tra scrittura e lingua nel<br />
caso delle sigle/acronimi è costituita dall’innescarsi <strong>di</strong> un processo <strong>di</strong><br />
lessicalizzazione 9, tramite il quale queste entità, che per certi versi sono<br />
formazioni anomale, asistematiche, vanno ad acquisire uno statuto<br />
standard, <strong>di</strong>ventando parole a pieno titolo. Questa pulsione normalizzante<br />
può manifestarsi a valle come a monte del processo: da una parte, le sigle<br />
tendono nell’evoluzione linguistica ad acquisire lo status <strong>di</strong> parola,<br />
dall’altra, possono essere concepite nel loro stesso momento <strong>di</strong> fondazione<br />
come possibili parole.<br />
Nel primo caso si verifica un processo per cui ciò che è anomalo,<br />
immotivato tende a riacquistare motivazione, integrandosi nel sistema.<br />
Infatti, se le parole macedonia si conservano piuttosto trasparenti nella loro<br />
formazione, giacché, almeno in alcuni casi, è possibile riconoscerne gli<br />
elementi costitutivi che si presentano con una certa quantità <strong>di</strong> significante,<br />
le sigle, essendo fatte delle sole iniziali delle parole formanti il sintagma<br />
sottostante, sfuggono molto spesso alla consapevolezza del parlante che,<br />
per così <strong>di</strong>re, non è in grado <strong>di</strong> “etimologizzarle”, cioè <strong>di</strong> scioglierle 10.<br />
Questo è dovuto anche al fatto che molto spesso le sigle si originano in<br />
contesti settoriali e tecnici cosicché, sebbene possano conquistare una<br />
gran<strong>di</strong>ssima <strong>di</strong>ffusione, restano opache nella loro originaria significazione.<br />
Ciò è tanto più vero nei casi, molto frequenti, <strong>di</strong> sigle <strong>di</strong> origine alloglotta.<br />
Quanti italiani sono in grado <strong>di</strong> riportare la sigla Aids al sintagma<br />
sottostante (Acquired Immuno–Deficiency Syndrome)? Eppure tutti sono in<br />
grado <strong>di</strong> riconoscerne la designazione, che è assolutamente unitaria,<br />
piuttosto che la somma delle designazioni delle singole parole costituenti il<br />
sintagma. Ciò porta a considerare la sigla più che come un in<strong>di</strong>zio <strong>di</strong><br />
molteplici segni, come un segno compatto e unitario. Ecco che, laddove<br />
9 Su questo si veda, tra gli altri, López Rúa 2006, 677.<br />
10 Non è un caso che tra le sigle siano tutt’altro che rari i casi <strong>di</strong> omofonia, un fenomeno<br />
peraltro piuttosto ridotto nel resto del lessico <strong>di</strong> una lingua come l’italiano o l’inglese. A una<br />
stessa sigla possono s<strong>oggi</strong>acere più forme piene: la sequenza PC sta tanto per “personal<br />
computer” quanto per “politically correct”.
118<br />
Sigle e acronimi: <strong>di</strong>mensione grafica e statuto lessicale<br />
siano presenti più modalità <strong>di</strong> lettura (lettera per lettera/come parola), può<br />
accadere <strong>di</strong> assistere al prevalere e consolidarsi della pronuncia ortoepica:<br />
non più, o per lo meno non solo, /aj<strong>di</strong>'ʹɛsse/ ma piuttosto, /'ʹajds/, o /'ʹejds/<br />
per coloro che vogliono manifestare la consapevolezza dell’origine inglese.<br />
Anche a livello grafico si assiste all’alternanza tra AIDS, che conserva la<br />
forma canonica della sigla, e Aids/aids, che ha forma tipica <strong>di</strong> parola.<br />
D’altra parte, il <strong>di</strong>stacco dal sintagma sottostante, certamente più forte<br />
nei casi <strong>di</strong> sigle che sono <strong>di</strong> fatto dei prestiti, si riscontra agevolmente anche<br />
all’interno della stessa comunità linguistica nella quale si è generata la<br />
forma: un anglofono con cultura me<strong>di</strong>a non è in grado <strong>di</strong> sciogliere la sigla<br />
laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Ra<strong>di</strong>ation), anzi, non è<br />
nemmeno consapevole che si tratti <strong>di</strong> una sigla; per molti italiani l’Inps è<br />
un’entità molto chiara, anche per coloro che non sono in grado <strong>di</strong> leggere la<br />
sigla nelle sue componenti (Istituto nazionale della previdenza sociale) e che in<br />
molti casi attribuiranno alla p il valore <strong>di</strong> “pensione”, piuttosto che <strong>di</strong><br />
“previdenza”.<br />
Se, dunque, la sigla tende a <strong>di</strong>ventare parola è pur vero che, al polo<br />
opposto del processo, quello della genesi, essa già aspiri ad essere tale: in<br />
questa <strong>di</strong>rezione si verifica un allontanamento dal sintagma <strong>di</strong> base, allo<br />
scopo <strong>di</strong> un adeguamento fonologico e/o semantico ad una forma esistente<br />
o possibile <strong>di</strong> parola. Ciò spiega perché in alcune formazioni <strong>di</strong> sigle non<br />
vengano omesse le parole funzionali, che generalmente sono soppresse,<br />
come si verifica nel caso <strong>di</strong> AGESCI ( Associazione Guide e Scouts Cattolici<br />
Italiani), in cui la conservazione del connettivo e rende possibile una forma<br />
<strong>di</strong> parola italiana, e dà conto del perché si verifichino alcune inversioni<br />
dell’or<strong>di</strong>ne delle parole, come accade con l’acronimo RAD ( Regolamento<br />
<strong>di</strong>dattico d’ateneo) in cui il nesso consonantico [rd] sarebbe stato impossibile<br />
in inizio <strong>di</strong> parola.<br />
In altri casi, infine, gioca anche l’associazione semantica con una parola<br />
esistente, come nella formazione DICO ( Diritti e doveri delle persone<br />
stabilmente conviventi).<br />
Il fatto che le sigle/acronimi siano così fortemente attirati dal nucleo<br />
parola, determina un altro fenomeno, in cui si verifica un processo <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>rezionalità opposta: l’attribuzione dello statuto <strong>di</strong> sigla ad una parola,<br />
con conseguenti possibili e varie interpretazioni. In questi casi, si parla <strong>di</strong>
L. <strong>di</strong> Pace e R. Pannain 119<br />
“backronyns” 11 o “reverse acronyms” (in italiano “falsi acronimi”). Un<br />
esempio classico è quello dell’in<strong>di</strong>ce APGAR che misura alcuni parametri<br />
<strong>di</strong> vitalità e funzionamento delle attività del neonato. Apgar è il nome della<br />
dottoressa che lo ideò, ma è stato successivamente interpretato come<br />
acronimo <strong>di</strong> appearance, pulse, grimace, activity, respiration.<br />
La lessicalizzazione è dunque una tendenza consolidata nella storia<br />
delle sigle, confermata dalla presenza del processo contrario, e suggerita da<br />
numerosi in<strong>di</strong>zi che investono sia il piano squisitamente grafico, sia quello<br />
della resa orale, sia quello morfologico, che quello semantico.<br />
3.2 In<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> lessicalizzazione: grafia e pronuncia<br />
Alcune mo<strong>di</strong>ficazioni nella forma scritta delle sigle suggeriscono in<br />
modo chiaro l’instaurarsi del processo <strong>di</strong> spostamento verso l’entità<br />
“parola”; tra queste, è altamente in<strong>di</strong>ziale la sostituzione delle lettere<br />
maiuscole con le corrispondenti minuscole e la frequente cancellazione<br />
della puntazione che si accompagna al primo mutamento. Ecco dunque che<br />
la sigla C.T., che in modo palese ricorda come la C. e la T. siano le iniziali <strong>di</strong><br />
due parole (Commissario Tecnico), <strong>di</strong>venta CT, e con una deriva sempre più<br />
opacizzante ct 12.<br />
Questo processo si riconosce in numerose sigle come, ad esempio, D.J.<br />
→ DJ/ Dj / dj , T.G. → TG/ Tg /tg, C.D. → CD / Cd / cd , S.p.A. 13 → spa.<br />
Ma ancora più significativa è la tendenza a riscrivere le sigle<br />
pronunciate lettera per lettera con la sequenza dei nomi delle singole<br />
lettere, che vengono così a formare una parola del tutto nuova. È questo il<br />
caso <strong>di</strong> sigle come BR che dà vita alla parola Bierre/bierre 14, o PM che genera<br />
un sempre più frequente piemme 15. Un ulteriore tratto che sottolinea il<br />
11 Backronym è a sua volta una parola macedonia nata dalla fusione <strong>di</strong> backward e acronym.<br />
12 "ʺIl problema del movimento italiano non è il c.t. della Nazionale”<br />
(http://www.gazzetta.it/Sport_Vari/Rugby);<br />
“Sulle tracce <strong>di</strong> Prandelli: la fotostoria del nuovo ct azzurro”<br />
(http://sport.sky.it/sport/calcio_italiano/photogallery/2010/07).<br />
13 Nel caso <strong>di</strong> S.p.A. spa il venir meno della <strong>di</strong>stinzione tra parole funzionali e parole piene<br />
attraverso l’opposizione minuscola/maiuscola <strong>di</strong>mostra ulteriormente l’allontanamento dal<br />
sintagma <strong>di</strong> base.<br />
14 “Le Bierre lo hanno capito da un pezzo e si sono mobilitate.”<br />
(http://www.reggio24ore.com/Sezione.jsp).<br />
15 “… mi ero fatto l’idea <strong>di</strong> un piemme ven<strong>di</strong>cativo”.
120<br />
Sigle e acronimi: <strong>di</strong>mensione grafica e statuto lessicale<br />
<strong>di</strong>stacco dalla forma tipica <strong>di</strong> sigla è, oltre al processo appena illustrato,<br />
l’in<strong>di</strong>cazione dell’accento. La già citata sigla C.T. evolve in una nuova<br />
grafia, con tutto il corredo dei tratti tipici della parola, compreso l’accento:<br />
cittì 16. Similmente, TG <strong>di</strong>venta tigì (o tiggì) 17, TV genera tivvù / tivvì 18 .<br />
Questo tipo <strong>di</strong> riscrittura, che tiene conto della pronuncia, dà luogo a<br />
<strong>di</strong>verse soluzioni per le sigle <strong>di</strong> prestito, in quanto può riflettere le <strong>di</strong>verse<br />
pronunce, adattate e non. Nel primo caso assistiamo dunque ad un<br />
processo per il quale la grafia della sigla riflette il modo in cui questa viene<br />
pronunciata secondo le regole dell’italiano: PR 19 (public relations) viene<br />
riscritto come pi erre o pierre 20, LP (Long playing) dà vita a <strong>di</strong>verse forme<br />
come ellepi, ellepì 21, elleppì 22. La sigla KO (knock out), infine, genera molteplici<br />
grafie <strong>di</strong> parola che presentano gra<strong>di</strong> <strong>di</strong>versi <strong>di</strong> adattamento grafico, pur<br />
registrando, comunque, una pronuncia adattata: kappao 23, kappaò 24, e perfino<br />
cappaò 25.<br />
http://lecronache<strong>di</strong>fer<strong>di</strong>nandoterlizzi.blogspot.com/2010/03/ ).<br />
16 “…ultimo atto <strong>di</strong> un cittì che fino a quel momento aveva zittito tutti quanti come se avesse<br />
in tasca la formula magica” (http://lettera22punto0.wordpress.com/2010/06/26/).<br />
17 “…il promotore del tigì, che ha spiegato i temi trattati nell ultima settimana da giunta e<br />
consiglio regionali” (http://milano.repubblica.it/multime<strong>di</strong>a/home/11222263 ).<br />
18 “… le nuove solitu<strong>di</strong>ni contemporanee alimentate dallo schermo <strong>di</strong> una tivvù o un<br />
computer…”<br />
(http://napoli.repubblica.it/cronaca/2011/06/12/news/gli_attori_della_saga_twilight_in_un_alb<br />
ergo_<strong>di</strong>_casoria).<br />
19 A sottolineare l’ambiguità e quin<strong>di</strong> la potenziale omonimia delle sigle, c’è da notare che PR<br />
può essere anche sigla <strong>di</strong> un sintagma italiano che, a seconda dei contesti, starà per Procuratore<br />
della Repubblica o Piano Regolatore, o altro ancora.<br />
20 “per essere dei bravi pierre ci vogliono intraprendenza nel conoscere nuove persone e<br />
capacità <strong>di</strong> socializzare” (http://www.<strong>di</strong>ventapr.com/).<br />
21 “Ho appena comprato l’ellepì del Rocky Horror Picture Show, acquistato insieme a una<br />
meravigliosa doppia raccolta in vinile dei Clash<br />
(http://www.revolutionine.com/2009/10/04/rocky-‐‑horror-‐‑ellepi-‐‑show).<br />
22 “un gruppo <strong>di</strong> affezionati, sabato e domenica, prova a riba<strong>di</strong>re il culto per la lacca nera dei<br />
vecchi elleppì: si chiama Disco Days” (http://napoli.repubblica.it/dettaglio/articolo/1525567).<br />
23 “il tentativo mon<strong>di</strong>ale del fratello <strong>di</strong> Vincenzo, Giovanni Nar<strong>di</strong>ello, vittima <strong>di</strong> un terrificante<br />
kappao contro il tedesco Ottke”.<br />
(http://archiviostorico.corriere.it/1999/marzo/30/pugilato_finito_ko_co_10_9903301108.shtml ).<br />
24 “Roma kappaò a Pesaro. Siena, Milano e Biella in testa”<br />
(http://www.repubblica.it/sport/basket/2010/10/24/news/serie_a_seconda_giornata-‐‑8397182).<br />
25 “Magica Dinamo, Biella è cappaò”<br />
(http://www.unionesarda.it/Articoli/FotoGalleryDettaglio.aspx?pos=1&id=202464).
L. <strong>di</strong> Pace e R. Pannain 121<br />
Sempre all’interno della categoria dei prestiti, si registrano invece grafie<br />
che testimoniano una pronuncia non adattata, motivata da <strong>di</strong>screpanze<br />
fonico-‐‑grafiche tra le due lingue, come nel caso <strong>di</strong> DJ che viene riscritto<br />
come <strong>di</strong>gei 26 (oltre che come dee jay) o come nel caso del comunissimo OK 27,<br />
reso graficamente, oltre che come okay, forma inglese, anche come okkei 28 o,<br />
con un elevato grado <strong>di</strong> adattamento grafico, come occhei 29.<br />
Se, dunque, tutte queste riscritture testimoniano della tendenza alla<br />
lessicalizzazione, anche alcuni fenomeni <strong>di</strong> pronuncia ci restituiscono chiari<br />
in<strong>di</strong>zi in questa <strong>di</strong>rezione. Va sottolineato come anche le sigle che si<br />
pronunciano lettera per lettera (CNR, DC, TG) generino in realtà una<br />
pronuncia <strong>di</strong> parola, confermata dalla presenza <strong>di</strong> un accento unico30. Una<br />
conferma <strong>di</strong> tale processo ci viene dalla resa fonica <strong>di</strong> una sigla come CGIL<br />
/tʃiddʒi'ʹɛlle/, con cancellazione della pronuncia della I, o da altri fenomeni<br />
<strong>di</strong> coarticolazione presenti ad es. nella pronuncia <strong>di</strong> INPS /'ʹimps/, con resa<br />
labiale della nasale.<br />
Infine, si possono registrare anche casi in cui la pronuncia come parola<br />
si realizza come variante, molto connotata quanto a registro<br />
sociolinguistico, <strong>di</strong> sigle per lo più pronunciate lettera per lettera, come per<br />
O.K. / OK / Ok /ok pronunciato /'ʹɔk/.<br />
3.3 In<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> lessicalizzazione: morfologia e sintassi<br />
La deriva delle sigle in <strong>di</strong>rezione della con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> “parola” si coglie,<br />
con ancora maggiore evidenza, nei processi derivativi che assumono la<br />
sigla come lessema <strong>di</strong> base. Il fenomeno è piuttosto esteso e riscontrabile in<br />
26 “Da Colorado in esclusiva per TvBlog, Digei Angelo: "ʺIo come Roberto Balle? Ma se sono<br />
negato per la danza” (http://www.tvblog.it/post/15996).<br />
27 Come sostenuto nel GRADIT e nel vocabolario TRECCANI, quasi sicuramente sigla <strong>di</strong> Old<br />
Kinderhook, nome <strong>di</strong> un comitato elettorale costituito a New York nel 1840 per la rielezione del<br />
presidente M. van Buren soprannominato il "ʺvecchio Kinderhook"ʺ.<br />
28 “Lo sporco okkei ai Russi in Cecenia” (http://qn.quoti<strong>di</strong>ano.net/1999/11/06/306744).<br />
29 “Occhei sento già la febbre del successo ;-‐‑) Ottima idea …”<br />
(http://scorzadarancia.blogspot.com/2010/06).<br />
30 Questa caratteristica delle sigle è stata notata già da tempo, ad es. da Lepschy 1981: 73 che<br />
riflette sulla pronuncia unitaria della sigla BR /bi’ɛrre/.
122<br />
Sigle e acronimi: <strong>di</strong>mensione grafica e statuto lessicale<br />
forme sia suffissate che prefissate, che si originano da sigle pronunciate<br />
lettera per lettera o come parola:<br />
DS →<strong>di</strong>esse → <strong>di</strong>essino 31 ; BR → bierre → bierrista 32 ; laser 33 →laserista 34 ; IVA → iva →<br />
ivato 35 ; OK → okkei →okkeizzare 36 ; DC →<strong>di</strong>ccì →post-‐‑<strong>di</strong>ccì 37 ; PM → piemme →ex-‐‑<br />
piemme 38 ; AIDS / aids →pre-‐‑AIDS 39 .<br />
Si verificano anche casi <strong>di</strong> composizione, come nella formazione tivvù-‐‑<br />
<strong>di</strong>pendenti, in cui la sigla lessicalizzata e quin<strong>di</strong> rigrafizzata va a collocarsi<br />
in posizione <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficatore 40.<br />
Tra i composti si segnala ANLAIDS/Anlaids, in cui risulta<br />
particolarmente evidente il trattamento della forma AIDS come parola.<br />
Infatti, sebbene inserita in un’ulteriore sigla, Aids conserva la propria<br />
compattezza, anche a <strong>di</strong>spetto della consapevolezza del sintagma<br />
sottostante nel contesto settoriale in cui si è originata la forma composta. Si<br />
veda come la sigla composta viene sciolta nel sito ufficiale<br />
dell’associazione:<br />
Associazione Nazionale per la Lotta contro l'ʹAIDS, promuove stu<strong>di</strong> e ricerche<br />
sull'ʹAIDS attraverso ban<strong>di</strong> per borse <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o 41.<br />
31 “Il <strong>di</strong>essino è educato, rispettoso, solitamente onesto e leale”<br />
(http://www.leftisright.it/blog/al-‐‑<strong>di</strong>essino-‐‑alla-‐‑<strong>di</strong>essina/).<br />
32 “Chissà se uscirà dall archivio <strong>di</strong> Licio Gelli, che raccoglieva anche il volantino riven<strong>di</strong>cativo<br />
del delitto bierrista” (www.ilvelino.it/articolo.php?Id=984823).<br />
33 Si precisa che lo statuto <strong>di</strong> sigla della forma laser nella lingua italiana è probabilmente<br />
limitato ad ambiti settoriali, mentre il parlante me<strong>di</strong>o la percepisce come parola.<br />
34 “La filiale <strong>di</strong> Firenze Mosse dell agenzia per il lavoro Gi Group spa cerca, per azienda<br />
metalmeccanica, un saldatore-‐‑laserista” (http://www.njobs.it/lavoro-‐‑laserista.html).<br />
35 “io vorrei mettere il prezzo non ivato”<br />
(http://www.prestashop.com/forums/viewthread/8130/).<br />
36 “Non è più semplice okkeizzare un dossier piuttosto che chiudere una pratica?”<br />
(http://www.rosalio.it/2007/11/02/). Per questa formazione verbale si registra un parallelo<br />
nell’inglese to OK (“The Governor recently OK’d the execution of a man…”, SOED).<br />
37 “Logicamente dall’ala post-‐‑<strong>di</strong>ccì e dai Modem <strong>di</strong> Fioroni e Veltroni arriva un netto no a<br />
questo progetto”(http://www.rinascita.eu/index.php?action=news&id).<br />
38 “Il libro dell’ex-‐‑piemme Raffaele Cantone”<br />
(http://lecronache<strong>di</strong>fer<strong>di</strong>nandoterlizzi.blogspot.com/2010/03)<br />
39 “Lo sta<strong>di</strong>o <strong>di</strong> sieropositività corrisponde al periodo, più o meno lungo, della latenza clinica,<br />
della fase pre-‐‑AIDS e della fase AIDS” (http://www.me<strong>di</strong>cline.it/malattie-‐‑infettive/aids.html).<br />
40 “Bambini tivvù-‐‑<strong>di</strong>pendenti. Passano più tempo davanti al piccolo schermo che sui banchi”<br />
(http://staibene.libero.it/articolo_bambinitelevisionepsicologia_212599__1.html?refresh_cens).<br />
41 http://www.freeonline.org/sitogratis/anlaids-‐‑it.html
L. <strong>di</strong> Pace e R. Pannain 123<br />
Inoltre, nel processo <strong>di</strong> lessicalizzazione, la sigla si sgancia dalla<br />
categoria grammaticale della testa del sintagma sottostante e può acquisire<br />
nuove funzioni grammaticali, dando vita a processi paragonabili alla<br />
conversione.<br />
Il fenomeno è vistoso nel caso <strong>di</strong> sigle alloglotte <strong>di</strong> ampia <strong>di</strong>ffusione:<br />
ko aggettivo / nome / avverbio: il pugile è ko (agg.) / Il pugile è stato<br />
atterrato per ko (nome) / Questa serata mi ha messo ko (avv.)<br />
ok esclamazione / avverbio / aggettivo / nome: Ok! Prendo questo<br />
(escl.) / È andato tutto ok? / La prof è abbastanza ok (agg.) / Ha dato il<br />
suo ok (nome)<br />
vip (nome / aggettivo): Lele Mora è un vip (nome) / Quello è un locale vip<br />
(agg.)<br />
Ma si danno anche casi <strong>di</strong> sigle italiane:<br />
tivvù nome comune / aggettivo: davanti alla tivvù (nome com.) / la <strong>di</strong>retta<br />
tivvù (agg.)<br />
Pd nome proprio / aggettivo: Il Pd è all’opposizione (nome pr.) / Il<br />
senatore Pd ha votato contro (agg.).<br />
3.4 In<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> lessicalizzazione: semantica<br />
Le sigle, in particolare quelle <strong>di</strong> ampia <strong>di</strong>ffusione, sono soggette, anche<br />
sul piano del significato, a fenomeni e processi che si verificano<br />
comunemente nelle altre componenti del lessico. Infatti, il significato <strong>di</strong> una<br />
sigla può presentare molteplici “sfaccettature” 42:<br />
1. L’Inps non è la stessa cosa dell’Inpdap<br />
42 Cfr. Croft&Cruse 2004, 116. Cruse, nel cap. 4, de<strong>di</strong>cato a una puntualizzazione sulla<br />
semantica in prospettiva cognitivista, definisce le “sfaccettature” (facets) come unità <strong>di</strong> senso<br />
che costituiscono componenti <strong>di</strong>stinguibili <strong>di</strong> un tutto globale, le quali, sebbene mostrino un<br />
significativo grado <strong>di</strong> autonomia, non sono generalmente ritenute rappresentare veri esempi<br />
<strong>di</strong> polisemia.
124<br />
Sigle e acronimi: <strong>di</strong>mensione grafica e statuto lessicale<br />
2. All’Inps mi hanno detto che devo portargli la ricevuta della<br />
raccomandata.<br />
3. Abita accanto all’Inps<br />
Nei tre enunciati la sigla ha <strong>di</strong>versi referenti: l’ente / uno specifico<br />
ufficio e il personale che vi lavora / l’e<strong>di</strong>ficio che ospita gli uffici dell’ente.<br />
Ma le sigle possono essere soggette anche a veri e propri fenomeni <strong>di</strong><br />
polisemia e, come altrove, i processi <strong>di</strong> estensione semantica sono<br />
principalmente a carattere metaforico e metonimico.<br />
Si consideri il caso della sigla DNA, che, oltre al valore <strong>di</strong> partenza, ha<br />
acquisito in italiano anche quello <strong>di</strong> ‘matrice ideologica, politica e<br />
culturale’: Il dna della sinistra ra<strong>di</strong>cale 43. Un’altra sigla <strong>di</strong> origine alloglotta,<br />
KO, ha acquisito, in particolare nelle funzioni avverbiale e aggettivale (v.<br />
sopra), attraverso un insieme <strong>di</strong> associazioni metonimiche e metaforiche, il<br />
valore <strong>di</strong> ‘moralmente o fisicamente prostrato’, es. Stasera mi sento ko.<br />
Il fenomeno interessa, naturalmente, anche sigle originatesi in italiano.<br />
Ad es. il valore <strong>di</strong> DOC si è esteso a significare ‘autentico, genuino’, anche<br />
al <strong>di</strong> fuori dell’ambito agro-‐‑alimentare, come in Salvatore è un napoletano<br />
doc.<br />
Puramente metonimiche e, <strong>di</strong> conseguenza, meno percepibili per il<br />
parlante, sono le estensioni rappresentate nei seguenti due esempi:<br />
Io l’inps non ce l’ho (inps in quanto ‘prestazione previdenziale’)<br />
Gli ufo li immagino con la testa enorme e il corpo piccolo” (ufo in quanto<br />
‘essere extra-‐‑terrestre, alieno’)<br />
I fenomeni semantici appena menzionati sono possibili nella misura in<br />
cui le sigle in questione, come molte altre, si sono sganciate dal sintagma<br />
pieno sottostante, che, proprio in quanto sintagma, ha una referenza più<br />
ristretta, alla cui delimitazione concorrono un insieme <strong>di</strong> unità significanti.<br />
Negli esempi sopra riportati le sigle mostrano, quin<strong>di</strong>, <strong>di</strong> aver acquisito la<br />
relativa opacità del lessema in<strong>di</strong>viduale, che, essendo sostanzialmente<br />
immotivato nella forma, si presta a designare una pluralità <strong>di</strong> referenti, più<br />
o meno <strong>di</strong>rettamente connessi.<br />
43 Esempio tratto da De Mauro 2003.
4. Osservazioni conclusive<br />
L. <strong>di</strong> Pace e R. Pannain 125<br />
Come la coniazione <strong>di</strong> nuove parole, la creazione delle sigle (insieme ad<br />
altri fenomeni <strong>di</strong> riduzione) rappresenta uno strumento <strong>di</strong> formazione <strong>di</strong><br />
nuovi simboli linguistici che non si avvale dei meccanismi morfologici<br />
della lingua: tanto i conii quanto le forme ridotte vengono comunemente<br />
fatti rientrare nella classe delle formazioni non-‐‑morfologiche (López Rúa<br />
2006, 675; Fandrych 2008, 72).<br />
Si può affermare, infatti, che le sigle tendano a configurarsi come parole<br />
nuove piuttosto che come varianti <strong>di</strong> parole esistenti (un caso estremo è<br />
quello dell’ inglese Ok, apparentemente privo <strong>di</strong> un antecedente). Queste<br />
nuove formazioni, nel tempo, vanno a costituirsi in entità segniche<br />
compatte e unitarie con un rapporto arbitrario significato/significante:<br />
normalmente il parlante non conosce l’etimologia delle sigle-‐‑parole, pur<br />
conoscendone il referente. Un processo <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione opposta si verifica nel<br />
caso <strong>di</strong> forme lessicali (“backronyms” nella terminologia anglosassone) a<br />
cui viene attribuito a posteriori lo statuto <strong>di</strong> sigla, determinando la nascita<br />
<strong>di</strong> una “falsa etimologia”.<br />
Alla iniziale istanza <strong>di</strong> <strong>brevi</strong>tà ed economicità, che si esplica sul piano<br />
grafico, si contrappone, sul piano linguistico, una spinta normalizzante che<br />
riconduce la sigla verso una <strong>di</strong>mensionalità tipica <strong>di</strong> parola, determinando<br />
passaggi che possono comportare ricadute grafiche (come TV > tivvù, PM ><br />
piemme, LP > elleppì). Un ulteriore sganciamento dall’iniziale spinta alla<br />
riduzione si riconosce in fenomeni morfologici <strong>di</strong> tipo accrescitivo, quali<br />
l’affissazione (ivato) e la composizione (tivvù-‐‑<strong>di</strong>pendente). Infine,<br />
l’incremento si verifica anche, sul piano sintattico, con fenomeni <strong>di</strong><br />
conversione che aggiungono nuovi ruoli grammaticali rispetto a quello <strong>di</strong><br />
origine e, sul piano semantico, con un ampliamento del ventaglio<br />
denotativo, che conferisce all’ex-‐‑sigla (attraverso estensioni metaforiche e<br />
metonimiche) la complessità semantica che tipicamente caratterizza le<br />
parole <strong>di</strong> una lingua.<br />
Lucia <strong>di</strong> Pace e Rossella Pannain<br />
l<strong>di</strong>pace@unior.it<br />
rpannain@unior.it
126<br />
Bibliografia<br />
Sigle e acronimi: <strong>di</strong>mensione grafica e statuto lessicale<br />
Algeo 1975<br />
Algeo John, “The acronym and its congeners”, in A. Makkai, V. Makkai<br />
(eds.), The First Lacus Forum 1974, Columbia, Hornbeam Press, 217-‐‑234.<br />
Bauer 1983<br />
Bauer Laurie, English word formation. Cambridge, Cambridge University<br />
Press.<br />
Beccaria 1996<br />
Beccaria Gian Luigi (<strong>di</strong>retto da), Dizionario <strong>di</strong> linguistica e <strong>di</strong> filologia,<br />
metrica, retorica. Torino, Einau<strong>di</strong>.<br />
Bussmann 1996<br />
Bussmann Hadumod, Routledge <strong>di</strong>ctionary of language and linguistics,<br />
translated and e<strong>di</strong>ted by G. Trauth, K. Kazzari, London and New York,<br />
Routledge.<br />
Croft&Cruse 2004<br />
Croft William, Cruse D. Allan, Cognitive linguistics, Cambridge,<br />
Cambridge University Press.<br />
Crystal 2006<br />
Crystal David, A <strong>di</strong>ctionary of linguistics & phonetics, V ed., Oxford,<br />
Blackwell.<br />
De Mauro 2003<br />
De Mauro Tullio, “Introduzione”, in Grande <strong>di</strong>zionario italiano dell'ʹuso,<br />
Torino, UTET.<br />
Dressler et al. 1987<br />
Dressler Wolfgang U. et al., Leitmotifs in natural morphology, Amsterdam,<br />
Benjamins.<br />
Fandrych 2008
L. <strong>di</strong> Pace e R. Pannain 127<br />
Fandrych Ingrid, “Pagad, chillax and jozi: a multi-‐‑level approach to<br />
acronyms, blends, and clippings”, Nawa Journal of Language and<br />
Communication 2/2, 71-‐‑88.<br />
Graffi 2008<br />
Graffi Giorgio, Che cos’è la grammatica generativa, Roma, Carocci.<br />
Graffi&Scalise 2002<br />
Graffi Giorgio, Scalise Sergio, Le lingue e il linguaggio. Introduzione alla<br />
linguistica, Bologna, il Mulino.<br />
Kriedler 2000<br />
Kreidler C.W., “Clipping and acronymy”, in G. Booij, C. Lehmann, J.<br />
Mugdan et al. (ed. by), Morphologie–morphology. An international handbook<br />
on inflection and word-‐‑formation, Vol. 1, Berlin-‐‑New York, Walter de<br />
Gruyter, 956-‐‑963.<br />
Lepschy 1981<br />
Lepschy Giulio C., La lingua italiana, Milano, Bompiani.<br />
López Rúa 2006<br />
López Rúa P., “Nonmorphological word formation”, in K. Brown (ed.<br />
by), The encyclope<strong>di</strong>a of language and linguistics, II ed., Amsterdam,<br />
Boston, MA [etc.], Elsevier, 675-‐‑679.<br />
Mayerthaler 1981<br />
Mayerthaler W., Morphologische Natürlichkeit, Wiesbaden, Athenaeum.<br />
Thornton 2004<br />
Thornton Anna Maria, “Riduzione”, in M. Grossman, F. Rainer (a cura<br />
<strong>di</strong>), La formazione delle parole in italiano, Tubingen, Niemeyer, 556-‐‑567.<br />
Dizionari<br />
Devoto-‐‑Oli 1987: Nuovo vocabolario illustrato della lingua italiana, <strong>di</strong> Giacomo<br />
Devoto e Gian Carlo Oli; e<strong>di</strong>zione a cura <strong>di</strong> Gian Carlo Oli, Lorenzo<br />
Magini, Milano, Selezione Reader'ʹs Digest.
128<br />
Sigle e acronimi: <strong>di</strong>mensione grafica e statuto lessicale<br />
DISC 1997: Disc. Dizionario italiano Sabatini-‐‑Coletti, Firenze, Giunti.<br />
Gabrielli 2011: Grande <strong>di</strong>zionario italiano Aldo Gabrielli, Milano, Hoepli.<br />
GRADIT 2003: Grande <strong>di</strong>zionario italiano dell’uso, ideato e <strong>di</strong>retto da Tullio<br />
De Mauro, Torino, UTET.<br />
Sabatini-‐‑Coletti 2006: Il Sabatini-‐‑Coletti: Dizionario della lingua italiana,<br />
Milano, Rizzoli Larousse.<br />
SOED 2007: Shorter Oxford English <strong>di</strong>ctionary, VI ed., Oxford, Oxford<br />
University Press.<br />
Treccani 2008: Il vocabolario Treccani, Roma, Istituto dell'ʹEnciclope<strong>di</strong>a<br />
Italiana.<br />
Zingarelli 2006: Zingarelli, N., Vocabolario della lingua italiana, Bologna,<br />
Zanichelli (con CD-‐‑ROM).
Abstract<br />
Simboli e scrittura delle sperimentazioni scientifiche: la chimica<br />
Roberto Reali<br />
Nel percorso, più o meno accidentato, della storia della scienza, un posto che <strong>oggi</strong><br />
nessuno potrebbe negare appartenergli <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto riguarda la chimica. La strada che<br />
conduce però alla costruzione <strong>di</strong> una propria metodologia scientifica ha una vita<br />
abbastanza recente. E questo paradosso <strong>di</strong> scienza antichissima -‐‑ i cui primi<br />
esperimenti risalgono all’antico Egitto -‐‑ ma giovanissima nella messa a punto del<br />
proprio statuto <strong>di</strong>sciplinare ci permette <strong>di</strong> avere un osservatorio privilegiato <strong>di</strong><br />
come i linguaggi tecnici legati alle tra<strong>di</strong>zioni scientifiche siano sopravvissuti anche<br />
ai nostri tempi.<br />
Parole chiave: chimica, alchimia, storia della scienza, simboli chimici<br />
During the long and intricate history of science, a special place belongs to<br />
chemistry. But the path lea<strong>di</strong>ng to the construction of a scientific methodology in<br />
chemistry is rather early. This paradox of an old science -‐‑ whose early experiments<br />
date back to ancient Egypt -‐‑ but very young as to the development of its<br />
<strong>di</strong>sciplinary statute, gives us an advantageous point of view with regard to the<br />
ways technical languages associated with scientific tra<strong>di</strong>tions have survived to our<br />
times.<br />
Keywords: chemistry, alchemy, history of science, chemical symbols<br />
Premessa<br />
Il primo a intuire una teoria quantitativa degli elementi chimici fu,<br />
com’è noto, Antoine Laurent de Lavoisier che non aveva alcun titolo <strong>di</strong><br />
chimico: era considerato infatti un botanico, un naturalista, un economista<br />
ed anche un Fermier Général, sorta <strong>di</strong> concessionario per la riscossione delle<br />
imposte reali, carica a cui giunse a 26 anni e che lo arricchì e lo rese famoso<br />
ai tempi <strong>di</strong> Luigi XV. La sua formazione <strong>di</strong> giurista e <strong>di</strong> appassionato<br />
“misuratore” lo portò a creare il sistema metrico decimale e ad estenderlo<br />
in tutto il territorio francese prima <strong>di</strong> essere ghigliottinato, nel 1794, dai<br />
giacobini all’età <strong>di</strong> 51 anni. L’intuizione centrale <strong>di</strong> Lavoisier fu quella <strong>di</strong>
130<br />
Simboli e scrittura delle sperimentazioni scientifiche: la chimica<br />
applicare il sistema dei pesi e delle misure agli elementi che venivano via<br />
via combinati per la produzione <strong>di</strong> composti chimici stilando così un elenco<br />
<strong>di</strong> elementi “primi” che non potevano essere ulteriormente ridotti:<br />
ossigeno, azoto, idrogeno, fosforo, mercurio, zinco, zolfo ed anche luce e<br />
calorico che lui credeva fossero sostanze materiali e in realtà<br />
rappresentavano l’energia necessaria alla produzione <strong>di</strong> qualunque<br />
reazione chimica.<br />
L’idea <strong>di</strong> poter misurare e combinare i vari elementi secondo pesi<br />
determinati si ispira naturalmente alle in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> metodo galileiane<br />
esposte già nel XVII secolo. Galileo si incammina cioè verso la ridefinizione<br />
della scienza come strumento principe della conoscenza del mondo fisico<br />
avendo chiaro un modello (quello copernicano) e un metodo (quello<br />
matematico) i quali dovevano essere verificati, o, come si <strong>di</strong>rebbe <strong>oggi</strong>,<br />
“falsificati” dai dati dell’esperienza. Tale metodo crea il tratto <strong>di</strong>stintivo per<br />
la conoscenza della natura dalle altre forme del sapere. Galileo esprime<br />
tutto ciò nella famosa pagina del Saggiatore: “Parmi, oltre a ciò, <strong>di</strong> scorgere<br />
nel Sarsi ferma credenza, che nel filosofare sia necessario app<strong>oggi</strong>arsi<br />
all’opinioni <strong>di</strong> qualche celebre autore, sì che la mente nostra, quando non si<br />
maritasse col <strong>di</strong>scorso <strong>di</strong> un altro, ne dovesse in tutto rimanere sterile ed<br />
infeconda; e forse stima che la filosofia sia un libro e una fantasia d’un<br />
uomo, come l’Iliade e l’Orlando Furioso, libri né quali la meno importante<br />
cosa è che quello che vi è scritto sia vero. La filosofia è scritta in questo<br />
gran<strong>di</strong>ssimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi (io<br />
<strong>di</strong>co l’universo), ma non si può intendere se prima non s’impara a intender<br />
la lingua, e conoscer i caratteri ne’quali è scritto. Egli è scritto in lingua<br />
matematica e i caratteri sono triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche,<br />
senza i quali mezzi è impossibile intenderne umanamente parola; senza<br />
questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto.” 1<br />
L’affermazione su cui richiamare l’attenzione è quella relativa alla<br />
tra<strong>di</strong>zione su cui lo scienziato fiorentino ironizza e raffigura attraverso la<br />
polemica con il gesuita Orazio Grassi, il Sarsi del trattato, consapevole<br />
ormai della scoperta <strong>di</strong> un metodo che si <strong>di</strong>stingue ra<strong>di</strong>calmente da quello<br />
sinora tenuto nelle osservazioni naturali. L’affermazione <strong>di</strong> Galileo è<br />
realmente rivoluzionaria poiché la lingua formata da figure geometriche e<br />
cerchi sinora si era app<strong>oggi</strong>ata ad una conoscenza tra<strong>di</strong>zionale e solo con la<br />
metodologia sperimentale trova il suo vero senso interpretando i fenomeni<br />
1 Galileo Galilei, 121. La sottolineatura è nostra.
R. Reali 131<br />
del mondo naturale. Le osservazioni astronomiche e le ricerche sul<br />
movimento e la quiete dei corpi trovano così un’applicazione sperimentale<br />
imme<strong>di</strong>ata nelle leggi sulla caduta dei gravi, nella scoperta delle macchie<br />
solari e nel calcolo delle orbite dei pianeti me<strong>di</strong>cei per ricordare i più<br />
importanti ritrovamenti dello scienziato pisano. E il loro linguaggio è<br />
quello dell’algebra e della geometria perfettamente conosciute dalla<br />
tra<strong>di</strong>zione culturale precedente.<br />
Non così la chimica che non è scienza “<strong>di</strong> osservazione” ma <strong>di</strong><br />
“estrazione” e <strong>di</strong> “combinazione”. Il lavoro chimico compiuto sino a quel<br />
momento non aveva nella sperimentazione della regolarità del movimento<br />
dei corpi celesti una percezione imme<strong>di</strong>ata dei suoi fenomeni e la strada<br />
per giungere ad una sua autonomia <strong>di</strong>sciplinare e scientifica dovrà farsi<br />
largo ancora tra molteplici e <strong>di</strong>fferenti <strong>di</strong>scipline. I chimici non sono<br />
autonomamente <strong>di</strong>stinti, almeno sino al XVIII secolo, dai farmacisti, dai<br />
me<strong>di</strong>ci, dai naturalisti e, ovviamente, dai loro cugini prossimi: gli<br />
alchimisti.<br />
La carta d’identità della chimica moderna inizia il suo cammino con<br />
Lavoisier ma dovrà attendere ancora un secolo almeno per avere chiaro il<br />
rapporto quantitativo corretto tra la sequenza e le modalità <strong>di</strong><br />
combinazione degli elementi che verrà formulato dal chimico russo<br />
Mendeleev: “il sistema perio<strong>di</strong>co degli elementi, come è noto, raccoglie in<br />
maniera strutturata l’insieme degli elementi chimici considerati come<br />
atomi, a seconda delle loro proprietà e or<strong>di</strong>nati secondo una grandezza ad<br />
essi caratteristica e <strong>di</strong>stintiva. Per poter realizzare tale sistema era stato<br />
necessario <strong>di</strong>sporre innanzitutto dei <strong>di</strong>versi elementi allo stato isolato,<br />
puro, determinandone le proprietà chimiche e fisiche caratteristiche.” 2<br />
Questa sintesi tra metodo quantitativo e struttura primaria degli<br />
elementi contiene in sè la grande possibilità <strong>di</strong> prevedere con regolarità<br />
ulteriori elementi non ancora scoperti che però sono gli occupanti dei<br />
successivi legami atomici posti nella sequenza. “La chimica – afferma<br />
Mendeleev – ha trovato una risposta alla questione delle cause delle<br />
moltitu<strong>di</strong>ni; e pur mantenendo la concezione <strong>di</strong> molti elementi, tutti<br />
soggetti alla <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> una legge generale, offre una via d’uscita dal<br />
Nirvana indu – cioè l’assorbimento nell’universale – sostituendolo con<br />
2 Di Meo 2009, 317.
132<br />
Simboli e scrittura delle sperimentazioni scientifiche: la chimica<br />
l’in<strong>di</strong>vidualizzato.” 3 Ad una tale formidabile scoperta bisogna però<br />
apporre una data piuttosto recente, il 1869, in cui il chimico russo presentò<br />
la sua relazione L'ʹinter<strong>di</strong>pendenza fra le proprietà dei pesi atomici degli elementi<br />
alla Società Chimica Russa e <strong>di</strong>ede vita a quella che <strong>oggi</strong> noi conosciamo<br />
come Tavola Perio<strong>di</strong>ca degli elementi.<br />
Tavola perio<strong>di</strong>ca degli elementi<br />
Il linguaggio <strong>di</strong> questa tavola è, per gli specialisti ma anche per qualche<br />
studente <strong>di</strong> liceo, facilmente comprensibile: ogni singolo elemento, a<br />
secondo della sua posizione nell’insieme, presenta un affinità <strong>di</strong> struttura<br />
per quelli <strong>di</strong>stribuiti in ogni colonna (metalli, metallo-‐‑alcalini, <strong>di</strong><br />
transizione etc.) mentre la crescita del numero atomico, rappresentata dalla<br />
sequenza per righe, ci riporta invece ad una regolarità del numero <strong>di</strong><br />
elettroni esterni per ogni elemento. Non entrando in spiegazioni troppo<br />
specialistiche possiamo <strong>di</strong>re che la tavola perio<strong>di</strong>ca fornisce il ritmo degli<br />
elementi partendo da una legge quantitativa unitaria (la crescita del<br />
numero atomico) sino a poter prevedere ulteriori caselle che potranno via<br />
via essere inserite nel quadro generale. La tavola stessa è quin<strong>di</strong> lo schema<br />
logico entro cui i singoli elementi contrassegnati dalle prime lettere latine<br />
trovano un or<strong>di</strong>ne che imme<strong>di</strong>atamente richiama la sua maggiore o minore<br />
3 Mendeleev, in Di Meo, ibidem.
R. Reali 133<br />
reattività con gli altri elementi della tavola (se posti a sinistra o a destra<br />
dello schema).<br />
La semplicità <strong>di</strong> questa rappresentazione fa dunque vendetta <strong>di</strong> una<br />
ricerca durata secoli in cui gli uomini tentarono <strong>di</strong> comprendere come fosse<br />
possibile che alcuni prodotti reagivano a contatto con alcuni elementi e non<br />
con altri. Vi erano, nei secoli precedenti questa semplice formulazione,<br />
biblioteche intere <strong>di</strong> esperienze pratiche a cui mancava la fondazione del<br />
metodo e a cui mancava la possibilità <strong>di</strong> chiarire e costruire la ripetibilità<br />
dell’esperimento nelle con<strong>di</strong>zioni predeterminate dallo sperimentatore e<br />
quin<strong>di</strong> rientrare a pieno <strong>di</strong>ritto nello statuto delle scienze elaborato da<br />
Galileo tre secoli prima.<br />
Non è un caso che il progresso scientifico e tecnologico nella seconda<br />
metà del XIX secolo conosce, dalla scoperta degli elementi chimici e della<br />
loro combinazione, uno slancio straor<strong>di</strong>nario che porterà alla crescita<br />
industriale e alla produzione <strong>di</strong> materiali non esistenti in natura (<strong>di</strong> sintesi)<br />
oltre che la possibilità <strong>di</strong> utilizzo <strong>di</strong> componenti naturali per creare nuove<br />
opportunità <strong>di</strong> utilizzo (si pensi, ad esempio, alla <strong>di</strong>stillazione del petrolio<br />
o alla creazione <strong>di</strong> farmaci come l’aspirina).<br />
L’esperienza chimica<br />
Ma quale è alla fine, l’esperienza concreta che il chimico fa<br />
quoti<strong>di</strong>anamente? Per rispondere a questa domanda pren<strong>di</strong>amo in prestito<br />
le parole <strong>di</strong> uno scrittore e chimico italiano: “Distillare è bello. Prima <strong>di</strong><br />
tutto perché è un mestiere lento, filosofico e silenzioso, che ti occupa ma ti<br />
lascia tempo <strong>di</strong> pensare ad altro, un po’ come l’andare in bicicletta. Poi<br />
perché comporta una metamorfosi: da liquido a vapore (invisibile), e da<br />
questo nuovamente a liquido; ma in questo doppio cammino, all’insù e<br />
all’ingiù. Si raggiunge la purezza, con<strong>di</strong>zione ambigua ed affascinante, che<br />
parte dalla chimica ed arriva molto lontano.” 4<br />
Il chimico <strong>di</strong>stilla, combina, manipola elementi naturali, non esistendo<br />
mai in natura quelli descritti nella Tavola Perio<strong>di</strong>ca. Non esiste, in realtà, il<br />
Potassio ma ora posso combinare tutti gli elementi naturali per ottenere<br />
composti in cui la sua percentuale sia prevalente, misurandone così con<br />
4 Levi 1979, 60, voce Potassio.
134<br />
Simboli e scrittura delle sperimentazioni scientifiche: la chimica<br />
precisione la quantità e ricombinandola con altri elementi per produrre<br />
nuovi composti o nuovi materiali.<br />
Questa esperienza <strong>di</strong> lavoro, descritta da Primo Levi nel passo citato,<br />
non è però molto <strong>di</strong>versa dai farmacisti, naturalisti e alchimisti che si sono<br />
industriati per secoli a cercare <strong>di</strong> ricavare qualcosa dai prodotti presenti in<br />
natura. Possiamo quin<strong>di</strong> ipotizzare che anche la modalità <strong>di</strong> comunicare le<br />
loro esperienze che si venivano elaborando nel corso dei secoli sia stata<br />
molto <strong>di</strong>fferente? E se non vi è questa <strong>di</strong>stanza, quanto la moderna<br />
costruzione del linguaggio chimico appartiene nelle intenzioni anche a<br />
quella tra<strong>di</strong>zione che appariva agli scienziati “trionfanti” del XIX e del XX<br />
secolo come definitivamente superata?<br />
Alchimia come esperienza<br />
Gli alchimisti, considerati ormai dal senso comune come degli sciocchi<br />
oppure come pericolosi personaggi da cui guardarsi non avevano<br />
nemmeno nei tempi in cui operavano, buona stampa. L’alchimista è un<br />
uomo che silenziosamente, in casa o in luoghi <strong>di</strong>screti, combina e tenta<br />
esperimenti <strong>di</strong> cui <strong>oggi</strong> sappiamo non comprendesse quasi mai il senso. In<br />
una famosa tavola <strong>di</strong> Peter Bruegel viene rappresentato ironicamente come<br />
un in<strong>di</strong>viduo chino al suo tavolo <strong>di</strong> lavoro, mentre i poveri figli ne<br />
combinano <strong>di</strong> tutti i colori (figura 1). Un uomo che, <strong>di</strong>speratamente, cerca<br />
la ricchezza perdendo tempo e sol<strong>di</strong> riducendosi così in miseria, oppure un<br />
uomo che custo<strong>di</strong>sce dei segreti innominabili a cui devono essere estorti<br />
anche con la tortura (figura 2).
Figura 1 – Peter Bruegel. L’alchimista<br />
Figura 2 – La tortura dell’alchimista<br />
R. Reali 135
136<br />
Simboli e scrittura delle sperimentazioni scientifiche: la chimica<br />
Le esperienze alchemiche hanno invece conosciuto negli stessi perio<strong>di</strong><br />
in cui si elabora la rivoluzione scientifica galileiana un profondo<br />
ripensamento. La ricerca <strong>di</strong> affinità e <strong>di</strong>fferenze che potremmo <strong>oggi</strong><br />
chiamare <strong>di</strong> tipo “analogico” <strong>di</strong>stinguendola da quella quantitative non<br />
aveva infatti tralasciato <strong>di</strong> osservare come i singoli composti costituissero<br />
in realtà una sequenza or<strong>di</strong>nata e ne avevano rappresentata la loro affinità<br />
in modo puntuale attraverso una tavola (figura 3).<br />
La tavola era stata quin<strong>di</strong> elaborata in<strong>di</strong>cando nella combinazione degli<br />
elementi la loro maggiore o minore capacità <strong>di</strong> interagire e, posti in modo<br />
or<strong>di</strong>nato: “comparivano questi simboli per in<strong>di</strong>care la scala <strong>di</strong> reattività<br />
(per usare un termine attuale) <strong>di</strong> varie sostanze rispetto a quella che veniva<br />
in<strong>di</strong>cata nella casella superiore della colonna.” 5<br />
Figura 3 – Tabula Affinitatum <strong>di</strong> Geoffroy, 1718<br />
Le Tabule così elaborate erano abbastanza comuni nel XVIII secolo e<br />
furono anche riprodotte in alcune e<strong>di</strong>zioni dell’Encyclope<strong>di</strong>e <strong>di</strong> Diderot e<br />
5 Gianni Michelon, Fondamenti storico-‐‑espistemologici della chimica, in:<br />
http://www.univirtual.it/corsi%20V%20ciclo/II%20sem%20IND/michefond/04.htm.
R. Reali 137<br />
d’Alambert ed avevano lo scopo <strong>di</strong> sintetizzare il grado maggiore o minore<br />
<strong>di</strong> affinità <strong>di</strong> alcuni elementi rispetto ad altri. La maniera <strong>di</strong> leggere lo<br />
schema è, in fondo, semplice: ad ogni elemento che corrisponde alla prima<br />
riga, venivano elencati per ogni colonna, i composti che avevano maggiore<br />
o minore affinità (reagivano) in presenza <strong>di</strong> questi:” per l'ʹ"ʺacido del sale<br />
marino"ʺ (HCl) [cloruro <strong>di</strong> so<strong>di</strong>o], colonna b, la massima affinità è<br />
presentata da Sn [Stagno] (b2), minore da Cu (b4) [Rame], poi Ag (b5)<br />
[Argento], Hg (b6) [mercurio] e, molto lontano, Au (b9) [oro].” 6<br />
Come si può notare l’insieme delle descrizioni partivano da un<br />
composto complesso come il cloruro <strong>di</strong> so<strong>di</strong>o o sale marino e gli alchimisti<br />
conoscevano i metalli ottenuti con proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> raffinazione più o meno<br />
avanzati che, a contatto con il sale, generavano ulteriori reazioni. Non<br />
erano certo in grado <strong>di</strong> determinare il peso e la quantità <strong>di</strong> atomi presenti<br />
nel composto ma la regolarità delle interazioni e una certa sistematicità <strong>di</strong><br />
queste ultime era invece perfettamente chiara.<br />
I simboli poi che rappresentavano gli elementi e che ci interessano in<br />
modo particolare sono la notazione sintetica degli elementi derivati dai:<br />
“simboli astrologici usati per i metalli (…), per esempio, per l'ʹoro (Sole) in<br />
b9, per l'ʹargento (Luna) in b5, per il ferro (Marte) in c2, per il rame (Venere)<br />
in b4, per il piombo (Saturno) in c4, per lo stagno (Giove) in b2, per il<br />
mercurio (Mercurio) in c5.” 7<br />
6 Michelon, cit. le interpolazioni tra parentesi quadre sono nostre.<br />
7 Michelon, cit.
138<br />
Simboli e scrittura delle sperimentazioni scientifiche: la chimica<br />
Simboli astrologici che in<strong>di</strong>cano i metalli<br />
È interessante notare così che già all’inizio del XVIII secolo, l’esperienza<br />
alchemica mutuando la propria notazione degli elementi tra<strong>di</strong>zionali<br />
dall’astrologia rinascimentale e procedendo per analogia, aveva<br />
identificato simbolicamente una sorta <strong>di</strong> para<strong>di</strong>gma dell’uso che si fa degli<br />
elementi stessi nelle esperienze chimiche. In primo luogo i simboli sono<br />
utilizzati per identificare univocamente degli elementi esistenti in natura e<br />
non nel cielo iperuranio; in secondo luogo queste notazioni si richiamano<br />
ad una ricerca <strong>di</strong> regolarità che è rappresentata dalla tavola delle affinità in<br />
cui sono inseriti. Ogni elemento supporta la vicinanza o meno degli altri e<br />
ne descrive sinteticamente la maggiore o minore reattività. Non avrebbe<br />
infatti alcun senso mettere in sequenza e secondo una logica astrologica<br />
quei simboli mentre ne acquista uno rilevante se li inseriamo come<br />
rappresentazione simbolica delle reazioni a cui danno origine.<br />
È un importante passaggio in cui la vecchia tra<strong>di</strong>zione alchemica<br />
comincia, ben prima <strong>di</strong> una ricerca delle analisi quantitative, a mettere in<br />
or<strong>di</strong>ne le proprie conoscenze e soprattutto in<strong>di</strong>vidua l’insieme degli<br />
elementi che possono essere rappresentati in combinazione acquisendo un<br />
senso dalla loro interazione e dalla loro posizione reciproca. Questo dato lo<br />
ritroviamo intatto nella tavola <strong>di</strong> Mendeleev in cui la posizione dei singoli
R. Reali 139<br />
elementi ci fornisce in modo puntuale il comportamento chimico. Si<br />
potrebbe <strong>di</strong>re che è una modalità <strong>di</strong> replicare la musica “ad orecchio” senza<br />
conoscere ancora le singole note ma l’idea che esista uno spartito su cui la<br />
musica debba essere scritta è presente ed aiuta a comprendere questo<br />
nuovo linguaggio naturale. Una specie <strong>di</strong> termine “me<strong>di</strong>o” in cui le lettere<br />
sono ancora simboli della tra<strong>di</strong>zione alchemica precedente ma ormai<br />
contrapposti e strutturati secondo il metodo dell’esperienza che procede<br />
faticosamente secondo il metodo della similitu<strong>di</strong>ne e del contrasto.<br />
Veniamo quin<strong>di</strong> ai simboli e alle notazioni. Abbiamo visto che questi<br />
simboli risalgono alla tra<strong>di</strong>zione alchemica ma anch’essi hanno già subito<br />
in precedenza una profonda trasformazione nel secolo XVII, e già da<br />
simboli dell’analogia con l’universo sono <strong>di</strong>venuti un sistema in qualche<br />
modo “standar<strong>di</strong>zzato” <strong>di</strong> notazione.<br />
Per poter comprendere questo passaggio dobbiamo però fare<br />
riferimento ad un trattato <strong>di</strong> Alchimia intitolato Commentatio de Pharmaco<br />
Catholico, inserito nel più vasto libro intitolato Chymica Vannum che fu<br />
pubblicato anonimo in Germania e poi tradotto in latino nel 1666. Questo<br />
trattato viene censito da John Ferguson nella Bibliotheca Chemica nel 1906 8 e<br />
descritto come: “Reclusorium opulentiae sapientiaque Numinis Mun<strong>di</strong><br />
Magni, (….) sed Inventa Proauthoribus Immortalibus Adepti.” 9 Un libro<br />
che ha, in apparenza, tutti i crismi del testo alchemico con le sue richieste<br />
iniziatiche e i suoi richiami alla conoscenza magica che aveva fatto finire<br />
sul rogo parecchi personaggi durante il XIV e il XV secolo in giro per<br />
l’Europa.<br />
Eppure la tesi, soprendente, del Commentatio appare come molto vicina<br />
all’idea <strong>di</strong> affinità che il XVIII secolo aveva consegnato alla notazione della<br />
Tavola. Parlando degli elementi, scrive l’anonimo: “quattro elementi sono i<br />
fondamenti <strong>di</strong> tutte le cose corporali: da questi provengono tutti gli altri<br />
come figli da una madre, in questo mondo sono così composti e formati e<br />
gli elementi stessi si corrompono e si trasformano e nessuno degli elementi<br />
8 Ferguson 1906.<br />
9 Ferguson cit. tomo II, 246.
140<br />
Simboli e scrittura delle sperimentazioni scientifiche: la chimica<br />
visibili esiste per se allo stato puro [visibilium vero horum elementorum<br />
nullum est per se existens, neque purum] ma più o meno uniti tra loro” 10.<br />
L’estensore presuppone quin<strong>di</strong> l’estrazione, o “<strong>di</strong>stillazione”, degli<br />
elementi e quin<strong>di</strong> parte dal presupposto che in natura esista un insieme <strong>di</strong><br />
composti tutti, più o meno, uniti tra loro e che l’esperienza alchemica ha il<br />
compito <strong>di</strong> isolare e <strong>di</strong> ricombinare. Giunti alla necessità <strong>di</strong> comunicare<br />
quelle esperienze l’autore del trattato nel capitolo finale elabora però un<br />
sorprendente cambiamento. Egli afferma che la scienza alchemica deve<br />
costruire un nuovo modo <strong>di</strong> rappresentare questa estrazione e questa<br />
combinazione attraverso quello che lui chiama Chymico Alphabeto in cui si<br />
propone che i vecchi caratteri filosofici debbano essere <strong>di</strong> nuovo compresi e<br />
interpretati [signa ac verba intelligenda sint et interpretanda] 11.<br />
La richiesta <strong>di</strong> una nuova notazione è data dal fatto che i vecchi simboli<br />
e le vecchie notazioni sono ormai quasi inintellegibili nelle nuove<br />
esperienze <strong>di</strong> alchimia e che vi è bisogno <strong>di</strong> un nuovo Abecedario che<br />
illustri le proprietà delle cose naturali in modo da avere imme<strong>di</strong>atamente<br />
visibile le proprietà degli elementi che si vogliono unire [Chymicum<br />
Abecedarium ac aliquos novos characteres, qui proprietatem rerum designaturum<br />
veracent exhibent, annectere] 12.<br />
Nell’esposizione dell’Alfabeto proposto si ha quin<strong>di</strong> l’esposizione dei<br />
vari elementi principali che l’anonimo chiama Alphabeto Simplici, l’Alfabeto<br />
degli elementi primari:<br />
10 Commentatio de Pharmaco Catholico, Quomodo nimirum istud in tribus illis natura Regnis,<br />
Mineralium, Animalium ac Vegetabilium reperiendum: atque exinde conficiendum, per<br />
excellentissimum Universale Menstruum, vi pollens recluden<strong>di</strong> occlunden<strong>di</strong>que, tum metallum<br />
quodlibet, in primam sui materiam, reducen<strong>di</strong>, 3, la traduzione è nostra.<br />
11 Commentatio, cit., 55.<br />
12 Ibidem.
R. Reali 141<br />
Rappresentazioni delle lettere dell’Alfabeto chimico corrispondenti agli elementi<br />
semplici 13<br />
Come si nota molti <strong>di</strong> questi simboli saranno ripresi nella Tabula<br />
Affinatatis del XVIII secolo e corrispondono infatti ai simboli del Sole per<br />
l’Oro, della Luna per l’Argento, e così via. Le definizioni sono ancora<br />
composte con l’insieme degli attributi magici e mitologici, dei colori (nero,<br />
rosso e bianco) simbolo delle reazioni o degli animali (leone, drago, lupo)<br />
legati alla vecchia notazione degli alchimisti precedenti ma la ricerca <strong>di</strong> una<br />
notazione standar<strong>di</strong>zzata per creare un alfabeto comune già a metà del<br />
XVII secolo rappresenta un punto fermo che rompe con la tra<strong>di</strong>zione<br />
astrologico/magica e comincia a muovere i primi passi verso una vera e<br />
propria narrazione dell’esperienza chimica che sia comprensibile<br />
nonostante l’utilizzo <strong>di</strong> un’antica simbologia.<br />
Che questa maniera <strong>di</strong> comunicare sia, in realtà, un nuovo modo <strong>di</strong><br />
raccontare le esperienze sulla natura è confermato anche dalla successiva<br />
proposta <strong>di</strong> una costruzione <strong>di</strong> vere e proprie “frasi chimiche” elaborate in<br />
forma sintetica utilizzando quelle lettere e quei simboli.<br />
L’anonimo costruisce delle Syllabae Chymichae 14, veri e propri sintagmi<br />
combinatori degli elementi che sono annotati partendo dalla composizione<br />
dei semplici:<br />
13 Ibidem, 60.<br />
14 Commentatio, cit., 61.
142<br />
Sillabe chimiche<br />
Simboli e scrittura delle sperimentazioni scientifiche: la chimica<br />
Ogni singolo elemento che isolato in maniera grafica in modo standard<br />
viene legato ad altri “semplici” per la formazione <strong>di</strong> un composto e<br />
riconoscendo la simbologia si possono in<strong>di</strong>care in modo chiaro i composti:<br />
“con una parola avente significato o con un carattere universale che ho<br />
in<strong>di</strong>cato nel titolo <strong>di</strong> questo capitolo [his vero verbum significativum, vel<br />
universalem characterem, quem superius in titulo delineavit]”. Con questi segni,<br />
ora completamente trasparenti: “noi vogliamo consegnarti questo schema;<br />
questi segni sono un pochino più luminosi [tamquam lucioli] e potranno così<br />
condurti alla luce della vera conoscenza [qui ducere te debent ad veram<br />
cognitionis lucem].” 15<br />
È quin<strong>di</strong> un nuovo senso che appare sotto questa notazione sintetica che<br />
illustra come l’esperienza chimica possa essere correntemente e<br />
chiaramente rappresentata nella combinazione degli elementi dalla<br />
combinazione delle lettere e dei segni. Queste ormai seguono una logica<br />
del tutto <strong>di</strong>versa da quella tra<strong>di</strong>zionale da cui derivano e riproducono e<br />
trasmettono l’arte della miscelazione una volta appreso l’alfabeto e<br />
costruito le sillabe e le parole chimiche che hanno trasformato il simbolo<br />
astrologico ed alchemico in un nuovo linguaggio.<br />
L’arte <strong>di</strong> “<strong>di</strong>stillare” non ha atteso quin<strong>di</strong> la teoria quantitativa degli<br />
elementi per costruire due elementi fondamentali del proprio sviluppo<br />
scientifico. Il primo è <strong>di</strong> poter rappresentare in modo proprio l’esperienza<br />
con un grado sempre più raffinato isolando alcuni fenomeni come l’affinità<br />
tra gli elementi e la loro capacità combinatoria allo stato puro e<br />
rappresentandoli poi con notazioni chiare e definite. Il secondo, non meno<br />
15 Ibidem.
R. Reali 143<br />
importante, è che queste esperienze non sono più il frutto <strong>di</strong> iniziazioni<br />
magiche ma <strong>di</strong> una razionalizzazione ed un <strong>di</strong>verso utilizzo dei linguaggi a<br />
<strong>di</strong>sposizione che cominciano a corrodere dall’interno la struttura iniziatica<br />
dei proce<strong>di</strong>menti alchemici spingendoli al massimo delle loro possibilità<br />
sino ad arrivare ad una vera e propria grammatica (le sillabe nelle parole) e<br />
una sintassi (la tavola delle affinità) che ne strutturano il co<strong>di</strong>ce che la<br />
chimica “quantitativa” potrà poi liberamente riprendere e trasformare in<br />
qualcosa <strong>di</strong> metodologicamente utile non rinnegando la sua genesi storica<br />
giungendo in questo modo rapidamente ad una propria <strong>di</strong>stinta capacità <strong>di</strong><br />
indagine e <strong>di</strong> proposta scientifica rispetto alle altre <strong>di</strong>scipline.<br />
La tavola <strong>di</strong> Mendeleev, le <strong>di</strong>stillazioni e le sintesi degli elementi sono<br />
certamente qualcosa <strong>di</strong> fondamentalmente nuovo ma solo perché ora si<br />
comprende la struttura quantitativa degli atomi; l’esigenza <strong>di</strong> scrivere e<br />
annotare le reazioni chimiche in modo breve e standar<strong>di</strong>zzato sarà quin<strong>di</strong><br />
un lascito <strong>di</strong> quella tra<strong>di</strong>zione dei secoli XVII e XVIII che rapidamente la<br />
chimica moderna farà propria per giungere ai risultati straor<strong>di</strong>nari che<br />
affronterà nei secoli XIX e XX.<br />
Una ultima notazione va invece fatta <strong>di</strong> come fu recepita e trasmessa<br />
questa cultura alchemica. L’insieme delle sillabe chimiche e delle<br />
esperienze <strong>di</strong> combinazione illustrate sono state annotate, ed è l’unico<br />
esempio che ci è rimasto, sullo stipite della cosiddetta Porta alchemica 16<br />
della Villa sull’Esquilino a Roma appartenuta al Marchese <strong>di</strong> Palombara<br />
poi <strong>di</strong>strutta dalle successive inurbazioni. (figura 4)<br />
16 Sulla porta alchemica dell’Esquilino: Anna Maria Partini, La magia <strong>di</strong> una porta, in<br />
http://www.rivodutri.org/lamagia.htm con annessa bibliografia.
144<br />
Simboli e scrittura delle sperimentazioni scientifiche: la chimica<br />
Figura 4 – Porta alchemica nel giar<strong>di</strong>no <strong>di</strong> Piazza Vittorio -‐‑ Roma<br />
La porta a cui la leggenda popolare assegna molteplici significati<br />
colpisce soprattutto per la sua misteriosa e incomprensibile sequenza <strong>di</strong><br />
figure simboliche sugli stipiti seguiti da versi che illustravano in modo<br />
iniziatico la combinazione degli elementi. Sarebbe, se le ipotesi sin qui<br />
seguite sono corrette, una specie <strong>di</strong> Stele <strong>di</strong> Rosetta a cui la notazione<br />
proposta in simboli degli elementi viene tradotta nel ben più conosciuto<br />
linguaggio verbale della tra<strong>di</strong>zione magico alchemica. Oggi sappiamo<br />
ormai che tale sequenza non è altro che la notazione <strong>di</strong> reazioni chimiche<br />
perfettamente comprensibili ai contemporanei colti del tempo il cui<br />
significato, certamente <strong>di</strong>verso dal nostro, non ha però trasformato lo<br />
spirito con cui furono scritte e cioè la creazione <strong>di</strong> una comunicazione<br />
specifica nel linguaggio della natura delle esperienze che gli stu<strong>di</strong>osi del<br />
tempo andavano compiendo manipolando gli elementi e che si affrettava a<br />
considerarla come una specie <strong>di</strong> nuovo modo <strong>di</strong> comunicazione anche a<br />
chi, ignaro dei progressi, era rimasto fermo alla vecchia magica<br />
rappresentazione delle medesime esperienze. Una sorta <strong>di</strong> “<strong>di</strong>zionario”<br />
simbolico a cui però, curiosamente, l’aura <strong>di</strong> mistero incomprensibile lo<br />
<strong>di</strong>edero nel 1888, i sistematori del monumento inserendo, accanto alla<br />
porta, due rappresentazioni del <strong>di</strong>o egizio Bes, simbolo delle magie<br />
alchemiche egizie, rinvenuti nel giar<strong>di</strong>no del Quirinale e allontanando,
R. Reali 145<br />
anche visivamente, lo sforzo compiuto da quel linguaggio sintetico <strong>di</strong> dare<br />
nuova lingua alla chimica del tempo.<br />
Bibliografia<br />
Roberto Reali<br />
roberto.reali@cnr.it<br />
Di Meo 2009<br />
Di Meo Antonio, I chimici ebrei e le leggi razziali del 1938: l’Università e<br />
oltre, in Le leggi antiebraiche del 1938, le società scientifiche e la scuola in<br />
Italia, Atti del Convegno, Roma 26-‐‑27 novembre 2008, Roma, Accademia<br />
Nazionale delle Scienze detta dei XL, 287-‐‑320.<br />
Ferguson 1906<br />
Ferguson John, Bibliotheca chemica, A catalogue of the alchemical, chemical<br />
and pharmaceutical books in the collection of the late James Young of Kelly and<br />
Durris, Glasgow, Maclehose.<br />
Galilei<br />
Galileo Galilei, Opere, Roma, E<strong>di</strong>zione Nazionale a cura dell’Istituto<br />
dell’Enciclope<strong>di</strong>a Italiana, 2006.<br />
Levi 1979<br />
Levi Primo, Il sistema perio<strong>di</strong>co, Torino, Einau<strong>di</strong>.<br />
Fonti delle illustrazioni<br />
Tavola 1<br />
Riprodotta in Encyclope<strong>di</strong>a britannica. www.britannica.com<br />
Figura 1<br />
http://www.settemuse.it/pittori_scultori_europei/pieter_bruegel.htm<br />
Figura 2<br />
http://itis.volta.alessandria.it/episteme/ep6/ep6-‐‑alch.htm
146<br />
Simboli e scrittura delle sperimentazioni scientifiche: la chimica<br />
Figura 3<br />
La Tabula affinitatum inter <strong>di</strong>fferentes substantias si trova presso il Museo<br />
<strong>di</strong> Storia della scienza <strong>di</strong> Firenze. Riprodotta in<br />
http://venus.unive.it/miche/chimrestau/capitoli/01-‐‑2re.htm<br />
Figura 4<br />
http://www.officinarcheologica.it/visita-‐‑alla-‐‑porta-‐‑alchemica/
Un caso <strong>di</strong> tendenza alla <strong>brevi</strong>tà sintattica nell’italiano contemporaneo<br />
Abstract<br />
Sergio Marroni<br />
Nell’italiano contemporaneo si fa sempre più spiccata la tendenza a eliminare<br />
l’articolo determinativo davanti ai nomi <strong>di</strong> società, istituzioni, enti, associazioni, pur<br />
tra frequenti oscillazioni; ciò nonostante le descrizioni delle principali grammatiche<br />
<strong>di</strong> riferimento inducono a ritenere agrammaticale l’omissione. Sulla base<br />
d’un’ampia analisi <strong>di</strong> corpus dell’italiano parlato e scritto l’autore rintraccia il<br />
percorso d’un cambiamento possibile della norma linguistica in atto all’interno<br />
d’un microsettore della sintassi dell’articolo. In<strong>di</strong>viduata la sua origine nei<br />
linguaggi economico-‐‑finanziario e aziendale, vengono in<strong>di</strong>cati <strong>di</strong>versi fattori<br />
d’or<strong>di</strong>ne sia strutturale sia sociolinguistico che illustrano le motivazioni e le vie<br />
della recente e rapida <strong>di</strong>ffusione della costruzione.<br />
Parole chiave: italiano contemporaneo, sintassi, ellissi, articolo determinativo, nomi<br />
propri<br />
In the Italian language nowadays there is a relevant tendency to eliminate the<br />
definite article before names of companies, institutions, corporations, associations.<br />
This happens even if the main reference grammars consider this omission as<br />
ungrammatical. Based on extensive analysis of the corpus of spoken and written<br />
Italian, the path is here drawn of a possible change of the linguistic standard with<br />
regard to the syntax of the article. Tracing its origin in the economic-‐‑financial and<br />
business languages, several structural and sociolinguistic factors are mentioned,<br />
explaining the reasons and the ways of the recent and rapid spread of the<br />
construction.<br />
Keywords: contemporary Italian syntax, ellipsis, definite article, proper names<br />
I giornali <strong>di</strong> ieri, 21 febbraio 2011, riferivano delle <strong>di</strong>missioni <strong>di</strong><br />
Leonardo Del Vecchio dal Consiglio d’amministrazione delle Assicurazioni<br />
Generali. È l’ultimo evento, in or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> tempo, d’un aspro conflitto ai<br />
vertici del maggior gruppo assicurativo italiano, presieduto da Cesare<br />
Geronzi, un conflitto la cui posta è ancora più ampia, poiché investe la Rcs,
148<br />
Un caso <strong>di</strong> tendenza alla <strong>brevi</strong>tà sintattica nell’italiano contemporaneo<br />
vale a <strong>di</strong>re, fra l’altro, il «Corriere della Sera» 1. Il 2 febbraio nel sito della<br />
«Repubblica» 2 si leggeva un articolo intitolato «Della Valle: Generali esca<br />
da Rcs / “Non ci serve e porta solo malumori”»; sottotitolo: «Il patron <strong>di</strong><br />
Tod’s al Cda, consigliere e azionista, chiede che la compagnia triestina ceda<br />
la propria quota del gruppo e<strong>di</strong>toriale [...]». Nell’articolo si legge che<br />
«Vincent Bollorè, vicepresidente <strong>di</strong> Generali, ha detto ai giornalisti che il<br />
consiglio <strong>di</strong> amministrazione “valuterà con attenzione” la proposta <strong>di</strong><br />
cessione della quota Rcs avanzata da Della Valle». Nello stesso luogo, il 16<br />
febbraio, è apparso un articolo intitolato «Rcs, dopo lo scontro Della Valle-‐‑<br />
Geronzi poteri al cda e de Bortoli in sella fino al 2014» e ieri un altro dal<br />
titolo «Generali, Del Vecchio si <strong>di</strong>mette in polemica con Geronzi»;<br />
sottotitolo: «Il patron <strong>di</strong> Luxottica lascia; decisiva probabilmente l’intervista<br />
a Ft in cui il presidente annunciava scelte strategiche future mai <strong>di</strong>scusse<br />
dal consiglio [...]». Ne riporto, a conclusione <strong>di</strong> questo preambolo, il primo<br />
capoverso:<br />
MILANO -‐‑ Ora è ufficiale, Leonardo Del Vecchio si è <strong>di</strong>messo dal consiglio <strong>di</strong><br />
amministrazione <strong>di</strong> Generali. Non si conoscono ancora le motivazioni ufficiali che<br />
hanno spinto il patron della Luxottica a un simile gesto, ma tutto fa pensare a una<br />
presa <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza dal presidente Cesare Geronzi e dalla sua ultima intervista al<br />
Financial Times in cui delineava strategie della compagnia <strong>di</strong> Trieste mai <strong>di</strong>scusse<br />
con gli altri consiglieri.<br />
Richiamo l’attenzione sulla seguente oscillazione: mentre nel sottotitolo<br />
Leonardo Del Vecchio è il patron <strong>di</strong> Luxottica, nell’articolo è il patron della<br />
Luxottica. Le citazioni giornalistiche precedenti contengono per <strong>di</strong>eci volte<br />
il nome d’una società, solo nell’ultimo esempio citato esso viene introdotto<br />
dall’articolo determinativo.<br />
La ricerca <strong>di</strong> cui qui si presentano i primi risultati è partita da tre<br />
osservazioni:<br />
1) nell’uso attuale, in particolare giornalistico, i nomi <strong>di</strong> società, <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>tte, <strong>di</strong> imprese tendono, in linea generale, a rifiutare l’articolo<br />
determinativo in tutti i contesti sintattici, pur con grande incertezza;<br />
1 D’ora in poi «Cds».<br />
2 D’ora in poi «R».
S. Marroni 149<br />
2) nella mia sensibilità linguistica l’omissione produce un’impressione<br />
<strong>di</strong> estraneità, che tuttavia possiede intensità <strong>di</strong>verse, fino a giungere<br />
allo svanimento, a seconda delle situazioni;<br />
3) la “memoria del parlante” suggeriva che potesse trattarsi<br />
d’un’estensione recente, probabilmente <strong>di</strong>lagata in breve tempo al<br />
<strong>di</strong> là <strong>di</strong> argini più circoscritti.<br />
Chi fosse interessato alla grammatica dell’italiano, dopo aver letto<br />
nell’articolo del 2 febbraio citato la cessione della quota della compagnia in Rcs,<br />
per Generali "ʺnon è core business e non serve per lo sviluppo futuro"ʺ, patto <strong>di</strong><br />
sindacato Rcs, L'ʹiniziativa del patron <strong>di</strong> Tod'ʹs, intesa tra Tod'ʹs e ministero, pensa<br />
che la Rizzoli non sia un'ʹazienda che vada gestita come tutte le altre, avrebbe<br />
potuto immaginare una regola in cui l’articolo determinativo sarebbe<br />
presente solo se il nome ha la funzione <strong>di</strong> soggetto; ma nell’articolo del 16<br />
febbraio avrebbe trovato oltre a patto <strong>di</strong> sindacato <strong>di</strong> Rcs Me<strong>di</strong>agroup e<br />
<strong>di</strong>scussioni attorno a Rcs, anche il fondatore della Tod’s, alcuni soci della Rcs, dal<br />
presidente della Rcs e articoli giu<strong>di</strong>cati troppo duri nei confronti della Fiat e<br />
dell’Eni. E se, interessato anche alle vicende della Fiat, egli avesse letto<br />
l’articolo del «Sole 24 ore» 3 del 15 febbraio scorso, intitolato «Marchionne<br />
(in giacca e cravatta) alla Camera: la Fiat ha progetti ambiziosi per l’Italia»,<br />
avrebbe forse tratto un motivo ulteriore d’inquietu<strong>di</strong>ne, incontrando, nello<br />
stesso articolo, L’amministratore delegato <strong>di</strong> Fiat, il recente passato della Fiat, Su<br />
Fiat si “è aperto un ampio e lungo <strong>di</strong>battito [...]”, “Nessuno può accusare la Fiat <strong>di</strong><br />
comportamenti scorretti”, l’amministratore delegato <strong>di</strong> Fiat, Il motivo che ha<br />
spinto Fiat alle sue iniziative, Fiat era un'ʹazienda che nel 2004 perdeva 4 milioni al<br />
giorno, garantire a Fiat, Non è solo vero che la Fiat abbia salvato Chrysler, l'ʹad <strong>di</strong><br />
Fiat, il futuro della Fiat, la Fiat da sola non avrebbe potuto fare, Il futuro <strong>di</strong> Fiat e<br />
Chrysler, La Fiat ha il cuore in Italia, quota Fiat, l'ʹamministratore delegato della<br />
Fiat, Se il cuore della Fiat sarà in Italia, gli investimenti <strong>di</strong> Fiat, Fiat si aspetta un<br />
fatturato <strong>di</strong> “64 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> euro”, destinerà 4 miliar<strong>di</strong> a Fiat Industrial, il 65% per<br />
Fiat Group Automobiles, investimenti previsti [...] per Fiat Group Automobiles,<br />
prodotti da Fiat, L'ʹamministratore delegato <strong>di</strong> Fiat, stabilimenti Fiat, la Fiat è<br />
<strong>di</strong>sponibile a collaborare, degli accor<strong>di</strong> in Fiat, Fiat non ha nessuna intenzione <strong>di</strong><br />
abbandonare l'ʹItalia, Fiat fa parte <strong>di</strong> questo Paese, Per l'ʹamministratore delegato <strong>di</strong><br />
Fiat, la Fiat è l'ʹunica grande azienda, l'ʹad <strong>di</strong> Fiat, i trattamenti che la Fiat nel<br />
tempo ha riconosciuto alle proprie persone; in tutto 34 occorrenze, 12 delle quali<br />
3 D’ora in poi «S24o»
150<br />
Un caso <strong>di</strong> tendenza alla <strong>brevi</strong>tà sintattica nell’italiano contemporaneo<br />
introdotte dall’articolo, fra cui mi limito a sottolineare la Fiat ha progetti<br />
ambiziosi per l’Italia (nel titolo) <strong>di</strong> fronte a Fiat non ha nessuna intenzione <strong>di</strong><br />
abbandonare l'ʹItalia; l’amministratore delegato <strong>di</strong> Fiat alternato a<br />
l'ʹamministratore delegato della Fiat; il cuore della Fiat accanto a gli investimenti<br />
<strong>di</strong> Fiat. Il fatto è che al <strong>di</strong> là del conflitto economico, politico e sindacale,<br />
dobbiamo occuparci qui d’un conflitto <strong>di</strong> tutt’altra portata fra due norme<br />
sintattiche, <strong>di</strong> cui una più recente, della quale cercheremo <strong>di</strong> determinare<br />
l’origine e la natura.<br />
La norma tra<strong>di</strong>zionale è descritta dalle grammatiche dell’italiano, anche<br />
se la maggior parte <strong>di</strong> esse la <strong>di</strong>segna a una scala che non permette <strong>di</strong><br />
seguirne nitidamente tutti i frastagliati confini. Ci atterremo, quin<strong>di</strong>, solo a<br />
quelle che potranno servire ai fini della nostra analisi, a partire da alcuni<br />
paragrafi <strong>di</strong> Fornaciari (1884), il quale fra i nomi ai quali si premette<br />
l’articolo determinativo in<strong>di</strong>vidua la classe dei «nomi determinati <strong>di</strong> per<br />
sè», vale a <strong>di</strong>re quelli che<br />
significano cose uniche in natura, p. es. il sole, la luna, la terra; i nomi <strong>di</strong> materia,<br />
l’oro, il rame, il vino; i nomi proprii <strong>di</strong> nazioni, <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> isole, <strong>di</strong> fiumi, <strong>di</strong> monti, <strong>di</strong><br />
laghi, p. es. la Francia, la Corsica, il Tevere, l’Appennino ecc. ecc.; i nomi usati in senso<br />
d’antonomasia, p. es. la società, la Provvidenza (XIII 3).<br />
Si esaminano nel seguito sia le eccezioni a questa norma generale sia<br />
altri casi <strong>di</strong> ellissi. Così, nella sezione intitolata Omissione regolare<br />
dell’articolo, si legge che per lo più l’articolo è respinto dai «nomi in<br />
singolare <strong>di</strong> provincie e <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> isole, purchè <strong>di</strong> genere femminile in a [...]<br />
dopo le preposiz. <strong>di</strong> ed in (in senso locale)» (XIII 34); «nelle enumerazioni»<br />
(XIII 37); «dopo forme comparative, come, a guisa, a f<strong>oggi</strong>a, a modo <strong>di</strong>» (XIII<br />
40). Se i nomi vengono coor<strong>di</strong>nati, l’articolo può essere omesso «quando e il<br />
primo e gli altri sostantivi l’ometterebbero, se fossero soli» (XIII 43). In tutta<br />
la trattazione non vengono presi in considerazione nomi <strong>di</strong> <strong>di</strong>tte, <strong>di</strong><br />
associazioni o <strong>di</strong> istituzioni 4.<br />
4 Con l’eccezione del § 36 dove si trova «Parlamento italiano, Camera de’ Deputati, Cose esterne,<br />
Cronaca della città, Stato Civile», ma si sta esemplificando l’assenza dell’articolo «nelle<br />
soprascritte, nei titoli, nelle date, nelle rubriche dei libri o dei capitoli».<br />
Nelle grammatiche successive <strong>di</strong> solito non si arriva a trattare un caso così specifico come<br />
l’incontro fra articolo determinativo e nomi <strong>di</strong> questa specie: cfr. Dardano&Trifone (1995),<br />
Salvi&Vanelli (2004), Patota (2006), Pran<strong>di</strong> (2006) o anche Della Valle&Patota (2007). Più<br />
significativa l’assenza nel cap. L’uso dell’articolo <strong>di</strong> Lepschy&Lepschy (1981).
S. Marroni 151<br />
Questi ultimi sono invece inclusi negli esempi addotti da Serianni (1991)<br />
nei paragrafi de<strong>di</strong>cati all’uso dell’articolo con le sigle (IV 9-‐‑12). Li<br />
riportiamo integralmente, inserendoli in uno schema che illustra i casi<br />
possibili.<br />
Iniziale<br />
vocalica<br />
Femm. l’OLP,<br />
l’USL / la<br />
USL<br />
Masch. l’AUC,<br />
l’ENI,<br />
l’UFO<br />
gli USA<br />
Pronuncia<br />
unitaria<br />
la FIAT,<br />
la DIGOS<br />
il MEC, il<br />
PRI, il PSI<br />
lo SME,<br />
lo S<strong>di</strong> 7<br />
Tab. 1<br />
Iniziale consonantica<br />
Pronuncia con compitazione<br />
Iniziale<br />
consonantica<br />
Reggenza<br />
lessicale5 la DC, la BNL la FLM,<br />
la RSI<br />
il CNR, il BR 8 il FBI,<br />
il MSI<br />
Iniziale vocalica<br />
Reggenza<br />
fonetica6 l’FLM, l’RSI<br />
l’FBI, l’MSI,<br />
l’S<strong>di</strong><br />
(V) (Cu) (Cc) (Cvl) (Cvf)<br />
Quel che importa sottolineare qui sono le forme verbali impiegate da<br />
Serianni per enunciare la norma 9; caso (V): «Quale che ne sia la pronuncia<br />
[...] si usano gli articoli prevocalici»; caso (Cu): «vogliono l’articolo<br />
preconsonantico»; caso (Cc): «avremo il e un»; casi (Cvl) e (Cvf): si esamina<br />
l’oscillazione, in<strong>di</strong>cando una preferenza per (Cvl) nel femminile e<br />
5 L’articolo ha il genere e la forma richiesta dalla prima parola del sintagma pronunciata per<br />
esteso.<br />
6 L’articolo ha il genere richiesto dalla prima parola del sintagma, ma la forma si adegua alla<br />
realizzazione fonetica della sigla.<br />
7 Così nella «R» del 25.3.1986 ci si riferiva alla Strategic Defense Initiative, mentre «Il<br />
Gazzettino» del giorno prima ha l’S<strong>di</strong> (Serianni 1991, IV 11). Com’è noto, l’oscillazione nel<br />
genere degli anglicismi è frequente.<br />
8 Nel senso <strong>di</strong> ‘l’esponente delle Brigate Rosse’.<br />
9 Saranno evidenziate con il corsivo.
152<br />
Un caso <strong>di</strong> tendenza alla <strong>brevi</strong>tà sintattica nell’italiano contemporaneo<br />
concludendo che si ha «solo, ovviamente: la DC, la BNL, ecc.»; e se sulla<br />
defunta Dc siamo tutti d’accordo, le cose cambiano, invece, per la Bnl 10.<br />
Un possibile uso <strong>di</strong> sigle non articolate è in<strong>di</strong>cato nella sezione de<strong>di</strong>cata<br />
all’omissione dell’articolo nell’italiano contemporaneo; la regola generale<br />
non viene applicata, infatti,<br />
[i]n un certo numero <strong>di</strong> complementi <strong>di</strong> luogo, specie se introdotti da in: lavorare in<br />
fabbrica, restare in camera, pregare in chiesa, andare in ufficio, recarsi in prefettura, vivere<br />
in provincia, andare a casa; anche con sigle: «Il senatore Norberto Bobbio venerdì era<br />
a Roma in Rai» («Stampa sera», 29.12,1986, 13; ma si potrebbe <strong>di</strong>re anche «alla Rai»)<br />
(Serianni 1991, IV 72 d);<br />
dove si scorgerà il velato giu<strong>di</strong>zio racchiuso nella parentesi. Raccogliamo<br />
ancora l’osservazione relativa alle sequenze <strong>di</strong> più termini, in cui «è buona<br />
norma ripetere l’articolo (o la preposizione articolata o il partitivo) davanti<br />
a ciascuno <strong>di</strong> essi, oppure ometterlo sempre» (IV 73), e passiamo ad alcune<br />
osservazioni sui toponimi, utili ai fini del nostro <strong>di</strong>scorso. Trattando <strong>di</strong><br />
nomi <strong>di</strong> regioni, stati e continenti che normalmente vengono preceduti<br />
dall’articolo, Serianni (1991, IV 41) nota, fra l’altro,<br />
a) che, se il toponimo ha la funzione <strong>di</strong> soggetto o <strong>di</strong> oggetto <strong>di</strong>retto,<br />
«l’articolo è <strong>di</strong> norma presente: “la Basilicata ha due province”, “amare<br />
la Cina”», ma «è spesso assente nelle enumerazioni: “Olanda, Belgio e<br />
Lussemburgo costituiscono il Benelux”»;<br />
b) che, se il toponimo è preceduto da preposizione, «l’articolo è sempre<br />
presente, inglobato in una preposizione articolata, quando il toponimo<br />
ha forma plurale: “la politica degli Stati Uniti”, “andare nelle<br />
Filippine”. Con i singolari, è spesso assente quando il nome è retto da<br />
<strong>di</strong> e in, generalmente presente con le altre preposizioni [...]: “il re <strong>di</strong><br />
Spagna”, “vivere in Veneto” (ma anche: “a gloria della Spagna”,<br />
“vivere nel Veneto”)».<br />
10 Il focus <strong>di</strong> Serianni è sulla forma dell’articolo; a noi interessa principalmente, in questa sede,<br />
che l’ipotesi della sua assenza non sia contemplata. Maiden&Robustelli (2007, 3.14), trattando<br />
del genere delle sigle, elencano l’ONU, le FS, il PCI (un curioso anacronismo, viste le date della<br />
prima e della seconda e<strong>di</strong>zione), la NATO, la NASA, la CIA. Nel seguito non è fatto alcun<br />
cenno d’una possibile omissione che riguar<strong>di</strong> specificamente i nomi <strong>di</strong> <strong>di</strong>tte, associazioni o<br />
istituzioni, che, pertanto, appaiono inclusi nei casi generali.
S. Marroni 153<br />
Dal capitolo de<strong>di</strong>cato all’articolo della GGIC (2001) 11 traiamo innanzi<br />
tutto alcune considerazioni generali.<br />
I nomi propri, in virtù del loro valore intrinsecamente referenziale e quin<strong>di</strong> del loro<br />
carattere intrinsecamente determinato, sono ovviamente <strong>di</strong>versi dai nomi comuni<br />
(massa e/o numerabili) e hanno comportamenti <strong>di</strong>versi. Tale <strong>di</strong>versità è marcata<br />
innanzitutto dal fatto che le regole per l’uso dell’articolo determinativo, valide per i<br />
nomi comuni, non sono altrettanto valide per i nomi propri. Infatti, la presenza o<br />
assenza dell’articolo determinativo con tali nomi non in<strong>di</strong>ca l’opposizione<br />
determinatezza/indeterminatezza, ma l’articolo costituisce piuttosto, insieme con il<br />
nome proprio, una unica unità, arbitraria, <strong>di</strong> denominazione come in la Campania, le<br />
Alpi, la Fiat, il Giovanni, il Rossi, il Manzoni, ecc. (GGIC 2001, V.4.1.)<br />
Fra gli esempi compare la Fiat, presentata come un’unità <strong>di</strong><br />
denominazione al pari <strong>di</strong> la Campania o le Alpi. Nell’esaminare, poi, gli usi<br />
dell’articolo in relazione ai sintagmi intrinsecamente determinati, come i<br />
nomi propri, la GGIC fornisce numerosi esempi, avvertendo che<br />
«[l]’in<strong>di</strong>cazione dell’articolo determinativo o della sua mancanza, o della<br />
sua facoltatività, si riferisce al caso più frequente» e che alcuni contesti<br />
particolari possono limitarne la comparsa. Trascegliamo le categorie che<br />
riguardano più o meno da vicino la nostra analisi.<br />
II. Nomi <strong>di</strong> istituzioni, società, avvenimenti storici, ecc.<br />
f) il Cremlino, il Pentagono, la Crusca; la Fiat; le Generali; il Cristianesimo, il Terrore;<br />
il Novecento; la Disfida <strong>di</strong> Barletta<br />
[...]<br />
IV. Nomi <strong>di</strong> luogo<br />
[...]<br />
m) terre:<br />
i) continenti: l’Africa<br />
ii) stati; nazioni: l’Italia; gli Stati Uniti; ma: __ Cuba [...], __ Andorra<br />
iii) regioni (amministrative o geografiche): la Lombar<strong>di</strong>a, il Veneto, i<br />
Balcani, la Terra Santa, ecc.<br />
11 Scritto da Lorenzo Renzi.
154<br />
[...]<br />
Un caso <strong>di</strong> tendenza alla <strong>brevi</strong>tà sintattica nell’italiano contemporaneo<br />
s) locali pubblici; istituti (intesi come e<strong>di</strong>fici):<br />
i) il Roma (=caffè, cinema, albergo Roma)<br />
ii) la Kennedy (=scuola Kennedy); l’Ucciardone (=carcere<br />
dell’Ucciardone); il Mozartheum (=conservatorio); il Forlanini<br />
(=aeroporto)<br />
t) squadre sportive, gruppi e simili: il Napoli, il Petrarca, la ‘Sani e Forti’ (GGIC<br />
2001, VII.3.3.1.1).<br />
La norma richiede, quin<strong>di</strong>, la Fiat, le Generali. Sono ammesse deflessioni<br />
in alcuni contesti. Poiché si parla ancora <strong>di</strong> Fiat 12, riportiamo il commento a<br />
f).<br />
Bisogna <strong>di</strong>stinguere un nome come la Fiat (in<strong>di</strong>cante l’industria, o la fabbrica, o il<br />
consiglio <strong>di</strong> amministrazione della Fiat), che non ha plurale e non può avere<br />
articolo indeterminativo, da Fiat pseudo nome proprio, cioè in realtà nome comune<br />
[...], che ha anche l’articolo indeterminativo e il plurale: una Fiat = «un’automobile<br />
Fiat»; delle Fiat = «delle automobili Fiat»; o «delle azioni della Fiat», ecc. (GGIC 2001,<br />
VII.3.3.1.1).<br />
Aggiungiamo subito che ci sarà utile anche il commento a s) e t).<br />
Nelle categorie s) e t) l’articolo non si accorda per genere (e/o per numero) col<br />
nome. In realtà l’articolo è accordato con un nome comune sottinteso: la Kennedy<br />
(=la scuola Kennedy), il Napoli (=il club Napoli). Questi nomi sottintesi possono<br />
essere anche del tutto assenti della coscienza linguistica dei parlanti, come in<br />
quest’ultimo caso (GGIC 2001, VII.3.3.1.1).<br />
Tornando alle deflessioni dalla norma generale, la GGIC prende in<br />
considerazione due contesti: il primo si determina quando un nome<br />
proprio <strong>di</strong> luogo che ha obbligatoriamente l’articolo si trova preceduto<br />
dalla «preposizione <strong>di</strong>, in uno qualsiasi dei suoi significati», il secondo<br />
quando un nome della stessa classe viene preceduto dalla «preposizione in,<br />
con significato locale» (VII.3.3.1.2). In entrambi i casi l’omissione è limitata<br />
ai nomi singolari e può essere obbligatoria o facoltativa a seconda della<br />
sottoclasse coinvolta; talora la scelta appare del tutto i<strong>di</strong>osincratica.<br />
12 L’ellissi <strong>di</strong>pende, com’è ovvio, dalla norma secondo cui «[l]’articolo viene sempre omesso<br />
quando un termine sia adoperato in funzione metalinguistica» (Serianni 1991, IV 72 n).
S. Marroni 155<br />
Tuttavia «[l]a presenza <strong>di</strong> un mo<strong>di</strong>ficatore accanto al nome proprio rende<br />
obbligatorio l’articolo». Ora, benché il paragrafo si occupi <strong>di</strong> nomi propri <strong>di</strong><br />
luogo e tragga tutti gli esempi dalle lettere l) ed m), incluse nella classe<br />
Nomi <strong>di</strong> luogo del § VII.3.3.1.1., ad un tratto ricompare la Fiat, che, come<br />
abbiamo visto è inserita nella classe Nomi <strong>di</strong> istituzioni, società, avvenimenti<br />
storici, ecc.; si tratta tuttavia d’un esempio in cui il nome ha un ruolo<br />
locativo, un esempio che introduce un elemento semantico su cui<br />
torneremo.<br />
In genere l’uso <strong>di</strong> in senza articolo rivela familiarità con l’oggetto in questione. Solo<br />
un impiegato o un operaio della Fiat <strong>di</strong>rebbe:<br />
(227) Lavoro in Fiat.<br />
Gli altri <strong>di</strong>cono: alla Fiat. (VII.3.3.1.2.) 13<br />
Alla sintassi dell’articolo avevano de<strong>di</strong>cato anni prima alcune pagine<br />
Lepschy&Lepschy (1981). Fra le altre acute osservazioni, interessa qui<br />
riportare, poiché aggiunge un elemento assente anche nelle trattazioni più<br />
recenti, quella relativa ai titoli <strong>di</strong> giornale o <strong>di</strong> perio<strong>di</strong>co inserita nel<br />
paragrafo riguardante l’omissione dell’articolo,<br />
[p]er <strong>brevi</strong>tà, in telegrammi (e messaggi pubblicitari) [...] e in espressioni create per<br />
essere <strong>brevi</strong> e efficaci come titoli <strong>di</strong> libri, <strong>di</strong> perio<strong>di</strong>ci, <strong>di</strong> film: Guerra e pace; Rinascita;<br />
Senso, ecc. Si noti l’ho letto su Rinascita e non sulla Rinascita; ma sul Corriere della sera<br />
(sebbene il titolo sia Corriere della sera); su o sulla Repubblica (il titolo è la Repubblica)<br />
(150) 14 .<br />
Se ora, alla luce <strong>di</strong> quanto descritto dalle più autorevoli grammatiche<br />
della nostra lingua, tornassimo agli esempi da cui siamo partiti, dovremmo<br />
concludere che la maggioranza <strong>di</strong> essi andrebbe asteriscata. E tuttavia<br />
sarebbe imprudente attribuirli alla trascuratezza <strong>di</strong> alcuni giornalisti,<br />
perché quegli usi travalicano le pagine e i siti dei giornali o gli stu<strong>di</strong> dei<br />
telegiornali, ci circondano e penetrano nella nostra lingua quoti<strong>di</strong>ana fino a<br />
modellare il nostro sentimento della norma 15. Meglio porsi alcune domande<br />
intorno a quello che si configura come un possibile mutamento <strong>di</strong>acronico<br />
13 Nessuno dei passi della GGIC citati è stato mo<strong>di</strong>ficato rispetto all’e<strong>di</strong>zione del 1991.<br />
14 L’oscillazione non viene ricondotta ad alcuna regolarità.<br />
15 Cfr. Serianni (2004).
156<br />
Un caso <strong>di</strong> tendenza alla <strong>brevi</strong>tà sintattica nell’italiano contemporaneo<br />
che investe l’uso dell’articolo determinativo con i nomi propri <strong>di</strong><br />
istituzioni, società, enti 16.<br />
-‐ Le grammatiche recenti esaminate hanno descritto uno stato <strong>di</strong> lingua<br />
effettivo oppure hanno ignorato o emarginato o <strong>di</strong>storto fenomeni<br />
presenti nell’uso?<br />
-‐ Se esse hanno descritto uno stato effettivo, da quando la situazione è<br />
cambiata e quali sono stati i tempi del cambiamento?<br />
-‐ Da quale settore della lingua originano questi costrutti?<br />
-‐ In quali settori hanno potuto trovare un humus favorevole alla loro<br />
<strong>di</strong>ffusione?<br />
-‐ Perché si propagano con tanta rapi<strong>di</strong>tà?<br />
Per rispondere, abbiamo innanzi tutto condotto un’analisi con strumenti<br />
informatici su quattro corpus <strong>di</strong> testi: il LIP, il CoLFIS, l’OTA ComIC e l’OTA<br />
Newspapers 17. Sono stati compilate due liste, una <strong>di</strong> nomi <strong>di</strong> società 18, l’altra<br />
<strong>di</strong> nomi <strong>di</strong> istituzioni, enti, associazioni scelti in base alla loro <strong>di</strong>ffusione e<br />
alle loro caratterstiche linguistiche, tali cioè da rappresentare formazioni <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>verso tipo: sigle (Fiat), acronimi (Fininvest), troncamenti (Telecom),<br />
composti (Alitalia), nomi comuni (Poste), antroponimi (Barilla),<br />
polirematiche (Alleanza nazionale), polirematiche abitualmente scorciate<br />
(Assicurazioni generali → Generali).<br />
16 In realtà il mutamento sembra aggre<strong>di</strong>re anche altre classi <strong>di</strong> nomi intrinsecamente<br />
determinati, ma è in quest’ambito che gli effetti si sono manifestati con maggiore estensione e<br />
compattezza.<br />
17 Il LIP (Lessico <strong>di</strong> frequenza dell'ʹitaliano parlato), <strong>di</strong>retto da T. De Mauro, contiene 469 testi<br />
parlati registrati a Milano, Firenze, Roma e Napoli per un totale <strong>di</strong> 490.000 parole circa. Risale<br />
agli anni 1990-‐‑92. Il CoLFIS (Corpus e Lessico <strong>di</strong> Frequenza dell'ʹItaliano Scritto Contemporaneo),<br />
curato da P. M. Bertinetto e altri, raccoglie testi tratti da quoti<strong>di</strong>ani, perio<strong>di</strong>ci e libri per un<br />
totale <strong>di</strong> 3.798.275 occorrenze. È stato costituito tra il 1992 e il 1994. L’OTA (Oxford Text<br />
Archive) Corpus of Italian Newspapers, curato da E. Burr, comprende articoli pubblicati dal<br />
«Mattino» (d’ora in poi «M»), dalla «R» e dalla «Stampa» (d’ora in poi «S») nel 1989. L’OTA<br />
ComIC (Oxford Text Archive Commercial Italian Corpus), curato da S. Laviosa, contiene saggi e<br />
articoli d’argomento economico datati dal 1986 al 2001. Complessivamente i corpus oxoniensi<br />
contengono circa 600.000 occorrenze.<br />
18 Per la scelta ci si è avvalsi soprattutto <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>obanca (2010), oltre che delle statistiche <strong>di</strong><br />
«Forbes» e <strong>di</strong> «Fortune» relative allo stesso anno.
S. Marroni 157<br />
Tab. 2<br />
I. Società II. Istituzioni, enti, associazioni<br />
(Assicurazioni) Generali<br />
Acea<br />
Agip<br />
Alitalia<br />
Atac<br />
Ataf<br />
Atan<br />
Atm<br />
Autogrill<br />
Barilla<br />
Benetton<br />
Bnl<br />
E<strong>di</strong>son<br />
Enel<br />
Eni<br />
Fiat<br />
Fininvest<br />
Finmeccanica<br />
Ina<br />
Me<strong>di</strong>aset<br />
Monte<strong>di</strong>son<br />
Perugina<br />
Poste (italiane)<br />
Rai<br />
Telecom<br />
Alleanza Nazionale<br />
An<br />
Banca centrale (europea)<br />
Banca d'ʹItalia<br />
Bankitalia<br />
Bce<br />
Cgil<br />
Col<strong>di</strong>retti<br />
Confesercenti<br />
Confindustria<br />
Fi<br />
Fiom<br />
Fmi<br />
Fondo monetario (internazionale)<br />
Forza Italia<br />
Interpol<br />
Ocse<br />
Onu<br />
Prc<br />
Rifondazione (comunista)<br />
Sinistra democratica<br />
Sinistra giovanile<br />
Ue<br />
Unione europea<br />
È opportuno partire dai dati offerti dal LIP, per poi confrontarli con<br />
quanto emerge dai corpus d’italiano scritto, giacché qui pare situarsi una<br />
prima linea <strong>di</strong> confine. Dei nomi della I lista si danno 44 occorrenze, <strong>di</strong> cui<br />
11 vanno sottratte perché la presenza (2) o l’assenza (9) dell’articolo è del<br />
tutto normale. Sono stati scartati, infatti, da un lato i casi in cui l’articolo è<br />
richiesto dalla presenza d’un mo<strong>di</strong>ficatore del nome 19, dall’altro quelli,<br />
molto frequenti in particolare nei testi scritti, in cui l’articolo non può che<br />
19 O quelli, rari, in cui il nome è preceduto da un articolo indeterminativo, spia d’un uso come<br />
pseudo-‐‑nome proprio (cfr. GGIC VII.3.3.1.).
158<br />
Un caso <strong>di</strong> tendenza alla <strong>brevi</strong>tà sintattica nell’italiano contemporaneo<br />
mancare dato l’uso appositivo, come in orchestra Rai o vicende Fiat 20. Fra le<br />
33 occorrenze rimanenti in un unico caso si registra l’omissione, per <strong>di</strong> più<br />
in una struttura coor<strong>di</strong>nata: noi siamo la brutta copia del Corriere della sera<br />
senza Fiat senza inviati dell’Italia 21.<br />
La II lista conta complessivamente 65 occorrenze, <strong>di</strong> cui 12 vanno<br />
sottratte (7 con articolo e 5 senza) per i motivi appena esposti. Sui 53<br />
restanti, i casi <strong>di</strong> omissione sono 5: uno in dentro Rifondazione 22 e quattro<br />
davanti a CGIL, CISL e UIL.<br />
Concludendo, il quadro che emerge dal LIP si accorda alle regole<br />
esposte nelle grammatiche.<br />
Interroghiamo, allora, i corpus scritti, cominciando con la I lista. Le<br />
occorrenze totali sono 1360 23, utili 1004, tolte le 27 con articolo obbligatorio<br />
e le 329 con assenza con<strong>di</strong>zionata, soprattutto dall’impiego frequentissimo<br />
come apposizione ma anche da tipici moduli giornalistici. Nella titolazione<br />
è respinto l’articolo sia quando, raramente, titolo e nome sono tutt’uno sia<br />
quando, più spesso, il nome funge da tema separato da un qualche segno<br />
d’interpunzione, come per es. in Atac, la fermata è <strong>di</strong> notte; Fiat: Pace tra i<br />
giu<strong>di</strong>ci e guerra tra i sindacati. Più in generale l’articolo manca in formule<br />
sintetiche come RAI-‐‑SPONSOR, SOSPENSIONI CANCELLATE, l’accordo<br />
Alivar-‐‑Barilla, neologismi, come decreto salva Rai 24, liste, fra le quali<br />
20 Inoltre i pochi in cui l’omisssione è imposta dalla locuzione preposizionale precedente, per<br />
es. in qualità <strong>di</strong>.<br />
21 È significativo che nel LIP della I lista compaiano solo i nomi seguenti, in or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong><br />
frequenza: Rai, Fiat, Acea, Fininvest e con un’occorrenza ciascuno Agip, Alitalia, Atac, Bnl, Enel,<br />
Perugina.<br />
22 Nel febbraio 1991 si svolge l’ultimo congresso nazionale del Pci, nel quale si compie la<br />
scissione che dà vita al Movimento per la Rifondazione Comunista. Il LIP riflette imme<strong>di</strong>atamente<br />
gli eventi. Anche per la II lista è significativo l’elenco dei presenti, che poniamo in or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong><br />
frequenza: Cgil, Fiom, Confindustria, Sinistra giovanile, Onu, infine, con un’occorrenza ciascuno,<br />
Banca d’Italia e, per l’appunto, Rifondazione. Ai fini del nostro <strong>di</strong>scorso è opportuno ricordare<br />
che sia nell’uso giornalistico sia nel parlato quoti<strong>di</strong>ano Rifondazione (comunista) è stata sempre<br />
la designazione normale. È verisimile che una larga parte degli italiani ignorasse o trascurasse<br />
il fatto che il nome ufficiale fosse Partito della Rifondazione Comunista, tanto più che d’una<br />
rifondazione comunista s’era parlato vivacemente per mesi (ben 11 occorrenze nel LIP) prima del<br />
congresso costitutivo del <strong>di</strong>cembre 1991, che sancì il nome ufficiale dopo un lungo e<br />
controverso <strong>di</strong>battito in cui molti si opposero al termine partito. Di fatto, esso compare con una<br />
circolazione più limitata, quasi solo scritta e quasi solo nella sigla Prc.<br />
23 Assente solo Ataf.<br />
24 Composto non saldato graficamente; anche salva-‐‑Rai.
S. Marroni 159<br />
richiamiamo l’attenzione, ai fini del nostro <strong>di</strong>scorso, su quelle dei titoli <strong>di</strong><br />
borsa, che tendono a comparire privi dell’articolo anche nei resoconti degli<br />
andamenti della giornata 25. Si potrebbe obiettare che in questo campo ci si<br />
riferisce alle azioni, ma in realtà l’uso frequentemente al singolare del verbo<br />
o la sua assenza rendono tale riferimento molto ambiguo 26, come mostrano<br />
gli esempi seguenti: Tra i bancari ha chiuso in virata Bnl (meno 2,43%). In<br />
picchiata Banca <strong>di</strong> Roma che è scesa del 6,08% a 3,3 euro; Pesante Fiat che ha<br />
ceduto il 3,1%, proprio in relazione alla crisi argentina; Oltre 500 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
scambi in Piazza Affari, Fiat su del 5,9%, Generali del 3,08%, Me<strong>di</strong>obanca del<br />
4,87%, STET del 5,03%, Olivetti del 4,52%.<br />
Le occorrenze dei nomi della II lista sono 1334; anche qui vanno sottratti<br />
12 più 147 casi d’uso con<strong>di</strong>zionato, per un totale netto <strong>di</strong> 1175.<br />
A questo punto, se calcoliamo le percentuali dei contesti in cui l’articolo<br />
è necessariamente escluso sul totale delle occorrenze, si ottiene questa<br />
sequenza:<br />
Tab. 3<br />
S.I (= corpus scritto, lista I)<br />
P.I (= corpus parlato, lista I)<br />
S.II (= corpus scritto, lista II)<br />
P.II (= corpus parlato, lista II)<br />
24,19%<br />
20,45%<br />
11,01%<br />
7,69%<br />
dal che si ricava, anche se per via in<strong>di</strong>ziaria, che i nomi <strong>di</strong> società si<br />
presentano più facilmente in tali contesti (si arriva quasi a un quarto delle<br />
occorrenze nel corpus scritto) e che l’uso scritto costituisce un terreno più<br />
favorevole. Un altro fattore facilitante è la forma <strong>di</strong> sigla, come mostra la<br />
seguente tabella relativa al corpus scritto.<br />
25 Mentre le liste sono escluse, i resoconti sono inclusi nel nostro computo.<br />
26 All’interno d’un genere testuale che pre<strong>di</strong>lige l’espressione nominale.
160<br />
Un caso <strong>di</strong> tendenza alla <strong>brevi</strong>tà sintattica nell’italiano contemporaneo<br />
Tab. 4<br />
Forma Occ. tot. Occ. con omissione<br />
obbligatoria (% sul tot.)<br />
Banca Centrale Europea<br />
BCE<br />
Fondo Monetario Internazionale<br />
FMI<br />
Unione Europea<br />
UE<br />
13<br />
35<br />
26<br />
33<br />
105<br />
67<br />
7,69%<br />
17,14%<br />
3,84%<br />
15,15%<br />
0,95%<br />
41,79%<br />
Veniamo ora a quei costrutti in cui la caduta dell’articolo determinativo<br />
è una possibile alternativa in italiano registrata dalle principali<br />
grammatiche, cioè coppie, terne o sequenze <strong>di</strong> nomi coor<strong>di</strong>nati fra loro in<br />
maniera sindetica o asindetica 27, in<strong>di</strong>pendentemente dall’eventuale<br />
presenza <strong>di</strong> preposizioni. A riprova <strong>di</strong> questa libertà con<strong>di</strong>zionata traiamo<br />
qualche esempio illustre dal settore dei toponimi che normalmente esigono<br />
l’articolo 28.<br />
Rimase romana tutta la gente latina, Francia, Spagna, Italia. (F. De Sanctis, Storia<br />
della letteratura italiana)<br />
Spagna e papa non potevano <strong>di</strong>re: «L’Italia siamo noi». [...] E se vogliamo trovare i<br />
vestigi <strong>di</strong> una nuova Italia, che si vada lentamente elaborando, dobbiamo cercarli<br />
nell’opposizione fatta a Spagna e papa. (ibi) 29<br />
[...] e potete credere che cacciato <strong>di</strong> lì, né Francia né Spagna sarebbero state <strong>di</strong>sposte<br />
ad aprirmi le braccia (I. Nievo, Le confessioni <strong>di</strong> un italiano)<br />
Come se Spagna e Piemonte fossero due gemelli, che possono scambiarsi panni<br />
tagliati ad uno stesso dosso! (M. D’Azeglio, I miei ricor<strong>di</strong>)<br />
[...] e tutti que’ <strong>di</strong>scorsi che fanno, sul vicario <strong>di</strong> provvisione e il governatore e<br />
Ferrer e i decurioni e i cavalieri e Spagna e Francia e altre simili corbellerie, far vista<br />
27 Cfr. Serianni (1991, IV 73); GGIC (2001, VII.3.2., VII.5.2); Maiden&Robustelli (2007, 4.16). I<br />
connettivi considerati sono e, o, sia... sia, né e simili.<br />
28 Come abbiamo visto, la GGIC accosta la Fiat ai nomi <strong>di</strong> luogo in più d’un’occasione.<br />
29 Oltre alla reggenza preposizionale, è notevole l’assimilazione sintattica <strong>di</strong> papa a un nome <strong>di</strong><br />
nazione; cfr. anche «Ma saviezza fiorentina e immaginazione napoletana erano del pari<br />
sospette a Chiesa e Spagna» (ibi).
<strong>di</strong> non sentire (A. Manzoni, I promessi sposi) 30<br />
S. Marroni 161<br />
Per la pace conchiusa nel 1801 tra Francia e Austria (V. Monti)<br />
Aggiungiamo un esempio d’omissione in una coor<strong>di</strong>nazione asimmetrica<br />
con un primo termine appartenente ai nomi <strong>di</strong> città, che, quasi tutti,<br />
respingono l’articolo in qualsiasi contesto.<br />
Fu condannato da Roma e da Spagna, ribelle ed eretico, e tenuto in prigione<br />
ventisette anni, sottoposto alla tortura sette volte. (F. De Sanctis, Storia della<br />
letteratura italiana)<br />
Tornando ai nomi delle classi che c’interessano più <strong>di</strong>rettamente, nel LIP<br />
troviamo 14 presenze all’interno <strong>di</strong> costruzioni come queste: 10 articolate e<br />
4 non articolate (28,57%). Nel corpus scritto, invece, le presenze sono<br />
numerose, 281 in totale, e il rapporto fra presenza e assenza dell’articolo<br />
favorisce nettamente quest’ultima con l’80,07%. Va sgombrato, dunque, il<br />
campo da occorrenze in cui l’omissione può essere considerata regolare,<br />
come in Confindustria e sindacati hanno rinviato tutto; ma Generali e<br />
Bankamericard assicurano che [...]; conteggiando ministeri, università e Banca<br />
d’Italia; riunire in una superhol<strong>di</strong>ng energetica Eni ed Enel; consigliere <strong>di</strong><br />
Me<strong>di</strong>obanca e Generali; capitale riservato ad Ina e Inps; La manifestazione,<br />
organizzata da CGIL, CISL e UIL; Tra Stet, Sip, Snam ed Enel lo Stato “tiene” sui<br />
servizi; il problema della <strong>di</strong>visione dei posti tra Ina e Inps 31.<br />
Serve un’ultima potatura, per raccogliere quei nomi inclusi nella ricerca<br />
che rifiutano costantemente l’articolo; si tratta <strong>di</strong> nomi <strong>di</strong> raggruppamenti<br />
politici che non hanno o non presuppongono alla loro base nel sentimento<br />
dei parlanti un nome comune come partito, movimento, lega, unione o simili:<br />
Forza Italia (152 occorrenze totali più una <strong>di</strong> FI), Rifondazione Comunista (108<br />
30 Si noti l’assenza dell’articolo davanti ai nomi propri (<strong>di</strong> persona, ovviamente, e <strong>di</strong> nazione) e<br />
la sua presenza davanti ai nomi comuni nella medesima coor<strong>di</strong>nazione.<br />
31 A proposito del tipo tra SN e SN, vd. GGIC VII.4.3.4., in cui sono in<strong>di</strong>cati alcuni vincoli,<br />
l’ultimo dei quali («Il tipo riguarda due SN singolari. Il plurale è escluso del tutto, a meno che<br />
non sia limitato [...] al solo secondo membro») mi pare infondato, anche alla luce <strong>di</strong> esempi<br />
come: il “no” all’accordo fra sindacati, Confindustria e governo sul costo del lavoro o il duello era fra<br />
progressisti e Forza Italia, o, uscendo dall’ambito dei nostri nomi: Differenze tra bambini bianchi e<br />
bambini neri? Che sciocchezze; assi <strong>di</strong> raccordo tra aree industriali e grande viabilità; tra cattolici e<br />
marxisti; patto tra comunisti e Nuova Democrazia; Più che un incontro tra cronisti e tecnico è sembrato<br />
<strong>di</strong> partecipare ad uno «psicodramma»; tavolo <strong>di</strong> concertazione tra parti in causa e neo-‐‑Governo; e si<br />
potrebbe facilmente continuare.
162<br />
Un caso <strong>di</strong> tendenza alla <strong>brevi</strong>tà sintattica nell’italiano contemporaneo<br />
occorrenze totali più una <strong>di</strong> RC), cui si associa Alleanza Nazionale (50<br />
occorrenze totali) nonostante alleanza. Vengono percepiti, evidentemente,<br />
come “nomi titolo”, per riecheggiare la classificazione <strong>di</strong> Fornaciari (1884),<br />
anziché come nomi <strong>di</strong> partito, e come tali rifiutano l’articolo 32.<br />
Due grafici a torta permettono d’apprezzare quanto siano consistenti le<br />
fette delle omissioni riconducibili nel solco della tra<strong>di</strong>zione, oltre che<br />
sensibilmente più abbondanti nello scritto che nell’orale; i dati sono<br />
racchiusi in gran<strong>di</strong> sud<strong>di</strong>visioni: articolo od omissione obbligatori, articolo<br />
od omissione in strutture coor<strong>di</strong>nate od enumerative, omissione con i<br />
“nomi titolo” 33, articolo od omissione negli altri casi.<br />
Art<br />
64%<br />
Ø Art obbl.<br />
1% 8%<br />
LIP<br />
Ø obbl.<br />
13%<br />
Art Coord.<br />
9%<br />
Ø Coord.<br />
4%<br />
Ø "Nomi<br />
7tolo"<br />
1%<br />
32 Cfr. il CCD, l’MPA (il MPA), il PD, il PDCI, il PDS, il PPI, l’UDC, l’UDR. È significativa<br />
l’alternanza il PRC / Ø Rifondazione Comunista. Viene da chiedersi, naturalmente, quanto<br />
questo rifiuto dell’articolo consuoni con un rifiuto della forma e del termine partito che ha<br />
caratterizzato la politica italiana all’indomani della crisi del ’92-‐‑’94 (Alleanza Nazionale si<br />
costituisce nel gennaio del 1995). Nella microsintassi emergerebbe allora un sintomo <strong>di</strong><br />
processi <strong>di</strong> ben altra portata; ma su questo sarebbero necessarie analisi più approfon<strong>di</strong>te.<br />
33 Solo nei contesti restanti, in cui gli altri nomi oscillano nell’uso al <strong>di</strong> là della norma<br />
tra<strong>di</strong>zionale.
Art<br />
55%<br />
S. Marroni 163<br />
Ø Art obbl.<br />
5% 2% Ø obbl. SCRITTI<br />
18%<br />
Art Coord.<br />
2%<br />
Ø Coord.<br />
8%<br />
Ø "Nomi<br />
7tolo"<br />
10%<br />
All’interno <strong>di</strong> questi ultimi si situa la zona in cui la scelta <strong>di</strong> omettere<br />
l’articolo determinativo si fa via via più anomala rispetto a quanto esposto<br />
nelle grammatiche cui abbiamo fatto riferimento; una scelta, anche qui,<br />
decisamente più vistosa nello scritto che nell’orale.<br />
Nel LIP essa viene fatta solo una volta: senza Fiat 34, in cui l’assenza<br />
<strong>di</strong>pende dalla preposizione, che è solita fare a meno dell’articolo 35.<br />
34 Noi siamo la brutta copia del Corriere della sera senza Fiat senza inviati dell’Italia (Milano, testo <strong>di</strong><br />
tipo B: scambio comunicativo bi<strong>di</strong>rezionale con presa <strong>di</strong> parola libera non faccia a faccia).<br />
35 «[N]on compare l’articolo (e corrispondentemente si usa la preposizione semplice invece <strong>di</strong><br />
quella articolata, [...]) [...] nella grande maggioranza dei sintagmi modali formati me<strong>di</strong>ante con<br />
e senza: con astuzia, con allegria, senza paura, senza pace» (Serianni 1991, IV 72 a). Più<br />
particolareggiata l’analisi della GGIC (2001, VII.4.3.3.), che dopo aver enunciato alcuni vincoli<br />
generali («Mentre il complemento <strong>di</strong> modo, come abbiamo visto, si presenta con con (senza),<br />
assenza <strong>di</strong> articolo e nome astratto, gli altri complementi con con (senza) hanno tutti<br />
l’articolo»), si trova nella con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> doverli attenuare alla luce degli stessi esempi allegati,<br />
poiché anche con i complementi <strong>di</strong> mezzo, <strong>di</strong> unione e <strong>di</strong> compagnia, e con SN concreti si dà la<br />
possibilità dell’omissione dell’articolo; si tratterebbe allora, ma l’ipotesi è avanzata<br />
dubitativamente, d’una reinterpretazione modale. In effetti, le membrane che <strong>di</strong>vidono mezzo,<br />
unione, compagnia, privazione e modo sono permeabili e aggiungerei che una certa pressione<br />
potrebbe esercitare (come nell’es. del LIP e nel [321] della GGIC) anche la struttura coor<strong>di</strong>nata.<br />
Si colloca su un piano in parte <strong>di</strong>verso il punto <strong>di</strong> vista <strong>di</strong> Maiden&Robustelli (2007, 4.18):<br />
«When senza means ‘without any’ and is followed by a generic noun, the article is usually<br />
omitted [...] When the noun following senza is specified (i.e., identified as a particular member
164<br />
Un caso <strong>di</strong> tendenza alla <strong>brevi</strong>tà sintattica nell’italiano contemporaneo<br />
Insomma, la situazione rappresentata dal LIP circa trent’anni fa concorda<br />
pienamente con quanto descritto dalle grammatiche citate.<br />
Quanto ai corpus scritti, l’omissione dell’articolo nella zona che stiamo<br />
esaminando ricorre 132 volte. Si tratta, come mostra anche il grafico, d’una<br />
percentuale abbastanza modesta. Non sorprende rilevare che la<br />
maggioranza assoluta è costituita da occorrenze in cui i SN sono retti dalle<br />
preposizioni <strong>di</strong> e in (84, pari al 63,63%); da tempo, infatti, le grammatiche<br />
sottolineano come dopo queste due preposizioni la caduta dell’articolo<br />
determinativo sia frequente con i nomi <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> isole, <strong>di</strong> regioni o <strong>di</strong> stati<br />
che normalmente lo richiedono (si vedano gli esempi <strong>di</strong> Fornaciari [1884,<br />
XIII 34]: «il re <strong>di</strong> Francia, l’imperatore <strong>di</strong> Russia, l’ambasciatore<br />
d’Inghilterra, il vino <strong>di</strong> Spagna. – Sono in Francia, vado in Germania, vengo<br />
<strong>di</strong> Sardegna o <strong>di</strong> Corsica») 36. È probabile che, una volta avviato il processo,<br />
questa zona abbia rappresentato un guado favorevole al passaggio dei<br />
nomi <strong>di</strong> società, istituzioni, enti, associazioni ed è parimenti probabile che<br />
alcuni nomi siano stati la testa <strong>di</strong> ponte, come suggerisce la seguente tabella<br />
che riporta quelli con occorrenze maggiori <strong>di</strong> uno.<br />
or subclass of the set of entities referred to by the noun), then the article (definite or indefinite)<br />
is used accor<strong>di</strong>ng to the or<strong>di</strong>nary rules for use of the article»; un’osservazione che può<br />
attagliarsi anche alla frase del LIP, in cui, in effetti, Fiat va inteso come un’antonomasia.<br />
36 Il fenomeno è sensibile alle categorie del numero e del genere. I nomi plurali sono esclusi.<br />
Riguardo ai singolari, tuttavia, le grammatiche non concordano appieno sulla forza dei vincoli<br />
imposti da <strong>di</strong> e da in ai femminili e ai maschili e sulle sottoclassi <strong>di</strong> toponimi soggetti ad essi;<br />
cfr. Fornaciari (1884, XIII 34), Lepschy-‐‑Lepschy (1981, 153-‐‑54), Serianni (1991, IV 41), GGIC<br />
(2001, VII.3.3.1.2.), Salvi&Vanelli (2004, II.2.2.3.1.), Maiden&Robustelli (2007, 4.6). Un accordo<br />
può essere trovato sul fatto che il femminile è perlomeno favorito. Ricor<strong>di</strong>amo che la quasi<br />
totalità dei nomi che stiamo esaminando appartiene al femminile ed è singolare.
S. Marroni 165<br />
Tab. 5<br />
<strong>di</strong> in<br />
Confindustria 9 Rai 11<br />
Bankitalia 7 Monte<strong>di</strong>son 8<br />
Monte<strong>di</strong>son 6 Fiat 7<br />
Telecom 6 Confindustria 3<br />
Poste (italiane) 3 Banca d’Italia 3<br />
Fiat 2 Fininvest 2<br />
Finmeccanica 2<br />
Tot. 35 Tot. 34<br />
Un certo numero <strong>di</strong> omissioni riguarda i ruoli <strong>di</strong> soggetto e <strong>di</strong><br />
complemento <strong>di</strong>retto (rispettivamente 25 e 2, per una percentuale<br />
complessiva del 20,45% dei 132 casi su cui abbiamo aumentato<br />
l’ingran<strong>di</strong>mento). L’effetto deviante si fa qui ancora più avvertibile,<br />
ve<strong>di</strong>amo grazie alla tab. 6 con quali nomi viene prodotto più d’una volta.<br />
Tab. 6<br />
SOGG<br />
Fiat 4<br />
Alitalia 3<br />
Monte<strong>di</strong>son 3<br />
Autogrill 2<br />
Finmeccanica 2<br />
Me<strong>di</strong>aset 2<br />
OCSE 2<br />
Tot. 19<br />
Resta da rilevare che le omissioni si addensano più intorno ai nomi <strong>di</strong><br />
società che a quelli <strong>di</strong> istituzioni, enti e associazioni, e che, tolti i contesti<br />
esaminati fin qui (<strong>di</strong> + SN, in + SN, SN Sogg e SN Ogg Dir), rimangono 21<br />
occorrenze (il 15,9%), <strong>di</strong>stribuite fra <strong>di</strong>versi SP (le cui teste sono, in or<strong>di</strong>ne<br />
decrescente, da 7, a 4, con 3, per 3, su 2, tramite 1) e un come + SN<br />
comparativo.
166<br />
Un caso <strong>di</strong> tendenza alla <strong>brevi</strong>tà sintattica nell’italiano contemporaneo<br />
Possiamo concludere che il rilievo compiuto sul terreno <strong>di</strong> testi scritti,<br />
soprattutto giornalistici, situati cronologicamente fra il 1986 e il 2001<br />
mostra uno scostamento limitato rispetto alla norma tracciata dalle<br />
grammatiche <strong>di</strong> riferimento. Appaiono tuttavia già delineate le <strong>di</strong>rezioni<br />
d’una marcia d’espansione che verrà seguita negli anni seguenti.<br />
Un’ultima osservazione assume una certa importanza nella<br />
ricostruzione del fenomeno <strong>di</strong> cui stiamo cercando <strong>di</strong> tracciare<br />
l’andamento. Si sono già accumulati in<strong>di</strong>zi consistenti che ad<strong>di</strong>tano come<br />
sua incubatrice il linguaggio economico e, soprattutto, finanziario. Altri<br />
non trascurabili adombrano un’azione coa<strong>di</strong>uvante delle varietà<br />
settentrionali. Facciamo qualche esempio. Le 9 occorrenze <strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
Confindustria si leggono tutte nel «S24o» (le occorrenze <strong>di</strong> della Confindustria<br />
sono 55, e solo 3 si ritrovano nella stessa testata), così come l’unica in cui<br />
Confindustria è soggetto non articolato; in Confindustria compare una volta<br />
nel «M», una nella «R» e una nella «S» 37. Dei ben 24 casi in cui Monte<strong>di</strong>son è<br />
significativamente privo dell’articolo, 22 si leggono nel «S24o». Sono del<br />
«S24o» due dei quattro Fiat soggetti non articolati 38; <strong>di</strong> Fiat compare una<br />
volta nel «Cds» e una in un resoconto borsistico del «M» (sono 46 le<br />
occorrenze <strong>di</strong> della Fiat), mentre in Fiat si legge, in articoli firmati da<br />
giornalisti originari del Nord, nell’«Espresso», nella «S» 39 e in «Gente<br />
Motori» (sono 20 le occorrenze <strong>di</strong> alla Fiat, una <strong>di</strong> nella Fiat). La tab. 7, in cui<br />
sono inclusi i nomi più rilevanti, delinea un ruolo <strong>di</strong> apripista per la<br />
preposizione in.<br />
Tab. 7<br />
della <strong>di</strong> alla / nella in<br />
CGIL 54 1 2 1<br />
Confindustria 55 9 4 3<br />
Fiat 46 2 21 7<br />
Rai 90 1 34 11<br />
37 Nel <strong>di</strong>scorso <strong>di</strong>retto attribuito al leghista Vito Gnutti, membro dell’associazione.<br />
38 Un terzo si trova in un titolo del «Cds» fra virgolette in posizione iniziale, l’ultimo in un<br />
resoconto borsistico della «S».<br />
39 In entrambe le occasioni nel contesto <strong>di</strong>cono in Fiat.
S. Marroni 167<br />
Mentre il rapporto fra della e <strong>di</strong> tocca il 90:1 e non scende al <strong>di</strong> sotto del<br />
6,1, con in va dal 3,1 all’1,3.<br />
Tiriamo le fila. Nell’arco <strong>di</strong> pochi anni alcuni usi devianti nella sintassi<br />
dell’articolo con i nomi <strong>di</strong> società, <strong>di</strong> enti, <strong>di</strong> istituzioni, <strong>di</strong> associazioni sono<br />
straripati dall’alveo in cui erano confinati, quello dei linguaggi economico-‐‑<br />
finanziario e aziendale, e hanno invaso i più <strong>di</strong>versi tipi testuali, senza<br />
tuttavia riuscire ancora ad emarginare la norma tra<strong>di</strong>zionale, come<br />
testimoniano le continue, fitte oscillazioni anche in una medesima frase. Sui<br />
mo<strong>di</strong> e le motivazioni cre<strong>di</strong>amo che abbiano una buona soli<strong>di</strong>tà le seguenti<br />
ipotesi, da sottoporre a un ulteriore approfon<strong>di</strong>mento.<br />
– Possono causare situazioni <strong>di</strong> referenza ambigua generatrici<br />
d’interferenza sintattica quei nomi <strong>di</strong> società che coincidono col cognome<br />
della famiglia proprietaria o del fondatore (Benetton, Ferrero ecc.).<br />
– Ben più incisivo, ovviamente, il ruolo delle costruzioni in cui l’assenza<br />
dell’articolo è già tra<strong>di</strong>zionale; si tratta del 17% delle occorrenze nel LIP e<br />
del 26% nei corpus scritti.<br />
– Quanto ai “nomi titolo” <strong>di</strong> associazioni politiche (l’1% nel LIP, ma il<br />
10% nei corpus scritti), <strong>di</strong> cui una fucina prolifica erano già stati i gruppi<br />
extraparlamentari <strong>di</strong> sinistra e <strong>di</strong> destra degli anni ’60 e ’70 (Avanguar<strong>di</strong>a<br />
Operaia, Lotta Continua, Or<strong>di</strong>ne Nuovo ecc.), essi conquistano ruoli <strong>di</strong> primo<br />
piano negli anni del dopo-‐‑Tangentopoli grazie a formazioni come<br />
Rifondazione Comunista, Forza Italia, Alleanza Nazionale. Sono nomi propri<br />
che programmaticamente rifiutano l’articolo caratteristico dei nomi<br />
tra<strong>di</strong>zionali delle forze politiche, Lega inclusa; perfino in contesti come<br />
responsabili della sezione <strong>di</strong> Alleanza Nazionale <strong>di</strong> Ciampino («R», 1994), in cui<br />
l’aggiunta del mo<strong>di</strong>ficatore non sortisce alcun effetto.<br />
– Forza Italia spinge il processo a conseguenze estreme: il nome <strong>di</strong><br />
partito va in cortocircuito con il nome <strong>di</strong> società e con il nome <strong>di</strong> prodotto;<br />
si pensi a Che banca, un nome dalla struttura ormai lontanissima da quelle<br />
tra<strong>di</strong>zionali, come il Banco <strong>di</strong> Napoli, il Banco <strong>di</strong> Santo Spirito (> il Santo<br />
Spirito), l’Istituto Bancario San Paolo (> il San Paolo), il Monte dei Paschi <strong>di</strong><br />
Siena, la Cassa <strong>di</strong> Risparmio <strong>di</strong> Venezia, la Banca Popolare <strong>di</strong> Milano ecc., in cui<br />
sono ben riconoscibili la testa del SN e il suo mo<strong>di</strong>ficatore. A uno sta<strong>di</strong>o<br />
interme<strong>di</strong>o si pongono nomi come Banca Intesa, in cui il mo<strong>di</strong>ficatore,<br />
acquistando un peso semantico maggiore e annacquando la relazione
168<br />
Un caso <strong>di</strong> tendenza alla <strong>brevi</strong>tà sintattica nell’italiano contemporaneo<br />
sintattica con la testa, finisce col saldarsi ad essa in un blocco che funziona<br />
come un titolo, talora anche graficamente, come in BancoPosta. Il processo<br />
linguistico è stato favorito dai recenti rapi<strong>di</strong> processi <strong>di</strong> fusione che hanno<br />
generato nomi quali Intesa San Paolo (esito d’una “decapitazione” dei SN),<br />
oltre a numerosi acronimi.<br />
– I nomi <strong>di</strong> moltissime banche si sono trasformati in acronimi, ma, più<br />
in generale, l’acronimomania è <strong>di</strong>lagata nell’onomastica economica,<br />
finanziaria e aziendale. Le tabb. 5 e 6 mostrano chiaramente come<br />
l’omissione dell’articolo sia favorita dagli acronimi in misura maggiore che<br />
dalle sigle: mentre queste ultime consentono, anche se non sempre<br />
agevolmente, <strong>di</strong> risalire al nome testa in esse contenuto (BNL > banca) e,<br />
quin<strong>di</strong>, <strong>di</strong> usare e accordare l’articolo <strong>di</strong> conseguenza, l’acronimo tende a<br />
<strong>di</strong>venire un oggetto uni<strong>di</strong>mensionale che slitta più facilmente verso un uso<br />
assoluto, mentre l’eventuale articolo viene accordato, <strong>di</strong> fatto, «con un<br />
nome comune sottinteso» come nel caso dei nomi <strong>di</strong> locali pubblici, e<strong>di</strong>fici<br />
sede d’istituti, squadre sportive trattato dalla GGIC (2001, VII.3.3.1.1) 40. Del<br />
resto, la sigla e l’acronimo sono sempre più ricercati da chi opera nel<br />
mondo dell’economia per la loro aura <strong>di</strong> tecnicità e d’efficienza e da chi<br />
opera nel mondo del giornalismo per la loro <strong>brevi</strong>tà e per il rispetto che<br />
incutono. Il mostriciattolo Bankitalia, con il suo glamour anglicizzante e un<br />
po’ pubblicitario ne è un esempio eloquente 41.<br />
– La riflessione sull’acronimo conduce, per associazione, sul versante<br />
aziendale, ad alcune strategie politico-‐‑economiche come quella del<br />
cosiddetto “spezzatino”, applicata negli ultimi decenni a molte aziende, o<br />
come quella delle “scatole cinesi”, le quali hanno comportato una<br />
40 Vd. sopra e cfr. nomi come Monte<strong>di</strong>son, Unipol o Interpol. Il fenomeno dell’accordo con un<br />
nome sottinteso emerge percettibilmente in casi come la Generali le ha utilizzate per garantire il<br />
tramutamento delle obbligazioni convertibili in azioni; La Generali non ha brillato; La maggior parte dei<br />
titoli guida, dalla Fiat alla Generali a Me<strong>di</strong>obanca si è mossa in linea con l'ʹin<strong>di</strong>ce; anche la Poste<br />
potrebbe entrare nel prossimo futuro a far parte del matrimonio, nei quali l’articolo singolare è in<br />
apparente <strong>di</strong>saccordo con il SN.<br />
41 E doppiamente paradossale: non solo perché, com’è noto, l’ingl. bank, come le parole<br />
analoghe nelle principali lingue straniere, deriva dall’italiano, ma perché segna un<br />
capovolgimento connotativo del carattere k, fino a pochi decenni fa intriso d’implicazioni<br />
negative, basti pensare al “kappa politico” <strong>di</strong> maskio, amerikano, Kossiga, citati da Maraschio<br />
(1993, 148), «frequenti sui muri delle nostre città in anni <strong>di</strong> politicizzazione e femminismo<br />
accesi». Poche righe sopra si accenna al “kappa pubblicitario” <strong>di</strong> trovate come Mukkilatte. Cfr.<br />
Serianni (1991, I 153 b).
S. Marroni 169<br />
proliferazione <strong>di</strong> nomi, <strong>di</strong> solito ancora acronimi o composti. Anche questi<br />
ultimi tendono a essere percepiti come “nomi titolo”; si veda quest’esempio<br />
<strong>di</strong> «Gente Money»: Se il Governo decidesse <strong>di</strong> metterle entrambe sul mercato,<br />
tutti correrebbero a comperare l'ʹAgip al posto <strong>di</strong> Agip petroli, in cui Agip<br />
conserva l’articolo, ma lo perde Agip petroli; o questa oscillazione<br />
ravvicinata: ricorda da vicino quanto avvenuto nel gruppo Ferruzzi tra<br />
Monte<strong>di</strong>son Milano e la Monte<strong>di</strong>son Finance NV («R»).<br />
– Una forte spinta alla caduta dell’articolo viene dalla scrittura<br />
giornalistica, in particolare dei titoli, a partire dal modello più consolidato<br />
Poste italiane, con "ʺPegasus"ʺ la coda si azzera («La Gazzetta del<br />
Mezzogiorno» 42, titolo). Esigenze <strong>di</strong> spazio e <strong>di</strong> tematizzazione si<br />
coniugano e producono strutture come Ocse più ottimista dell'ʹFmi. Italia:<br />
allarme sanità e welfare («S24o», titolo). Si tratta d’un processo accelerato<br />
dalla <strong>di</strong>ffusione attraverso i nuovi canali della notizia, che per brama <strong>di</strong><br />
<strong>brevi</strong>tà e <strong>di</strong> velocità si fa titolo <strong>di</strong> sé stessa. Lo stile tende al telegrafico (Ocse<br />
promuove l'ʹItalia: un «miracolo» in <strong>di</strong>eci anni [«GdM», titolo]), incurante<br />
d’una goffaggine che col tempo finisce con l’essere percepita come<br />
andatura normale 43.<br />
– Come spesso avviene, la scrittura giornalistica si fa moltiplicatrice <strong>di</strong><br />
novità emerse altrove, in questo caso nel settore economico-‐‑finanziario.<br />
L’ellissi con i nomi d’istituzioni, enti, associazioni appare, data la sfasatura<br />
cronologica nelle percentuali, come l’estensione d’un uso che ha il suo<br />
centro in un’area contigua. Non a caso sono le istituzioni, gli enti, le<br />
associazioni economiche o più legate al mondo economico le prime ad<br />
essere coinvolte (Confindustria, OCSE). Va richiamata l’attenzione in<br />
particolare sul linguaggio della borsa, in cui la concitazione, la velocità e la<br />
<strong>brevi</strong>tà sono <strong>di</strong> casa. Non solo vi si trova l’uso assoluto con referenza<br />
ambigua già notato (si parla della società o delle sue azioni?), ma<br />
s’incontrano esempi come questo: Vigorose Me<strong>di</strong>aset a più 3,08% e Class<br />
E<strong>di</strong>tori (più 2,04%) mentre Mondadori (più 6,31%) è stata la migliore del<br />
comparto («S24o»), in cui l’articolo è eliminato anche con il soggetto<br />
“azioni” sottinteso e non ambiguo grazie al morfema femminile plurale<br />
42 Nel seguito «GdM».<br />
43 Se si torna al sottotitolo dell’articolo della «R» <strong>di</strong> ieri citato all’inizio, si troverà decisiva<br />
probabilmente l’intervista a Ft, mentre nell’articolo si legge intervista al Financial Times: la forma<br />
testuale “titolo” e l’uso d’una sigla (compresa da quanti lettori?) hanno congiurato contro<br />
l’articolo determinativo.
170<br />
Un caso <strong>di</strong> tendenza alla <strong>brevi</strong>tà sintattica nell’italiano contemporaneo<br />
dell’aggettivo per i primi due soggetti, mentre il verbo concorda con un<br />
soggetto sottinteso singolare per il terzo. Lo spazio limitato in cui il<br />
giornalista deve condensare le informazioni <strong>di</strong> borsa, l’abitu<strong>di</strong>ne alla lista<br />
dei titoli accompagnati <strong>di</strong>rettamente dalle percentuali, forse la stessa<br />
incertezza del referente possono essere alla ra<strong>di</strong>ce dell’omissione, e ciò vale<br />
ancor più per l’operatore <strong>di</strong> borsa che s<strong>oggi</strong>ace, fra l’altro, a<br />
con<strong>di</strong>zionamenti temporali <strong>di</strong> confezionamento del messaggio orale o<br />
scritto più stringenti <strong>di</strong> quelli imposti dalla stampa quoti<strong>di</strong>ana. Credo che<br />
vada cercato qui il motore primo del fenomeno che stiamo trattando.<br />
– Esso si sviluppa certamente in un ambito in cui l’inglese esercita un<br />
influsso considerevole; tuttavia, prima d’ipotizzare un'ʹinterferenza a un<br />
livello linguistico, come quello sintattico, generalmente refrattario 44, è<br />
prudente chiedersi se nelle strutture dell’italiano non siano presenti fattori<br />
tali da giustificare l’innovazione e il suo accoglimento. A mio avviso, questi<br />
fattori non solo esistono, ma sono numerosi e consistenti.<br />
– A quelli d’or<strong>di</strong>ne linguistico s’aggiungono fattori d’or<strong>di</strong>ne<br />
extralinguistico. Il decennio che va dal delitto Moro al 1989 è segnato da<br />
una profonda ristrutturazione dei sistemi valoriali e degli or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong><br />
prestigio me<strong>di</strong>ante i quali si classificano realtà materiali e immateriali. In<br />
questo processo i settori e i linguaggi economici, finanziari e aziendali sono<br />
saliti fino ai primissimi posti 45. Non sorprende, quin<strong>di</strong>, che innovazioni<br />
nate sul terreno economico-‐‑finanziario o aziendale (il che implica, in Italia,<br />
su un terreno situato, <strong>di</strong> solito, al Nord) abbiano la capacità d’imporsi come<br />
modello prestigioso ai parlanti e agli scriventi.<br />
– Intrecciato con quest’ultimo fattore ve n’è probabilmente un altro: la<br />
familiarità del referente. L’osservazione della GGIC a proporsito della<br />
<strong>di</strong>fferenza tra alla Fiat e in Fiat meriterebbe un approfon<strong>di</strong>mento maggiore<br />
<strong>di</strong> quello qui consentito. Ci limitiamo a rilevare che quasi tutti gli 11 casi <strong>di</strong><br />
in Rai in<strong>di</strong>cati nella tab. 5 si trovano all’interno d’interviste con persone che<br />
lavorano alla Rai, e 7 sono tratti dai perio<strong>di</strong>ci «Sorrisi e canzoni tv» e<br />
44 Basti ricordare, per restare sul terreno dell’articolo, al contrasto fra l’uso articolato nella<br />
lingua d’origine d’una delle parole simbolo della forza <strong>di</strong> penetrazione dell’inglese<br />
informatico, the Internet, e il suo uso privo d’articolo in italiano (cfr. Maiden&Robustelli [2007,<br />
4.6]).<br />
45 Due fatti sintomatici: nel 1985 l’Unità, all’epoca quoti<strong>di</strong>ano del PCI, pubblica per la prima<br />
volta nella sua storia, non senza polemiche, le quotazioni della Borsa; l’anno dopo esce il<br />
primo numero dell’inserto economico della «R» Affari & Finanza.
S. Marroni 171<br />
«Telepiù» (qualcosa <strong>di</strong> analogo si potrebbe <strong>di</strong>re delle occorrenze <strong>di</strong> in Fiat).<br />
Non è, forse, azzardato ipotizzare che il modulo privo d’articolo abbia<br />
agito in concomitanza con il fattore precedente, cosicché alla Fiat <strong>di</strong>venta, in<br />
una comunione apparente d’efficienza e <strong>di</strong> familiarità, per tutti, in Fiat.<br />
Bibliografia<br />
Sergio Marroni<br />
marroni@lettere.uniroma2.it<br />
GGIC 2001<br />
Renzi Lorenzo, Salvi Giampaolo, Car<strong>di</strong>naletti Anna (a cura <strong>di</strong>), Grande<br />
grammatica italiana <strong>di</strong> consultazione, nuova ed., 3 voll., Bologna, il Mulino.<br />
Dardano&Trifone 1995<br />
Dardano Maurizio, Trifone Pietro, Grammatica italiana con nozioni <strong>di</strong><br />
linguistica, Bologna, Zanichelli.<br />
Della Valle&Patota 2007<br />
Della Valle Valeria, Patota Giuseppe, Il nuovo salvalingua, Milano,<br />
Sperling & Kupfer.<br />
Fornaciari 1884<br />
Fornaciari Raffaello, Sintassi italiana dell’uso moderno, II ed., Firenze,<br />
Sansoni.<br />
Lepschy&Lepschy 1981<br />
Lepschy Anna Laura, Lepschy Giulio C., La lingua italiana. Storia, varietà<br />
dell’uso, grammatica, Milano, Bompiani.<br />
Maiden&Robustelli 2007<br />
Maiden Martin, Robustelli Cecilia, A reference grammar of modern Italian,<br />
II ed., London, Hodder.
172<br />
Un caso <strong>di</strong> tendenza alla <strong>brevi</strong>tà sintattica nell’italiano contemporaneo<br />
Maraschio 1993<br />
Maraschio Nicoletta, “Grafia e ortografia: evoluzione e co<strong>di</strong>ficazione”,<br />
in L. Serianni, P. Trifone (a cura <strong>di</strong>), Storia della lingua italiana, vol. I, I<br />
luoghi della co<strong>di</strong>ficazione, Torino, Einau<strong>di</strong>.<br />
Me<strong>di</strong>obanca 2010<br />
Le principali società italiane (2010), Milano, Me<strong>di</strong>obanca – Ufficio Stu<strong>di</strong>.<br />
Patota 2006<br />
Patota Giuseppe, Grammatica <strong>di</strong> riferimento dell’italiano contemporaneo,<br />
Novara, De Agostini-‐‑Garzanti.<br />
Pran<strong>di</strong> 2006<br />
Pran<strong>di</strong> Michele, Le regole e le scelte. Introduzione alla grammatica, Torino,<br />
UTET.<br />
Salvi&Vanelli 2004<br />
Salvi Giampaolo, Vanelli Laura, Nuova grammatica italiana, Bologna, il<br />
Mulino.<br />
Serianni 1991<br />
Serianni Luca, con la collaborazione <strong>di</strong> Alberto Castelvecchi, Grammatica<br />
italiana. Italiano comune e lingua letteraria, II ed., Torino, UTET.<br />
Serianni 2004<br />
Serianni Luca, “Il sentimento della norma linguistica nell’Italia <strong>di</strong> <strong>oggi</strong>”,<br />
Stu<strong>di</strong> Linguistici Italiani 30, 85-‐‑103.
La traduzione delle sigle e degli acronimi dallo spagnolo all’italiano.<br />
Un problema <strong>di</strong> interpretazione linguistica e culturale<br />
Abstract<br />
Matteo Lefèvre<br />
L’articolo è de<strong>di</strong>cato all’analisi della traduzione degli acronimi dallo spagnolo<br />
all’italiano, focalizzando l’attenzione su questioni <strong>di</strong> natura linguistica, culturale e<br />
traduttologica. Dopo una prima parte definitoria, in cui particolare importanza è<br />
data al contesto dei linguaggi settoriali e sono descritti anche alcuni repertori e<br />
strumenti lessicografici specifici, si introducono rilievi <strong>di</strong> semantica e pragmatica<br />
applicate all’interpretazione e resa linguistica delle sequenze acronimiche. Viene<br />
infine proposta e analizzata una casistica <strong>di</strong> sigle e acronimi con equivalenti<br />
uniformi e <strong>di</strong>fformi tra la lingua spagnola e quella italiana e, conseguentemente,<br />
delle possibilità <strong>di</strong> traduzione che essi offrono.<br />
Parole chiave: acronimia, traduzione specializzata spagnolo-‐‑italiano, acronimi<br />
spagnoli, acronimi italiani, traduzione sigle<br />
This article is de<strong>di</strong>cated to the translation of the acronyms between spanish and<br />
italian language, focusing linguistic, cultural and traductological problems. After a<br />
first part concerning the definition of the acronym, especially in its importance in<br />
the special languages, we face semantics and pragmatics of the acronym translation<br />
and analyse some useful lexicographic instruments. Besides, we suggest a case<br />
record of spanish and italian acronyms underlining correspondence and <strong>di</strong>fference<br />
between them and proposing translation strategies and procedures.<br />
Keywords: acronyms, spanish-‐‑italian translation, spanish acronyms, italian<br />
acronyms, acronym translation<br />
Il problema della traduzione <strong>di</strong> sigle e acronimi rientra a pieno titolo<br />
nell’orizzonte della traduzione specializzata, nella casistica – teorica e<br />
pratica – che investe tanto i linguaggi settoriali in genere (giuri<strong>di</strong>co-‐‑<br />
economico, scientifico-‐‑tecnico, giornalistico ecc.) quanto, in particolare,<br />
l’universo dei tecnicismi che contribuiscono ad arricchire e connotare tali<br />
linguaggi. Eppure il ricorso all’acronimia non solo risponde all’alto<br />
coefficiente <strong>di</strong> densità e pregnanza che i <strong>di</strong>versi settori professionali
174<br />
La traduzione delle sigle e degli acronimi dallo spagnolo all’italiano<br />
richiedono al proprio linguaggio tecnico e ai propri addetti ai lavori – si<br />
pensi, a puro titolo <strong>di</strong> esempio, all’abbondanza <strong>di</strong> sigle <strong>di</strong> cui ci si serve in<br />
me<strong>di</strong>cina (TAC, ECG, EEC ecc.) –, ma riflette anche, in linea più generale, la<br />
tendenza alla sintesi e all’imme<strong>di</strong>atezza che è alla base della lingua<br />
standard e del moderno universo della comunicazione. In tal senso,<br />
viviamo davvero in un’epoca <strong>di</strong> “scritture <strong>brevi</strong>”, in cui la rapi<strong>di</strong>tà del<br />
sistema comunicativo, il cosiddetto “tempo reale” in cui tutto è chiamato a<br />
consumarsi, così come il brivido della velocità e della sintesi che permea<br />
ogni umana espressione, trovano uno strumento linguistico e una metafora<br />
efficace proprio nel costante utilizzo della siglazione, che dal linguaggio<br />
della politica a quello della scienza e dell’informazione funziona e seduce<br />
espressamente per la cripticità e al contempo la riconoscibilità del suo<br />
contenuto e dei suoi referenti. Sì, perché se pure certe sigle popolano in<br />
primo luogo le varie lingue <strong>di</strong> specialità e risultano spesso oscure ai non<br />
iniziati, è pur vero che in molti casi quegli stessi acronimi vengono poi<br />
integrati e decifrati nel sistema me<strong>di</strong>atico e <strong>di</strong> lì passano, ormai “in chiaro”,<br />
nel linguaggio comune. Se i gran<strong>di</strong> narratori dell’Ottocento – pensiamo a<br />
Balzac, a Dickens, a Galdós – pensavano il mondo come materia<br />
“romanzabile”, estensibile e declinabile all’infinito nelle sue <strong>di</strong>namiche, al<br />
contrario <strong>oggi</strong> abitiamo un tempo in cui tutto appare “ab<strong>brevi</strong>abile”,<br />
sintetizzabile ed etichettabile attraverso sigle della più varia origine e<br />
provenienza che, come <strong>di</strong>cevamo, superata l’oscurità iniziale,<br />
rappresentano una certezza culturale, un patrimonio rassicurante e<br />
con<strong>di</strong>viso da tutto il villaggio globale.<br />
Nel rapporto tra le lingue, dunque, l’acronimia ha ormai un’importanza<br />
centrale, che non soltanto si manifesta nei meccanismi <strong>di</strong> formazione <strong>di</strong> tali<br />
microstrutture, che rispondono al pensiero linguistico, alle consuetu<strong>di</strong>ni<br />
culturali e ideologiche del paese che le conia o le accoglie, ma che appare<br />
evidente anche nella sua traduzione, come fattore fondamentale della<br />
relazione che si stabilisce tra più universi linguistici e culturali. Le sigle,<br />
lungi perciò dall’essere esclusivamente un’espressione sintetica o un<br />
elemento dei <strong>di</strong>fferenti linguaggi tecnici, rappresentano un dato <strong>di</strong> realtà –<br />
quella che descrivono e sintetizzano –, più o meno comprensibile e<br />
con<strong>di</strong>visibile a livello internazionale e interlinguistico, e allo stesso tempo<br />
un elemento significativo <strong>di</strong> una cultura, sia essa specifica <strong>di</strong> un territorio,<br />
<strong>di</strong> un’area storica e geografica circoscritta oppure <strong>di</strong>ffusa in misura più<br />
ampia. In questa prospettiva, pertanto, riteniamo che molti acronimi<br />
possano essere assimilati ai culturemi e che come tali vadano svincolati da
M. Lefèvre 175<br />
una mera esistenza tecnica e funzionale: soprattutto certe sigle in<strong>di</strong>cative <strong>di</strong><br />
una determinata realtà storica, politica, sociale assumono un valore<br />
precipuo nella definizione e nella conoscenza della nazione che le ha<br />
prodotte e che le utilizza regolarmente e costituiscono uno snodo cruciale<br />
nella comprensione e nella traduzione <strong>di</strong> tale universo culturale e<br />
linguistico. Se infatti è vero che la maggior parte degli acronimi <strong>di</strong>ffusi nel<br />
mondo globalizzato sono <strong>di</strong> matrice anglosassone e che, più che incarnare<br />
caratteristiche specifiche <strong>di</strong> tale cultura, costituiscono strutture <strong>di</strong> uso<br />
generalizzato, <strong>di</strong> sicura riconoscibilità e agevole comprensione<br />
internazionale – si pensi a sigle come ONU, UEFA, CIA ecc. –, è altrettanto<br />
manifesto che ogni paese, ogni peculiare identità linguistica, <strong>di</strong>nanzi ad<br />
esse si comporta in modo <strong>di</strong>fferente, accogliendole nella loro veste<br />
originale o “nazionalizzandole” – è quanto osserveremo puntualmente nel<br />
caso spagnolo –, ma soprattutto crea continuamente delle sigle proprie, che<br />
a volte sostituiscono in toto i referenti dell’acronimia globale o, più spesso,<br />
identificano determinate realtà nazionali, locali. E naturalmente, ai fini<br />
della traduzione, sono proprio queste ultime, cioè le microstrutture non<br />
in<strong>di</strong>viduabili e funzionanti su un piano internazionale, che creano i<br />
maggiori problemi <strong>di</strong> interpretazione e ancor più <strong>di</strong> resa linguistica tra due<br />
o più lingue. Nell’analisi del rapporto spagnolo-‐‑italiano, come vedremo,<br />
ciò è particolarmente evidente.<br />
Come la traduzione nel suo complesso, pertanto, anche la traduzione<br />
delle sequenze acronimiche, <strong>di</strong> un elemento in apparenza marginale,<br />
criptico, sintetico e “ristretto” all’interno del corpus lessicale, collabora a<br />
svelare analogie e <strong>di</strong>fferenze tra le lingue coinvolte a livello <strong>di</strong> abitu<strong>di</strong>ni<br />
morfosintattiche, <strong>di</strong> prospettive culturali e perfino <strong>di</strong> istanze ideologiche.<br />
Nel rapporto tra spagnolo e italiano, ad esempio, ciò si può facilmente<br />
osservare nel caso dell’acquisizione e riproposizione <strong>di</strong> sigle <strong>di</strong> origine<br />
straniera – dal punto <strong>di</strong> vista linguistico sono prestiti a tutti gli effetti –, le<br />
cui strategie <strong>di</strong> interpretazione (e <strong>di</strong> traduzione) mettono spesso in luce non<br />
solo le <strong>di</strong>verse consuetu<strong>di</strong>ni grammaticali <strong>di</strong> ogni i<strong>di</strong>oma, ma anche il<br />
pensiero linguistico e l’approccio culturale nei confronti dell’altro che esso<br />
porta con sé. Allo stesso tempo, però, anche nei confronti dell’acronimia<br />
tutta spagnola il processo traduttivo consente <strong>di</strong> esaminare tendenze<br />
linguistiche e fattori culturali che animano i meccanismi <strong>di</strong> formazione <strong>di</strong><br />
queste strutture, che investono appunto l’orizzonte dei culturemi.
176<br />
La traduzione delle sigle e degli acronimi dallo spagnolo all’italiano<br />
E infine, non si può sottovalutare il <strong>di</strong>scorso legato alla pragmatica della<br />
traduzione. Anche nei confronti dell’acronimia il contesto in cui<br />
l’operazione traduttiva viene effettuata ha un’importanza fondamentale. Si<br />
tratta, pertanto, <strong>di</strong> “me<strong>di</strong>are” tra testo e contesto, tra ciò che si traduce e<br />
l’orizzonte <strong>di</strong> attesa, tra le esigenze <strong>di</strong> un determinato linguaggio e settore<br />
professionale e quelle del luogo – testuale e situazionale – in cui la<br />
traduzione si produce, della tipologia e del destinatario <strong>di</strong> un testo e della<br />
sua versione tradotta. Nel caso spagnolo-‐‑italiano, ad esempio, i maggiori<br />
problemi sorgono <strong>di</strong> fronte alle sigle <strong>di</strong> matrice ispanica, che non sempre<br />
trovano degli equivalenti funzionali al contesto <strong>di</strong> enunciazione e ricezione<br />
italiano e che spesso necessitano <strong>di</strong> esplicitazioni e soluzioni <strong>di</strong><br />
compromesso la cui opportunità e le cui modalità sono dettate proprio dal<br />
singolo ambito testuale e settoriale nel quale si esercita la traduzione.<br />
1. Questioni preliminari<br />
1.1. Morfosintassi<br />
L’uso delle sigle è ormai un fenomeno in grande espansione e, oltre ad<br />
essere un punto critico del rapporto tra l’inglese e le altre lingue, suscita<br />
spesso dubbi in merito alla natura e alla collocazione morfosintattica <strong>di</strong> tali<br />
microstrutture nonché incertezze nella pronuncia e nella deco<strong>di</strong>fica.<br />
Richiamiamo in primo luogo la definizione che <strong>di</strong> sigla e acronimo<br />
fornisce il Diccionario de la Real Academia Española (DRAE 2001):<br />
sigla.<br />
1. f. Palabra formada por el conjunto<br />
de letras iniciales de una expresión<br />
compleja; p. ej., O(rganización de)<br />
N(aciones) U(nidas), o(bjeto) v(olante)<br />
n(o) i(dentificado), Í(n<strong>di</strong>ce de) P(recios<br />
al) C(onsumo).<br />
acrónimo.<br />
1. m. Tipo de sigla que se pronuncia<br />
como una palabra; p. ej., o(bjeto)<br />
v(olador) n(o) i(dentificado).<br />
2. m. Vocablo formado por la unión de<br />
elementos de dos o más palabras,<br />
constituido por el principio de la<br />
primera y el final de la última, p. ej.,<br />
ofi(cina infor)mática, o, frecuentemente,<br />
por otras combinaciones, p. ej., so(und)<br />
n(avigation) a(nd) r(anging), Ban(co)<br />
es(pañol) (de) (cré<strong>di</strong>)to.
M. Lefèvre 177<br />
Al <strong>di</strong> là della sottile <strong>di</strong>fferenza in<strong>di</strong>viduata dal DRAE, la mera<br />
definizione <strong>di</strong> sigla e acronimo non fornisce spunti particolari ai fini del<br />
rilievo morfosintattico e ancor meno dell’operazione traduttiva se non per<br />
il riscontro <strong>di</strong> una sostanziale omogeneità tra spagnolo e italiano<br />
nell’utilizzo dei due termini, che in queste pagine useremo<br />
in<strong>di</strong>fferentemente poiché <strong>di</strong> fatto sinonimi o comunque inquadrabili allo<br />
stesso modo all’interno del <strong>di</strong>scorso sulla traduzione. In ogni caso, per<br />
quanto riguarda la morfosintassi, va rilevato che tanto in spagnolo quanto<br />
in italiano esistono sigle che si comportano come sostantivi e finiscono per<br />
incorporarsi al lessico comune. È il caso <strong>di</strong> acronimi come láser (Light<br />
Amplification by Stimulated Emission of Ra<strong>di</strong>ation), radar e ovni, che in effetti anche<br />
nei loro equivalenti italiani – laser, radar e ufo – risultano pienamente<br />
lessicalizzati e perciò considerati vocaboli tout court, rispondenti in pieno<br />
alle regole della flessione e della sintassi. Queste sigle sono dunque<br />
<strong>di</strong>ventate lessemi a tutti gli effetti, si sottraggono, in quanto ormai nomi<br />
comuni, a qualsiasi uso della maiuscola iniziale e recano anche una tilde<br />
secondo il sistema accentuativo dello spagnolo (láser) e sono pluralizzabili<br />
(láseres). Proprio perché presenti in entrambe le lingue, alcuni acronimi<br />
lessicalizzati non pongono particolari problemi <strong>di</strong> traduzione (è il caso <strong>di</strong><br />
radar, graficamente identico nei due i<strong>di</strong>omi), tuttavia in altri casi<br />
l’interpretazione e la resa linguistica sono più problematiche, poiché<br />
spagnolo e italiano ricorrono a sigle <strong>di</strong>verse per in<strong>di</strong>care la medesima realtà<br />
(è il caso <strong>di</strong> ovni → ufo).<br />
1.2. Tendenze della lingua spagnola e italiana <strong>di</strong> fronte all’acronimia<br />
Quest’ultimo <strong>di</strong>scorso ci invita a considerare, ai fini <strong>di</strong> una coerente e<br />
corretta traduzione degli acronimi, la <strong>di</strong>fferente tendenza che mostrano<br />
spagnolo e italiano nei meccanismi <strong>di</strong> formazione delle sigle. Se appunto<br />
torniamo all’esempio precedente, <strong>di</strong> fronte all’acronimo lessicalizzato <strong>di</strong><br />
matrice anglosassone ufo (Unidentified Flying Object), notiamo che in<br />
italiano tale sigla è ripresa in maniera integrale, mentre in spagnolo si<br />
ricorre all’acronimo ovni (Objeto Volador No Identificado), che si genera<br />
dalla traduzione letterale dei costituenti dell’espressione originale.<br />
Possiamo <strong>di</strong>re che spesso la lingua spagnola opera in tal modo <strong>di</strong> fronte a<br />
sigle <strong>di</strong> origine straniera, ma al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> questa tendenza generale non<br />
mancano numerosi casi in cui, invece, anche in spagnolo troviamo la<br />
riproposizione imme<strong>di</strong>ata <strong>di</strong> un acronimo <strong>di</strong> provenienza inglese (ad es.
178<br />
La traduzione delle sigle e degli acronimi dallo spagnolo all’italiano<br />
FBI → FBI). In questa prospettiva, nella Grammatica spagnola <strong>di</strong> Manuel<br />
Carrera Díaz, che ha un <strong>di</strong>chiarato approccio contrastivo, il problema delle<br />
sigle è affrontato proprio nel paragrafo de<strong>di</strong>cato ai forestierismi. Nota<br />
correttamente Carrera che tra spagnolo e italiano risulta<br />
[…] <strong>di</strong>versa la procedura <strong>di</strong> formazione delle sigle provenienti da espressioni<br />
straniere. In italiano normalmente vengono prese <strong>di</strong> peso dalla lingua che le ha<br />
coniate: NATO (North Atlantic Treaty Organization), AIDS (Acquired<br />
ImmunoDeficiency Syndrome). In spagnolo molte volte si traduce prima<br />
l’espressione straniera e poi si forma la sigla: OTAN (Organización del Atlántico<br />
Norte), SIDA (Síndrome de InmunoDeficiencia Adquirida), ma non sempre è così:<br />
anche in spagnolo la nota Central Intelligence Agency si conosce con la sigla CIA<br />
(Carrera Díaz 1997, 24).<br />
L’atteggiamento delle due lingue <strong>di</strong>nanzi alle sigle <strong>di</strong> provenienza<br />
straniera è dunque simile a quello che si ha con i prestiti, che appunto<br />
possono essere integrali o adattati e che lo spagnolo tende spesso a<br />
“ispanizzare”, a omologare al proprio sistema grammaticale (ortografia,<br />
fonetica, genere ecc.). E ai fini della traduzione italiana, proprio la peculiare<br />
abitu<strong>di</strong>ne della lingua spagnola rispetto agli extranjerismos può in alcuni<br />
casi creare dei problemi <strong>di</strong> decifrazione al cospetto <strong>di</strong> acronimi che sono<br />
noti sul piano internazionale nella loro forma originale, ma che rischiano <strong>di</strong><br />
risultare criptici nella loro veste spagnola (si vedano gli esempi appena<br />
citati: NATO → OTAN; AIDS → SIDA).<br />
Problemi <strong>di</strong> decifrazione e interpretazione<br />
Prima <strong>di</strong> osservare da vicino casistica e strategie della traduzione<br />
italiana degli acronimi che si riscontrano nella lingua spagnola, è<br />
opportuno richiamare alcuni strumenti che consentono una dettagliata<br />
ricerca e un preciso scioglimento <strong>di</strong> tali sigle. In questa sede è<br />
imprescin<strong>di</strong>bile segnalare soprattutto alcuni siti internet specializzati e<br />
alcune banche dati on line che non solo annoverano e decifrano un<br />
amplissimo repertorio degli acronimi più <strong>di</strong>ffusi nell’universo ispanico, ma<br />
spesso forniscono su questi ultimi anche notizie storiche e ulteriori dettagli<br />
utili alla loro interpretazione. Tra i più interessanti e completi siti web <strong>di</strong><br />
questo tipo va ricordato in primo luogo quello <strong>di</strong> Acronym finder<br />
(http://www.acronymfinder.com). All’interno <strong>di</strong> questo portale è possibile<br />
in<strong>di</strong>viduare agevolmente acronimi in varie lingue, e per moltissimi <strong>di</strong> essi è
M. Lefèvre 179<br />
fornita anche una spiegazione etimologica e storica nonché, ove possibile, il<br />
link corrispondente. Si veda l’esempio del BOE spagnolo:<br />
Boletín Oficial del Estado<br />
The Boletín Oficial del Estado (BOE), Spanish for Official Bulletin of the State, is the<br />
official gazette of the Government of Spain. It publishes the laws of the Cortes<br />
Generales (the nation'ʹs legislature, comprising the Senate and the Congress of<br />
Deputies) and the <strong>di</strong>spositions of the Autonomous Communities. Also, ju<strong>di</strong>cial<br />
rulings, royal decrees, and decrees of the Council of Ministers are published in it.<br />
From 1600 to 1900 was called the Gaceta de Madrid.<br />
See also<br />
Boletín Oficial del Estado (Spanish Wikipe<strong>di</strong>a)<br />
External links<br />
Official website of the Boletín Oficial del Estado (BOE)<br />
Vi è poi anche il sito <strong>di</strong> Acronyma (http://www.acronyma.com/), il cui<br />
data-‐‑base, per quanto ampio, appare tuttavia meno completo e capillare <strong>di</strong><br />
Acronym finder. Molto utile è invece il Libro de Estilo Interinstitucional<br />
dell’Unione Europea (Manuale interistituzionale <strong>di</strong> convenzioni redazionali<br />
della UE), anch’esso <strong>di</strong>sponibile on line<br />
(http://publications.europa.eu/code/es/es-‐‑5000400.htm): si trovano qui i più<br />
significativi acronimi del settore giuri<strong>di</strong>co-‐‑amministrativo nelle lingue dei<br />
paesi della UE, e la finestra <strong>di</strong> consultazione consente agevolmente <strong>di</strong><br />
passare da una lingua a un’altra, offrendo dunque la possibilità <strong>di</strong><br />
comparare i costituenti <strong>di</strong> una determinata sigla nei principali i<strong>di</strong>omi<br />
europei. De<strong>di</strong>cato specificamente alle regole dell’ortografia ispanica è poi il<br />
sito <strong>di</strong> Reglas de Ortografía, che tra le varie sezioni ne ha una de<strong>di</strong>cata<br />
espressamente a sigle e acronimi <strong>di</strong>ffusi in lingua spagnola<br />
(http://www.reglasdeortografia.com/siglasyacronimos.html). E infine,<br />
naturalmente, non si <strong>di</strong>mentichino neppure i vocabolari monolingui più<br />
aggiornati, dal celebre DRAE, anch’esso dotato <strong>di</strong> versione on line<br />
(http://www.rae.es), al CLAVE, uno dei migliori <strong>di</strong>zionari d’uso<br />
(http://clave.librosvivos.net/), i quali comunque inventariano un numero<br />
molto limitato <strong>di</strong> sigle (per lo più sono presenti gli acronimi lessicalizzati e
180<br />
La traduzione delle sigle e degli acronimi dallo spagnolo all’italiano<br />
più consolidati) e non consentono una decifrazione e comparazione <strong>di</strong><br />
questi ultimi in rapporto alle sigle straniere corrispondenti.<br />
2. La traduzione delle sigle e degli acronimi dallo spagnolo all’<br />
italiano<br />
2.1 Problemi e casistica generale<br />
Come detto, le sigle si possono trovare in qualsiasi ambito professionale<br />
e comunicativo, dalla giurisprudenza alla me<strong>di</strong>cina, dalla pubblicità<br />
all’industria. In un contesto pluri<strong>di</strong>sciplinare e su un piano generale,<br />
limitatamente al problema della relazione e della traduzione spagnolo-‐‑<br />
italiano, possiamo in<strong>di</strong>viduare tre tipi <strong>di</strong> sigle:<br />
a) le sigle che hanno una precisa corrispondenza nella nostra lingua, per<br />
lo più <strong>di</strong> provenienza anglosassone (FIFA, ONU, CIA)<br />
b) quelle che non hanno una corrispondenza in italiano perché legate a<br />
specifiche realtà ispaniche (PSOE → Partido Socialista Obrero Español;<br />
LOGSE → Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo;<br />
CCAA → Comunidades Autónomas);<br />
c) gli acronimi lessicalizzati e ormai parte integrante del vocabolario <strong>di</strong><br />
entrambe le lingue (radar, láser, sónar).<br />
a) Appartengono generalmente alla prima categoria le sigle<br />
internazionali, circolanti nella più estesa realtà europea o mon<strong>di</strong>ale. In certi<br />
frangenti, quando la sigla è <strong>di</strong> amplissima circolazione, è possibile che<br />
entrambe le lingue la prendano con la formula del prestito non adattato:<br />
UEFA, UNESCO, UNICEF ecc. In questi casi, dunque, la lingua spagnola<br />
non traduce la sigla per poi riproporla secondo il proprio sistema<br />
grammaticale (come faceva invece nel caso <strong>di</strong> ovni rispetto a ufo), ma la<br />
riprende integralmente. Ad ogni modo, anche quando lo spagnolo traduce<br />
l’acronimo straniero per poi coniarne un equivalente nazionale, nella<br />
migliore delle ipotesi c’è una totale coincidenza tra le due lingue: è il caso<br />
<strong>di</strong> FMI, che a fronte della sigla originale inglese (IMF) vale sia per Fondo<br />
Monetario Internacional sia per Fondo Monetario Internazionale; oppure <strong>di</strong>
M. Lefèvre 181<br />
ONU, che traduce sia Organización de las Naciones Unidas sia Organizzazione<br />
delle Nazioni Unite. Ovviamente, esempi <strong>di</strong> questo tipo non generano alcun<br />
problema <strong>di</strong> traduzione in italiano.<br />
In altre occasioni, tuttavia, e soprattutto con sigle <strong>di</strong> derivazione<br />
anglosassone, può darsi che lo spagnolo adatti la sigla e l’italiano no. Ad<br />
esempio, l’inglese AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) passa nella<br />
nostra lingua con il medesimo or<strong>di</strong>namento <strong>di</strong> parole della sigla originale,<br />
anche se quando capita <strong>di</strong> sciogliere l’acronimo <strong>di</strong>ciamo «Sindrome da<br />
Immuno-‐‑Deficienza Acquisita»; in spagnolo, invece, AIDS <strong>di</strong>venta SIDA, il<br />
cui or<strong>di</strong>ne riflette la traduzione e l’adattamento al proprio sistema<br />
linguistico (Síndrome de Inmuno-‐‑Deficiencia Adquirida). In questo modo<br />
funzionano moltissimi acronimi <strong>di</strong>ffusi nella lingua spagnola, e proprio il<br />
campo della me<strong>di</strong>cina sembra essere in tal senso un territorio fertile per<br />
questa tendenza e per evidenziare le <strong>di</strong>verse abitu<strong>di</strong>ni tra spagnolo e<br />
italiano, che per lo più riprende la <strong>di</strong>citura e l’acronimo inglese, abitu<strong>di</strong>ni<br />
che naturalmente invitano a porre particolare attenzione nel momento<br />
dell’interpretazione e della traduzione. Si veda giusto qualche altro<br />
esempio:<br />
Italiano:<br />
HIV (Human Inmunodeficiency Virus)<br />
RNA (Ribonucleic Acid)<br />
RES (Reticuloendothelial system)<br />
STD (Sexually transmitted <strong>di</strong>sease)<br />
WBC (White blood cell count)<br />
Spagnolo:<br />
VIH (Virus de la inmunodeficiencia<br />
humana)<br />
ARN (Ácido ribonucléico)<br />
SRE (Sistema reticuloendotelial)<br />
ETS (Enfermedad de transmisión<br />
sexual)<br />
RL (Recuento de leucocitos)<br />
In generale, sul fronte della resa linguistica proprio la tendenza alla<br />
“ispanizzazione” degli acronimi <strong>di</strong> matrice anglosassone può far sì che<br />
alcune sequenze appaiano <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficile riconoscibilità – specialmente se non<br />
si ha esperienza del contesto <strong>di</strong> enunciazione <strong>di</strong> queste ultime e dell’ambito<br />
linguistico e professionale <strong>di</strong> riferimento –, mentre in realtà nascondono le<br />
sigle <strong>di</strong> più comune dominio. Nei casi più eclatanti, comunque, un
182<br />
La traduzione delle sigle e degli acronimi dallo spagnolo all’italiano<br />
semplice vocabolario bilingue aiuta a sciogliere l’acronimo e a ricondurlo al<br />
più familiare ambito italiano. In altre occasioni, invece, ai fini <strong>di</strong> una<br />
corretta <strong>di</strong>sambiguazione e della successiva riproposizione in italiano della<br />
sequenza occorre ricorrere alla consultazione <strong>di</strong> quei vocabolari<br />
monolingui che contengono un regesto delle sigle più conosciute e usate<br />
oppure ai <strong>di</strong>zionari bilingui generali e <strong>di</strong> settore 1; ma in genere risultano<br />
più efficaci gli strumenti del web, dai forum ai <strong>di</strong>versi corpora linguistici e<br />
alle varie banche dati on line a cui abbiamo fatto riferimento, fino ai veri e<br />
propri traduttori on line 2, che in certi casi danno esiti sod<strong>di</strong>sfacenti.<br />
b) Possono essere inseriti nel secondo gruppo quegli acronimi spagnoli<br />
che mancano <strong>di</strong> una corrispondenza a livello internazionale e che,<br />
ovviamente, non hanno degli equivalenti italiani imme<strong>di</strong>ati. Sono sigle del<br />
tipo: INEM (Instituto Nacional de Empleo); TAPEA (Texto Articulado del<br />
Proce<strong>di</strong>miento Económico Administrativo); o il già ricordato BOE (Boletín<br />
Oficial del Estado). In questi casi la realtà espressa dalla sigla fa riferimento<br />
esclusivamente al contesto storico, politico, sociale spagnolo e pertanto<br />
l’acronimo può essere considerato alla stregua <strong>di</strong> un culturema. Va da sé che<br />
cercare o ideare una sigla equivalente italiana sarebbe una forzatura: il BOE<br />
spagnolo, che pure ha la medesima funzione della Gazzetta Ufficiale<br />
italiana, non può tradursi e “ab<strong>brevi</strong>arsi” in GU e necessita <strong>di</strong> una strategia<br />
<strong>di</strong> resa e spiegazione <strong>di</strong>fferente. Inoltre, la sigla ha un suo valore pregnante<br />
che non può essere alterato, e non è pertanto praticabile neppure la strada<br />
<strong>di</strong> adattare le lettere secondo i principi linguistici italiani riproducendone le<br />
iniziali tradotte: una sigla *BUS (Bollettino Ufficiale dello Stato) per rendere<br />
in italiano il BOE non è naturalmente accettabile né a livello teorico né<br />
1 Giusto per fare un esempio legato a un linguaggio settoriale ampio e <strong>di</strong>fferenziato, sul fronte<br />
giuri<strong>di</strong>co-‐‑amministrativo ricor<strong>di</strong>amo il Dizionario commerciale, a cura <strong>di</strong> A. M. Gallina, Milano,<br />
Mursia, 1992; il Dizionario giuri<strong>di</strong>co: italiano-‐‑spagnolo, español-‐‑italiano, a cura <strong>di</strong> Luigi Di Vita e<br />
Maria Gabriella Piemonte, Milano, Giuffrè, 2001; e il più recente Dizionario spagnolo economico<br />
& commerciale, a cura <strong>di</strong> L. Tam, Milano, Hoepli, 2006.<br />
2 Tra i forum generali, per altro orientati al confronto tra <strong>di</strong>verse lingue, menzioniamo il<br />
celebre WordReference (http://www.wordreference.com) e il sito http://www.proz.com/search,<br />
in cui è possibile reperire interessanti suggerimenti relativi soprattutto all’ambito giuri<strong>di</strong>co.<br />
Per le banche dati ci siamo limitati alla raccolta dell’Euro<strong>di</strong>cautom (http://iate.europa.eu),<br />
vincolata per lo più al linguaggio della burocrazia internazionale, e, limitatamente a sigle e<br />
acronimi, al già ricordato sito <strong>di</strong> Acronym finder (http://www.acronymfinder.com), ma ulteriori<br />
in<strong>di</strong>rizzi sono localizzabili nel libro <strong>di</strong> Bruno Osimo, Traduzione e nuove tecnologie, Milano,<br />
Hoepli, 2001. Infine, <strong>di</strong> fronte all’acronimia più semplice e invalsa, può risultare utile perfino il<br />
traduttore automatico del noto motore <strong>di</strong> ricerca Google (http://translate.google.com).
M. Lefèvre 183<br />
pratico, poiché tra l’altro non risolverebbe il problema della riconoscibilità<br />
e della corretta interpretazione nel contesto <strong>di</strong> arrivo. In questi casi, è<br />
preferibile <strong>di</strong> norma mantenere la sigla spagnola nella sua integralità,<br />
riservando lo scioglimento del suo significato tra le righe, in una parentesi<br />
seguente o in una nota al testo.<br />
c) Infine, la traduzione spagnolo-‐‑italiano degli acronimi lessicalizzati è<br />
in linea <strong>di</strong> massima agevole, poiché essi sono ormai entrati a far parte della<br />
lingua standard o <strong>di</strong> certi linguaggi <strong>di</strong> settore in entrambi gli i<strong>di</strong>omi. Questi<br />
acronimi per lo più provengono dall’inglese, dove anche hanno assunto il<br />
valore <strong>di</strong> lessemi a tutti gli effetti, e sono per lo più introdotti nelle due<br />
lingue come prestiti integrali (radar → radar, sónar → sonar, quásar → quasar<br />
ecc.), il che appunto, con le dovute eccezioni (è il caso più volte ricordato <strong>di</strong><br />
ovni → ufo), non crea particolari problemi traduttivi.<br />
2.2. Ipotesi per una casistica puntuale della traduzione italiana <strong>di</strong><br />
acronimi in lingua spagnola<br />
Se affrontiamo sistematicamente e capillarmente il problema della resa<br />
in italiano degli acronimi e delle sigle <strong>di</strong>ffuse nella lingua spagnola,<br />
possiamo ricostruire un quadro piuttosto ampio e articolato che non solo<br />
dà conto <strong>di</strong> una casistica complessa, ma offre anche tutta una serie <strong>di</strong><br />
spunti utili ai fini <strong>di</strong> una traduzione efficace sul piano interlinguistico e<br />
pragmalinguistico. Si tratta <strong>di</strong> un’analisi sistematica che ha a che vedere<br />
con la pratica concreta della traduzione, spesso dettata dalle necessità <strong>di</strong> un<br />
determinato ambito professionale, e che allo stesso tempo investe questioni<br />
più generali <strong>di</strong> teoria e metodologia della traduzione. Certo, non è nostra<br />
intenzione enunciare qui assunti definitivi, e tantomeno fornendo un<br />
quadro che, per quanto omogeneo, non può pretendere <strong>di</strong> essere esaustivo<br />
a fronte della continua proliferazione ed espansione dell’acronimia nel<br />
tessuto della comunicazione linguistica internazionale, <strong>di</strong> cui Spagna e<br />
Italia rappresentano esclusivamente due realtà circoscritte; tuttavia,<br />
proprio la serie degli esempi che proponiamo consente a nostro avviso <strong>di</strong><br />
ottenere una buona dose <strong>di</strong> esperienza e <strong>di</strong>mestichezza e può fornire al<br />
traduttore elementi utili a valutare e operare le proprie scelte. In primo<br />
luogo, è il caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>videre l’insieme in due gran<strong>di</strong> categorie: le sigle<br />
internazionali e le sigle spagnole.
184<br />
La traduzione delle sigle e degli acronimi dallo spagnolo all’italiano<br />
Nel primo caso, come ricordato in più occasioni nel corso <strong>di</strong> queste<br />
pagine, il problema della formazione dell’acronimo in lingua spagnola e<br />
della sua traduzione italiana va inquadrato all’interno del comportamento<br />
<strong>di</strong> ogni i<strong>di</strong>oma nei confronti dei forestierismi e dei prestiti. È quanto cerca<br />
<strong>di</strong> sintetizzare lo specchietto seguente, che appunto in tal senso dà conto<br />
della versione spagnola dell’acronimo straniero e del suo equivalente<br />
italiano.<br />
2.2.1. Sigle internazionali<br />
prestito non adattato con equivalente identico:<br />
CIA → CIA<br />
UEFA → UEFA<br />
FIFA → FIFA<br />
Interpol → Interpol<br />
Láser → Laser<br />
prestito adattato con equivalente identico:<br />
FMI (Fondo Monetario Internacional) → FMI (Fondo Monetario<br />
Internazionale)<br />
ONU (Organización de las Naciones Unidas) → ONU (Organizzazione<br />
delle Nazioni Unite)<br />
prestito adattato con equivalente <strong>di</strong>fforme:<br />
ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) →<br />
UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)<br />
VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) → HIV (Human Immunodeficiency<br />
Virus)<br />
OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos) → OCSE<br />
(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico)<br />
OMG (Organismo Mo<strong>di</strong>ficato Genéticamente) → OGM (Organismo<br />
Geneticamente Mo<strong>di</strong>ficado)<br />
Come può notarsi, la casistica contempla sia esempi <strong>di</strong> cui abbiamo<br />
ampiamente <strong>di</strong>scusso sia altri casi, quali i <strong>di</strong>versi adattamenti che spagnolo<br />
e italiano propongono <strong>di</strong> un acronimo <strong>di</strong> provenienza straniera. A tal
M. Lefèvre 185<br />
proposito, in particolare si noti che nel caso delle sigle che in spagnolo<br />
risultano dei prestiti adattati con equivalente <strong>di</strong>fforme – il terzo caso qui<br />
proposto –, l’italiano tende in alcuni frangenti a mantenere la sigla<br />
d’origine senza tradurla (ad es. UNHCR), in altri a proporre una propria<br />
versione adattata dell’acronimo <strong>di</strong> partenza (ad es. OCSE).<br />
Nel caso delle sigle <strong>di</strong> origine spagnola, che dunque anche nella loro<br />
veste grafica e nella loro morfologia rispondono appieno alle consuetu<strong>di</strong>ni<br />
grammaticali del proprio i<strong>di</strong>oma, il problema della traduzione italiana si fa<br />
più complicato, anche perché la resa puntuale dell’acronimo non investe<br />
solamente la <strong>di</strong>mensione linguistica, ma anche quella culturale, che per sua<br />
natura ha in sé una rete <strong>di</strong> implicazioni e sfumature molto fitta. Inoltre, la<br />
casistica <strong>di</strong> sigle che offriamo <strong>di</strong> seguito permette <strong>di</strong> commentare svariati<br />
aspetti delle problematiche traduttive che non riguardano soltanto la sfera<br />
dell’acronimia, ma che rimandano anche a <strong>di</strong>namiche più generali che si<br />
innescano, in maniera consueta o inattesa, nella traduzione dallo spagnolo<br />
all’italiano.<br />
2.2.2. Sigle spagnole<br />
acronimo spagnolo con equivalente e significato identici:<br />
MAE (Ministerio de Asuntos Exteriores) → MAE (Ministero degli Affari<br />
Esteri)<br />
IVA (Impuesto sobre el Valor Aña<strong>di</strong>do) → IVA (Imposta sul Valore<br />
Aggiunto)<br />
acronimo spagnolo con equivalente <strong>di</strong>fforme ma significato identico:<br />
PNB (Producto Nacional Bruto) o PIB (Producto Interior Bruto) → PIL<br />
(Prodotto Interno Lordo)<br />
OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) → AIEA (Agenzia<br />
Internazionale per l’Energia Atomica)<br />
INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social) → INPS (Istituto Nazionale<br />
Previdenza Sociale)<br />
acronimo spagnolo con equivalente identico e significato <strong>di</strong>fferente:<br />
ETS (Enfermedad de Transmisión Sexual) ≠ ETS (E<strong>di</strong>zioni Universitarie –<br />
Pisa)
186<br />
La traduzione delle sigle e degli acronimi dallo spagnolo all’italiano<br />
CEI (Comunidad de Estados Indepen<strong>di</strong>entes o Consejo Europeo de<br />
Investigación) ≠ CEI (Conferenza Episcopale Italiana)<br />
MEC (Ministerio de Educación y Cultura o Marco Europeo de<br />
Cualificaciones) ≠ MEC (Mercato Comune Europeo)<br />
acronimo spagnolo con equivalente <strong>di</strong>fforme ma con funzione e significato<br />
analoghi:<br />
AVE (Alta Velocidad Española) → TAV (Treno ad Alta Velocità)<br />
CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) → CNR (Consiglio<br />
Nazionale delle Ricerche)<br />
RENFE (REd Nacional de FErrocarriles) → FFSS (Ferrovie dello Stato)<br />
BOE (Boletín Oficial del Estado) → GU (Gazzetta Ufficiale)<br />
acronimo spagnolo senza equivalente in italiano:<br />
a) realtà storico-‐‑politica:<br />
GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación)<br />
ETA (Euska<strong>di</strong> Ta Askatasuna)<br />
b) realtà storico-‐‑culturale:<br />
RAE (Real Academia Española)<br />
c) realtà socio-‐‑culturale:<br />
BUP (Bachillerato Unificado Polivalente)<br />
ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria)<br />
d) realtà geo-‐‑politica e amministrativa:<br />
CCAA (Comunidades Autónomas)<br />
Diversi sono i rilievi che si possono formulare a fronte <strong>di</strong> tale<br />
sud<strong>di</strong>visione che, per quanto arbitraria e ine<strong>di</strong>ta, ci sembra poter<br />
riassumere gran parte della casistica in oggetto. In primo luogo, sul fronte<br />
della ricerca e del lavoro traduttivo, è opportuno rilevare che se pure
M. Lefèvre 187<br />
ognuno dei gruppi in cui abbiamo sud<strong>di</strong>viso le sigle spagnole presenta un<br />
coefficiente <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà variabile ai fini della decifrazione e della<br />
susseguente traduzione italiana <strong>di</strong> ognuna <strong>di</strong> esse, tuttavia una ricerca<br />
attraverso i siti web e gli strumenti lessicografici più adeguati consente al<br />
traduttore <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare con un sufficiente margine <strong>di</strong> certezza la realtà<br />
storica e culturale a cui l’acronimo spagnolo rinvia e quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> guidare la<br />
versione italiana nella giusta <strong>di</strong>rezione. Per una <strong>di</strong>sambiguazione e una<br />
resa linguisticamente e culturalmente efficace della sigla spagnola appare<br />
poi sempre decisivo, come abbiamo già rimarcato, il contesto <strong>di</strong><br />
enunciazione del testo <strong>di</strong> partenza, che consente dapprima al traduttore <strong>di</strong><br />
sciogliere e interpretare l’acronimo originale e quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> riproporlo<br />
adeguatamente nel proprio universo linguistico e culturale. Il terzo gruppo,<br />
ad esempio, annovera <strong>di</strong> fatto una sorta <strong>di</strong> “falsi amici” acronimici, cioè<br />
delle sigle che, se non ben analizzate e contestualizzate – non tanto<br />
linguisticamente, ma tematicamente e a livello <strong>di</strong> referente –, possono<br />
creare non pochi imbarazzi in sede <strong>di</strong> traduzione (si vedano gli esempi CEI<br />
e MEC). L’orizzonte referenziale del testo è pertanto centrale nella corretta<br />
lettura <strong>di</strong> certe sigle, e ciò risulta particolarmente evidente quando una<br />
medesima sequenza rimanda a più significati, a <strong>di</strong>fferenti realtà. Ma<br />
questioni <strong>di</strong> pragmatica ovviamente entrano in gioco anche a proposito<br />
delle strategie con cui tradurre un determinato acronimo nel contesto <strong>di</strong><br />
ricezione, tanto all’interno delle <strong>di</strong>namiche testuali e grammaticali della<br />
lingua d’arrivo quanto nel sistema storico, culturale e sociale in cui la<br />
traduzione viene proposta. In questo senso, come <strong>di</strong>cevamo poco sopra,<br />
alcune sigle acquisiscono a tutti gli effetti il valore <strong>di</strong> culturemi e a livello <strong>di</strong><br />
traduzione vanno trattate come tali, con tutte le <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> interpretazione<br />
e resa linguistica che ciò comporta. Se si prende la casistica degli ultimi due<br />
insiemi, è innegabile che la traduzione dell’acronimia coinvolga sia aspetti<br />
strettamente linguistici e grammaticali sia più complesse questioni<br />
culturali. Anche se nel primo dei due a fronte dell’acronimo spagnolo<br />
abbiamo azzardato degli equivalenti italiani sul piano semantico e<br />
funzionale, è ovvio che le sigle italiane rispetto agli originali non possono<br />
essere proposte come delle traduzioni in senso stretto, tecnico: nell’ottica <strong>di</strong><br />
una versione che sappia me<strong>di</strong>are tra un testo e soprattutto un contesto <strong>di</strong><br />
partenza e uno <strong>di</strong> arrivo, come spiegavamo, non è praticabile la resa <strong>di</strong><br />
BOE con GU, e tantomeno quella <strong>di</strong> AVE con TAV, per il semplice fatto che<br />
le realtà in<strong>di</strong>viduate da dette espressioni, pur svolgendo funzione analoga<br />
nei due paesi ed essendo sovrapponibili anche a livello concettuale, non
188<br />
La traduzione delle sigle e degli acronimi dallo spagnolo all’italiano<br />
sono del tutto equivalenti, poiché incarnano valori culturali <strong>di</strong>fferenti. Nel<br />
caso <strong>di</strong> AVE (Alta Velocidad Española), ad esempio, nell’aggettivo che<br />
sottolinea la “spagnolità” del progetto cre<strong>di</strong>amo <strong>di</strong> poter leggere un<br />
investimento ideologico e una riven<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> orgoglio nazionale che è<br />
senz’altro assente, o comunque neutralizzata, nell’equivalente <strong>di</strong>citura<br />
italiana (TAV = Treno ad Alta Velocità). È così che in sede <strong>di</strong> traduzione è<br />
raccomandabile riproporre la sigla originale – che nell’italiano<br />
assumerebbe le caratteristiche <strong>di</strong> un prestito integrale – e tradurla<br />
spiegandola tra le righe o in nota (ad es. «i progressi dell’AVE, la rete<br />
spagnola <strong>di</strong> treni ad alta velocità, hanno ridotto le <strong>di</strong>stanze tra le principali<br />
città iberiche»; oppure, per analogia acronimica, «i progressi dell’AVE, la<br />
TAV spagnola, hanno ridotto le <strong>di</strong>stanze tra le principali città iberiche» ecc.).<br />
Ancora più complesso è l’ultimo gruppo <strong>di</strong> acronimi proposti, poiché essi,<br />
rinviando alla specifica realtà ispanica nei suoi aspetti storici, politici e<br />
sociali, non hanno, non possono avere degli equivalenti italiani, neppure<br />
come semplici analoghi funzionali e semantici. Di fatto, in ottica traduttiva,<br />
in questo frangente il problema riguarda sia la corretta interpretazione<br />
della sigla sia le ipotesi <strong>di</strong> una sua riproposizione. È ovvio che nella<br />
maggioranza dei casi si dovrà lasciare inalterato l’acronimo spagnolo e,<br />
come nel caso precedente, offrire eventualmente un inciso o<br />
un’annotazione esplicativa: le sigle GAL o ETA rinviano a realtà della<br />
storia politica della Spagna degli ultimi anni e come tali vanno preservate e<br />
presentate anche nel testo italiano (tra l’altro, il movimento terroristico<br />
dell’ETA è ormai tristemente famoso da tempo anche in Italia). In altri casi,<br />
invece, come con ESO, dal momento che la sigla identifica in maniera<br />
generale una realtà presente anche in Italia – il sistema dell’istruzione<br />
obbligatoria – e non ci sembra avere in sé un valore connotativo al <strong>di</strong> là<br />
dell’ab<strong>brevi</strong>azione dettata dai rituali della burocrazia (Enseñanza<br />
Secundaria Obligatoria), in italiano si può anche pensare <strong>di</strong> non ripetere<br />
l’acronimo e scioglierlo nella sua traduzione, proponendo <strong>di</strong>rettamente la<br />
<strong>di</strong>citura «scuola dell’obbligo» o «istruzione obbligatoria» (ad es. «in Spagna<br />
al termine della scuola dell’obbligo, lo studente è chiamato a scegliere un<br />
in<strong>di</strong>rizzo successivo <strong>di</strong> ambito scientifico o umanistico»).<br />
3 . Conclusioni<br />
In base alla serie <strong>di</strong> esempi e riflessioni proposte, nella traduzione <strong>di</strong><br />
sigle e acronimi dallo spagnolo all’italiano emerge in primis la necessità <strong>di</strong>
M. Lefèvre 189<br />
tenere in considerazione non soltanto il fronte dell’equivalenza linguistica,<br />
ma anche quello dell’equivalenza culturale, quel sistema <strong>di</strong> valori<br />
extralinguistici – storici, sociali, politici ecc. – a cui l’acronimia, in modo più<br />
o meno scoperto, frequentemente rimanda e che la traduzione non può<br />
trascurare nel momento della sua riproposizione nel contesto <strong>di</strong> arrivo. Dal<br />
punto <strong>di</strong> vista grammaticale, dato che spagnolo e italiano sono lingue<br />
affini, esse hanno un comportamento simile per quanto riguarda le<br />
modalità <strong>di</strong> lessicalizzazione dell’acronimo e le sue caratteristiche<br />
morfologiche, fattore che semplifica le <strong>di</strong>namiche della resa traduttiva, ad<br />
esempio anche nel mantenimento frequente del genere e del numero della<br />
sigla originale: in entrambi gli i<strong>di</strong>omi si <strong>di</strong>ce una ONG; las ONGs → le<br />
ONG; la FIFA; el SIDA → l’AIDS ecc. E sempre in relazione al principio <strong>di</strong><br />
equivalenza linguistica, se da un lato va sottolineato che spagnolo e italiano<br />
tendono a lessicalizzare più o meno gli stessi acronimi, soprattutto quando<br />
questi ultimi hanno origine straniera – e ciò favorisce naturalmente la<br />
traduzione –, dall’altro invece, come abbiamo visto, nel caso <strong>di</strong> alcune sigle<br />
tipiche del contesto spagnolo, l’italiano non sempre è in grado <strong>di</strong> produrre<br />
un’equivalenza linguistica imme<strong>di</strong>ata (GAL → ?, CCAA → ?), ma spesso<br />
può ugualmente reperire degli equivalenti semantici e concettuali (AVE →<br />
TAV, RENFE → FFSS), i quali comunque in sede <strong>di</strong> traduzione non<br />
possono funzionare automaticamente e necessitano <strong>di</strong> una spiegazione<br />
ulteriore. Di fatto, questi ultimi esempi verificano la possibilità <strong>di</strong><br />
considerare alcuni acronimi alla stregua <strong>di</strong> culturemi, i quali in quanto tali<br />
nel processo traduttivo implicano la considerazione <strong>di</strong> tutta una serie <strong>di</strong><br />
fattori extralinguistici che, come abbiamo sottolineato, non possono essere<br />
ignorati o, peggio, scavalcati nel momento del passaggio dallo spagnolo<br />
all’italiano. La traduzione delle sigle, pertanto, implica le <strong>di</strong>namiche della<br />
trasmissione e della relazione culturale tra due o più mon<strong>di</strong>, che appunto si<br />
confrontano sia sul piano strettamente linguistico sia su quello della<br />
propria storia e delle proprie <strong>di</strong>namiche sociali, economiche e politiche. In<br />
questo senso, al <strong>di</strong> là della frequenza d’uso all’interno <strong>di</strong> un determinato<br />
campo tematico o settore professionale, al <strong>di</strong> là della vocazione sintetica<br />
propria della lingua della comunicazione burocratica o massme<strong>di</strong>atica,<br />
l’acronimia va considerata come parte integrante del patrimonio storico e<br />
culturale <strong>di</strong> un determinato orizzonte, sia esso legato alla sfera dei rapporti<br />
globali, sia esso circoscritto al rapporto tra due paesi.<br />
In secondo luogo, fondamentale ai fini <strong>di</strong> una corretta <strong>di</strong>sambiguazione<br />
e resa dell’acronimia è sia il contesto linguistico sia quello referenziale in
190<br />
La traduzione delle sigle e degli acronimi dallo spagnolo all’italiano<br />
cui la sigla si inserisce. È un problema <strong>di</strong> pragmatica della traduzione che<br />
coinvolge sia la tipologia testuale in cui l’acronimo appare sia i suoi<br />
destinatari privilegiati. Senza riba<strong>di</strong>re quanto detto a proposito<br />
dell’importanza <strong>di</strong> una conoscenza dei <strong>di</strong>versi linguaggi e ambiti tecnici,<br />
per una resa puntuale delle sequenze acronimiche, è ovvio che ad ogni tipo<br />
<strong>di</strong> testo si ad<strong>di</strong>ca una traduzione specifica e in linea con le esigenze <strong>di</strong><br />
settore, che della sigla non fornisca soltanto una mera equivalenza<br />
linguistica, ma tutto il suo portato culturale e la sua funzionalità<br />
comunicativa e professionale. Di fatto, in un testo <strong>di</strong> ambito politico-‐‑<br />
amministrativo, ad alto coefficiente <strong>di</strong> rigore e ufficialità, è consigliabile<br />
una riproposizione integrale della sigla – che a questo punto entrerebbe nel<br />
tessuto linguistico come un prestito non adattato – con un’eventuale<br />
spiegazione tra parentesi o in una nota esplicativa che sciolga la sigla e ne<br />
chiarisca il significato («il PNV (Partito Nazionalista Basco) ha presentato una<br />
mozione d’or<strong>di</strong>ne…»). Al contrario, in testi che appartengono al mondo<br />
dell’informazione o del giornalismo, in cui l’acronimia ben si sposa con la<br />
sintesi e l’imme<strong>di</strong>atezza spesso richiesta ai mezzi <strong>di</strong> comunicazione <strong>di</strong><br />
massa, <strong>di</strong> fronte alla sigla presente in un brano spagnolo in certi frangenti<br />
si può ricorrere <strong>di</strong>rettamente all’utilizzo del suo omologo italiano (PNB:<br />
Producto Nacional Bruto → PIL: Prodotto Interno Lordo) o, naturalmente,<br />
della sigla equivalente valida a livello internazionale (OTAN → NATO). In<br />
altri casi, quando la sigla identifica una specifica realtà ispanica<br />
(culturema), si ricorre spesso a soluzioni <strong>di</strong> compromesso in linea con i<br />
manuali <strong>di</strong> stile che le principali testate compilano a favore dei propri<br />
redattori e che <strong>di</strong> fatto richiamano le strategie già più volte riscontrate,<br />
introducendo una imme<strong>di</strong>ata spiegazione dell’acronimo, obbligatoria<br />
quando si ha la prima occorrenza della sigla (ad es. «sul BOE, il Bollettino<br />
ufficiale dello stato spagnolo, l’equivalente della Gazzetta Ufficiale<br />
italiana,…»).<br />
Infine, per quanto riguarda gli strumenti utili all’interpretazione e alla<br />
traduzione degli acronimi dallo spagnolo all’italiano, contrariamente a<br />
quello che si potrebbe pensare, risultano poco funzionali i gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>zionari<br />
bilingui e monolingui (generali e tecnici), che <strong>di</strong> fatto annoverano<br />
solamente gli acronimi più conclamati e che, dal momento che molte sigle<br />
sono da considerarsi alla stregua <strong>di</strong> prestiti non sempre “adottati” dalla<br />
lessicografia ufficiale, lasciano ai margini tutto un universo <strong>di</strong> acronimi a<br />
cui invece il sistema della comunicazione globale ricorre costantemente e<br />
copiosamente. Più utili, se usati con intelligenza e scaltrezza, possono
M. Lefèvre 191<br />
essere invece i Manuali <strong>di</strong> convenzioni redazionali delle principali<br />
organizzazioni internazionali (si pensi al già menzionato Libro de estilo della<br />
UE), che offrono la possibilità <strong>di</strong> passare da una lingua a un’altra con<br />
grande rapi<strong>di</strong>tà. Ma soprattutto è opportuno segnalare i già ricordati<br />
portali e siti internet de<strong>di</strong>cati espressamente agli acronimi internazionali<br />
(ad es. Acronymfinder) e spagnoli in particolare (ad es. Reglas de Ortografía),<br />
che forniscono dettagli importanti ai fini dello scioglimento e della corretta<br />
esegesi <strong>di</strong> questi ultimi. E infine, sul fronte specifico della traduzione, al<br />
cospetto delle sigle più semplici, non vanno neppure snobbati alcuni<br />
traduttori automatici <strong>di</strong>ffusi nel web: uno <strong>di</strong> questi è il già ricordato<br />
traduttore <strong>di</strong> Google (http://translate.google.it) che, poco utile in linea<br />
generale, limitatamente agli acronimi più noti e <strong>di</strong>ffusi può offrire risultati<br />
veloci e sorprendenti.<br />
Bibliografia<br />
Matteo Lefèvre<br />
matteo.lefevre@libero.it<br />
Carrera Díaz 1997<br />
Carrera Díaz Manuel, Grammatica spagnola, Roma-‐‑Bari, Laterza.<br />
DRAE 2001<br />
Diccionario de la Real Academia Española, Madrid, RAE, XXII ed., versión<br />
on line (http://buscon.rae.es/draeI/)
Abstract<br />
Forme e mo<strong>di</strong> delle scritture <strong>brevi</strong> <strong>di</strong> <strong>oggi</strong><br />
Felicia Logozzo<br />
Il contributo propone una classificazione delle scritture <strong>brevi</strong> dell’italiano,<br />
in<strong>di</strong>viduate all’interno <strong>di</strong> un corpus <strong>di</strong> Twit, sulla base <strong>di</strong> criteri intrinseci alle forme<br />
delle ab<strong>brevi</strong>azioni e <strong>di</strong> criteri basati sul rapporto tra le forme scritte stesse e<br />
l’oralità della lingua.<br />
Parole chiave: scritture <strong>brevi</strong>, lingua orale e lingua scritta, lingua italiana<br />
This paper offers a classification of short forms of written Italian, identified in a<br />
corpus of Twits. The classification is based both on their formal features and on<br />
their relations with oral language.<br />
Keywords: short writings, oral and written language, Italian language<br />
Quando si è deciso <strong>di</strong> intraprendere la ricerca sulle scritture <strong>brevi</strong>, si è<br />
posta come prima esigenza quella <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare un corpus dal quale<br />
partire.<br />
Un corpus <strong>di</strong> lingua viva presenta delle problematicità insite nella sua<br />
stessa natura perché non è circoscritto nel tempo e nello spazio, non è<br />
definito ed è in continua evoluzione. In particolar modo, testi provenienti<br />
da scambi <strong>di</strong> SMS e da chat non sono facili da reperire, soprattutto se si<br />
vuole che provengano da un numero sufficientemente alto <strong>di</strong> parlanti da<br />
essere rappresentativi dei fenomeni da analizzare.<br />
Per aggirare il problema, si è deciso <strong>di</strong> scegliere come fonte Twitter, un<br />
servizio gratuito <strong>di</strong> social network e microblog che permette agli iscritti,<br />
tramite l’aggiornamento della propria pagina personale con testi <strong>di</strong><br />
massimo 140 caratteri, <strong>di</strong> scambiarsi in tempo reale messaggi <strong>di</strong> qualunque<br />
tipo. Pur essendo anche esso un servizio <strong>di</strong> instant messaging ha, rispetto<br />
ad altre chat e agli SMS, un grosso vantaggio dal nostro punto <strong>di</strong> vista: ogni
F. Logozzo 193<br />
nuovo account è impostato automaticamente come “profilo pubblico” 1 e,<br />
considerato che non tutti gli utenti si prendono la briga <strong>di</strong> inserire delle<br />
restrizioni <strong>di</strong> privacy, moltissime conversazioni possono essere lette da<br />
chiunque. Per creare il corpus non è stato necessario quin<strong>di</strong> reperire<br />
materiale custo<strong>di</strong>to su cellulari e computer privati, ma è stato sufficiente<br />
effettuare una ricerca mirata su Twitter.<br />
Il motore <strong>di</strong> ricerca interno <strong>di</strong> Twitter non permette tuttavia <strong>di</strong><br />
selezionare la lingua dei testi tra i quali indagare; molte ab<strong>brevi</strong>azioni,<br />
estremamente <strong>di</strong>ffuse in italiano, hanno dato, <strong>di</strong> conseguenza, risultati in<br />
altre lingue in cui una certa sequenza <strong>di</strong> simboli ha tutt’altro valore<br />
linguistico, e dunque inservibili. Inserendo però, non solo parole singole,<br />
ma anche sequenze <strong>di</strong> parole ab<strong>brevi</strong>ate -‐‑ vd dmn (vado domani), scste<br />
(scusate), qll (quell-‐‑), c gg (ci… <strong>oggi</strong>), cs fai (cosa fai), prp ora (proprio ora),<br />
sn tt (sono tutt-‐‑), smp qst (sempre quest-‐‑), tt ftt (tutto fatto), bellix (bellissi-‐‑) -‐‑<br />
si è riusciti a ottenere un gran numero <strong>di</strong> conversazioni, in lingua italiana,<br />
riccamente farcite <strong>di</strong> ab<strong>brevi</strong>azioni, dalle quali sono state selezionate e<br />
analizzate in maniera del tutto casuale circa 30 pagine <strong>di</strong> conversazioni <strong>di</strong><br />
cui qui si riportano alcune righe a mero titolo esemplificativo, tratte dal<br />
profilo <strong>di</strong> K4T3R1N4_93 2.<br />
• vbb storia pure io me la rivedo meglio dmn ke gg ho ftt finoa<br />
nerone-‐‑... ohi ale io vd ci ve<strong>di</strong>amo dmn mattina kisss<br />
• io nn so francese uffaaaaaaa :(<br />
• sei sveglia <strong>di</strong> piè?<br />
1 Tali sono le impostazioni del social network alla data <strong>di</strong> creazione del presente contributo<br />
(febbraio 2011).<br />
2 Da notare la scelta del nickname della ragazza K4T3R1N4_93 = KATƎRINA che mantiene<br />
molto probabilmente il suo nome <strong>di</strong> battesimo ma lo trascrive alternando alle consonanti<br />
alcuni numeri, per la loro somiglianza formale rispettivamente alle vocali A, E (rovesciata) e I<br />
dell’alfabeto latino. Non si tratta naturalmente <strong>di</strong> un espe<strong>di</strong>ente ab<strong>brevi</strong>ativo, quanto piuttosto<br />
<strong>di</strong> un elemento per così <strong>di</strong>re stilistico che rimane confinato nella scrittura, non mo<strong>di</strong>ficando in<br />
alcun modo la realizzazione fonetica della parola. Spesso infatti la manipolazione del<br />
linguaggio e della scrittura <strong>di</strong> elementi delle lingue può essere ricondotta esclusivamente a fini<br />
lu<strong>di</strong>ci. E’ anche attraverso le scelte scrittorie, all’interno <strong>di</strong> un contesto <strong>di</strong> comunicazione<br />
informale tra pari quali effettivamente si rivelano essere solitamente le conversazioni via chat<br />
o via SMS, che il parlante/scrivente può concretizzare la sua creatività linguistica, primo<br />
motore universale del mutamento e dell’evoluzione delle lingue, manifestando la propria<br />
originalità ed in<strong>di</strong>vidualità o anche l’appartenenza ad un gruppo <strong>di</strong> parlanti/scriventi col<br />
quale con<strong>di</strong>videre gli stessi “gusti” scrittori. Per la funzione lu<strong>di</strong>ca del linguaggio in generale<br />
si veda Crystal 1998; per gli aspetti lu<strong>di</strong>ci delle scritture <strong>brevi</strong> si veda Crystal 2008, 71 e ss.
194<br />
Forme e mo<strong>di</strong> delle scritture <strong>brevi</strong> <strong>di</strong> <strong>oggi</strong><br />
• :D :D<br />
• Anke io :)<br />
• però io vengo a fare colazione cn voi :)<br />
• Ohi allò dmn mattina confermato x le otto al terminal? lau forse<br />
prende qll dll 8 quin<strong>di</strong> ci ved al term alle 9 -‐‑ 1 quarto<br />
• Notteeeee popolo <strong>di</strong><br />
twitteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer :D<br />
I brani analizzati sono particolarmente marcati in senso <strong>di</strong>amesico e<br />
<strong>di</strong>afasico e, per chi non è allenato a questo tipo <strong>di</strong> scrittura e <strong>di</strong> testualità,<br />
possono risultare <strong>di</strong>fficili da leggere, da seguire e da comprendere. Non ci<br />
si vuole qui occupare della loro analisi testuale (tanto ci sarebbe da <strong>di</strong>re del<br />
continuo code switching, <strong>di</strong> caratteri morfologici e sintattici, se non anche<br />
fonetici, attribuibili a varianti regionali, ecc.) quanto piuttosto dell’utilizzo<br />
<strong>di</strong> forme <strong>di</strong> scritture <strong>brevi</strong>.<br />
Di queste, non saranno oggetto <strong>di</strong> analisi quelle entrate nell’uso<br />
comune, <strong>di</strong>ventate ab<strong>brevi</strong>azioni <strong>di</strong> tutti -‐‑ più o meno longeve che siano 3 -‐‑<br />
quanto piuttosto quelle che sono per il momento ab<strong>brevi</strong>azioni <strong>di</strong> gruppi e<br />
che sono strettamente correlate alla Computer Me<strong>di</strong>ated Communication<br />
(CMC) 4 e agli SMS, ovvero contesti comunicativi caratterizzati dalla<br />
combinazione <strong>di</strong> due o più tra i seguenti fattori (cfr. anche Crystal 2006,<br />
Bazzanella 2003):<br />
-‐‑ <strong>brevi</strong>tà , se i caratteri a <strong>di</strong>sposizione sono <strong>di</strong> numero limitato o se<br />
ci sono esigenze <strong>di</strong> <strong>di</strong>gitare il minor numero <strong>di</strong> caratteri per<br />
favorire la velocità <strong>di</strong> scrittura e, soprattutto nel caso <strong>di</strong> programmi<br />
<strong>di</strong> instant messaging, <strong>di</strong> interazione e scambio 5;<br />
-‐‑ informalità intesa come scarsa o nulla esigenza <strong>di</strong> rispetto degli<br />
standard linguistici e scrittori, favorita dal contesto della<br />
interazione tra pari in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> comunicazione colloquiale;<br />
-‐‑ scarsa o nulla pianificazione del testo;<br />
3 Per sigle e ab<strong>brevi</strong>azioni <strong>di</strong> uso comune si veda, all’interno <strong>di</strong> questo volume, il contributo <strong>di</strong><br />
Lucia Di Pace e Rossella Pannain.<br />
4 Per il ruolo della tecnologia nella comunicazione attraverso la lingua si veda Poe 2010.<br />
5 L’esigenza <strong>di</strong> <strong>brevi</strong>tà non è strettamente correlata alla velocità <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> cui può<br />
rappresentare invece un ostacolo. E’ il caso degli SMS in scriptio continua del tipo<br />
“<strong>oggi</strong>SnAndAllUniMaNnCeraLezXkèIlProfEMalato” che impongono un faticoso alternare<br />
maiuscole e minuscole per delimitare le varie parole.
F. Logozzo 195<br />
-‐‑ pianificazione non tra<strong>di</strong>zionale del testo ovvero elaborazione<br />
volontaria <strong>di</strong> neologismi, strutture sintattiche non standard e forme<br />
grafiche, anche estremamente elaborate, manifestazione non <strong>di</strong><br />
incompetenza ma <strong>di</strong> forte creatività linguistica e riflessione<br />
metalinguistica 6;<br />
-‐‑ code switching;<br />
-‐‑ elaborazione <strong>di</strong> testi <strong>di</strong> supporto a comunicazioni au<strong>di</strong>o-‐‑video,<br />
ovvero uso contestuale con lo stesso interlocutore <strong>di</strong> chat e video-‐‑<br />
chat, siano esse messe a <strong>di</strong>sposizione da un unico strumento<br />
(Skype, MSN), siano esse frutto dell’abbinamento simultaneo <strong>di</strong><br />
chat e video-‐‑chat <strong>di</strong> <strong>di</strong>versa origine.<br />
Prima <strong>di</strong> procedere ad una classificazione è bene precisare che non si<br />
ab<strong>brevi</strong>a sempre per necessità e non solo per necessità.<br />
La pratica delle scritture <strong>brevi</strong>, che nasce, in prima istanza, come<br />
esigenza concreta <strong>di</strong> risparmio <strong>di</strong> spazio per la CMC e gli SMS, si<br />
trasferisce presto a tutti i testi che si collocano nella stessa posizione<br />
all’interno del <strong>di</strong>asistema, ovvero testi elettronici elaborati da una certa<br />
categoria <strong>di</strong> parlanti in un contesto informale <strong>di</strong> con<strong>di</strong>visione tra pari <strong>di</strong><br />
interessi, pensieri e sensazioni. L’operazione <strong>di</strong> ab<strong>brevi</strong>azione <strong>di</strong>venta<br />
quin<strong>di</strong> consuetu<strong>di</strong>ne, marca sociolinguistica <strong>di</strong> un determinato tipo <strong>di</strong> testi<br />
a prescindere dalle reali esigenze <strong>di</strong> economia 7.<br />
Se si osservano casi <strong>di</strong> twit quali: “io nn so francese uffaaaaaaa :(” o<br />
“strabll!! =)”, il primo dei quali occupa solo 30 caratteri dei 140 <strong>di</strong>sponibili e<br />
il secondo ad<strong>di</strong>rittura 12, ci si rende conto facilmente del fatto che le forme<br />
nn invece <strong>di</strong> “non” e strabl al posto del completo “strabiliante” siano da<br />
6 David Crystal (2008, 151 e ss.) ritiene che i nuovi mezzi <strong>di</strong> comunicazione hanno messo in<br />
con<strong>di</strong>zione i parlanti/scriventi <strong>di</strong> manifestare al meglio le proprie creatività e competenza<br />
linguistiche e sottolinea, con dati quantitativi, che chi scrive SMS, nella quasi totalità dei casi, è<br />
perfettamente consapevole <strong>di</strong> utilizzare occasionalmente delle varianti grafiche (e più<br />
genericamente linguistiche), legate al mezzo in questione, ed è lungi dal confondere i vari<br />
registri a sua <strong>di</strong>sposizione. Piuttosto è probabile che chi non ha una buona <strong>di</strong>mestichezza con<br />
la lettura e la scrittura non sia in grado <strong>di</strong> sfruttare al meglio le possibilità linguistiche che le<br />
tecnologie offrono: “The arrival of Netspeak is showing us homo loquens at its best” (Crystal<br />
2006, 276).<br />
7 Lorenzetti&Schirru 2006 parlano, a questo proposito <strong>di</strong> “gergalismi grafici”<br />
(Lorenzetti&Schirru 2006, 82).
196<br />
Forme e mo<strong>di</strong> delle scritture <strong>brevi</strong> <strong>di</strong> <strong>oggi</strong><br />
considerare senza dubbio ab<strong>brevi</strong>azioni “<strong>di</strong> lusso”, e non certo “<strong>di</strong><br />
necessità” (volendo utilizzare una tra<strong>di</strong>zionale <strong>di</strong>stinzione terminologica<br />
applicata solitamente ai prestiti). Dal punto <strong>di</strong> vista formale le prime sono<br />
certamente identiche alle seconde ma non sono giustificabili in termini <strong>di</strong><br />
esigenze imme<strong>di</strong>ate <strong>di</strong> economia, tanto più se si pensa che, nel caso del<br />
primo twit, chi scrive “spreca” ben 6 caratteri per enfatizzare con<br />
uffaaaaaaa 8 l’insofferenza verso il francese e la propria impreparazione.<br />
Le ab<strong>brevi</strong>azioni <strong>di</strong> lusso – nella maggior parte dei casi dovute solo alle<br />
abitu<strong>di</strong>ni scrittorie <strong>di</strong> chi produce il messaggio o create per gioco -‐‑ non<br />
sono riconducibili a esigenze <strong>di</strong> economia nell’applicazione tra<strong>di</strong>zionale <strong>di</strong><br />
questo termine alla scrittura, intesa come risparmio <strong>di</strong> spazio, ma possono<br />
talvolta più probabilmente essere considerate economiche in termini <strong>di</strong><br />
tempo necessario allo scrivente per trasmettere un messaggio,<br />
salvaguardando al contempo la comprensibilità dello stesso, vale a <strong>di</strong>re<br />
ottenere un segno comprensibile con il minor numero <strong>di</strong> <strong>di</strong>gitazioni:<br />
sarebbe stato inutile infatti <strong>di</strong>gitare n-‐‑o-‐‑n quando due <strong>di</strong>gitazioni sullo<br />
stesso tasto n-‐‑n non mo<strong>di</strong>ficano per nulla il messaggio e la sua leggibilità.<br />
Se la <strong>brevi</strong>tà non implica automaticamente una maggiore velocità <strong>di</strong><br />
produzione del messaggio, come già esplicitato alla nota 5, vale<br />
l’implicazione contraria ovvero il fatto che la velocità <strong>di</strong> produzione è quasi<br />
certo che si colleghi alla <strong>brevi</strong>tà della scrittura.<br />
Nel processo <strong>di</strong> ab<strong>brevi</strong>azione delle forme scritte, relativamente al<br />
parametro “velocità”, occorre considerare a pieno titolo anche il<br />
destinatario/lettore che deve essere in grado <strong>di</strong> deco<strong>di</strong>ficare, e se necessario<br />
<strong>di</strong>sambiguare, in un tempo ragionevole il segno stesso. È sfavorito infatti<br />
un messaggio che implichi, a causa della sua <strong>brevi</strong>tà, una lenta deco<strong>di</strong>fica o<br />
probabili frainten<strong>di</strong>menti o che pregiu<strong>di</strong>chi, nei casi <strong>di</strong> comunicazione<br />
sincrona o solo leggermente asincrona, l’efficacia dell’interazione.<br />
8 Caso <strong>di</strong> “scrittura lunga/scrittura parlata” volta a mimare, attraverso la ripetizione della<br />
vocale finale, la presunta persistenza fonica della vocale stessa qualora lo stesso messaggio<br />
venisse comunicato oralmente. (cfr. anche Pistolesi 2003, 440). Espe<strong>di</strong>ente non certo nuovo e<br />
comune a tutti i generi letterari e a tutte le forme <strong>di</strong> scrittura antiche e moderne, molto<br />
frequente in instant messages e twits, per la loro stessa natura <strong>di</strong> interazioni scritte fortemente<br />
<strong>di</strong>alogiche (cfr. Crystal 2006, 45 e 47) e spesso sostitutive <strong>di</strong> conversazioni che altrimenti si<br />
sarebbero svolte oralmente.
Forme e mo<strong>di</strong><br />
F. Logozzo 197<br />
Le scritture <strong>brevi</strong> che si incontrano nel corpus <strong>di</strong> twit analizzato sono<br />
sostanzialmente riconducibili a 5 tipologie: scritture fonetiche, sigle,<br />
contrazioni, troncamenti, uso <strong>di</strong> segni grafici non alfabetici.<br />
Le scritture fonetiche, sono le forme <strong>di</strong> scritture <strong>brevi</strong> che mantengono il<br />
più stretto rapporto con la lingua parlata, <strong>di</strong> cui esse vogliono costituire<br />
una rappresentazione quanto più possibile fonografica. Di seguito alcuni<br />
brani d’esempio:<br />
(1) davvero ke bello!!!!!!!!nn vedo l'ʹora anke io<br />
(2) wiwo cm 1 fiume in piena ma dolce sll skiena x farmi andare oltre 1 po'ʹ +<br />
forte 1 altra wolta...<br />
(3) hihihihi...io e la mia amika inwece pren<strong>di</strong>amo dei regali<br />
(4) consijo de tojerle xke ve le copiano sicuramente<br />
(5) ti kiedo solamente pe nn pijarte a parolacce de TOJERLA<br />
(6) waaaaaaaaaw straaaabll!!!!!!! idea straoriginaleee!! =)<br />
Quasi tutti i casi (oltre a quelli già riportati: ke, kimika, kiudevano, okki,<br />
kieda, anke, parekkio, amiko, skiena, ki, maskio, notifike, mankate, stakkato, poko,<br />
neankio, vikingo, skifo, orekkio) riguardano la resa delle occlusive velari sorde<br />
con kappa, che va a sostituire sia sia il <strong>di</strong>gramma livellando così<br />
un’incoerenza della scrittura dell’italiano 9. Non si verifica un fenomeno<br />
analogo per la rappresentazione della occlusiva sonora poiché non vi è a<br />
<strong>di</strong>sposizione un segno per rappresentarla fedelmente. Quest’ultima ricorre<br />
inoltre in parole <strong>di</strong> minor frequenza, a <strong>di</strong>fferenza della sorda che si trova<br />
nel pronome relativo e nella congiunzione che, in una parola del lessico<br />
fondamentale come cosa, nell’ interrogativo chi, ecc.<br />
I casi <strong>di</strong> per la resa dell’approssimante palatale (vojo, consijo de tojerle)<br />
sono rappresentazione della variante romanesca [j] della laterale palatale<br />
standard [λ] resa nella scrittura standard .<br />
Si riscontra un uso piuttosto frequente piuttosto frequente della<br />
cosiddetta “doppia w” per rappresentare la fricativa labiodentale sonora<br />
[v] (oltre agli esempi già riportati: wolta, invece, wotiamo, wotarli, wotazioni,<br />
trowato, <strong>di</strong>wertita, wiwo, dewono, wedo, werona, wai, nuowo, wideo)<br />
9 Uso già attestato in italiano negli anni ’70 (Lorenzetti&Schirru 2006).
198<br />
Forme e mo<strong>di</strong> delle scritture <strong>brevi</strong> <strong>di</strong> <strong>oggi</strong><br />
riconducibile verosimilmente a vezzo/moda/esotismo/scrittura non<br />
convenzionale, non essendo motivata una scelta <strong>di</strong> questo tipo, né da<br />
problemi <strong>di</strong> economia della scrittura né tantomeno da incoerenze nella<br />
grafia dell’italiano.<br />
Da notare all’esempio (6) un simpatico tentativo <strong>di</strong> resa fonografica<br />
dell’inglese “wow”.<br />
Le scritture fonetiche sono una tipologia <strong>di</strong> scritture <strong>brevi</strong> molto più<br />
<strong>di</strong>ffusa in ambiti linguistici in cui, a <strong>di</strong>fferenza dell’italiano dove il rapporto<br />
segni alfabetici e suoni della lingua è quasi 1:1, vi sono molte incoerenze tra<br />
la prassi ortografica e la fonetica, quale per esempio l’inglese.<br />
Qui abbondano scritture fonetiche come thru (trough), luv (love), wot<br />
(what), sum (some), cos (because), omigod (oh my God) (Crystal 2008, 48-‐‑49).<br />
Forma tra<strong>di</strong>zionale <strong>di</strong> scritture <strong>brevi</strong> è la parola troncata 10 che si basa<br />
sull’assunto che, in un segno linguistico, la sillaba iniziale fornisce una<br />
certa quantità <strong>di</strong> informazioni, la seconda ne fornisce <strong>di</strong> meno e così via;<br />
tale scala <strong>di</strong> valore informativo è valida soprattutto per le lingue flessive in<br />
cui le informazioni grammaticali, depositate nelle ultime sillabe delle<br />
parole, sono spesso ridondanti e reperibili da altri elementi della frase.<br />
Per esemplificare, data una parola come “capito”, nella frase “ho capito”<br />
in un contesto semi<strong>di</strong>alogico quale quello <strong>di</strong> Twitter, la prima sillaba “ca”<br />
permette <strong>di</strong> stabilire che l’insieme nel quale ricercare il completamento è<br />
quello dei participi passati dell’italiano che possono stare dopo il verbo<br />
avere; tra questi occorre poi selezionare uno che comincia per “ca”.<br />
Nell’insieme che comprende “capito”, “calpestato”, “calato”, “calcato”,<br />
ecc., considerato il contesto entro il quale la parola ricorre, ci sono buone<br />
probabilità che la sillaba “ca” sia sufficientemente informativa da<br />
permettere inferire che sia il troncamento <strong>di</strong> capito. Se poi ad essa si<br />
aggiunge la seconda, “pi”, la probabilità <strong>di</strong> frainten<strong>di</strong>mento è pressoché<br />
trascurabile 11.<br />
È questo, in sostanza, il meccanismo <strong>di</strong> funzionamento del suggeritore<br />
elettronico (scrittura pre<strong>di</strong>ttiva) <strong>di</strong> cui sono dotati molti telefoni cellulari e<br />
10 Definiti da Serianni 1989, 59 ab<strong>brevi</strong>azioni “per compen<strong>di</strong>o”.<br />
11 Cfr. Calvet 1980, 25 e ss.
F. Logozzo 199<br />
alcuni programmi <strong>di</strong> video scrittura che propongono le soluzioni, or<strong>di</strong>nate<br />
secondo in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> frequenza, con cui completare una certa sequenza <strong>di</strong><br />
lettere per formare parole. Come tutti i software, solo i suggeritori più<br />
evoluti sono però in grado <strong>di</strong> ponderare il contesto sintattico e semantico in<br />
base al quale proporre un certo termine piuttosto che un altro. Di seguito<br />
alcuni esempi ad ognuno dei quali è posposto, tra parentesi tonde, la<br />
parole troncata con relativa integrazione:<br />
(7) sisi, l'ʹho capi!!!;-‐‑) (capito)<br />
(8) allora non ci possiamo vedere doma (domani)<br />
(9) io ho stakkato da poko il lavoro e ora sto anda da mia nonna k e il<br />
compleanno (andando)<br />
(10) Io nulla sto col mio ragazzo qst fine sett vado io a dormire da lui<br />
(settimana)<br />
(11) ve la state prendendo tt co 12 qst twit (con)<br />
(12) Mi <strong>di</strong>sp k nn hai trovato nulla (<strong>di</strong>spiace)<br />
(13) strabll!! =) (strabiliante)<br />
(14) ale allò x stasera ke avete deciso? <strong>di</strong>temi voi :) (allora)<br />
(15) ohi ale cmq ti ho mandato un mess privato...ve<strong>di</strong> 1 pò se ti è arr...xk nn è<br />
ke sn tanto esperta ihihi (messaggio)<br />
(16) Stima x android :-‐‑)) google calendar k t manda ank l notifike via sms ed e'ʹ<br />
sync 13 cn qll del cell!!! (sincronizzato)<br />
Le sigle, estremamente comuni nel mondo anglosassone e delle lingue<br />
germaniche in generale 14, come ab<strong>brevi</strong>azioni <strong>di</strong> frasi <strong>di</strong> alto uso o veri e<br />
propri sintemi, non sono uno strumento molto amato per l’ab<strong>brevi</strong>azione<br />
spontanea, non convenzionale e non me<strong>di</strong>ata da mezzi <strong>di</strong> comunicazione <strong>di</strong><br />
massa, sono invece molto più <strong>di</strong>ffusi nel lessico specialistico e in livelli <strong>di</strong><br />
lingua non standard ma comunque <strong>di</strong> uso comune.<br />
12 Non conoscendo l’origine regionale degli autori dei twit analizzati, non è possibile stabilire<br />
se la preposizione è stata ab<strong>brevi</strong>ata per troncamento nello scritto o se, più probabilmente,<br />
rappresenta la variante romanesca <strong>di</strong> “con”. In tal caso la scrittura riprodurrebbe<br />
regolarmente la forma usata oralmente.<br />
13 Forma ab<strong>brevi</strong>ata <strong>di</strong> inglese standard sync(h) < “synchronization”, <strong>di</strong> uso comune nel lessico<br />
internazionale e plurilingue del web grazie anche alla <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> software e applicazioni <strong>di</strong><br />
sincronizzazione <strong>di</strong> agende elettroniche (“Google Sync per il tuo cellulare. Tieni sincronizzati<br />
Gmail, Calendar e Contatti”).<br />
14 Per l’inglese: bbl = be back later, pcm = please call me, ptmm = please tell me more, rotfl =<br />
rolling on the floor laughing, aamof = as a matter of fact, etc; per il Tedesco: dbee = du bist ein<br />
engel, ldnu = lass <strong>di</strong>ch nicht unterkriegen, mdt = mag <strong>di</strong>ch trotzdem, etc. (Crystal 2008, 189 e<br />
ss.).
200<br />
Forme e mo<strong>di</strong> delle scritture <strong>brevi</strong> <strong>di</strong> <strong>oggi</strong><br />
Di uso comune, standar<strong>di</strong>zzate e non frutto <strong>di</strong> creazione imme<strong>di</strong>ata e<br />
originale sono infatti anche quelle che si trovano nel corpus analizzato<br />
riferite rispettivamente al Grande Fratello (17), a Facebook (18), alla frasi “ti<br />
amo tanto” (22) e “ti voglio bene” (19) con le loro numerose estensioni tra<br />
cui “ti voglio tanto bene” (20), “ti voglio un kasino <strong>di</strong> bene” (21), “ti voglio<br />
un mare <strong>di</strong> bene” (22).<br />
(17) ale allò ma cm s fa a paragonare il gf ai minatori<br />
(18) scste del messaggio sotto l'ʹimmagine...FB è pazzo!! xDxDxD<br />
(19) anke in mess privato :) Please :P Tvb!!<br />
(20) anche tu sei una persona simpatica e buona come tutte siamo un bel<br />
gruppo tvtb baci<br />
(21) Ti loVvò (n.a. = lovvo = amo < ingl. to love) anche io, ansi tvukdb
F. Logozzo 201<br />
Di seguito alcuni esempi tratti dal corpus analizzato ad ognuno dei<br />
quali è posposto, tra parentesi quadre, lo scioglimento della/e contrazioni:<br />
(23) a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> qlkn altro...6unica (qualcuno)<br />
(24) Fai capire alle xsone a cui tieni ke sn importanti x te (sono)<br />
(25) SCS sn le 12 passate dovrei andare :) (scusa sono)<br />
(26) Sarò smp dalla tua parte a sostenerti (sempre)<br />
(27) bnbn te?? (bene bene)<br />
(28) vbb storia pure io me la rivedo meglio dmn ke gg ho ftt finoa nerone-‐‑...<br />
(va bene)<br />
(29) lau forse prende qll dll 8 quin<strong>di</strong> ci ved al term (quello delle)<br />
(30) Sl ke il tmp è poco! (tempo)<br />
(31) Io vgl bene a qlla ragazza km se la conoscessi.... (voglio… quella…<br />
come)<br />
(32) Tnt ho vissuto bene anke snz sentirle xttt qsti anni :)(tanto… senza…<br />
tutti… questi)<br />
(33) scste del messaggio sotto l'ʹimmagine...FB è pazzo!! (scusate)<br />
(34) Notte a tutti e ancora tnti auguri a Bren (tanti)<br />
Gli scriventi che hanno prodotto il corpus analizzato non hanno certo<br />
appreso un sistema <strong>di</strong> ab<strong>brevi</strong>azioni regolamentato, né utilizzano con<br />
precisione e coerenza le norme <strong>di</strong> contrazione delle parole come erano state<br />
elaborate, per esempio, nell’ambito della paleografia latina laddove invece<br />
era in uso un sistema abbastanza standar<strong>di</strong>zzato che ha caratterizzato la<br />
scrittura manoscritta fin dall’antichità 16.<br />
A <strong>di</strong>fferenza del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> contrazione delle parole latino, che<br />
prevede in quasi tutti i casi il mantenimento <strong>di</strong> una vocale finale delle<br />
desinenze dei nomi variabili, le ab<strong>brevi</strong>azioni del corpus considerato si<br />
configurano quasi sempre come proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> eliminazione delle vocali.<br />
Ne consegue che, essendo in italiano alcune categorie morfologiche, come<br />
per esempio il genere e il numero, affidate a morfemi quasi esclusivamente<br />
vocalici e finali, troncamenti e ab<strong>brevi</strong>azioni per eliminazione appunto <strong>di</strong><br />
vocali vanno a cancellare i morfemi grammaticali stessi.<br />
16 La creazione del sistema ab<strong>brevi</strong>ativo latino, che si basa essenzialmente sulla presenza <strong>di</strong><br />
ab<strong>brevi</strong>azioni per contrazione e ab<strong>brevi</strong>azioni per troncamento, affonda le sue ra<strong>di</strong>ci nelle<br />
cosiddette note tironiane, così chiamate perché tra<strong>di</strong>zionalmente attribuite a Marco Tullio<br />
Tirone, liberto e scriba <strong>di</strong> Cicerone. (Cappelli 1912, Bischoff 1992).
202<br />
Forme e mo<strong>di</strong> delle scritture <strong>brevi</strong> <strong>di</strong> <strong>oggi</strong><br />
Nella maggior parte dei casi questo non pregiu<strong>di</strong>ca la comprensione dei<br />
rapporti sintattici tra i vari membri della frase, in virtù dell’accordo tra più<br />
parti del <strong>di</strong>scorso che permette <strong>di</strong> recuperare in altri punti le informazioni<br />
grammaticali ridondanti eliminate. È comunque tendenza prevalente,<br />
all’interno del corpus analizzato, quella <strong>di</strong> eliminare la desinenza per la<br />
forma meno marcata del para<strong>di</strong>gma (che non sempre corrisponde alla<br />
forma lemmatizzata dal <strong>di</strong>zionario ma alla forma flessa <strong>di</strong> più alta<br />
frequenza d’uso, considerata quin<strong>di</strong> non marcata dagli scriventi),<br />
mantenendola invece in altri casi:<br />
(35) Io vgl bene a qlla ragazza km se la conoscessi....<br />
(36) Tnt ho vissuto bene anke snz sentirle xttt qsti anni :)<br />
(37) scste del messaggio sotto l'ʹimmagine...FB è pazzo!!<br />
(38) Notte a tutti...e ancora tnti auguri a Bren<br />
Si noti all’esempio (36) che all’interno della stessa frase, nella sequenza<br />
“per tutti questi anni”, si mantiene espressa solo in un caso la desinenza<br />
vocalica <strong>di</strong> plurale (qsti), procedendo alla sua eliminazione nel caso <strong>di</strong> xttt.<br />
Nello specifico è possibile che la scelta <strong>di</strong> omettere la vocale nella forma<br />
ab<strong>brevi</strong>ata ttt, interpretabile fuori contesto con qualunque forma flessa del<br />
para<strong>di</strong>gma dell’aggettivo “tutto”, sia stata favorita dalla presenza della<br />
sequenza triconsonantica che rimanda alla consuetu<strong>di</strong>ne del<br />
raddoppiamento della consonante per l’espressione del plurale nei<br />
troncamenti e nelle sigle: s. v. (“signoria vostra”) vs. ss. ll. (“signorie loro”),<br />
prof. (“professore”) vs. proff. (“professori”).<br />
I monosillabi, a <strong>di</strong>spetto della loro intrinseca <strong>brevi</strong>tà, risultano<br />
dall’analisi del corpus estremamente soggetti ad ab<strong>brevi</strong>azioni che possono<br />
essere considerate, nella maggior parte dei casi -‐‑ esempi dal (39) al (43) -‐‑ sia<br />
ab<strong>brevi</strong>azioni per troncamento sia ab<strong>brevi</strong>azioni per eliminazione <strong>di</strong> vocali.<br />
La frequenza dei processi ab<strong>brevi</strong>ativi a carico <strong>di</strong> questo specifico gruppo<br />
<strong>di</strong> segni linguistici è da ricondurre al fatto che essi posseggono le due<br />
caratteristiche necessarie affinché si possano innescare i processi stessi:<br />
-‐ altissima frequenza d’uso (molte sono infatti parole grammaticali)<br />
-‐ conseguente facile <strong>di</strong>sambiguazione.<br />
(39) t (ti) = Scs se t risp in rita<br />
(40) m (mi) = nn c'ʹè nessuno sveglio m sa<br />
(41) c (ci) = wotiamo i dARI c mancano poke ore x continuare a wotarli!!!
F. Logozzo 203<br />
(42) k (ke) / m (mi) / d (<strong>di</strong>) = k m <strong>di</strong>ci d bello?<br />
(43) s (si) = qnd metto"ʺaggiorna"ʺ,automaticamente s ricollega<br />
(44) nn (non) = Nn è <strong>di</strong>fficile<br />
(45) kn (con) / m (mi) = kn la febbre infatti gg m hanno ft staccare prima<br />
Una volta effettuata una prima categorizzazione delle forme delle<br />
scritture <strong>brevi</strong>, occorre considerare il rapporto che i vari gruppi<br />
intrattengono con la lingua all’interno della quale si inseriscono come<br />
varietà <strong>di</strong>amesiche. È dunque necessario affrontare la questione dei<br />
possibili luoghi <strong>di</strong> creazione e dei possibili luoghi d’uso, che, per entrambi<br />
gli ambiti, possono essere la lingua scritta o la lingua orale.<br />
Procedendo a questa nuova categorizzazione si <strong>di</strong>stingueranno:<br />
-‐ Ab<strong>brevi</strong>azioni che rappresentano fenomeni della lingua parlata.<br />
A questa categoria appartengono le scritture fonetiche e le<br />
ab<strong>brevi</strong>azioni con elementi logografici (o inserimenti <strong>di</strong> elementi<br />
logografici in sequenze a base fonografica). È frequente infatti<br />
l’impiego <strong>di</strong> numeri e <strong>di</strong> altri segni matematici, in funzione <strong>di</strong><br />
logogrammi all’interno <strong>di</strong> unità linguistiche (parole o frasi) che<br />
finiscono quin<strong>di</strong> rappresentate con due criteri grafici non<br />
omogenei.<br />
(46) x farmi andare oltre 1 po'ʹ + forte 1 altra wolta...<br />
(47) ascolto i dARI e mex cn 1 mia amika te???<br />
(48) <strong>di</strong>wertita 1 botto a cantare<br />
(49) Ohi allò dmn mattina confermato x le otto al terminal? lau forse prende qll<br />
dll 8 quin<strong>di</strong> ci ved al term alle 9 -‐‑ 1 quarto<br />
(50) ti credo...magari...infondo 6 simpatica...<br />
(51) xkè n poxo averti?<br />
(52) GIA LO SAI XRO MOVEMOSE! 17<br />
I troncamenti possono appartenere al gruppo delle ab<strong>brevi</strong>azioni<br />
generate a livello <strong>di</strong> lingua parlata ma ciò è verosimile soprattutto se il<br />
troncamento si verifica dopo sillaba tonica. In linea generale, si <strong>di</strong>rà che<br />
ogni troncamento va analizzato singolarmente per reperire il suo luogo<br />
d’origine.<br />
17 Si noti in XRO l’applicazione non perfetta dei due criteri logografico + fonografico: [per]ro.<br />
Per questo tipo <strong>di</strong> scritture miste si veda Valeri 2000, 199.
204<br />
Forme e mo<strong>di</strong> delle scritture <strong>brevi</strong> <strong>di</strong> <strong>oggi</strong><br />
-‐ Ab<strong>brevi</strong>azioni originate nella lingua scritta e successivamente<br />
imprestati a quella orale, o comunque passibili <strong>di</strong> essere trasferiti<br />
alla lingua parlata.<br />
Sono quelli che Bloomfield 1933 chiama “<strong>di</strong>alect borrowings” tra<br />
varietà della stessa lingua, parlando del fatto che esistono segni<br />
linguistici interpretabili come casi <strong>di</strong> pronuncia secondo la grafia, e<br />
non viceversa: “Written ab<strong>brevi</strong>ations like prof., lab., ec. lead to<br />
spoken forms ... in students'ʹ slang for professor, laboratory,<br />
economics” 18.<br />
A questo gruppo appartengono troncamenti come appunto<br />
l’italiano prof.<br />
-‐ Ab<strong>brevi</strong>azioni nate e utilizzate solo a livello <strong>di</strong> lingua scritta.<br />
Appartengono a questo gruppo parole o sequenze ab<strong>brevi</strong>ate in<br />
forme non pronunciabili oralmente del tipo c vd dmn. In casi <strong>di</strong><br />
particolare frequenza d’uso e connotazione dell’ab<strong>brevi</strong>azione, è<br />
possibile che forme <strong>di</strong> questo tipo siano soggette a processo <strong>di</strong><br />
lessicalizzazione come quello che sta interessando l’acronimo TVB.<br />
In questi casi, il prestito dalla lingua scritta a quella orale si<br />
comporta come un prestito da lingua straniera, con regolare<br />
integrazione fonetica (in questo caso attraverso l’inserimento <strong>di</strong><br />
una vocale d’app<strong>oggi</strong>o ([i]/[u]) sul modello dell’integrazione <strong>di</strong><br />
parole come DVD).<br />
Sono ab<strong>brevi</strong>azioni nate e utilizzate solo a livello <strong>di</strong> lingua scritta<br />
tutte le contrazioni per eliminazione delle vocali.<br />
Questa seconda categorizzazione delle scritture <strong>brevi</strong> induce a fare<br />
alcune importanti considerazioni <strong>di</strong> carattere generale sul rapporto tra<br />
oralità e scrittura.<br />
Tra<strong>di</strong>zionalmente si considera la scrittura -‐‑ nata per rappresentare il<br />
pensiero, con o senza la me<strong>di</strong>azione della lingua -‐‑ e soprattutto la scrittura<br />
alfabetica, come la migliore forma <strong>di</strong> trascrizione della lingua.<br />
18 Bloomfield 1933, 488.
F. Logozzo 205<br />
Altrettanto tra<strong>di</strong>zionalmente si considera la evoluzione della lingua un<br />
fatto puramente orale: è la lingua parlata ad essere soggetta a fenomeni <strong>di</strong><br />
“ab<strong>brevi</strong>azione”, intesi come erosione <strong>di</strong> consonanti e vocali foneticamente<br />
deboli, che a volte riducono la catena fonica senza che la scrittura, dal canto<br />
suo conservatrice, riesca a registrarli costantemente.<br />
Le scritture <strong>brevi</strong>, contrariamente a quanto detto finora, collocano la<br />
lingua scritta a pieno titolo tra i luoghi <strong>di</strong> creazione linguistica, e fanno sì<br />
che non vi sia più corrispondenza tra fatti grafici e fatti fonetici. Il risultato<br />
è l’autonomia del sistema scrittorio che nasce derivato da un altro ma<br />
manifesta una sua in<strong>di</strong>pendenza come motore del mutamento 19.<br />
E sempre grazie alle scritture <strong>brevi</strong> si può riconsiderare il concetto <strong>di</strong><br />
linearità del segno: la parola ab<strong>brevi</strong>ata infatti, <strong>di</strong>venta un tutt’uno, un<br />
insieme <strong>di</strong> in<strong>di</strong>zi collocati in un campo pieno <strong>di</strong> altri in<strong>di</strong>zi (il contesto) dai<br />
quali tocca al lettore ricostruire lessemi, morfemi e rapporti sintagmatici<br />
con il resto della frase.<br />
Bibliografia<br />
Felicia Logozzo<br />
felicialogozzo@yahoo.it<br />
Bazzanella 2003<br />
Bazzanella Carla, “Nuove forme <strong>di</strong> comunicazione, contesto e segnali<br />
<strong>di</strong>scorsivi”, in N. Maraschio, T. P<strong>oggi</strong> Salani (a cura <strong>di</strong>), Italia linguistica<br />
anno Mille. Italia linguistica anno Duemila, Atti del XXXIV Congresso<br />
della Società <strong>di</strong> linguistica italiana, Roma, Bulzoni.<br />
Bischoff 1992<br />
Bischoff Bernhard, Paleografia latina, trad. it. Padova, Antenore.<br />
Bloomfield 1933<br />
Bloomfield Leonard, Language, New York, Holt, Rinehart and Winston.<br />
19 Cfr. Calvet 1980.
206<br />
Forme e mo<strong>di</strong> delle scritture <strong>brevi</strong> <strong>di</strong> <strong>oggi</strong><br />
Calvet 1980<br />
Calvet Louis-‐‑Jean, Les sigles, Paris, Presses Universitaires de France.<br />
Cappelli 1912<br />
Cappelli Adriano, Dizionario delle ab<strong>brevi</strong>ature latine e italiane, Milano,<br />
Hoepli.<br />
Crystal 1998<br />
Crystal David, Language play, London, Penguin Books.<br />
Crystal 2006<br />
Crystal David, Language and the Internet, II ed., Cambridge, Cambridge<br />
University Press.<br />
Crystal 2008<br />
Crystal David, Txng. The Gr8 Db8, Oxford, Oxford University Press.<br />
Haas 1976<br />
Haas William, Writing without letters, Manchester, Manchester<br />
University Press.<br />
Lee&Rayner &Pollatsek 2001<br />
Lee Hye-‐‑Won, Rayner Keith, Pollatsek Alexander, “The relative<br />
contribution of consonants and vowels to word identification during<br />
rea<strong>di</strong>ng”, Journal of Memory and Language 44/2.<br />
Lorenzetti&Schirru 2006<br />
Lorenzetti Luca, Schirru Giancarlo, “La lingua italiana nei nuovi mezzi<br />
<strong>di</strong> comunicazione: SMS, posta elettronica e Internet”, in S. Gensini (a<br />
cura <strong>di</strong>), Fare comunicazione, Roma, Carocci.<br />
Pistolesi 2003<br />
Pistolesi Elena, “L’italiano nella rete”, in N. Maraschio, T. P<strong>oggi</strong> Salani<br />
(a cura <strong>di</strong>), Italia linguistica anno Mille. Italia linguistica anno Duemila, Atti<br />
del XXXIV Congresso della Società <strong>di</strong> linguistica italiana, Roma,<br />
Bulzoni.
F. Logozzo 207<br />
Poe 2010<br />
Poe Marshall T., A history of communications: me<strong>di</strong>a and society from the<br />
evolution of speech to the Internet, Cambridge, Cambridge University<br />
Press.<br />
Serianni 1989<br />
Serianni Luca, Grammatica italiana, Torino, UTET.<br />
Shimron 1993<br />
Shimron Joseph, “The role of vowels in rea<strong>di</strong>ng: A review of stu<strong>di</strong>es of<br />
English and Hebrew”, Psychological Bulletin 114/1.<br />
Stilp&Kluender 2010<br />
Stilp Christian, Kluender Keith, “Cochlea-‐‑scaled entropy, not<br />
consonants, vowels, or time, best pre<strong>di</strong>cts speech intelligibility”,<br />
Procee<strong>di</strong>ngs of the National Academy of Sciences of United States of<br />
America, July 6.<br />
Valeri 2000<br />
Valeri Vincenzo, La scrittura, Roma, Carocci.
Abstract<br />
Language evolution in social me<strong>di</strong>a: a preliminary study<br />
Fabio Massimo Zanzotto & Marco Pennacchiotti<br />
Language, as a social phenomenon, is in constant evolution. New words are added,<br />
<strong>di</strong>sused ones are forgotten, and some others change their morphology and<br />
semantics to adapt to a dynamic World. Today we are leaving a new “Social<br />
Me<strong>di</strong>a” revolution, that is changing many languages. The pace with which new<br />
words are created in social me<strong>di</strong>a is unprecedented. People from <strong>di</strong>fferent<br />
demographic groups are often “speaking <strong>di</strong>fferent languages”, in that not only they<br />
use a <strong>di</strong>fferent set of words, but also assign <strong>di</strong>fferent meanings to the same words.<br />
In this paper, we investigate whether it is possible to lower the “linguistic barrier”,<br />
by analyzing the phenomenon of language evolution in social me<strong>di</strong>a, and by<br />
evaluating to what extent the use of cooperative on-‐‑line <strong>di</strong>ctionaries and natural<br />
language processing techniques can help in tracking and regulate the evolution of<br />
languages in the social me<strong>di</strong>a era. We report a study of language evolution in a<br />
specific social me<strong>di</strong>a, Twitter; and we evaluate whether cooperative <strong>di</strong>ctionaries<br />
(specifically Urban Dictionary) can be used to deal with the evolving language. We<br />
<strong>di</strong>scover that this method partially solves the problem, by allowing a better<br />
understan<strong>di</strong>ng of the behavior of new words and expressions. We then analyze<br />
how natural language processing techniques can be used to capture the meaning of<br />
new words and expressions.<br />
Keywords: Twitter language analysis, language evolution, natural language<br />
processing<br />
1. Introduction<br />
Language, as a social phenomenon, is in constant evolution. New words<br />
are added, <strong>di</strong>sused ones are forgotten, and some others change their<br />
morphology and semantics to adapt to a dynamic World.<br />
Ra<strong>di</strong>cal changes in a language mostly happen when a social group<br />
moves from its native location or separates from an original and bigger<br />
social group. A clear example is the English language, that in the last three
Zanzotto&Pennacchiotti 209<br />
centuries has evolved following the path of expansion of the British<br />
Empire, and giving birth to tenths of <strong>di</strong>fferent <strong>di</strong>alects, inclu<strong>di</strong>ng General<br />
American English, Australian English and In<strong>di</strong>an English [Crystal 2003].<br />
Language evolution is also caused by the social impact of new scientific<br />
and technological <strong>di</strong>scoveries. New words and new word meanings are the<br />
tools for better understan<strong>di</strong>ng and communicate the world around us.<br />
Organizations such as the Académie française in France and the Accademia<br />
della Crusca in Italy and <strong>di</strong>ctionary producers such as the Oxford Dictionary,<br />
have the goal of institutionalize and regulate the evolution of languages, by<br />
formally ad<strong>di</strong>ng and removing words as they appear and <strong>di</strong>sappear from<br />
common usage. Though, it is a rare event that words are added and their<br />
senses are ruled, making more than often news in the me<strong>di</strong>a, as in the case<br />
of the symbol of the heart included in the Oxford Dictionary in March<br />
2011 1. The exponential growth of new scientific <strong>di</strong>scoveries and techniques<br />
in the 19th century Industrial Revolution, and in the 20th centrury<br />
Electronic and Digital Revolution, has certainly put <strong>di</strong>ctionary producers to<br />
the test, that more than once struggled to keep up with the rapid language<br />
evolution of a more and more sophisticated society. The job of producing<br />
and institutionalize new <strong>di</strong>ctionaries is not a mere intellectual excercise.<br />
The American industrial worker of the 19th century and the English<br />
manufactures of his machineries had to share a common basic <strong>di</strong>ctionary,<br />
in order to keep industry alive and functional. Producers of train carriages<br />
had to correctly and precisely understand the names and the measures of<br />
standard track components in the <strong>di</strong>fferent target countries. Workers in<br />
nuclear power plants need to correctly understand words in technical<br />
manuals. To deal with these technical problems, terminology has been<br />
introduced as an important area of language stu<strong>di</strong>es to support and<br />
complement the work of <strong>di</strong>ctionary producers [Wüster 1931].<br />
Today we are leaving a new “Social Me<strong>di</strong>a” revolution, that is once<br />
again, and with a faster pace, changing many languages. Social me<strong>di</strong>a such<br />
as forums, blogs, Twitter, Facebook, Skype, and MSN Messenger, allow<br />
people to write their stories and ideas and share them with the Internet<br />
community. From a linguistic perspective, this is a much bigger and ra<strong>di</strong>cal<br />
innovation than the Web itself. Indeed, the introduction of the Web in the<br />
1 Repubblica, 24/3/2011, Quel cuoricino che <strong>di</strong>ce tutto: Il segno “I love” entra nel <strong>di</strong>zionario (That<br />
little hearth says everything: The sign “I love” is included in the <strong>di</strong>ctionary).
210<br />
Language evolution in social me<strong>di</strong>a: a preliminary study<br />
early 90ies allowed people to read content from <strong>di</strong>fferent sources, such as<br />
me<strong>di</strong>a organizations and companies. Most of the information flow was<br />
therefore one-‐‑way, with people acting as readers. On the contrary, Social<br />
me<strong>di</strong>a allows a two-‐‑way communication. Common people become content<br />
producer and, ultimately, language creators. Single in<strong>di</strong>viduals or small<br />
demographic groups rapidly coin and share new words and new meanings<br />
that can potentially and virally spread to larger groups, until they become<br />
of common usage and ultimately accepted into formal <strong>di</strong>ctionaries.<br />
The pace with which new words are created in social me<strong>di</strong>a is<br />
unprecedented. People from <strong>di</strong>fferent demographic groups (e.g. hip-‐‑hop<br />
teenagers and their older parents) are often “speaking <strong>di</strong>fferent languages”,<br />
in that not only they use a <strong>di</strong>fferent set of words, but also assign <strong>di</strong>fferent<br />
meanings to the same words. In an extreme late-‐‑Wittgensteinian view,<br />
people may end up hardly communicating or understan<strong>di</strong>ng each other,<br />
buil<strong>di</strong>ng around themselves a “linguistic barrier” that inevitably isolates<br />
groups from each other. Dictionary producers and linguistic organizations<br />
cannot keep up with such a rapid evolution. Too many people and too<br />
many fractioned social groups have today the power of shaping the<br />
language. New methods and new resources for tracking and regulate<br />
languages’ evolution are required.<br />
In this paper, we investigate whether it is possible to lower the<br />
“linguistic barrier”, by analyzing the phenomenon of language evolution in<br />
social me<strong>di</strong>a, and by evaluating to what extent the use of cooperative on-‐‑<br />
line <strong>di</strong>ctionaries and natural language processing techniques can help in<br />
tracking and regulate the evolution of languages in the social me<strong>di</strong>a era.<br />
The paper is organized as follows. In Section 2 we report a study of<br />
language evolution in a specific social me<strong>di</strong>a, Twitter; and we evaluate<br />
whether cooperative <strong>di</strong>ctionaries (specifically Urban Dictionary) can be<br />
used to deal with the evolving language. We <strong>di</strong>scover that this method<br />
partially solves the problem, by allowing a better understan<strong>di</strong>ng of the<br />
behavior of new words and expressions. In Section 3, we analyze how<br />
natural language processing techniques can be used to capture the meaning<br />
of new words and expressions. Finally, in Section 4, we conclude with<br />
ideas for future work.
Zanzotto&Pennacchiotti 211<br />
2. Lexicon evolution and crowd-‐‑sourced <strong>di</strong>ctionaries<br />
In this section we investigate whether crowd-‐‑sourced <strong>di</strong>ctionaries are<br />
valid tools to model the evolution of languages in social me<strong>di</strong>a. In<br />
particular, we are interested in understan<strong>di</strong>ng if new words introduced in<br />
the me<strong>di</strong>a are captured and stored in crowd-‐‑sourced <strong>di</strong>ctionaries in a<br />
timely manner, i.e. as soon as the new words become of common usage. If<br />
this is true, crowd-‐‑sourced <strong>di</strong>ctionaries could be used as prominent<br />
references for outsiders to a specific demographic group, to uderstand the<br />
language of that community.<br />
We also explore automatic models to detect when a new linguistic entity<br />
in a social me<strong>di</strong>um is actually promoted to a full fledged status of “new<br />
word”, i.e. a linguistic entity with a specific meaning shared in a wide<br />
community.<br />
In the rest of this section, we present an experiment that investigates the<br />
above issues. In detail, our experiment aims at answering the following<br />
questions: (1) Are crowd-‐‑sourced <strong>di</strong>ctionaries good tools to support the<br />
undertan<strong>di</strong>ng of new words? (2) Can crowd-‐‑sourced <strong>di</strong>ctionaries induce<br />
regularites of new words and expressions?<br />
As social me<strong>di</strong>um we experiment with Twitter, the second largest<br />
microbl<strong>oggi</strong>ng service available today. As for the crowd-‐‑sourced <strong>di</strong>ctionary<br />
we use Urban Dictionary, which is to date the largest collaborative effort to<br />
build an up-‐‑to-‐‑date <strong>di</strong>ctionary of new lingusitic expressions. We begin in<br />
Section 2.1 by describe the experimental set up for our study, and then<br />
comment on result in Section 2.2.<br />
2.1. Twitter and Urban Dictionary: the experimental set-‐‑up<br />
Twitter is a microbl<strong>oggi</strong>ng web service, where users are able to post<br />
short messages (called tweets)of a maximum length of 140 characters, and<br />
read the posts of all other users. Each user can also follow specific users he<br />
wants to be friend of. When a user logs into Twitter, a personalized<br />
“timeline” shows all his latest messages, and the messages of the users he<br />
follows.<br />
Twitter is today one of the largest real-‐‑time microbl<strong>oggi</strong>ng service,<br />
having more than 200 millions users and more than 200 millions tweets per
212<br />
Language evolution in social me<strong>di</strong>a: a preliminary study<br />
day worldwide. People tweet about many <strong>di</strong>fferent topics, from personal<br />
updates (“I am eating pizza”) and conversation with friends, to breaking<br />
news (“Eartquake in Saf Francisco just now! ”) and sen<strong>di</strong>ng web links.<br />
Accor<strong>di</strong>ng to a 2009 by Pear Analytics 2, 40% of tweets are personal updates,<br />
37% are conversations, 9% are re-‐‑posting of other users (called retweets), 6%<br />
are ads, 4% are spam, and a last 4% are news. Despite these numbers,<br />
Twitter has recently played a prominent role in social and political<br />
happenings, such as the Arab Spring in 2011, and the riots in England in<br />
the summer of the same year. It has also been used to coor<strong>di</strong>nate rescues<br />
during major eartquakes, such as those in Chile and Haiti in 2010.<br />
From a demographic perspective, the latest US Quantcast study on<br />
Twitter released in September 2011 3 shows that Twitter is mostly adopted<br />
by people between 18 and 34 years (45% of the total), while people under<br />
18 years are only the 18% and over 35 years the 38%. Twitter is adopted by<br />
people with a <strong>di</strong>versified social status (30% earn more than 100K USD a<br />
year, 28% between 60K and 100K, 25% between 30K and 60K, 17% below<br />
30K). Twitter is still mostly a American phenomenon, with 33% of the<br />
traffic localized in the USA 4, followed by In<strong>di</strong>a at 8%, Japan, Germany,<br />
United Kingdom and Brazil. English is overwelmingly the most used<br />
language: almost two third of the tweets are in English, followed by<br />
Portugese (11%) and Japanese (6%).<br />
While Twitter has the form of a big connected graph [Cha et al. 2010],<br />
recent stu<strong>di</strong>es [Pennacchiotti&Popescu 2011] show that sub-‐‑communities<br />
exist. Twitter can be therefore seen as one of the meeting places in the web<br />
where <strong>di</strong>fferent communities try to interact. In this study, we show that<br />
often standard language is not properly used, both because temd tend to<br />
adopt peculiar expressions proper of their own community, and because<br />
the short-‐‑lenght nature of tweets forces users to write in a succint style,<br />
with frequent use of acronyms, ab<strong>brevi</strong>ations and truncated words. Tweets<br />
2 http://www.pearanalytics.com/blog/wp-‐‑content/uploads/2010/05/Twitter-‐‑Study-‐‑August-‐‑<br />
2009.pdf<br />
3 http://www.quantcast.com/twitter.com<br />
4 website-‐‑monitoring.com
Zanzotto&Pennacchiotti 213<br />
like the following can easily appear: “è prp uno skifo l’hanno kiusa… allò<br />
dmn mattina confermato x le otto a piazza del popolo” 5<br />
Twitter is therefore the perfect me<strong>di</strong>um for our study, as it is a place<br />
that can host potentially fast evoving languages of <strong>di</strong>fferent communities.<br />
Our study is based on a corpus of tweets ranging from September 2009 to<br />
December 2010 written in any of the English <strong>di</strong>alects. From this corpus ,<br />
starting from October 2009, we extracted the monthly frequencies of all<br />
words 6 that were not present in Twitter in the month of September 2009.<br />
We retain these expressions as potential “new words” that have been just<br />
introduced in the language. The final output of the corpus creation is<br />
therefore a list of potentially interesting new words along with their<br />
frequency for each month in the considered period (9/2009-‐‑12/2010).<br />
Figure 1: Urban Dictionary: two definitions of Emo<br />
Urban Dictionary is a crowdsourced web <strong>di</strong>ctionary. Web<br />
crowdsourcing is a powerful way of producing resources, where common<br />
users can contribute to enrich, mantain and mo<strong>di</strong>fy an on-‐‑line knowledge<br />
repositories. Crowdsourcing has emerged as a very succesfull para<strong>di</strong>gm in<br />
the last decades, producing resources such as Wikipe<strong>di</strong>a, an on-‐‑line<br />
encyclope<strong>di</strong>a of human knowledge available in many <strong>di</strong>fferent languages.<br />
The evolving version of Wikipe<strong>di</strong>a is rivaling with the most important<br />
5 in an Italian of SMSs or tweets: it is really bad it has been closed… then tomorrow morning<br />
it’s confirmed 8 o’clock in piazza del popolo.<br />
6 Words are extracted by a standard regular expression tokenizer.
214<br />
Language evolution in social me<strong>di</strong>a: a preliminary study<br />
encyclope<strong>di</strong>as for number of entries and, sometimes quality and quantity<br />
of content. All entries are written and mo<strong>di</strong>fied exclusively by Wikipe<strong>di</strong>a<br />
users without any reward. Crowdsourcing guarantees that many users can<br />
access and mo<strong>di</strong>fy a specific entry, resulting in a balanced, objective and<br />
truthful description of the entry. Indeed, the revision system allow a fast<br />
control of content through a collaborative filtering of the knowlegde. The<br />
success of wikipe<strong>di</strong>a proves that it is possible to solve many knowledge<br />
accumulation and enco<strong>di</strong>ng problems using crowsourcing methodologies.<br />
The crowdsourcing approach is also used for <strong>di</strong>ctionaries, e.g.<br />
Wikictionary and Urban Dictionary. In our study we use Urban Dictionary,<br />
because it is specifically de<strong>di</strong>cated to specific community languages and to<br />
the tracking of new verbal expressions, while Wikictionary aims at<br />
modelling standard language.<br />
Urban Dictionary does not adopt a wiki approach, i.e. a site where users<br />
can change definitions. Instead, it prefers a more trivial model similar to a<br />
Web forum, where users post new words along with their definitions. As in<br />
many forums, votes are associated to each <strong>di</strong>ctionary entry (that roughly<br />
correpsonds to a forum message). Urban Dictionary was created in 2003 as<br />
a sort of game, to collect definitions of new “street” words and colloquial<br />
language expressions. Today, Urban Dictionary has consitently grown up,<br />
becoming a solid reference for fin<strong>di</strong>ng newly introduced colloquial words<br />
and expressions.<br />
Entries in Urban Dictionaries are organized as follows (see example in<br />
Figure 1). Each entry has a set of definitions. Each definition is introduced<br />
by a user and it is striclty related to him. For example, the first definition of<br />
“Emo” (see Figure 1) is given by 7ThisIsWu<strong>di</strong>e7. Each definition is also<br />
given along with its introduction date. For each definition, other<br />
anonymous users can give a positive or a negative judgement. These<br />
judgements are used to sort definitions for a given word. In the example,<br />
the first definition has 62,243 positive and 18,625 negative judgements.<br />
The organization of entries of Urban Dictionary makes this resource<br />
attractive for our study, for two main reasons. First, it is a source of<br />
colloquial words that are tipical in Twitter. Second, Urban Dictionary<br />
allows to easly find the date of introduction of the word in the <strong>di</strong>ctionary,<br />
by looking at the date of the word’s oldest definition. For our study we
Zanzotto&Pennacchiotti 215<br />
created a repository of all words in Urban Dictionary with their associated<br />
date of introduction.<br />
Input of our study are therefore two lists. The list of words in words in<br />
Urban Dictionary with their date of introduction; and the list of new words<br />
in Twitter with their monthly frequencies. By performing a time-‐‑sensitive<br />
comparisons these two lists we aim at investigating if (and when) Urban<br />
Dictionary captures the new words introduced in Twitter.<br />
2.2. Results and analysis<br />
2.2.1. Freshness of Urban Dictionary<br />
In this first analysis we investigate the freshness of Urban Dictionary<br />
with respect to Twitter, i.e. whether Urban Dictionary adds new words<br />
before or after they emerge in Twitter. This analysis will therefore reveal if<br />
Urban Dictionary can provide a useful support to an outsider, for<br />
understan<strong>di</strong>ng the language of specific communities in the social network.<br />
In order to provide an objective quantitative analysis, we define, for a<br />
given word, a TimeShift in<strong>di</strong>cator. The TimeShift is defined as the <strong>di</strong>fference<br />
in time between the introduction of a word in Twitter and the introduction<br />
of the word in Urban DIctionary. More formally, we define the following<br />
measures:<br />
• Month of Maximum Twitter Use (MMTU). Words in Twitter have a<br />
life: they appear, spread, have a period of high frequecy, and then stabilize<br />
or <strong>di</strong>sappear. We define MMTU as the month in which a new word has its<br />
maximum frequency in Twitter. We consider this period as the landmark<br />
for the new word, i.e. the moment in which the word experiences its<br />
maximum success.<br />
• Month of Introduction in Urban Dictionary (MIUD). This measure<br />
in<strong>di</strong>cates the month in which a word has been first introduced and defined<br />
in Urban Dictionary.<br />
Given the two above definition, we further define the TimeShift of a<br />
words as follows:<br />
TimeShift=MMTU−MIUD (1)<br />
For example, TimeShift=+1 in<strong>di</strong>cates that a word has been first<br />
introduced in Urban Dictionary, and then a month later in Twitter.
216<br />
Language evolution in social me<strong>di</strong>a: a preliminary study<br />
Conversely, TimeShift=−1 in<strong>di</strong>cates that the word has been introduced in<br />
Twitter a month before than in Urban Dictionary. A TimeShift=0 in<strong>di</strong>cates<br />
that the word has been introduced in Twitter and Urban Dictionary in the<br />
same month.<br />
Figure 2: Time Shift between Urban Dictionary and Twitter<br />
Figure 2 plots a summarizing analysis of the TimeShift across all words<br />
that have been introduced both in Urban Dictionary and Twitter. The<br />
figure shows that the TimeShift has a multimodal <strong>di</strong>stribution that, we<br />
hypothise, should converge to a normal <strong>di</strong>strubtion with mean in 0, if more<br />
data was available for the experiment. It is interesting to note that the mode<br />
of the <strong>di</strong>stribution (i.e. its most frequent value) is 0, which is also<br />
approximately the mean value of the <strong>di</strong>stribution. This means that new<br />
words in Twitter should be expected with highest probability to be timely<br />
captured by Urban Dictionary in the same month of their introduction in<br />
Twitter. Urban Dictionary is therefore likely to support outsiders of a<br />
Twitter community in rea<strong>di</strong>ng and understan<strong>di</strong>ng the tweets posted in that<br />
community.<br />
The Figure also shows that the TimeShift <strong>di</strong>stribution has a high<br />
variance, i.e. there are many words with postive or negative TimeShift.<br />
This result suggest that many words that are adopted by Twitter after they<br />
have been introduced via other me<strong>di</strong>a and fixed in Urban Dictionary<br />
(positive values of the TimeShift); and there are also many words that are<br />
created in Twitter and then spread outside it (negative values of the<br />
TimeShift). We also observe that the <strong>di</strong>stribution is skewed to negative
Zanzotto&Pennacchiotti 217<br />
values, i.e. it is more common that a word is first introduced in Twitter,<br />
and only after a few months added to Urban Dictionary.<br />
2.2.2. Discovering novel words using frequency counts<br />
With the previous experiment, we undestood that there is an important<br />
set of words that, even if covered by Urban Dictionary, their definitions are<br />
not timely given. We need then to envisage methods and models to capture<br />
the meaning of these words. For doing this, we need to focus on two issues:<br />
First, we need to spot words that are relevantly new in streams like twitter.<br />
Not all the words that appear to be new are really novel words. There are<br />
many proper nouns or product nouns that gain fame for a short period of<br />
time. These are not novel words.<br />
Second, we need to define methods to find the meaning and, then, the<br />
definition of these new words.<br />
In this experiment we focus on the first issue. Possible ways to tackle the<br />
second issue are instead described in Section 3.<br />
Figure 3: Word frequency in Twitter with respect to the peak of use<br />
We want here to evaluate how simple models based on frequency<br />
analysis can be adopted for <strong>di</strong>scovering novel words among words newly<br />
introduced in Twitter. To develop these models we can exploit the data<br />
used for the previous experiments. We firstly observe the behavior of
218<br />
Language evolution in social me<strong>di</strong>a: a preliminary study<br />
words in twitter and, then, we propose simple models to pre<strong>di</strong>ct novelty<br />
observing the evolution of the frequency of words with respect to the time.<br />
The first issue is observing the behavior of words: we took the set of<br />
new Twitter words that we used for the previous experiment. We analyzed<br />
all the words in this set and not only those in Urban Dictionary. Figure 3<br />
plots the mean relative frequency and variance of all these words. Given a<br />
word, the relative frequency is the ratio between its actual frequency in a<br />
given month and its maximun frequency. We want to understand how<br />
words behave before and after their point of maximum sprea<strong>di</strong>ng. Given<br />
this latter point, Figure 3 plots the relative frequencies of words with<br />
respect to the months before and the months after. We can observe that the<br />
average behavior of words in this set has a peak in time. Before and after<br />
this peak, words basically <strong>di</strong>sappear. This seems to be the average behavior<br />
of words that have a peak of use and then are totally lost. These words<br />
cannot be novel words or expressions as their popularity last for a too short<br />
period. Words behaving averagely can be people names or product names.<br />
But, the analysis of the plot in Fig. 3 lead to an interesting conclusion. The<br />
standard deviation with respect to the average behavior is high. This<br />
implies that there are many words that are not know before their peak or<br />
they are steadly known and used after their peak. Words having these<br />
features are extremely interesting.<br />
Figure 4: Simple methods for selecting novel words<br />
Having the above analysis on the behavior of words with respect to<br />
their peak of popularity, we can propose simple models to spot novel
Zanzotto&Pennacchiotti 219<br />
words. This is the second issue we wanted to address. The idea is simple.<br />
We propose models based on this idea. Novel words should find thier<br />
space in new utterances. After a peak of use, these words should find a<br />
nearly constant <strong>di</strong>stribution in the used language. Then, we should tend to<br />
prefer those words that have a steady frequency after the peak of use.<br />
Second, novel words should gain popularity in a short period of time. We<br />
should prefer can<strong>di</strong>date words that have a fast popularity. With these<br />
observations, we can define three <strong>di</strong>fferent models for novel words. Models<br />
are presented in Fig. 4. We propose three models for the novelty of words:<br />
Model A: novel words are words that, before thier peak of use, are less<br />
frequent than the average minus the standard deviation<br />
Model B: novel words are words that, before after peak of use, are more<br />
frequent than the average plus the standard deviation<br />
Model C: novel words ar words that have the properties of Model A and<br />
Model B<br />
Figure 5: Simple methods for selecting novel words: recall vs. precision<br />
We evaluate the results of the models proposed by using Urban<br />
Dictionary. Twitter words that are in Urban Dictionary are good novel<br />
words. We want then to evaluate how good these models are in capturing<br />
these good novel words. To evaluate these models we use the classical<br />
information retrevial measure of precision and recall. Let’s suppose that<br />
with a selection method we can find a set of words that we call selected
220<br />
Language evolution in social me<strong>di</strong>a: a preliminary study<br />
words. Precision counts how many good novel words are in the list of<br />
selected words. This measure states how good is the method in deci<strong>di</strong>ng<br />
whether or not a word is a novel word. Recall counts how many words<br />
among the possible novel words are in selected words. This measure tends to<br />
say how good is the method in retreiving novel words. There is a strict<br />
correlation between precision and recall. Generally, when recall increases<br />
precision decreases. To increase recall, we need to have smaller threshold<br />
to have a bigger set of selected words. This bigger set can contain more<br />
words that are not novel words. This is why it is important to study recall<br />
and precision in combination. Figure 5 plots recall vs precision of the three<br />
methods. Tendentially higher curves represent better methods. Among the<br />
three methods, the best one seems to be Model A, i.e., the model that takes<br />
into consideration the behavior of can<strong>di</strong>date words before the peak. Novel<br />
words, that go into Urban Dictionary in the considered period, are those<br />
words that are basically not present in the period before the peak. Method<br />
B, that takes into consideration the behavior of the word after the peak<br />
period, is the worst method. The combined method, i.e., Method C,<br />
behaves similarly to Method A. The combination of the two methods does<br />
not add a considerable gain.<br />
To conclude this section, we can say that simple frequency-‐‑based<br />
methods for selecting novel words are useful but these methods do not<br />
completely solve the problem.<br />
3. Natural language processing and machine learning: basic<br />
techniques<br />
We have shown that only a part of novel words are covered by crowd-‐‑<br />
sourced <strong>di</strong>ctionaries. These <strong>di</strong>ctionaries do not completely open the<br />
possibility to understand interacions on social me<strong>di</strong>a. We need <strong>di</strong>fferent<br />
methods and models to help outsiders to understand the language of a<br />
social group.<br />
In this section, we want to introduce basic natural language techniques<br />
that can help in solving the two issues expressed in Sec.<br />
2.2.2: (1) "ʺspotting novel words"ʺ task; (2) "ʺgive meaning to novel words"ʺ<br />
task. We will also report on how these basic techniques have been applied<br />
in Twitter and in Social Me<strong>di</strong>a.
Zanzotto&Pennacchiotti 221<br />
We will focus on four problems: part-‐‑of-‐‑speech tagging, named-‐‑enity<br />
recognition, <strong>di</strong>stributional semantics, and automatic classification. The<br />
combined use of these techniques can help in the two above tasks.<br />
3.1. Part-‐‑of-‐‑speech tagging<br />
Part-‐‑of-‐‑speech tagging is considered the first step for a syntactic<br />
analysis. It has been proposed as a separate task in early ’90 [Church 1988,<br />
Brill 1992,<br />
Abney 1996] when the big issue of natural language understan<strong>di</strong>ng<br />
(NLU) [Allen 1995] in a pool of tasks that can be independently solved by<br />
applying specific theories, models, and systems.<br />
The task aims to assign part-‐‑of-‐‑speech tags to a sequence of words in a<br />
sentence. For each word, a part-‐‑of-‐‑speech (POS) tagger must state if the<br />
word is a noun, an adjective, a verb, etc. The task is formally defined as<br />
follows. Given a sentence s=w1...wn, a POS tagger is a function POS that<br />
assigns to s a sequence of POS tags:<br />
POS(s)= t1...tn<br />
Each word wi should have only one interpretation, i.e., a tag ti. For<br />
example, consider the sentence “the boat sinks”. The PoS tagger, after<br />
analysing the overall sentence s= w1w2w3, assigns the POS-‐‑tags t1=Article,<br />
t2=Noun and t3=Verb. The tagger has to <strong>di</strong>sambiguate words performing a<br />
simple analysis and looking, for each word, at its close context. For<br />
example, sinks is both a noun and a verb. This decision should be taken<br />
using the context (i.e., “the boat”). Given this information, the tagger has to<br />
draw the most likely decision. However, the PoS tagger is not a word sense<br />
<strong>di</strong>sambiguator. Homograph forms with the same PoS (e.g., the noun bank<br />
as institution or river bank) are not <strong>di</strong>sambiguated with PoS taggers.<br />
PoS taggers are important in a first step of analysis as these tools can<br />
help in better modelling later stage of analysis. These PoS taggers can be<br />
also used to focus the attention only on some word categories.<br />
As social me<strong>di</strong>a have a language that it is not completely standard,<br />
some adaptation of existing and well estabished taggers has to be done.<br />
Similarly to the adaptation to historical languages [Pennacchiotti&Zanzotto
222<br />
Language evolution in social me<strong>di</strong>a: a preliminary study<br />
2008], stu<strong>di</strong>es have been carried out in porting techniques used for<br />
standard language to social me<strong>di</strong>a language [Gimpel et al., 2011].<br />
3.2. Named entity extraction<br />
Detecting named entities, i.e., named entity recognition (NER), in texts<br />
is one of the fundamental issue in the task of natural language processing<br />
called Information Extraction (IE) [MUC-‐‑7 1997]. Named Entity<br />
Recognition is the first step to <strong>di</strong>scover more complex facts or relations<br />
between people, locations, date, companies, etc. Given a set of target classes<br />
(e.g., person and location), the task of named entity recognition in IE or<br />
semantic annotation in SW consists of detecting text fragments in<br />
documents or in web documents that represent an instance of a target class.<br />
For example, consider the following text fragment: "ʺBefore Moscow! "ʺ<br />
repeated Napoleon, and inviting M. de Beausset, who was so fond of travel, to<br />
accompany him on his ride, he went out of the tent to where the horses stood<br />
saddled. A named entity recognizer should extract the three named entities<br />
Moscow, Napoleon, and M. de Beausset and should determine the their<br />
class, i.e., Moscow is a location while Napoleon and M. de Beausset are two<br />
instances of the class person. Fin<strong>di</strong>ng these bits of information are useful to<br />
determine more interesting facts such as the relation between Napoleon<br />
and M. de Beausset that, accor<strong>di</strong>ng to this piece of texts, know each other.<br />
A survey of the methods can be found in [Nadeau&Sekine 2007].<br />
Named entity extraction is very relevant for social me<strong>di</strong>a and<br />
microbl<strong>oggi</strong>ng as twitter. Named entities can be products or brands.<br />
Monitoring opinons on brands and products is an attractive application for<br />
social me<strong>di</strong>a data. For this reason, named entity recognition has been<br />
adapted to social me<strong>di</strong>a [Ritter et al. 2011] and specific annontations have<br />
been done to help in buil<strong>di</strong>ng better named entity recognizers [Finin et al.<br />
2010].<br />
Named entity recognizers can be also useful for the problems presented<br />
in this paper as it can help in filtering out words that we do not have to<br />
analyze. For celebrities, products, and brands, we do not have to find a<br />
definition or a meaning.<br />
3.2.1. Classifiers and machine learning
Zanzotto&Pennacchiotti 223<br />
A well-‐‑assessed trend in natural language processing research is to<br />
design systems by combining linguistic theory and machine learning (ML).<br />
The latter is typically used for automatically designing classifiers. A<br />
classifier is a function:<br />
C:I→T<br />
that assigns a category in T to elements of the set I. In supervised ML,<br />
the function C is learnt using a set of training instances Tr. Each training<br />
instance is a pair (i,t)∈Tr, where i∈I and t∈T, i.e. a class label subset.<br />
ML algorithms extract regularities from training instances observing<br />
their description in feature spaces F=F1×…×Fn. Each <strong>di</strong>mension j of the<br />
space F is a feature and Fj is the set of the possible values of j. For example,<br />
if we want to learn a classifier that decides if an animal is a cat or a dog<br />
(i.e., the set T={cat,dog}), we can use features such as the number of teeth,<br />
the length of the teeth, the shape of the head, and so on. Each of the<br />
features has values in the range defined with the set Fj. We can then define<br />
a function F that maps instances i∈I onto points in the feature space, i.e.<br />
F(i)=(f1,…, fn) (2)<br />
Once F and Tr have been defined, ML algorithms can be applied for<br />
learning C, e.g., decision trees in [Quinlan 1993].<br />
Classifiers are extremely important as these methods can help in<br />
automatically decide whether or not a can<strong>di</strong>date word is really a novel<br />
word. These techniques have been also used in the similar problem of<br />
deci<strong>di</strong>ng whether or not a novel expression is a term in a specific domain<br />
as me<strong>di</strong>cine, space, physics, etc. [Basili&Zanzotto 2002].<br />
3.3 Distributional semantics<br />
run eat window<br />
Dog 1 1 0<br />
Cat 1 1 0<br />
Car 1 0 1
224<br />
Language evolution in social me<strong>di</strong>a: a preliminary study<br />
Table 1: Context vectors for the words “dog”, “cat”, and “car”<br />
the car runs on the highway<br />
she opened the window of the car<br />
the cat eats the mouse<br />
the dog eats the bone<br />
the cat runs in the gardern<br />
the dog runs in the gardern<br />
Table 2: A small set of contexts for the words “dog”, “cat”, and “car”<br />
Distributional semantics (DS) is a very important model to deal with<br />
word meaning. Its aim is to give models to determine similarity between<br />
words. It stems from the solid linguistic basis of Firth’s principle, “You shall<br />
know a word by the company it keeps.” [Firth 1957], and Harris’s Distributional<br />
Hypothesis, “Words that occur in the same contexts tend to have similar<br />
meanings” [Harris 1964]. Firth’s principle justifies the idea that the meaning<br />
of words (or word sequences) can be modeled using contextual<br />
information and can be represented in vector spaces. Harris’ Distributional<br />
Hypothesis suggests that the meaning of words can be compared through<br />
the vectors representing the context in which they occur. For example,<br />
Table 1 represents the vectors for “dog”, “cat”, and “car” derived from the<br />
set of sentences in Figure 2. Rows represent contextual vectors for words<br />
and columns represent co-‐‑occuring words. “Dog” occurs once with “run”<br />
(see Fig. 2). Similarity between words is given by the similarity between<br />
vectors: simple <strong>di</strong>stance measures between vectors such as dot product can<br />
be used. Then, “dog” and “cat” are more similar than “dog” and “car”, as<br />
their <strong>di</strong>stributional vectors are closer.
Zanzotto&Pennacchiotti 225<br />
Different kinds of context can be considered to build the <strong>di</strong>stributional<br />
vector representing a word:<br />
a word occurring in a window of n tokens around the target word [Schutze<br />
1997]<br />
a lexicalized syntactic relation in which the target word participates<br />
[Pado&Lapata 2007]<br />
a document in which the target word occurs [Deerwester et al. 1990]<br />
Such contexts, co-‐‑occurring frequently with a target word, comprise its<br />
possibly salient attributes [Turney 2006].<br />
This is a key model that can be used in assigning meaning to novel<br />
words. Similarity with existing and known words can help in better<br />
understan<strong>di</strong>ng novel ones.<br />
4. Conclusions<br />
In this paper, we stu<strong>di</strong>ed the language evolution in a specific social<br />
me<strong>di</strong>a, Twitter and we evaluated whether cooperative <strong>di</strong>ctionaries<br />
(specifically Urban Dictionary) can be used to deal with the evolving<br />
language. We <strong>di</strong>scovered that this method partially solves the problem, by<br />
allowing a better understan<strong>di</strong>ng of the behavior of new words and<br />
expressions. We then analyze how natural language processing techniques<br />
can be used to capture the meaning of new words and expressions. Starting<br />
on these solid grounds, we can start studying to which extent we can use<br />
natural language techniques to lower language barriers in the social me<strong>di</strong>a<br />
era.<br />
Fabio Massimo Zanzotto & Marco Pennacchiotti<br />
fabio.massimo.zanzotto@uniroma2.it<br />
marco.pennacchiotti@gmail.com
226<br />
References<br />
Language evolution in social me<strong>di</strong>a: a preliminary study<br />
Abney 1996<br />
Abney, Steven, “Part-‐‑of-‐‑speech tagging and partial parsing”, in G.<br />
K.Church,S.Young (ed. by), Corpus-‐‑based methods in language and speech,<br />
Dordrecht, Kluwer Academic Publishers.<br />
Allen 1995<br />
Allen, James F., Natural language understan<strong>di</strong>ng, II ed., Redwood City,<br />
CA, USA, Benjamin-‐‑Cummings Publishing Co., Inc.<br />
Basili&Zanzotto 2002<br />
Basili Roberto, Zanzotto Fabio Massimo, “Parsing engineering and<br />
empirical robustness”, Natural Language Engineering 8/2-‐‑3, 1245–1262.<br />
Brill 1992<br />
Brill Eric, “A simple rule-‐‑based part of speech tagger”, in Procee<strong>di</strong>ngs of<br />
the third conference on Applied Natural Language Processing, ANLC ’92,<br />
Stroudsburg, PA, USA, Association for Computational Linguistics, 152–<br />
155<br />
Cha et al. 2010<br />
Cha Meeyoung, Hadda<strong>di</strong> Hamed, Benevenuto Fabrício, Gumma<strong>di</strong><br />
P. Krishna, “Measuring user influence in Twitter: The million follower<br />
fallacy”, in W. W. Cohen & S. Gosling (eds.), ICWSM, The AAAI Press.<br />
Church 1988<br />
Church Kenneth W., “A stochastic parts program and noun phrase<br />
parser for unrestricted text”, in Procee<strong>di</strong>ngs of the second conference on<br />
Applied Natural Language Processing, ANLC ’88, Stroudsburg, PA, USA,<br />
Association for Computational Linguistics, 136-‐‑143.<br />
Crystal 2003<br />
Crystal David, English as a global language, II ed., Cambridge, Cambridge<br />
University Press.<br />
Deerwester et al. 1990
Zanzotto&Pennacchiotti 227<br />
Deerwester Scott C., Dumais Susan T., Landauer, Thomas K., Furnas<br />
George W., Harshman Richard A., “Indexing by latent semantic<br />
analysis”, Journal of the American Society of Information Science 41/6,<br />
391–407.<br />
Finin et al. 2010<br />
Finin Tim, Murnane Will, Karan<strong>di</strong>kar Anand, Keller Nicholas,<br />
Martineau Justin, Dredze Mark, “Annotating named entities in twitter<br />
data with crowdsourcing” in Procee<strong>di</strong>ngs of the NAACL HLT 2010<br />
Workshop on creating speech and language data with Amazon’s mechanical<br />
Turk, CSLDAMT ’10, Stroudsburg, PA, USA, Association for<br />
Computational Linguistics, 80–88.<br />
Firth 1957<br />
Firth John R., Papers in linguistics. London, Oxford University Press.<br />
Gimpel et al., 2011<br />
Gimpel Kevin, Schneider Nathan, O’Connor Brendan, Das Dipanjan,<br />
Mills Daniel, Eisenstein Jacob, Heilman Michael, Yogatama Dani,<br />
Flanigan Jeffrey, Smith Noah A., “Part-‐‑of-‐‑speech tagging for twitter:<br />
annotation, features, and experiments”, in Procee<strong>di</strong>ngs of the 49th annual<br />
meeting of the Association for Computational Linguistics: human language<br />
technologies: short papers -‐‑ Volume 2, HLT ’11, Stroudsburg, PA, USA,<br />
Association for Computational Linguistics, 42-‐‑47.<br />
Harris 1964<br />
Harris Zellig, “Distributional structure”, in J. J. Katz & J. A. Fodor (eds.),<br />
The philosophy of linguistics, New York, Oxford University Press.<br />
MUC-‐‑7 1997<br />
MUC-‐‑7, Procee<strong>di</strong>ngs of the seventh message understan<strong>di</strong>ng conference<br />
(MUC-‐‑7), in Columbia, MD: Morgan Kaufmann.<br />
Nadeau&Sekine 2007<br />
Nadeau David, Sekine Satoshi, “A survey of named entity recognition<br />
and classification”, Linguisticae Investigationes 30/1, 3-‐‑26.<br />
Pado&Lapata 2007
228<br />
Language evolution in social me<strong>di</strong>a: a preliminary study<br />
Pado Sebastian, Lapata Mirella, “Dependency-‐‑based construction of<br />
semantic space models”, Computational Linguistics 33/2, 161–199.<br />
Pennacchiotti&Popescu 2011<br />
Pennacchiotti Marco, Popescu, Ana-‐‑Maria, “A machine learning<br />
approach to Twitter user classification”, in L. A. Adamic, R. A. Baeza-‐‑<br />
Yates, & S. Counts (eds.), ICWSM, The AAAI Press.<br />
Pennacchiotti&Zanzotto 2008<br />
Pennacchiotti Marco, Zanzotto Fabio Massimo, “Natural language<br />
processing across time: an empirical investigation on Italian”, in B.<br />
Nordström, A. Ranta (eds.), GoTAL, volume 5221 of Lecture notes in<br />
Computer Science Springer, 371-‐‑382.<br />
Quinlan 1993<br />
Quinlan, John Ross, C4:5: programs for machine learning, San Mateo,<br />
Morgan Kaufmann.<br />
Ritter et al. 2011<br />
Ritter Alan, Clark Sam, Etzioni Mausam, Etzioni Oren, “Named entity<br />
recognition in tweets: An experimental study”, in Procee<strong>di</strong>ngs of the 2011<br />
conference on empirical methods in natural language processing, E<strong>di</strong>nburgh,<br />
Scotland, UK., Association for Computational Linguistics, 1524-‐‑1534.<br />
Schutze 1997<br />
Schutze Hinrich, Ambiguity resolution in language learning, Stanford, CA,<br />
CSLI.<br />
Turney 2006<br />
Turney Peter D., “Similarity of semantic relations” Computational<br />
Linguistics 32/3, 379–416.<br />
Wüster 1931<br />
Wüster Eugen, Die Internationale Sprachnormung in der Technik besonders<br />
in der Elektrotechnik, Berlin, VDI Verlag.
I curatori ringraziano per la collaborazione Azzurra Mancini e Francesca De Rosa<br />
che, coor<strong>di</strong>nate in Redazione dal collega Alberto Manco, hanno reso possibile<br />
l’impaginazione e gli altri passaggi necessari per l’uscita del libro.
ISBN: 978-‐88-‐6719-‐017-‐1