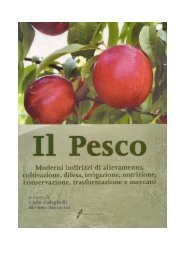B. BIONDI - Sulla dottrina romana dell' actio arbitraria.pdf
B. BIONDI - Sulla dottrina romana dell' actio arbitraria.pdf
B. BIONDI - Sulla dottrina romana dell' actio arbitraria.pdf
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ru$-<br />
{j<br />
t<br />
IIr.<br />
SUI,LA DOTTRINA ROMANA<br />
DEI.I,"AC1TIO ARBITRARIA'<br />
IN'TROI)UZIONE.<br />
SOMMAITI(, : r. I)imcoltò drc prcscnta I'lstituto <strong>dell'</strong> '<strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong>'. Secourkr<br />
I tcstl rlclkr cotupllozlorrc giustinlanea 1' 'actlo <strong>arbitraria</strong>' pernetteva<br />
In stlmt <strong>dell'</strong>ftrtcrcssc locl del convenuto e <strong>dell'</strong>attore; quest'ultimo sarebbe<br />
strrtn irrttodotto da latreone e da Giuliano, Opinioni degli scrittori srr tale<br />
svolgimento. - 2. Questa evoluzione a nostro awiso awenne solo per opera<br />
di Giustinlano. - 3. Piano e scopo del presente scritto.<br />
I. - Su vari elementi dell" <strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong>', chiamata dagli<br />
interpreti '<strong>actio</strong> de eo quod ceîto loco', regnatuttoragrave<br />
incertezza ed oscudtà. Non del tutto chiara ed omogenea<br />
appare la struttura e la funzione <strong>dell'</strong>istituto, nè ci è dato d'intendere<br />
appieno ed in maniera non dubbia la nattra e la costruzione<br />
delf interesse loci <strong>dell'</strong>attor-e e del convenuto che<br />
in detta azione veniva valutato. L'evoluzione poi <strong>dell'</strong>istituto<br />
nel diritto classico, la ricostruzione della formula, il<br />
significato di 'arbitrium iudicis' e <strong>dell'</strong>appellativo di ' <strong>actio</strong><br />
arbilraria ', rappresentano nella abbondante lettetatura antica<br />
e moderna sull'argomento 1) dei problerìli non ancora ri-<br />
r) ConN, Die sogenannte <strong>actio</strong> de co quod cerlo loco, r.877; ntlla<br />
di interessante reca la d.isseitazione di poco anteriore di Tnrprow,<br />
Zur Lehre aon dey <strong>actio</strong> d,e eoquod certo loao, 1875; LpNEr,, Beitrriga<br />
d,es sogenannte ac-<br />
rur Kunde des prdtorisohen Edihls. Die formel<br />
tio de eo quod certo loco und, d,as Wesen dev <strong>arbitraria</strong>e acl'ienes, pagg. 55roo;<br />
Das Ed'ictum Pelpeluurn, II Aufl., pagg. 23+-240 ; LEoIvr, nella
2(' BIONDO IJIONDI slll,t,A t)(yl'l'l{tNA R()MANA t)lir.I,'' Ac't'I() AI{ItI',tRARIA<br />
soluti in nroclo sicuro e definitivo. Tutt'altro che facili e piani<br />
sorro infirrc i testi della materia : si consideri che nel breve<br />
titolo clclle Pandette 'de eo quod certo loco dari oportet ',<br />
XIII, 4, si contengono leggi annoverate sempre ciagli interpreti<br />
fra le più astruse e contradittorie; specialmente poi<br />
la 1. B costituì per essi addirittura una 'lex damnata '.<br />
Ira ragione di tutto ciò, a mio parere, va ricercata nel fatto<br />
che tutto i'istituto <strong>dell'</strong> '<strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong>' subì nelle sue linee<br />
fonclamentali an'alterazione profonda ed essenziale per opefa<br />
dei commissari giustinianei, e credo quindi che ad essi debbano<br />
attribuirsi buona parte delle lamentate contradizioni<br />
ecl incoerenze.<br />
I.a nuova <strong>dottrina</strong> giustinianea <strong>dell'</strong> ' <strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong>'<br />
si fonda su di un elernento sostanziale di cui rnai si è dubitato.<br />
Si assume infatti concordemente, sulla base dei testi della compilazione,<br />
che nell' ' <strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong>' dovesse valutarsi ugualmentc<br />
l'interesse del debitore o del creditore ad eseguire od<br />
ottenere il pagamento nel luogo fissato anzichè nel luogo del-<br />
I'azione r). Si ritiene zrnzi che in proposito f istituto in esame<br />
abbia subito uno svolgimento nel diritto classico : fino a Giuliano<br />
1' '<strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong>' avrebbe compreso solo la valutazione<br />
<strong>dell'</strong>interesse del debitore, a cui, più tardi, per opera di<br />
I,abeone e di Giuliano, si sarebbe aggiunto il nuovo elemento<br />
<strong>dell'</strong>interesse del creditore. Un passo delle Panclette dìt notizia<br />
cli tale svolgimento :<br />
fr. z $ B D. c1e eo quod certo loco, 13, 4: '... Iulianus I,abconis<br />
opinioncm secutus ctiam actoris habuit rationem,<br />
traduz. ctel lib. XIII, tit. 4 tlal Couttnentario all.e I'a.ndette del Gr,uÉcx,<br />
Ap.pendice prima., pagg. 71y96; NlnEn, Obsevuatiu.ncwlae de iwre<br />
rotir,ano. Ad formulam <strong>actio</strong>nis arbitraúae, nella Mnemosyne, trova<br />
series, vol. XXX, pagg. 3tg-3zz; GneoEsrwî2, Aelterc und, neuere<br />
formula avbitraria, nella-Zeitschrift der Sauign-v Stiftung, Bd. XXIV,<br />
rom. Abth., pagg. 2.38-z5r; BEstir,ER, Das Edictunt. de co qttod certo<br />
loco, rgoT; Riccbeowo, nella recensione all'editto perpetuo dci I,I.:NEI,,<br />
iel Bullettino <strong>dell'</strong>Istitttto d,i, dívitlo roinano, vol. XX, pztfl. ror e segg.<br />
I)t'r lau lcl.tcratura anteriore vedi le inclicazioni clel (ìl.urtcr. Contmenlurirt<br />
cif ., t' rlc'l l,tr;peudiac cit.<br />
r) l,rr lor-rrrulaziorrc è clel PaccrtroNI, (-ioz.so di dirilto rorn.drto,<br />
vol. ll, l):ut. .l()1.<br />
I<br />
il<br />
cuius interdum potuit interesse Ephesi recipere : itaclue<br />
utilitas quoque actoris veniet.... '.<br />
Questa evoluzione è però raffigurata t'ariamente dagii scrittori.<br />
Il Lenel 1), cui aderisce il Gradenwitz 2), opinir che Giuliano<br />
nella sua qualità di redattore <strong>dell'</strong>editto perpetuo, tenuta<br />
presente una conforme osservazione cli Labeone, abbia nrodificato<br />
la formula <strong>dell'</strong> '<strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong>'in modo che l'interesse<br />
del creditore potesse pure venire valutato; la ' condemnatio'<br />
giulianea, secondo la ricostruzione clel Lenel, era concepita<br />
ne1 modo seguente : ( fr{n f\u Ao Ao decem aut si quicl alterutrius<br />
interfuit eanr peculliani Ephesi potius quam Rornae solvi,<br />
tanto pluris minorisve condemna, s. n. p. a.' 3).<br />
Di diverso avviso è il Naber a) il quale contro la ricostruzione<br />
leneliana obbietta che difficilmente la formula avrebbe<br />
contenuto l'espressa menzione 'cluanti alterutrius', c1al rnonrento<br />
che, come appare dal fr. z $ B h. t., i giuristi trattavano<br />
e cliscutevano ampiamente sull"officium iudicis' in ordine<br />
alla valutazione delf interesse delle parti 5); ciò fa supporre al<br />
Naber che la 'condemnatio' dorreva essere concepita in urodcr<br />
r) Das Edictttttt, pag. 23r).<br />
'!) Op. cit., pag. :21j ; in questo senso vecli zrnclte I(IPI', Geschichlc<br />
dev Quellen-de:s vóm. Rechts,III Aufl., pag. 68.<br />
$) Analoga è la formula proposta da LrxTEnnor,zNER, Oucllenntcissisc<br />
Zusamnu:nslelluns der Lelne dcs ròrtt. Rechls ton dev Scltttlduerhciítnissen,<br />
Bcl. l, pag.ls5. Nello stesso orrline di idee il BESIiI,ER,<br />
op. cit., pag. 90, suliè òrme clel Ruoonrr, De juris dicliont ed'iclunt,<br />
pàe. ro6, p-ropone la ' condemnatio' : 'quanti altetntrius iuterfuit<br />
l..irr rr."ttrri"rri Euhesi uotius cruarrr Ronra'e solti. tarrto pluris núno-<br />
,isv.,'c. '. I,'equiioco però di qiresta red.aziolte, osservato giustanteute<br />
lrIoNIX) llTONI)I<br />
generico : 'quanti id nomen Romae esse arbitraturus eris,<br />
eius iudex condemnato '. Secondo il Naber, adunque, quello<br />
svolgimento di cui si fa cenno nel fr. z $ B h. t., si sarebbe compiuto,<br />
seÍrpre per opera di Labeone e di Giuliano, per via di<br />
interpretazione dei giuristi in ordine all"officium iuclicis',<br />
senza alcuna particolare modificazione della formula primitiva.<br />
z. - Or a rnc sembra che la cansa c'volutiva <strong>dell'</strong>istituto,<br />
su cui turrto si è discusso, vada ricercata in altra direzione, e<br />
chc clui non si tratti cli una lenta evoluzione iniziatasi con Labt'onc<br />
e ruaturata con Giuliano, ma invece di una profonda<br />
alf,erazione operata dai compilatori nella costruzione classica<br />
<strong>dell'</strong>' <strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong>'.<br />
fl rnotivo di questa riforma giustinianea, a mio awiso, va<br />
ricercato nelle mutate condizioni del nuovo diritto, le quali<br />
non avrebbero comportato afiatto la recezione integrale <strong>dell'</strong>istituto,<br />
cosi corne era stato plasmato dall'attività del Pretore<br />
e dei giureconsulti classici. Come si vedrà appresso, infatti, nel<br />
diritto classico l' '<strong>actio</strong> arbttraúa ', in quanto permetteva la<br />
valutazione delf interesse del debitore, aveva una funzione<br />
speciale, in peifetta armonia ed intima connessione colr tutto<br />
il sistema giuridico del tempo. Con Giustiniano, invece, mutate<br />
le condizioni del diritto, e quindi venuti meno quei presupposti<br />
necessari per la sua esistenza,l" <strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong>'<br />
dcrvette sembrare una soprawívenza inutile, e perciò i compilatori,<br />
per accogliere l'istituto nella codificazione, credettero<br />
opportuno cli ampliarlo, e snatutare quella particolare funzioue<br />
classica clella stirrra clell'interesse del debitore, ponendovi<br />
accanto il nuovo elemento delf interesse del creditore.<br />
3. - Pertanto urr riesame critico cli tutto l'istituto, ricostruendone<br />
la struttura e la funzione che aveva nel diritto<br />
classico, studiando il cadere di questa funzione nel nuovo diritto<br />
e la causa della riforma giustinianea, non sarà del tutto<br />
lrrivo cl'importarza.<br />
l,'iltlagine clte iutenclo intraprenclcrc, come si vetle, è rnolto<br />
coull)lessr ccl irta cli varie clifficoltà ; nra oso sperare che racco-<br />
J-<br />
strt,l^ Ito'l"r'|RlN^ RoMANA 3tCI.r.'' Ac:l'Io ARBI_I'R:c.RIA_' :]<br />
glicnrlo tutto il materiale che ci forniscono le fonti in proposito<br />
c sottoponendolo ad un rigoroso esame critico, si potrà<br />
lrervenire ad un risultato plausibile su questo vessatissimo<br />
istituto <strong>dell'</strong> '<strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong>' e sulle ardue questioni ad esso<br />
attinenti che hanno sempre tormentato gli scrittori.<br />
Iiine del presente lavoro è quello di restituire alla originaria<br />
perfezione ed armonia 1o stato d.el diritto classico su questo<br />
punto, sceverandolo.dalle torbide ed afirettate sovrapposizioni<br />
cli Giustiniano. Dopo questi risultati sostanziali potrà allora<br />
con maggiore facilità afirontarsi il problema della ricostruzione<br />
della formula classica.<br />
Ecco ora il piano del mio esame.<br />
Nel primo capitolo cercherò di determinare qual fosse la<br />
funzione <strong>dell'</strong> '<strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong> ' e della stima clell'interesse del<br />
24 BIONDO <strong>BIONDI</strong><br />
I.<br />
SOMùI.q.RIO : 4. I,' '<strong>actio</strong> rrrbitraria' nel diritto c'lassico fu intrtxlotta per far evitare<br />
all'attore La 'pluspetitioloco'.-.5.Concetto formale della'pluspetitioloco'<br />
e necessità che l"intentio'
zb tlroNDo llIoNt)I<br />
sunl est utilem <strong>actio</strong>nem in eam rent<br />
comparafe'.<br />
Che questa 'utilis <strong>actio</strong>' nulla sia di diverso dall,,<strong>actio</strong><br />
<strong>arbitraria</strong>', chiarisce un passo delle Istituzioni giustinianee,<br />
che di sicuro deve ricondursi allo stesso Gaio 1) :<br />
$ S: c. IV,6'...ideo autem plus petere intellegitur...<br />
propter quam causam alio loco pe_<br />
tenti <strong>arbitraria</strong> <strong>actio</strong> proponitur...l<br />
la nredesirrra fuuzionc <strong>dell'</strong> '<strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong> ' trovasi inoltre<br />
clelineatzr rrclla parafrasi greca clelle Istituzioni :<br />
IV, 6, 33 '...èrer,Ai ouvéBar,vé oe &nq.r.reio0ar,, oúce èv<br />
tfr'flgéoor òlà tò pl eúpioxeoìuL oe év aùcfr, oúàè èxcò<<br />
ri6 'Egéoou òrà clv plus petitiona, roúrou 7.úpr,v ó praétcor<br />
ènevó1oe .totuitvp èva.yay.fiv. ùóòcoze yàp por è{ouolav<br />
ei xaí èxròq 6vrt tril1'Egéoou xweiv xurú. oou... xry.ì,<br />
òr,*gúyco riv 1>lus petitiona...' 2)<br />
5. - Accertato come 1' '<strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong> ' sia stata introclotta<br />
per far evitare all'attore il pericolo della ,plus petitio<br />
loco ', bisogna da questa prendere le mosse per vedere<br />
in che rnodo cletta azione abbia potuto conseguire lo scopo<br />
voluto,<br />
Nel concetto dei giureconsulti classici 'plus petere, equivale<br />
in ogni caso a 'plus intendere 'B). La causa aclunque per<br />
_ .) Ctr. Irrnnrxr, Stille fonti delle [stíh.r,zioni di G.i,ustinictno, lel<br />
Bttlleltirto <strong>dell'</strong>Isti,hr,to di diritto roilta.no, vol. XIII, pag. r95 ; BnsÉr,nn,<br />
o1r. cit., Pag 5.3; lf.q.Nc:rLEoxr, Cotttyiútdo alto sttutio clcilc iu,terbola-<br />
zitnt.i .<br />
"'...1'te ttniu' -ul. fltrntlc, ncl l;ilan.girrr, r'ol. X-\VJ, y>irt. tìt_r, d. ro.<br />
11 'l'rrrrl. lrr.r'rirri : ' . . . st'r[ crrrn ilzr. ficrt.t, utt,qo a te ìrriiaouamne_<br />
tetc Ptrsstrrr, ('lutr ullll(lniurr. liplrc-si (.ssr.s (lrt:(luc erriur tiphÉsi petère<br />
potcralr_r, crrrrr-ibi lulrr(lr.riun irrvi.rrit.rrrtrrs (.sscs,^nc(flle extrà Ephàsum.<br />
ne iu.plusp,t.titiorrerrr.i'rrcirltr-crrr), itlco Pr.aetor haric i'tentiori";;;"1<br />
posuit, Iacnltatcrrr errirrr rrrihi tlctlit extra Elthesunr (luoque a te^petendi.<br />
. . ut ita plus petitionern titenr. . . '<br />
3) Cfr. KELr.En-\VacH, Dey yòtnisclteCit'ilbyozess. \rl .4.ufl.. r)as.2ro<br />
Annr..5or, e di reccnte BESÉLER, op. cit., paàg:-ó. A lorto ii Òr,nr-,<br />
Bettrdge zuv Bearb"iltntg de s ròtn. RecJtts, iteii. "r, IJeber t,tttsl>etilioti.<br />
pag. 44 e segg., Iiurita
28 BIONDO <strong>BIONDI</strong><br />
m gr.rt"l,A rxvr"tRiNA RoMANA I)DLI.' ARU:'I-RAR:IA'<br />
.lcr-to ?2<br />
Questo risultato è però combattuto dal Cohn 1) il quale<br />
sostiene invece esser 1' 'intentio ' della formula ' in lokaler<br />
Beziehung ganz indiffeîent' e nega quindi che nell' '<strong>actio</strong><br />
<strong>arbitraria</strong>' sia stata necessaria I'inserzione del 'locus solutionis'<br />
nell' 'intentio '.<br />
Ma, a parte la fragilità degli argomenti addotti dal Cohn 2),<br />
i testi che qui riporto costituiscono la più splendida riprova<br />
delle induzioni fatte :<br />
$ E3 c. Inst. IV, 6 : 'Loco plus petitur, veluti cum quis<br />
icl, quocl certo loco sibi stipulatus est, alio loco petit sine<br />
comrncmoratione illius 1oci, in quo<br />
sibi dari stipulatus fuerit: verbi gratia<br />
BEKKER, D'ie Ahtionen des vòmischen Priuatvechts, Bil. II, pag. r33<br />
Anm. 8. Ma contro l' ' iatentio in factum', decisive sono le osservazioni<br />
del f.ENEr., Bei,trcige cit., pag. 65 e segg. ; Das Ed,'ictum, p^9. 234;<br />
per l" intentio in ius' vedi anchel(aRr,owA, Ròrn. Reclttsgesahichte,<br />
II, pag. 1366.<br />
r) Op. cit., pag. z6 e segg. ; Bei,trtige zwr Bearbe'ítttng des rònr..<br />
Rechts, Bd. l, Heft L, Uebev Pluspctilion, pag. 55 e segg.<br />
2) Vedi per una minuta confntazione BESF;LER, op. cit., loc. cit.<br />
Su d'uno clei principali argornenti conviene ancora irrsistere. Il Conw<br />
obbietta che se f intentio : ' s. p. Ntt Nn Ao Ao d.ecem clare oportere '<br />
fosse uguale a ' s. p. Nn N" Ao Ao decem hoc loco (Romae) oportere ',<br />
quest'ultima ' intentio ' non potrebbe consurirare l'obbligazione lrasèente<br />
dalla 'stipulatio' : 'ilecem Ephesi mihi date épondes ? ',<br />
e quindi il cred.itore avrebbe potuto ripropoÍre l'azione. Ma è stato<br />
ossèrvato giustamerrte clal BBsÈrBn, op. "i1., pag. 2,.23., she la corsumazione<br />
si avverava, appunto perche ' Ephesi dare' e 'Romae dare'<br />
sono 'eadern res '. }I. l(nunCnn però (recensione al Beselet, nella<br />
Zcilschrift der Sauigny StiJhLng, rom. Abth., Bcl. XXIX, pag. igz e<br />
seg.) osserva in contrario, che ' Ephesi dare' e 'Romae d.ate' non<br />
soiro ' caclcnr rcs ', tzurto vero, che se il creditore per il sodisfacirnento<br />
tli rura obbligaziorre di rlare ccl .Efeso agisce a Iìorna, viene respinto<br />
pt.r ' lllrrs lx,titio '. I.'olrhieziorre parrrri ch
:ìo<br />
I]IONDO IJIONDI<br />
nese'l), dalle prime parole con cui s'inizia il foglio zo7 che<br />
chiudono la trattazione sulla 'plus petitio loco ' : 'id est non<br />
adiecto loco'.<br />
6. - Ma la ragione sostanziale per cui il creditore, agendo<br />
in un luogo diverso da quello stabilito, incorreva nella 'plus<br />
petitio loco', consisteva in ciò, che coll'azione ordinaria proposta'alibi',<br />
si veniva a togliere al debitore quel particolare<br />
vantaggio, quella speciale 'utilitas ', come si dice nelle fonti,<br />
che egli si riprometteva di conseguire paganclo la sommadovuta<br />
nel luogo stabilito.<br />
Ciò è cletto esplicitamentc nel citato passo delle Istituzioni<br />
giustinianee :<br />
$ Sg c. IV, 6 ' . . . ideo autem plus petere intellegitur,<br />
quia utilitatem, quam habuit promissor,<br />
si Éphesi solveret, adimit ei<br />
pura intentione...'.<br />
Conforme troviamo altresl la Parafrasi:<br />
'...ei '8è puros,... eio&yera.r. plus petìticon.
,<br />
i<br />
32<br />
BIONI)O AIONDI<br />
incompetenza del magistrato avente giurisdizione in un luogo<br />
diverso da quello stabilito dalle parti 1), ed il Cohn 2) credè di<br />
aver trovato il fondamento della 'plus petitio loco' nella<br />
limitazione <strong>dell'</strong> 'officium iudicis' la quale avrebbe vietato che<br />
il giudice potesse conoscere d.i una obbligazione da eseguirsi in<br />
un luogo diverso da quello <strong>dell'</strong>azione.<br />
I testi sopra riportati e le consiclerazioni fatte ci dispensano<br />
da una critica particolare cli queste opinioni.<br />
Z. - Se il fondarnento della ' plus petitio loco ' stava adunque<br />
in ciò, che il creditore agenclo 'alibi' veniva a togliere al debitore<br />
il vantaggio ('utilitas ') di pagare nel luogo stabilito,<br />
è intuitivo che 1' '<strong>actio</strong> arbittaria', destinata appunto a far<br />
evitare la 'plus petitio loco ', doveva essere costruita in modo<br />
che il debitore non venisse a perdere quella 'utilitas '. Ed in<br />
realtà la formula <strong>dell'</strong> ' <strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong> 'proposta dal Pretore<br />
permise che venisse stimata giudizialmente questa 'utilitas '<br />
del debitore e dedotta dalla somnra contrattuale s).<br />
Ciò trovasi enunciato nel modo più chiaro nel $ pitì volte<br />
citato delle Istituzioni giustinianee e nella parafrasi :<br />
'... id.eo autem plus petere intellegitur, quia utilitatem,<br />
quam habuit promissor, si Ephesi solveret, adimit ei pura<br />
intentione : propter quam causam alio loco petenti a r b itraria<br />
<strong>actio</strong> proponitur, in qua scilicet<br />
ratio habetur utilitatis, quae<br />
promissori competitura fuisset, si<br />
illo loco solveret...'<br />
con maggiore determinatezza il parafraste riferisce :<br />
_ 1) Cf_r. Sevrcxv, Sistema di diyilto lolna.no attotale, trad.. Scialoja,<br />
vol. VIII, pag. 216; BEîHMANN-HoLr.wEc, Verswahe ùber einzelnen<br />
The,íle dey fkeorie der Ciuil,prozcssds, pag. 46; recentemente<br />
anche _LEoNntno, Erfii,llungsort wid, Schuldoit,,"pa!. ú.<br />
,) Qp. cit., pag. z1j e segg.<br />
3) E un mero equivoco quello <strong>dell'</strong>Acc,lnres (précis dc d,roit<br />
rotnain, tom. II, n. 86.3 n. r) il quale, a proposito di ouei eiuristi che<br />
avversavallo la considerazione àell'inte^resie <strong>dell'</strong>attòre, "scrive che<br />
essi: 'aboutissaient à un résultat bizarte; c'est que l,<strong>actio</strong> de eo<br />
q. c. l. aurait protégé le débiteur bien mieux que le créàncier e t tr o u r _<br />
tant c'cst en f aveur de ce d.ernier c1 u',elle<br />
avait été introduite'!!<br />
il<br />
I<br />
I<br />
I<br />
Iilrt,t,A txfl"ltUNA l{()MAN^ l)lil,l,' ' Act'ro Al{IlI'l'l{Àt{I^ .)J<br />
' ,.. xal où Eei xucuSm&(ea0ocl ei6 tù p vopíoptocta aútòv<br />
èxr6q rìÉ'Egéoou. 8ei yùp è(ocr,pe0!var, t6v p vopr,opr,cÍcov<br />
tooocùca, 6oa (1plloùron èxrè,< t!6 'Egéoou xacapotì,óv.<br />
ru1òv yàp èv tfr 'Pópr,1 cò Xpéo6 xoccaBctleiv uvuyxa.(6prevo(,<br />
Socruav{ x volt"iop.ata ei6 cò zcepr,zcor,iooct éocutQ clv<br />
xooótntu, iv èXpiv pr,or So0ivar xai Arù coùto oú xotraStx&(eru<br />
èu< cù. p, d).ì.' ei< rù.7E...")<br />
Dopo queste esplicite attestazioni, non metterebbe conto insistere<br />
sulla funzione della stima <strong>dell'</strong>interesse del debitore e<br />
sulla sua esclusiva connessione colla 'plus petitio loco ', se<br />
ciò non fosse stato disconosciuto di recente dal Beseler. Questo<br />
scrittore, come si è visto sopra, riconosce giustamente la necessità<br />
che 1' '<strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong>' menzionasse nell' ' intentio '<br />
il luogo di pagamento frssato dalle parti, ma prende uno strano<br />
abbaglio quanclo ritiene che ad evitare la ' plus petitio loco'<br />
bastasse solo 1' ' adiectio loci ' rrell' 'intentio', e concepisce<br />
la stima delf interesse nell' '<strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong>' come qualche<br />
cosa di inclipendente ed autonomo dalla 'plus petitio loco' ').<br />
Come si può infatti disconoscere la vera funzione della stima<br />
delf interesse del debitore, quando essa trovasi scolpita nettamente<br />
nel pensiero dei giuristi classici, ed è sempre viva ed<br />
operante nelle loro decisioni ?<br />
Gaio da cui fu estratto il S S: c. Inst, IV, 6, un testo inso-<br />
t; îracl. Ferrini : '. . . ncqrle oportet eurn extra ììphesunr in C<br />
arreos condemnare : a C ergo aureis tantura est deducerrdum, quanti<br />
eius interest Ephesi solr'ere. forte enim coactus Rontae debitum solvere<br />
XX aureoS impend-it ad summarn comparandam, (pram mihi dare<br />
oportebat; et ideo non in C aureos conclemnabitut, sed in LXXX. . . .<br />
^ t) Op. cit., pag. 68 e seg. Il pensiero del Beseler su ciò si deduce<br />
chiaralrente, oltre che dalla ricostruzione <strong>dell'</strong>editto (pag. 67) da<br />
ouanto scrive a oae. 68 : 'Dnrch z.rvei llomente unterscheidet sich<br />
d.ìe <strong>actio</strong> arbitraiia" von der cond.ictio certae pecuniae, tlurch die<br />
loci in intentione adiectio un
34<br />
BroNr)o I]roNI)r<br />
spettabile sotto tutti i punti di vista, e ritenuto quindi a torto<br />
interpolato dal Beseler 1), ci delinea nettamente il concetto<br />
della ' plus petitio loco ' in questi termini:<br />
'...plus petere intellegitur, qui a utilitatem,<br />
!Iuam habuit promissor, si Ephesi<br />
solveret, adimit ei pura intentione';<br />
ed in stretta connessione, come di causa ad effetto, continua<br />
immediatamente glopo :<br />
'propter quam causarn... <strong>arbitraria</strong> <strong>actio</strong> proponitur,<br />
in qua scilicet ratio habetur utilitatis,<br />
quae promissori competitura<br />
fuisset, si illo loco solveret'.<br />
Inoltre i giuristi, anche posteriori a Gaio, riguardo all'applicazione<br />
<strong>dell'</strong> '<strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong> ' sono sempre guidati unicamente<br />
dal criterio della esisteîza o meno <strong>dell'</strong>interesse del<br />
debitore e de1la possibilità che esso venga valutato.<br />
Cosi nel fr. z $ z h. t., Ulpiano, lib. XXVII ad ed., in<br />
caso di stipulazione alternativa, decide che il creditore :<br />
'...non debet detracto altero loco experiri, n e a u f erat<br />
loci utilitatem reo.<br />
E Paolo, lib. XXVUI ad ed., nel fr. z7 D. tz,6 nega l'applicabilità<br />
<strong>dell'</strong> '<strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong> ' alla 'indebiti solutio' con<br />
questa motivazione :<br />
non enimexi sti mati onem solventi s eadem<br />
species repetitionis sequitur .'<br />
Lo stesso ci attesta Ulpiano, lib. XXVIII ad ed., nel fr. g,<br />
pr. D. 13, 6 in orcline ai giudizi di buona fede per la ragione che<br />
'offi.cioiudicisinest, u t r at i o n e m I o c i h a b e a t'.<br />
1) Op. cit., pag. .53 e seg. Non è possibile ammettete, come vorrebbe<br />
if Bnsnr,En, che Gaiò abbia scritto 'ea intentio proponitur<br />
in qua loci mentio fit...': a parte la strana singolarità della proposizione<br />
di una 'intentio ', Gaiocertamentenon potèavere scritto:<br />
î ea 'intent'ío proponiturin qua. . .inquatatio habdturutilitatis. . .'<br />
La parafrasi, a cui si richiama il Beseler, a mio avviso, conferma<br />
pienamente la classicità clel passo; è strano però corne il Fnnnrrcr,<br />
traduca la frase ènevó1oe ror,arltr;v Évayorl{v per ' hanc inten tionem<br />
proposuít'. 'Evory
36<br />
lroNIX) llroNt)r<br />
debatur agendi facultas competere... ideo visum est<br />
utilem <strong>actio</strong>nem in eam rem comparare'.<br />
fr. 3 h. t. Gaius, lib. IX ad ed. prov. : 'Ideo in arbitrium<br />
iudicis refertur haec <strong>actio</strong>, quia scimus,<br />
quam varia sint pretia r e r u m per singulas civitates...'<br />
fr. 5 h. t. Paulus, lib. XXVIII ad ed. : 'Si heres a testatore<br />
iussussitcerto loco quid d a re, a r b i tr aria<br />
<strong>actio</strong> competit'.<br />
îr. 7 h. t. Paulus, lib. XXVIII ad ed. : ' In bonae frdei<br />
iudiciis, etiamsi itr contrahendo convenit, ut certo loco<br />
qui d p raestetur, ex empto vel vendito veldepositi<br />
<strong>actio</strong> competit, non <strong>arbitraria</strong> <strong>actio</strong>'.<br />
S r: 'Si'tamen certo loco traditurum se quis<br />
stipulatussit, hac <strong>actio</strong>ne utendum erit'1).<br />
Or nulla prova che questi frammenti siano stati alterati<br />
dai compilatori a fi.ne di ricomprendere nell'ambito <strong>dell'</strong> '<strong>actio</strong><br />
<strong>arbitraria</strong> ' anche I'azione'de certa re', e che i giuristi abbiano<br />
scritto invece, come vuole il Beseler, 'ea intentio proponitur<br />
in qua loci mentio fit ', oppure 'adiecto loco in intentione<br />
agendum' e simili.<br />
Non 1o provano affatto quei due testi su cui il Beseler costruisce<br />
la sua congettura 2), e che qui bisogna prendere brevemente<br />
in esame :<br />
fr. 4 D. 13, 3, Gaius lib. IX ad ed., prov. : ' Si merx aliqua<br />
quae certo die dari debebat, petitasit, veluti vinum oleum<br />
frumentum, tarfti litem aestimanclam Cassius ait, quanti<br />
fuisset eo die, quo dari debuit : si cle die nihil convenit,<br />
quanti tunc, cum iucliciun acciperetur. idemque iuris in<br />
loco esse, ut primum aestimatio sumatur eius loci, quo<br />
dari debuit, si de loco nihil convenit, is locus spectetur,<br />
quo peteretur. [quod et de ceteris rebus iuris est Tribi 21.<br />
1) <strong>Sulla</strong> genuinità o rleno di questo frammento ved.i però oltre.<br />
- 2) Nou è.serio I'argomento.che il BBsnr,DR, op. cit., pag. 53, vuol<br />
ricavarc ,"lolla c. un. C. 3, 18.<br />
3) Cfr. I{rccr)BoNo, nello scritto citato alla nota seguente.<br />
ri<br />
suì.f,^ txtt'fltlNA I{oMANA tlr':1,r," lcîro ARlllTRARra JI<br />
fr. zz D. rz, t, J:ulianus lib. IV ex Minicio : ' Vinum,<br />
quod mutuum datum erat, per iudicem petitum est : quae'<br />
situm est, cuius temporis aestimatio fieret, utrum cum da'<br />
tum esset an cum litem contestatus fuisset an cum res<br />
iudicaretur. Sabinus respondit, si dictum esset quo tempore<br />
redderetur, quanti tunc fuisset, cum petitum esset. interrogavi,<br />
cuius loci pretium sequi oporteat' respondit, si<br />
convenisset ut certo loco redderetur, quanti eo loco esset,<br />
si dictum non esset, quanti ubi esset petitum' 1).<br />
Questi frammenti distinguono due ipotesi : una in cui è<br />
stato determinato dalle parti il ' locus solutionis ', l'altra in cui<br />
nulla su ciò si sia stabilito. Riguardo alla prima, i1 Beseler<br />
sostiene che l'azione intentata 'alibi', che in quei testi si<br />
plesuppone, non poteva essere l"<strong>actio</strong> arbitratia ', mainvece<br />
la comune'condictio 'coll' 'adiectio loci 'nell' 'intentio '.<br />
Or questa alternativa presentata da1 Beseler importa che<br />
duplice o con diversa caratteristica dovesse essefe 7'azione pte'<br />
supposta nelle due ipotesi fatte da quei testi: l" <strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong>'<br />
o la ' condictio certae rei ' coll' 'adiectio loci'<br />
qualora fosse stato determinato il 'locus solutionis', e<br />
la semplice 'condictio' nel caso inverso. Ma l'identitàr as'<br />
soluta <strong>dell'</strong>azione risulta eviclente. Nel fr. 22, cotne pure nel<br />
fr. 4, si ammette come premessa generale : 'Vinum, quod mutuum<br />
d.atum erat, per iudicem petitum est...' ; e solo in ordine<br />
alla questione ' cuius temporis aestimatio fieret ' e ' cuius loci<br />
pretium sequi oporteat', Minicio riferisce il responso di Sabino<br />
che distingueva le due ipotesi 'si dictum esset' e 'si<br />
dictum non esset'. Se questo era ad.unque l'ordine di idee<br />
clel giurista, vuol dire che assolutamente identica doveva essere<br />
l'azione nelle due ipotesi 'si convenisset ut certo loco<br />
rcclderetur', 'si dictum non esset', e che quindi questa distinzione,<br />
come la precedente sulla determinazione o meno<br />
rl A torto uuesto frammento è stato collocato a capolista delle<br />
Irrrrr,',sr' 'lt'gcs dàmrratae': cfr. RrccoBoNo. Studi cvitici -sulle fonti del<br />
liritto rorn'rhto, :nel Bulleltino delt'Ist. di dir.rcm., vol. VIII, pag,232.
38 BIONDO <strong>BIONDI</strong><br />
del 'tempus quo redderetur', rifletteva unicamente l,interpretazione<br />
della 'condemnatio ' nella . condictio certae rei ,<br />
in ordine alla 'aestimatio ' della cosa dovuta ). Nè il .locus<br />
solutionis ' fi.ssato delle parti avrebbe potuto avere efficacia<br />
per la determinazione del luogo <strong>dell'</strong>azione, dapoichènel caso<br />
esaminato dai giuristi in quei frammenti, come ci attestano<br />
le espressioni c1i indubbio significato da essi adoperate 2), il<br />
luogo di pagarnento anzichè forrnare parte integrante del con_<br />
ttatto , era stato fissato mediante ' conventio , priva d i forma B) ,<br />
la quale se poteva avere efficacia, secondo la d.ecisione<br />
di Sabino e di Cassio, in ordine alla stima della cosa d.ovuta,<br />
certarnente no' sarebbe stata di ostacolo a che il creditore<br />
agisse in un luogo diverso.<br />
9. - Riguardo alla natura della stima dell,interesse nell, , <strong>actio</strong><br />
<strong>arbitraria</strong>', il Beseler opi'a che il giuclice dovesse cond.annare<br />
in una somma avente 1o stesso valore obbiettivo di quella<br />
dor,'uta nel luogo stabilito a).<br />
Questa costruzione è però campata in aria e prescinde dai<br />
dati più sicuri che noi abbiamo <strong>dell'</strong>istìtuto 6).<br />
Se, come si è cercato sopra di mettere in evidenza, l,,<strong>actio</strong><br />
<strong>arbitraria</strong> ' fu introdotta per evitare il pericòlo della'plus petitio<br />
loco', e con questa particolare funzioneconnettevasiesclu_<br />
sivamente, fino agli ultimi giuristi classici, la stirna dello inte-<br />
- t) gò non era irrfrequerrte rrei giuristi: vedi fr. sq D. ai. r :<br />
fr. óo D. eod. ; fr. 3 D.13,3 (su di e"sso cfr. peròftancúí. ""ntl':Sia;<br />
1.n onorc di Vittorio Scialoja, vol. I, pag. r j3) ; per la,"cndita védi<br />
anche fr. 3 D. 19. r.<br />
.. .r.) Fr. r.3 cit. : . . . si de die nihil convc nit. . . si de loco<br />
ntl_rl_Icoltvcnit; ir. z: ci1.:'... si ùictrrur csset ouotemtore<br />
redderetur... si clicturn rron esset... si co"uèrìl .r;;T;<br />
certo loco redderetur... si d.ictur' nonesset'. ni r.àul" a à"iste<br />
espressioni si comPrend.ono affatto<br />
'on<br />
i dubbi t.<br />
I-(quocUn, recensione cilatq, pag. 496 ; certanrente, " cred.o, ".itu"7Jààr ;";1;;<br />
di$coltà nel fr. 13 tluel 'daii deuujt ;, it cui ;È;i"-;H".i;;<br />
dalle parole seguenti 'si de die nihil convenit, ";i";;<br />
. t) ln q_uesto senso ve
40<br />
BIONDO <strong>BIONDI</strong><br />
presso rnutilato dai compilatori, inizia una speciale trattazione<br />
sull' 'officium iudicis' nell" <strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong>', la quale<br />
doveva essere molto particolareggiata ecl estesa, come lasciano<br />
supporre le prime parole introduttive : 'Nunc de officio iudicis<br />
huius <strong>actio</strong>nis loquendum est... '.<br />
ro. - Dalf indagine fatta sin qui si può concludere che<br />
l' '<strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong> ' fu introdotta nel diritto classico perfare<br />
evitare all'attore il pericolo della 'plus petitio loco' e che a<br />
tal fine constava di due elementi caratteristici : l'' adiectio '<br />
del 'locus solutionis ' nell" intentio' e la deduzione dalta<br />
somma clovuta dcll'interesse del debitore ad eseguire la prestazione<br />
nel luogo stabilito anzichè in quello <strong>dell'</strong>azione. I-,a<br />
stima delf interesse del debitore, aclunque, in tanto giustificavasi<br />
in quanto aveva la funzione essenziale di far evitare<br />
la 'plus petitio loco '.<br />
II.<br />
SOIII{^.\RIO : rr. Iivoluzir:ne tlclf istituto. Scorruessione e clisarnronia in cui viene<br />
a ttovarsi f interessc tlcl crccìitore col precerlentc stato tli tliritto. - r:. Nel diritto<br />
giustinianeo cleve suplnrsi rura rnorlificazionc nei priucipi clell' '<strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong>'<br />
a cansa (Ìel lenir nreno tlel cotrcetto r: degli effetti dcller 'pltts petitio ' classica.<br />
,A.rgonrento che si ricara rìal $ 33 Inst. IV, 6. - r3. I'interesse del creclitore<br />
non fu introdotto da l,abeone. !ìsame (lel fr. 15 I). 16, z. - 14. Difficilmente<br />
potè essere introdotto tla Giuliano: I'aolo (fr, z7 D. ra, (r) ecl tl$iano (tr. z $ z<br />
D. h. t.) mostrano cf iqnorarlo completamente.- 15. I frarnrnenti r e 3 D. h. t.<br />
ed il 33 c. Inst. I\r, 6, airpartenenti a Gaio attestauo che 1a formola <strong>dell'</strong>editto<br />
"s perpetuo anlnettcva la stima clel solo interesse del debitole. --- ró. Conclusione<br />
su questi testi.- 17. 11 îr.8 h. t. e la sua iltelpolazione. Valore rÌi essa.<br />
18. Il fr. z -<br />
1rr. h. t. non è che una fonmtlazione generale ilei compilatori.-<br />
r9. IlsaÌrc del fr. : S 1l h. t. Ricostruzione rlella prirna parte. -<br />
zo. I.,-satne della<br />
secorrdn partt'. I'irrtervento r'lei conrlriliìtori. -- 2r. hr.dizi rli fonuir. -- 22.Iilemerrti<br />
ricaviLti dalla sostrurza. .\rgonrclto rÌecisivo conlro le classicità rlelf interesse<br />
rìcl crcrìitorc. l,rr citazionc rli lalrconc e rii (iiuliauo ù unar courplcta falsi6caziorre<br />
dci cornpilirtori. * 23. I.u riprovir rlclla eszìtta ricostrnziole della prima<br />
parte clel fr. z g E e dcllzr intcqrolazione tli tutto il resto siiha nel sunto dei Basilici.-24.<br />
Interpolazionerlcllac.un.C.3,18.-25.In tretestidellePandette<br />
si pre-supporre come ligcnte nell"<strong>actio</strong> atbitraria' I'iuteresse del creclitore.<br />
Si pone lir tesi che essi siano stati adattati a ciò clai compilatori. - zC). Esame<br />
clel fr. ro Lt. t. - 27. Del fr. .z "s 7 h. t. - 28. Del Ir. 4 1,r. h. t.<br />
rr. <strong>Sulla</strong> base clei testi della cornpilaziorre cli Giustiniano,<br />
-<br />
si assume clagli sclittori che ia <strong>dottrina</strong> deil' '<strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong>',<br />
l)cr ol)cra di I,abeone e cii Giuliano, dovette subire un anrplia-<br />
!i(Il,t,^ I)()'l"l'tìtNA fìolfÀNA I)ÉLI,, . ACTIO ARBITRARIA<br />
ur('nl(t ttotc'vtllc tìcterminato dalla introduzione del nuovo<br />
t'lt'utt'ttt
42<br />
BIONDO <strong>BIONDI</strong><br />
tore 1), e corlle mai il Pretore, secondo la formula proposta<br />
dal l,enel (' cluanti alterutrius interfuit'), ed i giuristi nei<br />
loro scritti abbiano potuto accomunare sotto unico concetto<br />
ed unica espressione (' alterutrius ' 'utriusque ') elementi sì<br />
disparati.<br />
Si aggiunga inoltre, che mentre la concezione originaria<br />
delf istituto balza limpida e ben netta dai testi riportati nel capitolo<br />
precedente, e s'incardina perfettamente con i principi<br />
processuali vigenti nel diritto classico, invece la concezione<br />
<strong>dell'</strong>istituto clopo Ia presunta iturovazione giulianea appare torbida<br />
ed incoercibile per una ricostruzioncorganicaccl unitaria.<br />
Ecl invero, quclla clisparità. cli prcsupposti c c1i nornre regolatrici<br />
dei due interessi, testè messa in evidenza, rende un tal<br />
compito poco agevole, e pertanto i vari tentativi fatti in<br />
proposito devono riputarsi falliti. Così il sommo Cuiacioz),<br />
volendo unifi.care tutto f istituto sotto il concetto della mora,<br />
ammise che I'interesse del creditore dovesse essere valutato<br />
in caso di 'rnora solvcndi ', e c1uello del clebitore nel caso di<br />
' mora accipierr
44<br />
rlIoNl)() IrIoNl)I<br />
niano appurto nel $ 33 Inst. IV, 6, copiando sostanzialmente<br />
c1a Gaio, tratta clegli efietti della ' plus petitio' classica come<br />
cli norme non più vigenti a1 suo tempo :<br />
'Si qui agens in intentione sua plus complexus fuerit,<br />
quam adeum pertinet, causa cadebat id est rem<br />
amittebat, nec facile in integrum a praetore<br />
restituebatur...<br />
Nello stesso $ si parla della ' plus petitio loco ' e clelf introduzione<br />
c1ell" <strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong>':<br />
' ... proptcr qrlallt causanr alio loco pctcnti <strong>arbitraria</strong><br />
<strong>actio</strong> proponitur, irr rlua scilicet ratio habctur utilitatis,<br />
quae prom,issora compctitura fuissct si illo loc
,lr ) IIIONIX) JII()NI)I<br />
I,a lezionc ' Titii ' al posto di 'tua ', che si trova nella<br />
Vulgata r) certaruente va respinta ; anzittttto, perchè il testo<br />
in tal rnodo verrebbe a comprendere nella 'causa crediti '<br />
per una obbligazione di dare in un luogo stabilito solo l'interesse<br />
del creditore, in secondo luogo, è avversata dal passo<br />
corrispondente dei Basilici, il quale ci attesta come ladecisione<br />
di Giavoleno riferivasi solo all'interesse del debitore 2).<br />
Che nel testo non sia tutto in ordine, è provato da quell'assoluta<br />
non corrispondenza del 'quoque' : nessun giurista a<br />
cui fosse stato richiesto'an hoc quoque pensandum sit<br />
quanti nlea interf uit', avrcbbc supinamente risposto'earn<br />
quoque l)ccuniant, clua"nl ccrto<br />
loco promisit in cornpensationem clcduci oportet':<br />
ed inelegante riesce poi la frase'an hoc...!truanti mea<br />
interfuit'.<br />
Ora il responso di Giavoleno, la cui indiscutibile integrità<br />
ci è confermata dai Basilici, dimostra come ben diversa doveva<br />
essere la questione sottoposta al giurista. Nel responso<br />
la valutazione delf interesse ha un'importanza del tutto<br />
accessoria, dipendente dalla decisioneprincipale :' eam quoque<br />
pecuniam... in compensationem deduci oportet' ; il giurista<br />
decide che anche quel credito può compensarsi, ma, tenendo<br />
presente i principi dell" <strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong>', si affretta asoggiungere<br />
che il credito deve essere compensato ' cum sua causa',<br />
cioè tenendo conto delf interesse del debitore 'certo loco '.<br />
Quindi probabilmente il clubbio del richiedente verteva<br />
appunto su ciò, se ancheilcredito' certoloco' potessecompen-<br />
sarsi e la 'quaestio' presso a poco doveva essere formulata<br />
così : ' an hoc quoque peusanclum sit [quanti mea inter-<br />
fuit certo loco dari 'l 3).<br />
1) Ved.i anch.e Scnur,TrNG, Nolde ad Digesta, ad h. l.<br />
2) Bas. XXIV. ro, 5 ; Eleimb. III, 46.<br />
s) Cfr. anche Busr:rBn, op. cit., pag. 92. Il prononre ' ltoc ' si riferiva,<br />
comè risulta senza alcuna ambiguità dal cbntesto, al credito ccrto<br />
loco da oppotsi in compensazióne. Il periodo chiuso itr parcntesi<br />
rluadra "i,frre manifeétamente insiti'cio ; f intrusione ^proviene<br />
lirol;abilmèite cla clualche studioso che avesse poco o nulla ctrmpreso<br />
rrel tcsto di Giavoleno.<br />
illll.l,A<br />
lrlrl I l
46<br />
IJIONI)O I}IONI)I<br />
è vero non si parla direttamente della valutazione d'interesse<br />
nell" <strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong> ', ma è chiaro che se al tempo di Paolo<br />
detta azione avesse compreso anche la stima <strong>dell'</strong>interesse del<br />
creditore, sicuramente il giurista, comentando I'edittol), non<br />
avrebbe datounaragione così unilaterale (' non enim existimationem<br />
solaentis eadem species repetitionis sequitur ') per negare<br />
l'applicazione <strong>dell'</strong> '<strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong>' alla 'indebiti solutio'.<br />
Nello stesso ordine di idee troviamo altresì Ulpiano il<br />
quale nel fr. z $ 2 h. t., estratto dal lib. XXVII ad ed., a proposito<br />
di stipulazione alternativa 'Dphesi decern aut Capuae<br />
honrinem clari ', clecide chc il creclitore :<br />
'nonclebetdetracto altero lclco cxperiri, ne auf e -<br />
rat loci utilitatem reo'2).<br />
Di fronte a questi frammenti rispecchianti ancora nella fi.ne<br />
del periodo classico quella concezione delf istituto che sopra<br />
ho cercato d.i ricostruire, riesce ben difficile ammettere che<br />
essa si sia potuta mutare ed ampliare al tempo di Giuliano ;<br />
e pertanto, sorge grave il sospetto che non ai classici debba<br />
ricoirdursi quella lluova figura <strong>dell'</strong> '<strong>actio</strong> arl>itraria ', che si<br />
affaccia ora nei testi de1la compilazione giustinianca.<br />
1) Nel lib. XXVIII Paolo comentava l'editto 'de eo quod certo<br />
loco dari oportet' : cfr. LENEL, Palingencsia, vol I, col. rozr. Ed<br />
il fu. z7 faieva parte di una rnirruta Irattazione intorno ai singoli<br />
casi di applicazione dell"<strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong>', come ci attestano iJr.i<br />
5 D. 13, 4 e 7 pr.,g r D. eod..<br />
':)<br />
11 principio contenuto in questo g lungi dall'essere annientato<br />
dal successivo S:, court. si ò preteso, (cfr. Gr,unt'x, op. cit.,846,<br />
tra.J. it., l)lrgg. r zz-rz5) ricevr: rla csso solo rrna rlLgiortwolc limitazione<br />
lcl seuso chc la facoltà
5o<br />
BIONDO <strong>BIONDI</strong><br />
Il silenzio assoluto di Gaio sulla innovazione di Giuliano è<br />
spiegato dal I,enel 1) ritenendo che ivi I'istituto dell" <strong>actio</strong><br />
<strong>arbitraria</strong>' sia considerato, non nel suo insieme, ma solo come<br />
il mezzo per evitare la 'plus petitio loco', e perciò ilgiurista<br />
s'intrattiene solo sulf interesse del clebitorc trascurando del<br />
tutto la innovazione giu.lianea.<br />
Or se ben si guardi, questo rilicvo
jj.?<br />
ÙIONDO IJIONDI<br />
qualc iruportanza poteva, i'fatti, avere per il creditore la cli_<br />
versità clel tasso delle . usurae , nei vari iuoghi ? fnvéce ciò<br />
riguarclava esclusivamente il debitore: suppongasi che questi,<br />
convenuto a Roma, mentre erasi obbligato a pagare acl Efeso,<br />
è costretto a prendere a prestito nel luogo ilelr'azione ra somma<br />
cla pagare ; ora, se nel luogo clell,azione il tasso clelle . usurae ,<br />
è uraggiore che ar1 Efeso, si comprencle bene corne questa differenza<br />
possa costituire<br />
' suo int"r".se loci da dedursi clatel<br />
solnnìa dovuta 1).<br />
E lc stessc parore cri Gaio; . pecu'iarur,... .riis locis faci_<br />
lius et levibus usuris invcriorrtur, alìis rliflìcilius et<br />
gravibus usuris ', lireserrta'o lr|1lu'to alla noslra nrcltc l,idea<br />
di un debitore che, convenuto in un luogo cliverso cla quelio<br />
stabilito, va a farsi prestare la somma clovuta ed è costretto<br />
acl impegnarsi per .usurae , maggiori di quelle consuete nel<br />
luogo in cui erasi obbligato u pug-".<br />
Adunclue Gaio tanto nelle , res cottidianae , quanto nel<br />
comento all'edittoprovinciale conosce come vigente nell, .ac_<br />
tio <strong>arbitraria</strong>' solo la stinra clell,interesse del debitore; e ciò<br />
rnentre fa cadere la spiegazione clel Lenel sul ,if"rrrio ìfi<br />
Gaio nel $ SS c intorno all,interesse del creclitore, esclude al_<br />
tresì che tale silenzio possa spiegarsi ammettencì.o che quel<br />
giurista anche qui, come spesso 2), si mostri ignaro del rnovi_<br />
mento giuridico del suo tempo perchè segue un antico mo_<br />
clello s).<br />
_ - t) Questo caso trovasi configurato, come<br />
i:t$,ffi :i?drit1=r;a-.'i,'i'''i*-itii**i#<br />
F^:r_,: &;;:ft;{ù';;? eaur
17. - Qualsiasi<br />
lIIONI)O I}IONL)I<br />
clubbio intorno all'origine giustinianea dello<br />
intercsse clel creclitore dovrà svanire di fronte al fr. B h. t.<br />
chc, opportullamente sceverato dalle alterazicni tribonianee,<br />
inostrlr c1uali siauo state le norme vigenti nel diritto classico<br />
in ordine alla stirna delf interesse nell' ' <strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong>'.<br />
Africanus, lib. III quaestionurn: ' Centum Capuae dari<br />
stipuiatusfideiusscrem accepisti: ea pecunia ab eo sinriiiter<br />
ut ab ipso promissore peti ciebebit, id est ut, si alibi<br />
cluam Capuae petantur', <strong>arbitraria</strong> agi clebeat lisclue tanti<br />
aestiructtrr, cluariti cius ucl actoris interftierit cam summaru<br />
Capuac potius tluam rrlibi solvi. nec oportcbit,
5r)<br />
DIONDO <strong>BIONDI</strong><br />
clire: ' lisque tanti aestimetur quanti e'ius et debitoris interfuerit...'<br />
Riguardo alla seconda parte clel testo, nessun aiuto ci fornisce<br />
il passo dei Basilici. Però come ho rilevato nel citato<br />
lavoro, è impossibile che Africano, come fa il testo delle Pandette<br />
avesse menzionato solo l'interessc cleli'attore :<br />
'offi.cium iudicis tale esse clebcat, nt aestimet quanti<br />
actoris intersit...'.<br />
Infatti, se f interesse dcl debitorc, tlala Lt sua funzionespeciale,<br />
doveva sernprc valutarsi ncll" <strong>actio</strong> urbitraria ', è<br />
chiaro che tzrle intercssc clovcva sictrnnrcntc csscre nrenzionato<br />
da Africano; clcve amntettcrsi,
5li IltoNl)o rrloNl)I<br />
Quiu
III()NJX) IìI()NUI<br />
lstrruírcf at lacl excedere ael] minuere quantitatem [in_<br />
tcrrtionis Ulp.'l debeat, ut si interfuisset rei Ephesi po_<br />
tius solvere quam co loci quo conveniebatur, iatio e]us<br />
haberetur'.<br />
Questa ricostruzione concorda già pienamente con l,intona_<br />
zione cli tutto il frammento, quale risulta clai $$ 2 e 3 t),<br />
con l'ordine di idee da'cui muovono paolo (fr. z7n.,r, Oj,<br />
Gaio (g 33 c fnst., IV, 6 ; fr. r e 3, h. t.) cc1 Africano (ir. 'B<br />
h. r) nei testi sopra esaminati, c, colnc si vedrà più oltre,<br />
trova sicura confcrnra 'er str't. grcco corrscrvato rei Basilici.<br />
20' - ulpiano 'el conrcrrt' arllr 'co'cler''atio ,
(t.t<br />
BIONDO <strong>BIONDI</strong><br />
per fortuna 11or1 lnancano gli elementi sicuri ed abbonclanti che<br />
svelano la 'bellissima machinatio ' dei cornpilatori.<br />
Già una circostanza, da nessuno rilevata, sernbrami che<br />
traclisca in modo evidente le preoccupazioni c l'intervento dei<br />
cornmissari giustinianei nel fr. z $ 8.<br />
Sarebbe strano che Ulpiano, dovcnrlo courentare in quel<br />
testo la 'condemnatio ' della formrrla, fossc stato così minuzioso,<br />
anzi prolisso, riguarclo all'intt'rcssc del creditore, e<br />
avesse tol.lrhucnte diurcnticato cli tr:rttarc clclf interesse clel<br />
ciebitore ; cir) srrrcblrc stato vclrrucirlt' irrtpcr-
(,.1 ttoNl)o BIONI)t st,l,t,A t)()'l"lt{lNr\ N()MANA r)tir,t,'' AC',t'I() ARI}l'fl{All.tA' 65<br />
tcrpolazioue nel fr. z $ B in esame. Riporto qui in due colonne<br />
i cluc tcsti perchè il lettore giudichi a vista:<br />
îr. 3 D. rz, 3<br />
' Nummis depositis judicem<br />
non oportet in litem iusiurandum<br />
deferre, utiuret quisque<br />
quocl sua interfuit, curn certa<br />
sit numrnorum aestinratio [nisi<br />
forte cle eo quis juret, tpod sua<br />
interfuit nulnrnos sibi sua clic<br />
redditos esse: quicl enint., si<br />
sub poena pecuniant, debuit ?<br />
aut sub pignore, quod, quia<br />
deposita ei pecunia adnegata<br />
est, d,istracturn est ?f '.<br />
fr.zgBht.<br />
' ...quid utiur, si traiccticiam<br />
pecuniam dederit Iiphesi recepturus,<br />
ubi szró poena debebat<br />
pecuniam ael sub p,ignoribus,<br />
et d'istracta pignora sL4nt...'<br />
L'interpolazioue del fr. 3 nella parte segnata in parentesi,<br />
già avvertita dal Iìabro t), pu,) ritcnersi come sicura z) ; il<br />
giurista nella prina parte è così rcciso contro la clcferibilità<br />
del giuramento e la motivazione così assoluta, che il seguito del<br />
testo cucito con uno dei soliti 'nisi forte' 3) appare una evidente<br />
intrusione.<br />
Adunque, anche il î.r, z $ B non può non avere la stessa<br />
origine del corrispondente ft. 3 ; e data la vicinanza della<br />
sede, non è improbabile che i compilatori abbiano riportato<br />
.-7) Coniecturac, lib.-XVI c. r3 (Lugduni 166r), pag. 587; Deenoribus.pragmaticorwm,<br />
dcc. r7 err. q (I,ugduni ró58j, -pag.'z3r e seguenti.<br />
2) Ne dubita il BEntor,rNr, Il giwramento nel d,it'itto friuato ro-<br />
,nano, pagg. 237-240. Ma l'interpolazione avvertita dall'àcutissimo<br />
Fesno è troppo conforme allo -stile ed. alle tendenze tli Giustiniano<br />
per potersi respingere; sulla terrdenza del nuovo diritto ad<br />
esterrdere l'applicabililà -dcl giuramento, vedi ora Sor.tzzr, Deil,iusiurandum<br />
in litem, neTl'Archiuio giurid,ico, vol. LXV, pag. r53 e<br />
seguenti.<br />
. 3) Cfr. .-ErsEr,n, Bgitydge, nw Eyhenntniss der Digesteninterpolat_r91ten,<br />
nella Zeitschrift der-Sau. Stift., Bd.. X, pag. 3ó3 e segg.i fd.<br />
XI, pag.- z6; Bd. XIiI, pagg. r5z-í54; Sncxni, ÍIeiynanns"frandteticon,<br />
ad h. v.<br />
I<br />
h<br />
cou rlnirlche ampliazioue a proposito delf interesse <strong>dell'</strong>attore<br />
nt.ll''<strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong>' quanto sopra avevano scritto in matcria<br />
rli giurarrrento<br />
Assai siugolare infine appare la citazione di Giuliano nel<br />
uostro fr. z $ B. Il l,ene1 1) ammette che qui Giuliano sia<br />
citato non come sernplice autorità, ma conle redattore <strong>dell'</strong>eclitto<br />
perpetuo, in quanto in tal qualità avrebbe modifi.cato<br />
la fornrula primitiva c1e11' ' <strong>actio</strong> arbitraia ' ; ed invero quella<br />
frase ben determinata: 'Julianus... etiam actoris habuit ratioriem',<br />
non ammette interpretazione cliversa. Ora si può constatare<br />
che le innovazioni apportate nell'editto perpetuo sono sempre<br />
riferite dai giuristi senza ruai citare il nome di Giuliano2).<br />
Raccolgo qui qualche esempio:<br />
Fr. r $ r D. 49, 14, Callistratus lib. I cle iure fisci :<br />
'... Labeo scribit... secl contra sententiam<br />
eius edictutn pcrl)ctuurn scriptum est...'<br />
I,'r. r S r l). 13,6, IJlpianus lib. XXVIII as ed. '... unuÍr<br />
solummondonotandum,quod qui ec1 ictum conc<br />
e p i t commodati fecit mentionem, culn Paconius<br />
utencli fecit mentionenl...'<br />
Fr. r D. 4,z,Ulpianuslib. XI ad ec1.: ' Ait Praetor:<br />
Quocl netus causa gesturn erit,.. o 1i m ita edicebatur<br />
1) Das lldiclutit, pag. zt6.<br />
2) I.'unica eccezione, che io sapltia, trovasi nel fr. 3 D.Zz,8, ltarcellus<br />
lib. IX dig., in cui a proposito del nuovo eclitto ' de coniungendis<br />
curn emancipato liberis èiuS ' si d.ice : ' . . . sinrul cum eo boiorun<br />
possessionem accipere posset propter id caput edicti q u o d. a Iuliano<br />
introcluctum est, id est ex nova clausola<br />
In cpresta stessa materia pero Ulpiano nel comento ali'eclitto (lib,<br />
XLI) scive: fr. r g 13 D. D. 37, gt'. . . namque natus solet patri ex<br />
novo edicto iungi...'; 10 stesso Ulpianonessuna indicazione<br />
aggiunge iniziando il suo comento al nuovo editto nel fr. r { r D. r7,<br />
B :' Hoc edictum aecprissinmm est. . .' ; analogaruentc ltónrporiiò,<br />
lib. IV ad Sab.:fr. 5 pr. D. .18, 6. Il corrfrolto ora corr rluesti-passi,<br />
l'uso costante dei giuristi rlocrrrncutrrlo rrcl tc.sto, la fórma stessa<br />
del riportato fr.3 D.37,8, in cui tluclla citazione interrompe malamerrte<br />
e senza alcun motivo la claborata tlecisione di l\Iarcello, fanno<br />
fortemente sospettare che quella inopportuna citazione di Giuliano<br />
che ivi si legge sia dovuta a qrralche glóssa, mentre il giurista probabilnrente<br />
doveva esprimersi in maniera analoga a quella di Ulpiano<br />
ncl cltato lr. I S t3 -D. 3;, 9.<br />
5
nI()Nl)o rìIoNt)l<br />
quod vi lnetusvecausa... sed postea detracta<br />
est vis mentio..'t).<br />
Qucsto rilievo deve perlomeno persuadere il lettore a<br />
diffidare della relazione dei Digesti sulla innovazione apportata<br />
da Giuliano alla <strong>dottrina</strong> <strong>dell'</strong> ' a.ctio <strong>arbitraria</strong>' .<br />
22. - Questo quanto alla forma ; l'esame poi sostanziale<br />
del testo ci porterà ad attaccare nella sua essenza tutta la<br />
<strong>dottrina</strong> <strong>dell'</strong>interesse del creditore.<br />
Questo int.eresse viene raffigurato come il pieno inclennizzo<br />
dei danni e dci iucri in dipenclcnza rirlkL nrora dcl
(rlr ttl()NIX) ltt()Nl.)f<br />
Itr. .i.l l). 19, 5, Africanuslib. XIII quaestionum: '...resporrdit<br />
l)ccLluiiìe quidem cretlitae usuras nisi in stipulaliotrc'ur<br />
7o<br />
BIONDO <strong>BIONDI</strong><br />
redclendo moram adhibuit... usuras quoque eum praestare<br />
clebere Labeo ait, sed non quasi usuras sed<br />
quòc1 socii intersit moram eum non adhibuisse... '<br />
Nel concetto di l,abeone la equivalenza doveva essere perfetta<br />
fra le 'usurae ' e il ' quod socii intersit motam eum non<br />
adhibuisse ', giacchè tutto f interesse del creditore è valutato<br />
solamente alla stregua delle 'usurae ' 1).<br />
Quali siano invece le idee di Giustiniano in ordine agli effetti<br />
della mora mostra il fr. 3 D. r.z, 3, la cui interpolazione<br />
feci rilevare sopra ($ zr in fine) :<br />
' Nummis depositis iudicem non oportet in liteur iusiurandum<br />
deferre... [nisi forte de eo quis iuret, quod sua<br />
interfuit nummos sibi sua die redditos esse : quicl enim,<br />
si sub poena pecuniam debuit ? aut sub pignore, quod,<br />
quia deposita ei pecunia adnegata est, distractum est ?]'<br />
Come risolvere ora la patente antinomia fra questi testi,<br />
cioè tra ilfr. z $ B ecl il fr. 3 D. T2,3 da un parte, ec1 i fr. zo<br />
(rg) D. rB, 6'e zr, 3D. 19, r dall'altra, su cui c1a tempo si è<br />
rivolta la pazienza e I'ingegno degli ihterpreti 2) ? Come spiegare<br />
che Paolo nel fr. zr $ 3 nega recisarnente quelf iudennizzo<br />
dei lucri che poi il suo contemporaneo Ulpiauo arnmette<br />
sic et simpliciter nel fr. z $ B ?<br />
Il principio generale del diritto classico secondo cui la<br />
mora per le obbligazioni di cose fungibili aveva per effetto<br />
nei ' iu
7z<br />
I'IOND() I]IONI)I<br />
ria ' solo lir ' stipulatio ' pel capitale ' circa cuius exsecutionenr<br />
aestirnatiorris ratio arbitrio iudicis committitur'.<br />
Il
74 BIONDO <strong>BIONDI</strong><br />
È stato dimostrato mirabilmente dal Riccobono che i<br />
coevi cli Giustiniano, adattando per le loro raccolte di diritto,<br />
antichi sunti fatti in oriente nel periodo pregiustinianeo dai<br />
maestri greci sui iesti genuini dei giuristi, per ridurre gli efementi<br />
classici in armonia coi nuovi detta.mi di Giustiniano ripetevano<br />
sui testi greci quanto i commissari giustinianei avevano<br />
operato per la compilazione ufficiale. I sunti greci cosl<br />
rimaneggiati presentano ad.unque clue strati : uno derivante<br />
direttamente dal diritto classico, l,altro rtffazzonato in conformita<br />
ale modificazioni apportate cla ,lriboniano nei testi<br />
genuini r).<br />
Questi due strati appunto, il classico ecl il giustinianeo,<br />
sono ben distinti nella summa clell,Anonirno sul fr. z $ B<br />
(Bas. XXIV, Q, 2, B; Heim.IV,45). Riporto qui in clue colonne<br />
il testo greco e quello latino clelle pandette :<br />
'Eùv òr,agépet có èvayogr,évco<br />
xdrdBu)'eív évOa ouvéòole xai<br />
pf évOa èvd..yerut pleroùrar, rò<br />
èzrepot{Oev rócov.2)<br />
iKai fuèp còvvóp.rpov .cóxov,<br />
où ycùp Vóvr1q (r)pla
76<br />
BIONDO <strong>BIONDI</strong><br />
niam obligat, si solutioni satis non fecerit, arbitraúa<br />
. <strong>actio</strong>ne et in alio loco potest conveniri: in qua venit<br />
aestimatio, qru.od al,terufu,íus L) interfuit suo loco potius<br />
quam in eo in quo petitur solvi'.<br />
La costituzione genuina, riferentesi certo alla ' plus petitio<br />
loco' 2) a mio parere sicuramente doveva dire : 'in qua venit<br />
aestimatio qrod sua interfuit...<br />
25. - In tre testi delle Pandette, cioè nei fr, . z S Z ,4 pr. , ro, h.<br />
t.,si accenna indirettamente all'interesse del creditore secondo<br />
l' '<strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong> ', odinvario modo si presuppone come vigente<br />
3). Ma dopo aver cercato di climostrare come la clottrina<br />
delf interesse del creditore è tutta creazione di Giustiniano,<br />
si presenta ora sommamente probabile f ipotesi che i compilatori<br />
con opportuni ritocchi abbiano adattato quei testi<br />
alla materia delf interesse del creditore. L'esame da istituire<br />
adunque su questi frammenti, la cui interpetrazione ha presentato<br />
agli scrittori serie difficoltà, consisterà nel cercare cli<br />
mettere in chiaro questo lavorio di adattamento e di ricostruire,<br />
almeno approssimativamente, il contenuto genuino<br />
dei testi medesimi.<br />
26. - t'esempio più cospicuo di simili adattamenti, a mio<br />
awiso, è fornito dal fr. ro h. t. :<br />
Paulus, lib. IV quaestionum : 'Si post motam factam,<br />
1) La ,sola volta che incontriamo 'altetutrius ' è in" questa costitnzione,<br />
da cui il LENDL, Das Ediclunt, pag. 236, l'assime per la<br />
ricostruzione della 'condemnatio '. Altrè volte nei testi si -trova<br />
'utriusque' (Ír. z pr. h. t.), 'eiu5 1'e1 actoris' (fr. 8 h. t.). Se la formula<br />
diceva, comc perrsa il I.nur.)L, ' alterutrius', come si spiega<br />
tale diversità di espiessiorri ? ' Alterutrius ', poi, è sostanz.ialmente<br />
d.iverso cla 'utriusque' ; sul valorc di quest'irltirno vedi ora Wr.essar,<br />
Vi,nd,ihation und, Vind,ihationslegat, nella Zeitschrift d,er Saa. Stift.,<br />
rom. Abt., Bd. XXXI, pag. 3o2 e seg.<br />
,) Notisilafrase: '... <strong>arbitraria</strong> <strong>actio</strong>ne etinalioloco potest<br />
coú'tteniri...'<br />
' 3) Credo superffno far notare che Papiniano nel fr. 43 D s, r colle<br />
parole: . . .' quocumque loco agere possè i n i d. q u o d. in t e re s t<br />
constat ' non allu.d.e afiatto all'interesse d.el crecLitore; I'azione, infatti,<br />
che ivi si ptesuppone non è 1' ' <strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong> ', ma la comune<br />
' l,ctio ex stipulatu 'è quind,i quell' ' id quod interest ' si riferisce<br />
setrtpliccmctrtc ai
76 I}IONDO <strong>BIONDI</strong> sULLA DorrRrNA RoMANA DÉr,L' 'acrro ansrTnAnre' 79<br />
scnte'tia iudicis accedere potest 'e tutta la questione giuridica<br />
cher su cli essa si poggia, sarebbe un non senso, dato che l,azi''e<br />
che si voleva pfoporre fosse stata l' '<strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong> ,.<br />
L' 'inscriptio del frammento, a mio avviso, ci indica la via<br />
per risolvere questa difficoltà : 1a ' quaestio ' cli paolo fuestratta<br />
dal lib. rv che nell'opera genuina costituiva la secle materiae<br />
dei 'iudicia bonae fidei ' r), mentre il giurista clorreva<br />
trattare <strong>dell'</strong>'<strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong> ' 'el lib. rrr a proposito cleli'editto'<br />
de rebus creditis'2). Dopo questo rilievo, si presenta<br />
come sonulranrentc probabile f ipotesi che il testo genuiilo<br />
no' si riferisse, conrc ora fn credere la lcggc clelle pa,dette,<br />
all' ' <strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong> ', r'a invece acl u' 'iuclici'm bonae fidei '<br />
in cui appunto era possibile che al capitale acceclessero . usu_<br />
rae<br />
" vari inclizi confermano questa ipotesi. r termini , accedere<br />
pecunia' t), 'poena' n), , esse in obligationem , solro<br />
tecnici per le ' usurae '. Come c1,altra parte i rimaneggiame'ti<br />
che il testo subì per essere adattato arla materia <strong>dell'</strong> . <strong>actio</strong><br />
<strong>arbitraria</strong>' si tradiscono facilmente.<br />
Il frammento, così come si trova nelle pandette, appare<br />
staccatoclalla sua originaria connessione: quella .rrror" qoo<br />
rninus Capuae solveretur ' presuppone, specie in una ..1u""stio<br />
', elementi di fatto di cui non si ha traccia nel testo crei<br />
Digesti ; io reputo assai probabile che i dati di fatto premessi<br />
da Paolo siano stati eliminati dai compilatori, i quali cre_<br />
clettero cli rabberciare alla meglio il testo, trasportanclo c1i peso<br />
la frase 'quominus Capuae solvatur , clal vicinissino fr. E.<br />
.. t-). si te'ga prese*tc chc r)aolo ribri 'quaestiorrurn,<br />
l'ordine.<br />
sesue<br />
rtetlèditto : cfr. l,Ex-*r,, t,r t 'ci lì,irilrii,.,'ói. i, ;;i. "iisr' iÌi<br />
aat ifi*i,-' "È,,'<br />
t ii gi i rì ;, rài] ì,'?;Ì:<br />
^'z) Ciò è. stato bene rr89 n. r, il qualc<br />
.rilevato<br />
credé- necessario di-.il"ttaur""t; ì"J"iióìió" JÉi<br />
te,sto per cottócarlo ".t. tuogo -ópp;rt,il-a;iì;-b;udift:;5:'i,, i;:<br />
scriptio' a mio avvi'so è esatta èiiceve conferma dalle osser'azioni<br />
fatte nel testo.<br />
3) Dello stesso paolo.vedi acl esempio : îr. 4o D. rz, t,lib. III<br />
r;rrir,t,st. ; lr. tz D. ?.s. ll! 14 acl ed. ;'vedi anòhe fr.-óà"ú.- ir,^ì,<br />
,1.'ornlxrnirrs, lib. IIi éx ptauiio; -fr.ii bB)'i<br />
rir, .i. ji"ììj :';. ";l:' 4, 32, Diocletial,us et il"j#;,ffJ.phoniirus,<br />
d) Vt.rti fr.. so. q D,:i,-r, .pautus, iiu.-iv i;;p.li;'r4, 14 D.<br />
;r', ,, I tlf i:urrrs,'iili. V na"iiómriris.-""i<br />
I<br />
.L<br />
I<br />
i<br />
I<br />
L'incisò ' cum <strong>arbitraria</strong> vellet agere ', che costituisce ola<br />
la pietra angolare del testo delle Panclette, è sicuramente insiticio<br />
: il 'vellet' è senza soggetto.<br />
Anche l'altro inciso 'vel si Capuae petatur ' è una sciatta<br />
intrusione dei compilatori : esso, inîatti, stona con tutto l'ordine<br />
di idee del giurista e col seguito del testo in cui non si<br />
contempla affatto questa ipotesi.<br />
Quella inelegante proposizione, poi, 'arbitrium iudicis cesset'<br />
difficilmente può essere stata scritta da Paolo per clire<br />
che-non possa domandarsi quella solxrna che poteva accedere<br />
'ex arbitrio iudicis ' ; evidentemente questa proposizione<br />
era indispeusabile ai compilatori per adattare il testo genuino<br />
ali' '<strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong> ' ed al relativo interesse del creditore.<br />
In conclusioue, credo che il testo c,li Paolo vacla ricostruito<br />
presso a poco r.rcl mo
8o BIONDO <strong>BIONDI</strong><br />
che, dato il carattere'bonae fidei'del giudizio, si sarebbero<br />
potute aggiudicare al. creditore se l'azione si fosse proposta.<br />
Ire parole di Paolo : 'videamus, ne ea pecunia, quae ex<br />
sententia iudicis accedere potest, non debeatur nec sit in obligatione',<br />
alludono sia al debitore che al ficleiussore ; ma le<br />
due ipotesi nel concetto del giurista sono per cosl dire concentriche.<br />
I-re ' usurae ' le quali potevano essere aggiudicate se l'azione<br />
si fosse proposta, pagato il capitale, non sono dovute dal debitore<br />
1). Esse infatti nòu sono 'in obbligatiorre', non costituiscono<br />
un obbligo per sè stante e cou azione separata, rna derivano<br />
solo 'ex officio iuclicis' ; ed essenclo quincli matcrialmente<br />
e formalmente dipendenti dall'obbligo principale, estinto<br />
questo per la 'solutio', nessun diritto si ha più di domandarele<br />
' usurae ' 2). Paolo però previene un'obbiezione (' nisi si quis dicat<br />
') : dato che il creditore, se si fosse proposta l'azione, avrebbe<br />
potuto conseguire rzo (cioè roo pel capitale e zoperinteressi),<br />
il pagamento di roo potrebbe considerarsi come fatto per una<br />
quota di capitale più gl'interessi corrispondenti, in modo che<br />
resterebbe ancora la 'petitio' <strong>dell'</strong>altra parte di capitale con<br />
gf interessi relativi. Questo ragionamento in quanto tende ad<br />
ammettere la sussistenza <strong>dell'</strong>azione per una quota del capitale,<br />
viene a rimuovere quella difficottà per la prestazione<br />
delle 'usurae ' derivante clalla estinzione <strong>dell'</strong>obbligo principale<br />
; ma Paolo 1o combatte ('quod non puto admittendurn ')<br />
scrrKE, loc. cit., vorrebbe introdurre nelle Panclette: ii é6 pr,óvov ró<br />
xegd.).r,ov 'o èvocyópr,evo( xa,ta8t,xao0fr [vel si in sortem tantum<br />
reus cond.emnatus sit]; a parte la banalità del coutenuto, esso costituisce<br />
una stonatura nel tèsto in cui si suppone sempre che L'azione<br />
non si fosse proposta.<br />
r) Su questa questione vedi il îr.49, r D. 19, r, Hermogenianus,<br />
lib. II iuris epit. La frase di Paolo nel testo che abbiamo in esame:<br />
'vid.eamus nè . . . ' contiene in sè la clecisione; con questa forma e<br />
dello stesso giurista vedi acl esempio: fr. 98, 6 D. a6,.3; frag. Vat.<br />
S 5r, lib. f-manualiqm. Che la décisione doveva essere negàtiva è<br />
provato poi dai Basilici.<br />
- -,') So Questo principio ved.i quanto scrive egregiamente ii Faooe,<br />
nella Riuisla italianaper le scienze giuridiche, vol. III, pag. 16 e segg.;<br />
cfr. pure Pn*ozzr, nella traduz. d.el Gr.uncx, lib. XXII , nota o,<br />
pag. 38o e seg.; BoNrLNIa, Istituzioni, IY ed., pag. 384.<br />
(<br />
SULLA DOTTRTNA ROMANA DEI,L, . ACTIO ARBITRARIA I 8r<br />
adducendo la presunzione di rinunzia da parte del creditore<br />
che ha accettato il pagamento di roo, qioè del capitale.<br />
Ora tutto. ciò costituisce la base per escludere alttesl che<br />
quelle ' usurae ' che potevano aggiudicarsi qualora il giudizio<br />
si fosse proposto, siano dovute dal fi.deiussore : di nessun rilievo<br />
è il fatto che il fideiussore è intervenuto ' eius <strong>actio</strong>nis nomine ',<br />
la qual cosa farebbe supporre una obbligazione incerta del<br />
f.d.eiussore, comprendente cioè tutto quello che poteva aggiudicarsi<br />
in quel giudizio se I'azione si fosse proposta; Paolo,<br />
escludendo la responsabilità anche del fideiussore per le 'usurae<br />
', opera evidentemente con un altro principio fondamentale<br />
di diritto : cioè, che il fid.eiussore non può essere tenuto in<br />
'duriorem causam', vale a dire in più di quanto il debitore<br />
sia tenuto r). Come si vede, adunque, le ipotesi clel debitore e<br />
del fideiussore sono interdipendenti, giacchè la decisione della<br />
priura costituiscc la. base della seconda.<br />
Questa a me pare che sia stata la vera portata della questione<br />
esposta d.a Paolo, e l'ordine di idee da cui muoveva il<br />
giureconsulto nella sua decisione.<br />
I1 testo delle Pandette, come si è visto, fu adattato dai compilatori<br />
alla materia <strong>dell'</strong> ' <strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong>' ; e pertanto,<br />
per d.iritto giustinianeo bisogna riferire tutto quanto abbiamo<br />
esposto alf interesse del creditore secondo 1' '<strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong>'.<br />
zZ. - Un altro testo ritoccato dai compilatori in relazione<br />
alf interesse del creditore, è il fr. 2 S Z h. t., estratto da Ulpiano,<br />
lib. XVII ad ed. :<br />
' Idem Iulianus tractat, an is, qui Ephesi sibi aut Titio<br />
daii stipulatus est, si alibi Titio solvatur, nihilo minus<br />
possit intend.ere sibi dari oportere. et Iulianus scribit<br />
liberationem non contigisse latque ideo />osse petó quod<br />
'interest]. Marcellus autem et alias tractat et apud lulia-<br />
1) Questo principio richiamò, già, sebbene molto vagamente, il<br />
Curecro, Opera, loc. cit.; cfr. anche IVIecNvs, Rat. et different. iuris<br />
aiail,is, in Nouus Thesaurus di MnÉnruax, tom. III, pag. zS e segg.<br />
6
8z BIONDO SIONDI<br />
nunt notat posse dici et si mihi alibi solvatur, liberationem<br />
contigisse, quamvis invitus accipere non cogaf i plane<br />
si non contingit liberatio, dicendum ait superesse petitionem<br />
integrae summae, quemadmodum si quis insulam<br />
alibi fecisset quam ubi promiserat, in nihilum liberaretur.<br />
lsed, miki udd,etur surnrnae sol,utio d,istare a labrica ínsulae<br />
et ideo quod, 'interest sol,urn petendum)' .<br />
Le due proposizioni segnate in parentesi quadre, a mio av'<br />
viSo, appartengono ai compilatori e sono tali da intorbidare<br />
tutto il testo rendendolo non poco arduo e difficile.<br />
Quell' 'atque ideo ' che si ripete in maniera stereotipata 1)<br />
non depone certo per la loro classicità ,). Ec1 inoltre un giurista<br />
che scriveva sotto l'impero del processo formulare non<br />
avrebbe certo mancato di indicare quello che praticamente più<br />
interessava il cittadino romano, cioè quale formula doveva<br />
richiedersi a1 Pretore per ottenere questo 'id quod interest'.<br />
Nè i giuristi in proposito potevano senz'altro riferirsi all" <strong>actio</strong><br />
<strong>arbitraria</strong>', come si ritiene generalmente 3), giacchè, anche<br />
volendo ammettere per classico l'interesse dell;attore, è certamente<br />
esatta I'osservazione del Beseler a), che cioè coll' '<strong>actio</strong><br />
<strong>arbitraria</strong>' potesse domandarsi la somma dovuta aamentata<br />
dalf interesse <strong>dell'</strong>attore, ma non solo questo interesse. Ma è<br />
insostenibile d'altra parte f ipotesi del Beseler che nella prima<br />
1) Come è risaputo, i compilatori non furono alieni dall'usate<br />
spesso delle particelle ' atque id,eo ', ' et ideo ', ' id.eorlue ' per condurre<br />
a conseguenze sversate le decisioni dei giuristi : cfi. Dr Menzo,.<br />
in Studi in onore di. V. Scialoja, vol. II, pag. 58 ; ; Sfcrfy, Heurnanns<br />
Handelexicon, ad. h. v.<br />
2) Ad. ammettere l'emblema non osta che la decisione è resa,<br />
con un 'mihi vicletur' ; i compilatori, infatti, non rifuggirono dall'usare<br />
nelle loro decisioni formè di opinamento perfettàù.ente clasclassiche<br />
: esempio evidente si ha neÎ 'puto' : ófr. Rrccosowo, in.<br />
Stud,i in onoye A,,i V. Scialoja, vol. I, pa!. 5g7 rr. r; ecl in generale<br />
Pertpar,oNr, nell'Arch'iaio Àituidico, vól LV, pag. so4 n. rs ; e sulle<br />
forme classiche adoperate"dai compilatori'vèdi lé èsatte" ósser.razioni<br />
clello Scra1o;ejnel Bultettino àelt'Ist. di dir. yom., vol. XI, pagtDa<br />
66 n. 7.<br />
:r). C{r. I,BNBr,, Das Edictun, pag. 234; Beitrdge, pag.69; Conw,<br />
84 tsIONDO <strong>BIONDI</strong><br />
l'aziorre pet l'intero credito, cioè <strong>dell'</strong>azione comune se il creditorc<br />
agissc nel luogo stabilito, dell, ,<strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong>, se<br />
altrove.<br />
Inaspettata, quindi, arriva la proposizione che segue:<br />
' atque ,ideo posse peti quod interest '.<br />
Questa proposizione può comprendere l,esercizio dell,azione<br />
o cumulativamente per f intera somma e per l,interesse, oppure<br />
solo per quest'ultimo. I.a prima interpretazione non può<br />
sostenersi perchè non si saprebbe giustificare questo risarcimento<br />
di danni : giacchè, se il debitore non è liberato, il creditore<br />
ha certo facoltà di domandare l'intera somma, e se mai, qualora<br />
avesse proposto l"<strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong>,, stand.o alla <strong>dottrina</strong><br />
comune su questa azione, sarebbe stato possibile questo risarcimento<br />
di danni, ma allora il giurista non avrebbe trascurato<br />
questa circostanza e non avrebbe scrittto semplicemente<br />
quell" atque,id.eo...'. Si potrebbe intendere quella proposizione<br />
conformemente all'altra della chiusa del testo, nel senso di domanda<br />
del solo risarcimento di danni; ma ciò non si accorda<br />
con quell'assoluto 'liberationem non contigisse ,: dappoichè,<br />
se il creditore non può agire per l'intera somma, è chiaro che<br />
il debitore resta liberato, sebbene sussidiariamente responsabile<br />
per 1' 'id quod interest '.<br />
In ogni senso, adunque, quella proposizione consequenziale<br />
' atque ideo .,.' appare una sversata intrusione.<br />
La prova poi che essa era completamente estranea a Giu_<br />
liano si ha nella nota di Marcello il quale, come consegu enza naturale<br />
ed indiscussa della non liberazione del debitore che<br />
ha pagato in un luogo diverso, ammette semplicemente la<br />
facoltà di domandare I'intera somma d.ovuta :<br />
' ... plane si non contingit liberatio dicendum ait<br />
superesse petitionem integrae sum_<br />
mae...'.<br />
Marcello avrebbe mai avuto tanta sicure zza se preced.entetucrrtc<br />
ncl testo da lui annotato difiorme fosse stata la decisione<br />
girrlirrru'ir ? Acl un dissenso in proposito fra i due giuristi è<br />
itrrl'ssilril. l)c'sarc, poichè Marcello, come sempre, lo avrebbe<br />
suLI.A Dorrr{IN^ RoMANA DDr,L' 'Acrlo aRnTTRARTA' 85<br />
fatto rilevaré chiaramente. Aggiungasi che in maniera del<br />
tutto conforme a Marcello, e senza alcuna ombra di dubbio<br />
decide aicora Scevola, lib. XXVII dig., nel fr. tzz pt. D.<br />
45, f: 'Qui Romae mutuam pecuniam acceperat solvendam<br />
in longinqua provincia per menses tres eamque ibi dari<br />
stipulanti spopondisset, post paucos dies Romae testato<br />
creditori dixit paratum se esse Romae eam numeîare detracta<br />
ea summa, quam creditori suo usurarum nomine<br />
dederat. quaesitum est, cum in integrum 1) summam, qua<br />
stipulatione obbligatus est,optulerit, an eo loco, in quo<br />
solvenda promissa est, sua die integra petit posset. respondit<br />
posse stipulatorem sua die ibi ubi, solvendam sti'<br />
pulatus est, petere' 2).<br />
Possibile adunque che quella singolare decisione di Giuliano<br />
del nostro fr. z $ 7 non abbia lasciato alcuna traccia nella<br />
gigrispruclenza posteriore, tanto che Marcello, annotando la<br />
medesima decisione di Giuliano, e Scevola riproducono ancora<br />
tranquillamente la <strong>dottrina</strong> comune ? 8).<br />
Dopo tutto ciò non è azzardato concludere che quella<br />
singolare decisione 'atque ideo posse peti quod interest'<br />
non proviene da Giuliano ma dai compilatori.<br />
Identica decisione i compilatori attribuirono poi ad IIIpiano<br />
nella chiusa del testo in esame:<br />
'sed mihi videtur summae solutio distare a fabrica<br />
insulae et ideo quod interest solum petendum'.<br />
Bisogna riprendere per poco la nota di Marcello a cui questo<br />
brano mostra di essere in opposizione.<br />
r) 'Nec integram'MouIrrsEN, ad h. l.<br />
z) Inesatta è a mio awiso l'esegesi di questo testo fatta clal ConN,<br />
op. 'cit., pagg. 96-99. Accettando-anche ia riferita emendazione d.ei<br />
Mourr,rsEw, uno deeli elementi, se non il più importante, per la d.ecisione<br />
d.el giurista -di sicuro era costituitd clal fàtto che I'ofierta era<br />
awenuta ln un luogo diverso da'quello stabilito: cfr. per tutti WrNpscEED,<br />
Pandette, g z8z, trad.. it., vol. II, p. I, pag. ro8 e seg. n. 3;<br />
SlvrcNv, Le d.voit des obli,gations, trad. Gèrard.in, tom. II, pag. t27<br />
nota i.<br />
r) Ved.i anche la c. 9 C. 8, $ ($).
86 BIONDO <strong>BIONDI</strong><br />
Marcello, annotando Giuliano, presentava un'altra ipotesi<br />
(' et alias tractat ') ; cioè, se il debitorè paga in un luogo di-<br />
verso al creditore (' et si mihi alibi solvatur ') col suo consenso<br />
('quamvis invitus accipere non cogar') ), il debitore è liberato<br />
in base al principio secondo cui il pagamento fatto 'alibi '<br />
ha efiicacia liberatoria qualora vi consenta il creditore 2).<br />
Al caso inverso riferivasi poi il giurista in seguito :<br />
'plane si non contingit liberatio, dicendum ait superesse<br />
petitionem integrae sunmae, quemadmod.um si<br />
quis insulam alibi fecisset quam ubi promiserat, in nihilum<br />
liberaretur'.<br />
L'ipotesi posta dal 'si non contingit liberatio ' doveva logicamente<br />
essere rappresentata dal1a maîcaÍLz& di quell'elemento<br />
per cui il giurista più avanti aveva ammesso la'liberatio',<br />
cioè il consenso del cred.itore a che la somma dovuta<br />
fosse pagata 'alibi '. In tal caso, secondo l'opinione di Marcello,<br />
il debitore non resta liberato nello stesso modo ('quemadmodum')<br />
che non sarebbe liberato se, trattandosi di<br />
promessa di fabbricare un" insula' in un dato luogo, il promittente<br />
l'avesse fabbricato 'alibi' ; l'analogia è abbastanza<br />
forte, poichè, come scrive Paolo in un caso simile, ' nemo enim<br />
dixit facto pro facto soluto liberationem contingere' 3).<br />
A questo argomento analogico si sarebbe riferita la presunta<br />
critica di Ulpiano:<br />
'sed mihi vid.etur summae solutio distare a fabrica<br />
insulae et ideo quod interest solum petend"um'.<br />
Ora io comprenderei che Ulpiano confutando l'analogia invocata<br />
da Marcello pervenga logicamente ad una decisione<br />
opposta a quella di quest'uftimo giurista che si era servito<br />
1) Atorto sembrami che il NesBn, op. cit., pag. 32r, abbia ritenuto<br />
interpolate queste due proposizioni; esse, infatti, presentano<br />
I'clcnrento di fatto la prima, la ratio decid.endi I'altra, le quali apprurto<br />
facevano d.iversíficate l'ipotesi e la decisione di l\{aicello da<br />
rlrrr:llt di Giuliano.<br />
r) Cfr. fr. rfi g r D.46, r,Iulianus, lib. LIII dig.; fr. r22pt. D.45, r,<br />
Scnt,volir, lilr. XXVIII dig.; fr. 9 D. h. t. Ulpianus, lib. XLXIII ad Sab.<br />
It) ltr. t1t3, tt D. 46,3, Paulus, lib. XV quaestionum<br />
SULLA I).,'.1.RINA ROMANÀ DELL'' ecîro ARBITRARIA'<br />
di quella analógia, cioè alla liberazione del debitore 1), ma<br />
non si comprende come mai il giurista pervenga, si noti come<br />
conseguenza diretta e necessaria, alla inopinata conclusione<br />
' et ódeo quod, interest solum petendum<br />
"<br />
Quindi non ad Ulpiano ma ai compilatori deve ascriversi<br />
questa decisione ; ed invero, avendo Giustiniano sancito il<br />
principio che il creditore possa richiedere il risarcimento dei<br />
darrrri in seguito al mancato pagamento nel luogo stabilito,<br />
nulla di strano se il legislat ore bizantino decida che ove il pagamento<br />
sia fatto'alibi' senza volontìr clel creditore, questi, anzichè<br />
l,intera somma, debba domandare so10 il suo interesse 2).<br />
28. _IJn accenno ind.iretto all'interesse del creditore si trova<br />
infine nel fr. 4 pr. D. h' t', estratto da Ulpiano, lib' XXVII<br />
aded:<br />
'Quod si Ephesi petetur, ipsa sola summa petetur,<br />
nec amplius quid', nis'i si, quid' esset st'ípul'atus uel' s'i tem'<br />
pori,s uti,litas interaen'it<br />
Questo brano, infatti, quand,o dice che nell'azione istituita<br />
nel luogo stabilito non si può d-omandare di póu della somma<br />
pattuita, lascia evidentemente supporle che, agendo in un<br />
luogo diverso coll'<strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong>' ,il creditore avrebbe diritto a<br />
domand.are qualche cosa d,i più, vale a dire il suo interesse loci.<br />
Se non che questo accenno indiretto all'interesse del creditore<br />
appartieme a Giustiniano, poichè laproposizione 'nec<br />
amplius... intervenit' deveritenersi interpolata come giìr avvertl<br />
vagamente il Naber 3).<br />
Riguardo a1la forma, è degno d'i nota l'uso inesatto ed irregolare<br />
dei modi e d'ei tempi: ' nisi si... asseú stipul'atus, vel<br />
rì Dico losicamente perchè a ciò in realtà non potev,a per-venire<br />
il siirista: ví sarebbe slato tli ostacolo il principio assoluto formuiat?<br />
in teimini generali dallo stesso Ulpiano (fr'^ t h-' t') secondo cur<br />
il oasamento fa{to ' alibi ' ha efficacia liberatoria sol quanclo vr conseàtí<br />
it cred.itore.<br />
zì In ouesto senso credo che debba interpretarsi la_ precedente<br />
aeciéione àello stesso frammento: 'atque ideo posse peti quod rnterest'<br />
.<br />
'*"il bp cit., pag. 3zr. Anche. il Brser,rn, .oP. cit', pag'98' sospetta<br />
di ciuèsio brório,"seúza però dirne le ragioni'<br />
87
fJtÌ 1IIONDO I]IONDI<br />
si... intcructr.it' , addirittura insopportabile specie in una brevissinra<br />
proposizione ; ed il verbo 'esset stipulatus ' dovrebbe<br />
averc per soggetto un ipotetico stipulatore che si trovava solo<br />
nella nreqte dei compilatori.<br />
Sostanzialmente, poi, quelbrano non può appartenere ad Ulpiano.<br />
Sarebbe stato invero troppo banale scrivere che non si<br />
può domandare di più della somma pattuita, a meno che non<br />
si sia stipulato qualcosa di più. E la proposizone' vel si temporis<br />
utilitas intervenit ' t; in bocca ad un giurista classico sarebbe<br />
una vera eresia, dappoichè, come è noto (vedisopra$zz),<br />
in uno 'iudicium strictum', a cui evidentemente si riferisce<br />
il testo in esame, non potevano essere aggiudicate 'usurae'<br />
senza un'apposita stipulazione.<br />
Il giureconsulto nel testo genuino, malamente troncato dai<br />
compilatori, colle parole 'ipsa sola summa petetur' senza dubbio<br />
intendeva solo dire che per agire nel luogo stabilito non<br />
occorreva 1''<strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong> '. fn sostanza sarebbe lo stesso<br />
concetto che esprime Gaio, cui appartiene il $ 33 c. Inst.<br />
IV, 6 : ' si quis tamen Ephesi petat, id est eo loco petat quo<br />
ut sibi detur stipulatus est, pura <strong>actio</strong>ne recte agit' 21.<br />
1)<br />
Questa innocente proposizione di îriboniano fomì la base<br />
al Curecro, Obera,tom. l, c1ol. rz8o, per sostenere che l" adiectio<br />
temooris ' così tome l' ' adiectio loci ' trasformasse l'azione d.a ' stricta'<br />
in 'àrbitraria ', ammettenclo in tal modo la possibilità di un' ' <strong>actio</strong><br />
de eo quod. certo tempore' accanto all' '<strong>actio</strong> de eo quod certo loco '.<br />
La corrgettura, credo, non ha bisogno di confutazíone; nessuna necessità,<br />
infatti, avrebbe potuto giustificare l'esercizio clell'azione prima<br />
del tem' o fissato; per la letteratura 'in proposito vedi Gr,uEcr,<br />
op. cit., pagg.<br />
- t26-t27.<br />
zi Di Îrolte a questa patente testinronianza di Gaio, non si comprende<br />
come il CouN, o1i. cit., pagg. 159-162, ammetta la possibi-<br />
Iità di esercitare l'' <strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong>' nel 'locus solutionis' ; evidentemente<br />
sarebbe stato un non senso l'esercizio d.ell' ' <strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong>'<br />
nel luogo fissato.<br />
4>.<br />
I<br />
sur,r,A r)()'l"l'r{INA R()lvIANl ur)r.r,' ' .tctro anuTRAlua' B9<br />
III.<br />
SO flfARIo : zq, Cause tleterminanti nel diritto giustinianeo l'ampliazione della<br />
struttura e clella funzione classica <strong>dell'</strong> '<strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong>'. - 3o. I,'assetto conceto<br />
dato da Giustiniano alf interesse del creditore e la ulteriore elaborazione<br />
deifistitutonelclirittoconlune.-1r.!'interpolazionedelfr.4$rD.h.t. deve<br />
nettersi in rapporto colla innovazione di Giustiniano, Esame di rltlesto teito.<br />
29. - La causa della innovazione giustinianea relativa<br />
alla stima delf interesse <strong>dell'</strong>attore, dopo quanto si è cercato<br />
di dimostrare precedentemente, appare ben chiara e precisa :<br />
fu infatti la scomparsa nel nuovo diritto della funzione classica<br />
<strong>dell'</strong> '<strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong> ' che non permise ai compilatori<br />
di accogliere integralmente questo istituto così come era stato<br />
elaborato dall'attivitèr del Pretore e della giurisprudenza.<br />
La furrzionc unica ecl essenziale <strong>dell'</strong> ' <strong>actio</strong> arbtttaria' ,<br />
come si è visto, nel diritto classico consisteva nel far evitare<br />
all'attore il pericolo della 'plus petitio loco' mediante la<br />
stima e la deduzione delf interesse del debitore dalla somma<br />
dovuta 1).<br />
Ora questi principi dovevano necessariamente esser travolti<br />
a causa del nuovo ordinamento vigente al tempo di Giustiniano<br />
in materia di 'plus petitio' : infatti, se il rimedio generale<br />
fissato dal legislatore bizantino per owiare alla 'p1us<br />
petitio' fu quello di tenere responsabile l'attore del triplo<br />
delle maggiori spese giudiziali 2), si comprende assai agevolmente<br />
come la funzione speciale <strong>dell'</strong> ' <strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong> ' ed<br />
i principi di diritto ad essa relativi dovessero venir meno.<br />
Tuttavia Giustiniano credè che quei rapporti sostanziali determinati<br />
nel diritto classico dall' '<strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong> ' potevano<br />
ancora essere uLtilizzati per un nuovo assetto da dare<br />
alf istituto. Ma è facile comprendere come quei rapporti consistenti<br />
ne1 diritto classico nella stima e cleduzione delf inte-<br />
t1 Verlisopra$6eseg.<br />
z1 Vedi sopra g re.
9o<br />
I]IONDO I}IONDI<br />
rcssc (lcl
1l.!<br />
I'IONt)O J}IONDI<br />
lnoriÌ (lcl
9.{<br />
BIONDO tsIONDI srrI,I.A ì)()'r'îl{rNn ROMÀNA DELL' ' actro AngrrnAnla' 95<br />
cotrfusitxre per la esatta ricostruzione della formula <strong>dell'</strong> ' <strong>actio</strong><br />
lrrllit,rariir ,, è il fr. + S r h' t., attribuito nelle Parrdette acl<br />
Ulpiano:<br />
' Interdum iudex, qui e1 hac <strong>actio</strong>ne cognoscit, cum sit<br />
arbitra:':ia, absolvere reum debet cautione ab eo exacta<br />
de pecunia ibi solvenda ubi pronissa est' quid enim si ibi<br />
vel oblata pecunia actori dicatur vel deposita vel ex<br />
facilisolvenda?nonnedebebitinterdumabsolvere?<br />
in summa aequitatem quoquc atrte oculos habere debet<br />
iudex, qui huic <strong>actio</strong>ni acldictus est ' t)'<br />
VocabolielocuzionipropriecliTribonianocluitrorrmancano.<br />
' Interd.um'che si ripete ben due volte, corne è risaputo' è<br />
assai spesso di origiue giustinianea z;' Queil'ablativo assoluto<br />
'cautione ab eo exacta' posto in fine del periodo'<br />
come si sa, è una particolaritàr dello stile tribonianeo 3)'<br />
Ira forma interrogativa ' quid enim si"' ' è molto sospetta a)'<br />
I1 verbo 'debebit' è senza soggetto' Le due locuzioni<br />
'iudex clui ex hac <strong>actio</strong>ne cognoscit ' e 'iudex qui huic<br />
<strong>actio</strong>ni aclclictus est', richiamano troppo da vicino quel<br />
famigerato 'competens iudex' 5), perchè si possano attribuire<br />
ad Ulpiano; si noti inoltre che nel linguaggio dei giuristi<br />
classici il . cognoscere ' da parte del giudice è riferito sempfe<br />
1l L'interpolazione rla ' vel ex facili solvenda ' in poi è stata già<br />
.ntrdttltu it"i sesnrrn, Das Edictttm cit',-.P1cg 76-.77',qa senza<br />
sufEciente d.imostrazione, specie dal punto d1 vlsta sostanzlale' e cer-<br />
;ffiilii;i"".t"i"-it" ii testó in motlo assai infelice'^ora p"tÈ,qt::19<br />
r"iittot" ritiene interamente interpolato tutto tl $ senza del resto<br />
;ìi;;;.s;;iii,<br />
atitragt zur h.ri.tik d.cs votn; Rechtsquel.lert: l'"8; -6{;<br />
i,lì"ìi".ii dei 6.ubbi sulÉ genrrinità di qualch,e_proposlzlone anche,rl<br />
DE RucclDrìo, Nole sul cosidello deposilo pubb.ltco o.gtt.rdt?xat'e lnra7'<br />
iiiio ,orr., negli Sftrdi economico-giuríd.ici-.puhltlicatt Òer cu/& detta<br />
t"ióu,i'ii'iiiiirpi,,ar,,rài"[."u"iiài'iìà-cli'casliari, i\nno l' P"8s'<br />
t"il'3ir. Sncxrr,, Heunranns Handlexicon, ad h' v'<br />
.i òi;: É;úi; 7ii nios"oyih tlev Interpolatiortnt in den-Dig-e-sta'<br />
,,,,,t' i,i' òolli,"iíil 2t iliií ift der sau. sti/t., Roma Abth " Bil' vrr,<br />
l)irl1. 2.1 ('segg.<br />
' {) ('ir. Ilt.:sEr,h;R, Beitvrjee cit., pagg. 6r-69: Loxco, Vocabolario'<br />
ìn tirtlltilitt,,, I'ol. X, atl v. 'enim ''<br />
r) ('lt. (ìt
9l;<br />
BIONDO I}IONDI<br />
Qualc rrcccssità. giustifica l'assoluzione del convenuto, se<br />
egli 1>ronrctte di pagare nel luogo stabilito ? Se il debitore<br />
avcssc avuto un interesse a prestare nel luogo fissato, egli,<br />
secondo i principi <strong>dell'</strong> '<strong>actio</strong> arbifraria ', avrebbe potuto dedurre<br />
dalla somma dovuta tale interesse, ma è assurd.o pensare<br />
che l'esistenza di tale interesse avrebbe potuto legittimare<br />
una d.ilazione nel pagamento ; tanto più che questo<br />
sistema di assoluzione dietro promessa di pagamento potrebbe<br />
continuare un numero indefinito di volte e sarebbe, come<br />
scrive argutamente il Cohn, 'eine Schraube ohne Ende'1).<br />
Già il Fabro 2) aveva attribuito ai compilatori quella parte<br />
del testo che si riferisce a1la 'cautio ' osservando : ' cluid magis<br />
contrarium est quam absolvi reum et condemnari ut caveat<br />
? ' L'osservazione, a dire il vero, 11011 convince troppo e<br />
porge i1fi.anco a1la giusta critica del Glùck 3) il quale obbietta<br />
che la prestazione del1a 'cautio' è necessaria appunto per<br />
mantenere in vita tn'azione da esercitarsi dal creditore dopo<br />
che l'azione principale coll'assoluzione del convenuto si è<br />
consumata.<br />
In tutto ciò parmi chc i termini della questione siano spostati.<br />
fl difetto della decisione in esame consiste non già. nella<br />
necessità. o meno della 'cautio' qualora i1 convenuto venga<br />
assolto, ma nella assoluta ingiustificabilità di tale assoluzione.<br />
Con ciò credo che venga meno altresì quell'argomento<br />
che il Glùck trae da molti testi delle fonti per concludere non<br />
essere insolita nel diritto romano la prestazione di una ' cautio '<br />
ove il convenuto sia assolto. In questi frammenti citati, infatti,<br />
fra cui anzi qualcuno proviene dai cornpilatori a), si afferma<br />
r) Op. cit., pag. 136<br />
2) Rationali.a ìn Paid,ectas, ad h. 7. ; Coniecturae iuris oiuilis, llb,<br />
XV c. .r, T,uےduni 166r, pag. 495.<br />
3) Op. cit., S BtZ n.16, trad. it., pag. r5-1.<br />
a) Così ad. esempio fu . 5, z D. rz, 4 e éu di èsso cfr. Gn.loEwwrtz, Die<br />
Interfolalionen, pag. 146; anche nel fr. zr D. 5, r, a cui si richiama<br />
per analogia F. IloilrnrsEN, Be,îtrrige cit., Die Lehre uon d,er Mora,<br />
pag. 4rl Anrn. B, I'inciso 'cum cornpetenti cautela' è clei.conrpilatori:<br />
cfr. ()trrrorllvwrîz, nella Zeitschift'der Sau. Sll1., Rom. Abth., Btl.<br />
Vll, lratu. (14-65. Ed in generale sulla frequenza ili Giustiniano ad<br />
inrlxrrrr '
-T<br />
(ls NIONDO I]IONDI SI]I.T,A I)O'I'1'IìINA ROMANA DI.:I,L, . ACTIO ARBI'I'RARIA' 99<br />
ttrrz.a in clucl modo tauto superficiale ed assiomatico : ' quid<br />
crrinr si ?... rronne debebit interdumabsolvere?'. Sostanzialrrrcnl.cr<br />
poi questa decisione si appalesa del tutto difiorme dai<br />
priucipi vigenti nel diritto classico.<br />
Se I'offerta ed il deposito di cui tatta il nostro testo fossero<br />
stati compiuti prima della 'litis contestatio', non si<br />
comprende come mai il giurista possa richiamarsi vivamente<br />
all'equità del giudice, quando invece vigeva assoluto il principio<br />
che I'offerta validamente fatta produceva la liberazione<br />
del debitore o 'ipso iure ' 1) od 'ope exceptionis ' 2).<br />
Si dovrebbe ritenere, e l'intonazione del testo 1o fasupporre,<br />
che I'ofierta ed il deposito fossero stati fatti dopo la 'litis<br />
contestatio '. Ma allora questa decisione urta eviclentemente<br />
col principio assoluto del diritto classico, secondo cui l'ofierta<br />
ed il deposito in tanto avevano efficacia liberatoria in quanto<br />
1a prestazione fosse stata offerta o depositata prima che la<br />
'litis contestatio' avesse estinto il contenuto della originaria<br />
obbligazione 3). Questo principio ci viene attestato in termini<br />
recisi da Paolo in clue notissitrri framnrenti :<br />
fr. 84 D. 54, r (lib. I,XXIV ad ed.) : 'Si insulam fi.eri<br />
stipulatus sim et transierit tempus, cluo potueris facere,<br />
quamdiu litem contestatus non sim, posse te facientem<br />
lib. X quaest.; f imperatore Caracalla in un caso simile ammetteva<br />
l'intervento del Preside: c. ó. C. -1, 32.<br />
1) Fr. ro5 D. 45, r, favolenus, lib. II cp.; îr. 7z pr. D. 4ó, 3<br />
I\'Iarcellus lib. XX dig. ; fr. 9 $ r D. 46, 3, Ulpianus, lib. XXIV ad.<br />
Sab.; fr. 3o D. eod., Ulpianus.lib. LI ad ed.; per il deposito, vedi<br />
cli recente DE RuccrEno, op. cit., pag. r45 e sgg.<br />
2) Fr. 84 S : D. So, Iulianus lib. XXI(III dig.; fr. 6D. ++,4, Gaius<br />
lib. XXX ad ecl. prov. ; k. 73, $ z, D. 45, r, Paulus lib. XXIV ad ccl.<br />
3) Cfr. per tutti MADAT, D'íe Lehre uond,ey Mora,pag.492 e segg.;<br />
FEnnrNr, Obbligaziotrc,nella Encicloped,ia giwr. italiana, pag. 6zr e<br />
sgg. Non si cornprende I'opposizione del Wrxpscuerr, Pandette,<br />
g z8r n. z, e degli Scrittori ivi citati, alla <strong>dottrina</strong> che scaturisce limniclameute<br />
dai testi rioortati e che risoonde in maniera oerfetta al<br />
i'trattere della ' litis còntestatio ' nel diritto classico. Nè può rrrenorrr:urrcnte<br />
invocarsi ouella <strong>dottrina</strong> Sabiniana che ' omnia iirdicia esse<br />
rrbsolrrtotia', giacchè questa, se fu accolta da Giustiniano (g z Inst,<br />
lV, r.:), cortre risulta dai testi riportati, non ebbe certo la prcvalenza<br />
rrcl 1x,ri
I (X) IìfONDO T]IONDI<br />
offrerxlo o rlcpositando la somma anche dopo la 'litis conte'<br />
stutio ' sarc'bbe mancata di qualsiasi giustificazione.<br />
Lrvece, se si tien presente che fu appunto Giustiniano a<br />
sancire il principio che il debitore debba indennizzare l'avversario<br />
dei danni e dei lucri clipendenti clal rnancato pagarnento<br />
nel luogo stabilito, non sembrerà strano che i compilatori<br />
deciclano che la responsabilità clel clebitore venga meno<br />
ove egli presti una ' cautio ' c1i pagare nel luogo stabilito, o dichiari<br />
in ogni caso che la somma ir.i trovasi offerta o depositata.<br />
A Giustiniano dovctte seurbrarc irrirluo che in certi<br />
casi il debitore dovessc subire tllla grave c
oz BIONDO <strong>BIONDI</strong><br />
zione come provenienti tutti clal periodo classico. Oltre a ciò,<br />
l'appellativo di ' <strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong> ' ha traviato gran parte degli<br />
scrittori portancloli a conclusioni spesso assurde e per giunta<br />
cozzanti colle più chiare ed esplicite attestazioni delle fonti :<br />
infatti, gli scrittori si sono sforzati cli ricostruire la formula<br />
clell' '<strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong> ' sul tipo clelle ' <strong>actio</strong>nes <strong>arbitraria</strong>e '<br />
e di dare all' 'arbitrium iudicis ' nell' '<strong>actio</strong> de eo q. c. l. '<br />
un contenuto ed un significato identico a quello delle 'acticlnes<br />
<strong>arbitraria</strong>e '.<br />
Ora io creclo fermamente che questo metoclo aprioristico<br />
nel ricostruire la 'condeurnatio'
)1,ì"L"'<br />
l()4 BIONDO <strong>BIONDI</strong><br />
speciale <strong>dell'</strong> ' <strong>actio</strong> de eo q. c. 1. ', delineando la natura e la<br />
funzione <strong>dell'</strong> 'arbitrium iudicis ' in questi termini :<br />
' ... hic autem qpa pecuniae creditae est, ci rca cuius<br />
exseòutionem aesti mationis ratio arbitrio<br />
iudicis committitur...'<br />
Identica concezione troviamo infinc anche in Ulpiano nel<br />
fr. z $ 8 in cui ilgiurista, trattando ampiamente dell" officium<br />
iudicis'nell"<strong>actio</strong> de eo q. c. l.', attesta comelaformuladia<br />
potere al giudice di diminuire l'ammontare della somma dovuta<br />
in modo che ' si interfuisset rei Ephesi potius solvere quam<br />
eo loci quo converliebatur ratio eius haberetur' 1).<br />
Il concetto che l' ' arbitriunr iudicis ' denoti una ampliazione<br />
dei poteri del giudice in ordine alla stima ecl alla deduzione<br />
<strong>dell'</strong>interesse del debitore, come si vede, è nettamente scolpito<br />
nei testi riportati e trova inoltre una splendida riconferma sol<br />
che si tenga presente la sfera di applicazione <strong>dell'</strong>'<strong>actio</strong> de<br />
eo q. c. 1.'. Questa, infatti, applicavasi per quei crediti generanti<br />
uno 'iudicium strictum ' ,), itr cui la limitazione rigorosa<br />
dei poteri del giudice non avrebbe permesso affatto la<br />
stima e la decluzioue <strong>dell'</strong>interesse del debitore. Invece era<br />
del tutto superfluo applicare l" <strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong> ' a quei crediti<br />
generanti un giudizio in cui il giudice avesse i poteri<br />
sufrcienti per stimare e dedurre tale interesse.<br />
Così per le azioni 'in factum', la 'condemnatio' 'quanti<br />
ea res erit' bastava per escludere l'applicazione <strong>dell'</strong>'<strong>actio</strong><br />
<strong>arbitraria</strong> ' a) ; nel fr. 5 pr. D. 13, 6, che si riferiva certo al<br />
1) Per la ricostruzione di questo testo vedi sopra $ r9.<br />
z; 'Stipulatio : ît. =, r D. h. t., Ulpianus, Ub. XXVII ad ed.. ;<br />
fr. r'D. filt;, Gaius, lib. IX acl ed. prov. ; fr. 7, r D. h. t., Paulus,<br />
lib. XXVIII ad. ecl.; quest'ultimo testo però è corrotto dai compila-<br />
tori: cft.fBÈTnrvrexrv-Hor,r,wÉc,Vevsuche i,ibev e'inz. Thei.le der Theovie<br />
des Ciuilirozessas, pag. 43 Anm. 97, 9d. ota BÉ^sEr,ER, op. cit., pag. 67 .<br />
- MUjrio: fr. 6 D. h. t., Pomponius, lib. XXII ad Sab. - I.egaÍo<br />
per fd-arnnationem ': fr. '5 D. É. t., Paulus, lib. XXVII ad ed. -<br />
- s1 l,'tipplicabilità al ' constitutum ' è molto d.iscussa : cfr. Gr.uDcr,<br />
op. cit., póg. 136 e l'Appendice del LEoNr, pag. 90; ConN, op. ci,t.,<br />
.tsEslir,ER, op. cit., pag. ro4 e segg. Il solo testo che tratta tlella<br />
06 BIONDO <strong>BIONDI</strong><br />
Questo canpo di applicazione <strong>dell'</strong> ' <strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong>' chiarisce<br />
meglio e conferma stupendamente le prececlenti considerazioni<br />
intorno al carattere <strong>dell'</strong>' arbitrium iudicis' nell'' <strong>actio</strong><br />
cle eo q. c. l. '.<br />
34. - Una ulteriore determinazione del concetto cli 'arbitrium<br />
iudicis' è ora necessaria, nel senso di precisare nettamente<br />
i limiti e la estensione di quei poteri speciali che la<br />
formula <strong>dell'</strong> '<strong>actio</strong> de eo q. c. l. ' attribuiva al giudice.<br />
fl concetto tradizionale che ci proviene clagli antichi interpreti<br />
e che si ripete anche da recenti scrittori r), costruisce in<br />
modo latissimo l' 'arbitrium iudicis ' nell' r <strong>actio</strong> de eo q. c. l. ',<br />
raffigurando questa azione come essenzialmente regolata clall'equità<br />
ed in cui il giudice avesse i pitì ampi poteri.<br />
Questo concetto, a mio avviso, se rispecchia lo stato del<br />
diritto giustinianeo, è però ben lungi dall'esser vero per il<br />
diritto classico. Infatti, tatt'alfua è la conclusione che deve ricavarsi<br />
dai testi immuni da alterazioni tribonianee. Io credo<br />
che per diritto classico nella semplice stima e deduzione <strong>dell'</strong>interesse<br />
del debitore si esaurisse tutto l' ' officiurq iudicis '<br />
nell' '<strong>actio</strong> de eo q. c. 1. '.<br />
Nel fr. 3 h. t. e nel fr. B h. t. Gaio ed Africano, come si è<br />
visto nel paragrafo precedente, niente altro comprendono nell'<br />
' arbitrium iudicis ' se non la stima e la deduzione <strong>dell'</strong>interesse<br />
del debitore. Di peculiare importanza dal nostro<br />
punto di vista è poi il fr. z $ B h. t., in cui Ulpiano, comentando<br />
la ' condemnatio ' della formula, inizia una lunga ttattazione<br />
empto vel ...vel ...'non possono provenire dal giurista, Manon<br />
posso consentire col LOucochequi il siufista abbíanarlato <strong>dell'</strong>.ac-<br />
[io depositi in factum' e che siaio staii i conrpilatoria generaTizzare.<br />
Inlatti, nulla d.i strano che Paolo occupand.oii nel sud comento dei<br />
vari casi d.i applicazione <strong>dell'</strong> ' <strong>actio</strong> ar6itraria ' (fr. s h. t.: lesato:<br />
Ir. 7,r h. t. : stìpulaziote; tu. z7 D. rz, 6: 'indebiti solútio ') abbia negato<br />
in generale l'applicazione <strong>dell'</strong> ' <strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong>' aí giudizi di<br />
buona fed.e. A mio avviso l'interyento dei comoilatori in ouel testo<br />
dovctte essere puramente formale, o come spesio, ditucidajtivo. IvIa<br />
la classicità def contenuto, in quanto s'inquadra perfettamente con<br />
I'orrlirrc cli idee che espongo nel-testo, per rire è indiscutibile.<br />
r) ( )rr^DrtNtvrî2, nella Zeilschrìft dey Sau. Stift., Bd. XXIV. Das. 2 io :<br />
Wr,.rssrx, in Paulys Real-Encyclopridic, ad r..-'<strong>actio</strong>' pag 3ò91<br />
r<br />
J<br />
tolj I]IONI)O I]IONDI<br />
chiusa clel fr. 4 $ r h. t., si può concludere che la forrnula<br />
<strong>dell'</strong> ' <strong>actio</strong> cle eo q. c. 1. ' ampliò i poteri del giudice solo lim,itatamente<br />
alla stima <strong>dell'</strong>interesse del debitore. Ma non<br />
basta ; clevesi ancora aggiungere che 1" <strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong>' per<br />
tutto il resto ebbe il carattere di uno 'iudicium strictum',<br />
e per conseguenza tutti quei principi peculiari dei' iudicia<br />
stricta ' trovavano in essa la loro integrale applicazione.<br />
Ecco un assunto che a qualcuno il quale concepisca le<br />
'<strong>actio</strong>nes <strong>arbitraria</strong>e' come qualche cosa di antitetico ai<br />
'iudicia sctricta ' r), potrà sentbrare una contraclizione in ter.<br />
nrini ocl una irrsana eresia. Ma I'crcsia, se così vuol chiamarsi,<br />
riguardo all' ' <strong>actio</strong> de eo q. c. l. ', ci vienc attestata proprio<br />
dagli stessi giuristi classici.<br />
Nel fr. B h. t., estratto da Africano lib. III quaest., si trova<br />
applicato dal giurista con tutta naturalezza quel principio<br />
caratteristico dei 'iudicia stricta ', secondo cui affinchè vengano<br />
in giudizio 'usurae ' anche moratorie, è necessaria una<br />
apposita stipulazione :<br />
' ... l1ec oportebit, quod forte per reum steterit, quo mi:<br />
nus tota centum Capuae solverentur, obligationem fideiussoris<br />
augeri : neque enim haec causa recte comparabitur<br />
obligzrtioni usurarum: ibi enim duae stipulationessunt,<br />
hic autem una pecuniae creditae est, circa cuius exsecutionem<br />
aestimationis ratio arbitrio iudicis cornmittitur... '<br />
t) Cfr. Narntt, Obseyt'atittncu,lae dc iute romano, tella Xt[neutosyne,<br />
rrova scries, vol. XXIV, pagg. 55-.58, al quale aderisce ora il Pnpózzt,<br />
Lslitttziotti, vol. II, pag. 68. Urra conrplèta parifr.cazione delle '<strong>actio</strong>nes<br />
<strong>arbitraria</strong>e'ai'iu
I l{) IIIONIX) IJIONDI<br />
lio ràlorischen Ediltls, pag. .58, il rluale non esita a<br />
..1ualificarla come 'eirre unbegreifflicher lritlium' ;-cd il Cons, Die<br />
sogenatcmte <strong>actio</strong> ecc., pag. r35 e se.q., osserva eiustamente cl-re il sistenra<br />
ploposto dal Savigny uelle sue attuazioni pratiche sarebbe<br />
stato 'eine Schraube ohne Enùe' .<br />
_ 1) VoIGî, Das jus maturale ae(lxturi.L et bonum u,nd, jws genti.mz,<br />
Bd. III, pag. 9r9: WAECHI'ER, ErórtertLngen.,Helt II,pag. 60; vAN<br />
WETTER, Le s obligations ed dyoit yotmain, tom. I, pag. 34; PuNrscHART,<br />
recensione al CosN, rrella Griinhuts Zeìtschl7ft, Bc1. VII,<br />
pag. 6zo; LEoNgenp, Instíl.utionen des ronz. Rechts, pag. 48o.<br />
5) Ròm. Rechtsgesclrichte, Bd. II, pag. r3ó9.<br />
6) Anche su questa opinione vedi I,Éxr,)L, op. cit., pag. 59 e seg. ;<br />
I)as Edicltntt, pag. 238 ; ConN, op. cit., pag. {^-.19 cì segg.<br />
7) ZTNIMTIRN, Gesclt'ichÍe des ròm. I'rit'atrtchl;, Ikl. lIl, l)Ír.i
tl2 I}IoNI)O ÙIONI)I<br />
Si consirlcri, difatti, che se nella formula dell" <strong>actio</strong> de eo<br />
11. c. l. ' fossc contenuta una clausola del tipo 'neque arbitrio<br />
tuo... ', c se c1a ciò derivasse l'appellativo tecnico di 'arbitrtria<br />
', necessariamente noi dovremmo trovare riferito nei<br />
testi della materia l' 'arbitrium iudicis ' e I'appellativo di<br />
' <strong>arbitraria</strong> ' allo 'iussus ' del giuclicc, appunto come si riscontra<br />
sempre per 1' '<strong>actio</strong>nes <strong>arbitraria</strong>e ' 1).<br />
Ora è faciie constatare che 'arbitriunr iudicis' nei testi<br />
relativi all' ' <strong>actio</strong> cle co q. c. l. ' si riferisce, come ho rilevato<br />
sopra ($ z3 e seg.), ad ulra ampliaziorrc dei poteri del giudice;<br />
tale da rendere possibilc' la stinra c la
.l<br />
BIONI)O ]IIONDI<br />
I,ir
d,ell'attore, costituisce tale assurdítà che uon può afiatto attríbuirsi<br />
a nessnn legislatore o giurista del mondo. - impossibile è la redazione<br />
della-'condemhàtio' 'quanti ea îes est'i se I'<strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong>'<br />
fu introtlotta col pteci3o scopo di penrrettere la valutaa.ione<br />
<strong>dell'</strong>interesse tlel debitore] come nfai il Pretore avrebbe prooosto<br />
tale 'condemnatio " cosl ind.eterminata ed. incolore ? -'tnàstenibile<br />
è La conge*tua del D. (paeg. 66t-66s1 la buale anmetterebbs<br />
che fino al ll;ec. I'interesse àef-crediiore-ilovedse valutarsi in ma-.<br />
niera pura^mente obbiettiva, mentte che nel III sec. avrebbe compreso<br />
ogni risarcimento di danni e di lutti : infatti, ilessun siutista<br />
romano awebbe potuto mettere avanti l'eresia che danni é lucri<br />
dovessero iudennízzarsi in sezuito alla àora nell,'<strong>actio</strong> <strong>arbitraria</strong>'<br />
il cui earattere tli 'iudiciùn strictrrm ' è a,fferu.ato tra I'altro<br />
sic et simpliciter ttallo stesso D. (p. 66s). - Per non dilunsar.mi<br />
troppo, rilevo un'ultima inesattezza'i. tl l, (p.s. 66q n. r) -crede<br />
che le parole d.i Africano del fr. 8 h. t. ' quanti èius .I . inteifuerit ,<br />
alludano all'interesse del debitore princibale, e sossiurree : . voir<br />
aussi B. Biontli, Bul,l. d,i D. Rom., réro, pàe. àz+, q!í"taoiroche ce<br />
fragment des Basiliques, 24, 9, où I'iutéré-t suliieótif au frdeiusseur<br />
est pris en consid.ération'. I,'equivoco iu cui inborre il D. è rnanifesto:<br />
qudl' ' eius ' d.el.fr.8 senza dubbio si riferisce al fid.eiussore convenuto,<br />
e d.'altra parte io in quel lavoro cercai di dimostrare che il giu-<br />
_ rista ivi tloveva parlare acc^a.trto alf interesse del fid.eiussore an"che<br />
d.ell'interesse del-debitore prrncipale, e che quest'ultimo fu sostituito<br />
dai compilatori coll'iúteres6e del credito?e. oromettendo aopunto.<br />
di dimoitrate in altro lavoro come la doitrlna clell,intere$e<br />
del cred,itore appartenga a Giustiniano