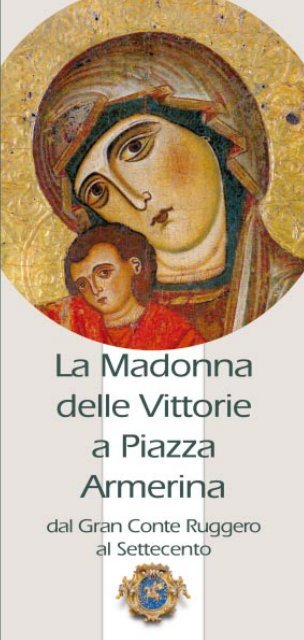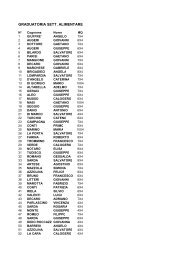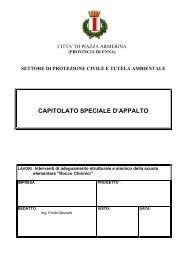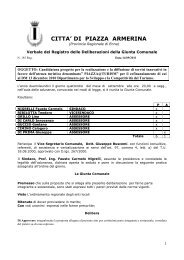Allegato 3 - Comune di Piazza Armerina
Allegato 3 - Comune di Piazza Armerina
Allegato 3 - Comune di Piazza Armerina
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
La Madonna delle Vittorie a <strong>Piazza</strong> <strong>Armerina</strong><br />
dal Gran Conte Ruggero al Settecento<br />
Direzione e coor<strong>di</strong>namento generale<br />
Beatrice Basile<br />
Coor<strong>di</strong>namento tecnico e amministrativo<br />
Angelo Giunta<br />
Progetto scientifico e cura della mostra<br />
Maria Katja Guida<br />
Progetto espositivo e <strong>di</strong>rezione dei lavori<br />
Angelo Giunta<br />
Percorso espositivo<br />
Maria Katja Guida<br />
Realizzazione dei lavori <strong>di</strong> allestimento<br />
Associazione Domus Artis, <strong>Piazza</strong> <strong>Armerina</strong><br />
Interventi <strong>di</strong> manutenzione opere d’arte<br />
Mario Arancio, Enna<br />
C.S.R. Restauro Beni Culturali <strong>di</strong> Riccardo Mancinelli, Roma<br />
Geraci Restauri s.r.l., Messina<br />
Giordano s.r.l., Palermo<br />
Enza Gulino, Gangi<br />
Gigantografie<br />
Magika s.r.l. <strong>di</strong> Alessandro Mancuso, Messina<br />
Pannelli <strong>di</strong>dattici<br />
Maria Katja Guida<br />
Coor<strong>di</strong>namento tecnico della sicurezza e dei trasporti<br />
Angelo Giunta<br />
Accoglienza opere e con<strong>di</strong>tion report<br />
Angelo Giunta<br />
Paolo Russo<br />
Trasporti<br />
Montenovi s.r.l., Roma<br />
Assicurazioni<br />
Axa Art<br />
Segreteria organizzativa<br />
Elisa Bonanno, Maurizio Bruno, Salvatore Lopinzino, Rosa Anna<br />
Marino, Cinzia Nicoletti, Paolo Russo, Salvatore Scalisi<br />
Catalogo a cura <strong>di</strong><br />
Maria Katja Guida<br />
Campagna fotografica<br />
Magika s.r.l. <strong>di</strong> Alessandro Mancuso, Messina<br />
Ufficio stampa<br />
Paola Nicita<br />
Comunicazione visiva e <strong>di</strong>ffusione<br />
E<strong>di</strong>topera <strong>di</strong> Antonio Cristal<strong>di</strong>, Enna<br />
Testo brochure<br />
Maria Katja Guida<br />
Contabilità<br />
Francesco Palillo<br />
Prestatori<br />
Agira, chiesa <strong>di</strong> S. Filippo, chiesa del SS. Salvatore; Bari, Pinacoteca<br />
Provinciale “Corrado Giaquinto”; Caltanissetta, chiesa dell’abbazia <strong>di</strong><br />
S. Spirito; Enna, Biblioteca Comunale, chiesa <strong>di</strong> Maria SS. della Visitazione;<br />
Gela, chiesa <strong>di</strong> Maria SS. Assunta; Messina, Museo Regionale;<br />
<strong>Piazza</strong> <strong>Armerina</strong>, Archivio Storico Diocesano, Cattedrale <strong>di</strong> Maria SS.<br />
delle Vittorie, chiesa <strong>di</strong> S. Andrea, chiesa <strong>di</strong> S. Pietro, Museo Diocesano;<br />
Roma, Museo <strong>di</strong> Palazzo Venezia; Troina, chiesa <strong>di</strong> Maria SS.<br />
Assunta; Velletri, Museo Diocesano; Viterbo, Museo Civico.
DA CIPRO A PIAZZA<br />
ARMERINA<br />
Secondo la tra<strong>di</strong>zione fra l’XI e il XII secolo l’imperatore<br />
Alessio I Comneno donò al monastero <strong>di</strong> Kikko a Cipro<br />
una delle tre icone della Madonna <strong>di</strong>pinte da San Luca.<br />
L’immagine della Madonna, che prende perciò il nome <strong>di</strong><br />
Kikkotissa, è raffigurata mentre regge il Bambino sgambettante<br />
che con una mano afferra il velo della Madre; essa è<br />
ora negata alla vista dei fedeli perché ricoperta da una riza<br />
metallica e da paramenti ricamati ed ex voto che si sono<br />
sovrapposti sull’icona a partire dal XVI secolo; ma è ricostruibile<br />
sulla base delle repliche pervenuteci. La replica<br />
più antica finora conosciuta è la Madonna delle Vittorie <strong>di</strong><br />
<strong>Piazza</strong> <strong>Armerina</strong>, la quale conserva l’iconografia della Kikkotissa<br />
ma assume l’epiteto delle Vittorie perché il suo arrivo<br />
in Sicilia è da collegare alle vittorie riportate dal Gran<br />
Conte Ruggero I d’Altavilla contro i Saraceni. La tra<strong>di</strong>zione,<br />
tramandata da alcune fonti seicentesche, identifica<br />
l’immagine con quella <strong>di</strong>pinta su un vessillo <strong>di</strong> seta verde<br />
che il Papa aveva donato al Gran Conte il quale lo aveva<br />
poi donato a <strong>Piazza</strong> <strong>Armerina</strong> al termine delle battaglie<br />
contro i Saraceni, vinte grazie all’intercessione della<br />
Madonna. In seguito il vessillo con la Madonna sarà nascosto<br />
per <strong>di</strong>fenderlo dalle insi<strong>di</strong>e <strong>di</strong> Guglielmo il Malo e sarà<br />
miracolosamente ritrovato nella chiesa <strong>di</strong> S. Maria <strong>di</strong> <strong>Piazza</strong><br />
Vecchia in occasione della peste del 1348.<br />
La Madonna sarà portata in città dove il 22 ottobre 1742 Le<br />
sarà consacrata la Cattedrale in cui viene conservata.<br />
Alessio I Comneno, da una miniatura<br />
conservata in Vaticano.<br />
1
LA MADONNA DELLE<br />
VITTORIE<br />
L’iconografia dell’icona riprende quella della famosa<br />
icona della Kikkotissa <strong>di</strong> Cipro, anche se alcuni<br />
particolari la <strong>di</strong>versificano dall’originale, come la<br />
presenza <strong>di</strong> larghe bretelle legate alla cintura e l’assenza<br />
del velo rosso posto <strong>di</strong> traverso sul capo della Vergine.<br />
Quanto ai dati formali, il pittore sembra ispirarsi a una<br />
cultura <strong>di</strong> un vasto ambito me<strong>di</strong>terraneo che collegano<br />
l’icona ad altre opere esistenti sia a Cipro, che nel Sinai,<br />
che in Italia meri<strong>di</strong>onale fra la Puglia e la Campania.<br />
Secondo la tra<strong>di</strong>zione che collega l’opera al Gran Conte<br />
Ruggero, essa dovrebbe datarsi a quell’epoca, ma la critica<br />
ha più volte sostenuto una cronologia più avanzata.<br />
In questa mostra viene proposto <strong>di</strong> riferire la produzione<br />
dell’immagine all’età sveva quando sia Enrico VI che<br />
Federico II ebbero rapporti con Cipro.<br />
In particolare Federico II nel 1228 in viaggio per la VI<br />
Crociata verso Gerusalemme fa scalo a Cipro e una<br />
nuova fermata compie nel 1229 dopo la conclusione<br />
<strong>di</strong>plomatica della Crociata prima <strong>di</strong> tornare in Puglia; non<br />
meno interessanti sono altre notizie riguardanti l’Imperatore<br />
che nel 1229 confermò alcuni beni alla vicina città <strong>di</strong><br />
Aidone, sede <strong>di</strong> una chiesa dell’or<strong>di</strong>ne militare dei Templari,<br />
nel 1234 promosse la costruzione a <strong>Piazza</strong> <strong>di</strong> una Casa<br />
<strong>di</strong> Cavalieri Teutonici e nello stesso anno scelse la città<br />
come sede della Corte Nazionale per la Sicilia.<br />
2
LE REPLICHE PUGLIESI<br />
E LA MADONNA DELL’ALEMANNA A GELA<br />
1 2<br />
L’iconografia della Madonna delle Vittorie <strong>di</strong> <strong>Piazza</strong><br />
<strong>Armerina</strong> ebbe un seguito notevole in Puglia, dove<br />
il pittore Giovanni da Taranto eseguì in vari<br />
momenti tre repliche che ora si conservano a Velletri (1),<br />
a Viterbo e a Bari, tutte esposte alla mostra.<br />
La loro cultura denuncia un momento più evoluto rispetto<br />
all’icona <strong>di</strong> <strong>Piazza</strong> perché vi si notano sia connotazioni<br />
tipicamente pugliesi – come la forma allungata dell’ovale e<br />
le sopracciglia lunghe e <strong>di</strong>ritte – che connessioni con<br />
l’ambito campano per quella insistenza plastica che<br />
caratterizza varie icone campane del terzo quarto del<br />
XIII secolo.<br />
Anche in Sicilia alla fine dello stesso secolo o agli inizi<br />
del successivo si annovera una replica, quale può considerarsi<br />
l’interessante icona della Madonna dell’Alemanna a<br />
Gela (2); mentre a livello iconografico è anch’essa una chiara<br />
gemmazione dalla Kikkotissa <strong>di</strong> <strong>Piazza</strong>, a livello stilistico<br />
denuncia nuovi collegamenti in <strong>di</strong>rezione della Madonna<br />
del Terremoto a Potenza e <strong>di</strong> alcuni passi della Madonna <strong>di</strong><br />
S. Guglielmo a Montevergine.<br />
A questo complesso <strong>di</strong> dati iconografici e stilistici è però<br />
da aggiungere che il manto della Madonna e del Bambino<br />
e soprattutto le decorazioni dorate sovrapposte sembrano<br />
denunciare un rifacimento più tardo in ambiente neobizantino.<br />
3
PREMESSE CULTURALI.<br />
IL PRIMO STRATO DEGLI AFFRESCHI<br />
DELLA CHIESA DEL GRAN PRIORATO<br />
DI SANT’ANDREA<br />
Fin dal XII secolo la circolazione <strong>di</strong> cultura me<strong>di</strong>terranea<br />
legata alle Crociate dovette mettere ra<strong>di</strong>ci ed<br />
evolversi nella Sicilia centrale anche nel settore<br />
degli affreschi: dai brani pertinenti a quella che è stata<br />
ritenuta la più antica delle fasi in<strong>di</strong>viduabili nella chiesa<br />
del Gran Priorato <strong>di</strong> Sant’Andrea a <strong>Piazza</strong> <strong>Armerina</strong>, a<br />
quelli della Grotta dei Santi a Enna, ai pochi lacerti leggibili<br />
conservati nell’oratorio rupestre <strong>di</strong> Assoro.<br />
Gli affreschi della fase più antica della decorazione della<br />
chiesa del Gran Priorato <strong>di</strong> Sant’Andrea – Santa Barbara<br />
con arcangelo (fig. in alto), una Santa non ben identificabile<br />
con un angelo, un S. Martino e il povero, a cui è da aggiungere<br />
un Santo bene<strong>di</strong>cente non presente in mostra per le<br />
notevoli <strong>di</strong>mensioni – costituiscono infatti un documento<br />
importante <strong>di</strong> questa circolazione <strong>di</strong> cultura “franca”<br />
perché ricordano sia alcuni affreschi della chiesa della<br />
Panaghia a Moutoullas (Cipro), che alcune icone del<br />
Sinai, che i cicli pugliesi <strong>di</strong> Gravina, Mottola, Laterza,<br />
Monte D’Elio, che gli affreschi della chiesa <strong>di</strong> S. Nicola a<br />
Castiglione <strong>di</strong> Sicilia e quelli del castello <strong>di</strong> Paternò, tutti<br />
variamente datati tra la fine del XII e il XIII secolo.<br />
4
FRA ORIENTE<br />
E OCCIDENTE<br />
Anche gli affreschi<br />
della Grotta dei<br />
Santi a Enna si<br />
legano sia all’ambito<br />
me<strong>di</strong>orientale che a quello<br />
pugliese, al punto che<br />
certe fisionomie sono<br />
intercambiabili; in particolare<br />
la Santa coronata<br />
denuncia <strong>di</strong> essere stata<br />
<strong>di</strong>pinta in un’area che si<br />
collega ai prodotti ciprioti,<br />
sinaitici e pugliesi con un<br />
aggiornamento sulla cultura dell’Occidente in particolare<br />
nella corona gigliata. Legami sia con la koinè siciliana dell’avanzato<br />
XII secolo che con una cultura occidentale più<br />
progre<strong>di</strong>ta denunciano invece alcuni frammenti <strong>di</strong> affreschi<br />
venuti alla luce alcuni decenni fa nella chiesa <strong>di</strong> S. Maria <strong>di</strong><br />
<strong>Piazza</strong> Vecchia in seguito all’abbattimento sulla parete<br />
destra <strong>di</strong> un muro perpen<strong>di</strong>colare ad essa; essi si presentano<br />
perciò con una forma rettangolare alta e stretta. Si tratta<br />
<strong>di</strong> tre piccole storie sovrapposte, frammentarie e poco leggibili.<br />
A iniziare dal basso è visibile un panneggio che per la<br />
decorazione a rotae attesta legami con l’ambito siciliano, ma<br />
in una versione così libera e mossa da richiamare connotazioni<br />
gotiche. Leggibile è anche la scena superiore, che per la<br />
presenza dell’arca e <strong>di</strong> alcuni operai sembra raffigurare<br />
appunto la costruzione dell’Arca <strong>di</strong> Noè (fig. in alto), in cui<br />
si colgono legami con antecedenti monrealesi ed anche con<br />
opere più evolute, in particolare con alcune immagini del<br />
Liber ad honorem Augusti <strong>di</strong> Pietro da Eboli. Tale cultura nella<br />
Sicilia centrale avrà una prosecuzione nella sconosciuta<br />
tavola con la Madonna col Bambino in trono <strong>di</strong> Troina, la<br />
quale partendo dai fatti monrealesi si evolve in <strong>di</strong>rezione<br />
delle esperienze messinesi rappresentate dal gruppo <strong>di</strong><br />
Madonne in trono <strong>di</strong> Messina e soprattutto della tavola con<br />
l’O<strong>di</strong>gitria in pie<strong>di</strong> <strong>di</strong> Lentini, a cui l’opera rimanda per vari<br />
particolari stilistici come la forma del capo e delle mani e le<br />
sottili ageminature d’oro sulla veste. Allo stesso ambito<br />
messinese sono stati collegati dalla storiografia anche alcuni<br />
oggetti preziosi come il reliquiario <strong>di</strong> <strong>Piazza</strong> <strong>Armerina</strong> e<br />
il pastorale e la mitra <strong>di</strong> Agira, forse provenienti da una<br />
delle se<strong>di</strong> degli or<strong>di</strong>ni gerosolimitani della città.<br />
5
LA REPLICA<br />
DI LUCA DI GALIZIA<br />
E L’INCIDENZA DELLE RIFORME<br />
Fra gli avvenimenti collegati<br />
all’icona delle Vittorie<br />
dalla tra<strong>di</strong>zione ha particolare<br />
rilievo quello tramandato<br />
dalle fonti secondo le quali all’epoca<br />
<strong>di</strong> Guglielmo I l’immagine<br />
fu nascosta. Al momento del<br />
“nascon<strong>di</strong>mento”, ne furono realizzate<br />
due repliche secondo una<br />
operazione tipica nella “vita”<br />
delle icone: una nella chiesa francescana<br />
<strong>di</strong> S. Pietro e una presso<br />
la chiesa <strong>di</strong> S. Maria <strong>di</strong> <strong>Piazza</strong><br />
Vecchia. Della replica <strong>di</strong> <strong>Piazza</strong><br />
Vecchia non si ha traccia nelle immagini pervenuteci; il racconto<br />
sembra poggiarsi ad una certa base <strong>di</strong> verità per ciò<br />
che riguarda la replica ad affresco nella chiesa <strong>di</strong> S. Pietro<br />
(fig. in alto). A riferire ed esaltare i pro<strong>di</strong>gi dell’icona<br />
<strong>di</strong> San Pietro è soprattutto il padre francescano Pietro<br />
Tognoletto che nel Para<strong>di</strong>so serafico del fertilissimo Regno <strong>di</strong><br />
Sicilia del 1667 ce ne tramanda il racconto più ampio e<br />
circostanziato: sull’e<strong>di</strong>cola primitiva in cui era <strong>di</strong>pinta<br />
l’immagine, sul trasferimento nella nuova chiesa costruita<br />
dai Francescani Osservanti, sui miracoli da essa compiuti.<br />
Il <strong>di</strong>pinto è stato recentemente riferito al pittore<br />
Luca <strong>di</strong> Galizia che appone la sua firma sotto la Madonna<br />
dalla faccia grande nella chiesa <strong>di</strong> Sant’Andrea e che è<br />
forse autore anche del S. Agostino <strong>di</strong> Caltanissetta. Egli<br />
appare come una nuova personalità nell’ambito della<br />
pittura del Quattrocento in rapporto con pittori dell’ambito<br />
aragonese fra i quali l’autore – che potrebbe essere lo<br />
stesso Luca – della Madonna della Misericor<strong>di</strong>a nel palazzo<br />
vescovile <strong>di</strong> Teruel e della Coronación de la Virgen del<br />
Museo Lázaro Galdeano a Madrid. La ripresa del culto della<br />
Madonna delle Vittorie nel XV secolo viene in<strong>di</strong>cato come<br />
effetto delle varie riforme monastiche, fra le quali si sottolinea<br />
l’interesse dell’Osservanza Francescana ad assumere<br />
l’immagine della Kikkotissa come proprio palla<strong>di</strong>o nell’ambito<br />
<strong>di</strong> una ripresa del culto delle icone me<strong>di</strong>evali basata sulla<br />
<strong>di</strong>mostrazione della loro antichità e autenticità, anticipando<br />
così un programma che sarà enfatizzato dagli scrittori e<br />
dagli artisti dell’età della Controriforma.<br />
6
LA DIFFUSIONE DEL CULTO<br />
E DELLA TRADIZIONE<br />
IL GRAN CONTE RUGGERO<br />
Le fonti seicentesche che narrano la storia del vessillo<br />
rientrano in una programmazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffusione<br />
del culto della Madonna delle Vittorie basata su un<br />
mix <strong>di</strong> tra<strong>di</strong>zioni, <strong>di</strong> miracoli e <strong>di</strong> topoi che ne comprovano<br />
l’antichità e l’autenticità secondo le finalità <strong>di</strong> riabilitazione<br />
delle icone me<strong>di</strong>evali volute dalla Controriforma<br />
Cattolica in seguito al decreto tridentino De invocatione,<br />
veneratione reliquiis Sanctorum et sacris imaginibus del 3<br />
<strong>di</strong>cembre 1563. Il topos fondamentale intorno a cui si<br />
articolano tutte le storie sulla Madonna delle Vittorie è<br />
l’impresa del Gran Conte Ruggero contro i Saraceni per<br />
liberare la Sicilia e la sua devozione verso la Vergine - che<br />
più <strong>di</strong> una volta interviene in suo soccorso nelle battaglie<br />
- tanto da raffigurarla sulle monete che egli fa battere in<br />
varie zecche fra la Sicilia e la Calabria.<br />
La figura <strong>di</strong> Ruggero e i fatti a lui collegati sono ricordati<br />
in varie opere figurative: dalla manta d’argento - <strong>di</strong> cui<br />
è esposto il <strong>di</strong>segno - dell’orafo don Camillo Barbavara<br />
autore anche del reliquiario del capello della Madonna; alla<br />
monumentale “macchinetta”, su cui sono scolpite le storie<br />
del Conte e dell’icona (fig. in alto); alla statuina d’argento<br />
col Conte Ruggero a cavallo; al Ritratto <strong>di</strong> Ruggero col<br />
vessillo proveniente dall’abbazia <strong>di</strong> S. Maria Latina ad<br />
Agira; alle altre opere presenti nella Cattedrale come le<br />
storie dell’immagine nel cosiddetto “coretto” e l’immagine<br />
del Conte col vessillo scolpita sulla cantoria.<br />
7
IL RUOLO DEGLI ORDINI<br />
RELIGIOSI E DELLA NOBILTÀ<br />
All’affermazione e <strong>di</strong>ffusione del culto della Madonna<br />
delle Vittorie contribuirono gli scrittori degli Or<strong>di</strong>ni religiosi,<br />
specie Gesuiti e Francescani quali Ottavio Gaetani,<br />
Rocco Pirro, Giovan Paolo Chiarandà e Pietro Tognoletto;<br />
fra questi, G. P. Chiarandà ci tramanda anche la<br />
descrizione della Madonna seguendo il De Vita B. Virginis<br />
del monaco Epifanio del IX secolo<br />
“… capillo flavo… supercilia inflexa… nasus est ei longior,<br />
labia florida, facies non rotunda, nec acuta, sed aliquanto longior,<br />
manus simul, et <strong>di</strong>giti longiores …”<br />
e pubblica alcune incisioni eseguite da Placido Donia raffiguranti<br />
Ruggero a cavallo col vessillo e la riproduzione<br />
della tavola con la Madonna.<br />
Sullo sfondo <strong>di</strong> questa intensa politica <strong>di</strong> ritorno alle<br />
immagini me<strong>di</strong>evali si verificano anche avvenimenti storici<br />
che fin dalla fine del XVI secolo e nei secoli successivi<br />
facilitano la <strong>di</strong>ffusione del culto e l’esaltazione delle immagini<br />
come l’intervento della nobiltà locale – in particolare<br />
per <strong>Piazza</strong> le cospicue donazioni e ren<strong>di</strong>te da parte del<br />
barone Marco Trigona – che rendono possibili sia decorazioni<br />
volte alla glorificazione delle immagini, anche per<br />
fini <strong>di</strong>dascalici, che ristrutturazioni e ampliamenti architettonici.<br />
Alla mostra è presente il modello ligneo della cupola<br />
della Cattedrale realizzato nel 1767 dall’architetto catanese<br />
Francesco Battaglia e il <strong>di</strong>segno relativo alla cupola<br />
attribuito al romano Nicola Giansimoni.<br />
8
Su espressa volontà <strong>di</strong> Marco Trigona, che nel 1598 nomina<br />
erede universale la principale chiesa <strong>di</strong> <strong>Piazza</strong> <strong>Armerina</strong>,<br />
vengono eseguite opere finalizzate all’arredo e<br />
all’arrichimento del patrimonio della chiesa per il “fastu<br />
et decoru, musica, giogalli et altri cosi necessari”.<br />
Vengono realizzate così su commissione dei fidecommissari<br />
dell’ere<strong>di</strong>tà Trigona fra il XVII e il XVIII secolo alcune<br />
opere <strong>di</strong> notevole livello come il piviale eseguito nel 1608<br />
dal ricamatore palermitano Cesare Vitali e le opere <strong>di</strong><br />
argento prima ricordate.<br />
Anche altri Or<strong>di</strong>ni esprimono la loro devozione alla<br />
Madonna delle Vittorie con donazioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>pinti nelle chiese<br />
dei loro or<strong>di</strong>ni come Sant’Andrea Avellino che intercede<br />
per <strong>Piazza</strong> <strong>Armerina</strong> presso la Madonna delle Vittorie della<br />
chiesa <strong>di</strong> San Lorenzo dei Teatini.<br />
La devozione all’icona continuerà anche nei secoli successivi<br />
insieme con la connessa produzione <strong>di</strong> immagini,<br />
oggetti e scritti vari dei quali fra i più recenti è il libretto<br />
del 1931 <strong>di</strong> F. <strong>Piazza</strong> Il Vessillo del Conte Ruggero e la<br />
Madonna dei Fascisti, nel quale l’autore incita Benito Mussolini<br />
a portare, come il Gran Conte Ruggero, il vessillo<br />
della Madonna delle Vittorie nelle sue battaglie.<br />
9
Regione Siciliana<br />
Assessorato Regionale Beni Culturali<br />
ed Ambientali e Pubblica Istruzione<br />
Dipartimento Regionale Beni Culturali<br />
ed Ambientali, dell'Educazione Permanente<br />
dell'Architettura e dell'Arte Contemporanea<br />
Soprintendenza Beni Culturali<br />
ed Ambientali - Enna<br />
Diocesi <strong>di</strong> <strong>Piazza</strong> <strong>Armerina</strong><br />
MOSTRA<br />
<strong>Piazza</strong> <strong>Armerina</strong><br />
• Museo Diocesano<br />
• Cattedrale<br />
• Chiesa Maria SS. <strong>di</strong> <strong>Piazza</strong> Vecchia<br />
dal 21 Dicembre 2009<br />
al 27 Febbraio 2010