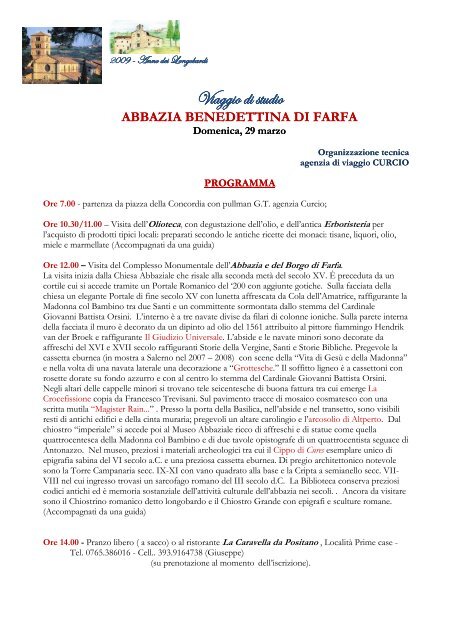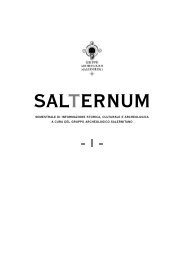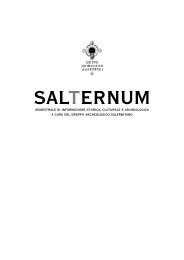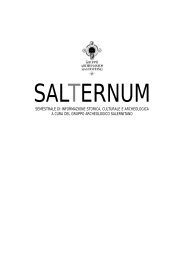abbazia benedettina di farfa - Gruppo Archeologico Salernitano
abbazia benedettina di farfa - Gruppo Archeologico Salernitano
abbazia benedettina di farfa - Gruppo Archeologico Salernitano
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ECCL CCL @ TÇÇÉ wx| _ÉÇzÉutÜw|<br />
i|tzz|É w| áàâw|É<br />
ABBAZIA BENEDETTINA DI FARFA<br />
Domenica, 29 marzo<br />
PROGRAMMA<br />
Ore 7.00 - partenza da piazza della Concor<strong>di</strong>a con pullman G.T. agenzia Curcio;<br />
Organizzazione tecnica<br />
agenzia <strong>di</strong> viaggio CURCIO<br />
Ore 10.30/11.00 – Visita dell’Olioteca, con degustazione dell’olio, e dell’antica Erboristeria per<br />
l’acquisto <strong>di</strong> prodotti tipici locali: preparati secondo le antiche ricette dei monaci: tisane, liquori, olio,<br />
miele e marmellate (Accompagnati da una guida)<br />
Ore 12.00 – Visita del Complesso Monumentale dell’Abbazia e del Borgo <strong>di</strong> Farfa.<br />
La visita inizia dalla Chiesa Abbaziale che risale alla seconda metà del secolo XV. È preceduta da un<br />
cortile cui si accede tramite un Portale Romanico del ‘200 con aggiunte gotiche. Sulla facciata della<br />
chiesa un elegante Portale <strong>di</strong> fine secolo XV con lunetta affrescata da Cola dell’Amatrice, raffigurante la<br />
Madonna col Bambino tra due Santi e un committente sormontata dallo stemma del Car<strong>di</strong>nale<br />
Giovanni Battista Orsini. L’interno è a tre navate <strong>di</strong>vise da filari <strong>di</strong> colonne ioniche. Sulla parete interna<br />
della facciata il muro è decorato da un <strong>di</strong>pinto ad olio del 1561 attribuito al pittore fiammingo Hendrik<br />
van der Broek e raffigurante Il Giu<strong>di</strong>zio Universale. L’abside e le navate minori sono decorate da<br />
affreschi del XVI e XVII secolo raffiguranti Storie della Vergine, Santi e Storie Bibliche. Pregevole la<br />
cassetta eburnea (in mostra a Salerno nel 2007 – 2008) con scene della “Vita <strong>di</strong> Gesù e della Madonna”<br />
e nella volta <strong>di</strong> una navata laterale una decorazione a “Grottesche.” Il soffitto ligneo è a cassettoni con<br />
rosette dorate su fondo azzurro e con al centro lo stemma del Car<strong>di</strong>nale Giovanni Battista Orsini.<br />
Negli altari delle cappelle minori si trovano tele seicentesche <strong>di</strong> buona fattura tra cui emerge La<br />
Crocefissione copia da Francesco Trevisani. Sul pavimento tracce <strong>di</strong> mosaico cosmatesco con una<br />
scritta mutila “Magister Rain...” . Presso la porta della Basilica, nell’abside e nel transetto, sono visibili<br />
resti <strong>di</strong> antichi e<strong>di</strong>fici e della cinta muraria; pregevoli un altare carolingio e l’arcosolio <strong>di</strong> Altperto. Dal<br />
chiostro “imperiale” si accede poi al Museo Abbaziale ricco <strong>di</strong> affreschi e <strong>di</strong> statue come quella<br />
quattrocentesca della Madonna col Bambino e <strong>di</strong> due tavole opistografe <strong>di</strong> un quattrocentista seguace <strong>di</strong><br />
Antonazzo. Nel museo, preziosi i materiali archeologici tra cui il Cippo <strong>di</strong> Cures esemplare unico <strong>di</strong><br />
epigrafia sabina del VI secolo a.C. e una preziosa cassetta eburnea. Di pregio architettonico notevole<br />
sono la Torre Campanaria secc. IX-XI con vano quadrato alla base e la Cripta a semianello secc. VII-<br />
VIII nel cui ingresso trovasi un sarcofago romano del III secolo d.C. La Biblioteca conserva preziosi<br />
co<strong>di</strong>ci antichi ed è memoria sostanziale dell’attività culturale dell’<strong>abbazia</strong> nei secoli. . Ancora da visitare<br />
sono il Chiostrino romanico detto longobardo e il Chiostro Grande con epigrafi e sculture romane.<br />
(Accompagnati da una guida)<br />
Ore 14.00 - Pranzo libero ( a sacco) o al ristorante La Caravella da Positano , Località Prime case -<br />
Tel. 0765.386016 - Cell.. 393.9164738 (Giuseppe)<br />
(su prenotazione al momento dell’iscrizione).
Il menù proposto dallo Chef comprende:<br />
affettati misti, fagioli cotti in tegame <strong>di</strong> coccio, polenta alla conta<strong>di</strong>na, pizza fritta e<br />
sott’olio locali.<br />
Primi piatti: RISOTTO CON ZUCCA E TARTUFO (veramente da degustazione)<br />
CASARECCE ALLA SABINESE CON POMODORINI OLIVA RAIA E<br />
CARBONCELLA (olive <strong>di</strong> nostra produzione prodotto tipico e genuino)<br />
Secon<strong>di</strong> piatti: ARROSTO E GRIGLIATO CON ABBACCHIO dei nostri pascoli,<br />
POLLO ruspante e BISTECCHINA DI MAIALE<br />
Contorni: patate arrosto e insalata <strong>di</strong> campo<br />
Dessert della casa, caffè e bibite comprese<br />
Costo a persona € 25,00 (venticinque/00)<br />
Ore 16.00 – Visita del Monastero delle Suore Clarisse Eremitane e Museo del Silenzio.<br />
Ore 17.30 – Visita del Museo Civico <strong>Archeologico</strong> <strong>di</strong> Fara Sabina.<br />
Istituito nel 1980 presso l’Abbazia <strong>di</strong> Farfa il Museo Civico è stato trasferito nel 2001 a Palazzo<br />
Brancaleoni, un e<strong>di</strong>ficio rinascimentale situato nella piazza del Duomo del borgo me<strong>di</strong>evale <strong>di</strong> Fara<br />
Sabina. Nel museo sono esposti i reperti provenienti dagli scavi archeologici effettuati nel territorio a<br />
partire dagli anni ‘70 relativi ai due inse<strong>di</strong>amenti principali dell’antica Sabina tiberina: Cures ed Eretum,<br />
più volte citati dagli scrittori romani per il ruolo che svolsero nella storia della fondazione <strong>di</strong> Roma e<br />
della civiltà romana, cui passarono il testimone in queste terre.<br />
Grazie alle ricerche condotte dalla Soprintendenza archeologica del Lazio e dall’Istituto per<br />
l’archeologia etrusco-italica del CNR che hanno riportato in luce i resti <strong>di</strong> queste antiche città, è stato<br />
possibile delineare il profilo storico e culturale <strong>di</strong> questo popolo, inse<strong>di</strong>atosi in Sabina a partire dalla<br />
seconda metà dell’VIII secolo a.C. fino alla conquista da parte dei Romani nel III sec. a.C.<br />
Ore 19. 30 – Partenza per Salerno.<br />
QUOTA DI PARTECIPAZIONE<br />
€ 30,00 (trenta/00)<br />
La quota comprende: viaggio in pullman G.T.; guida; depliants illustrativi.<br />
La quota non comprende: pranzo in ristorante. Offerta libera al Monastero.<br />
Per Informazioni e Prenotazioni<br />
GRUPPO ARCHEOLOGICO SALERNITANO<br />
C/o DLF - via Dalmazia, 14 - tel/fax 089/337331 – 089/274061 - cell.ri 338/1902507 -<br />
329/0761908 – 320/8676400<br />
riunioni venerdì h. 19.00 - 20.30 – saletta Olimpia -<br />
www.gruppoarcheologicosalernitano.org; archeogruppo@alice.it
Ulteriori informazioni storiche<br />
RESTI DELLA CITTÀ DI CURES<br />
Cures era il centro che la tra<strong>di</strong>zione romana ricordava come la capitale dell’intera Sabina, citato dagli storici<br />
romani soprattutto per aver dato i natali a Numa Pompilio e ad Anco Marzio, secondo e terzo re <strong>di</strong> Roma.<br />
La storia della sua fondazione, giunta a noi grazie a Dionigi <strong>di</strong> Alicarnasso narra del principe reatino Mo<strong>di</strong>o<br />
Fabi<strong>di</strong>o che qui si stabilì in seguito a una migrazione sacra. Situato lungo la valle del torrente Corese nei<br />
pressi <strong>di</strong> Talocci (oggi comune <strong>di</strong> Fara Sabina) l’inse<strong>di</strong>amento occupava nella fase protourbana una<br />
superficie <strong>di</strong> circa 30 ettari <strong>di</strong>stribuiti su tre colli, prospicienti la valle del Tevere e dominanti il suo corso,<br />
secondo un modello inse<strong>di</strong>ativo ampiamente attestato per la Sabina Tiberina.<br />
I materiali <strong>di</strong> rinvenuti nel corso degli scavi illustrano lo sviluppo del centro nella fase <strong>di</strong> fondazione<br />
(seconda metà dell’VIII secolo a.C.) e il suo passaggio verso una <strong>di</strong>mensione urbana nell’orientalizzante. La<br />
rilevanza <strong>di</strong> Cures dal punto <strong>di</strong> vista archeologico risiede nel fatto <strong>di</strong> essere l’unico centro abitato fino ad<br />
oggi indagato: l’in<strong>di</strong>viduazione e l’esplorazione <strong>di</strong> questa area occupata dalla fine del IX secolo a.C. da<br />
capanne, mentre nel VI sorgeranno e<strong>di</strong>fici più complessi con tetti in tegole. Il recupero <strong>di</strong> una considerevole<br />
quantità <strong>di</strong> reperti, ha costituito la base per allargare lo sguardo su tutta l’area della Sabina Tiberina fornendo<br />
un quadro abbastanza completo della cultura materiale, del sistema economico, produttivo e <strong>di</strong> scambio<br />
dell’inse<strong>di</strong>amento sabino nelle fasi più antiche. In età romana la sommità del colle venne abbandonata ed<br />
utilizzata a partire dal IV secolo d.C. come necropoli.<br />
LA STORIA DELL’ABITATO ERETUM<br />
Eretum (oggi in località Casacotta, nel comune <strong>di</strong> Montelibretti), situata nella valle del Tevere al confine con<br />
la regione dei Latini, era una delle due città più importanti della Sabina Tiberina.<br />
Nel corso del VII secolo iniziò l’organizzazione dell’inse<strong>di</strong>amento in senso urbano che si andò estendendo su<br />
un colle separato dalle alture circostanti destinate a necropoli, secondo uno schema ben noto in Etruria e nel<br />
Lazio. In epoca arcaica l’abitato occupava tutta la collina, con una superficie <strong>di</strong> 18-21 ettari, ed era privo <strong>di</strong><br />
sistema <strong>di</strong>fensivo murario.<br />
Gli scavi della necropoli <strong>di</strong> Colle del Forno - eseguiti sotto la <strong>di</strong>rezione scientifica del Centro <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o per<br />
l’archeologia etrusco-italica del CNR - hanno permesso <strong>di</strong> ricostruire l’organizzazione dell’inse<strong>di</strong>amento<br />
dall’VIII fino al II secolo a.C. corre<strong>di</strong> delle tombe della prima metà del VI documentano una fiorente attività<br />
artigianale a opera <strong>di</strong> officine locali anche se non mancano oggetti <strong>di</strong> importazione che testimoniano i<br />
rapporti con le popolazioni della riva opposta del Tevere. La continua menzione <strong>di</strong> Eretum nei conflitti tra<br />
Romani e Sabini sottolinea la tenace resistenza della città <strong>di</strong> fronte all’espansionismo romano.<br />
Dal III secolo a.C la necropoli <strong>di</strong> Colle del Forno cadde in <strong>di</strong>suso e l’altura fu sfruttata come terreno<br />
agricolo. Un rituale <strong>di</strong> desacralizzazione dell’area, probabilmente dovuto al crollo delle tombe, è<br />
testimoniato dal ritrovamento <strong>di</strong> una fossa votiva databile alla metà del II secolo a.C. che accoglieva, oltre ad<br />
anfore vinarie, brocche e ollette <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse misure in ceramica a vernice nera, i resti ossei <strong>di</strong> un gran<strong>di</strong>oso<br />
sacrificio (12 pecore, 2 cani, 1 maiale, parte <strong>di</strong> un equino e <strong>di</strong> un bue).<br />
Con la romanizzazione Eretum perse gradualmente la sua importanza fino a <strong>di</strong>ventare, nell’età imperiale, un<br />
villaggio in cui passava la stazione <strong>di</strong> posta della via Salaria e la zona venne utilizzata dai generali, dai<br />
consoli e dai senatori romani per la costruzione delle loro ville. Successivamente l’inse<strong>di</strong>amento fu<br />
abbandonato, probabilmente con l’inizio delle scorrerie barbariche, perché poco <strong>di</strong>fen<strong>di</strong>bile.<br />
a cura <strong>di</strong> Corinna Fumo - <strong>Gruppo</strong> <strong>Archeologico</strong> <strong>Salernitano</strong> -