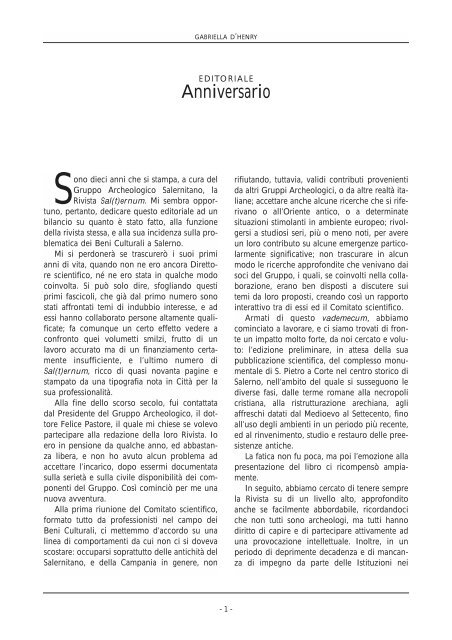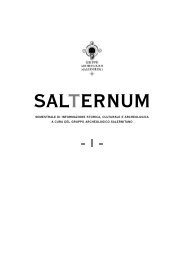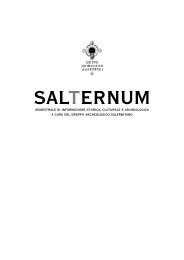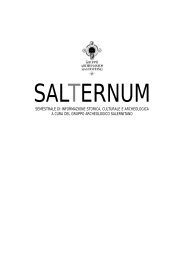Download del file - Gruppo Archeologico Salernitano
Download del file - Gruppo Archeologico Salernitano
Download del file - Gruppo Archeologico Salernitano
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Sono dieci anni che si stampa, a cura <strong>del</strong><br />
<strong>Gruppo</strong> <strong>Archeologico</strong> <strong>Salernitano</strong>, la<br />
Rivista Sal(t)ernum. Mi sembra opportuno,<br />
pertanto, dedicare questo editoriale ad un<br />
bilancio su quanto è stato fatto, alla funzione<br />
<strong>del</strong>la rivista stessa, e alla sua incidenza sulla problematica<br />
dei Beni Culturali a Salerno.<br />
Mi si perdonerà se trascurerò i suoi primi<br />
anni di vita, quando non ne ero ancora Direttore<br />
scientifico, né ne ero stata in qualche modo<br />
coinvolta. Si può solo dire, sfogliando questi<br />
primi fascicoli, che già dal primo numero sono<br />
stati affrontati temi di indubbio interesse, e ad<br />
essi hanno collaborato persone altamente qualificate;<br />
fa comunque un certo effetto vedere a<br />
confronto quei volumetti smilzi, frutto di un<br />
lavoro accurato ma di un finanziamento certamente<br />
insufficiente, e l’ultimo numero di<br />
Sal(t)ernum, ricco di quasi novanta pagine e<br />
stampato da una tipografia nota in Città per la<br />
sua professionalità.<br />
Alla fine <strong>del</strong>lo scorso secolo, fui contattata<br />
dal Presidente <strong>del</strong> <strong>Gruppo</strong> <strong>Archeologico</strong>, il dottore<br />
Felice Pastore, il quale mi chiese se volevo<br />
partecipare alla redazione <strong>del</strong>la loro Rivista. Io<br />
ero in pensione da qualche anno, ed abbastanza<br />
libera, e non ho avuto alcun problema ad<br />
accettare l’incarico, dopo essermi documentata<br />
sulla serietà e sulla civile disponibilità dei componenti<br />
<strong>del</strong> <strong>Gruppo</strong>. Così cominciò per me una<br />
nuova avventura.<br />
Alla prima riunione <strong>del</strong> Comitato scientifico,<br />
formato tutto da professionisti nel campo dei<br />
Beni Culturali, ci mettemmo d’accordo su una<br />
linea di comportamenti da cui non ci si doveva<br />
scostare: occuparsi soprattutto <strong>del</strong>le antichità <strong>del</strong><br />
<strong>Salernitano</strong>, e <strong>del</strong>la Campania in genere, non<br />
GABRIELLA D’HENRY<br />
EDITORIALE<br />
Anniversario<br />
- 1 -<br />
rifiutando, tuttavia, validi contributi provenienti<br />
da altri Gruppi Archeologici, o da altre realtà italiane;<br />
accettare anche alcune ricerche che si riferivano<br />
o all’Oriente antico, o a determinate<br />
situazioni stimolanti in ambiente europeo; rivolgersi<br />
a studiosi seri, più o meno noti, per avere<br />
un loro contributo su alcune emergenze particolarmente<br />
significative; non trascurare in alcun<br />
modo le ricerche approfondite che venivano dai<br />
soci <strong>del</strong> <strong>Gruppo</strong>, i quali, se coinvolti nella collaborazione,<br />
erano ben disposti a discutere sui<br />
temi da loro proposti, creando così un rapporto<br />
interattivo tra di essi ed il Comitato scientifico.<br />
Armati di questo vademecum, abbiamo<br />
cominciato a lavorare, e ci siamo trovati di fronte<br />
un impatto molto forte, da noi cercato e voluto:<br />
l’edizione preliminare, in attesa <strong>del</strong>la sua<br />
pubblicazione scientifica, <strong>del</strong> complesso monumentale<br />
di S. Pietro a Corte nel centro storico di<br />
Salerno, nell’ambito <strong>del</strong> quale si susseguono le<br />
diverse fasi, dalle terme romane alla necropoli<br />
cristiana, alla ristrutturazione arechiana, agli<br />
affreschi datati dal Medioevo al Settecento, fino<br />
all’uso degli ambienti in un periodo più recente,<br />
ed al rinvenimento, studio e restauro <strong>del</strong>le preesistenze<br />
antiche.<br />
La fatica non fu poca, ma poi l’emozione alla<br />
presentazione <strong>del</strong> libro ci ricompensò ampiamente.<br />
In seguito, abbiamo cercato di tenere sempre<br />
la Rivista su di un livello alto, approfondito<br />
anche se facilmente abbordabile, ricordandoci<br />
che non tutti sono archeologi, ma tutti hanno<br />
diritto di capire e di partecipare attivamente ad<br />
una provocazione intellettuale. Inoltre, in un<br />
periodo di deprimente decadenza e di mancanza<br />
di impegno da parte <strong>del</strong>le Istituzioni nei
iguardi <strong>del</strong> Beni Culturali, cercammo di fare le<br />
nostre battaglie e di dimostrare, per quanto<br />
potesse servire, il nostro dissenso.<br />
Ora, non so ancora se questo periodo sia<br />
passato; ma noi siamo sempre pronti ad espri-<br />
SALTERNUM<br />
- 2 -<br />
mere chiaramente il nostro pensiero ed a collaborare,<br />
da volontari, alla tutela e valorizzazione<br />
dei nostri Beni Culturali.
CHIARA LAMBERT<br />
Testimonianze di vita dalle iscrizioni funerarie<br />
infantili <strong>del</strong>la Campania (secoli IV-VIII d.C.)<br />
Il quotidiano manifestarsi <strong>del</strong>la morte ne<br />
rende il tema eternamente attuale e<br />
costituisce parte integrante <strong>del</strong> bagaglio<br />
emotivo, affettivo e culturale di tutti e di ciascuno.<br />
Il momento esiziale, comunque lo si<br />
intenda, è infatti ‘l’unica certezza che si ha<br />
nella vita’ ed il modo di affrontarlo rappresenta<br />
un elemento unificante nel sentire di un consesso<br />
umano e di una civiltà, in tutte le epoche.<br />
Toccandoci più o meno da vicino, la morte<br />
accompagna e scandisce molti momenti <strong>del</strong>l’esistenza<br />
individuale e familiare, a tal punto che,<br />
negazione <strong>del</strong>la vita e sua contrapposizione e<br />
contraddizione in termini, paradossalmente,<br />
essa ne è complementare. Con questa realtà si<br />
instaura pertanto un rapporto personale e soggettivo:<br />
la scomparsa <strong>del</strong>le persone care induce<br />
a riflettere sulla caducità <strong>del</strong>la vita, traducendosi<br />
in scelte o mutamenti comportamentali,<br />
condizionati dai convincimenti religiosi di<br />
ognuno e <strong>del</strong>la collettività di cui è parte, ma in<br />
cui la sfera <strong>del</strong>l’individualità dei sentimenti e<br />
<strong>del</strong>le azioni è molto più salvaguardata di quanto<br />
non si creda comunemente 1 .<br />
Il trattamento riservato ai propri defunti<br />
dalla comunità dei vivi - vale a dire ciò di cui<br />
resta segno più tangibile attraverso i riti di inumazione,<br />
le tipologie tombali e gli eventuali<br />
oggetti deposti accanto ai corpi 2 – rappresenta<br />
la traduzione materiale dei rapporti socio-economici<br />
che regolano la collettività al suo interno;<br />
al contempo, la pietas che impone il rispetto<br />
e la cura nei confronti dei defunti è elemento<br />
primario di distinzione <strong>del</strong>l’uomo dagli altri<br />
esseri animati. Considerando il passato storico,<br />
le citazioni letterarie potrebbero essere numerose,<br />
ma per limitarsi a due estremi temporali e<br />
- 3 -<br />
culturali, basti pensare, nell’Iliade omerica, alle<br />
umiliazioni che Priamo è pronto a subire pur di<br />
riavere il corpo <strong>del</strong> figlio Ettore, non solo per<br />
piangerlo, ma per assicurargli degna sepoltura,<br />
e a quale livello di condivisione giunse infine il<br />
vincitore Achille 3 ; a circa dodici secoli di<br />
distanza, nell’Occidente tardoantico, Agostino<br />
di Ippona (354-430 d.C.) compone una sorta di<br />
trattato sulle attenzioni che si devono prestare<br />
ai corpi dei propri defunti, in cui viene negata<br />
l’importanza <strong>del</strong>le modalità e <strong>del</strong> luogo di seppellimento<br />
ai fini <strong>del</strong>la salvezza <strong>del</strong>l’anima,<br />
esplicitando il significato <strong>del</strong> tutto nuovo che i<br />
cristiani conferiscono alla morte 4 . Inteso come<br />
trapasso ad una condizione migliore, di riposo<br />
eterno e di raggiungimento <strong>del</strong>la pienezza <strong>del</strong>la<br />
vera vita in Cristo, il momento <strong>del</strong> distacco<br />
diventa dies natalis, compleanno alla vita 5 . Ne<br />
risulta evidente la fondamentale differenza dall’atteggiamento<br />
di sconforto o di generica speranza<br />
in un aldilà indistinto che aveva caratterizzato<br />
parte <strong>del</strong> paganesimo e ancor più dalle<br />
posizioni di quanti, sulla scia <strong>del</strong>l’epicureismo,<br />
filtrato nel mondo romano da Lucrezio, guardavano<br />
alla fine <strong>del</strong>l’esistenza come ad un inevitabile<br />
accadimento biologico: ‘la morte non ci<br />
riguarda in nulla e non è un male’, essendo l’anima,<br />
come tutti gli elementi <strong>del</strong>l’universo, formata<br />
di atomi, solo più leggeri e sottili <strong>del</strong>la<br />
materia corporea e, in quanto tale, destinata a<br />
disgregarsi, per poi raggiungere un diverso<br />
stato 6 .<br />
L’individualità <strong>del</strong> ‘sentire’ di fronte alla<br />
morte, se si eccettuano le non infrequenti citazioni<br />
nella letteratura poetica od epistolare, è<br />
tuttavia un fatto che raramente lascia testimonianze<br />
documentarie, al di là dei manufatti
tombali e dei segni dei riti di deposizione: un<br />
corredo più o meno ricco non traduce la sincerità<br />
degli affetti feriti, né questi vengono<br />
espressi da un cordoglio manifestato con maggiore<br />
o minore pompa, spesso inserita in un<br />
contesto socio-economico che la richiede 7 .<br />
E’ di particolare interesse, pertanto, indagare<br />
in che modo gli antichi vivevano il loro rapporto<br />
con l’ineluttabilità di questo evento finale,<br />
come lo traducevano a livello di espressioni<br />
esteriori che, oltre ad assolvere alla più elementare<br />
funzione memorativa o quella più<br />
complessa <strong>del</strong>la commemorazione, potevano<br />
anche essere strumenti in qualche modo ‘catartici’:<br />
l’esternazione <strong>del</strong> dolore e <strong>del</strong> cordoglio<br />
permette di alleggerirsi, condividendolo con<br />
altri, da un peso interiore troppo profondo, di<br />
liberarsi dalla sua componente negativa e di<br />
recuperare la carica vitale 8 .<br />
Da questo punto di vista, i testi <strong>del</strong>le epigrafi<br />
funerarie <strong>del</strong>la tarda antichità e <strong>del</strong>l’altomedioevo<br />
rappresentano una sorta di osservatorio<br />
privilegiato per la storia <strong>del</strong>le mentalità, con<br />
straordinari punti di tangenza con il mondo<br />
contemporaneo, che trovano giustificazione<br />
proprio nell’universalità dei messaggi e <strong>del</strong>le<br />
aspettative che essi trasmettono.<br />
Nel caso specifico <strong>del</strong>le morti premature, tali<br />
considerazioni sembrano accentuarsi ulteriormente:<br />
il dolore di fronte ad una vita che appare<br />
umanamente violata, inspiegabilmente strappata<br />
(un dono sottratto a chi lo ha ricevuto – i<br />
genitori – e rubato a chi ne è portatore – il neonato<br />
o il bambino in tenera età), non sembra<br />
trovare alcuna spiegazione adeguata. E al concetto<br />
<strong>del</strong> distacco si associa, inevitabilmente, il<br />
dolore che ne deriva.<br />
Fig. 1 - Mortalità<br />
infantile nella<br />
Campania<br />
tardoantica<br />
(IV-VII sec. d.C.).<br />
Istogramma di<br />
distribuzione per<br />
Province attuali.<br />
SALTERNUM<br />
- 4 -<br />
Quale che sia l’età nella quale essa sopravviene,<br />
la morte di una persona cara, e soprattutto<br />
quella di un figlio, è sempre ‘prematura’, tuttavia<br />
da un punto di vista strettamente biometrico,<br />
nonché sotto il profilo giuridico, per immmaturae<br />
mortes si intendono quelle circoscritte nella<br />
fascia di età che va dagli 0 ai 12 anni. La documentazione<br />
in questo senso è discretamente<br />
ricca per il mondo antico, in cui la mortalità fetale,<br />
perinatale, infantile era – per tutta una serie<br />
di ragioni sociali e igienico-comportamentali<br />
ben note - piuttosto alta 9 . Nel territorio <strong>del</strong>l’attuale<br />
Campania, gli elementi relativi al periodo<br />
qui preso in considerazione - la tarda antichità e<br />
l’altomedioevo, con i secoli dal IV all’VIII d.C. -<br />
sono tuttavia relativamente esigui da un punto<br />
di vista quantitativo; nella loro valutazione si<br />
deve comunque tenere presente che le testimonianze<br />
epigrafiche pervenute sono spesso occasionali<br />
e non rappresentano che una percentuale<br />
minima di quanto originariamente prodotto.<br />
Diversamente da altri tipi di fonti, inoltre, quasi<br />
mai esse nascono con la consapevole finalità di<br />
divenire documento storico da tramandare alla<br />
posterità 10 .<br />
Su un campione verificato di 338 iscrizioni, di<br />
cui una minima percentuale intestata a due individui,<br />
quelle di bambini al di sotto dei 12 anni<br />
sono in numero di 44, ripartiti in 26 maschi e 18<br />
femmine 11 (fig. 1). I decessi risultano relativamente<br />
più alti nei primi 4 anni di vita; più bassi tra i<br />
5 ed i 6 anni; scarsamente o per nulla attestati tra<br />
i 7 ed i 9, per poi risalire leggermente tra i 10 ed<br />
i 12 12 (fig. 2). Questi dati, pur con i limiti segnalati,<br />
sembrano sostanzialmente allineati con quelli<br />
di altre aree e dalla valutazione generale se ne<br />
evince che la soglia media di mortalità per i bam-<br />
Fig. 2 - Mortalità<br />
infantile nella<br />
Campania<br />
tardoantica<br />
(IV-VII sec. d.C.).<br />
Istogramma di<br />
distribuzione<br />
per fasce di età.
ini ed i giovani, calcolata sul range 3÷17 anni, è<br />
di 10 anni, sia per i maschi che per le femmine,<br />
mentre le condizioni generali di salute di quanti<br />
poterono permettersi un’epigrafe funeraria dovevano<br />
essere discretamente buone: l’età media<br />
degli individui adulti, sostanzialmente omogenea<br />
nelle località considerate, è di 56 anni per gli<br />
uomini e di 46 per le donne.<br />
Dal punto di vista numerico le iscrizioni<br />
infantili rappresentano dunque solo il 13% <strong>del</strong><br />
totale censito; esse sono tuttavia estremamente<br />
‘parlanti’ sotto il profilo <strong>del</strong> formulario e <strong>del</strong><br />
tenore dei testi e la loro stessa esistenza, inquadrata<br />
nel più generale contesto <strong>del</strong>la contrazione<br />
<strong>del</strong>la produzione epigrafica attuatasi proprio<br />
nel corso <strong>del</strong>la tarda antichità, conferma il carattere<br />
di assoluto privilegio goduto dagli individui<br />
in età preadolescenziale ai quali venne concessa<br />
una memoria lapidaria. Da manufatto relativamente<br />
comune quale era stato nei secoli centrali<br />
<strong>del</strong>l’impero, l’iscrizione funeraria divenne<br />
ovunque un riconoscimento di natura non solo<br />
affettiva, ma principalmente sociale ed appannaggio<br />
sempre più esclusivo di persone fortemente<br />
connotate dall’appartenenza ad un rango<br />
elevato 13 ; uno status proprio degli adulti - gli<br />
ultimi rappresentanti <strong>del</strong>l’aristocrazia senatoria,<br />
fino a che questa sopravvisse, e in seguito dei<br />
membri <strong>del</strong>le nuove élite di stirpe germanica –<br />
che eccezionalmente venne riverberato sui giovanissimi<br />
deceduti prima <strong>del</strong>l’assunzione di<br />
qualsiasi ruolo di prestigio.<br />
Nelle iscrizioni precristiane dei primi secoli<br />
<strong>del</strong>l’Impero manca inoltre un formulario specifico<br />
per i bambini (fig.3 a, b, c), ma la loro qualità<br />
anagrafica è talora esplicitata, oltre che dall’indicazione<br />
degli anni, mesi e giorni vissuti, da<br />
aggettivi o apposizioni quali parvulus/a, infans,<br />
accompagnati da vocaboli che esprimono i sentimenti<br />
(dulcissimus/a); così come per gli adulti,<br />
esistono tuttavia testi ad hoc per i piccoli<br />
defunti di famiglie agiate o altolocate, come<br />
Caius Longinius Proculus, di quasi cinque anni,<br />
per il quale il padre e la madre fecero comporre<br />
in Castellamare di Stabia un lungo testo metrico,<br />
autentico florilegio di citazioni poetiche 14 ,<br />
che lo ricorda insieme al cuginetto Antonio, premortogli:<br />
«Rapito da una malattia, secondo la<br />
CHIARA LAMBERT<br />
- 5 -<br />
Fig.3.- Iscrizioni infantili di I sec.d.C.<br />
3a*. Neoptolemus, di 9 anni, collactius<br />
(‘fratello di latte’) <strong>del</strong>l’anonimo<br />
dedicante. Sorrento, Museo<br />
Correale di Terranova (da<br />
MAGALHAES 2003).<br />
Fig. 3b*. Fronto, di 2 anni e 6 mesi.<br />
Salerno, Museo Provinciale (da<br />
ROMITO 1996).<br />
Fig. 3c. Eclecies, ragazzina di 10 anni. Salerno, Museo Provinciale<br />
(da ROMITO 1996).<br />
*Lastre antropomorfe, <strong>del</strong> tipo detto “a columella” o “ad ombra”.<br />
dura legge <strong>del</strong>le Parche, giaccio in questo luogo<br />
di nera terra, quattordici giorni prima di aver<br />
compiuto, io piccolo, i cinque anni. Un tempo<br />
avevo il nomen di Longinio, il praenomen Gaio,<br />
il cognomen Proculo; ora sono un’ombra, né,<br />
posto sotto terra, la tomba mi protegge dall’ombra<br />
<strong>del</strong>la morte. E, non diversamente, il figlio<br />
generato dal fratello di mia madre, maggiore di<br />
quattro anni meno quaranta giorni, immerse i<br />
suoi occhi nella notte eterna. Questo mio quasi<br />
fratello è sepolto con me nel lido di Stabia e nelle<br />
tenebre scivola sulle onde <strong>del</strong>l’Acheronte. Ora,<br />
per te, felice passante, chiunque tu sia, non sia
Fig.4. Iscrizione di Caius Longinius Priscus. II sec. d.C. (CIL X 8131).<br />
Fig.6. Iscrizione di Dianeses.Apografo (da<br />
MASIELLO 2003).<br />
Fig.6a. Iscrizione di Dianeses. 397 d.C.<br />
Capua, Museo Campano, sala XXX, inv. 324<br />
(CIL X 4493).<br />
Fig.5. Iscrizione di<br />
Marcellus, che visse 1<br />
anno e 46 giorni. IV sec.<br />
d.C. Particolare <strong>del</strong><br />
simbolo iconografico.<br />
Capua, Museo Campano,<br />
Sala I ‘Mommsen’, inv.<br />
195 (CIL X 4715).<br />
di peso dire: se i Mani hanno una qualche pietà<br />
dopo i funerali, le ossa di Antonio e di Proculo<br />
possano riposare dolcemente. Il Padre, Caio<br />
Longinio Prisco, trierarca <strong>del</strong>la prima flotta<br />
misenate e la madre Licinia Procella (posero)<br />
per il dolcissimo figlio» 15 (fig. 4).<br />
SALTERNUM<br />
- 6 -<br />
La progressiva diffusione ed il successivo radicamento<br />
<strong>del</strong> Cristianesimo, che poté esplicitarsi a<br />
partire dai provvedimenti di legalizzazione voluti<br />
da Costantino (a. 313 d.C.), si manifestarono a<br />
livello epigrafico con un graduale adattamento<br />
<strong>del</strong> formulario, che inizialmente abolì le espressioni<br />
proprie <strong>del</strong>la religiosità pagana, conferendo<br />
un carattere ‘neutro’ alle iscrizioni, quindi, in rapido<br />
progresso di tempo, le sostituì o le ‘risemantizzò’<br />
in chiave cristiana, attribuendo significati<br />
nuovi ad antichi vocaboli o simboli iconografici<br />
(fig. 5). Anche per i tituli 16 di bambini le formule<br />
di apertura furono quelle maturate a partire dal<br />
secondo quarto <strong>del</strong> IV sec. d.C. e codificatesi nel<br />
corso <strong>del</strong> V sec. d.C., che presentano rare varianti<br />
all’espressione locativo-obituaria hic requiescit<br />
in pace, hic requiescit in somno pacis (‘qui riposa<br />
in pace’; ‘qui riposa nel sonno <strong>del</strong>la pace’) 17 , finalizzata<br />
ad indicare il luogo <strong>del</strong>la tomba, a garantirne<br />
il rispetto e, al contempo, a dichiarare la<br />
fede <strong>del</strong>la famiglia dei piccoli inumati. Alla loro<br />
tenera età viene dato tuttavia un risalto particolare,<br />
ricorrendo ad una semplice aggettivazione,<br />
già presente nelle iscrizioni di età classica, ma<br />
che muta in modo emblematico con il generalizzarsi<br />
<strong>del</strong> nuovo credo religioso: si assiste infatti al<br />
passaggio dall’uso <strong>del</strong> qualificativo infans (raramente<br />
infas) –antis 18 , che significa: ‘non ancora in<br />
grado di parlare’ (quindi, bambino o bambina in<br />
tenerissima età), all’omologo innocens,-tis, che<br />
contiene in sé la radice <strong>del</strong> verbo nocére: ‘nuocere’’.<br />
Il bimbo cristiano viene dunque connotato<br />
non più solo dalla sua incapacità di esprimersi<br />
con un linguaggio compiuto, bensì, secondo una<br />
categoria morale, dal suo essere ‘esente dal male<br />
o da colpe’ 19 . Un’evoluzione ben attestata in<br />
Campania, a titolo di esempio, dalle iscrizioni<br />
<strong>del</strong>la piccola innocens Infansia di Benevento (IV<br />
– V sec. d.C.) 20 , <strong>del</strong> bimbo capuano Dianeses di<br />
due anni (a.397) 21 , (figg.6-6a), o <strong>del</strong>l’innocens<br />
Theodenanda, bimba di 3 anni, 6 mesi e 9 giorni,<br />
che nell’anno 566 fu sepolta nel cimitero antistante<br />
la chiesa tardoantica dei SS. Pietro e Paolo<br />
in Salerno, oggi meglio nota come complesso di<br />
S. Pietro a Corte 22 (figg. 7-7a). In taluni contesti<br />
particolari, quali le catacombe di S. Gennaro in<br />
Napoli, vennero realizzati manufatti esclusivi,<br />
quali gli affreschi a complemento degli arcosolî di
Fig.7. Iscrizione di Theodenanda. 566 d.C. Salerno, Chiesa dei SS. Pietro e<br />
Paolo (S.Pietro ‘a Corte’).<br />
famiglie agiate, ove al ritratto dei defunto viene<br />
associato un titulus pictus che ne esplicita il<br />
nome e l’età: è il caso <strong>del</strong>le piccole Nicatiola, di<br />
cui non viene indicata l’età, e Nonnosa di 2 anni<br />
e 10 mesi, entrambe riconducibili al V-VI sec.<br />
d.C. 23 (figg. 8-9).<br />
Sempre al VI secolo va riferita la toccante<br />
iscrizione metrica voluta da un Petrus, alto esponente<br />
<strong>del</strong>l’aristocrazia senatoria <strong>del</strong>l’area salernitana,<br />
per la moglie Fortunata e la figlioletta<br />
Petronia, morte insieme, tragicamente: «Qui<br />
Fig.8. Iscrizione di Nicatiola, dipinta sulla parete di<br />
un arcosolio.VI sec. d.C. Napoli, Catacomba di<br />
S.Gennaro.<br />
CHIARA LAMBERT<br />
Fig.9. Iscrizione di Nonnosa, dipinta sulla parete<br />
di un arcosolio.VI sec. d.C. Napoli, Catacomba di<br />
S.Gennaro.<br />
- 7 -<br />
Fig.7a. Iscrizione di Theodenanda. 566 d.C. Salerno, Chiesa dei SS. Pietro<br />
e Paolo (S. Pietro ‘a Corte’). Particolare.<br />
giaci, o Fortuna, abbattuta a terra da un disgraziato<br />
crollo. Ahimé!, o dolce moglie, ciò che mi<br />
opprime maggiormente è che hai concluso la tua<br />
vita all’improvviso, con una rovinosa morte. E<br />
mentre tu muori, per me non muore il dolore.<br />
Casta, graziosa, saggia, umile, gradita al marito,<br />
hai trasformato in gemiti tutta la mia gioia.<br />
Ma a te questa morte tanto cru<strong>del</strong>e non poté<br />
nuocere in nulla: la tua vita, infatti, rimane nei<br />
tuoi meriti. Giace anche questa figlioletta<br />
Petronia, uccisa dal destino che il giorno crude-<br />
Fig.10. Iscrizione di Fortunata, Clarissima<br />
Femina, e <strong>del</strong>la figlioletta Petronia, di 6 anni.VI<br />
sec. d.C. Ravello, perduta (CIL X 664 = CLE<br />
1440 = I.I., Salernum, n.168).
le <strong>del</strong>la morte ha congiunto a te.<br />
Qui riposa in pace Fortunata,<br />
Clarissima Femina, moglie di Petrus,<br />
Vir clarissimus, Pater Pauperum, la<br />
quale visse circa 36 anni e fu deposta<br />
in pace con la figlioletta Petronia,<br />
di 6 anni, nel VII giorno dalle<br />
Calende di Febbraio (il 26 gennaio),<br />
nell’Indizione … » 24 (fig. 10).<br />
Di grande impatto emozionale<br />
anche il breve testo di accompagnamento<br />
per il piccolo Caius Nonius Flavianus,<br />
membro di una famiglia altolocata di Pozzuoli<br />
che ancora ricorre al sistema trinominale per<br />
l’indicazione onomastica 25 , e che gli elementi di<br />
cui si dispone inducono a datare, ugualmente,<br />
nell’ambito <strong>del</strong> VI secolo. La sua iscrizione, carica<br />
di un sofferto pathos che travalica il tempo,<br />
testimonia di una maternità e paternità fortemente<br />
volute, <strong>del</strong>la trepida attesa dei genitori e<br />
<strong>del</strong> loro strazio per una morte davvero inattesa<br />
e prematura: ‘… richiesto con preghiere per molti<br />
anni, una volta nato, visse un anno ed undici<br />
mesi …’ 26 (fig. 11).<br />
In conclusione, un ultimo testo permette di<br />
tornare su due concetti già espressi in apertura:<br />
quello <strong>del</strong> valore ‘liberatorio’, oltre che memorativo,<br />
che alle antiche iscrizioni veniva affidato<br />
dai committenti e quello <strong>del</strong>la relatività <strong>del</strong> concetto<br />
di ‘morte prematura’. Si tratta <strong>del</strong> lungo<br />
epitaffio che Stefano II, vescovo di Napoli nella<br />
seconda metà <strong>del</strong>l’VIII secolo, fa predisporre per<br />
il figlio, il Console Cesario, che egli dice ‘teneris<br />
sublatus in annis’ benché avesse compiuto ventisei<br />
anni 27 : «Qui riposa Cesario Console rapito<br />
negli anni <strong>del</strong>la giovinezza; … E voi, o miei<br />
parenti, compiangete le ferite di me che l’ho<br />
generato, voi che tanto desiderate di godere <strong>del</strong>la<br />
buona sorte dei figli. La mia sorte è tanto più<br />
SALTERNUM<br />
Fig.11. Iscrizione <strong>del</strong> piccolo Caius Nonius Flavianus.Pozzuoli, perduta (CIL X 3310/11).<br />
- 8 -<br />
infelice per il lutto <strong>del</strong> figlio amato e la sua fiamma<br />
mi consuma dentro nel petto…. Con l’aiuto<br />
di lui, la mia annosa vecchiezza di padre si sentiva<br />
sicura, ed io ero ormai un uomo tranquillo….Console<br />
e poi vescovo io, tuo padre, ho<br />
dovuto prepararti la tomba, mentre avresti<br />
dovuto comporre tu i resti di tuo padre….Egli<br />
aveva appena superato i ventisei anni, quando<br />
restituì il suo spirito a Cristo nel cielo. Fragile<br />
diventa la vita di un vecchio dopo la morte acerba<br />
<strong>del</strong> proprio figlio; dopo di lui, credo, non<br />
durerà che pochi giorni. Ti preceda la luce di<br />
Cristo, o figlio carissimo, e tu, S. Gennaro, porta<br />
a Dio la mia preghiera. Deposto il 20 settembre,<br />
nell’anno XIII <strong>del</strong>l’impero di Costantino il giovane<br />
(VI) e di Irene, Augusti, nell’Indizione XII<br />
(789)» 28 .<br />
E’ una dimostrazione estremamente eloquente<br />
<strong>del</strong> dramma di un padre che vede rovesciarsi<br />
le leggi naturali e che si trova a riflettere sull’absurdum<br />
di un destino che impone, a lui ormai<br />
anziano, di prestare al giovane figlio premortogli<br />
quelle ultime cure che la logica avrebbe<br />
voluto essere riservate, dal figlio, a lui. Al di là<br />
<strong>del</strong> mero dato biometrico, anche in presenza di<br />
una fede che alimenta la speranza di un ricongiungimento<br />
e assicura la continuità <strong>del</strong>la vita<br />
nell’aldilà, nella sfera degli affetti, un funus è<br />
sempre acervus e la mors semper immatura.
*Il testo, con alcuni ampliamenti ed i dovuti rimandi bibliografici,<br />
ripropone quanto presentato nella seduta pomeridiana<br />
degli Incontri di Archeologia in occasione <strong>del</strong>la IX<br />
Borsa Mediterranea <strong>del</strong> Turismo <strong>Archeologico</strong>, Paestum<br />
18.11.2006, su invito <strong>del</strong> dott. Felice Pastore, Direttore <strong>del</strong><br />
<strong>Gruppo</strong> <strong>Archeologico</strong> <strong>Salernitano</strong>, che ringrazio vivamente.<br />
NOTE<br />
1 Circa gli atteggiamenti <strong>del</strong>l’uomo, antico e moderno, di<br />
fronte alla morte, l’incidenza <strong>del</strong>le credenze religiose nei<br />
riti di seppellimento ed il ruolo <strong>del</strong>la Chiesa nella loro<br />
codificazione a partire dall’età tardoantica e particolarmente<br />
nell’altomedioevo carolingio, cf. SICARD 1978; ARIÈS<br />
1977 (1985), part. capp. I; III-IV; IDEM 1980; VOVELLE 1976;<br />
IDEM 1983; DUCOS 1987; FÉVRIER 1987; GEARY 1984, part.<br />
pp.89-92; TREFFORT 1996; REBILLARD 2003.<br />
2 Per una panoramica sui principali temi <strong>del</strong>l’archeologia<br />
funeraria, cf. L’inhumation privilegiée 1986; Sepolture e<br />
necropoli 1988; Burial Archaeology 1989; Archéologie du<br />
cimetière chrétien 1996; Sepolture tra IV e VIII secolo 1998.<br />
Circa i significati <strong>del</strong>la deposizione di oggetti in età altomedievale<br />
e la loro sostituzione con altre forme di ritualità,<br />
cf. LA ROCCA 1997; EADEM 1998 e 2000.<br />
3 HOMERI, Ilias, XXIV, 500-601.<br />
4 Il famoso scritto, significativamente intitolato De cura pro<br />
mortuis gerenda, fu occasionato da una lettera <strong>del</strong>l’amico<br />
Paolino da Nola, che interrogava Agostino circa l’atteggiamento<br />
da assumere nei confronti dei fe<strong>del</strong>i che richiedevano<br />
la pratica <strong>del</strong> seppellimento ad sanctum presso la<br />
tomba <strong>del</strong> confessore Felice nella basilica di Cimitile.<br />
5 LAMBERT 2004, Glossario, s.v., p.112.<br />
6 LUCR., De rerum Natura, III, 830: «nihil igitur mors est ad<br />
nos neque pertinet hilum»; per una sintesi <strong>del</strong> pensiero e<br />
<strong>del</strong>l’opera di Tito Lucrezio Caro, cf. PERELLI 1969 1 , pp.129-<br />
132; 134-135; TODINI 2005, pp.78-82; 145-151.<br />
7 Per un inquadramento <strong>del</strong> tema sotto il profilo filosofico,<br />
teologico e religioso cf. COENEN 1991 e DE CHIRICO 2007;<br />
per una trattazione monografica <strong>del</strong>l’atteggiamento <strong>del</strong>l’uomo<br />
moderno, credente e non, di fronte alla morte, cf.<br />
inoltre MESSORI 1982.<br />
8 L’iscrizione cristiana di un bimbo di 2 anni e 2 mesi (da<br />
Capua, a. 563 d.C.) recita: «…cuius rememoratio dolum<br />
parentibus demisit», («…Il ricordarlo, lenì il dolore ai genitori»),<br />
(MASIELLO 2003, p.65).<br />
9 Sulla mortalità antica letta attraverso i documenti epigrafici<br />
cf. MAZZOLENI s.d., p.62; IDEM 1999, pp.207-227.<br />
10 Circa le finalità <strong>del</strong>le iscrizioni, in cui domina la componente<br />
memorativa a livello per lo più familiare, e la loro<br />
potenziale durata nel tempo, cf. LAMBERT 2004, pp. 47-48.<br />
11 Il computo - nel quale non rientrano le iscrizioni infantili<br />
<strong>del</strong> secolo VIII, perché in numero così ridotto da non<br />
essere utilizzabili a fini statistici - è stato effettuato sulla<br />
base dei tradizionali corpora (CIL, I I, ICI, ILCV), nonché<br />
<strong>del</strong>le più recenti acquisizioni. Non si è conteggiata l’ulteriore<br />
ottantina di epigrafi proveniente dalla basilica paleocristiana<br />
di Atripalda, al momento ancora sostanzialmente<br />
inedita, ma di prossima pubblicazione in un volume <strong>del</strong>le<br />
Inscriptiones Christianae Italiae (ICI) a cura di Heikki<br />
Solin. Da colloqui intercorsi con l’A., sembra tuttavia che<br />
i bambini non vi siano significativamente rappresentati<br />
(per qualche anticipazione, cf. SOLIN 1998).<br />
12 Il numero relativamente più elevato di maschi non è di<br />
CHIARA LAMBERT<br />
- 9 -<br />
per sé significativo, data l’esiguità <strong>del</strong> campione, e può<br />
essere imputato alla casualità <strong>del</strong>la conservazione <strong>del</strong> materiale,<br />
che raramente proviene da scavi sistematici e che in<br />
passato è stato oggetto di ulteriori selezioni finalizzate al<br />
collezionismo museale o privato, che privilegiava testi integri,<br />
ben impaginati ed eventualmente dotati di un apparato<br />
iconografico.<br />
13 Sull’argomento, cf., da ultimo, DE RUBEIS 2007, part. pp.<br />
387-390.<br />
14 Il testo contiene tre citazioni da Ovidio, due dall’Eneide<br />
virgiliana, due da Valerio Flacco. I passi sono indicati in<br />
CLE, Indices, Versuum Auctores cognitores, pp. 915; 916-<br />
917; 919-920. Al Bücheler era tuttavia sfuggito, al v. 15,<br />
l’eco diretta <strong>del</strong>l’ovidiano «Anchisae molliter ossa cubent»,<br />
segnalatomi da U. Todini.<br />
15 CIL, X 8131= CLE, 428. L’iscrizione è databile tra I e II sec.<br />
d.C. La traduzione proposta nel testo è di U. Todini e di chi<br />
scrive.<br />
16 Il termine titulus (pl. tituli) indica in primo luogo la lastra<br />
di supporto di un testo iscritto (tituli erano definite anche<br />
le tabelle marmoree con incisi i nomi dei proprietari di una<br />
casa o di un mausoleo); per estensione definisce anche il<br />
contenuto <strong>del</strong> testo stesso (LAMBERT 2004, Glossario, s.v.,<br />
p.116).<br />
17<br />
COLAFRANCESCO CARLETTI 1995; CARLETTI 1997 e, per l’ambito<br />
specificamente campano, LAMBERT 2003, p.124, tabb. 1-4;<br />
EADEM 2007, pp. 47-48; EADEM cdsb , Tab. 3a.<br />
18 Il termine latino è mutuato dal greco in-femì [fhmí ><br />
fasía; a-fasía] > lat. fateor: ‘dire’, ‘dichiarare’, ‘parlare’.<br />
19 Il termine infans permane comunque occasionalmente<br />
anche nel corso <strong>del</strong> VI sec. Cf. ad es. il titulus dipinto di<br />
Nicatiola su di un arcosolio <strong>del</strong>la catacomba napoletana di<br />
S. Gennaro (figg. 8-9).<br />
20ICI VIII, Hirpini, pp.31-32, n.1. Il Felle non esclude che<br />
‘Infansia’ sia il nome <strong>del</strong>la defunta; quanto alla datazione,<br />
l’indicazione <strong>del</strong> console Albino rende possibili gli anni 345<br />
(?); 444; 493.<br />
21 CIL X 4493, a. 397 d.C.; MASIELLO 2003, p.63: «A-chrismòn-<br />
Ω. Hic est positus / Dianeses innocens/ qui vixit annos II /<br />
menses duo dep(ositus) / XV kal(endas) Iunias/ Fl(avio)<br />
Caesario et Nonio / Attico consul(ibus). Benemerenti et<br />
Dulci/tio parentes fecerunt», («Qui è deposto l’innocente<br />
Dianeses, che visse 2 anni e 2 mesi. Sepolto il XV giorno<br />
dalle calende di Giugno (18 maggio), sotto il consolato di<br />
Flavio Cesario e Nonio Attico. I genitori fecero per il dolcissimo figlio che ben meritò»).<br />
22 Ǡ Hic requiescit / in pace innocens / Theodenanda / quae<br />
vixit in pace / ann(os) pl(us) m(inus) III m(enses) VI / d(ies)<br />
VIIII deposita est / sub d(ie) V kal(endas) oct(o)b(res) /<br />
imp(erante) Iustino p(er)p(etuo) Aug(usto) / anno primo<br />
eodem / c(o)ns(ule) ind(ictione) XV». («Qui riposa in pace<br />
l’innocente Theodenanda, che visse circa tre anni, sei mesi<br />
e nove giorni; fu deposta il quinto giorno dalle calende di<br />
ottobre (27 settembre), nell’indizione quindicesima <strong>del</strong><br />
primo anno di consolato <strong>del</strong>l’imperatore Giustino (a.566)»,<br />
(LAMBERT 2004, pp.78-79, con bibliografia precedente).<br />
Circa la frequenza <strong>del</strong>l’apposizione innocens nei titoli<br />
sepolcrali infantili, cf. ILCV, Indices, p.539.<br />
23<br />
SILVAGNI 1943, Tabb. VII, 4; VIII, 1.<br />
24 «Hic Fortuna iaces casu prostrata ruinae/ heu dulcis<br />
coniunx me magis illa premit / clausisti subito cru<strong>del</strong>i<br />
funere vitam / et mihi non moritur te pereunte dolor / casta
decens sapiens humilis iocunda marito / vertisti in gemitus<br />
gaudia tanta meos / sed tibi nil potuit mors haec tam saeva<br />
nocere / de meritis veniens nam tua vita manet / hac quoque<br />
nata iacet Petronia sorte perempta / quam tecum iunxit<br />
mortis acerva dies. / Hic requiescit in pace Fortunata<br />
cl(arissima) fem(ina) coniux / Petri v(iri) c(larissimi)<br />
pat(ris) pau(perum) qui vixit / annos pl(us) m(inus) XXXVI<br />
cum filia Petronia / annorum sex deposita in pace sub d(ie)<br />
VII Kal(endas) / Feb(ruarias) indict(ione) [- - -]». (L’iscrizione<br />
proveniva da Ravello: CIL X 664 = CLE 1440 = I.I., Salernum<br />
- a c. di V. Bracco, 1981- p.93, n.168; LAMBERT cds c , Allegati,<br />
testo n.2; EADEM cds d . La traduzione proposta nel testo è di<br />
chi scrive).<br />
25 A partire dal IV sec. si generalizzò ovunque l’uso quasi<br />
esclusivo <strong>del</strong> solo cognomen, che corrisponde al nostro<br />
nome proprio; rari esempi di attardamento <strong>del</strong> sistema<br />
binominale/trinominale a livello di singole realtà locali,<br />
soprattutto nel territorio <strong>del</strong>le antiche diocesi di Aeclanum<br />
e Benevento, si riscontrano generalmente in testi di individui<br />
di alto rango dichiarato (cf. LAMBERT cds b ).<br />
26 CIL X 3310/11: «C(aius) Nonius Flavianus / plurimis annis<br />
orationibus petitus natus vixit anno uno / m(enses) XI in<br />
cuius honorem basilica haec a parentibus adquisita / contectaquae<br />
est requievit in pace XVIII kal(endas)<br />
ian(uarias)», («Caio Nonio Flaviano, richiesto con preghiere<br />
per molti anni, una volta nato visse un anno e 11 mesi.<br />
In suo onore questa basilica è stata acquistata e dotata di<br />
un tetto dai suoi genitori. Riposa in pace nel diciottesimo<br />
giorno dalle calende di gennaio (il 15 dicembre)». Il termine<br />
‘basilica’, come già sottolineato a suo tempo dal mons.<br />
Galante, è da intendersi come una cella memoriae, un piccolo<br />
mausoleo privato (GALANTE 1987, pp.79-82).<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
Corpora<br />
CIL, Corpus Inscriptionum Latinarum, Berolini 1863 ss.<br />
ICI, Inscriptiones Christianae Italiae septimo saeculo antiquiores,<br />
Bari 1985 ss.<br />
II, Inscriptiones Italiae, Roma 1931 ss.<br />
ILCV, Inscriptiones Latinae Christianae Veteres, ed. E.Diehl,<br />
voll. I-III, Dublin – Zürich 1970 (1925 1 ;1927 1 ; 1931 1 ); vol. IV,<br />
Supplementum, edd. J.Moreau – H.I.Marrou, Ibidem 1967.<br />
* * *<br />
Archéologie du cimetière chrétien 1996, Actes du 2 e Colloque<br />
A.R.C.H.E.A., G.D.R. 94 du C.N.R.S., Sociétés et cadres de vie<br />
au Moyen-Âge: Approches archéologiques, Orléans 1994, a c.<br />
di H. Galinié – E. Zadora Rio, Tours.<br />
ARIÈS PH. 1977, L’homme devant la mort, Paris (ed. it. 1985,<br />
L’uomo e la morte dal medioevo ad oggi, Bari).<br />
IDEM 1980, La liturgie ancienne des funérailles, «La Maison<br />
Dieu», 144, pp.49-57.<br />
Burial Archaeology 1989, Burial Archaeology. Current<br />
Research, Methods and Developments, a c. di Ch. A. Roberts<br />
- F. Lee – J.Bintliff, “BAR”, British Series, 211.<br />
COENEN L. 1991, s.v. Morte, in Dizionario dei concetti biblici<br />
<strong>del</strong> Nuovo Testamento, a c. di L. Coenen – E. Beyreuher – H.<br />
Bietenhard, Bologna (Woppertal 1970 1 ), pp. 1024-1039.<br />
DE CHIRICO L. 2007, s.v. Morte, in Dizionario di Teologia evan-<br />
SALTERNUM<br />
- 10 -<br />
27 Stefano II fu duca di Napoli dal 755 e vescovo dal 767; il<br />
figlio, che egli si associò nel ducato, fu ostaggio di Arechi<br />
II a Benevento nel corso di una guerra tra Napoletani e<br />
Longobardi beneventani. Il carme, in distici, è acrostico<br />
nelle lettere iniziali degli esametri. L’iscrizione è giunta per<br />
tradizione indiretta (RUSSO MAILLER 1981, pp.83-86).<br />
28 «Caesarius Consul, teneris sublatus in annis,/ Hic recubat;<br />
moriens vae Ubi Parthenope!/ Aeternum medio gestas in<br />
pectore vulnus;/ Militibus periit murus et arma tuis./ Et<br />
mea, qui hunc genui, vos vulnera flere parentes, /Qui sobolum<br />
cupitis tam bene sorte frui. /Sors mea deterior dulcis in<br />
funere nati, /Cuius flamma meum pectus ubique cremat.<br />
/Aptus erat cunctis verbo, probus in actu; in /Consilio sollers,<br />
fortis ad arma simul. /Rex Romae praecelsa Novae quo<br />
sceptra reguntur, / Praetulit hunc nostra civibus urbe suis.<br />
/ Istius auxilio longeva paterna senectus /Tuta regebantur,<br />
tamque quietus eram. /Virtus, ingenium, pietas, patientia<br />
summa, /Vae cui cum genito tot periere bona! / Sic blandus<br />
Bardis eras, ut foedera Grais / Servares sapiens inviolata<br />
tamen. /Consul, post praesul genitor monumenta parabi,<br />
/Cui fuerat curae condere membra patris. /O mihi non prolis<br />
tantum sed collega fidus, /Cui tantos linquis quos tuus<br />
auxit amor. /Nutritus obses Arichis moderamine sancti,<br />
/Salvasti patriam, permemorande, tuam. /Sex quater et<br />
binos hic iam trascenderat annos /Cum flamen Christo reddidit<br />
aethre suum. / Vita senis tenuis post nati funus acervum,<br />
/Post illum paucis credo diebus eam. /Lux te praecedat<br />
Christi, carissime fili, /Sancte Ianuari quod peto posce<br />
Deum. /Depositus est XII Kalendas Octobris, imperante<br />
novo /Costantino et Eireni Aug., anno XIIII, Ind. XII» (RUSSO<br />
MAILLER 1981, pp.83-86).<br />
gelica, a c. di P. Bolognesi- L. De Chirico – A. Ferrari,<br />
Giungano (NA), pp.472-474.<br />
DE RUBEIS F. 2007, Rappresentatività sociale <strong>del</strong>le epigrafi tra<br />
IV e X secolo, in Archeologia e società tra tardo antico e alto<br />
medioevo, 12° Seminario sul tardoantico e l’alto medioevo,<br />
Padova 2005, a c. di G.P. Brogiolo – A. Chavarría Arnau,<br />
Mantova, pp.387-399.<br />
DUCOS M. 1987, Le juriste romain et la mort, dans La mort,<br />
les morts et l’au-<strong>del</strong>à dans le monde romain. Actes du<br />
Colloque, Caen 1985 (éd. F. Hinard), Caen, pp.145-257.<br />
FÉVRIER P.-A. 1987, La mort chrétienne, in Segni e riti nella<br />
chiesa altomedievale occidentale, XXXIII Settimana <strong>del</strong><br />
Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto 1985,<br />
pp.881-952.<br />
GALANTE G. A. 1987 (ms. ined. XIX sec.), La catacomba di<br />
S.Severo in Napoli (a c. di G. Rassello), Napoli.<br />
GEARY P. J. 1994, Living with the dead in the Middle Ages, New<br />
York.<br />
LA ROCCA C. 1997, Segni di distinzione. Dai corredi funerari<br />
alle donazioni ‘post obitum’ nel regno longobardo, in L’Italia<br />
centro-settentrionale in età longobarda, Atti <strong>del</strong> Convegno,<br />
Ascoli Piceno 1995, a c. di L. Paroli, Firenze, pp.31-54.<br />
EADEM 1998, Donare, distribuire, spezzare. Pratiche di conservazione<br />
<strong>del</strong>la memoria e <strong>del</strong>lo status in Italia tra VIII e IX secolo,<br />
in Sepolture tra IV e VIII secolo 1998, pp.77-87.<br />
EADEM 2000, Rituali funerari nella transizione dai Longobardi
ai Carolingi, in Il futuro dei Longobardi. L’Italia e la costruzione<br />
<strong>del</strong>l’Europa di Carlo Magno, a c. di C. Bertelli, G.P.<br />
Brogiolo, Ginevra-Milano, pp.50-53.<br />
LAMBERT C. 2003, Testimonianze epigrafiche tardoantiche e<br />
altomedievali in Campania: alcuni esempi a confronto, in<br />
Atti <strong>del</strong> III Congresso Nazionale di Archeologia Medievale,<br />
Salerno 2003, Firenze, pp.122-126.<br />
EADEM 2004, Pagine di pietra. Manuale di epigrafia latinocampana<br />
tardoantica e medievale, ‘Taccuini di Ippocrate’, 2,<br />
Baiano-Quarto (NA).<br />
EADEM 2007, Iscrizioni di vescovi e presbiteri nella Campania<br />
tardoantica ed altomedievale (secc. IV-VIII), in “Schola<br />
Salernitana”, Annali, XI (2006), pp.31-70.<br />
Eadem cds a , Socrates, Eutychia e Theodenanda: tre testimonianze<br />
epigrafiche <strong>del</strong>la presenza bizantina a Salerno tra V<br />
e VI secolo, in Atti <strong>del</strong> Convegno Internazionale di Studi “Ai<br />
confini <strong>del</strong>l’impero. Insediamenti e fortificazioni bizantine<br />
nel Mediterraneo occidentale (VI-VIII sec.)”, Bordighera 2002,<br />
Istituto Internazionale di Studi Liguri, pp.539-548.<br />
EADEM CDS B , La cristianizzazione <strong>del</strong>la Campania: il contributo<br />
<strong>del</strong>l’epigrafia, in Atti <strong>del</strong> IX Congresso Nazionale di<br />
Archeologia Cristiana “La cristianizzazione in Italia fra tardoantico<br />
ed altomedioevo. Aspetti e problemi, Agrigento 20-25<br />
nov. 2004.<br />
EADEM CDS C , Gli esponenti <strong>del</strong> potere civile nella documentazione<br />
epigrafica <strong>del</strong>la Campania tra tarda antichità ed altomedioevo<br />
(VI-X sec.), in Atti <strong>del</strong> Convegno “Uomini, merci e commerci<br />
nel Mediterraneo da Giustiniano all’Islam (VI-X sec.)”,<br />
Bordighera 3-4 dic. 2004.<br />
EADEM CDS D , Epigrafia e città nella Campania tardoantica e<br />
altomedievale. Uomini, istituzioni, opere, in Atti <strong>del</strong> Secondo<br />
Seminario sul Tardoantico e l’altomedioevo in Italia meridionale.<br />
Paesaggi e insediamenti urbani in Italia meridionale<br />
fra Tardoantico e Altomedioevo (2° STAIM), Foggia 27-30<br />
maggio 2006.<br />
L’inhumation privilegiée 1986, L’inhumation privilegiée du<br />
IV e au VIII e siècle en Occident, Actes du Colloque, Créteil 1984,<br />
a c. di Y.Duval – J.-Ch. Picard, Paris.<br />
MAGALHAES M. M. 2003, Storia, istituzioni e prosopografia di<br />
Surrentum romana: la collezione epigrafica <strong>del</strong> Museo<br />
Correale di Terranova, Sorrento.<br />
EADEM 2006, Stabiae romana: la prosopografia e la documentazione<br />
epigrafica. Iscrizioni lapidarie e bronzee, bolli laterizi<br />
e sigilli, Castellamare di Stabia.<br />
MASIELLO S. 2003, La Basilica di S.Prisco. Dalle origini alla<br />
seconda metà <strong>del</strong> XVIII secolo, S.Prisco (CE).<br />
MAZZOLENI D. s.d., Vita quotidiana degli antichi cristiani nelle<br />
CHIARA LAMBERT<br />
- 11 -<br />
testimonianze <strong>del</strong>le iscrizioni, “Archeodossier”, Novara.<br />
IDEM 1999, La vita <strong>del</strong> popolo cristiano a Roma alla luce <strong>del</strong>le<br />
testimonianze epigrafiche (dal III secolo alla fine <strong>del</strong> VI), in La<br />
comunità cristiana di Roma. La sua vita e la sua cultura<br />
dalle origini all’alto Medioevo, Città <strong>del</strong> Vaticano 1999,<br />
pp.207-227, ora in IDEM 2003, Epigrafi <strong>del</strong> mondo cristiano<br />
antico, Roma, pp.73-84.<br />
MESSORI V. 1982, Scommessa sulla morte. La proposta cristiana:<br />
illusione o speranza?, Torino.<br />
PERELLI L. 1969 1 , Storia <strong>del</strong>la Letteratura Latina, Torino.<br />
REBILLARD É. 2003, Religion et sépulture. L’Église, les vivants et<br />
les morts dans l’Antiquité tardive, ‘Civilisations et sociétés’,<br />
115, Paris.<br />
ROMITO M. 1996, I reperti di età romana da Salerno nel Museo<br />
<strong>Archeologico</strong> Provinciale <strong>del</strong>la città, Napoli.<br />
RUSSO MAILLER C. 1981, Il senso medievale <strong>del</strong>la morte nei<br />
carmi epitaffici <strong>del</strong>l’Italia meridionale fra VI e XI secolo,<br />
Napoli.<br />
Sepolture e necropoli 1988, Sepolture e necropoli tra tardoantico<br />
e alto-medioevo nell’Italia nord-occidentale, Atti <strong>del</strong>la<br />
giornata di studio in ricordo di Nino Lamboglia nel decimo<br />
anniversario <strong>del</strong>la sua scomparsa, Savona 1997, in “Rivista di<br />
Studi Liguri”, LIV, 1-4, pp.61-336.<br />
Sepolture tra IV e VIII secolo 1998, 7° Seminario sul tardoantico<br />
e l’alto medioevo in Italia centro settentrionale, Gardone<br />
Riviera 1996, a c. di G. P. Brogiolo – G. Cantino Wataghin,<br />
Mantova.<br />
SICARD D. 1978, La liturgie de la mort dans l’église latine des<br />
origines à la réforme carolingienne, Münster.<br />
SILVAGNI A. 1943, Monumenta epigraphica christiana saecula<br />
XII antiquiora quae in Italiae finibus adhuc exstant, vol. IV,<br />
fasc.I, Neapolis, in Civitate Vaticana.<br />
SOLIN H. 1998, Le iscrizioni paleocristiane di Avellino, in<br />
Epigrafia romana in area adriatica, Actes de la IX e rencontre<br />
franco-italienne sur l’épigraphie du monde romain,<br />
Macerata 1995, Macerata, pp.471-484.<br />
TODINI U. 2005, Antichità per appunti, coll. ‘Taccuini di<br />
Ippocrate’, 3, Baiano-Quarto (NA).<br />
TREFFORT C. 1996, L’Église carolingienne et la mort.<br />
Christianisme, rites funéraires et pratiques commémoratives,<br />
Lyon.<br />
VOVELLE M. 1976, Les attitudes devant la mort: problèmes de<br />
méthode. Approches et lectures différentes, «Annales», I,<br />
pp.120-132.<br />
IDEM 1983, La mort et l’Occident de 1300 à nos jours, Paris.
BIANCA<br />
CANCELLARE
VINCENZA IORIO<br />
La gens Fadena nell’Italia centrale<br />
(Roma, Regio IV e Regio V)<br />
Il gentilizio Fadenus è una variante <strong>del</strong><br />
gentilizio Fadienus 1 , entrambi poco attestati<br />
nell’onomastica romana 2 .<br />
Secondo alcuni studiosi il gentilizio Fadenus<br />
deve essere legato al gentilizio Fadius 3 , quest’ultimo<br />
ben attestato nell’Italia centro-meridionale<br />
ed in particolare nella Regio IV e nella Regio V 4 .<br />
Recenti ritrovamenti avvenuti nell’attuale provincia<br />
di Ferrara, e più precisamente nella frazione<br />
di Gambulaga <strong>del</strong> comune di Portomaggiore,<br />
hanno fornito ulteriori conoscenze sulla gens<br />
Fadiena, essendo stato portato alla luce un<br />
sepolcreto gentilizio 5 .<br />
Come si è detto, si tratta di gentes poco attestate<br />
nell’onomastica romana ed infatti nessun<br />
personaggio con il gentilizio Fadenus o<br />
Fadienus è presente in opere che si occupano di<br />
prosopografia 6 .<br />
La necropoli di Gambulaga non è la prima di<br />
epoca romana ad essere venuta alla luce nel territorio<br />
<strong>del</strong> <strong>del</strong>ta <strong>del</strong> Po, poiché tra le necropoli<br />
<strong>del</strong>l’attuale provincia di Ferrara bisogna annoverare<br />
quella rinvenuta nel territorio <strong>del</strong> Comune<br />
di Voghenza 7 , la necropoli <strong>del</strong>la Vallona di<br />
Ostellato 8 e la necropoli di Stellata nei pressi di<br />
Bondeno (Fig. 1) 9 .<br />
Uno degli aspetti più importanti <strong>del</strong>la necropoli<br />
di Gambulaga è scuramente quello epigrafico,<br />
poiché gli scavi eseguiti 10 hanno messo in<br />
luce cinque iscrizioni nelle quali sono menzionati<br />
personaggi <strong>del</strong>la gens Fadiena, vissuti tra la<br />
fine <strong>del</strong> I sec. a.C. e la fine <strong>del</strong> I sec. d.C. 11 .<br />
Il Camodeca, che si è occupato <strong>del</strong>lo studio<br />
<strong>del</strong>le epigrafi, afferma che il gentilizio Fadienus<br />
è molto raro ed è presente in alcune città<br />
<strong>del</strong>l’Italia settentrionale, mentre la sua variante<br />
Fadenus è meglio attestata ed in particolare lo è<br />
- 13 -<br />
Fig. 1 - Ubicazione <strong>del</strong>le necropoli e <strong>del</strong>le tombe singole nel territorio<br />
<strong>del</strong>la provincia di Ferrara (da BERTI 2006, p. 2, Fig. 1).<br />
Fig. 2 - Il territorio <strong>del</strong>la Regio IV e <strong>del</strong>la RegioV (da CIL IX,Tav. I).<br />
in Sabina, con un preciso riferimento a Nursia<br />
(Norcia), dove sono state rinvenute alcune epigrafi<br />
nelle quali ricorrono personaggi di questa<br />
gens.<br />
I Fadieni di Gambulaga quindi avrebbero<br />
avuto le loro origini nell’Italia centrale ed in<br />
questa sede si cercherà di tracciare un quadro<br />
topografico <strong>del</strong>la presenza <strong>del</strong>la gens Fadena a<br />
Roma, nella Regio IV e nella Regio V (Fig. 2).
La Regio IV comprendeva parte <strong>del</strong> territorio<br />
<strong>del</strong>le moderne regioni <strong>del</strong>l’Abruzzo, <strong>del</strong>la<br />
Campania, <strong>del</strong> Lazio, <strong>del</strong> Molise e <strong>del</strong>l’Umbria 12 ,<br />
mentre la Regio V comprendeva parte <strong>del</strong> territorio<br />
<strong>del</strong>le moderne regioni <strong>del</strong>l’Abruzzo e <strong>del</strong>le<br />
Marche 13 .<br />
La Regio IV e la Regio V rientrano in quel programma<br />
amministrativo attuato da Augusto in<br />
base al quale tutto il territorio che allora indicava<br />
l’Italia fu diviso in varie regiones 14 .<br />
Nel Corpus Inscriptionum Latinarum le iscrizioni<br />
provenienti dalla Regio IV e dalla Regio V<br />
sono presenti nel IX volume <strong>del</strong>l’opera 15 , dal<br />
quale si partirà prendendo in considerazione<br />
quelle epigrafi lì riportate nelle quali compaiono<br />
personaggi <strong>del</strong>la gens Fadena 16 .<br />
Oltre alle epigrafi <strong>del</strong> Corpus Inscriptionum<br />
Latinarum, si esamineranno anche quelle riportate<br />
nei Supplementa Italica, nell’Année Épigraphique<br />
ed in un volume <strong>del</strong>la Rivista Notizie<br />
degli Scavi <strong>del</strong>l’Antichità.<br />
REGIO IV:<br />
1) Foruli:<br />
Non abbiamo molte notizie su questa località,<br />
che era comunque un vicus dipendente da<br />
Amiternum, ricordato dagli autori <strong>del</strong>la letteratura<br />
classica 17 e che oggi corrisponde a Civitatomassa<br />
(AQ), sita tra i resti <strong>del</strong>l’antica Amiternum e Rieti.<br />
In epoca romana ebbe una grande importanza<br />
poiché da qui partiva la Via Claudia Nova, aperta<br />
nel 47 d.C. 18 .<br />
1.1) CIL IX 4408 (Fig. 3).<br />
L’ iscrizione fu rinvenuta nella parete esterna<br />
<strong>del</strong>la chiesa di San Giovanni a Civitatomassa<br />
(AQ).<br />
Fig. 3 - CIL IX 4408.<br />
SALTERNUM<br />
- 14 -<br />
Trascrizione:<br />
C(aius) FADENUS (aii) F(ilius) PATER<br />
SEIENA TIBERI F(ilia) MATER<br />
FADENA C(aii) F(ilia) SOROR<br />
Q(uintus) FADENUS C(aii) F(ilius)<br />
Traduzione:<br />
Caio Fadeno, figlio di Caio, padre (e) Seiena, figlia di<br />
Tiberio, madre (e) Fadena, figlia di Caio, sorella (e)<br />
Quinto Fadeno, figlio di Caio.<br />
Il Mommsen, curatore <strong>del</strong> IX volume <strong>del</strong><br />
Corpus Inscriptionum Latinarum afferma che le<br />
lettere <strong>del</strong>l’epigrafe sono piuttosto antiche.<br />
L’osservazione <strong>del</strong> grande studioso concorda<br />
con la mancanza <strong>del</strong> cognomen nei personaggi<br />
citati, essendo il cognomen, tra gli elementi dei<br />
tria nomina distintivi <strong>del</strong> cittadino romano,<br />
quello il cui uso è più recente 19 .<br />
Si tratta di un’epigrafe sepolcrale relativa alla<br />
gens Fadena, nella quale sono riportati al nominativo<br />
i nomi <strong>del</strong>le persone i cui resti erano<br />
deposti nel sepolcro. Le parole sono divise da<br />
un punto di forma rotonda, molto usuale nell’epigrafia<br />
latina 20 .<br />
Alla prima riga si legge il nome <strong>del</strong> capofamiglia,<br />
cioè C. Fadenus, alla seconda riga il<br />
nome di una donna, Seiena, indicata come<br />
mater, ma non è chiaro se si tratti <strong>del</strong>la madre<br />
di C. Fadenus o di sua moglie, poiché nell’ultima<br />
riga è riportato il nome <strong>del</strong> figlio di C.<br />
Fadenus, Q. Fadenus e quindi Seiena, in quanto<br />
mater, potrebbe esserlo sia di C. Fadenus sia<br />
di Q. Fadenus.<br />
Nella terza riga invece è riportato il nome di<br />
un’altra donna, Fadena, figlia di Caius, indicata<br />
come soror e quindi sorella di C. Fadenus.<br />
Il secondo gentilizio riportato nell’epigrafe,<br />
Seienus, è anch’esso poco attestato nell’onomastica<br />
romana 21 .<br />
Le donne citate nell’epigrafe non hanno il<br />
praenomen poiché questo elemento nell’onomastica<br />
romana femminile era arcaico e raro 22 .<br />
La lettura <strong>del</strong>l’epigrafe pone qualche problema<br />
nella prima riga, dove dopo il praenomen ed il<br />
nomen <strong>del</strong> primo personaggio è riportata una lettera,<br />
la cui trascrizione, secondo chi scrive, è errata.
La lettera infatti sembra rappresentare una<br />
“A” con al di sopra un’asticella orizzontale, cosa<br />
che apparentemente non sembra avere un significato.<br />
Si potrebbe ipotizzare che l’asticella al di<br />
sopra <strong>del</strong>la “A” sia in realtà una scalfittura <strong>del</strong>la<br />
pietra e che chi ha ricopiato l’epigrafe, pensando<br />
che il segno facesse parte <strong>del</strong> testo, lo abbia<br />
comunque riportato.<br />
Questa presunta errata trascrizione non ci<br />
meraviglia, poiché la lettura di un’epigrafe può<br />
facilmente ingannare chi la trascrive e soprattutto<br />
perché molte <strong>del</strong>le epigrafi presenti nel<br />
Corpus Inscriptionum Latinarum non sono state<br />
trascritte da specialisti, per cui la possibilità di<br />
fraintendimento di lettere o spesso di semplici<br />
segni, è molto alta.<br />
Quindi nella nostra epigrafe dovremmo leggere<br />
semplicemente la lettera “A”, la quale, trovandosi<br />
dopo il nomen <strong>del</strong> nostro personaggio,<br />
corrisponderebbe al suo patronimico e quindi il<br />
praenomen <strong>del</strong> padre di C. Fadenus sarebbe<br />
stato Aulus.<br />
Come però si è detto, nell’epigrafe, alla terza<br />
riga, è ricordata la sorella di C. Fadenus, indicata<br />
anche con il nome <strong>del</strong> padre che inizia con la<br />
lettera “C” e che quindi deve essere letto come<br />
Caius.<br />
Essendo quindi C. Fadenus e Fadena, figlia di<br />
Caius, fratello e sorella, ne deduciamo che Caius<br />
era anche il padre di C. Fadenus e che quindi<br />
padre e figlio avevano lo stesso praenomen.<br />
Tenendo presente quanto sopra esposto, in<br />
questa sede si ipotizza che la trascrizione <strong>del</strong>la<br />
lettera “A” con un’asticella al di sopra sia errata,<br />
e che quindi in quella posizione era scritta la lettera<br />
“C”.<br />
L’epigrafe, per la mancanza dei cognomina<br />
dei personaggi, potrebbe essere datata tra la fine<br />
<strong>del</strong> I sec. a.C. e gli inizi <strong>del</strong> I sec. d.C.<br />
2) Nursia:<br />
È la località, tenendo presente che ad essa<br />
apparteneva anche il territorio <strong>del</strong>l’odierna<br />
Cascia, dalla quale proviene il maggior numero<br />
di iscrizioni relative a personaggi <strong>del</strong>la gens<br />
Fadena. Tutti gli autori antichi concordano sul<br />
fatto che l’antica Nursia, corrispondente all’at-<br />
VINCENZA IORIO<br />
- 15 -<br />
Fig. 4 - Suppl. It. XIII, n. 19.<br />
Fig. 5 - CIL IX 4550.<br />
tuale Norcia, fosse una città dei Sabini 23 . Dopo la<br />
conquista romana <strong>del</strong> territorio, Nursia divenne<br />
prima praefectura e poi un municipium retto da<br />
octoviri e da octoviri duovirali potestate 24 .<br />
2.1) CIL IX 4550= AE, 1950, n. 89; 1989, n.<br />
204; 1996, n. 529 a-f ; Suppl. It. XIII, n. 19 (Fig.<br />
4). Si tratta di un’epigrafe parzialmente nota nel<br />
Seicento, forse perché seminterrata sotto un’altra,<br />
sulla parete <strong>del</strong>l’abside <strong>del</strong>la chiesa di San<br />
Lorenzo a Norcia. Fu per la prima volta riportata<br />
parzialmente nel Corpus Inscriptionum<br />
Latinarum (IX 4550) (Figg. 4 e 5) ma il Ciucci,<br />
autore <strong>del</strong> manoscritto dal quale l’epigrafe fu<br />
tratta, commise alcuni errori nel trascriverla.<br />
L’epigrafe fu poi rinvenuta nel 1942 frammentata<br />
e capovolta, a mezzo metro sotto terra,<br />
nel campanile <strong>del</strong>la suddetta chiesa, e quindi<br />
ricomposta e murata a filo terra sul fianco<br />
destro, dov’è tuttora. In questa sede, si segue l’epigrafe<br />
pubblicata più recentemente e cioè quella<br />
presenta in Suppl. It. XIII, n. 19.<br />
Trascrizione:<br />
a. prima colonna:<br />
C(aio) FADENO Q(uinti) F(ilio)<br />
QUI(rina) BASSO<br />
VIII VIR(o) II VIR(ali) POT(estate)<br />
PATRONO PLEB(is)
. seconda colonna:<br />
[Q(uinto) F]ADEN[no – f(ilio)]<br />
QU[i(rina)—-]<br />
VIII[vir(o)]<br />
PATR[i]<br />
c. Terza colonna:<br />
[P?]ETILLENAE Q(uinti) F(ilia)<br />
MAXIMAE<br />
MATRI<br />
d. Quarta colonna:<br />
FA[denae - f]<br />
MA[ximae]<br />
A[mitae]<br />
e al centro ed in mezzo:<br />
[Ex t]ESTAMENTO C(aii) FADENI [Q(uinti) F(ilii)<br />
Qui(rina) Bassi]<br />
MODERATUS [l(ibertus)],<br />
f. nell’estremità inferiore:<br />
L(ocus)[d(atus) d(ecreto) d(ecurionum)?]<br />
Traduzione<br />
a. prima colonna:<br />
A Caio Fadeno, figlio di Quinto, <strong>del</strong>la tribù Quirina,<br />
Basso, octoviro per potestà duovirale, patrono <strong>del</strong>la<br />
plebe<br />
b. seconda colonna:<br />
A Quinto Fadeno, figlio di [-], <strong>del</strong>la tribù Quirina [—-<br />
], octoviro, padre<br />
c. terza colonna:<br />
A Petillena, figlia di Quinto, Massima, madre<br />
d. quarta colonna:<br />
A Fadena, figlia di [-] Massima, zia paterna<br />
e al centro ed in mezzo:<br />
per testamento di Caio Fadeno, figlio di Quinto, <strong>del</strong>la<br />
tribù Quirina, Basso<br />
il liberto Moderato<br />
f. nell’estremità inferiore:<br />
Il luogo è stato dato per decreto dei decurioni<br />
SALTERNUM<br />
- 16 -<br />
Le parole nell’epigrafe sono divise da un<br />
punto di forma rotonda, molto usuale nell’epigrafia<br />
latina 25 .<br />
L’epigrafe è l’unione di tre frammenti, ma<br />
probabilmente manca un quarto frammento da<br />
inserire tra il secondo ed il terzo, a partire da<br />
sinistra, sul quale doveva essere riportato alla<br />
prima riga il patronimico di Q. Fadenus e la<br />
prima lettera <strong>del</strong> gentilizio <strong>del</strong>la moglie di Q.<br />
Fadenus e madre di C. Fadenus Bassus, mentre<br />
nella seconda riga doveva essere riportato il<br />
cognomen <strong>del</strong>lo stesso Q. Fadenus. Si tratta di<br />
un’epigrafe scolpita per un monumento funerario<br />
costruito dal liberto Moderatus, seguendo il<br />
testamento di C. Fadenus Bassus. Nel monumento<br />
funerario, oltre allo stesso C. Fadenus<br />
Bassus, erano seppelliti suo padre, Q. Fadenus,<br />
di cui come si è detto non conosciamo il cognomen,<br />
sua madre Petillena Maxima e la zia paterna,<br />
Fadena Maxima. Si tratta di personaggi<br />
appartenenti ad una classe sociale molto alta,<br />
poiché Q. Fadenus era stato un membro <strong>del</strong> collegio<br />
degli octoviri, mentre suo figlio era stato<br />
membro di un sottocollegio degli octoviri duovirali<br />
potestate, con funzione giurisdicente, un sottocollegio<br />
che sembra proprio <strong>del</strong>l’amministrazione<br />
nursina 26 .<br />
Nell’epigrafe, oltre al gentilizio Fadenus è<br />
presente anche il gentilizio (P?)etillenus,<br />
anch’esso poco attestato nell’onomastica romana<br />
27 , mentre lo è maggiormente il gentilizio<br />
Petillius, al quale Petillenus potrebbe essere<br />
legato 28 .<br />
Due i cognomina presenti nell’epigrafe: il<br />
primo, Bassus, è quello di C. Fadenus, il secondo<br />
invece, Maxima, appartiene sia alla madre di<br />
C. Fadenus, Petillena Maxima sia alla sua zia<br />
paterna, Fadena Maxima.<br />
L’etimologia <strong>del</strong> cognomen Bassus pone alcuni<br />
problemi, poiché la parola non è di origine<br />
latina 29 , mentre molto semplice è l’etimologia <strong>del</strong><br />
cognomen <strong>del</strong>le due donne, Petillena Maxima e<br />
Fadena Maxima, poiché è un cognomen che<br />
augura la perfezione a chi lo possiede 30 .<br />
L’epigrafe può essere datata, per le caratteristiche<br />
paleografiche ed onomastiche e per il formulario,<br />
nella prima metà <strong>del</strong> I sec. d.C.
2.2) CIL IX 4594 (Fig. 6).<br />
Si tratta di un’epigrafe ricopiata dal Ciucci,<br />
così come è riportato nel Corpus Inscriptionum<br />
Latinarum. L’epigrafe fu vista dallo stesso<br />
Ciucci due volte presso due distinte case, la<br />
prima volta presso la casa dei signori Tesorieri<br />
e la seconda presso la casa <strong>del</strong>la signora Marzia<br />
Pichini.<br />
Trascrizione:<br />
D(iis) M(anibus) SECUNDO<br />
C(aii) FADEN(i) BASSI SERVO<br />
SECUNDUS PATER ET<br />
[—-]BLECAS MATER<br />
PARENTES FILIO (pi)ISSIMO<br />
V(ixit) ANN(um) MEN(ses) II DIES XII<br />
P(osuerunt)<br />
Traduzione<br />
Agli Dei Mani. A Secondo, schiavo di Caio Fadeno<br />
Basso, il padre Secondo e la madre [—-]blecas, genitori,<br />
al figlio piissimo (che) visse un anno, due mesi e<br />
dodici giorni, posero.<br />
Le parole nell’epigrafe sono divise da un<br />
punto di forma rotonda, molto usuale nell’epigrafia<br />
latina 31 .<br />
Nel riportare l’epigrafe è stato probabilmente<br />
commesso un errore, poiché le prime due lettere<br />
D(iis) M(anibus) nelle iscrizioni sepolcrali si<br />
trovano isolate e non sulla stessa riga di altre<br />
parole 32 .<br />
L’espressione D(iis) M(anibus) è molto frequente<br />
nelle iscrizioni sepolcrali e ricorda che la<br />
proprietà <strong>del</strong>la tomba, divenuta res religiosa, è<br />
degli Dei Mani e ciò anche per proteggerla da<br />
possibili manomissioni 33 .<br />
Il senso <strong>del</strong>l’epigrafe è molto chiaro poiché si<br />
tratta di una dedica da parte di due schiavi,<br />
marito e moglie, al loro figlio che visse un anno,<br />
due mesi e dodici giorni. Il padre ed il figlio<br />
avevano lo stesso nome, cioè Secundus, un<br />
nome ben attestato tra gli schiavi, la cui origine<br />
è un numerale 34 . Nell’onomastica romana,<br />
Secundus è anche attestato come cognomen 35 .<br />
Poco chiaro invece il nome <strong>del</strong>la madre <strong>del</strong><br />
bimbo morto, che il Ciucci riporta come IIBLE-<br />
VINCENZA IORIO<br />
- 17 -<br />
Fig. 6 - CIL IX 4594.<br />
CAS, ma nella cui trascrizione è stato forse commesso<br />
un errore, poiché nell’onomastica romana<br />
schiavile non è presente il nome (...)blecas,<br />
se lo leggiamo come il Ciucci lo ho trascritto.<br />
Secondo chi scrive, non è possibile stabilire<br />
con quali lettere iniziasse il nome <strong>del</strong>la madre<br />
<strong>del</strong> bambino morto, che poteva comunque terminare<br />
in - ECAS poiché questa terminazione è<br />
presente nell’onomastica romana schiavile 36 .<br />
Secundus e sua moglie erano schiavi di C.<br />
Fadenus Bassus, probabilmente lo stesso personaggio<br />
<strong>del</strong> quale si è discusso nel commento<br />
<strong>del</strong>l’epigrafe precedente, per cui l’epigrafe può<br />
essere datata nella prima metà <strong>del</strong> I sec. d.C.<br />
3) Cascia e dintorni<br />
Come si è detto, probabilmente in epoca<br />
romana il territorio <strong>del</strong>l’attuale cittadina di<br />
Cascia apparteneva a quello di Nursia (Norcia),<br />
non essendo Cascia presente nelle fonti <strong>del</strong>la<br />
letteratura classica. Il territorio era però abitato,<br />
come attestano numerosi ritrovamenti, soprattutto<br />
quelli legati alla presenza di un tempio etrusco-italico<br />
in località Villa San Silvestro 37 .<br />
3.1) CIL IX, 4627 (Figg. 7-9).<br />
L’epigrafe fu rinvenuta nell’ingresso <strong>del</strong>la<br />
chiesa di Santa Anatolia, ma già nell’Ottocento<br />
era irreperibile 38 . Nel Corpus Inscriptionum<br />
Latinarum di questa iscrizione si riportano due<br />
versioni, su due colonne, la prima a sinistra<br />
<strong>del</strong>l’Holstenius (Fig. 7) 39 , il quale affermò anche<br />
che l’epigrafe era fratturata nella parte inferiore,<br />
e la seconda, a destra, <strong>del</strong> Gudius (Fig. 8) 40 .
Fig. 7 - CIL IX, 4627 (lato sinistro).<br />
Inoltre il Sordini, nel volume di Notizie degli<br />
Scavi di Antichità pubblicato nel 1893, riporta<br />
un’altra versione <strong>del</strong>la stessa epigrafe, differente<br />
dalla prime due, ma più simile a quella <strong>del</strong><br />
Gudius (Fig. 9) 41 . Tra le versione <strong>del</strong> Sordini e<br />
quelle <strong>del</strong> Corpus Inscriptionum Latinarum si<br />
contano dieci anni di differenza, essendo il IX<br />
volume <strong>del</strong> Corpus pubblicato nel 1883.<br />
In questa sede si segue la versione <strong>del</strong><br />
Sordini poiché si ritiene che sia quella più verosimile,<br />
<strong>del</strong>la quale comunque si riportano due<br />
trascrizioni, diverse.<br />
1a Trascrizione:<br />
T(iti) FADENI [—-] T(iti) F(ilii)<br />
[—-] CATIANI T(iti) F(ilii)<br />
T(iti) [—-]<br />
C(aii) [—-]<br />
L(ucii) | FA[—-]<br />
T(itii) [·····]AERAR(i) [—-]<br />
Fig. 8 - CIL IX, 4627 (lato destro).<br />
Fig. 9 - da Sordini 1893,<br />
p. 381, n. 42.<br />
1a Traduzione<br />
Di Tito Fadeno, figlio di Tito, di Catiano, figlio di Tito,<br />
di Tito [—-], di Caio [—-], di Lucio Fa[—-], di Tito [—<br />
-]erario.<br />
SALTERNUM<br />
- 18 -<br />
2a Trascrizione:<br />
T(iti) FADENI [—-] T(iti) F(ilii)<br />
[—-] CATIANI T(iti) F(ilii)<br />
T(iti) [—-]<br />
C(aii) [—-]<br />
L(ucii)<br />
FA[—-]<br />
T(itii) [·····] AERAR[—-]<br />
2a Traduzione<br />
Di Tito Fadeno, figlio di Tito, di Catiano, figlio di Tito,<br />
di Tito [—-], di Caio [—-], di Lucio Fa[—-], di Tito [—-<br />
]erario.<br />
Le parole nell’epigrafe sono divise da un<br />
punto di forma rotonda, molto usuale nell’epigrafia<br />
latina 42 .<br />
L’epigrafe presenta numerosi problemi di lettura:<br />
sembra riportare una lista di nomi, in caso<br />
genitivo. Il primo nome sembra essere quello di<br />
T. Fadenus, seguito da uno spazio la cui presenza<br />
non è chiara poiché ci aspetteremmo subito il<br />
patronimico <strong>del</strong> personaggio e cioè Titi filus, che<br />
invece è riportato alla fine <strong>del</strong>la prima riga.<br />
La seconda riga potrebbe iniziare con il cognomen<br />
<strong>del</strong> primo personaggio, seguito dal gentilizio<br />
<strong>del</strong> secondo personaggio che era Catianus, un<br />
gentilizio attestato nell’onomastica romana 43 .<br />
Al gentilizio <strong>del</strong> secondo personaggio segue,<br />
sulla stessa riga, il suo patronimico e cioè Titi<br />
filius.<br />
Nelle righe terza e quarta sono probabilmente<br />
riportati i praenomina Titus e Caius, mentre nel<br />
quinto è riportato il praenomen Lucius di un personaggio<br />
il cui gentilizio inizia con le lettere FA,<br />
che potrebbe essere anch’egli un Fadenus, ma<br />
molti sono i gentilizi che iniziano con queste due<br />
lettere 44 .<br />
Veniamo infine all’ultima riga che differenzia<br />
le due trascrizioni sopra riportate da chi scrive. La<br />
prima parte <strong>del</strong>la riga è la stessa per entrambe le<br />
trascrizioni e sembra iniziare con le lettere Titi,<br />
genitivo <strong>del</strong> praenomen Titus.<br />
La differenza tra le due trascrizioni è posta nell’interpretazione<br />
<strong>del</strong>le lettere seguenti. Infatti<br />
dopo il probabile praenomen c’è uno spazio nel<br />
quale ci aspetteremmo il gentilizio al quale<br />
apparterrebbero le lettere “AERAR”.
In tal caso ci troveremmo di fronte ad un<br />
gentilizio che al caso nominativo avrebbe almeno<br />
dodici lettere, non essendo possibile stabilire<br />
quanto in realtà fosse lunga questa parola,<br />
poiché dopo la “T” <strong>del</strong> praenomen <strong>del</strong> personaggio<br />
ricordato nell’epigrafe c’è uno spazio<br />
con un puntino nel centro, che è quello di divisione<br />
tra il praenomen ed il gentilizio, come per<br />
i personaggi riportati nel primo e nel quinto<br />
rigo 45 ; successivamente c’è un altro spazio dove<br />
potrebbero essere collocate cinque lettere che<br />
vanno sommate alle cinque che leggiamo e cioè<br />
AERAR, alle quali andrebbe aggiunta la terminazione<br />
in –i <strong>del</strong> gentilizio al genitivo <strong>del</strong> nostro<br />
personaggio, come al genitivo sembrano essere<br />
i gentilizi dei personaggi riportati nella prima e<br />
nella seconda riga <strong>del</strong>l’epigrafe.<br />
Questa ipotesi potrebbe corrispondere al<br />
vero poiché nell’onomastica romana esistono<br />
gentilizi che al caso nominativo sono formati da<br />
dodici ma anche da più lettere 46 .<br />
Nella seconda trascrizione invece le lettere<br />
AERAR non sono considerate come parte <strong>del</strong><br />
gentilizio <strong>del</strong> personaggio riportato nell’epigrafe,<br />
ma come facenti parte di un’altra parola che<br />
potrebbe essere la parola AERAR, che indicherebbe<br />
l’erario, cioè il tesoro pubblico 47 , ma di cui<br />
non conosciamo il caso e quindi la desinenza<br />
con la quale la parola terminava.<br />
In questa seconda ipotesi quindi, il gentilizio<br />
<strong>del</strong> personaggio riportato andrebbe posto tra il<br />
suo praenomen e le lettere AERAR e quindi ci troveremmo<br />
di fronte ad un gentilizio che al caso<br />
genitivo era composto da cinque lettere, e che<br />
quindi al caso nominativo ne era composto da sei.<br />
Questa ipotesi potrebbe corrispondere al<br />
vero poiché nell’onomastica romana esistono<br />
gentilizi che al caso nominativo sono composti<br />
da sei lettere 48 .<br />
In questa ipotesi infine, dopo il gentilizio <strong>del</strong><br />
personaggio nominato, non sarebbe riportato il<br />
patronimico poiché lo spazio tra il praenomen e<br />
la parola AERAR sarebbe occupato totalmente<br />
da un gentilizio, in caso genitivo, composto da<br />
cinque lettere.<br />
A causa <strong>del</strong>l’esiguità <strong>del</strong> testo e <strong>del</strong>la difficoltà<br />
di trascrizione, non è possibile ipotizzare una<br />
datazione per questa epigrafe.<br />
VINCENZA IORIO<br />
- 19 -<br />
Fig. 10 - da SORDINI 1893,<br />
pp. 378-379, n. 35.<br />
3.2) Sordini 1893, pp. 378-379, n. 35 (Fig. 10).<br />
Le notizie relative a questa epigrafe sono<br />
riportate dal Sordini che così scrive 49 : “Cippo di<br />
travertino, di m 1,35x0,72 nel podere <strong>del</strong> sig.<br />
Caroli-Franceschini presso la Via di Malignano di<br />
Cascia…fu trovata nel 1764, nel piano di Padule,<br />
nel luogo dove era l’antica collegiata di San<br />
Panfilo e fu trasportata nel casale <strong>del</strong> sig. Luigi<br />
Franceschini, dove serve di piedistallo alla tracanna”.<br />
In questa sede si propongono due trascrizioni<br />
con le relative traduzioni poiché il testo,<br />
alla sesta riga, pone problemi di lettura.<br />
1a Trascrizione:<br />
D(iis) M(anibus)<br />
C(aio) VEDINACO<br />
DEXTRO MIL(iti) CHOR(tis)<br />
II PRAETOR(iae) OPTIONI<br />
CARCARIS MIL(itavit) A(nnis) XIIII<br />
V(ixit) A(nnis) XXXVII M(ensibus) IIII<br />
M(arcus) IULIUS SECUNDUS<br />
PATER FIL(io) PIENTISSIMO<br />
EQUITI AUGUSTOR(um) ET<br />
FADENAE SEMELINI MA(tri) SUIS B(ene) M(erenti) F(ecit)<br />
ET SIBI<br />
Fig. 11 - da SORDINI 1893,<br />
p. 381, n. 46.<br />
1a Traduzione<br />
Agli Dei Mani. A Caio Vedinaco Destro, soldato <strong>del</strong>la<br />
seconda coorte pretoria, soldato scelto <strong>del</strong> carcere.<br />
Militò per quattordici anni, visse trentasette anni e quattro<br />
mesi, Marco Iulio Secondo, padre, al figlio pietosissimo,<br />
cavaliere degli Augusti ed a Fadena Semelinis, sua<br />
madre, ben meritevole, fece e per i suoi.
2a Trascrizione:<br />
D(iis) M(anibus)<br />
C(aio) VEDINACO<br />
DEXTRO MIL(iti) CHOR(tis)<br />
II PRAETOR(iae) OPTIONI<br />
CARCARIS MIL(itavit) A(nnis) XIIII<br />
V(ixit) A(nnis) XXXVII M(ensibus) II (iebus) II<br />
M(arcus) IULIUS SECUNDUS<br />
PATER FIL(io) PIENTISSIMO<br />
EQUITI AUGUSTOR(um) ET<br />
FADENAE SEMELINI MA(tri) SUIS B(ene) M(erenti) F(ecit)<br />
ET SIBI<br />
2a Traduzione<br />
Agli Dei Mani. A Caio Vedinaco Destro, soldato <strong>del</strong>la<br />
seconda coorte pretoria, soldato scelto <strong>del</strong> carcere.<br />
Militò per quattordici anni, visse trentasette anni, due<br />
mesi e due giorni, Marco Iulio Secondo, padre, al figlio<br />
pietosissimo, cavaliere degli Augusti ed a Fadena<br />
Semelinis, sua madre, ben meritevole, fece e per i suoi.<br />
Le parole nell’epigrafe sono divise da un<br />
punto di forma rotonda, molto usuale nell’epigrafia<br />
latina 50 .<br />
Il senso <strong>del</strong>l’epigrafe, di carattere sepolcrale, è<br />
molto chiaro ma, oltre ai problemi di lettura, c’è<br />
un errore grammaticale (suius al posto di eius). Si<br />
tratta di un’epigrafe sepolcrale relativa ad una<br />
tomba che M. Iulius Secundus fece costruire per<br />
C. Vedinacus Dexter, morto all’età di trentasette<br />
anni durante il suo quattordicesimo anno di servizio<br />
militare, e per Fadena Semelinis.<br />
Nell’iscrizione M. Iulius Secundus indica C.<br />
Vedinacus Dexter come suo figlio, ma probabilmente<br />
doveva trattarsi di un figlio che la moglie<br />
doveva aver avuto da un precedente matrimonio,<br />
poiché se i due personaggi fossero stati padre e<br />
figlio naturali avrebbero dovuto avere lo stesso<br />
gentilizio, mentre hanno due gentilizi differenti:<br />
quello <strong>del</strong> primo è Iulius e quello <strong>del</strong> secondo<br />
Vedinacus. Quindi, quando M. Iulius Secundus<br />
sposò sua moglie questa doveva essere vedova<br />
ed avere almeno un figlio, e cioè C. Vedinacus<br />
Dexter, al quale M. Iulius Secundus si affezionò<br />
moltissimo, tanto da considerarlo come figlio proprio,<br />
così come lo indica nell’epigrafe.<br />
Dalla lettura <strong>del</strong>l’epigrafe inoltre non è possi-<br />
SALTERNUM<br />
- 20 -<br />
bile stabilire bene quale età Caius Vedinacus<br />
Dexter avesse quando morì e per questo motivo<br />
si propongono due trascrizioni e due traduzioni.<br />
L’unico dato certo sono gli anni, cioè trentasette,<br />
leggibili in entrambe le trascrizioni, mentre<br />
non è possibile stabilire bene i mesi che<br />
potrebbero essere quattro 51 o due 52 , a seconda<br />
<strong>del</strong>l’interpretazione che si dà all’ultima parte<br />
<strong>del</strong>la sesta riga <strong>del</strong>l’epigrafe.<br />
Il problema nasce in particolare dai quattro<br />
segni che seguono la lettera “M”, cioè mensibus;<br />
tali segni infatti possono essere intesi come il<br />
numerale quattro e quindi leggeremmo “mesi<br />
quattro” 53 oppure i primi due, come il numerale<br />
due e gli ultimi due come un altro numerale<br />
due, ma questa volta riferito ai giorni e quindi<br />
leggeremmo “mesi due e giorni due” 54 .<br />
Nel primo caso lo spazio lasciato tra le prime<br />
due asticelle e le seconde due asticelle <strong>del</strong><br />
numerale sarebbe puramente casuale 55 , nel<br />
secondo caso invece dopo le prime due asticelle,<br />
nello spazio che segue, il lapicida avrebbe<br />
dimenticato di apporre la lettera D(iebus) 56 .<br />
Un altro problema riguarda Fadena<br />
Semelinis, poiché nell’epigrafe è indicata come<br />
madre, ma non è possibile stabilire se essa fosse<br />
la madre di C. Vedinacus Dexter, e quindi la<br />
moglie di M. Iulius Secundus, oppure fosse la<br />
madre di M. Iulius Secundus, e quindi la nonna<br />
di C. Vedinacus Dexter.<br />
Infine, dalla lettura <strong>del</strong>l’epigrafe, apprendiamo<br />
che C.Vedinacus Dexter aveva ricoperto<br />
alcune cariche durante il suo servizio militare ed<br />
in particolare era stato un soldato <strong>del</strong>la seconda<br />
coorte pretoria, cioè la guardia <strong>del</strong> corpo dei<br />
generali 57 , un optio carcaris, cioè un soldato<br />
scelto, aiutante dei centurioni, 58 preposto alla<br />
sorveglianza <strong>del</strong> carcere 59 ed eques singularis<br />
Augusti, appartenente quindi al corpo di guardia<br />
a cavallo personale <strong>del</strong>l’imperatore, istituito probabilmente<br />
già durante l’impero di Nerva e rimasto<br />
attivo forse fino a Costantino 60 .<br />
Per quanto riguarda l’onomastica dei personaggi<br />
citati nell’epigrafe, Vedinacus è un gentilizio<br />
poco attestato nell’onomastica romana 61 ,<br />
mentre non lo è Iulius 62 .<br />
Ben attestati sono anche i cognomina dei<br />
personaggi maschili <strong>del</strong>l’epigrafe e cioè Dexter
che potrebbe essere relativo alla prudenza <strong>del</strong>l’intelletto<br />
63 e Secundus che invece si riferisce<br />
all’ordine di nascita tra i figli 64 .<br />
Probabilmente M. Iulius Secundus era un<br />
liberto, poiché il suo cognomen è diffuso come<br />
nome di schiavi 65 ; uno schiavo infatti quando<br />
diventava liberto assumeva il praenomen ed il<br />
nomen <strong>del</strong> patrono o <strong>del</strong>la patrona che lo<br />
aveva liberato e quello che era stato il suo<br />
nome da schiavo diventava il suo cognomen di<br />
liberto 66 .<br />
Nell’onomastica romana non è attestato<br />
invece il cognomen <strong>del</strong> personaggio femminile<br />
<strong>del</strong>l’epigrafe, Semelinis, probabilmente di provenienza<br />
greca, da accostare a Semele, che la<br />
mitologia greca indica come figlia di Cadmo e<br />
madre di Bacco 67 e che nell’onomastica romana<br />
è attestato come cognomen 68 .<br />
Per l’onomastica dei personaggi e per la presenza<br />
<strong>del</strong> corpo degli equites Augusti è possibile<br />
ipotizzare che l’epigrafe si dati alla fine <strong>del</strong><br />
I sec. d.C.<br />
3.3) Sordini 1893, p. 381, n. 46 (Fig. 11).<br />
Le notizie relative a questa epigrafe sono<br />
riportate dal Sordini che così scrive 69 : “Cippo di<br />
travertino di m. 0,80x0,68x0,25, murato in un<br />
gradino, a destra di chi entra, nella chiesa di s.<br />
Maria di Roccadervi alla Cerasola. Ivi stesso la<br />
vide e ne trasse copia il Franceschini”.<br />
Trascrizione:<br />
D(iis) <br />
C(aius) <br />
C(aio) FADEN(o)<br />
FORTUNA[to]<br />
PATRI PATRO<br />
NO BENE MER[en]<br />
TI V(ixit) AN(nis) LXXX<br />
SIBI ET<br />
POSTERI<br />
QE SUIS<br />
Traduzione<br />
Agli Dei Mani. Caio Fadeno, a Caio Fadeno Fortunato,<br />
padre (e) patrono, ben meritevole. Visse ottanta anni,<br />
per sé e per i suoi posteri.<br />
VINCENZA IORIO<br />
- 21 -<br />
Le parole nell’epigrafe sono divise da un<br />
punto di forma rotonda, molto usuale nell’epigrafia<br />
latina 70 .<br />
L’epigrafe, di carattere sepolcrale, pone problemi<br />
di lettura, inoltre non si conserva per intero ed<br />
in particolare non si conserva la sua parte sinistra.<br />
Nella prima riga <strong>del</strong>l’epigrafe, dopo la lettera<br />
D(iis) doveva esserci la M(anibus) 71 in quella<br />
parte <strong>del</strong>l’epigrafe che non si è conservata.<br />
Nell’epigrafe sembrano essere indicati due<br />
personaggi maschili, il primo nella seconda riga<br />
ed il secondo nella terza riga.<br />
Il nome <strong>del</strong> personaggio riportato nella<br />
seconda riga dovrebbe essere quello <strong>del</strong> dedicante<br />
e quindi dovremmo leggere, in caso nominativo,<br />
il suo praenomen ed il suo gentilizio;<br />
probabilmente questo personaggio non aveva il<br />
cognomen, che si sarebbe dovuto trovare nella<br />
riga successiva, dove invece si trovano già gli<br />
elementi onomastici <strong>del</strong> secondo personaggio.<br />
Inoltre nel ricopiare il nome <strong>del</strong> primo personaggio<br />
probabilmente sono stati commessi errori;<br />
infatti se il suo praenomen è chiaro e cioè,<br />
Caius, non lo è il suo gentilizio.<br />
Chi scrive ipotizza che il gentilizio <strong>del</strong> personaggio<br />
potese essere stato Fadenus poiché nelle<br />
righe successive <strong>del</strong>l’epigrafe è riportato Caius<br />
Fadenus Fortunatus, indicato come padre e<br />
patrono e che morì ad ottanta anni, un’età molto<br />
avanzata in epoca romana.<br />
Se l’ipotesi che qui si propone è giusta, dei<br />
due personaggi menzionati, il primo era il liberto<br />
ed il secondo il patrono e quindi entrambi<br />
dovevano avere lo stesso praenomen e gentilizio<br />
e cioè Caius Fadenus.<br />
Il liberto Caius Fadenus costruì quindi la<br />
tomba per il proprio patrono, che chiama affettuosamente<br />
anche “padre” forse perché lo aveva<br />
anche adottato, per se stesso e per i suoi posteri.<br />
Il cognomen Fortunatus <strong>del</strong> patrono è un<br />
cognomen molto attestato nell’onomastica romana<br />
ed è un nome di tipo augurale 72 .<br />
Per l’onomastica dei personaggi è possibile<br />
ipotizzare che l’epigrafe sia stata scolpita alla<br />
fine <strong>del</strong> I sec. d.C.
REGIO V<br />
4) Interamna Praettutorium.<br />
L’antica Intermna Praettutorium o<br />
Interamnia Praettutorium corrisponde all’attuale<br />
Teramo e la città è ricordata nelle fonti letterarie<br />
73 . La prima parte <strong>del</strong> nome <strong>del</strong>la città deriva<br />
dal fatto che era posta tra due fiumi (Interamnes),<br />
mentre la seconda deriva dal fatto che<br />
era la località più importante <strong>del</strong>l’Ager<br />
Praettutorum 74 .<br />
Fig. 12 - CIL IX, 5104.<br />
4.1) CIL IX, 5104 (Fig. 12)<br />
Non si conosce la provenienza <strong>del</strong>l’epigrafe<br />
che comunque si trovava nel Museo Delfico di<br />
Teramo e che è di tipo sepolcrale. L’epigrafe,<br />
come è presentata nel Corpus Inscriptionum<br />
Latinarum, è in realtà composta da due frammenti<br />
che rappresentano la sua parte iniziale e<br />
la sua parte finale. Dovrebbe però esistere almeno<br />
un terzo frammento che doveva essere posto<br />
tra i primi due.<br />
L’epigrafe pone qualche problema di lettura,<br />
per cui si propongono due trascrizioni e due traduzioni.<br />
1a Trascrizione:<br />
P(ublius) FADE[us] [—-] [—-]RUS SIBI ET<br />
FA[denae] [—-]E PATRON(ae)<br />
FA[dena] [—-]AE MATRI<br />
FERO(niae) [—-]AE UXOR(i)<br />
SP(urio) (f)AD(eno) [—-]EROT L(ucii)<br />
[—-]<br />
SALTERNUM<br />
- 22 -<br />
1a Traduzione<br />
Publio Fadeno [—-] [—-]rus per sé (e) per Fadena [—-<br />
]e, patrona (e) per Fadena [—-]ae madre (e) per<br />
Feronia [—-]ae, moglie, per Spurio Fadeno [—-]erote<br />
L(ucii)<br />
2a Trascrizione:<br />
P(ublius) FADE[us] [—-] [—-]RUS SIBI ET<br />
FA[denae] [—-]E PATRON(ae)<br />
FA[dena] [—-]AE MATRI<br />
FERO(niae) [—-]AE UXOR(i)<br />
SP(urio) (f)AD(eno) EROT L(ucii)<br />
[—-]<br />
2a Traduzione<br />
Publio Fadeno [—-] [—-]rus per sé (e) per Fadena [—-<br />
]e, patrona (e) per Fadena [—-]ae madre (e) per<br />
Feronia [—-]ae, moglie (e) per Spurio Fadeno Erote<br />
L(ucii)<br />
Le parole nell’epigrafe sono divise da un<br />
punto di forma rotonda, molto usuale nell’epigrafia<br />
latina 75 .<br />
L’epigrafe è di tipo sepolcrale e la sua lettura<br />
pone qualche problema nell’ultima riga. Nella<br />
prima riga è riportato il prenome P(ublius) ed il<br />
gentilizio Fade(nus) di colui che ha fatto costruire<br />
la tomba per sé e per le persone che sono<br />
elencate nelle righe successive.<br />
Nella seconda riga è probabilmente riportata<br />
la patrona di P. Fadenus poiché nella parte finale<br />
<strong>del</strong>la riga si leggono le lettere “PATRON” e<br />
poiché precedentemente a queste si legge “E”,<br />
questa ultima lettera molto probabilmente appartiene<br />
al cognomen in caso dativo terminante in -<br />
ae e quindi femminile. La presenza <strong>del</strong>la patrona<br />
di P. Fadenus nella seconda riga <strong>del</strong>l’epigrafe è<br />
anche attestata dalle prime lettere che si leggono,<br />
cioè “FAD” da integrare probabilmente con<br />
Fadenae, poiché essendo questa la padrona di P.<br />
Fadenus, i due personaggi devono avere lo stesso<br />
gentilizio; quando uno schiavo diventava<br />
liberto, assumeva il gentilizio <strong>del</strong> patrono o <strong>del</strong>la<br />
patrona che lo aveva liberato 76 .<br />
Alla terza riga <strong>del</strong>l’epigrafe sono riportati il<br />
nomen e il cognomen <strong>del</strong>la madre di P. Fadenus,<br />
mentre il suo gentilizio inizia con le lettere “FA”
quindi probabilmente era anch’essa una Fadena,<br />
per cui madre e figlio erano liberti <strong>del</strong>la stessa<br />
gens Fadena. In realtà però il gentilizio <strong>del</strong>la<br />
donna potrebbe anche essere un altro poiché<br />
molti sono i gentilizi attestati nell’onomastica<br />
romana che iniziano con le lettere “FA” 77 .<br />
Nella quarta riga <strong>del</strong>l’epigrafe sono riportati il<br />
nomen <strong>del</strong>la moglie di P. Fadenus, Feronia e la<br />
terminazione in –ae <strong>del</strong> suo cognomen.<br />
Il gentilizio Feronius è attestato nell’onomastica<br />
romana 78 ed ad Interamnia Praettutiorum<br />
ricorre anche in un’altra epigrafe 79 . Questo gentilizio<br />
si riallaccia alla dea Feronia, molto venerata<br />
tra le popolazioni <strong>del</strong>l’Italia centrale e protettrice<br />
dei liberti 80 .<br />
Anche nell’ultima riga <strong>del</strong>l’epigrafe, la quinta,<br />
sembra essere riportato il nome di un altro personaggio<br />
il quale probabilmente apparteneva<br />
anch’egli alla gens Fadena. Il praenomen <strong>del</strong><br />
personaggio era Sp(urius), il suo gentilizio iniziava<br />
con le lettere “FAD” e perciò probabilmente<br />
era anch’egli un Fadenus ed il suo cognomen<br />
potrebbe terminare in –erote 81 o essere Erote 82 . Il<br />
cognomen Erotis è attestato nell’onomastica<br />
romana 83 , per cui nella trascrizione Erote potrebbe<br />
essere sbagliata l’ultima lettera che dovrebbe<br />
essere la terminazione <strong>del</strong> dativo in –i e quindi<br />
è possibile che in realtà fosse scritto Eroti.<br />
L’ultima lettera che si legge nella quinta riga<br />
e una “L”, forse l’abbreviazione <strong>del</strong> praenomen<br />
Lucius e quindi l’epigrafe doveva continuare<br />
riportando in una riga successiva la parola libertus<br />
o filius.<br />
Per l’onomastica dei personaggi è possibile<br />
ipotizzare che l’epigrafe si dati nel I sec. d.C.<br />
5) Pausulae<br />
Si tratta di una località oggi nei pressi di<br />
Corridonia, in provincia di Macerata, che è ricordata<br />
da Plinio 84 come località <strong>del</strong> Piceno 85 .<br />
5.1) CIL IX, 5796 (Fig. 13).<br />
L’epigrafe proviene dalla località S. Claudio e,<br />
nel 1852, Ernesto Tambroni la spedì al<br />
Raffaellio.<br />
VINCENZA IORIO<br />
- 23 -<br />
Trascrizione:<br />
MEM(oria)<br />
C(aii) FADENI SE<br />
CUNDINI QUI<br />
VIX(it) AN(nis) XXXVI<br />
FADENUS EPIC<br />
TETUS FRATRI<br />
PIENTISSI(mo)<br />
Traduzione<br />
In memoria di Caio Fadeno Secondino che visse trentasei<br />
anni, Fadeno Epicteto al fratello piissimo.<br />
Fig. 13 - CIL IX, 5796.<br />
Le parole nell’epigrafe sono divise da un<br />
punto di forma rotonda, molto usuale nell’epigrafia<br />
latina 86 .<br />
La traduzione <strong>del</strong>l’epigrafe non pone problemi.<br />
Si tratta infatti di un’epigrafe sepolcrale nella<br />
quale Fadenus Epictetus dedica il sepolcro al fratello<br />
C. Fadenus Secundinus che visse trentasei<br />
anni.<br />
Il cognomen Secundinus è attestato nell’onomastica<br />
romana e deriva dal cognomen<br />
Secundus che si riferisce all’ordine di nascita tra<br />
i figli 87 .<br />
Di origine greca è invece il cognomen <strong>del</strong><br />
secondo personaggio <strong>del</strong>l’epigrafe, Epictetus,<br />
che deriva dall’aggettivo greco piktëtoß, che<br />
significa “di nuovo acquisto”, “aggiunto” 88 .<br />
Per l’assenza <strong>del</strong> praenomen di Fadenus<br />
Epictetus, l’epigrafe si potrebbe datare nel II sec.<br />
d.C., quando il praenomen comincia a non essere<br />
più utilizzato 89 .<br />
6) Roma<br />
Le epigrafi latine che riguardano Roma sono
accolte nel volume VI <strong>del</strong> Corpus Inscriptionum<br />
Latinarum. In particolare, l’epigrafe che qui si<br />
prende in considerazione è presente in CIL VI<br />
Pars III, dove sono raccolte le iscrizioni sepolcrali<br />
di Roma.<br />
Fig. 14 - CIL VI, 17647<br />
6.1) CIL VI, 17647 (Fig. 14).<br />
Non sappiamo in realtà se questa epigrafe sia<br />
stata veramente rinvenuta a Roma, ma questa è<br />
l’opinione di E. Bormann, G. Henzen ed Ch.<br />
Huelsen che hanno curato il volume CIL VI Pars<br />
III, pubblicato a Berlino nel 1886.<br />
Infatti per quanto riguarda l’epigrafe che qui<br />
si prende in considerazione, nel CIL VI Pars III<br />
si riporta quanto segue: “Tavola di marmo di origine,<br />
come sembra, urbana, si trovava a Parigi<br />
nel museo <strong>del</strong> comandante Blacas”. L’epigrafe<br />
fu descritta dal Mommsen.<br />
Trascrizione:<br />
FADENA C(aii) L(iberta) LAIS<br />
SIBI ET SUIS<br />
C(aio) PHELGINATI C(aii) L(iberto)<br />
PHAMPHILO VIRO SUO<br />
Traduzione<br />
Fadena Lais, liberta di Caio, per sé e per i suoi e per<br />
Caio Felginate Panfilo, liberto di Caio, suo marito.<br />
Le parole nell’epigrafe sono divise da un<br />
punto di forma rotonda, molto usuale nell’epigrafia<br />
latina 90 .<br />
SALTERNUM<br />
- 24 -<br />
La traduzione <strong>del</strong>l’epigrafe non pone problemi.<br />
Nella prima riga è menzionata una liberta,<br />
Fadena Lais che costruisce un sepolcro per sé,<br />
per i suoi e per suo marito C. Phelginas<br />
Pamphilus, anch’egli un liberto.<br />
Lais, il cognomen di Fadena, deriva dalla lingua<br />
greca ed era proprio <strong>del</strong>le etere 91 ; dalla lingua<br />
greca derivano anche il gentilizio<br />
Phelginas 92 ed il cognomen Pamphilus <strong>del</strong> marito<br />
di Fadena Lais 93 .<br />
Per il formulario e l’onomastica dei personaggi<br />
riportati nell’epigrafe, questa potrebbe essere<br />
datata nel I sec. d.C. La datazione inoltre potrebbe<br />
essere confermata anche dal modo di rendere<br />
la lettera I <strong>del</strong>la parola SVIS nel secondo rigo,<br />
essendo questa più lunga rispetto alle altre,<br />
fenomeno abbastanza frequente nelle epigrafi<br />
che datano tra il I sec. a.C. ed il I sec. d.C. 94<br />
Tenendo presente le trascrizioni e le traduzioni<br />
proposte, diciotto quindi sono i personaggi<br />
<strong>del</strong>la gens Fadena attestati a Roma, nella<br />
Regio IV e nella Regio V ed in particolare undici<br />
nella Regio IV, sei nella Regio V ed uno a Roma<br />
(Fadena Lais).<br />
Per quanto riguarda più precisamente le città<br />
antiche <strong>del</strong>la Regio IV e nella Regio V dove i personaggi<br />
<strong>del</strong>la gens Fadena erano presenti,<br />
abbiamo il seguente schema:<br />
REGIO IV:<br />
1) Foruli:<br />
CIL IX 4408:<br />
1.1) C. Fadenus<br />
1.2) Fadena<br />
1.3) Q. Fadenus<br />
2) Nursia ed Ager Nursinus:<br />
CIL IX 4550 = AE, 1950, n. 89; 1989, n. 204;<br />
1996, n. 529 a-f ; Suppl. It. XIII, n. 19.<br />
2.1) C. Fadenus Bassus (probabilmente si<br />
tratta <strong>del</strong>lo stesso C. Fadenus Bassus riportato in<br />
CIL IX 4594)<br />
2.2) Q. Fadenus<br />
2.3) Fadena Maxima<br />
CIL IX 4627:<br />
2.4) T. Fadenus
2.5) L. Fadenus<br />
Sordini 1893, pp. 378-379, n. 35:<br />
2.6) Fadena Semelinis<br />
Sordini 1893, p. 381, n. 46:<br />
2.7) C.Fadenus<br />
2.8) C.Fadenus Fortunatus<br />
REGIO V:<br />
3) Interamna Praettutorium:<br />
CIL IX 5104.<br />
3.1) P. Fadenus Bassus<br />
3.2) Fadena<br />
3.3) Fadena<br />
3.4) Sp. Fadenus<br />
4) Pasulae:<br />
CIL IX 5796.<br />
4.1) C. Fadenus Secundinus<br />
4.2) Fadenus Epictetus<br />
Le epigrafi qui analizzate confermano la tesi<br />
<strong>del</strong> Camodeca sull’origine nursina <strong>del</strong>la gens<br />
Fadena.<br />
La gens Fadena forse non doveva essere una<br />
gens molto antica poiché, come si è visto, le epigrafi<br />
che attestano i suoi esponenti si datano a<br />
partire dalla fine <strong>del</strong> I sec. a.C.; inoltre si tratta<br />
di una gens appartenente all’aristocrazia locale, i<br />
cui esponenti principali furono probabilmente<br />
quelli riportati in CIL IX 4550, cioè C. Fadenus<br />
Bassus e suo padre Q. Fadenus, i quali avevano<br />
ricoperto importanti cariche amministrative a<br />
Nursia.<br />
Forse all’interno <strong>del</strong>la gens Fadena, i suddetti<br />
personaggi furono gli unici a ricoprire cariche<br />
importanti, poiché degli altri esponenti di questa<br />
gens attestati nelle epigrafi esaminate sono ricordati<br />
solo i lori nomi senza il cursus honorum,<br />
cosa che ci testimonia che essi probabilmente<br />
non dovettero ricoprire alcuna carica.<br />
Anche se non si tratta di una gens numerosa,<br />
molti però dovettero essere i suoi liberti e quindi<br />
si presuppone che i Fadeni dovettero avere<br />
molti interessi economici nei quali i loro liberti<br />
erano coinvolti.<br />
Inoltre, gli esponenti di questa gens non<br />
dovettero avere rapporti con gentes i cui espo-<br />
VINCENZA IORIO<br />
- 25 -<br />
nenti ricoprirono importanti cariche nel mondo<br />
romano poiché, come si è visto dall’analisi <strong>del</strong>le<br />
epigrafi, questi contrassero matrimoni con esponenti<br />
di gentes poco attestate nell’onomastica<br />
romana, come la gens Seiena 95 , la gens<br />
Petillena 96 , la gens Feronia 97 e la gens<br />
Phelginas 98 , mentre in un solo caso il matrimonio<br />
fu contratto con un personaggio appartenente<br />
ad una gens importante <strong>del</strong> mondo romano<br />
e cioè la gens Iulia 99 .<br />
Dall’Italia centrale, la gens Fadena si spostò<br />
poi in quella settentrionale e probabilmente lì<br />
cambiò leggermente il proprio gentilizio che da<br />
Fadenus diventò Fadienus; si tratta comunque<br />
di un cambiamento linguistico ben attestato nell’onomastica<br />
romana 100 .<br />
Non sappiamo però perché avvenne questo<br />
cambiamento, forse per meglio adattare la pronuncia<br />
<strong>del</strong> loro gentilizio alla fonetica <strong>del</strong>l’idioma<br />
parlato nell’area dove la gens Fadena si trasferì.<br />
Per quanto riguarda poi l’area <strong>del</strong>l’Italia settentrionale<br />
dove la gens Fadena si trasferì, lo<br />
Scarano Ussani ipotizza che sia quella <strong>del</strong>l’Italia<br />
nord-occidentale 101 , dove quindi il suo gentilizio<br />
diventò Fadienus, poiché in questa area sono<br />
attestati esponenti di questa gens databili non<br />
anteriormente all’età augustea.<br />
In particolare si tratta di esponenti attestati a<br />
Placentia 102 , ad Augusta Taurinorum 103 , a San<br />
Massimo di Collegno (TO), un vicus <strong>del</strong>la stessa<br />
Augusta Taurinorum 104 , mentre da Dertona (l’attuale<br />
Tortona), proveniva un esponente di questa<br />
gens, ricordato in un’epigrafe rinvenuta a<br />
Iader, l’attuale Zara 105 .<br />
La gens Fadiena è attestata comunque anche<br />
nell’Italia nord-orientale, ed in particolare nel<br />
Polesine, poiché suoi esponenti sono presenti a<br />
Stienta (RO), quindi sempre nell’area <strong>del</strong> <strong>del</strong>ta<br />
padano 106 .<br />
Dall’Italia nord-occidentale, i Fadieni si<br />
sarebbero quindi spostati verso quella nordorientale<br />
ed in particolare nella zona tra Stienta<br />
e Gambulaga di Portomaggiore (FE), dove è<br />
stato rinvenuto quello che fino ad ora è il loro<br />
maggiore sepolcreto.<br />
Per quanto riguarda l’epoca in cui avvenne il<br />
trasferimento di esponenti <strong>del</strong>la gens Fadena
dall’Italia centrale a quella settentrionale, questa<br />
deve essere posta prima <strong>del</strong>l’età augustea poiché,<br />
come si è detto, le epigrafi rinvenute nell’Italia<br />
settentrionale relative alla gens Fadiena, si datano<br />
non anteriormente a questa età.<br />
Non tutta però la gens Fadena lasciò l’Italia<br />
centrale poiché, come si è visto dall’analisi <strong>del</strong>le<br />
epigrafi, l’attestazione dei suoi esponenti in que-<br />
NOTE<br />
1 Con quest’articolo si dà inizio ad uno studio relativo alle<br />
attestazioni <strong>del</strong>la gens Falena, <strong>del</strong>la gens Fadiena e <strong>del</strong>la<br />
gens Fadia nel mondo romano.<br />
2 SOLIN – SALOMIES 1994, p. 76; CAMODECA 2006, p. 21.<br />
3 Cor<strong>del</strong>la – CRINITI 1988, p. 54.<br />
4 SOLIN – SALOMIES 1994, p. 76.<br />
5 BERTI 2006.<br />
6 Personaggi <strong>del</strong>la gens Fadiena e Fadena non sono infatti<br />
presenti nella prima edizione <strong>del</strong>la Prosopographia Imperii<br />
Romani: l’eventuale presenza dei loro gentilizi avrebbe<br />
dovuto essere riportata nel primo volume, dove sono raccolti<br />
tutti i personaggi compresi tra la lettera A e la lettera<br />
L, ed in particolare dopo Fabulla e prima di L. Fadius<br />
Gallus (cfr. PIR, 1897, p. 54). Tale mancanza si nota anche<br />
nella editio altera <strong>del</strong>la Prosopographia Imperii Romani,<br />
nella quale gli eventuali suddetti gentilizi avrebbe dovuto<br />
essere riportati nel quinto volume, dove sono raccolti tutti<br />
i personaggi compresi tra la lettera D e la lettera F, ed in<br />
particolare dopo Fabullus e prima di Fadilla (cfr. PIR,<br />
1943, p. 115).<br />
7 BERTI 1984, pp. 79-201; 2006, pp. 1-3.<br />
8 CORNELIO CASSAI 1997, pp. 33-65; DESANTIS 1997, pp. 15-31;<br />
BERTI 2006, pp. 3-4.<br />
9 CORNELIO CASSAI 1988, pp. 219-235; BERTI 2006, p. 4.<br />
10 DE DONNO 2006, pp. 49-54; NEGRELLI 2006, pp. 55-68.<br />
11 CAMODECA 2006, pp. 21-28.<br />
12 Plinio il Vecchio (PLIN. N. H., III, 12) riporta che nella<br />
Regio IV abitavano le seguenti etnie: Aequiculani,<br />
Albenses, Frentani, Marrucini, Marsi, Paeligni, Sabini,<br />
Samnites e Vestini.<br />
13 Plinio il Vecchio (PLIN. N. H., III, 12) riporta che nella<br />
Regio V abitavano le seguenti etnie: Piceni e Praetutii.<br />
14 Augusto divise quella che allora era considerata Italia in<br />
10 regiones (cfr. LO CASCIO, 1991, pp. 131-133).<br />
15 Il IX volume <strong>del</strong> Corpus Inscriptionum Latinarum fu<br />
edito a cura di T. MOMMSEN nel 1883.<br />
16 In questa sede si prendono in considerazione solo epigrafi<br />
nelle quali la lettura <strong>del</strong> gentilizio Fadenus è sicura, per<br />
cui non si esamina l’iscrizione CIL IX 3374, proveniente<br />
dalla Regio IV, nella quale sono riportate le lettere FAD che<br />
potrebbero appartenere al gentilizio Fadenus ma potrebbero<br />
appartenere anche al gentilizio Fadius, quest’ultimo ben<br />
SALTERNUM<br />
- 26 -<br />
sta area è databile fino al II sec. d.C.<br />
È auspicabile quindi il prosieguo degli scavi<br />
nel territorio <strong>del</strong> <strong>del</strong>ta <strong>del</strong> Po, poiché questi<br />
potrebbero offrirci ulteriori informazioni su una<br />
gens che dall’Italia centrale si spostò in quella<br />
settentrionale partecipando così a quell’importante<br />
fenomeno che fu la romanizzazione <strong>del</strong>le<br />
zone <strong>del</strong>l’Italia settentrionale.<br />
attestato (cfr. SOLIN – SALOMIES, 1994, p. 76). Per lo stesso<br />
motivo non si esamina l’iscrizione riportata in CORDELLA –<br />
CRINITI 1982, p. 65, nella quale la lettura sicura riguarda<br />
solo le lettere EN precedute da un’altra lettera che potrebbe<br />
essere D e quindi si potrebbe leggere [Fa]den[us]; l’esiguità<br />
<strong>del</strong>le lettere però non permette alcuna certezza.<br />
17 LIV. XVI 11, 11; XXVI, 12; SIL ITAL. VIII 415; STRABO V, 228;<br />
VERG. AEN. VII 714.<br />
18 Per una bibliografia su Foruli, cfr. MAU, s.v. Foruli, c. 55.<br />
19 CALABI LIMENTANI 1985, p. 157.<br />
20 CALABI LIMENTANI 1985, p. 149.<br />
21 SOLIN – SALOMIES 1994, p. 166.<br />
22 CALABI LIMENTANI 1985, p. 156.<br />
23 DIO XLVIII 13; PLIN. N. H. III 12; PLUT. SERT. II; PTOL. III 1,<br />
55; SERV. AD AEN. VII 715; SIL ITAL. VIII 418.<br />
24 Per una bibliografia su Nursia (Norcia), cfr. CIOTTI, s.v.<br />
Norcia, p. 544; Manconi, s.v. Norcia, pp. 42-44; PHILIPP, s.v.<br />
Nursia, cc. 1489-1490.<br />
25 CALABI LIMENTANI 1985, p. 149.<br />
26 Suppl. It. XIII 19.<br />
27 SOLIN – SALOMIES 1994, p. 142.<br />
28 CORDELLA – CRINITI 1982, p. 60; 1988, p. 54.<br />
29 KAJANTO 1982, p. 244.<br />
30 KAJANTO 1982, p. 275.<br />
31 CALABI LIMENTANI 1985, p. 149.<br />
32 CALABI LIMENTANI 1985, p. 202.<br />
33 CALABI LIMENTANI 1985, p. 202.<br />
34 SOLIN 1996, pp. 149-150.<br />
35 KAJANTO 1982, p. 292.<br />
36 SOLIN 1996, p. 656.<br />
37 CIOTTI, s.v. Cascia, pp. 400-401.<br />
38 CORDELLA – CRINITI 1988, p. 134.<br />
39 Cfr. 1a Trascrizione.<br />
40 Cfr. 2a Trascrizione.<br />
41 SORDINI 1893, pp. 381, n. 42<br />
42 CALABI LIMENTANI 1985, p. 149.<br />
43 SOLIN – SALOMIES 1994, p. 311.<br />
44 SOLIN – SALOMIES 1994, pp. 76-77.<br />
45 Come si è detto, è un segno molto usato nell’epigrafia latina<br />
per dividere le parole (cfr. CALABI LIMENTANI, 1985, p. 149).<br />
46 È questo il caso, ad esempio, di gentilizi come<br />
Abrupaternius, Blaesidienus, Cabdollonius, Demincilonius,<br />
Fagifulanius, Gallatronius, Haldauvonius, Instumennius,
Lacutulanius, Maetilianus, Navicularius, Ocbrotsinius,<br />
Pescennedius, Quintilianus, Rucletianius, Sallustucius,<br />
Taemulentius, Venicotenius, ecc…, cfr. SOLIN – SALOMIES<br />
1994, pp. 3, 35, 39, 67, 76, 85, 90, 97, 100, 110, 125, 130,<br />
141, 153, 157, 161, 180, 201.<br />
47 TLL, s.v. aerarium, cc. 1055-1059.<br />
48 È questo il caso, ad esempio, di gentilizi come Abbius,<br />
Babius, Cacius, Damius, Eienus, Fabius, Gabius, Halinus,<br />
Ialius, Labius, Maccus, Nacius, Occius, Pacius, Rabius,<br />
Sabius, Tadius, Ubcius, Vabius ecc…, cfr. SOLIN – SALOMIES<br />
1994, pp. 3, 30, 39, 66, 76, 90, 95, 100, 109, 124, 130, 135,<br />
153, 159, 180, 193, 196.<br />
49 SORDINI 1893, pp. 378-379, n. 35<br />
50 CALABI LIMENTANI 1985, p. 149.<br />
51 Cfr. 1a Trascrizione.<br />
52 Cfr. 2a Trascrizione.<br />
53 Cfr. 1a Trascrizione.<br />
54 Cfr. 2a Trascrizione.<br />
55 Cfr. 1a Trascrizione.<br />
56 Cfr. 2a Trascrizione.<br />
57 LE BOHEC 1990, pp. 20, 47, 59, 66, 104, 132, 203-204, 210,<br />
238; TLL, s.v. cohors, cc. 1549-1559; s.v. praetorianus – a -<br />
um, cc. 1066-1067.<br />
58 LE BOHEC 1990, pp. 44-45, 49-51, 53-55, 57, 119; TLL, s.v.<br />
optio, cc. 823-824.<br />
59 Il sostantivo carcar riportato nell’epigrafe è una variante<br />
di carcer, cfr. TLL, s.v. carcar, cc. 433-438.<br />
60 LE BOHEC 1990, pp. 23, 59, 66, 105, 131; BARTOCCINI, s.v.<br />
Equites singulares, pp. 2144-2153.<br />
61 SOLIN – SALOMIES 1994, p. 199.<br />
62 SOLIN – SALOMIES 1994, p. 98.<br />
63 KAJANTO 1982, p. 250.<br />
64 KAJANTO 1982, p. 292.<br />
65 SOLIN 1996, pp. 149-150.<br />
66 CALABI LIMENTANI 1985, p. 161.<br />
67 PARIBENI, s.v. Semele, pp. 189-190.<br />
68 SOLIN 2003, p. 604.<br />
69 SORDINI 1893, p. 381, n. 46.<br />
70 CALABI LIMENTANI 1985, p. 149.<br />
71 Sulla presenza <strong>del</strong>la formula D. M. nelle iscrizioni sepolcrali,<br />
cfr. CALABI LIMENTANI 1985, p. 202.<br />
72 KAJANTO 1982, p. 273.<br />
73 FRONT. p. 18; PTOL. III 1, 58.<br />
74 LA REGINA, s.v. Teramo, pp. 712-713; PHILIPP, s.v.<br />
Interamnia, cc. 1602-1603; SOMMELLA, s.v. Teramo, pp. 665-<br />
666.<br />
75 CALABI LIMENTANI 1985, p. 149.<br />
76 CALABI LIMENTANI 1985, p. 161.<br />
VINCENZA IORIO<br />
- 27 -<br />
77<br />
SOLIN – SALOMIES 1994, pp. 76-77.<br />
78<br />
SOLIN – SALOMIES 1994, p. 78.<br />
79 CIL IX 5140.<br />
80<br />
AEBISCHER, 1934, pp. 5-23.<br />
81 Cfr. 1a Trascrizione.<br />
82 Cfr. 2a Trascrizione.<br />
83<br />
SOLIN 2003, p. 361.<br />
84<br />
PLIN. N. H. III 13, 111.<br />
85<br />
ALFIERI, s.v. Pausulae, p. 998; BANTI, s.v. Pausulae, cc.<br />
2426-2428.<br />
86<br />
CALABI LIMENTANI 1985, p. 149.<br />
87<br />
KAJANTO 1982, p. 292.<br />
88 TLG, s.v. piktëtoß, c. 1660.<br />
89 CALABI LIMENTANI 1985, p. 156.<br />
90 CALABI LIMENTANI 1985, p. 149.<br />
91 SOLIN, 2003, pp. 274, 1451.<br />
92 SOLIN – SALOMIES 1994, p. 162.<br />
93 SOLIN 2003, pp. 134.<br />
94 CALABI LIMENTANI 1985, p. 148.<br />
95 CIL IX 4408.<br />
96 CIL IX 4550= AE, 1950, n. 89; 1989, n. 204; 1996, n. 529<br />
a-f ; Suppl. It. XIII, n. 19.<br />
97 CIL IX 5104.<br />
98 CIL VI 17647.<br />
99 SORDINI 1893, pp. 378-379, n. 35.<br />
100 È questo il caso, ad esempio, di gentes come la Aberrinia<br />
e la Aberrina, la Babrenia e la Babrena, la Caecinia e la<br />
Caecina, la Dativia e la Dativa, la Eitia e la Eita, la<br />
Faiania e la Faiana, la Gabinia e la Gabina, la Helenia e<br />
la Helena, la Iassia e la Iassa, la Labenia e la Labena, la<br />
Maccia e la Macca, la Naeriania e la Naeriana, la<br />
Octavenia e la Octavena, la Pacenia e la Pacena, la<br />
Quintinia e la Quintina, la Raiania e la Raiana, la Sabellia<br />
e la Sabella, la Tamsinia e la Tamsina, la Ultenia e la<br />
Ultena, la Vagellania e la Vagellana, ecc…, cfr. SOLIN –<br />
SALOMIES 1994, pp. 3, 30, 39, 67, 72, 76, 84, 91, 95, 99, 109,<br />
124, 130, 135, 153, 159, 181, 194, 196.<br />
101 SCARANO USSANI 2006, pp. 29-40. L’area <strong>del</strong>l’Italia nordoccidentale<br />
per la provenienza dei Fadieni <strong>del</strong>la necropoli<br />
di Gambulaga potrebbe essere confermata anche da una<br />
parte <strong>del</strong> vasellame da mensa vitreo rinvenuto nelle tombe<br />
(cfr. MARCHIONI 2006, p. 150).<br />
102 CIL XI 1217.<br />
103 CIL V 7002.<br />
104 CRESCI MARRONE – CULASSO GASTALDI 1984, pp. 170-172.<br />
105 CIL III 2915.<br />
106 CIL V 2469.
SALTERNUM<br />
ABBREVIAZIONI<br />
AE: Année Épigraphique.<br />
EAA: Enciclopedia <strong>del</strong>l’Arte Antica.<br />
RE: Real-Encyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft, PIR 1897: Prosopographia Imperii Romani saec. I.II.III, I,<br />
Berolini, 1897.<br />
PIR 1943: Prosopographia Imperii Romani saec. I.II.III, V, Berolini et Lipsiae, 1943.<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
AEBISCHER 1934: P. AEBISCHER, “Le culte de Feronia et le gentilice<br />
Feronius”, in Revue Belgique de Philologie et d’Histoire,<br />
XIII, 1934, pp. 5-23.<br />
Alfieri, s.v. Pausulae: N. Alfieri, “Pausulae”, in EAA, V, p. 998.<br />
Banti, s.v. Pausulae: L. Banti, “Pausulae”, in RE, XVIII, 4, cc.<br />
2426-2428.<br />
Bartoccini, s.v. Equites Singulares: R. Barroccini, “Equites<br />
Singulares”, in E. De Ruggiero (a cura di), Dizionario<br />
Epigrafico di Antichità Romane, II, Roma, 1922, pp. 2144-<br />
2153.<br />
BERTI 1984: F. Berti, “La necropoli romana di Voghenza”, in<br />
AA. VV. Una necropoli di età romana nel territorio ferrarese,<br />
Ferrara, 1984, pp. 79-201.<br />
BERTI 1997: F. Berti (a cura di), Percorsi di archeologia,<br />
Migliarino, 1997.<br />
BERTI 2006: F. Berti (a cura di), Mors inmatura. I Fadieni e il<br />
loro sepolcro, Firenze, 2006.<br />
BERTI 2006a: F. Berti, “La necropoli <strong>del</strong> Verginese e altre di età<br />
romana nel territorio di Ferrara”, in Berti 2006, pp. 1-8.<br />
Calabi Limentani 1985: I. Calabi Limentani Epigrafia latina,<br />
Milano-Varese, 1985.<br />
Camodeca 2006: G. Camodeca, “Le iscrizioni funerarie dei<br />
Fadieni”, in Berti 2006, pp. 21-30.<br />
Ciotti, s.v. Cascia: U. Ciotti, “Cascia”, in EAA, II, pp. 400-401.<br />
Ciotti, s.v. Norcia: U. Ciotti, “Norcia”, in EAA, V, p. 544.<br />
Cor<strong>del</strong>la – Criniti 1982: R. Cor<strong>del</strong>la – N. Criniti, Iscrizioni latine<br />
di Norcia e dintorni, Spoleto, 1982.<br />
Cor<strong>del</strong>la – Criniti 1988: R. Cor<strong>del</strong>la – N. Criniti, Nuove iscrizioni<br />
latine di Norcia, Cascia e Valnerina, Spoleto, 1988.<br />
Cornelio Cassai 1988: C. Cornelio Cassai, “La necropoli di<br />
Stellata”, in F. Berti – S. Gelichi – G. Steffè (a cura di),<br />
Bondeno ed il suo territorio dalle origini al Rinascimento,<br />
Bologna, 1988, pp. 219-235.<br />
Cornelio Cassai 1997: C. Cornelio Cassai, “1955-1995: la necropoli<br />
romana <strong>del</strong>la Vallona di Ostellato a quarant’anni dal ritrovamento”,<br />
in Berti 1997, pp. 33-65.<br />
Cresci Marrone – Culasso Gastaldi 1984: G. Cresci Marrone –<br />
E. Culasso Gastaldi, “Epigraphica Subalpina (S. Massimo di<br />
Collegno)”, in Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino,<br />
LXXXII, 1984, pp. 166-174.<br />
De Donno 2006: M. De Donno, “Podere Santa Caterina,<br />
Verginee (Gambulaga): da un rinvenimento fortuito a una<br />
prima indagine archeologica. La campagna di scavo 2002”, in<br />
Berti 2006, pp. 49-54.<br />
Desantis 1997: P. Desantis, “Per una carta archeologica <strong>del</strong><br />
territorio di Ostellato: appunti preliminari”, in Berti 1997,<br />
pp. 15-31.<br />
- 28 -<br />
Kajanto 1965: I. Kajanto, The Latin Cognomina, Roma, 1982.<br />
La Regina, s.v. Teramo: A. La Regina, “Teramo”, in EAA, VII,<br />
pp. 712-713.<br />
Le Bohec 1990: Y. Le Bohec, L’Armée Romaine, Paris, 1990.<br />
Lo Cascio 1991: E. Lo Cascio, “Le tecniche <strong>del</strong>l’amministrazione”,<br />
in AA. VV., Storia di Roma, II, Torino, 1991, pp. 116-<br />
192.<br />
Manconi, s.v. Norcia: D. Manconi, “Norcia”, in EAA, Secondo<br />
Supplemento, IV, pp. 42-44.<br />
Marchioni 2006: M. Marchioni, “I vetri”, in Berti 2006, pp.<br />
147-158<br />
Mau, s.v. Foruli: A. Mau, “Foruli”, in RE, VII, 1-2, c. 55.<br />
Negrelli 2006: C. Negrelli, “Lo scavo: campagna 2005”, in<br />
Berti 2006, pp. 55-68.<br />
Paribeni, s.v. Semele: E. Paribeni, “Semele”, in EAA, VII, pp.<br />
189-190.<br />
Philipp, s.v. Interamnia: H. Philipp, “Interamnia”, in RE, IX,<br />
1-2, cc. 1602-1603.<br />
Philipp, s.v. Nursia: H. Philipp, “Nursia”, in RE, XVII, 2, cc.<br />
1489-1490.<br />
Scarano Ussari 2006: V. Scarano Ussari, “I Fadieni nel <strong>del</strong>ta<br />
padano”, in Berti 2006, pp. 29-40.<br />
Solin, 1996: H. Solin, Die Stadtrömischen Sklavennaman.<br />
Ein Namenbuch, Stuttgart, 1996.<br />
Solin 2003: H. Solin, Die Griechischen Personennamen in<br />
Rom. Ein Namenbuch, Berlin – New York, 2003.<br />
Solin – Salomies 1994: H. Solin – O. Salomies, Repertorium<br />
nominum gentilium et cognominum Latinorum, Hildesheim<br />
– Zürich – New York, 1994.<br />
Sommella, s.v. Teramo: P. Sommella, “Teramo”, in EAA,<br />
Secondo Supplemento, V, pp. 665-666.<br />
Sordini 1893: G. Sordini, “Cascia – Notizie intorno alle scoperte<br />
di antichità avvenute in Cascia, ed iscrizioni antiche<br />
trovate in Cascia e nel suo territorio”, Notizie degli Scavi di<br />
Antichità, 1893, pp. 362-383.<br />
TLG, s.v. piktëtoß: Thesaurus Linguae Graecae, s.v. piktëtoß,<br />
III, c. 1660.<br />
TLL, s.v. aerarium: Thesaurus Linguae Latinae, s.v. aerarium,<br />
I, cc. 1055-1059.<br />
TLL, s.v. carcar: Thesaurus Linguae Latinae, s.v. carcar, III,<br />
cc. 433-438.<br />
TLL, s.v. cohors: Thesaurus Linguae Latinae, s.v. cohors, III,<br />
cc. 1549-1559.<br />
TLL, s.v. optio: Thesaurus Linguae Latinae, s.v. optio, IX.II,<br />
cc. 823-824.<br />
TLL, s.v. praetorianus: Thesaurus Linguae Latinae, s.v. praetorianus<br />
– a - um, X.II, cc. 1066-1067.
Quella <strong>del</strong> titolo è un’espressione in cui<br />
anche coloro che hanno una conoscenza non<br />
molto profonda <strong>del</strong>la civiltà e <strong>del</strong>la cultura<br />
romana avvertono tutto l’orgoglio dei cives, i<br />
cittadini, di sentirsi parte di Roma, membri di<br />
quella società di uomini liberi che costituiscono<br />
la res publica. Un’espressione questa che<br />
sostanzialmente ha il significato <strong>del</strong>la convergenza<br />
degli interessi <strong>del</strong>l’intera collettività attraverso<br />
quelli di tutti i singoli individui che la<br />
compongono. Il perseguimento e la difesa di<br />
questi comportano un insieme di diritti e di<br />
doveri commisurati al peso sociale <strong>del</strong>l’individuo.<br />
Colui che dispone di mezzi più consistenti<br />
e che ottiene o può ottenere, per nascita o<br />
per censo, onori più elevati ha per contropartita<br />
doveri maggiori e più onerosi. E’ il principio<br />
definito <strong>del</strong>la “uguaglianza geometrica” differente<br />
da quello <strong>del</strong>la “uguaglianza aritmetica”,<br />
al quale noi siamo abituati, in cui i diritti ed i<br />
doveri sono gli stessi per tutti. Non c’interessa<br />
qui discutere <strong>del</strong>la bontà dei due sistemi e di<br />
quale sia il migliore, sta di fatto che quello<br />
adottato a Roma ha funzionato abbastanza<br />
bene fino ai primi decenni <strong>del</strong> I sec. a.C., finchè<br />
onori ed oneri sono rimasti in sostanziale<br />
equilibrio. Nel momento in cui questo si è alterato,<br />
la situazione si è complicata sempre di<br />
più, al punto che, alla fine <strong>del</strong>la Repubblica e<br />
con l’inizio <strong>del</strong>l’Impero, le cose sono cambiate<br />
completamente. Il cittadino non era più quello<br />
che era stato in precedenza, ma solamente un<br />
suddito, talvolta blandito e viziato, ma senza<br />
più alcun peso effettivo nella vita pubblica.<br />
Tuttavia i privilegi fondamentali <strong>del</strong> singolo,<br />
connessi con la cittadinanza, restavano inalterati.<br />
È noto l’episodio di Paolo di Tarso, che,<br />
PIETRO CRIVELLI<br />
Civis Romanus sum<br />
- 29 -<br />
Alessandro Algardi,<br />
Decapitazione di San Paolo.<br />
San Paolo Maggiore - Bologna.<br />
arrestato perché cristiano, stava per essere sottoposto<br />
a tortura: la sua rivendicazione d’appartenenza<br />
alla cittadinanza romana sospese<br />
ogni procedimento contro di lui; fu condotto a<br />
Roma per essere giudicato e qui, ritenuto colpevole,<br />
fu condannato a morte per decapitazione,<br />
come si conveniva ad un cittadino romano.<br />
Così, fu sottratto alle umiliazioni ed ai tormenti<br />
che normalmente in tali circostanze erano<br />
riservati ai non cittadini. La sua affermazione<br />
comportava ciò che giuridicamente si definiva<br />
provocatio ad Cesarem, evoluzione <strong>del</strong>la provocatio<br />
ad populum, ovvero il diritto <strong>del</strong> cittadino<br />
romano di essere giudicato a Roma dal<br />
popolo romano, che in epoca imperiale era<br />
rappresentato dall’Imperatore, e non da altri<br />
magistrati periferici come invece accadeva ai<br />
“peregrini”, a coloro cioè che cittadini romani<br />
non erano.<br />
Durante la Repubblica dunque i cives, che<br />
fossero senatori o no, intervenivano energicamente<br />
nella vita pubblica, naturalmente sempre<br />
in proporzione al loro peso sociale, mentre<br />
sotto l’Impero quasi tutte le facoltà decisionali<br />
erano rimesse all’Imperatore.
Statua di patrizio<br />
(il cosiddetto “Patrizio Barberini”)<br />
che tiene in mano i busti dei suoi<br />
antenati (I secolo a.C.).<br />
Nella Roma repubblicana ogni cittadino, tra<br />
quelli che per la loro posizione nella comunità<br />
potevano aspirarvi, era geloso <strong>del</strong> suo diritto di<br />
seguire il cursus honorum, la carriera <strong>del</strong>le cariche<br />
pubbliche che poteva portarlo fino a quella<br />
più elevata e di maggior prestigio, il consolato.<br />
Lungi dal comportare vantaggi di carattere economico,<br />
l’accesso alle magistrature, almeno in<br />
teoria, rappresentava un onore, ma anche un<br />
onere notevole. La consuetudine, soprattutto<br />
nella tarda Repubblica, imponeva a colui che<br />
era stato eletto di offrire ai concittadini spettacoli<br />
circensi, o d’altro genere, quando non addirittura<br />
la costruzione a proprie spese di edifici<br />
pubblici a vantaggio <strong>del</strong>la città. Molti si impegnavano<br />
in attività simili ancora prima di essere<br />
eletti o di presentare la propria candidatura, allo<br />
scopo di guadagnarsi la benevolenza degli elettori,<br />
tanto forte era il desiderio di raggiungere il<br />
prestigio connesso con le magistrature. A questo<br />
proposito si deve ricordare che Cicerone fece<br />
approvare una legge che introdusse, per coloro<br />
che intendevano presentare la propria candidatura<br />
a qualche funzione statale, il divieto di allestire<br />
giochi circensi nei due anni precedenti la<br />
tornata elettorale. Era un tentativo, <strong>del</strong> resto<br />
facilmente aggirabile, di ridurre l’effetto <strong>del</strong>la<br />
disparità economica fra i concorrenti nella competizione<br />
politica.<br />
SALTERNUM<br />
- 30 -<br />
È importante notare che, sia pure con il<br />
secondo fine di acquisire presso i concittadini<br />
dei meriti da sfruttare in un momento successivo<br />
a scopi politici, la sollecitudine e l’impegno<br />
dei Romani nell’abbellire la città con la costruzione<br />
di edifici, portici, basiliche ed altro erano<br />
molto vivi e ciò accadeva non solo a Roma, ma<br />
anche nelle altre località <strong>del</strong>l’Impero di una<br />
certa importanza. Abbiamo molteplici esempi di<br />
restauri di edifici, o di costruzioni ex novo,<br />
finanziate, nel corso degli anni, da personaggi<br />
<strong>del</strong>le varie città soggette a Roma anche se appartenenti<br />
a ceti di non grande rilievo. Se così non<br />
fosse stato non si vedrebbero tante imponenti<br />
rovine ancora presenti ovunque siano arrivate le<br />
aquile romane.<br />
Come si vede, l’esborso di denaro per candidarsi<br />
alle più alte cariche <strong>del</strong>lo stato era particolarmente<br />
oneroso. Infatti, se osserviamo i nomi<br />
dei consoli che si sono succeduti nel periodo<br />
repubblicano, fino alla fine <strong>del</strong> II sec. a.C, vediamo<br />
che appartengono quasi tutti ad un numero<br />
ristretto di gentes, una quindicina. Il seguito di<br />
popolarità e di clientele era conseguenza <strong>del</strong><br />
potere economico <strong>del</strong>la famiglia cui apparteneva<br />
l’aspirante magistrato.<br />
L’impegno richiesto dalle funzioni pubbliche<br />
era gravoso. Marco Terenzio Varrone, reatino,<br />
(116-27 a.C.), personaggio eminente per erudizione,<br />
nella sua opera De Lingua Latina (6.46)<br />
scrive testualmente: curare a cura dictum. Cura<br />
quod cor urat. (Curare si dice da cura. Cura perché<br />
brucia il cuore). Da questo stesso etimo fa<br />
derivare anche Curia. È noto che le etimologie<br />
varroniane sono piuttosto bizzarre e fantasiose e<br />
perciò il più <strong>del</strong>le volte non possono essere<br />
prese per buone, nondimeno la spiegazione fornita<br />
dallo studioso latino, pure se errata, è idonea<br />
a darci un’idea <strong>del</strong>l’impegno, anche emotivo,<br />
che i cives mettevano nello svolgimento dei<br />
compiti connessi con l’attività di magistrato e<br />
con le responsabilità che ne derivavano e quali<br />
preoccupazioni avessero di ben figurare di fronte<br />
ai concittadini. Lo stesso concetto, con le stesse<br />
parole, è ripetuto, più di due secoli dopo, da<br />
Sesto Pompeo Festo, che evidentemente segue<br />
Varrone e ne ritiene valida la spiegazione, nel<br />
suo lavoro De Verborum Significatu. Non posso-
no esservi dubbi perciò che gli incarichi di governo<br />
fossero molto gravosi e che gli onori avevano<br />
un prezzo molto alto, da pagarsi in termini di attività,<br />
di apprensione e di sforzo costante.<br />
Sarà proprio il peso rilevante <strong>del</strong>le prestazioni<br />
gravanti sugli eletti, unito alla perdita di potere<br />
e conseguentemente d’autorevolezza, che in<br />
epoca imperiale finirà per disamorare sempre di<br />
più strati progressivamente più vasti <strong>del</strong>la popolazione<br />
dall’impegnarsi nel cursus honorum.<br />
Divenire tribuno, console o altro significava<br />
solamente impegnare il proprio nome in una<br />
carica che era diventata priva di valore effettivo,<br />
mentre le spese connesse con la funzione o,<br />
meglio, con la non funzione, restavano sempre<br />
molto rilevanti. In proposito vale la pena ricordare<br />
l’acuta osservazione che fece, intorno al<br />
1780, lo storico inglese Edward Gibbon: “Il consolato<br />
in età repubblicana fu una realtà, con<br />
Augusto divenne un’ombra, con Diocleziano un<br />
nome”. Ma fino a quando le cariche pubbliche<br />
avevano avuto un vero valore, la gara si faceva<br />
accanita e i concorrenti si adoperavano in ogni<br />
modo per ottenere la vittoria, ricorrendo spesso<br />
anche a mezzi che stavano ai limiti <strong>del</strong>la legalità,<br />
e qualche volta anche superandola, tanto era<br />
il desiderio di emergere e di ottenere quegli<br />
onori e quella considerazione che il popolo<br />
romano riconosceva ai suoi magistrati.<br />
È stata ventilata l’ipotesi, forse non <strong>del</strong> tutto<br />
peregrina, che il Senato, al fine di distruggere<br />
Cesare, comprendendo di non averne la forza<br />
né il coraggio, gli abbia consapevolmente riversato<br />
addosso una montagna d’onori al fine di stimolare<br />
contro di lui il sospetto e soprattutto la<br />
gelosia e l’invidia di tutti coloro che, a torto o a<br />
ragione, ritenevano di esserne stati defraudati.<br />
Una maligna, sottile astuzia che non poteva<br />
suscitare il risentimento <strong>del</strong> destinatario di siffatte<br />
attenzioni, ma che doveva inesorabilmente<br />
portarlo alla rovina 1 .<br />
A ben vedere, gelosie e sospetti si accompagnano<br />
sistematicamente nelle società connotate<br />
da un forte sentimento di libertà a quelle personalità<br />
che, pur meritevoli, emergono eccessivamente<br />
al di sopra <strong>del</strong>la massa dei concittadini; in<br />
altri termini: va bene buoni e bravi, ma non<br />
troppo.<br />
PIETRO CRIVELLI<br />
- 31 -<br />
Rilievo che raffigura la cavalcata dei giovani (dall’Austria).<br />
Busto d’argento<br />
raffigurante un<br />
patrizio (da<br />
Vaison-Francia).<br />
Prima di Cesare aveva fatto l’esperienza di<br />
questi sentimenti Scipione l’Africano, costretto a<br />
lasciare Roma in un volontario semiesilio al fine<br />
di placare la tempesta che Catone, forse per<br />
dispetto, si era caparbiamente impegnato ad<br />
addensare su di lui e su suo fratello Lucio, ventilando<br />
il dubbio che avessero tenuto per sé una<br />
parte <strong>del</strong> denaro riscosso come contributo risarcitorio<br />
da Antioco. Catone riuscì, in ogni modo, ad<br />
ottenere che Lucio Scipione Asiatico, fratello<br />
<strong>del</strong>l’Africano, che nel frattempo era deceduto<br />
(183 a.C.), fosse radiato dalla lista dei cavalieri. Il<br />
livore nutrito da Catone non doveva essere sfuggito<br />
ai contemporanei e il ricordo di quegli avvenimenti<br />
persistette nel tempo. Infatti, circa tre<br />
secoli dopo, Plutarco, nella vita di M. Catone,<br />
commentava: “Sembrò averlo fatto in spregio alla<br />
memoria di Scipione Africano”.
Un console sul carro circondato da quattro cavalieri; pannello dalla<br />
basilica di Giunio Basso (331 d.C. ca.) Roma.<br />
Eppure l’integrità di colui che aveva salvato<br />
Roma, sconfiggendo Annibale a Zama, era ben<br />
al di sopra di ogni sospetto. Riflettendo su questo<br />
comportamento che getta un’ombra poco<br />
edificante sulla figura di M. Porcio Catone, si è<br />
detto: “Forse obbediva ad un senso vivo <strong>del</strong><br />
dovere, ma non è escluso che tale nobile sentimento<br />
<strong>del</strong>l’homo novus fosse esasperato dalla<br />
gelosia contadinesca verso chi apparteneva ad<br />
illustri casate patrizie.” 2 . Ma ancora in precedenza<br />
era accaduto a Furio Camillo, colui che aveva<br />
conquistato Veio, di essere accusato di aver<br />
tenuto per sé una parte <strong>del</strong> bottino. Tutto questo<br />
non avveniva solo a Roma; pensiamo a ciò<br />
che accadde a coloro che ebbero il merito di salvare<br />
la Grecia dall’invasore persiano: Temistocle<br />
fu costretto a riparare in esilio proprio presso<br />
quei Persiani che aveva così aspramente combattuto<br />
e vinto. Pausania, il generale spartano<br />
che aveva sbaragliato e distrutto l’esercito nemico<br />
a Platea, fu accusato di tradimento e fatto<br />
morire. Gli scavi archeologici ci hanno restituito<br />
degli óstraka (frammenti di coccio) recanti<br />
graffito il nome di Aristide, esiliato con quella<br />
procedura che è ricordata appunto con il nome<br />
di “ostracismo”, perché aveva il “difetto” di essere<br />
troppo giusto e onesto. Certamente la libertà<br />
è bella, ma anche pericolosa; Leonida in<br />
fondo poteva dirsi fortunato per non avere<br />
dovuto fare l’esperienza <strong>del</strong>l’ingratitudine dei<br />
concittadini. Nil de mortuis nisi bonum (dei<br />
morti si dice solo bene).<br />
Parrebbe che a Roma, così come ad Atene, si<br />
sia attuato uno sforzo collettivo e costante per<br />
SALTERNUM<br />
- 32 -<br />
impedire che qualcuno arrivasse ad emergere<br />
eccessivamente sopra la massa degli altri. Ed<br />
invero quando ciò accadde fu la fine <strong>del</strong>la<br />
Repubblica. Non è un caso che il grande storico<br />
<strong>del</strong>la Roma antica, Teodoro Mommsen, ponga la<br />
nascita <strong>del</strong>la monarchia non dopo le battaglie di<br />
Farsalo e di Tapso, “…essa può datare la sua esistenza<br />
dal momento in cui Pompeo e Cesare,<br />
uniti, fondarono il potere autocratico e rovesciarono<br />
la costituzione aristocratica fino allora<br />
vigente” 3 .<br />
La funzione senatoriale era, normalmente, a<br />
vita, fatta salva la decadenza per motivi molto<br />
gravi, ma quelle di console, di edile e tutte le<br />
altre erano di durata annuale; addirittura semestrale<br />
quella, molto rara, di dittatore. Scopo evidente<br />
di questi limiti temporali era di evitare che<br />
un magistrato, con un maggior tempo a disposizione,<br />
potesse crearsi un seguito o addirittura un<br />
potere personale che si estendesse più in là<br />
<strong>del</strong>la durata <strong>del</strong>la magistratura.<br />
Tutto ciò era possibile ovviamente perché<br />
alle origini <strong>del</strong>lo stato repubblicano non si<br />
avvertiva ancora l’esigenza di sviluppare politiche<br />
di così ampio respiro da richiedere dei<br />
tempi che andassero al di là di quelli necessari<br />
all’ordinaria amministrazione. Per la continuità<br />
di un eventuale disegno politico era bastevole<br />
l’azione <strong>del</strong> Senato e l’appartenenza a quel consesso<br />
era a vita.<br />
Essere cittadini romani era la condizione<br />
essenziale per rivestire le cariche pubbliche, per<br />
i sacerdozi maggiori, per servire nell’esercito<br />
anche come semplice legionario. In nome <strong>del</strong>l’uguaglianza<br />
geometrica a cui si è accennato in<br />
precedenza, per queste incombenze si partiva<br />
dall’alto: alle magistrature ed ai sacerdozi più<br />
prestigiosi si accedeva partendo dagli strati<br />
sociali più elevati, ma così si procedeva anche<br />
per la chiamata alle armi. Teoricamente tutti<br />
coloro che godevano <strong>del</strong>la cittadinanza potevano<br />
esercitare il diritto e il dovere di essere soldati,<br />
di essere eletti alle cariche pubbliche o<br />
essere elettori, ma anche in questo caso vigeva<br />
il principio che la precedenza, nel bene e nel<br />
male, doveva essere riservata a coloro che avevano<br />
più da perdere nell’eventualità che non<br />
tutto andasse per il meglio; in fondo erano quel-
li che, sia per dignitas, sia per interesse economico,<br />
erano i più motivati ad impegnarsi al massimo<br />
<strong>del</strong>le loro energie per raggiungere un risultato<br />
che poi sarebbe stato utile all’intera collettività.<br />
Che il peso per il buon funzionamento <strong>del</strong>lo<br />
stato gravasse soprattutto sulle classi più abbienti<br />
è dimostrato dal fatto che, nel corso <strong>del</strong>la<br />
guerra annibalica, fu chiesto ai cittadini di sottoscrivere<br />
un prestito alla res publica, rimborsabile<br />
in tre rate, per fare fronte alle spese belliche.<br />
Nel 204 a.C. il Senato <strong>del</strong>iberò il pagamento<br />
<strong>del</strong>la prima rata <strong>del</strong> prestito. La seconda fu restituita<br />
due anni dopo, ma la terza, che doveva<br />
essere resa dopo cinque anni dalla prima, a<br />
causa <strong>del</strong>la guerra macedonica, scoppiata nel<br />
frattempo, fu liquidata solo nel 196, dopo la battaglia<br />
di Cinocefale. È evidente che l’onere economico<br />
ricadeva sulle classi più abbienti, che<br />
erano anche quelle che avevano potuto sostenere<br />
le finanze statali.<br />
Bisognava avere un patrimonio valutabile<br />
almeno ad un milione di sesterzi per accedere al<br />
Senato e ad almeno quattrocentomila per essere<br />
iscritti nella classe dei Cavalieri; questo era certamente<br />
un privilegio per coloro che potevano<br />
vantare una sostanza cospicua. Per contro,<br />
quando i consoli procedevano alla leva per formare<br />
le legioni che dovevano affrontare qualche<br />
nemico, la scelta degli uomini da arruolare per<br />
la guerra iniziava dai più facoltosi, perciò le classi<br />
meno abbienti erano quasi sempre escluse dai<br />
pericoli <strong>del</strong>la milizia se non in casi assolutamente<br />
eccezionali, così come accadde durante la<br />
guerra annibalica. In quella circostanza vennero<br />
perfino riscattati a spese <strong>del</strong>lo Stato circa ottomila<br />
schiavi che dichiararono la propria disponibilità<br />
ad arruolarsi in difesa di Roma. Ma si trattava<br />
di una situazione di particolare emergenza,<br />
che proprio per questo è rimasta memorabile.<br />
Fu Caio Mario il primo ad accogliere stabilmente<br />
nell’esercito i capite censi a preferenza<br />
<strong>del</strong>le altre classi sociali, con il risultato che quei<br />
soldati, altrimenti nullatenenti, combattevano<br />
più per i loro interessi, il bottino e il soldo, che<br />
per quelli <strong>del</strong>la collettività. In tal modo le legioni<br />
furono da allora in poi legate soprattutto ai<br />
loro generali piuttosto che alla res publica.<br />
PIETRO CRIVELLI<br />
- 33 -<br />
L’area di più<br />
arcaica<br />
occupazione <strong>del</strong><br />
Foro, fra la Curia e<br />
le pendici <strong>del</strong><br />
Campidoglio,<br />
prende il nome di<br />
comitium: qui<br />
avevano luogo le<br />
assemblee<br />
cittadine.<br />
L’innovazione mariana dunque risolse dal solo<br />
punto di vista numerico il problema di avere<br />
disponibile per la milizia un numero maggiore<br />
di cittadini, ma ebbe conseguenze devastanti<br />
per lo Stato, perché fu all’origine <strong>del</strong>le guerre<br />
civili e degli scontri tra generali che portarono<br />
alla fine <strong>del</strong>la Repubblica. E gli effetti negativi<br />
continuarono durante l’Impero, crescendo in<br />
modo esponenziale quando gli arruolamenti<br />
compresero sempre meno i cittadini romani e<br />
sempre più uomini dalle origini più disparate,<br />
con la conseguenza di portare al principato elementi<br />
discussi come Eliogabalo o Massimino il<br />
Trace, voluti non dal popolo romano ma dai soldati,<br />
allettati solo dai vantaggi economici che<br />
dall’uno o dall’altro aspirante all’imperio erano<br />
stati promessi. Naturalmente quei soldati, quasi<br />
totalmente privi di ogni senso <strong>del</strong> dovere e di<br />
fe<strong>del</strong>tà alla res publica, non si facevano scrupolo<br />
di massacrare ferocemente quegli stessi personaggi<br />
che avevano precedentemente elevato<br />
alla dignità imperiale qualora non avessero soddisfatto<br />
le aspettative.<br />
È possibile che Caio Mario, uomo di origini<br />
provinciali e assolutamente non nobili, con la<br />
sua innovazione abbia voluto scardinare a proprio<br />
vantaggio la prevalenza <strong>del</strong>la nobiltà nell’organizzazione<br />
statale. Molto difficilmente<br />
sarebbe riuscito in altro modo a divenire console<br />
per ben sette volte, pure se le sue qualità di<br />
generale erano fuori <strong>del</strong> comune.<br />
Anche quando si procedeva all’elezione dei<br />
magistrati cittadini ci si regolava in un modo<br />
molto simile a quello che si adottava per la leva<br />
militare prima <strong>del</strong>la riforma mariana.<br />
La società romana, pur non disponendo di un<br />
esercito permanente, almeno durante il periodo<br />
repubblicano, era strutturata militarmente<br />
appunto perché ogni cittadino era un potenzia-
Dipinto ottocentesco riferito a un episodio verificatosi in senato nel<br />
279 a.C., che vide l’anziano Appio Claudio, ormai cieco, esortare i<br />
senatori a respingere le offerte di pace <strong>del</strong> re epirota Pirro.<br />
le soldato. Tutti i cittadini erano divisi in tribù<br />
che dalle tre originarie (Ramnes, Titii, Luceri)<br />
erano salite nel corso degli anni a trentacinque<br />
di cui quattro urbanae e trentuno rusticae. In<br />
questa veste partecipavano ai Comitia Tributa<br />
per eleggere i magistrati minori (edili, questori,<br />
tribuni militari) ma anche per votare le leggi<br />
proposte dai tribuni (una magistratura che deriva<br />
il proprio nome da tribus). Accanto e al di<br />
sopra di questi esistevano i Comitia centuriata,<br />
di chiara derivazione militare che erano l’assemblea<br />
più importante <strong>del</strong>lo stato romano e che<br />
Cicerone definisce comitiatus maximus.<br />
Quando dovevano riunirsi, la convocazione era<br />
bandita nel Foro, ma le operazioni di voto avvenivano<br />
al di fuori <strong>del</strong> Pomerium. Appare qui<br />
evidente l’origine militare <strong>del</strong>l’istituzione, perché<br />
l’accesso all’interno <strong>del</strong> pomerio (il sacro perimetro<br />
cittadino) era interdetto ai militari in attività<br />
di servizio. Inoltre, in quella circostanza<br />
doveva esporsi sulla rocca <strong>del</strong> Campidoglio il<br />
signum,cioè la bandiera di colore rosso indicante<br />
che le legioni erano in armi. Le centurie furono<br />
stabilite in numero di centonovantatre, di cui<br />
le prime diciotto erano di equites: queste comprendevano<br />
coloro che appartenevano al vecchio<br />
patriziato che nell’esercito militavano col<br />
cavallo fornito dallo stato, equites equo publico,<br />
integrati da plebei che disponessero di un censo<br />
almeno quattro volte superiore a quello occorrente<br />
per essere iscritti nella categoria dei combattenti<br />
a piedi, pedites. Le altre centurie comprendevano<br />
i rimanenti cittadini, suddivisi in<br />
cinque classi patrimoniali che arrivavano fino ai<br />
capite censi, cioè ai liberi privi di patrimonio<br />
censiti solo come individui. Naturalmente le<br />
varie fasi <strong>del</strong>la cerimonia erano accompagnate<br />
SALTERNUM<br />
- 34 -<br />
da riti religiosi che i Romani osservavano scrupolosamente.<br />
Il cerimoniale era anche certamente<br />
differente in base ai motivi di convocazione<br />
dei comitia, se di carattere legislativo,<br />
elettorale o giudiziario. La mentalità spiccatamente<br />
razionale dei Romani li portava a cogliere<br />
quelle differenze, anche sottili, che ad altri<br />
sarebbero sembrate irrilevanti.<br />
La tradizione vuole che i Comitia centuriata<br />
siano stati introdotti nella struttura statale di<br />
Roma da Servio Tullio intorno alla metà <strong>del</strong> VI<br />
secolo a.C. Ciò è possibile, ma naturalmente<br />
non certo. Cicerone, Livio e Dionigi di<br />
Alicarnasso narrano che quel re, quando creò le<br />
centurie, stabilì anche l’ordine in cui dovevano<br />
esprimere il loro voto allorché erano consultate.<br />
Le assemblee di cittadini, e per i Comitia centuriata<br />
e per i Comitia tributa, non potevano<br />
mai convocarsi autonomamente né si riunivano<br />
a date fisse, ma solo quando erano chiamate a<br />
<strong>del</strong>iberare, con un sì o con un no, su un preciso<br />
quesito che doveva essere posto da un magistrato<br />
giuridicamente abilitato a proporlo. Il tutto<br />
era regolato da norme di legge aventi un’origine<br />
sacra che erano intese ad evitare qualsiasi forma<br />
di abuso. Al cittadino non era consentito di decidere<br />
l’argomento su cui <strong>del</strong>iberare; egli poteva<br />
solo accettare o respingere la proposta <strong>del</strong> magistrato<br />
al quale la legge attribuiva la competenza<br />
sulla materia da esaminare.<br />
In ogni caso si votava per tribù o per centurie,<br />
iniziando da quelle che comprendevano le<br />
classi più abbienti per scendere via via a quelle<br />
più povere. Le operazioni di voto s’interrompevano<br />
allorché si era raggiunta la maggioranza<br />
<strong>del</strong>le tribù o <strong>del</strong>le centurie in un senso o in<br />
quello opposto. Cicerone, nella Pro Flacco,<br />
difende il sistema romano di votazione, rilevando<br />
la decadenza <strong>del</strong>la Grecia, che aveva pure<br />
avuto un passato glorioso, causata a suo giudizio,<br />
da «… un solo vizio: la libertà illimitata e la<br />
licenza <strong>del</strong>le sue assemblee. Uomini incompetenti<br />
in tutto, rozzi ed ignoranti, si adunavano nel<br />
teatro, decidevano inutili guerre, assegnavano il<br />
governo a uomini faziosi ed esiliavano i cittadini<br />
che avevano servito al meglio la patria».<br />
È chiaro che in questo sistema il censo aveva<br />
un’importanza fondamentale, perciò ogni cin
que anni avveniva il censimento: tutti coloro che<br />
godevano <strong>del</strong>la cittadinanza dovevano presentarsi<br />
a Roma per dichiarare ufficialmente le loro<br />
sostanze, la composizione <strong>del</strong>la familia (moglie,<br />
figli, servi) ed ogni altra notizia utile alla loro<br />
esatta collocazione nel quadro generale <strong>del</strong><br />
popolo romano. Nel caso che qualcuno non lo<br />
facesse o che fornisse una dichiarazione mendace<br />
avrebbe corso il rischio di vedersi confiscare<br />
tutti i beni e di essere venduto come schiavo. La<br />
gravità <strong>del</strong>la pena per i non adempienti a quel<br />
dovere è la prova <strong>del</strong>la rilevanza che i Romani<br />
davano alla conoscenza ufficiale di come era<br />
strutturata la loro società.<br />
Le operazioni <strong>del</strong> censimento erano presiedute<br />
e dirette da due magistrati appositamente<br />
eletti, scelti fra coloro che già avevano precedentemente<br />
fornito prova di serietà e di probità<br />
assolute. Quando dovevano valutare i meno<br />
abbienti, in genere si limitavano alla registrazione<br />
dei beni posseduti, ma quando esaminavano<br />
coloro che per la posizione economica erano<br />
anche automaticamente possibili candidati alle<br />
magistrature più elevate l’esame si faceva più<br />
puntiglioso e si estendeva non più alla sola persona<br />
ed alla sua famiglia, ma anche al suo modo<br />
di essere nella vita privata o addirittura familiare.<br />
Un uomo dal comportamento non irreprensibile<br />
o poco oculato nella conduzione degli<br />
affari, tollerante di una condotta sconveniente<br />
dei figli o <strong>del</strong>la moglie, poteva essere declassato<br />
nella scala sociale in modo irreparabile.<br />
Uno di questi magistrati valutatori, che è<br />
rimasto famoso, fu proprio Marco Porcio<br />
Catone, detto appunto “il censore”, lo stesso che<br />
abbiamo visto accanirsi contro gli Scipioni, fustigatore<br />
dei costumi licenziosi che si andavano<br />
diffondendo. Egli non accettava neppure che i<br />
Romani si dedicassero allo studio <strong>del</strong> greco che,<br />
a suo modo di vedere, era destinato a corrompere<br />
i sacri costumi degli antenati.<br />
Catone ostentò sempre, mentendo, di ignorare<br />
la lingua greca, che invece conosceva benissimo,<br />
e si accanì contro gli Scipioni che coltivavano<br />
con passione la cultura ellenica.<br />
È evidente che lo status di cittadino comportava<br />
oneri anche gravosi, nondimeno era una<br />
condizione ambita al punto che i socii italici, che<br />
PIETRO CRIVELLI<br />
- 35 -<br />
Ricostruzione<br />
di un littore di età<br />
repubblicana Roma.<br />
Museo <strong>del</strong>la Civiltà<br />
Romana.<br />
erano stati alleati fe<strong>del</strong>i di Roma durante la guerra<br />
annibalica e che successivamente avevano<br />
fornito armati per le truppe ausiliarie nel corso<br />
<strong>del</strong>le varie guerre, presero nuovamente le armi<br />
per rivendicare quel riconoscimento che stimavano<br />
di avere ben meritato con il loro precedente<br />
comportamento. Il conflitto, ricordato come la<br />
Guerra Sociale, iniziato nel 91 a.C., si concluse<br />
nell’89 a.C. con la sconfitta definitiva degli insorti<br />
per mano di Lucio Cornelio Silla, che aveva<br />
ricondotto all’ordine quasi tutta la Campania e<br />
che quindi vi fece dedurre dal nipote Publio<br />
alcune colonie, fra queste una a Pompei, dei<br />
suoi veterani. Fu un provvedimento non eccessivamente<br />
punitivo, però ci si rese conto che la<br />
concessione <strong>del</strong>la cittadinanza era una misura<br />
non più procrastinabile, perciò nello stesso<br />
anno 89 a. C. fu accordato a tutti gli italici liberi,<br />
con solo qualche eccezione, quel riconoscimento<br />
che appena due anni prima aveva porta-
Ricostruzione<br />
di un cavaliere<br />
romano <strong>del</strong> I<br />
sec. d.C.<br />
Roma,<br />
Museo<br />
<strong>del</strong>la Civiltà<br />
Romana.<br />
to all’assassinio <strong>del</strong> tribuno Livio Druso, che per<br />
primo aveva osato proporlo. Da questi eventi<br />
emerge chiaramente quanto la cittadinanza fosse<br />
importante sia per chi già la possedeva, sia per<br />
chi ambiva ad ottenerla.<br />
I Romani erano discretamente generosi a<br />
concedere questo stato di privilegio a singoli<br />
individui: lo dimostra il fatto che un gran numero<br />
di ex schiavi, i liberti, erano accolti senza<br />
troppi problemi tra i cives, anche se con qualche<br />
limitazione, che però scompariva per i loro figli;<br />
al contrario erano molto restii a concederlo ad<br />
intere comunità. Evidentemente ciò accadeva<br />
perché il singolo individuo veniva ad essere<br />
come diluito nell’insieme <strong>del</strong>la popolazione,<br />
mentre coloro che appartenevano già ad una<br />
comunità omogenea erano adusi a proprie leggi<br />
e consuetudini e per questo, se accolti collettivamente,<br />
potevano in qualche modo inquinare<br />
quelle romane. Si deve anche osservare che lo<br />
schiavo liberato, il “liberto”, era ammesso a<br />
godere dei diritti civili, ma per poterne usufruire<br />
doveva entrare a fare parte di una familia,<br />
che era quella <strong>del</strong>l’ex padrone, prenderne il<br />
SALTERNUM<br />
- 36 -<br />
nome ed adottarne i culti familiari. In questo<br />
modo il padrone, divenuto patrono, veniva ad<br />
essere in qualche modo garante <strong>del</strong> successivo<br />
comportamento <strong>del</strong> suo ex schiavo.<br />
Sarà Cesare che, al suo ritorno a Roma dopo<br />
la vittoria su Pompeo ed i pompeiani, supererà<br />
quella diffidenza verso gli stranieri e concederà<br />
la cittadinanza ad intere regioni, così alla Gallia<br />
Cisalpina, alla città di Gades e all’intera legione<br />
V Alaudae, reclutata totalmente fra i Galli transalpini;<br />
ma non bisogna dimenticare che Cesare<br />
aveva bisogno di crearsi un seguito personale<br />
per consolidare anche politicamente la sua vittoria.<br />
Bisognerà attendere il 212 d.C. per vedere<br />
l’imperatore Caracalla emanare una “costituzione”<br />
che, con poche eccezioni, estendeva la cittadinanza<br />
a tutti gli uomini liberi <strong>del</strong>l’Impero.<br />
Poiché fra gli oneri che gravavano sul cittadino<br />
c’era anche quello di pagare le tasse di successione,<br />
gli avversari di Caracalla sostennero che<br />
lo scopo recondito <strong>del</strong>la sua costituzione era di<br />
assicurare a Roma i proventi di quell’imposta.<br />
Fra i vantaggi di essere cittadini c’era senza<br />
dubbio quello di potere usufruire <strong>del</strong>le distribuzioni<br />
di grano a prezzo calmierato o anche a<br />
titolo gratuito. Questa forma di elargizione, nata<br />
in un primo momento per alleviare i disagi che<br />
sorgevano in periodi di carestia, finì per divenire<br />
costante, con notevole gravame economico<br />
per le finanze statali. Da provvedimento episodico<br />
quale era stato in precedenza, fu con Gaio<br />
Gracco (lex Sempronia frumentaria, 123 a.C.)<br />
che si giunse a renderlo permanente, anche se<br />
le resistenze ad una misura chiaramente demagogica<br />
furono molte. Cicerone (Tusc., III, 48)<br />
racconta che Lucio Calpurnio Pisone si era battuto<br />
aspramente contro l’approvazione <strong>del</strong>la<br />
legge, ma che quando si giunse alla distribuzione<br />
<strong>del</strong> grano si presentò con gli altri per prelevare<br />
la sua quota. Gaio Gracco vedendolo tra la<br />
folla gli chiese innanzi a tutti, con evidente<br />
intento ironico, perché rivendicasse i benefici di<br />
una legge che aveva osteggiato e quegli rispose:<br />
«Avrei preferito, Gracco, che tu non distribuissi i<br />
miei beni, ma se lo fai voglio la mia parte».<br />
La riottosità dei Romani a concedere la cittadinanza<br />
ad intere popolazioni nel loro comples
so era giustificata da alcuni episodi che ci illuminano<br />
su quanto talvolta potessero essere inaffidabili<br />
coloro che bussavano alla porta <strong>del</strong>l’Urbe.<br />
Nel 216 a.C. dopo la disastrosa sconfitta dei<br />
Romani a Canne, mentre a Roma si diffondeva<br />
la preoccupazione, i Capuani sollecitarono la<br />
cittadinanza pretendendo anche che uno dei<br />
due consoli dovesse essere campano, ma contemporaneamente,<br />
di nascosto, si preparavano<br />
alla sedizione ed all’alleanza con Annibale. Tito<br />
Livio (XXIII, 6,6-7) ci racconta che essi inviarono<br />
un’ambasceria a Roma con siffatte proposte,<br />
affermando con una certa arroganza che questo<br />
era il prezzo da loro richiesto per l’aiuto che<br />
avrebbero fornito. Era chiaro che si erano convinti<br />
che i Romani in quella circostanza terribile<br />
avrebbero accettato qualsiasi condizione, anche<br />
la più gravosa che fosse stata loro offerta, pur di<br />
uscire da una situazione a dir poco drammatica.<br />
Ma non avevano capito nulla <strong>del</strong>l’orgoglio e <strong>del</strong>l’animo<br />
romano. Il tentativo di ricatto fu respinto<br />
con sdegno e gli ambasciatori furono letteralmente<br />
cacciati dal Senato. Qualche anno dopo,<br />
il 211 a.C. il pretore Claudio Nerone, lo stesso<br />
che al Metauro aveva vinto e ucciso Asdrubale,<br />
fratello di Annibale, conquistò Capua che nel<br />
frattempo si era data al Cartaginese ed i Capuani<br />
pagarono a caro prezzo il loro precedente comportamento.<br />
Una via di mezzo era già stata trovata con la<br />
concessione ad alcune città di una forma ridotta<br />
di cittadinanza, la civitas sine suffragio, una<br />
soluzione che escludeva quei cittadini dal diritto<br />
di voto, per cui in realtà con questo accorgimento<br />
quelle comunità erano poste in uno stato<br />
di dipendenza, non avendo alcuna voce in capitolo.<br />
Il primo caso fu quello <strong>del</strong>l’etrusca Caere,<br />
che ebbe questo riconoscimento come ringraziamento<br />
per l’aiuto fornito al tempo <strong>del</strong>l’invasione<br />
dei Galli nel 390 a.C. I cives sine suffragio tuttavia<br />
godevano degli stessi vantaggi di tutti gli altri<br />
e di una uguale protezione da parte <strong>del</strong>la legge;<br />
erano solamente esclusi dall’elettorato attivo e<br />
passivo per quanto concerneva le cariche <strong>del</strong>la<br />
res publica.<br />
Non deve sembrare eccessiva la resistenza<br />
dei Romani ad accordare la cittadinanza ad intere<br />
comunità di estranei: era ispirata dall’esigen-<br />
PIETRO CRIVELLI<br />
- 37 -<br />
za di difendere la propria identità politica, sociale<br />
e religiosa da forze che potevano alterarla.<br />
Infatti, come si è detto, si mostrarono sempre<br />
piuttosto liberali nel concederla a singoli individui.<br />
In fondo nel mondo greco la concessione<br />
<strong>del</strong>la cittadinanza era ancora più difficile.<br />
Accantoniamo pure il caso di Sparta per la sua<br />
particolarissima costituzione, ma Atene non era<br />
certamente più generosa in questo senso e l’identica<br />
cosa si può dire <strong>del</strong>le altre città greche,<br />
tutte gelose custodi di se stesse. Va anzi ricordato<br />
che una legge ateniese <strong>del</strong> 451/450 a.C., forse<br />
ispirata da Pericle, stabilì che non potevano<br />
essere cittadini di Atene coloro che non fossero<br />
figli di genitori già entrambi cittadini. Come<br />
curiosità aggiungeremo che di questa legge fu<br />
vittima lo stesso Pericle, perché il figlio che lui<br />
ebbe da Aspasia, donna di Mileto, poté ottenere<br />
la cittadinanza solo in virtù di una speciale <strong>del</strong>ibera<br />
popolare dopo la morte degli altri due figli<br />
che lo statista aveva avuto dalla prima moglie.<br />
Quanto fosse ambita la cittadinanza romana<br />
lo dimostra il fatto che molti Latini, che pure si<br />
trovavano in uno stato di privilegio rispetto agli<br />
altri Italici, pur di ottenerla ricorrevano a dei sotterfugi,<br />
come quello di vendere se stessi o i propri<br />
figli a dei cittadini romani compiacenti, che<br />
subito dopo la vendita li affrancavano, rendendoli<br />
così, sia pure come liberti, cittadini a loro<br />
volta. Questa procedura creava dei problemi alle<br />
città da cui quelle persone provenivano perché,<br />
mentre quelli si sottraevano all’obbligo di pagare<br />
i tributi, le città d’origine erano costrette<br />
comunque a farvi fronte poiché le imposte<br />
erano già state in precedenza calcolate e concordate<br />
con Roma. Il Senato, riconoscendo la validità<br />
<strong>del</strong>le lamentele di alcune città latine ordinò<br />
al console in carica di presentare una legge che<br />
obbligasse tutti i Latini iscritti nel censo a tornare<br />
nelle città di provenienza. Così furono rimandati<br />
indietro dodicimila Latini (T. Livio, XXXIX,<br />
3,4).<br />
Accanto ai cives sine suffragio ed in una posizione<br />
più elevata c’erano i cives optimo iure,<br />
cioè i cittadini tali a tutti gli effetti, che votavano<br />
e potevano essere votati. Erano questi coloro<br />
che più degli altri potevano affermare con orgoglio:<br />
civis romanus sum. Anche se di origini
modeste, quando si trovavano in territori soggetti<br />
a Roma erano in una posizione di privilegio,<br />
appartenevano al popolo dominante, erano sottratti<br />
alle leggi ed ai tribunali locali, dovevano<br />
rendere conto <strong>del</strong> proprio operato solo ai magistrati<br />
ed al popolo romano. Abusavano di siffatta<br />
situazione? Forse non tanto quanto si pensa<br />
comunemente. In genere quando alcuni episodi<br />
o personaggi come Verre in Sicilia (propretore<br />
dal 73 al 71 a.C.) sono ricordati, è perché non<br />
rientrano nella consuetudine. Indubbiamente le<br />
orazioni di Cicerone, le Verrinae, hanno contribuito<br />
a dare a quegli avvenimenti un rilievo letterario<br />
e quindi una risonanza che altrimenti<br />
forse non avrebbero avuto, ma Verre era un<br />
magistrato, non un comune cittadino e anzi fra i<br />
capi di accusa che gli furono mossi c’era anche<br />
quello di non aver rispettato i diritti di alcuni cittadini<br />
romani. È risaputo che a Roma non si era<br />
teneri con gli autori di certi abusi, come è dimostrato<br />
dal fatto che Verre, dopo la prima orazione<br />
di Cicerone, non attese la fine <strong>del</strong> dibattimento<br />
ma preferì andare volontariamente in esilio,<br />
evitando guai peggiori.<br />
In ogni caso il crimen repetundarum contemplava<br />
le eventuali malversazioni che potevano<br />
essere commesse dai magistrati romani in<br />
danno di singoli o di intere comunità nelle provincie<br />
loro assegnate. Diverse furono le leggi<br />
che furono promulgate in proposito: la lex Acilia<br />
<strong>del</strong> 123 a.C. prevedeva per questo reato una<br />
sanzione pecuniaria pari al doppio <strong>del</strong> valore di<br />
quanto estorto. Questa sanzione fu poi confermata<br />
dalla lex Servilia <strong>del</strong> 111 a.C., dalla lex<br />
Cornelia <strong>del</strong>l’81 e dalla lex Iulia <strong>del</strong> 59 a.C.. Il<br />
susseguirsi di siffatte leggi, se da un lato evidenzia<br />
la volontà <strong>del</strong>lo Stato di stroncare gli abusi,<br />
dall’altro rivela che la tentazione di impinguare<br />
le tasche era comunque forte.<br />
Abbiamo affermato che in età imperiale si<br />
diffuse sempre più il rifiuto di impegnarsi nelle<br />
cariche pubbliche. Questo fenomeno era certamente<br />
negativo per lo stato romano ed era perciò<br />
necessario porvi riparo in qualche modo.<br />
Augusto, secondo quanto ricorda Svetonio 4 ,<br />
introdusse dei nova officia in modo da coinvolgere<br />
nell’attività di governo il maggior numero<br />
possibile di cittadini e farli partecipi <strong>del</strong>le<br />
SALTERNUM<br />
- 38 -<br />
responsabilità connesse alla pubblica amministrazione<br />
<strong>del</strong>egandoli alla cura <strong>del</strong>le opere pubbliche,<br />
<strong>del</strong>le vie, <strong>del</strong>le acque, <strong>del</strong>l’alveo <strong>del</strong><br />
Tevere, alla distribuzione di grano al popolo.<br />
Istituì anche la prefettura <strong>del</strong>la città, un triumvirato<br />
per la nomina dei senatori ed ancora altre<br />
funzioni, ma tutte di carattere amministrativo e<br />
con poca o nulla rilevanza politica. Gli incarichi<br />
di importanza vitale nella gestione <strong>del</strong>la res<br />
publica restavano nelle mani <strong>del</strong>l’Imperatore e<br />
di poche altre persone a lui vicine e di accertata<br />
fe<strong>del</strong>tà.<br />
La formazione di quella comunità di cives che<br />
va sotto il nome di civitas è in qualche modo<br />
avvolta nelle nebbie di un tempo antico. Si è<br />
avanzata l’ipotesi da parte di alcuni studiosi che<br />
sia stata una forma evolutiva di alcune strutture<br />
sociali caratteristiche dei popoli indoeuropei 5 .<br />
Naturalmente al riguardo mancano <strong>del</strong>le prove<br />
certe e pertanto si deve fare ricorso ad indizi<br />
tratti da quanto conosciamo <strong>del</strong>la vita e dei<br />
costumi religiosi e militari <strong>del</strong>la società romana.<br />
Come tutti sanno, fin dalle origini il popolo<br />
romano era costituito da due classi di cittadini: i<br />
patrizi ed i plebei. La derivazione <strong>del</strong> termine<br />
“patrizio” da pater è più che evidente. I Patres<br />
erano i capifamiglia (Paterfamilias) che, riuniti<br />
in assemblea, discutevano i problemi <strong>del</strong>la collettività<br />
arcaica e prendevano insieme le decisioni<br />
che ritenevano più opportune. L’espressione<br />
rimase e si consolidò col passare <strong>del</strong> tempo<br />
assumendo un significato politico. Patres o<br />
Patres conscripti erano chiamati i senatori,<br />
riunendo in un unico termine i Patres, d’origine<br />
patrizia, ed i Conscripti, ovvero i senatori d’origine<br />
plebea. La parola plebe, con l’aggettivo<br />
corrispondente plebeo, sembra invece che si<br />
possa far risalire etimologicamente ad un termine<br />
arcaico d’origine indoeuropea (radice ples)<br />
affine al greco plêqoß significante la moltitudine,<br />
la massa dei cittadini, quelli, in altri termini,<br />
che non avevano rilevanza politica.<br />
Era inevitabile che la separazione <strong>del</strong> popolo<br />
in due classi, una dominante e l’altra sottomessa,<br />
dovesse avere la conseguenza di determinare<br />
attriti e scontri, di cui la leggenda di Menenio<br />
Agrippa e <strong>del</strong> suo famoso apologo è una lontana<br />
eco. Senza alcun dubbio ci furono tentativi di
secessione da parte <strong>del</strong>la plebe, rientrati in<br />
seguito ad accordi fra le parti. Il primo, che risale<br />
al 494 a.C., vide i secessionisti ritirarsi fuori<br />
<strong>del</strong>le mura cittadine, sull’Aventino, ove risiedeva<br />
una comunità di mercanti greci adusi ad idee e<br />
costumi democratici. Questi movimenti popolari<br />
non rimasero senza effetto, ma portarono alla<br />
pubblicazione di leggi scritte su tavole bronzee,<br />
esposte al pubblico in modo che tutti potessero<br />
leggerle e farvi riferimento. Leggi dette “<strong>del</strong>le XII<br />
Tavole” (451 a.C.). Seguirono altri attriti, altre<br />
trattative ed altre leggi, fra le quali è importante<br />
ricordare le leges Liciniae Sextiae <strong>del</strong> 367 a.C.<br />
che avevano decretato una divisione dei poteri<br />
fra le due classi sociali, stabilendo l’attribuzione<br />
<strong>del</strong>le cariche pubbliche in modo bilanciato: un<br />
console patrizio ed uno plebeo, alternanza nelle<br />
altre magistrature, ecc.<br />
L’aspetto più importante <strong>del</strong>la questione è<br />
tuttavia il fatto che per i Romani non c’era alcun<br />
dubbio che la loro società, così com’era, risalisse<br />
alla mitica fondazione <strong>del</strong>l’Urbe e ciò dimostra<br />
quanto fosse sentita l’appartenenza alla civitas.<br />
Seguendo Tito Livio (I, 13,4), si può arguire<br />
che quel concetto si sia formato allorché i<br />
Romani e i Sabini, facendo la pace, fusero in<br />
una sola “le due città” ed insieme assunsero il<br />
nome di Quiriti.<br />
Come accade molto frequentemente, anche<br />
questo mito contiene un fondo di verità. Infatti,<br />
la parola civitas è l’equivalente romano <strong>del</strong>la<br />
parola greca politeía. Tuttavia, mentre il significato<br />
originario di quest’ultima è legato all’altra<br />
parola póliß, che letteralmente significherebbe<br />
“citta<strong>del</strong>la”, la parola latina etimologicamente si<br />
riallaccia ad una radice indoeuropea che ha il<br />
significato di “famiglia, amico, ospite”, legato<br />
cioè alle persone ed ai rapporti fra queste e non<br />
a <strong>del</strong>le strutture architettoniche.<br />
Continuando nell’esposizione <strong>del</strong>l’indagine<br />
etimologica si può affermare al di là di ogni<br />
dubbio che il nome di Quiriti si può fare derivare<br />
da co-uiri “uomini che si uniscono” e lo stesso<br />
vale per Curia. Con queste considerazioni<br />
PIETRO CRIVELLI<br />
- 39 -<br />
Ricostruzione<br />
di una <strong>del</strong>le XII tavole.<br />
Roma, Museo <strong>del</strong>la Civiltà<br />
Romana.<br />
siamo arrivati al momento <strong>del</strong>la formazione o,<br />
se si preferisce, <strong>del</strong>la fondazione di Roma.<br />
Un’aggregazione di uomini che insieme si<br />
danno <strong>del</strong>le leggi e regolano la vita <strong>del</strong>la loro<br />
società guardando sia all’interno che all’esterno<br />
di essa, riservando a se stessi, come è naturale,<br />
dei privilegi che non sono riconosciuti agli estranei.<br />
In conclusione, bisognerà osservare che il<br />
prestigio e la struttura mentale, prima ancora<br />
che politica, dei Romani determinò il formarsi di<br />
una “nazione” italiana, il confluire verso un<br />
unico centro politico e culturale dei popoli che<br />
vivevano nella penisola, l’aspirazione a sentirsi<br />
tutti cives romani. La stessa guerra sociale <strong>del</strong> 91<br />
a.C. fu una guerra intrapresa dai socii italici per<br />
ottenere il diritto di unirsi a Roma. Una guerra<br />
“per” e non “contro” Roma. Un modo energico<br />
per fare conoscere il proprio desiderio di confluire<br />
nella romanità. È importante avere presente<br />
che in siffatto impulso centripeto furono progressivamente<br />
coinvolte anche quelle città greche<br />
<strong>del</strong>l’Italia meridionale e <strong>del</strong>la Sicilia che<br />
pure avevano in atto ed alle spalle una tradizione<br />
culturale di prim’ordine. Molte di quelle città,<br />
pur continuando a vivere alla greca nella quotidianità,<br />
utilizzando il greco come lingua locale,<br />
ebbero strutture politiche tipicamente romane,<br />
mostrando altresì una effettiva adesione alla<br />
romanità.
NOTE<br />
1<br />
F.DUPONT, La vita quotidiana nella Roma repubblicana,<br />
Laterza, Bari 2000, p.12<br />
2 G. CORRADI, Le grandi conquiste mediterranee, Ed.<br />
Cappelli, Bologna, 1945, passim.<br />
3 T. MOMMSEN, Storia di Roma, Berlino, 1854-1856 cap. X,<br />
p. 42.<br />
SALTERNUM<br />
- 40 -<br />
4 SVETONIO, Aug. XXXVII<br />
5 R.E.PALMER, The Archaic Community of the Romans,<br />
Cambridge, 1970. Citato da CLAUDE NICOLET in Il Mestiere di<br />
Cittadino nell’antica Roma, Roma 1992, p. 31.
WALTER FALAPPA<br />
La città romana di Suasa (Ancona)<br />
La presentazione di questo sito sarà divisa<br />
in due parti: questa prima parte<br />
riguarda la storia <strong>del</strong> ritrovamento, la<br />
presentazione <strong>del</strong>le prime fasi di scavo e la<br />
descrizione dei ritrovamenti dei materiali all’interno<br />
<strong>del</strong>la domus dei Coiiedi, su cui si sono<br />
concentrate le forze vista l’imponenza <strong>del</strong> ritrovamento<br />
<strong>del</strong>la domus.<br />
La seconda parte tratterà <strong>del</strong>le procedure<br />
adottate nelle fasi di scavo ai fini conservativi, i<br />
metodi, gli interventi di prima necessità, la situazione<br />
al momento <strong>del</strong>lo scavo e le problematiche<br />
<strong>del</strong>la messa in luce dei materiali.<br />
Si farà anche una analisi <strong>del</strong>le metodologie<br />
ed un accenno a come il volontariato può collaborare<br />
con le diverse strutture operanti a Suasa<br />
sulla base di una esperienza condotta a maggio<br />
2007 dal <strong>Gruppo</strong> <strong>Archeologico</strong> Ferrarese.<br />
Introduzione al sito archeologico.<br />
Direzione dei lavori:<br />
PIER LUIGI DALL’AGLIO, SANDRO DE MARIA<br />
I resti <strong>del</strong>la città romana di Suasa sorgono<br />
lungo la valle <strong>del</strong> Cesano all’altezza di Pian<br />
Volpello.<br />
La città antica, menzionata dagli autori latini<br />
tra i centri <strong>del</strong>la stessa regio <strong>del</strong>la divisione<br />
Augustea (che comprende l’Umbria e le Marche<br />
meridionali), (Fig. 1) fu oggetto di interesse da<br />
parte di importanti studiosi locali. Tra questi<br />
possiamo ricordare Vincenzo Maria Cimarelli<br />
che descrisse alcuni ruderi ancora visibili nel<br />
1642, a cui si aggiunse, alla metà <strong>del</strong> secolo<br />
appena trascorso, la solerte opera di recupero di<br />
oggetti di varia provenienza da parte di Gello<br />
- 41 -<br />
Fig. 1 - Territorio <strong>del</strong>le Marche.<br />
Si noti come le valli abbiano un andamento a pettine verso il mare.<br />
Fig. 2 - La RegioVI<br />
<strong>del</strong>la divisione<br />
Augustea.<br />
Giorni. Questi reperti, assieme agli altri necessari<br />
a ricostruire la storia <strong>del</strong> territorio, erano conservati<br />
nel vicino museo di S. Lorenzo in Campo<br />
(in fase di ristrutturazione), mentre quelli provenienti<br />
dall’area urbana si trovano nel Museo di<br />
Castelleone di Suasa.
Fig. 3 - La via Flaminia.<br />
Fig. 4 - La<br />
viabilità dei<br />
diverticoli nella<br />
valle <strong>del</strong> Cesano.<br />
La viabilità: l’abitato di Suasa si è formato<br />
negli ultimi decenni <strong>del</strong> III secolo a.C. sul fondovalle<br />
alla destra <strong>del</strong> Cesano (Fig. 2), dopo che<br />
il plebiscito promosso da Gaio Flaminio nel 232<br />
a.C. stabilì la necessità di distribuzione di terra ai<br />
coloni romani anche in questo territorio. Poiché<br />
la viabilità <strong>del</strong> sistema stradale legato alla<br />
Flaminia venne attuata nel 220 a.C. sul fianco<br />
sinistro <strong>del</strong>la valle (Fig. 3), si ritiene che a quel<br />
tempo il primo insediamento dovesse già esiste-<br />
SALTERNUM<br />
Fig. 5 - Veduta aerea <strong>del</strong>la città di Suasa. Figg. 6 - 7 - Pianta<br />
<strong>del</strong>la città di Suasa.<br />
- 42 -<br />
re, altrimenti l’abitato sarebbe stato attratto dall’importante<br />
via di transito posta sull’altro lato<br />
(Fig. 4).<br />
La presenza di coloni all’interno di un denso<br />
popolamento rurale rese necessaria la creazione<br />
di luoghi adatti per il commercio e l’amministrazione<br />
<strong>del</strong>la giustizia da parte di un prefetto.<br />
Suasa si strutturò dunque prima come Prefettura<br />
e poi si ampliò fino a diventare, dopo il 49 a.C.,<br />
Municipio retto da duoviri. Proprio in questo<br />
momento si pone lo sviluppo <strong>del</strong>la città con<br />
spazi pubblici adeguati e aree abitative all’interno<br />
di un sistema urbano regolare e pianificato<br />
(Figg. 5-6), di cui ci sono giunte significative<br />
tracce. Nel corso <strong>del</strong> II e III secolo d.C. crebbe<br />
a cavallo <strong>del</strong>l’asse stradale basolato che percorre<br />
ancor oggi Pian Volpello, con edifici pubblici<br />
privati di grande impegno edilizio, taluni ben<br />
noti dai recenti scavi: una grande piazza porticata<br />
sul lato settentrionale, l’anfiteatro sul lato<br />
meridionale, il teatro, forse le terme (Fig. 7), il<br />
sistema idrico di approvvigionamento, diverse<br />
abitazioni private, talvolta sontuose come la<br />
domus dei Coiiedi.<br />
Gli edifici principali<br />
L’area di abitazioni posta a Est <strong>del</strong>la strada<br />
principale rappresenta la parte più cospicua <strong>del</strong>l’area<br />
archeologica già musealizzata, che comprende<br />
una grande domus di età imperiale e<br />
un’abitazione più piccola di età repubblicana.<br />
La domus dei Coiiedi prende nome dalla<br />
importante famiglia che ne fu proprietaria, nota<br />
per mezzo di epigrafi gemelle a quella rinvenuta<br />
nel corso <strong>del</strong>lo<br />
scavo.<br />
La dimora fu edificata<br />
nel II d.C. su<br />
un’originale casa ad<br />
atrio di metà <strong>del</strong> I<br />
a.C., di cui rimase in<br />
uso il sistema di<br />
ingresso, mentre il<br />
nuovo atrio (A) fu<br />
spostato a Est. Il<br />
vano di maggior<br />
rilievo era l’oecus
tricliniare (G), pavimentato in opus sectile con<br />
vista sul giardino retrostante, mentre in un piccolo<br />
quartiere autonomo, con una diaeta (AF)<br />
e due cubicula (AK e AN), fu ricavata nel III d.C.<br />
più a Sud. Il settore sud-occidentale era occupato<br />
dal quartiere termale e da alcuni vani di servizio<br />
(Fig. 8).<br />
I resti <strong>del</strong>l’abitato repubblicano sono stati<br />
individuati anche nell’area a ridosso <strong>del</strong> muro<br />
perimetrale sud, dove si trovano intatte alcune<br />
strutture <strong>del</strong> II a.C.<br />
La situazione <strong>del</strong>la domus dei Coiiedi<br />
Gli scavi iniziati nel 1988, incentrati particolarmente<br />
nell’area <strong>del</strong>la domus dei Coiiedi, è<br />
stata interamente indagata e l’espansione complessiva<br />
comporta un fronte sulla strada di m.<br />
33,50 e un’estensione all’interno di circa m. 103,<br />
per una superficie complessiva assai rilevante di<br />
quasi 3.500 mq (Fig. 9).<br />
(PIER LUIGI DALL’AGLIO, SANDRO DE MARIA,<br />
ENRICO GIORNI, BEPPE LEPORE, MIRCO ZACCARIA,<br />
Scavi e Ricerche <strong>del</strong> Dipartimento di<br />
Archeologia, University Press Bologna: 1977,<br />
pp. 55-67).<br />
Durante le prime campagne di scavo effettuate<br />
dall’allora Istituto di Archeologia <strong>del</strong>l’Università<br />
di Bologna, oggi Dipartimento di Archeologia,<br />
(1988-1992), è emersa una rilevante presenza di<br />
intonaci dipinti, che accompagnano, con rifacimenti<br />
e nuove stesure, le diverse fasi edilizie <strong>del</strong><br />
complesso.<br />
Le pitture possono essere raggruppate in tre<br />
categorie, distinte a seconda <strong>del</strong>la situazione di<br />
rinvenimento e <strong>del</strong>lo stato di conservazione: frammenti<br />
isolati, zoccolature, stati di crollo (Fig. 10).<br />
1. Frammenti isolati.<br />
Frammenti di intonaco dipinto di ridotte<br />
dimensioni sono stai rinvenuti in tutta l’area di<br />
scavo,variamente distribuiti nei vani <strong>del</strong>le diverse<br />
unità stratigrafiche.<br />
La provenienza di tali lacerti nel sistema<br />
decorativo di una parete (o soffitto) <strong>del</strong>l’ambiente<br />
di ritrovamento è spesso incerta, poiché i<br />
frammenti non appartengono a strati di crollo<br />
definiti, ma vengono in luce talvolta frammisti a<br />
WALTER FALAPPA<br />
- 43 -<br />
Fig. 8 - Pianta <strong>del</strong>la domus dei Coiiedi.<br />
Fig. 10 - Situazione planimetrica dei crolli.<br />
Fig. 9 - Pianta <strong>del</strong>la domus di<br />
Coiiedi. Prima fase: domus<br />
tardo-repubblicana ad atrio.<br />
Seconda fase: grande domus<br />
degli inizi <strong>del</strong> II sec. d.C.<br />
(3.000 mq).<br />
materiali all’interno di strati di abbandono di<br />
fosse agricole.<br />
Degno di nota è, poi, il ritrovamento di alcuni<br />
frammenti di intonaco dipinto all’interno di<br />
sondaggi eseguiti al di sotto <strong>del</strong>la fase edilizia
medio-imperiale: essi sono stati riutilizzati come<br />
materiale di riempimento e attestano l’esistenza<br />
di una fase pittorica precedente a quella <strong>del</strong> rifacimento<br />
degli inizi <strong>del</strong> II sec. d.C.<br />
Fig. 11 - Ambiente G.<br />
Fig. 12 -Zoccolo <strong>del</strong>l’ambiente C.<br />
Fig. 13 - In questo dettaglio si evidenziano i numeri di stati preparatori<br />
degli intonaci che rispondono ai canoni scritti da Vitruvio.<br />
Gli stati di intonaco sono 5; fra il primo ed il secondo si evidenzia una<br />
infiltrazione argillosa.<br />
L’ultimo strato (intonachino), di soli 0,2 - 0,5 mm è poco visibile ed è lo<br />
strato su cui si ancora la pellicola pittorica.<br />
SALTERNUM<br />
- 44 -<br />
2. Zoccolature.<br />
In tutta l’area di scavo i resti <strong>del</strong>le pareti conservano<br />
una parte, più o meno ampia, <strong>del</strong> rivestimento<br />
dipinto. Si tratta <strong>del</strong>la parte bassa <strong>del</strong>la<br />
decorazione, a contatto col pavimento. Essa si<br />
presenta in due varianti: come vasta campitura<br />
monocroma oppure come imitazione di crustae<br />
marmoree, variamente ripartite da bande di<br />
separazione.<br />
L’osservazione di queste porzioni di pittura<br />
ha permesso di trarre diverse indicazioni utili:<br />
l’ordine di stesura, il numero e la composizione<br />
degli strati preparatori ed il rapporto tra la pavimentazione<br />
e la decorazione parietale; infine ha<br />
permesso di verificare l’applicazione di una<br />
norma raccomandata da Vitruvio (VII, 4) per<br />
preservare l’intonaco dalle infiltrazioni di umidità:<br />
infatti nei vani C, E e G il primo strato aderente<br />
alla muratura è costituito da cocciopesto<br />
spesso 1,5-2 cm, che, nella sua impermeabilità,<br />
assolve alla funzione ricordata da Vitruvio (Figg.<br />
11-12-13).<br />
3. Strati di crollo.<br />
Diversi ambienti <strong>del</strong>l’edificio hanno restituito<br />
interi strati di crollo <strong>del</strong>le pitture parietali, talora<br />
ancora in posizione di caduta, talora manomessi<br />
durante le fasi di frequentazioni successive<br />
all’abbandono <strong>del</strong>la domus. Semplificando, possiamo<br />
distinguere diverse categorie, che tuttavia<br />
presentano un elemento in comune: l’assenza (o<br />
la minima presenza) dei materiali <strong>del</strong> crollo<br />
<strong>del</strong>le coperture e dei muri (laterizi, tegole,<br />
coppi, chiodi <strong>del</strong>le travature, ecc…).<br />
Questo fenomeno è dovuto, probabilmente,<br />
alla massiccia operazione di spoglio <strong>del</strong>le strutture<br />
avvenuta nelle fasi successive all’abbandono<br />
<strong>del</strong>la domus, al fine di recuperare materiali<br />
riutilizzabili (Figg. 14-15-16).<br />
Un primo tipo di crollo si può definire “pluristratificato”:<br />
si tratta di un accumulo d’intonaco<br />
dipinto disposto su diversi strati sovrapposti fino<br />
all’altezza massima di 60-70 cm. Gli esempi più<br />
consistenti sono stati rinvenuti nell’ala Q e nell’atrio<br />
B, ma presentano alcune differenze: l’ala<br />
Q ha restituito il crollo <strong>del</strong>la decorazione di tre<br />
pareti, variamente mescolato, ma sostanzialmente<br />
in posizione di caduta, se si esclude l’azione
Fig. 14.<br />
distruttrice di alcune fosse agricole che, attraversando<br />
lo scavo in senso est-ovest, hanno intaccato<br />
gli strati più superficiali <strong>del</strong> crollo. Il crollo<br />
<strong>del</strong>l’atrio B, invece è relativo ad una sola parete<br />
dipinta (quella orientale), per di più manomessa<br />
durante la fase di abbandono <strong>del</strong>la dimora, in<br />
cui le placche dipinte sono state ammassate in<br />
un angolo <strong>del</strong> vano per permettere il passaggio<br />
verso il giardino (Fig. 17).<br />
Un secondo tipo si può individuare nei crolli<br />
cosi detti “planari”: l’intonaco crollato si presenta<br />
come un unico strato, direttamente a contatto<br />
col pavimento e occupa per lo più l’intera<br />
estensione <strong>del</strong> vano. E’ il caso dei vani O (il cui<br />
intonaco completamente bianco si può riferire al<br />
soffitto) e AF (in cui l’intonaco è riferibile alla<br />
parete sud <strong>del</strong>l’ambiente) (Fig. 18).<br />
Nel crollo cosiddetto “a fisarmonica” l’intonaco<br />
si è staccato dal supporto murario, ammassandosi<br />
alla base <strong>del</strong>la parete in strati disposti<br />
con la superficie dipinta alternatamente verso<br />
l’alto e verso il basso.<br />
E’ il caso dei vani G e AK (Figg. 19-20-21-22-23).<br />
Nei vani <strong>del</strong> settore sud <strong>del</strong>la domus<br />
(BA,BB,BC) sono stati recuperati i crolli e alcune<br />
strutture murarie intere: in questo caso il<br />
muro ha conservato il rivestimento pittorico su<br />
entrambe le facce, relative a due vani comunicanti.<br />
In questo settore (portico ovest <strong>del</strong> peristilio)<br />
sono state recuperate, inoltre, ampie porzioni<br />
<strong>del</strong>le colonne in laterizi, col rivestimento in<br />
WALTER FALAPPA<br />
- 45 -<br />
Fig. 16 - Ambiente A. Si notino le fosse.<br />
Fig. 15.<br />
Fig. 17.<br />
Fig. 18.
stucco modanato e dipinto (Figg. 24-25).<br />
Un ultimo tipo di crollo si può definire<br />
“misto”: si tratta di vani che hanno restituito<br />
macerie dei muri in cui sono mescolati frammenti<br />
di intonaco dipinto (vano AQ e AO).<br />
Conclusioni<br />
Sin dal primo anno di scavo si è resa necessaria<br />
una scheda analitica che potesse riassumere,<br />
in maniera il più possibile sintetica, tali differenti<br />
situazioni di rinvenimento. La scheda è stata elaborata<br />
dall’équipe che opera a Suasa. Questa<br />
scheda è stata messa a punto considerando e<br />
ampliando – in base alle mutate esigenze – alcune<br />
proposte precedenti e già utilizzate (Fig. 26).<br />
La scheda è stata concepita in modo tale da<br />
permetterne l’uso in una casistica il più possibile<br />
ampia: essa è composta di otto sezioni distinte,<br />
disposte in ordine “cronologico”, così che la<br />
scheda possa accompagnare la pittura durante<br />
tutte le fasi di lavorazione, dal recupero al<br />
Fig. 19.<br />
Fig. 20 - Crollo omogeneo esteso.<br />
SALTERNUM<br />
- 46 -<br />
restauro. La prima sezione riguarda le generalità<br />
e permette l’identificazione <strong>del</strong> frammento<br />
(località, anno, unità stratigrafica, etc.).<br />
La seconda riguarda la situazione di rinvenimento:<br />
sono riportati almeno tre casi: “crollo”,<br />
“parete” e “isolato”. Per ognuna di queste situazioni<br />
sono suggerite diverse condizioni conservative<br />
(“difetti di coesione”, “di adesione”, “fratture”,<br />
“incrostazioni”, etc.). Si prosegue poi coi<br />
primi interventi, effettuati direttamente sullo<br />
scavo (“pulitura”, “consolidamento”, “velatura”,<br />
etc.). La sezione successiva riguarda la stratigrafia:<br />
in primo luogo si riportano i dati generali<br />
<strong>del</strong>l’intero frammento (spessore e numero degli<br />
strati, misure), poi si procede ad una descrizione<br />
analitica dei singoli strati, a partire dall’intonachino.<br />
Una sezione a parte è dedicata alla pellicola<br />
pittorica, con un ampio spazio riservato<br />
alla descrizione verbale, da sostituire eventualmente<br />
con il disegno oppure con la fotografia<br />
<strong>del</strong>la decorazione dipinta.<br />
Fig. 21 - Crollo omogeneo composto.<br />
Fig. 22 - Crollo omogeneo frammentato.
Fig. 23 - Esempio di un’altra situazione simile nella prima unità si scavo,<br />
si noti come il crollo omogeneo sia caduto a fisarmonica su se stesso<br />
nello stesso ambiente<br />
I due settori successivi possono essere compilati<br />
solo quando lo studio è in una fase avanzata:<br />
l’interpretazione, con riferimento ad una<br />
datazione e ai confronti con decorazioni note e<br />
il restauro. L’ultima sezione chiude la scheda<br />
con i riferimenti alla documentazione: disegni,<br />
fotografie e piante.<br />
Ogni voce <strong>del</strong>la scheda può essere compilata<br />
semplicemente barrando una casella desiderata,<br />
mentre lo spazio restante permette di specificare<br />
meglio il dato riportato (materiali usati, percentuali,<br />
note, etc.).<br />
(PIER LUIGI DALL’AGLIO, SANDRO DE MARIA,<br />
ENRICO GIORNI, GIUSEPPE LEPORE, MIRCO ZACCARIA,<br />
Functional and spatial analysis of wall painting,<br />
Amsterdam, 8-12 sept., edit. by ERIK M.<br />
MORORMAN 1992, pp. 205 -211).<br />
*L’articolo è composto di vari stralci di documenti ufficiali<br />
di convegni internazionali sulla pittura romana e su<br />
documenti prodotti dal Dipartimento di Archeologia<br />
<strong>del</strong>l’Università di Bologna .<br />
Gli autori sono S. DE MARIA, P. L. DALL’AGLIO, G. LEPORE,<br />
E. GIORGI eM. ZACCARIA.<br />
WALTER FALAPPA<br />
- 47 -<br />
Fig. 24 - Ambienti A e B<br />
Fig. 25.<br />
Fig. 26 - Uno dei metodi per una prima schedatura quello di rilievi 1:1 e<br />
rodotti a tavole disegno in vari formati, che illustrano lo stato <strong>del</strong> crollo<br />
in ciascuna unità di scavo.
BIANCA<br />
CANCELLARE
VINCENZO INTORCIA<br />
L’Arco <strong>del</strong> Sacramento in Benevento<br />
Delle vicende attraverso i secoli che hanno<br />
interessato l’Arco <strong>del</strong> Sacramento e il sito sul<br />
quale insiste e come essi si mostrano al presente<br />
Nell’articolo pubblicato sul precedente<br />
numero <strong>del</strong>la rivista Sal(t)ernum<br />
riguardante l’Arco <strong>del</strong> Sacramento in<br />
Benevento si sono date le coordinate circa la<br />
descrizione <strong>del</strong> monumento, l’epoca di costruzione<br />
e le sue funzioni urbanistiche nella città<br />
romana. Nel presente contributo si cercherà<br />
invece di mettere in luce le trasformazioni accorse<br />
al monumento nel corso dei secoli dagli albori<br />
<strong>del</strong>l’età medievale fino ai nostri giorni.<br />
Dopo la caduta <strong>del</strong>l’Impero romano d’Occidente,<br />
l’Italia fu sconvolta dalla guerra grecogotica<br />
(535-553). In questo frangente le mura<br />
romane di Benevento furono rase al suolo nel<br />
545 da Totila, il quale, secondo Procopio di<br />
Cesarea, espugnò la città che si era data a<br />
Belisario. Sulla traccia <strong>del</strong> De Nicastro, che attribuì<br />
a Narsete l’epigrafe dedicata all’eminente<br />
personaggio che provvide al restauro <strong>del</strong>la città, 1<br />
gli storici locali seguirono questa tradizione<br />
secentesca, come fa l’Isernia che indica sempre<br />
il generale bizantino quale autore <strong>del</strong> restauro<br />
<strong>del</strong>la cinta difensiva, precisando che le nuove<br />
mura furono ricostruite in un perimetro assai<br />
ristretto che toccava l’Arco <strong>del</strong> Sacramento. 2<br />
Secondo l’ipotesi più verosimile e oggi largamente<br />
condivisa, la cinta muraria fu ricostruita al<br />
tempo <strong>del</strong> primo duca longobardo Zottone, o al<br />
massimo nei primi anni <strong>del</strong> governo di Arechi I. 3<br />
In effetti le condizioni di indigenza provocate<br />
dalle guerre fecero sì che l’abitato <strong>del</strong>la<br />
Benevento longobarda si restringesse lasciando<br />
fuori dal nuovo perimetro le zone occidentali e<br />
l’area <strong>del</strong> Teatro.<br />
2 A PARTE<br />
- 49 -<br />
Benevento. Il piano<br />
particolareggiato Zevi-Rossi<br />
per la sistemazione <strong>del</strong>’area<br />
<strong>del</strong> Duomo e <strong>del</strong>l’Arco <strong>del</strong><br />
Sacramento (1988-89).<br />
Così, come all’altro capo <strong>del</strong>la città, nella<br />
zona settentrionale, l’Arco di Traiano andava a<br />
costituire la Porta Aurea, anche l’Arco <strong>del</strong><br />
Sacramento, raggiunto dalle mura, diveniva l’ingresso<br />
a meridione. Questa funzione la mantenne<br />
però fino all’addizione <strong>del</strong>la cinta muraria<br />
promossa da Arechi II (758-787), la civitas nova,<br />
che permise alla città longobarda di recuperare<br />
all’abitato la zona <strong>del</strong> Teatro. A Sud <strong>del</strong>l’Arco <strong>del</strong><br />
Sacramento, allora, si andò sviluppando il quartiere<br />
medievale “Triggio”.<br />
Da questo momento comunque, per la scarsità<br />
di documenti e di reperti, il percorso che si<br />
può tracciare <strong>del</strong>le vicende <strong>del</strong>l’Arco attraverso i<br />
secoli è reso difficile da molte zone d’ombra.
Benevento.Veduta area <strong>del</strong>l’area <strong>del</strong> Duomo con in evidenza la zona a Ovest<br />
<strong>del</strong>l’Arco <strong>del</strong> Sacramento (1985).<br />
Benevento. Lavori di restauro per lo svuotamento <strong>del</strong> fornice <strong>del</strong>l’arco romano ad<br />
Ovest <strong>del</strong>l’Arco <strong>del</strong> Sacramento (2005).<br />
Può darsi che già al tempo <strong>del</strong>la guerra<br />
greco-gotica, o con l’arrivo dei Longobardi, per<br />
le vicende belliche o durante i saccheggi, l’Arco<br />
<strong>del</strong> Sacramento avesse perso la sua decorazione<br />
marmorea, visto che invece, quando si diede<br />
una prima sistemazione <strong>del</strong>la città, all’atto di<br />
divenire Port’Aurea, le sculture <strong>del</strong>l’Arco di<br />
Traiano furono accuratamente conservate integre.<br />
Diversamente, non credo che la dispersione<br />
<strong>del</strong> paramento decorativo sia da imputarsi ad<br />
uno stato di incuria e di abbandono, poiché la<br />
zona in questione non fu lasciata in disuso dalla<br />
nuova città longobarda, e anzi un episodio<br />
monumentale come l’Arco <strong>del</strong> Sacramento<br />
sarebbe risultato molto gradito ai Longobardi<br />
per nobilitare un ingresso cittadino, così come<br />
fu fatto con l’Arco di Traiano. C’è da considerare,<br />
inoltre, che probabilmente molte strutture<br />
romane siano giunte alle soglie <strong>del</strong> Medioevo<br />
già in stato di parziale degrado, incoraggiando-<br />
SALTERNUM<br />
- 50 -<br />
ne così l’adattamento a nuovi usi o lo sfruttamento<br />
quali cave di materiale da costruzione.<br />
Mentre il centro <strong>del</strong>la Benevento longobarda<br />
si andò spostando verso Oriente attorno al<br />
Piano di Corte, la zona <strong>del</strong>l’antico Foro e<br />
<strong>del</strong>l’Arco <strong>del</strong> Sacramento rimase comunque viva,<br />
caratterizzandosi per numerosi edifici religiosi.<br />
Qui, infatti, forse sulle strutture <strong>del</strong> Tempio di<br />
Iside, sorse la prima Cattedrale consacrata alla<br />
Vergine. E in questa zona in epoca medievale<br />
sono documentate l’ecclesia S. Jacobi a Foro e<br />
l’ecclesia S. Stephani de monialibus de Foro. 4<br />
Secondo l’uso consueto <strong>del</strong>l’epoca, probabilmente<br />
le chiese e gli edifici longobardi furono<br />
costruiti sfruttando anche le imponenti cave di<br />
ottimo materiale a buon mercato e già lavorato<br />
fornito dalle vestigia <strong>del</strong>le strutture romane:<br />
adattamenti a nuovi usi o reiterate spoliazioni.<br />
Ma oltre che una funzione meramente costruttiva,<br />
i pezzi provenienti dagli edifici romani potevano<br />
assolvere anche un altro ufficio. La pratica<br />
diffusa nel Medioevo di riutilizzare i marmi e le<br />
pietre già decorate e scolpite dei monumenti<br />
romani con funzioni di ornamento e di nobilitazione<br />
dei propri edifici, può anche aver giocato<br />
a favore <strong>del</strong>la perdita <strong>del</strong>le sculture <strong>del</strong>l’Arco <strong>del</strong><br />
Sacramento. In effetti sia nella cinta muraria, sia<br />
negli edifici religiosi, negli edifici di rappresentanza<br />
<strong>del</strong> potere longobardo come nelle case<br />
civili, si possono notare molti resti e frammenti<br />
d’arte classica. Nella peggiore <strong>del</strong>le ipotesi,<br />
sarebbe da considerare anche la possibilità che<br />
le sculture <strong>del</strong>l’Arco <strong>del</strong> Sacramento siano andate<br />
a finire nelle fornaci per produrre <strong>del</strong>la buona<br />
calce. La Port’Arsa che si trova nelle vicinanze,<br />
tra l’altro, era conosciuta anche con il nome di<br />
Porta <strong>del</strong>le Calcare 5 , appunto per la presenza in<br />
quel sito di tali attività produttive. Né, infine, è<br />
da sottovalutare l’eventualità che la perdita <strong>del</strong>la<br />
decorazione <strong>del</strong>l’Arco sia avvenuta in seguito ad<br />
uno dei tanti sismi che colpirono la città di<br />
Benevento a cominciare dal primo che ci è stato<br />
tramandato, nel 369 d.C., di cui ci informa<br />
Aurelio Simmaco, o quello violentissimo <strong>del</strong>l’11<br />
ottobre 1125, che, narra il cronista Falcone,<br />
rovesciò al suolo anche le mura <strong>del</strong>la città diroccando<br />
le torri e le case in modo da non sembrare<br />
più umane abitazioni. 6
Quel che è probabile, comunque, in mancanza<br />
di dati certi, è che la perdita dei rilievi marmorei<br />
<strong>del</strong>l’Arco <strong>del</strong> Sacramento sia avvenuta<br />
abbastanza presto nei tempi 7 : in un certo senso<br />
è proprio la carenza di notizie documentarie che<br />
induce a pensare che l’attenzione verso il monumento<br />
sia stata poco rilevante in ragione <strong>del</strong>lo<br />
spoglio <strong>del</strong>le sculture ab antiquo; di conseguenza,<br />
neanche il nome <strong>del</strong>l’importante personalità<br />
a cui l’Arco era dedicato fu tramandato attraverso<br />
i secoli.<br />
Nel Seicento cominciano un po’ a dissiparsi<br />
le nebbie nelle quali è avvolto il percorso storico<br />
<strong>del</strong> nostro monumento fino ai giorni nostri, e<br />
abbiamo la prima notizia di un intervento<br />
sull’Arco <strong>del</strong> Sacramento trasmessa dal<br />
Meomartini, il quale scrive:<br />
“fo avvertire che il grosso <strong>del</strong>la muratura che<br />
oggi si eleva al di sopra degli stilobati non è tutto<br />
antico, e che una parte, cioè quella che guarda<br />
a settentrione, è moderna, essendovi stata<br />
aggiunta dal Cardinale Arcivescovo Agostino<br />
Oregio … sulla serraglia <strong>del</strong>l’archivolto settentrionale<br />
esiste ancora il suo stemma, scolpito su<br />
di una pietra rettangolare, la quale misura m.<br />
0.40 x 0.60. Sulla cartella sottoposta allo scudo<br />
vi è l’iscrizione: AVG. CARD. ORECIVS<br />
ARCHPVS. BNVS.<br />
Nelle due sezioni si vede preciso il distacco tra<br />
la muratura aggiunta e l’antica che si appartiene<br />
proprio al monumento, come si scorge pure<br />
bene che l’archivolto sulla facciata settentrionale,<br />
costituito di ventisette cunei di tufo trachitico<br />
intercalati con un filare di mattoni, sia di epoca<br />
moderna. Di modo che l’aggiunzione è stata<br />
praticata non solo nelle pilastrate, ma ben anche<br />
nel volto”. 8<br />
L’Arcivescovo Agostino Oregio resse<br />
l’Arcidiocesi di Benevento dal 1633 al 1635, 9 un<br />
tempo piuttosto breve, e i suoi biografi si soffermano<br />
più sulle sue sottigliezze teologiche che<br />
sugli interventi edilizi promossi. La notizia riferita<br />
dal Meomartini non ha trovato ancora un<br />
fonte documentaria d’archivio, e allo stato attuale<br />
<strong>del</strong> monumento non sono purtroppo più visibili,<br />
perché asportati, né le aggiunte nell’archivolto<br />
né lo stemma <strong>del</strong>l’Arcivescovo con l’iscrizione<br />
di cui faceva fede sempre il Meomartini.<br />
VINCENZO INTORCIA<br />
- 51 -<br />
In una rarissima foto <strong>del</strong>la facciata settentrionale<br />
<strong>del</strong>l’Arco <strong>del</strong> Sacramento prima degli interventi<br />
<strong>del</strong> secondo dopoguerra <strong>del</strong> Novecento, è<br />
però ancora visibile la decorazione <strong>del</strong>l’archivolto,<br />
mentre non risulta più in situ lo stemma<br />
<strong>del</strong>l’Arcivescovo con l’iscrizione.<br />
Non si sa con certezza se i terremoti di fine<br />
Seicento e di inizio Settecento arrecarono danni<br />
al monumento e in quale misura. È probabile,<br />
però, che in conseguenza <strong>del</strong>le ricostruzioni cit-<br />
Benevento. Pianta per il progetto di recupero e la valorizzazione <strong>del</strong>l’area nodale<br />
<strong>del</strong>l’Arco <strong>del</strong> Sacramento (2000).<br />
Benevento.Arco romano ad Ovest <strong>del</strong>l’Arco <strong>del</strong> Sacramento (1985).<br />
tadine successive al 1702 e di quelle promosse<br />
dall’Orsini nel palazzo Arcivescovile, l’Arco <strong>del</strong><br />
Sacramento venisse completamente inglobato<br />
da case d’abitazione e dall’ampliamento<br />
<strong>del</strong>l’Episcopio. 10<br />
La prima fonte 11 che ci mostra una descrizione<br />
attendibile <strong>del</strong>l’Arco è un’incisione ad acquaforte<br />
rinforzata a bulino eseguita da Pierre<br />
Gabriel Berthauld (1748-1819) 12 su disegno di<br />
De Pres ed inserita con il nome di Vue d’une
Benevento. Arco <strong>del</strong> Sacramento, incisione ad acquaforte rinforzata e bulino di<br />
Pierre Gabriel Berthauld (1781-1785).<br />
Benevento. Arco <strong>del</strong> Sacramento,“Arco antico in Benevento, incisione ad<br />
acquaforte o bulino di Luigi Rossini (fine XIX secolo).<br />
ancienne Porte de Benevent nel Voyage pittoresque<br />
ou description des Royaumes de Naples et de<br />
Sicile di Richard de Saint-Non, edito a Parigi tra<br />
il 1781 e il 1785. Che l’incisione sia una veduta<br />
dal vero e non un’opera di fantasia, è confermato<br />
almeno da tre ordini di fattori. Innanzitutto,<br />
dal confronto tra le costruzioni descritte e le<br />
indicazioni topografiche rinvenibili nelle mappe<br />
<strong>del</strong>l’epoca che andremo a presentare. In secondo<br />
luogo, la veduta <strong>del</strong> Berthauld appare assolutamente<br />
veritiera se confrontata con un’altra<br />
incisione di Luigi Rossini <strong>del</strong> 1839 e con le<br />
prime fotografie disponibili di fine Ottocento.<br />
Infine, non c’è motivo di dubitare <strong>del</strong>l’attendibilità<br />
<strong>del</strong>la veduta per il semplice fatto che anche<br />
le altre incisioni contenute nel Voyage <strong>del</strong> Saint-<br />
Non, come la veduta <strong>del</strong> Teatro Romano incisa<br />
sempre dallo stesso Berthauld, risultano precise<br />
e obiettive.<br />
La Vue d’un ancienne Porte de Benevent 13 è<br />
presa dallo slargo oggi intitolato a Manfredi di<br />
SALTERNUM<br />
- 52 -<br />
Svevia, e ci mostra, quindi, la facciata meridionale<br />
<strong>del</strong>l’Arco <strong>del</strong> Sacramento. La decorazione<br />
marmorea risulta ormai inesistente. Nel pilastro<br />
orientale sono riconoscibili i blocchi di pietra<br />
degli stilobati, mentre l’incavo <strong>del</strong>la nicchia è<br />
stato riempito. Il pilastro è subito collegato a<br />
destra senza soluzione di continuità con la fabbrica<br />
<strong>del</strong> Palazzo arcivescovile. Il pilastro occidentale,<br />
invece, risulta completamente occultato<br />
da un’abitazione a due piani, dove in corrispondenza<br />
<strong>del</strong>la pilastrata vi è una veranda con il<br />
tetto che termina all’altezza <strong>del</strong>l’imposta <strong>del</strong> fornice.<br />
Fortunatamente la veduta è di ampio respiro,<br />
e possiamo scorgere l’Arco in tutta la sua<br />
altezza che si staglia sul cielo. Al di sopra <strong>del</strong>l’archivolto,<br />
infatti, si elevano ben due piani,<br />
appartenenti e collegati con l’Episcopio, coperti<br />
con un tetto di tegole dove si intravedono due<br />
camini. In corrispondenza <strong>del</strong>la linea mediana<br />
con la chiave di volta <strong>del</strong>l’archivolto, in ciascuno<br />
dei due piani è aperta una finestra. Dunque<br />
l’attico <strong>del</strong>l’Arco romano, dove si trovava un<br />
seconda arcata, risulta completamente inglobato,<br />
mentre sopra di esso è stato elevato un altro<br />
piano. Guardando il primo piano subito al di<br />
sopra <strong>del</strong>l’archivolto:<br />
“vien fatto di scorgere sulla sinistra, in alto,<br />
verso il cantone sud-ovest, un blocco di muratura<br />
a getto, lungo m. 3.00, altrettanto alto e sporgente<br />
di m. 1.10 dal vivo <strong>del</strong>la pilastrata.<br />
Sebbene questa muratura sia antica, non la si<br />
può affatto ritenere coeva <strong>del</strong> monumento che<br />
stiamo esaminando; vi fu aggiunta in processo<br />
di tempo, per collegare probabilmente quest’arco<br />
a qualche fortilizio innalzato colà presso per<br />
difesa <strong>del</strong>la città”. 14<br />
Vedremo poi cosa ci dice Meomartini, al suo<br />
tempo, di questi vani che si innalzano al di<br />
sopra <strong>del</strong> fornice. Sempre ad Occidente, poco<br />
sotto quel blocco di muratura ora descritto e al<br />
di sopra dei tetti <strong>del</strong>le abitazioni, si può osservare<br />
un tratto di muro che si ammorsa sul cantone<br />
esterno <strong>del</strong>l’Arco; questo pezzo è probabilmente<br />
parte <strong>del</strong>la prima cinta di murazione medievale<br />
che raggiunse l’Arco quando divenne porta<br />
cittadina.<br />
Conducendo lo sguardo sotto l’arcata, si vede<br />
bene che la strada continua con un muro rettili
neo fino ad un pontile. All’epoca la via si chiamava<br />
Chiaviche Vecchie, poiché vicino si trovava<br />
probabilmente il macello, e, come mostra la<br />
seppure un po’ schematica 15 Pianta <strong>del</strong>la pontificia<br />
città di Benevento <strong>del</strong>ineata da Liborio<br />
Pizzella e incisa dall’Aloia entro il 1764, l’Arco<br />
<strong>del</strong> Sacramento si trovava effettivamente stretto<br />
da costruzioni sia ad Oriente che ad Occidente.<br />
La Topografia <strong>del</strong>la Pontificia Città di<br />
Benevento umiliata alla Santità D.N.S. Papa Pio<br />
Sesto dai Consoli <strong>del</strong>la medesima redatta dall’architetto<br />
Saverio Casselli e incisa da Carlo<br />
Antonini intorno il 1781, è praticamente coeva<br />
all’incisione <strong>del</strong> Berthauld, e in maniera <strong>del</strong> tutto<br />
attendibile riporta sulla mappa la pianta reale<br />
degli edifici <strong>del</strong>la città. Si nota perfettamente la<br />
linea <strong>del</strong> cardo romano che costeggia ad Occidente<br />
la fabbrica <strong>del</strong> Duomo. Qui l’Arco <strong>del</strong><br />
Sacramento è individuabile dal tratteggio di due<br />
linee che corrispondono all’identificazione di un<br />
passaggio voltato. Ad Est lo vediamo congiunto<br />
con l’Episcopio, e ad Ovest è <strong>del</strong>ineata la pianta<br />
dei fabbricati che abbiamo visto riprodotti<br />
nell’incisione. Dietro l’Arco <strong>del</strong> Sacramento, ad<br />
Occidente, troviamo uno slargo chiuso ad Est<br />
verso via Chianche Vecchie da un muro che<br />
abbiamo osservato essere anche nell’incisione;<br />
risalendo la via, infine, si possono notare segnati<br />
anche gli altri pontili.<br />
Nel 1839, all’interno <strong>del</strong> Viaggio pittoresco da<br />
Roma a Napoli di Luigi Rossini (1790-1857), 16<br />
troviamo l’Arco <strong>del</strong> Sacramento raffigurato in<br />
un’incisione ad acquaforte e bulino dal titolo<br />
Arco antico in Benevento/creduto avanzi di<br />
terme. L’incisione di Rossini (che ritrae sempre<br />
la facciata meridionale) mostra notevoli somiglianze<br />
con quella di Berthauld, confermando<br />
che la situazione <strong>del</strong> monumento è rimasta nell’arco<br />
di tempo trascorso sostanzialmente la stessa.<br />
La veduta riguarda sempre la facciata meridionale<br />
<strong>del</strong> monumento. Ad Occidente notiamo<br />
ancora la veranda <strong>del</strong>l’abitazione che si sovrappone<br />
al pilastro ovest <strong>del</strong>l’Arco, e al di sopra <strong>del</strong><br />
tetto <strong>del</strong>la dimora si scorge sempre il collegamento<br />
con il muro di cinta di matrice medievale.<br />
Ad Oriente l’Arco è sempre collegato con il<br />
Palazzo arcivescovile. I blocchi degli stilobati<br />
sotto il fornice e <strong>del</strong> pilastro orientale si mostra-<br />
VINCENZO INTORCIA<br />
- 53 -<br />
no già consunti e si possono osservare i resti<br />
<strong>del</strong>le cornici <strong>del</strong>la decorazione originaria<br />
<strong>del</strong>l’Arco che praticamente sono quelle che<br />
vediamo anche al presente. Il chiaroscuro <strong>del</strong><br />
tratteggio <strong>del</strong>l’artista mostra che la superficie<br />
<strong>del</strong>la muratura <strong>del</strong>l’Arco lascia osservare la sua<br />
struttura di mattoni nell’arcata principale e nelle<br />
arcate <strong>del</strong>le nicchie laterali; anche da alcuni tratti<br />
<strong>del</strong> monumento si intravede l’opera in laterizi,<br />
Benevento. Progetto di<br />
recupero e la<br />
valorizzazione <strong>del</strong>l’area<br />
nodale <strong>del</strong>l’Arco <strong>del</strong><br />
Sacramento (2000).<br />
Benevento. Plastico per il progetto di<br />
recupero e la valorizzazione <strong>del</strong>l’area<br />
nodale <strong>del</strong>l’Arco <strong>del</strong> Sacramento<br />
(2000).<br />
mentre altri tratti sono intonacati. Purtroppo dall’incisione<br />
di Rossini non è possibile seguire lo<br />
sviluppo in altezza <strong>del</strong>le fabbricazioni che si elevano<br />
alla sommità <strong>del</strong> fornice, (anche se queste<br />
si lasciano ancora intuire), ma come vedremo<br />
nello scritto e nelle foto di Meomartini, l’attico<br />
<strong>del</strong>l’Arco è ancora occupato da due piani di<br />
costruzione. Risalendo il cardo/via <strong>del</strong><br />
Sacramento notiamo che ad Ovest, lì dove nell’incisione<br />
di Berthauld vi era un muro rettilineo,<br />
adesso la zona è occupata dal prospetto laterale<br />
di un edificio. In fondo poi si scorge sempre un<br />
passaggio voltato. Nella Mappa originale <strong>del</strong>la<br />
città di Benevento realizzata sotto la direzione di
Benevento. L’arco <strong>del</strong> Sacramento dopo i bombardamenti <strong>del</strong> 1943.<br />
Benevento.Area ad Occidente <strong>del</strong>l’Arco <strong>del</strong> Sacramento con i resti dei pilastri <strong>del</strong><br />
palazzo residenziale, iniziato a costruire e poi bloccato nel 1946.<br />
Luigi Mazzarini nel 1823 (quindi di pochi anni<br />
antecedente l’incisione di Rossini), si nota, difatti,<br />
che la zona libera ad Occidente <strong>del</strong>l’Arco è<br />
stata coperta dalla mole di un nuovo fabbricato,<br />
l’Ospedale femminile di S. Gaetano.<br />
La profonda trasformazione urbanistica che<br />
interessa Benevento nei primi decenni dopo<br />
l’Unità d’Italia, 17 nell’ambito <strong>del</strong> centro storico,<br />
si concentra soprattutto lungo l’asse <strong>del</strong>la vecchia<br />
via Magistrale, ora diventata Corso<br />
Garibaldi, e ne fanno le spese ampi tratti <strong>del</strong><br />
circuito <strong>del</strong>le antiche mura, ma per quanto<br />
riguarda la zona <strong>del</strong>l’Arco <strong>del</strong> Sacramento, l’area<br />
rimase dunque pressoché inalterata secondo<br />
la sistemazione settecentesca post-terremoto.<br />
Nel 1889, ne I monumenti e le opere d’arte<br />
<strong>del</strong>la città di Benevento, Almerico Meomartini,<br />
che fu il primo studioso ad interessarsi <strong>del</strong>la<br />
costruzione romana, così introduceva la descrizione<br />
<strong>del</strong> monumento: “di fronte alla casa <strong>del</strong>la<br />
famiglia Torre, trovasi quest’arco, il quale pre-<br />
SALTERNUM<br />
- 54 -<br />
sentemente è serrato in mezzo, ad occidente dall’ospedale<br />
di S. Gaetano e da basse case <strong>del</strong>l’avvocato<br />
Ferdinando Torre, ad oriente dalle fabbriche<br />
<strong>del</strong>l’episcopio; per la qual cosa, ove non vi<br />
fosse un quadrivio dinanzi la facciata meridionale,<br />
tutto l’antico edifizio sarebbe occultato alla<br />
vista”. 18<br />
Tenendo presenti le indicazioni sin qui offerte<br />
dallo studioso su come si presentava l’Arco<br />
alla fine <strong>del</strong>l’Ottocento, leggiamo cosa egli ci<br />
riferisce a proposito <strong>del</strong>la zona <strong>del</strong>l’attico:<br />
“Allorquando io rilevai i disegni di questo<br />
monumento potei discendere nel vuoto sotto questa<br />
volto [si riferisce al secondo arco presente<br />
nella zona <strong>del</strong>l’attico] per una botola che vi esisteva<br />
in un fianco, sotto la cucina <strong>del</strong>l’episcopio;<br />
ma ora vi si può pervenire dal vicino ospedale di<br />
San Gaetano, al quale questo vuoto è stato<br />
aggregato da un paio di anni per concessione<br />
temporanea <strong>del</strong> nostro Emin. Arcivescovo<br />
[Cardinale Camillo Siciliano Di Rende], che ne<br />
aveva il possesso. Al presente tal vuoto è stato<br />
ridotto ad uso di stanza, ed è stata aperta una<br />
finestra nel muro meridionale…oggi l’interno è<br />
stato pure intonacato a nuovo; ma allorquando<br />
io vi penetrai la prima fiata vi era un intonaco<br />
antico su porzione <strong>del</strong>le pareti con avanzi di pitture<br />
e molte iscrizioni graffite. Supposi che fosse<br />
servito di prigione in una certa epoca, e vi siano<br />
fatti discendere i condannati per la botola per la<br />
quale io vi discesi”. 19<br />
Dunque, per esperienza verificata personale,<br />
il Meomartini ci conferma che ai suoi tempi, al<br />
di sopra <strong>del</strong>l’archivolto principale <strong>del</strong>l’Arco, esistevano<br />
ancora ulteriori due piani di costruzione<br />
di proprietà <strong>del</strong>l’Arcivescovato. Nel primo era<br />
stato ricavato un ambiente abitabile, mentre ai<br />
giorni nostri, che l’Arco è stato liberato, si può<br />
notare il volto dove questa stanza era stata adattata.<br />
Nel secondo piano, invece, trovava posto<br />
una cucina <strong>del</strong> palazzo Arcivescovile, ma questo<br />
ambiente dopo i bombardamenti <strong>del</strong>la seconda<br />
guerra mondiale non è più esistente. La botola<br />
attraverso la quale era disceso il Meomartini,<br />
seppure sussistesse ancora ai giorni nostri, non<br />
potrebbe essere più visibile, visto che l’attico<br />
<strong>del</strong>l’Arco è stato consolidato con uno strato di<br />
cemento. Per il passaggio menzionato che colle-
gava l’ambiente sotto il secondo archivolto<br />
<strong>del</strong>l’Arco all’Ospedale di San Gaetano (dunque<br />
fungeva da collegamento diretto di servizio tra<br />
l’ospedale e il palazzo <strong>del</strong>l’Arcivescovo), diversamente,<br />
è possibile accertarne l’esistenza, visto<br />
che attualmente alla costruzione romana non è<br />
addossato più alcun edificio. Ed infatti, alla sommità<br />
<strong>del</strong> pilastro occidentale, si può tutt’oggi<br />
scorgere questo varco aperto nell’attico.<br />
Rispetto all’incisione di fine Settecento, dopo<br />
circa un secolo, non si registrano per il nostro<br />
Arco sostanziali cambiamenti. Una foto pubblicata<br />
da Meomartini nel volume Benevento con<br />
144 illustrazioni edito a Bergamo nel 1909,<br />
mostra che al di sopra <strong>del</strong>l’archivolto sussistono<br />
sempre due piani, e più specificamente sembra<br />
che la muratura sia sensibilmente aumentata in<br />
altezza. C’è la finestra descritta da Meomartini, e<br />
salendo ancora si scorge una seconda finestra<br />
sulla sinistra. Mentre tra le due finestre, ad Occidente,<br />
si osserva pure bene e ancora esistente il<br />
blocco di muratura che fuoriesce dalla struttura<br />
che si è già in precedenza esaminato. La porzione<br />
al di sopra <strong>del</strong> fornice risulta quasi completamente<br />
intonacata, viceversa nelle zone laterali<br />
<strong>del</strong>l’Arco affiora la struttura primigenia di mattoni.<br />
Anche in alcune fotografie di fine Ottocento<br />
e di inizio Novecento che riguardano la porzione<br />
inferiore <strong>del</strong>l’Arco <strong>del</strong> Sacramento si evince<br />
che la situazione non mostra sostanziali cambiamenti.<br />
Ad Occidente si vede sempre la casa <strong>del</strong>l’avvocato<br />
Torre, e le linee <strong>del</strong>l’archivolto e degli<br />
archi <strong>del</strong>le edicole sono individuabili dalla<br />
muratura in laterizi, così come si osservano<br />
anche i blocchi in cinque filari sovrapposti agli<br />
stilobati. Sussistono ancora qualche pezzo <strong>del</strong>le<br />
piccole cornici d’imposta al di sopra <strong>del</strong>la cimasa<br />
degli stilobati e all’inizio <strong>del</strong>la curvatura <strong>del</strong><br />
fornice. La nicchia destra è riempita di legante<br />
misto a pietrisco in opera incerta. Dalla fotografia<br />
si nota anche che l’illuminazione elettrica sta<br />
sostituendo le lampade a petrolio. Via Carlo<br />
Torre è ormai un suggestivo e stretto vicolo<br />
dove salendo si osserva il bel pontile sovrastato<br />
ormai da una considerevole porzione di muratura.<br />
Il contesto architettonico <strong>del</strong>la zona <strong>del</strong>l’Arco<br />
<strong>del</strong> Sacramento risulta stabile, 20 quindi, nelle sue<br />
VINCENZO INTORCIA<br />
- 55 -<br />
caratteristiche principali fino ai bombardamenti<br />
anglo-americani che colpiscono Benevento nell’agosto<br />
e nel settembre <strong>del</strong> 1943, nel corso <strong>del</strong>la<br />
campagna di liberazione dal nazi-fascismo. Il<br />
Piano regolatore redatto da Luigi Piccinato nel<br />
1932 non prevedeva alterazioni rilevanti nella<br />
zona <strong>del</strong> centro storico e si pose comunque in<br />
maniera sostanzialmente eccentrica, per la considerazione<br />
deputata all’edilizia storica rispetto<br />
ai progetti in parte eseguiti in parte paventati<br />
dalla retorica <strong>del</strong> regime fascista, risultando tuttavia<br />
ineffettivo per l’ostracismo politico e l’avvento<br />
<strong>del</strong>la guerra; mentre neanche gli invocati<br />
interventi di risanamento <strong>del</strong>l’edilizia storica <strong>del</strong><br />
quartiere “Triggio”, subito a Sud <strong>del</strong>l’Arco <strong>del</strong><br />
Sacramento, ritenuta dall’ing. Antonio Fabrizio<br />
“meschine casupole”, furono mai attuati. 21<br />
L’area compresa tra piazza Orsini e piazza<br />
Cardinal Pacca fu una <strong>del</strong>le zone più colpite nel<br />
secondo conflitto bellico. Ad eccezione <strong>del</strong> campanile<br />
e <strong>del</strong>la facciata, il Duomo è completamente<br />
distrutto, altrettanto il Palazzo arcivescovile.<br />
Nello spazio ad Ovest <strong>del</strong>l’Arco <strong>del</strong> Sacramento<br />
una profonda ferita si apre nel tessuto edilizio. Le<br />
case e l’Ospedale femminile di San Gaetano vengono<br />
rasi al suolo. Tra le macerie affiorano, dopo<br />
che erano stati coperti dalle abitazioni, i resti<br />
<strong>del</strong>le costruzioni romane <strong>del</strong>l’area <strong>del</strong> Foro.<br />
Agli inizi degli anni Cinquanta, dall’allora<br />
Sovrintendente A. De Franciscis, fu condotta una<br />
prima campagna di scavi: “Nella zona tra il<br />
Duomo ed il fiume Calore, dove attraverso gli<br />
eventi bellici s’erano rivelati numerosi ruderi<br />
antichi, si è sterrata un’area limitata prospiciente<br />
il fianco <strong>del</strong> Duomo. Son venuti in luce i resti<br />
di un grandioso edificio, probabilmente termale,<br />
d’età romana imperiale, che comprende in particolare<br />
una grande aula rettangolare con pilastri<br />
in muratura addossati alle pareti e con tracce<br />
di un doppio pavimento; una seconda aula,<br />
anch’essa con tracce di doppio pavimento e una<br />
suspensura; un’aula rettangolare col piano leggermente<br />
sopraelevato rispetto alle precedenti,<br />
con ingressi sui quattro lati, tracce <strong>del</strong>la volta ed<br />
elementi di un piano superiore, e con vasche<br />
quadrate nel pavimento, ma forse costituenti un<br />
rifacimento posteriore; infine una sala poligonale<br />
solo in parte esplorata, probabilmente a pian-
ta esagonale con vasca rivestita di lastre di<br />
marmo nel pavimento. Essendo i ruderi enucleati<br />
in abitazioni medievali e moderne, lo scavo ha<br />
dato scarsi reperti di materiale vario. Tra questi<br />
si nota qualche base e qualche mozzo di colonna<br />
ed un capitello corinzio, probabilmente pertinenti<br />
alla decorazione <strong>del</strong>l’edificio”. 22<br />
I complessi romani riportati in luce non furono<br />
però oggetto di un restauro dai criteri scientifici<br />
con la conseguente conservazione e valorizzazione<br />
dei ruderi emersi, né fino ai giorni<br />
nostri sono stati completamente liberati dalle<br />
abitazioni che ne incastellavano le strutture.<br />
Furono consolidati in fretta e qua e là furono<br />
eretti dei barbacani in tufo per puntellarli e preservarli<br />
da ulteriori demolizioni. Nell’area più a<br />
Sud subito ad Occidente <strong>del</strong>l’Arco <strong>del</strong><br />
Sacramento, è stato inoltre rinvenuto un secondo<br />
Arco romano, in posizione obliqua rispetto il<br />
nostro monumento, completamente inglobato in<br />
un’abitazione. Ad esso si ammorsa un tratto<br />
<strong>del</strong>la prima cinta difensiva longobarda in opus<br />
incertum. È possibile però osservare di questo<br />
altro Arco romano la struttura in opera di mattoni<br />
molto simile a quella <strong>del</strong>l’Arco <strong>del</strong><br />
Sacramento, e dal terreno affiorano due filari dei<br />
blocchi <strong>del</strong> basamento. Probabilmente questo<br />
Arco costituì un secondo ingresso da Sud all’area<br />
<strong>del</strong> Foro.<br />
Venendo adesso alla situazione <strong>del</strong>l’Arco <strong>del</strong><br />
Sacramento, si deve purtroppo registrare che<br />
nessun resoconto e relazione degli interventi<br />
subiti dal monumento è stata mai pubblicata<br />
dalla Soprintendenza. Dal materiale fotografico<br />
a disposizione è però possibile dedurre alcune<br />
conclusioni di come siano andate le vicende. È<br />
verosimile che l’Arco <strong>del</strong> Sacramento sia stato<br />
interessato a più riprese da restauri nel corso dei<br />
primi tre decenni dopo i bombardamenti. In un<br />
primo momento è infatti probabile che sia stato<br />
soltanto liberato, insieme all’area sulla quale<br />
insiste, dalle macerie <strong>del</strong>la guerra. Le prime fotografie<br />
di cui si è in possesso risalgono alla fine<br />
degli anni Cinquanta o agli inizi degli anni<br />
Sessanta. Alle spalle <strong>del</strong>l’Arco si vede già ricostruito<br />
il palazzo Arcivescovile edificato, insieme<br />
al Duomo, su progetto <strong>del</strong>l’architetto romano<br />
Paolo Rossi De Paoli, a partire dal 1952. 23 A<br />
SALTERNUM<br />
- 56 -<br />
monte <strong>del</strong>la zona è già stato costruito il palazzo<br />
(ex Upim), mentre ancora non sono stati innalzati<br />
gli altri edifici che come vedremo circonderanno<br />
l’area dalla metà degli anni Sessanta.<br />
L’Arco <strong>del</strong> Sacramento si presenta completamente<br />
isolato sia dalla fabbrica <strong>del</strong> vecchio<br />
Episcopio sia dalle case e dall’ospedale ad Occidente.<br />
Il pilastro ovest sulla facciata meridionale<br />
mostra di essere stato sventrato al momento<br />
<strong>del</strong>la liberazione dalle abitazioni, ed alcuni suoi<br />
blocchi giacciono ancora riversi sul terreno. I<br />
parallelepipedi <strong>del</strong>lo stilobate occidentale nel<br />
cantone esterno, invece, si presentano in buone<br />
condizioni poiché qui, probabilmente, la muratura<br />
<strong>del</strong>le abitazioni vi era solamente addossata.<br />
Si conservano bene lo zoccolo e la cimasa <strong>del</strong><br />
pilastro, e sono venute alla luce un pezzo <strong>del</strong>la<br />
piccola cornice di marmo che decorava l’Arco e<br />
più in su il solco da essa lasciata. Le nicchie<br />
sulle pilastrate sono state interamente svuotate,<br />
e l’arco non mostra più alcuna traccia di intonaco<br />
sulla muratura a vista di mattoni. Nella zona<br />
<strong>del</strong>l’attico il secondo arco di scarico è stato liberato<br />
dalle abitazioni ricavate sin dal Settecento,<br />
e alla sommità <strong>del</strong>l’archivolto è stato liberato dal<br />
secondo ambiente un tempo adibito a cucina<br />
<strong>del</strong>l’Episcopio. A destra <strong>del</strong> pilastro orientale<br />
<strong>del</strong>l’Arco è inoltre venuta allo scoperto una<br />
parte di muratura romana con due ordini di<br />
archi in mattoni che si ammorsa direttamente nel<br />
cantone <strong>del</strong> pilastro, e ad Est si congiunge con<br />
un'altra muraglia sempre romana di grossi blocchi<br />
di parallelepipedi di struttura pseudisodoma.<br />
24<br />
I profili generali murari <strong>del</strong>l’Arco, dunque, si<br />
mostrano abbastanza consunti, segno che dalla<br />
prima fase di liberazione <strong>del</strong>la struttura ancora<br />
non si è passati alla fase di consolidamento <strong>del</strong>la<br />
muratura. Faccio inoltre notare che sulla superficie<br />
<strong>del</strong> monumento sono cresciuti abbondantemente<br />
cespugli di vegetazione spontanea, indice,<br />
questo, che forse già da qualche anno l’Arco<br />
è stato interessato dal primo intervento.<br />
Nel volume di F. Romano edito nel 1968,<br />
all’interno di un paragrafo dedicato all’Arco <strong>del</strong><br />
Sacramento si legge la seguente informazione:<br />
“L’Arco, inferiore a quello di Traiano solo per<br />
le dimensioni e per le sculture, ultimamente è
stato oggetto di una frettolosa riparazione non<br />
secondo le regole <strong>del</strong> restauro dei monumenti.<br />
Per la piena valorizzazione <strong>del</strong> monumento è<br />
opportuno che si proceda alla sistemazione <strong>del</strong>la<br />
zona”. 25<br />
La fotografia a corredo <strong>del</strong> paragrafo, <strong>del</strong>la<br />
fine degli anni Sessanta (l’area <strong>del</strong> Sacramento si<br />
presenta difatti aggredita dalla mole dei palazzi<br />
moderni), ci mostra una situazione <strong>del</strong>le strutture<br />
<strong>del</strong>l’Arco molto diversa rispetto a quanto si<br />
poteva osservare nell’immediato dopoguerra. Il<br />
monumento, infatti, è stato interessato da un<br />
intervento volto al rafforzamento <strong>del</strong>le murature.<br />
Per quanto riguarda la facciata meridionale,<br />
nello stilobate Ovest, quello più danneggiato,<br />
nell’ultimo filare di pietre, in corrispondenza<br />
con l’apertura <strong>del</strong>l’edicola, il vuoto presente è<br />
stato colmato con una fascia di cemento. La stessa<br />
cosa si ripete alla base <strong>del</strong>l’altra nicchia nel<br />
pilastro orientale. Ma ad osservare bene tutta la<br />
muratura, si nota che un po’ in ogni punto dove<br />
la superficie in laterizi era disgregata, i fori sono<br />
stati riempiti con getti di cemento. Soprattutto in<br />
corrispondenza <strong>del</strong>l’imposta dei volti <strong>del</strong>le edicole,<br />
dove correvano le cornici marmoree, i solchi<br />
lasciati dalla loro asportazione sono stati<br />
ricoperti sempre con materiale cementizio. Un<br />
uso altrettanto abbondante se ne è fatto anche<br />
nella facciata settentrionale, nella corona <strong>del</strong> fornice,<br />
nei pilastri <strong>del</strong>le nicchie ed in modo veramente<br />
copioso nell’attico. Uno strato spesso di<br />
cemento, infine, ricopre come una fodera la<br />
sommità <strong>del</strong>l’attico e la spalla di muratura sopra<br />
la nicchia orientale. Riguardo il fronte settentrionale<br />
<strong>del</strong>l’Arco vi è da notare che qui <strong>del</strong>la decorazione<br />
marmorea originaria permangono attualmente<br />
una colonna sulla pilastrata occidentale<br />
(rifissata alla muratura in modo molto approssimativo),<br />
e due pezzi <strong>del</strong> fregio alla sommità di<br />
essa che lasciano intuire come fosse costituita la<br />
trabeazione. Lo spigolo nord-est <strong>del</strong> pilastro<br />
orientale, inoltre, ha perso i suoi blocchi calcarei<br />
<strong>del</strong> dado e <strong>del</strong>la cimasa, e salendo con lo<br />
sguardo si incontra nell’attico il passaggio che<br />
collegava l’ambiente installato nel secondo arco<br />
di scarico all’Ospedale di S. Gaetano.<br />
Il consolidamento <strong>del</strong>la muratura, però, non<br />
si è limitato solo a getti di cemento: soprattutto<br />
VINCENZO INTORCIA<br />
- 57 -<br />
ai lati <strong>del</strong>l’archivolto e nell’attico <strong>del</strong>la facciata<br />
meridionale, i profili <strong>del</strong>l’Arco sono stati ripristinati<br />
con <strong>del</strong> pietrisco di piccola grandezza <strong>del</strong><br />
tipo ad opus incertum. La medesima soluzione<br />
si osserva, in maniera più limitata, alla sommità<br />
<strong>del</strong>l’attico <strong>del</strong> fronte settentrionale. Ora, data la<br />
evidente disparità dei due metodi adottati, sembrerebbe<br />
quasi di trovarsi di fronte a due distinti<br />
interventi di restauro. Ad ogni modo se risulta<br />
<strong>del</strong> tutto accettabile la scelta di ripristinare le<br />
linee di inviluppo <strong>del</strong>l’Arco con la differenziazione<br />
però dei materiali e <strong>del</strong>l’opera muraria in<br />
pietrisco rispetto all’opera originale in laterizi<br />
<strong>del</strong>l’Arco (e questa soluzione rende subito evidenti<br />
gli inserti come opera moderna ma non<br />
fortemente dissonante nei confronti <strong>del</strong>l’opera<br />
antica, secondo i corretti principi <strong>del</strong> restauro<br />
dei monumenti che mirano anzitutto a consolidare<br />
la struttura per trasmetterla al futuro nel<br />
rispetto <strong>del</strong>l’istanza estetica <strong>del</strong> monumento,<br />
senza commettere un falso artistico e un falso<br />
storico) appare al contrario <strong>del</strong> tutto approssimativa,<br />
superficiale, poco decorosa e irrispettosa,<br />
la rappezzatura <strong>del</strong>le chiazze di cemento,<br />
che sembra essere stato applicato in maniera<br />
frettolosa, senza alcun riguardo per l’estetica <strong>del</strong><br />
monumento.<br />
Ma il fattore che ha compromesso maggiormente<br />
una corretta conservazione <strong>del</strong>l’area<br />
monumentale <strong>del</strong>l’Arco fu lo sviluppo urbanistico<br />
<strong>del</strong> dopoguerra. Il Piano di Ricostruzione<br />
post-bellica <strong>del</strong> 1947, 26 infatti, che rimase in<br />
sostanza in vigore fino all’approvazione <strong>del</strong><br />
Piano Regolatore <strong>del</strong> 1970, 27 consentì un’elevata<br />
proliferazione <strong>del</strong>le volumetrie nell’edificazione<br />
dei nuovi edifici, anche per quelli subentranti<br />
sul suolo <strong>del</strong>le abitazioni distrutte nel centro storico.<br />
Così nel corso degli anni Cinquanta e<br />
Sessanta vediamo sorgere nell’intorno <strong>del</strong><br />
Duomo e <strong>del</strong>l’Arco <strong>del</strong> Sacramento tutta una<br />
serie di costruzioni che superano costantemente<br />
i sette piani di altezza. I caratteri architettonici e<br />
ambientali <strong>del</strong>l’area storica di via Carlo Torre<br />
sono stati in questo modo irrimediabilmente<br />
compromessi. Scomparsa quasi <strong>del</strong> tutto l’edilizia<br />
minore prebellica che, seppur priva di specifici<br />
caratteri monumentali, garantiva comunque<br />
una compatta armonia <strong>del</strong>l’insieme <strong>del</strong> costruito,
l’area <strong>del</strong>l’Arco è soffocata dall’arroganza speculativa<br />
<strong>del</strong>le costruzioni moderne. Né il Piano<br />
regolatore di Luigi Piccinato <strong>del</strong> 1958, 28 che prevedeva<br />
una più contenuta e tipologicamente<br />
corretta ricostruzione edilizia, insieme all’individuazione<br />
di diverse aree di salvaguardia nel<br />
centro storico soprattutto quella nella zona <strong>del</strong><br />
Teatro, riuscì ad invertire la tendenza, perché<br />
prima osteggiato e poi reso ineffettivo dal ‘partito<br />
dei costruttori’.<br />
Ma la vicenda che di più ha pregiudicato i<br />
valori storici <strong>del</strong>l’area fu la concessione di una<br />
licenza edilizia per una costruzione a soli pochi<br />
metri ad Ovest <strong>del</strong>l’Arco, nel cuore <strong>del</strong>la zona di<br />
grande rilevanza archeologica: “A seguito di una<br />
edificazione avviata alla fine degli anni ’60 in<br />
attuazione di un superficiale Piano di<br />
Ricostruzione, l’area si presenta, ad una lettura<br />
aerea, nettamente divisa in due parti…la parte<br />
più vicina all’Arco <strong>del</strong> Sacramento è stata interessata,<br />
a partire dai primi anni ’60, da una<br />
campagna di scavi archeologici che una poco<br />
esigente (rispetto agli attuali criteri conservativi)<br />
Soprintendenza archeologica ritenne all’epoca<br />
di poter concludere senza necessità di preservare<br />
alcuna struttura. Sull’area di tale scavo venne<br />
avviata la costruzione di un grande (circa<br />
14.000 metri cubi) edificio residenziale. Di tale<br />
edificio, interrotto per la decadenza <strong>del</strong>la<br />
Licenza Edilizia fortunatamente non rinnovata,<br />
restano oggi le fondazioni e gli imponenti pilastri”.<br />
29<br />
Dunque sull’area <strong>del</strong>l’antico Foro romano fu<br />
prima concessa, e poi avallata finanche dal giudizio<br />
<strong>del</strong>la Soprintendenza competente la<br />
costruzione di un edificio di sette piani.<br />
SALTERNUM<br />
- 58 -<br />
Nel 1970, però, il Comune aveva approvato il<br />
nuovo Piano Regolatore e all’atto <strong>del</strong>la richiesta<br />
<strong>del</strong> rinnovo <strong>del</strong>la Licenza Edilizia presentò il suo<br />
diniego. Purtroppo, nel frattempo, il getto <strong>del</strong>le<br />
fondazioni era già stato effettuato, ed erano stati<br />
innalzati una serie di pilastri in cemento armato.<br />
In attesa che se ne decidesse il nuovo destino,<br />
l’intera area di via Carlo Torre fu lasciata al<br />
degrado e assalita dallo sviluppo spontaneo<br />
<strong>del</strong>la vegetazione, completamente in abbandono<br />
per oltre un trentennio.<br />
Il Piano Particolareggiato <strong>del</strong> centro storico in<br />
attuazione al P.G.R. <strong>del</strong> Settanta, redatto da Bruno<br />
Zevi e Sara Rossi, che prevedeva un progetto di<br />
massima per la riqualificazione <strong>del</strong>l’area, vide la<br />
sua stesura, infatti, solo nel 1978, 30 per essere<br />
però ritirato nel 1982 a seguito <strong>del</strong>le urgenti problematiche<br />
urbanistiche emerse dopo il terremoto<br />
<strong>del</strong> 1980 che colpì la città di Benevento. Nel<br />
1985 si decise così la redazione di una Variante<br />
Generale al Piano Regolatore, che comportò la<br />
progettazione di ulteriori Piani Particolareggiati,<br />
affidati sempre al gruppo Zevi-Rossi, approvati<br />
nel 1989. 31 La zona ad Ovest <strong>del</strong> Duomo viene<br />
quindi indicata come area interessata ad un Piano<br />
di Recupero in base alle prescrizioni <strong>del</strong> piano<br />
particolareggiato <strong>del</strong> 1989. Solo alle soglie <strong>del</strong><br />
Duemila si giunti però al bando di un “Concorso<br />
nazionale di progettazione per il recupero e la<br />
valorizzazione <strong>del</strong>l’area nodale Arco <strong>del</strong><br />
Sacramento” per tentare di offrire una decorosa<br />
sistemazione ad una <strong>del</strong>le più importanti zone,<br />
carica di memorie, <strong>del</strong> tessuto urbanistico e <strong>del</strong><br />
patrimonio storico-artistico di Benevento.
NOTE<br />
1 R. GARRUCCI, 1875, pp. 78-79.<br />
2 E. ISERNIA, 1895, p. 424 vol. I, p. 145 vol. II; D. PETROCCIA, in<br />
F. ROMANO, 1968, p. 115.<br />
3 M. ROTILI, 1986, pp. 86-87.<br />
4 A ZAZO, Le chiese parrocchiali di Benevento <strong>del</strong> XII-XIV<br />
secolo, in “Samnium” 1959, n. 1/2, p. 98.<br />
5 S. BORGIA, 1769, ristampa fotomeccanica 1968, vol. II. p. 420,<br />
6 D. PETROCCIA, 1968, p. 130.<br />
7 Un’indicazione in proposito potrebbe essere fornita dalla<br />
pietra sicuramente non appartenente alla costruzione originaria<br />
sullo stilobate ovest, nel fronte nord, posta alla sommità<br />
<strong>del</strong> dado, con il lato verso l’esterno che presenta la raffigurazione<br />
di un vaso da cui fuoriescono dei tralci. Come<br />
argomentato, infatti, l’Arco in epoca romana dovette certamente<br />
essere rivestito da lastre di marmo, la qual cosa, quindi,<br />
fa escludere che tale blocco si trovasse in opera originariamente<br />
al di sotto <strong>del</strong>la fodera marmorea, né la consuetudine<br />
costruttiva dei romani, che per queste costruzioni usavano<br />
materiale tutto prodotto ex novo, induce a pensare<br />
contrariamente. Si deve perciò concludere che già in epoca<br />
medievale, l’Arco <strong>del</strong> Sacramento, già spoglio di parte <strong>del</strong><br />
suo rivestimento, fu interessato da un intervento di consolidamento<br />
e sistemazione <strong>del</strong>le sue strutture che portò alla<br />
collocazione sullo stilobate di questo blocco.<br />
8 A. MEOMARTINI, 1889, p. 224.<br />
9 M. TURDEK, 1965; “Cardinale Agostino Oregio <strong>del</strong> tit. di S.<br />
Sisto, Arcivescovo LVI eletto da papa Urbano VIII a’ 17 di<br />
novembre 1633. Ne prese il possesso a’ 16 di dicembre <strong>del</strong>lo<br />
stesso anno. Sedette un anno, mesi sette, giorni 25. Morì in<br />
Benevento a’ 12 di luglio 1635; P. SARNELLI, 1691, p. 151.<br />
10 Il lungo episcopato (1686-1724) a Benevento di frate<br />
Vincenzo Maria Orsini <strong>del</strong>l’ordine dei Predicatori, lascia un<br />
impronta sulla città <strong>del</strong>la sua forte personalità, <strong>del</strong> magistero<br />
<strong>del</strong>la Chiesa e, soprattutto, segna il volto di un notevole<br />
cambiamento nel tessuto urbano e nei suoi monumenti. G.<br />
GIORDANO, L’impegno missionario <strong>del</strong> card. V. M. Orsini,<br />
Benevento 1982, p. 29; per una fonte diretta vedi: I primi<br />
diari beneventani <strong>del</strong> card. V.M.Orsini, a cura di G.<br />
GIORDANO, Benevento 1984. La prova di gran lunga più difficile<br />
e gravosa per il cardinale Orsini e per Benevento furono<br />
i terremoti distruttori <strong>del</strong> 5 giugno 1688 e <strong>del</strong> 14 marzo<br />
1702, che rovinarono in macerie copiosa parte <strong>del</strong> costruito.<br />
Lo stesso Orsini, sorpreso nel suo palazzo e fortunosamente<br />
scampato ai crolli, lo vediamo subito affaccendarsi tra i detriti<br />
e, per la ricostruzione, attingere al suo patrimonio personale<br />
di famiglia, chiamare in città gli architetti: Raguzzini,<br />
Buratti e Nauclerio. Gli eventi sismici arrecano gravi danni e<br />
aprono ferite in vari punti di Benevento, in particolare nell’area<br />
che ci interessa, dov’è sito l’Arco <strong>del</strong> Sacramento, notevoli<br />
guasti vengono riportati dalla Cattedrale e dal palazzo<br />
vescovile. L’Orsini, che non ama il fasto barocco dei superflui<br />
ornamenti, degli apparati teatrali, nella ricostruzione<br />
sembra già orientato verso quella semplificazione e sobrietà<br />
<strong>del</strong>le architetture e decorazioni che nel giro di pochi anni<br />
spingeranno, soprattutto con anticipo a Roma, le forme <strong>del</strong><br />
Barocco non verso l’evanescenza <strong>del</strong> Rococò, ma nel solco<br />
<strong>del</strong>la stagione neoclassica. Applica, quindi, alle strutture<br />
danneggiate e nelle ricostruzioni quella sua particolare visione<br />
<strong>del</strong> ‘restauro’ che si concretizza: “nel ridurre la proporzione<br />
degli edifici alla simmetria <strong>del</strong>lo spazio”. Una pratica, non<br />
bisogna dimenticare, dettata anche dalle necessità economi-<br />
VINCENZO INTORCIA<br />
- 59 -<br />
che. Di questo tono sono proprio gli interventi che porteranno<br />
all’abbattimento di una <strong>del</strong>le navate <strong>del</strong>la Cattedrale, precisamente<br />
quella retrostante il campanile, e la ricostruzione<br />
<strong>del</strong> palazzo arcivescovile alla chiesa contiguo. S. BASILE,<br />
Restauri settecenteschi a Benevento, in “Samnium”, Napoli n.<br />
3/4, 1970.<br />
11 Dalla fine <strong>del</strong> Settecento e soprattutto nel corso<br />
<strong>del</strong>l’Ottocento, l’Italia è la meta prediletta di viaggiatori, artisti,<br />
uomini di cultura. Al di là di personaggi molto conosciuti<br />
come Goethe o Stendhal, è tutta la società europea di certa<br />
una certa cultura <strong>del</strong>l’epoca ad essere attratta dalle bellezze<br />
artistiche e dal patrimonio storico <strong>del</strong> nostro Paese. Così, da<br />
autodidatti, o alla fine dei corsi di studi alle accademie <strong>del</strong>le<br />
belle arti di tutta Europa, i giovani venivano in Italia per<br />
quello che fu detto il grand tour <strong>del</strong>la cultura, tappa ormai<br />
quasi obbligata di una completa formazione. Le soste principali<br />
erano naturalmente le città di Roma, Napoli, Milano,<br />
Firenze, Genova, Bologna, Venezia, e i viaggiatori affascinati<br />
dai paesaggi naturali e artistici lasciavano spesso nei loro<br />
diari i resoconti <strong>del</strong>le impareggiabili bellezze visitate. Anche<br />
numerosi artisti si spostavano, attratti dalle opere <strong>del</strong>l’antichità,<br />
diffondendo, tramite i loro quaderni di vedute e di<br />
‘viaggi pittoreschi’, l’immagine dei luoghi osservati. In tutto<br />
questo pellegrinaggio di ‘turisti’ (sicuramente più coscienti e<br />
preparati dei loro corrispettivi contemporanei), la città di<br />
Benevento, pur non essendo al centro dei percorsi principali,<br />
attirava anch’essa numerosi artisti italiani e stranieri. Da<br />
Luigi Vanvitelli a Carlo Labruzzi, da Gian Paolo Pannini a<br />
Jean Du Plessys Berteaux, Saverio Casselli, Achille Vianelli,<br />
Nicola Palizzi, fino al grande Giovan Battista Piranesi, soprattutto<br />
richiamati dal maestoso esempio <strong>del</strong>l’Arco di Traiano,<br />
ma affascinati poi anche dagli altri monumenti quali il<br />
Teatro, il Ponte Leproso, i Santi Quaranta, e da aspetti caratteristici<br />
<strong>del</strong>le vie di Benevento che seducevano la curiosità<br />
<strong>del</strong> loro occhio, ci lasciarono stupendi disegni e testimonianze<br />
<strong>del</strong>la città <strong>del</strong>l’epoca (cfr. G. ANIELLO, 1982).<br />
12 Artista abilissimo nello schizzo e nella veduta, venne a<br />
Roma al seguito <strong>del</strong> conte Tessè. Collaborò, così, largamente<br />
al Voyage pittoresque <strong>del</strong> Saint-Non. A 69 anni, per incarico<br />
di Napoleone, diresse la pubblicazione di una monumentale<br />
opera dedicata all’Egitto. E. GALASSO (a cura di), 1965, p. 23<br />
13 Il nome suggerisce che ormai nel Settecento il monumento<br />
non veniva già più considerato nelle sue caratteristiche<br />
originali di arco onorario, ma secondo la funzione urbanistica<br />
storica di porta <strong>del</strong>la città medievale.<br />
14 A. MEOMARTINI, 1889, pp. 234-235.<br />
15 In questa pianta, infatti, le sagome degli edifici sono <strong>del</strong>ineati<br />
in maniera schematica secondo i loro contorni di massima,<br />
non seguendo una misurazione reale poi riportata<br />
sulla mappa in scala. Per le maggiori emergenze monumentali<br />
invece si ricorre ad una rappresentazione degli edifici in<br />
alzato, ma la raffigurazione assume più una valenza descrittiva<br />
non seguendo le regole <strong>del</strong>la prospettiva. Tuttavia, nel<br />
suo complesso, la Pianta <strong>del</strong> Piazzella <strong>del</strong>inea un’attendibile<br />
viabilità <strong>del</strong>la città pontificia di Benevento, dei suoi contorni<br />
dentro le mura e <strong>del</strong>la posizione dei maggiori edifici.<br />
16 Formatosi a Bologna e a Roma, operò quale architetto in<br />
molte città italiane, collaborando con il Canova nei disegni<br />
per la chiesa di Possagno. Gli studi prospettici per la basilica<br />
di S. Pietro a Roma furono i suoi primi tentativi nel campo<br />
<strong>del</strong>l’incisione, dove in breve tempo acquistò larga fama. Le<br />
stampe di soggetto beneventano, comprese nella raccolta Gli
archi di trionfo degli antichi Romani (1836) e nel Viaggio<br />
pittoresco da Roma a Napoli (1839) mostrano l’influsso di<br />
Piranesi. E. GALASSO (a cura di), 1965, p. 24.<br />
17 M. BOSCIA- F. BOVE, in F. ROMANO, 1968, p. 153.<br />
18 A. MEOMARTINI, 1889, p. 219.<br />
19 A. MEOMARTINI, 1889, pp. 231-232.<br />
20 Devo però riportare in nota il commento ad una fotografia<br />
<strong>del</strong>l’Arco <strong>del</strong> Sacramento che suscita alcuni interrogativi non<br />
facili da risolvere nella scarsità <strong>del</strong>le informazioni a disposizione.<br />
A pagina 204 <strong>del</strong> volume di F. ROMANO, <strong>del</strong> 1968, è<br />
infatti pubblicata un’immagine <strong>del</strong>l’Arco con una didascalia<br />
che reca genericamente: “L’Arco <strong>del</strong> Sacramento nell’anteguerra”.<br />
Il commento non specifica null’altro e non mi è<br />
stato possibile trovare gli estremi cronologici di detta fotografia.<br />
Intanto questa è l’unica immagine un po’ indietro nel<br />
tempo che mostra la facciata settentrionale <strong>del</strong>l’Arco, e purtroppo<br />
appare non di buona qualità ed è abbastanza sfocata.<br />
Come detto in precedenza qui si notano ancora le decorazioni<br />
nelle pilastrate e nell’archivolto fatte eseguire probabilmente<br />
dal vescovo Oregio (1633-1635). Le perplessità<br />
nascono però dal fatto che da un confronto tra la suddetta<br />
fotografia e le foto di fine Ottocento e di inizio Novecento<br />
che si è adesso esaminate, la situazione <strong>del</strong>l’Arco appare<br />
molto diversa tra i due termini di paragone. Se si prende per<br />
buona la didascalia <strong>del</strong>la foto di Romano, bisognerebbe<br />
necessariamente concludere invece che la zona e l’Arco <strong>del</strong><br />
Sacramento hanno subito profondi mutamenti. Innanzitutto<br />
l’Arco mostra di aver perso al di sopra <strong>del</strong> fornice i due piani<br />
di costruzione ancora sussistenti fino agli inizi <strong>del</strong><br />
Novecento. I contorni est e ovest sono inoltre liberi e non<br />
più completamente inglobati nelle fabbriche <strong>del</strong>l’Episcopio e<br />
<strong>del</strong>l’Ospedale. In via Carlo Torre non si vedono più i prospetti<br />
degli edifici che si congiungevano all’Arco, come<br />
mostrano diversamente le vedute sotto il fornice <strong>del</strong>le foto<br />
antecedenti, e al posto di queste costruzioni vi sono due<br />
muri rettilinei. L’atmosfera <strong>del</strong>la strada appare dunque libera<br />
e ariosa, in netto contrasto con le indicazioni sin qui accumulate.<br />
Si sarebbe quindi indotti a considerare che tra le due<br />
guerre siano intervenuti profondi mutamenti. Ma l’entità<br />
stessa dei cambiamenti a mio avviso non giustifica la collocazione<br />
<strong>del</strong>l’immagine tra i due conflitti bellici mondiali.<br />
Sono invece propenso a credere che la foto riproduca una<br />
situazione già posteriore ai bombardamenti, che spiegherebbero<br />
meglio le variazioni. Come esporrò nelle pagine<br />
seguenti, sono convinto che l’Arco <strong>del</strong> Sacramento fu interessato<br />
non da uno, ma da più interventi di restauro nel<br />
corso <strong>del</strong>la fine degli anni Quaranta e negli anni Cinquanta<br />
<strong>del</strong> Novecento. L’immagine di Romano potrebbe allora testimoniare<br />
una situazione intermedia in questi due decenni,<br />
SALTERNUM<br />
- 60 -<br />
una situazione in evoluzione dunque, in progresso, come a<br />
mio parere suggerisce il fatto che nella zona <strong>del</strong>l’attico è presente<br />
una piccola apertura che poi verrà chiusa in concomitanza<br />
con lo svuotamento <strong>del</strong> secondo arco; inoltre, la sommità<br />
<strong>del</strong>l’attico mostra già un contorno netto e deciso non<br />
facilmente ipotizzabile se non in seguito ad un restauro di<br />
chiusura <strong>del</strong>l’alto <strong>del</strong>l’Arco per preservarlo dalle infiltrazioni<br />
degli agenti atmosferici. Infine, il Palazzo arcivescovile, che<br />
prima risultava a filo con la muratura interna <strong>del</strong> pilastro<br />
orientale, non si vede più poiché dopo i bombardamenti che<br />
lo distrussero fu ricostruito leggermente più indietro rispetto<br />
al piano <strong>del</strong> profilo stradale e quello spazio, che adesso nella<br />
foto di Romano è chiuso da un muretto, verrà infine serrato<br />
da una ringhiera per <strong>del</strong>imitare l’accesso alle proprietà <strong>del</strong>la<br />
chiesa, così come è possibile vedere ai giorni nostri.<br />
21 A. BOSCO-P. IADICCIO, in F. ROMANO, 1968, p. 168; G.<br />
VERGINEO, 1985, p. 290; A. FABRIZIO, La bonifica <strong>del</strong> Triggio e<br />
lo scoprimento <strong>del</strong> Teatro Romano, “Il Sannio Fascista”, VII,<br />
n.11, 18 gennaio 1935, p. 3.<br />
22 A DE FRANCISCIS, Benevento. Scavi in “Fasti Archeologici”,<br />
1953, vol. VI, 4573, pp. 346-347.<br />
23 A. JELARDI, 2000, p. 77. La consacrazione <strong>del</strong> nuovo Duomo<br />
avvenne nel 1965.<br />
24 Tale porzione adiacente all’Arco era stata già osservata dal<br />
Meomartini che scriveva: “Da un contiguo sotterraneo <strong>del</strong>l’episcopio<br />
ebbi l’opportunità di osservare che la parete orientale<br />
<strong>del</strong>la pilastrata <strong>del</strong> nostro monumento è libera dalle fabbriche<br />
<strong>del</strong>l’episcopio stesso, essendovi un profondo vuoto<br />
(serve di pozzo nero), ed è rivestita tutta di mattoni. Di là<br />
ebbi occasione di scovrire che parallelamente a detta parete<br />
esiste ancora una muraglia romana, di grossi parallelepipedi<br />
calcarei di struttura pseudisodoma, la quale verrebbe tutta<br />
in luce, ove si demolisse appena il cantone sud-ovest <strong>del</strong><br />
muro <strong>del</strong> giardino <strong>del</strong>l’episcopio, dove al presente esiste una<br />
fontana pubblica”. A. MEOMARTINI, 1889, p. 232. Il cantone<br />
esterno <strong>del</strong> pilastro orientale è, infatti, in buono stato di conservazione<br />
dopo la liberazione poiché, come abbiamo adesso<br />
visto, qui il vecchio palazzo Arcivescovile lasciava un<br />
vuoto.<br />
25 F. ROMANO, 1968, p. 204.<br />
26 A. BOSCO-P. IADICCIO, in F. ROMANO, 1968. p. 169.<br />
27 Ibidem, p. 172.<br />
28 A. JELARDI, 2000, p. 85.<br />
29 G. IADICICCO, P. PALMIERI (a cura di), 2000, p. 15.<br />
30 Quando la zona fu finalmente sottoposta a vincolo urbanistico<br />
ai sensi <strong>del</strong>la legge 1089 <strong>del</strong> 1939. G. IADICICCO, P.<br />
PALMIERI (a cura di), 2000, p. 15.<br />
31 F. BENCARDINO, 1991, p. 84.
BIBLIOGRAFIA<br />
P. SARNELLI, Memorie cronologiche dei Vescovi ed Arcivescovi<br />
<strong>del</strong>la S. Chiesa di Benevento, Napoli 1691.<br />
R. GARRUCCI, Le antiche iscrizioni di Benevento, Roma 1875.<br />
S. BORGIA, Memorie istoriche <strong>del</strong>la pontificia città di<br />
Benevento, Roma 1769, ristampa fotomeccanica, Bologna<br />
1968.<br />
E. ISERNIA, Istoria <strong>del</strong>la città di Benevento dalla sua origine<br />
fino al 1894, Benevento 1895.<br />
A. MEOMARTINI, I monumenti e le opere d’arte <strong>del</strong>la città di<br />
Benevento, Benevento 1889, ristampa Benevento 1979.<br />
A. DE FRANCISCIS, Benevento. Scavi in “Fasti Archeologici”,<br />
1953, vol. VI, 4573, pp. 346-347.<br />
A. ZAZO, Le chiese parrocchiali di Benevento <strong>del</strong> XII-XIV<br />
secolo, in “Samnium” , XXXII, 1959, n. 1-2, pp 60-83.<br />
E. GALASSO (a cura di), Monumenti ed opere d’arte di<br />
Benevento, mostra di incisioni dei secoli XVIII e XIX, Museo<br />
<strong>del</strong> Sannio, Benevento 1965.<br />
M. TURDEK, Il Cardinale Agostino Oreggi, Roma 1965.<br />
D. PETROCCIA, L’evoluzione storica <strong>del</strong>l’urbanistica beneventana,<br />
in F. ROMANO, Benevento cerniera di sviluppo interregionale,<br />
Benevento 1968.<br />
VINCENZO INTORCIA<br />
- 61 -<br />
M. BOSCIA - F. BOVE, Questioni di urbanistica a Benevento<br />
(1860-1914) in F. ROMANO, cerniera di sviluppo interregionale,<br />
Benevento 1968.<br />
A. BOSCO-P. IADICCIO, Da Piccinato a Zevi, in F. ROMANO,<br />
cerniera di sviluppo interregionale, Benevento 1968.<br />
S. BASILE, Restauri settecenteschi a Benevento, in “Samnium”<br />
XLIII, 1970, n. 3-4, pp. 183-205.<br />
G. ANIELLO, Benevento nei ricordi dei viaggiatori italiani e<br />
stranieri, Napoli, 1982.<br />
G. VERGINEO, Storia di Benevento e dintorni, Benevento<br />
1985.<br />
M. ROTILI, Benevento romana e longobarda, l’immagine<br />
urbana, Benevento 1986.<br />
F. BENCARDINO, Benevento, funzioni urbane e trasformazioni<br />
territoriali tra XI e XX secolo, Napoli 1991.<br />
G. IADICCIO, P. PALMIERI (a cura di), Arco <strong>del</strong> Sacramento,<br />
progetti a concorso, Napoli 2000.<br />
A. JELARDI, Benevento antica e moderna, architettura e<br />
urbanistica dall’Unità d’Italia, Benevento 2000.
BIANCA<br />
CANCELLARE
CARLO EBANISTA<br />
La cristianizzazione <strong>del</strong>le aree funerarie nella tarda<br />
antichità: il caso di Cimitile/Nola<br />
Le necropoli di Nola<br />
Sebbene non manchino testimonianze di<br />
sepolcreti nella zona orientale <strong>del</strong>l’attuale<br />
centro urbano di Nola, le principali<br />
aree cimiteriali sorgevano a Nord-Ovest <strong>del</strong>l’abitato<br />
romano 1 . In via S. Massimo, tanto per<br />
segnalare i rinvenimenti di età tardoantica, sono<br />
state scoperte sepolture in anfora e alla cappuccina<br />
che hanno restituito monete di III-IV secolo<br />
d.C. 2 , mentre in via Anfiteatro Laterizio, presso<br />
la necropoli preromana, è stato individuato<br />
uno scarico contenente numerosissimi frammenti<br />
ceramici databili tra il II e il IV secolo d.C. 3 .<br />
Nella località Torricelle, che prende il nome dai<br />
due mausolei visibili ad Ovest <strong>del</strong>la città 4 (fig. 1),<br />
la necropoli sembra disporsi ai lati di un percorso<br />
stradale con orientamento nord-sud che<br />
mostra segni di usura e ricalca forse un percorso<br />
più antico: oltre a tombe ad inumazione di<br />
prima e media età imperiale, sono venute alla<br />
luce sepolture infantili in anfore, a cassa di tufo,<br />
a fossa semplice o alla cappuccina; in uno dei<br />
sarcofagi tufacei, ai piedi <strong>del</strong>la defunta, era<br />
deposto un gruzzolo di dieci sesterzi <strong>del</strong>la prima<br />
metà <strong>del</strong> III secolo d.C. 5 .<br />
Nel suburbio settentrionale, in corrispondenza<br />
<strong>del</strong>l’attuale territorio comunale di Cimitile, è<br />
stata individuata un’area cimiteriale costituita da<br />
una quindicina di mausolei in opus vittatum<br />
mixtum e da tombe sub divo 6 (fig. 2). Le sepolture<br />
in laterizi si succedevano con ordine perfetto<br />
in lunghe <strong>file</strong> all’aperto o serrate entro locali<br />
in gruppi ordinati 7 . I mausolei, che oltre alle<br />
tombe terragne accoglievano arcosoli e sarcofagi<br />
in marmo, corrispondevano in prevalenza ad<br />
unità familiari, destinate purtroppo a rimanere<br />
senza nome perché non si conosce la prove-<br />
- 63 -<br />
Fig. 1 - Nola, località Torricelle. Mausoleo funerario di età romana.<br />
Fig. 2 - Cimitile,<br />
l’area sepolcrale<br />
alla fine <strong>del</strong> III secolo,<br />
pianta ricostruttiva.<br />
nienza esatta <strong>del</strong>le iscrizioni 8 . La presenza di<br />
un’urna cineraria strigilata (fig. 3) risalente al I-<br />
II d.C. potrebbe costituire un utile elemento<br />
datante, qualora ne fosse accertata con sicurezza<br />
la pertinenza al sepolcreto 9 . Analoga considerazione<br />
va fatta per le due lastre di fregio-architrave<br />
con raffigurazioni d’armi anch’esse sistemate<br />
nell’Antiquarium (primo trentennio <strong>del</strong> II<br />
secolo d.C.), laddove fosse provata la loro<br />
appartenenza ad un mausoleo funerario 10 .<br />
L’assoluta predominanza <strong>del</strong>le inumazioni<br />
rispetto al rito <strong>del</strong>l’incinerazione, attestato soltanto<br />
dall’urna (per la quale non si può esclude-
Fig. 3 - Cimitile.<br />
Antiquarium, urna<br />
strigilata.<br />
re <strong>del</strong> tutto la provenienza da un’altra area cimiteriale)<br />
e da tre nicchie (non è chiaro se effettivamente<br />
destinate a cinerari) esistenti nel mausoleo<br />
7, sembrerebbe indicare che il sepolcreto<br />
sorse nel III secolo d.C. 11 . Nella necropoli di<br />
Porto all’Isola Sacra, ad esempio, a partire dai<br />
primi decenni <strong>del</strong> II secolo è documentata la<br />
compresenza dei riti <strong>del</strong>l’incinerazione e <strong>del</strong>l’inumazione,<br />
mentre dal secolo successivo si assistette<br />
alla graduale scomparsa <strong>del</strong>le nicchie per<br />
urne cinerarie e alla massiccia diffusione <strong>del</strong>le<br />
inumazioni 12 . I due sarcofagi marmorei con<br />
scene mitologiche tuttora conservati a Cimitile<br />
(fig. 4) attestano la presenza nel cimitero di strati<br />
sociali privilegiati, almeno sotto il profilo eco-<br />
Fig. 4 - Cimitile. Antiquarium, sarcofago con mito di Endimione.<br />
SALTERNUM<br />
- 64 -<br />
nomico 13 . Non va escluso che questa necropoli,<br />
ubicata a circa 1,5 km a Nord <strong>del</strong>la città romana,<br />
sia sorta in relazione alla popolazione residente<br />
nelle adiacenti ville rustiche; è noto, infatti, che<br />
soprattutto nelle aree più lontane dalle città in<br />
età imperiale si trovavano piccoli sepolcreti relativi<br />
per lo più a ville o fattorie che si estendevano<br />
direttamente sulle strade di passaggio o nelle<br />
immediate vicinanze <strong>del</strong>la villa di pertinenza 14 .<br />
La tomba di S. Felice e la cristianizzazione<br />
<strong>del</strong>la necropoli settentrionale<br />
Alla fine <strong>del</strong> III secolo d.C. nella necropoli a<br />
Nord di Nola fu seppellito il sacerdote Felice,<br />
morto il 14 gennaio di un anno a noi sconosciuto;<br />
prestigioso esponente <strong>del</strong>la locale comunità<br />
cristiana, Felice aveva amministrato la Chiesa<br />
nolana durante l’assenza forzata <strong>del</strong> vescovo<br />
Massimo, rinunciando però a succedergli nella<br />
carica 15 . Qualche decennio prima <strong>del</strong>la deposizione<br />
di S. Felice si era formato un nucleo di<br />
deposizioni cristiane con tombe ornate di affreschi<br />
16 . Le scene veterotestamentarie dipinte nel<br />
mausoleo 13 nella seconda metà <strong>del</strong> III secolo<br />
indicano, infatti, l’appartenenza <strong>del</strong>l’ambiente<br />
funerario a membri <strong>del</strong>la comunità cristiana 17 .
Paolino di Nola nel carme 18, composto per<br />
il 14 gennaio 400, riferisce che S. Felice fu seppellito<br />
in una solitaria e profumata campagna,<br />
ma non fornisce indicazioni sulla tipologia <strong>del</strong>la<br />
sepoltura 18 . Gli scavi hanno invece appurato che<br />
il santo fu inumato in una tomba terragna in<br />
laterizi (usm 892) nell’ambito <strong>del</strong>la preesistente<br />
necropoli 19 (fig. 2). La sepoltura, orientata secondo<br />
l’asse est-ovest, fu costruita sul terreno vergine,<br />
a breve distanza dal mausoleo 1. Il fondo<br />
venne costituito da quattro mattoni: sull’esemplare<br />
situato più ad Ovest fu realizzato il cuscino<br />
funebre in malta con incavo centrale per<br />
accogliere il capo <strong>del</strong> defunto. Per la copertura<br />
s’impiegarono tre grossi laterizi decorati, sul<br />
piatto inferiore, da una sorta di T (con il tratto<br />
orizzontale leggermente ricurvo) realizzata con<br />
la pressione <strong>del</strong> dito sull’argilla ancora fresca. La<br />
circostanza che la sepoltura 892 fu impiantata<br />
sul terreno vergine potrebbe giustificare, in un<br />
certo senso, quanto Paolino dice a proposito<br />
<strong>del</strong>la deposizione di S. Felice in una solitaria<br />
campagna 20 .<br />
S. Felice, come hanno accertato gli scavi, fu<br />
deposto a Sud di una tomba con orientamento<br />
est-ovest (usm 893), impiantata sul terreno vergine;<br />
realizzata anch’essa in laterizi, la sepoltura<br />
venne completamente rivestita all’interno da<br />
lastre di marmo 21 . Il rivestimento marmoreo indica<br />
che si tratta di un sepoltura privilegiata, relativa<br />
ad un esponente di rilievo <strong>del</strong>la societas<br />
christiana di Nola; non va escluso che possa<br />
trattarsi <strong>del</strong> vescovo Massimo, contemporaneo<br />
di S. Felice. A Nord <strong>del</strong>la tomba 893 è stata scoperta<br />
la forma 894, rivestita di marmo e impiantata<br />
quasi alla stessa quota <strong>del</strong> sepolcro di S.<br />
Felice; è stato supposto che questa tomba sia<br />
appartenuta al vescovo Quinto, successore di<br />
Massimo sulla cattedra nolana 22 .<br />
Nei primi anni <strong>del</strong> IV secolo, anteriormente<br />
alla pace religiosa, le sepolture 892, 893 e 894<br />
furono racchiuse da un piccolo edificio quadrato<br />
(mausoleo A), cui si accedeva da Sud in rapporto<br />
alla strada che giungeva da Nola.<br />
Realizzato in opus vittatum mixtum, l’ambiente<br />
era rivestito all’esterno da un intonaco dipinto in<br />
rosso; all’interno, invece, le pareti erano affrescate<br />
con un motivo ad imitazione <strong>del</strong>l’opus sec-<br />
CARLO EBANISTA<br />
- 65 -<br />
Fig. 5 - Lastra<br />
con i due fori e il<br />
crioforo sulla tomba<br />
di S. Felice.<br />
Fig. 6 - Il mausoleo A, ricostruzione assonometrica.<br />
tile 23 . Qualche tempo dopo la costruzione <strong>del</strong><br />
mausoleo A, la tomba di S. Felice venne interessata<br />
da un intervento volto a consentire alla<br />
comunità cristiana una più adeguata venerazione<br />
24 . L’operazione comportò l’innalzamento <strong>del</strong><br />
calpestio e la parziale distruzione <strong>del</strong>l’affresco: i<br />
due laterizi, che coprivano la parte occidentale<br />
<strong>del</strong>la tomba, furono incavati e sfondati per sistemarvi<br />
un vaso marmoreo a corpo troncoconico<br />
terminante con un puntale. Il recipiente, che<br />
venne a trovarsi pressappoco all’altezza <strong>del</strong> torace<br />
<strong>del</strong> defunto, fu murato tra due strati di malta<br />
con interposto piano di laterizi. Su questo con-
Fig. 8 - Epigrafe di un diacono morto nel 541.<br />
Fig. 7 -<br />
Cimitile.<br />
L’area<br />
sepolcrale<br />
alla fine <strong>del</strong> III<br />
secolo, pianta<br />
ricostruttiva.<br />
Fig. 9 - Ricostruzione assonometrica <strong>del</strong>l’aula ad corpus e <strong>del</strong> mausoleo<br />
15 (prima metà <strong>del</strong> IV secolo).<br />
glomerato e sull’orlo <strong>del</strong> vaso, pressappoco in<br />
quota con la soglia <strong>del</strong> mausoleo A, venne sistemata<br />
una lastra marmorea di reimpiego (fig. 5)<br />
che in origine doveva essere inquadrata, su<br />
almeno tre lati, da una cornice con fregio vegetale,<br />
da un listello e da un kyma lesbio. Il fregio<br />
che decorava verosimilmente il quarto lato <strong>del</strong>la<br />
SALTERNUM<br />
- 66 -<br />
lastra (quello attualmente rivolto verso Sud)<br />
dovette scomparire in occasione <strong>del</strong> reimpiego,<br />
allorché il marmo fu tagliato fino ad assumere<br />
una larghezza di 81 cm. Nel campo centrale<br />
venne scolpito a rilievo un personaggio stante<br />
che indossa una corta tunica e reca un animale<br />
(pecora?) all’altezza <strong>del</strong> torace. Alcuni indizi<br />
sembrano suggerire che la raffigurazione, riconoscibile<br />
come l’immagine <strong>del</strong> Buon Pastore, sia<br />
stata scolpita in occasione <strong>del</strong> reimpiego e che,<br />
quindi, non facesse parte <strong>del</strong>l’originaria decorazione.<br />
In occasione <strong>del</strong> riutilizzo, ad Ovest <strong>del</strong><br />
crioforo ma sempre all’interno <strong>del</strong> campo centrale<br />
<strong>del</strong>la lastra, furono praticati due fori circolari<br />
di diverso diametro. Quello meridionale<br />
venne fatto corrispondere al sottostante vaso ed<br />
era chiuso da un tappo marmoreo circolare.<br />
L’altro foro intercettò il vaso solo parzialmente,<br />
tanto che per metterlo in comunicazione con il<br />
recipiente si dovette tagliarne l’orlo; tutt’intorno<br />
venne ricavato un leggero avvallamento in corrispondenza<br />
<strong>del</strong> quale furono praticati quattro<br />
piccoli incassi destinati ad alloggiare un coperchio<br />
metallico o una grata.<br />
La lastra con i due fori ha permesso di identificare<br />
la sottostante sepoltura 892 con la tomba<br />
di S. Felice. Il primo riferimento al marmo che<br />
copriva il venerato sepolcro ricorre nel carme<br />
18 25 (scritto per il 14 gennaio 400), ove Paolino<br />
di Nola racconta che i fe<strong>del</strong>i cospargevano di<br />
profumo di nardo la tomba e ne traevano<br />
unguenti resi salutari dal contatto 26 , secondo l’usanza<br />
descritta anche dal contemporaneo<br />
Prudenzio. I due foramina sono descritti nel<br />
carme 21, composto per il 14 gennaio 407, nel<br />
quale Paolino narra la ricognizione <strong>del</strong> sepolcro<br />
di S. Felice 27 ; l’iniziativa fu originata dal desiderio<br />
di comprendere il motivo per cui i vasetti<br />
calati nei due fori <strong>del</strong>la lastra, invece di trarre<br />
fuori il nardo che vi era stato versato, trascinavano<br />
su sabbia, polvere, ossicini, cocci e calcinacci<br />
28 . La presenza dei foramina e la loro posizione<br />
rispetto alla tomba sottostante rinviano<br />
alla consuetudine, diffusa in ambito pagano ma<br />
anche tra i cristiani, di versare nelle tombe latte,<br />
miele, vino, sostanze aromatiche attraverso fori<br />
o tubuli (metallici oppure fittili) che terminavano<br />
in corrispondenza <strong>del</strong> capo <strong>del</strong> defunto.
La sistemazione <strong>del</strong>la tomba di S. Felice a<br />
Cimitile documenta un precoce caso di reimpiego<br />
di spolia; la lastra, databile forse al I secolo<br />
d.C., venne prelevata da un monumento abbandonato.<br />
Il riutilizzo lascia intuire un discreto<br />
impegno finanziario da parte <strong>del</strong>la comunità cristiana<br />
di Nola e nello specifico di quella élite<br />
colta, ma praticamente anonima, attiva in campo<br />
edilizio prima <strong>del</strong>l’arrivo di Paolino 29 . L’uso <strong>del</strong><br />
marmo, sia pure di reimpiego, indica una certa<br />
disponibilità economica e il desiderio di conferire<br />
pregio alla tomba di S. Felice. Rilavorata<br />
accuratamente per ricavare l’immagine <strong>del</strong> Buon<br />
Pastore e i fori, la lastra venne adattata con<br />
attenzione al contesto funerario e al sottostante<br />
vaso, onde allestire al meglio il dispositivo cultuale<br />
(fig. 6). Se l’orlo arrotondato dei fori sembra<br />
finalizzato a facilitare l’introduzione <strong>del</strong>le<br />
essenze odorose e dei vascula, la fuoriuscita di<br />
sabbia, polvere, ossicini, cocci e calcinacci<br />
segnalata da Paolino nel carme 21 indica che<br />
almeno uno di essi fosse lasciato aperto o, piuttosto,<br />
che fosse protetto soltanto da una grata<br />
che permetteva l’infiltrazione di sporcizia e altro.<br />
Le sepolture ad sanctos e la trasformazione<br />
<strong>del</strong>la prassi funeraria<br />
Nel panorama funerario tardoantico l’elemento<br />
nuovo è, senza dubbio, rappresentato dalle<br />
tombe dei martiri, ma un’altra significativa innovazione<br />
è costituita dalla costruzione <strong>del</strong>le aule<br />
di culto capaci di appagare il desiderio dei più<br />
di ottenere una sepoltura ad sanctos, oltre che<br />
di accogliere i fe<strong>del</strong>i nelle celebrazioni annuali 30 .<br />
Le inumazioni usufruivano, grazie alla vicinanza<br />
alla tomba venerata, <strong>del</strong>l’energia salvifica attribuita<br />
alla presenza <strong>del</strong> corpo santo 31 . Il sepolcro<br />
di S. Felice rientra a pieno titolo in questa prassi<br />
dal momento che funzionò da polo di attrazione<br />
<strong>del</strong>le sepolture e determinò una massiccia<br />
e disordinata sovrapposizione di tombe cristiane<br />
in tutti gli spazi disponibili, sia all’interno degli<br />
ambienti funerari sia al loro esterno 32 .<br />
Già anteriormente alla pace religiosa <strong>del</strong> 313<br />
d.C. due sepolture ad sanctos (usm 926, 927)<br />
furono impiantate nello stesso mausoleo A, al di<br />
CARLO EBANISTA<br />
- 67 -<br />
sopra rispettivamente <strong>del</strong>le tombe 893 e 894, di<br />
cui conservarono l’orientamento. Solo lo spazio<br />
occupato dal sepolcro di S. Felice venne lasciato<br />
libero per il riguardo dovuto e per consentire<br />
le pratiche devozionali 33 . Ben più numerose<br />
furono le sepolture ad sanctos sistemate, agli<br />
inizi <strong>del</strong> IV secolo, nei mausolei B e C che prospettavano<br />
sul piazzale antistante l’edificio funerario<br />
A 34 (fig. 7). L’ambiente B, che è coevo al<br />
mausoleo A, ospitò sei inumazioni orientate<br />
Nord-Sud e disposte su tre strati. Il mausoleo C,<br />
cui si accedeva da Sud, accolse forse nove<br />
tombe; al di sopra <strong>del</strong>le coperture, costituite da<br />
laterizi alloggiati nelle pareti <strong>del</strong>l’ambiente, iniziava<br />
la decorazione a fresco che alla base presentava<br />
un motivo vegetale analogo a quello<br />
che ornava il mausoleo B. Il desiderio di essere<br />
deposti presso il sepolcro di S. Felice diede<br />
luogo all’affollamento di inumazioni anche all’esterno<br />
dei mausolei. Nel piazzale antistante gli<br />
ambienti A e B, ad esempio, vennero sistemati<br />
due sarcofagi ricavati da un unico blocco di<br />
tufo, ma con due distinti coperchi 35 . Anche negli<br />
altri edifici funerari <strong>del</strong>la necropoli, ubicati a<br />
maggiore distanza dalla tomba di S. Felice, le<br />
sepolture occuparono tutti gli spazi disponibili.<br />
Diversamente da quanto era accaduto in precedenza,<br />
allorché le tombe terragne sfruttavano<br />
razionalmente lo spazio, le sepolture finirono<br />
per occupare disordinatamente l’interno (raggiungendo<br />
talora quasi le volte) e l’esterno degli<br />
ambienti funerari. Queste sepolture ‘disordinate’<br />
sono databili per lo più al IV secolo, quando la<br />
necropoli, costellata sempre più di tombe cristiane<br />
sin dalla fine <strong>del</strong> secolo precedente, perse<br />
forse già dall’epoca <strong>del</strong>la pace religiosa il suo<br />
carattere privato o famigliare accentuando quello<br />
comunitario 36 . Questo cambiamento è certamente<br />
all’origine <strong>del</strong>l’addensarsi <strong>del</strong>le sepolture<br />
negli edifici funerari e nelle loro vicinanze,<br />
secondo una prassi ricorrente nelle aree cimiteriali<br />
cristiane. In relazione a questo fenomeno<br />
faccio rilevare, tanto per citare qualche esempio,<br />
le stringenti analogie con quanto avvenne nella<br />
necropoli <strong>del</strong>la via Laurentina ad Ostia 37 o nell’area<br />
cimiteriale di età imperiale ubicata nel suburbio<br />
orientale di Pozzuoli. In quest’ultimo caso<br />
negli ambienti funerari, entro il IV secolo, furo-
no realizzate <strong>del</strong>le sepolture «in fossa terragna o<br />
in cassa di muratura di tufo e copertura di tegole,<br />
che spesso riempivano gli edifici sino al livello<br />
d’imposta <strong>del</strong>le volte» 38 , senza che ci fossero<br />
«più risorse economiche sufficienti ad erigere<br />
nuove costruzioni» 39 .<br />
Sebbene fuori contesto, le epigrafi cristiane<br />
forniscono utili elementi datanti sull’utilizzo<br />
funerario <strong>del</strong>la necropoli di Cimitile. Tra le iscrizioni<br />
recanti la data consolare, la più antica è<br />
quella di Serbilla deceduta nel 359 40 , mentre la<br />
più recente è dedicata ad una diciottenne di<br />
nome Urbica 41 († 567). La gran parte <strong>del</strong>le epigrafi<br />
appartiene al V-VI secolo, a testimonianza<br />
<strong>del</strong>la modesta frequenza d’inumazioni di riguardo<br />
presso la tomba di S. Felice per buona parte<br />
<strong>del</strong> IV secolo 42 . Nell’interessante varietà di personaggi<br />
cui fanno riferimento le iscrizioni troviamo,<br />
oltre a rappresentanti <strong>del</strong> clero (fig. 8), vergini<br />
consacrate, personalità <strong>del</strong>la vita cittadina e<br />
<strong>del</strong>la pubblica amministrazione 43 .<br />
1<br />
EBANISTA, 2005, pp. 317-320.<br />
2<br />
POZZI PAOLINI, 1987, pp. 567-568; POZZI PAOLINI, 1988, pp. 722-723;<br />
POZZI PAOLINI, 1989-90, p. 629; SAMPAOLO, 1990, p. 54.<br />
3<br />
SAMPAOLO, 1984, p. 507.<br />
4 Le più antiche attestazioni dei due monumenti sono dovute agli<br />
eruditi locali (LEONE, 1514, c. 12v; REMONDINI, 1747, pp. 106-107); i<br />
resti di un terzo monumento funerario di età augustea sono stati<br />
scoperti in via traversa S. Agata, nei pressi di uno dei mausolei da<br />
sempre in vista (ZEVI, 2004, p. 907).<br />
5<br />
ALBORE LIVADIE - MASTROLORENZO - VECCHIO, 1988, p. 79; DE CARO,<br />
1999a, p. 840.<br />
6<br />
EBANISTA, 2003, pp. 49-111.<br />
7<br />
CHIERICI, 1957, p. 107.<br />
8<br />
TESTINI, 1985, p. 341.<br />
9<br />
EBANISTA, 2003, pp. 61-63, fig. 11.<br />
10<br />
PENSABENE, 2003, p. 163.<br />
11<br />
EBANISTA, 2003, p. 58.<br />
12<br />
CALZA, 1940, p. 68; BALDASSARRE, 1980, p. 127; PAVOLINI, 1983, p.<br />
262; TAGLIETTI, 2001, p. 149.<br />
13<br />
EBANISTA, 2003, pp. 64-68, figg. 12-13.<br />
14<br />
EBANISTA, 2003, p. 558.<br />
15<br />
EBANISTA, 2006, pp. 17-18.<br />
16<br />
TESTINI, 1985, p. 339.<br />
17<br />
KOROL, 1987, p. 177.<br />
18<br />
PAUL. NOL. carm. 18, 131-137.<br />
19<br />
EBANISTA, 2006, pp. 23-24, figg. 4-7.<br />
20<br />
EBANISTA, 2003, pp. 49, 101.<br />
21<br />
EBANISTA, 2006, pp. 24-27, figg. 4-5, 8.<br />
22<br />
EBANISTA, 2006, pp. 27-28, figg. 4-5, 9.<br />
23<br />
EBANISTA, 2003, pp. 98-99.<br />
24<br />
EBANISTA, 2006, pp. 31-37, figg. 11-15.<br />
25<br />
PAUL. NOL. carm. 18, 92-93 (Ecce vides tumulum sacra martyris<br />
ossa tegentem | et tacitum obtento servari marmore corpus).<br />
26<br />
PAUL. NOL. carm. 18, 38-39 (Martyris hi tumulum studeant perfundere<br />
nardo, | ut medicata pio referant unguenta sepulchro).<br />
27<br />
PAUL. NOL. carm. 21, 558-642; cfr. EBANISTA, 2003, p. 135.<br />
28<br />
PAUL. NOL. carm. 21, 590-600 (Ista superficies tabulae gemino patet<br />
SALTERNUM<br />
- 68 -<br />
Nessuna memoria, invece, è rimasta <strong>del</strong>la<br />
massa anonima dei devoti <strong>del</strong> santo, se si eccettua<br />
la preziosa testimonianza dei graffiti 44 che<br />
alcuni pellegrini tracciarono all’esterno <strong>del</strong>la<br />
chiesa (fig. 9) eretta dai Nolani, nella prima metà<br />
<strong>del</strong> IV secolo, sulla tomba di S. Felice, a seguito<br />
<strong>del</strong>la demolizione dei mausolei A, B e C 45 . L’area<br />
cimiteriale si stava intanto trasformando in un<br />
grandioso e frequentatissimo santuario, grazie<br />
soprattutto alla fervente attività di Paolino di<br />
Nola che vi si stabilì alla fine <strong>del</strong> IV secolo.<br />
Presso il complesso martiriale, collegato a Nola<br />
da una strada lastricata, sorse un villaggio che<br />
Paolino ricorda per la prima volta nel 399-400.<br />
Dall’originaria destinazione sepolcrale, il santuario<br />
e l’abitato derivarono la denominazione di<br />
Cimiterium che nell’altomedioevo si affiancò a<br />
quella ben più antica di Nola; attestato per la<br />
prima volta nell’839, il toponimo si trasformò nel<br />
corso dei secoli in Cimitino e quindi in Cimitile 46 .<br />
ore | praebens infuso subiecta foramina nardi. | Quae cineris<br />
sancti veniens a sede reposta | sanctificat medicans arcana spiritus<br />
aura, | haec subito infusos solito sibi more liquores | vascula de<br />
tumulo terra subeunte biberunt, | quique loco dederant nardum,<br />
exhaurire parantes, | ut sibi iam ferrent, mira novitate repletis | pro<br />
nardo vasculis cumulum erumpentis harenae | inveniunt pavidique<br />
manus cum pulvere multo | faucibus a tumuli retrahunt), 605-<br />
608 (pulvis ... | quem manus e tumulo per aperta foramina promptum<br />
| hauserat et varia concretum sorde ferebat | cum ossiculis<br />
simul et testis cum rudere mixtis).<br />
29 TESTINI, 1985, p. 365.<br />
30 PANI ERMINI, 1989, p. 845; ARIÈS, 1992, pp. 37-45; DELLE ROSE, 1993,<br />
p. 772.<br />
31 L’orientamento canonico <strong>del</strong>le tombe scomparve quando il culto<br />
dei martiri provocò nei cimiteri il formarsi di poli di attrazione intorno<br />
ai quali sorsero sepolcri e mausolei; è proprio la presenza di<br />
edifici-fulcro di carattere monumentale, verso i quali convergono le<br />
sepolture, che più colpisce nei cimiteri sub divo <strong>del</strong>l’epoca <strong>del</strong>la<br />
pace e che distingue nettamente l’urbanistica <strong>del</strong>le necropoli cristiane<br />
da quella <strong>del</strong>le antiche aree pagane (FASOLA - FIOCCHI NICOLAI,<br />
1989, p. 1175).<br />
32 EBANISTA, 2003, pp. 59-60, 558.<br />
33 EBANISTA, 2003, p. 107.<br />
34 EBANISTA, 2003, pp. 97-98, 558-559, fig. 23.<br />
35 EBANISTA, 2003, p. 111, fig. 27 (usm 919-920).<br />
36 TESTINI, 1978, p. 168.<br />
37 PAROLI, 1993, p. 155.<br />
38 GIALANELLA - DI GIOVANNI, 2001, p. 166.<br />
39 DE CARO, 1999b, p. 226, tav. X n. 1.<br />
40 CIL,X/1, p. 152, n. 1338.<br />
41 CIL, X/1, p. 154, n. 1361.<br />
42 TESTINI, 1985, p. 368.<br />
43 TESTINI, 1985, pp. 367-370.<br />
44 FERRUA, 1965; EBANISTA, 2003, pp. 124-126, fig. 37; LAMBERT, 2004,<br />
p. 61, fig. 18; GALANTE, 2005; EBANISTA, 2006, pp. 52-53, fig. 27.<br />
45 EBANISTA, 2003, pp. 118-158; EBANISTA, 2006, pp. 49-51, figg. 24-25.<br />
46 EBANISTA, 2003, pp. 556-558; EBANISTA, 2005, pp. 350-357.
BIBLIOGRAFIA<br />
ALBORE LIVADIE - MASTROLORENZO - VECCHIO, 1998: ALBORE<br />
LIVADIE, C. - MASTROLORENZO, G., - VECCHIO G., “Eruzioni pliniane<br />
<strong>del</strong> Somma-Vesuvio e siti archeologici <strong>del</strong>l’area nolana”,<br />
in GUZZO, P.G. - PERONI, R. (a cura di), Archeologia e<br />
vulcanologia in Campania, Atti <strong>del</strong> convegno, Pompei, 21<br />
dicembre 1996, Napoli 1998, pp. 39-86.<br />
ARIÈS, 1992: ARIÈS, P., L’uomo e la morte dal medioevo a<br />
oggi, Roma-Bari 1992.<br />
BALDASSARRE, 1980: BALDASSARRE, I., “La necropoli <strong>del</strong>l’Isola<br />
Sacra”, in GIGLI QUILICI S. (a cura di), Archeologia laziale,<br />
Terzo incontro di studio <strong>del</strong> Comitato per l’archeologia<br />
laziale, Roma 1980, Roma 1980, pp. 126-128.<br />
CALZA, 1940: CALZA, G., La necropoli <strong>del</strong> Porto di Roma<br />
nell’Isola Sacra, Roma 1940.<br />
CHIERICI, 1957: CHIERICI, G., “Cimitile I. La necropoli”, in<br />
Rivista di Archeologia Cristiana, XXXIII, 1957, pp. 99-125.<br />
CIL, X/1: MOMMSEN, T., Corpus Inscriptionum Latinarum.<br />
Inscriptiones Bruttiorum Lucaniae Campaniae Siciliae<br />
Sardiniae Latinae, X/1, Berolini 1883.<br />
DE CARO, 1999a: DE CARO, S., “L’attività <strong>del</strong>la<br />
Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta nel 1997”,<br />
in Confini e frontiera nella grecità d’Occidente, Atti <strong>del</strong><br />
trentasettesimo Convegno di Studi sulla Magna Grecia,<br />
Taranto 3-6 ottobre 1997, Taranto 1999, pp. 793-843.<br />
DE CARO, 1999b: DE CARO, S., “Dati recenti sul tardoantico<br />
nella Campania settentrionale”, in L’Italia meridionale in<br />
età tardoantica. Atti <strong>del</strong> trentottesimo convegno di Studi<br />
sulla Magna Grecia, Taranto 2-6 ottobre 1998, Taranto<br />
1999, pp. 223-242.<br />
DELLE ROSE, 1993: DELLE ROSE, M., “Cimitero”, in<br />
Enciclopedia <strong>del</strong>l’Arte Medievale, IV, Roma 1993, pp. 770-<br />
785.<br />
EBANISTA, 2003: EBANISTA, C., et manet in mediis quasi<br />
gemma intersita tectis. La basilica di S. Felice a Cimitile:<br />
storia degli scavi, fasi edilizie, reperti (Memorie<br />
<strong>del</strong>l’Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti in<br />
Napoli, XV), Napoli 2003.<br />
EBANISTA, 2005: EBANISTA, C., “Il ruolo <strong>del</strong> santuario martiriale<br />
di Cimitile nella trasformazione <strong>del</strong> tessuto urbano di<br />
Nola”, in VITOLO, G. (a cura di), Le città campane fra tarda<br />
antichità e alto medioevo, Salerno 2005, pp. 313-377.<br />
EBANISTA, 2006: EBANISTA, C., La tomba di S. Felice nel santuario<br />
di Cimitile a cinquant’anni dalla scoperta<br />
(Coemeterium, 4), Marigliano 2006.<br />
FASOLA, - FIOCCHI NICOLAI, 1989: FASOLA, U.M. - FIOCCHI<br />
NICOLAI, V., “Le necropoli durante la formazione <strong>del</strong>la città<br />
cristiana”, in Actes du XIe Congrès International<br />
d’Archéologie Chrétienne, Lyon-Vienne-Grenoble-Genève et<br />
Aoste, 21-28 septembre 1986, II, Città <strong>del</strong> Vaticano 1989,<br />
pp. 1153-1205.<br />
FERRUA, 1965: FERRUA, A., “Graffiti di pellegrini alla tomba di<br />
S. Felice”, in BORRARO, A. –BORRARO, P. (a cura di), Studi in<br />
memoria di Gino Chierici [...], Roma 1965, pp. 17-19.<br />
CARLO EBANISTA<br />
Referenze <strong>del</strong>le illustrazioni: figg. 1, 3-4 (Carlo Ebanista); figg. 2, 6-7, 9 (Rosario Claudio La Fata); figg. 5, 8 (EBANISTA, 2006,<br />
figg. 13, 48).<br />
- 69 -<br />
GALANTE, 2005: GALANTE, M., “Scritte avventizie tra tarda<br />
antichità e medioevo. I casi di Cimitile e <strong>del</strong>la grotta di San<br />
Michele ad Olevano sul Tusciano”, in OLDONI, M. (a cura<br />
di), Fra Roma e Gerusalemme nel medioevo. Paesaggi<br />
umani ed ambientali <strong>del</strong> pellegrinaggio meridionale<br />
(Schola Salernitana. Studi e testi, 11), Salerno 2005, pp.<br />
193-216.<br />
GIALANELLA, C. - DI GIOVANNI, V. 2001: GIALANELLA, C. - DI<br />
GIOVANNI, V., “La necropoli <strong>del</strong> suburbio orientale di<br />
Pozzuoli”, in HEINZELMANN, (a cura di) 2001, pp. 159-168.<br />
HEINZELMANN, (a cura di) 2001: HEINZELMANN, M. (a cura di),<br />
Römischer Bestattungsbrauch und Beigabensitten: in Rom,<br />
Norditalien und den Nordwestprovinzen von der späten<br />
Republik bis in die Kaiserzeit. Internationales Kolloquium,<br />
Rom 1.-3. April 1998, Wiesbaden 2001.<br />
KOROL, 1987: KOROL, D., Die frühchristlichen<br />
Wandmalereien aus den Grabbauten in Cimitile/Nola. Zur<br />
Entstehung und Ikonographie alttestamentlicher<br />
Darstellungen (Jarhbuch für Antike und Christentum,<br />
Ergänzungsband 13), Münster 1987.<br />
LAMBERT, 2004: LAMBERT, C., Pagine di pietra. Manuale di<br />
epigrafia latino-campana tardoantica e medievale, Quarto<br />
2004.<br />
LEONE, 1514: LEONE, A., De Nola, Venetiis 1514.<br />
PANI ERMINI, 1989: PANI ERMINI, L., “Santuario e città fra tarda<br />
antichità e altomedioevo”, in Santi e demoni nell’alto<br />
medioevo occidentale, XXXVI Settimana di Studio <strong>del</strong><br />
Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto 7-13<br />
aprile 1988, Spoleto 1989, pp. 837-877.<br />
PAVOLINI, 1983: PAVOLINI, C., Ostia (Guide archeologiche, 8),<br />
Bari 1983.<br />
PAROLI, 1993: PAROLI, L., “Ostia nella tarda antichità e nell’alto<br />
medioevo”, in PAROLI, L. - DELOGU, P. (a cura di), La storia<br />
economica di Roma nell’alto Medioevo alla luce dei<br />
recenti scavi archeologici, Atti <strong>del</strong> Seminario, Roma 2-3<br />
aprile 1992, Firenze 1993, pp. 153-175.<br />
PENSABENE, 2003: PENSABENE, P., “Marmi e reimpiego nel santuario<br />
di S. Felice a Cimitile”, in BRANDENBURG, H. - ERMINI<br />
PANI, L. (a cura di), Cimitile e Paolino di Nola. La tomba di<br />
S. Felice e il centro di pellegrinaggio. Trent’anni di ricerche,<br />
Atti <strong>del</strong>la giornata tematica dei Seminari di Archeologia<br />
Cristiana, École Française de Rome, 9 marzo 2000, Città<br />
<strong>del</strong> Vaticano 2003, pp. 129-207.<br />
POZZI PAOLINI, 1987: POZZI PAOLINI, E., “L’attività archeologica<br />
nelle province di Napoli e Caserta – 1986”, in Lo stretto<br />
crocevia di culture, Atti <strong>del</strong> ventiseiesimo Convegno di Studi<br />
sulla Magna Grecia, Taranto-Reggio Calabria, 9-14 ottobre<br />
1986, Taranto 1987, pp. 557-578.<br />
POZZI PAOLINI, 1988: POZZI PAOLINI, E., “Soprintendenza<br />
archeologica di Napoli e Caserta. Attività di scavo tutela e<br />
valorizzazione 1986-1987”, in Poseidonia-Paestum, Atti <strong>del</strong><br />
ventisettesimo Convegno di Studi sulla Magna Grecia,<br />
Taranto-Paestum, 9-15 ottobre 1987, Taranto 1988, pp.<br />
699-746.
POZZI PAOLINI, 1989-90: POZZI PAOLINI, E., “Nola (Napoli)”, in<br />
Studi Etruschi, serie III, LVI, 1989-90, pp. 628-629.<br />
REMONDINI, 1747: REMONDINI, G., Della nolana ecclesiastica<br />
storia, I, Napoli 1747.<br />
SAMPAOLO, 1984: SAMPAOLO, V., “Nola (Napoli)”, in Studi<br />
Etruschi, serie III, LII, 1984, pp. 506-507.<br />
SAMPAOLO, 1990: SAMPAOLO, V., “La presenza <strong>del</strong>la<br />
Soprintendenza Archeologica a Palma Campania e Nola”,<br />
in Didattica e Territorio, Corso di formazione per docenti in<br />
servizio, 30° Distretto Scolastico-Nola, Nola, 30 marzo-8<br />
giugno 1988, Nola 1990, pp. 47-56.<br />
TAGLIETTI, 2001: TAGLIETTI, F., “Ancora su incinerazione e<br />
inumazione: la necropoli <strong>del</strong>l’Isola Sacra”, in HEINZELMANN,<br />
(a cura di) 2001, pp. 149-158.<br />
SALTERNUM<br />
- 70 -<br />
TESTINI, 1978: TESTINI, P., “Cimitile. L’antichità cristiana”, in<br />
L’art dans l’Italie Méridionale. Aggiornamento <strong>del</strong>l’opera<br />
di Émile Bertaux sotto la direzione di A. Prandi, IV, Rome<br />
1978, pp. 163-176.<br />
TESTINI, 1985: TESTINI, P., “Note per servire allo studio <strong>del</strong><br />
complesso paleocristiano di s. Felice a Cimitile (Nola)”, in<br />
Mélanges de l’École Française de Rome. Antiquité, 97, 1985,<br />
pp. 329-371.<br />
ZEVI, 2004: ZEVI, F., “L’attività archeologica a Napoli e<br />
Caserta nel 2003”, in Alessandro il Molosso e i “condottieri”<br />
in Magna Grecia, Atti <strong>del</strong> quarantatreesimo convegno di<br />
studi sulla Magna Grecia, Taranto-Cosenza, 26-30 settembre<br />
2003, Taranto 2004, pp. 853-923.
STEFANIA DE MAJO<br />
Il commercio <strong>del</strong>l’allume in età romana:<br />
un monopolio dimenticato<br />
‘La grande storia ha per lungo tempo ignorato<br />
l’allume, protagonista assai discreto <strong>del</strong>le<br />
vicende umane, così come ha lungamente trascurato<br />
il grano, l’olio e, in generale, tutto ciò<br />
che è indispensabile alla vita quotidiana: <strong>del</strong><br />
resto è soltanto quando il fornaio non ha più il<br />
pane che si parla di lui. Contadini, artigiani e<br />
operai sono più necessari alla vita degli uomini<br />
che non tutti i Carlo V, ma si tratta di gente<br />
modesta che non ama parlare di sé’ (DELUMEAU,<br />
1962, p. 301).<br />
La bellissima riflessione di Jean<br />
Delumeau, calzante perfettamente con<br />
qualsiasi periodo storico, è in particolar<br />
modo riferita, nel discorso specifico <strong>del</strong>l’allume,<br />
all’età moderna, ma sarebbe, a mio parere,<br />
ancor più appropriata per l’età antica. Se è vero<br />
che quelle classi sociali che hanno permesso a<br />
tutte le altre di esistere e di fare la storia al posto<br />
loro sono state poco considerate dalla storia di<br />
tutti i tempi, è anche vero che gli scrittori greci<br />
e romani sono stati i più inclementi. Esaltato nel<br />
1540 come ‘non meno utile per i tintori che il<br />
pane per l’uomo’ 1 , l’allume non ritrova la stessa<br />
popolarità nel mondo antico se non in pochi<br />
autori. Giuseppe Nenci denuncia a ragione<br />
come l’allume sia “il grande dimenticato nella<br />
storia <strong>del</strong>l’economia antica” 2 , eppure esso ha<br />
ricoperto un ruolo tale, per la molteplicità di usi<br />
cui si prestava, da essere un prodotto non solo<br />
utile ma indispensabile.<br />
Ma che cos’è l’allume?<br />
Alla luce <strong>del</strong>la chimica moderna, quello che<br />
Plinio definisce un ‘sale sudato dalla terra’ 3 è un<br />
solfato doppio di alluminio e potassio (K 2 SO 4 .<br />
- 71 -<br />
Fig. 1 - Anfora tipo Richborough 527-<br />
Lipari 2b (da TYERS 1996*).<br />
Al 2 (SO 4 ) 3 . 24H2 O) che assume il nome di<br />
‘‘allume di rocca’’ quando si presenta sotto<br />
forma vetrosa. Attualmente viene impiegato nell’industria<br />
<strong>del</strong>la carta per la sbiancatura e la collatura,<br />
per la depurazione <strong>del</strong>l’acqua, come<br />
emostatico dopobarba, come antiodorante (lo<br />
troviamo di frequente in vendita sulle bancarelle<br />
sotto il nome di ‘cristallo di potassio’), nell’agricoltura<br />
biologica per la conservazione <strong>del</strong>le<br />
banane durante l’immagazzinamento, come<br />
ignifugo per vernici e prodotti antincendio.<br />
Nelle fonti antiche è indicato di frequente<br />
come medicinale utilizzato per scongiurare mali<br />
diversi grazie alle sue proprietà astringenti, antisettiche,<br />
lenitive. Era poi utilizzato come impregnante<br />
in strutture architettoniche lignee,<br />
soprattutto in ambito bellico, per proteggerle<br />
dagli incendi; nella lavorazione dei metalli 4 e per<br />
la conservazione <strong>del</strong>l’uva e <strong>del</strong> vino. L’allume<br />
però trovava il suo maggiore impiego in ambito<br />
artigianale come mordente nella tintura dei tessuti<br />
e nella concia <strong>del</strong>le pelli, essendo, se non<br />
l’unica, la migliore sostanza atta a questo scopo<br />
fino all’introduzione <strong>del</strong> tannino nell’Ottocento.
Fig. 2 - Alcuni tipi di allume nativo (da SINGER 1948, p. 235).<br />
Riflettere su quali e quanto svariati usi trovavano<br />
prodotti quali cuoio (dall’abbigliamento alla<br />
costruzione di barche, alla fabbricazione di<br />
scudi e contenitori) e lana (‘frutto straordinario<br />
<strong>del</strong> bestiame [...] come la pecora ci dà il suo frutto<br />
per le vesti, così la capra il pelo per usi nautici,<br />
per macchine da guerra, e per vasi fabbrili’) 5 ,<br />
aiuta a comprendere ancor di più il peso anzi, la<br />
necessità <strong>del</strong>l’allume nell’economia antica.<br />
Il termine greco στυπτηρíα (στúφειν =<br />
restringere) è indicativo <strong>del</strong>la caratteristica per la<br />
quale era meglio nota questa sostanza (‘Summa<br />
omnium generum vis astringendo, unde nomen<br />
Graecis’ 6 ; τοúνοµα παρωνóµασται τêß sτúφει 7 ),<br />
mentre la falsa etimologia latina di ‘alumen…a<br />
lumine quod lumine coloribus praestat tingendis’<br />
di Isidoro di Siviglia 8 proviene dalla proprietà<br />
di rendere le sostanze coloranti insolubili<br />
nelle fibre e più brillanti. In effetti l’origine <strong>del</strong><br />
termine latino non è chiara e secondo alcuni<br />
potrebbe derivare, insieme con bitumen, da una<br />
lingua non indoeuropea. Il primo autore in cui<br />
si trova questo termine è Varrone, il quale lo<br />
associa allo zolfo 9 .<br />
SALTERNUM<br />
- 72 -<br />
Il monopolio eoliano<br />
L’informazione di maggior rilievo che riusciamo<br />
ad acquisire dalle fonti antiche è che l’allume<br />
era un prodotto di monopolio, dunque un<br />
prodotto indispensabile e raro. Indispensabile<br />
perché legato ad un artigianato volto a produrre<br />
beni di prima necessità (lana e pelli). Raro per<br />
quantità ma soprattutto qualità. Formato soprattutto<br />
dall’azione fumarolica o idrotermale, l’allume<br />
è potenzialmente presente in tutte le zone<br />
vulcaniche ma in forme spesso molto impure. Le<br />
terre alluminose di Pozzuoli, ad esempio, sono<br />
conosciute in età romana (ne fa menzione<br />
Vitruvio 10 ) ma non sfruttabili in ambito artigianale<br />
perché le frequenti impurità avrebbero macchiato<br />
i tessuti. Era invece la piccola isola di<br />
Lipari a produrre l’allume più puro e a rifornire<br />
tutto l’Occidente romano 11 detenendo un vero e<br />
proprio monopolio. Preziose sono state per l’individuazione<br />
<strong>del</strong>l’isola le testimonianze di<br />
Strabone 12 e soprattutto di Diodoro Siculo: “ E<br />
quest’isola (Lipari) possiede miniere di allume,<br />
da cui i Liparesi e i Romani traggono grandi<br />
profitti. Dal momento che l’allume non si trova<br />
da nessuna parte nel mondo abitato ed è di<br />
grande utilità, essi ne detengono il monopolio e<br />
possono alzarne il prezzo traendo un incredibile<br />
guadagno” 13 . A livello archeologico però non<br />
esisteva alcuna conferma di quanto affermato<br />
dai due storici fino alla scoperta nel 1993 <strong>del</strong>la<br />
prima ed unica fornace di anfore da allume, le<br />
cosiddette Richborough 527, in contrada<br />
Portinenti a Lipari, anfore rimaste per decenni<br />
senza patria né contenuto 14 (Fig. 1). La loro<br />
incredibile diffusione, che copre tutti i paesi<br />
<strong>del</strong>l’Occidente romano e non solo, rappresenta<br />
l’unica testimonianza materiale <strong>del</strong> monopolio<br />
esercitato da Lipari, permettendoci di seguire le<br />
rotte commerciali di un bene deperibile e finora<br />
ignorato.<br />
Una ulteriore conferma che si trattasse proprio<br />
di allume e non di un altro prodotto è costituta<br />
da una testimonianza proveniente dalla<br />
necropoli romana di Lipari. Si tratta di un’iscrizione<br />
marmorea ormai perduta, appartenente al<br />
basamento di un monumento dedicato al ‘procurator<br />
Cornelius Masutus Tiberii Caesaris<br />
Augusti et Iuliae Augustae’ 15 . Questi non poteva
certo essere l’amministratore di un latifondo<br />
imperiale in un’isola di 9x4 km e non coltivabile<br />
per più <strong>del</strong>la metà. Seppure la rimanente<br />
parte è ricordata sia da Strabone che da Diodoro<br />
per la particolare fertilità, i prodotti potevano<br />
essere sufficienti per il consumo locale, non<br />
certo per avviare una rete commerciale nel<br />
Mediterraneo. Più logico sarebbe dunque pensare<br />
che questo Cornelio Masuto amministrasse le<br />
cave di zolfo e allume.<br />
E’ probabile che l’allume eoliano fosse sfruttato<br />
sin dalla preistoria insieme con l’ossidiana.<br />
E’ invece quasi certo che questo era un importante<br />
motivo di richiamo per le popolazioni<br />
micenee che, tra XVI e IX secolo a.C., hanno<br />
lasciato ampie tracce di frequentazione commerciale<br />
in Sicilia e Italia meridionale.<br />
Nonostante l’interesse che l’allume ha risvegliato<br />
negli studi degli ultimissimi anni, restano<br />
ancora diversi aspetti da comprendere, soprattutto<br />
per quanto riguarda i metodi di estrazione<br />
e lavorazione in età antica. Per le epoche successive<br />
siamo infatti più fortunati.<br />
L’età medievale e moderna: l’allume artificiale<br />
A partire dall’età medievale la storia <strong>del</strong>l’allume<br />
comincia ad essere meno oscura; compare<br />
spesso in trattati tecnici e appunti artigiani.<br />
In opere quali le Compositiones varia ad tingenda<br />
musiva, ricette messe insieme all’inizio<br />
<strong>del</strong>l’800, la Mappae Clavicula, <strong>del</strong> 950 circa, l’opera<br />
<strong>del</strong> monaco Teofilo De diversis artibus o il<br />
De coloribus et artibus Romanorum attribuita<br />
ad Eraclio, l’allume è ingrediente fondamentale<br />
di numerose ricette. Per la proprietà di fissare i<br />
colori e quindi anche di ‘inaurare’, è citato in<br />
moltissimi scritti di alchimia araba e latina (‘gli<br />
alchemici e li parteliori molto se ne serveno,<br />
anzi senza esso le loro acque acutesar non posseno…’<br />
16 ). Non dobbiamo poi dimenticare<br />
quanto grande sia in età medievale la diffusione<br />
di libri miniati detti anche ‘alluminati’ o ‘illuminati’<br />
poiché la loro brillantezza era dovuta<br />
soprattutto a lacche alluminate (miscele di allume,<br />
zucchero e miele, incorporate in soluzioni<br />
di gomma arabica e chiara d’uovo) cosparse sui<br />
colori per fissarli e proteggerli. In più la pergamena<br />
(presumibilmente conciata all’allume),<br />
STEFANIA DE MAJO<br />
- 73 -<br />
Fig. 3<br />
VANNUCCIO<br />
BIRINGUCCIO,<br />
De la<br />
pirotechnia<br />
libri decem,<br />
1540.<br />
prima <strong>del</strong>la pittura, era impregnata di una<br />
soluzione di allume e piccole quantità di cinabro.<br />
L’allume liparota si esaurisce nell’VIII secolo<br />
circa a causa probabilmente di una violenta eruzione,<br />
costringendo l’intero mercato artigiano<br />
alla ricerca di altre cave. E’ di fondamentale<br />
importanza sottolineare che questo tipo di allume,<br />
detto naturale o nativo, era una cristallizzazione,<br />
una efflorescenza che non necessitava di<br />
una lavorazione complessa. Tuttavia aveva il<br />
grande svantaggio di trovarsi in natura in forme<br />
quasi sempre impure, mescolate con altre<br />
sostanze, e soprattutto di essere solubile in<br />
acqua, quindi facilmente deperibile. A partire<br />
dal X secolo si scopre nel Vicino Oriente il<br />
modo di ottenere allume da rocce comuni contenenti<br />
solfato di alluminio e zolfo (scisti piritici)<br />
mettendole a bollire con urina, che è una<br />
sostanza ammoniacale: si formava così allume di<br />
ammonio. In Asia Minore intanto si incominciava<br />
già da tempo a ricavare il prezioso mordente<br />
dal minerale di alunite che, dopo una lunga e<br />
complessa lavorazione, viene trasformato in<br />
allume, detto erroneamente artificiale, che gradualmente<br />
sostituisce quello naturale.
Fig. 4<br />
Lavorazione<br />
<strong>del</strong>l’alunite<br />
per ottenere<br />
allume<br />
(da GIORGIO<br />
AGRICOLA<br />
1556, p. 571<br />
ed. Hoover).<br />
Purtroppo l’Occidente non disponeva di<br />
minerale di alta qualità e dovette usufruire <strong>del</strong>le<br />
importazioni di allume da Oriente che, durante<br />
le Crociate, diventarono problematiche ma non<br />
cessarono mai <strong>del</strong> tutto. Dal 1275 l’allume orientale<br />
torna in auge grazie ai mercanti genovesi<br />
che estraggono e importano in Occidente il<br />
minerale da Focea e da Chio, dando vita ad un<br />
traffico esteso e redditizio, un vero e proprio<br />
monopolio. La conquista ottomana nel 1453<br />
andrà a colpire questi traffici in un momento di<br />
particolare sviluppo, i Genovesi perdono Focea,<br />
mentre la Maona di Chio è costretta a subire tributi<br />
sempre più pesanti, tanto da rendere, alla<br />
fine <strong>del</strong> XV secolo, raro e costoso l’allume orientale<br />
sui mercati occidentali. In una situazione<br />
così disperata la scoperta dei giacimenti laziali<br />
<strong>del</strong>la Tolfa fu provvidenziale. Le parole di<br />
Giovanni da Castro, commerciante e parente di<br />
Papa Pio II, all’indomani <strong>del</strong> felice rinvenimento<br />
sono significative:<br />
‘‘Oggi ti reco la vittoria sui Turchi. Essi estorcono<br />
ai Cristiani ogni anno più di trecentomila<br />
SALTERNUM<br />
- 74 -<br />
ducati, fornendoci l’allume con il quale tingiamo<br />
la lana nei diversi colori. E ciò perché l’allume<br />
non si trova presso i Latini se non in piccola<br />
quantità nell’isola d’Ischia, un tempo chiamata<br />
Aenaria, vicino a Pozzuoli, e nella grotta<br />
Liparea di Vulcano, che però fu a tal punto sfruttata<br />
dai Romani da essere quasi esaurita 17 ”<br />
E’ in questo contesto che si collocano due<br />
opere davvero interessanti per lo studio <strong>del</strong>l’allume<br />
poiché descrivono in maniera dettagliata il<br />
processo di lavorazione <strong>del</strong> minerali: Li diece<br />
libri de la pirotechnia 18 (1540) di Vannuccio<br />
Biringuccio e il De re metallica 19 (1556) di<br />
Giorgio Agricola, testimoni importanti di una<br />
pratica che per più di tre secoli, fino all’epoca<br />
industriale, non è mutata (Figg. 3-4).<br />
Sarebbe davvero interessante poter compensare<br />
la carenza di notizie che abbiamo sull’allume<br />
sfruttato in età antica con gli scritti successivi.<br />
Purtroppo ciò non è sempre possibile per un<br />
motivo molto semplice: l’allume di cui parlano<br />
Biringuccio e Agricola è sempre di tipo artificiale,<br />
derivato soprattutto da alunite. E’ più che<br />
probabile che in epoca romana non si conoscesse<br />
il modo di ricavare l’allume da questo minerale;<br />
mancano infatti tracce di strutture o testimonianze<br />
scritte di questa complessa lavorazione:<br />
‘Fu cosa cognita fin da gli antichi, ma non<br />
si vede per gli scrittori che usassero li modi per<br />
trovarlo e per estraerlo che usano li moderni, e<br />
materia che oltre alintrinseca e natural sua salsedine<br />
ha grandissima viscosità…’ 20 .<br />
Il ruolo <strong>del</strong>l’artigiano: una diversa prospettiva<br />
La conoscenza che abbiamo <strong>del</strong>l’allume in<br />
età romana è dovuta in gran parte ai ritrovamenti<br />
di anfore che, oltre a confermare quanto riportato<br />
dalle fonti, rappresentano l’unico fossileguida<br />
di una produzione e di un traffico commerciale<br />
di portata eccezionale, che ha contribuito<br />
alla studio <strong>del</strong>l’economia antica in generale,<br />
di Lipari in particolare e soprattutto <strong>del</strong>l’artigianato<br />
antico che tanto necessita di uscire dalla<br />
penombra. Tintori, lanaioli e pellai fanno parte<br />
di quella schiera di lavoratori che avendo prodotto<br />
beni deperibili sono destinati ad essere<br />
sottorappresentati fra le testimonianze archeologiche.<br />
Un aiuto proviene dalle strutture rimaste,
in pochi fortunati casi, intatte o quasi <strong>del</strong>le fulloniche,<br />
<strong>del</strong>le officine infectoriae e offectoriae di<br />
Pompei, di Ercolano, di Ostia, e <strong>del</strong>le uniche<br />
due officine coriariae presenti in Italia, quella<br />
<strong>del</strong>la Regio I di Pompei e quella di Sepino.<br />
Il mondo artigiano merita di ottenere il giusto<br />
riconoscimento per ciò che ha rappresentato<br />
all’interno <strong>del</strong>la società (in questo caso) antica.<br />
Lo studio <strong>del</strong>la cultura materiale sta in questo<br />
NOTE<br />
1 VANNUCCIO BIRINGUCCIO, 1540, VI, p. 13.<br />
2 G. NENCI 1982 , 183.<br />
3 Naturalis Historia, XXXV, 183.<br />
4 Di particolare interesse è l’uso <strong>del</strong>l’allume per la purificazione<br />
degli strati superficiali <strong>del</strong>le leghe d’oro o d’argento<br />
da altri metalli, in modo da far apparire, esternamente, una<br />
percentuale di metallo prezioso più alta. Questo procedimento<br />
(arricchimento superficiale <strong>del</strong>le leghe) era usato dai<br />
Romani in periodi di inflazione (tra il 63 e il 260 d.C.) per<br />
fabbricare i denarii d’argento con solo il 12-18 % di metallo<br />
prezioso.<br />
5 VARRONE, De re rustica, II, 11, 1.<br />
6 PLINIO, Naturalis Historia, XXXV,LII, 189.<br />
7 GALENO, De compositione medicamentorum secundum<br />
locos, p. 236 (ed. Kuhn).<br />
8 Etymologiae, XVI, 2, 2.<br />
9 De Lingua latina, V, 25.<br />
10 De Architectura, VIII, 4-5.<br />
11 Il mercato di allume orientale era probabilmente soddisfatto<br />
da un altro centro di produzione, l’isola di Milo. Oltre<br />
STEFANIA DE MAJO<br />
- 75 -<br />
senso continuando a dare grandi contributi,<br />
ricostruendo la storia dal punto di vista di chi<br />
l’ha vissuta senza poter tramandare altro ai<br />
posteri se non, quando possibile, i propri resti<br />
materiali. Le anfore di Lipari ci permettono di<br />
risalire ad un mezzo, l’allume, attraverso il quale<br />
si può indirettamente ‘spiare’ il mondo di un<br />
artigiano e il suo umile quanto indispensabile<br />
lavoro.<br />
ad essere menzionata nelle fonti insieme a Lipari, negli ultimissimi<br />
anni sono state scoperte anfore da allume di produzione<br />
melina che raggiungono anche le coste adriatiche<br />
<strong>del</strong>la nostra penisola. Tuttavia l’allume di Milo doveva essere<br />
di ottima qualità ma di scarsa quantità (Diodoro Siculo<br />
ne dà conferma), motivo per cui Lipari si trovò a sopperire<br />
anche al mercato orientale, anche non sappiamo ancora<br />
in che misura.<br />
12 “...στυπτηρíα µéταλλον éµπρósoδον” (Geografia, VI, 2,<br />
10).<br />
13<br />
DIODORO SICULO, V, 10, 2 .<br />
14 L’allume è solubile in acqua, motivo per cui non se ne è<br />
mai trovata traccia all’interno <strong>del</strong>le anfore.<br />
15 CIL X , 7489.<br />
16<br />
VANNUCCIO BIRINGUCCIO, 1540, VI.<br />
17<br />
PIO II, De la pirotechnia, Commentarii, VII, 12.<br />
18 VI, p. 12-14.<br />
19 De re metallica, XII, p. 564-572 (ed. Hoover).<br />
20 De la pirotechnia, VI.<br />
* www.intarch.ac.uk
BIBLIOGRAFIA<br />
AA.VV., 2006. L’Alun de Méditerranée, Actes du Colloque<br />
International (Naples/Lipari, 4-8 juin 2003), a cura di PH.<br />
BORGARD, J.P. BRUN, M. PICON. D’AURIA Ed., Napoli, 2006.<br />
BERNABÒ BREA L., CAVALIER M., 1977. Lipari (isola), in G.<br />
NENCI, G. VALLET, Bibliografia Topografica <strong>del</strong>la colonizzazione<br />
greca in Italia e nelle isole tirreniche IX, Pisa-Roma,<br />
pp. 164-185.<br />
BERNABÒ BREA L., CAVALIER M., 2000. Scavi in proprietà Leone<br />
(XLVI, 1993-95), in Meligunìs Lipara X. Scoperte e scavi<br />
archeologici nell’area urbana e suburbana di Lipari,<br />
L’Erma Bretschneider, Roma, 2000, pp. 263-303.<br />
BORGARD PH., 2001. L'Alun de l'Occident romain: production<br />
et distribution des amphores Romaines de Lipari, 4<br />
vol., 30 cm. Th. doct,: Archéol,: Aix-Marseille 1, 2001.<br />
DELUMEAU J., 2003. L’allume di Roma. XV-XIX secolo. Ed.<br />
SALTERNUM<br />
- 76 -<br />
italiana de ‘L’alun de Rome’, 1962. Comunità Montana<br />
‘Monti <strong>del</strong>la Tolfa’, Allumiere (Roma), 2003.<br />
MANNONI T., GIANNICHEDDA E., 1996. Archeologia <strong>del</strong>la produzione,<br />
Einaudi, Torino, 1996, pp. xiii-xx.<br />
NENCI G., 1982. L’allume di Focea, in «Parola <strong>del</strong> Passato»,<br />
CCIV-CCVII, Napoli, 1982, pp . 183-188.<br />
PICON M., 2006. Des aluns naturels aux aluns artificiels et<br />
aux aluns de synthèse: matières premières gisements et procédés,<br />
in AA.VV., L’Alun de Méditerranée, pp. 13-38.<br />
SINGER C., 1948. The Earliest Chemical Industry. An Essay in<br />
the Historical Relations of Economics & Technology<br />
Illustrated from the Alum Trade. Chiswick Press, London,<br />
1948.
SOFIA LOVERDOU<br />
Il Diolco antico:<br />
speranze per un monumento indifeso<br />
Chi sta presso il limite occidentale <strong>del</strong><br />
Canale di Corinto diventa spesso testimone<br />
di una specie di tsunami: al<br />
passaggio di una grossa nave, dapprima l'acqua<br />
si ritira e, subito dopo, onde furiose si scagliano<br />
contro alcune pietre, che conservano a mala<br />
pena la loro forma originale. Sono i resti di un<br />
grande monumento, il Diolco antico.<br />
Il passaggio degli antichi Corinzi per l'istmo<br />
era una cosa nota. La loro città, ai piedi <strong>del</strong>la<br />
rocca <strong>del</strong>l'Acrocorinto, aveva il controllo <strong>del</strong><br />
commercio tra due terre, ed anche tra due mari.<br />
Chi desiderava evitare il terribile Capo Maléaß<br />
ed il giro <strong>del</strong> Peloponneso, non aveva che da<br />
avvicinarsi alla città “dei due mari” e affidarsi ai<br />
Corinzi. Era tale la prontezza dei Corinzi a superare<br />
quell'ostacolo naturale, che Aristofane ci<br />
scherza su nelle Qesmoforiáqusai. "Quando le<br />
donne scoprono che un uomo si è intromesso fra<br />
di loro, lui cerca di nascondere la ...prova <strong>del</strong><br />
suo sesso girandola ora davanti ora di dietro".<br />
"Hai qualche istmo là, buon uomo?" gli fa il giovane<br />
che aveva avvertito le donne <strong>del</strong>l'intruso.<br />
“Trascini (diélkeiß) quel tuo fallo su e giù più<br />
lesto dei Corinzi”. Anche se il riferimento a navi<br />
non è esplicito, si sa che quando la commedia<br />
fu presentata, ai tempi <strong>del</strong>la Guerra <strong>del</strong><br />
Peloponneso, intere flotte furono trasportate da<br />
una parte all'altra <strong>del</strong>l'Istmo, passando per il<br />
Diolco. Tucidide ci dà un primo riferimento relativo<br />
a tale trasporto nel 428 a.C. Ma anche per il<br />
411 a.C. (anno <strong>del</strong>la rappresentazione <strong>del</strong>le<br />
Qesmoforiáqusai) lo storico ci informa che gli<br />
Spartani mandarono dei rappresentanti nella<br />
zona <strong>del</strong>l'Istmo, per disporre un passaggio di<br />
navi verso il Golfo Saronico, allo scopo di procedere<br />
contro Chio. Per distrarre l'attenzione<br />
- 77 -<br />
Fig. 1 - Un maestoso monumento ridotto in bran<strong>del</strong>li. La stessa parte <strong>del</strong><br />
Diolco nel 1960 e nel 2006. Da notare, nella prima foto, la costruzione a<br />
destra. Data la prematura morte di Nikos Ver<strong>del</strong>is, il Diolco non è stato<br />
mai propriamente pubblicato, quindi molte informazioni vengono<br />
cancellate dall’erosione.<br />
Foto: En Athinais Archaiologiki Etairia (1960), S. Loverdou (2006).<br />
Fig. 2 - Il tracciato <strong>del</strong> Diolco, parzialmente portato alla luce, durante gli<br />
scavi. La piattaforma si estende nella zona in fondo, a destra.<br />
Foto: En Athinais Archaiologiki Etairia.<br />
degli Ateniesi, si decise anche di far passare<br />
dapprima metà <strong>del</strong>la flotta, e di farla partire<br />
subito. All'epoca di Aristofane e di Tucidide, il<br />
Diolco non era una novità. Le lettere <strong>del</strong>l'alfabeto<br />
corinzio che, durante gli scavi condotti tra il<br />
1956 ed il 1962 da Nikos Ver<strong>del</strong>is, furono trovate<br />
incise sulle sue pietre, anche se non permettono<br />
una datazione sicura fanno pensare ad
Fig. 3 - Il fronte <strong>del</strong>l’erosione negli ultimi mesi <strong>del</strong> 2005.Tutta una serie di<br />
blocchi è caduta nel periodo 2002 – 2005. L’erosione sta per attaccare<br />
l’intera zona <strong>del</strong> monumento anche lateralmente.<br />
Foto: S. Loverdou.<br />
Fig. 4 - Un primo atto di rispetto, messo in atto dalla Direzione per il<br />
Restauro dei Monumenti Antichi (DAAM) agli inizi di marzo 2007.<br />
Troppo poco, a giudicare dal fatto che l’erosione chiaramente prosegue.<br />
Foto: S. Loverdou.<br />
un'epoca di costruzione <strong>del</strong>la struttura intorno o<br />
poco dopo il 600 a.C., in una Corinto fiorente,<br />
governata da Periandro (VERDELIS 1956). Tutte le<br />
fonti che parlano <strong>del</strong>l'utilizzo <strong>del</strong> Diolco si riferiscono<br />
a navi da guerra. Molti studiosi ritengono,<br />
però, che il Diolco fosse usato anche per le<br />
navi mercantili: in questo caso, i due porti di<br />
Corinto servivano forse come luoghi di carico e<br />
scarico <strong>del</strong>le merci. Plinio non sembra riferirsi<br />
solo a navi militari quando menziona il difficile<br />
passaggio oltre Capo Maléaß per i natanti che,<br />
a causa <strong>del</strong>le loro dimensioni, non potevano<br />
oltrepassare l'Istmo. Le leggere liburnae di<br />
Ottaviano poterono invece essere trainate al di<br />
là <strong>del</strong>l'Istmo nel 31 a.C., quando, dopo la battaglia<br />
di Azio, il futuro imperatore inseguiva la<br />
flotta di Antonio (Dione Cassio). Le difficoltà di<br />
circumnavigare il Peloponneso, e le dimensioni<br />
<strong>del</strong>le navi, certamente spinsero Nerone a tenta-<br />
SALTERNUM<br />
- 78 -<br />
re quello che Periandro aveva sognato: la realizzazione<br />
di un canale. E non si sa se i lavori che<br />
l'imperatore iniziò nel 67 d.C. avessero lasciato<br />
il Diolco intatto. Non mancano testimonianze di<br />
navi che passavano sopra l'Istmo. Intorno all'880<br />
d.C., troviamo un generale di Bisanzio che arriva<br />
al porto di Kexréia e, nella stessa notte, fa<br />
trasportare le sue navi nell'altro mare, servendosi<br />
di numerosa manodopera (FRANTZIS). Ci si<br />
domanda se il Diolco fosse ancora funzionale<br />
quasi quindici secoli dopo la sua costruzione. Le<br />
fonti esistenti non riferiscono dettagli né sulla<br />
costruzione, né sull'uso <strong>del</strong> Diolco; Strabone,<br />
nel 30 d.C., è uno dei pochi che lo nomina, e<br />
non manca di informarci che il suo sbocco nel<br />
Golfo Saronico si trovava presso l'odierna<br />
Kalamáki, ad una distanza di 45 stadi dal porto<br />
di Kexréia. Nonostante vari indizi, non è chiaro<br />
il tracciato <strong>del</strong> Diolco: si ritiene che seguisse<br />
l'andamento <strong>del</strong> terreno, formando un'ampia<br />
curva dalla parte <strong>del</strong> Peloponneso (WERNER<br />
1997). Il suo sbocco vicino a Kalamáki non è<br />
ancora venuto alla luce. Pausania, nel II secolo<br />
d.C., non fa riferimenti al Diolco. Le ultime testimonianze<br />
<strong>del</strong> trasporto <strong>del</strong>le navi sopra l'Istmo<br />
risalgono alla metà <strong>del</strong> XII secolo con Edrisi, che<br />
riferisce (in francese): “Le piccole imbarcazioni<br />
(...) arrivano all'estremità <strong>del</strong> canale e vengono<br />
trainate per terra per sei miglia”. Parlando <strong>del</strong><br />
canale, Edrisi intende naturalmente il lungo<br />
golfo di Corinto, visto che il canale vero e proprio<br />
non fu scavato che alla fine <strong>del</strong> XIX secolo.<br />
Dopo di che, le fonti tacciono.<br />
RINVENIMENTO DEL DIOLCO<br />
Nel 1883, l'archeologo Habbo Gerhard<br />
Lolling ci dà notizie di tracce <strong>del</strong> Diolco in un<br />
luogo che doveva trovarsi all'estremità superiore<br />
<strong>del</strong>l'Istmo (LOLLING); nel 1913, l'etnologo scozzese<br />
J.G. Frazer parla di suoi possibili resti sulla<br />
via da Kalamáki a Corinto (FRAZER). Oggi questo<br />
luogo non si può più localizzare con esattezza.<br />
Le lastre di pietra cui H.N.Fowler si riferiva nel<br />
1932 (FOWLER), situate vicino all'ingresso occidentale<br />
<strong>del</strong> canale dalla parte <strong>del</strong> Peloponneso,<br />
sono invece chiaramente identificabili. Lo stesso<br />
vale per le tracce che, secondo lo stesso Fowler,<br />
erano state identificate dall'archeologo america
no Oscar Broneer, ai lati <strong>del</strong>la via che, da<br />
Corinto, portava al "passaggio" dove si traghettava<br />
tra le due sponde <strong>del</strong> Canale. Come si è<br />
potuto constatare durante gli scavi, le lastre visibili<br />
erano parte di una piattaforma che si estendeva<br />
prima, ed al lato, <strong>del</strong> tracciato vero e proprio<br />
<strong>del</strong> Diolco. Questa ampia struttura ha sofferto<br />
danni a metà degli anni quaranta, durante<br />
i lavori di riapertura <strong>del</strong> Canale dopo gli eventi<br />
<strong>del</strong>la seconda guerra mondiale (ELEFTHERIA,<br />
1956). Nel 1946, alcune pietre <strong>del</strong> Diolco vennero<br />
alla luce - e distrutte - durante l'apertura di<br />
una strada secondaria (VERDELIS 1956): esse<br />
erano situate alcune centinaia di metri più ad<br />
oriente, e dalla parte <strong>del</strong>l'Attica. Una di queste<br />
pietre, su cui è incisa la lettera X, venne trasferita<br />
al Museo di Corinto. Nel 1956, la scoperta<br />
accidentale di testimonianze <strong>del</strong> Diolco nell'area<br />
<strong>del</strong>la Scuola <strong>del</strong> Genio Militare diede l'avvio agli<br />
scavi. I lavori, effettuati lungo le due sponde <strong>del</strong><br />
canale fino al 1962, hanno portato alla luce<br />
un'ampia strada in blocchi di poros, larga da<br />
m.3,5 a quasi m.6. La lunghezza complessiva <strong>del</strong><br />
Diolco, di cui abbiamo conoscenza, è di m.1.100<br />
(VERDELIS 1962), mentre la parti conservate sono<br />
molto meno estese. La prima parte <strong>del</strong> tracciato<br />
proprio <strong>del</strong>la struttura (interrotta dopo circa 145<br />
metri dalla via che conduce al luogo <strong>del</strong> traghetto),<br />
era quasi parallela al canale odierno; e dopo<br />
circa 53 metri il tracciato riprendeva verso Est.<br />
Di questa porzione si conservavano 42 metri;<br />
seguiva un'interruzione di 15 metri, dopo di che<br />
l'antico tracciato si ritrovava lungo l'orlo <strong>del</strong><br />
canale. La porzione di Diolco, scavata in territorio<br />
attico, nel terreno <strong>del</strong>la Scuola <strong>del</strong> Genio, si<br />
estende invece per una lunghezza di 204 metri<br />
(VERDELIS 1960). Caratteristici, sulla superficie <strong>del</strong><br />
Diolco, i solchi lasciati dalle ruote dei veicoli<br />
con cui venivano effettuati i trasporti: essi sono<br />
molto più pronunciati nel settore occupato dalla<br />
Scuola <strong>del</strong> Genio. La distanza tra queste tracce<br />
parallele è di m.1,50. Altre tracce, meno profonde,<br />
sono presenti nello stesso settore: non è<br />
chiaro se si tratti di veicoli più stretti, o piuttosto<br />
se una traccia, a questa parallela, ricadeva al di<br />
fuori <strong>del</strong>l'area esplorata (RAEPSAET e TOLLEY).<br />
Torniamo però al limite occidentale <strong>del</strong> Diolco.<br />
Una possibile riproduzione <strong>del</strong> modo in cui le<br />
SOFIA LOVERDOU<br />
- 79 -<br />
navi venivano trasportate le vedrebbe dapprima<br />
trainate sull'ampia piattaforma, per essere poi<br />
portate su di una costruzione rettangolare, racchiusa<br />
da muretti su tre lati; ma questa costruzione<br />
costituisce un'aggiunta posteriore al tracciato<br />
originale <strong>del</strong> Diolco, il quale, come<br />
VERDELIS ha potuto constatare, prosegue sotto<br />
questa pavimentazione (Ver<strong>del</strong>is 1960). I primi<br />
resti visibili <strong>del</strong> tracciato <strong>del</strong> Diolco vero e pro-<br />
Fig. 5 - Alcuni dei blocchi con lettere incise, durante gli scavi. Oggi, la stessa<br />
parte <strong>del</strong> monumento è dislocata, quasi sempre sommersa e perennemente<br />
minacciata.Foto:En Athinais Archaiologiki Etairia (1960),S.Loverdou (2006).<br />
Fig. 6 - Alcuni dei blocchi con lettere incise, durante gli scavi.<br />
Foto: En Athinais Archaiologiki Etairia (1960), S. Loverdou (2006).<br />
prio dimostrano di essere stati costruiti con grande<br />
cura; essi non presentano solcature. Le lettere<br />
che troviamo incise sui blocchi, e che sono<br />
diffuse in altre parti <strong>del</strong>la struttura, qui sono frequentissime,<br />
anzi, alcuni blocchi ne portano più<br />
d'una. La porzione <strong>del</strong> Diolco che insiste sul terreno<br />
<strong>del</strong>la scuola <strong>del</strong> Genio è ancora da interpretare.<br />
Quasi alla metà <strong>del</strong> tracciato rinvenuto<br />
vi è una doppia serie di pietre che si estende per<br />
una quindicina di metri al di sopra <strong>del</strong> tracciatobase.
Fig. 7 - Lo smagliamento <strong>del</strong> Diolco porta alla luce anche caratteristiche<br />
nascoste, come una lettera incisa nella parte inferiore di un blocco. La<br />
presenza di lettere incise sul «rovescio» di alcune pietre era stato già<br />
notato da Werner. Foto: S. Loverdou.<br />
Fig.8 - Nikos Ver<strong>del</strong>is accanto alla prima parte rinvenuta <strong>del</strong> monumento.<br />
Il termine occidentale <strong>del</strong> Diolco è in fondo. Davanti a Ver<strong>del</strong>is, la strada<br />
che porta al «passaggio».<br />
Foto: archivio privato di Fivos Ver<strong>del</strong>is (figlio di Nikos Ver<strong>del</strong>is).<br />
A giudicare dall'assenza di solcature lungo<br />
questo tratto, e dal fatto che questa assenza continua<br />
anche oltre, Ver<strong>del</strong>is è <strong>del</strong> parere che questa<br />
struttura, originariamente, si estendesse per<br />
31 metri e suggerisce che essa, situata su una<br />
curva <strong>del</strong> tracciato, proteggesse i veicoli da<br />
eventuali sbandamenti (VERDELIS 1956); Raepsaet<br />
eTolley, che riportano, tra l'altro, una lunghezza<br />
inferiore, propongono invece che si tratti di<br />
una rampa di carico (RAEPSAET e TOLLEY). Inoltre,<br />
procedendo verso Oriente, venne alla luce una<br />
parte <strong>del</strong>la struttura con i solchi; ma questa parte<br />
è ora coperta, ragione per cui è visibile soltanto<br />
il tracciato generico. Un moderno parcheggio<br />
per i veicoli <strong>del</strong>la Scuola non è stato esplorato<br />
ed alcune tracce <strong>del</strong> Diolco sono venute alla<br />
luce anche al di fuori dei terreni <strong>del</strong>la Scuola.<br />
SALTERNUM<br />
- 80 -<br />
DISAVVENTURE RECENTI.<br />
Oggi, chi si reca nell'area <strong>del</strong> limite occidentale<br />
dei Diolco non vede la maestosa struttura<br />
venuta alla luce appena cinque decenni fa; questo<br />
documento di fama internazionale è ridotto<br />
a decine di metri di blocchi sconnessi, in parte<br />
anche sommersi o addirittura coperti da terreno<br />
in frana. Dapprima la terra, che al tempo degli<br />
scavi separava la struttura dal canale, ed in<br />
seguito la struttura stessa, sono state lasciate alla<br />
mercè <strong>del</strong>l'erosione, senza neppure un tentativo<br />
di salvaguardarla. Il Diolco aveva resistito per<br />
migliaia di anni per arrivare fino a noi; poi, in<br />
cinquant'anni, tanto scempio...Anche la piattaforma<br />
che si estendeva presso l'inizio <strong>del</strong> tracciato<br />
vero e proprio si è in gran parte dispersa;<br />
e questa era l'unica parte <strong>del</strong> tracciato che, all'epoca<br />
degli scavi, era a contatto con l'acqua. I<br />
dettagli <strong>del</strong> travaglio moderno <strong>del</strong> Diolco, come<br />
appaiono anche dai documenti, sono raccapriccianti:<br />
il monumento veniva dilaniato, non solo<br />
senza che nessuno si preoccupasse di proteggerlo,<br />
ma anche sotto false dichiarazioni di salvaguardia.<br />
Dopo cinquanta anni di abbandono,<br />
una comunicazione <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>la Cultura<br />
informava così il Primo Ministro greco: "le onde<br />
hanno ormai cominciato ad erodere il substrato<br />
<strong>del</strong> monumento". Dopo decenni di quasi sistematica<br />
distruzione <strong>del</strong> Diolco, i servizi che<br />
avrebbero dovuto salvaguardarlo e non l'hanno<br />
fatto, trovavano per l'ennesima volta una "via<br />
d'uscita", descrivendo l'erosione come se fosse<br />
appena iniziata. Ma questo “teatro <strong>del</strong>l'illogico”<br />
potrebbe anche contenere <strong>del</strong>le buone notizie.<br />
Se queste arriveranno, il monumento verrà finalmente<br />
protetto e restaurato senza ulteriori indugi<br />
e senza ipocrisia, come chiede la petizione<br />
internazionale indirizzata al Primo Ministro<br />
greco. Contrariamente a quanto pensano (e<br />
forse sperano) alcuni, il Diolco è ancora vivo.<br />
Chi si è chinato sopra le sue ferite, ha sentito il<br />
suo respiro.
Fig. 9 - La piattaforma, unica parte <strong>del</strong> Diolco che era a contatto con<br />
l’acqua ai tempi degli scavi, nel suo stato attuale.<br />
Foto: S. Loverdou<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
ARISTOFANE: ARISTOFANE, Qesmoforiáqusai.<br />
ELEFTERIA 1956: La scoperta e l'importanza <strong>del</strong> Diolco di<br />
Corinto, articolo non firmato sul giornale “Elefteria”, 18<br />
agosto 1956.<br />
DIONE CASSIO: DIONE CASSIO, Storia Romana I, 1,5 (Augusto);<br />
EDRISI: EDRISI 1154 (Geographie), p.123.<br />
FOWLER: H.N. FOWLER, Diolcus, Nero's Canal, Kechreia, in<br />
“Corinth and the Corinthia, Corinth I”, pp. 49-71,<br />
Cambridge Mass. 1932.<br />
FRAZER: J.G. FRAZER, Pausanias III, p.5 (riportato in FOWLER,<br />
p.50).<br />
LOLLING 1883: H.G. LOLLING, in Griechenland Handbuch fur<br />
Reisende, Leipzig, 1883.<br />
PHRANTZIS: GEORGIUS PHRANTZES (o Phrantzis), e, 33 in Corp.<br />
Script. Hist. Byz, XX, ed. Becker, p.96.<br />
PLINIO: PLINIO, Naturalis Historia, IV, 10.<br />
SOFIA LOVERDOU<br />
Fig. 11 - Solchi scavati nel poros, che caratterizzano la parte orientale <strong>del</strong> Diolco (recinto<br />
<strong>del</strong>la Scuola <strong>del</strong> Genio). Condizioni al 1960 ed al 2006.<br />
Foto: archivio di Fivos Ver<strong>del</strong>is<br />
- 81 -<br />
Fig. 10 - I resti <strong>del</strong> Diolco, danneggiati dal passaggio di una grossa nave<br />
(agosto 2006).<br />
Foto: S. Loverdou<br />
Fig. 12 - Parte <strong>del</strong> Diolco come si presentava nel 1960.<br />
Oggi devastata dall’erosione.<br />
Foto:En Athinais Archaiologiki Etairia<br />
RAEPSET E TOLLEY: G.RAEPSAET e M. TOLLEY, “Le diolkos de l'Istme<br />
à Corinthe: son tracé, son fonctionnement.” in Bulletin de<br />
Corrispondence Hellenique 117, 1993, 233-261, C369; H,<br />
2, C335; H, 22, C380.<br />
STRABONE: STRABONE, Geografia, H, VI, 4.<br />
TUCIDIDE: TUCIDIDE, Storia, 15,1.<br />
VERDELIS 1956: N. VERDELIS, in Archaiologikà Chronikà, 1956;<br />
VERDELIS 1960: N.VERDELIS, Praktikà tes en Athinais<br />
Archaiologikis Etairias, pp.136-143.<br />
VERDELIS 1962: N. VERDELIS, Praktikà tes en Athinais<br />
Archaiologikis Etairias, pp.48-50.<br />
WERNER : W. WERNER, “The largest ship truckway in ancient<br />
times: the Diolkos of the Isthmus of Corinth, Greece, and<br />
early attemps to build a canal”, in The International Journal<br />
of Nautical Archaeology (1997) 26.2, 98-119, The Nautical<br />
Archaeology Society, 1997.
BIANCA<br />
CANCELLARE
Tu sì sei santa, tu sei in ogni tempo<br />
salvatrice <strong>del</strong>l’umana specie, tu, nella tua<br />
generosità, porgi sempre aiuto ai mortali,<br />
tu offri ai miseri in travaglio il dolce<br />
affetto che può avere una madre.<br />
(Apuleio, Metamorfosi, XI, 25)<br />
Il legame fra l’Egitto e Benevento, due<br />
mondi apparentemente estranei sia geograficamente<br />
che culturalmente, è rappresentato<br />
da una dea, anzi dalla dea per eccellenza<br />
<strong>del</strong> pantheon egizio: Iside, “una che sei tutte le<br />
cose”, come recita una celebre epigrafe capuana<br />
(CIL X 3800). Il culto <strong>del</strong>la grande divinità egizia<br />
si diffuse, nel corso <strong>del</strong> II sec. a.C., in tutto il bacino<br />
<strong>del</strong> Mediterraneo, approdando ai porti campani<br />
insieme ai mercanti italici che commerciavano<br />
con l’Egeo. Pozzuoli ha ospitato il primo Serapeo<br />
<strong>del</strong>la Penisola 1 , mentre Iside, sposa e paredra<br />
(divinità che forma una coppia divina o che<br />
generalmente si accompagna ad un’altra <strong>del</strong><br />
medesimo pantheon) di Serapide, in virtù forse<br />
<strong>del</strong>la maggiore antichità e <strong>del</strong> carattere fortemente<br />
soterico <strong>del</strong> suo culto, da “compagna” <strong>del</strong> dio<br />
tolemaico assurse presto al ruolo di protagonista<br />
e fulcro <strong>del</strong>l’attenzione dei fe<strong>del</strong>i; alla fine <strong>del</strong> II<br />
sec. a.C. la maggior parte dei templi sono dedicati<br />
a lei, mentre il culto <strong>del</strong> compagno è sovente<br />
ospitato in una piccola cella attigua al naòs,<br />
luogo in cui si trovava la statua <strong>del</strong>la dea, inaccessibile<br />
ai semplici fe<strong>del</strong>i.<br />
A Pompei si conserva l’unico Iseo pressoché<br />
integro, che nella sua prima fase costruttiva è di<br />
poco posteriore al Serapeo puteolano; contemporaneamente<br />
molte città <strong>del</strong>la Campania, come<br />
Cuma, Neapolis e Capua divennero importanti<br />
luoghi di culto per le divinità egizie, e il loro successo<br />
superò presto i confini campani, seguendo<br />
GIOVANNI VERGINEO<br />
L’Egitto a Benevento<br />
- 83 -<br />
le grandi rotte commerciali. Anche il Lazio<br />
(Praeneste, Ostia) accolse favorevolmente Iside e<br />
gli altri dei nilotici, e la stessa Roma, nonostante<br />
l’iniziale ostilità <strong>del</strong>la classe senatoria, dovrà alla<br />
fine cedere al fascino <strong>del</strong>la religione egizia.<br />
Non sappiamo se Benevento sia stata coinvolta<br />
dal grande moto di diffusione dei culti egizi iniziato<br />
nel II sec. a.C., poiché mancano in merito<br />
prove archeologiche o documentarie, tuttavia è<br />
molto probabile che questo si sia verificato,<br />
essendo la città un importante centro commerciale,<br />
nonché fondamentale snodo stradale lungo<br />
l’Appia, regina viarum, e punto di passaggio<br />
obbligato per il tragitto <strong>del</strong>le merci da Roma<br />
all’Oriente e viceversa.<br />
Durante il periodo imperiale, il successo dei<br />
culti isiaci fu dovuto, più che ai commerci o alle<br />
attività di proselitismo, alla volontà degli Imperatori.<br />
Se alcuni di essi, come Augusto e Tiberio,<br />
furono ostili, anzi nemici degli isiaci, pur non<br />
potendosi sottrarre all’incredibile fascino <strong>del</strong>la<br />
cultura egizia, percepibile ad esempio nella<br />
splendida decorazione <strong>del</strong>l’Aula Isiaca sul<br />
Palatino, altri principi furono ad essi estremamente<br />
favorevoli. La dinastia flavia 2 fu assai benevola<br />
nei confronti <strong>del</strong>le divinità egizie, favorendo la<br />
diffusione <strong>del</strong> loro culto ed edificando grandiosi<br />
santuari. Il legame fra i Flavi e l’Egitto fu sempre<br />
molto forte: Domiziano aveva nei confronti di<br />
Iside un debito di gratitudine, essendosi salvato<br />
dall’assalto dei vitelliani al Campidoglio travestendosi<br />
da sacerdote <strong>del</strong>la dea. Alla sua iniziativa si<br />
deve la ricostruzione <strong>del</strong>l’Iseo Campense (il tempio<br />
isiaco edificato a Roma nel I sec. a.C. ed ospitato<br />
nel Campo Marzio, al di fuori <strong>del</strong> pomerio)<br />
nonché l’edificazione <strong>del</strong> santuario di Iside a<br />
Benevento, che si data, grazie alle iscrizioni<br />
geroglifiche sui due obelischi in granito presenti
Fig. 2.<br />
Fig. 1.<br />
in città, all’ottavo anno <strong>del</strong> principato domizianeo,<br />
cioè all’88-89 d.C.. L’interesse <strong>del</strong>l’Imperatore<br />
allo sviluppo dei culti egizi era legato non<br />
tanto ad una personale propensione religiosa,<br />
quanto al desiderio di essere venerato come un<br />
monarca ellenistico, presentandosi al popolo<br />
romano come dominus et deus e sfruttando il<br />
carisma divino che la cultura egizia conferiva al<br />
sovrano. Ma il sovrano ricorse all’arte egizia<br />
anche per distinguere nettamente il tempio <strong>del</strong>la<br />
dea orientale dai santuari <strong>del</strong>le divinità tradizionali<br />
romane, di cui tentò di riportare in auge il<br />
culto, proseguendo la politica religiosa <strong>del</strong> padre.<br />
Sull’obelisco che il princeps flavio fece erigere a<br />
Roma, egli è definito “amato da Iside”, mentre gli<br />
obelischi beneventani, edificati in un periodo in<br />
cui l’imperatore aveva dato una svolta più marcatamente<br />
teocratica al principato, lo presentano<br />
SALTERNUM<br />
- 84 -<br />
come “figlio di Ra ”, al pari dei Faraoni. E’ per<br />
questo che il Müller interpreta le statue di falco<br />
beneventane come incarnazione di Domiziano in<br />
Horus 3 . Domiziano, quindi, da un lato conferisce<br />
nuova linfa vitale agli dèi nilotici, dall’altro, adottando<br />
per i loro templi i canoni <strong>del</strong>l’arte egizia,<br />
mira a far avvertire al popolo la differenza fra le<br />
religioni orientali e le divinità <strong>del</strong> pantheon romano.<br />
Il Malaise 4 rileva un altro elemento di notevole<br />
importanza: il legame che sotto i Flavi Iside<br />
presenta con gli eventi bellici. La dea viene molte<br />
volte avvicinata a Minerva, che compare al centro<br />
<strong>del</strong>l’Arcus ad Isis, innalzato dall’imperatore nei<br />
pressi <strong>del</strong>l’Iseo Campense. L’uguaglianza Iside =<br />
Neith (dea guerriera <strong>del</strong>la tradizione egizia) =<br />
Athena era già stata formulata all’epoca di<br />
Erodoto (V sec. a.C.) 5 e le prerogative di Iside-<br />
Athena guerriera sarebbero confluite, per volontà<br />
dei Flavi, nella figura di Minerva. Anche a<br />
Benevento la costruzione <strong>del</strong> tempio domizianeo<br />
è strettamente connessa all’impresa dacica, come<br />
testimoniano le iscrizioni degli obelischi, e vi<br />
sono molti elementi per ritenere che i Flavi abbiano<br />
creato un legame fra Iside-Minerva guerriera e<br />
le loro conquiste militari, come testimonia la vicinanza<br />
<strong>del</strong>l’Iseo Campense al tempio di Minerva<br />
Chalcidica in Roma.<br />
La maggior parte dei materiali conservati al<br />
Museo <strong>del</strong> Sannio sono pertinenti a questo edificio,<br />
ed è la loro qualità più che quantità a sorprendere<br />
il visitatore: Domiziano, infatti, volle<br />
edificare, decorare ed arredare il santuario beneventano<br />
secondo i canoni <strong>del</strong>l’arte egizia, utilizzando<br />
materiali come il granito rosa, il porfido<br />
rosso, l’anfibolite e facendo ricorso al repertorio<br />
iconografico faraonico per le opere all’interno <strong>del</strong><br />
luogo di culto. E’ per questo che è parso opportuno<br />
intitolare quest’articolo “L’Egitto a<br />
Benevento”, piuttosto che “I culti isiaci a<br />
Benevento”, poiché l’Egitto fu “fisicamente” presente<br />
nel capoluogo sannita dal I sec. d.C. almeno<br />
fino al III sec. d.C., e gli dèi nilotici furono<br />
venerati in atmosfere consone alle loro origini,<br />
anziché in templi simili a quelli <strong>del</strong>le altre divinità<br />
<strong>del</strong> pantheon greco- romano, come avveniva<br />
invece a Pozzuoli, Pompei, Napoli ed in molti<br />
altri contesti.
I materiali<br />
I reperti egizi presenti a Benevento 6 , circa cinquanta,<br />
possono essere divisi in quattro gruppi<br />
principali:<br />
1) Reperti di epoca faraonica, fabbricati in<br />
Egitto in tempi molto antichi e portati a<br />
Benevento in occasione (o in conseguenza) <strong>del</strong>l’edificazione<br />
<strong>del</strong> santuario. Essi sono: un frammento<br />
di statua <strong>del</strong> faraone Meri-shepses-Ra assiso<br />
in trono, <strong>del</strong>la XIII dinastia, datata al 1700 a.C.<br />
circa, che è il pezzo più antico presente in città;<br />
la statua-cubo <strong>del</strong>lo Scriba Reale Neferhotep (fig.<br />
1) <strong>del</strong>la XXII dinastia, datata alla seconda metà<br />
<strong>del</strong> IX sec. a.C.; due statue di Horus-falco <strong>del</strong>la<br />
XXX dinastia.<br />
2) Reperti di epoca tolemaica fabbricati in<br />
Egitto: una testa di Iside proveniente da Behbetel-Hagar<br />
(fig. 2), sul Delta <strong>del</strong> Nilo, forse un frammento<br />
<strong>del</strong>la statua venerata nel naòs; cinque<br />
<strong>del</strong>le dieci sfingi beneventane (fig. 3) oggi conservate<br />
in parte al Museo <strong>del</strong> Sannio ed in parte<br />
al Museo Barracco di Roma, e che probabilmente<br />
erano pertinenti ad un unico drómos, corridoio<br />
monumentale che fungeva da accesso al naòs, ai<br />
lati <strong>del</strong> quale trovavano collocazione le sfingi, le<br />
statue di faraone con “pilastro dorsale” e gli obelischi<br />
in granito.<br />
3) Reperti <strong>del</strong>la tarda epoca ellenistica di fabbricazione<br />
greca: frammento <strong>del</strong>la nave di Iside<br />
Pelagia (?) (fig. 4 ) e toro Apis (?) in marmo bianco.<br />
4) Reperti di epoca romana imperiale, alcuni<br />
fabbricati in Egitto, altri in Italia che testimoniano<br />
lo “stato di decadenza” <strong>del</strong>l’arte egizia nel I sec.<br />
<strong>del</strong>la nostra era: due obelischi in granito (fig. 5);<br />
le statue regali che riproducono Domiziano (fig.<br />
6) e Caracalla (?); la statua di Anubis (?); la coppia<br />
di sacerdoti con “vaso canopo” (fig. 7); il<br />
sacerdote con sistro, tre oranti inginocchiate e<br />
diverse statue di animali sacri (due cinocefali, tre<br />
falchi, le restanti cinque sfingi, fra cui due teste di<br />
faraone, tre leoni gradienti in granito rosa, di cui<br />
uno incastonato nel campanile <strong>del</strong>la Cattedrale, il<br />
toro Apis di viale S. Lorenzo ed il toro Apis in pietra<br />
scura). A questo gruppo appartengono anche<br />
l’elemento di decorazione architettonica con toro<br />
Apis e quattro frammenti di rilievo raffiguranti<br />
Iside alata, un ginocchio con parte <strong>del</strong> gonnelli-<br />
GIOVANNI VERGINEO<br />
- 85 -<br />
no tipico egizio (lo shendit), l’imperatore<br />
Domiziano in vesti faraoniche con le corone<br />
<strong>del</strong>l’Alto e <strong>del</strong> Basso Egitto (fig. 8), oggi perduto,<br />
Fig. 3.<br />
Fig. 4.<br />
Fig. 5.
Fig. 7.<br />
Fig. 6.<br />
e la sfinge alata acefala (fig. 9) riutilizzata nella<br />
costruzione <strong>del</strong> settecentesco Convento degli<br />
Scolopi, in p.zza Piano di Corte. Fanno inoltre<br />
parte di questo gruppo un’epigrafe in cui è menzionata<br />
Iside ed un’altra in cui si celebra la costruzione<br />
<strong>del</strong> Canopus 7 , anch’essa perduta. Grande<br />
interesse destano le opere “egittizzanti” fabbrica-<br />
SALTERNUM<br />
- 86 -<br />
te in Italia da artisti locali o romani, che testimoniano<br />
da un lato l’affezione <strong>del</strong>l’imperatore<br />
Domiziano alle forme ed ai materiali <strong>del</strong>la plastica<br />
faraonica, dall’altro la scarsa familiarità che<br />
avevano gli artisti italici con le forme ed i materiali<br />
tipici <strong>del</strong>l’arte egizia 8 .<br />
Uno degli oggetti più interessanti è la c.d. cista<br />
mystica (fig. 10), oggetto dal contenuto e dalla<br />
funzione misteriosi pertinente al tempio di “Iside<br />
Signora di Benevento”. Una cista analoga, in<br />
vimini, era portata in trionfo durante le processioni<br />
sacre assieme alle statue degli dèi e conteneva,<br />
secondo la testimonianza di Apuleio, i “<br />
sacri corredi, e nascondeva nell’intimo i misteri di<br />
quella sublime religione” 9 . Il Müller ritiene che la<br />
cista contenesse dei serpenti - visto che un rettile<br />
è appunto rappresentato sul coperchio - oppure<br />
il fallo <strong>del</strong> dio Osiride o un “vaso canopo”<br />
pieno di acqua lustrale 10 .<br />
L’ipotesi dei serpenti sembra tuttavia da scartare.<br />
In molte raffigurazioni la cista è accompagnata<br />
da due rettili 11 . L’uno, recante la corona <strong>del</strong><br />
Basso Egitto, è Agathodaimon; l’altro, con le<br />
corna bovine ed il disco solare di Isis-Hator sul<br />
capo, è Thermouthis. Agathodaimon era il patrono<br />
di Alessandria, venerato presso un heroon edificato<br />
in suo onore; è l’interpraetatio graeca<br />
(alessandrina) <strong>del</strong> dio egizio Psois, dio <strong>del</strong> destino<br />
che regge le sorti degli uomini e degli Stati.<br />
Thermouthis è invece la dea <strong>del</strong>la fertilità e <strong>del</strong>la<br />
vegetazione, che sovente accompagna il primo<br />
nelle raffigurazioni.<br />
Sul disco di una lucerna rinvenuta a Pozzuoli 12<br />
(fig. 11) è raffigurata Isis Panthea nell’atto di versare<br />
il contenuto di una patera all’interno di una<br />
cista, la quale è piena di frutti dalla forma tondeggiante,<br />
indistinguibili. In un rilievo conservato<br />
al Museo Egizio di Torino 13 (fig. 12) è possibile<br />
notare la medesima cista, questa volta accompagnata<br />
da entrambi i rettili, il cui contenuto è<br />
chiaramente rappresentato da una pigna. Resti di<br />
pigne e di altri frutti carbonizzati (datteri, fichi,<br />
castagne, noci, nocciole) sono stati rinvenuti nella<br />
fossa in muratura presso l’altare maggiore<br />
<strong>del</strong>l’Iseo di Pompei, destinata ad accogliere i resti<br />
di ciò che veniva bruciato durante i sacrifici 14 . E’<br />
quindi probabile che a ciò fosse destinata anche<br />
la cista beneventana.
I Santuari<br />
Hans Wolfgang Müller, l’egittologo tedesco<br />
che per primo ha portato alla ribalta internazionale<br />
l’importanza <strong>del</strong>le scoperte beneventane,<br />
sulla base dei materiali rinvenuti ipotizzò l’esistenza<br />
di tre santuari distinti 15 :<br />
1) Un santuario dedicato a Iside “Signora di<br />
Benevento”, costruito per volere <strong>del</strong>l’imperatore<br />
Domiziano nell’88-89 d.C., la cui esistenza è<br />
dimostrata, oltre che dal gran numero di opere<br />
egizie o egittizzanti, anche dalle epigrafi sui due<br />
obelischi. Nella ricostruzione <strong>del</strong> Müller questo<br />
edificio sarebbe stato eretto secondo i canoni <strong>del</strong>l’architettura<br />
e <strong>del</strong>l’arte egizia, rappresentando<br />
pertanto una vera e propria “enclave egizia” in<br />
territorio italico.<br />
2) Un Canopus dedicato al culto di Osiride-<br />
Canopo, divinità paredra di Iside-Menouthis<br />
venerata nella città nilotica di Canopo. A tale tempio<br />
sono riferibili un numero minore di opere, la<br />
cui datazione si colloca fra la metà <strong>del</strong> I e la<br />
seconda metà <strong>del</strong> II sec.d.C.. Un’iscrizione di<br />
carattere celebrativo, oggi perduta, ci informa che<br />
l’edificio è frutto <strong>del</strong>la munificenza di un privato,<br />
Umbrio Eudrasto, Patronus Coloniae<br />
Beneventanorum, cui il collegium Martensium<br />
Infraforanum dedica appunto l’epigrafe.<br />
3) Un tempio in cui era venerata Iside Pelagia,<br />
epiclesi 16 ellenistica <strong>del</strong>la dea molto diffusa in<br />
ambiente egeo dal II sec. a.C., e strettamente<br />
legata alla navigazione ed al commercio.<br />
L’esistenza di questo terzo edificio è testimoniata<br />
da un numero esiguo di reperti, e poggia sull’interpretazione<br />
<strong>del</strong> frammento di imbarcazione<br />
in marmo pario come parte <strong>del</strong>la statua di culto<br />
di Iside Pelagia. Tale ipotesi, come vedremo, è<br />
fortemente criticata da molti studiosi.<br />
Non essendo stata individuata la collocazione<br />
di nessuno dei tre templi, è possibile solo formulare<br />
ipotesi circa la loro architettura ed i loro arredi,<br />
partendo dallo studio dei reperti ad essi pertinenti.<br />
Riguardo al santuario di epoca domizianea,<br />
ciò che colpisce è l’uso di materiali e forme che<br />
rimandano immediatamente al mondo egizio.<br />
Allo stesso modo, le divinità non sono mai raffigurate<br />
nella loro interpraetatio graeca o romana<br />
(ovvero secondo tipi iconografici elaborati in<br />
GIOVANNI VERGINEO<br />
- 87 -<br />
Fig. 9.<br />
Fig. 10.<br />
Fig. 8.
Fig. 12.<br />
Fig. 11.<br />
contesti ellenistico-romani e più consoni ai canoni<br />
<strong>del</strong>l’arte “occidentale”); sono invece presentate<br />
secondo la più antica iconografia faraonica, che<br />
ignora le conquiste <strong>del</strong>l’arte greca. Questo elemento<br />
distingue le opere egizie beneventane da<br />
quelle rinvenute in molti contesti campani, come<br />
Pozzuoli o Pompei. La città flegrea, soprattutto,<br />
ospitava un importante tempio ellenistico dedicato<br />
alla divinità tolemaica Serapide, di cui si conserva<br />
al Museo Nazionale di Napoli una statua <strong>del</strong><br />
II sec. d.C. che, secondo l’ipotesi di molti studiosi,<br />
riprende il prototipo elaborato sotto Tolomeo<br />
I Sotér. Mentre nella zona costiera <strong>del</strong>la<br />
Campania, infatti, gli dèi egizi erano “giunti attraverso<br />
il mare” grazie soprattutto al contributo dei<br />
mercanti, a Benevento il tempio di Iside è frutto<br />
<strong>del</strong>la diretta volontà imperiale, eseguita mediante<br />
un “demiurgo” il cui nome appare più volte sugli<br />
obelischi: Rutilio Lupo. Pertanto è possibile inter-<br />
SALTERNUM<br />
- 88 -<br />
pretare il santuario beneventano come manifestazione<br />
<strong>del</strong>la stessa ideologia domizianea, volta<br />
all’autoesaltazione mediante l’uso di sculture e<br />
materiali che, richiamando il mondo degli antichi<br />
sovrani egizi, conferisse dignità divina allo stesso<br />
Princeps, nuovo Faraone.<br />
Dato il grande numero di sculture egizie, è<br />
ipotizzabile un coinvolgimento diretto <strong>del</strong>lo stesso<br />
imperatore nella decisione di importarle. Onde<br />
arricchire maggiormente il tempio, però, fu<br />
necessario anche far produrre molte opere, le<br />
quali sono qualitativamente inferiori alle più antiche,<br />
dato lo stato di decadenza <strong>del</strong>la stessa arte<br />
egizia in età flavia o la scarsa pratica degli scultori<br />
locali con le forme ed i materiali egizi 17 .<br />
I materiali rinvenuti inducono a pensare che il<br />
santuario di “Iside Signora di Benevento” (come è<br />
chiamata la dea sui due obelischi) fosse simile<br />
nella struttura agli antichi templi egizi <strong>del</strong>la Valle<br />
<strong>del</strong> Nilo, e la presenza di un così elevato numero<br />
di sfingi, alcune <strong>del</strong>le quali molto simili fra di<br />
loro, porta a ipotizzare l’esistenza di un drómos,<br />
ove queste opere potessero essere collocate. Al<br />
termine di tale corridoio erano posti i due obelischi,<br />
antico simbolo <strong>del</strong> dio Atoum ed ora recanti<br />
il nome di Domiziano identificato pienamente<br />
con Horus. Il naòs, imitando nella struttura i templi<br />
egizi, avrebbe potuto trovarsi al livello <strong>del</strong><br />
suolo, con una cella ipostila che introduce al<br />
sancta sanctorum.<br />
L’esistenza stessa <strong>del</strong> drómos induce a ritenere<br />
che il tempio isiaco a Benevento fosse integrato<br />
architettonicamente nel contesto urbanistico e<br />
collegato in modo “aperto” con il centro urbano,<br />
e non isolato dal suo peribolo dal resto <strong>del</strong>la città,<br />
come avviene invece a Pompei. Non è facile proporre<br />
una collocazione <strong>del</strong>le altre opere, ma è<br />
probabile che la statua di Domiziano si trovasse<br />
all’interno <strong>del</strong> tempio, come anche la statuetta di<br />
Caracalla. Il frammento <strong>del</strong>la testa di Iside, che<br />
potrebbe appartenere alla vera e propria statua di<br />
culto, si trovava certo all’interno <strong>del</strong>la cella, e<br />
forse era posizionata in modo da essere visibile<br />
anche dall’esterno, dato che i fe<strong>del</strong>i non potevano<br />
entrare nel luogo ove era il simulacro. La statua<br />
di Anubis probabilmente non era ospitata<br />
all’interno <strong>del</strong> naòs, ma in una <strong>del</strong>le nicchie ricavate<br />
nelle pareti esterne <strong>del</strong>la cella, ancora visibi-
li a Pompei e dinanzi ad ognuna <strong>del</strong>le quali era<br />
un altare. Le altre sculture provenienti dall’Egitto<br />
facevano parte <strong>del</strong>l’arredo <strong>del</strong> tempio; è probabile<br />
che non fossero posizionate nella cella ma in<br />
qualche altro luogo <strong>del</strong> santuario.<br />
La collocazione <strong>del</strong>l’Apis in pietra scura è<br />
anch’essa problematica: il toro avrebbe potuto<br />
essere venerato in uno spazio attiguo al tempio,<br />
in una cappella privata o forse nel naòs stesso,<br />
data l’assenza, a Benevento, di testimonianze <strong>del</strong><br />
culto di Serapide, che avrebbe potuto essere<br />
sostituito da Osiride (venerato nel Canopus) e,<br />
appunto, da Apis, cioè dalle due divinità cui deve<br />
il nome 18 . Il culto di Apis, data l’avversità dei<br />
Romani verso gli dèi zoomorfi, non ebbe mai<br />
grande successo in Italia, tuttavia il toro, che in<br />
Egitto incarnava il potere faraonico, venne ben<br />
presto collegato da Domiziano al potere imperiale,<br />
di cui divenne espressione. E’ significativo che<br />
durante il principato domizianeo siano state<br />
coniate molte monete alessandrine con l’immagine<br />
<strong>del</strong>l’animale, il cui legame con il sovrano era,<br />
in Egitto, una prassi consolidata. Apis era venerato<br />
nel tempio beneventano non perché godesse<br />
di particolare seguito fra i fe<strong>del</strong>i, ma perché simboleggiava<br />
la divinità <strong>del</strong> sovrano.<br />
Il Canopus è legato strettamente al foro cittadino<br />
dall’epigrafe <strong>del</strong> collegium dei Martenses<br />
Infraforani 19 , datata ad epoca adrianea (117- 138<br />
d.C.), in cui i membri <strong>del</strong>l’associazione ringraziano<br />
Umbrio Eudrastus, patronus coloniae per aver<br />
edificato il tempio “a solo propriis sumptibus”. Il<br />
culto di Osiride-Canopo nasce come “variante”<br />
<strong>del</strong> culto ellenistico di Osiride-Hydreios, ovvero<br />
di Osiride incarnato nell’acqua fecondatrice <strong>del</strong><br />
Nilo, conservata in appositi contenitori (hydreia)<br />
oggetto di venerazione. Il legame fra lo sposo di<br />
Iside e l’acqua <strong>del</strong> Nilo è antichissimo; già i Testi<br />
<strong>del</strong>le Piramidi identificano Osiride con il Nilo in<br />
piena e con il limo fecondatore. In ambito ellenistico<br />
il culto <strong>del</strong>l’acqua sacra verrà esteso anche<br />
al suo contenitore, che diventerà esso stesso<br />
oggetto di adorazione. Dall’isola di Delo la devozione<br />
verso il vaso, soprattutto nella sua variante<br />
“canopica”, passerà in Italia insieme a quella per<br />
gli dèi nilotici 20 . Nella città di Canopo, sul Delta<br />
<strong>del</strong> Nilo, l’acqua era venerata in particolari contenitori<br />
panciuti, con la testa <strong>del</strong> dio come coper-<br />
GIOVANNI VERGINEO<br />
- 89 -<br />
chio, chiamati “canopi”, i quali in epoca imperiale<br />
presero in Italia il posto <strong>del</strong>l’hydreion 21 .<br />
Tali vasi compaiono nelle due sculture beneventane<br />
di “sacerdoti con canopo”, opere di<br />
epoca adrianea prodotte in una bottega alessandrina.<br />
Esse facevano parte di un gruppo scultoreo<br />
completato dalla figura di sacerdote con abito<br />
frangiato, gruppo che rappresentava la celebrazione<br />
<strong>del</strong>l’atto principale <strong>del</strong> culto isiaco mattutino,<br />
ovvero l’esposizione <strong>del</strong> ritrovato Osiride<br />
sotto forma di “vaso canopo” davanti alla folla dei<br />
fe<strong>del</strong>i. Un confronto con tale raffigurazione è fornita<br />
da un affresco ercolanense, in cui è visibile il<br />
gruppo dei tre ministri (sacerdoti con canopo e<br />
sacerdote con abito frangiato) nell’atto di eseguire<br />
la cerimonia di apertura <strong>del</strong> tempio 22 . Il Müller<br />
colloca queste sculture all’interno <strong>del</strong> Canopus,<br />
che ospitava anche le tre statue di oranti inginocchiate,<br />
omogenee tipologicamente ma molto<br />
distanti cronologicamente: la più antica, infatti, è<br />
databile alla prima metà <strong>del</strong> I sec. d.C. mentre la<br />
più recente alla prima metà <strong>del</strong> II sec. d.C..<br />
Non è inoltre necessario ipotizzare l’esistenza<br />
di un edificio separato dall’Iseo domizianeo per<br />
ospitare il culto <strong>del</strong> “canopo”: una cappella adiacente<br />
al tempio avrebbe potuto svolgere tale funzione,<br />
anche perché durante il rito d’apertura <strong>del</strong><br />
naòs il sacerdote faceva libagioni versando da un<br />
vaso l’acqua sacra presa all’interno <strong>del</strong> santuario<br />
23 .<br />
Il collegamento stabilito dall’iscrizione <strong>del</strong> collegium<br />
Martensium Infraforanum tra il Canopus<br />
ed il foro non autorizza a ritenere che il tempio<br />
si trovasse al suo interno, anche se i culti isiaci,<br />
dato il loro legame con la classe mercantile, si sviluppano<br />
spesso in ambienti vicini al cuore cittadino,<br />
come è evidente dall’esempio di Pompei.<br />
L’ipotesi <strong>del</strong> Müller circa l’esistenza di un tempio<br />
isiaco più antico di quello domizianeo è basata<br />
sull’interpretazione di due controversi reperti:<br />
il frammento di imbarcazione interpretata come<br />
Iside Pelagia ed il toro in marmo bianco interpretato<br />
come Apis.<br />
La statua di Iside Pelagia è la più antica testimonianza<br />
a Benevento di un culto <strong>del</strong>la dea<br />
schiettamente ellenistico, diverso da quello introdotto<br />
da Domiziano che aveva invece carattere<br />
“faraonico”. Inoltre, il santuario di Iside Pelagia è
strettamente connesso al culto di Serapide, divinità<br />
creata dalla dinastia Lagide (l’ultima e la più<br />
longeva <strong>del</strong>l’Antico Egitto, che regnò dal 304 al<br />
30 a.C.) diffusamente venerata in ambito mediterraneo,<br />
specie fra i mercanti, ma di cui a<br />
Benevento non c’è traccia.<br />
La provenienza <strong>del</strong>l’opera da un contesto (alla<br />
base <strong>del</strong> muro longobardo settentrionale) in cui<br />
sono stati rinvenuti altri oggetti legati ai culti egizi<br />
non ne prova la pertinenza a tali culti; nello stesso<br />
luogo sono state portate alla luce anche statue<br />
di divinità romane.<br />
Lo stile e il materiale <strong>del</strong> manufatto sono<br />
molto diversi dalle altre sculture egizie; esse sono<br />
quasi sempre, infatti, realizzate in materiale “esotico”,<br />
come il granito di Assuan, la diorite, l’anfibolite,<br />
mentre lo stile è, nella maggior parte dei<br />
casi, egizio o comunque una imitazione <strong>del</strong>lo<br />
stile egizio. Al contrario, Bruneau crede che nemmeno<br />
il toro in marmo <strong>del</strong> Museo <strong>del</strong> Sannio sia<br />
da identificare con Apis 24 . A sfavore <strong>del</strong>l’identificazione<br />
<strong>del</strong>l’opera come Iside Pelagia gioca<br />
anche la posizione geografica di Benevento,<br />
alquanto distante dal mare.<br />
Se è probabile che la città ospitasse un culto<br />
isiaco già prima <strong>del</strong>la tarda epoca flavia, è dunque<br />
molto difficile pensare che si tratti <strong>del</strong> culto<br />
di Iside Pelagia; la sua festività annuale, il<br />
Navigium Isidis, era la cerimonia con cui si riapriva<br />
la navigazione estiva dopo la pausa invernale.<br />
Essa aveva luogo il 5 marzo, e ci è descritta in<br />
modo molto dettagliato da Apuleio, che ambienta<br />
proprio nel corso di questa festa la deuterometamorfosi<br />
di Lucio in forma umana.<br />
Anche se di certo gli interessi dei commercianti<br />
locali erano legati anche alla navigazione, risulta<br />
difficile collocare la processione <strong>del</strong> Navigium<br />
nel contesto beneventano.<br />
Il problema <strong>del</strong>la collocazione nell’ambito<br />
urbano dei santuari beneventani è stato sollevato<br />
fin dall’inizio <strong>del</strong> secolo scorso. Il Meomartini era<br />
convinto che l’Iseo si trovasse nei pressi <strong>del</strong><br />
Convento di S. Agostino, vista la grande quantità<br />
di reperti rinvenuti nelle vicinanze. Il Müller, che<br />
ipotizza invece l’esistenza di tre templi diversi,<br />
colloca il santuario domizianeo nel pressi <strong>del</strong>l’attuale<br />
Palazzo Arcivescovile, che si trovava all’incrocio<br />
fra la via Appia e la Latina, in una zona<br />
SALTERNUM<br />
- 90 -<br />
quindi di grande traffico nei pressi <strong>del</strong> foro.<br />
Nella stessa zona sono stati rinvenuti alcuni<br />
reperti di grande rilevanza, come i due obelischi,<br />
la statua-cubo <strong>del</strong>lo scriba reale Neferhotep ed il<br />
fregio con il toro Apis. Infine sono noti casi di<br />
“sostituzione” di luoghi di culto isiaci con luoghi<br />
di culto cristiani; la cattedrale di Benevento, originariamente<br />
dedicata a S. Maria, potrebbe sorgere<br />
sui resti <strong>del</strong>l’antico Iseo domizianeo 25 .<br />
Altra zona interessata da notevoli rinvenimenti<br />
è piazza Cardinal Pacca 26 , che molti studiosi<br />
sono concordi nel considerare la sede <strong>del</strong>l’antico<br />
foro, il quale si estendeva probabilmente sino<br />
all’odierna piazza Orsini 27 . Secondo il Müller è in<br />
quest’area che doveva sorgere il Canopus <strong>del</strong> collegium<br />
Martensium Infraforanum. A questo<br />
complesso apparterrebbero le due statue di<br />
sacerdoti con “vaso canopo” di epoca adrianea e<br />
la statua di sacerdote isiaco, datata all’età di<br />
Domiziano. La pertinenza <strong>del</strong> Canopus ad un collegio<br />
di militari, a mio avviso, conferma l’ipotesi<br />
formulata dal Malaise sulla relazione fra le imprese<br />
belliche <strong>del</strong>l’ultimo imperatore flavio ed Iside;<br />
anche i veterani <strong>del</strong> Canopus, in linea con la politica<br />
imperiale, avrebbero quindi scelto come divinità<br />
protettrice e rappresentativa <strong>del</strong> collegium<br />
non una divinità romana, ma la dea che<br />
Domiziano aveva collegato alle proprie conquiste.<br />
L’esistenza di un culto isiaco nella zona di<br />
piazza Cardinal Pacca, sia esso legato al tempio<br />
di Iside Pelagia, al santuario domizianeo o al<br />
Canopus, potrebbe essere suffragata anche dalla<br />
presenza – attestata per la prima volta nell’VIII<br />
sec. d.C. - di una chiesa dedicata a S. Stefano,<br />
oggi non più esistente 28 . Il legame fra il culto <strong>del</strong><br />
protomartire ed i luoghi in cui erano venerate le<br />
divinità egizie non è stato ancora chiarito, ma è<br />
provato che presso le antiche sedi di santuari<br />
isiaci è possibile trovare successivamente chiese<br />
dedicate a questo santo. Tale legame risulta evidente<br />
anche dall’analisi di altri contesti: il Müller<br />
osservò come a Roma nell’area occupata in<br />
epoca imperiale dall’Iseo Campense sia sorta<br />
poi la chiesa di S. Stefano <strong>del</strong> Cacco, ed anche<br />
a Verona si è avuta un’evoluzione analoga.<br />
Nemmeno Pozzuoli, ho notato, sfugge a questa<br />
norma: la lex parieti faciendo, infatti, è stata rin
venuta all’interno <strong>del</strong>la chiesa di S. Stefanino a<br />
Pontone, oggi non più esistente 29 .<br />
Basandosi ugualmente sull’ipotesi che le<br />
chiese dedicate al protomartire indichino una<br />
precedente frequentazione isiaca, altri studiosi<br />
sostengono che nei pressi di piazza Piano di<br />
Corte, dove un tempo sorgeva un’altra chiesa di<br />
S. Stefano in plano curie (sic), debba essere collocato<br />
almeno uno dei templi cittadini 30 .<br />
Ne sarebbero ulteriore prova il rinvenimento<br />
di un bassorilievo raffigurante una sfinge alata,<br />
elemento probabilmente collegabile ai culti isiaci<br />
cui si è conferita finora scarsa importanza 31 . Al<br />
piano terra di un edificio che affaccia sul lato<br />
nord <strong>del</strong>la piazza vi è inoltre una colonna frammentaria<br />
in granito rosso, di dimensioni minori<br />
rispetto a quelle usate per S. Sofia 32<br />
Nonostante siano state formulate molte ipotesi<br />
valide sulla collocazione dei templi isiaci,<br />
nessuna di esse può considerarsi definitiva; solo<br />
il Canopus, legato al foro dal nome <strong>del</strong> citato<br />
collegium, trova collocazione con molta probabilità<br />
nell’area di piazza Cardinal Pacca, che<br />
avrebbe potuto ospitare, secondo l’opinione <strong>del</strong><br />
Müller, anche uno dei santuari isiaci.<br />
Non c’è accordo fra gli studiosi nemmeno<br />
circa l’aspetto originario <strong>del</strong>l’edificio. Il Müller,<br />
che riteneva esistessero due edifici distinti per<br />
il culto di Iside Pelagia e di Iside “Signora di<br />
Benevento”, propone un’architettura in stile<br />
ellenistico-romano per il primo, paragonabile<br />
quindi ai templi di Pozzuoli e di Pompei, ed in<br />
stile egizio per il secondo, il mo<strong>del</strong>lo <strong>del</strong> quale<br />
sarebbe stato l’Iseo Campense. Un terzo edificio,<br />
separato dagli altri due, avrebbe ospitato il<br />
culto di Osiride-Canopo, ubicato nel foro 33 . La<br />
Pirelli, che considera l’edificio domizianeo un<br />
ampliamento <strong>del</strong> santuario preesistente e non<br />
un’alternativa ad esso, propende al contrario<br />
per attribuire alla sua architettura uno stile<br />
misto, influenzato dall’arte ellenistica ed egizia<br />
quanto a forme e decorazioni 34 . L’intervento<br />
domizianeo autorizza a pensare che, effettivamente,<br />
la struttura <strong>del</strong>l’edificio si rifacesse a<br />
quello in Roma; in tal caso l’Iseo beneventano<br />
avrebbe avuto una pianta simile a quella ricostruita<br />
dal Roullet per il santuario <strong>del</strong> Campo<br />
Marzio 35 .<br />
GIOVANNI VERGINEO<br />
- 91 -<br />
In sintesi, il contesto cultuale beneventano<br />
appare molto complesso, e non è possibile,<br />
ovviamente, chiarirne tutti gli aspetti. E’ certo che<br />
vi fu un grande interesse da parte <strong>del</strong>l’imperatore<br />
Domiziano a che il culto beneventano venisse<br />
ospitato in un santuario adatto, di notevoli<br />
dimensioni e arredato con elementi esotici il cui<br />
trasporto dall’Egitto o dalla Grecia fu certamente<br />
costoso.<br />
Le tracce <strong>del</strong> culto “imperiale” ed ufficiale<br />
sono numerose, mentre le testimonianze di devozione<br />
privata sono praticamente nulle; non è<br />
stato rinvenuto nemmeno un sistro o un ex voto.<br />
Tuttavia non credo che la religione isiaca abbia<br />
goduto di scarso seguito in Benevento. E’ vero<br />
che essa era strettamente legata all’imperatore ed<br />
alla dignità principesca, ma la decisione stessa di<br />
Domiziano di impiantare un santuario proprio in<br />
questa città è indicativa <strong>del</strong> successo di cui le<br />
divinità nilotiche già godevano. Inoltre, non c’è<br />
motivo di supporre che il capoluogo sannita, al<br />
centro di traffici commerciali di grande portata e<br />
collegata sia con la costa campana che con Roma,<br />
sia stata esclusa dal fenomeno di diffusione <strong>del</strong>la<br />
religione egizia che ha interessato in modo vario<br />
tutta la Penisola fra la metà <strong>del</strong> II e l’inizio <strong>del</strong> I<br />
sec. a.C.<br />
Il culto di Iside è attestato in città almeno fino<br />
al III sec. d.C.: il reperto più tardo, infatti, è la statuetta<br />
che ritrae l’imperatore Caracalla (che regna<br />
dal 211 al 217).<br />
La fine dei culti isiaci, in tutto il mondo romano,<br />
è parallela alla fine <strong>del</strong> Paganesimo: nel 391<br />
d.C. il patriarca cristiano Teofilo diede alle fiamme<br />
il Serapeo di Alessandria e distrusse la statua<br />
di Briasside. Poco dopo, in Campania, Paolino di<br />
Nola lanciava contro Iside ed i suoi fe<strong>del</strong>i un’invettiva<br />
feroce 36 .<br />
Non conosciamo il momento preciso in cui il<br />
Paganesimo ebbe fine in modo definitivo nel territorio<br />
beneventano. E’ probabile che questo sia<br />
avvenuto fra il V e VI sec.; durante la guerra <strong>del</strong><br />
535-553 la città venne colpita gravemente, ed è<br />
probabile che anche i templi pagani siano stati<br />
materialmente distrutti nel corso di questo conflitto,<br />
oppure abbattuti in seguito.<br />
In forma di superstizione popolare, però, è<br />
possibile che i culti isiaci siano sopravvissuti fino
al VII sec., se il vescovo Barbato chiese l’estirpazione<br />
di ogni culto idolatrico per salvare la città<br />
dall’assedio <strong>del</strong>l’imperatore Costante II (663) 37 . A<br />
seguito di tale richiesta il duca longobardo<br />
Grimoaldo munì il palazzo mediante la costruzione<br />
<strong>del</strong> muro nord, che fu eseguita in fretta ed alla<br />
base <strong>del</strong> quale, forse a dimostrazione <strong>del</strong> voto<br />
mantenuto, vennero gettate varie spoglie provenienti<br />
da antichi templi pagani, fra cui proprio<br />
molti dei più importanti reperti legati ad Iside; è<br />
molto probabile, quindi, che ancora nel VII seco-<br />
*Articolo tratto dalla Tesi di Laurea in Beni Culturali “L’Egitto<br />
a Benevento fra fonti letterarie e archeologia”, a.a. 2005-<br />
2006, Università degli Studi di Salerno (Relatore prof.ssa C.<br />
M. Lambert, Correlatore prof.ssa E. Mugione).<br />
NOTE<br />
1 Tempio di Serapide, dio che nel pantheon tolemaico prende<br />
il posto <strong>del</strong> “vecchio” sposo di Iside, Osiride, assumendone<br />
molti dei tratti iconografici. Serapide nasce come dio<br />
dei morti, ma ben presto diviene protettore dei mercanti e<br />
<strong>del</strong>la navigazione, ed il suo culto attecchisce nei grandi<br />
emporia <strong>del</strong> Mediterraneo come Delo, che ospitava ben tre<br />
Serapeia (BRUNEAU - DUCAT 2005, pp. 58-60; 277-279).<br />
2 Tale dinastia, che regnò dal 69 al 96 d.C., fu rappresentata<br />
da Vespasiano, Tito e Domiziano.<br />
3 Di diverso avviso il Malaise, che sottolinea l’avversione dei<br />
Romani verso le divinità zoomorfe (MALAISE 1972, pp. 295-<br />
305).<br />
4<br />
MALAISE 1972, pp. 295-305.<br />
5<br />
ERODOTO, Historiae, II, 28.<br />
6 La pertinenza dei materiali beneventani al santuario di<br />
epoca domizianea, al Canopus o al tempio più antico di<br />
Iside Pelagia è fondata esclusivamente su ipotesi di carattere<br />
tipologico, formulate per la prima volta dal Müller (MÜLLER<br />
1971) e poi accolte dalla maggior parte degli studiosi. Non è<br />
possibile tuttavia essere certi <strong>del</strong>l’attribuzione <strong>del</strong>le opere.<br />
7 Vedi infra.<br />
8 A questo gruppo appartengono tre <strong>del</strong>le sfingi rinvenute,<br />
due <strong>del</strong>le quali conservate al Museo Barracco di Roma (cat.<br />
nn. 39, 306).<br />
9<br />
APULEIO, Metamorfosi, XI, 11.<br />
10<br />
MÜLLER 1971, p. 99.<br />
11 Cfr. affresco da Ercolano conservato al Museo<br />
<strong>Archeologico</strong> Nazionale di Napoli, inv. 8848; Egittomania<br />
2006, p. 111, Tav. II.51, 1.74; ibidem p. 187, Tav. III.57.<br />
12 Cfr. TRAN TAM TINH 1973, pp. 69-70, Tav. XXXI, 40, 40 bis.<br />
13 Cfr. TRAN TAM TINH 1973, pp. 79-80, Tav. VII, 8.<br />
14 Cfr. TRAN TAM TINH 1964, p. 34.<br />
15<br />
MÜLLER 1971, pp. 27- 30.<br />
16 Particolare interpretazione di una determinata divinità,<br />
caratterizzata da certi attributi e rituali che la distinguono<br />
dalle altre. Nel caso di Iside, le epiclesi più note, oltre<br />
appunto a quella di Pelagia o Pharia, sono Isis -Fortuna o<br />
SALTERNUM<br />
- 92 -<br />
lo vi fosse un luogo in cui tali antichi simulacri<br />
erano conservati e forse oggetto di venerazione.<br />
Ancora nell’VIII sec. i resti <strong>del</strong> santuario domizianeo<br />
dovevano essere ben visibili in città, se<br />
Arechi II – o forse il suo predecessore Gisulfo II<br />
– nell’edificare la chiesa di S. Sofia utilizzò alcune<br />
monumentali colonne in granito rosa <strong>del</strong>l’antico<br />
tempio, che data la loro mole non poteva<br />
essere eccessivamente lontano dal cantiere <strong>del</strong><br />
nascente monastero.<br />
Tyche, in cui la dea è assimilata alla Fortuna; Isis-Regina,<br />
assimilabile a Iuno Regina e legata sovente alla figura <strong>del</strong>l’imperatore<br />
(spesso nella forma di Isis-Augusta), Isis-Venus,<br />
in cui la dea egizia è rivestita degli attributi di Venere. Molto<br />
diffuso è anche il tipo iconografico Isis-Lactans, con la dea<br />
nell’atto di allattare il figlio Horus.<br />
17 MÜLLER 1971, p. 22.<br />
18 Per l’interpretazione <strong>del</strong> nome Sarapis come fusione fra<br />
Osiris ed Apis, cfr. TURCAN 1989, pp. 76-77; MALAISE 1972, p.<br />
212.<br />
19 Associazione di veterani il cui stesso nome indica un collegamento<br />
con il foro cittadino (Torelli 2002, pp. 218-219).<br />
20 MALAISE 1972, pp. 206, 280, 307-311.<br />
21 Id, ibidem, p. 307.<br />
22 MÜLLER 1971, pp. 94-96; tuttavia, la statua di sacerdote n.<br />
286 appare anteriore alle altre due, forse di epoca domizianea.<br />
23 PIRELLI 2006, p. 134.<br />
24 “Dans l’état actuel de la statue, ne présente aucune des particularités<br />
auxquelles se reconnaît Apis”.<br />
BRUNEAU 1974, p.24.<br />
25 MÜLLER 1971, pp. 30-33.<br />
26 Nell’area sono stati trovati il frammento <strong>del</strong>la statua di<br />
faraone in trono ed il frammento <strong>del</strong> piccolo obelisco in<br />
marmo con pseudo-geroglifici.<br />
27 TORELLI 2002, pp. 109-110.<br />
28 ZAZO 1964, p. 25; nei pressi di piazza Piano di Corte esiste<br />
ancora un vicolo intitolato a S. Stefano. Esso porta ad una<br />
chiesa, sconsacrata, che corrisponde alla descrizione fornita<br />
dal lo Zazo e reca sull’ingresso la scritta “RESTAURATA<br />
ANNO 1690”.<br />
29 Egittomania 2006, p. 77.<br />
30 GALASSO 1968.<br />
31 Il rilievo è stato riutilizzato nella parete esterna <strong>del</strong> settecentesco<br />
Convento degli Scolopi.<br />
32 Vedi infra.<br />
33 MÜLLER 1971, pp. 27-30.<br />
34 PIRELLI 2006, pp. 129-136.<br />
35 Egittomania 2006, p. 136.<br />
36 Paolino, Carmina, XIX, 110-113, cit. in SANZI 2003, pp. 428-<br />
429.<br />
37 VERGINEO 1985, pp. 58-60, 64-67.
BIBLIOGRAFIA<br />
BRUNEAU 1974 - Ph. Bruneau, Esiste-t-il des statues d’Isis<br />
Pélagia ?, in “Bulletin de Correspondance Hellénique”,<br />
XCVIII, 1.<br />
BRUNEAU - DUCAT 2005 - Ph. Bruneau e J. Ducat, Guide de<br />
Délos, Ecole Française d'Athènes, Sites et monuments - 1,<br />
4ème éd. Athènes, pp.58-60; 277-279.<br />
Egittomania. Iside e il mistero 2006, Catalogo <strong>del</strong>la Mostra<br />
tenutasi al Museo <strong>Archeologico</strong> Nazionale di Napoli, 12<br />
Ottobre 2006 - 26 Febbraio 2007 (a cura di S. De Caro).<br />
GALASSO 1968 - E. Galasso Il tempio di Iside ed il Sacrum<br />
Palatium, problemi di urbanistica storica, in Benevento cerniera<br />
di sviluppo interregionale, a cura di F. ROMANO,<br />
Napoli.<br />
MALAISE 1972 - M. Malaise Les conditions de pénétration et<br />
de diffusion des cultes égyptiens en Italie, “Études<br />
Préliminaires aux Religions Orientales dans l’ Empire<br />
Romain”, vol. 22, Leiden.<br />
MEOMARTINI, MARUCCHI, SAVIGNONI 1904 - A. Meomartini, O.<br />
Marucchi, L. Savignoni Scoperta archeologica nelle<br />
vicinanze <strong>del</strong> Tempio di Iside, in “Notizie dagli Scavi”, 1904,<br />
pp.107-13.<br />
GIOVANNI VERGINEO<br />
- 93 -<br />
MÜLLER 1971 - H.W. Müller, Il culto di Iside nell’antica<br />
Benevento - Catalogo <strong>del</strong>le sculture provenienti dai santuari<br />
egiziani <strong>del</strong>l’antica Benevento nel Museo <strong>del</strong> Sannio,<br />
Benevento.<br />
PIRELLI 2006 - R. Pirelli, Il culto di Iside a Benevento, in<br />
Egittomania 2006, Verona pp. 128-143.<br />
SANZI 2003 - E. Sanzi, I culti orientali nell’Impero Romano,<br />
un’antologia di fonti, Cosenza.<br />
TORELLI 2002 - M. R. Torelli, Benevento Romana, Roma.<br />
TRAN TAM TINH 1964 - V. Tran Tam Tinh, Essai sur le culte<br />
d’Isis a Pompéi, Paris.<br />
TRAN TAM TINH 1972 - V. Tran Tam Tinh, Le culte des divinités<br />
orientales en Campanie, Leiden.<br />
TURCAN 1989, R. Turcan, Les Cultes Orientaux dans le<br />
monde Romain, Paris, (Trad. inglese a cura di A. Neville,<br />
The Cults of the Roman Empire, Oxford 1996).<br />
VERGINEO 1985 - G. Vergineo, Storia di Benevento e dintorni,<br />
1, Benevento.<br />
ZAZO 1964 - A. Zazo, Le chiese Parrocchiali di Benevento<br />
<strong>del</strong> XII-XVI secolo, in Ricerche e studi storici, VI, p. 31,<br />
Napoli.
BIANCA<br />
CANCELLARE
STEFANIA FIORE<br />
La Valle <strong>del</strong> Sabato<br />
tra Tarda Antichità e Medioevo<br />
Il fiume Sabato, uno dei principali affluenti<br />
<strong>del</strong> Calore irpino, lungo circa 50 Km,<br />
nasce ai piedi <strong>del</strong> massiccio <strong>del</strong>l’Accellica<br />
(1.660 m s.l.m.), ai confini <strong>del</strong>le province di<br />
Avellino e Salerno, e scorre nella vallata attraversando<br />
il territorio irpino per raggiungere infine<br />
Benevento. Il fiume, oggi ridotto ad un modesto<br />
ruscello a causa <strong>del</strong>la captazione <strong>del</strong>le acque, in<br />
antico doveva avere una portata maggiore e fu<br />
di vitale importanza per Abellinum ed il suo<br />
entroterra, poiché, grazie all’ampio sistema di<br />
percorsi naturali che raccordavano il territorio<br />
con le principali arterie <strong>del</strong>la regione e soprattutto<br />
con il Beneventano e il <strong>Salernitano</strong>, assicurò<br />
le comunicazioni e permise lo sviluppo di<br />
aree estreme poste in altura.<br />
Una <strong>del</strong>le principali traverse stradali era la<br />
Via antiqua maior che, passando per la colonia<br />
romana di Abellinum (oggi Atripalda), univa la<br />
Via Appia alla Regio – Capuam. Nel periodo<br />
Medievale a tale strada sarà preferita la Via<br />
Regia <strong>del</strong>le Puglie, fatto che favorì l’abbandono<br />
e il successivo degrado <strong>del</strong>le antiche vie consolari<br />
(Fig. 1) 1 .<br />
Il Sabato fu anche il fulcro dei primi insediamenti,<br />
per lo più sparsi nel fondovalle, fino alla<br />
dinamica occupazione dei Romani. A loro si<br />
deve la creazione in epoca sillana (88-80 a.C.)<br />
<strong>del</strong>la colonia di Abellinum che, posta lungo le<br />
maggiori direttrici, costituiva per i villaggi limitrofi<br />
il luogo dei mercati e <strong>del</strong>la vita associativa.<br />
In epoca imperiale si verificò un grande sviluppo<br />
edilizio soprattutto nella Civita, mentre nelle<br />
campagne si diffusero le ville rustiche, dove si<br />
svolgevano attività artigianali ed agricole. Nel<br />
corso <strong>del</strong>la tarda antichità e <strong>del</strong>l’altomedioevo<br />
queste terre divennero crocevia di apporti inno-<br />
- 95 -<br />
Fig. 1 - Sistema viario di epoca romana lungo la valle <strong>del</strong> Sabato.<br />
Fig. 2 – Atripalda (AV). Planimetria <strong>del</strong> quartiere di Capo la Torre. In<br />
evidenza le strutture murarie messe in luce, comprendenti i resti <strong>del</strong>la<br />
basilica paleocristiana <strong>del</strong> IV sec. d.C. e <strong>del</strong>l’edificio altomedievale a<br />
doppia abside (da FARIELLO SARNO 1996, p. 162).<br />
vativi, legati, in particolare, alla progressiva integrazione<br />
<strong>del</strong>le popolazioni allogene al sostrato<br />
culturale preesistente e al contestuale affermarsi<br />
<strong>del</strong> Cristianesimo, destinato a rivelarsi - qui<br />
come altrove - non solo determinante fattore di<br />
stabilità religiosa, ma anche elemento vitalizzante<br />
a livello insediativo.<br />
Le indagini archeologiche condotte dopo il<br />
sisma <strong>del</strong> 1980 nell’odierno quartiere di Capo la
Fig. 3 (come nel testo).Atripalda, Capo la Torre, planimetria <strong>del</strong>l’edificio<br />
absidato altomedievale, edificato sulla preesistente basilica<br />
paleocristiana.<br />
Fig. 4. Abellinum - Atripalda. Planimetria generale; al centro la Civita.<br />
Torre di Abellinum (Fig. 2) hanno riportato alla<br />
luce un cimitero paleocristiano (IV-VI d.C.) che<br />
si sviluppò intorno all’originaria cripta <strong>del</strong> santo<br />
martire Ippolisto (vissuto nel III sec. d.C.), con<br />
parte di una necropoli monumentale più antica,<br />
che ha restituito una fitta presenza di tombe<br />
disposte su più livelli, tra le quali si concentrano,<br />
nello strato superiore, quelle cristiane 2 .<br />
All’interno <strong>del</strong>la necropoli sono stati recuperati<br />
ampi resti monumentali, rivelatisi pertinenti<br />
ad una Basilica che ebbe forse anche il ruolo di<br />
chiesa episcopale. L’edificio basilicale, con<br />
SALTERNUM<br />
- 96 -<br />
orientamento Est-Ovest è riferibile, per l’impianto<br />
e la tipologia <strong>del</strong>le opere murarie in opus<br />
listatum, ai primi decenni <strong>del</strong> IV secolo d.C. ed<br />
è comparabile a numerosi monumenti edificati<br />
dopo l’Editto di Costantino (313 d.C.). Esso ha<br />
profondamente alterato il tessuto insediativo<br />
precedente, costituito da una necropoli pagana<br />
di età imperiale, cui vanno riferiti i numerosi<br />
elementi di spoglio reimpiegati nelle fondazioni<br />
3 .<br />
Le sepolture sono per la maggior parte corredate<br />
di iscrizioni che rappresentano un corpus di<br />
eccezionale valore, che si colloca tra il 357 ed il<br />
558 d.C 4 . Tali documenti attestano una diffusione<br />
<strong>del</strong> Cristianesimo relativamente tarda, ma<br />
profondamente radicata nel territorio soprattutto<br />
nel corso <strong>del</strong> V-VI secolo d.C 5 .<br />
Nel VI secolo d.C. l’area urbana <strong>del</strong>la Civita<br />
di Abellinum – già spopolatasi a causa <strong>del</strong> terremoto<br />
che si verificò nel 346 d.C., poi a causa<br />
<strong>del</strong>l’eruzione vesuviana datata tra il 472 d.C. e il<br />
507-511 d.C., e quindi a seguito <strong>del</strong>le invasioni<br />
barbariche – si contrasse e i suoi spazi furono<br />
rifunzionalizzati. La città fu in seguito abbandonata<br />
e non più ricostruita e la diocesi fu probabilmente<br />
soppressa: per il periodo che va dal VI<br />
al X secolo d.C. non si hanno più notizie circa i<br />
vescovi di Abellinum 6 .<br />
L’ultimo vescovo noto è Sabino, vissuto nel<br />
VI secolo d.C. e sepolto nello Speco di<br />
Atripalda, dove se ne conserva l’iscrizione metrica<br />
sul retro di un sarcofago reimpiegato 7 . Questo<br />
silenzio nella cronotassi vescovile viene da alcuni<br />
studiosi attribuito alla conquista e al dominio<br />
longobardo, che avrebbero provocato l’abbandono<br />
di Abellinum. La sede vescovile temporanea<br />
tra la seconda metà <strong>del</strong> VI secolo e il 663<br />
d.C. sarebbe stata la chiesa di San Johannis de<br />
Pratola (Pratola Serra, AV) che dista da<br />
Benevento 18 Km e da Abellinum circa 12 Km 8 .<br />
Tale chiesa, con orientamento Est-Ovest, fu<br />
scoperta nel 1981 sul pianoro “Pioppi” durante<br />
lo scavo di un settore (già adibito a magazzino),<br />
di una villa romana di II-III secolo d.C..<br />
L’edificio di culto era accompagnato da strutture<br />
riferibili ad un battistero con fonte a croce greca<br />
estradossa e da un sepolcreto, entrambi datati<br />
alla metà <strong>del</strong> VI secolo d.C.; i reperti archeolo-
gici rinvenuti in sepolture di epoca longobarda<br />
scavate all’interno <strong>del</strong>la chiesa si datano tra VI e<br />
VII secolo d.C.; sette croci in argento e una in<br />
oro e ricchi tessuti ricamati dimostrano che la<br />
costruzione fu voluta da classi agiate. La proposta<br />
di ritenere la chiesa di S. Giovanni di Pratola<br />
sede episcopale sarebbe avvalorata dalla natura<br />
<strong>del</strong>le strutture architettoniche, i cui resti lasciano<br />
intendere che in corrispondenza <strong>del</strong>l’arco trionfale<br />
vi fosse un triforium sorretto dal basamento<br />
<strong>del</strong>l’abside, dove poteva trovare posto un<br />
eventuale seggio vescovile.<br />
La rinascita <strong>del</strong>la sede episcopale <strong>del</strong>la<br />
Abellinum longobarda è documentata nel 969<br />
d.C., quando compare con il titolo di Sancta<br />
Maria sedis Abellinensis quale dipendenza<br />
<strong>del</strong>l’Arcivescovato di Benevento, con sede presso<br />
la collina “La Terra” (centro attuale di Avellino) 9 .<br />
Questa nuova sede venne ad assumere la<br />
giurisdizione ecclesiastica che in precedenza era<br />
stata svolta dalla basilica paleocristiana di Capo la<br />
Torre, le cui strutture in epoca altomedievale<br />
furono integrate da un edificio a doppia abside,<br />
con orientamento Nord-Sud, di cui ancora non è<br />
stata chiarita la funzione 10 (Fig. 3).<br />
Pochi sono i dati circa le dinamiche insediative<br />
longobarde in Abellinum, ma è appurato che<br />
i nuovi dominatori scelsero la collina “la Terra”,<br />
distante appena tre chilometri dall’antica colonia,<br />
per creare dapprima un abitato fortificato, poi<br />
una contea e una nuova sede episcopale (Figg. 4-<br />
5). La città ricoprirà dunque nel X secolo d.C. il<br />
ruolo di centro propulsore, fino a quando nel<br />
Medioevo si assisterà al moltiplicarsi di nuovi<br />
nuclei, attivi economicamente, politicamente e<br />
militarmente.<br />
Per quanto riguarda le campagne, in età tardoantica<br />
il fenomeno di abbandono dei centri<br />
era stato generale: il territorio, già disseminato di<br />
villae rusticae, durante il VI secolo risentì <strong>del</strong><br />
cedimento <strong>del</strong>l’economia, ma la vita non scomparve,<br />
riducendosi tuttavia alla sussistenza <strong>del</strong>la<br />
sola curtis. Con le distruzioni di Totila 11 (VI sec.<br />
d.C.) le genti abbandonarono le ville e cercarono<br />
riparo sui monti in posizioni naturalmente<br />
difese, secondo un fenomeno ampiamente<br />
documentato nella valle <strong>del</strong> Sabato, ma fu<br />
soprattutto a partire dal VII secolo d.C., durante<br />
STEFANIA FIORE<br />
- 97 -<br />
la prima costituzione <strong>del</strong> Ducato di Benevento,<br />
che la popolazione di Abellinum si andò disperdendo<br />
gradualmente nelle campagne lungo l’antica<br />
rete viaria, sviluppando una serie di nuovi e<br />
più sicuri insediamenti.<br />
In questo processo di riorganizzazione <strong>del</strong><br />
territorio, tra VI e IX secolo d.C., in piena espansione<br />
longobarda, si assiste alla costruzione di<br />
castra lungo tutta la valle <strong>del</strong> Sabato, fortificazioni<br />
che nei secoli successivi <strong>del</strong>imiteranno<br />
aree sulle quali si ergeranno dapprima i masti<br />
normanni, poi i castelli-residenza <strong>del</strong> periodo<br />
angioino-aragonese.<br />
fig. 5. Antica carta di Avellino.<br />
Fig. 6. Prata di Principato Ultra (AV). Pianta <strong>del</strong>la Basilica <strong>del</strong>la SS.<br />
Annunziata (da MUOLLO 2001, p. 23).<br />
Durante i primi secoli <strong>del</strong> Ducato di<br />
Benevento si assiste alla rivitalizzazione di luoghi<br />
già occupati in epoca imperiale, con la<br />
costruzione di basiliche con annessi cimiteri al<br />
posto <strong>del</strong>le ville rustiche, come abbiamo visto<br />
per Pratola Serra.
Un altro esempio è dato da Prata di<br />
Principato Ultra (AV), che da questa dista circa<br />
1 Km: qui si assiste alla trasformazione di una<br />
<strong>del</strong>le cripte cimiteriali di età imperiale (II-III<br />
sec. d.C.) in chiesa dedicata alla SS. Annunziata<br />
(Figg. 6-7). Grazie agli scavi e al restauro storico-artistico<br />
condotto nel 1999 sono stati messi<br />
in evidenza elementi che consentono di assegnare<br />
la basilica all’età longobarda e di proporne<br />
la datazione tra la fine <strong>del</strong> VII e la prima<br />
metà <strong>del</strong>l’VIII secolo 12 .<br />
Altro sito interessato da queste trasformazioni<br />
è Altavilla Irpinia: sul Monte Toro, l’impianto altomedievale<br />
<strong>del</strong>la chiesetta di S. Martino s’inserisce<br />
su un precedente insediamento rurale romano<br />
costituito da una villa con annesse fornaci 13 .<br />
Fig. 7. Prata di Principato Ultra (AV). Basilica <strong>del</strong>la SS.Annunziata.<br />
Planimetria generale e sezione.<br />
Fig. 8. Prata di<br />
Principato<br />
Ultra (AV).<br />
Triphorium e<br />
deambulatorio<br />
<strong>del</strong>la Basilica.<br />
SALTERNUM<br />
- 98 -<br />
I dati ricavati dall’analisi sistematica <strong>del</strong>le<br />
dinamiche insediative <strong>del</strong>la valle <strong>del</strong> Sabato, pur<br />
essendo limitati per alcune zone, offrono un<br />
quadro d’insieme abbastanza ricco per il periodo<br />
pre-romano e romano, mentre esiguo è quello<br />
relativo alla tarda antichità e all’altomedioevo.<br />
Labili le tracce <strong>del</strong> periodo bizantino, che si<br />
scorgono nell’influsso di alcuni culti provenienti<br />
dall’Oriente e nell’arte figurativa, caratterizzata<br />
da un’iconografia marcatamente aulica 14 (Fig. 9).<br />
Per il periodo medievale gli elementi sono<br />
maggiori: numerosi paesi conservano ancor oggi<br />
gli impianti e la struttura abitativa originaria di<br />
tale epoca, tipicamente arroccata su colline o su<br />
speroni rocciosi dominati da castelli più o meno<br />
riconoscibili.<br />
Sul piano cultuale, i vescovi si fecero promotori<br />
<strong>del</strong>la devozione verso i santi locali, talvolta<br />
in sostituzione <strong>del</strong>le scelte operate in precedenza<br />
dalle élite politiche longobarde, particolarmente<br />
legate all’Angelo Michele e al Salvatore.<br />
Con i Normanni non si avrà una particolare<br />
attenzione per i culti estranei alle comunità -<br />
come avverrà invece con gli Angioini e gli<br />
Aragonesi - ma soltanto la promozione di nuove<br />
costruzioni o ricostruzioni di chiese per legittimare<br />
il loro potere e per stabilire intese con i<br />
dominati. Solo in un caso essi introdussero un<br />
culto che apparteneva alla propria tradizione e<br />
riguardò gli Oldoini, attestati in Irpinia nella<br />
seconda metà <strong>del</strong>l’XI secolo, in particolare a<br />
Candida e a Serra (frazione di Pratola).<br />
Tutto il comprensorio si presenta dunque<br />
ricco di testimonianze archeologiche che attestano<br />
una continuità insediativa iniziata nella preistoria<br />
e protrattasi sino ad oggi. Gli elementi che<br />
emergono da tale contesto permettono di impostare<br />
lo studio di diverse problematiche storiche,<br />
che attendono di essere oggetto di studi e di<br />
ulteriori indagini, affinché i fatti antichi, i monumenti<br />
superstiti e le tracce archeologiche relativi<br />
alla vita che lungo gli argini <strong>del</strong> fiume Sabato<br />
si è andata svolgendo diventino un patrimonio<br />
comune.
*Questo articolo sintetizza i risultati di una tesi di<br />
Laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali,<br />
Università di Salerno a.a. 2005-2006 (Relatore:<br />
prof.ssa C. Lambert; Correlatore: prof. P.<br />
Peduto).<br />
NOTE<br />
1 Per la Via Antiqua Maior cfr. SCANDONE 1947,<br />
pp. 66-69; la Via Appia, detta “regina viarum”,<br />
fu costruita nel 312 a.C. dal console Appio<br />
Claudio, da cui prese il nome, e collegava Roma<br />
con Brindisi. La Via Regio-Capuam, detta anche<br />
Annia dal console Tito Annio Rufo, fu costruita<br />
nel 152 a.C.. Ad epoca medievale e moderna<br />
vanno ascritti i lavori <strong>del</strong>la Via Regia <strong>del</strong>le<br />
Puglie, iniziati nel 1270 e terminati solo nel 1585.<br />
2 L’originaria cripta va identificata con l’attuale<br />
ipogeo <strong>del</strong>la chiesa di S. Sabino o Specus<br />
Martyrum, in Atripalda. FARIELLO SARNO 1996, p.<br />
165; PESCATORI COLUCCI 2005, pp. 298-306.<br />
3 FARIELLO SARNO 1996b, p. 161.<br />
4 CIL, X, 1191; CIL, X, 1193; le iscrizioni abellinati sono state<br />
studiate da H. Solin e costituiranno un volume specifico<br />
<strong>del</strong>le Inscriptiones Christianae Italiae saeculo septimo antiquiores<br />
(ICI), di imminente pubblicazione. Alcune anticipazioni<br />
in SOLIN 1998, p. 483. Per la cristianizzazione <strong>del</strong>la<br />
regione cfr. LAMBERT 2004, cds.<br />
5 LAMBERT 2004, cds.<br />
6 La prima notizia certa sull’organizzazione diocesana di<br />
Abellinum risale al 499 d.C., quando il vescovo Timotheus<br />
partecipò al Sinodo Romano a favore di Papa Simmaco<br />
(498-514 d.C.) cui il partito bizantino aveva contrapposto<br />
l’antipapa Lorenzo che gli resistette fino all’anno 506 d.C.<br />
(UGHELLI 1721, p. 191). Sicuramente non attribuibile al<br />
presbyter Iohannis, citato nell’epigrafe funeraria CIL, X,<br />
1192 di Ajello <strong>del</strong> Sabato, il ruolo di ultimo vescovo di<br />
Abellinum voluto dallo Scandone e dal Mommsen; si tratta<br />
più probabilmente <strong>del</strong> sacerdote di una locale comunità<br />
rurale (in proposito, cfr. GAMBINO 1983, pp. 41-44; SOLIN<br />
1998, p. 472; LAMBERT 2004, cds; LAMBERT 2007, pp. 45; 52;<br />
67, fig. 1).<br />
STEFANIA FIORE<br />
Fig. 9. Prata di Principato Ultra (AV). Basilica <strong>del</strong>la SS.Annunziata, abside centrale:<br />
affresco <strong>del</strong>la Madonna orante tra due Santi (da MUOLLO 2001, p. 64).<br />
- 99 -<br />
7 CIL, X, 1194; LAMBERT C. 2007, pp. 43-45; 51-52; 69, fig. 3.<br />
8 Il 663 d.C. fu l’anno in cui il territorio <strong>del</strong> vasto Ducato<br />
beneventano fu totalmente ristrutturato da Grimoaldo (642-<br />
662 d.C. duca di Benevento; 662-671 d.C. re dei<br />
Longobardi) e da suo figlio Romualdo (671-687 d.C.) e<br />
venne contestualmente riorganizzata la diocesi di<br />
Benevento, che vide a sé annesse anche sedi molto lontane.<br />
L’ipotesi <strong>del</strong> trasferimento è in PEDUTO 1996, pp. 209-<br />
218.<br />
9<br />
PESCATORI COLUCCI 1996, p. 204.<br />
10<br />
FARIELLO SARNO 1996, p. 173.<br />
11 Totila, re degli Ostrogoti, durante la guerra greco-gotica<br />
(535-553 d.C.) distrusse tutte, o quasi tutte, le opere di difesa<br />
per impedire ai Bizantini la rioccupazione.<br />
12<br />
MUOLLO 2001, pp. 38-39.<br />
13<br />
FARIELLO SARNO 1987, pp. 171-179; PESCATORI COLUCCI 1996,<br />
p. 200.<br />
14 Un esempio è dato dagli affreschi <strong>del</strong>la Basilica di Prata<br />
Principato Ultra, per i quali cfr. MUOLLO 2001, pp. 49-62.
BIBLIOGRAFIA<br />
FARIELLO SARNO 1987 - M. FARIELLO SARNO, Complesso di fornaci<br />
tardo antiche ad Altavilla Irpina, in “L’Irpinia nella<br />
Società Meridionale”, Centro di Ricerca Guido Dorso,<br />
“Annali” 1985-1986, II, Milano, 1987, pp. 171-179.<br />
FARIELLO SARNO 1996 - M. FARIELLO SARNO, Abellinum paleocristiana,<br />
in Storia illustrata di Avellino e <strong>del</strong>l’Irpinia, I,<br />
1996, pp. 161-174.<br />
GAMBINO 1983 - N. GAMBINO, Rilettura <strong>del</strong>la iscrizione di<br />
Ajello <strong>del</strong> Sabato nel contesto <strong>del</strong>l’epigrafia cristiana avellinese,<br />
in “Civiltà altirpina” VIII, gennaio-aprile, fasc. 1-2,<br />
1983, pp. 35-44.<br />
LAMBERT 2004 cds - C. LAMBERT, La cristianizzazione <strong>del</strong>la<br />
Campania: il contributo <strong>del</strong>l’epigrafia, in Atti <strong>del</strong> IX<br />
Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana, Agrigento<br />
2004.<br />
LAMBERT 2007 - C. LAMBERT, Iscrizioni di vescovi e presbiteri<br />
nella Campania tardoantica ed altomedievale (secc. IV-<br />
VIII), in “Schola Salernitana”, Annali XI, 2006, Salerno,<br />
2007, pp. 31-70.<br />
MOMMSEN 1863-1872 - TH. MOMMSEN, Corpus Inscriptionum<br />
Latinarum, X, Berlino, 1863-72.<br />
MUOLLO 2001 - G. MUOLLO, La Basilica di Prata Principato<br />
Ultra, Viterbo, 2001.<br />
PEDUTO 1992 - P. PEDUTO, San Giovanni di Pratola Serra.<br />
SALTERNUM<br />
- 100 -<br />
Archeologia e storia nel ducato longobardo di Benevento,<br />
Salerno, 1992.<br />
PEDUTO 1996 - P. PEDUTO, Le Basiliche di Pratola e Prata, in<br />
Storia illustrata di Avellino e <strong>del</strong>l’Irpinia, I, 1996 pp. 209-<br />
223.<br />
PESCATORI COLUCCI 1996 - G. PESCATORI COLUCCI, Abellinum e<br />
l’alta Valle <strong>del</strong> Sabato tra tardo-antico e alto Medioevo, in<br />
Storia illustrata di Avellino e <strong>del</strong>l’Irpinia, I, 1996, pp. 193-<br />
206.<br />
PESCATORI COLUCCI 2005 - G. PESCATORI COLUCCI, Città e centri<br />
demici <strong>del</strong>l’Hirpinia: Abellinum, Aeclanum, Aequum<br />
Tuticum, Compsa, in Le città campane fra tarda antichità e<br />
alto medioevo (a cura di G. Vitolo), Salerno, 2005, pp. 283-<br />
311.<br />
SOLIN 1998 - H. SOLIN, Le iscrizioni paleocristiane di<br />
Avellino, in Epigrafia romana in area adriatica. Actes de la<br />
IX rencontre franco-italienne sur l’épigraphie du mond<br />
romain (Macerata, 1995), Macerata, 1998, pp. 471-484.<br />
SCANDONE 1947, F.SCANDONE Storia di Avellino, I, parte I,<br />
1947: Abellinum Romanum, Avellino, 1947.<br />
Storia illustrata di Avellino e <strong>del</strong>l’Irpinia 1996, (a cura) di<br />
G. Pescatori Colucci, E. Cuozzo, F. Barra, Pratola Serra,<br />
1996.<br />
UGHELLI 1721 - F. UGHELLI, Italia Sacra, vol. VIII, col. 191,<br />
Venezia, 1721.
ROSANNA BARONE<br />
Iconografia e scrittura nei mosaici<br />
<strong>del</strong>la Cattedrale di Salerno<br />
Nella seconda metà <strong>del</strong>l’XI secolo, grazie<br />
alla cooperazione <strong>del</strong>l’arcivescovo<br />
Alfano I e <strong>del</strong> duca Roberto il<br />
Guiscardo, in Salerno vennero poste le fondamenta<br />
e si diede forma alla Cattedrale romanica,<br />
che sarà consacrata a S. Matteo (fig. 1).<br />
I numerosi saggi dedicati al Duomo salernitano<br />
ne evidenziano principalmente il rapporto di<br />
filiazione dall’Abbazia di Montecassino, la valenza<br />
storica rivestita nell’età di trapasso dalla<br />
dominazione longobarda a quella normanna,<br />
nonché il valore <strong>del</strong>le opere d’arte scultoree che<br />
nel tempo contribuirono ad abbellirla. Gli studi<br />
in proposito sono numerosi e spesso di alto<br />
valore contenutistico: basti pensare all’amplissima<br />
bibliografia di Monsignor Arturo Carucci,<br />
che dedicò una vita di studi alla Cattedrale salernitana,<br />
ed al recente volume monografico di<br />
Antonio Braca 1 . In tutti questi scritti, di carattere<br />
descrittivo o di inquadramento <strong>del</strong> monumento<br />
nell’ambito <strong>del</strong>la cultura architettonica e storicoartistica<br />
<strong>del</strong> Medioevo nell’Italia meridionale,<br />
manca tuttavia una trattazione specifica sul rapporto<br />
architettura-decorazione musiva e, ancor<br />
più, sull’iconografia dei mosaici ed il loro legame<br />
con la scrittura epigrafica 2 .<br />
L’esame che si è condotto sulle decorazioni<br />
interne <strong>del</strong> Duomo di Salerno per indagare questo<br />
aspetto ha evidenziato, pur nella lacunosità<br />
<strong>del</strong>le parti conservate, uno stretto rapporto con<br />
la funzione didascalica <strong>del</strong>la scrittura, ridotta<br />
quasi esclusivamente a tituli esplicativi - quali i<br />
nomi dei personaggi - o a brevi passi biblici.<br />
La prima menzione sui mosaici <strong>del</strong>la<br />
Cattedrale è <strong>del</strong>l’arcivescovo M. A. Marsilio<br />
Colonna (1574-1581), il quale, nella descrizione<br />
<strong>del</strong>l’edificio, dopo aver ricordato che tre altari<br />
- 101 -<br />
Fig. 1 - Salerno, Duomo.<br />
Assonometria con localizzazione dei mosaici parietali.<br />
erano collocati “ad estremos parietes ad<br />
Orientem versus”, aggiunge che “hos vero parietes<br />
ultimos templi valde incunea miniati operis<br />
pictura convestit” 3 . Il muro orientale è indicato<br />
con il plurale “parietes”, che potrebbe significare<br />
“le absidi”, le quali rappresentano in effetti gli<br />
estremi <strong>del</strong>la cattedrale “ad Orientem versus” e<br />
che alla fine <strong>del</strong> secolo XVI erano rivestite sicuramente<br />
di mosaici e dotate di un altare. Il<br />
Colonna, immediatamente dopo, chiama però<br />
l’abside emispherium, precisando che il popolo<br />
le dava il nome di tribuna e non di parietes.<br />
Non si può escludere, pertanto, che l’intera<br />
parete orientale fosse rivestita di mosaici.<br />
Tale decorazione “ad Orientem versus” fu<br />
messa in opera tra la fine <strong>del</strong> secolo XI e la metà<br />
<strong>del</strong> secolo XII ed è oggi parzialmente superstite
Fig. 2 - Salerno, Duomo.Abside centrale ed arco trionfale.<br />
nell’abside di sinistra, in parte ripristinata in quella<br />
di destra 4 . L’abside centrale, dove l’originale è<br />
andato interamente perduto salvo che per ampi<br />
frammenti <strong>del</strong>l’arco trionfale 5 , è frutto <strong>del</strong> restauro<br />
<strong>del</strong> 1953, anno in cui, con l’approssimarsi <strong>del</strong>le<br />
celebrazioni millenarie <strong>del</strong>la traslazione in Salerno<br />
<strong>del</strong>le reliquie di San Matteo (954-1954), fu deciso<br />
di rivestire l’abside maggiore con nuovi mosaici,<br />
la cui composizione rivela il gusto <strong>del</strong> XX secolo<br />
(fig. 2). La Vergine vi campeggia in una mandorla<br />
dorata su fondo blu 6 ; nella parte inferiore un<br />
angelo in volo regge il libro <strong>del</strong> Vangelo aperto<br />
alla pagina iniziale di san Matteo. Ai lati <strong>del</strong>la<br />
Madonna vengono identificati, attraverso tituli,<br />
Alfano I (1015/20-1085), che fu l’ideatore e il<br />
direttore dei lavori nel Duomo salernitano e<br />
Gregorio VII (1020/1085) che lo consacrò nel<br />
1084 7 .<br />
Nella fascia sottostante si è inteso ricordare<br />
i Pontefici che hanno onorato Salerno con la<br />
propria presenza. Mancano tuttavia, strana-<br />
SALTERNUM<br />
- 102 -<br />
mente, Innocenzo II, che si trattenne a Salerno<br />
per più giorni nell’agosto <strong>del</strong> 1137, e Pio IX,<br />
che fu a Salerno nell’ottobre <strong>del</strong> 1849, né si<br />
conosce la ragione che ha fatto attribuire l’aureola<br />
e il titolo di “Santo” a ciascun Papa raffigurato,<br />
escludendo da questa arbitraria canonizzazione<br />
Clemente II e Alessandro III, che<br />
iniziano e chiudono la serie di questi Pontefici<br />
- santi solo nei mosaici salernitani; fanno eccezione<br />
Leone IX, unico effettivamente canonizzato<br />
dalla Chiesa, e Vittore III, il famoso<br />
Desiderio fondatore <strong>del</strong>l’Abbazia di Montecassino,<br />
ritenuto santo dai Benedettini. I singoli personaggi<br />
sono identificabili grazie ai tituli musivi.<br />
Alfano, il cui nome è trascritto per errata<br />
versione latina come Alphanus per Alfanus,<br />
regge con la mano un cartiglio con la scritta<br />
Laetare felix civitas / Laetare sanctis gaudiis. Il<br />
lettore, però, non troverà questi versi nei<br />
numerosi carmi <strong>del</strong> Vescovo poeta, perché<br />
sono opera di un ignoto epigono.
Finalità principalmente<br />
dedicatoria e celebrativa riveste<br />
invece il lungo testo sottostante<br />
8 , che pone l’edificio<br />
sotto la triplice protezione <strong>del</strong><br />
Cristo, <strong>del</strong>la Vergine e di S.<br />
Matteo, evidenziando al contempo<br />
il ruolo eminente<br />
<strong>del</strong>l’Arcivescovo Alfano I 9<br />
(fig. 3). La collocazione <strong>del</strong><br />
suo nome nei primi due versi<br />
<strong>del</strong>l’iscrizione musiva non<br />
può passare inosservata,<br />
riproponendosi come esaltazione<br />
<strong>del</strong>la figura <strong>del</strong> fondatore<br />
così come per Desiderio<br />
a Montecassino, il quale, proprio<br />
nel catino absidale, aveva a sua volta parafrasato<br />
la scritta di Costantino nella basilica di<br />
San Pietro in Vaticano. La presenza <strong>del</strong> solo<br />
nome di Alfano accompagnato alla preghiera<br />
indica l’esclusione dei laici dalla vita <strong>del</strong>la chiesa,<br />
una sottolineatura <strong>del</strong>la separazione dei ruoli<br />
e <strong>del</strong>le competenze sollecitata dalla Riforma<br />
<strong>del</strong>l’XI secolo. A differenza di Desiderio e di<br />
Costantino, nessun merito viene tuttavia rivendicato<br />
al Vescovo salernitano, il cui nome è invece<br />
“associato al programma teologico, che viene<br />
espresso nei versi successivi, con i dogmi<br />
<strong>del</strong>l’Incarnazione divina, dalla verginità mariana,<br />
<strong>del</strong>la Passione e <strong>del</strong>la Resurrezione, in altri termini<br />
la strada <strong>del</strong>la Salvezza” 10 . Ne emerge una figu-<br />
ROSANNA BARONE<br />
Fig. 3 - Salerno, Duomo.Abside centrale, particolare <strong>del</strong>l’iscrizione ai piedi <strong>del</strong>la teoria di Papi.<br />
- 103 -<br />
ra profondamente diversa e nuova rispetto ai<br />
suoi diretti mo<strong>del</strong>li, non legata ai fatti terreni e<br />
non collegata alle vicende materiali <strong>del</strong>la costruzione<br />
<strong>del</strong>l’edificio: non c’è una dedica al fondatore,<br />
ma una invocazione che ha l’arcivescovo<br />
per oggetto. Il secondo verso, dove si chiede che<br />
egli “sia per sempre beato” è particolarmente eloquente<br />
e poiché questo è uno status non concesso<br />
in vita, ma riconosciuto dalla Chiesa solo<br />
dopo la morte, da tali versi si possono trarre due<br />
indicazioni importanti: il personaggio va identificato<br />
inequivocabilmente con Alfano I ed il testo<br />
musivo è di sicuro postumo, poiché sarebbe<br />
stato singolare ed alquanto inopportuno che egli<br />
autocelebrasse in vita la propria beatitudine.<br />
Fig. 4 - Salerno, Duomo. Lunetta <strong>del</strong>la<br />
controfacciata con la raffigurazione di<br />
San Matteo.
Se ne evince dunque che le parti superstiti<br />
<strong>del</strong>la decorazione musiva, con le relative iscrizioni,<br />
si datano al XII secolo nella stesura originaria,<br />
anche se modificate nella forma a seguito<br />
<strong>del</strong> restauro.<br />
Nell’esame <strong>del</strong>la decorazione musiva <strong>del</strong>la<br />
Cattedrale va infine presa in considerazione la<br />
lunetta <strong>del</strong>la controfacciata, entro la quale campeggia<br />
la figura di S. Matteo; essa costituisce<br />
infatti un insieme cronologico omogeneo e riferibile<br />
con certezza al nucleo superstite <strong>del</strong>la fase<br />
decorativa più antica <strong>del</strong> Duomo (fig. 4).<br />
L’esame <strong>del</strong>le lettere, analizzate singolarmente<br />
nel tentativo di evidenziarne le variabili grafiche,<br />
*Articolo tratto dalla propria Tesi di Laurea in Beni<br />
Culturali: I mosaici <strong>del</strong> Duomo di Salerno: Iconografia e<br />
scrittura, Università degli Studi di Salerno, a.a. 2005-2006<br />
(Relatore: prof.ssa C. M. Lambert). Le foto n. 2-3-4-5<br />
(Archivio <strong>del</strong>la Soprintendenza per i Beni Ambientali,<br />
Architettonici, Artistici e Storici per le Province di Salerno e<br />
Avellino) sono state debitamente autorizzate. Per aver favorito<br />
la ricerca e l’acquisizione di tale materiale sono particolarmente<br />
riconoscente verso il sig. Vincenzo D’Antonio,<br />
Fotografo, e la sig.ra Amelia Storace. La figura n. 1 è una<br />
rielaborazione dalla Rivista “Bella Italia” n. 150, ott. 1998,<br />
p. 70.<br />
NOTE<br />
1 Le principali opere di monsignor A. Carucci, edite dal<br />
1922 al 2005 sono elencate in A. BRACA, Il Duomo di<br />
Salerno, architettura e culture artistiche <strong>del</strong> Medioevo e<br />
<strong>del</strong>l’Età Moderna, Salerno, 2003, testo cui si rimanda quale<br />
trattazione più aggiornata sul Duomo di Salerno, corredata<br />
inoltre da un ricco apparato fotografico.<br />
2 Nel panorama generale degli studi di epigrafia medievale,<br />
<strong>del</strong> resto, i contributi di tale genere sono ancora numericamente<br />
scarsi e limitati principalmente ad alcuni monumenti<br />
di età tardoantica-altomedievale <strong>del</strong>la città di Roma, o<br />
alle grandi costruzioni religiose normanne in Sicilia. In proposito<br />
cfr. rispettivamente P. BOSIO, Edifici di culto e produzione<br />
epigrafica (VI-IX secolo) in Ecclesiae Urbis, Atti <strong>del</strong><br />
congresso internazionale di studi sulle chiese di Roma, (IV<br />
- IX secolo) Roma 2000, Città <strong>del</strong> Vaticano, 2002 e G.<br />
CAVALLO - F. MAGISTRALE, Mezzogiorno normanno e scritture<br />
esposte, in Epigrafia medievale greca e latina ideologia e<br />
funzione, a cura di G. Cavallo - C. Mango, Spoleto, (Centro<br />
SALTERNUM<br />
- 104 -<br />
permette di trarre alcune conclusioni, pur nella<br />
consapevolezza <strong>del</strong>le peculiarità <strong>del</strong>la resa, legata<br />
alla materia prima e alle difficoltà intrinseche<br />
<strong>del</strong>la posa in opera <strong>del</strong>le tessere (fig. 5).<br />
I confronti paleografici con gli esempi scrittori<br />
su materiale morbido (pergamene) e duro<br />
(materiali lapidei), fatti salvi i limiti imposti dalla<br />
natura dei supporti e dalle differenti finalità di<br />
fruizione, consentono di confermare per questo<br />
specimen <strong>del</strong>la decorazione più antica la cronologia<br />
alla seconda metà <strong>del</strong>l’XI secolo, nota da<br />
altre fonti, ed un’attribuzione alla diretta committenza<br />
di Alfano I.<br />
Italiano di studi sull’alto medioevo), 1991, pp. 293-328.<br />
3 M. A. COLONNA, De vita et gestis Beati Matthaei Apostoli et<br />
Evangelistae, Napoli, 1580.<br />
4 L’abside di sinistra, in parte a mosaico e in parte ad affresco,<br />
raffigura il Battesimo di Gesù, cui assistono due schiere<br />
di angeli e cherubini. Nell’abside di destra, al centro di<br />
un luminoso fondo d’oro, campeggiano le immagini di san<br />
Michele e di san Matteo. A lato <strong>del</strong>l’Evangelista, divisi dall’arcata<br />
<strong>del</strong> finestrone absidale, sono raffigurati a sinistra<br />
Giovanni da Procida in ginocchio e i santi Fortunato e<br />
Giovanni; a destra i santi Giacomo e Lorenzo.<br />
L’identificazione di questi santi è affidata esclusivamente a<br />
tituli, peraltro frutto di restauro.<br />
5 J. SCHLOSSER, L’arte nel Medioevo, Torino, 1935.<br />
6 G. BERGAMO, Il Duomo di Salerno, Battipaglia, 1972.<br />
7 I due artefici <strong>del</strong>la edificazione <strong>del</strong> Duomo salernitano<br />
morirono entrambi nel 1085. Il papa fu sepolto presso il<br />
sepolcro di S. Matteo nella Basilica Inferiore e successivamente<br />
trasferito nella Basilica Superiore, a lato <strong>del</strong>la<br />
Cappella <strong>del</strong>le Crociate.<br />
8 E. KITZINGER, The first mosaic decoration of Salerno<br />
Cathedral in “Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik”,<br />
XXI, 1972, pp. 150-167. Il Kitzinger riporta che in una pubblicazione<br />
<strong>del</strong> 1580 si leggeva che “in Emispherio maiori”<br />
era collocata un’iscrizione musiva, la stessa che tutt’oggi è<br />
posta nell’abside maggiore sotto la teoria di Papi.<br />
9 La posizione e la funzione <strong>del</strong> testo trovano ampi riscontri<br />
nelle figurazioni absidali <strong>del</strong> Medioevo. In proposito cfr.<br />
P. BOSIO, Edifici di culto e produzione epigrafica (VI-IX<br />
secolo), cit., p. 284.<br />
10 A. BRACA, Il Duomo di Salerno, architettura e culture artistiche<br />
<strong>del</strong> Medioevo e <strong>del</strong>l’Età Moderna, cit. p. 115.
Fig. 5a.<br />
Fig. 5c.<br />
ROSANNA BARONE<br />
- 105 -<br />
Fig. 5b.<br />
Fig. 5d.
Fig. 5e.<br />
Fig. 5g.<br />
Fig. 5i.<br />
SALTERNUM<br />
Fig. 5f.<br />
Fig. 5h.
La chiesa di Sant’Ilario (fig.1), in base ai<br />
più recenti studi, potrebbe essere uno<br />
dei primi esempi di architettura altomedievale<br />
nel territorio beneventano, precedente<br />
anche alla costruzione <strong>del</strong>la nota chiesa di Santa<br />
Sofia, voluta da Arechi II nell’anno 758.<br />
L’edificio è noto con il nome di “Sant’ Ilario a<br />
port’Aurea” perché eretto nei pressi <strong>del</strong>l’arco di<br />
Traiano, inglobato in epoca longobarda nella<br />
nuova cinta muraria e divenuto la “porta Aurea”<br />
<strong>del</strong>la città (fig. 2).<br />
Problemi tuttora aperti sono l’attribuzione<br />
<strong>del</strong>la chiesa ad una matrice longobarda o bizantina<br />
e la sua datazione viene variamente collocata<br />
nel VII secolo, alla fine <strong>del</strong> VII – inizi VIII o<br />
perfino nell’XI secolo.<br />
La più antica fonte che permette di identificare<br />
nel modesto edificio superstite la chiesa di<br />
Sant’Ilario risale agli inizi <strong>del</strong> XII secolo: un<br />
documento datato al novembre 1110 attesta l’esistenza,<br />
fuori Port’Aurea, di un orto appartenente<br />
all’ecclesia vocabolo sancti ylari 1 . Questa<br />
cartula commutationis rappresenta il terminus<br />
ante quem per la fondazione <strong>del</strong>la piccola chiesa,<br />
ma l’attestazione di una presenza monastica<br />
in S.Ilario si ha solo nel dicembre 1148, in un<br />
documento in cui si legge:“In Nomine Domini,<br />
anno millesimo centesimo quadragesimo octavo<br />
a me Gaydo qui sum procurator et vicecomes<br />
Monasteri Sancti Ylari quod constructum est a<br />
foris prope Portam Auream …” 2 . Nei trent’anni<br />
tra la data <strong>del</strong> più antico documento relativo<br />
all’ecclesia e la prima attestazione <strong>del</strong> convento<br />
non è da escludere che un primo corpo di<br />
ambienti abitativi e di servizio si fosse già svilup-<br />
DANIELA VISCONTI<br />
La chiesa di Sant’Ilario a Benevento:<br />
un prototipo <strong>del</strong>l’architettura longobarda<br />
- 107 -<br />
Fig. 1 - Chiesa di Sant’Ilario, vista Sud – Ovest.<br />
Fig. 2 - Topografia di Benevento longobarda.<br />
pato intorno al Sant’Ilario (fig.3). Nei primi<br />
decenni <strong>del</strong> XIII secolo la chiesa appare attestata<br />
come dipendente dal monastero femminile di<br />
S.Paolo extra muros; nella prima metà <strong>del</strong> XV<br />
secolo essa era ormai semi-abbandonata e l’ultima<br />
attestazione compare nei decreti di una visita<br />
apostolica <strong>del</strong> 1581 3 . Prima <strong>del</strong> 1708 l’edificio<br />
venne adibito a casa colonica 4 e da allora divenne<br />
irriconoscibile e bisognerà attendere il 1802<br />
perché Emanuele Annecchini riconosca la chiesa<br />
e la citi nel suo inedito manoscritto “Breve<br />
Compendio Istorico <strong>del</strong>le principali notizie <strong>del</strong>la<br />
città di Benevento” 5 .
Fig. 3 - Veduta <strong>del</strong> monastero nel XVII secolo (da LEPORE 1995).<br />
Sull’identità <strong>del</strong>l’edificio, tuttavia, vi erano<br />
ancora perplessità, nate dalla lettura <strong>del</strong>la<br />
“Pianta Sofiana Orsina”, conservata nell’Archivio<br />
Storico Provinciale di Benevento (fol.7, n.2), che<br />
aveva fatto sorgere il dubbio che la struttura<br />
presso l’Arco di Traiano fosse l’antica chiesa di<br />
S.Pietro, a causa <strong>del</strong>le dimensioni pressocchè<br />
uguali. Anche quella piccola chiesa infatti era ad<br />
aula unica divisa in due campate, con una piccola<br />
abside semicircolare dove era stato ricavato<br />
un forno durante il suo uso abitativo. Fu Mario<br />
Rotili, in un suo intervento nel corso <strong>del</strong> III<br />
Congresso Internazionale di studi sull’Alto<br />
medioevo <strong>del</strong> 1956, a precisare, con convincenti<br />
argomenti, che si trattava proprio <strong>del</strong>l’antica<br />
chiesa di Sant’Ilario e non di quella di S.Pietro,<br />
che invece era situata nella contrada ad<br />
Caballum 6<br />
Durante gli interventi di consolidamento <strong>del</strong>l’edificio,<br />
eseguiti in seguito al terremoto <strong>del</strong><br />
1980, emersero elementi che resero indispensabili<br />
i primi scavi di emergenza (1981), nel corso<br />
dei quali vennero alla luce resti di costruzioni<br />
romane e alcune sepolture di età basso medievale,<br />
realizzate entro cassoni in muratura. Nel<br />
1986 furono pianificati gli scavi <strong>del</strong>l’interno, che<br />
misero in evidenza come la chiesa era stata<br />
costruita su un grossa struttura in opera laterizia,<br />
SALTERNUM<br />
- 108 -<br />
pertinente ad un complesso monumentale databile<br />
genericamente all’età imperiale. Nella tarda<br />
antichità si ebbe un primo parziale processo di<br />
obliterazione, sotto spessi strati di terreno di<br />
riporto. I vari livelli di riempimento hanno restituito<br />
materiali di età compresa tra il IV secolo<br />
a.C. ed il II secolo d.C. Nello spazio <strong>del</strong>la prima<br />
campata <strong>del</strong>la chiesa attuale fu rinvenuta una<br />
fossa granaria costituita da un’anfora di grandi<br />
dimensioni che conteneva statuette votive in terracotta<br />
(teste, bambini fasciati <strong>del</strong> tipo medio -<br />
italico) di difficile inquadramento cronologico 7 .<br />
L’abbandono potrebbe essere coinciso con il<br />
degrado strutturale determinato dai numerosi<br />
eventi sismici, come quello <strong>del</strong> 369 d.C., che<br />
provocò ingenti danni. Tra i secoli IV e V una<br />
parte degli antichi ambienti fu occupata da<br />
nuove murature, come la possente fondazione<br />
in opera cementizia ancor oggi visibile sotto<br />
l’angolo nord – orientale <strong>del</strong>la chiesa 8 , che sorse<br />
probabilmente tra la fine <strong>del</strong> VII e l’inizio<br />
<strong>del</strong>l’VIII secolo ed alla quale è forse pertinente<br />
un’area sepolcrale individuata nelle vicinanze 9 .<br />
L’utilizzo <strong>del</strong>le vecchie strutture influenzò l’orientamento<br />
e la planimetria <strong>del</strong>l’edificio di<br />
culto: l’aula rettangolare <strong>del</strong>la chiesa fu posizionata<br />
in modo tale da coincidere con il lato nord<br />
<strong>del</strong>l’antico ambiente rettangolare <strong>del</strong> II secolo<br />
d.C.<br />
Per la decorazione interna <strong>del</strong>l’edificio nel<br />
periodo altomedievale si dispone solo <strong>del</strong><br />
ritrovamento di 12 frammenti di stucco 10 ; quanto<br />
alla ceramica, se ne rinvennero frammenti<br />
databili al II secolo d.C. e alcuni pezzi dipinti “a<br />
bande strette”, riferibili ai secoli XIII e XIV,<br />
periodo cui vanno riferiti anche dei resti di<br />
intonaco affrescato. Ciò ha fatto supporre che la<br />
fase costruttiva <strong>del</strong>la chiesa abbia portato alla<br />
rimozione degli strati appartenenti ai secoli<br />
intermedi 11 .<br />
Nelle murature esterne invece è testimoniato<br />
il reimpiego di diversi elementi architettonici di<br />
età classica, a conferma di una pratica molto<br />
attestata nell’alto medioevo e che trova non<br />
poche conferme nel territorio beneventano 12 . In<br />
corrispondenza <strong>del</strong>l’angolo sud – ovest <strong>del</strong>l’accesso<br />
attuale e <strong>del</strong> portale maggiore, oggi murato,<br />
che sul lato sud si apriva verso la strada,
DANIELA VISCONTI<br />
Fig. 4 - Pianta e sezione <strong>del</strong>la chiesa di Sant’Ilario allo stato attuale (da G.AUSIELLO, Architettura medievale, tecniche costruttive in Campania, Napoli,<br />
1999, p. 53).<br />
compaiono due frammenti di architravi di età<br />
romana 13 e un’epigrafe. Oltre ai fregi, sempre di<br />
reimpiego, sono diversi blocchi squadrati, in calcare<br />
e marmo bianco, inseriti negli angoli e nei<br />
pilastrini interni, inquadrabili stilisticamente tra<br />
l’età tardo – repubblicana e l’età imperiale. Ad<br />
epoca successiva si possono attribuire i grandi<br />
blocchi di calcare di differente qualità, impiegati<br />
nella costruzione <strong>del</strong> plinto di fondazione <strong>del</strong><br />
pilastro centrale. L’epigrafe situata sul lato destro<br />
<strong>del</strong>l’ingresso occidentale <strong>del</strong>la chiesa, incisa su<br />
una lastra di calcare che reca ben visibili le tracce<br />
<strong>del</strong>l’usura, dovute presumibilmente alla sua<br />
precedente funzione di soglia, che l’hanno resa<br />
quasi illeggibile, è databile probabilmente ad età<br />
tardoantica 14 .<br />
Nell’età bassomedievale si assiste ad un<br />
ampliamento <strong>del</strong>le strutture <strong>del</strong> cenobio 15 : furono<br />
aggiunti due spazi porticati, uno di fronte<br />
all’ingresso ovest <strong>del</strong>la chiesa e l’altro lungo il<br />
lato nord; fu realizzata anche una struttura ipogea<br />
con archi di rinforzo, in cui è riconoscibile<br />
una cisterna, addossata alla fondazione <strong>del</strong>la<br />
- 109 -<br />
parete sud <strong>del</strong>la chiesa. Oltre ad essa sono state<br />
trovate anche tracce di molti pozzi per la captazione<br />
<strong>del</strong>l’acqua, probabilmente connessi ad usi<br />
agricoli.<br />
Uniche testimonianze antropologiche <strong>del</strong>la<br />
piccola comunità monastica sono le semplici<br />
sepolture terragne di età bassomedievale, che<br />
costituivano il nuovo sepolcreto situato lungo il<br />
muro perimetrale sud <strong>del</strong>la chiesa e che in parte<br />
si estendeva anche all’interno, lungo il lato nord<br />
<strong>del</strong>l’area conventuale - di cui peraltro non si<br />
conosce l’estensione - sostituendo definitivamente<br />
la zona sepolcrale precedente.<br />
Il monastero di Sant’Ilario non subì sostanziali<br />
modifiche fino al terremoto <strong>del</strong> 1688, che<br />
distrusse gran parte <strong>del</strong> complesso, portandolo<br />
al definitivo abbandono. La chiesa invece rimase<br />
intatta e si è conservata per i quattro secoli<br />
successivi, con l’aspetto di una piccola casa<br />
colonica 16 . E’ in questo lungo periodo che l’edificio<br />
subì <strong>del</strong>le trasformazioni finalizzate all’adeguamento<br />
a scopo residenziale 17 . Il terremoto<br />
<strong>del</strong> 1930 causò il crollo <strong>del</strong> tetto anteriore (che
Fig. 5 - Chiesa di Sant’Ilario. Planimetria <strong>del</strong>le evidenze architettoniche<br />
dal periodo romano ad oggi (da BURATTO 2003).<br />
Fig. 6 - Cupole <strong>del</strong>la<br />
chiesa di Sant’Ilario (da<br />
MA.ROTILI 1986).<br />
poi è stato ricostruito a capanna) e di parte <strong>del</strong>la<br />
parete occidentale. La struttura rimase tuttavia<br />
invariata fino al terremoto <strong>del</strong> 1980 cui seguirono<br />
gli interventi successivi, finalizzati a riportare<br />
la chiesa al suo aspetto originario.<br />
La chiesa di Sant’Ilario si presenta ad aula rettangolare<br />
monoabsidata, divisa in due campate.<br />
La copertura è formata da due cupole in asse, di<br />
altezza diversa, contenute entro tiburi separati e<br />
con tetto a padiglione. In ciascuna campata<br />
quattro pennacchi sostengono le cupole 18 . Sia<br />
l’arco che separa le campate che quelli laterali<br />
presentano una tessitura listata in tufo grigio e<br />
mattoni (fig. 4). Il paramento murario, in opus<br />
incertum, si avvale di materiale reperito in loco,<br />
conci calcarei di origine fluviale, rotondeggianti,<br />
SALTERNUM<br />
- 110 -<br />
ed elementi di spoglio, entrambi messi in opera<br />
senza alcun tipo di lavorazione<br />
L’utilizzo <strong>del</strong>le cupole spinse molti studiosi a<br />
sostenere che la chiesa fosse un esempio di<br />
architettura bizantina. Studi più approfonditi,<br />
incentrati soprattutto sull’analisi <strong>del</strong> paramento<br />
murario, hanno portato a datare il Sant’Ilario<br />
all’età longobarda 19 . L’impiego <strong>del</strong>la struttura<br />
cupolata si ritrova a Benevento anche in altre<br />
due chiese: S.Sofia e S.Pietro ad Caballum.<br />
In Campania ci sono anche altri edifici con<br />
copertura a cupola inquadrabili nel periodo tardoantico<br />
- altomedievale, come gli illustri esempi<br />
<strong>del</strong> battistero di S.Maria Maggiore a Nocera<br />
Superiore e quello di S. Giovanni in Fonte a<br />
Napoli, databili entrambi al VI sec. d.C. La chiesa<br />
di Sant’Ilario e quella di S.Pietro ad Caballum<br />
si differenziano tuttavia dagli altri esempi campani<br />
perché hanno <strong>del</strong>le caratteristiche strutturali,<br />
come i pennacchi e i tiburi staccati tra loro,<br />
che, associati, conferiscono a questi due edifici<br />
un segno di originalità, rendendole i prototipi<br />
meridionali <strong>del</strong> tipo di chiese con cupole in<br />
asse.<br />
In piena età romanica questa idea<br />
architettonica troverà eco nell’ambiente pugliese,<br />
dove la cupola, entro un involucro piramidale di<br />
pietra, diverrà motivo costante di molti edifici di<br />
culto. Il tempietto di Seppannibale (fig.7) presso<br />
Fasano (BR), è ritenuto una derivazione proprio<br />
<strong>del</strong>la chiesa di Sant’Ilario.<br />
La chiesetta è un edificio di piccole<br />
dimensioni, la cui abside è andata<br />
completamente distrutta. Lo spazio interno è<br />
suddiviso in tre navate; la centrale risulta<br />
qualificata dalla presenza di due cupolette <strong>del</strong>la<br />
stessa altezza, di sezione quasi parabolica,<br />
arricchite nei tamburi, oltre che da monofore, da<br />
quattro nicchie angolari, in parte ancora<br />
affrescate, che permettono il passaggio dalla<br />
pianta quadrata di base a quella circolare <strong>del</strong>le<br />
cupole. Gli studi più recenti la datano tra gli<br />
ultimi decenni <strong>del</strong>l’VIII secolo e i primi <strong>del</strong> IX<br />
secolo 20 . Un elemento a sostegno di questo<br />
confronto è rappresentato dalla viabilità antica<br />
che fu alla base di collegamenti vitali e duraturi<br />
tra il territorio campano e quello pugliese.<br />
Anche la chiesa di Seppannibale infatti, come
l’edificio beneventano, sorge negli immediati<br />
dintorni <strong>del</strong> tracciato medievale <strong>del</strong>la via Traiana<br />
ed è probabilmente proprio attraverso questa via<br />
di comunicazione che le maestranze<br />
longobarde, dal beneventano, importarono il<br />
proprio bagaglio di conoscenze anche in Puglia,<br />
dove per il IX e X secolo possono essere<br />
ricordatati altri due edifici qualificati dalla<br />
presenza di due cupole in asse, confrontabili<br />
con Seppannibale: S.Maria di Gallana e S.Pietro<br />
di Crepacore a Torre S. Susanna, presso Oria<br />
(Brindisi) 21 .<br />
Un’ulteriore caratteristica <strong>del</strong>la chiesa di<br />
Sant’Ilario è l’utilizzo di un particolare sistema di<br />
raccordo tra la pianta quadrata <strong>del</strong>l’edificio e<br />
quella circolare <strong>del</strong>le cupole, che si attua<br />
mediante l’inserimento di pennacchi angolari,<br />
soluzione tipicamente bizantina. Per quanto<br />
riguarda questo elemento è interessante il raffronto<br />
con il Battistero di S. Giovanni in Fonte a<br />
Napoli, <strong>del</strong>la fine <strong>del</strong> VI secolo, in cui si utilizza<br />
il pennacchio a cuffia.<br />
L’interno <strong>del</strong>l’edificio è caratterizzato dalla<br />
presenza di archi a tutto sesto e a sesto ribassato<br />
in tufo e mattoni. L’arco listato in tufo grigio<br />
alternato a mattoni si pone in posizione centrale<br />
nel raccordo dei due quadrati <strong>del</strong>la pianta, in<br />
alcuni archi di scarico <strong>del</strong>le pareti laterali, nei<br />
pennacchi di raccordo con le cupole, nella definizione<br />
<strong>del</strong> vano di ingresso e nelle tre piccole<br />
monofore che si aprono sul tiburio più alto. È<br />
uno dei più antichi esempi, in ambito altomedievale,<br />
di interposizione di elementi in laterizio tra<br />
due conci di tufo a cuneo, che anticipa il largo<br />
ed elegante uso che ne verrà fatto in S.Sofia.<br />
Per quanto riguarda il paramento murario<br />
(fig.8), in Benevento l’utilizzo di pietra calcarea<br />
arrotondata di origine fluviale, aggregata con<br />
malta, caratterizza anche alcuni tratti sia <strong>del</strong>la<br />
cinta <strong>del</strong> VI secolo, sia <strong>del</strong>la civitas nova <strong>del</strong><br />
secondo periodo longobardo (fig.9) e qualifica<br />
prevalentemente le cortine murarie <strong>del</strong>la Torre<br />
Catena. La tecnica costruttiva raffinata di tale<br />
struttura è contraddistinta dall’uso di conci più<br />
tondi e regolari, che garantiscono un risultato<br />
esteriore di grande uniformità e dall’uso di blocchi<br />
angolari di calcare per rafforzare gli spigoli<br />
(elemento che si ritrova anche in Sant’Ilario). La<br />
DANIELA VISCONTI<br />
- 111 -<br />
Fig. 7 -<br />
Tempietto di<br />
Seppannibale<br />
di Fasano<br />
(BR), (da<br />
BERTELLI<br />
1994).<br />
torre era in posizione molto avanzata rispetto al<br />
perimetro <strong>del</strong>le mura <strong>del</strong>l’VIII secolo, cosa che,<br />
insieme all’analisi <strong>del</strong>le tracce superstiti degli<br />
innesti murari, induce a stabilire la contemporaneità<br />
<strong>del</strong>la costruzione con la prima fortificazione<br />
longobarda <strong>del</strong> VI secolo.<br />
Fig. 8 - Chiesa di Sant’Ilario. Fregi riutilizzati nella muratura sud-est<br />
<strong>del</strong>l’edificio.<br />
Quello <strong>del</strong>la datazione è un problema che<br />
ancora non ha trovato una soluzione definitiva.<br />
Vari studiosi si sono pronunciati sulla questione,<br />
proponendo datazioni che si distribuiscono in<br />
un ampio arco temporale, che va dal VI all’XI<br />
secolo, ma la proposta che oggi gode di maggior<br />
favore è che l’edificazione <strong>del</strong>la chiesa sia<br />
da collocare nella metà <strong>del</strong> VII secolo, sulla base<br />
<strong>del</strong>le affinità con l’edificio di Seppannibale.<br />
Marcello Rotili data quest’ultimo all’VIII secolo<br />
in base alle caratteristiche paleografiche <strong>del</strong>l’iscrizione<br />
conservata nell’abside e ad un frammento<br />
di affresco con “l’annuncio di Zaccaria”.
Fig. 9 - Benevento. Cinta muraria <strong>del</strong> VI- VII secolo,Torre “De Simone”.<br />
Se dunque la chiesa pugliese può essere ritenuta<br />
di pochi decenni posteriore alla beneventana<br />
S.Sofia, S.Ilario, che di essa è considerata il prototipo,<br />
può quindi essere datata, se non alla fine<br />
<strong>del</strong> VII, almeno alla prima parte <strong>del</strong>l’VIII secolo 22 .<br />
SALTERNUM<br />
- 112 -<br />
Alcuni studiosi collocano l’edificio beneventano<br />
all’età protoromanica, anche per il fatto che<br />
la più antica notizia di Sant’Ilario si trova in un<br />
documento <strong>del</strong> 1148; la datazione all’XI secolo è<br />
però poco condivisibile, perché le murature di<br />
Sant’Ilario non sono confrontabili con esempi<br />
coevi.<br />
Allo stato attuale, si ritiene dunque verosimile<br />
l’attribuzione <strong>del</strong>l’edificio al periodo tra la fine<br />
<strong>del</strong> VI e l’inizio <strong>del</strong> VII secolo, principalmente<br />
per le caratteristiche architettoniche che – come<br />
si è visto – ricorrono anche in altre chiese databili<br />
all’VIII secolo e di cui l’edificio beneventano<br />
sembra essere il prototipo. In secondo luogo<br />
non va trascurata la dedica <strong>del</strong>la chiesa a S.Ilario<br />
di Poiters che, nato in Francia all’inizio <strong>del</strong> IV<br />
secolo, è ritenuto in Occidente il simbolo <strong>del</strong>la<br />
lotta <strong>del</strong> cattolicesimo contro l’arianesimo. Il<br />
fatto che il suo culto sia attestato soprattutto nel<br />
VI secolo potrebbe coincidere proprio con la<br />
lotta che nello stesso periodo i Romani cristiani<br />
intrapresero contro i Longobardi ariani e la<br />
costruzione di una chiesa dedicata a S. Ilario<br />
potrebbe alludere alla loro conversione 23 .
*Articolo tratto dalla tesi di Laurea in Beni Culturali, La<br />
Chiesa di Sant’Ilario a Benevento: fonti documentarie ed<br />
evidenze architettoniche, Università degli Studi di Salerno,<br />
a.a.2004-2005 (Relatore prof.ssa C.Lambert).<br />
NOTE<br />
1 C. LEPORE, Monasticon Beneventanum, in “Studi<br />
Beneventani”, Benevento, 1995, p. 71.<br />
2 Il documento è edito da STEFANO BORGIA in Memorie istoriche<br />
<strong>del</strong>la pontificia città di Benevento dal secolo VIII al secolo<br />
XVIII, vol. I, parte III, Roma 1769, pp.136 – 138. In esso è<br />
registrata la concessione per ventinove anni di una casa di<br />
proprietà <strong>del</strong>la curia da parte <strong>del</strong> cardinale Pietro, rettore pontificio<br />
<strong>del</strong>la città, a Guidone <strong>del</strong> fu Pietro, procuratore e<br />
visconte <strong>del</strong> monastero di Sant’Ilario situato presso la Porta<br />
Aurea.<br />
3 Il Lepore (C. LEPORE, Monasticon Beneventanum, cit., 71 –<br />
73) fornisce una esauriente documentazione sul periodo che<br />
va dalle prime menzioni fino all’abbandono <strong>del</strong>l’edificio. Al<br />
riguardo egli scrive: “Recensita come chiesa parrocchiale sul<br />
finire <strong>del</strong> secolo XII, nei primi decenni <strong>del</strong> secolo successivo<br />
appare attestata come grangia <strong>del</strong> monastero femminile di<br />
S.Paolo extra muros di Avellino e retta da monaci benedettini<br />
(…). Il 1° gennaio 1443 papa Eugenio IV unì una parte <strong>del</strong>le<br />
sue rendite alla mensa capitolare beneventana. Ciò nonostante<br />
la dipendenza da S.Paolo si perpetuò ancora per più d’un<br />
trentennio e cessò solo nel 1479. Unita definitivamente al<br />
Capitolo metropolitano nel 1504: il visitatore apostolico raccomandò<br />
che fosse risarcita, intonacata e riattata in breve tempo<br />
prescrivendo la demolizione <strong>del</strong> pulpito per il canto <strong>del</strong><br />
Vangelo e anche <strong>del</strong>le pareti che separavano l’altare maggiore<br />
da due piccoli altari laterali. Successivamente continuò ad<br />
essere ufficiata almeno fino al 1690, anno in cui risulta ancora<br />
registrata nell’inventario <strong>del</strong> beni capitolari”.<br />
4 Il foglio 85r <strong>del</strong> catalogo <strong>del</strong> 1713, contenente le piante dei<br />
beni <strong>del</strong> Rev.do Capitolo Metropolitano di Benevento, descrive<br />
la chiesa come “profanata”. In tale documento, conservato<br />
presso la Biblioteca Capitolare di Benevento, si legge: “Borgo<br />
di Port’Aurea possiede il Rev.do Capitolo nel sud.to Borgo la<br />
chiesa profanata di Sant’Ilario” (C. LEPORE, Monasticon<br />
Beneventanum, cit. pp.71 – 73).<br />
5 “(…) A mano sinistra uscendo da port’Aurea vi era anticamente<br />
la Badia di Sant’Ilario la quale nell’anno 1504 da papa<br />
Giulio II fu unita al Capitolo di Benevento”. (A. ANNECHINI,<br />
Breve compendio istorico <strong>del</strong>le principali notizie <strong>del</strong>la città di<br />
Benevento, Ms. LIV Archivio Storico Provinciale di Benevento,<br />
1802, p.49).<br />
6 “Ecclesia S.Petri ad Caballum, sita a lato <strong>del</strong> Trescene verso<br />
tramontana, annessa alla Commenda di S. Sofia, nella contrada<br />
ad Caballo” (M. ROTILI, La chiesa di Sant’Ilario a<br />
Port’Aurea a Benevento, in Atti <strong>del</strong> III Congresso<br />
Internazionale di studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 1956, pp.<br />
525 - 531).<br />
7 D. GIAMPAOLA, Il restauro <strong>del</strong>l’arco di Traiano e il resoconto<br />
<strong>del</strong>l’attività di scavo a Benevento, in Atti <strong>del</strong> XXVII Convegno<br />
sulla Magna Grecia, Taranto – Paestum, 1987, Taranto 1998,<br />
p. 830.<br />
DANIELA VISCONTI<br />
- 113 -<br />
8 Si è supposta una funzione di carattere difensivo per la possente<br />
costruzione, ma gli elementi a disposizione non consentono<br />
di andare oltre l’ipotesi (A. BURATTO, L’anticamera<br />
<strong>del</strong>l’Imperatore, in “La provincia sannita di Benevento”,<br />
Benevento, anno XIII, n°2, 2003, p. 8).<br />
9 Si tratta di deposizioni realizzate in fosse terragne, ad eccezione<br />
di un unico esemplare dotato di cassa in muratura,<br />
realizzata con blocchi irregolari di tufo giallo.<br />
10 Di tali frammenti prese visione il prof. P. Peduto che ne<br />
osservò le affinità con analoghi frammenti trovati nella<br />
Langobardia Maior, e precisamente con quelli <strong>del</strong> Tempietto<br />
di Cividale <strong>del</strong> Friuli e con altri di S. Salvatore di Brescia (P.<br />
PEDUTO, La Campania, in R. FRANCOVICH (a cura di), La storia<br />
<strong>del</strong>l’Alto medioevo italiano (VI-X secolo) alla luce <strong>del</strong>l’archeologia,<br />
Firenze, 1994, p. 293).<br />
11 M. ZAMPINO, Benevento, chiesa di Sant’Ilario, in Terremoto e<br />
restauro: dieci anni di esperienza, Soprintendenza dei<br />
B.A.A.A.S. per le Province di Caserta e Benevento (a cura di),<br />
Caserta 1991, p. 43.<br />
12 P. PENSABENE, A. LUPIA, Il reimpiego nel periodo longobardo<br />
a Benevento, in I longobardi dei ducati di Spoleto e<br />
Benevento - Atti <strong>del</strong> XVI Congresso internazionale di studi<br />
sull’Alto - medioevo, II, Spoleto, 2002, pp. 1555 - 1576.<br />
13 Uno dei due frammenti è di tipo ionico ed è parte di un<br />
fregio di cui si conservano altri elementi nel Museo <strong>del</strong><br />
Sannio. La decorazione è a motivi di animali fantastici entro<br />
due cornici orizzontali e si pensa sia ascrivibile alla fine <strong>del</strong><br />
periodo repubblicano o alla prima età augustea. L’altro<br />
frammento di fregio inserito come pietra d’angolo nella<br />
muratura <strong>del</strong>la facciata est ha un’ornamentazione più raffinata,<br />
con nastro a volute intervallato da fiori e palmette.<br />
14 F. BOVE, Città monastica beneventana in “Studi beneventani”,<br />
n° 6, Benevento, 1995, p. 186.<br />
15 Probabilmente a promuovere tale ingrandimento fu il<br />
convento avellinese di S.Paolo fuori le mura, a cui S.Ilario<br />
apparteneva.<br />
16 A. BURATTO, L’anticamera <strong>del</strong>l’Imperatore, cit., p. 10.<br />
17 L’edificio fu suddiviso in due livelli di abitazione mediante<br />
un solaio ligneo. Un forno fu localizzato nell’abside,<br />
dove fu aperta una porta. Infine le finestre <strong>del</strong>la facciata est<br />
vennero trasformate in porte di accesso al piano superiore,<br />
cui si arrivava a mezzo di due scale a giorno.<br />
18 La cupola più bassa è quella che copre lo spazio d’ingresso,<br />
mentre quella più alta è prossima all’abside e reca una<br />
monofora al centro di ognuno dei tre lati liberi <strong>del</strong> tiburio<br />
su cui è impostata (fig.6).<br />
19 A. VENDITTI, Architettura bizantina nell’Italia meridionale,<br />
Napoli, 1967, pp. 584 – 589.<br />
20 G. BERTELLI, Cultura longobarda nella cultura medievale,<br />
Il tempietto di Seppannibale, Bari, 1994, pp.28 – 32.<br />
21 G. BERTELLI, Cultura longobarda nella cultura medievale,<br />
cit. pp. 47 – 48.<br />
22 MA. ROTILI (Benevento romana e longobarda. L’immagine<br />
urbana, Napoli, 1986 pp. 182 – 183) posticipa quindi di<br />
qualche decennio la cronologia proposta dal padre.<br />
23 E. RAPISARDA, s.v Ilario di Poiters, in Enciclopedia<br />
Cattolica, vol. VI, Città <strong>del</strong> Vaticano, 1951, pp. 1614 – 1615.
BIANCA<br />
CANCELLARE
MARCO AMBROGI<br />
Monachesimo, fondazioni ecclesiastiche e sviluppo<br />
urbano nella Diano medioevale<br />
La cittadina di Teggiano, dall’alto di una<br />
terrazza protesa nel ferace Vallo di<br />
Diano, da secoli vigila il transito lungo<br />
l’antica Via Consolare Annia e controlla i valichi<br />
che alle sue spalle conducono verso il Cilento<br />
ed il mare di Paestum. La posizione di riguardo,<br />
scelta dagli antichi Lucani, ha costituito per<br />
secoli il vanto e la sicurezza di una città che ha<br />
saputo risollevarsi da distruzioni ed assedi, un’espressione<br />
geografica nata per motivi di controllo<br />
sugli attacchi esterni e per difesa dalle acque<br />
stagnanti <strong>del</strong> fondovalle tanagrino. Su quel pianoro<br />
i Romani elessero un fiorente municipium,<br />
dopo aver soggiogato la fierezza dei Lucani e<br />
dalle memorie latine <strong>del</strong>la civitas si sviluppò nel<br />
Medioevo uno dei borghi fortificati più importanti<br />
<strong>del</strong> Principato Citra.<br />
Teggiano, l’antica Diano medioevale, sonnecchiando<br />
nell’alto <strong>del</strong>la sua posizione strategica,<br />
ancora racconta, a chi sale per la via da<br />
Piedimonte o dalla strada a meridione, <strong>del</strong> suo<br />
glorioso passato, pregno di accadimenti storici,<br />
civili e militari, ma soprattutto di un mosaico<br />
ampio di storia religiosa, che ne ha decretato<br />
una sorta di “monte sacro”, in cui ancora permangono<br />
nella loro originalità chiese, monasteri,<br />
ruderi e cappelle, alcuni integri nel loro primitivo<br />
aspetto, altri menzionati solo nei documenti<br />
pergamenacei. La ricchezza artistica e<br />
monumentale <strong>del</strong>la Dianum medioevale affonda<br />
le sue radici storiche nell’alto Medioevo, in<br />
quel periodo in cui sulle vestigia <strong>del</strong> municipium<br />
di Tegianum si ricostituì l’assetto urbano<br />
di una nuova città, con l’insediamento dei<br />
monasteri italo-greci e di quelli benedettini sull’area<br />
interna alle mura, ma in posizione periferica.<br />
In quell’anello urbano si svilupperanno, nel<br />
- 115 -<br />
Fig. 1 - Teggiano dall’alto. Si noti l’ortogonalità degli assi cardo-decumanus.<br />
basso Medioevo, le strutture dei conventi mendicanti<br />
e degli ospedali, che oggi caratterizzano<br />
in modo originale l’impronta urbana <strong>del</strong> centro.<br />
Tegianum, il fiorente municipium, che<br />
Nerone considerava una <strong>del</strong>le colonie più rilevanti<br />
<strong>del</strong> primo Impero 1 , oggi si riconosce per lo<br />
più in pianta, dalla presenza <strong>del</strong>l’asse cardodecumanus,<br />
che equipartisce l’assetto urbano<br />
<strong>del</strong> pianoro in quattro quadranti, ognuno dei<br />
quali contrassegnato dalle sue chiese e dai suoi<br />
conventi. La parte più identificabile attualmente<br />
<strong>del</strong>l’impianto ortogonale <strong>del</strong>l’urbanistica romana<br />
di Teggiano è la piazza principale, su cui prospettano<br />
la cattedrale, il seggio ed il convento di<br />
San Francesco (attuale municipio), che nel suo<br />
proseguimento verso Sud, nella via che appellasi<br />
“discesa di Sant’Andrea”, allinea l’antico asse
Fig. 2 - Emergenze architettoniche di Teggiano romana: 1. Portello. 2.<br />
Foro.3.Barbacane o “posteruola”. 4. Porta <strong>del</strong>l’Annunziata. 5.Tempio. 6.<br />
Porta <strong>del</strong>le Pietà.<br />
<strong>del</strong> decumanus. A Nord, il “Portello” segna uno<br />
degli ingressi minori <strong>del</strong>la cittadina, in età romana<br />
e poi nel Medioevo, degradante su uno sperone<br />
roccioso molto ripido; dall’altro lato l’antica<br />
porta “<strong>del</strong>l’Annunziata”, costruita con grossi<br />
blocchi di calcare locale, riporta per analogia<br />
tipologica alle costruzioni di impianto lucano,<br />
pseudomegalitico, rendendo evidente che l’asse<br />
<strong>del</strong> cardo si formalizzò su un’urbanistica di più<br />
antica data. La via ortogonale alla piazza e all’asse<br />
appena descritto lo attraversa nel punto in cui<br />
si erge il seggio quattrocentesco e si <strong>del</strong>inea per<br />
la “salita Corpo di Cristo”, che conduce allo slargo<br />
<strong>del</strong> seminario, da un lato, e per la via “San<br />
Giorgio”, dall’altro, segnate agli estremi da punti<br />
in cui la memoria storica colloca altre due porte<br />
urbiche nella cinta muraria e di cui attualmente<br />
si riconosce solo il “Barbacane”, sul lato occidentale;<br />
la parte bassa <strong>del</strong>la torre di guardia di<br />
questa entrata minore è impostata su una base<br />
con grossi blocchi quadrangolari, in modo simile<br />
alla porta <strong>del</strong>l’Annunziata. Una porta collocabile<br />
cronologicamente all’epoca romana era sita<br />
nell’area <strong>del</strong>l’attuale convento <strong>del</strong>la Pietà 2 , mentre<br />
il centro latino individuava la presenza di<br />
edifici di importanza pubblica, tra cui è possibile<br />
ipotizzare un foro (sul posto <strong>del</strong>l’attuale via<br />
SALTERNUM<br />
- 116 -<br />
Roma ed in cui era collocata la mensa ponderaria,<br />
ora al Museo Diocesano), dei templi (si riconosce<br />
lo stilobate di uno di essi al di sotto <strong>del</strong><br />
portico <strong>del</strong>l’ex chiesa di San Pietro), una palestra<br />
e un teatro o odéon (da cui proverrebbe il telamone<br />
(?) nel Museo Diocesano di San Pietro, la<br />
cui iconografia, con le braccia dietro al collo, lo<br />
paragona ad altro simile <strong>del</strong> teatro di Pompei).<br />
Delle vestigia romane Teggiano conserva oggi<br />
numerose iscrizioni e le cosiddette imagines<br />
maiorum, alcune murate nella parete esterna<br />
<strong>del</strong> coro <strong>del</strong>la cattedrale ed altre presenti al<br />
Museo Diocesano. Alcuni storici hanno ipotizzato<br />
che la città romana ebbe un momento di gloria<br />
in età imperiale, considerato che in essa furono<br />
innalzati i monumenti a Galerio, Flavio<br />
Severo e Costantino, per opera dei decurioni e<br />
costituiti da basi con iscrizioni sormontate da<br />
statue 3 . Il pianoro <strong>del</strong>la civitas era racchiuso da<br />
una possente cinta muraria, ancora visibile nel<br />
‘600 e descritta dal cronista Luca Man<strong>del</strong>li, sulla<br />
quale si era <strong>del</strong>ineata con sovrapposizione la<br />
linea difensiva medioevale 4 .<br />
Dalla città retratta ai primi insediamenti<br />
monastici e agli ospedali di mendicità<br />
In età tardo antica ed alto medioevale, la città<br />
romana di Tegianum si contrasse al pari degli<br />
agglomerati antichi, come documentato altrove,<br />
finendo per ricompattarsi all’interno <strong>del</strong>le stesse<br />
mura: il fenomeno di restringimento urbano va<br />
sotto il nome di “città retratta” e riguarda le aree<br />
periferiche a ridosso dei circuiti murari, che vengono<br />
abbandonate per permettere alla scarsa<br />
popolazione <strong>del</strong>le città di origine romana di<br />
concentrarsi meglio al centro <strong>del</strong> nucleo antico.<br />
Ciò determina un’alta percentuale di suoli liberi,<br />
giardini e ruderi, sui quali verrà incentrato lo sviluppo<br />
successivo <strong>del</strong>la città, riguardante in<br />
modo particolare l’edilizia monastica e conventuale.<br />
Il monachesimo italo-greco preferì luoghi<br />
isolati e impervi, intorno ai quali poi sorsero<br />
agglomerati di piccoli borghi (come è documentato<br />
per il vicino paese di Sant’Arsenio), ma non<br />
disdegnò affatto gli antichi centri di tradizione<br />
latina (a Diano è documentata una via denominata<br />
dei Greci).
In effetti l’abbazia di Grottaferrata possedeva<br />
alcune grancie in vari paesi <strong>del</strong>la Lucania, tra cui<br />
Diano 5 , per cui è possibile ipotizzare la presenza<br />
di cenobi o piccoli monasteri anche nel centro<br />
dianense, nel quale il toponimo di Santa<br />
Venera, attuale succorpo <strong>del</strong>la chiesa di<br />
Sant’Angelo, è di chiara ascendenza greca. I<br />
Benedettini, con l’avvento <strong>del</strong>l’età normanna e<br />
la predominanza territoriale dei monaci di<br />
Venosa e di Cava dei Tirreni, non fecero altro<br />
che sostituire i religiosi di rito italo-greco o<br />
affiancarvisi. Nella cittadina dianense il<br />
Macchiaroli colloca qualche fondazione benedettina<br />
tacendo su altre di derivazione greca;<br />
infatti, secondo il cronista ottocentesco, alla<br />
china orientale <strong>del</strong> borgo, esistevano ai suoi<br />
tempi <strong>del</strong>le vestigia di mura nella contrada di<br />
San Nicola 6 , ultimo ricordo <strong>del</strong> monastero benedettino<br />
omonimo 7 , mentre il ramo femminile<br />
<strong>del</strong>l’ordine <strong>del</strong> patriarca umbro aveva una sua<br />
sede nell’area <strong>del</strong>l’attuale chiesa <strong>del</strong>la SS. Pietà.<br />
Il San Nicola riportato da Macchiaroli potrebbe<br />
identificarsi con la dipendenza cavense di<br />
Scaulano (entrata nell’orbita <strong>del</strong>la SS. Trinità tra<br />
il 1116 ed il 1136) 8 , mentre sulla fondazione religiosa<br />
<strong>del</strong>la Pietà non abbiamo dati documentari<br />
che vanno oltre il 1311 9 . Il cenobio <strong>del</strong>le<br />
Benedettine occupò già nel corso <strong>del</strong> Duecento,<br />
con molta probabilità, un’area perimetrale <strong>del</strong>l’abitato,<br />
ma entro le mura romane, proprio in aderenza<br />
alla porta di ingresso alla città dal lato<br />
orientale. Infatti, in un documento <strong>del</strong> 1420 10 ,<br />
quando le monache erano ancora presenti nel<br />
monastero, si specifica, per un atto di un’abitazione,<br />
che questa si trova “in convicinio porte<br />
seu posterule Monialium”. Se osserviamo attentamente<br />
l’attuale planimetria <strong>del</strong>la chiesa <strong>del</strong>la<br />
SS. Pietà, <strong>del</strong>l’ordine degli Osservanti, che ricalcò<br />
in parte (la navata minore) l’assetto <strong>del</strong>la<br />
chiesa <strong>del</strong>le Benedettine, appare evidente che la<br />
prima cappella di sinistra, dalla pianta poligonale,<br />
altro non è che una <strong>del</strong>le due torri <strong>del</strong>l’antica<br />
porta, su cui si innestavano le mura e su cui<br />
le monache avevano edificato parte <strong>del</strong>l’edificio<br />
religioso <strong>del</strong> loro monastero.<br />
Esisteva in età medioevale a Diano un monastero<br />
intitolato a San Vito 11 , che non sappiamo a<br />
quale ordine appartenesse, ma che risulta già<br />
MARCO AMBROGI<br />
- 117 -<br />
Fig. 3 - La porta <strong>del</strong>l’Annunziata in opera poligonale.<br />
Fig. 4 - Configurazione religiosa di Diano altomedievale: monasteri ed<br />
ospedali: 1. S. Giovanni de Hospitali (Gerosolimitani?). 2. Ospedale di S.<br />
Caterina. 3. Ospedale di S. Spirito. 4. Monastero <strong>del</strong>la SS.Annunziata<br />
(Celestini). 5. Ospedale di S. Nicola de Carranis (per le donne). 6.<br />
Monastero di S. Nicola (Scaulano, Benedettini). 7. Monastero di S.Vito<br />
(incerta localizzazione). 8. Ospedale di S.Antonio de Vienne (Antoniani).<br />
9. Monastero di S. Benedetto (femminile).<br />
vitale nel 1373. Il problema per il riconoscimento<br />
di questa fondazione è dato anche dalla presenza<br />
di più chiese dedicate al Santo, con appellativi<br />
diversi (tra essi figura spesso “alla<br />
Bucana”), di cui una di certo esistente al di fuori<br />
<strong>del</strong> perimetro murario <strong>del</strong>la città medioevale.<br />
Nel punto in cui la porta meridionale <strong>del</strong>la<br />
città 12 si apriva verso le prime lievi balze <strong>del</strong> pianoro<br />
su cui sorge Teggiano, ma entro il circuito<br />
difensivo di età romana, sorse nel secolo XIV o<br />
poco prima il monastero <strong>del</strong>la SS. Annunziata<br />
dei frati Celestini. Denominati così dal nome <strong>del</strong><br />
fondatore, fra Pietro da Morrone (1209-1296),
Fig. 5 - Ex Chiesa di Santo Spirito degli Ospitalieri.<br />
Fig. 6 - Frate Ospitaliere nell’affresco <strong>del</strong>la Cappella Franconi in San<br />
Pietro.<br />
eletto papa nel 1294, costituirono una riforma<br />
sotto la regola di San Benedetto, nata nel 1264,<br />
con forti connotazioni di eremitismo, povertà,<br />
austerità e centralizzazione. Ebbero discreto sviluppo<br />
in Italia, specialmente nel Meridione,<br />
favoriti dai regnanti Angioini 13 . Del ricordo che<br />
questi frati lasciarono nell’immaginario di<br />
Teggiano e dei suoi abitanti, ci è pervenuta<br />
soprattutto la foggia ed il colore <strong>del</strong>l’abito di San<br />
Cono, cittadino e patrono di Teggiano e diocesi,<br />
che pur facente parte <strong>del</strong>la congregazione benedettina<br />
cassinese (monastero di Cadossa a<br />
Montesano), è stato rappresentato nell’età<br />
moderna con l’abito dei Celestini. Paradosso evi-<br />
SALTERNUM<br />
- 118 -<br />
dente è che l’unica immagine più antica <strong>del</strong><br />
santo dianense, in abiti da benedettino, si trova<br />
proprio nella chiesa <strong>del</strong>l’Annunziata, nella parte<br />
chiusa <strong>del</strong>la navata destra. Il primo documento<br />
che possediamo sulla presenza dei monaci, che<br />
accolsero tra le loro fila anche un ramo <strong>del</strong>l’ordine<br />
francescano, i poveri eremiti di papa<br />
Celestino, aggregati nel 1294 all’ordine contemplativo<br />
ma dimoranti in romitaggi propri e indipendenti<br />
dalla giurisdizione <strong>del</strong>l’ordine 14 , è <strong>del</strong>l’anno<br />
1342 (7 dicembre), quando Marino di<br />
Ippolito, nobile di Diano, sceglie come luogo<br />
per la sua sepoltura Santa Maria Annunziata (il<br />
1504, data impressa sul portale di ingresso segna<br />
la seconda ricostruzione <strong>del</strong> sacro edificio), il<br />
cui cenobio era retto dall’abate Francesco de<br />
Galliciano 15 . Possediamo note circa la filiazione<br />
<strong>del</strong> monastero, dalla casa madre di Santo Spirito<br />
di Sulmona da un documento <strong>del</strong> 25 maggio<br />
1408 in cui si specifica la dipendenza <strong>del</strong>la casa<br />
di Diano dal monastero principale abruzzese,<br />
retto allora da frate Nicola di San Giuliano, abate<br />
<strong>del</strong>l’ordine dei Celestini 16 . Il monastero di Diano<br />
possedeva molti beni e proprietà, oltre ad alcuni<br />
edifici sacri, tra i quali figura una chiesa di<br />
Sant’Eustachio, che nel 1584 risulta cadente e in<br />
attesa di ricostruzione; la cappella, definita da<br />
tempo appartenente alla congregazione<br />
<strong>del</strong>l’Annunziata 17 , potrebbe anche identificarsi<br />
con l’antica parrocchia che in età medioevale<br />
curava spiritualmente una parte <strong>del</strong> territorio cittadino<br />
di Diano.<br />
Nel processo di insediamento degli ordini<br />
monastici italo-greci e benedettini, anche se in<br />
una fase tarda, sorsero i primi ricoveri di ospitalità<br />
urbana, dapprima, forse, in modo spontaneo,<br />
poi riassorbiti all’interno di congregazioni<br />
religiose votate all’accoglienza e al sostegno di<br />
poveri e mendicanti ammalati. Dalle fonti storiche<br />
18 apprendiamo che a Diano esistevano gli<br />
ospedali di San Nicola per le donne 19 , posto<br />
nelle vicinanze <strong>del</strong>la chiesa di Sant’Angelo (con<br />
fabbriche crollanti al tempo <strong>del</strong> Macchiaroli), di<br />
Santo Spirito (ancora esistente), di Santa<br />
Caterina alla “Postierla” o “Barbacane” (il<br />
Macchiaroli poteva ancora vederne le fabbriche<br />
<strong>del</strong> ricovero e <strong>del</strong>la piccola chiesa) e di<br />
Sant’Antonio di Vienne, alla china esterna con
ducente alla porta <strong>del</strong>la Pietà, extra muros. Gli<br />
ospedali di Sant’Antonio, di Santa Caterina<br />
(entrambi diruti) e di Santo Spirito, sono ricordati<br />
anche dal Man<strong>del</strong>li 20 . Per ciò che concerne il<br />
ricovero degli Ospitalieri di Santo Spirito (una<br />
casa era presente anche nella vicina Sala<br />
Consilina (SA) nel XVI sec.), la prima data che<br />
compare a conferma <strong>del</strong>la presenza in Diano<br />
<strong>del</strong>l’ordine è <strong>del</strong> 1309 (o 1310) 21 , esattamente il<br />
20 gennaio, quando fra Tommaso, precettore<br />
<strong>del</strong>l’ospedale, <strong>del</strong>la casa e <strong>del</strong>la chiesa di Santo<br />
Spirito, cede a Tommaso de Maliano un terreno<br />
lavorativo in cambio di un altro in Sassano. Il<br />
riferimento alla prima data sul cenobio dianense<br />
è messo in dubbio da un’affermazione di<br />
Vitolo, che considera esistente l’ospedale già nel<br />
XII secolo 22 . Gli Ospitalieri o Fratelli <strong>del</strong>la<br />
Colomba, ordine cittadino, furono fondati nel<br />
1175 da Guy di Montpellier nella sua città natale<br />
e la regola fu approvata nel 1198 da papa<br />
Innocenzo III, che affidò a loro in Roma l’ospedale<br />
di Santa Maria divenuto poi Santo Spirito<br />
(l’ordine fu sciolto nel 1847 da Pio IX). Le dipendenze<br />
erano state fondate con il motivo di assistere<br />
i poveri, gli infermi e i trovatelli. Sull’abito<br />
<strong>del</strong>l’ordine è bene soffermarsi, perché figura<br />
anche a Teggiano nell’affresco <strong>del</strong>la cappella<br />
Francone in San Pietro, giusto al di sopra <strong>del</strong><br />
corpo scolpito <strong>del</strong> soldato Bartolomeo (periodo<br />
di esecuzione: XIV sec.), dove una teoria di personaggi,<br />
tra cui una monaca benedettina ed un<br />
cavaliere di Malta 23 , fanno da ala all’immagine<br />
centrale <strong>del</strong> Cristo. Ebbene, l’ultima figura sul<br />
lato destro porta un abito bruno con una particolare<br />
croce bianca, che pare identificarsi proprio<br />
con la foggia <strong>del</strong>l’abito degli Ospitalieri 24 ,<br />
presenti nella città di Diano nel XIV secolo (già<br />
documentati). La regola <strong>del</strong>l’Ordine imponeva<br />
che tutti i religiosi dovessero portare il segno<br />
<strong>del</strong>la croce tanto sull’abito (sul petto), quanto<br />
sul mantello (a lato sinistro); nell’uno e nell’altro<br />
caso, esso doveva essere posto all’altezza <strong>del</strong><br />
cuore. Sia l’abito sia il mantello erano neri 25 . Le<br />
note <strong>del</strong>la presenza dei frati in Diano continuano<br />
per tutto il XV secolo 26 , segnando un’attività<br />
stabile e determinante per la comunità cittadina<br />
e per gli ospiti ed i forestieri che vi giungevano.<br />
Per questo già nel XVI secolo il centro di rico-<br />
MARCO AMBROGI<br />
- 119 -<br />
Fig. 7 - Parrocchie di Diano in età medievale e moderna: 1. Plebana di S.<br />
Maria Assunta. 2. S. Matteo al Barbacane. 3. S. Eustacchio. 4. S. Barbara. 5.<br />
S.Agostino Abate. Parrocchie recenti: A. S.Andrea. B. S.Angelo. C. S.<br />
Pietro. D. S. Martino.<br />
Fig. 8 - Pianta <strong>del</strong>la Cattedrale di S. Maria: l’edificio medievale era<br />
simmetricamente invertito.<br />
vero conventuale è oggetto di un’ampia ristrutturazione<br />
dei suoi ambienti, considerando la<br />
presenza di uno stemma, sul prospetto sudorientale<br />
<strong>del</strong>l’edificio, che riporta la data <strong>del</strong><br />
1585. Il ricovero di Sant’Antonio de Vienne (la
Fig. 10 - La Chiesa di San Pietro nella sua prima fase costruttiva.<br />
Fig. 9 - La Chiesa di San Pietro nella fase costrutiva finale.<br />
cui protezione era invocata contro il morbo <strong>del</strong>l’herpes<br />
zoster), da non confondere con la parrocchia<br />
e con la chiesa attuale di Sant’Antuono,<br />
figura per la prima volta nel 1369 27 , ma già nel<br />
1482 il precettore <strong>del</strong>l’Ospedale di Sant’Antonio<br />
de Vienne di Napoli, conferisce al presbitero<br />
Nicola de Monsa la facoltà di reggere l’ospedale<br />
dianense, extra moenia 28 . L’ordine, il cui nome<br />
effettivo era: “canonici regolari di Sant’Agostino<br />
di Sant’Antonio”, prese il nome <strong>del</strong> grande abate<br />
omonimo, le cui reliquie giunsero in Occidente<br />
SALTERNUM<br />
- 120 -<br />
presso Vienne. L’Ordine fu eretto come canonicato<br />
regolare con bolla di Bonifacio VIII <strong>del</strong><br />
1297 e terminò il suo compito verso la fine <strong>del</strong><br />
XVIII secolo, allorché fu unito all’Ordine di<br />
Malta. La protezione dal cosiddetto “fuoco di<br />
Sant’Antonio” (ergotismo), dovuto all’ingestione<br />
<strong>del</strong> fungo <strong>del</strong>la segala cornuta, costituì il motivo<br />
per erigere una confraternita nell’XI secolo che<br />
divenne successivamente Ordine regolare. I<br />
canonici vestivano nel XIV secolo con una tunica<br />
ampia completa di burello nero con cappuccio.<br />
Una cintura di cuoio o un cordone per la<br />
vita ed un semplice mantello, oltre agli zoccoli<br />
robusti e pesanti, completavano la foggia <strong>del</strong>l’abito<br />
29 . E la reggenza dei presbiteri di<br />
Sant’Antuono, nei confronti <strong>del</strong>l’ospedale di<br />
Sant’Antonio de Vienne, continuò almeno fino<br />
alla prima metà <strong>del</strong> XVI secolo, se è vero che nel<br />
1536 Giovanni De Velasco, commissario generale<br />
e procuratore <strong>del</strong>l’Ordine di Sant’Antonio de<br />
Vienne per le province di Principato Citra e<br />
Ultra, conferì al sacerdote Federico Marresio,<br />
arciprete <strong>del</strong>la terra di Diano, il beneficio <strong>del</strong>la<br />
cappella di Sant’Antonio de Carbonibus in<br />
Diano, con l’obbligo di censo alla precettoria<br />
generale <strong>del</strong>l’ordine, dimorante nel monastero<br />
di Sant’Antonio extra muros di Napoli 30 . Allo<br />
stato attuale, pur avendo distinto i due edifici<br />
sacri, entrambi intitolati a Sant’Antonio Abate, l’identificazione<br />
certa tra i documenti afferenti<br />
all’uno o all’altro non è ben chiara e <strong>del</strong>ineata.<br />
Anche la presenza di un istituto religioso denominato<br />
San Giovanni de hospitali, che compare<br />
in un documento <strong>del</strong> 1397 31 , lascia supporre l’esistenza<br />
di un altro monastero (i<br />
Gerosolimitani?) o meglio ancora di un ulteriore<br />
ricovero per gli ammalati.<br />
La plebana di Santa Maria e le parrocchie<br />
antiche<br />
Nella piazza centrale <strong>del</strong>la cittadina si erge<br />
imponente la cattedrale di Santa Maria, punto di<br />
contatto tra l’espressione dignitaria ecclesiastica<br />
<strong>del</strong>le parrocchie antiche di Diano ed il titolo di<br />
ecclesia cattedralis, centro <strong>del</strong>la diocesi di<br />
Teggiano-Policastro. L’edificio risulta nelle cronache<br />
storiche, già nel 967 32 e nel 1132 (mese di<br />
dicembre) come chiesa plebana 33 e con molta
probabilità l’istituzione rientrava nella particolare<br />
cura spirituale dei vescovi caputaquensi, che<br />
non mancavano di celebrarvi frequentemente.<br />
Infatti, è documentato negli anni ’40 <strong>del</strong> XII<br />
secolo il presule Giovanni, che, dimorando a<br />
Diano lungamente, vi morì (1146) e venne<br />
sepolto proprio in Santa Maria, nella cona maggiore<br />
34 . Nel luglio <strong>del</strong>l’anno 1261, la chiesa era<br />
diruta nelle strutture <strong>del</strong>la navata maggiore ed in<br />
quelle laterali, per cui vennero raccolti alcuni<br />
proventi di vendite e offerte al fine di ricostruire<br />
il sacro edificio 35 . Con la scelta, caduta su<br />
Diano e Padula, da parte dei Sanseverino di<br />
Marsico, quali sedi predilette dei propri domini,<br />
l’antico edificio <strong>del</strong>la pieve dianense venne<br />
ingrandito ed abbellito con un programma edilizio<br />
e architettonico degno di nota, che denota la<br />
presenza di un artifex o magister dalle notevoli<br />
conoscenze nel campo <strong>del</strong>l’architettura. Quel<br />
progettista potrebbe essere Melchiorre da<br />
Montalbano, allievo <strong>del</strong> ben più celebre<br />
Bartolomeo da Foggia, autore <strong>del</strong>la cattedrale di<br />
Rapolla e qui a Teggiano <strong>del</strong> portale e <strong>del</strong> pulpito,<br />
datato 1271, presenti nella cattedrale di<br />
Santa Maria. La scultura dei due pezzi più antichi<br />
<strong>del</strong>la chiesa potrebbe essere il suggello o la<br />
firma alla conclusione dei lavori di restauro,<br />
voluti nella seconda metà <strong>del</strong> XIII secolo dalla<br />
nobile casata dei Sanseverino, su concessione<br />
dei regnanti angioini, grati ai nobili marsicensi<br />
per aver dato un degno contributo nella battaglia<br />
di Scurcola Marsicana, decisiva per le sorti<br />
positive degli Angiò, contro gli Svevi. Ma il programma<br />
di ricostruzione, da quanto evidenziato,<br />
si rese necessario anche per le cattive condizioni<br />
in cui versava l’edificio. La chiesa fu consacrata<br />
il 12 agosto <strong>del</strong> 1274 da tre vescovi: monsignor<br />
Gualtieri, <strong>del</strong>l’Ordine dei Predicatori, presule<br />
di Potenza, monsignor Luca dei frati Minori,<br />
reggente la diocesi di Acerno, e da monsignor<br />
Palermo di Muro Lucano 36 . È significativo riportare<br />
per tratti la descrizione <strong>del</strong>la consacrazione<br />
<strong>del</strong>la chiesa di Santa Maria, al fine di evidenziarne<br />
l’importanza religiosa e spirituale nella società<br />
<strong>del</strong> tempo: l’altare maggiore fu benedetto dal<br />
vescovo Gualtieri con le reliquie <strong>del</strong> legno <strong>del</strong>la<br />
Croce, di Santo Stefano, di San Matteo, <strong>del</strong> Santo<br />
Sepolcro e di altri corpi santi. L’altare <strong>del</strong>la parte<br />
MARCO AMBROGI<br />
- 121 -<br />
destra fu dedicato dal vescovo di Muro Lucano<br />
a San Giacomo Apostolo, con il posizionamento<br />
<strong>del</strong>le reliquie <strong>del</strong>la “Mensa Domini” e di Santa<br />
Maria <strong>del</strong> Monte Calvario; l’altare di fronte, invece,<br />
fu dedicato dal vescovo di Acerno a San<br />
Nicola vescovo, con la deposizione <strong>del</strong>le reliquie<br />
<strong>del</strong> Beato Gennaro, di San Barbato, <strong>del</strong><br />
Beato Cono e <strong>del</strong>la Manna di San Nicola. Infine<br />
l’altare sotto il lettorino fu dedicato dal vescovo<br />
di Acerno alla “Vergine Dei Genitrix”, con la collocazione<br />
<strong>del</strong>le reliquie <strong>del</strong> beato Vincenzo martire,<br />
<strong>del</strong>la Manna <strong>del</strong>la Vergine, <strong>del</strong> dito di<br />
Sant’Anna e dei capelli di Santa Maria<br />
Maddalena. L’anno successivo, Pietro, vescovo<br />
di Capaccio, concesse 40 giorni di indulgenza<br />
per la festività <strong>del</strong>la Vergine Maria e l’anno 1276,<br />
Filippo, arcivescovo di Palermo, concesse nella<br />
festa <strong>del</strong>l’Assunta altri 40 giorni di indulgenza 37 .<br />
L’importanza <strong>del</strong>la chiesa di Santa Maria, quale<br />
centro religioso di una <strong>del</strong>le città fortificate più<br />
eminenti <strong>del</strong> territorio, risulta anche dalla presenza<br />
di una campana, ricordata ai tempi <strong>del</strong><br />
Macchiaroli 38 come la seconda più grande <strong>del</strong><br />
Principato Citra, dopo quella di San Matteo a<br />
Salerno; la chiesa dianense era retta poi da un<br />
abate, figura di spicco, che venne eletta successivamente<br />
anche per le altre parrocchiali di<br />
Diano. Un’interessante descrizione <strong>del</strong>la chiesa,<br />
prima che i restauri ottocenteschi ne sconvolgessero<br />
la planimetria e l’alzato, ci viene<br />
dall’Apprezzo <strong>del</strong> feudo <strong>del</strong>lo Stato di Diano di<br />
fine Seicento 39 :<br />
“Poco distante dal Castello vi è la chiesa<br />
Madre sotto il titolo di S. Maria <strong>del</strong>l’Assunta. In<br />
essa s’entra per porta lavorata attorno di pietra<br />
di taglio; consistente in tre navi di mediocre<br />
grandezza; la nave maggiore coverta a tetti con<br />
suo soffitto di tavole pintate, le navi piccole<br />
coverte a lamia con tetti sopra, in testa vi è la<br />
crociera medesimamente coverta a tetti con soffitto<br />
di tavole pintate, dove vi è il coro con suoi<br />
sedili di noce, avanti <strong>del</strong> quale mediante tre<br />
arcate di fabrica sostenute nel mezzo con due<br />
colonne di pietra viva <strong>del</strong> paese, in mezzo <strong>del</strong>le<br />
quali sta situato l’altare maggiore con cona<br />
grande di legname indorato anticha con statua<br />
<strong>del</strong>la Madonna Santissima nel mezzo, con due<br />
altre statue a’ fianchi, suoi quadri sopra rappre-
sentanti diversi Santi, vi è la sua custodia, et<br />
ornamenti.<br />
Al lato destro, e sinistro di detto altare maggiore<br />
vi sono due cappelle, una sotto il titolo <strong>del</strong>la<br />
Circoncisione con sua cona, e quadro grande, e<br />
l’altra <strong>del</strong>la Madonna Santissima <strong>del</strong> Rosario<br />
con quadro, a lato <strong>del</strong> quale altare in un stipo<br />
grande pintato conservano la statua di Nostra<br />
Signora <strong>del</strong> Rosario, quale portano in processione<br />
una volta l’anno nel giorno <strong>del</strong>la sua festa.<br />
Nelle due navi piccole vi sono cinque cappelle<br />
sotto il titolo di diversi Santi, due <strong>del</strong>le quali<br />
stanno sguarnite, e l’altre con li loro poveri<br />
ornamenti. Vi sono ancora due altre cappelle,<br />
seu altari, una sotto il pulpito, e l’altra sotto il lettorino<br />
formato di pietra viva all’antica. Vi sono<br />
similmente due organi dentro la detta crociera,<br />
a lato <strong>del</strong> detto coro, fonte battesimale, e confessionarij”.<br />
L’urbanizzazione <strong>del</strong>l’anello murario di Diano<br />
fu costituita non solo dagli insediamenti monastici<br />
e di ospitalità, ma anche da una serie non<br />
indifferente di parrocchie e di chiese, che hanno<br />
donato alla cittadina di Teggiano l’appellativo di<br />
“città dalle cinquanta chiese”, così come ricordano<br />
ancora molti anziani. L’alta presenza di luoghi<br />
sacri si può spiegare solo con il fenomeno<br />
<strong>del</strong>le aspettative ultraterrene dei fe<strong>del</strong>i ed il<br />
cosiddetto “timor di Dio”, che contribuirono a<br />
far sì che in molti testamenti (allo scopo <strong>del</strong>la<br />
salvezza <strong>del</strong>l’anima) i donanti lasciassero parte<br />
<strong>del</strong>l’eredità alle chiese, ai conventi ed agli ospedali.<br />
Il formulario unificato con cui sono stati<br />
redatti molti dei testamenti 40 <strong>del</strong>la Diano<br />
medioevale evidenzia le precise disposizioni per<br />
i riti funebri <strong>del</strong> donante e per le celebrazioni di<br />
messe, a cui seguono i lasciti alle chiese, ai conventi,<br />
alle confraternite e ai poveri. Trattasi di<br />
una condizione diffusa nella società medioevale<br />
e non solo, che riserva a ricchi e meno abbienti<br />
le stesse prerogative di poter beneficiare di<br />
preghiere ed invocazioni per l’anima <strong>del</strong> defunto.<br />
Allo stesso tempo dispensa ai luoghi beneficiari<br />
una serie considerevole di denaro, terreni o<br />
semplici oggetti, in grado di assommare i patrimoni<br />
sacri in un crescendo di fioritura economica<br />
e di benefici. Il ruolo strategico di posizionamento<br />
degli insediamenti monastici all’interno<br />
SALTERNUM<br />
- 122 -<br />
<strong>del</strong> circuito murario valse anche per le parrocchie.<br />
Infatti, oltre alla plebana di Santa Maria, le<br />
chiese con funzione di amministrazione parrocchiale<br />
più antiche ed operanti tra il IX ed il XIII<br />
secolo furono San Matteo, Sant’Eustachio, Santa<br />
Barbara e Sant’Antonio Abate 41 , <strong>del</strong>le quali se ne<br />
riescono attualmente a localizzare ben tre. San<br />
Matteo era posizionata nelle vicinanze <strong>del</strong><br />
“Barbacano”, di cui riportava l’appellativo e conservava,<br />
murata in una parete esterna, una lapide<br />
con iscrizione di età romana; la sua collocazione<br />
nel settore occidentale <strong>del</strong> nucleo antico<br />
la metteva in rapporti di vicinanza con la plebana,<br />
nella quale probabilmente confluirono i beni<br />
e le rendite di San Matteo al momento <strong>del</strong>la soppressione<br />
<strong>del</strong> beneficio parrocchiale. Ancora<br />
oggi una via che corre parallelamente al circuito<br />
murario nel settore <strong>del</strong>la “posteruola” (al<br />
Barbacane), si appella con il nome <strong>del</strong>l’apostolo<br />
ed evangelista. Sant’Eustachio invece non risulta<br />
al momento ben identificabile 42 , anche se un’equa<br />
partizione di influenze ecclesiastiche <strong>del</strong><br />
centro di Teggiano la porterebbe a collocarsi<br />
nelle vicinanze <strong>del</strong>la chiesa <strong>del</strong>l’Annunziata, ma<br />
nel settore occidentale (vedasi riferimento più<br />
avanti). Santa Barbara è riconoscibile nella piccola<br />
aula di culto situata alle spalle <strong>del</strong>la piazza<br />
dei Mori, alla giusta distanza tra la chiesa di<br />
Sant’Antuono e l’altra di San Martino. Infine<br />
Sant’Antonio Abate, volgarmente appellata<br />
Sant’Antuono, si trova alle spalle <strong>del</strong> castello dei<br />
Sanseverino ed è arricchita in facciata da un portale<br />
di età altomedioevale, costituito da un architrave<br />
con decorazioni, su cui è inciso anche il<br />
nome <strong>del</strong> suo artefice: Nicola de Selcia (“Hoc<br />
fieri fecit N. Nicolaus De Selcia). Il portale costituisce<br />
una <strong>del</strong>le opere d’arte lapidee sacre più<br />
antiche di Teggiano. Non possiamo accertare se<br />
le funzioni di parrocchia svolte dalle chiese<br />
menzionate siano principiate, come afferma il<br />
Macchiaroli 43 , nel IX secolo, avendo egli consultato<br />
antiche carte che affermavano la preminenza<br />
cronologica <strong>del</strong>le parrocchie citate rispetto a<br />
quelle <strong>del</strong> suo tempo, perché l’istituto parrocchiale,<br />
svolto dalla plebana di Santa Maria, ebbe<br />
di certo la sua preminenza almeno fino al XIII o<br />
XIV secolo 44 , ma per ciò che concerne l’esistenza<br />
di questi sacri luoghi in epoca anteriore alle
parrocchie, possiamo con molta probabilità<br />
affermarlo in modo chiaro. Nel tempo in cui<br />
Diano assurse a ruolo di guida <strong>del</strong>lo Stato che<br />
fino agli inizi <strong>del</strong> XIX secolo ne portò il nome,<br />
la saturazione <strong>del</strong>lo spazio all’interno <strong>del</strong> circuito<br />
murario e l’aumentata popolazione, nel centro<br />
e nei casali, contribuì a riorganizzare il sistema<br />
<strong>del</strong>le parrocchie dianensi, con la costituzione<br />
di quattro nuovi titoli: San Martino 45 , San<br />
Pietro, San Michele e Sant’Andrea 46 , che gradualmente<br />
si affiancarono alle vecchie parrocchie e<br />
poi andarono a sostituirle completamente, incamerandone<br />
i benefici e le prebende. Un’analisi<br />
attenta <strong>del</strong>la collocazione dei titoli parrocchiali<br />
integrali ci porta a comprendere che la vita religiosa<br />
<strong>del</strong>la cittadina nei secoli XIII e XIV fu<br />
alquanto ricca e fervida; infatti la disposizione<br />
<strong>del</strong>le chiese gerarchiche saturava uno spazio di<br />
influenze di benefici e di soggezioni spirituali,<br />
compresso e racchiuso dalle mura romane. Si<br />
comprende il perché i vecchi titoli siano stati<br />
soppressi a vantaggio <strong>del</strong>le nuove parrocchie,<br />
comunque riconoscendo il vertice di gerarchia<br />
alla primaziale di Santa Maria. La proliferazione<br />
dei luoghi di culto in epoca medioevale, costituiti<br />
da oratori privati e cappelle, completa il<br />
panorama religioso fin qui elencato, costituendo<br />
per la città di Diano una sorta di piccola<br />
Gerusalemme o “monte santo”: dai documenti<br />
pergamenacei traspare infatti una ricchezza di<br />
spiritualità costituita da una lunga serie di luoghi<br />
sacri e di confraternite, tra cui è da annoverare<br />
anche una di “Battenti”. Tra gli edifici religiosi<br />
<strong>del</strong>la cittadina medioevale più importanti figurano<br />
il Corpo di Cristo, la SS. Trinità al vicinato<br />
omonimo (con molta probabilità la chiesa fu<br />
riaccomodata dalle Benedettine sul finire <strong>del</strong><br />
‘400 47 , mutando il nome nel santo patriarca <strong>del</strong>l’ordine),<br />
San Mauro (vicina a San Matteo), San<br />
Giorgio (lungo la via omonima, parte <strong>del</strong> cardo<br />
romano), San Sebastiano (adiacente la chiesa di<br />
Sant’Andrea), Santa Venera (ora succorpo di<br />
Sant’Angelo), San Giuseppe 48 , ecc. Merita un’attenzione<br />
particolare la chiesa <strong>del</strong> Corpo di<br />
Cristo, allineata lungo la metà orientale <strong>del</strong><br />
cardo e ora ridotta a giardino, crollata a seguito<br />
<strong>del</strong> terremoto <strong>del</strong> 1857 insieme con l’adiacente<br />
Seggio, che doveva costituirne parte integrante.<br />
MARCO AMBROGI<br />
- 123 -<br />
Fig. 11 - L’isolato <strong>del</strong>l’Annunziata; in basso a sinistra si riconosce la<br />
pianta <strong>del</strong>la Chiesa <strong>del</strong> Santo Spirito.<br />
L’attuale disposizione <strong>del</strong> portico ad archi, conosciuto<br />
come sedile <strong>del</strong>la città medioevale, è frutto<br />
di una ricostruzione tardo-ottocentesca 49 o <strong>del</strong><br />
XX secolo, che ne ha modificato l’orientamento,<br />
disponendo la fuga degli archi sulla via Corpo di<br />
Cristo, diversamente dalla posizione originaria,<br />
che invece si allineava sulla discesa di<br />
Sant’Andrea. Il portico antico, opera di Iacobello<br />
de Babino 50 <strong>del</strong> 1472, costituì quasi sicuramente<br />
lo spazio di accesso voltato alla chiesa <strong>del</strong><br />
Corpo di Cristo 51 , nel quale l’Universitas Civium<br />
dianense si riunì per discutere e dirimere i problemi<br />
e le cause civili dall’età medioevale<br />
all’Ottocento. Nel Medioevo fu frequente per le<br />
corporazioni e le assemblee civiche “adottare”<br />
una chiesa, per lo più degli ordini mendicanti,<br />
da eleggere quale luogo fisso per le riunioni: lo<br />
stesso accadde a Diano, con la chiesa <strong>del</strong> Corpo<br />
di Cristo, la quale oltre ad avere un elegante<br />
portico 52 , nel quale si poteva bene espletare la<br />
funzione di assemblea, si trovava proprio sulla
Fig. 12 - Diano in età basso medievale: 1. Convento dei Minori<br />
Conventuali. 2. Convento dei Minori Osservanti. 3. Convento degli<br />
Agostiniani.A. Cattedrale. B. Monastero dei Celestini. C. Monastero<br />
<strong>del</strong>le Benedettine. D. Seminario Diocesano.<br />
piazza principale <strong>del</strong>la città, non lontana dai<br />
simboli <strong>del</strong> potere civile, il castello, e religioso,<br />
la plebana di Santa Maria. La cospicua presenza<br />
di edifici religiosi in città era eguagliabile a quella<br />
<strong>del</strong>la campagna. Nelle borgate ai piedi dei<br />
monti, infatti, si enumeravano anche qui tante<br />
fondazioni ecclesiastiche: San Paolo, San<br />
Salvatore, Santa Maria Piccirella (fabbricata su<br />
un tempio pagano con frammenti lapidei di<br />
reimpiego), Santa Lucia, Sant’Elia, Madonna<br />
<strong>del</strong>la Misericordia, San Biagio, Sant’Antonio<br />
Abate, San Giovanni, San Vito (vi è più di una<br />
chiesa a lui dedicata), Madonna di Piedimonte,<br />
San Michele, San Rocco, Santa Caterina, San<br />
Silvestro e San Marco 53 . La tradizione popolare<br />
ricorda anche altri edifici, tra cui la cappella di<br />
San Cono (edificata forse sul luogo in cui esisteva<br />
la casa <strong>del</strong> santo) e quella <strong>del</strong> Salvatore. A<br />
queste facevano seguito numerose congreghe,<br />
di cui le più vicine a noi cronologicamente<br />
erano intitolate al SS. Rosario, ai defunti sacerdoti,<br />
al SS. Corpo di Cristo, al Purgatorio ed a<br />
Santa Margherita 54 .<br />
SALTERNUM<br />
- 124 -<br />
Gli ordini mendicanti e la saturazione <strong>del</strong>lo<br />
spazio urbano<br />
Nonostante la ricchezza <strong>del</strong>le fondazioni religiose<br />
ed ecclesiastiche presenti già nel XIII<br />
secolo all’interno <strong>del</strong>la cerchia muraria di Diano,<br />
l’insediamento dei nuovi Ordini mendicanti finì<br />
col saturare in modo completo lo spazio libero<br />
nell’anello esterno <strong>del</strong>la cittadina medioevale.<br />
Evidentemente le aree disponibili a fine<br />
Duecento in Diano non erano di certo numerose<br />
ed i frati Minori di San Francesco si attestarono<br />
nell’angolo nord occidentale <strong>del</strong>lo spazio<br />
urbano, nelle immediate vicinanze <strong>del</strong> castello<br />
normanno e <strong>del</strong>le sue appendici militari. Non<br />
abbiamo date certe sulla presenza dei Francescani<br />
in Diano, anche se la loro venuta nella cittadina<br />
si deve collocare nell’arco di tempo che<br />
va dall’ultimo quarto <strong>del</strong> XIII secolo agli inizi <strong>del</strong><br />
secolo successivo, in analogia con le dinamiche<br />
insediative dei Mendicanti attestate nel territorio<br />
<strong>del</strong>la Lucania. La fama di santità di Angelo<br />
Clareno, <strong>del</strong> ramo spirituale dei Francescani, che<br />
visse gli ultimi anni <strong>del</strong>la sua vita nel convento<br />
di Santa Maria <strong>del</strong>l’Aspro di Marsico Vetere,<br />
venendovi ivi sepolto, contribuì a raccogliere<br />
consensi favorevoli intorno al nuovo ordine dei<br />
seguaci di Francesco d’Assisi. Il portale <strong>del</strong>la<br />
chiesa dianense di San Francesco, che data al<br />
1307, segna la fine dei lavori di costruzione <strong>del</strong><br />
grande edificio religioso, dalla forma tipologica<br />
inequivocabile, analoga alle costruzioni minoritiche<br />
di seconda generazione. Quindi, possiamo<br />
ipotizzare che il programma costruttivo <strong>del</strong>la<br />
chiesa risalga perlomeno alla fine <strong>del</strong> Duecento.<br />
La cronologia <strong>del</strong>l’edilizia mendicante viene<br />
spesso divisa in tre periodi: la prima fase che va<br />
dal 1220 al 1240 circa con un primo insediamento<br />
e uso di piccole chiese o cappelle esistenti da<br />
parte dei frati Minori; una seconda fase (1240<br />
ca.-1270 ca.) con la costruzione <strong>del</strong>le prime<br />
chiese, di medie dimensioni; l’ultimo periodo,<br />
dal 1270 circa in poi (fino al XV secolo), con l’edificazione<br />
<strong>del</strong>le grandi aule sacre 55 . I primi<br />
documenti certi sulla presenza dei frati Minori in<br />
Diano sono <strong>del</strong> 28 settembre 1311 56 e <strong>del</strong> 4 aprile<br />
1321, quando Sarolo, figlio di Ruggero de<br />
Lisa, giacendo a letto ammalato, detta il suo ultimo<br />
testamento, a favore di varie chiese, tra cui
figura appunto San Francesco 57 . E la chiesa <strong>del</strong>l’Ordine<br />
diviene presto luogo sacro al centro<br />
<strong>del</strong>la vita religiosa e civile <strong>del</strong>la cittadina. Nel<br />
1322 58 un documento pergamenaceo attesta il<br />
deposito di un testamento redatto in atto pubblico<br />
presso i Frati Minori, che rileva l’uso frequente<br />
nell’età medioevale di affidare ai Frati mendicanti<br />
la garanzia di particolari privilegi o testamenti.<br />
Ben presto il convento dei Minori si<br />
avvalse <strong>del</strong>la figura di un procuratore in grado<br />
di gestire i rapporti con il mondo esterno negli<br />
affari di compravendita di beni: nel 1355 59 figura<br />
un tal Macciotto de Guglielmotto, giudice e procuratore<br />
di San Francesco, al tempo <strong>del</strong> guardianato<br />
di frate Antonio di Montella. Da una descrizione<br />
<strong>del</strong>l’Apprezzo <strong>del</strong> feudo, di fine Seicento,<br />
abbiamo anche un’ampia presentazione <strong>del</strong>la<br />
chiesa dei conventuali:<br />
“Vicino il Castello vi è il convento dei pp.<br />
Minori Conventuali di S. Francesco, nel quale vi<br />
sono due sacerdoti, e due laici; questi hanno la<br />
commodità <strong>del</strong>la chiesa, consistente in un vase<br />
grande coverto con intempiatura di legname in<br />
testa <strong>del</strong>la quale vi è l’altare maggiore isolato con<br />
custodia grande di legname pintata, et indorata<br />
con li suoi ornamenti di frasche e can<strong>del</strong>ieri, alli<br />
lati <strong>del</strong> quale per portelle intagliate, e lumeggiate<br />
d’oro s’entra nel coro anche coverto con intempiatura<br />
di legname simile, have li suoi sedini<br />
attorno lavorati di noce, e lettorino nel mezzo, a<br />
lato destro <strong>del</strong> quale vi è la sagristia piccola coverta<br />
anche con intempiatura di legname, dove vi<br />
sono li suoi stipi, e bancone dove si conservano<br />
tutte le soppelletili necessarie, come pianete, e<br />
paliotti di tutti colori, et ogn’altro; have altresì la<br />
croce, calici, patene, ingensiero, navetta, sicchietto<br />
et aspersorio, con la pisside, il tutto d’argento.<br />
Sopra <strong>del</strong> detto altare maggiore vi è l’architrave di<br />
legname lavorato, et indorato con Crocifisso pintato<br />
sopra tavola contornata con tutti ornamenti<br />
di pottini di rilievo indorati.<br />
In essa chiesa vi sono n. 8 cappelle sotto il titolo<br />
di diversi Santi, parte con cone di legname<br />
indorate, parte di stucco, una <strong>del</strong>le quali è sfondata<br />
coverta a lamia, con sedini attorno di<br />
castagno scorniciati; due <strong>del</strong>le dette cappelle<br />
sono patronate, una degl’heredi <strong>del</strong> quondam<br />
Herrico di Costanzo e l’altra degl’heredi <strong>del</strong><br />
MARCO AMBROGI<br />
- 125 -<br />
Fig. 13 - Assonometria <strong>del</strong>la Chiesa di S. Francesco in epoca medievale.<br />
Fig. 14 - Chiesa e convento <strong>del</strong>la SS. Pietà. Si noti la cappella poligonale a<br />
sinistra <strong>del</strong>la navatella: residuo <strong>del</strong>l’antica porta urbica.<br />
quondam Francesco Buonuomo; tutte le dette<br />
cappelle hanno li loro apparati necessarij, organo<br />
pulpito, confessionarij, et altro; have il suo<br />
campanile con tre campane. Vi è la commodità<br />
di due dormitorij, chiostro con due corritori con<br />
suoi pilastri isolati, refettorio, cocina dispenza,<br />
cellaro, et altro; vi è la commodità di un giardino<br />
grande…” 60
Fig. 15 - Scorcio <strong>del</strong>la parte absidale <strong>del</strong>la chiesa <strong>del</strong>la SS. Pietà.<br />
Fig. 16 - Settore nord-ovest <strong>del</strong>la cittadina di Teggiano, con il<br />
castello, il Convento di San Francesco e la Cattedrale.<br />
La configurazione <strong>del</strong>la chiesa descritta è<br />
ancora quella originaria, prima che la ristrutturazione<br />
in chiave barocca ne cambiasse l’aspetto<br />
interno. È presente ancora la cappella di San<br />
Marco, che si apriva sul lato sinistro, sede pro-<br />
SALTERNUM<br />
- 126 -<br />
babilmente di una confraternita, visto che la si<br />
descrive provvista di un coro.<br />
I Francescani non sono l’unico Ordine mendicante<br />
a stabilirsi in Diano, nella seconda metà<br />
<strong>del</strong> Trecento; nel settore orientale <strong>del</strong>la cittadina,<br />
che guarda verso Sala Consilina, gli Eremitani di<br />
Sant’Agostino iniziano a fabbricare il loro convento,<br />
terminando la chiesa nel 1370 61 , secondo<br />
quanto si rileva dalla data <strong>del</strong> portale di ingresso.<br />
La presenza dei Frati è documentata perlomeno<br />
al 1369, quando in un documento <strong>del</strong> 19<br />
dicembre 62 si fa menzione <strong>del</strong>la chiesa di<br />
Sant’Agostino. La dinamica insediativa di questo<br />
nuovo Ordine si può ipotizzare che segua quella<br />
dei Minori, con un iniziale stanziamento in<br />
ricoveri di fortuna e poi la costruzione di una<br />
grande chiesa con convento annesso. La nascita<br />
<strong>del</strong>l’Osservanza francescana, nel XIV secolo,<br />
determina la presenza in Diano di un nuovo<br />
convento, che avrà migliore sorte e fortuna<br />
rispetto al San Francesco, per la benevolenza<br />
<strong>del</strong>la famiglia dei Sanseverino nei suoi confronti.<br />
La posizione <strong>del</strong> nuovo convento francescano<br />
si attesterà alla porta orientale <strong>del</strong>la cittadina, nel<br />
sito che fino al 1471 63 era <strong>del</strong>le Benedettine, in<br />
collocazione strategica rispetto ai due conventi<br />
mendicanti già presenti dei Minori e degli<br />
Agostiniani. Fu per ordine di Sisto IV che le<br />
Benedettine di Diano dovettero trasferirsi al centro<br />
<strong>del</strong>la città 64 , e in conseguenza di ciò venne<br />
più facile alla famiglia dei Sanseverino 65 donare<br />
il luogo sacro ai Minori Osservanti, per il loro<br />
nuovo insediamento nella cerchia muraria. La<br />
piazza d’armi configurata sullo slargo davanti al<br />
monastero <strong>del</strong>le Benedettine e la vicinanza alle<br />
mura urbiche non garantivano alle monache la<br />
sicurezza di una vita contemplativa e di reclusione<br />
senza rischi, per cui la soluzione di spostarsi<br />
al vicinato <strong>del</strong>la Trinità risolse molti problemi di<br />
carattere politico, di mecenatismo e di sicurezza.<br />
La scelta dei Mendicanti di posizionarsi ai<br />
margini <strong>del</strong>la città medioevale orientò anche le<br />
espressioni edilizie dei conventi con le relative<br />
tipologie architettoniche, contribuendo a far sì<br />
che il cenobio divenisse un polo stesso di orientamento<br />
per l’espansione urbana. Il significato<br />
ed il valore <strong>del</strong> convento si espresse così in considerazione<br />
<strong>del</strong>l’importanza che assumeva per la
città scelta dai religiosi: il cenobio diveniva un<br />
luogo di relazioni comuni, quasi un’attrezzatura<br />
al servizio pubblico, utilizzato per la cittadinanza<br />
in diverse occasioni. Nelle chiese si tenevano<br />
assemblee, si rogavano atti notarili, ad esse facevano<br />
capo le comunità forestiere che vi fondavano<br />
le loro cappelle, ed in esse si usava seppellire<br />
i personaggi importanti <strong>del</strong>la politica,<br />
<strong>del</strong>l’economia e <strong>del</strong>la cultura 66 . Non solo, in caso<br />
di calamità naturali o belliche il convento offriva<br />
ospitalità come ospizio e ospedale con l’assistenza<br />
spirituale e materiale. L’insediamento dei<br />
ritiri dei Mendicanti era di frequente sollecitato<br />
da personaggi influenti e costituiva un evento<br />
positivo per tutta la comunità, di carattere spirituale,<br />
oltre a garantire anche una stabilità economica<br />
e sociale. Il convento diveniva così un simbolo<br />
<strong>del</strong>l’autorità insieme a quelli <strong>del</strong> potere<br />
comunale e vescovile. L’insediamento <strong>del</strong>la<br />
comunità, che spesso dava il nome al luogo<br />
stesso ove si attestava (nel corso <strong>del</strong> tempo),<br />
sfruttava la forma disponibile <strong>del</strong> lotto di terreno<br />
concesso o acquistato, formando le strutture<br />
secondo le condizioni <strong>del</strong> luogo, senza imporre<br />
direttive stilistiche e strutturali (agli inizi), tranne<br />
che per le chiese, che seguirono l’assetto tipologico<br />
degli Ordini contemplativi (i Cistercensi, in<br />
particolare, seguirono la tipologia <strong>del</strong>le grange)<br />
costruite con le proprie finanze e i propri mezzi<br />
manuali (i cosiddetti frati costruttori).<br />
Al lungo elenco di parrocchie, monasteri e<br />
ospedali di Diano fin qui menzionati, bisogna<br />
aggiungere anche altre istituzioni caritatevoli e<br />
religiose, tra le quali un posto di rilievo spetta<br />
alla dipendenza <strong>del</strong>l’Ordine Gerosolimitano,<br />
facente capo alla Commenda di San Giovanni in<br />
Fonte di Padula, documentata fino al 1722 67 . In<br />
effetti un luogo di culto dedicato a San Giovanni<br />
Gerosolimitano figura a Diano nel 1597 68 , mentre<br />
l’Ordine omonimo è presente nella cittadina<br />
con fra Giovanni de Adamo già nel 1352 69 . Come<br />
riferito in precedenza la sede <strong>del</strong>l’Ordine<br />
potrebbe essere quella di San Giovanni de<br />
hospitali, riportato dai documenti antichi e per il<br />
quale non sembra azzardato indicarne la sede<br />
nella cappella omonima posta su via Roma, di<br />
fronte alla Cattedrale, per la quale sembra certa<br />
la sua funzione di Battistero <strong>del</strong>la vicina Santa<br />
MARCO AMBROGI<br />
- 127 -<br />
Fig. 17 - Vecchia fotografia <strong>del</strong> largo <strong>del</strong>la SS.Annunziata, con il<br />
monastero dei Celestini e l’Ospedale di S. Spirito (sulla sinistra).<br />
Maria. L’unica fondazione monastica che non<br />
ebbe seguito fu quella <strong>del</strong> monastero di Santa<br />
Chiara, al vicinato di Sant’Angelo, per il quale il<br />
nobile Giovanni Carrano aveva lasciato nel<br />
testamento l’ordine per gli eredi di innalzare le<br />
strutture <strong>del</strong> cenobio, che avrebbe dovuto accogliere<br />
4 o 5 monache 70 .<br />
Sul finire <strong>del</strong> ‘300 la società religiosa di Diano<br />
era molto vitale e arricchita anche dalla presenza<br />
di confraternite, tra le quali la posizione preminente<br />
era occupata di certo dal sodalizio dei<br />
Disciplinati, documentato nel 1396 71 , e da altre<br />
congreghe, afferenti alle chiese parrocchiali<br />
locali, tra cui figurano Santa Maria Maggiore, San<br />
Nicola e la SS. Annunziata 72 . La confraternita dei<br />
Disciplinati figura anche nell’anno 1397, ma con<br />
il nome di Battenti 73 , che rimanda alla tipica particolarità<br />
nelle processioni penitenziali dei membri<br />
di questo sodalizio di battersi il petto. In<br />
Campania già dal periodo medioevale è diffusa<br />
la presenza di questa congrega, che segna per<br />
Diano una ricchezza in termini religiosi esemplificativa<br />
<strong>del</strong>l’importanza <strong>del</strong>la cittadina assunta<br />
tra il periodo medioevale e quello moderno: per<br />
intenderci, dalla ricostruzione <strong>del</strong>la civitas rupta<br />
(la città retratta) al tramonto <strong>del</strong>la fortuna dei<br />
Sanseverino. Una particolarità finale per evidenziare<br />
con maggiore dettaglio la fortuna economica,<br />
sociale e religiosa di Diano in età medioevale<br />
e moderna è data dalla presenza di una sinagoga,<br />
sita nella località omonima sotto il paese<br />
attuale (distrutta per il passaggio di una strada)<br />
e di cui il ricordo di una fontana a mascherone<br />
di Gorgone, trasportata nell’ex chiesa <strong>del</strong> Corpo
di Cristo (ora non più esistente). L’unica testimonianza<br />
è resa visibile in passato <strong>del</strong>l’antico luogo<br />
di riunione <strong>del</strong>la colonia ebraica dianense.<br />
La presenza <strong>del</strong> luogo di culto ebraico a<br />
Diano è confermata anche dall’attività, agli inizi<br />
<strong>del</strong> XVI secolo, di un banco di pegni, tenuto dai<br />
NOTE<br />
1 A giudizio di Nerone, Pozzuoli, Anzio, Teggiano e Pompei<br />
erano colonie esemplari; il Mommsen nel suo Corpus<br />
Inscriptionum Latinarum, riporta che nella casa dei Vettii<br />
di Pompei esisteva un’iscrizione ora non più visibile che<br />
così recitava: Iudicis Aug(usti) felic(iter)! Puteolos Antium<br />
Tegeano Pompeios: hae sunt verae colonia(e); ARTURO<br />
DIDIER, Teggiano romana, Ricerche storiche, Salerno 1964,<br />
p. 6.<br />
2 Ivi, p. 13.<br />
3 A. DIDIER, Teggiano romana, op. cit., p. 4. Lo storico riferisce<br />
<strong>del</strong>la presenza di un’iscrizione murata nell’atrio laterale<br />
<strong>del</strong>la chiesa di San Giovanni a Napoli, risalente al II<br />
sec. d. C., in cui figura il genitivo plurale Tegianensium, a<br />
testimoniare la presenza e l’importanza <strong>del</strong>la colonia <strong>del</strong><br />
Vallo di Diano; op. cit., p. 7. Documenti già analizzati<br />
nell’Ottocento per la storia romana di Teggiano sono in<br />
Stefano Macchiaroli, Diano e l’omonima sua valle, Ricerche<br />
Storico-Archeologiche, Napoli 1868, Ristampa Anastatica<br />
con L’Ambone <strong>del</strong>la cattedrale di Diano, Napoli 1874,<br />
Teggiano 1995, p. 75 e segg. L’autore riferisce che le porte<br />
romane <strong>del</strong>la città, propriamente dette, erano quelle <strong>del</strong>la<br />
Pietà e <strong>del</strong>l’Annunziata, cit. p. 128. Gli ingressi ulteriori<br />
sono da intendere quindi come piccole porte o postierle.<br />
4 A. DIDIER, Teggiano romana, op. cit., p. 13. Nelle campagne<br />
di Teggiano esistono alcune vestigia che riconducono<br />
alla storia romana <strong>del</strong>la cittadina, tra cui è doveroso menzionare<br />
i ponti di San Marco e <strong>del</strong>l’Anca, nelle omonime<br />
località campestri, il mosaico posto alla base <strong>del</strong> campanile<br />
<strong>del</strong>la parrocchiale di San Marco e frammenti di iscrizioni<br />
e sculture disseminate nelle borgate rurali.<br />
5 R. ALAGGIO, Monachesimo e territorio nel Vallo di Diano,<br />
Salerno 2004, p. 84. I dati sono ripresi da A.S.S. (Archivio<br />
di Stato di Salerno), Fondo Corporazioni Religiose, busta<br />
15, Grancie di Grottaferrata a. 1710.<br />
SALTERNUM<br />
- 128 -<br />
fratelli Daniele e Michele (documentato nel<br />
1510), che prestavano denaro nella cittadina ed<br />
a Sala Consilina, Polla, Sassano, San Giacomo,<br />
Padula, Sanza e Laurino, ricevendone in pegno<br />
dei corrispettivi da restituire con il ritorno <strong>del</strong>la<br />
somma prestata, comprensiva di interessi 74 .<br />
6 I priorati di San Nicola e di Santa Maria di Diano, figurano<br />
nel Medioevo come dipendenze di Cava (R. ALAGGIO,<br />
Monachesimo…, op. cit., p. 83, estratto da P. GUILLAME,<br />
L’Abbaye de Cava, LXXX-LXXXIX).<br />
7 S. MACCHIAROLI, Diano…, op. cit., p. 168.<br />
8 G. VITOLO, “Dalla pieve rurale alla chiesa ricettizia”, in<br />
Storia <strong>del</strong> Vallo di Diano, Vol. II, Età medievale, Salerno<br />
1982, p. 147. L’autore afferma, a p. 151, che il San Nicola<br />
di Diano nel 1248 era officiato o dal priorato di<br />
Sant’Arsenio o da quello di San Pietro di Polla.<br />
9 A. DIDIER, Regesti <strong>del</strong>le pergamene di Teggiano (1197-<br />
1806), Salerno 2003, p. 10, doc. 22. Altri documenti relativi<br />
al monastero femminile di San Benedetto sono <strong>del</strong> 1349<br />
e <strong>del</strong> 1359, quando viene nominata suor Benedetta, quale<br />
rettrice e badessa <strong>del</strong> monastero; Ivi, pp. 34-35 e 53, doc.<br />
84 e 132.<br />
10 Ivi, p. 98, doc. 239.<br />
11 Il documento riferisce di una vendita a fra Marco<br />
Martusciello di una vigna nel luogo detto “Pastina”, indicativa<br />
<strong>del</strong> sistema di coltivazione in uso nel Cilento già<br />
nell’alto Medioevo. In un altro documento si parla <strong>del</strong>la<br />
chiesa di San Vito alla Bucana per la quale si lasciano 3<br />
tarì per la commissione <strong>del</strong>la statua <strong>del</strong> santo. (A.DIDIER,<br />
Regesti…, op. cit., pp. 34-35 e 69, doc. 84 e 168). La chiesa<br />
di San Vito “de capite Bucane” era suffraganea di<br />
Sant’Andrea già nel 1359 per cui probabilmente non poteva<br />
costituire il centro di un monastero. (Ivi, p. 52, doc.<br />
129).<br />
12 Mons. Sacco enumerava venticinque torri intramezzate<br />
alle mura, di cui la metà esistente al suo tempo. (A. SACCO,<br />
La Certosa di Padula, disegnata, descritta e narrata su<br />
documenti inediti, Ristampa Anastatica, Salerno 1982,<br />
Vol. II, p. 194).<br />
13 La sostanza <strong>del</strong>l’effimero, Gli abiti degli Ordini religiosi in<br />
Occidente, G. ROCCA (a cura di), Roma 2000, p. 202.
14 Ivi, p. 332.<br />
15 A. DIDIER, Regesti…, op. cit., p. 29, doc. 73.<br />
16 Ivi, p. 91, doc. 223.<br />
17 Ivi, p. 263, doc. 638. Il monastero aveva beni anche alla<br />
contrada Sinagoga, il cui toponimo indica la presenza di un<br />
edificio per il culto di una colonia di Ebrei, presente a<br />
Diano, che tra l’altro vi teneva anche un banco di pegni.<br />
18 S. MACCHIAROLI, Diano…, op. cit., pp. 168-169.<br />
19 Il ricovero dovrebbe coincidere con quello che si appellava<br />
“San Nicola de Carranis” e che figura in un documento<br />
<strong>del</strong> 1 aprile 1545, con Ferdinando Brittonio quale procuratore.<br />
(A. DIDIER, Regesti…, op. cit., p. 191, doc. 461). Nella<br />
descrizione <strong>del</strong>l’Apprezzo <strong>del</strong> feudo di fine Seicento, nella<br />
SS. Pietà era presente una cappella, dedicata a San<br />
Francesco, afferente all’Abbadia di San Nicola <strong>del</strong>la famiglia<br />
Carrani (A.DIDIER, Diano città antica e nobile,<br />
Documenti per la storia di Teggiano, Teggiano 1997, p.<br />
110).<br />
20 “La Lucania sconosciuta”, in A. DIDIER, Diano…, op. cit.,<br />
p. 82. Nel 1420 le chiese di Santa Barbara e Sant’Antonio<br />
dei Carboni risultano dirute (A. DIDIER, Regesti…, op. cit., p.<br />
98, doc. 239).<br />
21 A. DIDIER, Regesti…, op. cit., p. 9, doc. 21.<br />
22 G. VITOLO, “Dalla pieve…”, op. cit., p. 149, ripreso da P.<br />
De Angelis, L’Ospedale di Santo Spirito in Saxia e le sue<br />
filiali nel mondo, Roma 1958, p. 146.<br />
23 S. MACCHIAROLI, Diano…, op. cit., pp. 152-3.<br />
24 I contatti frequenti <strong>del</strong>l’ospedale dianense con quello<br />
gerarchico romano di Saxia, sono evidenti anche da riferimenti<br />
artistici, infatti Ercole Perillo, pittore nativo di Diano,<br />
affrescò tra il 1575 ed il 1582 i locali <strong>del</strong> ricovero romano<br />
e non è escluso che la presenza <strong>del</strong>l’artista nella città eterna<br />
sia stata favorita da una benevolenza personale <strong>del</strong> priore<br />
di Diano.<br />
25 La sostanza…, op. cit., p. 391.<br />
26 Nel 1408, il 14 novembre, fra Corrado de Trevio, precettore<br />
generale <strong>del</strong>l’Ospedale di Santo Spirito in Saxia di<br />
Roma, autorizza i frati <strong>del</strong>l’Ospedale di Santo Spirito di<br />
Diano ad amministrare i beni <strong>del</strong>l’ospedale stesso (A.<br />
DIDIER, Regesti…, op. cit., p. 92, doc. 227). Tra le fila <strong>del</strong>la<br />
comunità figurano nel XV secolo anche degli oblati, tale è<br />
fra Marino de Cineda nel 1409 (ivi, pp. 92-93, doc. 228).<br />
27 A. DIDIER, Regesti…, op. cit., pp. 65-66, doc. 163.<br />
28 Ivi, p. 130, doc. 320.<br />
29 La sostanza…, op. cit., pp. 252-253.<br />
30 A. DIDIER, Regesti…, op. cit., p. 174, doc. 421.<br />
31 Ivi, pp. 84-85, doc. 207.<br />
32 G. VITOLO, Dalla pieve…, op. cit., p. 131; trattasi <strong>del</strong> privilegio<br />
concesso da Giovanni XIII al vescovo di Paestum-<br />
Capaccio il 23 agosto ed in cui figurano le località di<br />
Matinianu Dianu, Sassanu e Atena, quali centri con altrettante<br />
pievi. Matunianu potrebbe essere la localizzazione<br />
<strong>del</strong>la chiesa di Santa Maria, sempre a Diano, distrutta in<br />
tempi antichi ed aggregata, prima <strong>del</strong> 1149, all’Abbazia<br />
<strong>del</strong>la Trinità di Cava (Ivi, p. 131, ripreso da C. CARLONE, I<br />
principi Guaimario e i monaci cavensi nel Vallo di Diano,<br />
in “Archivi e Cultura”, 10, 1976, pp. 47-60).<br />
33 G. VITOLO, Dalla pieve rurale…, op. cit., p. 130; Santa<br />
Maria era conosciuta come plebs dianensis. Vitolo riprende<br />
la nota dall’archivio <strong>del</strong>l’Abbazia <strong>del</strong>la Trinità di Cava,<br />
XXIII, 54. Più tardi il sacro edificio figura come ecclesia<br />
archipresbiteralis, nelle Rationes Decimarum Italiae, op.<br />
MARCO AMBROGI<br />
- 129 -<br />
cit., p. 131.<br />
34 A. TORTORELLA, La Chiesa di Teggiano-Policastro: alcune<br />
annotazioni storiografiche, in “Annuario 2004-2005”,<br />
Diocesi di Teggiano-Policastro, Castelcivita, 2004, pp. 21 e<br />
22.<br />
35 G. VITOLO, Dalla pieve rurale…, op. cit., p. 135.<br />
36 S. MACCHIAROLI, Diano…, op. cit., p. 134.<br />
37 Estratto dalle “Memorie Antiche”, raccolte da don Michele<br />
Cavallaro di Teggiano nel 1806, Archivio Vescovile di<br />
Teggiano, ciclostilato, a me pervenuto per mano <strong>del</strong> defunto<br />
e caro don Peppino Cataldo, archivista e bibliotecario<br />
<strong>del</strong>la diocesi.<br />
38 S. MACCHIAROLI, Diano…, op. cit., p. 133.<br />
39 A. DIDIER, Diano…, op. cit., pp. 104 e segg.<br />
40 A. DIDIER, Regesti…, op. cit.<br />
41 S. MACCHIAROLI, Diano…, op. cit., p. 165.<br />
42 Nei regesti dei documenti di Teggiano di A. Didier, la<br />
chiesa compare già in un documento <strong>del</strong> 1365 (doc. 157,<br />
p. 62-63), anche se la sua presenza è da ascrivere a data<br />
anteriore. Il culto è ben attestato anche nella vicina Sala<br />
Consilina, ove sussiste ancora l’edificio di culto.<br />
43 S. MACCHIAROLI, Diano…, op. cit., p. 165<br />
44 G. VITOLO, Dalla pieve …, op. cit., p. 136, documenta che<br />
nel febbraio <strong>del</strong> 1433 il vescovo caputaquense, Francesco<br />
Tomacello, affidò la cura <strong>del</strong>le parrocchie di Sant’Eustachio<br />
e <strong>del</strong> Salvatore all’abate ed ai canonici di Santa Maria. La<br />
discordanza tra i riferimenti di Macchiaroli e Vitolo riguarda<br />
in particolare la parrocchia <strong>del</strong> Salvatore, ulteriore fondazione<br />
ecclesiastica o identificabile con una <strong>del</strong>le altre tre<br />
parrocchie <strong>del</strong>la prima generazione a Diano<br />
45 Riedificata in forme più ampie per la munificenza <strong>del</strong>la<br />
famiglia Carrano, di cui si vedono impressi gli stemmi in<br />
più punti <strong>del</strong> sacro edificio, nell’anno 1526. A. Didier, “La<br />
società <strong>del</strong> Cilento e <strong>del</strong> Vallo di Diano nei secoli XV e XVI,<br />
in «Il Cilento ritrovato», La produzione artistica nell’antica<br />
diocesi di Capaccio, Napoli 1990, p. 36.<br />
46 S. MACCHIAROLI, Diano…, op. cit., p. 169.<br />
47 Figura ancora in costruzione a fine Seicento l’attuale chiesa<br />
di San Benedetto, secondo la descrizione <strong>del</strong>l’Apprezzo<br />
<strong>del</strong> feudo (A. DIDIER, Diano…, op. cit., p. 109); stando a ciò<br />
la chiesa preesistente alla ricostruzione potrebbe essere<br />
appunto la SS. Trinità.<br />
48 S. MACCHIAROLI, Diano…, op. cit., pp. 166 e segg.<br />
49 S. MACCHIAROLI, Diano…, op. cit., p. 131, riferisce <strong>del</strong> crollo<br />
<strong>del</strong> sedile nel 1857, specificando che al suo tempo<br />
(quando compose lo scritto) esisteva il solo spazio.<br />
50 Sepolto nella chiesa <strong>del</strong>la SS. Pietà, in cui se ne riconosce<br />
la lapide terragna, avanti alla cappella dei duchi di Diano,<br />
a forma di torre con pianta centrica poligonale e coperta<br />
con volta ad ombrello.<br />
51 Nello spazio <strong>del</strong> giardino che occupa l’area di sedime<br />
<strong>del</strong>la chiesa è collocata una notevole scultura in pietra raffigurante<br />
un Cristo o un Eterno Padre in mandorla, richiamo<br />
al titolo <strong>del</strong> sacro luogo. Anche il SACCO, La certosa…,<br />
op. cit., Vol. III, p. 106, specifica che Teggiano ai suoi<br />
tempi (considerando il periodo <strong>del</strong>la prima stesura dei<br />
volumi, la fine <strong>del</strong>l’Ottocento), possedeva quattro portici:<br />
di San Martino, <strong>del</strong>la Pietà, <strong>del</strong>l’Annunziata e <strong>del</strong> Corpo di<br />
Cristo, profanato.<br />
52 Al centro <strong>del</strong> timpano sommitale vi fu collocato lo stemma<br />
<strong>del</strong>la città, costituito da una stella a cinque punte con<br />
coda, dove i cinque cunei rappresentano gli altrettanti
casali <strong>del</strong>lo Stato di Diano: Sant’Arsenio, San Pietro, San<br />
Rufo, San Giacomo e Sassano.<br />
53 S. MACCHIAROLI, Diano…, op. cit., pp. 169-170.<br />
54 Ivi, p. 170.<br />
55 R. BONELLI, Nuovi sviluppi di ricerca sull’edilizia mendicante,<br />
in “Gli ordini mendicanti e la città”, a cura di J. RASPI<br />
SERRA, Milano 1990, p. 25.<br />
56 A. DIDIER, Regesti…, op. cit., p. 10, doc. 22.<br />
57 Ivi, p. 13, doc. 30.<br />
58 Ivi, p. 13, doc. 31.<br />
59 Ivi, p. 50-51, doc. 125.<br />
60 A. DIDIER, Diano…, op. cit., p. 111. La descrizione<br />
<strong>del</strong>l’Apprezzo presenta anche le chiese ed i conventi <strong>del</strong>la<br />
SS. Pietà e di Sant’Agostino, oltre agli altri luoghi sacri <strong>del</strong>la<br />
città.<br />
61 È di quella data la fondazione <strong>del</strong>la chiesa, da parte di<br />
Marino de Forza e <strong>del</strong> figlio Antonio, secondo A. SACCO, La<br />
Certosa…, op. cit., Vol. III, p. 93.<br />
62 A. DIDIER, Regesti…, op. cit., pp. 65-66, doc. 163. La fabbrica<br />
<strong>del</strong> convento è ancora in piedi nel dicembre <strong>del</strong> 1397,<br />
op. cit., pp. 84-85, doc. 207.<br />
63 È di quella data la donazione ai frati Minori, da parte dei<br />
Sanseverino (A. SACCO, La certosa…, op. cit., Vol. III, p. 94).<br />
SALTERNUM<br />
- 130 -<br />
64 Il riferimento è di L. MANDELLI, monaco agostiniano, originario<br />
di Diano, che compose negli anni ’70 <strong>del</strong> XVII secolo<br />
la sua opera: La Lucania sconosciuta (in A. DIDIER,<br />
Diano città antica…”, op. cit., p. 81).<br />
65 La tradizione storica lega a Roberto e Giovanna<br />
Sanseverino, nell’anno 1474, la fondazione <strong>del</strong>la SS. Pietà.<br />
A. DIDIER, La società…, op. cit., p. 36.<br />
66 Per una più ampia panoramica sull’insediamento dei francescani<br />
nel territorio si rimanda a: M. AMBROGI,<br />
L’architettura e l’urbanistica francescana nel Vallo di<br />
Diano, in “Il Francescanesimo nel Vallo di Diano”, Atti dei<br />
convegni di Atena Lucana, 28 dicembre 2002 e Polla, 4<br />
aprile 2003, Cava dei Tirreni 2003, pp. 53 e segg.<br />
67 R. ALAGGIO, Monachesimo…, op. cit., p. 132, nota 57.<br />
68 A. DIDIER, Regesti…, op. cit., pp. 298-299, doc. 724.<br />
69 Ivi, p. 45, doc. 110.<br />
70 A. DIDIER, “La società…”, op. cit., p. 36.<br />
71 G. VITOLO, “Dalla pieve…”, op. cit., p. 145 e nota 86.<br />
72 Ivi, p. 145.<br />
73 A. DIDIER, Regesti…, op. cit., p. 85, doc. 207.<br />
74 A. DIDIER, Un banco di pegni di ebrei a Teggiano agli inizi<br />
<strong>del</strong> Cinquecento, in “Rassegna Storica Salernitana”, Nuova<br />
Serie, n. 8, 1987, pp. 185 e ss.
LAURA MAGGIO<br />
Archeosud: notizie dagli scavi<br />
Nel leggere le notizie sui<br />
tanti avvenimenti legati<br />
all’ambito storico-archeologico<br />
<strong>del</strong> 2007, si rintracciano interessanti<br />
spunti che meritano di essere<br />
rimarcati e che coprono, quest’anno<br />
più di altri, l’intero arco cronologico<br />
degli studi di antichità. Intensa<br />
ci è apparsa principalmente l’attività<br />
di studio e restauro di complessi e di<br />
singoli reperti, tra cui risalta l’impegnativo<br />
progetto di valorizzazione<br />
<strong>del</strong> Parco di Veio e <strong>del</strong>le statue di<br />
Apollo ed Eracle, provenienti da<br />
Portonaccio e conservate presso il Museo di<br />
Villa Giulia, a Roma. Dalla stessa area etrusca<br />
proviene anche una nuova interessante tomba a<br />
camera, denominata “dei Leoni Ruggenti” dai<br />
soggetti <strong>del</strong>le pitture in essa rinvenute, databile<br />
verso la fine <strong>del</strong> VII a.C. Dovendo necessariamente<br />
operare una scelta si è preferito, però,<br />
approfondire la disamina di due rinvenimenti<br />
particolarmente interessanti, tanto da richiamare<br />
l’interesse degli studiosi in tutto il mondo.<br />
Per quanto concerne il Pleistocene inferiore<br />
(tra 1,3 ed 1,6 milioni di anni fa) sono proseguite<br />
infatti le ricerche presso Apricena (FG) dove,<br />
in una <strong>del</strong>le note cave di pietra calcarea locale,<br />
un consorzio di cinque Università italiane,<br />
Torino, Roma La Sapienza, Roma Tre, Ferrara e<br />
Firenze, ha evidenziato un nuovo possibile scenario<br />
sulle dinamiche <strong>del</strong> popolamento<br />
<strong>del</strong>l’Europa; esso non risulta essere più legato<br />
in maniera esclusiva ai processi migratori che<br />
dall’Africa settentrionale si sarebbero diretti<br />
verso la Spagna, raggiungendo di lì il continente<br />
europeo, ma piuttosto si è individuata una<br />
Fig. 1 - Apricena (FG), la cava<br />
Pirro (Foto Consorzio<br />
universitario).<br />
- 131 -<br />
diversa direttrice che, dall’Est<br />
<strong>del</strong>l’Africa, attraverso una sorta di<br />
passaggio a Levante, ha percorso il<br />
bacino <strong>del</strong> Mediterraneo, raggiungendo<br />
l’Italia meridionale e da lì il<br />
resto d’Europa. Infatti il recupero di<br />
diversi ciottoli e schegge di selce<br />
attesta la più antica presenza <strong>del</strong>l’uomo<br />
in Europa, comprovando il<br />
possesso di un bagaglio di conoscenze<br />
tecnologicamente complesse,<br />
tanto da saper produrre oggetti di<br />
grande utilità per la vita quotidiana.<br />
Una vasta eco l’ha riscossa, anche<br />
al di là <strong>del</strong>le pubblicazioni scientifiche e di settore,<br />
il rinvenimento in territorio cisgiordano, da<br />
parte <strong>del</strong>l’Università Ebraica di Gerusalemme,<br />
<strong>del</strong>la cosiddetta tomba di Erode il Grande.<br />
Si tratta di un complesso di edifici costruiti a<br />
partire dal 20 d.C. per eseguire le cerimonie<br />
funebri in memoria <strong>del</strong> “re dei Giudei”.<br />
L’ubicazione sulla “collina di Furedidis” era<br />
nota già dalle descrizioni <strong>del</strong>lo storico<br />
Giuseppe Flavio, ma il rinvenimento dei frammenti<br />
di un sarcofago con decorazione a rosette,<br />
entro l’area destinata ad un grande edificio<br />
circolare con podio ed alcune urne affini a<br />
coevi rinvenimenti di Petra, suggerisce l’esatta<br />
ubicazione <strong>del</strong> luogo, distrutto tra il 62 ed il 72<br />
d.C., in connessione con la rivolta dei Giudei<br />
contro i Romani.<br />
Sembra opportuno, infine, accennare ad<br />
alcune riflessioni legate all’acceso dibattito<br />
politico, e quindi culturale, attualmente in<br />
corso sulla figura istituzionale <strong>del</strong>l’archeologo<br />
in Italia, e sulle prospettive lavorative di chi<br />
oggi decide di intraprendere questa carriera.
Fig. 2 - I° congresso nazionale Associazione Nazionale Archeologi<br />
(Foto Laura Maggio).<br />
I concorsi pubblici sono sempre stati piuttosto<br />
ridotti, i giovani perlopiù assolvono un<br />
ruolo minimo e decisamente transitorio nel privato,<br />
affatto garantiti nei diritti essenziali, mentre<br />
i più adulti tendono a cambiar lavoro o ad<br />
affiancarlo ad altro, di fatto rinunciando non<br />
solo alle proprie aspirazioni ma anche e soprattutto<br />
a titoli di studio e professionali piuttosto<br />
elevati, accontentandosi di svolgere incarichi<br />
spesso di livello inferiore alla propria qualifica<br />
pur di vedere garantita una certa continuità<br />
lavorativa.<br />
La mancata pubblicazione di concorsi adeguatamente<br />
calibrati per sanare le gravi carenze<br />
d’organico <strong>del</strong>le Soprintendenze archeologiche,<br />
con la conseguente ineluttabile necessità di<br />
demandare sempre più spesso impegni e obblighi<br />
<strong>del</strong>lo Stato alle Università o a gruppi di<br />
volontari, di fatto negli anni ha ampliato una<br />
lacuna gravissima per l’Italia, dove i Beni Culturali<br />
restano una significativa ed imprescindibile<br />
risorsa economica.<br />
SALTERNUM<br />
- 132 -<br />
Ma il mancato ricambio di personale qualificato<br />
negli uffici periferici <strong>del</strong> Ministero promette<br />
di determinare nel tempo una dequalificazione<br />
dei futuri funzionari, che non potranno<br />
godere <strong>del</strong> privilegio di un contatto diretto con<br />
le esperienze maturate nel passato, non garantendo<br />
quindi alcuna continuità con il pregresso.<br />
In quest’ottica ha fatto molto discutere il<br />
bando di concorso per Dirigente archeologo<br />
promulgato dal Ministero per i Beni Culturali, in<br />
base al quale il titolo di studio richiesto per<br />
accedere ad una qualifica di così alto livello<br />
è…il diploma di laurea triennale!<br />
Già lo scorso marzo a Pompei la problematica<br />
era stata affrontata nel corso <strong>del</strong> I Congresso<br />
nazionale <strong>del</strong>la neonata Associazione<br />
Nazionale Archeologi, che vede raggruppati per<br />
la prima volta gli archeologi operanti in Italia al<br />
fine di ottenere il riconoscimento e la regolamentazione<br />
di questa professione. I Delegati<br />
giunti da tutt’Italia in quella sede hanno proposto<br />
una definizione <strong>del</strong>la nuova figura <strong>del</strong>l’archeologo<br />
alla luce <strong>del</strong>la riforma universitaria,<br />
suggerendo una ripartizione <strong>del</strong>le competenze<br />
specifiche in due livelli: quello <strong>del</strong>la laurea<br />
magistrale e quello <strong>del</strong>la specializzazione post<br />
lauream, che, insieme ad un congruo curriculum<br />
professionale devono corrispondere a mansioni<br />
distinte e direttamente proporzionali ai<br />
titoli conseguiti.<br />
---------------------------www.beniculturali.it<br />
www.archeologi.org<br />
www.patrimoniosos.it<br />
archeosud@yahoogroups.com
O. Bounegrou, Traffiquants et navigateus<br />
sur le Bas Danube et dans le Pont Gauche à<br />
l’époque romaine, Wiesbaden, 2006, pp. 197.<br />
Nella prospettiva <strong>del</strong>la storia economica<br />
antica, l’area occidentale <strong>del</strong><br />
Mar Nero va analizzata come un<br />
organismo complesso che funziona in collegamento<br />
con le zone adiacenti. In realtà, questo<br />
spazio era aperto su due fronti verso il bacino<br />
<strong>del</strong> Mediterraneo: attraverso la Dalmazia, con il<br />
mondo occidentale e, attraverso l’Egeo, verso il<br />
mondo orientale. In tutto ciò, la Propontide<br />
giocava un ruolo fondamentale, perché per il<br />
suo tramite si realizzava il collegamento tra i<br />
Balcani e l’Anatolia, e cioè tra Oriente e<br />
Occidente. In tale quadro di rapporti, il punto<br />
più estremo ad Occidente era rappresentato da<br />
Aquileia, ad Oriente troviamo Tomis sul Mar<br />
Nero, ed all’estremità meridionale c’era<br />
Tessalonica. Al di fuori di questo contesto, non<br />
va sottovalutata l’importanza di Nicomedia, in<br />
Bitinia, che rappresentava il punto di passaggio<br />
per la penetrazione in Anatolia.<br />
Le vie commerciali sopra <strong>del</strong>ineate poggiavano<br />
su una solida tradizione ellenistica, che<br />
funzionava in parallelo, senza apparente rivalità,<br />
con le istituzioni romane: le strutture <strong>del</strong>l’impero<br />
romano rappresentavano un prolungamento,<br />
su un piano superiore, <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo<br />
economico di tradizione ellenistica.<br />
L’interesse dimostrato da Roma per l’area<br />
occidentale <strong>del</strong>le rive <strong>del</strong> Mar Nero era motivato<br />
dal contesto geopolitico <strong>del</strong>le tre provincie,<br />
la Mesia, la Tracia, la Dacia: provincie che vennero<br />
integrate abbastanza rapidamente nell’insieme<br />
generale <strong>del</strong>la vita economica <strong>del</strong>l’Impero<br />
romano.<br />
GABRIELLA D’HENRY - ALFREDO PLACHESI<br />
Recensioni<br />
- 133 -<br />
Fig. 1 -<br />
Colonna<br />
Traiana:<br />
l’Imperatore<br />
si imbarca<br />
per la<br />
seconda<br />
campagna<br />
dacica.<br />
Queste, in sintesi, sono le conclusioni esposte<br />
dallo storico rumeno O. Bounegrou, nel suo<br />
ottimo trattato Trafiquants et navigateurs sur le<br />
Bas Danube et dans le Pont Gauche à l’époque<br />
romaine, pubblicato a Wiesbaden nel 2006, nell’ambito<br />
<strong>del</strong>la collana “PHILIPPIKA”, Marburger<br />
altertumskundliche Abhandlungen, 9, e che noi<br />
abbiamo avuto la fortuna di poter esaminare per<br />
una recensione. Tanto più importante è questo<br />
contributo, in quanto abbiamo l’occasione di<br />
osservare un episodio <strong>del</strong>la conquista romana in<br />
Europa non dal punto di vista <strong>del</strong>l’Urbe, ma da<br />
quello di un’area periferica che è stata oggetto<br />
di conquista e che è la patria <strong>del</strong>lo studioso.<br />
Il volume, corredato da una ricca bibliografia,<br />
da indici analitici e dalla trascrizione di tutti i<br />
testi epigrafici che sono serviti di supporto alla<br />
ricerca, è suddiviso in diversi capitoli che verranno<br />
esaminati partitamente in questa sede.
Fig. 2 - M. BARATTA - P. FRACCARO, Atlante storico - fasc. primo: la Mesia,<br />
La Tracia e la Dacia in età imperiale romana.<br />
Nell’introduzione, lo studioso afferma che già<br />
nella seconda metà <strong>del</strong> II secolo a.C. alcuni<br />
avvenimenti storici sono alla base di quel processo<br />
di integrazione <strong>del</strong>lo spazio balcanico<br />
nelle strutture amministrative romane; ma, con<br />
la creazione graduale <strong>del</strong>le tre provincie, di<br />
Mesia, di Tracia e di Dacia, l’equilibrio si modifica,<br />
con il prolungamento <strong>del</strong>l’asse commerciale<br />
fino al Mar Nero.<br />
Con il primo capitolo, il Bounegrou fa un<br />
excursus storico, percorrendo la storia <strong>del</strong>la<br />
nascita <strong>del</strong>le provincie romane nell’area nordorientale,<br />
iniziando con l’istituzione <strong>del</strong>le provincie<br />
di Macedonia ed Illiria; quindi, in occasione<br />
<strong>del</strong>le guerre mitridatiche, l’interesse di Roma<br />
si sposta ancora più ad Est. Dapprima, l’area <strong>del</strong><br />
Basso Danubio era ancora scarsamente controllata;<br />
ma già Giulio Cesare, dopo la battaglia di<br />
Farsalo, avrebbe voluto espandersi in direzione<br />
<strong>del</strong> regno geto-dacico, però non ne ebbe il<br />
tempo. Con l’avvento di Augusto, l’interesse per<br />
queste terre si fa sempre più pressante, interesse<br />
che si concretizza nell’istituzione <strong>del</strong>le tre<br />
provincie: di Mesia, tra il 13 a.C. ed il 15 d.C.; di<br />
Tracia, il 46 d.C.; infine di Dacia, già nel corso<br />
<strong>del</strong> II secolo d.C.<br />
Il secondo capitolo (“Denominazione degli<br />
armatori nelle fonti letterarie ed epigrafiche greche<br />
e latine”) è, con il terzo, la parte più significativa<br />
<strong>del</strong> trattato. Anzitutto, lo studioso analizza<br />
i termini usati nelle fonti per indicare, sia in<br />
SALTERNUM<br />
- 134 -<br />
greco che in latino, i navigatori. Le<br />
nostre conoscenze sono ancora piuttosto<br />
sommarie su questo argomento, ma<br />
comuque lo storico fa un tentativo di<br />
decrittare alcuni termini, quali il greco<br />
naúklhroß, che probabilmente corrisponde,<br />
in linea di massima, al latino<br />
navicularius. Questo termine, in<br />
ambiente romano, indicava un imprenditore<br />
di trasporti marittimi, sottoposto<br />
ad un sistema corporativo e forse anche<br />
legato ad un servizio per l’annona,<br />
mentre il corrispettivo greco indicava<br />
probabilmente un imprenditore marittimo<br />
indipendente; difatti, i commercianti<br />
nel mondo greco-orientale non seguivano<br />
dei criteri rigorosi, le loro funzioni<br />
erano molto elastiche, e godevano di una<br />
notevole mobilità.<br />
Il terzo capitolo (“Denominazione dei mercanti<br />
nelle fonti letterarie ed epigrafiche greche<br />
e latine”), tratta <strong>del</strong>la terminologia degli operatori<br />
di commercio. In base alla documentazione<br />
scritta, sembrerebbe che il termine negotiatores,<br />
corrispondente in linea di massima al greco<br />
Émporoi, si riferisca ai grandi mercanti, quelli<br />
che praticavano il commercio sulle lunghe<br />
distanze. Invece, il termine mercatores, corrispondente<br />
al greco káphloi, indicava i commercianti<br />
al dettaglio. Ma con il passare dei secoli,<br />
questa distinzione si fa sempre più sfumata. Ad<br />
un’attenta analisi <strong>del</strong>le sfere di attività dei grandi<br />
mercanti, appare chiaro che la loro attestazione<br />
nella zona <strong>del</strong> Basso Danubio è essenziale<br />
per l’individuazione <strong>del</strong>le grandi linee commerciali,<br />
viste nel contesto <strong>del</strong>le aree economiche<br />
con cui le provincie danubiane erano in contatto.<br />
Un discorso a parte va fatto per i commercianti<br />
in dettaglio, a cui si possono avvicinare i<br />
venditori che erano anche produttori in proprio.<br />
In questo commercio di tipo locale era molto<br />
più forte la tradizione ellenistica di lunga durata;<br />
e ciò si può dedurre anche dalla loro presenza<br />
più numerosa in Tracia e nella Mesia<br />
Inferiore, che erano le zone in cui si sentiva più<br />
forte l’influsso greco-orientale; nella Mesia<br />
Superiore e nella Dacia, invece, i mo<strong>del</strong>li orga-
nizzativi romani erano prevalenti, anche se il<br />
controllo non era assoluto.<br />
Dai documenti, inoltre, si ricava la presenza<br />
di una particolare comunità, quella dei cives<br />
romani consistentes: di questa comunità, che<br />
compare già nel II secolo a.C., non si conosce<br />
bene la funzione. Lo studioso avanza l’ipotesi<br />
che si tratti di comunità italiche stabilite in<br />
Oriente, che erano in concorrenza con i mercanti<br />
orientali, ed avevano probabilmente anche un<br />
incarico di controllo da parte <strong>del</strong>le strutture<br />
romane; essi non erano quasi mai assimilati alla<br />
gente <strong>del</strong> luogo ed in un certo senso diffondevano<br />
la cultura latina; dovevano essere organizzati<br />
secondo un mo<strong>del</strong>lo corporativo ed agivano<br />
anche in zone rurali, forse allo scopo di attuare<br />
una politica di colonizzazione.<br />
Il quarto capitolo tratta di navigazione e di<br />
mezzi marittimi e fluviali di trasporto.<br />
Dal 1895, data <strong>del</strong>la scoperta <strong>del</strong> mosaico di<br />
Althiburus in Tunisia, su cui sono rappresentate<br />
ventiquattro navi, di cui ventidue con i nomi<br />
indicati a fianco, si conoscono i nomi di molte<br />
imbarcazioni antiche; anche le esplorazioni subacquee<br />
hanno dato il loro contributo, anche se<br />
su questo argomento ci sono ancora molti elementi<br />
oscuri.<br />
In ogni modo, le grandi navi a vela che avevano<br />
funzioni commerciali interprovinciali venivano<br />
chiamate corbitae; esse erano onerarie e,<br />
quando trasportavano cereali, venivano chiamate<br />
frumentariae; queste ultime erano al servizio<br />
<strong>del</strong>l’annona per recare approvigionamenti nelle<br />
città <strong>del</strong>l’Impero, e venivano sorvegliate da militari.<br />
Esse sono rappresentate su alcuni rilievi di<br />
Tomis e di Histria.<br />
Abbiamo pure la testimonianza <strong>del</strong>le naves<br />
lapidariae, che trasportavano pietre e marmi dalla<br />
cave <strong>del</strong> bacino egeo verso le aree danubiane.<br />
Navi più piccole servivano per il controllo dei<br />
porti, per il trasbordo di materiale dalle navi più<br />
grandi che restavano alla fonda, o anche per la<br />
pesca: esse venivano chiamate musculi, ed<br />
erano usate anche per scopi militari. Le scaphae<br />
erano invece imbarcazioni ausiliarie.<br />
Esiste la documentazione anche di navi a<br />
funzioni miste (le naves auctariae), che risalivano<br />
i corsi d’acqua, e spesso trasportavano anfo-<br />
GABRIELLA D’HENRY - ALFREDO PLACHESI<br />
- 135 -<br />
re, e di navi prettamente fluviali, cui forse accennano<br />
le imbarcazioni rappresentate numerose<br />
sulla Colonna Traiana.<br />
La presenza documentata di tutte queste navi<br />
prova l’intensità di scambi nei porti danubiani<br />
più importanti, Histria, Tomis, Callatis, Odessos,<br />
che si ponevano come punti di diffusione verso<br />
l’interno dei prodotti trasportati, e, con questi, di<br />
cultura materiale.<br />
Per quanto riguarda le basi navali, resti e<br />
tracce di porti si sono trovati a Callatis, Tomis,<br />
Histra; altri attracchi esistevano certamente<br />
lungo il corso <strong>del</strong> Basso Danubio, ma non ne è<br />
rimasta alcuna traccia: di essi, il più importante<br />
era quello di Noviodunum, situato vicino ad uno<br />
stanziamento militare.<br />
Nel sesto capitolo, lo studioso affronta il tema<br />
<strong>del</strong>l’organizzazione doganale.<br />
Anche su questo argomento non si sa ancora<br />
molto, ma se il rinvenimento ad Efeso di una<br />
lunga ed importante iscrizione, la lex Portori<br />
Asiae, battezzata per assonanza con il<br />
Monumentum Ancyranum di Augusto il<br />
Monumentum Ephesenum, ci fa capire qualcosa<br />
di più. Questo documento è estremamente lungo<br />
e si riferisce alla Provincia d’Asia; fu elaborato nel<br />
75 a.C, l’anno prima <strong>del</strong>la terza guerra mitridatica,<br />
e venne rivisto varie volte, fino al 62 d.C., in<br />
età neroniana. In esso si nominano i publicani,<br />
gli esattori <strong>del</strong>le tasse che erano localizzati sulla<br />
due rive <strong>del</strong> Bosforo, ed il centro doganale per la<br />
Propontide, che era situato presso lo stretto, a<br />
Calcedonia. Dal documento si ricava che il controllo<br />
romano in Asia Minore e nel bacino egeo<br />
era già molto forte nel I secolo a.C.; ma il suo<br />
regolamento rigido era anche un espediente politico,<br />
fatto per mettere in difficoltà Mitridate: nella<br />
zona <strong>del</strong> Bosforo non si applicava, infatti, alcuna<br />
esenzione doganale, che veniva applicata<br />
invece in altre realtà, come l’area danubiana. Da<br />
altre documentazioni si può dedurre, infine, che<br />
nella zona <strong>del</strong> Basso Danubio esisteva un organismo<br />
doganale autonomo.<br />
Copia <strong>del</strong> trattato <strong>del</strong> Bounegrou è depositata<br />
presso la Biblioteca <strong>del</strong> <strong>Gruppo</strong> <strong>Archeologico</strong> di<br />
Salerno, per permettere la lettura a chi volesse<br />
approfondire l’interessante argomento.
Adriano CAFFARO - Giuseppe<br />
FALANGA, Il libellus di Chicago.<br />
Un ricettario veneto di arte, artigianato<br />
e farmaceutica (secolo<br />
XV), ArciPostiglione, Salerno<br />
2005, pp. 175.<br />
Lo studio storico <strong>del</strong>le<br />
tecniche artistiche non<br />
può non considerare i<br />
fattori ideali e materiali che, in<br />
una data epoca, hanno determinato<br />
la genesi e la fortuna <strong>del</strong>l’opera<br />
d’arte. Tale considerazione<br />
ha un rilievo storiografico particolare,<br />
perché il “momento” teorico<br />
e quello pratico trovano<br />
nella trattazione storica <strong>del</strong>l’arte una forma<br />
spontanea di coniugazione, che può riflettere il<br />
naturale dispiegarsi <strong>del</strong>le vicende culturali.<br />
Nel XX secolo, la storia sociale <strong>del</strong>l’arte, alla<br />
luce <strong>del</strong>le acquisizioni scientifiche relative anche<br />
alla cultura materiale, ha inteso esprimere tale<br />
assunto in termini d’opportunità metodologica,<br />
invitando a considerare insieme all’interazione<br />
tra gli artisti, i mecenati, i committenti ed il pubblico<br />
anche l’altra importante tripartizione esistente<br />
tra la disponibilità di taluni materiali in<br />
un’area geografica, la competenza tecnica richiesta<br />
all’artista-artigiano nel lavorare la materia e le<br />
condizioni socio-economiche in cui il lavoro<br />
<strong>del</strong>l’arte poteva esprimersi al meglio.<br />
Questa considerazione ha permesso, insomma,<br />
di disegnare una fisionomia più nitida <strong>del</strong><br />
contesto dinamico in cui s’è realizzato il perfezionamento<br />
tecnico <strong>del</strong>la produzione artistica. È<br />
quanto tenta di dimostrare l’ultima impresa di<br />
studi che ha oggi il suo referente divulgativo<br />
nella collana “L’officina <strong>del</strong>l’arte”, ideata e diretta<br />
da Adriano Caffaro per le “Edizioni Arci<br />
Postiglione”. Lo studioso salernitano, da anni<br />
impegnato nella ricerca <strong>del</strong>le fonti letterarie <strong>del</strong>l’arte<br />
medievale e moderna, è andato a ritroso<br />
nel tempo lungo i sentieri <strong>del</strong>l’ermeneutica<br />
testuale per giungere a dischiudere ‘mondi’ inesplorati<br />
<strong>del</strong>l’arte e <strong>del</strong>l’artigianato. Capire come<br />
la conoscenza tecnica e l’ambiente sociale, in<br />
cui essa maturò, si sono entrambe sedimentate<br />
SALTERNUM<br />
- 136 -<br />
nelle tracce talvolta lacunose dei<br />
documenti letterari è la sfida sottesa<br />
a questo ambizioso progetto<br />
editoriale.<br />
L’ultimo volume in catalogo,<br />
scritto da Caffaro insieme a<br />
Giuseppe Falanga, segue questa<br />
luminosa scia di domande per<br />
darne una risposta. Si tratta de Il<br />
libellus di Chicago. Un ricettario<br />
veneto di arte, artigianato e farmaceutica<br />
(secolo XV), terzo<br />
numero <strong>del</strong>la nuova Collana<br />
inaugurata da entrambi gli storici<br />
con Il papiro di Leida. Un<br />
documento di tecnica artistica e<br />
artigianale <strong>del</strong> IV secolo d. C. e<br />
arricchita dal prezioso volume di Adriano<br />
Caffaro De clarea. Manuale medievale di tecnica<br />
<strong>del</strong>la miniatura (secolo XI).<br />
Il nuovo libro propone una lettura, per l’appunto<br />
“integrata”, di un testo latino quattrocentesco,<br />
presumibilmente composto in area veneta,<br />
in ambiente speziale, trascritto e pubblicato<br />
nel 1985 da Domenico Bommarito, ora migliorato<br />
nella trascrizione, tradotto in lingua italiana e<br />
commentato dai due studiosi salernitani. A testimoniare<br />
la dinamicità <strong>del</strong> contesto genetico <strong>del</strong>l’arte<br />
è, in questo caso, una fonte letteraria che<br />
potremmo definire “anfibia”, giacché essa vive<br />
<strong>del</strong>la duplice natura che oggi consente di associare<br />
un giudizio di valore all’originaria funzione<br />
pragmatica per cui il testo stesso fu redatto.<br />
Si tratta, infatti, di un “libellus”, ossia di un<br />
ricettario, in cui trovano spazio ben 90 prescrizioni<br />
il cui ambito applicativo non è invero di<br />
facile definizione, perché le nozioni raccolte<br />
nelle singole ricette fanno riferimento a campi<br />
disparati <strong>del</strong> sapere, oscillanti tra l’arte e l’artigianato,<br />
la cosmetica e la farmaceutica. Un esempio?<br />
La prima ricetta indica come rendere azzurra<br />
l’acqua, la seconda suggerisce come tingere i<br />
capelli di nero o rosso scuro. Tra un rigo e l’altro,<br />
la terza slitta nel campo <strong>del</strong>la miniatura ed<br />
indica come scrivere lettere d’oro, d’argento e di<br />
rame, seguita dalla quarta che riporta come far<br />
scomparire quelle lettere. La quinta ricetta arriva<br />
a suggerire in un sol tempo come cancellare le
lettere dalla pergamena e come sbiancare i<br />
denti! Con la sesta si passa a lucidare finestre...<br />
Insomma, la presenza simultanea di tecniche e<br />
materiali eterogenei risponde ad un ordine concettuale<br />
che, a quanto pare, non segmenta le<br />
competenze artigianali in attività specialistiche,<br />
bensì trattiene lo spettro <strong>del</strong>le contingenze in cui<br />
quelle competenze si misuravano ed affinavano<br />
nella pratica quotidiana <strong>del</strong> mestiere. Del resto,<br />
quest’ordine testuale tradisce una consuetudine<br />
che, pur variando nel tempo, non ha mai smarrito<br />
alcuni tratti tipici <strong>del</strong>la tradizione ricettaria.<br />
Basti guardare alla varietà <strong>del</strong>le materie naturali<br />
citate nel testo, recuperate in loco o importate<br />
dall’Oriente: dall’aloe al buon miele, dal fico<br />
all’allume saccarino, dall’incenso alla resina di<br />
lentisco, dal bolo armeno alla gomma amigdali-<br />
GABRIELLA D’HENRY - ALFREDO PLACHESI<br />
- 137 -<br />
na. Il più <strong>del</strong>le volte, però, sono materie che<br />
ritroviamo già sui deschi <strong>del</strong>le officine monastiche<br />
medievali. Per non parlare <strong>del</strong>le tecniche:<br />
quella di bollire le sostanze in aceto, ad esempio,<br />
era già nota a Plinio il Vecchio, agli alchimisti<br />
egizi <strong>del</strong>l’età tardo-antica, ai Romani e ai<br />
monaci artigiani <strong>del</strong>l’Europa medievale.<br />
L’edizione <strong>del</strong> libellus, curata da Caffaro e<br />
Falanga, è pregevole, quindi, per la corretta<br />
impostazione metodologica che non manca di<br />
integrare l’analisi dei contenuti specifici emergenti<br />
dal testo in una più ampia panoramica,<br />
che sovente dilata le proprie coordinate tanto in<br />
senso sincronico, con lo sguardo rivolto a ciò<br />
che c’è “dietro” la formula ricettaria, quanto in<br />
senso diacronico, allo scopo di ricostruire il filone<br />
evolutivo cui quel testo appartiene.
BIANCA<br />
CANCELLARE
CORINNA FUMO<br />
L’enigma degli avori medievali<br />
da Amalfi a Salerno<br />
La mostra “L'enigma degli avori medievali<br />
da Amalfi a Salerno” (20 Dicembre<br />
2007 - 30 Aprile 2008), cofinanziata dal<br />
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla<br />
Regione Campania con fondi <strong>del</strong>l’Unione<br />
Europea, nasce da un'idea progettuale di rilevante<br />
interesse storico-artistico, che punta a<br />
ricostruire il tessuto figurativo <strong>del</strong>la lavorazione<br />
<strong>del</strong>l’avorio fra Amalfi e Salerno fra XI e XII secolo.<br />
Curata dal prof. Ferdinando Bologna d’intesa<br />
con la Soprintendenza per i B.A.P.P.S.A.E. di<br />
Salerno ed Avellino e giunta ormai ad un avanzato<br />
livello operativo, essa riunirà le non poche<br />
opere eburnee prodotte nella regione fra Amalfi<br />
e Salerno, due dei principali centri mediterranei<br />
di lavorazione <strong>del</strong>l’avorio, caratterizzati da un’elevata<br />
raffinatezza tecnica ed ideologica.<br />
Le sale <strong>del</strong> Museo Diocesano di Salerno, che<br />
per l’occasione saranno oggetto di una completa<br />
ristrutturazione, ospiteranno le varie sezioni<br />
<strong>del</strong> percorso espositivo, il cui nucleo principale<br />
verterà intorno alle pregevoli tavolette che compongono<br />
il ciclo Vetero - Neo Testamentario<br />
salernitano. Unico al mondo nel suo genere,<br />
questo insieme di 69 tavolette, narranti episodi<br />
biblici ed evangelici, rappresenta l’espressione<br />
di una fervente congiuntura culturale che, attraverso<br />
una profonda conoscenza <strong>del</strong>la teologia<br />
medievale e <strong>del</strong>l’iconografia paleocristiana, racchiude<br />
in sé elementi stilistici di assoluta novità<br />
in campo artistico, dove in maniera rinnovata<br />
trovano sintesi istanze di matrice carolingia,<br />
ottoniana e bizantina, con particolari riferimenti<br />
alla cultura islamica. Il risultato è stata una<br />
straordinaria e complessa opera di dimensione<br />
europea oltre che mediterranea.<br />
- 139 -<br />
Salerno. Museo Diocesano “San Matteo”.<br />
Tavoletta d’avorio: Visitazione; I Magi presso Erode (fine <strong>del</strong>l’XI sec.).<br />
A questa sezione si lega tutta una serie di<br />
pezzi che, anche se in maniera diversa, manifestano<br />
l’ampio raggio di influenza culturale <strong>del</strong>la<br />
bottega salernitana o comunque amalfitana e<br />
che nel corso dei secoli successivi sono andati<br />
ad arricchire le collezioni di diversi musei stra-
nieri. Proprio i Direttori di questi Musei, ben<br />
consapevoli <strong>del</strong>l’importanza culturale <strong>del</strong>l’evento,<br />
hanno permesso alle opere di essere nuovamente<br />
riunite insieme, anche solo temporaneamente.<br />
Fra questi pezzi, in particolare, rientrano nel<br />
ciclo <strong>del</strong> Vecchio Testamento la tavoletta con la<br />
Creazione degli uccelli, dei pesci e degli animali<br />
terrestri, segata in due parti, una <strong>del</strong>le quali conservata<br />
al Museo <strong>del</strong>le arti applicate di Budapest<br />
e l’altra al Metropolitan Museum of Art di New<br />
York. Notevoli pure i rilievi con il Fratricidio di<br />
Caino e Abele e l’ammonizione di Caino <strong>del</strong><br />
Museo <strong>del</strong> Louvre di Parigi e i due medaglioni<br />
quadrati raffiguranti i simboli degli evangelisti<br />
Matteo e Giovanni, i quali, insieme con la<br />
Visitazione, giungeranno dall’Hermitage di San<br />
Pietroburgo.<br />
Tavoletta eburnea. Creazione degli uccelli, dei pesci e degli animali terrestri.<br />
(Parte conservata a Budapest, Museo <strong>del</strong>le Arti Applicate).<br />
Astuccio d'avorio amalfitano. New York, Metropolitan Museum of Art.<br />
SALTERNUM<br />
- 140 -<br />
Nella sezione “amalfitana”, ossia quella<br />
dedicata ad opere attribuibili alla bottega di<br />
Amalfi, si collocano certamente la cassetta<br />
eburnea proveniente dall’Abbazia di Farfa, consegnata<br />
già alle cure dei Funzionari <strong>del</strong>la<br />
Soprintendenza per un intervento di restauro,<br />
nonché l’astuccio eburneo proveniente dal<br />
Dipartimento di Arti Islamiche <strong>del</strong> Metropolitan<br />
Museum of Art di New York, entrambe sicuramente<br />
commissionate da amalfitani. La prima,<br />
infatti, reca il nome di Mauro de Maurone<br />
Comite, ricco mercante amalfitano. Il secondo,<br />
invece, porta sui lati corti il nome di Manso<br />
figlio di Tauro.<br />
L’individuazione di una bottega amalfitana<br />
consente l’apertura di un filone di ricerca<br />
orientato verso l’arte saracena e fatimida, come<br />
si evince soprattutto dall’astuccio di New York<br />
e dall’olifante <strong>del</strong> Museo di Cluny di Parigi.<br />
Altre due cassette di avorio saranno presenti<br />
in mostra ed in particolare si tratta <strong>del</strong>la cassetta<br />
con figure di Santi <strong>del</strong> Victoria and Albert<br />
Museum di Londra e una cassetta con scene di<br />
caccia proveniente dalla Basilica di San<br />
Servatius di Maastricht.<br />
Nella complessa questione figurativa fra<br />
Amalfi e Salerno si collocano gli avori provenienti<br />
dal Museo <strong>del</strong> Castello Sforzesco di<br />
Milano, dal Victoria and Albert Museum di<br />
Londra (Sogno di San Giuseppe, la<br />
Presentazione al tempio, le Nozze di Cana) e<br />
da altri Musei, appartenenti alla cosiddetta<br />
Cattedra di Grado, nei quali si nota una forte<br />
tangenza iconografica con la serie evangelica<br />
di Salerno, che diventa addirittura identica<br />
nella Natività <strong>del</strong>la Dumbarton Oaks Collection<br />
di Washington.
Presenti alla mostra sono anche altri musei<br />
italiani, tra i quali il Museo <strong>del</strong> Bargello di<br />
Firenze e il Museo Civico medievale di<br />
Bologna. Nessuna notizia positiva è purtroppo<br />
giunta dai musei tedeschi, i quali sono custodi<br />
di opere che fino agli anni Cinquanta <strong>del</strong> secolo<br />
scorso erano parte integrante <strong>del</strong> ciclo di<br />
Salerno.<br />
Il repertorio figurativo è arricchito, inoltre,<br />
da altre sezioni nelle quali saranno esposti una<br />
serie di oggetti eburnei come gli olifanti, grandi<br />
corni d’avorio, completamente intarsiati,<br />
ricavati dalla zanna <strong>del</strong>l’elefante e usati a<br />
seconda dei casi come strumento musicale, di<br />
richiamo oppure come reliquiario. Notevoli<br />
sono gli olifanti prestati per questo evento:<br />
l’Olifante di Cluny (Francia), quello di Boston,<br />
l’Olifante <strong>del</strong> Tesoro <strong>del</strong>la Basilica <strong>del</strong> Pilar di<br />
Saragoza (Spagna) e l’ Olifante <strong>del</strong>l’Abbazia di<br />
Muri <strong>del</strong> Kunsthistorisches Museum di Vienna<br />
(Austria).<br />
Altri oggetti rilevanti che completano le<br />
varie sezioni sono un altarolo a tre ante raffigurante<br />
l’Ascensione di Cristo e numerosi<br />
Crocifissi, alcuni dei quali appartengono a collezionisti<br />
privati. La dimostrazione, invece, di<br />
quanto l’uso <strong>del</strong>l’avorio fosse attestato non solo<br />
in ambito religioso ma anche laico e ludico, è<br />
favorita dalla presenza di alcuni pezzi <strong>del</strong> gioco<br />
degli scacchi di provenienza italiana.<br />
Fanno da corollario alle opere di avorio, ma<br />
legati ideologicamente ad esse, dei documenti<br />
a stampa che arricchiscono la sezione <strong>del</strong>le<br />
fonti e <strong>del</strong>le ipotesi di ricostruzione, una porta<br />
di legno proveniente da Celano e due frammenti<br />
scultorei <strong>del</strong> Museo <strong>Archeologico</strong> di<br />
Venosa, il trono ligneo di Montevergine, che<br />
presentano evidenti similitudini con le decorazioni<br />
realizzate negli avori.<br />
Un anticipo <strong>del</strong>la mostra si è potuto avere<br />
nella recente manifestazione, tenutasi presso il<br />
Museo Diocesano, con la presentazione <strong>del</strong><br />
restauro e relativa esposizione <strong>del</strong>la cassetta<br />
eburnea di Farfa.<br />
L'opera costituisce un fondamentale tassello<br />
per gli sviluppi <strong>del</strong>la lavorazione eburnea nella<br />
regione, in quanto fu commissionata dal ricco<br />
e potente mercante amalfitano Mauro de<br />
CORINNA FUMO<br />
- 141 -<br />
Maurone. Quest'ultimo offrì il cofanetto-reliquiario<br />
all'abbazia di Farfa, in provincia di<br />
Rieti, noto santuario mariano.
BIANCA<br />
CANCELLARE
CORINNA FUMO<br />
La presentazione <strong>del</strong> restauro <strong>del</strong>la cassetta eburnea<br />
di Farfa al Museo Diocesano<br />
Dal 14 al 30 Settembre presso il Museo<br />
Diocesano di Salerno è stata esposta<br />
la celebre cassetta d’avorio di Farfa,<br />
dal nome <strong>del</strong>l’Abbazia benedettina in provincia<br />
di Rieti dov’è conservata. Si tratta di una straordinaria<br />
opera d’arte con la quale si dimostra la<br />
nascita di una bottega <strong>del</strong>l’avorio in costa<br />
d’Amalfi. Essa, infatti, fu commissionata dal<br />
potente mercante amalfitano Mauro, appartenente<br />
alla nobile famiglia dei Maurone Comites,<br />
il quale ha fatto incidere sui lati lunghi una preghiera<br />
alla Vergine, di protezione per sé e per i<br />
suoi sei figli di cui riporta il nome. La scritta epigrafica<br />
fornisce un terminus post quem non alla<br />
datazione <strong>del</strong>l’opera, in quanto al 1072 i figli di<br />
- 143 -<br />
Mauro, Giovanni e Mauro, risultano morti nella<br />
guerra con i Longobardi di Salerno. Il carattere<br />
mariano <strong>del</strong> cofanetto, forse una piccola urnareliquiario,<br />
si evince chiaramente anche dalle<br />
immagini scolpite a rilievo, fra le quali la più<br />
rappresentativa è quella <strong>del</strong>la Koimésis (la dormizione<br />
di Maria), raffigurata su tutto un lato<br />
lungo, e in coerenza con la Crocifissione e<br />
l’Ascensione di Cristo presenti sull’altro lato.<br />
Da un punto di vista storico-artistico la scritta<br />
inserisce l’opera a pieno titolo nel dibattito<br />
sull’esistenza di una bottega specializzata nella<br />
lavorazione <strong>del</strong>l’avorio ad Amalfi. Altro elemento<br />
che certamente radica in maniera inequivocabile<br />
la manifattura <strong>del</strong>la cassetta all’ambiente
amalfitano è la presenza, nella scena<br />
<strong>del</strong>l’Annuncio ai pastori, di un suonatore di<br />
liuto, strumento conosciuto solo in una città<br />
come Amalfi che, nell’XI secolo, era al centro<br />
dei commerci con l’Oriente bizantino. Si tratta di<br />
una <strong>del</strong>le principali scoperte venute fuori dallo<br />
studio che ha accompagnato la manifestazione.<br />
Il restauro <strong>del</strong>la cassetta è ancora in corso e<br />
viene effettuato dalla Soprintendenza per i<br />
B.A.P.P.S.A.E. di Salerno e Avellino in collaborazione<br />
con l’Opificio <strong>del</strong>le Pietre Dure di Firenze.<br />
Esso costituisce un raffinato anticipo <strong>del</strong>la<br />
SALTERNUM<br />
- 144 -<br />
Mostra internazionale “L'enigma degli avori<br />
medievali da Amalfi a Salerno”, prossima all’inaugurazione<br />
(20 Dicembre 2007).<br />
Sebbene il confronto con gli avori <strong>del</strong> nostro<br />
Museo Diocesano, di manifattura certamente più<br />
raffinata e intellettualmente più elevata, sia<br />
caratterizzato da un evidente divario, la cassetta<br />
di Farfa costituisce sicuramente l’avvio di un<br />
percorso tecnico e stilistico nell’area fra Amalfi e<br />
Salerno che trova nella materia eburnea un<br />
momento di espressione figurativa molto significativo.
ROSA ALBA TRUONO IANNONE<br />
Appunti di viaggio:<br />
Arzachena, tra antiche pietre megalitiche<br />
Nel territorio di Arzachena, tra i mirti, i<br />
ginepri ed i cisti <strong>del</strong>la sarda Gallura,<br />
misteriose e suggestive pietre granitiche<br />
si ergono in forma spettacolare a rappresentare<br />
due “tombe di giganti”: quelle di Li Lolghi e<br />
di Coddu Vecchju o Ecchju. Nomi e siti interessanti,<br />
che accendono curiosità e fantasie, siti che<br />
evocano usi e costumi dei primi abitanti di quell’isola<br />
meravigliosa che è la Sardegna. Avvolti<br />
dall’intenso profumo di lentisco e da un millenario<br />
silenzio, le pietre incantano lo spettatore<br />
attento, pronto a raccogliere il loro racconto<br />
affascinante sulla presenza, in quel luogo, di<br />
una grande civiltà autoctona, vitale nel periodo<br />
<strong>del</strong> bronzo. E i recinti megalitici, i cerchi magici<br />
di sapore più celtico che mediterraneo, accertano<br />
la confluenza nell’isola di popoli e civiltà<br />
provenienti da ogni dove, elementi che indicano<br />
nella Sardegna il “Reader’s Digest” <strong>del</strong>la storia<br />
antica mediterranea. Le tombe dei giganti di<br />
Li Lolghi e di Coddu Vecchju evocano rituali,<br />
consuetudini e comportamenti di antiche comunità;<br />
testimoniano un tipo di sepolcro collettivo,<br />
proprio <strong>del</strong>la civiltà nuragica. Dei due monumenti<br />
ciò che colpisce di più la vista <strong>del</strong> visitatore<br />
è la fronte: l’esedra, con i suoi quattordici<br />
lastroni infissi a coltello, di altezza decrescente<br />
verso i lati. Al centro campeggia un’alta stele,<br />
formata da un’unica lastra granitica e decorata<br />
da un bordo a bassorilievo, che divide la superficie<br />
in due parti. Questa grande lastra appare<br />
come un maestoso portale: l’ingresso alla vita<br />
ultraterrena. Quella di Coddu Vecchju è più<br />
slanciata, infatti è alta 4,40 metri e meno larga<br />
(1,90 metri) di quella di Li Lolghi. Essa è formata<br />
da due blocchi di granito sovrapposti.<br />
L’esedra, che attesta l’elaborazione sarda di un<br />
- 145 -<br />
Fig. 1 - Arzachena (Sassari), Coddu Ecchiu.<br />
Fig. 2 - Arzachena (Sassari), Li Lolghi.<br />
tipo tombale diffuso nel resto <strong>del</strong>l’Europa, era<br />
riservata al culto e alle offerte per i defunti. I<br />
due monumenti sono il risultato di due momenti<br />
costruttivi. Nel primo, risalente all’età <strong>del</strong><br />
Bronzo Antico (1800-1600 a.C.), venne realizzata<br />
la parte terminale che costituisce una allée<br />
couverte, ossia una tomba di forma allungata,<br />
formata da lastre verticali e coperta, inizialmente,<br />
da lastroni piani circondata da un recinto<br />
ellissoidale di pietre: il peristatile, con funzione<br />
di contenimento <strong>del</strong> tumulo che lo ricopriva. In
un secondo momento, alla fine <strong>del</strong> Bronzo<br />
Medio (1400 a.C.), si aggiunsero il lungo corridoio<br />
funerario e l’esedra. Il primo è costituito da<br />
lastroni infissi verticalmente nel terreno, integrati<br />
da muratura con in fondo una lastra orizzontale,<br />
una specie di ripiano per contenere oggetti<br />
di corredo. In corrispondenza di essa è l’unica<br />
lastra di copertura, attualmente conservata.<br />
Della parte più antica restano vasetti a peducci,<br />
ciotole troncoconiche, riferibili al Bronzo Antico<br />
SALTERNUM<br />
- 146 -<br />
(1800-1600 a.C.), mentre altri materiali <strong>del</strong> corridoio<br />
funerario e <strong>del</strong>l’esedra risalgono al periodo<br />
compreso tra il 1400 e il 1100 a.C. È da allora<br />
che ancora oggi nel silenzio <strong>del</strong>la profumata<br />
macchia mediterranea queste pietre, testimoni<br />
<strong>del</strong> passato, vivono. Le loro considerevoli<br />
dimensioni ci lasciano fantasticare e pensare,<br />
come nella credenza popolare, ai “giganti” che<br />
gli antichi credettero abitarvi e che oggi aleggiano<br />
come fantasmi misteriosi.
La nuova sede <strong>del</strong> Museo <strong>Archeologico</strong> Nazionale<br />
di Pontecagnano è stata realizzata con il proposito<br />
di dare una adeguata collocazione alla ricchissima<br />
raccolta di materiali archeologici portati<br />
alla luce nel corso degli ultimi quaranta anni nel<br />
territorio comunale, con una intensa e inarrestabile<br />
attività di ricerca che ha consentito di <strong>del</strong>ineare<br />
la forma e gli aspetti culturali di un grande<br />
insediamento. Con lo scavo sistematico <strong>del</strong>le<br />
necropoli, intrapreso da Bruno d’Agostino nel<br />
1962, si è aperto un nuovo capitolo <strong>del</strong>la storia<br />
antica <strong>del</strong>la Campania. Le vaste necropoli, che, a<br />
partire dalla fine <strong>del</strong> X - inizi <strong>del</strong> IX sec. a.C., si<br />
distribuiscono intorno ad un ampio spazio abitativo,<br />
sono la più eloquente testimonianza <strong>del</strong>l’espansione<br />
<strong>del</strong>le genti protoetrusche ed etrusche<br />
nell’Italia meridionale, in anticipo<br />
e poi in concomitanza con il processo<br />
di colonizzazione greca<br />
<strong>del</strong>la fascia costiera. Il grande centro<br />
di Pontecagnano costituisce la<br />
punta più avanzata di quella<br />
espansione e, almeno a partire<br />
dalla fine <strong>del</strong> VI sec. a.C., ebbe<br />
vere e proprie caratteristiche urbane.<br />
La notevole quantità di oggetti<br />
di importazione presenti nei<br />
corredi funerari, sia dal mondo<br />
greco e orientale sia da quello<br />
magnogreco e italico, ne testimoniano<br />
la funzione emporica e la<br />
ricchezza culturale.<br />
La realizzazione <strong>del</strong> nuovo<br />
Museo, che illustra in maniera<br />
rigorosamente scientifica, ma al<br />
tempo stesso suggestiva e attraente,<br />
l’evidenza restituita dall’antico<br />
GIULIANA TOCCO SCIARELLI<br />
Gli Etruschi di frontiera<br />
Pontecagnano (SA). Oinochoe d’argento<br />
con palmetta in lamina d’oro all’attacco<br />
<strong>del</strong>l’ansa, dalla tomba 928. Secondo<br />
quarto <strong>del</strong> VII sec. a.C.<br />
- 147 -<br />
Pontecagnano (SA). Museo <strong>Archeologico</strong> Nazionale. Kotyle eponima <strong>del</strong><br />
‘Pittore <strong>del</strong> Lupo Cattivo’, dalla tomba 865. Inizio <strong>del</strong> VI secolo a.C.<br />
insediamento, nasce da un’intensa e proficua collaborazione<br />
tra la Soprintendenza per i Beni<br />
Archeologici <strong>del</strong>le province di Salerno, Avellino e<br />
Benevento, l’Università degli Studi di Napoli<br />
‘l’Orientale’ e l’Università degli Studi di Salerno. Il<br />
Museo è stato realizzato per lotti funzionali, grazie<br />
ai finanziamenti assicurati in<br />
tutti questi anni dal Ministero per<br />
i Beni e le Attività Culturali e dalla<br />
Regione Campania, mentre il<br />
Comune di Pontecagnano ha<br />
acquisito il suolo sul quale sorge il<br />
nuovo edificio.<br />
Pontecagnano (SA).<br />
Coppa carenata<br />
d’impasto con l’ansa<br />
sormontata da due<br />
cavallini, dalla tomba<br />
575. Ultimo quarto<br />
<strong>del</strong>l’VIII secolo a.C.
BIANCA<br />
CANCELLARE
LAURA IBISCO<br />
Pesci, barche, pescatori nell’area mediterranea<br />
dal Medioevo all’età contemporanea<br />
Si è svolto dal 3 al 6<br />
ottobre, tra Fisciano,<br />
Vietri sul Mare e<br />
Cetara, il Convegno<br />
Internazionale Pesci, barche,<br />
pescatori nell’area mediterranea<br />
dal Medioevo all’età contemporanea<br />
inserito nell’ambito<br />
dei seminari permanenti <strong>del</strong>la<br />
SISE (Società Italiana degli<br />
Storici <strong>del</strong>l’Economia). Questo<br />
incontro segue quelli precedenti<br />
di Bosa (1994), Alghero-<br />
Cabras (2001) e Roma (2003) e<br />
ha aperto il confronto con aree<br />
geografiche diverse al fine di<br />
approfondire il momento <strong>del</strong>la<br />
comparazione storica. E’ stato scelto un ambito<br />
geografico molto vasto, comprendente l’intero<br />
Mediterraneo, partendo dall’area lusitana e<br />
marocchina, proprio per confrontare le diverse<br />
realtà storiche e storiografiche <strong>del</strong> settore<br />
peschiero.<br />
La pesca ha da sempre rappresentato una<br />
<strong>del</strong>le attività primarie <strong>del</strong>l’uomo sin dalle originarie<br />
forme di organizzazione economica ed è<br />
quindi possibile tracciare un continuum tra età e<br />
periodi anche distanti molti secoli tra di loro attraverso<br />
la ricostruzione di tecniche di pesca e di<br />
lavorazione, di tipologie <strong>del</strong>le imbarcazioni utilizzate,<br />
di strumenti di lavoro e di cicli biologici ed<br />
economici al contempo.<br />
- 149 -<br />
Al Convegno hanno partecipato<br />
31 relatori, di cui ben 13<br />
stranieri da Malta, Marocco,<br />
Portogallo, Spagna, Francia,<br />
Tunisia, Albania, Romania;<br />
hanno inoltre aderito alla<br />
Tavola Rotonda 8 relatori che<br />
hanno affrontato i temi più<br />
urgenti <strong>del</strong>la pesca italiana ed<br />
europea, evidenziando limiti e<br />
prospettive di questo settore<br />
che potrebbe costituire, in realtà,<br />
una risorsa di primaria<br />
importanza nei prossimi decenni<br />
da un punto di vista <strong>del</strong>l’alimentazione<br />
e <strong>del</strong>l’economia<br />
regionale così come avveniva<br />
nei secoli precedenti e come è emerso dalle relazioni<br />
storiche presentate.<br />
La pubblicazione degli Atti, prevista per il<br />
prossimo anno, permetterà di apprezzare l’apporto<br />
scientifico innovativo degli interventi succedutisi<br />
nelle 8 sessioni di studio. Durante le giornate<br />
di lavoro è stata allestita, a cura <strong>del</strong>l’Assessorato<br />
ai Beni e Attività Culturali <strong>del</strong>la Provincia di<br />
Salerno e <strong>del</strong>la Direzione Provinciale, la mostra<br />
Arti e Mestieri nell’antico Sud. Il Ceramista e il<br />
Pescatore, che ha permesso di ammirare numerosi<br />
oggetti di cultura materiale legati al mondo<br />
<strong>del</strong>la pesca nell’antichità e, ancora, altri reperti<br />
conservati e messi gentilmente a disposizione dal<br />
<strong>Gruppo</strong> Habitat di Vietri sul Mare.
BIANCA<br />
CANCELLARE
MONICA VISCIONE<br />
In ricordo di Antonella Fiammenghi<br />
È passato qualche mese dalla sua scomparsa,<br />
ma il vuoto che ha lasciato appare ancora incolmabile!<br />
È una perdita per l’Archeologia e per chi<br />
ha imparato ad apprezzarla per il suo infaticabile<br />
lavoro per la salvaguardia e la valorizzazione<br />
di Velia e tutto il Cilento.<br />
Fin dai suoi primi passi di Funzionario <strong>del</strong><br />
Ministero dei Beni Culturali, sul finire degli anni<br />
Settanta, aveva conquistato il cuore e la simpatia<br />
di tutti; nel corso <strong>del</strong>la sua lunga carriera<br />
aveva incrementato anche l’ammirazione e la<br />
gratitudine dei tanti giovani archeologi che<br />
hanno avuto la fortuna di completare la loro formazione<br />
sul campo con la sua guida, ma soprattutto<br />
aveva accresciuto la stima e la considerazione<br />
degli amministratori con i quali ha sempre<br />
concertato una politica di collaborazione per<br />
valorizzare l’inestimabile patrimonio archeologico<br />
presente nel Cilento. Antonella è stata per 20<br />
anni l’anima degli scavi di Elea-Velia, l’ideatrice<br />
<strong>del</strong> Parco <strong>Archeologico</strong>, l’attenta custode dei siti<br />
archeologici cilentani, da Agropoli a Sapri.<br />
- 151 -<br />
Al primo posto la salvaguardia <strong>del</strong> Cilento!<br />
Era una forza <strong>del</strong>la natura, la sua straordinaria<br />
vitalità era pari alla sua professionalità, al suo<br />
rigore scientifico; a lei si devono gli studi sulla<br />
fase arcaica di Agropoli, sulla necropoli di S.<br />
Marco di Castellabate, sull’abitato lucano di<br />
Caselle in Pittari, oltre che i numerosi approfondimenti<br />
su Velia.<br />
Era una entusiasta che infondeva entusiasmo,<br />
un paladino <strong>del</strong>la tutela instancabile, un vulcano<br />
di iniziative e di idee. Era una persona speciale!<br />
Il suo sorriso e la luce che brillava nei suoi occhi<br />
sono indimenticabili. Ci lascia in eredità un tesoro<br />
come Velia, la rete dei piccoli Musei <strong>del</strong><br />
Cilento, da Roccagloriosa a Palinuro, e i siti da<br />
Moio <strong>del</strong>la Civitella a Policastro a Caselle in<br />
Pittari, ma soprattutto resteranno come punto di<br />
riferimento la sua tenacia, la sua intelligenza e<br />
la sua capacità di non dimenticare mai il valore<br />
<strong>del</strong>l’amicizia e <strong>del</strong>l’amore verso gli altri.
Finito di stampare<br />
nel mese Novembre 2007<br />
da Arti Grafiche Sud, Salerno