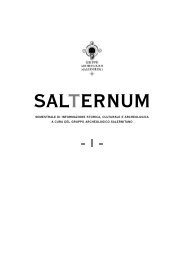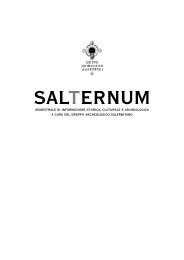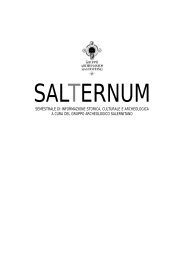Download del file - Gruppo Archeologico Salernitano
Download del file - Gruppo Archeologico Salernitano
Download del file - Gruppo Archeologico Salernitano
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
modeste, quando si trovavano in territori soggetti<br />
a Roma erano in una posizione di privilegio,<br />
appartenevano al popolo dominante, erano sottratti<br />
alle leggi ed ai tribunali locali, dovevano<br />
rendere conto <strong>del</strong> proprio operato solo ai magistrati<br />
ed al popolo romano. Abusavano di siffatta<br />
situazione? Forse non tanto quanto si pensa<br />
comunemente. In genere quando alcuni episodi<br />
o personaggi come Verre in Sicilia (propretore<br />
dal 73 al 71 a.C.) sono ricordati, è perché non<br />
rientrano nella consuetudine. Indubbiamente le<br />
orazioni di Cicerone, le Verrinae, hanno contribuito<br />
a dare a quegli avvenimenti un rilievo letterario<br />
e quindi una risonanza che altrimenti<br />
forse non avrebbero avuto, ma Verre era un<br />
magistrato, non un comune cittadino e anzi fra i<br />
capi di accusa che gli furono mossi c’era anche<br />
quello di non aver rispettato i diritti di alcuni cittadini<br />
romani. È risaputo che a Roma non si era<br />
teneri con gli autori di certi abusi, come è dimostrato<br />
dal fatto che Verre, dopo la prima orazione<br />
di Cicerone, non attese la fine <strong>del</strong> dibattimento<br />
ma preferì andare volontariamente in esilio,<br />
evitando guai peggiori.<br />
In ogni caso il crimen repetundarum contemplava<br />
le eventuali malversazioni che potevano<br />
essere commesse dai magistrati romani in<br />
danno di singoli o di intere comunità nelle provincie<br />
loro assegnate. Diverse furono le leggi<br />
che furono promulgate in proposito: la lex Acilia<br />
<strong>del</strong> 123 a.C. prevedeva per questo reato una<br />
sanzione pecuniaria pari al doppio <strong>del</strong> valore di<br />
quanto estorto. Questa sanzione fu poi confermata<br />
dalla lex Servilia <strong>del</strong> 111 a.C., dalla lex<br />
Cornelia <strong>del</strong>l’81 e dalla lex Iulia <strong>del</strong> 59 a.C.. Il<br />
susseguirsi di siffatte leggi, se da un lato evidenzia<br />
la volontà <strong>del</strong>lo Stato di stroncare gli abusi,<br />
dall’altro rivela che la tentazione di impinguare<br />
le tasche era comunque forte.<br />
Abbiamo affermato che in età imperiale si<br />
diffuse sempre più il rifiuto di impegnarsi nelle<br />
cariche pubbliche. Questo fenomeno era certamente<br />
negativo per lo stato romano ed era perciò<br />
necessario porvi riparo in qualche modo.<br />
Augusto, secondo quanto ricorda Svetonio 4 ,<br />
introdusse dei nova officia in modo da coinvolgere<br />
nell’attività di governo il maggior numero<br />
possibile di cittadini e farli partecipi <strong>del</strong>le<br />
SALTERNUM<br />
- 38 -<br />
responsabilità connesse alla pubblica amministrazione<br />
<strong>del</strong>egandoli alla cura <strong>del</strong>le opere pubbliche,<br />
<strong>del</strong>le vie, <strong>del</strong>le acque, <strong>del</strong>l’alveo <strong>del</strong><br />
Tevere, alla distribuzione di grano al popolo.<br />
Istituì anche la prefettura <strong>del</strong>la città, un triumvirato<br />
per la nomina dei senatori ed ancora altre<br />
funzioni, ma tutte di carattere amministrativo e<br />
con poca o nulla rilevanza politica. Gli incarichi<br />
di importanza vitale nella gestione <strong>del</strong>la res<br />
publica restavano nelle mani <strong>del</strong>l’Imperatore e<br />
di poche altre persone a lui vicine e di accertata<br />
fe<strong>del</strong>tà.<br />
La formazione di quella comunità di cives che<br />
va sotto il nome di civitas è in qualche modo<br />
avvolta nelle nebbie di un tempo antico. Si è<br />
avanzata l’ipotesi da parte di alcuni studiosi che<br />
sia stata una forma evolutiva di alcune strutture<br />
sociali caratteristiche dei popoli indoeuropei 5 .<br />
Naturalmente al riguardo mancano <strong>del</strong>le prove<br />
certe e pertanto si deve fare ricorso ad indizi<br />
tratti da quanto conosciamo <strong>del</strong>la vita e dei<br />
costumi religiosi e militari <strong>del</strong>la società romana.<br />
Come tutti sanno, fin dalle origini il popolo<br />
romano era costituito da due classi di cittadini: i<br />
patrizi ed i plebei. La derivazione <strong>del</strong> termine<br />
“patrizio” da pater è più che evidente. I Patres<br />
erano i capifamiglia (Paterfamilias) che, riuniti<br />
in assemblea, discutevano i problemi <strong>del</strong>la collettività<br />
arcaica e prendevano insieme le decisioni<br />
che ritenevano più opportune. L’espressione<br />
rimase e si consolidò col passare <strong>del</strong> tempo<br />
assumendo un significato politico. Patres o<br />
Patres conscripti erano chiamati i senatori,<br />
riunendo in un unico termine i Patres, d’origine<br />
patrizia, ed i Conscripti, ovvero i senatori d’origine<br />
plebea. La parola plebe, con l’aggettivo<br />
corrispondente plebeo, sembra invece che si<br />
possa far risalire etimologicamente ad un termine<br />
arcaico d’origine indoeuropea (radice ples)<br />
affine al greco plêqoß significante la moltitudine,<br />
la massa dei cittadini, quelli, in altri termini,<br />
che non avevano rilevanza politica.<br />
Era inevitabile che la separazione <strong>del</strong> popolo<br />
in due classi, una dominante e l’altra sottomessa,<br />
dovesse avere la conseguenza di determinare<br />
attriti e scontri, di cui la leggenda di Menenio<br />
Agrippa e <strong>del</strong> suo famoso apologo è una lontana<br />
eco. Senza alcun dubbio ci furono tentativi di