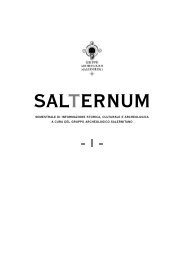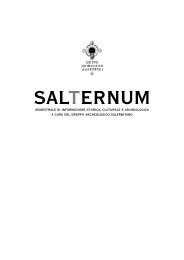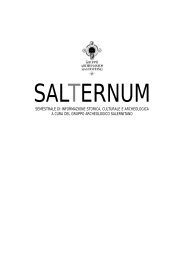Download del file - Gruppo Archeologico Salernitano
Download del file - Gruppo Archeologico Salernitano
Download del file - Gruppo Archeologico Salernitano
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Statua di patrizio<br />
(il cosiddetto “Patrizio Barberini”)<br />
che tiene in mano i busti dei suoi<br />
antenati (I secolo a.C.).<br />
Nella Roma repubblicana ogni cittadino, tra<br />
quelli che per la loro posizione nella comunità<br />
potevano aspirarvi, era geloso <strong>del</strong> suo diritto di<br />
seguire il cursus honorum, la carriera <strong>del</strong>le cariche<br />
pubbliche che poteva portarlo fino a quella<br />
più elevata e di maggior prestigio, il consolato.<br />
Lungi dal comportare vantaggi di carattere economico,<br />
l’accesso alle magistrature, almeno in<br />
teoria, rappresentava un onore, ma anche un<br />
onere notevole. La consuetudine, soprattutto<br />
nella tarda Repubblica, imponeva a colui che<br />
era stato eletto di offrire ai concittadini spettacoli<br />
circensi, o d’altro genere, quando non addirittura<br />
la costruzione a proprie spese di edifici<br />
pubblici a vantaggio <strong>del</strong>la città. Molti si impegnavano<br />
in attività simili ancora prima di essere<br />
eletti o di presentare la propria candidatura, allo<br />
scopo di guadagnarsi la benevolenza degli elettori,<br />
tanto forte era il desiderio di raggiungere il<br />
prestigio connesso con le magistrature. A questo<br />
proposito si deve ricordare che Cicerone fece<br />
approvare una legge che introdusse, per coloro<br />
che intendevano presentare la propria candidatura<br />
a qualche funzione statale, il divieto di allestire<br />
giochi circensi nei due anni precedenti la<br />
tornata elettorale. Era un tentativo, <strong>del</strong> resto<br />
facilmente aggirabile, di ridurre l’effetto <strong>del</strong>la<br />
disparità economica fra i concorrenti nella competizione<br />
politica.<br />
SALTERNUM<br />
- 30 -<br />
È importante notare che, sia pure con il<br />
secondo fine di acquisire presso i concittadini<br />
dei meriti da sfruttare in un momento successivo<br />
a scopi politici, la sollecitudine e l’impegno<br />
dei Romani nell’abbellire la città con la costruzione<br />
di edifici, portici, basiliche ed altro erano<br />
molto vivi e ciò accadeva non solo a Roma, ma<br />
anche nelle altre località <strong>del</strong>l’Impero di una<br />
certa importanza. Abbiamo molteplici esempi di<br />
restauri di edifici, o di costruzioni ex novo,<br />
finanziate, nel corso degli anni, da personaggi<br />
<strong>del</strong>le varie città soggette a Roma anche se appartenenti<br />
a ceti di non grande rilievo. Se così non<br />
fosse stato non si vedrebbero tante imponenti<br />
rovine ancora presenti ovunque siano arrivate le<br />
aquile romane.<br />
Come si vede, l’esborso di denaro per candidarsi<br />
alle più alte cariche <strong>del</strong>lo stato era particolarmente<br />
oneroso. Infatti, se osserviamo i nomi<br />
dei consoli che si sono succeduti nel periodo<br />
repubblicano, fino alla fine <strong>del</strong> II sec. a.C, vediamo<br />
che appartengono quasi tutti ad un numero<br />
ristretto di gentes, una quindicina. Il seguito di<br />
popolarità e di clientele era conseguenza <strong>del</strong><br />
potere economico <strong>del</strong>la famiglia cui apparteneva<br />
l’aspirante magistrato.<br />
L’impegno richiesto dalle funzioni pubbliche<br />
era gravoso. Marco Terenzio Varrone, reatino,<br />
(116-27 a.C.), personaggio eminente per erudizione,<br />
nella sua opera De Lingua Latina (6.46)<br />
scrive testualmente: curare a cura dictum. Cura<br />
quod cor urat. (Curare si dice da cura. Cura perché<br />
brucia il cuore). Da questo stesso etimo fa<br />
derivare anche Curia. È noto che le etimologie<br />
varroniane sono piuttosto bizzarre e fantasiose e<br />
perciò il più <strong>del</strong>le volte non possono essere<br />
prese per buone, nondimeno la spiegazione fornita<br />
dallo studioso latino, pure se errata, è idonea<br />
a darci un’idea <strong>del</strong>l’impegno, anche emotivo,<br />
che i cives mettevano nello svolgimento dei<br />
compiti connessi con l’attività di magistrato e<br />
con le responsabilità che ne derivavano e quali<br />
preoccupazioni avessero di ben figurare di fronte<br />
ai concittadini. Lo stesso concetto, con le stesse<br />
parole, è ripetuto, più di due secoli dopo, da<br />
Sesto Pompeo Festo, che evidentemente segue<br />
Varrone e ne ritiene valida la spiegazione, nel<br />
suo lavoro De Verborum Significatu. Non posso-