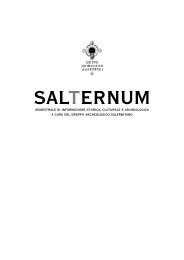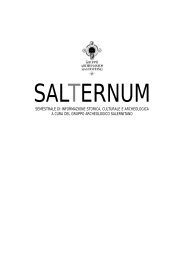Download del file - Gruppo Archeologico Salernitano
Download del file - Gruppo Archeologico Salernitano
Download del file - Gruppo Archeologico Salernitano
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
SALTERNUMSEMESTRALE DI INFORMAZIONE STORICA, CULTURALE E ARCHEOLOGICAA CURA DEL GRUPPO ARCHEOLOGICO SALERNITANO
REG. TRIB. DI SALERNON. 998 DEL 31/10/1997ANNO XV - NUMERO 26-27GENNAIO/DICEMBRE 2011
Premio ‘Nicola Fierro’Concorso bandito dal <strong>Gruppo</strong> <strong>Archeologico</strong> <strong>Salernitano</strong>per il miglior saggio originale su un tema di Archeologiadi area campana in età antica o medievale
PREMIO NICOLA FIERROPremio ‘Nicola Fierro’CONCORSO BANDITO DAL GRUPPO ARCHEOLOGICO SALERNITANOPER IL MIGLIOR SAGGIO ORIGINALESU UN TEMA DI ARCHEOLOGIA DI AREA CAMPANA IN ETÀ ANTICA O MEDIEVALE- PRIMA EDIZIONE -Venerdì, 15 luglio 2011, a Bisaccia, nellasede <strong>del</strong> Museo Civico <strong>Archeologico</strong>, sala‘Federico II’, si è svolta la premiazione<strong>del</strong> Concorso ‘Nicola Fierro’, durante la quale sonostati conferiti i premi istituiti dal <strong>Gruppo</strong> <strong>Archeologico</strong><strong>Salernitano</strong> per ricordare la figura <strong>del</strong> professore,Ispettore onorario <strong>del</strong> Ministero per i Beni e leAttività Culturali e appassionato cultore di studi classici,recentemente scomparso.L’Associazione, di cui il prof. Nicola Fierro fuSocio Fondatore e Direttore Tecnico, e la famiglia,con il Patrocinio <strong>del</strong> Comune di Bisaccia, suo paesenatale, in collaborazione con la SoprintendenzaArcheologica di SA-AV-BN-CE, hanno voluto dedicarealla sua memoria un Premio, finalizzato ad incoraggiarei giovani allo studio <strong>del</strong>l’Antichità. I requisitiper la partecipazione erano i seguenti:- essere iscritti ad un Corso di Laurea (triennale omagistrale) od essere laureati da non oltre 2 annipresso una <strong>del</strong>le Università degli Studi <strong>del</strong> territorionazionale;- essere iscritti al <strong>Gruppo</strong> <strong>Archeologico</strong> <strong>Salernitano</strong>;- avere un’età non superiore ai 30 anni.La Giuria <strong>del</strong> Premio era composta dalla dott.ssaGabriella d’Henry - Direttore Scientifico <strong>del</strong>laRivista ‘Salternum’, da tutti i Membri <strong>del</strong> ComitatoScientifico <strong>del</strong>la Rivista e dal dott. Felice Pastore –Direttore <strong>del</strong> <strong>Gruppo</strong> <strong>Archeologico</strong> <strong>Salernitano</strong>.La cerimonia è stata preceduta dagli indirizzi disaluto <strong>del</strong> Sig. Sindaco di Bisaccia, dott. SalvatoreFrullone, che ha voluto ricordare con parole toccantila figura di questo illustre cittadino a cui sarà dedicatoprossimamente il Museo Civico <strong>Archeologico</strong>.Sono seguiti gli interventi <strong>del</strong> dott. Felice Pastoree <strong>del</strong>la dott.ssa Gabriella d’Henry. Particolarmentesignificativa è stata la partecipazione <strong>del</strong> dott.PierFrancesco Talamo, archeologo e amico personaledi Nicola, che ha voluto mettere in evidenza come ilruolo <strong>del</strong>l’ Ispettore Onorario, ricoperto per anni dalFierro, sia importantissimo per le Soprintendenze, cheproprio grazie a queste figure riescono a salvare interenecropoli e importanti siti archeologici dalladistruzione selvaggia dovuta sia all’ignoranza cheall’indifferenza anche di chi dovrebbe tutelare, aisensi <strong>del</strong>l’articolo 9 <strong>del</strong>la Costituzione, il Patrimoniostorico-artistico <strong>del</strong>la Nazione.Fig. 1 - Bisaccia (AV), Museo Civico. Premio ‘Nicola Fierro’ - tavolo <strong>del</strong>la Giuria: dasinistra, il dott. Salvatore Frullone, Sindaco di Bisaccia, la dott.ssa Gabriella d’Henry, ildott. Pier Francesco Talamo, il dott. Felice Pastore.Fig. 2 - Bisaccia (AV), Museo Civico. Premio ‘Nicola Fierro’ - La Sig.ra Angelina Mieleved. Fierro premia il vincitore, dott. Giovanni Vergineo.- 5 -
SALTERNUMLa cerimonia di premiazione ha inizio con la voce<strong>del</strong>la prof.ssa Angela Cherchi, che scandisce i nomidei vincitori.Il primo premio - Edizione 2011 - viene assegnatodalla Commissione <strong>del</strong> Comitato Scientifico <strong>del</strong>laRivista ‘Salternum’ al dott. Giovanni Vergineo per il suoarticolo Il culto di Mitra in Campania, «in riconoscimento<strong>del</strong>l’elevato contenuto culturale <strong>del</strong> saggio presentato».Al vincitore è stato consegnato un premio di €500,00 (Euro CINQUECENTO,00), una pergamena euna targa ricordo.A consegnare il premio è stata la sig.ra AngelinaMiele Fierro, moglie <strong>del</strong> compianto Nicola Fierro.Il secondo premio è stato attribuito ex-aequo alladott.ssa Elena Gigantino per il suo articoloArcheometria ed epigrafia: applicazioni sperimentali sulle iscrizionitardoantiche di Abellinum e alla dott.ssa MariannaMelfi per il suo articolo L’apporto <strong>del</strong>l’archeometria aglistudi epigrafici: l’esempio <strong>del</strong>le iscrizioni <strong>del</strong>la basilica paleocristianadi Abellinum - Atripalda (AV), «in riconoscimento<strong>del</strong>l’originalità dei contenuti scientifici dei saggi presentati».Una menzione di merito viene conferita alladott.ssa Rosanna Barone per il suo articolo IlComplesso di San Pietro a Corte in Salerno: restituzione in ‘3D’ <strong>del</strong>la fase tardoantica «in riconoscimento <strong>del</strong>la validaapplicazione <strong>del</strong>le tecnologie informatiche per la restituzionevirtuale di un bene archeologico».Vengono inoltre consegnati attestati di partecipazioneal dott. Ferdinando Ferraioli per l’articolo Un quattuorvirin una stele funeraria da Carife (AV); al dott.Giammatteo Funicelli per l’articolo La “Stele eburina”, unpotere su pietra. Testimonianze <strong>del</strong> Municipium eburinorumall’ombra <strong>del</strong>la romanità imperiale (II sec. d.C); alla dott.ssaGilda Napoli per l’articolo La Piana <strong>del</strong> Sele alla fine<strong>del</strong>l’Età <strong>del</strong> Rame: riflessioni per un inquadramento culturale.- 6 -
GIOVANNI VERGINEOIl culto di Mitra in CampaniaDa principio, come dice Eubulo,quando Zoroastro consacrò una caverna naturalesui monti vicino alla Persia, florida e ricca di sorgenti,in onore di Mithra, fattore e padre di tutte le cose,la caverna costituiva per lui una immagine <strong>del</strong> mondo,che Mithra creò, giacché le cose che vi erano dispostead intervalli appropriati portavano i simbolidegli elementi e <strong>del</strong>le regioni <strong>del</strong> mondo.Porfirio, L’antro <strong>del</strong>le ninfe, VI.La Campania è storicamente una <strong>del</strong>le regionipiù intensamente ‘abitate’ dalle divinitàorientali. L’importanza <strong>del</strong>lo scalo diPozzuoli, che fu il principale porto commerciale inItalia dal II sec. a. C. fino alla costruzione <strong>del</strong> portotraianeo presso Ostia nel II sec. d. C., ha infatti sempreattratto mercanti, compratori, operatori commercialidi vario tipo da tutto il bacino <strong>del</strong> Mediterraneo 1 .Le idee, come è noto, spesso seguono le merci, ecosì fanno anche le divinità. Il meltin’ pot flegreo eraluogo naturalmente predisposto ad accogliere fe<strong>del</strong>i diogni provenienza e razza, i quali portavano con séabiti culturali e cultuali. Altre volte invece furono i mercatorescampani che operavano in contesti commercialiparticolarmente ‘vivi’ (come ad esempio l’isola grecadi Delo) a trovarsi esposti alle più varie influenze culturalie religiose. Talvolta essi stessi imparavano avenerare divinità straniere, per le quali talvolta edificavanotempli anche in patria: è il caso degli dèi egizi, ilcui culto giunse a Pozzuoli nel II sec. a. C. insieme aimercanti campani che operavano nell’Egeo.Nonostante la grandissima quantità e qualità dimateriale archeologico legato ai culti orientali inCampania, tuttavia, bisogna segnalare la scarsa presenzain questa area geografica di reperti relativi al cultodi Mitra, divinità di origine indo-iranica venerata inOccidente a partire dall’inizio <strong>del</strong> II sec. d. C. 2 Il motivoper cui le attestazioni ‘mitraiche’ in Campania sonoquantitativamente più esigue rispetto a quelle relative,ad esempio, al culto <strong>del</strong>la Grande Madre o di Iside, èforse da collegare all’arco cronologico durante il qualeil Mitraismo trovò diffusione, che coincide con la paraboladiscendente <strong>del</strong> porto puteolano, gradualmente marapidamente soppiantato da quello ostiense durantel’età antonina. Non è possibile però trarre conclusioniex silentio sulla limitata diffusione in questa regione <strong>del</strong>Mitraismo, soprattutto perché, come avremo modo diesporre nel corso <strong>del</strong>la trattazione, il dio Mitra nongodette mai di un culto pubblico presso i Romani e fusempre venerato da un ristretto numero di persone.E’ proprio in Campania, tuttavia, che troviamouno dei monumenti mitraici più importanti e meglioconservati di tutto l’Orbis Romanus: il mitreo affrescatodi S. Maria Capua Vetere, la cui esegesi costituirà laparte più considerevole di questa trattazione.Il MitraismoIl Mitraismo è una religione ‘orientale’?Tradizionalmente, il Mitraismo è inserito all’interno<strong>del</strong>le cosiddette religioni ‘orientali’, definizione cheaccorpa culti di diversa natura, provenienza, cronologia,tipologia entrati in contatto con il mondo romanoe praticati anche da cittadini romani 3 ; essi formano uninsieme eterogeneo e vario e sono a volte accomunatida una ‘generica’ provenienza orientale e da un forteesotismo nell’iconografia o anche solo nella liturgia,cosa che le distingue dalla religione greco-romana.In questa categoria si inseriscono il culto <strong>del</strong>laGrande Madre, di Iside, di divinità arabe e siriane qualiIuppiter Damascenus, Iuppiter Dolichenus e così via. Ladefinizione ‘orientale’ porta però a facili fraintendimenti:in queste religioni, infatti, di orientale c’è- 7 -
SALTERNUMsoprattutto l’origine <strong>del</strong>le divinità venerata e – talvolta– parte <strong>del</strong>l’iconografia o <strong>del</strong>la pratica rituale. Esseperò hanno subito tutte una profonda ‘occidentalizzazione’e una serie di trasformazioni che ne hanno permessol’accettazione presso i cittadini romani ed unalarga diffusione nell’ambito <strong>del</strong>l’Impero: seguendo l’esempiodi Walter Burkert, sarebbe forse più correttochiamare queste religioni ‘di origine orientale’ 4 .Tuttavia, la terminologia usata comunemente non èfrutto di una scelta arbitraria o di una classificazioneaccademica: anche gli Antichi, infatti, percepivanoqueste manifestazioni religiose come facenti parte diun sistema ‘diverso’ da quello <strong>del</strong>la religione grecoromana,differenza che l’identificazione di molte divinitàegizie, frigie, siriache con gli dei ‘classici’ e persinol’inserimento di alcune loro festività all’interno <strong>del</strong>calendario ufficiale non hanno contribuito ad eliminare.L’esotismo che caratterizza questi culti rappresentauna componente essenziale <strong>del</strong> loro successo, e ancheuno degli aspetti più criticati dai loro osteggiatori 5 .In che misura il Mitraismo può essere consideratouna religione ‘orientale’? Nonostante il dio Mitra siaeffettivamente di origine iranica, l’inserimento <strong>del</strong> suoculto in questa categoria pone dei problemi: gli studiosimoderni fanno infatti fatica a seguire tutte le tappe<strong>del</strong> fil rouge che lega l’originario contesto indo-iranicoal successivo - e profondamente diverso - fenomenoreligioso d’età romana.Nonostante molti elementi di origine iranica possanoessere individuati all’interno <strong>del</strong> Mitraismo romano,esso differisce dal suo precedente iranico per moltiaspetti, in primo luogo la liturgia. Mentre nel primocaso abbiamo un culto di stato, ben inserito nell’ambito<strong>del</strong>la religione ufficiale e celebrato da sacerdotiappositamente preposti, nel secondo ci troviamo difronte a un religione esclusivamente misterica, senzaindizi che facciano pensare a una liturgia giornaliera ecelebrato in ambienti oscuri, nascosti, segreti e piccoli:i mithraea.Fin dall’inizio dei moderni studi sull’argomento, glistorici <strong>del</strong>le religioni, con l’aiuto dei dati storici earcheologici, hanno tentato di riempire il ‘vuoto storico’che separa il culto di stato iranico dalla religione dimistero romana. Uno degli interrogativi di più difficilesoluzione resta il perché ed in che modo ilMitraismo, originariamente privo di elementi misterici,sia evoluto in un culto esclusivamente misterico, profondamentediverso dal precedente persiano.Una <strong>del</strong>le notizie più interessanti riguardo la genesidei riti misterici di Mitra è riferita da Plutarco il quale, aproposito <strong>del</strong>la vittoria conseguita da Pompeo nel 67a. C. contro i pirati <strong>del</strong>la Cilicia, ricorda che questi‘compivano sull’Olimpo (in Licia) degli strani sacrifici evi celebravano in segreto dei misteri, tra i quali c’eraquello di Mitra che si è mantenuto fino ad oggi 6 ’.Robert Turcan ritiene che un culto misterico militaristae tipicamente maschile quale è il Mitraismo piùmaturo avrebbe potuto facilmente svilupparsi in unambiente come quello dei pirati, che combattevano adarmi impari contro l’Impero Romano, creando allostato serie difficoltà nei trasporti e nel commercio;banchetti comuni e giuramenti avrebbero avuto lafunzione di creare un senso di profonda unità e di galvanizzareil morale dei combattenti 7 . Nonostante questaipotesi sia tutt’altro che peregrina, il percorso cheha condotto l’iranico Mitra ad essere venerato nel sottosuolodi Roma è però ancora lungi dall’essere chiarificato8 .Un indizio circa il primo ‘arrivo’ <strong>del</strong> Mitraismo aRoma potrebbe essere costituito da un passo di Plinio,il quale afferma che il re d’Armenia Tiridate giunse aRoma nel 66 d. C. con un seguito di cavalieri Parti e diMagi per ricevere da Nerone l’investitura regale 9 ; il revolle adorare l’imperatore ‘come Mitra’ e Plinio, riferendosial medesimo episodio, riporta che Tiridate iniziòNerone ‘alle cene magiche’ 10 .Il dio nella grottaAlcune peculiarità nel rito e nella liturgia di Mitra,dio miracolosamente nato da una roccia 11 , hannoindotto diversi studiosi a non considerare il Mitraismoromano una religione nel senso comune <strong>del</strong> termine:esso infatti manca di ogni forma di ritualità pubblica edi eventi aperti anche ai non iniziati 12 .Il culto di Mitra era praticato – a quanto ne sappiamo- solo da uomini, i quali si riunivano in luoghiseminascosti chiamati spaelea (grotte, antri) costruitispesso all’interno di teatri, terme o altri edifici pubblici,talvolta ricavati all’interno di grotte naturali, e chepotevano ospitare in genere non più di trenta - quarantapersone.Quale che fosse la tecnica costruttiva, gli antrisacri questi venivano quasi sempre edificati seguendoun mo<strong>del</strong>lo comune. La caverna, di forma longitudinale,era solitamente coperta con volta a botte; architettonicamenteessa voleva riprodurre il luogo ove si- 8 -
GIOVANNI VERGINEORaggiungendo il primo grado si entrava a tutti glieffetti nel novero dei mystae: il Corax (corvo) è l’uccellooracolare per eccellenza, simbolo di Apollo e capacedi parlare come gli uomini. E’ il trait d’union fra ipiani <strong>del</strong>l’umano e <strong>del</strong> divino ed è presente nella mitoeraconsumato il mitico sacrificio <strong>del</strong> toro, centro <strong>del</strong>lamitologia e <strong>del</strong>la liturgia mitraica, a volte raffiguratosulla parete di fondo in un affresco 13 o a mosaico osotto forma di gruppo scultoreo. Ai lati <strong>del</strong>la cavernaerano disposti dei pancali su cui i fe<strong>del</strong>i potevanosedere e libare; l’abside era spesso sopraelevata a formareuna sorta di nicchia, collegata all’aula da pochiscalini. Al suo interno era sovente sistemata la statua<strong>del</strong> dio; dinanzi e anche dietro di questa erano postetavole per consacrare il cibo poi distribuito ai mystae.L’ambiente, illuminato da fiamme che bruciavano sualtari e bracieri, era a volte arricchito da sculture dipersonaggi intimamente connessi al dio e alla sua leggenda:il Leontocefalo e i dadofori Cautes e Cautopates.La cripta era solitamente preceduta da un vestiboloin cui era possibile indossare gli indumenti tipici diogni grado iniziatico; le dimensioni stesse dei mitrei,che pur variano considerevolmente da caso a caso,non superano però mai i 40-45 metri di lunghezza.La partecipazione al culto era trasversale: vi eranoammesse persone di rango e cultura elevata ma ancheschiavi; sembra invece che fossero escluse le donne.Dal punto di vista sociale una netta prevalenza avevanoi militari, che veneravano il dio persiano soprattuttonelle zone di frontiera.Mysteria Mitrae:il Mitraismo romano come religione misterica e misteriosoficaNon esistevano ‘semplici’ fe<strong>del</strong>i di Mitra: per avereaccesso allo spaeleum era necessario essere un iniziatoai misteri <strong>del</strong> dio iranico, un mysta, e si poteva entrarea far parte di questo ristretto gruppo solo dopo aversuperato una o più prove.E’ questa una caratteristica unica nell’ambito <strong>del</strong>lereligioni antiche; di solito, infatti, l’iniziazione era unascelta personale, che poneva l’iniziato ad un livellosuperiore rispetto ai semplici fe<strong>del</strong>i. Non si trattavaperò di una scelta obbligata: era anzi praticata da unnumero ristretto di persone in quanto richiedeva unintenso sforzo personale (preparazione al rito, astinenza)ed economico 14 .Nella liturgia mitraica invece non abbiamo nessunacomponente ‘pubblica’: tutto si svolge all’interno <strong>del</strong>lospaeleum, secondo un gioco di ruoli che segue la rigidagerarchia iniziatica. Ogni fe<strong>del</strong>e è inserito in una determinatacategoria, in un determinato ‘grado’ iniziaticoche lo qualifica, e svolge una funzione che è tipica diquel livello.La ‘conoscenza’ <strong>del</strong> dio avveniva attraverso unduplice coinvolgimento, emotivo e razionale. Se da unlato era infatti necessario partecipare con il corpo aduna prova, ad un’ ‘impresa’, il sistema semantico <strong>del</strong>Mitraismo suggerisce una grossa complessità dei rituali,che molto probabilmente prevedevano uno studio,una preparazione <strong>del</strong> mysta e, soprattutto, il più assolutoriserbo circa il contenuto dei misteri. E’ questo unodei motivi per cui il Mitraismo è definito non solo‘religione misterica’ ma anche ‘misteriosofica 15 ‘: mentrenella liturgia degli altri culti ‘di mistero’ (Iside,Eleusi, Samotracia e così via) si conferisce estremaimportanza al rito e al significato che esso riveste nellapratica iniziatica, vissuta come apprendimento <strong>del</strong>lepene <strong>del</strong> dio ‘in vicenda’ mediante la rituale riproposizione<strong>del</strong>le sue disavventure, i culti misteriosofici invecedanno maggiore importanza alla sophia e alla dottrina:l’iniziazione e l’avanzamento attraverso i gradi iniziatici,infatti, più che sulla mera ritualità e sull’empatiafra la divinità e l’uomo, avviene mediante l’apprendimentodi determinate conoscenze precluse ai noniniziati.Come nell’Orfismo e nel Pitagorismo, il mathein hala stessa importanza <strong>del</strong> pathein, se non addiritturamaggiore.I sette gradiPeculiare <strong>del</strong> culto mitraico è l’inserimento deife<strong>del</strong>i in una rigida gerarchia, composta da sette gradiiniziatici ognuno dei quali collegato con un corpo celeste:la ‘carriera’ dei fe<strong>del</strong>i prevedeva quindi un’ ascensioneattraverso sette livelli secondo modalità che tuttaviaancora ignoriamo. Il cursus degli iniziati si articolavasecondo il seguente schema 16 :1. CORAX (corvo) MERCURIO2. NYMPHUS (sposo) / CRYPHIUS (nascosto) VENERE3. MILES (soldato) MARTE4. LEO (leone) GIOVE5. PERSES (persiano) LUNA6. HELIODROMUS (messaggero <strong>del</strong> Sole) SOLE7. PATER (padre) SATURNO- 9 -
SALTERNUMlogia mitraica quale messaggero checomunica al dio persiano il compitoassegnatogli dal Sole: l’uccisione <strong>del</strong>toro 17 .Il Nymphus è lo ‘sposo’ che almomento <strong>del</strong>l’iniziazione era tenuto aindossare un velo come quello portatodalle donne romane nel giorno <strong>del</strong>matrimonio, il quale veniva poi toltoper scoprire il viso nel corso <strong>del</strong> rituale.La simbologia legata al Nymphusnel mitreo ostiense di Felicissimo (sucui sono raffigurati un diadema e unalampada) rimanda al mondo <strong>del</strong>matrimonio, forse alla ierogamia fraAmore e Psiche intesa come ‘matrimonio<strong>del</strong>l’anima’ 18 .Il rito per la consacrazione <strong>del</strong>Miles era caratterizzato dal rifiuto<strong>del</strong>la corona, offerta all’iniziando conla spada, che egli doveva rifiutare diporre sul capo pronunciando la formula‘Mitra è la mia corona’ e lasciandoche gli venisse deposta sulle spalle19 . I simboli relativi a questo gradosono il giavellotto, il sacco che i militariportavano sulle spalle e l’elmo.Il grado di Leo è caratterizzatodalla simbologia <strong>del</strong> fuoco: nel mitreodi Felicissimo esso è indicato dall’attizzatoio,dal sistro (elemento mutuatodai culti isiaci) e dalla folgore <strong>del</strong>fuoco divino. Le mani <strong>del</strong> mysta erano immerse nelmiele, spalmato poi anche sulla lingua per purificarloda tutti i ‘peccati’ 20 ; le api erano considerate sacre daife<strong>del</strong>i, poiché secondo il mito esse erano nate dalcorpo <strong>del</strong> sacro toro 21 .Anche le mani <strong>del</strong> Perses erano asperse di miele, macon un altro significato simbolico: egli era il guardianodei frutti, inteso come custode <strong>del</strong>la natura rinata dalsangue <strong>del</strong> toro; il miele infatti è ‘custode’ <strong>del</strong>lo zucchero.I simboli <strong>del</strong> Persiano sono la mezzaluna (era ilgrado protetto dalla Luna), la stella, la falce e il falcetto,che lo collegano al mondo agrario da una parte, ea Mitra dall’altra (il quale è a volte raffigurato comemietitore o raccoglitore di frutti 22 ).Sul rito dedicato all’Heliodromus non disponiamo dialcuna informazione; i suoi simboli sono la coronaFig. 1 - S. Maria Capua Vetere. Il mitreo. Vedutad’insieme.Fig. 2 - S. Maria Capua Vetere. Il mitreo. Pianta (daVERMASEREN 1971).radiante, la torcia e la sferza <strong>del</strong> Sole;indossava un cappello broccato, similea quello <strong>del</strong> dio, che era indossatoanche dal sacerdote di rango più elevato:il Pater 23 . Anche su quest’ultimole notizie in nostro possesso sonoestremamente scarse: probabilmentepoteva essere consacrato solo da unaltro Padre o da un Pater Patrum, titoloraro, ma attestato a Roma, Ostia eDura Europos, che forse indica un personaggioal di fuori <strong>del</strong> normale cursuslegato alle ‘Sette Sfere’ e la cuiautorità era riconosciuta da piùcomunità 24 . I simboli <strong>del</strong> Pater sonol’anello, la canna (simbolo di sapienza)e la falce, attributo che lo collegadirettamente al dio protettore di questogrado: Saturno. Il Padre aveva ilcompito di gestire la comunità ed erapreposto alle cerimonie iniziatiche inqualità di Pater Sacrorum 25 .Il passaggio da un grado all’altroera un evento importante, e richiedevaadeguata preparazione: i mystaedovevano innanzitutto purificarsi conl’acqua (sostituita dal miele per il Leoe il Perses), quindi affrontare una seriedi dure prove che consistevano nelsopportare il fuoco, il freddo, la fame,la sete e ‘un grande vagare’ 26 ; non sappiamose si tratti di forme puramenterituali di sofferenza o se davvero fosse necessario subireil dolore per essere degni di accedere all’universomitraico.L’iniziazione era reiterata ogni volta che si accedevaa un nuovo grado; non sappiamo che cosa comportasseil raggiungimento <strong>del</strong> grado finale, e se esso fosseutile alla salvezza in senso escatologico; l’escatologianei culti orientali è una vexata quaestio, in alcuni casi didifficile soluzione: nonostante alcune iscrizioni presentinei mitrei inducano a ipotizzare il raggiungimento<strong>del</strong>la salvezza post-mortem, dovuta al sacrificio benefico<strong>del</strong> toro, è difficile essere più precisi in tal senso:il Mitraismo, come <strong>del</strong> resto tutte le altre religioniorientali, manca di testi espliciti in merito. Le ipotesidegli studiosi sono a volte opposte: basti qui ricordarequella <strong>del</strong> Burkert, il quale nega ogni forma di ruolo- 10 -
GIOVANNI VERGINEOescatologico alle religioni di mistero, e quella di GiuliaSfameni Gasparro, che invece vede nella ‘scala’ mitraicaun percorso ascensionale verso la salvezza <strong>del</strong>l’anima27 .2. Il mitreo di S. Maria Capua Vetere (fig. 1)Lo spelaeum sito nell’antica città campana 28 , scopertonel 1922, si trova in uno dei criptoportici che sorgononei pressi <strong>del</strong> Capitolium urbano, vicino alla chiesadi S. Erasmo in Capitolio. L’antro, costruito probabilmenteall’inizio <strong>del</strong> II sec. d. C., alla fine <strong>del</strong>Paganesimo non fu distrutto dai Cristiani, che si limitaronoa riempirlo di detriti impedendone quindi l’accesso29 ; tale operazione ha permesso un’ottima conservazionedegli affreschi. Il mitreo è orientato secondol’asse est-ovest e misura m 12,27 in lunghezza, m3,49 in larghezza e m 3,37 in altezza; è preceduto daun vestibolo orientato nord-sud, privo di decorazioni,lungo m. 13,32, largo m 4,41; ciascuna <strong>del</strong>la paretilaterali è scandita in due parti da un pilastro che vi siaddossa (fig. 2). Il vestibolo veniva usato dai fe<strong>del</strong>i perspogliarsi dei vestiti quotidiani e indossare gli abitirituali; inoltre fungeva da diaframma fra il mondoesterno e l’antro vero e proprio, funzione importantedato il carattere segreto dei riti in esso praticati 30 .L’intera superficie <strong>del</strong>la grotta sacra è affrescata: lavolta è decorata con stelle a otto punte di colore rossoo blu, ognuna inscritta in un cerchio, al centro <strong>del</strong>lequali era posizionata una gemma in vetro o una pietrapreziosa; lo sfondo è di colore giallo scuro. La lucepenetrava attraverso tre finestre bordate in rosso, ricavatesul lato sud <strong>del</strong>la navata. Ai lati di questa, pavimentatain cocciopesto con frammenti di marmo inseriti,due lunghi pancali (praesepia) in muratura sonoaddossati alle pareti laterali: essi, che occupavano unaparte limitata <strong>del</strong>le pareti, sono stati ampliati in unmomento successivo alla costruzione <strong>del</strong> mitreo, inmodo da fiancheggiarne i lati lunghi per tutta la lunghezza.L’ampliamento dei pancali in senso longitudinaleha provocato la copertura <strong>del</strong>la parte inferiore<strong>del</strong>le pareti affrescate.La fronte dei banconi, rivolta vero il centro <strong>del</strong>lanavata, è dipinto con scenette di iniziazione. Il praesepiumlungo la parete sud ospita un piccolo bacino per l’acqualungo m 1, 28, largo m 0, 67 e profondo m 0,55;quello settentrionale ne ospita uno simmetrico, leggermentepiù grande e comunicante con un ampio pozzetto.Sulla faccia esterna di ciascun bacino è ricavataFig. 3 - S. Maria Capua Vetere. Mitreo. Affresco raffigurante la tauroctonia (parete est).una piccola nicchia rettangolare, forse usata per stipareoggetti per il culto. I pancali terminavano in piccoliscalini verso il fondo <strong>del</strong>la sala, sul lato est, interamenteoccupato dall’affresco raffigurante la tauroctonia;immediatamente al di sotto di questo sorge trovaun podio largo m 2, 83, profondo m 1, 57 e leggermentepiù alto de banconi laterali. Nella parte piùesterna di questo è ricavata una stretta conduttura checomunicava con il bacino <strong>del</strong>la parete nord.Dallo studio degli affreschi e <strong>del</strong>le strutture, ilVermaseren ha ipotizzato che il santuario, probabilmentein uso dall’inizio <strong>del</strong> II alla fine IV sec. d. C.,abbia avuto almeno tre fasi evolutive, individuabiligrazie ad alcuni indizi.Fase I (prima metà <strong>del</strong> II sec. d. C.): si edifica ilmitreo all’interno <strong>del</strong> criptoportico già esistente. Soloun affresco, palesemente più antico degli altri, è rimastoa testimoniare lo stile decorativo di questa primafase: si tratta <strong>del</strong> pannello ‘a’ sul muro nord, in cui èraffigurato il banchetto sacro fra Mitra e Sol.Fase II (periodo antonino): si rinnova il programmafigurativo <strong>del</strong>l’antro, decorando la parete ovest conla tauroctonia (fig. 3) e la parete est con l’affresco <strong>del</strong>laLuna su carro (fig. 5). Si dipinge la volta stellata.Fase III (inizio <strong>del</strong> III sec. d. C.): si allungano i praesepiain modo che questi occupino tutta la parte bassa<strong>del</strong>le pareti laterali; sulle fronti, verso l’interno, sidipingono le scene di iniziazione.Parete ovest: la tauroctonia.La navata ovest è decorata con la scena di sacrificio<strong>del</strong> toro (fig. 3), concepita secondo i canoni <strong>del</strong>l’iconografiamitraica: il dio, vestito di una corta tunicamanicata rossa con gli orli in verde e giallo, colori che- 11 -
SALTERNUMritroviamo in tutti gli indumenti, indossa il cappellofrigio, il mantello, i tipici pantaloni persiani (anaxyrides);calza <strong>del</strong>le scarpe gialle. La tauroctonia è ilmomento topico <strong>del</strong> mito mitraico, ma non sappiamose questo sacrificio fosse poi effettivamente ripetutodai fe<strong>del</strong>i all’interno <strong>del</strong>la grotta. E’ molto probabileche non lo fosse e che anzi essi si limitassero a celebrarenon un sacrificio vero e proprio ma il ricordo diun sacrificio, differenziandosi in questo modo dallapratica <strong>del</strong> culto pagana ed avvicinandosi, al contrario,all’Eucaristia cristiana. Il Cristianesimo non rinuncia alsacrificio: semplicemente, esso si limita a reinterpretarloe, soprattutto, a ricordarlo. L’anamnesis <strong>del</strong> sacrificioumano di Cristo, al tempo stesso sacerdote e vittima,è al centro <strong>del</strong>la liturgia cristiana e ne rappresentail momento di maggiore importanza. Non si tratta<strong>del</strong>la semplice rievocazione di un sacrificio: esso èofferto e riofferto sempre di nuovo nel corso <strong>del</strong>lapratica quotidiana <strong>del</strong> culto 31 . E’ in questo, più che inaltri elementi, che va forse cercata la similitudine fra ilCristianesimo ed il Mitraismo: in entrambi i casi si èrinunciato allo spargimento di sangue ed il centro <strong>del</strong>rituale non è l’offerta di un animale ma anzi il ricordo<strong>del</strong>l’offerta estrema (di Gesù per i cristiani, <strong>del</strong> toroper i mitraici). E’ forse per questo motivo che gli autoricristiani, al contrario di quanto facessero in relazioneai riti di Iside e <strong>del</strong>la Grande Madre, non accusavanoi devoti al dio persiano di eseguire sanguinosi sacrificima di imitare in modo sacrilego l’Eucaristiamediante l’uso rituale di acqua, vino e pane 32 ; ancheTertulliano, la cui conoscenza profonda dei misterimitraici ha fatto ipotizzare la sua parentela con unmysta <strong>del</strong>la divinità iranica, usa la parola oblatio, tipica<strong>del</strong>la terminologia cristiana, per indicare il consumorituale – in questo caso blasfemo - <strong>del</strong> pane nell’ambito<strong>del</strong>la liturgia mitraica 33 .Il dio è raffigurato nell’atto di sacrificare il toro biancoall’interno <strong>del</strong>la grotta, che si staglia netta sullo sfondopiù chiaro <strong>del</strong> cielo. Mitra poggia il ginocchio sinistrosul dorso <strong>del</strong>l’animale mentre con la mano sinistra gliafferra le narici torcendogli il collo verso l’alto; contemporaneamente,con la mano destra, affonda il coltellonel fianco <strong>del</strong>la bestia, voltandosi indietro a guardare ilSole. Il toro bianco, colpito a morte, si accascia al suolo;dalla sua coda nasce una spiga di grano. Un cane lecca ilsangue che copioso esce dalla ferita; un lungo serpenteche striscia in primo piano volge la testa verso la feritaaperta. Uno scorpione di colore giallo si attacca ai testicoli<strong>del</strong> bovide. Un corvo assiste, in alto alla scena dallato sinistro <strong>del</strong>la grotta. Poco più a sinistra è presente,all’esterno <strong>del</strong>la grotta, il dio Sole visibile di tre quarti,intento a osservare attentamente il sacrificio (fig. 4): èvestito di una clamide purpurea fissata alla spalla destracon una fibula dorata. Dalla sua testa partono undiciraggi, di cui uno giunge a colpire il dio nella caverna.Nella mano destra reca un sferza, come un auriga.Dalla parte opposta <strong>del</strong>la composizione è visibile laLuna, giovane dea dagli occhi scuri e carnagione chiara,con lunghi capelli raccolti e cinti da un diadema d’orodecorato con una gemma ovale (figg. 5-6); una mezzalunabianca si staglia sullo sfondo. Al di sotto di ciascunadivinità astrale, ai lati di Mitra, si notano i dadoforiCautes e Cautopates (figg. 7-8); il primo, in piedi a sinistra,alza una torcia con la mano destra mentre nellasinistra reca un arco; è vestito con una corta tunica manicatagialla dagli orli decorati in verde. Indossa il cappellofrigio, decorato con una stella dorata, e un mantellobordato in oro, entrambi rossi. Gli anaxyrides, al disottoFig. 4 - S. Maria Capua Vetere. Ritratto, particolare <strong>del</strong>la raffigurazione <strong>del</strong> Sole nellascena di tauroctonia.Fig. 5 - S. Maria Capua Vetere. Mitreo. Affresco raffigurante la Luna su carro (pareteovest).- 12 -
GIOVANNI VERGINEOdei quali si scorgono le scarpe rosse,presentano colore e decorazionesimile alla tunica.Cautopates è in piedi nella partedestra <strong>del</strong>la composizione; similmentea Cautes reca una torcia e unarco, ma la torcia è abbassata. Il suoabbigliamento consiste in una cortatunica manicata grigia, con orli edecorazioni in verde; il cappello èrosso ma non presenta decorazioni;gli anaxyrides e il mantello sono<strong>del</strong>lo stesso colore <strong>del</strong>la tunica.Entrambe le divinità sono atteggiate in modo da renderel’idea di una loro partecipazione alla cerimoniasacrificale che si svolge al centro <strong>del</strong>la scena. Dallaterra emergono due teste: l’una, pertinente ad unadivinità marina (probabilmente Oceanus) fa capolinoall’estrema sinistra <strong>del</strong>la composizione (fig. 9); l’altra,che invece appartiene ad una divinità <strong>del</strong>la terra(Tellus?) spunta da destra (fig. 10). Il dio marino èbarbato, con una chioma bluastra scompigliata da cuiemergono due chele di granchio o due corni; con igrandi occhi blu spalancati osserva il rito sacrificale;dall’altra parte, la dea volge il viso ovale verso il centro<strong>del</strong>l’azione; ha i capelli di colore grigio-blu egrandi occhi azzurri.La portata cosmica <strong>del</strong>la tauroctonia è evidente edenfatizzata dalla presenza <strong>del</strong> Sole e <strong>del</strong>la Luna, diOceanus e Tellus: si tratta di un evento benefico pertutto l’universo che si inserisce in un racconto mitico,oscuro per noi sotto molti punti di vista. L’uccisione<strong>del</strong> toro provoca la rinascita <strong>del</strong> grano, e dal suo sangueattingono nutrimento il cane ed il serpente. Loscorpione ha invece probabilmente una connotazionenegativa, ed attaccando i testicoli <strong>del</strong> bovide vuoleforse ostacolare il principio di fecondità che la suamorte sta liberando.Cautes e Cautopates sono sicuramente personaggiimportantissimi nella mitologia e nella liturgia mitraica:uno alza la torcia forse a simboleggiare l’alba, l’altroinvece la abbassa per indicare il tramonto. Insiemea Mitra che, trovandosi nel mezzo, incarna la luce <strong>del</strong>meriggio e <strong>del</strong> giorno pieno, essi formano una sorta ditriade: potrebbero essere interpretate come incarnazione<strong>del</strong>la sostanza divina <strong>del</strong> dio, che condividono 34 .La tauroctonia di Capua presenta alcune caratteristichepeculiari, individuate dal fondamentale studio<strong>del</strong> Vermaseren 35 , cui si fa riferimentoper questa parte <strong>del</strong>la trattazione.In Italia solo a S. Maria CapuaVetere si riscontra l’arco quale attributodi Cautes e Cautopates; altreattestazioni é possibile trovarle solonell’Europa <strong>del</strong> Nord 36 . Esiste soloun altro documento in cui compaionoentrambe le divinità con laFig. 6 - Particolare <strong>del</strong>la raffigurazione <strong>del</strong>la Luna nella torcia e l’arco: si tratta di un rilievoscena di tauroctonia.proveniente da Potaissa, in Dacia; laloro posizione è però inversa:Cautes è a destra, Cautopates a sinistra <strong>del</strong> dio. Secondol’interpretazione <strong>del</strong> LeRoy Campbell 37 , riportata dalVermaseren, questo è dovuto al fatto che l’iconografia<strong>del</strong>l’affresco capuano è legata al tipo ‘orientale’ <strong>del</strong>dadoforo, che induce a ipotizzare una forte influenzairanica nel culto, mentre invece il rilievo dacico è legatoal mo<strong>del</strong>lo ‘occidentale’. Tuttavia i due paredri diMitra, nell’ambito <strong>del</strong>l’antro capuano, compaionoanche secondo l’ordine ‘occidentale’: sulla parete sud,è infatti raffigurato Cautopates, mentre sulla paretenord è visibile Cautes (fig. 11).L’opinione di LeRoy Campbell è che la tauroctoniasia più antica <strong>del</strong>le decorazioni parietali, e risenta maggiormente<strong>del</strong>l’influenza mediorientale; il Vermaserenha tuttavia dimostrato che le due pitture sono contemporaneee sono state eseguite probabilmente nelperiodo antonino 38 . Il motivo per cui i due gemellisono raffigurati in modo diverso nello stesso contestoFig. 7 - Cautes raffigurato nella scena ditauroctonia.Fig. 8 - Cautopates raffigurato nella scenadi tauroctonia.- 13 -
SALTERNUMè difficile da comprendere 39 ; resta tuttavia da sottolineareche l’iconografia mitraica, pur costituendo uninsieme coerente, è lungi dall’essere universale e cambianotevolmente anche in contesti fra loro vicini;questo è probabilmente dovuto al fatto che mancavaun’istituzione centrale, un clero che concertasse l’attivitàliturgica di ogni spelaeum, e i fe<strong>del</strong>i di ciascuno diessi agivano come cellule autonome di un sistemacomplesso e vario.Parete est: Luna su carroAltra particolarità <strong>del</strong> mitreo capuano è la presenza,nel lato opposto alla tauroctonia, di un affrescocon la Luna su una biga 40 ; la dea volge le spalle all’osservatorenell’atto di correre via, sparendo gradualmentenella foschia. Ella è abbigliata solo di una leggeraveste trasparente, che svolazzando per la velocitàlascia gran parte <strong>del</strong> corpo scoperto. I capelli, castani,sono raccolti in uno chignon e la testa è decorata da undiadema, non chiaramente visibile data la posa <strong>del</strong>lafigura; nella sinistra stringe la sferza, mentre con ladestra conduce i cavalli, uno di colore bianco, l’altroscuro. Del carro, raffigurato di scorcio, è visibile solouna ruota. Il cielo stellato sovrasta l’intera scena,inquadrata in una lunetta bordata di rosso.Il motivo <strong>del</strong>la Luna raffigurata mentre si allontanasul carro verso l’oscurità è unico nell’arte mitraica,e probabilmente anche nell’arte romana. La dea sulcarro è presente in altre opere ispirate alla religioneiranica, ma nessuna di esse presenta l’audace punto divista e la <strong>del</strong>icata resa dei dettagli atmosferici <strong>del</strong>l’affrescocampano: si tratta di un’opera unica, posiziona-ta sul lato opposto alla tauroctonia come a voler sottolineareed enfatizzare, per opposizione, il caratteresolare di Mitra.Sulla stessa parete, al di sotto <strong>del</strong>l’affresco piùgrande, si notano le tracce di una figura alta, stante,rappresentata frontalmente; ha i capelli corti e indossaun cappello e una tunica rossi.Pareti laterali (fig. 12)La parete nord è divisa in cinque grandi pannelli dalarghe linee rosso scuro, in cui sono raffigurati diversipersonaggi; per motivi di brevità sarà opportunodescrivere qui solo la decorazione <strong>del</strong> pannello ‘b’, cheospita una figura di Cautes (fig. 11) in piedi fra duepiante d’alloro i cui rami, incrociandosi, formano unasorta di arco vegetale sopra la sua testa; le gambe sonoincrociate secondo lo stile ‘occidentale’ 41 . Il dio indossauna tunica manicata corta, il cappello frigio, il mantelloe gli anaxyrides tipici dei Persiani. Con la manodestra solleva una torcia verso un altare fumante; lamano sinistra, abbassata, stringe un ramo; alla sinistra<strong>del</strong>la figura si nota un gallo dalla cresta rossa. La suafigura fa da compendio alla rappresentazione, sullaopposta parete sud, di Cautopates 42 . Il dio, abbigliatocome il gemello e incorniciato dai rami d’alloro, tienenella mano destra una torcia, abbassata verso un altarefumante, mentre con l’altra mano stringe un falcetto.La parte inferiore <strong>del</strong> corpo, al di sotto <strong>del</strong>le ginocchia,è gravemente danneggiata.Il pannello ‘c’ <strong>del</strong>la parete sud è decorato anche conun bassorilievo in marmo bianco; esso è collocato al disotto <strong>del</strong> bacino e presenta il bordo dipinto di rosso 52 .Fig. 9 - Particolare <strong>del</strong>la raffigurazione di dio marino nella scena ditauroctonia.Fig. 10 - Particolare <strong>del</strong>la raffigurazione di Tellus nella scena ditauroctonia.Fig. 11 - Cautes raffigurato in un affrescoin parete.- 14 -
GIOVANNI VERGINEOVi sono raffigurati Psiche alata ed Eros (fig. 13). La dea,di cui è offerta una visione frontale, ha le ali di farfallaspiegate; indossa un lungo chitone stretto in vita da unacintura e un mantello, di cui afferra un lembo sollevandolocon la mano destra. La sua capigliatura è sollevataa formare uno chignon sulla nuca. Il piccolo Eros, anch’eglirappresentato con le ali aperte, è nudo; è raffiguratodi tre quarti e tiene nella mano sinistra una torcia, mentrecon la destra tocca la schiena <strong>del</strong>la dea. La gestualità<strong>del</strong> dio e la posizione dei piedi di entrambe le figureinduce a pensare che egli sia sul punto di portare Psichecon sé, illuminandole la via con la torcia.Pancale nordNel I pannello <strong>del</strong> pancale nord, verso la parete est(fig. 15), è raffigurato in rosso un uomo nudo, bendato,che si dirige verso sinistra; la sua andatura è esitantee un personaggio alle sue spalle, di statura notevolmentemaggiore, sembra guidarlo e vigilare sui suoipassi 55 . E’ vestito di una tunica bianca corta e di unamantellina, anch’essa bianca ma bordata di rosso, chegli copre le spalle; una corta barba gli incornicia ilvolto. La scena è stata interpretata come l’introduzione<strong>del</strong> mysta da parte di un mistagogo (un Pater o uniniziato di rango inferiore) 45 .Nel II pannello (fig. 16) è raffigurato un uomonudo, con il solo ginocchio destro poggiato a terra, gliFig. 13 - Bassorilievo con Amore e Psiche.Fig. 12 - Schema degli affreschi sulle pareti nord e sud.Affreschi che decorano la fronte dei praesepia 43La parte anteriore dei pancali su cui sedevano imystae è decorata con scene che ritraggono probabilmentealcuni momenti dei riti iniziatici (fig. 14).Esse sono dipinte all’interno di pannelli a fondobianco, separati fra loro da strisce rosse verticali. Lostile di questi affreschi è molto diverso di quello <strong>del</strong>lepitture più grandi: le figure sono semplici, impressenell’intonaco con rapidi colpi di pennello in modo daformare <strong>del</strong>le silhouette rosse sullo sfondo chiaro 44 . Sidescriveranno solo i pannelli il cui stato di conservazionepermetta ancora di osservare le pitture, in alcunicasi completamente o quasi completamente svanite.Fig. 14 - Schema degli affreschi che decorano la fronte dei pancali.- 15 -
SALTERNUMocchi bendati e le mani legate dietro laschiena, assistito da un mistagogovestito come nella scena precedente 46 .Quest’ultimo tiene la mano destra sullatesta <strong>del</strong>l’iniziando, mentre da sinistrasopraggiunge un uomo con un elmocrestato, una tunica rossa e un mantello<strong>del</strong>lo stesso colore, il quale avvicinauna torcia al mysta. Il Vermaseren hainterpretato la scena come ‘prova <strong>del</strong>fuoco’ cui il mysta, aiutato dal mistagogoche l’aveva introdotto al tempio, èsottoposto dal Miles. La posizione inginocchiata,per l’iconografia romana, ètipica dei vinti e dei prigionieri: l’iniziandosi trova nell’umiliante condizionedi un nemico battuto, ed è alla totalemercé dei sacerdoti 47 .Fig. 15 - Scena di iniziazione (I pannello <strong>del</strong>pancale nord).Una terza figura è presente a sinistra, mail cattivo stato di conservazione <strong>del</strong>l’affresconon permette di distinguerne lecaratteristiche. La scena raffigurata, didifficile interpretazione, può costituiresemplicemente la prosecuzione <strong>del</strong>leprecedenti, raffigurando quindi una <strong>del</strong>lefasi <strong>del</strong>l’iniziazione 49 .Pancale sudLa fronte <strong>del</strong> pancale che poggiasulla parete sinistra è divisa in sette pannelli,di cui solo tre sono leggibili.Nel II pannello (fig. 18), danneggiatonella parte superiore sinistra, sonoraffigurati tre personaggi: <strong>del</strong> primo, inpiedi a sinistra, è visibile solo la parteinferiore, la parte superiore essendoFig. 16 - Scena di iniziazione (II pannello <strong>del</strong> pancale nord).Il IV pannello, molto mal conservato, mostra duepersonaggi in piedi nell’atto di abbracciarsi. L’uno ènudo, rigido, mentre l’altro curva la schiena nell’atto dibaciare la figura che gli sta di fronte in segno di salutoe di accoglienza. Una terza figura, più grande, sopraggiungeda sinistra: indossa una tunica rossa e una mantellache gli copre le spalle.Nel V pannello (fig. 17) è rappresentato un iniziatopiegato, con il solo ginocchio destro a toccare il suolo,senza più la benda a coprire gli occhi e con le bracciaora poggiate sulle cosce 48 . Vicino a lui giace a terra unaspada o un bastone. Il mistagogo, in piedi alle sue spalle,è vestito di una tunica bianca bordata di rosso. Eglitiene con entrambe le mani una corona ornata di banderosse, che sembra stia per poggiare sul capo <strong>del</strong> mysta.Fig. 17 - Scena di iniziazione (V pannello <strong>del</strong> pancale nord).stata coinvolta nel danneggiamento <strong>del</strong> pannello; egliè abbigliato con una corta tunica bianca decorata conlinee rosse verticali 50 . Il secondo personaggio, nudo,giace prono con le braccia e le gambe distese: è probabilmentel’iniziando. Nonostante l’immagine sia moltorovinata, è possibile individuare qualcosa che poggiasulla sua schiena: il Vermaseren ipotizza si tratti di unoscorpione, e che il rito prevedesse l’immedesimazionenel toro sacrificale da parte <strong>del</strong> neofita 51 . A destra, un- 16 -
GIOVANNI VERGINEOterzo uomo vestito di una tunica rossa si avvicina almysta: le sue braccia, distese, recano oggetti che non èpossibile distinguere.Nel III pannello (fig. 19) sono dipinti tre personaggi:la figura al centro, inginocchiata, poggia entrambele ginocchia a terra. Si tratta probabilmente <strong>del</strong> mysta,nudo, il quale tende le braccia verso un uomo a destra<strong>del</strong>la composizione; questi indossa una corta tunicarossa e un elmo crestato mentre con le mani avvicinauna torcia alle mani <strong>del</strong>l’iniziando. Dietro la figurainginocchiata è visibile la testa di un personaggio inpiedi, di cui si intravede anche la toga bianca a strisceverticali rosse, mentre tiene entrambe le mani sullespalle <strong>del</strong> mysta. Potrebbe trattarsi <strong>del</strong> mistagogo, ilquale spinge e incoraggia il neofita a sottoporsi aun’altra prova <strong>del</strong> fuoco, cui è preposto, come nellascena simile sulla parete di fronte, il Miles. Questi purificale mani <strong>del</strong>l’iniziando con il fuoco, secondo la praticariportata da Porfirio 52 .Nel IV pannello (fig. 20) si può notare il mysta inginocchio, nudo con le braccia incrociate sul petto,mentre con la mano sinistra porge al mistagogo, inpiedi dietro di lui, un contenitore, forse un rhyton 66 . Ilcelebrante indossa la consueta tunica bianca a striscerosse, e sembra versare un liquido da una coppa nelrhyton <strong>del</strong>l’iniziato. Dinanzi a questo è un uomo vestitocon una tunica e un mantello, entrambi di colorerosso; avanza verso il mysta recando un bastone nellamano destra e puntandolo verso un oggetto posato aterra, presso le ginocchia <strong>del</strong>l’iniziando 53 .L’analisi degli affreschi capuani conferma quantodetto all’inizio <strong>del</strong> presente paragrafo in merito ai problemiinterpretativi che pone l’iconografia mitraica.Ciò è valido soprattutto per le scene di iniziazione, perle quali è difficile trovare confronti non solo nellefonti scritte ma anche in quelle archeologiche, dato ilcarattere unico di queste pitture.Nonostante i colori <strong>del</strong> mitreo campano continuinoa sorprenderci, fatichiamo a dare un significato alleimmagini raffigurate, a comprendere il messaggio cheinvece era chiarissimo per tutti i mystae. Nonostante ildisprezzo dei primi autori cristiani e la loro noncuranzanel divulgare diversi dettagli sulle religioni misteriche,sembra che il segreto sui misteri di Mitra sia statoalla fine preservato, costringendo gli studiosi a restaresulla soglia <strong>del</strong>la grotta interrogandosi sui riti che vi sicelebravano e sul loro significato, che riusciamo aintravedere senza mai afferrare appieno.Nel nostro sforzo interpretativo, siamo costretti acondividere la frustrazione dei non iniziati, restando,seppur al di fuori <strong>del</strong>la caverna, all’oscuro.Fig. 18 - Scena di iniziazione (II pannello <strong>del</strong> pancale sud).Fig. 19 - Scena di iniziazione (III pannello <strong>del</strong> pancale sud).Fig. 20 - Scena di iniziazione (IV pannello <strong>del</strong> pancale sud).- 17 -
SALTERNUMNote1La bibliografia sull’argomento è sterminata;per una sintesi si rimanda allo studio,ormai classico, di V. Tran Tam Tinh (TRANTAM TINH 1972). Sul culto di Iside e <strong>del</strong>ledivinità egizie in Campania si veda anche ilcontributo <strong>del</strong>lo scrivente sul n. 24-25 diquesta Rivista (VERGINEO 2010).2CUMONT 1896-1899, I, p. 265.3Il primo uso di questa definizione si deve aFranz Cumont, fondatore dei modernistudi sul tema (CUMONT 1929).4BURKERT 1987.5Luciano di Samosata (120 d. C. ca. - post180 d. C.) è un caso esemplare: siraco di origine,romano per formazione e cultura nonchéper religione, nella sua Assemblea deglidèi, capp. 9-10, critica aspramente il ‘degrado’<strong>del</strong>l’Olimpo, invaso da déi stranieri:«Questo Attis, questo Coribante, questoSabazio da dove vengono? Chi è questoMedio Mitra, con il suo kandys [tipica vestepersiana] e la sua tiara? Egli non conosceuna parola di Greco. (...) E tu, Egizio dallafaccia di cane, come pretendi di essere unadivinità? Che vuole da noi questo toromaculato di Memfi?».6Plutarco, Vita di Pompeo, XXIV, 5.7TURCAN 1989, p. 203.8Stimolanti ipotesi circa gli agenti chehanno contribuito a trasformare ilMitraismo iranico nella religione <strong>del</strong> II sec.d. C. e che ne hanno portato il culto inItalia, la cui critica esula dagli intenti di questocontributo, sono presenti in BIANCHI1979, TURCAN 1989, SFAMENI GASPARO2006.9Cassio Dione, XLIII, 5, 2; Svetonio,Nerone, XIII, 30.10Plinio il Vecchio, Storia Naturale, XXX, I, 6.11La nascita dalla Petra Genitrix è tipica <strong>del</strong>culto mitraico, cui fa menzione ancheFirmico Materno nella sua polemica controle religioni pagane (Firmico Materno,L’errore <strong>del</strong>le religioni profane, XX); il dio èspesso raffigurato mentre nasce dalla pietratenendo in mano una fiaccola, che alludealla sua natura solare e luminosa, e un coltello,presago <strong>del</strong>la tauroctonia che restituiràvita alla natura.12W. Burkert lo considera più affine ad unamoderna società segreta che ad una verareligione (BURKERT 1987, p. 59).13Come nel Mitreo di Capua, per il quale cfr.fig. 1.14Apuleio, Metamorfosi, XI.15BIANCHI 1979, pp. 8-9; secondo GiuliaSfameni Gasparro solo il Mitraismo, dato ilcarattere esclusivamente misterico e ‘nascosto’che lo contraddistingue, può essereconsiderato effettivamente un religione dimistero, termine di cui a volte si abusa; lealtre religioni possono avere una componentemisterica, ma non sono fondateesclusivamente sui riti segreti dei mystae(SFAMENI GASPARRO 1979, p. 310).16I nomi dei relativi gradi iniziatici sonoriferiti da S. Gerolamo, che nella suaEpistola ad Laetam riferisce <strong>del</strong>la distruzionedi un mitreo ad opera di un pagano convertitoal Cristianesimo; il grado di Cryphiuscompare solo raramente nelle iscrizioni,essendo più di frequente sostituito conquello analogo di Nymphus (SFAMENIGASPARRO 1971, p. 555); il legame con i pianetie le divinità è presente anche nelladecorazione di alcuni mitrei, quali quello diSanta Prisca a Roma e di Felicissimo a Ostia(BIANCHI 1979, pp. 32-33).17TURCAN 1989, p. 235.18ID., Ibidem, p. 235.19Tertulliano, Sulla corona, 15, 3-4.20Porfirio, L’antro <strong>del</strong>le Ninfe, 15.21TURCAN 1989, p. 236.22ID., Ibidem, p. 237.23ID., Ibidem.24Poteva essere una figura assimilabileall’Archigallus <strong>del</strong> culto di Cibele, che erapresente solo nelle comunità più importanti.25SFAMENI GASPARRO 1971, p. 556.26EAD., Ibidem.27BURKERT 1987, pp. 119-141; SFAMENIGASPARRO 1979, pp. 328-330.28VERMASEREN 1971, p. 1.29ID., Ibidem, p. 3; TRAN TAM TINH 1972, p.184.30STROUMSA 2006, pp. 76-77.31Giustino, 66, 3-5.32Tertulliano, Sulle prescrizioni degli eretici; sullaliturgia mitraica cfr. anche TURCAN 1989,pp. 233- 240.33SFAMENI GASPARRO 1971, p. 545.34VERMASEREN 1971.35ID., Ibidem, pp. 10-11.36LEROY CAMPBELL A. 1968, p. 30.37ID., Ibidem, p. 77; VERMASEREN 1971, p. 12.38VERMASEREN 1971, pp. 12-14.39Cfr. fig. 13 (schema che illustra la posizionedegli affreschi parietali).40Cfr. fig. 15 (schema degli affreschi sullafronte dei pancali, da VERMASEREN 1971).41Il Tran Tam Tinh definisce questo stile«impressionista, ma già venato d’espressionismo»a causa <strong>del</strong>la semplicità e <strong>del</strong> caratterefortemente emotivo <strong>del</strong>le figure (TRANTAM TINH 1972, p. 190).42VERMASEREN 1971, p. 27.43ID., Ibidem, pp. 28-34.44ID., Ibidem, pp. 36-42.45ID., Ibidem, p. 43.46Porfirio, L’antro <strong>del</strong>le Ninfe, 15.47L’interpretazione di questo pannello èdubbia e molto difficile; Vermaseren ritienesi tratti di un omicidio rituale, in cui il mistagogorecita la parte di Mitra tauroctono e ilmysta quella <strong>del</strong> toro (VERMASEREN 1971,pp. 45-47).- 18 -
GIOVANNI VERGINEOBibliografiaBIANCHI U. 1979, Mysteria Mithrae. Atti <strong>del</strong>Seminario Internazionale su “La specificità storico-religiosadei Misteri di Mithra, con particolareriferimento alle fonti documentarie di Roma eOstia”, Roma - Ostia 1978, Leiden.BURKERT W. 1987, Ancient Mistery Cults,Cambridge (trad. it. Antichi culti misterici,Roma-Bari 1989).CUMONT F. 1896-1899, Textes et monumentsfigurés relatif aux mystères de Mithra, 2 voll.,Bruxelles.CUMONT F. 1913, Les Mystères de Mithra,Bruxelles.CUMONT F. 1929, Les religions orientales dansle paganisme romain, 4 a ed., Paris.LEROY CAMPBELL A. 1968, MithraicIconography and Ideology, Leiden.SFAMENI GASPARRO G. 2006, Misteri e cultiorientali: un problema storico-religioso, in Religionsorientales-culti misterici, Neue perspektiven - prospettivenuove, a cura di C. BONNET - J. RÜPKE- P. SCARPI, Stuttgart, pp. 181-210.TRAN TAM TINH V. 1972, Le culte des divinitésorientales en Campanie, Leiden.TURCAN R. 1989, Les Cultes Orientaux dans lemonde Romain, Paris (trad. ingl. The Cults ofthe Roman Empire, a cura di A. NEVILLE,Oxford 1996).STROUMSA G. G. 2006, La fine <strong>del</strong> Sacrificio.Le mutazioni religiose nella Tarda Antichità,Torino.VERGINEO G. 2010, Il culto <strong>del</strong>le divinità egiziein Campania, in ‘Salternum’, 25-25, pp. 29-43.VERMASEREN M. J. 1971, The mithraeum atS. Maria Capua Vetere, Leiden.- 19 -
ELENA GIGANTINOArcheometria ed epigrafia: applicazioni sperimentalisulle iscrizioni tardoantiche di AbellinumL’epigrafe costituisce un documento cheassomma molteplici nature, in cui la componentespecificamente archeologica è rappresentatadal suo carattere di manufatto e dal suosupporto materiale: tali elementi rispondono alla funzione<strong>del</strong>la trasmissione di un testo, non meno che allavolontà ed alle possibilità economiche di chi ne commissional’esecuzione.Lo studio dei litotipi, che è finalizzato ad accertarela provenienza <strong>del</strong>la materia prima e le forme <strong>del</strong> suoapprovvigionamento, risulta pertanto utile per ricostruirel’economia di una determinata società in unospecifico periodo storico, a condizione che esistano -come nel caso in oggetto - una serie di requisiti imprescindibili,quali l’omogeneità <strong>del</strong> contesto di rinvenimentoed una cronologia accertata. La risposta a taleesigenza conoscitiva può venire da applicazioni di tiposcientifico, propriamente archeometriche, le quali possonosoddisfare molteplici richieste, permettendo, tral’altro, proprio la caratterizzazione dei materiali finalizzataallo studio <strong>del</strong>le tecniche produttive ed all’individuazione<strong>del</strong>l’area di origine dei manufatti 1 .Una proficua collaborazione tra specialisti di ambitoumanistico e scientifico ha consentito di dare inizioall’attuazione di un progetto finalizzato allo studiointegrale di un campione selezionato dei 116 manufattifunerari rinvenuti nell’area <strong>del</strong>la basilica paleocristiana<strong>del</strong>l’antica Abellinum (odierna Atripalda, localitàCapo La Torre), datati tra la seconda metà <strong>del</strong> V e laseconda metà <strong>del</strong> VI secolo d. C. 2 .Da prime interrogazioni macroscopiche, a caratterepropriamente geo-mineralogico 3 , è emerso che ilmateriale litologico adoperato come supporto per leiscrizioni abellinati proviene con alta probabilità dacave non locali: sono stati infatti classificati comemarmi i litoidi contraddistinti dal colore bianco obianco-grigio e come ‘marmi brecciati’ - cioè brecceche hanno subito un processo metamorfico tale damodificarne le originarie caratteristiche tessiturali -quelli colorati. Nel territorio campano, in ragione <strong>del</strong>lesue caratteristiche geomorfologiche, non si rinvengonolitotipi di natura metamorfica, quindi per gli esemplaribianchi l’ipotesi più accreditata è che siano diprovenienza lunense o greca; per quelli colorati, esclusauna provenienza italica, si ipotizza invece l’approvvigionamentodall’area euboica o tessala.L’esigenza di confermare o smentire le prime osservazioniha indotto a ricorrere all’applicazione <strong>del</strong>‘Protocollo di Analisi Isotopiche di caratterizzazione e diprovenienza dei reperti marmorei’ 4 . Si tratta <strong>del</strong>l’attuazionedi un procedimento basato sul principio secondo ilquale, al termine <strong>del</strong> processo di genesi <strong>del</strong>la roccia, la suacomposizione isotopica si mantiene immutata nel tempo,sia che essa divenga manufatto, sia che resti in coltivazione.I rapporti di 13 C- 12 C e di 18 O - 16 O restano relativamentecostanti all’interno <strong>del</strong>la stessa cava di approvvigionamento,mentre si riscontrano differenze significativetra cave diverse. Operativamente, si analizzano levariazioni <strong>del</strong> rapporto tra il numero di atomi <strong>del</strong>l’isotopo13 C e il numero degli atomi <strong>del</strong>l’isotopo 12 C in funzione<strong>del</strong> rapporto tra il numero di atomi <strong>del</strong>l’isotopo 18 O eil numero di atomi <strong>del</strong>l’isotopo 16 O in riferimento ad uncarbonato fossile assunto come campione standard 5 .Lo scopo <strong>del</strong>le analisi è mettere in evidenza eventualisimilitudini composizionali tra i vari reperti, inbase alle quali poter individuare gruppi con composizioniapprossimative. Al fine di eseguire indagini diprovenienza, va tuttavia tenuto presente che qualsiasitecnica scientifica venga impiegata, essa deve averenecessariamente soddisfatto il cosiddetto ‘postulato diprovenienza’, secondo il quale è possibile ottenere perun materiale un valido risultato solo se esiste una differenzachimica o mineralogica, qualitativa o quantitativa,tra le sorgenti da cui esso si ricava.- 21 -
SALTERNUMFig. 1 - Reperti di certa localizzazione all’interno <strong>del</strong>la basilica paleocristiana di Abellinum.Il ‘Protocollo di Analisi’, nelle sue fasi applicative,prevede in successione: la selezione dei campioni, ilcampionamento, la preparazione dei campioni per l’analisi,l’esecuzione <strong>del</strong>le analisi e l’interpretazione deirisultati 6 .Per la selezione dei reperti, sui quali effettuare ilprelievo dei microcampioni, si è attentamente esaminatala documentazione fotografica e le osservazioniinserite nella scheda di ciascun reperto durante la fasepreliminare, propriamente archeologica, <strong>del</strong> lavoro 7 .Ai fini <strong>del</strong>l’attuazione <strong>del</strong> progetto sono state considerateutili le iscrizioni integre sulle quali sono conservatii dati onomastici e biometrici <strong>del</strong> defunto e l’eponimiaconsolare, quelle che presentano rilevantiparticolarità grafiche e quelle con presenza di elementiiconografici; questa linea operativa è stata tracciatacon l’intento di verificare se specifiche peculiarità grafichesi leghino in qualche modo alla qualità <strong>del</strong> supportoutilizzato e se questi elementi, congiunti, sianoindice <strong>del</strong>le possibilità economiche dei committenti. Sisono considerati inoltre i reperti con localizzazionecerta nell’ambito <strong>del</strong> contesto di provenienza 8 (fig. 1).Considerate queste variabili di selezione, si è giuntiad individuare un lotto di 20 litotipi da sottoporre alcitato ‘Protocollo’. Successivamente, tra le 20 iscrizionicampionate ne sono state scelte 2 sulle quali avviare lostudio: la n° 14 (fig. 2), eseguita nel 533 d. C., e la n°113A/B (fig. 3) che corrisponde ad una sepoltura bisoma,probabilmente di coniugi, deceduti rispettivamentenel 519 e nel 535/537 d. C. La prima si distingue dall’interoinsieme <strong>del</strong>le epigrafi per le particolari peculiaritàgrafiche: le terminazioni dei tratti sommitali <strong>del</strong>lelettere, a spatola ed ondulate, impreziosiscono unmanufatto che risulta un unicum nel contesto abellinate.Anche la scelta di un supporto colorato, poco adatto afavorire la leggibilità <strong>del</strong>l’incisione - uno dei requisitifondamentali di un’iscrizione - rende questo esemplare<strong>del</strong> tutto eccezionale e sembra rispondere alla precisavolontà di commissionare un prodotto che si distinguessedagli altri. La seconda epigrafe ha come supportoscrittorio un litotipo bianco. Evidenti segni di degradoal recto, da ricondurre ad un processo esfoliativo perazione <strong>del</strong>l’acqua 9 , non hanno completamente abraso iltesto, che si presenta ancora leggibile. I caratteri grafici- 22 -
ELENA GIGANTINOdei due testi che commemorano rispettivamente ildiaconus Leo e la diacona Palumba presentano unaserie di elementi comuni, ma anche alcune difformità,tali da far pensare ad un’esecuzione da partedi due ‘mani’ diverse, a distanza di tempo - come<strong>del</strong> resto testimoniato dalle differenti date di decesso- ma con un chiaro intento imitativo.Durante la fase di campionatura 10 si è prestatamolta attenzione nella scelta <strong>del</strong> punto in cuieffettuare il prelievo, che deve essere il più possibilerappresentativo <strong>del</strong> reperto ed avere concentratala medesima composizione chimica <strong>del</strong>l’interosupporto. Tale piccola zona è stata individuataal verso di ogni epigrafe, per lo più negliangoli <strong>del</strong> supporto, in modo da non intaccareminimamente il testo inciso 11 . Il punto di prelievodi ciascun litoide è stato pulito accuratamenteda qualsiasi agente contaminante per le misure dilaboratorio, quali terriccio di scavo non rimossoo polvere accumulatasi dopo lo stoccaggio (fig.4). Si è poi proceduto all’esecuzione <strong>del</strong> microforo,mediante l’uso di un trapano elettrico, avendol’accortezza di raccogliere soltanto la polvereprodotta dalla trapanazione ad una profonditàsuperiore ai 5 mm e di cestinare quella precedente,perché inquinata da agenti esterni (fig. 5).Prima, durante e dopo ciascuna fase <strong>del</strong> prelievo,gli strumenti utilizzati sono stati puliti, in modotale da evitare contaminazioni tra i reperti; lastessa operazione è stata eseguita regolarmentesul tavolo da lavoro. Per ogni perforazione si èprovveduto a raccogliere 0,1 g di polvere 12 .Il prosieguo <strong>del</strong>le operazioni preliminari alleAnalisi Isotipiche con Spettrometria di massa prevedequindi la fase di pretrattamento <strong>del</strong> campione,che consiste essenzialmente nell’ottenereAnidride Carbonica (CO 2 ) allo stato gassoso dalCarbonato di Calcio (CaCO 3 ) contenuto neimicrocampioni, mediante attacco acido (H 3 PO 4 ).Concluso il processo di estrazione <strong>del</strong>la CO 2 ,viene effettuata la misura dei rapporti isotopici <strong>del</strong>Carbonio e <strong>del</strong>l’Ossigeno utilizzando la metodologiadi spettrometria di massa convenzionale(IRMS – Isotope Ratio Mass Spectrometry), con laquale si separano molecole cariche - gli ioni - inbase al rapporto <strong>del</strong>la loro massa e <strong>del</strong>la loro carica.La tecnica è in grado di distinguere isotopi diuno stesso elemento e di calcolare i loro rapporti.Fig. 2 - Campione n°14: recto, verso e sezione.Fig. 3 - Campione n°113A/B: recto e sezione.- 23 -
SALTERNUMI rapporti isotopici sono espressi in valori di δ[‘<strong>del</strong>ta’]; questi equivalgono alle deviazioni in parti permille rispetto al campione standard:Fig. 4 - Campionatura. Pulizia <strong>del</strong> campione.δX = [(R campione /R standard)-1)] x 1000in cui R esprime il rapporto tra la massa <strong>del</strong>l’isotopopesante e la massa <strong>del</strong>l’isotopo leggero ( 13 C/ 12 C;18O/ 16 O); X, l’elemento di cui si misura il rapporto isotopico(C o O).Le misure dei rapporti isotopici sono state quindirealizzate presso il Laboratorio di Spettrometria diMassa <strong>del</strong> Centro di Ricerca CIRCE, ottenendo iseguenti valori per i ‘<strong>del</strong>ta’ isotopici dei due campioni:δ 13 C = 2,475 e δ 18 O = -1,40 per il campione n°14;δ 13 C=3,34 e δ 18 O= -0,55 per il campione n°113A/B.Fig. 5 - Campionatura. Fase di prelievo.Operativamente, il composto gassoso ricavato dal pretrattamento<strong>del</strong> campione è introdotto nell’IRMS inalternanza ad un gas standard di riferimento aventedistribuzione isotopica ben definita; il confronto tracampione e standard è l’equivalente <strong>del</strong> rapporto isotopiconel campione. Il dispositivo che consente di avereun confronto in tempo reale tra il campione analizzatoe quello di riferimento è il Dual Inlet (doppia immissione).Nei materiali disponibili in natura, i rapporti isotopicidi nuclidi stabili sono sostanzialmente costanti neltempo ed equivalgono a ‘traccianti’ geochimici.Piccole variazioni di tali rapporti sono possibili conseguentementea specifici processi fisico-chimici di frazionamento;la misurazione è quindi sfruttata per rintracciaree monitorare tali processi ed in archeometriaè usata per ‘caratterizzare’ la materia prima di unreperto dato e per risalire alla sua provenienza 13 .L’entità <strong>del</strong> frazionamento dipende dalla temperatura,dalla quantità di umidità, dal tipo di condensazione eda fattori climatici e geografici.Fig. 6 - Grafico con i valori dei ‘<strong>del</strong>ta’ isotopici dei campioni n°14 e n°113A/B.Questi valori sono stati confrontati con i valoripresenti nel database internazionale dei ‘<strong>del</strong>ta’ isotopicidei differenti campioni di marmo, pubblicato nel 2002da Carlo Gorgoni 14 (fig. 6). Tale database è frutto <strong>del</strong>l’integrazionedi misure effettuate, in diversi studi, sucampioni provenienti dalle cave <strong>del</strong> Mediterraneo piùsfruttate nell’Antichità e da quelli ottenuti dalle analisidi manufatti marmorei antichi.Otto sono i siti di estrazione presenti: Afrodisia(Aph), Carrara (C), Dokimeion –Afyon (D), Nasso (N),Paro (Pa 1,2,4 ), Pentelico (Pe), Proconneso (Pr 1,2 ) e Taso(T 1,2,3 ). Da tale comparazione risulta che i valori <strong>del</strong>lacoppia di rapporti isotopici per il campione n° 14fanno propendere per una provenienza dall’area corrispondenteagli approvvigionamenti di Taso, mentre ilcampione n° 113 A/B mostra la coppia di valori di- 24 -
ELENA GIGANTINO‘<strong>del</strong>ta’ isotopici che lo identificano come provenientedall’area <strong>del</strong> Proconneso: entrambi i campioni trovanocoltivazione nell’area a Nord <strong>del</strong>l’Egeo.I risultati ottenuti per i due campioni prescelti <strong>del</strong>leepigrafi abellinati conferma, in parte, le valutazioniemerse dallo studio macroscopico a carattere geomineralogico15 .Il fatto che i valori di δ 13 C e δ 18 O trovino giusta collocazioneall’interno <strong>del</strong> database assunto come riferimentointernazionale prova che la natura tessiturale dientrambi i litoidi analizzati è prossima a quella marmorea,il che conferma che una provenienza locale deilitoidi va esclusa. E’ altresì indicativo che sia l’iscrizionen° 14 sia quella bisoma n°113A/B impieghinocome supporto specie litologiche localizzate nell’areaa Nord <strong>del</strong>l’Egeo, poiché i valori dei rapporti isotopicidi Carbonio ed Ossigeno si allontanano da quelliottenuti dal conteggio <strong>del</strong>lo standard di riferimento C1proveniente dalla catena montuosa <strong>del</strong>le Alpi Apuane,facendo escludere una estrazione in coltivazioni <strong>del</strong>learee <strong>del</strong> Mediterraneo Occidentale.Il litotipo scelto per realizzare l’epigrafe funeraria<strong>del</strong> Vir Inlustris et Patricius Abundantius (n° 14), sepoltoin un’area ad Ovest <strong>del</strong>l’abside <strong>del</strong>la basilica paleocristianadi Abellinum nel 533 d. C., sembra provenire daTaso o comunque da un distretto geologicamente affine<strong>del</strong> Nord <strong>del</strong>l’Egeo.Per indicare la sepoltura e fare una duplice azionememorativa di carattere verosimilmente familiare <strong>del</strong>Diaconus Leo e <strong>del</strong>la Diacona Palumba (n° 113 A/B), inumatirispettivamente nel 519 d. C. e nel 535/537 d. C.,si utilizzò un marmo cavato in Proconneso.Stando a questi dati parziali, sembra che nellaprima metà <strong>del</strong> VI secolo d. C. la scelta dei committenticada su marmi di coltivazione orientale piuttostoche occidentale 16 . Anche se parziale - e da considerareobbligatoriamente come tale - questo dato è un indizioimportante per il prosieguo <strong>del</strong> progetto di studio:una volta completate le analisi dei campioni preselezionatisi potrà valutare se in età tardoantica fosseancora attivo un circuito di estrazione e di trasportodall’Oriente verso la penisola italica ed in particolareverso il Meridione.La bibliografia disponibile sull’argomento sottolineache lo spostamento <strong>del</strong>la capitale <strong>del</strong>l’Impero aCostantinopoli fece cessare l’attività estrattiva nellecave occidentali, di contro ad uno sfruttamento ininterrottonelle zone orientali, su richiesta tuttavia di unacommittenza per lo più privata ed in quantità nonparagonabili a quelle <strong>del</strong>la piena età imperiale 17 .I due manufatti epigrafici qui considerati non recanosegni evidenti di reimpiego, anche se non si puòescludere che si tratti di lastre originariamente destinatead un’edilizia monumentale pubblica o privata dialto livello, rilavorate con perizia da abili lapicidi.Entrambe le iscrizioni sono destinate a soddisfare leesigenze memorative - familiari, ma anche collettive-–di una committenza di ceto elevato; i tre personaggioccupano ruoli ben definiti e di un certo prestigionella società abellinate: l’uno ostenta un elevatissimo eraro titolo di rango senatorio, gli altri due sono diretticollaboratori <strong>del</strong> clero nella vita liturgica e sociale <strong>del</strong>laChiesa locale 18 .Nell’epigrafe di Abundantius è evidente una particolarecura nell’impaginazione e nella resa grafica deisegni tanto alfabetici quanto iconografici; considerazionianaloghe valgono, per quanto in misura minore,anche per l’epigrafe di Leo e Palumba. Le due lapidi quiesaminate - ma l’intero corpus abellinate - presentanocaratteristiche esecutive assai diversificate e generalmentedi alto livello, con esiti da ricondurre ad un‘saper fare’ artigianale che non trova finora termini dicomparazione nella pur consistente produzione coeva<strong>del</strong>la Campania 19 .Dal punto di vista <strong>del</strong>le considerazioni storiche, vaosservato che il declino <strong>del</strong>la colonia romana diAbellinum viene posto generalmente in concomitanzacon l’arrivo di Alarico e dei suoi uomini nel 410 d. C.e con quello successivo di Genserico nel 455 d. C.; daimanufatti epigrafici di Capo la Torre non sembra tuttaviache si possa evincere un’involuzione <strong>del</strong>la societàper cause violente. Al 505 o 512 d. C. si data poi l’eruzionevesuviana cosiddetta di Pollena, di cui restanotracce anche nel sito <strong>del</strong>l’attuale Capo La Torre. Unacittà colpita da tali accadimenti e sulla quale avrebberogravato anche le ripercussioni <strong>del</strong>la Guerra grecogotica(535-553 d. C.) difficilmente può commissionareuna serie di prodotti il cui alto livello esecutivo - edunque i costi di materia prima e di manodopera - èreso evidente non solo dalle scelte grafiche, ma anchedall’uso di litotipi rari e di notevole pregio estetico.Anche ammettendo che tali manufatti siano stati commissionatiin prevalenza da ricche famiglie <strong>del</strong>l’aristocrazialocale, sulle cui possibilità economiche gli eventipossono aver inciso marginalmente, resta da chiarirecome una serie di fenomeni involutivi, di natura sia- 25 -
SALTERNUMantropica sia naturale, non abbiano avuto alcuna ripercussionesull’attività produttiva di manufatti non indispensabili.E’ pur vero che ad un’eventuale cessazione<strong>del</strong>l’attività <strong>del</strong>le botteghe locali si sarebbe potutoovviare importando manufatti analoghi da altri centrinon interessati da fattori di crisi, ma ben si comprendecome questo implichi l’organizzazione di un trasportooneroso, su vie di comunicazione ancora utilizzabilie la presenza di un potere centrale in grado diassicurarne la manutenzione. Per l’antica Abellinum gliindicatori archeologici attualmente disponibili – e inparticolare proprio la ricca documentazione epigraficaed i rivestimenti parietali in opus sectile <strong>del</strong>la basilica cristiana– inducono a leggere una realtà di sostanzialetenuta <strong>del</strong>le condizioni precedenti agli eventi <strong>del</strong> VIsecolo, se non addirittura un potenziamento <strong>del</strong>la città,legata ad uno spostamento dei traffici lungo l’Appia,ed un incremento degli stessi con la contigua Puglia 20 .- 26 -
ELENA GIGANTINONoteQuesto articolo sintetizza le fasi propriamente archeometriche di una ricerca sperimentale messa a punto e coordinata dai proff. ChiaraLambert, <strong>del</strong>l’ex-Dipartimento di Latinità e Medioevo, ora Dipartimento di Scienze <strong>del</strong> Patrimonio Culturale <strong>del</strong>l’Università degli Studi diSalerno, e Carmine Lubritto, <strong>del</strong> Dipartimento di Scienze Ambientali <strong>del</strong>la II Università di Napoli, nonché docente di Fisica applicata aiBeni Culturali presso l’Università degli Studi di Salerno. Chi scrive ha partecipato al progetto sin dall’inizio, facendone materia <strong>del</strong>le proprietesi di Laurea Triennale in Scienze dei Beni Culturali e Specialistica in Archeologia (GIGANTINO 2006/2007; EAD. 2009/2010).1MANACORDA 2003, pp. 140-141.2LAMBERT 2009 a , pp. 101-102.3Le prime interrogazioni macroscopiche acarattere geo-mineralogico hanno impegnatoi proff. Maurizio De’ Gennaro, <strong>del</strong>Dipartimento di Scienze <strong>del</strong>la Terra<strong>del</strong>l’Università degli Studi di Napoli‘Federico II’, e Alessio Langella, <strong>del</strong>Dipartimento di Studi Geologici edAmbientali <strong>del</strong>l’Università degli Studi <strong>del</strong>Sannio, entrambi docenti di GeorisorseMinerarie ed Applicazioni Mineralogico-Petrografiche per l’Ambiente ed i BeniCulturali (cfr. GIGANTINO 2006/2007, pp.36-39).4Per poter effettuare le operazioni direttesui manufatti è stata ottenuta la debita autorizzazioneda parte <strong>del</strong>la Soprintendenzaper i Beni Archeologici di SA-AV-BN-CE,nella persona <strong>del</strong>l’allora Soprintendentedott.ssa Maria Luisa Nava.5Le attività di ricerca archeometrica hannoavuto luogo presso il Laboratorio ‘CIRCE’,Centro di Ricerche Isotopiche per i Beni Culturalied Ambientali (San Nicola La Strada,Caserta), attivo nel settore <strong>del</strong>la Ricerca edei Servizi ad Alto Contenuto Tecnologicoapplicati allo Studio ed alla Conservazione<strong>del</strong> Patrimonio Culturale ed Ambientale.6LUBRITTO 2006/2007, pp. 7-10.7Nel novembre-dicembre 2007 si è realizzatoun censimento sistematico <strong>del</strong> materialeepigrafico, registrando i dati su una schedatipomessa a punto appositamente per ireperti tardoantichi e medievali (LAMBERT2010, pp. 288-294); GIGANTINO 2006/2007,pp. 28-30).8Dalla lettura dei quaderni di scavo questodato risulta disponibile solo per 33 (28%)<strong>del</strong>le 116 epigrafi censite.9GIGANTINO 2006/2007, pp. 38-39.10La campionatura, eseguita sui 20 esemplari,è stata svolta all’interno <strong>del</strong> magazzinolaboratorio<strong>del</strong>la Soprintendenza per i BeniArcheologici di SA-AV-BN-CE, situato inAvellino alla via Cicarelli 5, dove le epigrafifunerarie di Capo La Torre sono temporaneamentestoccate.11A questa fase di lavoro hanno partecipatoi Tecnici <strong>del</strong> Dipartimento di ScienzeNaturali <strong>del</strong>la II Università di Napoli, sig.riAntonio Palmieri e Paolo Marinelli; il sig.Alfonso De Concilio, Restauratore <strong>del</strong>laSoprintendenza Archeologica di SA-AV-BN-CE; la dott.ssa Paola Ricci <strong>del</strong>Laboratorio CIRCE; la dott.ssa MariannaMelfi e chi scrive.12La polvere ottenuta è stata raccolta inun’apposita provetta in plastica con coperchiettoa tenuta, sulla quale sono stati trascrittitutti i riferimenti identificativi.Contestualmente a queste operazioni è statacompilata la scheda di campionamento,inserendovi i dati di riferimento <strong>del</strong>l’epigrafe,<strong>del</strong> prelievo effettuato - individuato daun numero progressivo - e <strong>del</strong>le quantità dipolvere raccolta.13Nel caso specifico <strong>del</strong>le analisi isotopichedi caratterizzazione e provenienza deimarmi, il conteggio effettuato dal contatoredi ioni è sui nuclidi stabili, non idrogenici,<strong>del</strong> Carbonio e <strong>del</strong>l’Ossigeno, per i quali simisurano i rapportiR = 13 C/ 12 C e R = 18 O / 16 O.14GORGONI et Alii 2002, pp. 123.15GIGANTINO 2006/2007, pp. 36-37;LAMBERT 2009 a , p. 101.16Dopo che la Tesi di chi scrive era già statadiscussa, le analisi sui materiali di Abellinumsono proseguite sugli altri 18 campioni. Irisultati ottenuti - esposti nella tesi diLaurea Specialistica dalla dott.ssa MariannaMelfi (MELFI 2009/2010) - confermanopienamente quelli di cui si tratta in questasede.17WAELKENS 1992, p. 5; PENSABENE 1992,p. 11.18LAMBERT 2008, pp. 14-16.19SOLIN cds; LAMBERT 2008, p. 16.20LAMBERT 2009 b , p. 103.- 27 -
SALTERNUMBibliografiaFRANCOVICH R. - MANACORDA D. (a cura di)2003, Dizionario di archeologia, Bari.GIGANTINO E. 2006/2007 (ined.), Epigrafia,archeologia e scienze mineralogiche: primi risultati diuno studio sulle iscrizioni tardoantiche diAbellinum, Tesi di Laurea in Scienze dei BeniCulturali, Università degli Studi di Salerno,a.a. 2006/2007 (Relatore: prof.ssa C.Lambert; Correlatore: prof. A. Langella).GIGANTINO E. 2009/2010 (ined.),Archeometria ed epigrafia: nuovi dati dalle iscrizionitardoantiche di Abellinum, Tesi di LaureaSpecialistica in Archeologia, Università degliStudi di Salerno, a.a. 2009/2010 (Relatore:prof.ssa C. Lambert; Correlatore: prof. C.Lubritto).GORGONI et Alii 2002, An update and detailedmineropetrographic and C-O stable isotopic referencedatabase for the main Mediterranean marbles used inantiquity, Museum of Fine Arts, Boston, 1998, inHERRMANN J. - HERZ N. – NEWMAN R.(eds.), Interdisciplinary Studies on Ancient Stones,Proceedings of the 5 th Internazional Conference ofthe Association for the Study of Marble and OtherStones in Antiquity, Archetype Publication,London, pp. 115-131.LAMBERT C. 2008, Studi di epigrafia tardoantica emedievale in Campania. Volume I. Secoli IV-VII,Collana «Medioevo scavato», «ScholaSalernitana», 3, Firenze.LAMBERT C. 2009 a , Epigrafia, Archeologia eScienze geomineralogiche: nuovi risultati dai materialitardoantichi e medievali di Abellinum eBeneventum, in G. VOLPE –P. FAVIA (a curadi), Atti <strong>del</strong> V Congresso Nazionale di ArcheologiaMedievale, Foggia 2009, Firenze, 2009, pp. 101-104.LAMBERT C. 2009 b , Espressioni <strong>del</strong> potere politicoe riflessi <strong>del</strong>l’ambiente religioso nelle iscrizioni <strong>del</strong>laCampania tardoantica ed altomedievale, inTRISTANO C. - ALLEGRIA S. (a cura di),‘Civis/Civitas. Cittadinanza politico-istituzionale eidentità socio-culturale da Roma alla prima etàmoderna’, Atti <strong>del</strong> Seminario internazionaleSiena/Montepulciano 10-13 luglio 2008, ‘MedievalWriting’, 3, Recanati (MC), pp. 85-104.LAMBERT C. 2010 (2004 1 ), Pagine di pietra.Manuale di epigrafia latino-campana tardoantica emedievale. Seconda edizione riveduta ed ampliata,Coll. «Taccuini di Ippocrate», 2, Manocalzati (AV).LUBRITTO C. 2006/2007 (ined.), Dispensedattiloscritte per il corso di ‘Fisica applicata ai BeniCulturali’ <strong>del</strong> CdL triennale in Scienze deiBeni Culturali <strong>del</strong>l’Università degli Studi diSalerno, a.a. 2006/2007.MANACORDA D. 2003, Archeologia ed epigrafia,in FRANCOVICH - MANACORDA 2003, pp. 139-143.MELFI M. 2009/2010 (ined.), Le iscrizioni <strong>del</strong>labasilica paleocristiana di Abellinum: primi risultatiarcheometrici, Tesi di Laurea Specialistica inArcheologia, Università degli Studi diSalerno, a. a. 2009/2010 (Relatore: prof.ssaC. Lambert; Correlatore: prof. C. Lubritto) .PENSABENE P. 1992, Transport, diffusion et commercedes marbres. La situation ou Bas-Empire, in‘Les dossiers d’archéologie, le marbre dansl’Antiquité’, n° 173, Juillet-Aôut, pp. 11-15.SOLIN H. in cds (a cura di), Abellinum,Inscriptiones christianae Italiae septimo saeculoantiquiores (ICI), Bari.WAELKENS M. 1992, Carrières et marbres <strong>del</strong>’Asie Mineure. L’exploitation Byzantine, in ‘Lesdossiers d’archéologie, le marbre dans l’Antiquité’, n°173, Juillet-Aôut, pp. 5-7.- 28 -
MARIANNA MELFIL’apporto <strong>del</strong>l’archeometria agli studi epigrafici:l’esempio <strong>del</strong>le iscrizioni <strong>del</strong>la basilicapaleocristiana di Abellinum - Atripalda (AV)Negli ultimi anni la collaborazione fraFisici, Chimici, Biologi, Geologi edArcheologi riguardo ad iniziative voltealla conoscenza e alla salvaguardia dei Beni Culturali ècresciuta notevolmente. Le competenze tecnico-scientifiche,infatti, possono essere utilizzate con profitto indiverse situazioni in cui non è possibile ottenere informazioniattraverso valutazioni di tipo storico o artistico.L’Archeometria consiste nello studio scientificodei reperti archeologici e, in senso più lato, di tutti iBeni Culturali. Le sue finalità sono molteplici e coinvolgonocampi come la datazione di oggetti e sitiarcheologici, la caratterizzazione chimico-fisica deimateriali per lo studio <strong>del</strong>la tecnologia produttiva el’individuazione <strong>del</strong>l’area di origine di manufatti, lostudio di oggetti antichi, opere d’arte e monumentiper la conservazione e il restauro, test di autenticità diopere d’arte 1 .Nell’ambito <strong>del</strong>la disciplinaepigrafica gli studi dicaratterizzazione e provenienzadei materiali lapideiusati come supporti scrittorimediante analisi scientificheconsentono di risalire allaprovenienza <strong>del</strong>la materiaprima, di individuarne illuogo d’approvvigionamentoe di ottenere - insieme aglistudi di tipo propriamentestorico ed epigrafico - diverseinformazioni inerenti alleciviltà antiche (relazionicommerciali, sviluppo economicoraggiunto, strutturasociale, competenze tecno-logiche acquisite) e, più in generale, per ricostruire ilquadro storico di uno o più siti archeologici 2 .Nel presente contributo 3 sono presentati i risultati<strong>del</strong>le indagini archeometriche condotte su un gruppodi epigrafi provenienti dal contesto <strong>del</strong>la basilicapaleocristiana di Abellinum, con le ipotesi di caratterizzazionee provenienza dei materiali lapidei utilizzaticome supporti <strong>del</strong>le stesse 4 .L’antico edificio di culto - di impianto basilicale a trenavate con orientamento Est-Ovest, databile ai primidecenni <strong>del</strong> IV secolo d. C. - sorse sulla riva destra <strong>del</strong>fiume Sabato, in un’area extra urbana già sede di unaprecedente necropoli pagana 5 , inglobata nell’odiernacittà di Atripalda, al di sotto <strong>del</strong>l’antico quartiere medievaledi ‘Capo La Torre’. Indagini archeologiche condottea più riprese nell’ambito di tale complesso, hannofatto emergere un numero considerevole di sepoltureaccompagnate da epigrafi con formulario tipicamenteFig. 1 - Esempio di scheda di campionamento compilata per ogni epigrafe analizzata (da MELFI 2009-2010).- 29 -
SALTERNUMcristiano 6 . In ragione <strong>del</strong>l’importanza di questa riccadocumentazione - costituita da 116 iscrizioni databili inun arco cronologico compreso tra la prima metà <strong>del</strong> IVe la seconda metà <strong>del</strong> VI secolo d. C. - e <strong>del</strong> fatto che leFig. 2 - Tabella con i valori dei ‘<strong>del</strong>ta’ isotopici dei 20 campioni epigrafici analizzati nelpresente studio (da MELFI 2009-2010).Fig. 3 - Grafico dei ‘<strong>del</strong>ta’ isotopici per C ed O dei 20 campioni epigrafici analizzati (daMELFI 2009-2010).Legenda: Aph = Aphrodisias, C = Carrara, D = Dokimeion (Afyon), N = Naxos, Pa-1 =Paros-1 (valle di Marathi), Pa-2 = Paros-2 (Lefkes, Chorodaki), Pa-3 = Paros-3 (SE <strong>del</strong>lavalle di Marathi), Pa-4 = Paros-4 (Karavos), Pe = Pentelico, Pr-1 = Prokonnesos-1(Saraylar, Kavala), Pr-2 = Prokonnesos-2 (Camlik) T-1 = Thasos-1 (Capo Fanari), T-2 =Thasos-2 (Alikì), T-3 = Thasos-3 (Capo Vathy, Saliara).indagini archeometriche da effettuare comportanotempi di esecuzione e costi non irrilevanti, si è resonecessario selezionare un primo insieme di reperti,costituito da 20 campioni significativi da sottoporre allesuccessive fasi analitiche. Per tale scelta sono stati consideratidiversi elementi, come la tipologia dei supporti,l’integrità generale <strong>del</strong> manufatto epigrafico, la rappresentativitàgrafica, e, più in generale, la completezza<strong>del</strong>le informazioni desumibili dal testo iscritto (datazione;sesso e posizione sociale <strong>del</strong>l’inumato) 7 .Dopo tale selezione sono stati prelevati 20 microcampionida altrettante epigrafi, facendo attenzione anon pregiudicare l’integrità generale <strong>del</strong> manufatto 8 .Nella maggior parte dei casi la microperforazione èstata effettuata nella faccia posteriore non iscritta, o,nel caso di epigrafi affisse al muro, nello spessore.Per ogni campione si è provveduto alla compilazionedi un’apposita scheda di analisi, nella quale sonostati riportati i dati relativi ai reperti campionati (giorno,mese, anno <strong>del</strong> campionamento, n° di epigrafe, n°di prelievo e il peso di ogni campione) 9 , (fig. 1).Dopo la fase di prelievo, è stato necessario sottoporread un pre-trattamento di natura chimico-fisica icampioni di Carbonato di Calcio (CaCO 3 ) medianteestrazione <strong>del</strong>la CO 2 contenuta nel campione dimarmo polverizzato; operazione analoga è stata effettuatasu alcuni standard internazionali di riferimentonecessari per i confronti 10 . Successivamente per ciascuncampione è stata eseguita la misura dei rapportiisotopici <strong>del</strong> Carbonio e <strong>del</strong>l’Ossigeno medianteSpettrometro di massa 11 .I valori ottenuti dalle misure isotopiche (fig. 2)sono stati confrontati con quelli presenti nella ‘bancadati isotopica per i marmi utilizzati in antico’ (databasemarmi), i cui diagrammi sono stati realizzati sulla scortadei risultati ottenuti dall’analisi di oltre un migliaiodi campioni prelevati dalle principali cave mediterraneedi marmi antichi, integrati con quelli ricavati damanufatti di provenienza accertata con metodologie dilaboratorio 12 .Il posizionamento <strong>del</strong>le coppie dei valori dei ‘<strong>del</strong>ta’isotopici <strong>del</strong> Carbonio e <strong>del</strong>l’Ossigeno derivanti dalleanalisi archeometriche nel database marmi (fig. 3), faemergere che per due campioni (identificati con i n i 80e 95) sui 20 analizzati nel presente studio è possibiledeterminare un’unica area di provenienza, poiché ivalori assunti dalla coppia dei ‘<strong>del</strong>ta’ isotopici cadonoin una zona ben distinta e non sovrapposta alle altre 13- 30 -
MARIANNA MELFI(figg. 4-5), mentre per gli altri 18 non è possibile determinareun’unica area di approvvigionamento <strong>del</strong>materiale lapideo, bensì diverse probabili 14 . Anche inquesti casi, comunque, le analisi isotopiche rivelano laloro utilità e l’interpretazione accurata dei risultati sirivela preziosa per confermare o smentire <strong>del</strong>le ipotesidi partenza sulla caratterizzazione e la provenienza<strong>del</strong> materiale usato come supporto scrittorio. Ciò puòessere dimostrato dal campione n° 89 15 (fig.6) - costituito da un litotipo grigio scuro -per il quale mediante preliminari osservazionimacroscopiche 16 si era ipotizzato si trattassedi un’ardesia cavata presso Lavagna,nell’Appennino Ligure 17 o di una roccia vulcanica<strong>del</strong> Vesuvio 18 ; i risultati <strong>del</strong>le analisiisotopiche sembrano smentire tali ipotesipoiché la coppia di valori numerici (δ 13 C=0,6; δ 18 O = -3,2) rimanda alle aree di approvvigionamentodi Paros 2 (3) e di Afrodisia.Questi dati suggeriscono innanzi tutto che ilmateriale lapideo in oggetto sia un marmo;inoltre, confronti macroscopici con i marmiscuri più usati nel mondo romano induconoad ipotizzare che si tratti <strong>del</strong> bigio antico obigio morato, una pietra estratta in svariatelocalità greche (Isola di Lesbo e di Chios) eanatoliche (Teos, Izmir e Afrodisia) 19 . Inaccordo con i risultati archeometrici, si ipotizzaquindi una provenienza da Afrodisia 20 .Dall’esame dei risultati ottenuti emergonodue dati importantissimi: il primo è che i20 litotipi analizzati sono marmi e non altritipi di rocce, quali ad esempio quelle vulcaniche21 ; il secondo è la prevalenza dei marmicon valori di δ 13 C compresi tra 0,6 ÷ 3,6 e diδ 18 O tra 0,7 ÷ 4,2, che permette di individuarequali aree di approvvigionamento quelleanatoliche <strong>del</strong> Proconneso 1 e di Afrodisia ea quelle greco-insulari di Taso 1, Taso 2 eParos 2 (3) 22 (fig. 3).Dall’integrazione degli esiti <strong>del</strong>le analisidi laboratorio con le notizie desunte dallaletteratura sui marmi storici 23 e con le caratteristichemacroscopiche dei materiali lapideipiù usati nel mondo romano 24 , sembraemergere che l’area dalla quale proviene lamaggior parte dei supporti impiegati adAbellinum è quella <strong>del</strong> Proconneso 1 e ingenerale <strong>del</strong>la regione anatolica 25 . Ciò porta ad ipotizzareche nel periodo che va dalla prima metà <strong>del</strong> IValla prima metà <strong>del</strong> VI - nel quale si datano la maggiorparte <strong>del</strong>le epigrafi prese in considerazione nel presentelavoro - le cave di quest’area geografica fosseroancora attive e che è da esse che venivano importati lamaggior parte dei materiali marmorei verso la penisolaitalica ed in particolare verso il Meridione 26 .Fig. 4 - Epigrafe n° 80, a.a. 492/497 (Abellinum, basilica cimiteriale di ‘Capo la Torre’ ad Atripalda,Deposito <strong>del</strong>la Soprintendenza ai Beni Archeologici <strong>del</strong>le Province di SA-AV-BN).Fig. 5 - Epigrafe n° 95, a.a. 432/521 (Abellinum, basilica cimiteriale di ‘Capo la Torre’ ad Atripalda,Deposito <strong>del</strong>la Soprintendenza ai Beni Archeologici <strong>del</strong>le Province di SA-AV-BN).- 31 -
SALTERNUMTale dato sembra trovare conferma anche per altricontesti <strong>del</strong>l’Italia meridionale, per Roma, Porto edOstia nello stesso periodo 27 . Il marmo <strong>del</strong>le cave <strong>del</strong>Proconneso - con le sue qualità bianche, bianco-grigioe azzurrognole - era tra i più diffusi nell’impero romanoed era anche tra i più economici, come si evincedall’Editto dei Prezzi di Diocleziano. La sua esportazioneverso Occidente continuò anche nel periodobizantino.Fig. 6 - Epigrafe n° 89 (Abellinum, basilica cimiteriale di ‘Capo la Torre’ Atripalda,Deposito <strong>del</strong>la Soprintendenza ai Beni Archeologici <strong>del</strong>le Province di SA-AV-BN).Nonostante queste ipotesi, però, non possiamoescludere che in realtà tali materiali fossero di reimpiegoe che provenissero da edifici di età romana dismessi,rispecchiando quindi relazioni commerciali di fasiprecedenti.Tra i manufatti epigrafici qui considerati, alcunirecano segni evidenti di riuso (n 1 8 e 61) e quindi sipuò ipotizzare che si tratti di lastre originariamentedestinate ad un’edilizia monumentale pubblica o privatadi alto livello, rilavorate con perizia da abili lapicidi.Per le restanti 18, ugualmente, non si può escludere ilreimpiego da edifici preesistenti. Questa ipotesipotrebbe essere avvalorata dal ritrovamento di edificipubblici o privati con le stesse tipologie di materiali 28 .Se - come pare più verosimile - si tratta di marmidi reimpiego e non ‘freschi di cava’, dalla qualità evarietà dei supporti lapidei di queste iscrizioni emergechiaramente - in accordo con i caratteri epigrafici - chequesti manufatti erano espressione di una committenzadi ceto elevato e di un saper fare artigianale che nontrova finora termini di comparazione nella pur consistenteproduzione coeva <strong>del</strong>la Campania 29 .Dal punto di vista <strong>del</strong>le considerazioni storiche, vaosservato che il declino <strong>del</strong>la colonia romana diAbellinum viene posto generalmente in concomitanzacon l’arrivo di Alarico e dei suoi uomini nel 410 d. C.,poi con quello di Genserico nel 455 d. C. e successivamentecon l’eruzione vesuviana cosiddetta di Pollena<strong>del</strong> 505 o 512 d. C. - di cui restano tracce anche nel sito<strong>del</strong>l’attuale Capo La Torre - nonché con le ripercussioni<strong>del</strong>la Guerra greco-gotica (535-553 d. C.) 30 .Per l’antica Abellinum gli indicatori archeologiciattualmente disponibili - e in particolare proprio laricca documentazione epigrafica ed i rivestimentiparietali in opus sectile <strong>del</strong>la basilica cristiana - induconoa leggere una realtà di sostanziale tenuta <strong>del</strong>le condizioniprecedenti agli eventi <strong>del</strong> VI secolo d. C. 31 .Le ipotesi fatte sulla base dei risultati qui descritti insintesi incoraggiano ad approfondire ulteriormente leindagini archeometriche mediante studi minero-petrografici,per determinare una sicura provenienza deimarmi 32 e ad estendere le analisi di laboratorio a tutto ilcorpus epigrafico e ai rivestimenti parietali in opus sectilerestituiti dalla stessa basilica paleocristiana di Abellinum,al fine di ottenere un quadro più completo dei litotipiutilizzati e <strong>del</strong>le relative aree di provenienza.Se ne potranno ricavarne ulteriori dati utili allaricostruzione di importanti aspetti storico-archeologicinon solo inerenti al contesto specifico, ma anche aquello più ampio <strong>del</strong>l’intero territorio abellinate neisecoli <strong>del</strong>la Tarda Antichità 33 .- 32 -
MARIANNA MELFINote1OLCESE 2000, p. 25.2Per l’ideazione <strong>del</strong>la sperimentazione e<strong>del</strong>le sue linee guida cfr. LAMBERT 2006, pp.51-54; EAD. 2008, pp. 52-67; EAD. 2009,pp. 101-104.3Il presente articolo sintetizza i risultati<strong>del</strong>la tesi di Laurea Specialistica inArcheologia di chi scrive (MELFI 2009-2010), discussa presso l’Università degliStudi di Salerno sotto la guida dei proff.C. LAMBERT e C. LUBRITTO, cui si deve lamessa a punto <strong>del</strong>la sperimentazione inoggetto.4MELFI 2009-2010, p. 2. Cfr. LAMBERT2006, pp. 51-54; EAD. 2008, pp. 52-67;EAD. 2009, pp. 101-104.5FARIELLO SARNO 1991, pp. 11-34; EAD.1996, p. 161; LAMBERT 2008, pp.14-16.6FARIELLO SARNO 2003, p. 619; SOLIN 1998,pp. 471-484. L’intero corpus epigrafico diAbellinum è stato studiato analiticamente dalprof. HEIKKI SOLIN e sarà pubblicato inuno specifico volume <strong>del</strong>le ICI (SOLIN cds).7MELFI 2009-2010, pp. 27-28. Cfr. SOLIN1998, pp. 471-484; ID. cds; LAMBERT 2008,capp. I, II; V.8MELFI 2009-2010, pp. 43-45.9EAD., Ibidem, p. 45.10EAD., Ibidem, p. 46.11EAD., Ibidem, p. 50.12GORGONI et Alii 2002, p. 123.13MELFI 2009-2010, pp. 54-55.14EAD., Ibidem, pp. 53-59.15EAD., Ibidem, pp. 55-56.16GIGANTINO 2006-2007, pp. 37-38.17BRUNO 2002, pp. 277-278.18PRICE 2008, p. 214.19ID., Ibidem, pp. 75-76.20MELFI 2009-2010, p. 56.21EAD., Ibidem, p. 60.22EAD., Ibidem, pp. 54, 60.23PENSABENE 2002, pp. 203-221.24PRICE 2008, pp. 61-186.25MELFI 2009-2010, p. 54.26GIGANTINO 2009-2010, pp. 32-33; MELFI2009-2010, p. 61.27PENSABENE -ALVAREZ I PEREZ 1998, p.364; PENSABENE et Alii 2007, pp. 433-434.28MELFI 2009-2010, p. 61.29LAMBERT 2008, pp.14-16.30Bibliografia di riferimento in MELFI 2009-2010, pp. 61-62.31EAD., Ibidem, pp. 61-62.32LAZZARINI - TURI 2007, pp. 588-595.33MELFI 2009-2010, p. 62.- 33 -
SALTERNUMBibliografiaBRUNO M. 2002, Il mondo <strong>del</strong>le cave in Italia:Considerazioni su alcuni marmi e pietre usati nell’antichità,in DE NUCCIO et Alii 2002, pp.277-289.DE NUCCIO et Alii 2002, DE NUCCIO M. -UNGARO L. - LAZZARINI L. - PENSABENE P.(a cura di), I marmi colorati <strong>del</strong>la Roma imperiale.Catalogo <strong>del</strong>la mostra, Venezia.FARIELLO SARNO M. 1991, Il complesso paleocristianodi S. Ippolisto-Capo la Torre. Nuove scopertee prospettive di ricerca, in “Rassegna StoricaIrpina”, Rivista semestrale <strong>del</strong>la SocietàStorica Irpina, a. II, nn. 3-4, pp. 11-34.FARIELLO SARNO M. 1996, Abellinum paleocristiana,in PESCATORI COLUCCI G. (a curadi), L’Irpinia antica, Vol. I, in PESCATORICOLUCCI G. - CUOZZO E. - BARRA F. (a curadi), Storia illustrata di Avellino e <strong>del</strong>l’Irpinia,Pratola Serra (AV), pp. 161-175.FARIELLO SARNO M. 2003, Atripalda-Necropoli, in CIAVOLINO N., Scavi e scoperte diArcheologia Cristiana in Campania dal 1983-1993, in Atti <strong>del</strong> VII Congresso Nazionale diArcheologia Cristiana, Università degli Studi diCassino 1993, Cassino, pp. 618-623.FRANCOVICH R. - MANACORDA D., (a curadi) 2000 Dizionario di Archeologia 2000,Dizionario di archeologia, a cura di , Bari.GIGANTINO E. 2006/2007 (ined.), Epigrafia,archeologia e scienze mineralogiche: primi risultatidi uno studio sulle iscrizioni tardoantiche diAbellinum, Tesi di Laurea Triennale inEpigrafia Medievale, C.d.L. in Scienze deiBeni Culturali, Università degli Studi diSalerno (Relatore: prof.ssa C. LAMBERT;Correlatore: prof. A. LANGELLA), a.a. 2006-2007.GIGANTINO E. 2009/2010 (ined.),Archeometria ed epigrafia: nuovi dati dalle iscrizionitardoantiche di Abellinum, Tesi di LaureaSpecialistica in Archeologia Tardoantica,Università degli Studi di Salerno (Relatore:prof.ssa C. LAMBERT; Correlatore: prof. C.LUBRITTO), a.a. 2009-2010.GORGONI C. et Alii 2002, An updated anddetailed mineropetrographic and C-O stable isotopicreference database for the main Mediterranean marblesused in Antiquity, Boston 1998, in AttiASMOSIA V, Interdisciplinary Studies onAncient Stone, J. J. jr. HERMANN, N. HERZ, R.NEWMAN eds., London, pp. 115-131.LAMBERT C. 2006, Epigrafia, Archeologia eScienze geomineralogiche: acquisizioni recenti enuovi progetti multidisciplinari per lo studio <strong>del</strong>laCampania tardoantica e medievale, in Atti <strong>del</strong> IVCongresso Nazionale di Archeologia Medievale,S. Galgano (Chiusdino–Siena) 2006, a cura diR. FRANCOVICH - M. MILANESE, Firenze,pp. 51-54.LAMBERT C. 2007 a , Iscrizioni di vescovi e presbiterinella Campania tardoantica ed altomedievale(secc. IV-VIII), in “Schola Salernitana”,Annali, XI (2006), pp. 31-70.LAMBERT C. 2008, Studi di epigrafia tardoantica emedievale in Campania. Volume I. Secoli IV-VII,Collana «Medioevo scavato», «ScholaSalernitana», 3, Firenze.LAMBERT C. 2009, Epigrafia, Archeologia escienze geomineralogiche: nuovi risultati dai materialitardoantichi e medievali di ‘Abellinum’ e‘Beneventum’, in Atti <strong>del</strong> V CongressoNazionale di Archeologia Medievale, Foggia2009, a cura di G. VOLPE - P. FAVIA,Firenze, pp. 101-104.LAZZARINI L.-TURI B. 2007, L’identificazionedei marmi bianchi più usati nell’antichità, inPENSABENE et Alii 2007, pp. 588-595.MELFI M. 2009/2010 (ined.), Le iscrizioni<strong>del</strong>la Basilica paleocristiana di Abellinum-Atripalda: primi risultati archeometrici, Tesi diLaurea Specialistica in ArcheologiaTardoantica, Università degli Studi diSalerno (Relatore: prof.ssa C. LAMBERT;Correlatore: prof. C. LUBRITTO), a.a. 2009-2010.OLCESE G. 2000, s.v. Archeometria, inFRANCOVICH - MANACORDA, 2000, pp. 25-29.PENSABENE P. 2002, Le principali cave dimarmo bianco, in DE NUCCIO et Alii 2002, pp.203-221.PENSABENE P.-ALVAREZ I PEREZ A. 1998,Marmi antichi 2: cave e tecnica di lavorazione, provenienzae distribuzione, Roma.PENSABENE et Alii 2007, PENSABENE P. -LAZZARINI L. - MARTINEZ M. P. - TURI B.2007, Ostiensium marmorum decus etdecor: studi architettonici, decorativi e archeometrici,vol. 33, Roma.PRICE M. T. 2008, Atlante <strong>del</strong>le pietre decorative,Milano.SOLIN H. 1998, Le iscrizioni paleocristiane diAvellino, in Epigrafia romana in area adriatica.Actes de la IX rencontre franco-italienne sur l’épigraphiedu mond romain, Macerata 1995, pp.471-484.SOLIN H. cds, (a cura di), Abellinum,Inscriptiones christianae Italiae septimo saeculoantiquiores (ICI), Bari.- 34 -
ROSANNA BARONEIl Complesso di San Pietro a Corte in Salerno:restituzione in 3D <strong>del</strong>la fase tardoanticaIl Complesso monumentale di San Pietro aCorte si configura come uno dei principalidocumenti architettonici <strong>del</strong>la città di Salernotardoantica e medievale.La fitta stratigrafia e l’antichità <strong>del</strong> sito impedisconodi analizzare in dettaglio le singole strutture superstiti;partendo dalle evidenze archeologiche e dall’analisi didocumenti di scavo, è stata pertanto realizzata un’ipotesiricostruttiva che restituisce gli alzati <strong>del</strong>la fase tardoantica,caratterizzata dalla trasformazione di un precedenteedificio termale, da tempo in disuso, in un edificiodi culto cristiano con annesso cimitero privilegiato.Gli interventi di riconversione funzionale hannointeressato la ricostruzione di archi e ghiere, che furonoin seguito obliterati da altre strutture, e le coperture,nonché alcune porzioni <strong>del</strong>la pavimentazione.Nella restituzione grafica 3D si è proposto a livellodi ipotesi l’inserimento di un triphorium sulla parete checostituì, ad un tempo, il muro di chiusura <strong>del</strong>l’area cimiterialee la facciata <strong>del</strong> sacello paleocristiano; lungo lepareti perimetrali nord e sud sono state posizionate<strong>del</strong>le bifore, di dimensioni e ad un’altezza che sonoparse compatibili con la volumetria generale <strong>del</strong>l’impiantoe con alcune tracce persistenti sulle murature.Il lavoro, condotto con finalità epistemologichecomputazionali, in totale interazione tra più archeologie informatici, ha coinvolto in primo luogo chi hadiretto lo scavo nel XX secolo - il prof. Paolo Peduto<strong>del</strong>l’Università degli Studi di Salerno -, ma anche chiha lungamente frequentato il sito a restauro ormaiavvenuto e condotto studi su strutture coeve di altricontesti – la prof.ssa Chiara Lambert.L’avanzamento <strong>del</strong> lavoro è stato sottoposto acostante verifica, con la discussione di problemi generalie di dettaglio, apportando le opportune correzionialle soluzioni ipotetiche, il cui ampio margine di ipotesipotevano sconfinare nella creazione di un ‘falso’.Fig. 1 - Rilievo grafico assonometrico <strong>del</strong>l’area cimiteriale realizzata con Autocad(ambiente C), (dati Archivio prof. P. Peduto).I software utilizzati per la realizzazione di questoprogetto sono stati: Adobe Photoshop per l’elaborazione<strong>del</strong>le immagini, Blender e 3d Studio Max per la ricostruzionetridimensionale <strong>del</strong> complesso monumentale diSan Pietro a Corte e Autocad per l’analisi 2D.Gli alzatiIl primo lavoro effettuato è stato quello <strong>del</strong>la raccoltadati, rappresentati dai rilievi grafici e fotograficidi piante e alzati realizzati duranti gli scavi archeologicicurati negli anni ’70-’80 <strong>del</strong> secolo scorso dal prof.P. Peduto 1 .La prima fase <strong>del</strong>la realizzazione - la costruzionedegli alzati - è stata resa possibile utilizzando in partefotopiani e restituzioni in Autocad eseguiti in passato dauna ditta specializzata; si è così evidenziata una primaipotesi <strong>del</strong>la struttura <strong>del</strong>la fase tardoantica (fig. 1).- 35 -
SALTERNUMFig. 2 - Ricostruzione in 3D <strong>del</strong>la parete nord e <strong>del</strong> settore nord-orientale <strong>del</strong>l’areacimiteriale.Fig. 3 - Area cimiteriale (ambiente C),parete nord. Arcosolio con la tomba diSocrates.Fig. 4 - Area cimiteriale (ambiente C), paretenord. Ghiera di arcone romano.Lo studio è iniziato con la parete nord, ambiente C,con la ricostruzione in 3D 2 (fig. 2) sia <strong>del</strong>l’arco monumentaleche ospita una tomba privilegiata, il quale è inparte ricoperto ad Ovest da un muro di rinforzo <strong>del</strong>periodo arechiano, sia quello <strong>del</strong>la ghiera romanaposta accanto (figg. 3-4). A sua volta la ghiera è quasicompletamente occupata ad Ovest dal pilastro altomedievalee ad Est da un ulteriore muro di rinforzo. Inseguito sono state analizzati gli altri muri legati all’areacimiteriale.Nella zona sud <strong>del</strong>l’ambiente C la parete presentauna soglia d’ingresso (figg. 5-6), che durante la fase tardoanticaè possibile fungesse da accesso all’area cimiteriale,in quanto il precedente ingresso, legato al periodoromano, fu obliterato ed intonacato per far posto allatomba ad arcosolio <strong>del</strong> vir spectabilis Socrates (fig. 3).Anche questa parete è stata ricostruita, con l’aggiuntadi un’apertura ad arco, poiché sul muro neerano evidenti le tracce (figg. 7-8).Per quanto riguarda la parete est, poiché le successivefasi le si sono sovrapposte, non è stato possibileipotizzare alcuna ricostruzione.Riguardo all’area <strong>del</strong> sacello paleocristiano, infine,non si hanno resti tali da permetterne un’analisi esau-Fig. 5 - Area cimiteriale (ambiente C), parete sud.Fig. 6 - Area cimiteriale (ambiente C), parete sud. Particolare <strong>del</strong>la soglia d’ingresso.- 36 -
ROSANNA BARONEstiva, a causa <strong>del</strong>le successive fasi di frequentazione <strong>del</strong>sito. Per gli alzati si è potuta ipotizzare la presenza diun triphorium, il quale assolveva la duplice funzione difacciata e accesso al luogo di culto e, contemporaneamente,di parete orientale di chiusura <strong>del</strong>l’area cimiteriale(figg. 9-10-11-12).Nel periodo tardoantico il fe<strong>del</strong>e poteva entrare nelcomplesso dall’ingresso sulla parete sud e, dopo averattraversato il cimitero, ad Est si ritrovava di fronte untriphorium, che offriva un accesso monumentale alla piccolachiesa. Questa era formata da un’aula unica rettangolarecon dei gradini interni ancor oggi in situ (fig. 13);la struttura terminava con un’abside quadrata che recatutt’ora tracce di intonaci e incisioni preparatorie per unprobabile mosaico parietale (figg. 14-15).Per quanto riguarda le pareti nord e sud <strong>del</strong> sacello,l’analisi dei fotopiani e dei disegni di scavo ha per-messo di ipotizzare la presenza di una bifora nellaparte superiore e di archi nella parte inferiore; è probabileche tali archi fossero stati aperti nel periodoromano e successivamente chiusi nella fase tardoantica(fig. 16).Dopo aver effettuato la costruzione in 3D deglialzati si è passati all’inserimento <strong>del</strong>le volte: esse presentavanouna struttura a crociera all’interno <strong>del</strong>l’area cimiterialee a botte a copertura <strong>del</strong> sacello paleocristiano.La finalità scientifica posta a premessa <strong>del</strong> lavoro èstata rispettata ed il risultato ottenuto consente divisualizzare in maniera chiara una serie di struttureantiche che, col passare <strong>del</strong> tempo, non hanno conservatola loro integrità. Il mo<strong>del</strong>lo ricostruito, senza alterarel’esistente, si propone come un’esemplificazioneapplicativa <strong>del</strong>le risorse <strong>del</strong>la multimedialità, di cuisono evidenti le potenzialità per affinare la letturaFig. 7 - Area Cimiteriale (ambiente C). Dettaglio<strong>del</strong>l’ingresso.Fig. 8 - Ricostruzione in 3D <strong>del</strong>la parete sud e <strong>del</strong>settore sud-est <strong>del</strong>l’area cimiteriale (ambiente C).Figg. 9-10 - Area cimiteriale (ambiente C), parete est.Figg. 11-12 - Ricostruzioni 3D <strong>del</strong>la parete est <strong>del</strong>l’area cimiteriale.- 37 -
SALTERNUMFig. 13 - Abside <strong>del</strong> sacello paleocristiano (ambiente D), particolare <strong>del</strong>la ricostruzionein 3D.Fig. 15 - Abside <strong>del</strong> sacello paleocristiano (ambiente D), parete sud. Linee diagonaligraffite sull’intonaco, verosimile preparazione di una stesura musiva.Fig. 14 - Abside <strong>del</strong> sacello paleocristiano (ambiente D), parete sud. Figura di un pavonegraffita sull’intonaco, verosimile preparazione di una stesura musiva.Fig. 16 - Sacello paleocristiano (ambiente sud). In alto, tracce di una bifora; in basso, arcoromano, probabilmente tamponato nella fase tardoantica e successivamente coperto dauna fodera muraria affrescata (XII sec.).Fig. 17 - Pianta <strong>del</strong>l’area cimiteriale (ambiente C), con sovrapposizione <strong>del</strong>le lastrepavimentali superstiti.Fig. 18 - Area cimiteriale (ambiente C). Texture <strong>del</strong>la superstite pavimentazione a lastremarmoree su preparazione in battuto di malta.- 38 -
ROSANNA BARONEdegli elementi superstiti, favorirne la comprensione e,in una prospettiva auspicabile, renderne più efficace lafruizione a livello didattico-museale.Appendice sulle tecniche applicateTextureTerminato questo primo step, ci si è indirizzati aduna seconda fase di lavoro che prevedeva l’inserimento<strong>del</strong>le texture 3 ; l’operazione che si è presentata di unamaggiore complessità è stata quella <strong>del</strong>la realizzazione<strong>del</strong>la texture <strong>del</strong>la pavimentazione nella fase tardoantica.La pavimentazione superstite è ubicata in tuttol’ambiente C, mentre nell’ambiente D se ne conservanopoche tracce. Per la restituzione <strong>del</strong>la pavimentazionesono state scattate fotografie zenitali eseguite insitu con apparecchio digitale; le immagini sono statepoi inserite nel perimetro geometrico 4 .La realizzazione <strong>del</strong>la prima texture si è rivelatamolto impegnativa, poiché è stato necessario elaborareil materiale fotografico per ogni singola lastra, modificandogli eventuali toni di luce, i contrasti e bilanciandoi colori. Per posizionare con esattezza le lastre ci si èavvalsi <strong>del</strong>la pianta di scavo. Affinché la texture nonrisultasse ‘piatta’ all’interno <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo tridimensionale,è stata realizzata una bump mapping 5 (figg. 17-18).Un’ulteriore texture è stata rappresentata dall’intonacoparietale. Dall’analisi <strong>del</strong>le tracce in situ è statopossibile ipotizzare che nella fase tardoantica la strutturafosse ricoperta da un intonaco molto chiaro, ilquale rivestiva totalmente le murature romane.Un’altra texture è quella usata per la lapide diSocrates; per evidenziare l’incisione <strong>del</strong> testo scrittosulla lastra è stata realizzata, anche in questo caso, unabump mapping (figg. 19-20).Presso l’abside sono state inserite le texture di ciòche rimane degli intonaci e <strong>del</strong>le incisioni di un probabilemosaico parietale; per le colonne <strong>del</strong> triphorium e<strong>del</strong>le monofore infine è stata inserita una texture dimarmo chiaro.LuciPer calcolare l’intensità <strong>del</strong>la luce visibile in undeterminato punto <strong>del</strong>la superficie di un oggetto,viene utilizzato un ‘mo<strong>del</strong>lo di illuminazione’. Unalgoritmo di rendering superficiale usa i valori di intensitàattraverso un mo<strong>del</strong>lo di illuminazione per deter-minare l’intensità <strong>del</strong>la luce per tutti i pixel appartenentialle varie superfici nella scena.I mo<strong>del</strong>li di illuminazione fisica coinvolgononumerosi fattori, come il tipo di oggetto, la posizione<strong>del</strong>l’oggetto in relazione alla sorgente luminosa e adaltri oggetti <strong>del</strong>la scena. Questi ultimi possono esserecomposti di un materiale opaco, oppure di un materialepiù o meno trasparente e possono avere inoltre unasuperficie luminosa o buia, oppure composta da unavarietà di texture superficiali. Le sorgenti luminosesono di vario tipo, colore e posizione e possono essereusate per conferire effetti di illuminazione allascena. Una volta forniti i parametri per le proprietàottiche <strong>del</strong>le superfici, la posizione relativa di esseall’interno <strong>del</strong>la scena, il colore e le posizioni <strong>del</strong>le sorgentiluminose, i mo<strong>del</strong>li di illuminazione calcolanol’intensità proiettata da un particolare punto superficialein una specifica direzione 6 .Per l’illuminazione <strong>del</strong> Complesso di San Pietro acorte sono state inseriti il Daylight System per gli esternied lo Sky Portal per l’illuminazione degli interni.Rendering finaleIl rendering è il processo di generazione di una o piùimmagini effettuato a partire dalla descrizione matematicadi una scena tridimensionale, la quale vieneinterpretata da algoritmi che calcolano il colore di tuttii pixel che compongono l’immagine. Tale descrizione èfornita in un linguaggio o in una struttura dati e devecontenere la geometria, il punto di vista, le informazionisulle caratteristiche ottiche <strong>del</strong>le superfici visibilie sull’illuminazione.Nella computer grafica 3D, un materiale che abbiaun aspetto naturale viene definito mediante un valorecostante dei colori oppure mediante Texture. Esistonodiverse tecniche, alcune in tempo reale, altre chenecessitano di lunghi tempi di calcolo, le quali, pertanto,agiscono nei motori di rendering 7 . In un materialeprocedurale, valgono le seguenti proprietà:Ambient Lighting: descrive il colore <strong>del</strong>l’oggettomediante un valore costante e simula l’illuminazioneindiretta <strong>del</strong>l’ambiente;Diffuse Lighting: descrive il comportamento di unasuperficie ‘matta’, che distribuisce la luce equamentein tutte le direzioni;Specular Lighting: stabilisce con quale colore edintensità un corpo debba riflettere la luce di una sorgenteluminosa; una buona approssimazione di un- 39 -
SALTERNUMFig. 19 - Texture <strong>del</strong>l’epigrafe funeraria <strong>del</strong> vir spectabilis Socrates († 497).Fig. 20 - Particolare <strong>del</strong>la restituzione in 3D <strong>del</strong>l’epigrafe funeraria di Socrates.comportamento reale viene ottenuta mediante l’utilizzodi un’apposita mappa (detta Specular Map) che indica,pixel per pixel, il comportamento che la superficiedeve mantenere per quanto concerne la specularità;Emissive Lighting: descrive l’autoilluminazione deglioggetti, come ad esempio le lampade;Transparence: descrive l’opacità di un materiale;Reflection: simula le riflessioni su di un oggettomediante il semplice uso di una texture, che prestabilisceun’immagine che si rifletterà sulla superficie <strong>del</strong>l’oggetto,oppure mediante un complesso algoritmo diraytracing, che fa sì che sulla superficie <strong>del</strong>l’oggetto sirifletta realmente l’ambiente circostante.Molte <strong>del</strong>le tecniche elencate non riproducono fisicamentei fenomeni di luce, ma ne danno una convincenteillusione.- 40 -
ROSANNA BARONENoteQuesto testo costituisce una sintesi <strong>del</strong>la propria Tesi di Laurea Specialistica in Archeologia: Il Complesso di San Pietro a Corte in Salerno: restituzionein 3D <strong>del</strong>la fase Tardoantica, Università degli Studi di Salerno, a.a. 2007-2008 (Relatore: prof. P. Peduto e Correlatore prof. M. Nappi).1PEDUTO et Alii 1988, pp. 9-63.2I rilievi grafici e fotografici sono stati fornitidal prof. Peduto che ne ha debitamenteautorizzato l’utilizzo.3La grafica computerizzata tridimensionaleè la scienza, lo studio e il metodo diproiezione <strong>del</strong>la rappresentazione matematicadi oggetti tridimensionali tramiteun’immagine bidimensionale. Essa si avvaledi tecniche come la prospettiva e l’ombreggiatura(shading) per simulare la percezionedi questi oggetti da parte <strong>del</strong>l’occhioumano. I mo<strong>del</strong>li 3D sono una collazione didati (punti ed informazioni) che spessorisiedono virtualmente all’interno <strong>del</strong>lamemoria di un computer. Un mo<strong>del</strong>lo 3D ècomposto essenzialmente di due sottoelementi:i vertici e gli archi (o sponde) che siconnettono tra di loro. L’unione di questidue elementi dà vita ad un reticolo dettowireframe, che è lo stadio elementare <strong>del</strong>mo<strong>del</strong>lo 3D (RUSSO 2005).4La Texture è un’immagine di tipo bitmaputilizzata per rivestire la superficie di unoggetto virtuale, tridimensionale o bidimensionale,con un apposito programma digrafica (FOLEY et Alii 1997 b ).5La documentazione fotografica è stata realizzataappositamente dalla prof.ssaC. Lambert, che ringrazio vivamente.6IL Bump Mapping descrive i vari rilievi (ointagli) che possono coprire una superficie,mediante l’uso di una mappa in scala di grigio.Le aree bianche <strong>del</strong>la mappa solitamentespecificano un rilievo, mentre quelle nereun’incavatura; l’intensità di tali operazioni,invece, è data dall’intensità <strong>del</strong> colore: biancoperfetto (valore RGB=0,0,0) per un’estrusionemassima, nero perfetto (valoreRGB=255,255,255) per un’intrusione massimae grigio perfetto (valoreRGB=128,128,128) per lasciare invariata lasuperficie; è inutile dire che valori intermediavranno effetti intermedi (c’è da tenereconto <strong>del</strong> fatto che la bump map non estrudeo intrude letteralmente le facce <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>loma, come già detto, indica tali dettagli almo<strong>del</strong>lo di illuminazione; quest’ultimo sipreoccuperà di creare ‘l’illusione’ che talidettagli siano effettivamente presenti sull’oggetto),(ENGEL 2006).7FOLEY et Alii 1997 a .- 41 -
SALTERNUMBibliografiaENGEL W. 2006, ShaderX5: AdvancedRendering Techniques, Oxford.FOLEY et Alii 1997 a , FOLEY J. D.- VAN DAMA.-FEINER S.K.-HUGHES J. F., ComputerGraphics: Principles and Practice, Second Editionin C, Los Angeles.FOLEY et Alii 1997 b , FOLEY J.D.-VAN DAMA.-FEINER S.K.-HUGHES J.F.-PHILLIPSR. L., Introduction to Computer Graphics,Oxford.PEDUTO et Alii 1988, Un accesso alla storia diSalerno: stratigrafie e materiali <strong>del</strong>l’area palazialelongobarda, in ‘Rassegna Storica Salernitana’,10, pp. 9-63.RUSSO M. 2005, Polygonal Mo<strong>del</strong>ing: Basic andAdvanced Techniques, Oxford.- 42 -
GILDA NAPOLILa Piana <strong>del</strong> Sele alla fine <strong>del</strong>l’Età <strong>del</strong> Rame:riflessioni per un inquadramento culturaleÈ’ con l’età <strong>del</strong> Rame, la cui durata è compresain un periodo che va dalla primametà <strong>del</strong> IV alla metà <strong>del</strong> III millennio a.C. ca. 1 , che nella piana <strong>del</strong> Sele appaiono i primi significativifenomeni di complessità sociale 2 , emersi graziealle diverse campagne di scavo effettuate nel corso <strong>del</strong>XX secolo.Due sono gli orizzonti culturali attestati, la facies <strong>del</strong>Gaudo e la facies di Laterza, inquadrabili cronologicamente,la prima nell’Eneolitico medio, la secondanell’Eneolitico finale.La necropoli <strong>del</strong> Gaudo, situata nella località eponimaa ca. 2 km a Nord di Paestum e scoperta nel 1943,si estende su una superficie di 2000 m 2 e consta di 43tombe, di cui 34 esplorate in maniera sistematica 3 . Oltrea Paestum, contesti di tipo Gaudo sono noti a MirabellaEclano 4 , a Buccino 5 , ad Eboli 6 , a Pontecagnano 7 , aPiano di Sorrento 8 , a Napoli Materdei 9 e recentementea Caivano 10 e, con un’unica tomba, ad Acerra 11 , per ilterritorio <strong>del</strong>la Piana Campana (fig.1).In Campania, le testimonianze <strong>del</strong>la facies <strong>del</strong>Gaudo sono esclusivamente di tipo funerario e solonegli ultimi anni si sono aggiunti interessanti rinvenimentida contesti abitativi nell’area romana 12 .Per lo studio <strong>del</strong>la facies di Laterza 13 , il cui areale didiffusione interessa tutta l’Italia centro-meridionale,notevole importanza hanno avuto le indagini archeologicheeseguite nell’area <strong>del</strong>la Piana Campana, per larealizzazione di grandi impianti infrastrutturali, comela citta<strong>del</strong>la <strong>del</strong>la Marina Militare degli Stati Uniti inlocalità Boscariello <strong>del</strong> Comune di Gricignanod’Aversa 14 (Caserta), la linea Alta Velocità Roma-Napoli 15 e le indagini condotte nell’area <strong>del</strong> PoloCalzaturiero <strong>del</strong> comune di Carinaro 16 (Caserta).Materiali di tipo Laterza sono stati rinvenuti, inoltre,nelle aree interne <strong>del</strong>la Campania centro-settentrionale17 , nel vallo di Diano, dove, nella Grotta <strong>del</strong>Fig. 1 -Fig. 2 -Pino 18 , presso Sassano, sono stati raccolti frammentiinquadrabili in un orizzonte avanzato <strong>del</strong>la facies e,verso la costa, a Pontecagnano 19 e a Paestum (fig. 2).- 43 -
SALTERNUMA Pontecagnano, come a Paestum, è stata notataun’interessante polarità tra la facies <strong>del</strong> Gaudo e quelladi Laterza. Infatti, in prossimità <strong>del</strong> fiume Picentino,nel corso degli scavi effettuati nel 1992 da GianniBailo Modesti, è stata individuata una vasta necropoliinteramente riferibile alla facies <strong>del</strong> Gaudo, che perampiezza e qualità dei reperti recuperati, può essereconsiderata uno dei principali ritrovamenti dopo lanecropoli eponima. Solo pochi chilometri la separanodal nucleo di sepolture in località S. Antonio 20 , compostodalle TT. 1497, 551 e 548, e la T. 156 in propr.Negri (scoperte negli anni ’60), dove ai materiali tipici<strong>del</strong> Gaudo si affiancano quelli <strong>del</strong>l’orizzonte eneoliticodi Laterza. La tomba 1497, costituita da un pozzettodi accesso che si apriva in una nicchia semicircolare,conteneva due scheletri in un cattivo stato di conservazionee, come corredo, due bicchieri biconici 21 ,un’olla biansata 22 di tipo Gaudo insieme ad una tazzatroncoconica 23 riconducibile al repertorio di Laterza; laT. 548, interpretata come una fossa poco profondacon un solo inumato in posizione rannicchiata sulFig. 3 -fianco destro, conteneva due ollette e una tazza globulareinornata 24 tipo Laterza; la T. 551, una grotticellacon un vestibolo di forma irregolare, anch’essa con unsolo inumato in posizione rannicchiata sul fiancodestro, conteneva una tazza globulare tipo Laterza,decorata con motivo a zig-zag 25 . La T. 156, isolatarispetto agli altri ritrovamenti, in fossa terragna, contenevaun unico scheletro accompagnato da una tazzatroncoconica con orlo indistinto 26 .Interessante è segnalare, a Pontecagnano, l’assenzadi sepolture collettive tra le tombe attribuibili all’orizzonteLaterza, caratteristica che ne legittima l’accostamentoal sito di Gricignano d’Aversa e a quello diCastel Baronia.A Gricignano 27 , nell’area <strong>del</strong>la citta<strong>del</strong>la U.S. Navy,sono state indagate sul paleosuolo cd. <strong>del</strong>le ‘PomiciUmificate’, formatosi a tetto <strong>del</strong>l’eruzione di Agnano-Monte Spina, due necropoli: la prima nell’area <strong>del</strong>‘Forum’, costituita da una quarantina di tombe la maggiorparte a inumazione singola in fossa semplice (rettangolareo subellittica), la seconda nell’area <strong>del</strong>‘Centro Commerciale’ con 155 tombe e nell’area <strong>del</strong>‘Bowling’ con 20 tombe, anche qui monosome in fossasemplice (subrettangolare o circolare) o a pseudogrotticella.Lo stesso rituale è attestato a Castel Baronia 28 consepolture singole in fossa semplice. Dalla T. 139 diCastel Baronia si dispone <strong>del</strong>la seguente datazioneradiometrica ottenuta su carbone, 3257-2914 B.C. cal.1σ, che risulta essere abbastanza alta, indicando la presenzadi attestazioni di tipo Laterza già alla fine <strong>del</strong> IVmillennio 29 .In più a Gricignano come ad Afragola, significativaè la sequenza geo-archeologica, poiché i livelli attribuitialla facies di Laterza sono compresi tra due eventieruttivi altamente distruttivi: il flusso piroclastico<strong>del</strong>l’eruzione flegrea di Agnano-Monte Spina (2780-2610 a. C. cal.) alla base, e quella vesuviana <strong>del</strong>lePomici di Avellino (1782-1690 a. C. cal.) alla sommità30 . Per Afragola si dispone, inoltre, di una datazioneradiometrica ottenuta su carboni da un’area di combustione<strong>del</strong> lotto 13: 2660-2460 a. C. cal. 1σ 31 .Particolare attenzione merita la necropoli eneoliticadi facies Laterza <strong>del</strong>l’area archeologica di Paestum 32(fig. 3). Alla luce <strong>del</strong>l’esame analitico, che verrà qui sinteticamentepresentato, si può affermare che la necropolidi Paestum si pone come un elemento di cernierafra l’area campana e laziale 33 , con cui condivide parte<strong>del</strong> repertorio ceramico, e l’area apulo-lucana (di cui lanecropoli di Laterza è il caso più emblematico) doveprevale la sepoltura collettiva 34 , rappresentata dalla T. 4nel caso di Paestum.La necropoli si inserisce in un contesto sconvoltodall’urbanizzazione storica <strong>del</strong>la colonia greca diPoseidonia, a circa 60 m a Nord/Ovest <strong>del</strong> tempio cd.di Cerere. Era formata da cinque tombe, ubicate pressouna depressione triangolare <strong>del</strong> banco roccioso ditravertino. Le uniche tombe ancora oggi chiaramenteindividuabili sono la T. 4 e la T. 5: a pseudo-grotticella<strong>del</strong>imitata da quattro lastroni irregolari di travertino- 44 -
GILDA NAPOLIla prima; a grotticella la seconda. La T. 4, di dimensionimaggiori, in fase di scavo risultava riempita danumerose inumazioni sconvolte e solo in una nicchiaera superstite uno scheletro di adulto rannicchiato sulfianco destro 35 . La T. 5 conteneva una sola deposizionemal conservata ma verosimilmente anch’essa inposizione rannicchiata 36 . Delle TT. 1, 2 e 3 non rimanedocumentazione grafica esaustiva e non è possibileubicarle con precisione nell’area <strong>del</strong>la necropoli.L’area indagata doveva essere a sola destinazionefuneraria; l’abitato, invece, si suppone fosse nelle vicinanze,anche se archeologicamente non ve n’è traccia.Lo studio tipologico <strong>del</strong> repertorio ceramico, rappresentatodai corredi 37 <strong>del</strong>le TT. 1, 2, 4 e 5, è stato funzionalealla costruzione di una cronologia interna allanecropoli, che, seppur costituita da poche sepolture,potrebbe essere stata utilizzata per un arco di tempoabbastanza ampio; ciò ha anche permesso di analizzarele possibili ricadute di tale seriazione nell’ambitodegli altri contesti di facies Laterza <strong>del</strong>l’Italia centromeridionale.Punto di riferimento per la costruzione<strong>del</strong>la seriazione è la scansione in tagli <strong>del</strong>la tomba 3 diLaterza secondo i livelli presentati da F. Biancofiore 38 .Nella T. 5 risulta essere presente un tipo attestatonei tagli più bassi <strong>del</strong>la tomba 3 di Laterza, vale a direla patera a decorazione radiale, sia interna che esterna,con vasca poco profonda 39 (fig. 4): è probabile, quindi,che l’utilizzo di questa tomba sia inquadrabile nell’orizzonteiniziale 40 <strong>del</strong>la facies. Anche per la tomba 1 sipuò ipotizzare un utilizzo in un momento iniziale, inquanto sono presenti dei tipi (oltre alla patera a decorazioneradiale con vasca profonda, anche la sco<strong>del</strong>laemisferica con tratto <strong>del</strong>l’orlo sopraelevato) attestatisempre nei tagli più bassi <strong>del</strong>la tomba 3 di Laterza.Invece nella T. 4, secondo la seriazione crono-tipologica,il repertorio vascolare sembra indicare una frequentazioneche si protrae fino alle fasi recenti<strong>del</strong>l’Eneolitico, poiché, oltre ai tipi riferibili al primoorizzonte <strong>del</strong>la facies pugliese, vi sono due reperti dinotevole valore diagnostico: una tazza carenata condiametro massimo alla carena 41 (fig. 5) e un boccalebreve a profilo arrotondato 42 (fig. 6), entrambi confrontabilicon i medesimi tipi rinvenuti nello strato Xdi Laterza 43 . La tazza carenata è caratterizzata da unadecorazione a grossi punti excisi, che trova confrontinell’Italia centrale, precisamente nell’areale di diffusione<strong>del</strong>la facies di Ortucchio 44 .Dallo studio tipologico, risultano essere presentinella necropoli <strong>del</strong>l’area archeologica di Paestumforme ceramiche tipiche sia di un momento inizialeche di un momento finale <strong>del</strong>la facies, quindi la sua frequentazionericopre, probabilmente, l’intero periodo<strong>del</strong>la cultura di Laterza.Fig. 4 -Fig. 5 -Fig. 6 -- 45 -
SALTERNUMLa patera a decorazione radiale, considerato il ‘fossileguida’ <strong>del</strong>la facies, attestata a Piscina di TorreSpaccata, a Gricignano, a Carinaro e a Pontecagnano,oltre che a Paestum e a Laterza, conferma la definizionedi facies di Torrespaccata-Gricignano, già propostada D. Cocchi Genick 45 . L’‘aspetto tirrenico’ 46 diLaterza risulta contraddistinto da uno specificomo<strong>del</strong>lo insediativo con tombe a fossa all’interno <strong>del</strong>l’abitatoo nelle vicinanze 47 , proprio come nei siti diPiscina di Torrespaccata, Osteria <strong>del</strong> Curato, CastelBaronia e Gricignano.Quindi l’evidenza di Paestum, nel suo insieme, siricollega piuttosto all’‘aspetto sud-orientale’ 48 diLaterza, caratterizzata da una rarefazione antropica siarispetto alla precedente facies <strong>del</strong> Gaudo sia rispettoalle coeve testimonianze <strong>del</strong>la Piana Campana, conun’occupazione episodica <strong>del</strong> territorio in piccolinuclei cimiteriali pertinenti verosimilmente a comunitàdi entità limitata.Forse non è <strong>del</strong> tutto inesatto parlare di una koinèlucana ante litteram, in quanto il rituale funerario <strong>del</strong>lasepoltura plurima, il tipo di struttura tombale (la grotticellaartificiale) e la presenza di vasi a forma chiusa,in particolare il boccale breve, sono aspetti che colleganola T. 4 di Paestum direttamente alle TT. 402 e403 di Lavello (Potenza) 49 .- 46 -
GILDA NAPOLINote1Per un quadro aggiornato di tutte le datazioniradiometriche disponibili dai siti eneolitici<strong>del</strong> territorio campano, cfr.PASSARIELLO et Alii 2010, p. 29, tab. 2.2ARCURI 1989, p. 57.3Per quanto riguarda le indagini eseguitesubito dopo il secondo conflitto mondiale,vi sono i contributi di P. C. Sestieri, il qualemise in luce 19 tombe (SESTIERI 1946-1948,pp. 251-308) e le pubblicazioni di G. Voza,che diresse le campagne di scavo tra gli anni1962-1965 (VOZA 1964 pp. 265-274; ID.1974, pp. 7-24). Recente è la revisione <strong>del</strong>latomba ‘Brinson’ (dal nome <strong>del</strong> Tenente statunitenseche nel 1944 scavò e documentòaccuratamente una tomba rinvenuta semprein località Gaudo), realizzata da A. Salerno(SALERNO 1993, pp. 323-328; ID. 1995, pp.395-414.4TALAMO 2008, pp. 193-199: negli anniventi <strong>del</strong> Novecento, la necropoli diMadonna <strong>del</strong>le Grazie è stata rinvenutaprima <strong>del</strong>la scoperta <strong>del</strong>la necropoli eponimain contrada Gaudo a Paestum, che ne hadeterminato la definizione. Risulta costituitada 14 tombe, ma la più nota è quella <strong>del</strong>‘capo tribù’ (oggi ricostruita all’interno <strong>del</strong>Museo Irpino) che si distingue per alcunepeculiarità <strong>del</strong> rituale, per la ricchezza <strong>del</strong>corredo che avrebbe accompagnato ununico inumato, accanto al quale fu trovata ladeposizione di un cane.5HOLLOWAY 1974, pp. 43-49: si tratta <strong>del</strong>lanecropoli in località Sant’Antonio, situatasu un pianoro collinare <strong>del</strong>imitato dal corso<strong>del</strong> Tanagro e <strong>del</strong> Platano, e di un secondogiacimento, in località San Mauro, dove fuscoperto <strong>del</strong> materiale in giacitura secondarianel riempimento di un corso d’acqua.6BAILO MODESTI - SALERNO 1995, pp. 327-393: analogie con la necropoli di Buccinosono state evidenziate in quella venuta allaluce ad Eboli, in località Madonna <strong>del</strong>laCatena, costituita da 4 tombe monocellulariricavate in un banco calcareo di un’ampiacava.7BAILO MODESTI - SALERNO 1998, pp. 33-82.8ALBORE LIVADIE 1990, pp. 39-51: in localitàTrinità, nel 1987, dopo la scoperta fortuitadi una tomba a grotticella con riccocorredo, grazie ad una regolare campagnadi scavo sono state portate alla luce altre 4strutture funerarie di tipo analogo; già nel1874, in località Carotto, era stata scopertauna tomba con ricco corredo di cui orarimangono soltanto una brocca e un pugnalein metallo.9MARZOCCHELLA 1985, pp. 27-33: 2 tombea grotticella sono venute alla luce durante ilavori di sterro per la costruzione di un edificionel 1950, nella zona di NapoliMaterdei.10LAFORGIA - BOENZI – SIGNORELLI 2007,pp. 615-628; LAFORGIA - BOENZI 2009, pp.181-121: tra la fine <strong>del</strong> 2001 e gli inizi <strong>del</strong>2002, sotto l’allora Soprintendenza per iBeni Archeologici <strong>del</strong>le Province di Napolie Caserta, hanno avuto inizio le indaginiarcheologiche lungo il tratto destinatoall’Alta Velocità Roma-Napoli, poste tra ilmargine meridionale <strong>del</strong>la Prov. di Caserta el’area nord-orientale <strong>del</strong>la Prov. di Napoli. Iltracciato ferroviario entra nel territorio diCaivano all’altezza <strong>del</strong>l’area industriale ecosteggia i Regi Lagni fino al limite con ilcomune di Afragola (cfr. infra nota 15),dove devia verso Sud-Ovest in direzione diNapoli. Il ritrovamento <strong>del</strong>la necropoli diCaivano, costituita da 8 tombe a grotticellaartificiale monocellulari, tranne la T. 11,bicellulare, e la T. 10, a tre celle, è ubicatoall’interno <strong>del</strong>la zona industriale.11Si tratta <strong>del</strong>la T. 112, a grotticella artificialemonocellulare, in loc. Parmiano (RONGA1998, pp. 85-91).12ANZIDEI et Alii 2007 a , pp. 565-568: manufatticorrelabili con la facies <strong>del</strong> Gaudo sonostati identificati nell’insediamento diTorrino-Mezzocammino 1 e 2, nel villaggiodi Le Cerquete-Fianello a Maccarese e nell’areacompresa tra le vie Collatina e H.Spencer nel settore Est di Roma, durante ilavori per la costruzione <strong>del</strong>la tratta urbana<strong>del</strong>la linea A.V.13BIANCOFIORE 1967, pp. 195-300; ID. 1971,pp. 193-309: la facies prende il nome dallanecropoli individuata da F. Biancofiore nel1966 nel territorio di Laterza (Taranto). Lascoperta destò enorme scalpore per l’eccezionalità<strong>del</strong> materiale ritrovato; attraverso ilsuo studio si pervenne alla puntuale definizionedi una cultura che si distingueva dallealtre realtà, più o meno contemporanee,<strong>del</strong>la penisola, per un repertorio articolatodi fogge vascolari, tipi di anse e schemidecorativi, oltre che per la presenza dinuovi elementi nell’industria litica ed osseae nella produzione di oggetti di ornamento.Nel territorio di Laterza, nel corso <strong>del</strong>lecampagne di scavo effettuate tra il 1966 e il1968, vennero alla luce 8 tombe a grotticella:gli ipogei 2, 3, 4, 5 e 7 in ContradaCandile, l’ipogeo 1 in ContradaSpaccaturnisi e 6 presso la MasseriaGraziantonio, mentre <strong>del</strong>l’ipogeo 8 non neè precisata l’ubicazione. La più rilevante<strong>del</strong>le tombe, dal punto di vista archeologico,è la T. 3 che conteneva un centinaio diindividui e un ampio repertorio ceramico.14FUGAZZOLA DELPINO et Alii 2003, pp.199-214: tra il 1998 e il 2001, sotto la direzione<strong>del</strong>la Soprindentenza Speciale alMuseo Nazionale Preistorico Etnografico‘L. Pigorini’, è stata scavata l’area <strong>del</strong> ‘Forum’per un’estensione di ca. 7000 m 2 ; nel biennio2002-2004, sempre sotto la direzione<strong>del</strong>la Soprintendenza Speciale ‘L. Pigorini’,è stata indagata l’area destinata alla costruzione<strong>del</strong> ‘Centro Commerciale’ e quellalimitrofa <strong>del</strong> ‘Bowling’ per una superficiecomplessiva di 25000 m 2 (FUGAZZOLADELPINO - SALERNO - TINÈ 2007, pp. 521-537).15NAVA et Alii 2007, pp. 101-126: nel territorio<strong>del</strong> comune di Afragola, è stato scavatoun nucleo insediativo composto da abitazionia pianta ovale e circolare, con palocentrale e area di cottura, circondate darecinti. Le ceramiche associate sono di tipoLaterza, ma sono presenti anche frammentiriconducibili all’orizzonte campaniformee alla facies di Capo Graziano. Anche nel territoriocomunale di Caivano (Ibidem p. 112)sono stati evidenziati nuclei insediativi il cuimateriale archeologico riporta alla medesimafacies, indiziati da una capanna a piantasubovale e fila di pali centrali e da altrestrutture a pianta circolare e aree di combustione.Inoltre, a ca. 4 km a Nord <strong>del</strong>l’areainsediativa, è stato indagato un pozzo conprobabile funzione votiva (Ibidem p. 113),che conteneva 14 vasi su quattro livelli, il- 47 -
SALTERNUMcui repertorio presenta analogie stringenticon la facies di Laterza.16LAFORGIA - BOENZI - VISCONE 2007, pp.623-626: il sito si pone ad ovest <strong>del</strong>l’insediamentoU.S. Navy di Gricignano, a Sud <strong>del</strong>tracciato <strong>del</strong>le linea ferroviaria A.V. e a 7 kmdal corso <strong>del</strong> Regi Lagni. Sul paleosuolo atetto <strong>del</strong>l’eruzione di Agnano-Monte Spinaè stato rinvenuto un grande insediamento,inquadrabile in un momento avanzato<strong>del</strong>l’Eneolitico.17Per un inquadramento più ampio, cfr.TALAMO 2008, pp. 204-216; per il sito diIsca <strong>del</strong> Pero, Comune di Castel Baronia(Av), dove son stati rinvenuti un insediamentoe alcune tombe a fossa, cfr.GANGEMI 1988, pp. 570-571; per l’insediamentodi S. Maria a’ Peccerella pressoFoglianise (Bn), cfr. LANGELLA et Alii 2008,pp. 165-190; per la necropoli eneolitica diFelette, presso Torre Le Nocelle (Av), cfr.TALAMO - PALERMO ROSSETTI cds.18Pellegrini, Piperno 2003, pp. 393-405.19Cfr. supra, nota 7.20 D’AGOSTINO 1964, pp. 89-108; ID. 1974,pp. 87-108.21BAILO MODESTI - SALERNO 1996, p. 121,figg. 1.2-3.22IID., Ibidem, p. 121, fig. 1.4.23IID., Ibidem, p. 121, fig. 1.1.24 D’AGOSTINO 1964, p. 95, fig. 5,b.25ID., Ibidem, p. 105, fig. 13,c.26ID., Ibidem, p.105, fig.13,a.27Cfr. supra, nota 14.28Cfr. supra, nota 17.29ALBORE LIVADIE 1996, p. 132, nota 5.30NAVA et Alii 2007, p. 105.31EAD., Ibidem, p. 110.32VOZA 1962, pp. 13-37; SESTIERI 1965, pp.336-339; ARCURI - ALBORE LIVADIE 1988,pp. 568-569; per il rilievo planimetrico <strong>del</strong>lanecropoli cfr. ALBORE LIVADIE et Alii cds,fig. 2: la scoperta <strong>del</strong> giacimento preistoricoavvenne nel 1960 ad opera <strong>del</strong>l’archeologoGiuseppe Voza. I primi lavori di scavo portaronoalla luce un sito, il cui patrimonioergologico fu inquadrato in un momentocronologico che va dal Neolitico e all’Etàdei Metalli, caratterizzato da una prima faseinsediativa e una successiva fase funeraria.Nel 1961, data l’importanza e la ricchezzadei rinvenimenti, prese il via una nuovacampagna di scavo, promossa dallaSoprintendenza speciale al Museo Pigorini,diretta sempre dal Voza. L’anno successivo, ilSoprintendente presso il Museo Pigorini, dott.P. C. Sestieri, richiese alla Soprintendenza diSalerno una nuova campagna di scavo percompletare le ricerche; tale richiesta non ebbeesito e l’area non è stata più oggetto di indaginearcheologica. Agli inizi degli anni ’80,però, la documentazione <strong>del</strong>la necropoli èstata accuratamente e meticolosamente riordinataed esaminata dalla dott.ssa FlaminiaArcuri per il lavoro di tesi presso la Scuola diPerfezionamento in Archeologia e Antichitàdi Napoli. Successivamente il repertorio ceramicorelativo al periodo eneolitico è statooggetto di studio, nell’ambito di una piùampia classificazione tipologica <strong>del</strong>le formevascolari <strong>del</strong>la necropoli pestana e di tutti i sitiediti di facies Laterza <strong>del</strong>l’Italia centro-meridionale,per la tesi di laurea specialistica inArcheologia <strong>del</strong>la scrivente (cattedra diPreistoria e Protostoria <strong>del</strong>l’area vesuviana -Univ. degli Studi ‘Suor Orsola Benincasa’,Napoli, 19 dicembre 2008).33ALBORE LIVADIE et Alii cds.34In ambito pugliese, questo tipo di ritualeè attestato a Grotta Cappuccini pressoGalatone (INGRAVALLO 2002), con sepoltureipogeiche plurime in grotta naturale(dove colpisce l’alto numero di deposizioni,300 unità ca.), e nel gruppo degli ipogei diCasal Sabini presso Altamura (CATALDO1996).35ALBORE LIVADIE et Alii cds, fig. 3, A-B.36EAD., Ibidem, fig. 3, C.37La T. 1 ha restituito 20 reperti, tra cuiframmenti di patera a decorazione radiale esco<strong>del</strong>le emisferiche poco profonde. NellaT. 2 prevale la ceramica grossolana e ununico frammento di sco<strong>del</strong>la a decorazioneradiale, per cui poco rilevante è l’interessedal punto di vista tipologico. La T. 3, invece,ha restituito solo ceramica di epoca storicadai livelli più superficiali, tra cui sisegnalano 2 ffr. di ceramica a vernice nera.La T. 4, che costituisce l’evidenza più significativa<strong>del</strong> complesso sepolcrale, ha restituitoun cospicuo nucleo di materiali; dallaT. 5 provengono pochi reperti, tra cui duepatere a decorazione radiale.38Biancofiore suddivide la tomba in tredicitagli (BIANCOFIORE 1967, p. 204 ss.), dove,secondo la seriazione crono-tipologica elaboratadalla scrivente, i tagli XIII, XII-XIII,XI-XII-XIII, XI-XII, X-XI-XII risultanorelativi alla fase arcaica <strong>del</strong>la facies, mentrerelativi alla fase recente sono i tagli X, IX-X, IX, VIII-IX, VII.39ALBORE LIVADIE et Alii cds, fig. 4,1.40Già R. Peroni aveva sottolineato la necessitàdi distinguere due gruppi nell’ambito<strong>del</strong>l’evidenza pugliese: il gruppo di Andria el’orizzonte di Laterza (PERONI 1971, pp.314-320). D. Cocchi Genick ipotizza un’articolazionein almeno due fasi <strong>del</strong>la necropoli,per cui propone la definizione diLaterza 1 e Laterza 2 (COCCHI GENICK1996, p. 608).41ALBORE LIVADIE et Alii cds, fig. 4,4.42EAD., Ibidem, fig. 4,3.43Per la tazza carenata cfr. BIANCOFIORE1967, p. 291, fig. 51,27; per il boccale brevecfr. ID. 1967, p. 289, fig. 50,11.44Per l’Eneolitico in Abruzzo e la facies diOrtucchio, cfr. RADI 1988, pp. 370-377.L’ipotesi <strong>del</strong> confronto, già avanzata dalladott.ssa F. Arcuri nella propria tesi diPerfezionamento, è avvalorata oggi dall’evidenza<strong>del</strong>lo scavo di Osteria <strong>del</strong> Curato, dovead un livello di facies Laterza segue immediatamenteun livello di facies Ortucchio(ANZIDEI et Alii 2007b, pp. 491-496.45COCCHI GENICK 2008, p. 437.46Questa definizione (da affiancare a quellaindicata da D. Cocchi Genick, per il qualecfr. supra, nota 45) raggruppa in manieracomplessiva i siti <strong>del</strong>l’area campano-laziale,caratterizzati da una medesima tipologiainsediativa e sepolcrale e da un comunerepertorio ceramico.47COCCHI GENICK 2007, p. 453.48La necropoli si pone come testa di pontetra l’area campano-laziale e l’area apulolucana(ALBORE LIVADIE et Alii, cds.). Con isiti <strong>del</strong>l’areale tirrenico condivide la presenza<strong>del</strong>la patera a decorazione radiale ascrivibile,secondo la seriazione crono-tipologica,alle fasi iniziali <strong>del</strong>la facies; mentre con i siti<strong>del</strong>l’areale apulo-lucano condivide la presenzadi strutture ipogeiche e quella parte<strong>del</strong> repertorio ceramico, costituito prevalentementeda forme chiuse, ascrivibile allefasi finali <strong>del</strong>la facies.49CIPOLLONI SAMPÒ 1988, pp. 559-560.- 48 -
GILDA NAPOLIBibliografia‘AION’, Annali Dipartimento di Studi <strong>del</strong>Mondo Classico e <strong>del</strong> Mediterraneo Antico,Istituto Orientale di Napoli, sez.Archeologia e Storia Antica, Napoli.ALBORE LIVADIE C. 1990, Il sepolcreto eneoliticoin località Trinità, in ALBORE LIVADIE C. (acura di), Archeologia a Piano di Sorrento.Ricerche di Preistoria e Protostoria nella PenisolaSorrentina, Napoli, pp. 39-51.ALBORE LIVADIE C. 1996, Articolazioni cronologiche<strong>del</strong> Bronzo Antico, in COCCHI GENICKD. (a cura di), L’antica età <strong>del</strong> Bronzo in Italia,Atti Viareggio, pp. 122-126.ALBORE LIVADIE C. - ARCURI F. - NAPOLIG. cds, Vecchi scavi, nuove conferme: riesame <strong>del</strong>lanecropoli di facies Laterza presso il tempio diCerere (Paestum, Salerno), in AttiIIPP, XLIII.ANZIDEI et Alii 2007 a , ANZIDEI A. P. -BUCCELLATO A. - CARBONI G. - TORRI C.2007, Ceramiche <strong>del</strong>la facies <strong>del</strong> Gaudo provenientida via H. Spencer, nei pressi <strong>del</strong>la via Collatina(Roma), in AttiIIPP, XL, pp. 565-568.ANZIDEI et Alii 2007 b , ANZIDEI A. P. -CARBONI G. - CASTAGNA M. A. - CELANT A.- CIANCA M. - EGIDI R. - FAVORITO S. -FUNICIELLO R. - GIORDANO G. - MALVONEM. - TAGLIACOZZO A., L’abitato eneolitico diOsteria <strong>del</strong> Curato - via Cinquefrondi: nuovi datisulle facies archeologiche di Laterza e Ortucchio nelterritorio di Roma, in AttiIIPP, XL, pp. 477-508.ARCURI F. 1989, Preistoria e Protostoria, inCANTALUPO P. - LA GRECA A. (a cura di),Storie <strong>del</strong>le terre <strong>del</strong> Cilento antico, Agropoli, pp.53-63.ARCURI F. - ALBORE LIVADIE C. 1988,Paestum (Salerno): Le tombe eneolitiche presso iltempio di Cerere, in L’età <strong>del</strong> Rame in Europa,Atti Viareggio, 7, pp. 568-569.AttiIIPP, Atti <strong>del</strong>la Riunione Scientifica<strong>del</strong>l’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria,Firenze.Atti Viareggio, Atti <strong>del</strong> Congresso Internazionale diViareggio, Rassegna di Archeologia, Firenze.BAILO MODESTI G. - D’AGOSTINO B. -GASTALDI P. (a cura di), Seconda mostra <strong>del</strong>laPreistoria e Protostoria nel <strong>Salernitano</strong>, Salerno,pp. 7-24.BAILO MODESTI G. - SALERNO A. 1995, IlGaudo di Eboli, in ‘Origini’, XIX, pp. 327-393.BAILO MODESTI G. - SALERNO A. 1996,Articolazioni culturali e cronologiche. L’Italiameridionale: Campania, in COCCHI GENICK D.(a cura di), L’antica età <strong>del</strong> Bronzo in Italia,Atti Viareggio, pp. 119-122.BAILO MODESTI G. – SALERNO A. 1998,L’evidenza di Pontecagnano, in Pontecagnano. II.5. La necropoli eneolitica. L’età <strong>del</strong> Rame inCampania nei villaggi dei morti, in ‘AION’,Quad. n. 11, pp. 33-82.BIANCOFIORE F. 1967, La necropoli eneoliticadi Laterza, in ‘Origini’, I, pp. 195-300.BIANCOFIORE F. 1971, Origini e sviluppo <strong>del</strong>leciviltà preclassiche nell’Italia sud-orientale, in‘Origini’, V, pp. 193-309.CATALDO L. 1996, La tomba di Casal Sabini ei rinvenimenti funerari tra Eneolitico ed età <strong>del</strong>Bronzo nel territorio di Altamura (Bari): le faciesculturali indigene e i contatti transadriatici e con ilMediterraneo orientale, in ‘Origini’, XX, pp.109-164.COCCHI GENICK D. 1996, Manuale diPreistoria. III. L’età <strong>del</strong> Rame, Firenze.COCCHI GENICK D. 2007, Considerazioni sullepresenze Laterza nei siti tirrenici, in AttiIIPP,XL, pp. 437-459.COCCHI GENICK D. 2008, Articolazione territorialenell’età <strong>del</strong> rame: problemi di terminologia,in Atti <strong>del</strong>l’incontro di Studi ’Preistoria eProtostoria in Etruria’,VIII, pp. 429-440.CIPOLLONI SAMPÒ M. 1988, Le tombe 402 e403 di Lavello (Potenza, Basilicata), in AttiViareggio, 7, pp. 559-560.D’AGOSTINO B. 1964, Di alcuni rinvenimentipreistorici a Pontecagnano (Salerno), in ‘BPI’, 73,pp. 89-108.D’AGOSTINO B. 1974, Pontecagnano, in BAILOMODESTI - D’AGOSTINO - GASTALDI 1974,pp. 47-108.FUGAZZOLA DELPINO et Alii 2003,FUGAZZOLA DELPINO M. A. - SALERNO A.- TAGLIACOZZO A. - TINÈ V. - VANZETTI A.,Una comunità <strong>del</strong>la facies Laterza nella pianuracampana: l’area “Forum” di Gricignano - USNavy (CE), in AttiIIPP, XXXV, pp. 199-214.FUGAZZOLA DELPINO M. A. - SALERNO A.- TINÈ V. 2007, Villaggi e necropoli <strong>del</strong>l’area“Centro Commerciale” di Gricignano d’AversaUS Navy (Caserta), in AttiIIPP, XL, pp. 521-537.GANGEMI G. 1988, Un insediamento di tipoLaterza a Castel Baronia (Avellino), in AttiViareggio, 7, pp. 570-571.HOLLOWAY R. R. 1974, Buccino, in BAILOMODESTI - D’AGOSTINO - GASTALDI 1974,pp. 43-49.INGRAVALLO E. 2002, Grotta Cappuccini(Galatone) tra eneolitico e primo bronzo, Galtina.LAFORGIA E. - BOENZI G. 2009, La necropolieneolitica di Caivano (Napoli), in ‘RSP’, LIX,pp. 191-218.LAFORGIA E. - BOENZI G. - SIGNORELLI C.2007, Caivano (Napoli). Nuovi datisull’Eneolitico dagli scavi A.V. La necropoli <strong>del</strong>Gaudo, in AttiIIPP, XL, pp. 615-618.LAFORGIA E. - BOENZI G. - VISCONE M.2007, Un insediamento <strong>del</strong>l’Eneolitico finale aCarinaro: dati preliminari dagli scavi condottiall’interno <strong>del</strong> Polo Calzaturiero, in AttiIIPP,XL, pp. 623-626.LANGELLA et Alii 2008, LANGELLA M. -ANDALORO E. - BOCCI M. - BOSCAINO M. -COPPA A. - CURCI A. - DE FRANCESCO A.M. - SENATORE M. R. - RAMPA R. - VARGIUR., Foglianise (Benevento), loc. S. Maria a’Peccerella: un insediamento di tipo Laterza, in‘RSP’, LVIII, pp. 165-190.MARZOCCHELLA A. 1985, L’Eneolitico aNapoli, in Napoli Antica, Catalogo <strong>del</strong>laMostra, Napoli, pp. 27-33.NAVA et Alii 2007, NAVA M. L. - GIAMPAOLAD. - LAFORGIA E. - BOENZI G., Tra Clanis eil Sebeto: nuovi dati sull’occupazione <strong>del</strong>la pianacampana tra il Neolitico e l’età <strong>del</strong> Bronzo, inAttiIIPP, XL, pp. 101-126.‘Origini’, ‘Origini. Preistoria e Protostoria<strong>del</strong>le Civiltà Antiche’, Roma.PASSARIELLO et Alii 2010, PASSARIELLO I. -TALAMO P. - D’ONOFRIO A. - BARTA P. -LUBRITTO C. - TERRASI F., Contribution ofradiocarbon dating to the chronology of Eneolithicin Campania (Italy), in ‘Geochronometria’,35, pp. 25-33. (anche in:http://www.geochronometria.pl/).PELLEGRINI E. - PIPERNO M. 2003, Ritualifunerari <strong>del</strong>l’età <strong>del</strong> bronzo dalla grotta <strong>del</strong> Pino diSassano (SA) nel Vallo di Diano, in AttiIIPP,XXXV, pp. 393-405.PERONI R. 1971, L’età <strong>del</strong> bronzo nella penisolaitaliana. I. L’antica età <strong>del</strong> bronzo, Firenze.RADI G. 1988, L’Eneolitico in Abruzzo, inAtti Viareggio, 7, pp. 370-377.RONGA G. 1998, L’evidenza nella Piana diAcerra, in Pontecagnano. II. 5 La necropoli eneo-- 49 -
SALTERNUMlitica. L’età <strong>del</strong> Rame in Campania nei villaggi deimorti, in ‘AION’, Quad. n. 11, pp. 85-91.‘RSP’, ‘Rivista di Scienze Preistoriche’,Firenze.SALERNO A. 1993, Revisione <strong>del</strong>la tombaBrinson: lo scavo, in ‘AION’, 15, pp. 323-328.SALERNO A. 1995, Revisione <strong>del</strong>la tombaBrinson: i materiali, in ‘Origini’, XIX, pp. 395-414.SESTIERI P. C. 1946-1948, Primi risultati dalloscavo <strong>del</strong>la necropoli eneolitica di Paestum, in‘Rendiconti <strong>del</strong>l’Accademia di Archeologia,Lettere e Belle Arti di Napoli’, XXIII, pp.251-308.SESTIERI P. C. 1965, Il giacimento preistorico diPaestum, in Atti <strong>del</strong> VI Congresso Internazionale<strong>del</strong>le Scienze Preistoriche e Protostoriche, II,Comunicazione, sez. I-IV, Firenze, pp. 336-339.TALAMO P. 2008, Le aree interne <strong>del</strong>laCampania centro-settentrionale durante le fasi evolute<strong>del</strong>l’eneolitico: osservazioni sulle dinamiche culturali,in ‘Origini’, XXX, pp. 187-220.TALAMO P. - PALERMO ROSSETTI A. cds.,Primi dati sulla necropoli eneolitica in loc. Felettedi Torre Le Nocelle, in AttiIIPP, XLIII.VOZA G. 1962, Paestum. Giacimento presso iltempio di Cerere - Paestum, in D’AGOSTINO B.- NAPOLI M. - VOZA G. (a cura di), Mostra<strong>del</strong>la preistoria e protostoria nel <strong>Salernitano</strong>,Salerno, pp. 13-37.VOZA G. 1964, Ultimi scavi <strong>del</strong>la necropoli <strong>del</strong>Gaudo, in AttiIIPP, VIII-IX, pp. 265-274.VOZA G. 1974, Necropoli <strong>del</strong> Gaudo, in BAILOMODESTI - D’AGOSTINO - GASTALDI 1974,pp. 7-24.- 50 -
SALTERNUMSEMESTRALE DI INFORMAZIONE STORICA, CULTURALE E ARCHEOLOGICAA CURA DEL GRUPPO ARCHEOLOGICO SALERNITANO
GABRIELLA D’HENRYEditorialeVita da … ArcheologoNello scorso secolo, intorno agli anniCinquanta/Sessanta, eravamo in pochiad esercitare il mestiere <strong>del</strong>l’Archeologo.Ma anche allora gli inizi non erano molto agevoli.Era un mestiere per pochi, e possibilmente senzapreoccupazioni economiche; e questi pochi non eranopresi molto in considerazione.Si favoleggiava che al British Museum, o al Museo<strong>del</strong> Louvre, il numero dei tecnici corrispondeva all’interoorganico di tutta Italia; e credo che ci fosse <strong>del</strong>vero in questa considerazione. Eravamo aggregati alMinistero <strong>del</strong>la Pubblica Istruzione, nel cui ambito sioccupava dei Beni Culturali soltanto una DirezioneGenerale.Anche allora ci si lamentava, ma le nostre lamentelenon scalfivano la coscienza dei nostri amministratori.Poi, con gli anni Settanta, le cose cominciarono acambiare. Ci furono personaggi illuminati, si cominciòa parlare <strong>del</strong>la memoria storica e <strong>del</strong> Bene Culturalecome fonte di crescita civica e, indirettamente, comeoccasione di ricchezza: i più sprovveduti paragonaronoil nostro patrimonio al ‘petrolio italiano’. Fu istituito ilMinistero per i Beni Culturali, che venne retto pro temporeda un intellettuale, il senatore Giovanni Spadolini.Si cominciò a prendere in considerazione l’immissionemassiccia di giovani nell’ambito <strong>del</strong>le Soprintendenze.E ci fu un aumento d’interesse, si cominciò a parlare dinoi non solo come i responsabili <strong>del</strong>l’interruzione diutili lavori pubblici e privati, ma anche come protagonistidi una crescita culturale <strong>del</strong> Paese.Si moltiplicarono, a mio parere esageratamente, leScuole di Specializzazione in Archeologia e Storia<strong>del</strong>l’Arte, quasi una per Università; aumentarono gliallievi appassionati alla materia.Ora, a detta <strong>del</strong>la Presidente <strong>del</strong>la nuovaFederazione degli Archeologi Professionisti, dottoressaMonica Viscione, gli Archeologi con il diritto dichiamarsi tali sono circa 3.000. E, se fossimo un Paeseserio, queste 3.000 persone, assunte in pianta stabile,sarebbero appena sufficienti a tenere dietro a tutti iproblemi che si affacciano quotidianamente nelleSoprintendenze, dagli scavi d’urgenza a quelli preventivi,dalla inventariazione allo studio dei materiali rinvenuti,dalla creazione di contenitori adatti alla conservazionedei reperti - che è quanto ci resta <strong>del</strong>la nostraStoria - all’invenzione di percorsi ed itinerari mirati acoinvolgere i cittadini di questo Paese in una meditazionesu un ricco ed importante passato.Qualche dato più preciso: i 3.000 laureati inArcheologia al momento possono essere assorbitinelle Università e nelle Soprintendenze per un numeronon superiore a 600; gli altri, sotto varie forme,rientrerebbero nella categoria dei precari, privi di unasicura prospettiva di lavoro e privi anche <strong>del</strong>la possibilitàd’essere coperti da un’assicurazione per un lavoronon senza rischi; oltre alla certezza di essere ricompensaticon cifre ben inferiori alla loro funzione.Ma ora, con l’istituzione <strong>del</strong>la Federazione ArcheologiProfessionisti, e con la creazione di altre Associazionianaloghe, gli Archeologi hanno alzato la testa e sonodeterminati a far valere i propri diritti. Certamente,con la legislazione attuale non si può far molto; in questesituazioni l’importante è avere le idee chiare perpoter richiedere una revisione totale <strong>del</strong>la materia,attraverso incontri e commissioni, nei quali si possadiscutere alla pari tra lavoratori, amministratori edesperti di politica culturale.- 53 -
MONICA VISCIONELa Federazione Archeologi ProfessionistiLa Federazione Archeologi Professionisti, sorta aSalerno da qualche mese, riunisceArcheologi - soprattutto campani - cheintendono l’associazione come uno strumento comuneper incidere sulle scelte politiche relative ai BeniCulturali <strong>del</strong> nostro Paese, che credono che l’archeologiasia pedina fondamentale sullo scacchiere <strong>del</strong>latutela e <strong>del</strong>la valorizzazione <strong>del</strong> nostro patrimonio eche per questo contestano la politica dei tagli allaCultura. Essi affermano che la ricerca, la tutela e lavalorizzazione <strong>del</strong> nostro patrimonio debbano essereun volano per lo sviluppo sostenibile e per la crescitacivile ed economica <strong>del</strong> paese.La Federazione afferma fortemente la professionalitàdei suoi aderenti: nel Paese con la più alta concentrazionedi Beni Culturali al mondo, i professionistiche si prendono cura <strong>del</strong> patrimonio culturale nonhanno diritto di cittadinanza e non hanno mai ottenutoun riconoscimento professionale.Gli archeologi <strong>del</strong>la FAP credono fortemente nelvalore <strong>del</strong>la conservazione preventiva e contestano laprassi <strong>del</strong>l’emergenza; sottolineano l’importanza <strong>del</strong>laqualificazione <strong>del</strong>le imprese e dei professionisti cheintervengono sul patrimonio culturale, che deve esserefondata su adeguati requisiti di natura professionale.Per questo motivo, il ruolo <strong>del</strong> Ministero per i Benie le Attività Culturali va rilanciato e non mortificato,come invece si cerca di fare oggi.Gli Archeologi italiani sono studiosi la cui formazioneprevede 4 anni di Corso di Laurea universitariopiù 3 di Specializzazione e/o di Dottorato; essi sonoformati in un paese con una altissima percentuale diBeni archeologici, paese nel quale la spesa per la culturaè una percentuale infinitesimale <strong>del</strong> bilancio pubblico:0,18%. Si è passati, infatti, dai 2,1 miliardi <strong>del</strong>2003 agli 1,4 per il 2011. Un paese che sul mercato privatonon riconosce la loro professionalità; lo stessoFig. 1 - La tessere associativa <strong>del</strong>la FAP.Fig. 2 - Il Presidente, Monica Viscione (a destra) ed il Segretario, Teresa Virtuoso inoccasione <strong>del</strong>la 1 a Assemblea <strong>del</strong>la FAP (Salerno, Complesso di S. Pietro a Corte).paese in cui ogni anno sono circa 3000 i laureati inmaterie archeologiche, ma che ha alle dipendenzepubbliche solo 350 Archeologi strutturati presso ilMinistero, 150 nelle Università e 100 presso pochi evirtuosi Enti locali; lo stesso paese in cui il 51% degliArcheologi è un lavoratore occasionale o a progetto eil 14,84% è un libero professionista con Partita IVA.Lo stesso paese in cui all’ultimo concorso per funzionarioarcheologo presso il MIBAC le domande di partecipazionesono state 5551 per 30 posti. Ce l’ha fatta- 55 -
SALTERNUM1 su 185; gli altri contribuiscono a presidiare il nostropatrimonio in altri modi: lo status lavorativo prevalente èquello di collaboratore occasionale (per il 26,30%), dicollaboratore a progetto-ex co.co.co (per il 24,74%), unadiscreta parte è libero professionista (14,84%), mentrein bassissima percentuale (solo il 4,69%) è un lavoratoredipendente privato o un lavoratore dipendente pubblico(3,66%); bassa è la percentuale (8,85%) di socio o titolaredi società o cooperative, così come l’assegnista o borsistapresso l’Università. Gli Enti per i quali si lavorasono prevalentemente le società o cooperative private(45,25%); il 21,25% opera per le Università; il 19,25%per il Ministero e le Soprintendenze e in bassissima percentuale(8,75%) per i Musei (fonte: inchiesta de ‘L’E-SPRESSO’).Ma all’interno di questo panorama così vario vi èuna costante: l’Archeologia è un effetto collaterale e lo‘scavo di emergenza’ è diventata una regola<strong>del</strong>l’Archeologia italiana. La missione non è più quelladi fare ricerca sul campo per realizzare la conservazionepreventiva, aumentare le nostre conoscenze e arricchireil nostro patrimonio, ma di intervenire in emergenzain occasione di opere pubbliche e, con moltadifficoltà, di opere private. L’Archeologo così è pagatodall’impresa edile, ma deve rispondere <strong>del</strong> suo lavoroalla Soprintendenza: il suo committente è privato,ma deve fare l’interesse <strong>del</strong> Pubblico e non è assuntoné dall’una né dall’altra parte!La maggior parte degli Archeologi ha lo status dilibero professionista nella forma, ma è precario nellasostanza e passa da un incarico all’altro spesso conlunghe interruzioni. Il compenso varia dai 50 ai rari edeccezionali 200 Euro lordi al giorno. Sì, al giorno. Mavi assicuro che si è anche costretti ad accettare contrattiil cui compenso è calcolato ad ore, a cui vannosottratti gli oneri fiscali e contributivi per un totale <strong>del</strong>48%; se lo scavo si ferma per il maltempo non siincassa nulla, non vi sono ferie, non c’è la malattia!Certo non siamo i soli a vivere queste situazioni, adesercitare in condizioni difficili sia dal punto di vista<strong>del</strong>le regole di mercato, sia per i redditi bassi, sia perl’assenza di tutele sociali: in Italia sono oltre 3 milionigli individui che esercitano attività professionali nonregolamentate. Anche i giovani architetti, gli ingegneri,nonostante siano tutelati dagli Albi, subisconocome noi questo stato di precarietà, la concorrenza alribasso, le paghe al lumicino e con ritardi inaccettabiliquando il committente è un Ente pubblico.Ma per noi c’è una difficoltà in più: rispondiamocontemporaneamente al privato e al pubblico e il committenteti paga sì, ma non vede l’ora di liberarsi di te;siamo un ostacolo, un impedimento alla realizzazionedei loro progetti! Per i grandi lavori pubblici o le grandiimprese private chi vince le gare lo fa con il massimoribasso e spesso si rifà abbattendo i costi degliArcheologi; non vi sono regole: in teoria le impresepossono avvalersi anche di chi Archeologo non è osostituire un professionista che svolge onestamente ilsuo lavoro, senza dover giustificare tale scelta. Si consentealle imprese di vincere le gare con offerte cheprevedono lo scavo ‘a metro cubo’, ma lo scavo almetro cubo non è forse inconciliabile con le esigenzee le regole <strong>del</strong>la ricerca?La flessibilità, per carità, non è una malattia, ma civogliono regole certe, condizioni di tutela chiare econdivise. Non vogliamo più essere figure ridotte amanovalanza intellettuale, quasi sempre sottopagata einquadrata con contratti atipici, privi degli elementaridiritti e tutele; senza dover giustificare tale scelta,vogliamo invece che gli Archeologi, sulla base di adeguatirequisiti di natura professionale, ottengano ilriconoscimento legislativo e contrattuale; vogliamoindividuare in modo condiviso percorsi univoci perriconoscere chi effettivamente va inserito a pieno titoloin questa categoria. Esiste una leggesull’Archeologia preventiva. Avremmo voluto un elencodi persone abilitate a svolgerla e invece si sono fatteliste con valore solo consultivo e che comprendevanocirca 4000 Archeologi. Ci chiediamo: tutti abilitati asvolgere le operazioni previste dalla legge? Chiediamoun regolamento che dica chi è l’Archeologo, cosa devefare, quali sono le regole <strong>del</strong>l’Archeologia preventiva edegli scavi di emergenza, e anche quali sono le sueresponsabilità.Come ha ricordato il Dott. Malnati in una recenteintervista ad un noto settimanale, queste regole nonesistono, anzi sono ferme al 1913 e si occupano solo<strong>del</strong>la proprietà dei Beni ritrovati. Cito testualmente:«cent’anni dopo abbiamo testi unici e codici culturali,ma ancora nessuna regola su chi scava e come».Noi vogliamo contribuire a scrivere queste regole,ponendo come principio fondamentale l’alta qualificazionee la competenza, regole sane, nell’ottica <strong>del</strong> liberoaccesso al lavoro, regole e mansioni chiare, che rendanopiù semplice e regolare il lavoro per tutti gliArcheologi professionisti.- 56 -
MONICA VISCIONEVogliamo essere protagonisti<strong>del</strong>le scelte che riguardano ilmondo <strong>del</strong>la nostra professione;rivendichiamo il diritto adavere un futuro e ad esserneartefici.Siamo consapevoli cheaffinché questo accada è indispensabileche si rilanci il ruolo<strong>del</strong> Ministero dei BeniCulturali. Le strutture <strong>del</strong>latutela richiedono un processodi riorganizzazione: le necessitàattuali <strong>del</strong>la cura <strong>del</strong>Patrimonio, in continuo cambiamento,dovrebbero determinareun riordino ed un incrementodegli organigrammi,proprio considerando l’esistenzadi una strutturata e ampiacategoria professionale. Maicome in questo momento storicol’Italia ha a disposizione unbacino di Archeologi così diffusoe così ben formato! La differenziazionee complessità necessaria per scongiurarel’attacco al nostro territorio e al nostro patrimoniopossono trovare risposta proprio nelle specializzazionie nelle competenze <strong>del</strong>la nostra ampia e variegatacategoria professionale.In questo senso bisogna che tutti noi siamo consapevoliche la definizione <strong>del</strong>le mansioni nelle attualiSoprintendenze risultano, per così dire, abbastanza‘strette’ riguardo alle nostre competenze ed è per questoche, ad esempio, lavoreremo insieme alSoprintendente di Salerno ed ad alcuni Funzionariarcheologi alla definizione <strong>del</strong>le mansioni, <strong>del</strong>le attivitàche un Archeologo può svolgere responsabilmentee coerentemente con le sue reali competenze.L’ambiguità di talune proposte normative e l’inadeguatezzadi certe soluzioni giuridiche nascono inbuona parte dai tentativi di mediare tra un’attualitàestremamente dinamica e un potere statico, con esitispesso inutili. E’ una questione, se vogliamo, di indirizzopolitico: le leggi in materia di Beni archeologici,oggi, peggiorano le condizioni di lavoro degliArcheologi. E non può essere altrimenti se alla basesta il principio che è il mercato a produrre autonoma-Fig. 3 - Manifesto <strong>del</strong> I Incontro di studio promosso dalla FAP incollaborazione con la Soprintendenza ai Beni Archeologici di Napoli.mente ricchezza, opportunità eregole. Un Paese civile dovrebbeinvece comprenderel’Archeologo, che sia già strutturatoall’interno <strong>del</strong>leSoprintendenze o libero professionista,come ‘attore protagonista’nel panorama <strong>del</strong>le professionalitàche si candidano apianificare i territori e il loro sviluppo.Ripeto, è una questione diindirizzo politico: come si fa aprogettare un Piano Tecnico diCoordinamento Provinciale oun Piano Urbanistico Comunaleprescindendo dal patrimoniostorico-archeologico e ignorandola sana pratica <strong>del</strong>la conservazionepreventiva?Affinché il collegamento trala pianificazione <strong>del</strong> territorio ele strategie operative sia coerentecon gli obiettivi da raggiungereattraverso le singole azionipreviste dagli enti preposti, è indispensabile avere unaconoscenza approfondita <strong>del</strong> territorio e <strong>del</strong>la sua storiae degli aspetti sul quale il progetto di programmazionedi sviluppo andrà ad intervenire; bisogna mobilitarele risorse agendo su fronti diversi: formazionedegli operatori, realizzazione di interventi di riqualificazionee valorizzazione dei Beni culturali. Non a casola premessa al codice deontologico formulato dallaFederazione indica che «L’archeologo deve riconoscereil Patrimonio <strong>Archeologico</strong>, come definito dall’articolo9 <strong>del</strong>la Costituzione <strong>del</strong>la Repubblica Italiana;riconosciamo fondamentale quanto sancito nel 1992alla Conferenza di Rio, dove la preoccupazione <strong>del</strong>losviluppo sostenibile enunciata accordava al paesaggioun posto essenziale, in quanto fattore di equilibrio trapatrimonio culturale e naturale, riflesso <strong>del</strong>la identità e<strong>del</strong>la diversità, risorsa economica creatrice di posti dilavoro».Fondamentale e prioritaria è l’individuazione e lavalutazione dei paesaggi al fine di poggiare su basisolide un’azione di sviluppo sul lungo periodo, voltaa tutelarne e a migliorarne la qualità. Tale azione deveessere sostenuta dalla conoscenza approfondita <strong>del</strong>le- 57 -
SALTERNUMFigg. 4a - 4b - Napoli, Museo <strong>Archeologico</strong> Nazionale. Relatori e pubblico al I Incontrodi Studio promosso dalla FAP.particolarità di ogni paesaggio, <strong>del</strong> suo processo storicodi evoluzione e trasformazione e <strong>del</strong> valore chela popolazione interessata gli accorda.Per la stessa preoccupazione crediamo chel’Archeologo sia tenuto a svolgere la propria professionesecondo i più elevati standard scientifici e nondebba accettare incarichi per i quali non è adeguatamenteformato e per i quali non abbia la necessariacompetenza; crediamo che nello svolgimento <strong>del</strong>leproprie mansioni debba evitare qualsiasi conflittod’interessi, evitare la pratica <strong>del</strong>la concorrenza sleale- ancora diffusa - e a tal fine deve declinare ogni prestazioneprofessionale che contrasti con il propriostatus personale o giuridico e con le finalità <strong>del</strong>la propriafigura e professionalità.E’ necessario ricordare che purtroppo esistonoancora forme di sfruttamento, in cui soprattutto inoccasione di incarichi temporanei alcuni Colleghisono costretti ad accettare tipologie di intervento nonregolamentate, in assenza di retribuzione ed in condizionitali da compromettere la sicurezza sul lavoro;ancora, si è talora costretti ad accettare tariffe e condizionitali da danneggiare la propria dignità e quella <strong>del</strong>l’interacategoria!La Federazione pone tra le sue ragioni prioritarieproprio il controllo <strong>del</strong> rispetto <strong>del</strong>la dignità professionaledegli Archeologi professionisti in tutti gli ambiti,comprese le condizioni di lavoro e retributive, e chesia garantito il diritto di libero accesso al lavoro in baseai principi di qualità professionale, trasparenza e pariopportunità. Per questo chiederemo il riconoscimentogiuridico <strong>del</strong>la professione per gli Archeologi specializzati,per discutere anche <strong>del</strong>la disciplina fiscale,retributiva e contributiva, nel rispetto <strong>del</strong>le diverse formuledi inquadramento lavorativo degli archeologi,attraverso l’elaborazione di mansionari e tariffari diriferimento.Siamo consapevoli che al fine di promuovere etutelare gli interessi <strong>del</strong>la categoria dobbiamo dialogarecon tutti i Soggetti pubblici e privati impegnati nelcampo dei Beni Culturali, cooperare con associazionied organizzazioni i cui scopi e il cui operato siano insintonia con gli scopi <strong>del</strong>l’Associazione, e infine siamoconsapevoli che dobbiamo promuovere ogni iniziativautile alla tutela e alla valorizzazione <strong>del</strong> Patrimonioarcheologico italiano e vigilare che tali iniziative sianoefficienti ed efficaci.A proposito di strategie efficienti per la tutela e lavalorizzazione si fa sempre più forte la voce secondola quale a Pompei verranno assunti nuovi Archeologia partire dalle liste degli idonei <strong>del</strong>l’ultimo concorso.Speriamo che da errori non si generino altri errori:bisogna tentare di fermare un meccanismo che agiscesolo e soltanto su stati di emergenza momentanei. Sitratta di stabilire le regole di una buona amministrazionee di indicare quali siano le migliori strategie diintervento per dare una mano a costruire un sistemadi promozione e di tutela migliori.Abbiamo di fronte una grande opportunità. SiamoArcheologi preparati, siamo in gran numero, alcuni dinoi sono anche giovani; siamo abituati a lavorare inéquipe e siamo abituati a trattare i Beni archeologici inquanto effettivamente pubblici. Una Nazione con untale potenziale non può pensare di ‘tappare un buco’di organico ricorrendo ad alchimie dettate solo dall’emergenza.La crisi economica evidenzia l’inadeguatezza <strong>del</strong>letutele <strong>del</strong> lavoro intellettuale moderno che, paradossalmente,convive con le forme arcaiche con le quali siè disciplinato il mondo <strong>del</strong>le professioni fino ad ora.Tutto ciò mette in luce la necessità sia di nuove normelegislative, sia una regolazione contrattuale per la- 58 -
MONICA VISCIONEnostra figura professionale. Bisogna cogliere l’occasioneper affrontare in modo organico le necessità sia diammodernamento <strong>del</strong> sistema, sia di tutela dei professionisti.Bisogna rinnovare l’impianto <strong>del</strong>la nostra professione,introducendo un sistema duale - ordine oelenco/associazioni - che lasci al Ministero e alle suestrutture periferiche l’azione di controllo <strong>del</strong>le competenzesoprattutto in un settore come il nostro ad altointeresse pubblico, lasciando alle associazioni di settoreil compito <strong>del</strong>la rappresentanza e <strong>del</strong>la tutela <strong>del</strong>lacategoria.Una riforma, inoltre, che dia riconoscimento professionalee adeguate misure di concorrenza sempreleale e di garanzia sul piano <strong>del</strong>la qualità <strong>del</strong>le competenzepossedute e agite dai singoli professionisti. Vannoadottate forme trasparenti di inserimento dei giovaninel mondo professionistico a partire dalle competenzeconseguite durante il percorso di studi, ma anche inserendoe regolamentando contrattualmente il rapportodi ‘praticantato’ e tirocinio.Non è più rimandabile l’approvazione di nuoveregole. Sull’esempio <strong>del</strong>lo Statuto <strong>del</strong> LavoroAutonomo <strong>del</strong>la Spagna, vanno riconosciuti al lavoroautonomo e professionale adeguati diritti di sicurezzasociale in relazione a malattia, infortunio, gravidanza,disoccupazione. Sono eventi che riguardano o colpisconole persone e che devono essere fronteggiatisocialmente, a prescindere dal carattere autonomo osubordinato <strong>del</strong> rapporto di lavoro.Ci batteremo quindi per l’obbligo e per i contenuti<strong>del</strong> contratto scritto per tutti; per compensi minimispecifici, adeguati alle singole competenze e professionalità;per la definizione di tempi certi di pagamento edi penali in caso di abuso; per specifiche modalità digestione <strong>del</strong> lavoro e di utilizzo dei tempi; per la formazionecontinua e la certificazione <strong>del</strong>le competenzeacquisite sul lavoro.Dobbiamo rivolgere la nostra attenzione e farerivolgere quella degli altri ad un piano di riqualificazione<strong>del</strong> settore <strong>del</strong>la tutela, che deve necessariamentepassare attraverso l’ampliamento degli uffici pubblici,la rimodulazione <strong>del</strong>le funzioni e dei profili professionali,l’abrogazione di leggi che lasciano prevalere imeccanismi di mercato nella distribuzione <strong>del</strong>le mansionie dei lavori in alternativa al principio <strong>del</strong>le giustecompetenze e l’impegno ad aumentare progressivamenteil budget finanziario <strong>del</strong> comparto pubblico, cheversa davvero in uno stato pietoso.- 59 -
GIUSEPPINA BISOGNO – MONICA VISCIONELa necropoli di S. Marco di CastellabateIl toponimo Cilento nel suo significato originariocomprendeva il territorio posto a corolla<strong>del</strong> Monte Stella, solo con la costituzione<strong>del</strong> Principato Citeriore voluto da Bonaparte l’area siallargò fino a comprendere l’area <strong>del</strong> Bussento eSapri (fig. 1). Nell’Antichità questo territorio facevaparte <strong>del</strong>la Lucania e nella divisione augustea <strong>del</strong>l’Italiaentrò nella III regio (Brutii et Lucania). La presenza <strong>del</strong>l’uomoè segnalata già dal Paleolitico medio e le suetracce continuano attraverso il Neolitico fino all’Etàdei Metalli. Già nell’età <strong>del</strong> Bronzo appare definita unaorganizzazione territoriale in cui si evidenziano ledirettrici <strong>del</strong>la transumanza e dei traffici, lungo i percorsidi crinale, dal Tirreno allo Jonio e viceversa, chesaranno transito di culture anche nei secoli successivi.Sull’antica rotta <strong>del</strong> traffico <strong>del</strong>l’ossidiana i primi Greciapprodarono sulle coste dove più tardi nacqueroMolpa e Pyxunte. I Lucani seguirono i percorsi interninel V e IV sec. a. C. occupando in modo capillare ipunti nodali, generalmente in posizione strategica alfine <strong>del</strong> controllo degli accessi e dei traffici. Il nuovoassetto <strong>del</strong> territorio dato poi dai Romani, creazione<strong>del</strong> latifondo e concentrazione <strong>del</strong>le funzioni amministrativein pochi centri, causerà alla fine <strong>del</strong> III sec. a.C. l’impoverimento di alcuni centri lucani o la loroscomparsa. Con la fine <strong>del</strong>l’Impero Romanod’Occidente iniziò anche per il Cilento il lungo periodo<strong>del</strong>le dominazioni barbariche, il diffondersi <strong>del</strong>monachesimo basiliano e l’impostazione feudale deiLongobardi.Scarsissime sono le notizie sulla storia più antica <strong>del</strong>territorio di Castellabate 1 ; dagli itinerari di età romana etardo-antica è documentata una via litoranea che daSalerno dopo Paestum proseguiva lungo la costa versoVelia, e alcune fonti attestano la presenza di una statioHerculia, per altro non presente nella TavolaPeutingeriana; l’ipotesi che questa statio fosse ubicata neiFig. 2 - Castellabate. Fotoaerea <strong>del</strong> territorio.Fig. 1 - Cartageografica <strong>del</strong>Cilento.pressi <strong>del</strong>l’attuale centro di S.Marcodi Castellabate, dove si ipotizza l’esistenzadi un vicus di età imperialetrova conferma nelle esplorazioniarcheologiche condotte da C. A.Fiammenghi 2 , per le quali la fisionomia<strong>del</strong> sito si <strong>del</strong>inea con chiarezza,sopratutto grazie alle numeroseiscrizioni che attestano la presenzadi una base navale di appoggioalla flotta imperiale tra il I e il II sec. d.C.Alcuni rinvenimenti sporadici e notizie di storici localioltre alle indagini sistematiche <strong>del</strong>la Soprintendenzaconfermano questo quadro 3 (fig. 2).Nelle acque antistanti la cinquecentesca Torre <strong>del</strong>Pagliarolo, a circa 1 Km a Nord dalla frazione di S.Marco, notizie orali segnalano il rinvenimento di alcuneanfore di cui non è possibile precisare la datazione,probabilmente pertinenti al carico di qualche relitto.In prossimità <strong>del</strong>la contrada Alano, in localitàPiano <strong>del</strong>la Corte, situata lungo il percorso che daPaestum, passando alle spalle <strong>del</strong> promontorio diTresino, ritornava sulla costa, sono stati recuperatidalla Soprintendenza frammenti ceramici di grossicontenitori e di tegole, verosimilmente pertinenti aduna fattoria di età ellenistica romana. Ad Alano, ilCorcia nel secolo scorso riportava la notizia <strong>del</strong> rinve-- 61 -
SALTERNUMIl Sestieri negli anni ’50 <strong>del</strong> secoloscorso ebbe modo di osservare,oltre ai resti <strong>del</strong> porto, la presenza difosse pertinenti a sepolture depredatein antico e di un muro in operapseudopoligonale conservato percirca 2 m di lunghezza e 1,60 m dialtezza 5 .Nel 1983 la SoprintendenzaArcheologica ha avviato l’esplorazionesistematica <strong>del</strong> sito, sotto ladirezione <strong>del</strong>la dott.ssa C. A. Fiammenghi (fig. 3). Lecinque successive campagne di scavo dal 1983 al 1987che hanno interessato l’area <strong>del</strong>la necropoli, e alcuniscavi di emergenza condotti tra il 1993 e il 1996 aridosso <strong>del</strong> porto, fino allo scavo di emergenza condottotra il 2005 e il 2006, che ha interessato esclusivamentelo scavo <strong>del</strong>la necropoli, hanno permesso diaggiungere nuovi dati alla conoscenza <strong>del</strong> sito di S.Marco 6 .Della necropoli 7 , che presenta forti addensamentidi deposizioni, sono state messe in evidenza 261sepolture databili tra il I e il II sec. d. C. (figg. 4-5);molto ampia è la tipologia <strong>del</strong>le tombe: a semplicefossa terragna, alla cappuccina entro cassa, a cassa concopertura piana o parallelepipeda, entro anfora per ibambini; alcune presentavano sulla copertura in tegoleuna stratificazione di più livelli di pietre di arenariaposte come ulteriore chiusura <strong>del</strong>la tomba (figg. 6-7).La copertura parallelepipeda in materiale lapideo -strati di blocchi di arenaria di taglio irregolare e digrandi dimensioni legati da malta - presenta quasicostantemente tracce di intonaco colorato. Quantodescritto per la tipologia tombale di S. Marco corrinimentodi «sepolcri con armature evasi vagamente dipinti, frammentidi latine epigrafi»; anche più recentementeè stato segnalato il rinvenimentodi tombe con vasi a vernicenera, ma la trasformazione ediliziaha alterato la fisionomia <strong>del</strong> paesaggiodistruggendo le preesistenze.Un riparo in grotta risalente adetà paleolitica è da riconoscere inloc. S. Antonio, i resti faunistici e imanufatti litici costituiscono la più antica testimonianzadi questo tratto di costa.A ridosso <strong>del</strong> litorale <strong>del</strong> centro di S. Maria, traPalazzo Belmonte e Madonna <strong>del</strong> Carmine, è attestatauna cava di arenaria sfruttata in antico: sono visibili itagli nel banco roccioso ed alcuni rocchi di colonnasemilavorati.Sull’isola di Licosa è documentata la presenza di uncomplesso marittimo di età imperiale, di cui sono visibilila peschiera ed un ambiente a mosaico; in corrispondenza<strong>del</strong>l’isolotto di Punta Licosa, già MarioNapoli aveva segnalato la presenza di ceramica adimpasto attestata anche sulla terraferma. Il sito cherestituisce questa ceramica - olle con cordoni plastici edaltri materiali che rimanderebbero alla cultura appenninica,oltre che ceramiche di età ellenistica e romana - èposto lungo l’insenatura a Sud <strong>del</strong>l’estremità <strong>del</strong>la penisolatra il pianoro e il pendio che lo separano dal mare.Da Punta Licosa provengono anche iscrizioni latineandate disperse e si ha notizie di strutture rinvenute nel1949 dal Sestieri. Inoltre è segnalato un termine agrarioromano da mettere in relazione con il vicus di S. Marco.Nelle acque tra S. Marco e Punta Licosa il CESUB di S.Maria ha recuperato numerosi ceppi d’ancora in piombo,che fanno immaginare il naufragio in zona di numerosenavi; infatti è stato individuato e in parte esploratoun relitto di nave mercantile <strong>del</strong> II sec. a. C., <strong>del</strong> cui caricofacevano parte anfore vinarie e vasellame da mensa.Infine, in loc. Franco sono evidenti tracce di occupazionedi tipo rurale di III sec. a. C..L’importanza <strong>del</strong> sito di S. Marco era stata segnalatafin dal XIX secolo: il Corcia ricordava il rinvenimentodi tombe romane e di strutture oltre che diiscrizioni latine. Il Lenormant oltre alle sepolturesegnalò anche i resti di un antico porto. Le strutture<strong>del</strong> porto, ancora visibili, furono utilizzate dal I sec. a.C. almeno fino al IV sec. d. C. 4 .Fig. 3 - S. Marco di Castellabate.Foto aerea con indicazione <strong>del</strong>la area <strong>del</strong>la necropoli.Fig. 4 - S. Marco di Castellabate. Planimetria di scavo <strong>del</strong>la necropoli.- 62 -
GIUSEPPINA BISOGNO – MONICA VISCIONEFig. 5 - S. Marco di Castellabate. Necropoli, foto di scavo.Fig. 7 - S. Marco di Castellabate. Foto di scavo che mostra la tipologia <strong>del</strong>le coperture.Fig. 6 - S. Marco di Castellabate.Foto di scavo di alcune sepolture.Fig. 8 - S. Marco diCastellabate. Foto discavo <strong>del</strong>la T. 210.sponde spesso con quanto osservato per le sepolturedi Velia 8 e di Ostia 9 , dove al di sotto <strong>del</strong>la copertura inmuratura si conserva una cappuccina in tegole inseritanella fossa.Sono state rinvenute inoltre tombe recanti iscrizioni,alcune <strong>del</strong>le quali di grande interesse, perché documentanola presenza di veterani <strong>del</strong>la flotta imperialedi stanza a Misenum, oltre ai resti di un recinto funerario10 . I rituali funerari attestati sono l’incinerazione 11 ,effettuata direttamente nella tomba, e più frequentementel’inumazione. Nel caso <strong>del</strong>le inumazioni, ildefunto veniva deposto in posizione supina con ilcapo posto quasi sempre ad Est, spesso all’interno diuna cassa lignea, di cui sono stati recuperati i chiodi.Esse presentano l’orientamento E-O, in rari casi sidispongono con orientamento N-S, quasi mai sovrapponendosi.Il corredo, non sempre presente, è costituitopiù frequentemente dal boccaletto monoansato apareti sottili 12 , raramente associato alla lucerna condecorazione a perline 13 ; in un solo caso la lucerna presentavala decorazione figurata a rilievo. All’interno<strong>del</strong> boccaletto si segnala la presenza apotropaica, quasicostante, <strong>del</strong> chiodo in ferro e <strong>del</strong>la moneta in bronzoassociati a residui carboniosi. Inoltre è attestata la presenzadi unguentari in vetro di diverse tipologie. SiFig. 9 - S. Marco di Castellabate. Corredo <strong>del</strong>la T. 210.segnalano all’interno <strong>del</strong> panorama abbastanza omogeneodi questa parte di necropoli le tombe 172 - 210- 214 - 215 - 223 - 224 - 225 - 244 - 246. La prima èuna deposizione in anfora di un infante; la T. 210 èuna sepoltura alla cappuccina obliterata da una ulteriorecopertura piana in scaglie di travertino: l’inumatopresenta il capo ad Est ed esibisce come corredo ilboccaletto a pareti sottili, la lucerna e l’unguentario invetro con corpo troncoconico e lungo collo (figg. 8-9). La T. 214, <strong>del</strong>la stessa tipologia <strong>del</strong>la precedente, hail corredo distribuito sul corpo <strong>del</strong> defunto: la coppa- 63 -
SALTERNUM(fig. 10) con decorazione a rilievo trale gambe, l’unguentario di vetro sullaspalla, la moneta di bronzo di cui èappena leggibile un volto maschile diprofilo. La sepoltura 215, simile alleprecedenti per tipologia tombale, hail corredo ai piedi <strong>del</strong> defunto, il boccalettoe la lucerna con decorazione avolute e si conservano i chiodini inferro <strong>del</strong>le calzature, il cha fa attribuirela sepoltura verosimilmente ad un soldato (fig.11).La T. 223 ha la copertura piana costituita da tre livellidi scaglie di travertino e pietre; il corredo anche inquesto caso è deposto ai piedi e consiste nel boccalettoa pareti sottili, in una brocca acroma e nell’unguentariodi vetro; un secondo vaso in vetro è sul femore etra le costole vi era una moneta, probabilmente scivolatadalla bocca. La T. 224, a cassa, si presenta più articolatarispetto alle altre sepolture: la sua copertura èun parallelepido con i bordi intonacati (fig. 12); il corredo,distribuito tra le gambe e le spalle, è costituito datre unguentari in vetro, da una lucerna con decorazionea perline, un’anforetta con decorazione a rotellaFig. 10 - S. Marco di Castellabate. Coppa a rilievoproveniente dalla T. 214.oltre alla moneta in bronzo illeggibile(fig. 13). La T. 225, a cassa con coperturapiana, in cui il defunto aveva ilcranio adagiato su un embrice, puòessere attribuita ad un soldato poichéanche in essa si rinvenivano i chiodinipertinenti ai calzari; inoltre vi eranodeposti un boccaletto chiuso da unframmento di olla con tracce di combustione,con all’interno un chiodo inbronzo ed una lucerna in frammenti 14 . Le tombe 244 -245 e 246 costituiscono probabilmente un nucleofamiliare: con lo stesso orientamento e diversa tipologia,le due tombe di adulto chiudono al centro latomba infantile; questa era priva di corredo; La T. 244,con copertura piana in scaglie di travertino, conservatra le gambe <strong>del</strong> defunto il boccaletto con il chiodo ela moneta all’interno. Nella sepoltura 246 (fig. 14), allacappuccina, il defunto è ancora deposto con il corredotra le gambe: il boccaletto e la lucerna con decorazionea rilievo; si conservano anche la moneta e ilchiodo e, sulla spalla è collocato l’unguentario in vetro.Vanno segnalate alcune sepolture femminili: la T.228, la cui copertura si presentava abbastanza complessa,restituiva uno specchio in bronzo ed un anelloFig. 13 - S. Marco diCastellabate. Corredo<strong>del</strong>la T. 224Fig. 11 - S. Marco di Castellabate. Chiodini pertinenti a calzari dalla T. 215.Fig. 12 - S.Marco di Castellabate. Foto di scavo <strong>del</strong>la T. 224.Fig. 14 - S. Marco di Castellabate. Foto di scavo <strong>del</strong>la T. 246 e relativo corredo.- 64 -
GIUSEPPINA BISOGNO – MONICA VISCIONEcon il castone in pasta vitrea; la T.2, cher oltre al corredo generalmenteattestato presentava dueorecchini in oro con pendenti inpasta vitrea e la T. 25, dove fu rinvenutoun orecchino a filo d’oropiegato a cerchio.Dalla necropoli inoltre provengonoanche alcune iscrizioni 15 :dalla T. 81 - uno dei rari casi in cuiè attestato il rito <strong>del</strong>la cremazione -l’iscrizione, con il lato scritto voltoad Est, era inserita di taglio tra letegole <strong>del</strong>la cappuccina rincalzatada pietre e conservata in situ quasiper intero. In essa si fa riferimentoad un’Antonia Prisca defunta a 17anni, figlia e consorte di unTriarchus, quindi ufficiale <strong>del</strong>la flotta imperiale (fig. 15).Una seconda iscrizione fu rinvenuta in una nicchia pertinentealla tomba 92: in essa è menzionato il nomen<strong>del</strong>la defunta e dei due dedicanti e questo indica la lorocondizione servile, cui doveva appartenere anche ildefunto <strong>del</strong>la T. 96, un bustum, sulla cui iscrizione ancorauna volta sono segnalati solo il nomen <strong>del</strong> defunto e<strong>del</strong> dedicante. In corso di studio è invece l’iscrizionerinvenuta all’interno <strong>del</strong> recinto funerario venuto allaluce nelle indagini <strong>del</strong> 2005.Fig. 15 - S.Marco di Castellabate. Iscrizione proveniente dallaT. 81.I dati emersi dalla necropoli,soprattutto l’attestazione <strong>del</strong>lapresenza dei comandanti <strong>del</strong>le triremie dei militari, concordano agiustificare anche la presenza distrutture murarie e di sistemi dicaptazione e irreggimentazione<strong>del</strong>le acque rinvenute nel corso didiverse campagne di scavo condottea S. Marco: qui si può immaginarequindi la presenza di unabase di appoggio <strong>del</strong>la flottaimperiale che tra il I e il II secolo,all’apice <strong>del</strong>la sua potenza, e l’avviodi un modesto processo diurbanizzazione legato proprio allostanziamento dei militari <strong>del</strong>laflotta romana 16 (fig. 16).Fig. 16 - S. Marco di Castellabate. Foto di scavo e rilievo <strong>del</strong>le strutture.- 65 -
SALTERNUMNoteQuesto lavoro è dedicato alla memoria <strong>del</strong>la cara amica e collega C. A. Fiammenghi alla quale deve molto tutta la terra <strong>del</strong> Cilento che Leitanto amava e rispettava e per la cui valorizzazione ha lottato sempre con impegno.1Archeologia e Territorio 1992.2FIAMMENGHI 1985, pp. 259-277; EAD.1986, pp. 75-77; EAD. 1992, pp. 119-134.3Archeologia e territorio 1992, p. 11 e ss.4JOHANNOWSKY 1982, p. 135; FIAMMENGHI1992, p. 129, con bibliografia.5SESTIERI 1952, p. 248; p. 251, nota 9.6Gli interventi di scavo degli anni 1990 e2000 sono stati eseguiti dalla dott.ssa M.Viscione con la direzione <strong>del</strong>la dott.ssa C.A. Fiammenghi; allo scavo <strong>del</strong>la necropoli<strong>del</strong> 2006 ha partecipato anche la dott.ssa F.Di Paola.7Le tombe scavate negli anni ’80 <strong>del</strong> secoloscorso sono state studiate ed edite dalladott.ssa Fiammenghi (FIAMMENGHI 1992,pp. 119-134, con bibliografia precedente).8FIAMMENGHI 2003, pp. 49-61.9PELLEGRINO - ZACCAGNINI 1999, p. 85,fig. 13.10La nicchia per l’inserzione <strong>del</strong>l’iscrizionefuneraria si inserisce nel processo formativo<strong>del</strong>le tombe a cassone, cd. cupae, dove lacopertura in muratura viene rifinita a formadi cupola o semicilindro (cfr. BACCHIELLI1987, pp. 303-319, con bibliografia precedente,e ID. 1993, IX, p. 85, fig. A).11Nella tomba 96 sono stati recuperati iresti <strong>del</strong>la pira funebre con legno di pino epigne dischiusesi per l’azione <strong>del</strong> fuoco.12I boccaletti a pareti sottili, sia globulariche ovoidi e piriformi, trovano ampi confrontinelle produzioni di fine I secolo -inizi II (cfr. MARABINI 1973; CARANDINI1977, pp. 25-31, tav. VIII, 1; VIII, 6-7; IX,13; cfr. anche HAYES 1972, p.131, n. 1-2-3-4, p. 132 n. 1-3; Atlante II, p.38.13Il tipo di lucerna decorato a perline cherappresenta una imitazione <strong>del</strong> gruppo asemivolute è ben attestato in ItaliaMeridionale (cfr. PAVOLINI 1977, p. 33, Tav.XXI, 11).14Anche le TT. 8 e 16 hanno restituito ichiodini in ferro <strong>del</strong>le scarpe <strong>del</strong> tutto similia quelli rinvenuti nelle coeve sepolture<strong>del</strong>la necropoli pestana di Arcioni, verosimilmenteda attribuire a militari.15FIAMMENGHI 1992, pp. 119-134.16EAD., Ibidem.- 66 -
GIUSEPPINA BISOGNO – MONICA VISCIONEBibliografiaArcheologia e Territorio 1992, Archeologia e territorio.Ricognizioni, scavi e ricerche nel Cilento, acura di G. GRECO - L. VECCHIO, Agropoli.Atlante II 1985, La ceramica a pareti sottili, inEnciclopedia <strong>del</strong>l’Arte Antica, Atlante <strong>del</strong>le formeceramiche II, Roma.BACCHIELLI L. 1987, Monumenti funerari aforma di cupola: origine e diffusione in Italia meridionale,in L’Africa Romana, Atti <strong>del</strong> IIIConvegno di Studi, Sassari 1986, a cura di A.MASTINO, Sassari, pp. 303-319.BACCHIELLI L. 1993, Introduzione, inTOYNBEE J. M. C., Morte e sepoltura nel mondoromano Roma, 1993, pp. VII-XV.CARANDINI A. 1977, La ceramica a pareti sottilidi Pompei e <strong>del</strong> Museo Nazionale di Napoli,in L’instrumentum domesticum di Ercolanoe Pompei nella Prima età imperiale, Roma, pp.25-31, Tavv. VIII-IX.FIAMMENGHI C. A. 1985, La necropoli romanadi S. Marco di Castellabate, in ‘RassegnaStorica Salernitana’, n.s. II/1, pp. 259-277.FIAMMENGHI C. A. 1986, L’attività archeologica<strong>del</strong>la Soprintendenza di Avellino, Benevento eSalerno nel 1983 in Crotone, Atti <strong>del</strong> XXIIIConvegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto1983, Napoli, pp. 531-532.FIAMMENGHI C. A. 1986, S. Marco diCastellabate, in Il Museo di Paestum. Appunti peruna lettura critica <strong>del</strong> percdorso espositivo,Capaccio, pp. 75-77.FIAMMENGHI C. A. 1992, La necropoli di S.Marco di Castellabate. Nuovi spunti di riflessione, inArcheologia e Territorio, 1992, pp. 119-134.FIAMMENGHI C. A. 2003, Le necropoli di Elea-Velia: qualche osservazione preliminare, in Elea-Velia. Le nuove ricerche, Atti <strong>del</strong> Convegno diStudi, Napoli 2001, a cura di G. GRECO, pp.49-61.JOHANNOWSKY W. 1982, L’attività archeologicanelle province di Avellino, Benevento e Salerno nel1982, in Magna Grecia: il mondo miceneo, Atti<strong>del</strong> XXII Convegno di studi sulla Magna Grecia,Taranto 1982, p. 1035.HAYES J. W. 1972, Late roman pottery. Acatalogue of roman fine wares, London.MARABINI MOEVS M. 1973, The roman thinwalledpottery from Cosa, in ‘Memoires of theAmerican Academy in Rome’, XXXII.PAVOLINI L. 1977, Le lucerne fittili romane <strong>del</strong>Museo Nazionale di Napoli in L’ instrumentumdomesticum di Ercolano e Pompei nellaPrima età imperiale, Roma, p. 33, Tav. XXI.PELLEGRINO P. - ZACCAGNINI R. 1999,Necropoli presso la Basilica, in PELLEGRINO A.et Alii 1999, Dalle necropoli di Ostia: riti ed usifunerari, Roma, pp. 84-105.SESTIERI P. 1952, Scoperte presso la PuntaTresino, in ‘Bollettino d’Arte’, pp. 247 ss.- 67 -
PIETRO CRIVELLIImpero e Chiesa da Costantino a GiustinianoIl Comitato Scientifico <strong>del</strong>la Rivista accoglie con favore questo ulteriore saggio di Pietro Crivelli,fecondo autore di una lunga serie di ‘medaglioni’ sui principali imperatori <strong>del</strong>la Tarda Antichità.L’Impero romano inizia a trasformarsi,lentamente ed in partequasi insensibilmente, in‘impero cristiano’ agli inizi <strong>del</strong> IVsecolo. E’ un processo che, iniziatoin modo appena percettibilecon l’editto emanato daCostantino a Mediolanum il 313,arriverà al suo completamentocon Giustiniano, alla metà <strong>del</strong> VIsecolo.Dopo la dura quanto inutile persecuzionedi Diocleziano, i tempi erano oramaimaturi perché il Cristianesimo potesse rientraretra le religiones licitae legalmente ammesse nell’impero,tanto più che già in precedenza c’era stato qualche tentativonon andato a buon fine.La letteratura religiosa <strong>del</strong>l’epoca ci ha tramandatoche, prima <strong>del</strong>la battaglia di Saxa Rubra, più comunementericordata come battaglia di Ponte Milvio,Costantino ebbe in sogno la visione di una croceaccompagnata da una scritta che recitava «In hoc signovinces». Mettendo da parte ogni incontrollabile aspettosoprannaturale e restando nel concreto, si deve averepresente che le legioni di Massenzio, così come quelle<strong>del</strong> suo rivale Costantino erano tutte unità <strong>del</strong>l’esercitoromano, in gran parte formate da elementi di originebarbarica, identiche ed indistinguibili le une dallealtre per armamento, foggia di vestiario, addestramento;molto simili anche le insegne così come ogni altroaspetto esteriore. Il rischio che nella foga e nella confusione<strong>del</strong> combattimento potessero scontrarsi repartiappartenenti alla stessa fazione era più che concreto.Questa eventualità non poteva sfuggire ad un generaleesperto come Costantino, che veniva da una lungaesperienza militare anche per tradizione familiare.Logica conseguenza di questa riflessione sul pericoloFig. 1 - Costantino Divus Comes. Solido aureo (313 d.C.).di quello che noi adesso chiameremmo‘fuoco amico’ non poteva esserealtra che quella di applicare alleinsegne ed agli scudi dei propriuomini un qualche contrassegnoche li distinguesse dagli avversari:ecco il ‘signum’ sognato dal futuroimperatore. Ci si potrebbe spingereoltre immaginando la forma <strong>del</strong> segnodistintivo, forse realizzato con due pennellatedi vernice istintivamente disposte in croce, masarebbe un esercizio inutile che nulla aggiungerebbealla comprensione di quanto accaduto. Resta il fattoche quel particolare, assolutamente semplice nella suaovvietà, è servito per secoli ad indicare l’inizio di un’epoca<strong>del</strong>l’Impero che, pure restando romano, diventavaanche cristiano.La fama immediatamente diffusasi <strong>del</strong> pretesointervento divino fece il resto. Il nuovo imperatore percepìsubito l’opportunità che gli si offriva di acquisirealla sua causa l’elemento cristiano, ancora fortementeminoritario, ma tuttavia molto attivo; infatti, l’anno successivo(313) insieme al collega Licinio (invero piuttostoriluttante) emanò quel famoso Editto di Mediolanumche assicurava a tutti, perciò non solo ai Cristiani, pienalibertà di culto. In realtà l’Editto dei due ‘Augusti’ era laconferma di quello precedente emanato da Galerio aSerdica due anni prima, con la sola aggiunta <strong>del</strong>la restituzionedei beni che erano stati in precedenza confiscati1 . Nell’insieme appare più che evidente cheCostantino (fig. 1) intendeva agire con molta cautela,favorendo i Cristiani e pronto a sfruttare le loro simpatia,ma attento a non irritare gli appartenenti alle altrereligioni, soprattutto quella ufficiale <strong>del</strong>l’Impero.- 69 -
SALTERNUMFig. 2 - Roma. Arco di Costantino (315 d. C.).L’anno 315 fu inaugurato l’arco trionfale elevato aperenne ricordo <strong>del</strong>la vittoria su Massenzio (fig. 2). Ilfregio riporta le fasi <strong>del</strong>la vicenda bellica, ma, su quello«come figura dispensatrice di vittoria appare il dioSole» 2 . Va da sé che il monumento era stato eretto aRoma ove il Senato era ancora formato quasi esclusivamenteda elementi pagani. In ogni modo Costantinofece sempre rappresentare sé e la sua famiglia conimmagini aureolate e l’aureola, prima di diventare peri cristiani un simbolo di santità, era da molto tempoper i pagani un simbolo solare (fig. 3).Con l’impero di Costantino la Chiesa cominciò astrutturarsi nel senso in cui noi la conosciamo. La raggiuntalibertà di espressione religiosa favorì la discussioneinterna in un ambiente, l’Oriente <strong>del</strong>l’impero,ove la cultura greca era già da molto tempo dedita allaspeculazione filosofica, che trovò la sua naturaleestensione ai problemi d’ordine religioso i quali esigevanorisposte puntuali e logiche. A dire il vero, già inprecedenza nell’ambiente pagano i filosofi sierano impegnati nel tentare di comprendereil mondo degli dèi e l’essenza<strong>del</strong>la divinità, ma il Cristianesimoportava con sè qualche cosa di profondamenteinnovativo e ciò eraun forte stimolo alla speculazionefilosofica. In breve nasceva laTeologia. E furono i teologi imbevutidi cultura filosofica grecacoloro che sottoposero ad esamecritico le Sacre Scritture ereditatedall’Ebraismo. Un altro elemento impor-tante per l’organizzazione <strong>del</strong>la Chiesa venne dall’avereassimilato e fatto propria l’organizzazione politicoamministrativa<strong>del</strong>l’Impero Romano. Le gerarchieecclesiastiche si ordinarono sulla falsariga di quellepolitiche ed amministrative romane, mentre il periododi tranquillità sociale garantito dall’imperatore permiseai vescovi, ai predicatori ed ai religiosi in genere dimuoversi agevolmente per tutto l’Impero per diffonderela nuova religione ed organizzare i fe<strong>del</strong>i 3 .Contemporaneamente ai vescovi <strong>del</strong>le città piùimportanti venne riconosciuta una autorità di controllosulle diocesi circostanti e furono detti Metropoliti;intorno alla metà <strong>del</strong> V secolo cinque di loro assunseroun potere ancora maggiore, con il titolo diPatriarchi. Erano il Papa, il Patriarca diCostantinopoli, quello di Alessandria (talvolta chiamatoanche lui papa), quello di Antiochia ed infine ilPatriarca di Gerusalemme. Ciascuno di loro governava,dal punto di vista religioso, ma spesso anche sconfinandonella politica, estese regioni di quello che erastato l’Impero Romano ai tempi di Traiano 4 (fig. 4).Nessun’altra religione, diversa da quella cristiana,massimamente nella sua accezione cattolica, è strutturatacosì, con una gerarchia piramidale esercitante uncontrollo territoriale, con al vertice il Papa per quantoriguarda i Cattolici. Nelle altre religioni, al massimo,esistono personaggi ai quali viene riconosciuto un particolareprestigio e che per conseguenza vengonoascoltati e seguiti con speciale reverenza, ma l’autoritàdei personaggi deriva da loro stessi, dal loro comportamento,dalla loro parola e non dalla carica rivestita.(L’unica eccezione potrebbe essere quella <strong>del</strong> DalaiLama, ma anche in questo caso le differenze con ilCristianesimo sono grandissime, tanto da non potersineppure proporre un confronto).In un secondo momento, come direttaconseguenza <strong>del</strong>le invasioni barbariche,nella parte occidentale <strong>del</strong>l’imperovennero meno le locali struttureamministrative imperiali chefurono in gran parte sostituite daquelle ecclesiastiche, le unicherimaste, le quali si addossarono ilFig. 3 – Costantino con il Chi e il Rho sull’elmo. Medaglione inargento (315 d. C.). Monaco, Staatliche Münzsammlung.- 70 -
PIETRO CRIVELLIFig. 4 - Le comunità cristiane <strong>del</strong> IV secolo (da VAN DER MEER V. F. – MOHRMANN C., Bildatlas der frühchristlichen Welt, Amsterdam 1959).carico di trattare con i nuovi arrivati invasori assumendopertanto, de facto, gradatamente anche un valoregiuridico e politico.Nel modo che abbiamo descritto, per la maggiorparte sullo stesso territorio, sono venuti a coesisteredue imperi: l’uno, religioso, ma non solo, che facevacapo al Papa, in progressiva espansione e l’altro politico,che diverrà in seguito più frammentato e più deboledal punto di vista <strong>del</strong>l’autorevolezza, rettodall’Imperatore. E’ <strong>del</strong> tutto comprensibile come, conil trascorrere degli anni, si sarebbe arrivati ad un contrastoper la supremazia, dapprima in modo sommessoe poi in una maniera sempre più accesa.Nella provincia d’Africa era scoppiata una violentapolemica fra i Cristiani circa le condizioni per l’eventualeriammissione nella comunità dei fe<strong>del</strong>i dei ‘lapsi’,di coloro cioè che, per il timore <strong>del</strong>le persecuzioni, sierano lasciati indurre ad abbandonare la religione cristianaed a tornare, anche se solo formalmente, alpaganesimo. La parte più intransigente era rappresentatadal vescovo Donato, il quale sembra che fosseancora molto sospettoso circa la sincerità <strong>del</strong> sentimentoreligioso di quelle ‘pecorelle smarrite’. Per dipiù, il rigorista Donato sosteneva che ai Cristiani nonera lecito rivestire magistrature o combattere comesoldati. Certamente quest’ultima affermazione eraquella che più doveva preoccupare l’Imperatore, ilpericolo di trovarsi improvvisamente con un esercitodi obiettori di coscienza era realmente elevato, tantopiù che episodi isolati, narrati dagli agiografi, si eranogià verificati in precedenza. Tuttavia i ‘donatisti’ accettaronodi fare risolvere la controversia che li opponevaal più moderato vescovo Ceciliano 5 , rimettendosi algiudizio di un vescovo romano. Costantino affidò lasoluzione <strong>del</strong>la questione al vescovo Milziade, romanoma di origini africane. Questi si pronunciò controDonato che a sua volta, non accettando il verdetto e lascomunica comminatagli, si appellò ancora una voltaall’Imperatore. Fu così che quest’ultimo, volendochiudere definitivamente la questione, convocò adArelate (Arles) un Sinodo dei vescovi <strong>del</strong>la parte<strong>del</strong>l’Impero Romano a lui soggetta (314).- 71 -
SALTERNUMLe decisioni <strong>del</strong> Sinodo furono assolutamentenegative per i Donatisti, pienamente sconfessati,soprattutto per quanto atteneva alle magistrature ed alservizio militare, che era la cosa che presumibilmentestava più a cuore a Costantino.In questo modo possiamo dire che aveva inizio lacollaborazione <strong>del</strong>la Chiesa con l’Impero, rafforzatadal sentimento di riconoscenza dei Cristiani versocolui che li aveva dopo tanto tempo sollevati dalleambasce <strong>del</strong>le ricorrenti persecuzioni. Tuttavia alloranessuno sembrò rendersi conto che «Costantino avevapreso la Chiesa sotto la sua protezione ufficiale, incorporandolanello Stato, tanto da assoggettarla alla suavolontà» 6 . Quando, in seguito al rafforzamento <strong>del</strong>lestrutture religiose ed alla maggiore penetrazione <strong>del</strong>cristianesimo fra coloro che detenevano il controllopolitico <strong>del</strong>l’impero, la situazione iniziò a tendere alcapovolgimento, cominciarono i primi screzi, iniziatiin modo pressoché inavvertibile, ma accentuatisi conil passare <strong>del</strong> tempo.«Per questa ragione, le aspirazioni <strong>del</strong> papa romanoal primato <strong>del</strong>la Chiesa, costituendo un pericoloper l’unità <strong>del</strong>l’Impero e una minaccia per la posizione<strong>del</strong>l’imperatore, furono combattute come eranostati combattuti i movimenti separatisti che volevanofondare in Oriente diverse chiese indipendenti, concredi diversi da quello <strong>del</strong>la chiesa di stato» 7 .Quella <strong>del</strong>l’imperatore era una posizione di forza edi privilegio, che Costantino seppe gestire con moltasagacia in modo da non urtare nessuna <strong>del</strong>le compo-Fig. 5 - Roma nell’età di Costantino (330 d. C. ca.), (da KRAUTHEIMER 1987).nenti religiose <strong>del</strong>l’Impero, ma che i suoi successorinon furono capaci di seguire con altrettanta intelligenzae determinazione.Fece costruire molte chiese avendo cura che sorgesserotutte su proprietà private <strong>del</strong>la casa imperialee tutte al di fuori <strong>del</strong> Pomerium - rispettando in talmodo la consuetudine risalente al tardo periodorepubblicano che imponeva appunto che i luoghi diculto <strong>del</strong>le divinità non prettamente romane fosserosempre collocati all’esterno di quel sacro perimetro 8 -così da non offendere i sentimenti religiosi di coloroche erano di fede pagana (fig. 5). All’interno <strong>del</strong>Pomerium fece costruire solo edifici di carattere profano.Contemporaneamente (anno 321) stabilì che nel‘dies Solis’ fosse vietata ogni attività commerciale o giudiziaria,con la sola eccezione dei lavori campestri edegli atti di manomissione o di emancipazione 9 .In seguito (383), e sempre per disposizione imperialedei tre augusti 10 Graziano, Valentiniano II eTeodosio I il dies Solis prenderà il nome di diesDominicus.Con l’avvento <strong>del</strong> Cristianesimo cominciaronosubito ad apparire le prime interpretazioni e discussionisulla figura e, soprattutto, sulla natura umana e divinadi Gesù: in buona sostanza le prime eresie. Quellache più <strong>del</strong>le altre si diffuse, avendo anche una portatapolitica, fu l’eresia ariana, che prese il suo nome daArio (280 – 336), un prete alessandrino che sostenevala teoria che il Figlio, essendo stato generato dal Padre,poteva essere solo simile ma non uguale a chi l’avevagenerato. Inoltre, se il Padre è eterno, cioè non ha inizioné fine, lo stesso, secondo Ario, non poteva dirsi<strong>del</strong> Figlio, che invece aveva avuto un inizio nello stessomomento in cui era stato creato dal Padre. Come sipuò vedere, la speculazione filosofica irrompeva cosìprepotentemente, invadendo senza tanti complimentilo spazio <strong>del</strong>la Fede.L’eresia ariana si diffuse rapidamente per tuttol’Oriente cagionando scontri non solo sul piano dialettico.In quel periodo la Chiesa si era venuta organizzandonei Patriarcati di cui abbiamo fatto cenno inprecedenza, ciascuno dei quali aspirava ad una posizionedi rilievo, soprattutto quelli di Roma e diCostantinopoli; quello romano, che aveva il suoincontrastato primato in Occidente, aspirava ad acquisireanche quello in Oriente.L’Oriente mediterraneo tuttavia doveva essere illuogo ove maggiormente prendevano piede le varie- 72 -
PIETRO CRIVELLIcorrenti di pensiero che, inevitabilmente,dividevano i Cristiani, a favore o control’una o l’altra. Questo accadeva perchéin quelle regioni maggiormentesi avvertiva quel sottile ingegnospeculativo, talvolta pure esasperato,che era una <strong>del</strong>le eredità <strong>del</strong>lecultura filosofica greca. La tendenzageneralizzata a non accettare tutto inmodo assolutamente acritico spingevale menti più acute a porsi <strong>del</strong>le domandee, per conseguenza, a darsi <strong>del</strong>le risposte chenon sempre erano le stesse per tutti. Lamaggior parte <strong>del</strong>le eresie <strong>del</strong>l’epocanacque perciò proprio in questa parte<strong>del</strong>l’Impero, e fu causa di scontri nonsolamente verbali.Il contrasto divenne sempre piùvirulento e preoccupante, per cuiCostantino, oramai unico imperatoredopo la sconfitta e l’uccisione diLicinio (324), prese la decisione diconvocare un concilio a Nicea (325), nell’intentodi superare la contesa e di riportareordine nella Chiesa.L’Imperatore, che non era stato presenteal Concilio di Arelate, partecipòinvece attivamente a quello di Niceacome «vescovo di quelli di fuori» 11 ,una definizione che ha ingeneratotutta una serie di discussioni circa lasua esatta interpretazione, se daintendere come riferita ai soli cristianilaici o anche a coloro che cristianinon erano, i quali tuttavia nonsembra che dovessero essere interessati. Inogni modo il dubbio resta e non è irrilevante.I Padri Conciliari conclusero i loro lavori esprimendouna solenne condanna <strong>del</strong>l’Arianesimo allaquale doveva seguire un’azione decisa <strong>del</strong>l’Imperatoreper stroncare definitivamente l’eresia. A quanto parequest’azione non vi fu o, quanto meno, fu tanto blandada passare inosservata, anzi diversi vescovi aderential credo niceno negli anni successivi furono rimossidai loro seggi episcopali 12 . E’ appena il caso di ricordareche quando, nei suoi ultimi momenti di vita,Costantino si fece battezzare ciò avvenne, se avvenne,per opera d’Eusebio di Nicomedia vescovo ariano.Fig. 6 - Costantino (305-337 d. C.). Aureo. Belgrado, Museo Nazionale.Fig. 7 – Costante. Solido <strong>del</strong>la zecca di Aquileia (340-350 d. C.).Roma, Medagliere <strong>del</strong> Museo Nazionale Romano a PalazzoMassimo alle Terme.Fig. 8 - Costanzo II (337-361 d. C.). Multiplo in oro.E’ nota l’umoristica affermazione<strong>del</strong> Gibbon a proposito <strong>del</strong>lagran quantità di religioni presenti aRoma: tutte parimenti vere per laplebe, tutte false per i filosofi, ma tutteugualmente utili per le autorità. A quest’ultimoprincipio verosimilmente s’ispiravala condotta di Costantino (fig. 6). I suoi successori,pure se impegnati a combattersivicendevolmente con ferocia, appaionofideisticamente più sinceri ed inposizione molto ossequiosa nei confronti<strong>del</strong>la Chiesa anche se conposizioni diverse. Costante (337 –350), (fig. 7) aveva aderito pienamenteai principi scaturiti dalConcilio di Nicea, mentre Costanzo II(337 – 361), (fig. 8) era di fede ariana econtro di lui i vescovi occidentali, riuniti nelSinodo di Serdica, affermarono apertamentecon una lettera al sovrano la propriaostilità. Affermavano (Ilario diPoitiers) che agiva subdolamente,senza spargimento di sangue, senzacreare martiri, ma affossando lafede. 13 Queste voci di protesta tuttavianon impedirono che laChiesa, nel suo complesso, si consolidasseassumendo gradatamente unaposizione di privilegio. E’ in questoperiodo che il vescovo di Roma comincia adacquistare una posizione di sempre maggior prestigionella comunità dei Cristiani, entrando anche in concorrenzacon l’Imperatore che, fatalmente, per evitaredi essere ridotto in una posizione di subalternità, ècostretto ad appoggiarsi al vescovo <strong>del</strong>la nuova Roma,cioè di Costantinopoli, evitando così di essere esautorato,ma rafforzando anche l’autorità di quello.In questo periodo comincia a strutturarsi la religionecristiana che, per la liturgia, attinge copiosamente airiti pagani, in modo da facilitare la penetrazione <strong>del</strong>lanuova fede presso i popoli <strong>del</strong>l’Impero. Già dal IIsecolo era diffuso il culto dei martiri; ora, nel IV seco-- 73 -
SALTERNUMriguardi <strong>del</strong>l’imperatore. Si deveconsiderare anche che, seguendoil ragionamento di Ario,Gesù si sarebbe venuto a trovarein una posizione subalterna aquella <strong>del</strong> Padre e questo avrebbeportato ad un indebolimento <strong>del</strong>Cristianesimo e perciò <strong>del</strong>la Chiesa,soprattutto di quella di Roma, con possibile vantaggioper l’imperatore e, in minore misura, perl’Ebraismo che riconosceva solo il Padre in Yaweh. Inquesta situazione le interferenze <strong>del</strong>la Chiesa nellapolitica imperiale sarebbero state notevolmente ridotteo addirittura annullate.Il nuovo monarca fu Giuliano. Nipote di CostanzoII, si era salvato dalla strage dei suoi familiari volutadagli zii Costante e Costanzo per eliminare ogni possibilepretesa al trono che era stato di Costantino. Siera salvato, insieme al fratellastro Gallo, perché avevasolo sei anni - Gallo ne aveva undici ed era ancheammalato – e chiaramente in quel momento non rappresentavaun pericolo.«Una personalità gigantesca, certamente non inferioreallo zio Costantino, entrava così nella storia <strong>del</strong>mondo». Con queste parole il grande storico SantoMazzarino introduce la figura di questo imperatore 15 .Era nato nel 332 ed era rimasto presto orfano,avendo perduto prima la madre e quindi, nel 337, ilpadre, Giulio Costanzo, vittima appunto <strong>del</strong>le stragifamiliari. Era stato educato al Cristianesimo, ma avevacoltivato anche con passione la cultura greca in cuiaveva trovato la risposta a tutte le sue inquietudini edaspirazioni. Non ripudiò il Cristianesimo in modo plateale,se ne allontanò silenziosamente. Era ancoratutto immerso nei suoi studi quando inaspettatamenteCostanzo II lo nominò suo ‘Cesare’ e lo spedì nellaGallia, a difenderla dall’invasione di Franchi eAlemanni: correva l’anno 355. Due anni dopo, neipressi <strong>del</strong>l’odierna Strasburgo, respinse il tentativod’invasione dei barbari infliggendo loro una durasconfitta. Contemporaneamente si rese conto che lecondizioni economiche <strong>del</strong>la popolazione erano divelo,sulle loro tombe si innalzano monumenticommemorativi (martyria). Il discorsoteologico si fa più complesso e ci sipone anche il problema se la Madredi Gesù fosse realmente defunta ese il suo corpo poteva essersidecomposto nella tomba cosìcome avveniva per quelli deicomuni mortali: sembrava unacosa non confacentesi alla dignitàdi Colei che era stata la Madre <strong>del</strong>Salvatore. Si giunse alla conclusioneche al termine <strong>del</strong>la sua vita terrena sifosse addormentata ed in quello stato fossestata assunta in cielo (Dormitio Virginis) 14 .Costanzo II si sforzò in ogni modo di superare ilcontrasto che opponeva gli Ariani ai Cattolici, avendoperò sempre un particolare riguardo per la posizioneariana. A questo scopo indisse un considerevolenumero di Conciliî, ad Arelate (354), a Mediolanum(356), Ariminum (Rimini, 359) e ancora, nello stessoanno, un altro concilio, questa volta per i soli vescoviorientali, a Seleucia, poi, l’anno successivo, aCostantinopoli ed infine l’ultimo ad Antiochia nel 361.Non ve ne furono altri perché nello stesso anno l’imperatoremorì. In tutti i casi la linea fu sempre la stessa:cercare di imporre l’adesione all’Arianesimo oquanto meno giungere ad un compromesso fra leposizioni divergenti. Sebbene avesse ripetuto i tentativicon tanto zelo, i risultati furono pressoché nulli, leparti rimasero sulle loro posizioni e l’Arianesimo,sempre meno accettato nel tempo, rimase vivo solopresso le popolazioni barbariche: Goti, Burgundi,Vandali, Longobardi, ove era stato introdotto dalvescovo goto Ulfila, ma nel corso <strong>del</strong> VII secolo potevaconsiderarsi già estinto.Costanzo II morì all’età di 44 anni e senza alcundubbio se fosse vissuto ancora, avrebbe continuatonella sua opera a favore <strong>del</strong>l’Arianesimo che, per il suocontenuto squisitamente filosofico, appariva più facilmentecontrollabile dal potere politico rispetto alcredo, fideisticamente intransigente, scaturito dal conciliodi Nicea, che aveva bandito ogni forma di analisiteoretica; ma anche perché il suo fratello e rivaleCostante si era fatto campione dei Niceni e perciò,anche dopo la sua eliminazione dalla scena politica,l’atteggiamento dei Cristiani occidentali, fe<strong>del</strong>i alvescovo di Roma, non appariva dei più favorevoli neiFig. 9 - Missorium in argento di Teodosio I (379-395 d. C.), ø 74cm; sp. 3 cm. Mérida, Museo Nacional de Arte Romano (copia<strong>del</strong>l’originale a Madrid, Real Academia de la Historia).- 74 -
PIETRO CRIVELLInute insostenibili a causa <strong>del</strong>l’eccessivo gravame tributario.Lo ridusse senza esitazioni da 25 solidi a soli 7 16 .Questi provvedimenti gli fruttarono un consensoenorme, che fece sì che quando nel 359 Costanzo IIgli richiese parte <strong>del</strong>le sue legioni per affrontare laguerra contro i Persiani, i soldati si rifiutarono diabbandonarlo ed anzi, poco dopo, nel febbraio <strong>del</strong>l’annosuccessivo, lo acclamarono Augusto.Evidentemente la soluzione non poteva essere altrache quella di uno scontro armato fra zio e nipote. Labattaglia però non ebbe luogo perché il 3 novembre<strong>del</strong> 361 Costanzo II morì.Salito al trono, Giuliano gradatamente accentuò lasua propensione verso il paganesimo, dando sempremaggiore spazio ai seguaci <strong>del</strong>la vecchia religione adetrimento dei Cristiani. A dire il vero aveva continuatonella sua politica già messa in atto in Gallia a favoredegli humiliores e contro i possessores e, poiché gliuomini di Chiesa cominciavano a rappresentare laparte non povera <strong>del</strong>la popolazione, quando il gravamefiscale venne spostato verso la classe più abbiente,eliminando altresì le esenzioni di cui avevano in precedenzagoduto i decurioni ecclesiastici, il risentimentonei suoi confronti divenne ancora più rabbioso. Neiriferimenti all’‘Apostata’ degli scrittori cristiani siavverte tutto l’odio che costoro, allora, ma anche inseguito, nutriranno sempre nei confronti di questoImperatore, tanto da alimentare nel tempo falsi raccontie accuse di atrocità mai da lui commesse.Fortunatamente Ammiano Marcellino, soldato e storicorigoroso, ce ne ha fornito un ritratto più aderentealla realtà nelle sue Res Gestae. Si disse che durante labattaglia in cui riportò la ferita per cui morì fossestato colpito proditoriamente da un suo stesso soldatodi religione cristiana. La notizia naturalmente non èprovata in alcun modo, ma rivela quanto poco fosseamato dai Cristiani colui che in effetti fu uno deimigliori imperatori che la storia di Roma possa ricordare.Verso la metà <strong>del</strong> IV secolo cominciò ad apparireanche in Occidente il movimento monastico, già largamentediffuso in Oriente, tanto che alla fine <strong>del</strong> secolo,in tutta la Palestina esistevano conventi e romitaggied altri se ne costituivano in Asia Minore e in Siria.Il monachesimo era sostenuto dal rispetto e dallavenerazione <strong>del</strong>la comunità dei credenti, ammirati perl’austerità di vita e l’ascetismo dei religiosi. Fra questisi deve ricordare Basilio di Cesarea che, nato nel 329,aveva studiato a Costantinopoli e ad Atene, raggiungendoun grado di cultura veramente straordinario;nei suoi scritti teologici era riuscito a coniugare conmolto acume la filosofia greca con il Cristianesimo.Compose un trattato destinato ai giovani sull’uso <strong>del</strong>laletteratura ellenica, contribuendo il tal modo, indirettamente,al salvataggio <strong>del</strong>le opere degli Autori greci.A Basilio si deve la stesura di un ‘regola’ monastica,forse la prima nella storia.Se in Oriente il monachesimo fu accettato senzaproblemi sia dall’autorità politica sia da quella religiosaanche nelle sue forme più estreme, non così avvennein Occidente, dove gli atteggiamenti religiosi eccessivamenteduri ed intransigenti finirono per trovareun’altrettanto dura ed intransigente ostilità. E’ il casodi Priscilliano, un monaco asceta che in Spagna avevaradunato attorno alla sua persona un gruppo di seguaciche si sottoponeva ad una regola ferrea di mortificazione<strong>del</strong>la carne. Se Paolo di Tarso affermava che«chi non sa resistere agli impulsi <strong>del</strong>la carne è meglioche si sposi», Priscilliano riprovava apertamente ilmatrimonio. Ebbe un seguito notevole da parte <strong>del</strong>lapopolazione, che lo ammirava per le sue doti ascetichee per la forza d’animo, tanto che divenne vescovo diAvila, ma nello stesso tempo entrò in conflitto con laChiesa. Un Sinodo tenutosi a Burdigala (Bordeaux) nel385 condannò le sue tesi e per di più egli fu sottopostoa giudizio anche da un tribunale ordinario che, asua volta, lo condannò alla pena capitale, insieme adun numero considerevole di suoi seguaci.L’anno 385 deve essere ricordato come quello incui per la prima volta venne comminata ed eseguitauna condanna a morte di una persona per le sue ideereligiose considerate eretiche. E’ opportuno ricordareche, molti secoli dopo, il tribunale <strong>del</strong>la SantaInquisizione, quando giudicava colpevole l’eretico, loaffidava al tribunale ordinario ed era questo che emettevala sentenza capitale.Dopo la tragica e improvvisa uscita di scena diGiuliano, sul trono imperiale si assise Gioviano (363 –364), (fig. 10) che, in meno di otto mesi fece solo duecose degne di nota: ripristinò il Cristianesimo annullandotutte le concessioni che il suo predecessoreaveva elargito ai pagani e stipulò una pace umiliantecon i Persiani, ai quali abbandonò alcune regioni oltreil Tigri, con diverse città tra le quali «Nisibi, cittàromanissima e cristianissima» 17 , «...ma in realtà il gio-- 75 -
SALTERNUMvane imperatore Gioviano ha giurato l’umiliante pacecoi Persiani perché il suo compito, almeno per ilmomento, è compito di politica interna; egli deverestituire all’impero quella fisionomia cristiana cheGiuliano ha cercato di cancellare; deve ritogliere aglidèi i beni che Giuliano aveva destinato ai loro templi;deve preoccuparsi <strong>del</strong>l’unità <strong>del</strong>l’episcopato cristianodiviso fra atanasiani e antiatanasiani» 18 .Gioviano fu imperatore dal luglio 363 al febbraio<strong>del</strong>l’anno successivo ed alla sua morte divenne imperatoreFlavio Valentiniano I (364 – 375) che associò altrono, ma in posizione piuttosto subordinata, il fratelloFlavio Valente (364 – 378). I due Augusti amministraronocongiuntamente l’Impero occupandosi l’uno,Valente, <strong>del</strong>la parte orientale e l’altro di quella occidentalefino alla morte di Valentiniano I (375).Entrambi furono cristiani ferventi, ma anche loro sitrovarono divisi fra le due opposte tendenze: il primodecisamente a favore <strong>del</strong> credo niceno e l’altro,Valente, altrettanto decisamente ariano. Chi ne fecemaggiormente le spese fu il vescovo (homoiousiano)Atanasio, fieramente intransigente nei confronti<strong>del</strong>l’Arianesimo, che collezionò il suo quinto esilio. E’appena il caso di rilevare che era potuto rientrare daquello precedente in virtù <strong>del</strong>l’editto <strong>del</strong> 361 diGiuliano l’Apostata che, questa volta a favore <strong>del</strong>paganesimo, liberalizzava tutte le confessioni religiose.Atanasio, tempra di grande lottatore per la fede, nonesitò a combattere contro gli imperatori, ma anchecontro il papa Liberio (352 – 366) che lo aveva condannatoper l’uso <strong>del</strong> termine homoioùsios riferito allanatura di Gesù 19 .Dottore <strong>del</strong>la Chiesa, Atanasio è venerato comesanto da cattolici, ortodossi e copti.Alla morte di Valentiniano I, sembra per un’emorragiacerebrale conseguente ad un violento attacco dicollera, si ritrovarono nel ruolo di Augusti perl’Occidente i suoi due figli Graziano (375 – 383) eValentiniano II (375 – 393), mentre in Oriente salivaal trono Teodosio I (378 – 395), dopo la morte in battagliadi Valente. Graziano fu assassinato mentre siapprestava a combattere contro l’usurpatore MagnoMassimo, che era stato acclamato Augusto dalle legioniche erano stanziate in Britannia. E dieci anni doposcompariva in circostanze misteriose ancheValentiniano II. Così Teodosio rimase unico imperatoreper altri due anni fino alla sua morte. Fu l’ultimoa reggere da solo tutto l’impero.Valentiniano II non ebbe rilevanza come imperatore,essendo stato elevato al trono all’età di quattroanni; Teodosio e Graziano invece affrontarono dicomune accordo il problema <strong>del</strong>l’unità dei Cristiani<strong>del</strong>l’Impero, tutti e due profondamente religiosi eappartenenti alla fede nicena. Più o meno contemporaneamenteentrambi avevano abbandonato il titolo diPontifex Maximus. Graziano, di concerto con papaDamaso, si adoperò a Roma sopprimendo tutte leimmunità di cui godevano in precedenza i collegisacerdotali pagani e fece eliminare dalla curia l’altare<strong>del</strong>la Vittoria. La sua determinazione era sorretta dall’enormeautorevolezza esercitata dal vescovo milaneseAmbrogio.Per quanto riguarda la cultura profana, i seguaci <strong>del</strong>paganesimo avevano ancora una posizione dominante.Libanio, oratore e ‘sofista’, come si autodefiniscerifiutando di essere considerato un filosofo, era fortementelegato alla fede pagana, ma la sua personalità diuomo di cultura fece sì che fra coloro che seguivano lesue lezioni di retorica fossero annoverati numerosiallievi cristiani. Sembra che Libanio seguisse gli allievi<strong>del</strong>la sua scuola di Antiochia non solo durante le lezioni,ma anche nella loro vita privata, avendo cura che sitenessero alla larga dalle distrazioni e dalle insidiemorali che si nascondevano nella città. Molti suoidiscepoli occuparono in seguito posti di grande rilievonella vita pubblica. A Costantinopoli invece brillavaTemistio, docente di filosofia molto rispettato da tutti:fu tenuto in grande considerazione dallo stessoTeodosio, che lo nominò prefetto <strong>del</strong> pretorio e nonesitò ad affidargli l’educazione <strong>del</strong> figlio Arcadio unitamentead un altro maestro di religione cristiana. Ilretore Libanio si ispirava ai grandi classici greci,soprattutto a Demostene, mentre Temistio, filosofo,aveva come riferimenti Platone ed Aristotele. Anche aRoma continuarono a ricevere onori e rispetto personaggidi religione pagana che erano protetti dalloscudo <strong>del</strong>la loro grande cultura: fra questi VezioAgorio Protestato, appassionato e profondo studioso<strong>del</strong>la filosofia e praefectus urbis nel 367 – 368, VirioNicomaco Flaviano quaestor sacri palatii nel 382 eQuinto Aurelio Simmaco, anche lui praefectus urbis (384– 385). La sua perorazione rivolta all’Imperatore indifesa <strong>del</strong>l’antica fede non gli impedì di divenire consolenel 391.Naturalmente non sempre gli avvenimenti si svolgevanoin modo così <strong>del</strong>icato, se gli uomini di cultura- 76 -
PIETRO CRIVELLIe gli aristocratici romani erano protetti da una certaaura di rispetto, non altrettanto poteva dirsi per quellepersone di più modesta levatura che, essendo poco onulla tutelate furono estromesse dagli incarichi pubbliciricoperti. Se gli imperatori dovevano tenere contonei loro atti degli umori popolari e <strong>del</strong>la stabilità<strong>del</strong>l’Impero, gli uomini di Chiesa non avevano problemi<strong>del</strong> genere, anzi proclamavano che gli stessi monarchi,in quanto uomini e fe<strong>del</strong>i, erano soggetti alla leggedivina che era rappresentata e interpretata dalle gerarchiereligiose e nello stesso tempo percepivano che laresponsabilità politica ed amministrativa che gravavasulle spalle di quelli era anche il loro punto debole.Teodosio era un personaggio molto contradditorio,mentre da un lato era grandemente generoso ecapace di mostrasi amabile, perfino arrendevole eforse lo era veramente; in altre circostanze si lasciavaandare a manifestazioni colleriche che potevano giungerefino alla più becera cru<strong>del</strong>tà.Nel 390 la popolazione di Tessalonica si ammutinòe uccise il magister militum <strong>del</strong>l’Illirico che aveva fattoarrestare un auriga famoso, colpevole di un qualche<strong>del</strong>itto e, cosa ancor più grave agli occhi <strong>del</strong>la plebe,non aveva fatto celebrare i giochi <strong>del</strong> circo. Teodosiovolle dare una prova <strong>del</strong>la sua forza a dimostrazioneche con lui i tempi erano cambiati e che non avrebbemai più tollerato comportamenti eversivi contro leautorità. Durante lo svolgimento di alcuni giochi ordinòdi bloccare le porte <strong>del</strong> circo e senza tanti complimentifece uccidere un gran numero di persone (sembrafossero settemila). Ottenne lo scopo, perché dopodi lui episodi <strong>del</strong> genere non ne avvennero più peroltre un secolo o si manifestarono in modo assolutamenteirrilevante. Quando la notizia <strong>del</strong>la strage giunsea Milano al vescovo Ambrogio, questi, altro caratteredifficile ed impetuoso, immediatamente s’infuriò escrisse una lettera di fuoco all’Imperatore, ingiungendogliperentoriamente di fare penitenza e di invocarepubblicamente il perdono 20 . Ambrogio gli accordòl’assoluzione soltanto diversi mesi dopo, a Natale <strong>del</strong>lostesso anno. Tutto ciò accadeva sebbene dieci anniprima (27 febbraio 380) Teodosio avesse stabilito chela religione cristiana era la sola religione ufficiale <strong>del</strong>loStato. I tempi erano cambiati anche per i rapporti fral’Impero e la Chiesa. Alla disponibilità e all’acquiescenzamostrata in precedenza, forse anche in conseguenza<strong>del</strong>l’intermezzo di Giuliano l’Apostata, erasubentrata una maggiore intransigenza su questioni diFig. 10 - Sant’Ambrogio. Ritratto musivo (V sec. d. C.). Milano, Basilica di S. Ambrogio,sacello di San Vittore in Ciel d’Oro.fede e di comportamento dei fe<strong>del</strong>i, anche per l’operadi personalità di enorme rilievo quale fu quella diAmbrogio (fig. 10).Teodosio continuò a dare dimostrazione <strong>del</strong>la propriadeterminazione, se pure in una diversa direzione.Nel 391 - 392 emanò alcuni Editti contro i pagani, chearrivavano a prevedere 21 anche la pena capitale percoloro che avessero sacrificato vittime agli dèi.In questo periodo, su ispirazione di papa Damaso(366 – 384) - altra personalità di rilievo, eletta al pontificatodopo scontri violenti con molti morti e feritifra i suoi sostenitori e quelli <strong>del</strong> suo avversario, ilvescovo Ursino - comincia a <strong>del</strong>inearsi, ancora inmodo sottile e poco appariscente, il tentativo <strong>del</strong> Papadi collocarsi in una posizione di preminenza rispettoall’Imperatore. E’ evidente che il punto di forza diquello e di debolezza di questo consisteva nella sincerae profonda fede religiosa di Teodosio e dei suoi successori.Il popolo, i sudditi <strong>del</strong>l’Impero erano fuoridalla questione, anche se fra di loro gli elementi ancoralegati al culto pagano rappresentavano un buonamaggioranza. Solo pochi anni prima Giuliano aveva- 77 -
SALTERNUMpotuto iniziare un’inversione di tendenza religiosasenza che nessuno avesse la benché minima possibilitàdi ostacolarlo. Certamente molti si lamentarono, matutto si era concluso lì, e non vi furono sommovimentipopolari. Ora, dall’opera di personaggi comeDamaso, ma soprattutto Ambrogio, la Chiesa ed i suoirappresentanti furono grandemente rafforzati. «Se inOccidente la Chiesa si conquistò nei confronti <strong>del</strong>l’imperatoreuna posizione così diversa che aCostantinopoli, ciò fu opera più di Ambrogio che diDamaso» 22 . Un episodio vale a sostenere quantosopra: in quegli stessi anni giunse notizia che in unacittà sull’Eufrate erano avvenuti degli scontri fraCristiani ed Ebrei nel corso dei quali il vescovo <strong>del</strong>luogo aveva fatto incendiare la sinagoga. Teodosioordinò che i responsabili dei disordini <strong>del</strong>l’una e <strong>del</strong>l’altraparte fossero puniti e ingiunse al vescovo diricostruire la sinagoga a sue spese. Era un provvedimentoispirato ad una elementare giustizia, ma questonon interessava minimamente ad Ambrogio, il qualepretese ed ottenne che Teodosio revocasse il suodecreto.Sulla scorta di questi avvenimenti, molti storicihanno ritenuto che qui sia iniziata quella lotta per lasupremazia che per secoli contrappose il potere religiosoa quello politico. Sembra, a chi scrive, che inrealtà l’aspetto legato alla preminenza politica in questicasi non sia preponderante, tanto più che il protagonistanon è il papa, ma un vescovo, anche se distraordinaria levatura. Si tratta più semplicemente, nelprimo caso, <strong>del</strong>la severa ammonizione di un fe<strong>del</strong>e daparte <strong>del</strong> suo pastore o, se vogliamo, padre spirituale;nel secondo di una richiesta puntigliosa, ma non di unattacco alle prerogative imperiali. Non si ha l’impressioneche gli uomini di Chiesa abbiano cercato diandare oltre la sfera puramente religiosa nei rapporticon il sovrano, cercando di attuare qualche interferenzanon occasionale, ma di indirizzo strutturale con lapolitica imperiale. Ciò detto, non è tuttavia da sottovalutareil fatto che essi abbiano potuto rivolgersiall’Imperatore con toni così perentori, al limite <strong>del</strong>l’arroganzae che quello abbia subìto senza reagire,venendo meno al proprio ruolo e compromettendo ilsuo stesso prestigio. Certamente con Costantino nonavrebbero osato, ma i tempi erano cambiati.Come si è già detto, in quegli stessi anni, accanto alclero secolare costituito da chierici, presbiteri e vescovi,si stava diffondendo sempre di più il monachesimocristiano 23 che, originario <strong>del</strong>l’Oriente, in particolareEgitto e Palestina, cominciava a diffondersi anche inOccidente introdottovi da Atanasio, il già citato vescovodi Alessandria che, negli anni intorno al 340 eraarrivato a Roma insieme a due monaci egiziani.I monaci non erano interessati alla politica: essitendevano solo ad un’elevazione spirituale tale daavvicinarli a Dio e infatti la loro azione nei rapporti frala Chiesa e l’Impero fu solo marginale. Bisogna peròavere ben presente che a volte questa aspirazione cosìintensa recava con sé la tendenza ad eccedere. In unpassato non molto lontano Origene Adamanzio (185– 254), uomo di grande cultura che ha legato il suonome a profonde speculazioni teologiche ed alla interpretazioneallegorica <strong>del</strong>la Bibbia e che ha avuto unagrande influenza su Ambrogio, giunse all’autocastrazione,interpretando, alla lettera, un versetto diMatteo 24 .Un episodio che vale a spiegare quanto in quelperiodo fosse facile superare i limiti <strong>del</strong>la ragione e <strong>del</strong>vivere civile è quello che riguarda la vicenda di Ipazia.Donna di grandissima cultura, figlia, allieva e poi collaboratrice<strong>del</strong> matematico Teone, ultimo bibliotecario<strong>del</strong>la Biblioteca alessandrina <strong>del</strong> Serapeo, conducevauna vita casta e riservata; aveva coltivato la filosofia, lamatematica, la geometria e l’astronomia. A lei si debbonoalcune opere di matematica ed astronomia purtroppoperdute. Come studiosa <strong>del</strong>la filosofia s’ispiravaal Neoplatonismo. Insegnava a tutti coloro chevolessero seguire le sue lezioni; pagana, accettava tra isuoi allievi indifferentemente tutti, qualsiasi religioneprofessassero. Tra i suoi discepoli più illustri vi fuanche Sinesio, divenuto poi vescovo di Cirene. Ma ilsuo successo e la stima di cui godeva non piacevano alvescovo d’Alessandria, Cirillo, il quale chiamò ungruppo di monaci fanatici, i ‘Parabolani’ 25 che assalironola donna mentre rientrava a casa, la trascinarono inuna chiesa e lì la uccisero facendo strazio <strong>del</strong> suocorpo con pezzi di vetro, conchiglie e cocci vari, bruciandoinfine i miseri resti in una discarica. Era l’anno415. Oreste, prefetto di Alessandria, promosse un’inchiestae l’Imperatore Teodosio II (408 – 450), succube<strong>del</strong>la sorella Elia Pulcheria, donna di una religiositàaddirittura <strong>del</strong>irante, mandò una specie d’ispettore, uncerto Edesio che non fece assolutamente nulla.Cirillo sarà fatto santo.L’episodio appena narrato ci fa capire quantodiverso fosse il modo di pensare in Oriente rispetto a- 78 -
PIETRO CRIVELLIquello <strong>del</strong>l’Occidente. Un fatto <strong>del</strong> genere a Romasarebbe stato impossibile, perché quanto restava <strong>del</strong>lacultura e <strong>del</strong>la razionalità autenticamente romane loavrebbe rifiutato, ma anche perché il Papa avrebbeimmediatamente compreso l’impressione negativa chene sarebbe derivata e in nessun modo avrebbe permessoche si potesse giungere a simili manifestazionidi fanatismo.A Teodosio I successero i due suoi figli, Arcadioed Onorio (figg. 12). Al primo fu assegnato l’Orientee all’altro l’Occidente. Troppo giovani ed inesperti pergestire in proprio il potere imperiale, furono ‘guidati’nell’esercizio <strong>del</strong>lo stesso da personaggi comeStilicone, un generale di origine barbarica 26 , ma pienamenteromanizzato, elevato alla carica di magister militum;prima grandemente onorato e poi tradito nelmodo più abietto, egli fu impegnato soprattutto nelcercare di contenere come meglio era possibile lapressione sempre più forte che le popolazioni barbareesercitavano sulle frontiere. «Inoltre gli atteggiamentipsicologici dei pagani e dei cristiani non aiutavanoaffatto il governo nella sua inutile lotta per assicurarela sopravvivenza nazionale. I pagani nel complessosi appoggiavano troppo compiacentemente alleglorie <strong>del</strong> passato, mentre i teologi cristiani, incuranti<strong>del</strong>le decisioni prese ad Arelate, predicavano dottrineche deprecavano l’impegno a servire lo stato» 27 . Inquesto clima di estrema instabilità le magistrature civili<strong>del</strong>la parte occidentale diventavano sempre più evanescentinelle loro funzioni. «Delle antiche magistrature,solo la prefettura urbana conservava una notevoleimportanza, perché da essa dipendeva il mantenimento<strong>del</strong>l’ordine a Roma e la giurisdizione su tuttal’estensione <strong>del</strong>la città» 28 . Gradatamente il loro postovenne assunto dagli esponenti <strong>del</strong> clero che, dotati diun indubbio prestigio ed anche perché protetti da unacerta aura di sacralità, potevano estendere le loro funzionianche al campo <strong>del</strong>le attività civili, dapprimaconsigliando ed in seguito impartendo ordini. Ma laloro visione dei problemi era limitata nel tempo esoprattutto nello spazio: non servivano lo Stato, servivanola Chiesa e la loro azione nel campo civile eraristretta e non coordinata. La stessa Chiesa non eraomogenea nella sua struttura: abbiamo già accennatoalle molte dispute interne ed agli scontri, talvolta violentie sanguinosi, che già da molti anni avevano divisoil Cristianesimo. E’ appena il caso di ricordare chesi erano già avuti i primi antipapi (il primo fu IppolitoFig. 11 - Onorio (393-423 d. C.). Marmo, h 47,5 cm; peso 100 kg. Roma, MuseiCapitolini.dal 217 al 235, poi santificato; subito dopo venneNovaziano (251-258) e poi ci furono altri quattro finoa Dioscoro, nel 530 per 22 giorni, ultimo <strong>del</strong> periododi cui ci occupiamo). Contemporaneamente a questiavvenimenti la Chiesa diventava sempre più ricca inconseguenza <strong>del</strong>le offerte dei fe<strong>del</strong>i, di lasciti testamentaried anche di contributi imperiali. «Non sorprendeche l’alto clero, che nel III e IV secolo erastato alimentato prevalentemente dal ceto medio, oraattirasse anche uomini di origine senatoria e che ilsenatore pagano Protestato dicesse scherzosamente alpapa Damaso: ‘Fatemi vescovo di Roma e domanidivento cristiano’» 29 . E’ in questo clima che vediamo ilpapa Leone I (440 – 461) andare incontro all’unnoAttila, inducendolo a ritirarsi.In breve, come se il tempo avesse subito un’improvvisaaccelerazione, si giunse al fatidico anno 476,che vide il definitivo tramonto <strong>del</strong>l’Impero Romanod’Occidente. In Oriente invece l’Impero era ancoravivo e vitale ed aveva avanti a sé ancora quasi milleanni di vita.- 79 -
SALTERNUME’ un errore storico affermare che siastato Odoacre ad abbattere l’Imperod’Occidente, quello sostanzialmente eragià morto da tempo, al più il barbaro necelebrò le esequie quando mandò aCostantinopoli le insegne imperiali cheerano appartenute a Romolo, dettoAugustolo perché insignificante. Era unragazzino posto sul trono dal padre Orestequando Odoacre era già alle porte. Oreste fu ucciso edil figlio confinato a Napoli in condizioni tutto sommatopiù che buone. Il barbaro, dunque, rimandò le insegneimperiali a Costantinopoli e questo atto lo si puòinterpretare in due modi: come gesto di strafottenza ocome forma di ossequio. Il fatto che Odoacre abbiarichiesto per sé il titolo di patricius fa propendere per laseconda ipotesi. Il Senato di Roma, praticamenteridotto da molti anni ai soli compiti di un’amministrazionecittadina con rari casi in cui, in presenza di situazionieccezionali, tornava, ma per poco, a riprendere lesue funzioni più prestigiose, <strong>del</strong>iberò che un imperatored’Occidente era inutile e che era sufficiente quellodi Costantinopoli, con Odoacre a garantire sicurezzae stabilità politica 30 .La <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong> Senato appena citata è un indizio<strong>del</strong> risentimento o <strong>del</strong>la indifferenza di quel consessonei confronti <strong>del</strong>l’autorità imperiale che aveva abdicatoalle sue funzioni di reggitrice <strong>del</strong>lo Stato; sembravadire: vi siete disinteressati di noi? E così sia!L’abbandono <strong>del</strong>la città era sotto gli occhi di tutti,basti pensare che intorno al V secolo d. C. era invalsal’abitudine d’inumare i morti all’interno <strong>del</strong> perimetro<strong>del</strong>le mura, anche in luoghi ancora frequentati, quandoda quasi un millennio con le Leggi <strong>del</strong>le DodiciTavole (451 a. C.) ciò era assolutamente vietato 31 .Il declino civico <strong>del</strong>la città non era però attribuibilesolo a cause esterne: le irruzioni dei Visigoti diAlarico (410) e quella dei Vandali di Genserico (455)furono devastanti, ma tuttavia la città poté riprendersicon relativa facilità. Il vero nemico era all’interno, eranell’uomo di quella stessa Roma, per il quale l’affermazione«civis romanus sum», che lo aveva sorretto persecoli, facendogli superare i pericoli maggiori, nonaveva più alcun significato. Furono più rispettosi <strong>del</strong>laromanità sia Odoacre sia Teodorico: «tennero ad inserirsiin un quadro di legittimità imperiale; cercarono lacollaborazione <strong>del</strong>l’aristocrazia senatoria e mostraronoreverenza per Roma e per il suo prestigio ideale;Fig. 12 - Teodosio II (408-450 d. C.). Solido in oro.piuttosto che provocarne il degradocercarono di porvi rimedio, ad esempiopromuovendo il restauro di grandimonumenti simbolici, come ilColosseo» 32 .Si è già parlato di Teodosio II (fig. 12),figlio di Arcadio; uomo colto e molto religioso, amavala compagnia di persone dedite allo studio <strong>del</strong>le scienze,<strong>del</strong>l’astronomia e <strong>del</strong>la teologia. Nel 435 ordinò ladistruzione di tutti i templi pagani ancora esistenti. Lasua politica nel campo <strong>del</strong>la fede fu nel complessocondizionata dal doversi destreggiare fra varie istanzefra loro contrastanti. Durante il suo impero esploseuna nuova diatriba tutta interna alla Chiesa. Nel 427 fuelevato al Patriarcato di Costantinopoli Nestorio, undotto monaco. Il compito che si era prefisso era quello<strong>del</strong> completo sradicamento <strong>del</strong>l’eresia e, per raggiungerequanto più rapidamente possibile lo scopo,non esitò ad avvalersi <strong>del</strong>la forza pubblica. Sul pianopiù strettamente teologico alcune sue affermazionisulla figura divina ed umana di Gesù, pure senza allontanarsimolto dall’ortodossia, stridevano con le posizioniprofessate dalla Scuola alessandrina, ove eravescovo il già ricordato Cirillo. Tra il fanatismo di questoe la dura determinazione di Nestorio era naturaleche dovessero scoccare scintille. Per evitare il peggio,Teodosio II indisse un Concilio ad Efeso (431), ma ilrimedio fu peggiore <strong>del</strong> male: Cirillo, approfittando diun ritardo nel viaggio dei rappresentanti di Nestorio,radunati i suoi seguaci, lo scomunicò. Quando i <strong>del</strong>egatidi Nestorio, guidati dal patriarca di Antiochia,Giovanni, arrivarono, e presero atto di quanto erastato fatto in loro assenza, lo ripagarono di ugualemoneta, scomunicandolo a loro volta insieme aMemnone, vescovo di Efeso, che aveva preso le sueparti.L’imperatore, oramai emancipato dalla tutela di suasorella Pulcheria, questa volta perse la pazienza edebbe un soprassalto d’indignazione: confermò le scomunicheincrociate e nello stesso tempo li destituì tuttie tre; Nestorio andò in esilio e Cirillo, ritiratosi adAlessandria, ritrattò quanto aveva detto contro di lui.Dobbiamo notare che l’imperatore aveva ancora lafacoltà e la forza di rimuovere i vescovi dalle loro funzionisenza gravi ripercussioni nell’ambito sia politico- 80 -
PIETRO CRIVELLIsia ecclesiastico. Le acque si calmarono per circa quindicianni fino a quando il successore di Cirillo,Dioscoro, riprese la lotta contro la chiesa diCostantinopoli che aveva condannato gli insegnamentidi Eutichio, un vecchio monaco, abate di un monastero<strong>del</strong>la capitale, molto seguito e rispettato, che, eravenuto in odore di eresia per il suo modo di intenderela figura di Gesù, considerandone la natura umanasimile a quella divina. Questa volta Teodosio II presele parti di Eutichio e convocò un nuovo ConcilioEcumenico ad Efeso (449) organizzato in modo platealmentepartigiano 33 , giungendo ad impedire la partecipazionea coloro che non fossero allineati con laposizione imperiale e Dioscoro con altri suoi seguacifu incaricato di presiedere le sedute conciliari 34 . Inquesto modo cominciava a prendere corpo ilMonofisismo.La realizzazione di carattere profano più importantedi Teodosio II fu l’aver promosso la stesura di quelloche sarà ricordato come Codex Theodosianus, una raccoltadi leggi romane che circa un secolo dopo saràutile ai giuristi di Giustiniano per la compilazione <strong>del</strong>codice legato al nome di quell’imperatore.A Teodosio II successe il cognato Marciano (450 –457), un trace che aveva sposato in modo solo formalesua sorella Pulcheria. Durante l’impero di questo,forse per volere di sua moglie, si tenne il concilio diCalcedonia (451). I legati di papa Leone il Granderecarono una lettera <strong>del</strong> pontefice con l’interpretazioneufficiale <strong>del</strong>la Chiesa circa la persona di Gesù, chesi stabilì avesse due nature: divina e umana, distinte eseparate. Era la condanna <strong>del</strong> Monofisismo, ma non lasua fine. Marciano, pressato dalla moglie Pulcheria,emanò un editto che imponeva a tutti i Cristiani ilrispetto di quanto era stato stabilito dal Sinodo, ma larisposta <strong>del</strong>le masse fu, a dire poco, sconcertante e nenacque uno scisma con <strong>del</strong>le ripercussioni imprevedibili.In Siria ed in Palestina vi furono scontri armati.La difficoltà maggiore sorse in Egitto, dove il problemada religioso divenne politico e la resistenza al concetto<strong>del</strong>la duplice natura di Gesù divenne il principiosu cui s’innestava la resistenza <strong>del</strong> popolo egizianocontro la dominazione imperiale, sentita come un’oppressione.Alla morte di Marciano, nel periodo dipotere vacante, scoppiò un’insurrezione adAlessandria. I rivoltosi espulsero (457) il patriarcaProterio, che era stato imposto dall’imperatore, ed alsuo posto elessero Timoteo che si affrettò a rifiutarele conclusioni conciliari di Calcedonia e, per soprammercatolanciò la scomunica contro il papa Leone diRoma e il patriarca di Costantinopoli Anatolio. Fu ungesto di sfida che l’imperatore Leone (457 – 474)dovette subire in silenzio, per evitare che la sommossaarrivasse alle conseguenze più estreme.Seguì Zeno o Zenone (474 – 491), che cercò diplacare gli animi riuscendovi solo in parte 35 . Si devesottolineare ancora una volta che, se l’imperatore eravincolato nelle sue decisioni dalla responsabilità digovernare un impero e di assicurare per quanto possibilel’integrità dei confini nonché la sicurezza e condizionidi vita almeno decenti per i cittadini, non altrettantopoteva dirsi dei monaci, vescovi e patriarchi iquali agivano liberamente secondo i loro punti di vistasenza nessun condizionamento.Alla morte di Zenone, la sua vedova impose lanomina ad imperatore <strong>del</strong> ricco nobiluomo AnastasioI (491 – 518) che divenne poi il suo secondo marito.Era un funzionario di palazzo di bell’aspetto, con lacaratteristica di avere un occhio castano e l’altro azzurro(eterocromia) e per questo era stato soprannominatoDìcoro 36 .L’anno successivo a Roma fu eletto papa Gelasio I(492 – 496). Un uomo di grande e vasta cultura religiosae giuridica, di lui restano quarantadue letterecomplete, oltre ad altre quarantanove frammentarie.Nell’epistola XII. diceva di sé di essere cittadinoromano (romanus natus), nato in quella che era stata laprovincia d’Africa (il Liber Pontificalis lo indica di nationeafer) e per questo fu da taluno ritenuto erroneamenteun uomo di colore. Dotato di grande determinazioneed energia, subito dopo l’elezione al soglio pontificiosi accinse a riportare ordine fra i credenti. Riuscì afar sopprimere l’antichissima festa romana deiLupercalia, residuo <strong>del</strong>la cultura pagana ancora fortementeradicata nella popolazione <strong>del</strong>la Roma plebea.L’imperatore era di fede monofisita, ma al momento<strong>del</strong>l’incoronazione aveva firmato un documentocon il quale s’impegnava a rispettare l’ortodossia; nelcampo religioso la sua politica fu ispirata ad unasostanziale moderazione. Ciò nonostante il papa volletentare d’imporre la propria supremazia inviandogliuna lettera (494) dal tono paterno, che già di per sédoveva dimostrare la superiorità <strong>del</strong>lo scrivente; inessa affermava che sono due i poteri che reggono ilmondo, la potestas dei re e la sacrata auctoritas dei pontefici.Gelasio, profondo conoscitore <strong>del</strong> Diritto, aveva- 81 -
SALTERNUMben presente la sostanziale differenza esistente fra lapotestas e l’auctoritas e su questa fondava le sue asserzioni:secondo il diritto romano la prima apparteneva alpotere esecutivo, i Consoli, mentre la seconda era propriadi quello legislativo, ovvero <strong>del</strong> Senato. Per conseguenzal’auctoritas papale, rafforzata dall’aggettivosacrata, aveva la preminenza sulla potestas imperiale.Secondo questa visione (e senza dubbio anche secondol’intenzione <strong>del</strong> pontefice), l’imperatore si trovavaad essere ridotto a poco di più di un funzionario cheoperava per <strong>del</strong>ega papale. Non sappiamo se a questalettera abbia fatto riscontro una risposta imperiale, tuttaviaè proprio qui che si avverte per la prima volta inmodo chiaro ed inequivocabile l’attacco diretto <strong>del</strong>papa al potere imperiale. Un assedio che in Orientesarà destinato al fallimento, ma che in Occidente avràconseguenze importanti e durature. Il papa Gelasio Imancherà due anni dopo avere inviato questa lettera,per cui, se aveva dei programmi di maggiore portatanon poté portarli a compimento.In quel periodo l’istruzione legata al tradizionalestudio dei Classici, <strong>del</strong>la Filosofia e <strong>del</strong>la Retorica eraancora alla base <strong>del</strong>la preparazione culturale di grandiuomini di Chiesa. Tertulliano, Ambrogio, Agostino,Girolamo, Damaso, Gelasio avevano tutti ricevutouna solida educazione di tipo classico. Ed i Padri <strong>del</strong>laChiesa <strong>del</strong> IV e V secolo avevano acquisito da queglistudi le capacità retoriche per cui sono rimasti famosi37 . Tutti ferventi cristiani, ma con un pensiero differente:Tertulliano (169 – 220), pure avendo molto probabilmenteesercitato l’avvocatura in un passato dapagano, sosteneva che era la fede e non la ragione l’unicomezzo per raggiungere la verità ed arrivò adaffermare che l’insegnamento stesso era un peccato.Più calmo e prudente era Agostino (354 – 430), chevedeva un pericolo occulto nella cultura classica solose fosse utilizzata in senso assoluto, ma in quella riconoscevaanche un mezzo educativo valido se impiegatocorrettamente e nel più assoluto rispetto <strong>del</strong>la verafede.Come già detto, non sappiamo se alla lettera dipapa Gelasio sia stata data risposta, tuttavia abbiamoun indizio cha fa pensare che un seguito ci possa esserestato, perché uno dei suoi successori, Simmaco (498– 514) scrisse allo stesso imperatore un’altra letteramolto dura e dignitosa in risposta ad una missiva diaccuse mossegli da questi, quali quella di essere diventatomanicheo, concludendo: «Dio ha già giudicato.Chi sei tu che resisti alla suprema sentenza?» 38 . Questacircostanza fa pensare che un carteggio fra Roma eCostantinopoli debba esserci stato anche in precedenza;d’altra parte è difficile che gli agguerriti giuristicostantinopolitani non abbiano colto il senso <strong>del</strong>leparole di papa Gelasio. Alla fine si giunse ad una tregua,se non alla pace vera e propria, con i successori<strong>del</strong> papa Simmaco, Ormisda (514 – 523) e <strong>del</strong>l’imperatoreAnastasio, Giustino (518 – 527). Non bisognatrascurare però che Giustino, analfabeta, si avvaleva<strong>del</strong>l’opera e <strong>del</strong> sostegno <strong>del</strong> coltissimo nipoteGiustiniano, che era di profonda fede cattolica e quindinaturalmente portato ad accettare pienamente lapreminenza religiosa <strong>del</strong> romano pontefice, mantenendolatuttavia su un piano ben distinto e separato daquello politico, avendo egli un altissimo senso anche<strong>del</strong>la dignità imperiale.A Roma si succedono dei Papi di grande fede religiosa,ma di carattere piuttosto mite ed accomodante.C’è un avvenimento che inquadra sufficientementequesto periodo. Nell’anno 524 l’imperatore Giustino,naturalmente ispirato dal nipote Giustiniano, emise undecreto in forza <strong>del</strong> quale i luoghi di culto degli Arianidovevano passare in proprietà <strong>del</strong>la Chiesa cattolica.L’ordine imperiale fece imbestialire il vecchio reTeodorico, che da più di trenta anni era diventatopadrone di tutta l’Italia. Questi, sentendosi colpito nelsuo orgoglio di ariano, non esitò ad incarcerare e fareuccidere personaggi di alto rango, come Simmaco eSeverino Boezio, che pure erano stati suoi collaboratoriparticolarmente utili e fe<strong>del</strong>i, solo perché dissenzientidalla sua presa di posizione nei confronti <strong>del</strong>laChiesa. Quindi ordinò al papa Giovanni I di recarsi aCostantinopoli per ottenere la revoca <strong>del</strong> decretoimperiale ed in più il permesso di tornareall’Arianesimo per coloro che si fossero convertiti alCattolicesimo. Il Papa andò a Costantinopoli ed ottenneil ritiro <strong>del</strong> decreto, ma non accennò neppure alpermesso richiesto da Teodorico. Al suo ritorno aRoma fu incarcerato e morì in prigione (526).Teodorico non era <strong>del</strong> tutto incolto - era stato educatoa Costantinopoli, alla corte imperiale, ove avevaappreso il latino ed il greco, ma evidentemente sotto lavernice culturale classica restava pur sempre l’anima diun barbaro.Con Giustiniano (fig. 13) i rapporti fra l’Impero ela Chiesa subiscono un ulteriore mutamento.- 82 -
PIETRO CRIVELLIL’Imperatore dà prova, se pure ce ne fossestato bisogno, <strong>del</strong>la sua sentitissima fedecristiana decapitando la grande culturaclassica, legata al paganesimo,con la chiusura <strong>del</strong>l’Accademia diAtene (529). In precedenza, giànel corso <strong>del</strong> IV e V secolo, lasituazione dei centri di studi accademiciera ridotta in condizioni diestrema precarietà. Il personale erainsufficiente per provvedere allatrascrizione dei testi classici piùimportanti, con la conseguenza che ipapiri più letti, e perciò più logori, non potevanoessere sostituiti e molte opere di grandi Autori <strong>del</strong>passato erano a rischio di andare perdute e molte lofurono effettivamente, <strong>del</strong> tutto o in parte 39 .L’insofferenza verso tutto ciò che ricordava il paganesimospingeva alcuni Cristiani più degli altri intollerantiad eccessi come quello già ricordato ai danni di Ipazia.Sempre in quel periodo un ulteriore notevole cedimentoalle istanze <strong>del</strong>la Chiesa venne dalla politica culturale<strong>del</strong> governo imperiale che limitò grandemente lalibertà d’insegnamento. Lo Stato sorvegliava le universitàed i docenti dovevano essere autorizzati all’insegnamento,ma non per accertare la loro idoneità dalpunto di vista culturale, bensì solo per la loro valutazionesotto l’aspetto <strong>del</strong>l’ortodossia religiosa.All’interno <strong>del</strong>la Chiesa il movimento monastico,che con il passare <strong>del</strong> tempo andava prendendo unamaggiore importanza, guardava il clero secolare conocchio sempre più critico: il tenore di vita dei vescovi,ma anche quello di tutti gli altri ecclesiastici, era messosotto accusa. I vescovi che frequentavano il circo, o iteatri, o anche spettacoli gladiatori non davano certouna buona impressione né di se stessi né di tutta laChiesa che tuttavia rappresentavano. Giustiniano siadoperò per correggere queste storture con diverseleggi, che ebbero anche l’effetto di aprire al monachesimola porta per entrare con pieno diritto là dove sidecideva la vita <strong>del</strong>la Chiesa.Mentre in Oriente accadeva quanto abbiamodescritto, in Occidente il Cristianesimo continuava asvilupparsi seguendo la via tracciata da Agostinod’Ippona e da Ambrogio di Milano. La commistionefra le popolazioni romane e quelle germaniche cheerano entrate nelle province d’Occidente portò ad unrapido distacco fra le due parti di quello che era statoFig. 13 - Giustiniano I (337-361 d. C.). Solido aureo emesso dalla zeccadi Costantinopoli. Paris, Bibliothèque Nationale.l’Impero di Roma ed infatti lariconquista giustinianea <strong>del</strong>l’Italiafu quanto mai effimera. Il legametra Oriente e Occidente era oramaireciso.Anche il monachesimo occidentaleassunse sempre più dei caratteriprofondamente diversi da quello orientale.La popolazione <strong>del</strong>le province occidentalinon era più quella di due secoli prima e nel 579 sarà elettoal soglio pontificio un monaco goto, Pelagio II (579 -590), primo barbaro a sedere sulla cattedra di Pietro.«…la svolta si deve ravvisare nel tempo diGiustiniano: la cultura <strong>del</strong>la tarda classicità e le nuoveforme sviluppatesi dal movimento monastico menanouna sorta di vita parallela. … Monaci e filosofi vivonol’uno accanto all’altro. Ma la fine <strong>del</strong>le università portòanche con sé il tramonto <strong>del</strong>la cultura antica comeforma dominante <strong>del</strong>l’esistenza. Con l’inizio <strong>del</strong> VIsecolo incomincia un periodo di silenzio. Nessunaopera letteraria ci resta di questo tempo. Una lacuna diquasi 150 anni si apre dal momento in cui l’ultimo storiografo<strong>del</strong>l’antica scuola classica depose la penna equello in cui, nell’umile forma di una cronaca conventuale,si riprese la narrazione <strong>del</strong> passato e <strong>del</strong> presente»40 .L’affermazione appena citata non tiene conto diProcopio di Cesarea. La sua contraddittorietà lo rendepiuttosto inaffidabile come storico. Come altri storici<strong>del</strong> passato afferma di scrivere di quello che ha vistopersonalmente. La domanda però che ci dobbiamoporre è: che cosa ha realmente visto Procopio? Sevogliamo darci una risposta corretta siamo costretti apensare che egli non abbia visto e, soprattutto, capitomolto. Era il segretario di Belisario, un generale che,ora sappiamo, era da lui poco stimato e con il quale, aquanto sembra, non aveva una particolare confidenza.Basta leggere la famosa ‘Storia Segreta’ per convincersene:viveva in penombra covando il suo rancoreverso Belisario e verso tutti gli altri potenti, passandodalla piaggeria più smaccata <strong>del</strong>le opere rese pubblichealla maldicenza più feroce di quelle che dovevanorestare nascoste. Il sospetto è che non avesse il tempo- 83 -
SALTERNUMné la voglia di esaminare, approfondire e comprenderele cause degli avvenimenti che si svolgevano in queltempo sotto i suoi occhi: in altri termini, che gli mancassel’anima <strong>del</strong>lo storico. Naturalmente queste sonoconsiderazioni attuali; sembra invece che la ‘Storia<strong>del</strong>le Guerre’ sia stata molto apprezzata dai contemporanei,forse perché non conoscevano quanto lostesso autore aveva scritto nell’altra sua opera destinataa rimanere nascosta e venuta alla luce solo nel Xsecolo, ma anche perché il suo stile, che si rifaceva aigrandi storici <strong>del</strong> passato, Erodoto, Tucidide e Tacito,era indubbiamente coinvolgente. Non si deve poidimenticare che non esistono altri storici contemporaneisu cui fare affidamento; Zosimo, quasi contemporaneo,termina la sua ‘Historía Néa’ con l’assedio diRoma da parte di Alarico (410), per cui, necessariamente,per il resto dobbiamo affidarci alla testimonianzadi Procopio.La cultura <strong>del</strong>l’epoca (VI secolo) era largamentedominata dal sentimento religioso, per conseguenzal’interesse per i grandi Autori classici latini e greci venneprogressivamente scemando, soprattutto in Occidente,restando appannaggio solo di alcune poche elevate personalità,a tutto vantaggio <strong>del</strong>le opere degli agiografi,anche le più insignificanti. Prova evidente di questomodo di sentire la cultura è il fatto che, verso la metà<strong>del</strong> secolo successivo, o poco dopo, nel monastero diBobbio 41 non si esitò a raschiare le pergamene su cuierano scritte le opere di Cicerone per riutilizzarle scrivendovigli atti <strong>del</strong> Concilio di Calcedonia (451).Il latino classico, di stampo ciceroniano, eraapprezzato da pochi ed anche quelli si sentivanocostretti ad usare un linguaggio plebeo per farsi capiredalle masse. Gregorio Magno (540 – 604, papa dal590) scrisse le sue opere teologiche nella lingua eruditadei grandi autori classici, ma quando doveva rivolgersial popolo, al basso clero ed ai monaci, allora utilizzavala parlata popolare, l’unica che quelli potesserocomprendere 42 .I Papi che successero al già citato Ormisda nonebbero un particolare rilievo dal punto di vista politico;le loro elezioni furono largamente influenzatedagli umori popolari o da condizionamenti pro o control’Impero, tanto che si giunse all’elezione al sogliodi Pietro <strong>del</strong> diacono Vigilio, voluta da Teodora,moglie di Giustiniano, ed imposta da Belisario, destituendosenza tanti complimenti il pontefice, Silverio,che era stato eletto in precedenza.In questa fase dei rapporti fra lo Stato e la Chiesal’imperatore ha la forza e l’autorevolezza per imporreal papa di presentarsi al suo cospetto a Costantinopoli,è un’umiliazione che quello deve subire in quantoinsediato sul soglio pontificio per imposizione imperialeed in contrasto con la volontà dei fe<strong>del</strong>i che giàcirca cinque anni prima avevano fatto sentire conforza il loro dissenso per la sua eventuale chiamata allacattedra pontificale, costringendo chi l’aveva proposta,papa Bonifacio II, a revocare il provvedimento inmodo pubblico e solenne.Il successore di Vigilio fu Pelagio I (556-561), cheera stato il rappresentante a Roma <strong>del</strong> precedentedurante gli otto anni in cui questi era stato trattenutoa Costantinopoli. Corse voce che avesse avuto partenel decesso di Vigilio, avvenuto a Siracusa nel 555,quando era di ritorno a Roma. Si disse pure che, perdifendersi dall’accusa di omicidio, fosse stato costrettoa giurare sulla tomba <strong>del</strong> martire Pancrazio 43 . Anchequesto papa era ‘sponsorizzato’ da Giustiniano. La suapolitica di totale acquiescenza ai voleri<strong>del</strong>l’Imperatore, conseguenza di un improvviso voltafacciaavvenuto appena dopo la sua elevazione altrono pontificio – in precedenza era stato quantomeno critico nei confronti di Costantinopoli – glivalse una caduta di stima che arrecò un danno notevoleal prestigio <strong>del</strong> pontificato.Ultimo papa <strong>del</strong> periodo preso in considerazionefu Giovanni III (561-574): di lui si sa poco, se non cheanch’egli fu molto vicino alle posizioni imperiali.In questa narrazione che comprende circa tre secolie mezzo di storia, esposta necessariamente in modopiuttosto sintetico, si è vista l’evoluzione di un rapportotra Stato e Chiesa dapprima paternalistico, conCostantino che si erge a garante e protettore <strong>del</strong>Cristianesimo, che convoca Sinodi e Concili e cheassume, lui non battezzato, una posizione molto prossimaa quella di capo <strong>del</strong>la cristianità: nasceva cosìquello che successivamente verrà chiamato ‘cesaropapismo’.I successori diretti di Costantino non avevano lasua stessa levatura intellettuale, fatta non di culturavera e propria, ma soprattutto di una grande capacitàdi vedere con grande chiarezza (talora non senza cinismo)la realtà e di sapere adottare, subito e senza tentennamenti,i provvedimenti più opportuni. L’unicoche avrebbe potuto reggere validamente il confronto- 84 -
PIETRO CRIVELLIfu Giuliano, il pagano, che però restò in carica per solidue anni, prima di morire nel modo che si è detto.Nessun altro imperatore, compreso Teodosio I potrebbeessere paragonato a Costantino e la debolezza progressivanella conduzione <strong>del</strong>l’impero fu avvertitaimmediatamente da Roma, ove i Papi cominciarono acoltivare desideri di supremazia, probabilmente dovutinon all’orgoglio personale, ma soprattutto all’alta considerazioneda essi nutrita per il ruolo rivestito.Tutto ciò fu reso possibile anche dalle invasioni<strong>del</strong>le popolazioni germaniche che tolsero all’autoritàimperiale gran parte <strong>del</strong>l’Italia, <strong>del</strong>la Gallia e tutta lapenisola iberica. Ormai quei territori erano perdutidefinitivamente per l’Impero, ma quello che più contaè che la stessa popolazione, da secoli non più autenticamenteromana e neppure italica, diluita in parte nellamoltitudine dei nuovi arrivati, si era rapidamenteimbarbarita; la cultura romana era rimasta appannaggiodi poche persone, per la maggior parte ecclesiastici,le masse popolari si erano subito adeguate allanuova situazione che, in fondo, per loro non era granchédiversa da quella precedente. Non dimentichiamoche per loro si trattava di sopravvivere in una situazionepolitica e soprattutto economica, estremamentedifficile ed in questa direzione l’opera <strong>del</strong>la Chiesasvolgeva un’attività molto intensa. In questo modo lacristianizzazione ebbe una forte accelerazione, ancheperché i popoli invasori erano già in gran parte cristiani,sia pure di confessione ariana. Inoltre è giusto chiedersiquanto le masse sia <strong>del</strong>la popolazione italica, siaquelle degli Eruli, Visigoti, Goti e successivamenteLongobardi arrivasse a capire <strong>del</strong>la differenza esistentefra l’Arianesimo ed il Cattolicesimo. Per loro l’appartenenzaall’una o all’altra parte <strong>del</strong> Cristianesimoera solo una questione di carattere etnico, tutto il restoesulava dalle loro pressoché inesistenti capacità speculative.Nella totale assenza di ogni altra autorità che sifacesse carico <strong>del</strong>le esigenze popolari, era logico cheacquisisse un potere sempre maggiore l’unica rimastasul territorio, il Papa.La parte orientale <strong>del</strong>l’Impero, che rimaneva ancorasaldamente sotto l’autorità di Costantinopoli, nondovette registrare lo stesso fenomeno di evoluzionepolitica che abbiamo riscontrato in Occidente proprioperché lì lo Stato era ancora tale.C’è un altro aspetto che differenzia profondamentela Chiesa d’Oriente da quella d’Occidente: se aRoma ed in tutto il mondo occidentale oramai, a partiredal III secolo, la lingua <strong>del</strong>la Chiesa era il Latino,nell’Oriente si continuava ad usare il Greco. La differenzadi linguaggio con la difficoltà lessicale di renderecompiutamente la trasmissione dei concetti teologicidall’una all’altra lingua è stata sicuramente un altrodei fattori, anche se, senza alcun dubbio, non il piùimportante, che hanno portato alla frattura fra Romae Costantinopoli ed è, con le epigrafi in lingua greca,uno degli elementi che ci fa riflettere sull’espansionedei riti liturgici greci in Italia 44 , particolarmente nelMeridione dove, ancora dal periodo repubblicano, lecittà di origine greca continuavano ad usare nel quotidianola lingua <strong>del</strong>la madrepatria.Abbiamo visto come, quando sedettero sul tronoimperatori dotati di scarsa forza e personalità, i papifossero indotti ad assumere una posizione di preminenzae come invece, allorché il più debole era il pontefice,l’imperatore, anche se sinceramente religioso -e Giustiniano lo era certamente - potesse arrivare adun comportamento che non è esagerato definire autoritario,se non proprio arrogante.E’ in questo periodo, che non è più Antichità e nonancora Medioevo, che incomincia a <strong>del</strong>inearsi in modosempre più netto quel contrasto che opporrà per quasialtri mille anni la Chiesa ad ogni forma monarchica inItalia ed in Europa, in una lotta caratterizzata da alti ebassi in ragione dei momentanei rapporti di forza.Mentre l’attrito con l’Impero e con la Chiesa diCostantinopoli sarà prevalentemente di carattere dogmaticoe dottrinario, in Occidente assumerà invece unaspetto prevalentemente politico e di potere, a mano amano che si verrà costituendo il potere temporale <strong>del</strong>Papato.- 85 -
SALTERNUMNote1VOGT 1965, pp. 115-116. A questo propositosarà bene ricordare che editti analoghifurono emessi circa 70 anni prima dall’imperatoreGallieno (253 – 260) ed che da allorala prima persecuzione dei Cristiani fu quelladi Diocleziano.2VOGT 1965, p. 114.3ZERNOV 1962, p. 17.4Come sappiamo questa articolazione strutturale,in origine voluta per dare maggioreforza e consistenza alla Chiesa, sarà anche lasua debolezza perché, in seguito, servirà piùper dividere che per unire le comunità cristiane.5Questi s’ispirava, apparentemente anche nelnome, alla posizione di Cipriano CecilioTàscio (S. Cipriano), vescovo di Cartaginedal 249 al 258, anno <strong>del</strong>la sua morte, autoredi un’opera - Sui Lapsi - in cui manifestavacomprensione e tolleranza nei confronti dicoloro che si erano momentaneamenteallontanati dal Cristianesimo.6KRAUTHEIMER 1987, p. 6.7HAUSSIG 1964, p. 39.8Un’eccezione fu fatta per Cibele (MagnaMater), divinità frigia, introdotta a Roma il204 a. C. quando i sacerdoti incaricati d’interpretarei Libri Sibillini ne consigliaronol’adozione, si era alle ultime fasi <strong>del</strong>la secondaGuerra Punica.9Codex Theodosianus, 2.8.1 – Altra manifestazionedi acume politico-religioso diCostantino: il dies Solis, non ancora diesDominicus, già da allora era diventato il giornofestivo per i Cristiani.10C.Th. 11.7.1311Eusebio di Cesarea, Vita Constantini, 4, 24.12MAZZARINO 1986, vol. II, p. 665.13VOGT 1965, p.143.14Nella Chiesa orientale la Dormitio Virginiscorrisponde all’Assunzione <strong>del</strong>la Chiesaromana.15MAZZARINO 1986, p. 705.16ID., Ibidem, p. 712.17ID., Ibidem, p. 726.18ID., Ibidem.19Homoiousios (ομοιούσιος ) = ‘<strong>del</strong>la stessasostanza’.20Ambrogio, epistola 51.21C. Th. 16.10.12.1.22VOGT 1965, p. 194.23Il monachesimo è un modo di vivere e disentire la religiosità sviluppatosi inizialmentein India e nell’estremo Oriente e diffusosi inseguito in ambiente cristiano.24Mt 19, 12: «Vi sono eunuchi usciti così dalventre <strong>del</strong>la madre, altri li hanno resi tali gliuomini, e c’è chi si fa eunuco per il regno diDio. Chi ne è capace lo faccia».25I ‘Parabolani’ erano una specie di scorta <strong>del</strong>patriarca di Alessandria che, pochi mesiprima dei fatti in argomento, avevano espulsocon la violenza dalla città la quasi totalità<strong>del</strong>la popolazione di fede ebraica o pagana.26Era il figlio di un capo dei Vandali cheaveva servito nell’esercito imperiale sottoValente. Era stato tenuto in grande considerazioneda Teodosio I al punto da dargli insposa sua sorella Serena.27GRANT 1981, p. 566.28VOGT 1965, p. 231.29ID., Ibidem, p. 239.30MARAZZI 2003, p. 354.31«Hominem mortuum in urbe ne sepelito neveurito» (Leggi <strong>del</strong>le XII Tavole, Tabula X, 1).32DELOGU 2001, p. 5.33Ricordato come il Concilio ‘dei Ladroni’.34ZERNOV 1962, pp. 60-66.35ID., Ibidem, p. 67.36Dal greco Δίκορος = ‘che ha due pupille’.37VOGT 1965, p. 244.38Epistulae Romanorum pontificum genuinae etquae ad eos scripta sunt a s. Hilario ad Pelagium II,A. Thiel (ed.), Brunbergae, 1848. p. 639.39HAUSSIG 1964, p. 90.40ID., Ibidem, p. 139.41Fondato verso il 612 dall’irlandese sanColombano.42La necessità di ricorrere a due diversi modidi esprimersi in relazione al pubblico cui eradestinata la perorazione era già stata posta inevidenza da Cicerone (De oratore I - XXI, 94).Qui il grande oratore immagina che Antoniodistingua nettamente colui che è abile a parlareda chi invece è realmente eloquente.43KRAUTHEIMER 1981, p. 105.44Un esempio è quel lacerto di pittura con lascritta bilingue che rinveniamo a Salerno nell’ipogeodi S. Pietro a Corte.- 86 -
PIETRO CRIVELLIBibliografiaDELOGU P. 2001, Il passaggio dall'Antichità alMedioevo, in Roma Medievale, a cura di A.VAUCHEZ, Milano, pp 3-40.Epistulae Romanorum pontificum genuinae et quaead eos scripta sunt a s. Hilario ad Pelagium II, A.THIEL (ED.), Brunbergae, 1848.GRANT M. 1981, Storia di Roma Antica,Roma.HAUSSIG H. W. 1964, Storia e Cultura diBisanzio, Milano.KRAUTHEIMER R. 1981, Roma profilo di unacittà 312 -1308, Roma.KRAUTHEIMER R. 1987, Tre CapitaliCristiane, Torino.MARAZZI F. 2003, L'ultima Roma antica, inRoma Antica, a cura di A. GIARDINA, Milano,pp. 349-378.MAZZARINO S. 1986, L’Impero Romano,Roma-Bari.VOGT 1965, Il Declino di Roma, Milano, 1965.ZERNOV N. 1962, Il Cristianesimo Orientale,Milano.- 87 -
FRANCESCO MONTONEScribo ergo sum.La presenza dei toponimi campani in SidonioApollinare, l’ultimo letterato <strong>del</strong>l’Impero romano«Litteras tuas Romae positus accepi, quibus ansecundum commune consilium sese peregrinationismeae coepta promoveant, sollicitus inquiris,viam etiam qualem qualiterque confecerim, quosaut fluvios viderim poetarum carminibus inlustresaut urbes moenium situ inclitas aut montesnuminum opinione vulgatos aut camposproeliorum replicatione monstrabiles, quiavoluptuosum censeas quae lectione compereriseorum qui inspexerint fi<strong>del</strong>iore didicisse memoratu».(Epist. I, 5, 1) 1«Ho ricevuto quando mi ero stabilito aRoma la tua lettera, nella quale mi chiedisollecito se sto perseguendo gli obiettivi<strong>del</strong> mio viaggio secondo il comuneaccordo, quale percorso abbia compiutoe di quale tipologia, quali fiumi famosiper i versi dei poeti abbia visto o cittàinclite per la presenza di mura o montagnecelebrate come sedi di divinità ocampi che suscitano interesse per lamemoria di battaglie, poiché reputi unpiacere imparare le cose che hai appresosui libri dal racconto più fede degno dicoloro che le hanno viste».Con queste parole Sidonio Apollinare (430ca. - 486), esponente <strong>del</strong>la nobiltà galloromana,ultimo letterato <strong>del</strong>l’Imperoromano, autore di un corpus di 24 carmina (tra cui 3panegirici per gli imperatori Avito, Maioriano,Antemio) e di 9 libri di epistole, si rivolge ad un suoamico, Heronius, al quale descrive le tappe <strong>del</strong> suo viaggioda Lione a Roma, ben analizzato dal Piacente 2 .Sidonio, aristocratico attivo nella vita politica,panegirista di successo e, dal 470 ca., vescovo diClermont-Ferrand, impegnato nella resistenza controi Visigoti di Eurico, vive in pieno l’ultima fase<strong>del</strong>l’Impero romano d’Occidente ed è testimone consapevole<strong>del</strong> tramonto definitivo di un mondo 3 . Nel467 diviene imperatore Antemio, un nobile orientale,scelto dalla Corte di Costantinopoli; Sidonio vieneconvocato a Roma e cerca, probabilmente, di farsiportavoce <strong>del</strong>le istanze dei suoi compatrioti Arverni,per cercar di acquistare per loro i maggiori vantaggi 4 .Il viaggio in Italia, però, diviene soprattutto occasioneper poter osservare quei luoghi che sono stati sede<strong>del</strong>la memoria letteraria estorica, per vedere queifiumi immortalati daipoeti, quelle montagnetradizionalmente legate alculto di particolari divinità,quelle pianure resefamose dalle battaglie chehanno immortalato Roma.Questo interesse ‘filologico’5 ben si sposa con lecaratteristiche <strong>del</strong>la coltaaristocrazia gallo-romana,di cui Sidonio è il piùfamoso rappresentante;questa nobiltà, di fronte alcrollo <strong>del</strong>le strutture politiche<strong>del</strong>l’Impero, riconoscela sua cifra esistenzialenella grande letteratura,per innalzare una barrieratra sé e i nuovi domini, queibarbari che stanno demolendol’Impero.Filtro <strong>del</strong>la realtà è unaletteratura preziosa 6 , estre-Fig. 1 - La cattedrale di Clermont-Ferrand.Fig. 2 - Vetrata <strong>del</strong>la cattedrale di Clermont-Ferrandche si credeva raffigurasse San Sidonio Apollinare.- 89 -
SALTERNUMmamente elaborata, ai limiti <strong>del</strong> manierismo 7 , che ha ilcompito di far sopravvivere, attraverso continuiriecheggiamenti, quei ‘Classici’ che rischiano di scompariredi fronte al tracollo <strong>del</strong>la Storia; Sidonio oltrepassale Alpi senza difficoltà (prova, come osservaPiacente 8 , <strong>del</strong>l’accurata gestione <strong>del</strong> cursus publicus maanche, a mio parere, gustoso ribaltamento <strong>del</strong> nototόpos <strong>del</strong>l’impervia scalata <strong>del</strong>la catena montuosa, attestatoad esempio in Petronio CXXIII, vv. 144-151 ein Silio Italico III, 479-99, oltre che nello stessoSidonio 9 ), rammenta navigando il Po il mito diFetonte, ricorda passando presso Cremona i sospiri<strong>del</strong> Titiro mantovano (Virgilio), menziona il Metauro,noto per la battaglia che segnò la sconfitta diAsdrubale, le fonti <strong>del</strong> Clitumno, immortalate daPlinio… La sua geografia è una geografia letteraria emitico-storica; è la letteratura che ha dato vita a fiumi,monti e città italiche, eternandone il ricordo.Va ricordato, inoltre, che il viaggio romano comportòdei risvolti interessanti per Sidonio; egli ebbel’incarico di scrivere e pronunciare, il 1° gennaio <strong>del</strong>468, il panegirico per l’imperatore Antemio; il gradimento<strong>del</strong> carme gli valse la nomina a praefectus urbis,carica che, come sottolinea Stevens 10 , comportava,all’epoca, l’onere di esercitare la giurisdizione non solosu Roma, ma su un’area di 100 miglia intorno all’Urbs:«thus portions of the provinces of Tuscia, Umbria, Campania,and Picenum were under his control» 11 . Sidonio, che già eravenuto a Roma per recitare il panegirico per l’imperatoreAvito il 1°gennaio 456, sitrattenne nell’Urbsper tutto il 468.In questa sedeprenderemo inesame i toponimicampani citati daSidonio 12 ; la loromenzione nei testidi un autore che haalle spalle tutta laletteratura classica,e che ambisce inmaniera glossografica13 a fondereplurimi echi letterari,a render contoai suoi colti lettoriFig. 3 - Edizione a stampa <strong>del</strong>l'opera sidoniana (1598).e corrispondenti 14 di tutto il patrimonio culturale diuna civiltà al tramonto, ne sancisce la suprema consacrazione.La presenza nell’opera di Sidonio di toponimicampani non è legata ad un’esperienza biografica<strong>del</strong>l’autore (Sidonio, che pure soggiorna in Italia, nonci dice nulla al riguardo), ma alla consuetudine conquei Classici, che ne hanno immortalato la bellezza ela memoria.Cercheremo, allo stesso tempo, di render conto allettore <strong>del</strong>la reale situazione economico-sociale in cuiversava la Campania nel V secolo, ricorrendo, in particolarmodo, al prezioso studio di Eliodoro Savino 15 ,affinché possa essere evidenziata con efficacia ancoramaggiore la trasfigurazione eminentemente letterariadei toponimi operata da Sidonio. I siti campani hanno,accanto al loro percorso storico, una prestigiosa esistenzaletteraria che non può essere taciuta dall’ultimoletterato <strong>del</strong>l’Impero.Campania, CampanusLa Campania 16 è nominata da Sidonio in carm. 18,7,luogo su cui avremo modo di tornare più innanzi, enel carme 5 (il Panegirico per l’imperatore Maioriano):vv. 385-390:«… post hostis aperto errabat lentus pelago,postquam ordine vobis ordo omnis regnum dederat,plebs, curia, miles, et collega simul.Campanam flantibus Austris ingrediens terramsecurum milite Mauro agricolam aggreditur; ...».«… in seguito un nemico in aperto mareerrava lento, dopo che ogni ordine avevaa voi consegnato il trono, la plebe, lacuria, l’esercito, ed anche il collega. Sottoi soffi <strong>del</strong>l’Austro invadendo la terracampana con i suoi soldati africaniaggredisce il contadino che si sentivasicuro…».Sidonio sta passando in rassegna sia le vittorie ottenuteda Maioriano in qualità di magister militum (nominache risale al 27 febbraio <strong>del</strong> 457), sia quelle conseguitedopo l’ascesa al trono imperiale (dal 28 dicembre <strong>del</strong>457). Ricorda la sconfitta inferta da Maioriano ai CampiCanini ad una banda di Alamanni dediti al saccheggio(vv. 373-385) e la vittoria conseguita contro l’incursionedei Vandali di Genserico (che aveva soggiogato i Mauri)in Campania nella primavera <strong>del</strong> 458 (vv. 385-440),- 90 -
FRANCESCO MONTONEquando era già imperatore. GiàAlarico, nel 410, dopo aver saccheggiatoRoma, aveva attraversato laCampania, percorrendo forse la viaAppia fino a Capua, provando adattaccare Napoli e Nola. Nel 456 iVandali di Genserico devastaronoalcune regioni italiane, tra cui laCampania 17 . Sidonio è l’unico, però,che attesta, nella primavera <strong>del</strong> 458(flantibus Austris), quest’altra incursione18 .Il Geisler 19 ed i commentatorinon registrano a proposito di questiversi echi intertestuali. L’aggettivo Campanus è qui utilizzatoin riferimento alla Campania (come accade perla prima volta in Hor. Sat. I, 5, 62 20 ) e non a Capua(deriva infatti dal greco Kappanós, come compare sullemonete greche in riferimento a Capua 21 ). Il sintagmaaperto…pelago compare, in poesia, prima di Sidonio, inVerg. Aen. V, 212; Lucan. III, 533; Stat. Theb. V, 351;Val. Flacc. IV, 678; Rut. Nam. I, 533; flantibus Austris èclausola claudianea (carm. 8, 339). Sidonio, tuttavia, haprobabilmente variato un’espressione di Lucano (II,660-61: rursus aperto/ vult hostes errare freto). Questatestimonianza sidoniana è particolarmente importante,perché descrive lo svolgimento <strong>del</strong>le scorrerie vandalee la loro connotazione di ‘guerra di corsa’, strategiaconsiderata dagli Antichi particolarmente ferocema in realtà unica in grado di garantire a gruppi nonmolto numerosi il controllo <strong>del</strong> mare 22 .Per il sintagma Campanam…terram si veda comeparallelo Hor. Sat. II, 8, 56, Campanis…agris. Nelmondo agreste <strong>del</strong>la Campania penetrano dei ‘barbari’,i Mauri milites; i contadini, che fino a quel momentovivevano, topicamente, nel loro mondo campestre,securi, cioè sine cura, sono aggrediti dai Vandali. Inseguito alla ‘provincializzazione dioclezianea’, laCampania rimaneva tra le regioni meridionali l’unicain grado di fornire, ad esclusione <strong>del</strong>l’olio, tutte le derrate<strong>del</strong>le distribuzioni pubbliche a Roma: grano, vino,carne suina, legna, calce. Nella seconda metà <strong>del</strong> IVsecolo, tuttavia, la produzione di frumento raggiungevaappena l’autosufficienza; le invasioni di Alarico e diGenserico misero in ginocchio la regione.Che la Campania sia terra legata all’agricoltura èevidente anche dall’altra menzione <strong>del</strong>l’aggettivoCampanus (in questo caso sostantivato), nell’ambitoFig. 4- Moneta <strong>del</strong>l'epoca di Maioriano.<strong>del</strong>lo stesso Panegirico (carm. 5,46).Sidonio descrive i territori<strong>del</strong>l’Impero (indicati con il nome deiloro abitanti) mentre offrono alladea Roma seduta sul suo trono lapropria migliore prelibatezza, il prodottopeculiare; se l’Indo porta l’avorio,il Caldeo l’amomo, l’Assiro legemme, l’Arcade i cavalli…, ilCampano porta il vino:…CampanusIacchum (fert). A Roma, infatti, Iaccoera talvolta identificato con Libero,la divinità romana corrispondente aDioniso.Ager FalernusIl prodotto peculiare <strong>del</strong>la Campania è, dunque, unprodotto agricolo, il vino, in particolare il più famosovino <strong>del</strong> mondo antico, il Falerno, denominato cosìdall’ager omonimo, che si trovava nella zone di SessaAurunca, a Nord <strong>del</strong> Volturno. L’ager Falernus, Bacchicura (Tib. I, 9, 34) era <strong>del</strong>imitato a Nord-Ovest da untratto <strong>del</strong> fiume Savone, dal territorio di Sinuessa e daparte <strong>del</strong>la cresta <strong>del</strong> monte Massico, almeno dal territoriodi Sessa Aurunca; a Nord-Est dall’ager Calenus edal Campus Stellatinus; a Est da un tratto <strong>del</strong> Volturno(il confine forse giungeva fino alle porte di Casilinum,l’odierna Capua); a Sud dal Volturno e dall’agerCampanus 23 . Appartenne a Capua, poi (nel 340 a. C.) fuannesso a Roma, che nel 318 istituì la tribù Falerna(insieme con la tribù Ufentina). Nel V sec. laCampania settentrionale, sebbene non sembra sia statacoinvolta nelle incursioni germaniche, subì un progressivoindebolimento <strong>del</strong> tessuto urbano e <strong>del</strong>le propriecapacità economiche, laddove nel IV sec. l’agerFalernus era ancora in grado di esportare sue produzionia Roma e in alcune aree <strong>del</strong> limes occidentale 24 .In Sidonio compaiono tre menzioni <strong>del</strong> Falerno.Nel carme 17 Sidonio ricorre ad un fortunato tόpos,che ha il suo antecedente più illustre nel celebre invitocatulliano a Fabullo (carm. 13) 25 ; il poeta veroneseinvitava l’amico a cena, chiedendogli di portare con sétutto il necessario, persino la compagnia femminile.Sidonio invita Ommazio nella sua dimora, dove, però,non vi saranno particolari prelibatezze; non vi saràpane prodotto dalle spighe <strong>del</strong>la libica Sirte, né sarannopresenti i più prestigiosi vini <strong>del</strong>l’antichità:- 91 -
SALTERNUMvv. 13-16:«Non panes Libyca solitos flauescere Syrteaccipiet Galli rustica mensa tui.Vina mihi non sunt Gazetica, Chia, Falernaquaeque Sarepteno palmite missa bibas».«La mensa rustica <strong>del</strong> tuo amico Gallonon accoglierà pane che è solito biondeggiarenella Sirti libica. Non ho vini diGaza, né di Chio né <strong>del</strong> Falerno, né quellospedito dalle vigne <strong>del</strong> Sarepta perchétu lo possa bere».Il Geisler 26 a proposito di panes Libyca solitos flavescereSyrte segnala la ripresa di Verg. Ecl. 4, 28, molli…flavescetcampus arista 27 . Per i versi successivi rimanda aHor. Carm. I, 20, 2, vile potabis…Sabinum; ib. 9 ss.:«Caecubum…tu bibes…mea nec Falernae temperant vitaeneque Formiani pocula colles». Il sintagma vina Falerna siritrova, in poesia in Hor. Sat. II, 4, 55-56, in Ov. Pont.IV, 2, 9. Il prestigio <strong>del</strong> Falerno è esaltato dalla collocazionein clausola, in una climax ascendente che dalpreziosismo Gazetica passa per il celebre vino di Chio.La contiguità vina mihi è attestato, in clausola, in Mart.XIII, 52, 2. I vv. 15-16 di Sidonio sono citati da Mart.Brac. Refect. 7-8. Per il sintagma Libyca…Syrte si vedaOv. Am. II, 16, 21, «Cum domina Libycas ausim perrumpereSyrtes»; abbonda di Falerno, invece, la mensa <strong>del</strong>lalussuriosa Cinzia di cui parla Properzio (II, 33, 39-40:«Largius effuso madeat tibi mensa Falerno,/ spumet et auratomollius in calice»). La mancanza <strong>del</strong> Falerno e di altri vinipregiati assume, perciò, anche una connotazione esistenziale;vale, cioè, a consacrare il sobrio tenore divita <strong>del</strong> poeta. Non è attestato in poesia, prima diSidonio, il sintagma rustica mensa: si vedano comeparalleli la pauper mensa di Tib. I, 1, 37 (che fa riferimentoanch’egli ai pocula); simplex è la mensa in Gratt.Cyn. 321; parca è la mensa in Sil. VI, 95; avara è la mensadi Mart. III, 58, 42; uncta è la mensa di Auson. Parent. 7, 9.Si veda quanto scrive Marziale (IX, 14):«Hunc quem mensa tibi, quem cena parauitamicum / esse putas fidae pectus amicitiae? /Aprum amat et mullos et sumen et ostrea, nonte. / Tam bene si cenem, noster amicus erit».«Costui che la tua mensa e le tue cene tihanno reso amico, pensi sia un animocapace di sincera amicizia? Lui ama ilcinghiale, le triglie, la tettina di scrofa e leostriche, non te. Se le mie cene fosserocosì buone, sarebbe amico mio».Se il ricco banchetto attira spesso personeinteressate e parassiti (si pensi alla fastosacena organizzata da Trimalchione), laparca mensa permette di stabilire sincerilegami di amicizia.Il secondo luogo è quello di Epist. II, 13, 7:«cumque pransuro Sardanapallicum in morempanis daretur e Leontina segete confectus, insuperdapes cultae ferculis cultioribus apponerentur,spumarent Falerno gemmae capaces inquecrystallis calerent unguenta glacialibus…».«Quando a lui, che si stava preparando apranzare alla maniera di Sardanapalo,veniva fornito pane preparato con spighedi Lentini, e inoltre vivande raffinategli venivano portate su vassoi ancorapiù raffinati, capaci tazze gemmate spumeggiavanodi Falerno e unguenti siriscaldavano in cristalli di ghiaccio…».Il destinatario <strong>del</strong>l’epistola sidoniana ha definitofelicissimus Petronio Massimo, che dopo un cursus honorumprestigioso riuscì nel 455 a divenire imperatore.Sidonio contraddice l’amico, dal momento chePetronio Massimo fu ucciso dopo pochi mesi, e il suobrevissimo regno costituì la parentesi più infelice <strong>del</strong>lasua vita. Il Princeps, anzi, rimpiangeva spesso i tempipassati, ricordando l’aneddoto <strong>del</strong>la spada diDamocle 28 , che Sidonio riprende dalla tradizione letterarialatina, contaminando le fonti, come sua consuetudine29 .La presenza di pane proveniente da terre lontane edi Falerno connotano ancora una volta un banchettosontuoso, anzi il banchetto sontuoso per eccellenza.Nell’epistola IX, 13 Sidonio racconta a Tonanzio, ilfiglio <strong>del</strong> suo amico, il nobile gallico TonanzioFerreolo, un episodio risalente agli anni <strong>del</strong>l’impero diMaioriano (457-461). Uno dei membri <strong>del</strong> sodalizioletterario riunisce alcuni amici a cena; uno dei divertimenti<strong>del</strong> banchetto è l’improvvisazione di versi; sisceglie come tema l’invito alla lettura <strong>del</strong> libro diPetrus, magister epistularum <strong>del</strong>l’Imperatore; i poeti ingara sono Domnulo, Severiano, Lampridio e Sidonio;- 92 -
FRANCESCO MONTONEciascuno dovrà recitare in un metro stabilito. Sidoniocompone in dimetri anacreontei; il componimento,che ora il poeta dopo tanti anni (l’epistola è datata trail 478 ed il 480) ha recuperato per inviarlo a Tonanzio,prende le mosse dalla pubblicazione <strong>del</strong> pregevolelibro di Petrus e si chiude con la celebrazione <strong>del</strong> successo<strong>del</strong> funzionario imperiale. In onore <strong>del</strong> volumedi Pietro si allestisce un elegante banchetto in cui tazzee coppe mescolano il Falerno al nardo (vv. 58-61):«Paterae, scyphi, lebetessocient Falerna nardo 30tripodasque 31 cantharosquerosa sutilis coronet»«Le tazze, le coppe, i catini mescolino ilFalerno al nardo, la rosa intrecciata coronie tripodi e boccali».Ancora una volta la presenza <strong>del</strong> Falerno è indispensabileper connotare la sontuosità <strong>del</strong> banchetto,che dovrà essere fastoso per essere all’altezza <strong>del</strong>la staturaumana e letteraria di Petrus. Sidonio riprende dueepigrammi di Marziale: in V, 64 Callisto è invitato aversare duos sextantes Falerni; le tempie saranno rilassaterosis…sutilibus (v. 4); in IX, 93 è presente il sintagmarosa… sutilis (v. 5) 32 , ed il puer è invitato a non smetteredi versare immortale Falernum (v. 1). La connessione travino e nardo è in un famoso luogo oraziano (Carm. IV,12, 16, nardo vina merebere). Sidonio, tuttavia, potrebbeanche aver presente un luogo lucaneo (X, 163-5: «indomitumMeroe cogens spumare Falernum. / Accipiunt sertasnardo florente coronas / et numquam fugiente rosa, multumquemadenti»).Sidonio, muovendosi sapientemente all’interno <strong>del</strong>palinsesto culturale costituito dalla tradizione letterarialatina, ricorre alla menzione <strong>del</strong> Falerno per connotareil banchetto fastoso; recuperando il tόpos <strong>del</strong>l’invitoa cena da parte <strong>del</strong> poeta (e quello <strong>del</strong> sobrio tenore divita <strong>del</strong> poeta!) sottolinea che la sua mensa è parca,priva, quindi, <strong>del</strong> Falerno; il suo umile desco, tuttavia,sarà propizio ad instaurare un sincero foedus con ildestinatario. Se Fabullo e Ommazio accetteranno didesinare in maniera parca nelle dimore di Catullo e diSidonio, vorrà dire che la loro lealtà verso i poeti èsalda e profonda. Un banchetto sontuoso, in cui saràservito il Falerno, è degno di Petrus, uomo potente chenon disdegna di cimentarsi nella letteratura, che è perSidonio il valore più alto; la mensa riccamente imbanditacon grano proveniente da lontano e l’immancabilevino campano può essere, però, anche allegoria <strong>del</strong>l’instabilità<strong>del</strong>la felicità umana, come nell’aneddoto<strong>del</strong>la spada di Damocle.Ampsancti vallesNell’epistola III, 13 Sidonio istruisce il figliodescrivendo la vita riprovevole di un parassita dei suoitempi, di nome Gnatone, dai cui vizi il giovaneApollinare dovrà tenersi lontano 33 . Un esempio per ilragazzo dovrà essere, invece, Potentino, cui il poeta sirivolge nell’epistola V, 16.Il parassita, che Sidonio immagina di origine lionese,rimanda all’omonimo personaggio <strong>del</strong>l’Eunuchus diTerenzio; è ritratto come un individuo spregevolesotto ogni punto di vista; è un personaggio volgare, uncacciatore di banchetti, avido nel bere, smodato neldenigrare: «è loquace senza essere arguto, ridicolosenza essere spiritoso, arrogante ma senza costanza,curioso ma senza perspicacia, e ancor più rozzo acausa di un’amabilità che ostenta a sproposito (Epist.III, 13, 2)». 34 Il suo aspetto fisico è davvero ripugnante.Ha orecchie elefantiache, labbra tumefatte, gengivepurulente e denti gialli ed un odore mefitico. Soffre dipitiriasi, la malattia <strong>del</strong>la pelle di cui si diceva soffrisseSilla. Sidonio aggiunge, a questo punto, un’ulterioreconnotazione (Epist. III, 13, 8): «Taceo quod alarum specubushircosis atque acescentibus latera captiva vallatus narescircumsedentum ventilata duplicis Ampsancti peste funerat».«Taccio <strong>del</strong> corpo prigioniero <strong>del</strong>le sue ascelle dallecavità caprine e acide che erigono uno steccato intornoa lui e che funestano le narici <strong>del</strong>le persone che glisiedono intorno con gli effluvi pestilenziali che sispandono nell’aria di un duplice Ansanto». 35L’Ansanto era un lago <strong>del</strong>l’Irpinia dalle esalazionimefitiche, considerato uno degli accessi all’Ade e‘ombelico d’Italia’, cioè corrispettivo di Delfi inGrecia. Ad immortalarlo era stato Virgilio in famosiversi <strong>del</strong>l’Eneide (VII, 563-71), che il nostro autore evidentementerichiama:«Est locus Italiae medio sub montibus altis, /nobilis et fama multis memoratus in oris, /Amsancti ualles; densis hunc frondibus atrumurget / utrimque latus nemoris, medioque fragosus/ dat sonitum saxis et torto uertice torrens./ hic specus horrendum et saeui spiracula Ditis/ monstrantur, ruptoque ingens Acheronteuorago / pestiferas aperit fauces, quis condita- 93 -
SALTERNUMErinys, / inuisum numen, terras caelumqueleuabat» 36 .«Nel cuore d’Italia giace, tra i monti, unluogo famosissimo, noto in molte regioni,la valle <strong>del</strong>l’Ansanto; una forestascura di foglie dense circonda il posto daogni parte, in mezzo scorre un torrenterumoroso, e rimbomba di vortici roteantie sassi. Qui si spalanca una speloncaorribile, porta che mena a Dite, un’immensavoragine che apre fauci pestiferesull’Acheronte. Qui si nascose l’Erinniodiosa, rasserenando il cielo e la terra» 37 .La Gualandri 38 sottolinea che l’autore allude alpuzzo di caprone, l’hircus in alis (Hor. Epod. 12, 5), utilizzaora il vocabolo preciso come acescentibus (carm. 5,342), ora la perifrasi burlesca alarum specubus (che ricordaCatull. 69, 6), ora l’immagine barocca latera captivavallatus, che indica l’assedio di cui il puzzo cinge la personafinendo per imprigionarla.Non viene sottolineato, però, che Sidonio hacostruito la sua immagine servendosi <strong>del</strong> lessico virgilianoin maniera straniante: da un paesaggio cheemana effluvi pestilenziali, che si pone al liminare, checollega mondo terreno e divino, ha ricavato una <strong>del</strong>letante connotazioni negative di Gnatone: un essereributtante, la sua puzza ‘infernale’. Il ventilata… pestesidoniano richiama il pestiferas fauces 39 : gli effluvi pestilenziali<strong>del</strong> parassita sono evidentemente doppiamente(duplicis) malefici rispetto alle bocche pestifere<strong>del</strong>l’Acheronte.Latera rimanda a latus (ma al fianco <strong>del</strong> colle sisostituiscono i fianchi <strong>del</strong> parassita), specubus sostituiscespecus (le cavità <strong>del</strong>le ascelle prendono il posto <strong>del</strong>lavoragine virgiliana); valles, inoltre, è ripreso nel vallatus;la trasformazione <strong>del</strong> locus horridus in un turpissimushomo, <strong>del</strong>la valle dagli effluvi mefitici nel parassita dalleascelle puzzolenti coinvolge anche chi lo circonda; aglialti monti che si trovano intorno alla valle si sostituiscono,infatti, coloro che siedono intorno a Gnatonee che sono costretti con le loro narici a respirare i suoifetidi odori (medio sub montibus altis/ nares circumsedentum).Il funerat richiama i luoghi di morte evocati daVirgilio: l’Acheronte, la cru<strong>del</strong>e porta di Dite, oltre aduna figura mitica come l’Erinni. Nel prezioso e iperbolicotesto sidoniano gli effluvi <strong>del</strong> parassita possonoessere letali e mortiferi, dato che per trovare un possibileconfronto occorre immaginare addirittura duemefitiche valli d’Ansanto. Gnatone è un essere ‘disumanizzato’,come la valle <strong>del</strong>l’Ansanto è luogo chepotremmo definire ‘trans-umano’.AvernusAltro luogo di passaggio verso l’Oltretomba eral’Averno, piccolo lago <strong>del</strong>la Campania, nei CampiFlegrei; era al centro di una zona paludosa e malsana;le sue esalazioni erano ritenute letali anche per gliuccelli che vi passavano a volo, onde il nome Averno(a- privativo e órnis uccello, cioè ‘privo di uccelli’). Ilnome fu esteso dai poeti latini a tutto il regno deimorti.Sidonio lo menziona in carm. 2, 70 (il Panegiricoper l’imperatore Antemio, recitato nel 468) e in carm.15, 163 (è il carme per le nozze di Polemio e Araneola,composto tra il 461 ed il 462). In entrambi i casi il riferimentocompare in connessione alla triste vicenda diOrfeo. Abbiamo, forse, un esempio di intenzionaleintratestualità. In carm. 15, 162-64,«Taenaron hic frustra bis rapta coniuge pulsat/ Thrax fidibus, legem postquam temeravitAverni, / et prodesse putans iterum non respicitumbram», («Là il tracio Orfeo (duevolte gli è stata rapita la sposa) fa risuonareinvano il Tènaro con la sua cetradopo aver violato la legge d’Averno e,pensando che possa giovare, non sivolge di nuovo a guardare l’ombra» 40 ); ilcanto di Orfeo e l’obbedienza tardivaalla prescrizione si rivelano vani a vince-Fig. 5 - Il lago d'Averno.- 94 -
FRANCESCO MONTONEre la lex Averni 41 (il sintagma legem…Averni è ripreso da Drac. laud. dei 2, 546).Come evidenzia il Ravenna 42 , «Orfeo èdescritto mentre suona ‘invano’; è questoun bellissimo esempio di sympatheiada parte <strong>del</strong> narratore, che proviene daOv. Met. X, 72-3 orantem frustraque iterumtransire volentem portitor arcuerat (scil.Orphea)», intertesto già rilevato dalGeisler 43 .Vediamo, invece, l’altro luogo: carm. 2,67-74: «…Tali tu ciuis ab urbe / Procopiogenitore micas, cui prisca propago / augustisuenit a proauis 44 ; quem dicere digno / nondatur eloquio, nec si modo surgat Auerno / quicantu flexit scopulos digitisque canoris / compulitauritas ad plectrum currere siluas, / cumstarent Hebri latices cursuque ligato / fluminisattoniti carmen magis unda sitiret» 45 : «…Tucittadino di tale città brilli per tuo padreProcopio, il cui antico lignaggio provieneda antenati imperiali; non sarebbe possibilecelebrarlo con un degno eloquio,nemmeno se ora dall’Averno si ergessecolui che piegò con il canto gli scogli econ le dita canore spinse le selve tutteorecchi a correre al suono <strong>del</strong> plettro,mentre le acque <strong>del</strong>l’Ebro erano ferme efrenato il corso l’onda <strong>del</strong> fiume attonitosi abbeverava piuttosto <strong>del</strong> carme».Dopo aver elogiato Costantinopoli, Sidonio esaltaProcopio, le cui lodi non potrebbero essere cantatenemmeno se dall’Averno si ergesse il mitico cantoretracio. Orfeo, pur esaltato per la sua capacità di smuoverele terre e di fermare le acque, subisce un’ulteriorepesante sconfitta; è incapace, infatti, non solo dismuovere nuovamente il Tènaro e di richiamare in vitaper la seconda volta Euridice, ma anche di lodareProcopio.Le uniche due menzioni <strong>del</strong>l’Averno nell’opera diSidonio e la datazione dei due carmi (l’epitalamio precedeil panegirico) potrebbero autorizzare un collegamentotra le due testualità: è missione impossibile perOrfeo (e per qualunque mortale) lodare Procopio,come vincere la morte e riabbracciare la donna amata.PuteoliAltro luogo dei Campi Flegrei citato da Sidonio èPozzuoli. L’area flegrea, già alla fine <strong>del</strong>la Repubblicatra le più urbanizzate d’Italia, beneficiò nei primi secoli<strong>del</strong>l’Impero <strong>del</strong>la straordinaria fortuna di Puteoli;almeno fino a Commodo fu capolinea <strong>del</strong>le navi <strong>del</strong>laclassis Alexandrina, che trasportavano il grano a Roma,e principale centro di traffico <strong>del</strong> Mediterraneo occidentale(fu Ostia a prendere il suo posto). Dopo ildeclino <strong>del</strong> II e <strong>del</strong> III sec. d. C., con la ‘provincializzazionedioclezianea’ <strong>del</strong>l’Italia, Puteoli riacquistò unruolo di rilievo nei meccanismi annonari di Roma, alpunto che l’area riprese ad essere frequentata dall’aristocraziaromana, che l’aveva abbandonata nel III sec.Verso la fine <strong>del</strong> IV secolo Puteoli fu colpita da fenomenibradisismici, che resero necessari lavori direstauro <strong>del</strong> porto 46 .Nel Panegirico per l’imperatore Antemio, Sidonioesalta Costantinopoli, costruita anche grazie al terrenovulcanico (la pulvis Puteolana) importato da Pozzuoli(vv. 59-61: «namque Dicearcheae 47 translatus pulvis harenae/ intratis solidatur aquis durataque massa / sustinet advectosperegrino in gurgite campos»: «e infatti la sabbia polverosadi Pozzuoli trasportata / è rassodata dalle acque penetratee la massa consolidata / sostiene i terreni importaticon acque straniere»).La pulvis Puteolana immersa nell’acqua dava originead un cemento molto resistente. Di tale pulvis parlano,in particolare, Plinio il Vecchio (Nat., I, 35a, 80; XVI,202, 4; XXXV, 166, 3) che fa riferimento ad essa,come Sidonio, utilizzando nello stesso contesto ancheil sostantivo harena (XXXIII, 161, 6 «accessit hisPuteolanum et Hispaniense, harena ibi confici coepta»), eSeneca, in un luogo <strong>del</strong>le Naturales Quaestiones (III, 20,3, 5: «Quemadmodum Puteolanus puluis, si aquam attigit,saxum est, sic e contrario haec aqua, si solidum tetigit, haeret etaffigitur»), che potrebbe essere presente nella memoriadi Sidonio, o che comunque dovrebbe essere citatocome locus similis (nessuno di questi luoghi è richiamatodai commenti e dal Geisler 48 ): aquam attigit divieneaquis intratis; saxum est e solidum sono sostituiti da solidatur.CapreaeAnche Capri è citata due volte nell’opera sidoniana,in entrambi i casi collegata a Tiberio, all’interno dicataloghi di imperatori. L’isola entrò a far parte <strong>del</strong>demanio imperiale sotto Augusto, che vi fece costrui-- 95 -
SALTERNUMFig. 6 - L’Anfiteatro flavio di Pozzuoli.re fastose residenze, imitato da Tiberio che vi soggiornò,come é noto, dal 26 al 37 d. C. 49 Secondo la testimonianzadi Tacito (Ann. IV, 67, 5), Tiberio risiedevain dodici diverse ville con differenti nomi, la piùimportante <strong>del</strong>le quali era la Villa Iovis, rinvenuta dalMaiuri tra il 1932 ed il 1935 50 . Nel suo soggiorno nell’isola,secondo Svetonio (Tib. XLII-XLV), Tiberiomostrò la sua vera natura, abbandonandosi a tutti i viziche aveva mal dissimulato fino a quel momento.Capri, come le altre isole <strong>del</strong> Golfo di Napoli (adeccezione, forse, di Procida), rimase immune dalledevastazioni germaniche <strong>del</strong> V secolo. Quasi ignoratadalle fonti in età tardoantica, non recise <strong>del</strong> tutto ilegami economici con la terraferma.Nel Panegirico ad Avito, ai vv. 104-105 la deaRoma, supplice al cospetto di Zeus, ricorda le tappe<strong>del</strong>la storia di Roma, il passaggio dalla Repubblica alPrincipato, elencando i primi imperatori: vv. 104-105:«(…). Capreasque Tiberi / et caligas Gai Claudi censura secutaest / et vir morte Nero …»: «Alla Capri di Tiberio / eai calzari di Gaio seguì la censura di Claudio e Neronesoltanto nel momento <strong>del</strong>la morte». Alla menzione <strong>del</strong>nome degli imperatori si accompagna il ricordo di unaloro caratteristica precipua: Caligola è immortalatocon le sue caligae, che indossava da piccolo negliaccampamenti renani; Claudio è ricordato per il comportamentoeccentrico tenuto durante il suo incaricodi censore (Suet. Claud. XVI); a Nerone si attribuisceun mo<strong>del</strong>lo virile soltanto nel momento <strong>del</strong>la morte; ilricordo letterario di Capri è ancorato indissolubilmentea Tiberio. Capri e Tibero sono legati in altri autoritardoantichi come Claudiano (8, 313 ss.: «quem diraNeronis / funera, quem rupes Caprearum taetra latebit /incestopossessa seni?»), che afferma che Tiberio non potrànascondere le sue infamie tra le rocce di Capri, eAusonio (Caes. 56-7: «Frustra dehinc solo Caprearum claususin antro / quae prodit vitiis, credit operta locis»), cheriprende Svetonio ribadendo che il soggiorno capresepermise a Tibero di abbandonarsi a quei vizi che credevainvano di occultare in altri luoghi (entrambi gliautori, forse, riprendono un luogo di Giovenale, in cuicompare l’unica altra attestazione di Caprearum in poesia:10, 92-4: «tutor haberi / principis angusta Caprearum inrupe sedentis / cum grege Chaldaeo»; si fa riferimento aSeiano, tutor principis, in quanto a capo <strong>del</strong>la guardiapretoriana di Tiberio, rappresentato mentre «se ne stanella sua stretta rupe di Capri col suo gregge diCaldei».).La morte violenta di Nerone è ricordata daSidonio, con la sua consueta tecnica contaminatoria,con le parole con cui Ausonio fa riferimento allamorte di Vitellio (Caes. 14: «Nec regno dignus nec morteVitellius ut uir».).Si vedano adesso i vv. 321 s. <strong>del</strong> Panegirico aMaioriano: «post Capreas Tiberi, post turpia numina Gai/censuram Claudi cithara thalamosque Neronis»: «dopo laCapri di Tiberio, dopo la turpe assunzione di divinitàda parte di Gaio e la censura di Claudio e la cetra e italami di Nerone». Claudio e Tiberio appaiono anchein questo luogo menzionati in riferimento rispettivamenteall’operato da censore ed al soggiorno a Capri,laddove altri comportamenti infamanti sono associatialle figure di Caligola e Nerone. Capri e Tiberio sonoindissolubilmente avvinti.Capua, Baiae, Lucrinus, GaurusCapua ed i Campi Flegrei sono legati, invece, agli‘ozi capuani’ di Annibale, di cui Sidonio fa menzionenel Panegirico a Maioriano, ai vv. 342-49:«(…) Non sic Barcaeus opimamHannibal ad Capuam periit, cum fortia bellointer <strong>del</strong>icias mollirent corpora Baiaeet se Lucrinas qua uergit Gaurus in undasbracchia Massylus iactaret nigra natator.atque ideo hunc dominum saltem post saeculatantaultorem mihi redde, precor, ne dimicet ultraCarthago Italiam contra…».«Non così andò in rovina Annibale Barcanella ricca Capua, quando Baia rammollì- 96 -
FRANCESCO MONTONEtra le sue <strong>del</strong>izie i corpi resi forti dallaguerra e il Massilo nuotatore agitava lenere braccia lì dove il Gauro si chinaverso le acque <strong>del</strong> Lucrino. Per questo, tiprego, dammi almeno questo sovranodopo tante generazioni, perché sia il miovendicatore e perché Cartagine non combattaun’altra volta contro l’Italia».Baia, città dei Campi Flegrei, sulla sponda occidentale<strong>del</strong> golfo di Pozzuoli, forse in origine porto diCuma, era famosa per le sue sorgenti sulfuree calde(Aquae Cumanae), la mitezza <strong>del</strong> clima e la bellezza <strong>del</strong>panorama. Nella tarda Repubblica divenne una stazionebalneare di moda, frequentata dalla classe dirigenteromana, come testimoniano i grandi edifici termali e lemolte ville appartenute a illustri personaggi 51 . GiàVarrone (Sat. Menipp. fr. 44 Buecheler) condannava ilussi di Baia: «quod non solum innubae fiunt communes, sedetiam veteres repuerascunt et multi pueri puellascunt». InCarm. II, 18, 17-22 Orazio descrive il fervore dei lavoriedilizi nel centro flegreo: «tu secanda marmora / locassub ipsum funus et sepulcri / inmemor struis domos / marisqueBais obstrepentis urges / submovere litora, / parumlocuplescontinente ripa»: «tu commissioni tagli ampi dimarmi nell’imminenza <strong>del</strong>la sepoltura e levi casa escordi la tua tomba, sconvolgi coste, argini il mare chepercuote Baia: per confine una spiaggia, è poco signorile»52 . Properzio si scaglia contro Baia, luogo di corruzioneper le fanciulle caste, ed esorta l’amata Cinzia adallontanarsi da quei vergognosi lidi (I, 11, 27-30).Seneca, a sua volta, nell’epistola LI, 1-3, afferma diaver lasciato Baia dopo un giorno, dal momento che èdivenuta un luogo che induce al vizio.Nel corso <strong>del</strong> III secolo, però, le lussuose ville diotium di Baia e Puteoli furono gradualmente abbandonate,anche perché spesso erano divenute fatiscenti.Fu con la ‘provincializzazione dioclezianea’, comedetto, che l’area tornò ad essere frequentata dalla riccaaristocrazia senatoria romana 53 . Le devastazioni deiGoti dopo il sacco di Roma <strong>del</strong> 410 comportarono unforte declino <strong>del</strong>l’area flegrea. Sebbene manchinoprove di incursioni alariciane ai danni di Puteoli, ad essee alla paura di quelle vandaliche si devono l’abbandono<strong>del</strong> porto ed il declino economico-demografico.L’aristocrazia romana frequentò sempre meno l’areaflegrea, abbandonando le ricche ville di otium di Baia,che erano minacciate da bradisismo, come pure quelledi Bauli (Bacoli) e di Lucrinum. 54 Tuttavia Baia è menzionata,successivamente, da Cassiodoro 55 , segno chedoveva essere presente qualche forma di insediamento,legata al funzionamento <strong>del</strong>la stazione termale.Fig. 7 - Le Terme di Baia.Il Lucrino è il lago costiero presso i Campi Flegrei,separato dal mare da un argine in parte artificiale, checongiungeva Baia a Pozzuoli; Agrippa (I sec. a. C.)fece costruire su di esso una strada, e tentò di metterein comunicazione il lago con l’Averno, da lui trasformatoin porto (portus Iulius). Il lago Lucrino era famosoper gli allevamenti di pesci e di ostriche. In seguitoAugusto fece tagliare l’argine.Il Gauro è un monte vulcanico <strong>del</strong>la Campaniacostituito da tufi gialli litificati. Il Geisler segnalacome intertesti Sil. Ital. X, 354, Barcaei…iuvenis eVerg. Aen. I, 13, Karthago Italiam contra 56 . L’Africa sirivolge alla dea Roma, perché le dia un vendicatore,l’imperatore Maioriano, contro il Vandalo Genserico.Per la quarta volta, quindi, Roma e l’Africa si accingonoa scontrarsi. La pigrizia e l’ignavia diGenserico, che ha ottenuto successi ma non per suoimeriti, sono paragonate agli ozi capuani cui si abbandonòAnnibale, secondo quanto ci racconta Livio(XXIII, 18, 10-16 57 ); la Campania felix, perciò, segnòun punto a favore di Roma, indebolendo con tutte lesue attrattive l’esercito punico, fin a quel momentoinvitto. Coloro che nessuno era riuscito a piegare,furono fiaccati dalle numerose bellezze e dai piacerisfrenati <strong>del</strong>la Campania (Liv. XXIII, 18, 11: «quosnulla mali uicerat uis, perdidere nimia bona ac uoluptatesimmodicae»).Il motivo compare, ad esempio, in Sil. Ital. VI, 648-52 58 e in Prud. C. Symm. II, 739-47: «… Ille petitae / post-- 97 -
SALTERNUMFig. 8 - Il lago Lucrino.quam perculerat tremefacta repagula portae, / Baianis resolutusaquis durissima luxu / robora destituit ferrumque libidinefregit. / At noster Stilico congressus comminus ipsa / ex acieferrata uirum dare terga coegit. / Hic Christus nobis deusaffuit et mera uirtus; / Illic lasciuum, Campania fertilis,hostem / <strong>del</strong>iciae uicere tuae».Come in Sidonio, in Prudenzio compare l’opposizionetra la durezza dei soldati cartaginesi e le mollezzecampane che finiscono per sopraffarli. Al durissimadi Prudenzio corrisponde il fortia di Sidonio, al roborail corpora; il Nostro fa riferimento alle lucrinae undae,anziché alle baianae aquae; attribuisce le <strong>del</strong>iciae direttamentea Baia, anziché alla Campania felix; l’immagine<strong>del</strong> Massilo che nuota nel Lucrino sembra essere suggeritadai balinea di cui parla Livio (XXIII, 18,12: «somnusenim et uinum et epulae et scorta balineaque et otium consuetudinein dies blandius ita eneruauerunt corpora animosque»);il mollirent corpora sidoniano rimanda ad enervaveruntcorpora di Livio, ma anche ai termini con cuiPrudenzio connotava la totale metamorfosi <strong>del</strong>la duritiadei soldati di Annibale (luxu – libidine – lascivum).Le suggestioni <strong>del</strong> polifonico testo sidoniano nonsi fermano qui. Fortia bello /…corpora è ripresa con leggeravariatio di fortia bello / robora di Verg. Aen. VIII,150 (la clausola compare solo in questi due Autori); ilsintagma inter <strong>del</strong>icias compare in poesia, prima diSidonio, sempre a inizio verso, in Mart. I, 59, 2 e VII,88, 2, oltre che in Repos. conc. 22; è evidente cheSidonio ha in mente il primo luogo <strong>del</strong> poeta di Bilbilis,in cui compare un riferimento a Baia (si parla al primoverso di Baiana…sportula) e si menzionano anche i suoibalnea (v. 3).Se nel testo di Prudenzio si evidenzia una progressivametamorfosi <strong>del</strong>la duritia dei soldati annibalici inmollitia, che è l’esito di uno ‘scontro’ tra l’esercito invasoree la Campania felix, destinata a vincere («Illiclasciuum, Campania fertilis, hostem / <strong>del</strong>iciae uicere tuae»),Sidonio ha reso la stessa antitesi ricorrendo a diverseanime poetiche: il fortia bello, clausola epica virgiliana,riferita (in Sidonio) ai corpi dei Cartaginesi, si opponeall’inter <strong>del</strong>icias, incipit di un verso di Marziale, riferito (inentrambi i poeti) alle mollezze di Baia; il tono altisonante<strong>del</strong>l’épos contrasta con la leggerezza <strong>del</strong>la poesiaepigrammatica.Un’oppositio, però, pur non messa in rilievo daSidonio, ha coinvolto anche i luoghi campani: Baia, ilLucrino e il Gauro hanno impedito con la loro amenitàla distruzione di Roma, mentre l’opima Capua, con lesue floride risorse, si è schierata dalla parte diAnnibale.L’espressione Barcaeus opimam /…Capuam ricalcauna costruzione virgiliana (Aen. I, 621-22: …Belus opimam/ …Cyprum). La ricchezza di Capua, oltre ad essereun dato storico, è anche un tòpos letterario (ad es.Verg. Georg. II, 224 dives Capua 59 , ripreso da Paol. Nol.carm. 14, 60); alla fine <strong>del</strong> IV secolo Ausonio (Urb. nob.61: «Illa potens opibusque ualens, Roma altera quondam» 60 )ne ricorda l’opulenza, che la rendeva una secondaRoma, la città italiana più importante dopo Roma eMilano e l’ottava <strong>del</strong>l’Impero. Le invasioni di Alaricoarrecarono forti danni agli edifici pubblici capuani, manon comportarono il ridimensionamento <strong>del</strong> ruoloamministrativo ed economico <strong>del</strong>la città 61 .Per l’utilizzo <strong>del</strong>la iunctura iactare bracchia con ilsignificato di ‘nuotare’ 62 , si vedano come loci similes Ov.epist. 17, 96 18, 58: «iactabam liquido bracchia lenta mari»;ID. met. V, 596: «mille modis labens excussaque bracchiaiacto»; ID. Pont. I, 6, 34: «Naufragus in mediis brachia iactetaquis»; Lucan. III, 650-651: «Versa caua texit pelagusnautasque carina, / bracchia nec licuit uasto iactare profundo»;ID. III, 661-2: «… Pars maxima turbae /naufraga iactatismorti obluctata lacertis». Una suggestione può averla fornitaanche Mart. IV, 57, 1:, «Dum nos blanda tenent lascivistagna Lucrini».Bracchia…nigra compare in uguale posizione metricain Iuv. 13, 45 63 (ma il sintagma è già, in poesia, inStat. Theb. VII, 45); un’altra suggestione può averlasuggerita un passo di Lucano (II, 666-67: «uel si conuulsouertice Gaurus / decidat in fundum penitus stagnantisAuerni»).La Campania è quindi topicamente celebrata peressere riuscita con le sue bellezze ad infliggere una- 98 -
FRANCESCO MONTONEpesante sconfitta al terribile esercito annibalico.Il tόpos <strong>del</strong>la Campania felix è ‘protagonista’ <strong>del</strong>carme 18 di Sidonio, su cui ho avuto già modo di soffermarmialtrove 64 ; non sarà inutile, però, procederead ulteriori precisazioni.Nel carme 18 Sidonio invita un interlocutore nonprecisato a visitare il suo praedium preferito, la villa diAvitaco, minutamente descritta nell’epist. II, 2; le amenità<strong>del</strong> sito sono paragonate alla bellezza <strong>del</strong>laCampania felix; Sidonio riutilizza un tόpos consolidatodalla tradizione letteraria, costruendo su di esso unintero componimento. Per lodare la sua tenuta,Sidonio la paragona al luogo più bello per eccellenza,la celebre Campania felix. Sidonio, tuttavia, introduceuna novitas: le bellezze <strong>del</strong>la regione italiana, le amenitàdi Baia hanno trovato finalmente un degno avversarionella sua Avitaco, in grado di sottrarle il suo inossidabileprimato.«Si quis Auitacum dignaris uisere nostram,Non tibi displiceat: sic quod habes placeat.Aemula Baiano tolluntur culmina conoParque cothurnato uertice fulget apex.Garrula Gauranis plus murmurat unda fluentisContigui collis lapsa supercilio.Lucrinum stagnum diues Campania nollet,Aequora si nostri cerneret illa lacus.Illud puniceis ornatur litus echinis:piscibus in nostris, hospes, utrumque uides.Si libet et placido partiris gaudia corde,Quisquis ades, Baias tu facis hic animo».«Chiunque tu sia, se ti degni di visitare lamia Avitaco, non ti spiaccia: così ti piacciaciò che hai. Il suo tetto si leva emulo<strong>del</strong> cono di Baia e pari la cima risplendesul coturno <strong>del</strong> vertice. L’onda che scendedal ciglio <strong>del</strong> colle contiguo mormorapiù risonante di quella che scorre dalGauro. La Campania felix rifiuterebbe illago Lucrino, alla vista <strong>del</strong>le celebriacque <strong>del</strong> nostro lago. Quel lido è adornodi ricci di mare rossi: nei nostri pesci,o ospite, vedi entrambe le caratteristiche.Se ti piace e condividi le nostre gioie concuore sereno, chiunque sia tu che vieni,ricrei qui Baia nell’animo».Nel momento stesso in cui Sidonio celebra le bellezze<strong>del</strong>la Campania ne decreta la loro inferioritàrispetto alla sua villa preferita. Con l’espressioneBaiano cono si fa riferimento, come notano Anderson ela Mesturini, al tetto <strong>del</strong>le terme di Baia 65 e non alVesuvio, come interpretano il Loyen e il Bellès.Lo spunto a Sidonio per paragonare le amenità diBaia a quelle <strong>del</strong>la sua Avitaco lo ha fornito Plinio ilGiovane, nella descrizione <strong>del</strong>la sua villa sul lago diComo: Epist. IX, 2: «altera (scil. Villa)…more Baianolacum prospicit, altera aeque more Baiano lacum tangit, itaqueillam tragoediam, hanc appellare comoediam soleo; illam, quodquasi cothurnis, hane, quod quasi socculis sustinetur».Sidonio, tuttavia, compie un’operazione letterariapiù complessa; si preoccupa di salvaguardare un tόposletterario dall’oblio che rischia di avvolgere la civiltàromana, sul punto di soccombere; allo stesso tempo,però, lo demolisce dall’interno: la stessa celebreCampania felix, nonostante tutte le sue amenità (Baia, leacque pescose <strong>del</strong> Lucrino) si dichiarerebbe vinta nelvedere le acque di Avitaco. Tra i numerosi intertesti, inparticolare di Marziale, che Sidonio ha in mente 66 , c’èanche un evidente richiamo a Georg. I, 107-110:«et, cum exustus ager morientibus aestuat herbis,ecce supercilio cliuosi tramitis undamelicit? illa cadens raucum per leuia murmursaxa ciet…».«e quando il campo bruciato avvampa disteli moribondi, ecco, dal ciglio di uncammino inclinato far sgorgare l’onda?Quella cadendo risveglia un roco mormoriotra i sassi politi …» 67 .Virgilio sta illustrando il duro compito che spettaagli agricoltori che vogliono rendere fecondo il lorocampo; questi, facendo sgorgare l’acqua e incanalandola,concedono alle terre un sollievo dall’arsura. Undaè ripreso da Sidonio, che aggiunge ad esso l’evocativogarrula 68 , che rende il suono scrosciante <strong>del</strong>le acque;lapsa riecheggia il virgiliano cadens; plus murmurat èriscrittura <strong>del</strong> virgiliano raucum murmur ciet; il supercilioclivosi tramitis <strong>del</strong> Mantovano diviene il contigui collissupercilio <strong>del</strong> nostro autore. A me pare, comunque, cheSidonio non si sia limitato, descrivendo lo spettacolarepaesaggio di Avitaco, a far proprio, come suo solito,il lessico virgiliano, riproducendone i significanti.- 99 -
SALTERNUMLa bellezza <strong>del</strong>le acque di Avitaco, paragonate a quelle<strong>del</strong> Gauro <strong>del</strong>la topica Campania felix, devono evocare,per contrasto, l’improbo lavoro nei campi cui Giove hacostretto l’uomo affinché aguzzassero i loro ingegni (sivedano, subito dopo, i famosi versi di Georg. I, 121-123:« … Pater ipse colendi / haut facilem esse viam voluit primusqueper artem /movit agros curis acuens mortalia corda»). La ‘naturalità’<strong>del</strong>le acque di Avitaco risulta ancor più accentuata,dalla riproposizione, e contrario, nella memoria letteraria<strong>del</strong> lettore, <strong>del</strong>l’immagine <strong>del</strong>l’‘artificialità’ <strong>del</strong> lavorocompiuto dal contadino virgiliano per dirottare l’acquanei campi che desidera far fruttare. È possibile, amio parere, pur nella consueta rete di riecheggiamentitessuta dal dettato sidoniano, individuare un’allusioneall’ipotesto virgiliano, un dialogo intenzionale tra il testodi Sidonio e quello <strong>del</strong> Mantovano 69 .Nell’ultimo verso <strong>del</strong> carme si osserva un uso traslatodi Baia; come paralleli si possono citare Mart. X,13, 3: strataque non unas cingant triclinia Baias e ibid., 58,2: et propius Baias litoreamque domum, oltre a Cassiod. var.XII, 22, 3 70 .Nelle altre due occorrenze sidoniane, Baia è, invece,citata come termine generico per indicare un locusaquis calidis instructus 71 , un luogo cioè dotato di sorgentitermali, come avviene anche in Anth. Lat. 179, 1 e377, 1 (ed. Riese); Carm. epigr. 1255, 3, Felix anth. 211, 1.Come il Falerno è il vino pregiato per eccellenza, Baiaè talmente rinomata da poter essere antonimo <strong>del</strong>lestazioni termali.In epist. V, 14 Sidonio si rivolge all’amico Apro e glichiede se si sta dilettando nelle calentes Baiae. Lo scrittore,a parere <strong>del</strong>l’Anderson-Warmington 72 , probabilmentesi riferisce alle Aquae Calidae che nella TabulaPeutingeriana (2, 4 73 ) identificano la moderna Vichy(sebbene con lo stesso appellativo si denominasserovarie sorgenti termali).Nel carme 23, 13, dedicato a Cosenzio, un poetaamico di Sidonio, si fa riferimento alle Sestiasque Baias,intendendo le rinomate terme di Aquae Sextiae (Aix),centro fondato da C. Sestio Calvino nel 122 a. C.SurrentumNell’opera sidoniana compare anche un riferimentoa Sorrento 74 ; il centro subì un forte spopolamentoin seguito all’eruzione <strong>del</strong> 79 d. C. I quartieri gravitantiintorno al porto furono rioccupati nel II sec.; lapenisola sorrentina, tuttavia, rimase indenne dalleNel brano che segue il carme 22 76 , Sidonio menzionaalcune Silvae di Stazio, tra cui la III, 1, dal titoloHercules Surrentinus Pollii Felicis, in onore <strong>del</strong> destinatario(oltre che <strong>del</strong> carme) <strong>del</strong> III libro <strong>del</strong>l’opera <strong>del</strong>poeta campano, Pollio Felice, che aveva fatto consacraresulla sua spiaggia a Sorrento un tempietto adErcole. La citazione è, quindi, eminentemente letterariae si traduce in un omaggio da parte di Sidonio aduno dei suoi autori preferiti, il campano Cecilio Stazio.ConclusioniNelle opere di Sidonio la Campania emerge comeluogo <strong>del</strong>la bellezza e <strong>del</strong> mistero. È celebrata comesito più bello <strong>del</strong>la terra (il cui primato può essere insidiatosolo dal praedium preferito di Sidonio, la sua villadi Avitaco); è filtrata attraverso una tradizione letterariache ha costruito immagini topiche, con cui il nostroautore, abilissimo a sfruttare l’immenso palinsesto culturaleche padroneggia, deve fare i conti per potercostruire la sua anthologia di motivi letterari baroccamentecontaminati; fine <strong>del</strong> poeta tardoantico è quellodi costituire nuovi segmenti testuali, che fondano insè plurimi echi letterari 77 . La Campania è terra agricolaper eccellenza, terra <strong>del</strong> vino e, in particolare, <strong>del</strong>più celebre vino, il Falerno, senza il quale un banchettonon può dirsi sontuoso; Capua è città opima pereccellenza; Baia è luogo <strong>del</strong> lusso e <strong>del</strong>l’otium, oltre cheantonimo di ogni rilassante e prestigioso luogo termale;il Lucrino è il lago ricco di pesci, su cui si affacciail Gauro; l’Averno e la valle <strong>del</strong>l’Ansanto sono misteriosiluoghi di passaggio tra la vita e la morte e accessiall’Ade; Capri è legata indissolubilmente a Tiberio;Sorrento è legata al culto di Ercole ed al ricordo letterariodi Stazio, Pozzuoli, uno dei porti più importanti<strong>del</strong>l’Impero romano, alla pulvis Puteolana.È l’immagine <strong>del</strong>la Campania che la tradizione letterariaha costruito e che Sidonio cerca in ogni mododi far rivivere, molto differente da quella che si sarebbeofferta ad un visitatore <strong>del</strong> V secolo.Studiare la memoria letteraria e la memoria storicadi una regione offre la possibilità di un percorso affascinanteche si rivela foriero di importanti acquisizionie riflessioni.In Silv. IV, 4 il poeta campano Cecilio Stazio sirivolge ai suoi versi, invitandoli a raggiungere l’amicoVittorio Marcello. Il suo canto, afferma Stazio, parteda Partenope, da quei luoghi che il Vesuvio distrusse.incursioni germaniche <strong>del</strong> V sec. 75 - 100 -
FRANCESCO MONTONEIl poeta, a questo punto, dopo aver accostato Etna eVesuvio, si abbandona ad una considerazione esistenziale:le generazioni dei posteri che abiteranno questiluoghi penseranno ai popoli e alle città qui sepolte persempre?vv. 78-84:«Haec ego Chalcidicis ad te, Marcelle, sonabamlitoribus, fractas ubi Vesvius erigit iras, aemulaTrinacriis volvens incendia flammis.Mira fides! credetne virum ventura propago,cum segetes iterum, cum iam haec deserta virebunt,infra urbes populosque premi proavitaque totorura abiisse mari?... ».«Questo canto, o Marcello, io facevorisuonare per te sulle spiagge calcidiche,dove il Vesuvio innalza la sua ira ormaiesplosa, emanando fiamme simili a quelle<strong>del</strong> vulcano di Trinacria. Quanta incredibilefede! Crederanno mai le generazionifuture degli uomini, quando ormaidi nuovo le messi e questi aridi luoghiverdeggeranno, che sotto i loro piedisiano sepolti città e popoli, che campagneavite siano scomparse nel mare?».La nostra Campania, oltre che zona martoriatadalle sistematiche azioni distruttive degli uomini, èanche depositaria di una memoria mitica, letteraria estorica fin dagli albori <strong>del</strong>la civiltà; oltre che paesaggiofisico è anche paesaggio mentale, spirituale, sede di unpatrimonio identitario che ciascuno, con le parole econ le opere, ha il compito di conoscere, trasmettereed eternare, perché possa risiedere non nei libri, manelle menti e nei cuori degli uomini.A ognuno di noi spetta l’onere di valorizzare lanostra terra, la cui bellezza è tale, potremmo aggiungere,da non poter essere celebrata nemmeno daOrfeo.- 101 -
SALTERNUMNote1Su quest’epistola di Sidonio si vedanoKÖHLER 1995, pp. 183-215 e MAZZOLI2005-2006. Il testo di Sidonio è citatosecondo l’edizione in cinque volumi curatadal BELLÈS (1989-1999).2PIACENTE 2005.3Come sottolinea HARRIES 1994, p. 17, inepist. VIII, 2, 2 Sidonio afferma che oramai(siamo nel 478) solo la cultura può distingueregli uomini migliori dagli altri dalmomento che il gradus dignitatum è venutomeno («nam iam remotis gradibus dignitatum perquas solebant ultimo a quoque summus quisquediscerni, solum erit posta nobilitatis indicium litterasnosse»).4È in realtà non chiaro il motivo per cuiSidonio fu convocato a Roma; lo scrittoredoveva perorare la causa <strong>del</strong>l’amicoArvando o chiedere ragguagli, a nome degliArverni, sulla politica che il nuovo Princepsavrebbe intrapreso nei confronti <strong>del</strong>laGallia. Le due ipotesi sono portate avantirispettivamente da SIVAN 1989, p. 92 e daHARRIES 1994, p. 144. A parere <strong>del</strong>laWATSON 1998, p. 180 nota 3: «These theoriesare equally attractive…Given the projected campaignagainst Geiseric, it might seen more likelythat there was concern the Gothic threat might beforgotten in the excitement of the anticipated overthrowof the Vandals».5Come osserva LOYEN 1943, pp. 20-25, leconoscenze geografiche dei Romani eranoinficiate dalla modalità di apprendimentoscolastico; l’allievo imparava a memorialiste di montagne, fiumi, regioni. I toponimisono, in primis, luoghi letterari. Il nozionismomnemonico faceva sì che non si avesse,ad esempio, cognizione esatta <strong>del</strong>ledistanze geografiche. La cultura di Sidonioè eminentemente letteraria.6Sul preziosismo come cifra stilistica <strong>del</strong>lostile di Sidonio si veda LOYEN 1943 (cfr. lepp. 152-153: lo stile prezioso si compone diun aspect alexandrin, che conduce alla sceltadi motivi futili, di soggetti frivoli e conducealla sottigliezza e all’artificiosità <strong>del</strong>lo stile,di un aspect asianiste, che comporta la grandiloquenceet la coquetterie, di un aspect scolaire, checomporta lo sfoggio di una certa pedantescaerudizione).7CONSOLINO 1974.8PIACENTE 2005, p. 100.9Sidonio utilizza il tόpos, in particolare, nelpanegirico a Maioriano (Carm. 5, 510-552).Il superamento <strong>del</strong>le Alpi, come rilevaBROLLI 2003/2004, p. 305, era un motivotipico <strong>del</strong>la letteratura panegiristica, inquanto permetteva di esaltare le virtù guerriere<strong>del</strong> Princeps. Si veda la nota di commento<strong>del</strong>la KÖHLER 1995, p. 191, a propositodi citus: «Adiektiv statt Adverb: in derDichtung haufig, erst spät in der Prosa (s. ThLLIII 1208. 59ff.). Vgl. Sid. Epist. IV, 24, 2precibus orantis citus adnui».10STEVENS 1933, p. 101.11Cfr. supra.12Per rintracciare i toponimi mi sono avvalsodegli Indices sidoniani (CHRISTIANSEN -HOLLAND 1993 e CHRISTIANSEN - HOLLAND- DOMINIK 1997).13Cfr. PRIVITERA 1993, pp. 134-135: la studiosaevidenzia che per gli autori tardoantichiè opportuno superare il concetto di‘memoria allusiva’; Sidonio lavora con uncorredo ‘bibliografico’, costituito probabilmenteda crestomazie, materiale scolastico,commentari. Non bisogna parlare, pertanto,di ‘attivazione di memoria’ quanto di‘memoria glossografica’, di recupero piùpuntuale possibile <strong>del</strong> palinsesto culturale.Sulle modalità di imitatio sidoniana si legganole osservazioni di GUALANDRI 1979, p.85: «L’imitatio che Sidonio persegue meritadi essere analizzata. Essa si svolge talorasecondo una rete particolarmente fitta, maspesso viene a tal punto ad essere occultatada essere identificabile solo se si seguonofino in fondo, con un paziente lavoro, indizidi per sé assai tenui, fino a comporli, nell’insieme,in un disegno preciso e in un quadropersuasivo. Questo più complesso enascosto gioco di richiami è l’elemento che,a nostro avviso, meglio caratterizza il procederedi Sidonio: un minuzioso lavoro che sialimenta dei succhi di molte letture e checon i suoi riferimenti celati sembra volersfidare gli amici – i destinatari più naturalidi questi prodotti – ad una sorta di gara:riconoscere coè nel prezioso, nel difficile,nell’enigmatico quanto è stato suggerito edispirato dalla furtiva lectio».14Le relazioni all’interno <strong>del</strong>la cerchia aristocraticadi Sidonio erano regolate da consuetudinidi amicizia e cultura. Una brillantericostruzione <strong>del</strong>le ‘regole’ di cortesia letterariache vi risultavano vigenti si deve aLOYEN 1943 (agli amici di Sidonio sonodedicate le pp. 56-94). Per la concezioneludica <strong>del</strong>la letteratura all’interno <strong>del</strong>lamondana società aristocratica nell’ambito<strong>del</strong>la quale vive Sidonio, cfr. LA PENNA1995.15SAVINO 2005.16Nella divisione che Augusto fece<strong>del</strong>l’Italia, la Campania formò la Regio Iinsieme con il Latium vetus ed il Latium adiectum;in seguito arrivò a comprendere ancheil territorio degli Irpini e parte <strong>del</strong> Sannio.Nel nuovo ordinamento <strong>del</strong>l’Impero allafine <strong>del</strong> III sec. d. C., più o meno con glistessi confini <strong>del</strong>la regione fissati daAugusto, la Campania formò una <strong>del</strong>le provincein cui allora fu divisa l’Italia (Cfr.MALAVOLTA 1984; SAVINO 2005, pp. 18-19).17SAVINO 2005, pp. 79-86.18LOYEN 1942, pp. 76 (in part. la nota 5);77.19GEISLER 1887.20ThlL Onom. II, s. v. Campanus, p. 126, l. 9.21Ibid. , p. 125, l. 43.22SAVINO 2005, p. 84.23Cfr. PALMIERI 1985 e la bibliografia ivicitata.24SAVINO 2005, pp. 200; 203.25Come esempi <strong>del</strong> tόpos (un invito da partedi un poeta o un finto invito, come quellocatulliano) possiamo citare un epigrammadi Filodemo (AP XI,44, rivolto a Pisone),vari esempi oraziani (Carm. I, 20, rivolto aMecenate; IV, 12, dove si verifica una parodiae un’inversione rispetto al carme diCatullo: il Virgilio, unguentarius, invitato daOrazio deve portare il nardo, condizioneineludibile perché possa accedere al convitoorganizzato dal Venosino), un epigrammadi Marziale (XI, 52 in cui il poeta di Bilbilisenfatizza le prelibatezze dalla cena, pur difar venire il suo invitato; costui potrà declamarei suoi versi, laddove Marziale promettedi tacere i propri). Sul carme di Catullo,cfr. THOMSON 1997, pp. 242-243.26GEISLER 1887, p. 409.27Cfr. CLAUSEN 1994, p. 136.- 102 -
FRANCESCO MONTONE28Il tiranno Dionisio il Vecchio (430 ca. -367 a. C.), per dimostrare al suo inferioreDamocle che la gestione <strong>del</strong> potere comportal’acquisizione di una felicità illusoria,lo fece sedere ad un banchetto e servirecome fosse il re; fece anche sospenderesopra la sua testa una spada affilata, trattenutasolo da un crine di cavallo, permostrargli l’instabilità e la precarietà <strong>del</strong> suopotere.29Sulla tradizione letteraria in ambito latino<strong>del</strong>l’aneddoto e sulla rielaborazione sidonianasi legga SQUILLANTE 2007/2008. La studiosarileva che «Sidonio riscrive Ciceronespesso citandolo ma più spesso filtrandoloattraverso la mediazione di Orazio eLucano a cui affianca la voce di altri auctores»(p. 258).30Cfr. BELLÈS 1999, p. 203, nota 157:«Creiem que aquì no hem d’interpretar que barregessinel vi amb el nard per aromar-lo, sinó simplementque a la taula hi havia gerros de vi i flasconsde nard com a senyal de luxe. Cfr. Ep. II 13,7:“Spumarent Falerno gemmae capaces inque crystalliscalerent unguenta glacialibus... “. Però tampocno hem de descartar la possibilitat de la barrejaesmentada, ja que l’existència d’un ‘vin de nard’ ésdocumentada. Cfr. Plaute, Mil. 824: Deprompsitnardini amphoram cellarius…».31Cfr. ANDERSON -WARMINGTON - SEMPLE1965, p. 575, nota 2: «Tripods are used asstands for craters».32Cfr. BELLÈS 1999, p. 203, nota 157. Lostudioso, inoltre, osserva: «Aquí le roses fand’ornament, però és molt semblant l’expressió quetrobem per al vi de roses en Apici, De re coqu.I,4,1: “ Folias rosarum...lino inseris ut sutilisfacias et vinum quam plurimas infundas; …postseptem dies rosam de vino tollis et alias sutilesrecentes similiter mittit… “».33Una finissima analisi <strong>del</strong>la grottescadescrizione di questo personaggio si trovain GUALANDRI 1979, pp. 56-66. Sulla famigliadi Sidonio si veda il recente studio diMASCOLI 2010; al figlio di Sidonio sonodedicate le pp. 23-33.34Trad. di MASCOLI 2010.35Cfr. supra.36Su questo luogo virgiliano si vedaHORSFALL 2000, pp. 373-375. Cfr. ancheGIGANTE 1984, pp. 33-34.37Trad. di C. Vivaldi, in DELLA CORTE 1995.38GUALANDRI 1979, pp. 64-65.39Il luogo virgiliano era stato ripreso già daClaud. Rapt. Pros. 2, 347 ss.: «Tunc et pestiferipacatum flumen Auerni / innocuae transistis,aues, flatumque repressit / Amsanctus: fixo tacuittorrente uorago», che, però, riferisce l’aggettivonon alla valle <strong>del</strong>l’Ansanto maall’Averno (cfr. ONORATO 2008, pp. 289-290). Il sito è ricordato anche da Cic. Div. I,79 e da Plin. Nat. II, 208. Si vedano a proposito<strong>del</strong> luogo sidoniano le note <strong>del</strong>BELLÈS 1997, p. 268 (note 87- 88), che,però, non mettono in luce il meccanismoallusivo che abbiamo cercato di illustrare.40Trad. di RAVENNA 1990.41Si veda Verg. Georg. IV, 487: «…namquehanc dederat Proserpina legem».42RAVENNA 1990, p. 85.43GEISLER 1887, p. 407.44Come sottolinea ANDERSON 1936, p. 11,nota 4, Procopio, padre di Antemio, avevaun avo che disputò il trono imperiale aValente nel 365-366 e che sembra fosselegato alla famiglia di Costantino.45A proposito di questi versi, GEISLER1887, p. 385 segnala come intertesti Hor.carm. I, 12, 7 ss. e Claud. carm. 34, 18 ss.,oltre a rimandare a Sidon. carm. 16, 3 s. ed acarm. 23, 181 ss.46SAVINO 2005, pp. 218-220.47Puteoli, fondata intorno al 527 a. C. dacoloni di Samo sfuggiti alla tirannia diPolicrate, era stata chiamata Dicearchia, ‘lacittà <strong>del</strong> giusto governo’.48GEISLER 1887.49DE FRANCISCIS 1984, cui rimanda ancheper la bibliografia. Nell’Eneide Capri vienecitata a proposito di Ebalo, uno dei re checombatte al fianco di Turno (v. 735, con ilcommento di HORSFALL 2000, p. 480).50Sulla presenza degli imperatori romani inCampania si veda D’ARMS 2003, pp. 79-115(al soggiorno di Tiberio nell’isola sonodedicate le pp. 88-93).51D’ARMS 2003, pp. 52-57. Si veda in particolarequanto lo studioso scrive a p. 52: «Atyet, when first mentioned frequently in the works offirst-century authors, Baiae is already famous as acity of hot sulphur baths and seaside allurements,catering alike, as Strabo later observed, to the ailmentsof the sick and the pleasure of thesound…Baiae was Rome’s first resort. Here itgave pleasure to build and the extend villas into thesea itself by means of supporting piers…». Cfr.anche D’AMBROSIO 1984.52Trad. di E. MANDRUZZATO in TRAINA2001.53SAVINO 2005, pp. 219-220.54ID. Ibidem, pp. 223-224.55ID. Ibidem, p. 228, nota 430, cita Cass. Var.IX, 6.56Cfr. COURCELLE 1976, pp. 49-51; l’auspiciodi un intervento di Maiorianonell’Africa <strong>del</strong> Nord occupata dai Vandali,che sarà una riproposizione <strong>del</strong>lo scontrotra Roma e Cartagine, é espresso da Sidoniocon famosi sintagmi virgiliani; si veda carm.V 346-349: «Atque ideo hunc dominum saltempost saecula tanta/ ultorem mihi redde, precor, nedimicet ultra /Carthago Italiam contra…», in cuiè evidente la ripresa di Aen. I, 11 « Karthago,Italiam contra Tiberinaque longe» e di Aen. IV,625 ss., «exoriare aliquis nostris ex ossibusultor…litora litoribus contraria, fluctibus undas /imprecor, arma armis; pugnent ipsique nepotesque».57Liv. XXIII, 18, 10-16: «ibi partem maioremhiemis exercitum in tectis habuit, aduersus omniahumana mala saepe ac diu duratum, bonis inexpertumatque insuetum. Itaque, quos nulla maliuicerat uis, perdidere nimia bona ac uoluptatesimmodicae, et eo impensius quo auidius ex insolentiain eas se merserant. Somnus enim et uinum etepulae et scorta balineaque et otium consuetudine indies blandius ita eneruauerunt corpora animosqueut magis deinde praeteritae uictoriae eos quam praesentestutarentur uires, maiusque id peccatum ducisapud peritos artium militarium haberetur quamquod non ex Cannensi acie protinus ad urbemRomanam duxisset; illa enim cunctatio distulissemodo uictoriam uideri potuit, hic error uires ademissead uincendum. Itaque hercule, uelut si cumalio exercitu a Capua exiret, nihil usquam pristinaedisciplinae tenuit. Nam et redierunt pleriquescortis impliciti et, ubi primum sub pellibus habericoepti sunt, uiaque et alius militaris labor excepit,tironum modo corporibus animisque deficiebant, etdeinde per omne aestiuorum tempus magna parssine commeatibus ab signis dilabebantur nequealiae latebrae quam Capua desertoribus erant».58Sil. Ital. VI, 648-52: «tum Palladios se fundit- 103 -
SALTERNUMin agros, / Picenum diues praedae, atque errantibusarmis, / quo spolia inuitant, transfert populantiasigna, / donec pestiferos mitis Campaniacursus / tardauit bellumque sinu indefensa recepit».59Cfr. HEURGON 1984, p. 658.60Sul luogo di Ausonio si rimanda a DISALVO 2000, pp. 183-195.61SAVINO 2005, p. 213.62Cfr. ThlL VII.1, s.v. iacto, p. 51, ll. 12-14.63Nel passo di Giovenale si fa riferimentoalle braccia di Vulcano, rese scure dallafuliggine (FICCA 2009, p. 68).64Mi sia consentito rinviare ad un mio contributo(MONTONE 2010).65Sono d’accordo con la tesi di ANDERSON1936 (p. 256, nota 2: «Apparently a prominentbathing – establishment at Baiae had a roof ofthat kind» e con la MESTURINI 1982, p. 74;ritengono che si faccia riferimento alVesuvio LOYEN 1960, p. 128 e BELLÈS 1992,p. 134 nota 2: «Sobre el ‘con de Baies’ no hi hacap altre testimoni literari. El text fa pensar queuna de les voltes de les termes tenia forma cònica,llevat que Sidoni vulgui fer una agosarada referènciaal cim de Vesuvi, no lluny de Baies»). Comeosserva la MESTURINI 1982, p. 74, le termedi Baia, sulla costa <strong>del</strong>la Campania (traCuma e Pozzuoli), erano un tόpos per indicareedifici architettonicamente eleganti,almeno da Properzio in poi. Nell’Ep. II, 2compare l’espressione in conum, riferita allacupola <strong>del</strong>le sue terme.66Gli intertesti di Marziale rintracciabili neiprimi otto versi sono: IV, 25, 1, aemulaBaianis Altini litora villis; IV, 57, 1 (stagniLucrini) e 6 (Baias); V, 37, 3, stagni Lucrini; IV,30, 1 (Baiano) e 3 (piscibus che compare al v.10 <strong>del</strong> carme di Sidonio); XI, 80 (dove compareuna lode sperticata di Baia e cuiSidonio forse allude attraverso la ripresa dilitus di v. 1 e gaudiorum di v. 8); il testo diMarziale, che ha probabilmente ispiratoSidonio, è, però, IV, 63, epigramma in cui ilpoeta di Bilbilis si rivolge a Castrico e loinvita a godere dei piaceri di Baia; egli sitrova invece a Nomento e dovrà lì ricrearela sua Baia e il suo Lucrino: vv. 3-6: «MeNomentani confirmant otia ruris /et casa iugeribusnon onerosa suis. /hoc mihi Baiani soles mollisqueLucrinus,/hoc mihi sunt vestrae, Castrice, divitiae».Ai vv. 11-12 <strong>del</strong> suo componimento,infatti, Sidonio afferma: «Si libet et placidopartiris gauda corde, /quisquis ades, Baias tu facishic animo». Sono ovviamente presenti altriechi testuali: Hor. Sat. II, 4, 32-34, «muriceBaiano melior Lucrina peloris,/ ostrea Circeis,Miseno oriuntur echini,/ pectinibus patulis iactatse molle Tarentum»; Rut. Nam. I, 531 contiguumstupui portum (contiguus è in posizione incipitariacome in Sidonio); ID. II, 14 murmuratunda (Rutilio a sua volta riprende Aen. X,212). Cfr. MONTONE 2010.67Trad. di A. BARCHIESI, in BARCHIESI -CONTE 1989.68La callida iunctura unda garrula è senz’altroda evidenziare: garrulus non è tipico <strong>del</strong>lacomunicazione non verbale (ThlL VI. 2,1699, ll. 32-39, in cui si raccolgono i casi incui l’aggettivo compare riferito a res quaesonum dant; occorrenza sidoniana non è registrata.Si annotano, però, due casi in cuil’aggettivo è riferito a rivus: Ov. Fast. II, 316e Sen. Oed. 493. L’onda, quindi, viene vivificata,divenendo ‘ciarliera’, come fosse dotatadi parola. Un altro caso non registrato dalThlL nella sezione suddetta (ma citato inThlL VI.2 1699. l. 14, nella sezione in cui sielencano i casi in cui l’aggettivo è riferitoagli uccelli) si trova in Mart. XIV, 75 dovel’aggettivo è riferito a Philomela, ma in riferimentoad una comunicazione non ‘verbale’;Philomela, cui era stata tagliata la lingua daTereo, rivela lo stupro subito a Procne attraversoun ricamo.69Che questo luogo virgiliano fosse benpresente nella memoria letteraria di Sidoniolo dimostra un passo <strong>del</strong>l’epistola II, 2(oltre alla ripresa <strong>del</strong> Gargara messes di Georg.I, 103 in carm. 7, 147), in cui sono ripresi glistessi termini virgiliani: II, 2, 8: «in hanc egopiscinam fluvium de supercilio / montis elicitum….sexfistulae prominentes leonum simulatiscapitibus effundunt»: «Dunque sei tubi che siprotendono lavorati a forma di teste dileone immettono in questa piscina un corsod’acqua, che scaturisce dalla vetta <strong>del</strong>lamontagna…».70Cfr. ThlL Onom. II, s.v. Baiae, p. 1684, ll. 3-13.71Cfr. ThlL Onom. II, s.v. Baiae, p. 1684, ll.15-25.72ANDERSON - WARMINGTON - SEMPLE1965, p. 216.73Si veda ThlL Onom. II, s.v. Baiae, p. 1684,l. 22 a proposito di questo luogo sidoniano:«fortasse idem locusTab. Peut. 2,4 ‘Aquis calidis’».74Altri nomi nell’opera sidoniana rinvianoalla Campania: Samnis (carm. 15, 51), Opiscus(epist. VIII,3,1) e vari riferimenti aiFescennini (carm. 12,2; carm. 10, 21; carm. 0.14.1 (si tratta <strong>del</strong>la sezione in prosa che precedeil componimento); Epist. I, 5, 10; Epist.VIII, 11, 6.75SAVINO 2005, pp. 233-234.76Carm. 22,6 (si tratta <strong>del</strong>la sezione in prosache segue il componimento): «si quis autemcarmen prolixius eatenus duxerit esse culpandum,quod epigrammatis excesserit paucitatem, istumliquido patet neque ‘balneas Etrusci’ neque‘Herculem Surrentinum’ neque ‘comas FlaviiEarini’ neque ‘Tibus Vopisci’ neque omnino quicquamde Papinii nostri silvulis lectitasse». Sonocitate le seguenti Silvae di Stazio: I, 5; III, 1;III,4; I, 3.77Per l’autocoscienza letteraria di Sidonio silegga CONDORELLI 2008. Cfr., in particolare,p. 243: « [Sidonio] sembra volere sancireuna sintesi tra la continuità culturale con ilpassato e la forte esigenza di dare espressionead istanze estetiche nuove e peculiari <strong>del</strong>diverso contesto in cui si collocano». Percomprendere le finalità artistiche di Sidoniosi vedano anche i giudizi di GUALANDRI1979, p. 104: «ancora una volta lo si coglie[l’Autore] sostanzialmente nell’atto diassorbire e compendiare in sé il massimopossibile <strong>del</strong> patrimonio letterario, protesoquindi in una operazione di conservazione,per la quale egli trasforma la sua opera inuna sorta di grande repertorio, di summa<strong>del</strong>la tradizione», e di FORMICOLA 2009, p.87: «Egli vuole esprimere una poeticanuova, che gli uomini <strong>del</strong> suo tempo avvertanocome nuova, e che consiste nel creareun’anthologia di temi vari mai prima d’alloraassemblati, un insieme che non trovavariscontri nella tradizione classica di generiletterari; aborrisce una poesia che alla primalettura ridesti il ricordo <strong>del</strong>la tradizione equindi ingeneri la sgradevole sensazione diun ennesimo, pedissequo rifacimento».- 104 -
FRANCESCO MONTONEBibliografiaScioglimento <strong>del</strong>le abbreviazioni:‘ASNP’: ‘Annali <strong>del</strong>la Scuola NormaleSuperiore di Pisa’.Enc. Virg.: Enciclopedia Virgiliana.‘GIF’: ‘Giornale Italiano di Filologia’.‘RomBarb’: ‘Romanobarbarica’.ANDERSON W. B. 1936 (eds.), Sidonius,Poems and Letters (ll. 1-2), vol. I, with anEnglish Translation by W. B. ANDERSON,Cambridge, Massachussets-London.ANDERSON W. B. - WARMINGTON E. H. -SEMPLE W. H. 1965 (eds.), Sidonius, Poemsand Letters (ll. 3-9), vol. II, with an EnglishTranslation by W. B. ANDERSON,Cambridge, Massachussets-London.BARCHIESI A. - CONTE G. B. 1989 (ed.),Virgilio. Georgiche, Milano.BELLÈS J. 1989 (ed.), SIDONI APOL·LINAR,Poemes, vol I [Panegìrics], Introducció, Textrevisat i Traducció, Barcelona.BELLÈS J. 1992 (ed.), SIDONI APOL·LINAR,Poemes, vol II [Pomes menors], Introducció,Text revisat i Traducció de J. BELLÈS,Barcelona.BELLÈS J. 1997 (ed.), SIDONI APOL·LINAR,Lettres, vol I [Llibres I-III], Introducció,Text revisat i Traducció, Barcelona 1997.BELLÈS J. 1998 (ed.), SIDONI APOL·LINAR,Lettres, vol II [Llibres IV-VI], Introducció,Text revisat i Traducció de J. BELLÈS,Barcelona.BELLÈS J. 1999 (ed.), SIDONI APOL·LINAR,Lettres, vol III [Llibres VI-IX],Introducció, Text revisat i Traducció,Barcelona.BROLLI T. 2003/2004, Silio in Sidonio:Maioriano e il passaggio <strong>del</strong>le Alpi, in‘Incontri triestini di Filologia Classica’, 3,pp. 297-314.CHRISTIANSEN P. G. - HOLLAND J. E. 1993(eds.), Concordantia in Sidonii Apollinariscarmina, Hildesheim – Zürich - New York.CHRISTIANSEN P. G. - HOLLAND J. E. -DOMINIK W. J. 1997 (eds.), Concordantiain Sidonii Apollinaris epistulas,Hildesheim – Zürich - New York.CLAUSEN W. 1994, A commentary on Virgil.Eclogues, Oxford.CONDORELLI S. 2008, Il poeta doctus nel Vsec. d. C. Aspetti <strong>del</strong>la poetica di SidonioApollinare, Napoli.CONSOLINO F. E. 1974, Codice retorico emanierismo stilistico nella poetica di SidonioApollinare, in ‘ASNP’, 4, pp. 423-460.COURCELLE P. 1976, Les lecteurs de l’ Éneidedevant les grandes invasions germaniques, in‘RomBarb’, 1, pp. 25-56.D’AMBROSIO A. 1984, s.v. Baia, in Enc.Virg., vol. I, Roma, pp. 452-453.D’ARMS J. 2003, The Romans in the Bay ofNaples and other essays on Roman Campania,Bari.DE FRANCISCIS A. 1984, s.v. Capri, in Enc.Virg., Vol. I, Roma, p. 655.DELLA CORTE F. 1995 (ed.), VIRGILIO.Eneide (libri I-VIII), Introduzione di F.DELLA CORTE, traduzione di C. VIVALDI,note di M. RUBINO, Milano (rist.).DI SALVO L. 2000 (ed.), Ausonio D.Magno. Ordo Urbium Nobilium.Introduzione, testo critico, traduzione enote di commento, Napoli.FICCA F. 2009 (ed.), Giovenale D. Giunio,Satira XIII, Napoli.FORMICOLA C. 2009, Poetica <strong>del</strong>l’imitatio efunzione <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo: Properzio nei versi diSidonio Apollinare, in ‘Voces’, 20, pp. 81-101.GEISLER E. 1887, Loci similes auctorumSidonio anteriorum, in Gai SolliiApollinaris Sidonii Epistulae et Carminarecensuit et emendavit CH. LUETJOHANN,Berolini (MGH VIII).GIGANTE M. 1984, Virgilio e la Campania,Napoli.GUALANDRI I. 1979, Furtiva lectio. Studi suSidonio Apollinare, Milano.HARRIES J. 1994, Sidonius Apollinaris and theFall of Rome. AD 407-485, Oxford.HEURGON J. 1984, s.v. Capua, in Enc. Virg.,Vol. I, Roma, pp. 656-658.HORSFALL N. 2000, VIRGIL. Aeneid 7: acommentary, Leiden-Boston.KÖHLER H. 1995, C. Sollius ApollinarisSidonius, Briefe Büch I. Einleitung-Text-Übersetzung-Kömmentar, Hei<strong>del</strong>berg.LA PENNA A. 1995, Gli svaghi letterari <strong>del</strong>lanobiltà gallica nella tarda antichità. Il caso diSidonio Apollinare, in ‘Maia’ 47, pp. 3-34.LOYEN A. 1942, Recherches historiques sur lesPanègyriques de Sidoine Apollinaire, Paris.LOYEN A. 1943, Sidoine Apollinaire e l’éspritprécieux en Gaule aux derniers jours <strong>del</strong>’Empire, Paris.LOYEN A. 1960 (ed.), Sidoine Apollinaire.Poèmes. Tome I, Paris.MALAVOLTA M. 1984, s.v. Campania, inEnc. Virg., Vol. I, Roma, p. 641.MASCOLI P. 2010, Gli Apollinari. Per la storiadi una famiglia tardoantica, Bari.MAZZOLI G. 2005/2006, Sidonio, Orazio ela lex saturae, in ‘Incontri triestini diFilologia Classica’, 5, pp. 171-184.MESTURINI A. M. 1982, SIDONIOAPOLLINARE. Carmina, tradotti da V.FAGGI, pref. di F. BANDINI, introd. e notedi A. M. MESTURINI, Genova.MONTONE F. 2010, Il tόpos <strong>del</strong>la Campaniafelix nella poesia latina, in ‘Salternum’, XIV, 24-25, pp. 48-57.ONORATO M. 2008 (ed.), CLAUDIANO. Deraptu Proserpinae, Napoli.PALMIERI R. 1985, s.v. Falerno, in Enc.Virg., Vol. II, p. 457.PIACENTE L. 2005, In viaggio con SidonioApollinare, in A. GARGANO - M.SQUILLANTE, (eds.) Il viaggio nella letteratura occidentaletra mito e simbolo, Napoli, pp. 95-106.PRIVITERA T. 1993, Ipotesi sulla ‘memoriaglossografica’ di Sidonio Apollinare, in ‘GIF’,45, pp. 133-150.RAVENNA G. 1990 (ed.), Le nozze di Polemioe Araneola (Sidonio Apollinare, Carmina 14.-15.). Introduzione, testo e commento,Bologna.SAVINO E. 2005, Campania tardoantica (284-604 d. C.), Bari.SIVAN H. 1989, Sidonius Apollinaris, TheodoricII, and Gothic-Roman Politics from Avitus toAnthemius, in ‘Hermes’, 117, pp. 85-94.- 105 -
SALTERNUMSQUILLANTE M. 2007/2008, La felicità e ilpotere: l’exemplum di Damocle nella rielaborazionetardoantica, in ‘Incontri triestini diFilologia Classica’, 7, pp. 249-260.STEVENS C. E. 1933, Sidonius Apollinansand his Age, Oxford.THOMSON D. F. S. 1997, Catullus. Editedwith a Textual and Interpretative Commentary,Toronto.TRAINA A. 2001 (ed.), Quinto OrazioFlacco. Odi e Epodi (2 Voll.), introduzionedi A. TRAINA, traduzione e note diE. MANDRUZZATO, Milano (rist.).WATSON L. 1998, Representing the Past,Redefining the Future: Sidonius Apollinaris’Panegyrics of Avitus and Anthemius, inM. WHITBY (ed.), The Propaganda of Power:the Role of Panegyrics in Late Antiquity,Leiden-Boston, pp. 177-198.- 106 -
GIUSEPPINA AMBRUOSONuove ipotesi interpretativeper il Battistero paleocristianodi Santa Maria Maggiore in Nocera SuperioreUbicato nella parte nord-orientale <strong>del</strong>lacittà antica, su di un edificio di età romanadi cui restano i mosaici pavimentaliemersi in occasione degli scavi archeologici <strong>del</strong> 1969 1 ,il Battistero di Nocera de’ Pagani 2 costituisce una <strong>del</strong>letestimonianze più importanti <strong>del</strong>l’architettura paleocristianain Campania (fig. 1).L’edificio, studiato da Storici <strong>del</strong>l’Arte locali e stranieri,tra cui ricordiamo il Krautheimer 3 , al quale va ilmerito di averlo inserito nel circuito degli studi internazionalidi Storia <strong>del</strong>l’Arte, pone ancora oggi degliinterrogativi irrisolti, cui solo un’indagine archeologicaaccurata e fondata sull’ausilio di nuovi strumentiscientifici potrà dare risposta.Ad aver reso l’edificio nocerino un caso eccezionaleed unico nel contesto campano è il carattere monumentale<strong>del</strong>l’architettura, che emerge sin dalle origini<strong>del</strong> dibattito storiografico che ha riguardato il battistero4 , ma anche i materiali di spoglio in esso conservati 5 ,i quali rivelano un substrato culturale fortementeinfluenzato dalla classicità romana. Proprio questaclassicità ha alimentato ipotesi interpretative diverserelative alla funzione primitiva <strong>del</strong>l’edificio: si è parlatodi un tempio pagano adibito al culto cristiano 6 , diun ninfeo termale 7 , di un mausoleo 8 e solo nel 1940,con l’intervento <strong>del</strong>lo Stettler 9 - al quale va il merito diaver pubblicato uno studio ancora oggi di assolutamodernità - alla luce <strong>del</strong>la centralità che la vasca assumenella struttura, è stata avanzata la tesi che l’edificiosia nato come battistero (fig. 2).Queste ipotesi allo stato attuale <strong>del</strong>la ricerca nontrovano conferma, così come ancora discussa é ladatazione e l’aspetto originario <strong>del</strong>l’edificio, alteratonel corso dei secoli e compromesso soprattutto dairestauri di età borbonica 10 , che hanno conferito allastruttura un carattere moderno. Sarà soltanto un rilievoarcheologico, strumento principale per interpretareFig. 1 - Nocera Superiore. Battistero di Santa Maria Maggiore, esterno.Fig. 2 - Nocera Superiore. Battistero di Santa Maria Maggiore, interno.- 107 -
SALTERNUMe ricostruire i monumenti <strong>del</strong> passato, che potràapportare nuovi contributi alla ricerca in questa direzione.La complessità <strong>del</strong> monumento ha indotto chi scrivead approfondire lo studio <strong>del</strong> ‘fenomenoBattisteri’ 11 , tema su cui sono stati pubblicati numerosistudi ed organizzati diversi Convegni e Seminari;grazie ad essi è stato possibile conoscere gli interrogativiche questo tipo di edificio di culto ha posto e continuaa porre agli studiosi impegnati nella ricercascientifica. Attraverso la ricostruzione <strong>del</strong>la genesi <strong>del</strong>l’edificiobattesimale, la definizione <strong>del</strong> momento storicoe le condizioni che ne hanno segnato la nascita,l’individuazione <strong>del</strong>le caratteristiche architettoniche edecorative che contraddistinguono questa particolaretipologia di edificio di culto, nonché la comprensione<strong>del</strong>la funzione che tali strutture assumono nell’ambito<strong>del</strong>la comunità cristiana e <strong>del</strong> contesto urbano 12 , si è<strong>del</strong>ineato lo sviluppo che i Battisteri hanno avuto inOriente 13 come in Occidente ed in particolare in Italia.L’indagine ha evidenziato per l’Italia una maggiorepresenza di edifici battesimali nella zona settentrionale,mentre al Sud, allo stato attuale <strong>del</strong>la ricerca, unnumero cospicuo si registra esclusivamente inCampania 14 .Fig. 3 - Nocera Superiore. Battistero di Santa Maria Maggiore, interno.Diversificati per planimetria e dimensioni, essisono da porre in relazione al processo di evangelizzazioneche interessò le città già in età apostolica e che apartire dal V sec. d. C. investì anche le campagne. Laloro presenza testimonia la diffusione precoce e ilradicamento capillare che il Cristianesimo ebbe nelterritorio 15 , ma non si esclude che in futuro nuovi rinvenimentipossano contribuire a modificare il quadrointerpretativo generale.L’esame dei battisteri campani prova scientificamentela monumentalità <strong>del</strong>la ‘Rotonda’ nocerina 16 :con la sua superficie di circa 446 mq, contro i 20 ÷ 30mq circa degli altri battisteri campani, la circolarità<strong>del</strong>la sua pianta - che non trova riscontri in Campania- e le dimensioni <strong>del</strong>la vasca battesimale, seconda inItalia dopo quella di San Giovanni in Laterano 17 , essasovrasta per grandezza e imponenza gli altri edificicultuali di età paleocristiana. Proprio la maestosità<strong>del</strong>la struttura è alla base <strong>del</strong>la più accreditata ipotesidi lettura <strong>del</strong>l’edificio. La ricerca bibliografica hadimostrato, infatti, che gran parte <strong>del</strong>la critica, dallaseconda metà <strong>del</strong>l’800 fino ai giorni nostri, ha interpretatol’eccezionale monumentalità <strong>del</strong>la Rotondanocerina come espressione <strong>del</strong>la volontà dei Bizantinidi sottolineare la loro vittoria sui Goti, inserendo lacostruzione in un progetto di riqualificazione <strong>del</strong> territorioall’indomani <strong>del</strong>la devastante guerra greco-gotica,che proprio in questo luogo vide il suo epilogo 18 .Nel corso <strong>del</strong>lo studio, però, l’attenzione posta sualcuni dati emersi dalla ricerca bibliografica e nuoveriflessioni basate proprio sui caratteri eccezionali <strong>del</strong>l’edificio,hanno spinto ad avanzare una lettura diversaper il monumento.Analizzando l’edificio, ponendolo in rapporto allaliturgia battesimale, la monumentalità <strong>del</strong>la strutturapotrebbe essere spiegata come la risposta alla necessitàdi accogliere al suo interno la numerosa comunitàreligiosa <strong>del</strong>l’agro nocerino-sarnese, come si èverificato a Roma in occasione <strong>del</strong>la costruzione diSanto Stefano Rotondo, che pure svolse solo funzionedi chiesa e che, come il battistero nocerino, presentauna pianta centrale e misure monumentali: undiametro di 22 metri che il Krautheimer ha giustificatoproprio alla luce <strong>del</strong>le esigenze pastorali 19 . Nelcaso nocerino, tuttavia, l’assenza di dati materiali efonti documentarie che informino sull’esistenza diuna basilica cui il battistero doveva essere annesso 20ha indotto chi scrive a considerare la ‘Rotonda’come- 108 -
GIUSEPPINA AMBRUOSOil luogo in cui non ci si limitava ad amministrare ilBattesimo, ma come uno spazio destinato allo svolgimentodi tutte le cerimonie che avevano luogo nellasettimana pasquale. Si tratta <strong>del</strong> rito <strong>del</strong>la lavanda deipiedi, eseguito il Giovedì Santo; <strong>del</strong>la solenne cerimonia<strong>del</strong>l’accensione <strong>del</strong> cero pasquale che, comedocumentato dalle fonti, si svolgeva il Sabato Santonella chiesa annessa all’edificio battesimale prima chei catecumeni si apprestassero ad entrare nel battisteroper ricevere il sacramento. L’accensione <strong>del</strong> cero,accompagnata dal canto <strong>del</strong>l’Exultet, aveva un fortevalore simbolico: la luce rappresentava la vittoria diCristo sul male e, di conseguenza, la liberazione degliuomini dalle tenebre. Con il battesimo, infatti, l’uomomuore e rinasce ad una nuova vita, libero dal peccato.Con molta probabilità, dunque, all’interno <strong>del</strong>battistero doveva trovare posto anche un pulpito dalquale veniva intonato l’Exultet. Le grandi dimensioni(fig. 3), quindi, sarebbero giustificate dalla necessitàdi ospitare una folla numerosa che prendeva partealla solenne cerimonia liturgica. Le fonti patristicheinformano infatti sulla partecipazione all’evento <strong>del</strong>l’interacomunità pronta ad accogliere al suo internoi nuovi battezzati; non bisogna dimenticare, inoltre,che nei primi secoli <strong>del</strong>la cristianizzazione i battisteri<strong>del</strong>l’Occidente cristiano presentano come caratteristichepeculiari proprio monumentalità e autonomiaarchitettonica rispetto agli edifici di culto anche neigruppi episcopali, attributi dettati da motivazioni diordine liturgico e dall’uso limitato al solo tempo pasquale.La tradizione degli studi, che solitamente data questobattistero alla metà <strong>del</strong> VI secolo, proponendocome mo<strong>del</strong>lo per l’edificio nocerino le architettureromane a pianta centrale quali il Mausoleo di SantaCostanza 21 (fig. 4) e il Battistero Lateranense (fig. 5), haspinto a riconoscere in esso, per la tecnica costruttivaromana e per i materiali di riuso, una ripresa, o megliouna continuità <strong>del</strong>la classicità, che in Campania risultaessere una caratteristica peculiare <strong>del</strong>l’architettura.Se da un lato, dunque, la monumentalità <strong>del</strong> battisteronocerino potrebbe essere legata ad un’esigenzadi tipo pastorale, dall’altro i dati emersi dalla ricercabibliografica, e in particolare da uno degli ultimi scritti,spingono a considerare il monumento come il prodottodi un evergetismo privato. L’archeologo MarioPagano 22 , pur non dedicando uno studio monograficoal monumento, ha infatti recentemente individuato unpossibile committente per l’edificio nell’antipapaLorenzo. L’interessante ipotesi avanzata dal Paganoha suggerito di indagare sulla figura di Lorenzo antipapae sul ruolo che ebbe nella città nocerina quandoottenne la nomina di Vescovo nel 499. I dati emersidalla ricerca sono tuttavia esigui e hanno evidenziatoche la storiografia - sia antica, sia moderna - relativa alcosiddetto ‘scisma laurenziano’, ha dedicato maggioreattenzione alla figura di Simmaco rispetto a quella diLorenzo. Dalle fonti sappiamo che Lorenzo (oLaurenzio o forse Celio), arciprete di Santa Prassede,nello stesso giorno in cui Simmaco ottenne la nominadi Pontefice in Laterano - il 22 novembre <strong>del</strong> 498 - fueletto Papa nella basilica romana di Santa MariaMaggiore. Le testimonianze documentarie informanosul fatto che mentre Simmaco era sostenuto da unaparte <strong>del</strong> clero e <strong>del</strong> popolo romano ostile aCostantinopoli, Lorenzo era appoggiato dal Senato, inparticolare dai senatori Festo e Probino, fautori di unapolitica di accordo con Bisanzio.Fig. 4 - Roma. Mausoleo di Santa Costanza, interno.Fig. 5 - Roma. Battistero di San Giovanni in Laterano, interno.- 109 -
SALTERNUML’autore di una fonte greca,Teodoro, lega lo scisma laurenzianoa quello acaciano, e quindi lo faapparire come una prosecuzione<strong>del</strong>la questione orientale; le fontioccidentali, invece, propongonocome causa <strong>del</strong>lo scisma romanoesclusivamente la doppia elezione.Non essendo questa la sede perdilungarsi sullo scisma, ci si limita adaccennare agli scontri sanguinosiche dilagarono in città e ad unSinodo in particolare, quello convocatoda Simmaco in San Pietro ilprimo marzo <strong>del</strong> 499, che affrontandoil problema <strong>del</strong>le modalità di elezione<strong>del</strong> vescovo di Roma, si conclusecon il riconoscimento ufficialedi Simmaco papa, appoggiato anchedal re Teodorico, e con la nomina diLorenzo a vescovo di Nocera 23 .Stando a quanto tramandatodalle fonti, Lorenzo fu a Nocera dal499 al 502, anno in cui, grazieall’appoggio di Teodorico, ritornò a Roma a sedere sulsoglio pontificio, approfittando <strong>del</strong> periodo di sospensionedalla carica di pontefice di Simmaco, accusato diimmoralità dai laurenziani. Da ciò si deduce chedurante il periodo <strong>del</strong> vescovado nocerino Lorenzonon rinunciò ad aspirare al ruolo di Pontefice.Parrebbe quindi plausibile – seguendo il Pagano - individuarein Lorenzo il committente <strong>del</strong> battistero nocerino,sia perché quattro anni sarebbero stati sufficientiper la costruzione <strong>del</strong>la ‘Rotonda’, sia perché, in unmomento di debolezza per Lorenzo, promuovere l’edificazionedi una struttura dal carattere monumentalesarebbe stato un modo per manifestare il propriopotere e per sottolineare il prestigio raggiunto dalladiocesi di Nocera sotto la sua direzione. La scelta diLorenzo quale committente contribuisce anche a giustificarela ripresa di un mo<strong>del</strong>lo romano, in particolareSan Giovanni in Laterano, cui gli studiosi che sisono interessati <strong>del</strong> Battistero nocerino hanno semprefatto riferimento. Il Laterano, prima cattedrale <strong>del</strong>lacittà pontificia e sede ufficiale per l’elezione <strong>del</strong> Papa,potrebbe essere stato scelto da Lorenzo come esempiocui guardare per la costruzione <strong>del</strong> battistero nocerinoin virtù <strong>del</strong> suo prestigio.Fig. 6 - Nocera Superiore. Battistero di Santa MariaMaggiore, particolare <strong>del</strong>la vasca battesimale.Fig. 7 - Nocera Superiore. Battistero di Santa MariaMaggiore, particolare <strong>del</strong>la vasca battesimale.Sul piano <strong>del</strong>l’architettura nocerina,accanto alla ripresa <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>loromano, è doveroso accennareanche al giudizio <strong>del</strong> Venditti 24 , chegià nel 1967 vi aveva tuttavia individuatola presenza di tratti orientali.In tale contesto essi potrebberoessere espressione <strong>del</strong>la volontà<strong>del</strong>l’Antipapa di sottolineare, ancheattraverso le scelte architettoniche, ilsuo legame con Bisanzio. Ad avvalorarel’ipotesi che qui si propone inaccordo con il Pagano, vi è il confrontocon uno studio condotto daErnst Kitzinger sulla cattedrale diSalerno 25 : come lo studioso - che perprimo l’ha inserita nell’ambito <strong>del</strong>laRiforma Gregoriana - sostiene cheessa sia stata edificata nel periodo incui il pontefice Gregorio VII era inesilio a Salerno, così a Nocera la‘Rotonda’ sorse, non a caso, contemporaneamenteal soggiornonocerino <strong>del</strong>l’antipapa Lorenzo.Come già accennato in precedenza, non va peraltrotrascurato il substrato culturale campano, fortementesegnato ab antiquo dalla presenza <strong>del</strong>la classicità romana,di cui si ha un’eco evidente, oltre che nella tecnicacostruttiva, nell’uso dei marmi pregiati reimpiegati adarte nel Battistero nocerino. La loro presenza, riscontrataanche in altri battisteri di ambito gallico - territorio incui, allo stesso modo che in Campania, i Romani riuscironoad imporre la loro civiltà - quali il battistero di Aixen-Provencee quello di Reiz presso Grenoble, sarebbeda porre in relazione soprattutto con la forte improntaromana che connotò questi luoghi.In conclusione, la recente proposta <strong>del</strong> Paganoapre dunque una nuova fase interpretativa sul monumento.Pur non essendo supportata da una fonte letterariae pur anticipando la datazione <strong>del</strong>l’edificio altempo <strong>del</strong>la dominazione dei Goti, questa ipotesi paregiustificare in parte sia la monumentalità inconsueta<strong>del</strong> battistero nocerino nel contesto campano, sia lascelta <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo romano, dato che l’iconografia <strong>del</strong>l’edificiorimanda al battistero lateranense e al mausoleodi Santa Costanza. Si potrebbe pensare che l’antipapaLorenzo volesse fare <strong>del</strong>la ‘Rotonda’ nocerina il‘suo Laterano’. Il fatto che non ci siano fonti che- 110 -
GIUSEPPINA AMBRUOSOdocumentino questa impresa non costituisce un ostacoloinsormontabile, anche per la mancanza di scrittiautografi <strong>del</strong>l’antipapa e la generale esiguità <strong>del</strong>le testimonianzeche ne riguardano l’operato.In questa prospettiva di lettura, la presenza dei pluteiche decorano la vasca battesimale, datati al VI secolograzie a confronti fatti con altri pezzi caratterizzati dallostesso motivo iconografico 26 , andrebbe attribuita ad unintervento più tardo; Lorenzo, ritornato a Roma nel 502per sedere sul soglio pontificio, con molta probabilitàdovette lasciare incompleto il progetto decorativo.A sfavore <strong>del</strong>la datazione <strong>del</strong> battistero alla metà<strong>del</strong> VI secolo, bisogna considerare che all’indomani<strong>del</strong>la guerra greco-gotica la città subì gravi perdite esicuramente la Diocesi perse il prestigio di cui avevagoduto nel V secolo 27 . Sembra dunque più ragionevolepensare che il Battistero fosse stato costruito nelperiodo in cui fu vescovo di Nocera proprio l’antipapaLorenzo, personaggio che, per le vicende di cui erastato protagonista, sicuramente rappresentò una personalitàautorevole nella realtà locale; egli, godendo<strong>del</strong>l’appoggio <strong>del</strong> governo orientale, sicuramentedisponeva <strong>del</strong>le risorse finanziare necessarie per lacostruzione di una così monumentale architettura.Tenendo conto, poi, che nell’elaborazione di un progettoarchitettonico incidono non soltanto i problemidi natura economica, ma anche quelli sociali e culturali,va considerato che tra fine V e inizi VI secolo lecondizioni, forse, dovettero essere più favorevoli.La cosiddetta battaglia dei Monti Lattari (553),come tutti gli eventi di guerra, ebbe dure conseguenzeper il territorio, quindi, pur includendo l’architettura inun progetto di rivitalizzazione <strong>del</strong>la città da parte deiBizantini, sembra più plausibile inserirla nel contestoculturale e sociale in cui operò Lorenzo.In conclusione, è doveroso affermare che i risultatiraggiunti non possono considerarsi conclusivi perl’assenza di fonti documentarie ed archeologiche. Perquanto concerne le fonti letterarie, non abbiamodocumenti che ci informano sul momento in cui fufondato l’edificio; i documenti più antichi in nostropossesso nei quali viene citato il battistero risalgono alIX secolo. Si tratta <strong>del</strong> diploma <strong>del</strong> Principe longobardodi Salerno Siconolfo <strong>del</strong>l’841 e <strong>del</strong> Codex diplomaticusCavensis <strong>del</strong>l’anno 1006 nei quali il battistero vienecitato sotto il nome di «S. Maria Plebis Nuceriae» o«Sanctae Maria Plevis» o «Plebem S. Maria de Nuceria».Dal primo si apprende che il principe longobardo diSalerno Siconolfo, su istanza <strong>del</strong> duca di NoceraGrimoaldo II, riconferma ad Aione, vescovo <strong>del</strong>la suacittà, l’edificio nocerino. Inoltre, il documento rivesteun’importanza singolare, perché oltre a configurarsicome prima fonte scritta, informa sul fatto che nel IXsecolo la struttura, da sede vescovile 28 , assunse la funzionedi pieve. Da altre testimonianze sappiamo poiche nel corso <strong>del</strong> Medioevo, e oltre, il monumento fuoggetto di una lite tra i vescovi di Nocera e gli arcivescovidi Salerno che ambivano ad esercitare la lorogiurisdizione su di esso, e che la questione si risolsesoltanto nel 1627, quando il battistero ritornò alla diocesinocerina. Fu forse in questa occasione che divennechiesa parrocchiale, funzione che conservò fino al1807, quando la struttura, inagibile a causa <strong>del</strong>le infiltrazionid’acqua, fu abbandonata.- 111 -
SALTERNUMNoteLe immagini <strong>del</strong>le figg. 3, 6 - 7 sono di C. Lambert.1Il 1955, il 1969 e il 1982 sono le date deitre scavi sistematici che nel corso <strong>del</strong> ‘900hanno interessato il Battistero. Le zone scavatesono da individuare nell’area antistantel’ingresso principale <strong>del</strong>l’edificio e nel corridoiomeridionale. Tra il 1989 e il 1993 laSoprintendenza Archeologica ha promossouna nuova campagna di scavo sul sagrato enel deambulatorio <strong>del</strong> battistero. Gli scavihanno evidenziato resti di un edificio romano- distrutto o a causa di un evento catastroficoo per eventi bellici - collocato aduna quota ancora più bassa rispetto all’attualeBattistero (LOMBARDO 1994).2Proprio sotto questo nome, di uso correntefin dall’Altomedioevo, viene in generecitato in letteratura l’edificio. Sull’origine<strong>del</strong>la denominazione ‘de’ Pagani’, cfr.LUNADORO 1610, p. 5. La denominazione‘de’ Pagani’ fu spesso attribuita a Nocera,con riferimento ad un gruppo di Saraceni lìinsediatosi, o per uno scambio di nomi conLucera de’ Pagani in Apulia, dove FedericoII aveva istituito una colonia di Saraceni, eche talvolta veniva chiamata Nuceria. Questaattribuzione è sbagliata; in realtà il terminedeve essere inteso nel senso di ‘pagani’ =‘contadini’, dal lat. pagus, ovvero ‘comunitàrurale’. Una fonte importante in propositoè data anche da SALAZARO 1871, vol. I, p.38, e da SCHULZ 1860, II, p. 218.3KRAUTHEIMER 1965. Nell’opera diKrautheimer l’edificio viene citato, erroneamente,come battistero di Nocera Inferiore;inoltre, lo studio sull’importante monumentonon viene adeguatamente approfondito.4Cfr. AMBRUOSO 2009-2010. Il lavoro di cuiil contributo che qui si presenta risulta essereun sunto, dedica il primo capitolo allaricostruzione <strong>del</strong>la storia degli studi sulBattistero nocerino. Attraverso la ricercabibliografica che ha puntato al recupero difonti letterarie italiane e straniere, è statopossibile apprendere non soltanto i puntisalienti su cui la critica ha impostato ildibattito, ma anche l’evoluzione <strong>del</strong> metododi studio di un monumento. A partire daun’analisi semplicemente descrittiva, propostanella seconda metà <strong>del</strong>l’800 dallo Schulze dal Salazaro – ai quali si deve una rivalutazione<strong>del</strong> patrimonio artistico medievale<strong>del</strong>le province meridionali - si passa, con igrandi storici <strong>del</strong>l’arte <strong>del</strong> primo ‘900, qualiAdolfo Venturi, Pietro Toesca ed ÉmileBertaux, ad un approccio filologico fondatosu di uno studio incrociato di fonti documentariee materiali, ovvero sulla conoscenzadiretta <strong>del</strong>l’opera d’arte e dei documentid’ archivio (VENTURI 1901; TOESCA1927; BERTAUX 1904).5Si fa riferimento ai materiali di reimpiegoche ancora oggi si conservano all’interno<strong>del</strong>l’edificio: colonne, basi e capitelli di etàclassica provenienti, con molta probabilità,da edifici nocerini in disuso quali il Teatro<strong>del</strong>la città, portato alla luce con gli scavidegli anni 70 <strong>del</strong> ‘900, per i quali cfr.MARIANI 1987, pp. 7-58; SANTANGELO2002-2003. Per la classificazione dei fusticfr. PENSABENE 2005.6ORLANDO 1884-87.7MAIURI 1958, p. 138.8BILOTTI 1925, pp. 91-95.9STETTLER 1940. La traduzione <strong>del</strong> saggio sideve all’iniziativa <strong>del</strong> Professore UmbertoPappalardo, che con l’aiuto dei suoi collaboratorie con il sostegno finanziario di due istituzionidi Berna, la Burgergemeinde Bern e laGesellschaft zu Ober-Gerwern, è riuscito a realizzareuna traduzione <strong>del</strong>l’opera in lingua italiana,offrendo la possibilità ad un pubblicopiù ampio e numeroso di accostarsi all’eccellentelavoro <strong>del</strong>lo Stettler (PAPPALARDO -GAMBARDELLA - STETTLER 2007).10I restauri <strong>del</strong> 1860, eseguiti grazie all’intervento<strong>del</strong> Re Ferdinando II di Borbone,furono giudicati negativamente dal Bilotti.Questi, in un suo scritto, critica l’attivitàsvolta dal Rizzi e dal Fortunato, i quali,invece di restaurare l’edificio, lo deturparono,rivestendo l’esterno con decorazionimoderne che non tennero conto <strong>del</strong>lanecessità di mantenere viva l’antichità <strong>del</strong>- 112 -
GIUSEPPINA AMBRUOSOtempio. In proposito, cfr. BILOTTI 1934; ID.1936. Con i restauri più recenti, conclusi nel2000, si è cercato di restituire al Battisterol’aspetto originario. È in questa occasioneche sono stati restaurati i mosaici pavimentali,sono state sottoposte ad un interventodi pulitura le colonne, i capitelli, le basi, lelastre marmoree <strong>del</strong>la piscina e sono statiliberati dall’intonaco di età borbonica i muriperimetrali, facendo così emergere parte<strong>del</strong>le primitive strutture murarie.11Per i molteplici aspetti legati all’edificiobattesimale in Italia, cfr. i due voll. degli Atti<strong>del</strong>l’VIII Congresso Nazionale di ArcheologiaCristiana tenutosi nel settembre <strong>del</strong> 1998 inLiguria (L’edificio battesimale in Italia 2001).12Cfr. WATAGHIN – CECCHELLI - PANIERMINI 2001, pp. 231-265.13FALLA CASTELFRANCHI 1980.14Cfr. AMBRUOSO 2009-2010, cap. III, pp.104-166.15FIACCADORI 1992, vol. II, pp. 145-170.16La forma circolare <strong>del</strong>l’edificio ha spintogli studiosi ad usare per il battistero nocerinodenominazioni come ‘Rotonda’, ‘S.Maria la Rotonda’, ‘Tempio Rotondo’.17La vasca <strong>del</strong> battistero di San Giovanni inLaterano misura 9 m, quella <strong>del</strong> battistero diSanta Maria Maggiore 7 m (cfr. FALLACASTELFRANCHI 2001, pp. 267-301;LUCHERINI 2009).18La battaglia, che ebbe il suo epilogo lungole rive <strong>del</strong> fiume Sarno con la morte di Teia,Re dei Goti, e la vittoria di Narsete allaguida <strong>del</strong>l’esercito bizantino, è descritta daProcopio di Cesarea, segretario di Belisario,in quattro degli otto libri <strong>del</strong>la sua Storia <strong>del</strong>leguerre di Giustiniano (cfr. La guerra gotica diProcopio di Cesarea).19KRAUTHEIMER 1980.20L’idea che in origine il Battistero fossestato affiancato da una Basilica fu propostaper primo dallo Stettler nel 1940.21Ciò che ha spinto gli studiosi a considerareil Battistero di Nocera una diretta filiazione<strong>del</strong> Mausoleo di Santa Costanza aRoma è l’organizzazione spaziale. Entrambigli edifici presentano una pianta circolare eun deambulatorio con copertura a botte.22PAGANO 2009, pp. 9-21; ID. 2010, pp.129-140.23La lista dei Vescovi di Nocera storicamenteattestati in età tardoantica va dai primianni <strong>del</strong> V secolo al 601; si tratta di Prisco,primo Vescovo, di cui non conosciamo lecoordinate cronologiche; Felice (402); CelioLorenzo (499); Aprile (502); Leone (510);Aurelio Prisciano (530); Numerio (593) ePrimerio (598). Circa tale cronotassi cfr.LAMBERT 2007, pp. 31-70.24VENDITTI 1967.25KITZINGER 1972, pp. 87 - 102.26LAMBERT 2006; EBANISTA 2009-2010, vol.40-41, pp. 161-226.27In realtà le informazioni in nostro possessoriguardo alla città di Nocera in epoca tardoanticasono piuttosto scarse, sia per l’esiguitàdegli scavi, sia per l’assenza di fontidocumentarie; tuttavia, alcuni dati, anchearcheologici - come gli scavi che negli anni‘70 <strong>del</strong> ‘900 che hanno portato alla luce ilteatro, edificato in età ellenistica nella partemeridionale <strong>del</strong>la città - hanno permesso dicapire che Nuceria già nel IV secolo visse unperiodo di decadenza. A contribuire allaperdita <strong>del</strong>la prosperità, che aveva invececaratterizzato la città in età classica, furonoalcuni fenomenici naturali: le alluvioni,piuttosto frequenti nella zona, e le eruzioni<strong>del</strong> Vesuvio, tra cui quella <strong>del</strong> 476 d. C. e lesuccessive <strong>del</strong> 512 e 536. A queste siaggiunsero le conseguenze <strong>del</strong>la guerragreco-gotica, che determinò l’abbandono<strong>del</strong>le città e il trasferimento degli abitantiverso le campagne, e una pestilenza checolpì l’intera penisola tra il 559 e il 562 e chepenetrò forse anche in Campania.28Alcune fonti attestano che nei primi secoliin cui fu istituita la Diocesi a Nocera ivescovi risiedettero nel Battistero di NoceraSuperiore.- 113 -
SALTERNUMBibliografiaFONTILa guerra gotica di Procopio di Cesarea, a cura diD. COMPARETTI, in Fonti per la storia d’Italia,(Istituto Storico Italiano, Tipografia <strong>del</strong>Senato), Roma, vol. 1, 1895; vol. 2, 1896;vol. 3, 1898.STUDIAMBRUOSO G. 2009-2010 (ined.), Il Battisteropaleocristiano di Santa Maria Maggiore, Tesi diLaurea in Storia <strong>del</strong>l’Arte Medievale,Università degli Studi di Salerno (Relatore:Prof.ssa G. Zanichelli; Correlatore: Prof.ssaC. Lambert) .BERTAUX É. 1904, L’art dans l’Italie méridionale,Paris.BILOTTI P. E. 1925, Il Tempio di S. MariaMaggiore in Nocera, in ‘Archivio Storico per laProvincia di Salerno’, V, fasc. I-II, pp. 91-95.EBANISTA C. 2009-2010, Domenico Mallardo el’Archeologia Cristiana in Campania, in‘Campania Sacra’, XL-XLI, pp. 161-226.FALLA CASTELFRANCHI M. 1980, Baptisteria.Intorno ai più noti battisteri <strong>del</strong>l’Oriente, Roma.FALLA CASTELFRANCHI M. 2001, L’edificio battesimalein Italia nel periodo paleocristiano, in L’edificiobattesimale in Italia 2001, I, pp. 267-301.FIACCADORI G. 1992, Il Cristianesimo. Dalleorigini alle invasioni barbariche, in Storia e civiltà<strong>del</strong>la Campania 1992, II, pp. 145-170.KITZINGER E. 1972, The Gregorian Reformand the Visual Arts: A Problem of Method, in‘Transactions of the Royal Historical Society’, s.V, XXII, pp. 87-102.KRAUTHEIMER R. 1965, Early Christian andBizantine architecture, Harmondsworth (trad.it.: Architettura paleocristiana e bizantina,Torino 1986).KRAUTHEIMER R. 1980, Rome. Pro<strong>file</strong> of aCity, Princeton (trad. it. Roma. Profilo di unacittà, Roma 1981).LAMBERT C. 2006, Un prezioso anello di congiunzionetra tarda antichità e altomedioevo nelMuseo di Nocera, in ‘Apollo’ (‘Bollettino deiMusei Provinciali <strong>del</strong> <strong>Salernitano</strong>’), Napoli,pp. 44-58.LAMBERT C. 2007, Iscrizioni di vescovi e presbiterinella Campania tardoantica ed altomedievale(secc. IV-VIII), in ‘Schola Salernitana’, Annali,XI, pp. 31-70.L’edificio battesimale in Italia 2001, L’edificiobattesimale in Italia. Aspetti e problem, Atti<strong>del</strong>l’VIII Congresso Nazionale di ArcheologiaCristiana, Genova, Sarzana, Albenga, FinaleLigure, Ventimiglia 21-26 settembre 1998, acura di D. GANDOLFI, Bordighera.LOMBARDO M. 1994, Lo scavo archeologicoentro e fuori la Rotonda, in Nuceria Alfaterna1994, II, pp. 91-105.LUCHERINI V. 2009, La Cattedrale di Napoli.Storia, architettura, storiografia di un monumentomedievale, Roma.LUNADORO S. 1610, Lettera intorno all’origine<strong>del</strong>la Città di Nocera de’ pagani e suo Vescovado,Napoli.MAIURI A. 1958, Vita d’Archeologo, Napoli.MARIANI A. 1987, La decorazione architettonicain marmo scolpito nel territorio <strong>del</strong>l’antica Nuceria,in ‘Rassegna Storica Salernitana’, n. s., IV,fasc. 1, pp. 7-58.Nuceria Alfaterna 1994, Nuceria Alfaterna eil suo territorio. Dalla fondazione ai Longobardi,a cura di A. PECORARO, Nocera Inferiore.ORLANDO G. 1884-1887, Storia di Nocera de’Pagani, Napoli.PAGANO M. 2009, Continuità insediativa <strong>del</strong>leville nella Campania fra tarda antichità e altomedioevo, in La Campania fra tarda antichità ealto medioevo 2009, pp. 9- 21.PAGANO M. 2010, Il primitivo cristianesimo aStabiae: nuove scoperte, in Ipsam Nolam barbarivastaverunt. L’Italia e il Mediterraneo occidentaletra il V secolo e la metà <strong>del</strong> VI, Atti <strong>del</strong>Convegno internazionale di studi, Cimitile – Nola- Santa Maria Capua Vetere 2009, a cura di C.EBANISTA - M. ROTILI, Cimitile, pp. 129-140.PAPPALARDO U. - GAMBARDELLA A. -STETTLER M. 2007, Il Battistero di NoceraSuperiore. Un capolavoro <strong>del</strong>l’architettura paleocristianain Campania, Napoli.PENSABENE P. 2005, Marmi e committenzanegli edifici di spettacolo in Campania, in‘Marmora’ (‘International Journal forArchaeology, History and Archaeometry of marblesand stones’), I, pp. 69-143.SALAZARO D. 1871, Studi sui monumenti<strong>del</strong>l’Italia meridionale dal IV al XIII sec.,Napoli.SANTANGELO G. 2002-2003 (ined.), L’arredoscultoreo tardoantico <strong>del</strong> Battistero di NoceraSuperiore (SA), Tesi di Laurea in ArcheologiaCristiana, Istituto Universitario ‘SuorOrsola Benincasa’ di Napoli (Relatore:Prof. F. Marazzi; Correlatore: Prof.ssa M.Falla Castelfranchi).SCHULZ H. W. 1860, Denkmaler der Kunst desMittelalters in Unteritalien, Dresda, 2 voll.STETTLER M. 1940, Das Baptisterium zuNocera Superiore, in ‘Archeologia Cristiana’,XVII, fasc. 1-2, Roma.TOESCA P. 1927, Storia <strong>del</strong>l’arte italiana. IlMedioevo, Torino.VENDITTI A. 1967, Architettura bizantinanell’Italia meridionale: Campania, Calabria,Lucania, Napoli.VENTURI A. 1901, Storia <strong>del</strong>l’arte italiana. Daiprimordi <strong>del</strong>l’arte cristiana al tempo diGiustiniano, I, Milano.WATAGHIN CANTINO G. - CECCHELLI M. -PANI ERMINI L. 2001, L’edificio battesimale neltessuto <strong>del</strong>la città tardoantica e altomedievale inItalia, in L’edificio battesimale in Italia 2001, I,pp. 231-265.- 114 -
MARIO MOLESL’affresco di ‘San Nicola e San Giorgio (?)’<strong>del</strong>l’ambiente ‘ipogeo D’<strong>del</strong>la Chiesa di San Pietro a Corte a SalernoOggetto <strong>del</strong> mio studio è il brano di pittura<strong>del</strong>l’ambiente ‘ipogeo D’ <strong>del</strong> complessomonumentale di San Pietro aCorte da sempre indicato come ‘San Nicola e il cavallo’(o anche ‘Santo Vescovo e il cavallo’), affresco chefinora non ha mai avuto un approfondimento iconograficoe stilistico, soprattutto a causa <strong>del</strong>lo stato diconservazione e <strong>del</strong>l’inconsueto accostamento <strong>del</strong>ledue figure che lo compongono.L’affresco, risalente con tutta probabilità al sec.XIII, è posto sul muro di separazione dei dueambienti ipogei, quasi di fronte all’affresco <strong>del</strong>laMadonna in Trono con Bambino e Santa Caterina.Ha dimensioni di circa 2,00 m. x 1,87 m. ed è, purtroppo,molto degradato e lacunoso: il personaggioritratto in abito vescovile è acefalo (fig.1).Lo schema compositivo è molto semplice, unSanto Vescovo alla destra, ritratto a figura intera coninquadratura frontale, ed un cavallo bianco alla sinistra,raffigurato con inquadratura laterale.Lo sfondo è bianco-ocra con sovrapposti pannellirettangolari di colore blu-verde ed il tutto è <strong>del</strong>imitatosuperiormente da una cornice composta da duestrette fasce rosse esterne seguite, verso l’interno<strong>del</strong>la cornice, da una riga mosaicata di colore biancoche racchiude, al suo interno, un elemento decorativo,con analoghe caratteristiche, a rombi (oggi pocoleggibile 1 ) su uno sfondo di colore blu. La cornice,invece, al lato destro si compone solo <strong>del</strong>la rigamosaicata bianca, che, però, è all’interno <strong>del</strong>la fasciarossa, mentre a sinistra <strong>del</strong>l’affresco c’è apparentementesolo una fascia rossa. L’affresco al di sotto,Fig. 1 - Salerno, Chiesa di San Pietro a Corte. Affresco di ‘San Nicola e San Giorgio (?)’. Fig. 2 - Salerno, Chiesa di San Pietro a Corte. Affresco di ‘San Nicola e San Giorgio (?)’,particolare <strong>del</strong> Santo vescovo. La mano destra è benedicente alla latina, mentre la sinistraregge il pastorale (che non è visibile nella parte superiore).- 115 -
SALTERNUMFig. 3 - Maiori (SA), Santa Maria de’Olearia (sec. XII).infine, sia a causa <strong>del</strong> forte degrado, sia, soprattutto,a causa di un’apertura successiva di esso, è privo dicornice, così come il cavallo è privo <strong>del</strong>la parte inferiore<strong>del</strong>le zampe, soprattutto posteriori.Il Santo Vescovo, la cui testa probabilmente èstata asportata, è ritratto con un camice bianco, unmantello rosso di forma conica - la casula - impreziositoda ricami circolari e concentrici , e con un pallioFig. 5 - Matera, San Nicola dei Greci (sec. XIII -XIV).Fig. 6 - Salerno, San Pietro a Corte. Teoria di Santi.bianco arricchito da croci alternate areticoli di quadrati 2 .Il Santo Vescovo, la cui testa probabilmenteè stata asportata, è ritrattocon un phelonion (mantello di formaconica) rosso, arricchito da ricami circolarie concentrici 3 , che copre lo sticharion(tunica) bianco, e con un omophorionbianco (stola lunga, decoratacon croci, che gira intorno al collo escende sul davanti, corrispondente alpallio dei paramenti vescovili occidentali),arricchito da croci alternate a reticolidi quadrati. La mano destra è benedicente alla latina4 , mentre la sinistra regge il pastorale, che non è visibilenella parte superiore (fig.2).Sul lato destro <strong>del</strong>l’affresco, nel punto quasi in corrispondenza<strong>del</strong>la mano sinistra <strong>del</strong> Santo e prima<strong>del</strong>la cornice ocra, sono visibili alcune lettere, finoranon decifrate: la prima è una ‘A’ ed al di sotto una ‘U’in capitale epigrafica latina. Sopra la ‘A’ è appena leggibileuna ‘L’ e superiormente ad essa una ‘O’. Sotto la‘U’, inoltre, è visibile la parte superiore di una ‘S’.Mettendo in ordine le lettere dall’alto verso il basso èleggibile la scritta «…OLAVS».Questa lettura trova conferma nelle immagini acorredo <strong>del</strong>la documentazione fotografica <strong>del</strong> 1982 diArturo Amarotta 5 e <strong>del</strong> 1988 di Daniela Mauro 6 dove,oltre a queste lettere, si leggono chiaramente al disopra anche le lettere «NIC» a partire dalla spalla sinistra.La presenza di tali lettere rende indiscutibile l’identificazione<strong>del</strong> Santo ritratto con Nicolaus, ovveroSan Nicola vescovo.L’iconografia <strong>del</strong> Santo cominciò ad avere caratteristichepiù costanti a partire dalla metà <strong>del</strong> X secolocirca. Il Santo è solitamente rappresentato confronte spaziosa, capelli bianchi o brizzolati e pocofolti, barba corta e nella mano sinistra il libro <strong>del</strong>Vangelo (figg. 3-4-5). In Europa occidentale, a partiredall’XI secolo, si iniziò a rappresentare San Nicolaanche con il pastorale ed il pallio, contrassegni <strong>del</strong>ladignità vescovile nella Chiesa latina. Nei secoli successivifu aggiunto il copricapo tradizionale deivescovi, la mitria 7 .Il più grande contributo all’affermazione <strong>del</strong> cultodi San Nicola lo diedero nel corso <strong>del</strong> secolo XI iNormanni 8 , che fecero <strong>del</strong> Santo il loro patrono.Avendo Bari perso il suo ruolo di capi tale <strong>del</strong>l’ItaliaFig. 4 - Nardò (LE),Cattedrale (sec. XIII-XIV).- 116 -
MARIO MOLESFig. 7 - Ruggero II - Liber ad honorem Augusti.Fig. 8 - Ingresso di Costanza di Sicilia a Salerno - Liber ad honorem Augusti.greco-bizantina a seguito <strong>del</strong>la conquista normanna(1071), la ricca ed attiva borghesia pensò di mantenereil prestigio <strong>del</strong>la città puntando sull’aspetto religioso.E, dato che nel Medioevo l’importanza di una cittàsi misura va anche dalla sua capacità di impadronirsi<strong>del</strong>le reliquie di Santi da terre infe<strong>del</strong>i, nel 1087 iBaresi organizzarono l’impresa per portare nella lorocittà le reliquie di San Nicola. La traslazione <strong>del</strong>le spoglie<strong>del</strong> Santo dalla Turchia a Bari fece sì che il culto,già molto vivo, ricevesse ulteriore impulso. INormanni, che avevano portato a termine l’impresain appoggio dei Baresi, divenne ro così i principalipropagandisti <strong>del</strong>la devozione al Santo 9 . Da quelmomento in poi la città di Bari, come illustrato daGiorgio Otranto 10 , grazie alla presenza <strong>del</strong>le reliquienicolaiane, divenne una tappa dei pellegrini e deiCrociati, che dall’Europa centrosettentrionale si recavanoin Terrasanta, attraversando la Puglia, visitandoanche il Santuario di San Michele sul Gargano 11 e,dando vita al Cammino <strong>del</strong>l’Angelo e di San Nicola(nel nome dei quali, durante il Medioevo, si creò unasorta di koiné culturale e religiosa tra Europa centrosettentrionale,Italia, Mediterraneo bizantino eTerrasanta), un itinerario medievale che si collegavaanche al pellegrinaggio compostellano.Accertato che il Santo Vescovo ritratto nell’affrescoè San Nicola, rimane inconsueto l’accostamento<strong>del</strong> Santo con il cavallo, in quanto, nell’iconografia tradizionale,il Santo di Myra viene generalmente ritrattoin relazione ai miracoli compiuti: con tre palle d’oro otre sacchetti di monete tra le mani, con tre fanciulle,con tre bambini, mentre seda la tempesta, mentreFig. 9 - Enrico VI - Liber ad honorem Augusti.salva tre innocenti dalla decapitazione, mentre vieneeletto vescovo 12 .Il cavallo, benché ritratto con un certo movimento,cioè con le zampe anteriori alzate (forse è al galoppo),tradisce nella semplicità <strong>del</strong> disegno, un’imperizia, daFig. 10 - Salerno, Chiesa di San Pietro a Corte. Affresco di ‘San Nicola e San Giorgio (?)’,particolare.- 117 -
SALTERNUMparte <strong>del</strong>l’artista, nel ritrarre i particolari anatomici<strong>del</strong>lo stesso o, in generale, una non eccelsa capacitàfigurativa in quanto le zampe non sono rese con sufficientesenso plastico <strong>del</strong>le articolazioni e <strong>del</strong>lamuscolatura. L’occhio, in particolare, è reso con eccessivafrontalità e dimensione ed è simile, come impostazione,sia agli occhi <strong>del</strong>le altre figure ritratte nellaTeoria di Santi (fig. 6) e <strong>del</strong>la Madonna in Trono, dovei tratti somatici <strong>del</strong> volto sono ritratti in modo marcatoe pesante, sia a quelli di altri cavalli miniati <strong>del</strong> Liberad honorem Augusti (figg. 7-8-9) di Pietro da Eboli (ca.1170 – ca. 1220, cronista, poeta e, forse, chierico).L’affresco ricalca, in generale, immagini di repertorioin stile bizantino, che vengono eseguite senzaapporti personali e denotano una qualitàalquanto modesta. Anche sotto ilprofilo tecnico si rileva l’uso di unatavolozza cromatica limitata, caratterizzatadall’impiego <strong>del</strong>l’ocra, <strong>del</strong> marrone,<strong>del</strong> rosso, <strong>del</strong> bianco e <strong>del</strong> grigioblu,visibilmente adoperati senza variazionio sfumature di particolare rilevanza.L’affresco, pertanto, così come glialtri presenti nello stesso ambiente,attesta la diffusione di determinateimmagini e di specifici codici espressivisia in area campana sia, in generale, inarea meridionale. Il panorama artisticosalernitano, quindi, fra il XII e il XIIIsecolo è dinamico per la committenza,ma è obsoleto per il repertorio iconograficodi riferimento, anche se la presenza<strong>del</strong> cavallo può essere consideratoun elemento di novità.Dall’osservazione più accurata <strong>del</strong>cavallo (fig. 10), sia autopticamente siasoprattutto nelle fotografie risalentiagli anni ’80 (Amarotta nella didascaliaalla fotografia precedentemente citatanomina l’affresco ‘Cavallo e cavaliere’senza, però, fare riferimento al SantoVescovo; la Mauro, invece, intitola ‘Santo Vescovo edun cavallo’), oltre che in quelle scattate da chi scrive,sembra raffigurato qualcosa che potrebbe andare al dilà <strong>del</strong>la semplice sella <strong>del</strong> cavallo. Si notano le redininon abbandonate, ma in tensione, alcune tracce di tessutorosso/marrone a piccoli rombi, dipinti nellaparte inferiore <strong>del</strong>la pancia <strong>del</strong> cavallo (dove sono piùFig. 11 – ‘Horus che uccide un coccodrillo’ (IVsec.). Parigi, Museo <strong>del</strong> Louvre.Fig. 12 - Giustiniano a cavallo. AvorioBarberini (527-530 ca.). Parigi, Museo <strong>del</strong>Louvre.evidenti), ma anche un’ombra rosso-marrone nellaparte superiore <strong>del</strong> dorso, che si protrae verso sinistrafin quasi sopra alla coda <strong>del</strong> cavallo, ma, dato lo statodi pessima conservazione <strong>del</strong>l’affresco, si può soloipotizzare, verosimilmente, che possa far parte <strong>del</strong>l’abbigliamento(ad esempio, un mantello - per ciò che sivede al di sopra <strong>del</strong> cavallo - ed una tunica per ciò cheè ancora visibile sul fianco <strong>del</strong>lo stesso) o di un cavaliereche si reca al cospetto <strong>del</strong> Santo Vescovo (perriceverne la sacra legittimazione per le sue conquiste oper ringraziarlo di una grazia ricevuta o per ricevernela benedizione prima di un’impresa) o, più verosimilmente,di un Santo Cavaliere.Nella descrizione <strong>del</strong> dipinto <strong>del</strong> 1988 la Mauro 13dice: «In alto a sinistra <strong>del</strong>la primaparete (US 69) è raffigurato un cavallopreceduto da un Santo Vescovo, il cuivolto, però, è stato asportato. Si trattadi un’immagine estremamente semplicecondotta anzi da un artefice la cuimano, per alcuni elementi, sembrerebbeinesperta, basti considerare la resafrontale <strong>del</strong>l’occhio <strong>del</strong> cavallo chenon tiene conto <strong>del</strong>l’impostazionecorporea laterale <strong>del</strong>l’animale. Il Santo,poi, è dipinto ancora in modo statico ebidimensionale e ricalca in ciò la resa<strong>del</strong>le altre figure esaminate; eppurel’affresco non è coevo alla teoria <strong>del</strong>laMadonna Eleusa o alle altre decorazionipresenti, rispetto alle quali è collocatoad un’altezza diversa. Di fatto siamodi fronte alla stanca ripetizione di unmo<strong>del</strong>lo rispetto al quale non esistenessuna novità. E’ probabile che taledecorazione sia da ascrivere al XVsecolo e coincida con una fase diabbellimento <strong>del</strong> sito prima <strong>del</strong>la suadecadenza».In un contributo successivo <strong>del</strong>2000 la stessa Mauro 14 , focalizzando lasua attenzione soprattutto sugli affreschi meglio conservati,non si sofferma sugli altri resti pittorici inquanto «si tratta di opere frammentarie e quasi illeggibili,databili in un arco di tempo abbastanza ampio(fino al XIV secolo), che testimoniano comunque unafrequentazione, ancora lunga nel tempo, <strong>del</strong>l’oratorium,con conseguenti interventi di abbellimento che,- 118 -
MARIO MOLESperò, non si discostavano da una pittura di repertorio».Al riguardo rinvia alla tav. X, chiamandola ‘SanNicola (acefalo) con cavallo’.Per Antonio Braca 15 lì «….dove si vede un vescovoacefalo, identificabile come San Nicola, accanto ad uncavallo al galoppo,….non è certamente accettabile unadatazione al XV secolo. Anch’esso, in verità, va ricondottoal XIII secolo …, come indica l’impaginazionesostanzialmente prossima al ciclo di San Nicola nellacappella superiore di Santa Maria de’Olearia ovvero inquello di San Giovanni nelle grotte di Calvi Vecchia. Iltipo di decorazione <strong>del</strong> cavallo con pendagli trova unpreciso riferimento iconografico nella miniatura <strong>del</strong>l’ingresso<strong>del</strong>la regina Costanza a Salerno <strong>del</strong> Liber adhonorem Augusti, che è databile agli ultimissimi anni <strong>del</strong>XII secolo».Il collare arricchito da pendagli era, infatti, tipicodei nobili cavalieri <strong>del</strong>l’epoca normanna e sveva (cfr.supra, figg. 7, 8, 9; tale bardatura era, però, già presentenel bassorilievo di ‘Horus che uccide un coccodrillo’, <strong>del</strong>IV sec. (fig. 11), e nell’Avorio Barberini, <strong>del</strong>la primametà <strong>del</strong> VI sec., raffigurante Giustiniano (fig. 12),ambedue conservati a Parigi nel Museo <strong>del</strong> Louvre.Si potrebbe, dunque, ipotizzare una nuova lettura<strong>del</strong>l’affresco: considerare San Nicola e il cavallo su duesfondi separati, ma all’interno <strong>del</strong>la stessa cornice esupporre la presenza di un Santo Cavaliere (SanGiorgio?), sulla base di testimonianze iconografichedei secc. XII-XIII calate nel contesto storico <strong>del</strong>leCrociate e <strong>del</strong> periodo normanno-svevo.Dall’analisi ravvicinata <strong>del</strong>l’affresco, si nota, infatti,che i pannelli di sfondo di colore blu <strong>del</strong>le due figure,San Nicola e il cavallo (fig. 1), sono separati verticalmenteda una fascia più chiara (forse all’origine dicolore bianco o ocra), così come è visibile nella Teoriadei Santi alla sinistra <strong>del</strong>la Madonna Eleusa, dove iSanti sono separati l’uno dall’altro con cornici dipinte16 (fig. 6). Questo elemento induce a pensare che lafigura di San Nicola sia separata dal cavallo e, pertanto,non sia da mettere in relazione ad esso.Il riquadro con il cavallo potrebbe, dunque, essereconsiderato come scena a se stante, anche sullabase di confronti iconografici in altre direzioni. Lafigura <strong>del</strong> cavallo, infatti, se attentamente analizzata,presenta, oltre agli elementi in precedenza citati, unafascia obliqua di un colore molto vicino al marrone,che inizia dal dorso vicino al collare e prosegueverso il basso quasi parallelamente alle zampe anteriori<strong>del</strong> cavallo, che potrebbe essere identificata conuna lancia. L’affresco, altresì lacunoso nella parteinferiore per circa un quarto <strong>del</strong>l’altezza totale, fasupporre la mancanza di un elemento che, consideratele proporzioni, poteva essere verosimilmentesotto le zampe <strong>del</strong> cavallo. Se tale lacuna avesse ospitatola figura di un drago, si potrebbe ipotizzare lapresenza sul cavallo di San Giorgio, nella sua classicaiconografia, ovvero nell’atto di trafiggere il drago.Una <strong>del</strong>le più antiche testimonianze iconografiche<strong>del</strong> Santo che uccide il drago è presente nella Chiesa diSanta Maria <strong>del</strong> Lago a Moscufo (PE), datato al 1158,dove l’abbigliamento <strong>del</strong> Santo Cavaliere (fig. 13) e,soprattutto, l’equipaggiamento <strong>del</strong> cavallo, con il collarea pendagli, sono molto vicini a quelli dei cavalierinormanni e svevi d’alto rango <strong>del</strong> Liber ad honoremAugusti.Tale raffigurazione è messa a confronto da ErricoCuozzo 17 con altre testimonianze iconografiche (pulvinie portali), provenienti dalle Chiese romaniche <strong>del</strong>Mezzogiorno d’Italia, databili al XII secolo, con preziosibassorilievi di cavalieri normanni armati allapesante 18 che si danno l’assalto con corazza di magliadi ferro, lancia, con o senza scudo, e cavalli con morso.Queste testimonianze iconografiche consentono diillustrare l’armatura dei cavalieri normanni nellaseconda metà <strong>del</strong> XII secolo.«Quello che è interessante sottolineare - in SanGiorgio - è … il significato emblematico <strong>del</strong>la raffigurazioneche, presente anche in uno dei capitelli <strong>del</strong>chiostro di Santa Sofia di Benevento, traduce in unaforma reale l’ideale immagine <strong>del</strong> defensor ecclesiae. … Ladiffusione dei culti <strong>del</strong>l’iconografia di San Giorgio nelFig. 13 - Moscufo (PE), Santa Maria <strong>del</strong> Lago. Ambone <strong>del</strong> 1158.- 119 -
SALTERNUMFig. 14 - San Vito dei Normanni (BR), Chiesa di San Biagio.Affresco con San Giorgio, San Demetrio, San Nicola.Fig. 15 – San Vito deiNormanni (BR), Chiesa di SanBiagio. Particolare: San Nicola.Fig. 16 - San Vito dei Normanni (BR), Chiesa diSan Biagio. Particolare: San Giorgio.Mezzogiorno <strong>del</strong> XII secolo, come quella <strong>del</strong>Cavaliere che è defensor ecclesiae, costituisce un datomolto significativo, perché consente di collegare ilrituale <strong>del</strong>la vestizione dei cavalieri normanni con leantiche forme franche di consacrazione <strong>del</strong> defensorecclesiae» 19 .San Giorgio era il Santo Cavaliere 20 , paladino <strong>del</strong>lafede, le cui miracolose apparizioni avevano aiutato iNormanni nella loro guerra agli infe<strong>del</strong>i. Nel 1063Ruggero d’Altavilla riportò una celebre vittoria suiMusulmani nelle vicinanze di Cerami in Sicilia. Nelracconto di Goffredo Malaterra 21 , monaco normanno<strong>del</strong>l’XI sec., si afferma, che San Giorgio, risplendentedi luce, avesse galoppato innanzi ai Cristiani per guidarlialla vittoria. Ai Normanni, infatti, apparve uncavaliere armato di spada, con un vessillo bianco sulquale c’era una grande croce rossa. Questa battagliasegnò la conquista <strong>del</strong>la Sicilia 22 da parte deiNormanni che, da quel momento, venerarono SanGiorgio come loro patrono e protettore, attribuendogliil titolo di ‘Vittorioso’. Una prima attestazione iconograficache potrebbe ricordare questo episodio e,quindi, la vittoria <strong>del</strong> bene sul male (riprendendo cosìculti più antichi, per i quali cfr. supra, fig. 12), siriscontra nella lastra marmorea, risalente alla secondametà <strong>del</strong>l’XI secolo, conservata nel deambulatorio<strong>del</strong>la cattedrale di Aversa, esempio di architettura normannaprimitiva, dove San Giorgio, armato di spada,è raffigurato nell’atto di uccidere il drago. Di questoSanto, infatti, esistono due raffigurazioni: in una é racchiusoin una corazza, a piedi, con la spada; nell’altraa cavallo, nell'atto di uccidere il drago. Questa secondarappresentazione si diffuse maggiormente al tempodei Crociati, i quali, avendo visto a Costantinopoli unastatua equestre colossale <strong>del</strong>l'imperatore Costantinoche ha sotto i piedi <strong>del</strong> cavallo impennato un dragomostruoso, la attribuirono a San Giorgio.La grande diffusione <strong>del</strong> culto di San Giorgio siebbe dunque, in Europa, proprio in conseguenza <strong>del</strong>leCrociate in Terrasanta e, più precisamente, ai tempi<strong>del</strong>la battaglia di Antiochia nel 1098.Alla diffusione <strong>del</strong>la leggenda <strong>del</strong> drago nelMedioevo contribuirono sia il Trovatore anglonormannoRobert Wace (1115ca. – 1183) sia il Fratedomenicano Iacopo da Varagine (Varazze, 1228 -Genova, 1298), con la sua Legenda Aurea, i quali fissaronola figura di San Giorgio come cavaliere eroico,che tanto influenzerà l’ispirazione figurativa degli artistisuccessivi e la fantasia popolare. Rapidamente eglidivenne un Santo tra i più venerati in ogni parte <strong>del</strong>mondo cristiano e l’ambiente <strong>del</strong>la cavalleria vi videincarnati i suoi ideali. A testimonianza <strong>del</strong>l'ampia diffusione<strong>del</strong> suo culto sono le numerosissime chiesededicate al suo nome e le molte Nazioni e città che lohanno come Patrono.Affreschi che ritraggono San Giorgio nella suaclassica iconografia, databili tra i secoli XII e XIII, neiquali é evidente il colore e la posizione <strong>del</strong> cavallo,<strong>del</strong>la lancia e <strong>del</strong> mantello, nonché la scansione volumetrica<strong>del</strong>le figure, sono presenti in alcune chieserupestri <strong>del</strong>l’Italia meridionale.Tra questi affreschi sono di notevole importanza,al fine di avvalorare la tesi <strong>del</strong> Santo Cavaliere ritrattoaccanto a San Nicola, soprattutto le testimonianze iconografiche<strong>del</strong>la chiesa di San Biagio a San Vito deiNormanni 23 (BR), databili alla fine <strong>del</strong> XII sec. e dedi-- 120 -
MARIO MOLESFig. 17 - Percorso <strong>del</strong>la ‘via Francigena <strong>del</strong> Sud’.cati contemporaneamente a Santi orientali come SanBiagio, San Nicola e Sant’Andrea e a Santi legati alleCrociate come San Giorgio, San Demetrio, SanGiacomo e San Giovanni. Le iscrizioni poste vicino aiSanti, con la funzione di identificarli, sono tutte ingreco, tranne la doppia iscrizione in latino e greco cheaccompagna la figura di San Nicola, simbolo di unitàreligiosa tra la chiesa ortodossa e quella latina. Questotestimonia la presenza in Puglia, ma anche in altrezone <strong>del</strong> Meridione, di gruppi di fede ortodossa e laconseguente pratica di culti religiosi diversi svolti nellestesse chiese.La chiesa è dedicata a San Biagio, un Santo taumaturgomolto venerato e amato dalla popolazione rurale,e sulla parete laterale a destra <strong>del</strong>l’ingresso sono raffiguratitre Santi: San Nicola, San Demetrio e SanGiorgio su un cavallo bianco (figg. 14-15-16). SanNicola, olosomo, indossa abiti episcopali, uno stichariondi color ocra, il phelonion rosso, l’epitrachelion ornatoda motivi geometrici e l’omophorion bianco con trecroci rosso scuro (come nel nostro San Nicola); nellasinistra ha il Vangelo e con la destra benedice. I dueSanti guerrieri cavalcano due cavalli riccamente bardati,indossano il chitone, la corazza, la clamide rossa elo scudo nella mano sinistra ed hanno entrambi unalancia nella mano destra nell’atto di trafiggere undrago sotto i loro piedi.Il fenomeno degli insediamenti rupestri interessasoprattutto territori quali la Puglia e la Basilicata,anche se con caratteri differenti in base alle caratteristichegeologiche e alle diverse tradizioni di scavo.Gli affreschi all’interno <strong>del</strong>le chiese rupestri, anchese lacunosi, risultano essere molto interessanti adun’attenta lettura iconografica. La presenza, inoltre, ditombe ed iscrizioni sia all’interno sia all’esterno <strong>del</strong>lechiese confermano la funzione e la fruizione a carattereprivato di queste strutture. Sono, infatti, innanzituttochiese funerarie e i cicli pittorici che ne decoranol’interno testimoniano la committenza laica (comeprobabilmente nel caso <strong>del</strong>l’ambiente ipogeo di SanPietro a Corte) e di esponenti <strong>del</strong> basso clero.Nelle absidi si nota la presenza di cicli cristologicianche se non completi, come la Dèesis, cioè la preghierache la Vergine e San Giovanni Battista rivolgono aCristo Pantocrator (Cristo Onnipotente raffigurato introno) per la salvezza <strong>del</strong>l’umanità, spesso con inmano il Vangelo con la scritta EGO SUM LUXMUNDI; anche in San Pietro a Corte è stato ritrovatoun lacerto di affresco raffigurante un libro apertocon la scritta EGO SUM LUX, anche in lingua greca,che lascia supporre la presenza <strong>del</strong> Cristo Pantocratornell’abside <strong>del</strong>l’ipogeo. In tali contesti, poi, compare avolte l’Annunciazione, ma generalmente è la rappresentazionedei Santi, la cui iconografia è bizantina, arivestire le pareti <strong>del</strong>le navate. Frequente è la raffigurazione<strong>del</strong>la Vergine con il Bambino (come in SanPietro a Corte la Madonna Eleusa e la Madonna introno con Bambino), intermediatrice tra gli uomini eDio, il cui mo<strong>del</strong>lo di riferimento era la Madonna diCostantinopoli.I Santi più rappresentati sono quelli taumaturghicome Nicola, Cosma e Damiano, Biagio, Giacomo eAndrea raffigurati con gli abiti inerenti alla loro funzioneall’interno <strong>del</strong>la Chiesa. Seguono i Santi militari 24 ,come Giorgio, Teodoro, Demetrio, Procopio, armati dicorazze, lance, scudi, stendardi e spesso a cavallo, e gliasceti con i consueti abiti semplici, simbolo <strong>del</strong> voto dipovertà, e le Sante vergini come Margherita, Marina,Teodosia, con tunica, mantello e velo.Gli affreschi spesso sono realizzati a crudo sullaroccia e non presentano strati di intonaci spessi; icolori ricorrenti sono l’ocra, il verde, l’azzurro, il biancoe il giallo. Accanto ai Santi vengono dipinti i loronomi tramite iscrizioni in greco o in latino e, in alcunicasi, anche dediche o commenti suggeriti dai committenti<strong>del</strong>l’opera.Lungo la via Appia-Traiana, divenuta in seguitovia Francigena, itinerario utilizzato sia per i pellegrinaggisia per le Crociate, sorgono le chiese rupestri piùimportanti come, a titolo esemplificativo, quella deiSanti Andrea e Procopio a Monopoli (BA), di Lamad’Antico a Fasano (BR), che conserva, se pur in stato- 121 -
SALTERNUMFig. 18 - Mottola (TA), interno <strong>del</strong>la chiesa rupestre di San Nicola.sono vestiti alla bizantina e, accanto a temi tipicamentebizantini come la Dèesis, la Thetόkos Odegitria (Madre diDio che indica nel Cristo Bambino in braccio la via<strong>del</strong>la salvezza) e gli arcangeli, compaiono Santi legati aipellegrinaggi e, anche qui, alle crociate.Nella prima archeggiatura a destra <strong>del</strong> bema è, infatti,raffigurato San Giorgio, in cotta di maglia, su di uncavallo bianco, con la destra che tiene la lancia con ilvessillo bianco a tre punte e con lo scudo a tracolla(fig. 19). Nella seconda archeggiatura sono rappresentatiSan Pietro e San Leone papa (vicari di Cristo) inatto benedicente e in quella successiva Sant’Elena e unSanto Vescovo ignoto, forse San Nicola (fig. 18).Nell’ultima archeggiatura, infine, è raffigurato dinuovo San Giorgio, su cavallo bianco, sempre in cottadi maglia, con calzari e manto rossi, lo scudo concroce a tracolla e con le mani che impugnano la lanciacon cui è trafitto il drago (fig. 20).Nella stessa chiesa su un’altra parete compare SanNicola nella sua iconografia più tradizionale, accantoalla Madonna con Bambino e San Basilio (fig. 21).Un altro, analogo, affresco di San Giorgio, in veritàin pessime condizioni, è visibile nella chiesa rupestredi Santa Margherita, sempre a Mottola (TA), doveSan Giorgio è raffigurato con altri Santi (l’ArcangeloMichele, Lorenzo, Marco e Vescovi) e dove su un’altraparete è rappresentato un episodio <strong>del</strong> ciclo <strong>del</strong>la vitadi San Nicola: il miracolo più celebre <strong>del</strong>la sua carità,la dote per il maritaggio di tre donzelle. La rappresentazioneè forse la più antica attestazione <strong>del</strong>la scena inPuglia (XI-XII sec.).Anche a Laterza (TA), vicino a Mottola, numerosesono le chiese rupestri interessanti per l’aspetto iconodidegrado, uno dei cicli pittorici più interessanti, tracui il Santo Cavaliere Teodoro, la già citata chiesa diSan Biagio a San Vito dei Normanni (BR), la chiesarupestre di San Pietro e di Santa Margherita a Mottola(TA) e la chiesa di San Giorgio a Laterza (TA).Nella chiesa dei Santi Andrea e Procopio aMonopoli (BA), la cui fondazione può essere inseritanel contesto politico e militare greco-normanno allametà <strong>del</strong>l’XI secolo, è affrescata sulle pareti <strong>del</strong> nàos lafigura di San Giorgio (purtroppo non in buone condizioni).Egli è rappresentato in assetto da battaglia, su diun cavallo bianco con un drappo chiaro, impugna un’astacon la quale colpisce il drago in basso al riquadro.Non indossa l’abito militare bizantino, secondo l’iconografiaoriginale, ma un abito militare all’occidentale,impreziosito con <strong>del</strong>le croci sullo scudo e sul drappo.È presumibile, dunque, che la committenza <strong>del</strong>l’operafosse legata in qualche modo alle crociate. Non ècasuale, inoltre, la dedica <strong>del</strong>la chiesa a Sant’Andrea,Santo taumaturgo, e a San Procopio, Santo militare,che sia per le loro vicende personali e per il culto natoin Oriente sia per i rapporti politici, religiosi e artisticitra la Puglia e l’area greco-bizantina sono legati alla tradizioneagiografica latina e bizantina.Un altro importante ciclo pittorico, risalente all’XIsecolo, poi aggiornato nel XIII, in cui è raffigurato SanGiorgio a cavallo accanto ad un Santo Vescovo (forseSan Nicola), è presente nella chiesa rupestre di SanPietro a Mottola (TA) 25 . Nelle 12 arcate cieche con ghieracaratterizzanti le pareti laterali (con didascalie scrittein due lingue, greco e latino, che farebbero ipotizzare lapresenza di un pittore greco o locale, appartenentecomunque ad un gruppo misto), i Santi rappresentatiFig. 19 - Mottola (TA), interno <strong>del</strong>la chiesa rupestre di San Nicola. Particolare primaarcata a sinistra.- 122 -
MARIO MOLESgrafico, anche se più esposto a degrado.Le figure principali sono effigiate inposizione centrale e sono caratterizzateda uno stile piatto, con figure frontalisenza movimento, ma molto espressive,soprattutto per la resa dei grandi occhi(come evidente anche negli affreschi diSan Pietro a Corte); la fronte è alta, lelabbra sono sottili e il naso è reso conuna linea verticale o lievemente curva.Molti dipinti murali raffigurano soprattuttoSanti, anche nelle nicchie o suipilastri (lo stesso Santo può essereriprodotto più volte nella cripta comenella Chiesa di San Giorgio, qui diseguito analizzata), la Dèesis e il CristoPantocrator. I colori predominanti per gliindumenti sono il rosso, il giallo, l’azzurroe il verde scuro.La chiesa di San Giorgio sorge nellacontrada Verdazzi a Laterza (TA). Lacripta si presenta come un’unica aularettangolare con due sedili posti longitudinalmentealle due pareti laterali econ il soffitto a schiena d’asino. Degnidi nota sono gli affreschi <strong>del</strong>l’abside e<strong>del</strong>la parete laterale destra, databili tra ilXIII ed il XV secolo. Sulla parete difondo in una nicchia a pianta rettangolareè affrescato San Giorgio, vestitocome un cavaliere medievale con unacorta cotta a maglia metallica ed unmantello, con uno scudo ed una lungalancia con cui trafigge un drago serpentiformee squamato (fig. 22). Sullaparete destra è raffigurato in un ditticodi nuovo San Giorgio che, trafiggendoil drago, salva sia la principessaElisabea sia il popolo da esso minacciati.San Giorgio porta capelli corti ebiondi circondati da un’aureola. Ilsecondo affresco <strong>del</strong> dittico rappresentauna Madonna in trono con ilBambino che tende le braccia versouna piccola figura di orante. Nellacalotta absidale, rinvenuta in seguitoallo svuotamento, è rappresentata unaDèesis.Fig. 20 - Mottola (TA), interno <strong>del</strong>la chiesarupestre di San Nicola. Particolare primaarcata di destra: San Giorgio.Fig. 22 - Laterza (TA), Contrada Verdazzi. Chiesa di San Giorgio.Fig. 24 - Itinerari <strong>del</strong>le Crociate.Fig.21 - Mottola (TA), interno <strong>del</strong>la chiesa rupestre di San Nicola.Madonna con Bambino tra S. Basilio e S. Nicola.Fig. 23 - Faggiano (TA), Cripta diSan Nicola.San Giorgio (fine XIII-inizio XIVsec.), (Pinacoteca Provinciale diBari).- 123 -
SALTERNUMNella Pinacoteca provinciale diBari è presente un affresco di SanGiorgio (fine sec. XIII - inizi sec.XIV) con un altro Santo Cavaliere,San Teodoro, ambedue provenientidalla cripta di San Nicola, pressoFaggiano (TA). San Giorgio (comesi legge dalla scritta frammentariain alto a destra) è raffigurato conun volto imberbe e rotondeggiante,con indosso un’armatura ed unacorta tunichetta verde con stola rossa, su di un cavallobianco, di cui trattiene le briglie con la mano sinistrae con la destra trafigge un drago steso ai suoi piedi(fig. 23).Il culto di San Giorgio era inoltre molto vivo, già apartire dall’XI secolo, anche lungo un altro itinerariopercorso dai Crociati (fig. 24) che toccava la città diReggio Calabria. Nel 1086, infatti, il duca normannoRuggero Borsa inflisse una sconfitta ai Saraceni cheinsidiavano le coste calabresi contrattaccando ed inseguendoil saraceno Bonavert, uccidendolo in battagliae conquistando Siracusa. Per questa vittoria i Regginiadottarono San Giorgio a loro protettore che, secondola leggenda, avrebbe assistito Ruggero controBonavert 26 . L’antica devozione <strong>del</strong>la città a SanGiorgio è testimoniata anche dalle numerose chieseche al Santo furono dedicate, tra cui San Giorgio diLagonia, San Giorgio intra moenia o San Giorgio diSartiano in La Judeca e San Giorgio extra moenia, andatepurtroppo distrutte nel terremoto <strong>del</strong> 1908 27 .Anche in Sicilia con la conquista da parte deiNormanni si diffusero nelle chiese rurali 28 cultiappartenenti alla cerchia devozionale normanna elegati all’ideologia monarchica e militare crociata,come i Santi guerrieri a cavallo (Giorgio, Teodoro eDemetrio), raffigurati ad esempio nella chiesa deiSanti di Cava d’Ispica a Modica (RG), disposti a coppiein un unico pannello all’ingresso <strong>del</strong>la chiesa. Ilciclo è databile all’inizio <strong>del</strong>la conquista normanna etestimonia la spiritualità orientale diffusa in Siciliaall’inizio <strong>del</strong> XII secolo. Tra i vari Santi, di cui spessosono visibili solo frammenti, sono riconoscibiliuna coppia di Santi (San Giorgio e San Teodoro?),San Nicola, la Vergine Theotόkos in trono, San Pietro,Santa Ciriaca e San Marco; lungo la parete destra unSan Giacomo, Santa Caterina d’Alessandria, una coppiadi Santi Cavalieri.Fig. 25 - Maiori (SA), Santa Maria de’ Olearia.Un radicale rinnovamento <strong>del</strong>ladecorazione parietale è nell’abside<strong>del</strong>la Grotta di San Nicola aModica (RG). La prima serie dipannelli iconici risalenti ad una culturagreca (sec.XII) fu ricoperta daaffreschi più grandi con didascalialatina da parte di un maestro chenel XIII sec. era ancora legato adun linguaggio iconografico tradizionale.Nel catino absidale è ilPantocrator nella Mandorla tra angeli, fiancheggiatodalla Madonna e dall’Arcangelo Michele. Spesso i pannelli,distanziati tra loro, risentono di un repertorioiconografico con soggetti tradizionali, legati alla religiositàpopolare, come il culto mariano e Santi locali,ma accanto ad essi sono spesso raffigurati Santiimportati in età normanna, come San Nicola, SanGiorgio, Santa Lucia, San Bartolomeo, Santo Stefano,Santi Anargiri.Nella Grotta <strong>del</strong> Crocifisso di Lentini (SR) si nota,inoltre, una rilevante stratificazione pittorica (tre strati),che appartengono a 5 fasi distinte <strong>del</strong>la decorazione.La prima fase (sec. XIII) vede il Pantocrator absidale,una Mater Domini, un San Giovanni Battista. Alcunipannelli <strong>del</strong>la prima fase vennero coperti da figure diSanti Cavalieri, San Calogero e un Santo diacono; nellaparete divisoria si collocarono 5 pannelli collegati alculto di San Leonardo (introdotto nel lentinese daiCavalieri Templari). In un pannello è visibile anche unSanto Vescovo, forse San Nicola.Risalendo in Campania 29 , a circa 2 km da Maiori(SA), all’interno di una grotta naturale, troviamo ilcomplesso monumentale di Santa Maria de’ Olearia 30con tre luoghi di culto sovrapposti: la cripta, che risalead un’epoca più antica rispetto alle altre costruzioni,cioè al X-XI secolo, la cappella principale, sicuramentededicata alla Vergine, e la cappella superiore,dedicata a San Nicola, costruite entrambe agli inizi <strong>del</strong>XII secolo. Di grande interesse gli affreschi sulle paretie sulle volte, che rappresentano uno tra i più importantigruppi di dipinti murali risalenti al primoMedioevo in Campania. Nella cripta è possibile ammirarel’affresco raffigurante la ‘Vergine orante’, tra unSanto barbuto che indossa una tunica bianca con iclavi rossi (striscia di stoffa purpurea cucita alla tunica)ed un mantello giallo ed un Santo guerriero, probabilmenteSan Giorgio (fig. 25), ritratto secondo l’i-- 124 -
MARIO MOLESconografia bizantina a piedi e non a cavallo(analogamente a quanto presente nellachiesa rupestre di Faicchio - BN, di X-XIsec.) 31 , con tunica, cotta metallica (questa,però, apparentemente di stile occidentaleperché non presenta la caratteristica fatturalamellare, evidente nelle immaginisuccessive - figg. 26-27), mantello rosso,lancia e scudo.Gli armamenti tipici di un guerrierobizantino pesantemente armato si possonoammirare in un affresco orientale <strong>del</strong>XII sec. (fig. 27). Egli indossa un klivanionlamellare, con protezioni per le braccia,gli pteruges intorno alla vita, l’elmo allacciatoal collo con quella che sembra esserestoffa ed è armato con una lancia kontarioned una spathion a tracolla.Proseguendo per la costiera amalfitanaanche ad Atrani (SA), poco al di sopra<strong>del</strong>l’antica via pubblica che la collegavacon Amalfi, c’è una piccola cavità naturaleche presenta un perimetro rettangolareirregolare e pareti interamente affrescate.L’ingresso alla piccola grotta è contornatoda uno degli archi di sostegno di unantico canale idrico. Gli affreschi sono incattivo stato di conservazione e rappresentanofigure di Santi, da cui il nome di‘Grotta dei Santi’ attribuito al ritrovamento. Tra i Santiraffigurati è facile identificare i quattro Evangelisti eSan Giorgio, ritratto su fondo verde e con il bracciolevato a reggere l’asta. Il problema <strong>del</strong>la datazione diquesti affreschi resta insoluto, tuttavia è possibileaffermare che, pur nella loro modesta qualità, le pitturedi Atrani risentono <strong>del</strong>la tipica diffusione di unimpianto iconografico riconducibile all’inizio <strong>del</strong> XIIsecolo e gravitante nell’orbita <strong>del</strong>la cultura bizantina.Pur appartenendo allo stesso ambito artistico-culturale,a Salerno in San Pietro a Corte potrebbe esserestata affrescata una <strong>del</strong>le prime immagini di SanGiorgio (se è valida l’ipotesi <strong>del</strong> Santo Cavaliere) nonpiù come un miles bizantino, ma come un cavaliereoccidentale accanto ad un Santo taumaturgo, SanNicola, in quanto anche Salerno risente <strong>del</strong>la nuovatemperie artistico-culturale diffusasi con le Crociate.Dal punto di vista artistico, si nota, infatti, complessivamente,una nuova koiné, fatta di contaminazione fraFig. 26 - Monastero di Vatopedy-Grecia- San Giorgio (XI secolo).L'episodio <strong>del</strong>la sauromachia è <strong>del</strong> tuttoignoto all'iconografia bizantina ecomplementare, invece, alla simbologiadei Santi Cavalieri.Fig. 27 - Affresco bizantino <strong>del</strong> XIIsecolo di Joshua, il guerriero <strong>del</strong>la fede,con una spada dritta.linguaggi greco-bizantini ed occidentali,conseguente alle Crociate, un quadrod‘insieme variegato fra attività di monasteri,artisti greci immigrati o artisti latini,rientrati dall’Oriente al seguito di Ordinicavallereschi, ed in più artisti locali.Per quanto riguarda le novità occidentaliè da pensare, per molte opere, a sempliciinnovazioni, quali un accenno dinaturalismo reso dal rilievo, dal chiaroscuro,dal movimento limitato e, talvolta,dalle semplici cadenze <strong>del</strong> panneggio; ilmodo di benedire alla latina; un abbozzod’ambiente realizzato con archeggiaturesu esili colonne ospitanti le figure deiSanti, visti come se fossero dentro unportico; la decorazione dei nimbi conracemi vegetali o con rilievi a pastigliadorata o, infine, cornici che inquadranol’immagine <strong>del</strong> Santo e ne accolgono, avolte, storie agiografiche. È, inoltre, datener presente che il pantheon bizantino siamplia con l’immissione di Santi occidentalie con la creazione di nuove e menovincolate iconografie, non accompagnatepiù da didascalie greche. Subentra, persino,qualche aggiornamento al mondocontemporaneo, come per i SantiCavalieri che indossano cotta d’arme, lunghetuniche e portano stendardi e scudi a mandorlacrocesegnati che riproducono colori e divise degliordini cavallereschi.Le Crociate, infatti, portarono nuovi stimoli di culturaoccidentale, ma anche di eco orientale in tutto ilMeridione e, soprattutto, in Puglia, che disponeva discali con l’Oriente 32 . Ulteriori stimoli avvennero con lapenetrazione benedettina, volta al recupero <strong>del</strong>le popolazionigreco-ortodosse <strong>del</strong> Mezzogiorno alla Chiesa diRoma, in sintonia con i Normanni, mediatori di nuovefrontiere culturali dopo la conquista <strong>del</strong>la Sicilia.Nella fascia costiera <strong>del</strong>la Puglia, da Barletta adOtranto, l’impatto <strong>del</strong>le Crociate fu notevole: sicostruirono le case-madri dei più potenti ordini monastico-cavallereschi,dai Templari ai Giovanniti, aiTeutonici, con relative sedi ospitaliere e nuovi edificisimili nel titolo o nella tipologia al Santo Sepolcro diGerusalemme. Le chiese, inoltre, ospitarono tombe dicavalieri con la croce incisa sull’omero sinistro.- 125 -
SALTERNUML‘eco degli eventi crociati dovettedurante la prima crociata che essariflettersi dalle coste <strong>del</strong>l’Adriaticoriscosse la più vasta eco. A Salerno,fino all’entroterra. Se ne ha testimonianza,come già analizzato, negliprovenienti dalla Terrasanta e veni-infatti, sbarcavano i feriti più graviaffreschi rupestri, dove compaionovano affidati ai medici <strong>del</strong>la Scuola.Santi Cavalieri che trafiggono draghiSuccesse allora anche che moltio serpenti, simbolo <strong>del</strong> male, cheFig. 28 - Fossa (AQ), Santa Maria ad Cryptas. Affresconobili e potenti condottieri crociati,diventa, per estensione, simbolo degli (XIII sec., tra il 1264 e il 1283).rientrando in patria, vollero fermarsiinfe<strong>del</strong>i.a Salerno per curare i malanni contratti.Fra essi si ricordano Boemondo e Roberto diI Santi Cavalieri Giorgio, Teodoro, Demetrio,Mercurio, venerati nella liturgia greca, per un fenomeno Normandia.di sincretismo diventano, nel Meridione, paladini di una Alla luce, dunque, <strong>del</strong>le precedenti testimonianzeguerra latina. Si favoleggiava, infatti, che avessero guidatopiù volte alla vittoria i Crociati contro i Saraceni. La si potrebbe ipotizzare che, se il nostro cavaliere è Saniconografiche e <strong>del</strong>le considerazioni storico-culturali,fantasia popolare aveva, quindi, attribuito l’appellativo Giorgio, i due Santi, San Nicola, Santo taumaturgo, emiles Christi ai Crociati e, poiché nella gerarchia militare San Giorgio, Santo cavaliere, siano stati ritratti suil rango più nobile era riservato ai cavalieri, questi Santi committenza di nobili normanni, svevi o salernitani,erano diventati Cavalieri di Dio.in quanto Santi protettori di un ordine cavalleresco diMolte città <strong>del</strong> Meridione, fra cui anche Salerno, cui, forse, il committente era esponente, come adoffrono testimonianze dirette di una partecipazione agli esempio per un affresco nella Chiesa di Santa Maria adeventi di Terrasanta. Per la prima crociata <strong>del</strong> 1096 partì Cryptas presso Fossa (AQ), dove sono ritratti Sananche Boemondo, il figlio di Roberto il Guiscardo e Giorgio a cavallo nell’atto di trafiggere il drago e San<strong>del</strong>la prima moglie Alberada di Buonalbergo, che, col Maurizio, erroneamente ritenuto San Martino, semprenipote Tancredi, fu uno dei più valorosi cavalieri nel la a cavallo. I due Santi furono realizzati per volere <strong>del</strong>conquista <strong>del</strong>la Terrasanta. Boemondo, principe di committente, un cavaliere <strong>del</strong> cui ordine i due SantiTaranto, dopo «essere stato toccato con la spada nel erano riconosciuti protettori (fig. 28) 36 .Duomo di San Matteo, partì da Salerno con diecimila Il nostro affresco, dunque, sia per gli specifici codiciespressivi usati nei secoli XII/XIII sia per l’icono-cavalieri e ventimila fanti» 33 . A Salerno, inoltre, durantela visita di Papa Urbano II, «venne fondata una confraternita,che fu la più antica, denominata Confraternita di stata a partire dalla seconda metà <strong>del</strong>l’XI sec., sia pergrafia di San Giorgio e <strong>del</strong>la leggenda <strong>del</strong> drago, atte-S. Matteo che in seguito, nel 1097, fu denominata il contesto storico <strong>del</strong>le Crociate (XI-XIII sec.), legateConfraternita <strong>del</strong>la Crociata, a ricordo di quanti, prima di anche alla dominazione normanno-sveva, sia ancoraintraprendere il cammino che li avrebbe condotti in per le innovazioni apportate da quell’eco crociata, traTerrasanta, si recavano a pregare sulla tomba <strong>del</strong>l’apostoloS. Matteo per invocare la sua protezione. … Nel Santi cavalieri, potrebbe essere datato, alla fine <strong>del</strong> XIIcui l’accostamento frequente di Santi taumaturghi eDuomo di Salerno esiste ancora la Cappella <strong>del</strong>la Crociata, o, meglio, al XIII secolo. Nel corso <strong>del</strong> XIII secolo,dove furono benedette, durante la prima crociata, le infatti, la predilezione per i soggetti iconici porta aarmi di quanti, muovendo dalle nostre contee, ebbero riempire le pareti dei luoghi di culto di numerose figuredi Santi giustapposti a scopo spesso devozionale el’onore di partecipare a quella grande avventura» 34 .Molti cavalieri, poi, a cominciare da quelli più ce - senza un vero e proprio programma iconografico.lebri <strong>del</strong>la prima crociata, erano soliti rendere omaggio L’attenzione alla realtà <strong>del</strong> tempo non sovverte, però,a San Nicola 35 nella Basilica di Bari, prima di partire il sostrato iconico dominante, per cui ogni precisazioneper Costantinopoli e Gerusalemme.cronologica resta opinabile e, per una stessa opera, siTra l’XI e il XIII sec. la Scuola Medica Salernitana hanno non soltanto incertezze sulla datazione, ma ancheebbe, inoltre, il suo massimo splendore e fu proprio differenti opinioni sulle componenti culturali.- 126 -
MARIO MOLESNote1La cornice è ben visibile in AMAROTTA1982, Documentazione fotografica, fig. 18.2Cfr. il mantello di forma conica, arricchitoda ricami circolari e concentrici, in SanNicola dei Greci a Matera, dove San Nicola(sec. XIII-XIV) è raffigurato, sulla sinistra,in veste dalmatica e benedicente alla grecaaccanto a Santa Barbara (sec. XII-XIII),con ricche vesti imperiali e i canonici capelliramati, e a San Pantaleone (sec. XII-XIII),che regge un cofanetto con ampolle, simbolo<strong>del</strong>la sua professione di medico.3L’abbigliamento di San Nicola, vescovoorientale, viene spesso descritto utilizzandoi termini bizantini (cfr. infra, chiese rupestriin Puglia): phelonion (casula), sticharion (camice),omophorion (pallio).4La posizione <strong>del</strong>la mano destra, nellamaniera latina, vede il pollice e le dita indicee medio in posizione eretta e direzionataverso l’alto, mentre in quella greca vede pollicee anulare uniti sulle punte (il pollicecongiunto all’anulare), mentre indice,medio e mignolo rimanere dritti. Nel casogreco l’interpretazione è quella <strong>del</strong>la trinitàe <strong>del</strong> monogramma IC e XC, ovvero IesusCristos, in quello latino la spiegazione cheviene data rimanda all’epoca dei Romani edei loro Cesari. Quest’ultimi nel momentodi dare disposizioni usavano alzare la manoe porre le dita appunto come rappresentatonella maniera benedicente alla latina.5AMAROTTA 1982, documentazione fotografica,fig. 18.6MAURO 1988, documentazione fotografica,fig. 17.7Su San Nicola cfr. DEL RE 1967, eCIOFFARI 1997 a ; BACCI 2006; ID. 2009.8CIOFFARI 1997 b , p. 223.9ID. 1987.10OTRANTO 1987; ID. 2004.11I Normanni, nuovi signori di Bari, nelloro Paese, avevano familiarizzato anche colculto di San Michele grazie alla presenza <strong>del</strong>santuario di Mont Saint-Michel, concepito,secondo la tradizione, a imitazione e comefiliazione di quello garganico.12CIOFFARI 1997 b , pp. 235-267; BACCI 2006.13MAURO 1988, p. 56.14EAD. 2000, p. 39.15BRACA 2000, p. 194.16Cfr. MAURO 2000, p. 37.17CUOZZO 1989, pp. 24-40; cfr. anche ZUGTUCCI 1995, p. 143.18Raffigurazioni analoghe sono presentinelle Chiese europee <strong>del</strong>lo stesso secolo(Modena, Ferrara, Angoulème, Mozac,Moissac, Saint-Gilles) e nel celebre arazzodi Bayeux.19CUOZZO 1995, p. 34.20Su San Giorgio cfr. BALBONI - CELLETTI1965; BALBONI 1983; KAFTAL 1986; DE’GIOVANNI-CENTELLES2004; GIORDANO2005; ONETO 2009.21MALATERRA 2002. Accadde che, nell’anno1098, durante una <strong>del</strong>le più furiose battaglie,i cavalieri crociati e i condottieri inglesivennero soccorsi dai Genovesi i qualiribaltarono l’esito <strong>del</strong>lo scontro e consentironola presa <strong>del</strong>la città, ritenuta inespugnabile.Secondo la leggenda il martire si sarebbemostrato ai combattenti cristiani in unamiracolosa apparizione con un gruppo dicavalieri (tra cui San Mercurio e SanDemetrio) su cavalli bianchi, sventolantibandiere in cui campeggiavano croci rossein campo bianco. (NAPOLITANO 2004, p.79).22In Sicilia il culto di San Giorgio assumeparticolare rilievo e i centri più legati alculto <strong>del</strong> Santo sono quelli che si eranodistinti nella lotta contro i Saraceni e quelliche per la loro posizione costituivano unimportante caposaldo difensivo. Ciò convaliderebbel'ipotesi che il culto di SanGiorgio sia stato introdotto dal ConteRuggero dopo la conquista <strong>del</strong>l’Isola.23Per le Chiese rupestri in Puglia e Basilicatacfr. CHIONNA 1988; FALLA CASTELFRANCHI1991; DELL’AQUILA - MESSINA 1998;LAVERMICOCCA 2001.24Sull’iconografia dei Santi Cavalieri cfr.MILELLA 1996; EAD. 1997.25Sulle chiese rupestri in Puglia cfr.FONSECA 1970; GENTILE 1987; FALLACASTELFRANCHI 1991.26SPANÒ BOLANI et Alii 1957.27DE LORENZO 1903, pp. 32-33.28Sulle chiese rupestri in Sicilia cfr. CIANCIO1948; AGNELLO 1962; MESSINA 1979; DISTEFANO 1983; ID. 1986; MESSINA 1994.29Sulla pittura medievale in Campania cfr.BOLOGNA 1992; PACE 1994 a ; ID. 1994 b .30Sugli insediamenti rupestri <strong>del</strong>la costad’Amalfi cfr. CAFFARO 1986; BERGMAN -CERENZA 1994; BRACA 2003.31Su San Giorgio nella chiesa rupestre diFaicchio (BN) cfr. GERVASIO 2009.32Sugli effetti <strong>del</strong>le Crociate anche in campoartistico-culturale cfr. MUSCA 2002.33NAPOLITANO 2004, p. 53.34Ibidem, pp. 111-112.35Boemondo, già il 1º ottobre 1089, insiemead altri conti normanni e alla duchessaSichelgaita, partecipò a Bari alla cerimonia<strong>del</strong>la deposizione <strong>del</strong>le reliquie di S. Nicoladalla chiesetta di S. Stefano alla cripta <strong>del</strong>laBasilica appena eretta, alla presenza di papaUrbano II. La tradizione vuole cheBoemondo fondò, forse con il padre, neipressi di Otranto il Monastero di SanNicola di Casole, che ospitò uno degli scriptoriapiù importanti <strong>del</strong> Medioevo (suBoemondo e la I Crociata cfr. HIESTAND2002).36LATTANZI 2010, pp. 28-29.- 127 -
SALTERNUMBibliografiaAGNELLO G. 1962, Le arti figurative nellaSicilia bizantina, Palermo.AMAROTTA A. R. 1982, La cappella palatina diSalerno, Salerno.BACCI M. 2006, San Nicola. Splendori d'arted'Oriente e d'Occidente, catalogo <strong>del</strong>la mostra(Bari, Castello Svevo, 7 dicembre 2006 - 6maggio 2007), Milano.BACCI M. 2009, San Nicola il GrandeTaumaturgo, Roma-Bari.BALBONI D. - CELLETTI M. C. 1965, s.v.Giorgio, in Bibliotheca Sanctorum, IstitutoGiovanni XXIII <strong>del</strong>la Pontificia Universitàlateranense, Roma, IV, pp. 512-531.BALBONI D. 1983, San Giorgio: martire,Roma.BERGMAN R. P. - CERENZA A. 1994, MaioriS. Maria de Olearia. Guida alla visita <strong>del</strong>l’abbaziamedievale, Amalfi.BOLOGNA F. 1992, Momenti <strong>del</strong>la cultura figurativanella Campania Medievale, in Storia e civiltà<strong>del</strong>la Campania. Il Medioevo, Napoli, pp.171-275.BRACA A. 2000, La pittura e i mosaici medievalia Salerno, in Storia di Salerno, a cura di G.CACCIATORE - I. GALLO - A. PLACANICA, 1,Salerno.BRACA A. 2003, Le culture artistiche <strong>del</strong>Medioevo in Costa d’Amalfi, Amalfi.CAFFARO A. 1986, Insediamenti rupestri <strong>del</strong>Ducato di Amalfi, Salerno.CHIONNA A. 1988, Beni Culturali di San Vitodei Normanni, Fasano.CIANCIO S. 1948, Grotte <strong>del</strong> Crocifisso e artebizantina in Lentini, in ‘Traguardo azzurro’,II, pp. 102-107.CIOFFARI G. 1987, Cronache <strong>del</strong> fatto. La traslazione<strong>del</strong>le reliquie e la formazione <strong>del</strong>l’iconografia,in Il segno <strong>del</strong> culto: San Nicola: arte, iconografia ereligiosità popolare, a cura di N. LAVERMICOCCA- G. OTRANTO, Bari, pp. 29-44.CIOFFARI G. 1997 a , S. Nicola nelle immaginianteriori al Mille e nella pittura italiana medioevale,in ‘Nicolaus’, VIII, 8, Bari, pp. 321-360.CIOFFARI G. 1997 b , San Nicola di Bari,Torino.CUOZZO E. 1989, ‘Quei maledetti Normanni’.Cavalieri e organizzazione militare nelMezzogiorno normanno, Napoli.DE’GIOVANNI-CENTELLES G. 2004 (a curadi), San Giorgio e il Mediterraneo, in Atti <strong>del</strong> IIColloquio internazionale per il XVII Centenario(Roma, 28-30 novembre 2003), Città <strong>del</strong>Vaticano.DE LORENZO A. M. 1903, I ricordi reggini <strong>del</strong>culto di S.Giorgio Martire, Napoli.DEL RE N. 1967, s. v. Nicola, in BibliothecaSanctorum (Istituto Giovanni XXIII <strong>del</strong>laPontificia Università Lateranense), Roma,IX, pp. 924-927.DELL’AQUILA F. - MESSINA A. 1998, Le chieserupestri di Puglia e Basilicata, Bari.DI STEFANO G. 1983, Cava d’Ispica. Recentiscavi e scoperte, Modica.DI STEFANO G. 1986, Recenti indagini sugliinsediamenti rupestri <strong>del</strong>l’area ragusana, in LaSicilia rupestre nel contesto <strong>del</strong>le civiltà mediterrane,Atti <strong>del</strong> Sesto Convegno Internazionale diStudio sulla civiltà rupestre medioevale <strong>del</strong>Mezzogiorno d’Italia, 1981, a cura di C. D.FONSECA, Galatina, pp. 251-294.FALLA CASTELFRANCHI M. 1991, Pitturamonumentale bizantina in Puglia, Bari.FONSECA C. D. 1970, Civiltà rupestre in TerraJonica, Milano-Roma.- 128 -
MARIO MOLESGENTILE A. 1987, La chiesa rupestre di SanNicola in agro di Mottola, Mottola.GERVASIO F. L. 2009, Gli affreschi medievali<strong>del</strong>la Chiesa di San Giorgio a Faicchio, in Scrittiin onore di Francesco Abbate, a cura di L.GAETA, in ‘Kronos’, 13, Martina Franca(TA), pp. 131-138.HIESTAND R. 2002, Boemondo I e la primaCrociata, in MUSCA 2002, pp. 65-94.KAFTAL G. 1986, Iconography of the saints inCentral and South Italian schools of painting,Firenze.LATTANZI G. 2010, Chiesa di Santa Maria adCryptas a Fossa (Aq), in Abruzzo illustrato.Monografie, Teramo.LAVERMICOCCA N. 2001, I sentieri <strong>del</strong>le grottedipinte, Bari.MALATERRA G. 2002, Ruggero I e Roberto ilGuiscardo, Introduzione, traduzione e notedi V. LO CURTO, Cassino.MAURO D. 1988, Gli affreschi, in ‘RassegnaStorica Salernitana’, n.s. V/2, pp. 46-57.MAURO D. 2000, Il ciclo pittorico di S. Pietro aCorte, in San Pietro a Corte. Recupero di unamemoria nella città di Salerno, a cura <strong>del</strong><strong>Gruppo</strong> <strong>Archeologico</strong> <strong>Salernitano</strong>, Napoli,pp. 33-42.MESSINA A. 1979, Le chiese rupestri <strong>del</strong>Siracusano, Palermo.MESSINA A. 1994, Le chiese rupestri <strong>del</strong> Val diNoto, Palermo.MILELLA M. 1996, Exercitus Dei. Appuntisull’iconografia dei Santi militari negli affreschipugliesi di età medioevale, in Studi in onore diMichele D’Elia, a cura di C. GELAO, Matera,pp. 140-147.MILELLA M. 1997, I cavalieri di Dio. Iconografiadei Santi cavalieri negli affreschi pugliesi in LeCrociate, Catalogo <strong>del</strong>la mostra a cura di M.REY DELQUÉ, Milano, pp. 214-218.MUSCA G. (a cura di) 2002, Il Mezzogiornonormanno-svevo e le crociate. Atti <strong>del</strong>le 14 eGiornate normanno-sveve, Bari.NAPOLITANO G. 2004, Salerno e l’ordine equestre<strong>del</strong> santo sepolcro di Gerusalemme, Salerno.ONETO G. 2009, Il santo uccisor <strong>del</strong> drago. SanGiorgio patrono <strong>del</strong>la libertà, Rimini.OTRANTO G. 1987, San Nicola e Bari, in SanNicola di Bari e la sua Basilica. Culto, arte, tradizione,a cura di G. OTRANTO, Milano, pp. 61-71.OTRANTO G. 2004, S. Nicola conteso: santuari epellegrinaggi nel vissuto cristiano, in Profili giuridici estoria dei santuari cristiani in Italia. Atti <strong>del</strong> IXConvegno di Studi, Il censimento dei santuari tradinamiche istituzionali e devozione popolare (Bari, 3-4 aprile 2003), a cura di G. DAMMACCO - G.OTRANTO, Bari, pp. 111-125.PACE V. 1994 a , La pittura medievale in Campania,in La pittura in Italia. L’Altomedioevo, a cura diC. BERTELLI, Milano, pp. 243-260.PACE V. 1994 b , La pittura rupestre in Italia meridionale,in La pittura in Italia. L’Altomedioevo, acura di C. BERTELLI, Milano, pp. 403-415.SPANÒ BOLANI D. - GUARNA LOGOTETA C.- DE GIORGIO D. 1957, Storia di ReggioCalabria, Reggio Calabria.ZUG TUCCI H. 1995, Armi e armature, inStrumenti, tempi e luoghi di comunicazione nelMezzogiorno normanno-svevo, a cura di G.MUSCA - V. SIVO, Bari, pp. 131-151.- 129 -
AURELIA DANIELA RANA - CLAUDIO ARMENISELa Chiesa di San Matteo in BisceglieLe origini normanne di Bisceglie e <strong>del</strong>la chiesa di San MatteoLa storia <strong>del</strong> Mezzogiorno d’Italia è legatainscindibilmente alla presenza <strong>del</strong>la popolazionenormanna che, a partire dal IX secolo,intraprende la propria memorabile discesa dallaNormandia producendo esiti dalle mille sfumature.Prima di tutto il dato che si registra nel Sud Italia,durante l’epoca medievale, è quello di una inevitabile,quanto mai palese, maggiorazione dei dati demografici,specie se si considera che le prime genti protagonistedi tale spostamento funsero da reale traino umanoper gli altri che rimasero nella nazione natia; a ciò siappaia uno stravolgimento <strong>del</strong> modus politico e socialecon cui sino ad allora si era gestito il territorio.Esistono, tuttavia, <strong>del</strong>le questioni che si sonodimostrate essere decisive per l’avvio di questo movimentomigratorio dal Nord al Sud Europa.In Normandia, difatti, era un costume tutto giovanile,o meglio un modus facendi esclusivo di quei giovaniappartenenti al ceto cavalleresco 1 , quello di costituiremilizie armate e di ardire viaggi anche molto lunghiverso destinazioni che reputavano essere idonee a sfidarela fortuna. Si lasciavano così alle spalle quel ducatodi Normandia che fu costituito già nel X secolo dagente originaria <strong>del</strong>la Scandinavia e che divenne palcoscenicodi lotte intestine, sino a quando giunse a ricoprirela carica di duca Guglielmo, detto Il Conquistatore,il quale riuscì, con la sua politica, a stabilire un climadi pacifica convivenza a cui seguì, da parte di molti,l’abbandono <strong>del</strong>le terre di cui egli era divenuto il direttoresponsabile.Tra le altre cause scatenanti di questo flusso migratorionormanno vi è certamente una accentuata irresolutezzanella gestione <strong>del</strong> tessuto politico <strong>del</strong> territorio<strong>del</strong> Mezzogiorno d’Italia, in particolar modo aseguito <strong>del</strong>le guerre che videro schierarsi Longobardie Napoletani tra il VI e XI secolo. Questo clima di tentennamentonella stabilità politica si presentò come lagiusta chiave di volta perché i Normanni potesserocominciare ad instillare nella mente <strong>del</strong>le genti da conquistarel’idea di una nuova esigenza dominatrice, un’ideache logorò lentamente quell’egemonia longobardache vide a poco a poco sfaldarsi e poi svanire il poteresino ad allora creato.Si aggiunga a questa lacerazione anche una nuovatendenza di sussistenza familiare che iniziò a condizionarel’aristocrazia, ossia quella <strong>del</strong>la primogenitura 2 .Attraverso tale nuova metodologia di gestione, ipadri di famiglia erano legittimati ad offrire sostentamentosolo ai primogeniti potendo, d’altro canto, trascurarei restanti figli che, invece, erano molto spessocostretti a spostarsi anche in zone geograficamenteremote per poter sperare in un futuro più fecondo.Lo stesso Tancredi d’Altavilla ebbe in totale dodicifigli ai quali. alla sua morte, sarebbe stato impossibilepoter garantire un medesimo trattamento in termini disuccessione; pertanto due di questi, Roberto ilGuiscardo e Ruggero, emigrarono in Italia.Tutti coloro i quali, a causa <strong>del</strong>la primogenitura,abbandonavano la casa paterna, andavano incontro adun futuro da mercenari che avrebbe successivamenteconsentito loro di poter intraprendere campagne diguerra e, nella maggior parte dei casi, avere a disposizioneuna quantità tale di pecunia da poter investire nell’acquistodi terre. La fortuna normanna in Italia meridionalesarebbe poi culminata nel momento <strong>del</strong> matrimoniocon una donna di ceto nobile, un connubio, questo,dal duplice risvolto: un legame sociale, ma anche esoprattutto un legame politico-economico a tutti glieffetti, poiché il giovane normanno, exmercenario,diventa parte integrante di una famiglia principescalocale.Per ciò che concerne il territorio pugliese, nonbisogna prescindere da una nozione storica rilevante,ossia che il ducato di Puglia era costituito dalla Puglia- 131 -
SALTERNUMbizantina, con il Ducato di Benevento eSalerno. In questo territorio l’egemonianormanna riuscì a trovare il giusto appiglioattraverso piccole signorie sparse intutto il territorio. Un esempio di come l’unionetra le famiglie locali e quelle di originenormanna portasse ad esiti quanto mailongevi nella storia <strong>del</strong>le stesse nelle zoneconquistate, è il matrimonio tra Roberto ilGuiscardo e la principessa longobarda diSalerno Sichelgaita, dopo che questi ebbesposato una normanna di nome Alberada.Fig. 1 - Bisceglie, Torre Maestra inuna foto storica.L’arrivo dei Normanni nel Mezzogiornorappresentò un momento di manifesto confronto<strong>del</strong>le piccole realtà campestri che vivacizzavano ilterritorio con un potere che, senza dubbio, dovette presentarsicome un baluardo di potenza militare e politicaallo stesso tempo, da sfruttare per difendersi dalle scorreriesaracene che allora depredavano i piccoli villaggi.Questo è quello che accadde anche nel territorio diVigiliae, nome originario <strong>del</strong>la odierna Bisceglie, cittàcostiera pugliese, sita a Nord di Bari.Gli abitanti vivevano disseminati in villaggi ruralidi modeste dimensioni, meglio conosciuti come casali3 , da cui il loro nome casalini, che avevano una strutturaarchitettonica articolata in maniera tale da garantirealla comunità un multifunzionalità e una particolareautosufficienza.Difatti ogni casale era costituito da una chiesa, dadepositi per le derrate alimentari, granai e cisterne perla raccolta <strong>del</strong>l’acqua piovana, il tutto racchiuso entroesili mura che costituivano un recinto difensivo. Ilpunto di forza di ogni casale restava comunque latorre di vedetta, che poteva presentarsi o come parteintegrante <strong>del</strong>le mura o sorgere a distanza da queste.L’impulso grazie al quale i Normanni si spinserosino a Bisceglie è riconducibile alla loro brama diappropriarsi <strong>del</strong>la vicina contea di Trani, che venneassegnata, nel 1042 4 , a Pietro I di Amico, detto‘Pietrone’.Tuttavia Trani, allora la città più importante <strong>del</strong>laregione, era ancora in mano ai Bizantini, per cui perpoter giungere a conquistarla i nuovi signori misero inopera la tecnica <strong>del</strong>l’accerchiamento, che avrebbestretto in una morsa sempre più soffocante la cittàbersaglio; fu proprio in questo modo, dunque, che iNormanni giunsero a Barletta, Andria, Corato eBisceglie.In quest’ultima si stabilirono intorno al1046 5 , fondando come loro presidio militareuna torre dalle dimensioni colossali(fig. 1), come dovette sembrare anche aquei casalini che, invece, erano abituati alledimensioni certamente più discrete <strong>del</strong>leloro torri.Il donjon normanno 6 è infatti, ancoraoggi, una presenza colossale all’interno deimonumenti storici <strong>del</strong> territorio biscegliese:svetta severo e imponente in prossimitàdi quella che all’epoca doveva essere latorre di vedetta <strong>del</strong> casale di Vigiliae, orainvece parte primaria <strong>del</strong>le fondamentaed esempio <strong>del</strong> tipico reimpiego di<strong>del</strong>la Cattedrale 7materiale costruttivo. All’innalzamento <strong>del</strong>la torre seguìla costruzione, a poche decine di metri da questa, di unacinta muraria 8 , oggetto di varie ricostruzioni ed ampliamentiin epoca angioina, aragonese e vicereale, entro laquale si stabilì la nuova civitas biscegliese; insommaandava definendosi una nuova città fortificata 9 .Certamente anche gli stessi casalini dovettero rimanereimpressionati dalle monumentali dimensioni diquesta torre che, solo per le dimensioni, poteva fungereda deterrente per eventuali attacchi nemici, e sepperoleggere dietro quella massiccia struttura architettonicala presenza di una nuova forza politica alla qualesarebbe stato più conveniente affidarsi, piuttosto checontrapporsi.Fu di fatto una scelta ponderata e saggia quella checondusse gli stessi a spostarsi dalle campagne, dovecontinuamente potevano essere preda facile per lescorrerie barbare frequenti durante l’epoca medievale,in prossimità <strong>del</strong> donjon dove, di contro, confidavanonella possibilità di poter trovare rifugio e protezionedopo aver prestato fe<strong>del</strong>tà ai nuovi arrivati.L’inurbamento dei casalini portò, dunque, all’ampliamento<strong>del</strong> tessuto urbanistico attorno alla torre maestrae stimolò la costituzione di nuovi luoghi di culto attornoai quali aggregarsi, alcuni dei quali vennero intitolatia santi pertinenti alla tradizione religiosa normanna.È possibile ascrivere all’interno di questo circuitocostruttivo luoghi di culto come la Cattedrale (1073),(fig. 2), Sant’Adoeno 10 , in origine Saint Ouen (1074) 11 ,S. Matteo (1080) e S. Nicola (1090) 12 , mentre altri studia riguardo rendono noto che nell’aprile <strong>del</strong> 1099, ilvescovo Stefano concede la chiesa di San Matteo aoltre 100 persone originarie dei casali di Giano e- 132 -
AURELIA DANIELA RANA - CLAUDIO ARMENISESagina, mentre nel 1100 la chiesa di S. Nicola vieneconcessa agli abitanti dei casali di S. Nicola eSalandro 13 .Tuttavia, se è pur vero che la nascita di queste chieseè strettamente riconducibile all’atto di conversionedei Normanni 14 , atto strategico per poter trovare il placetper le loro spedizioni da parte <strong>del</strong> papa, non è menoplausibile l’idea che almeno una di queste chiese sipossa ricollegare ad altri luoghi di culto di matriceperò aulica.Si tratta nello specifico <strong>del</strong>la chiesa di San Matteo,la cui intitolazione la pone in relazione con la cattedraledi Salerno (fig. 3).Nella città campana la presenza normanna risultaessere originariamente casuale: la Cronaca di Amato diMontecassino 15 narra che i Normanni si erano giàdistinti nell’anno 999 in una campagna di difesa diSalerno contro un’invasione musulmana, mentre tornavanoda una visita al Santo Sepolcro.Solo dieci anni dopo questo avvenimento i Principilongobardi, che erano rimasti ammaliati dal vigoremilitare di quei pellegrini, avviarono la consuetudine 16di assoldare dei mercenari normanni.Dell’originario nucleo architettonico <strong>del</strong>la chiesabiscegliese si trovano alcune descrizioni all’interno<strong>del</strong>le visite pastorali effettuate dal vescovo AlessandroCospi tra il 1584 e 1595.Edificata verso la fine <strong>del</strong>l’XI secolo, come giàanticipato, la chiesa sorge nella piazza omonima, tra ivicoli sottili e le vetuste case medievali <strong>del</strong> centro storico,a pochi passi dalle Cattedrale.Rientra in quello straordinario piano urbanisticoche vide, dopo l’arrivo e l’insediamento dei Normanninella città e nei dintorni di essa, nell’ambito di unpreordinato piano di conquista <strong>del</strong> territorio pugliese,il costante e fecondo inurbarsi <strong>del</strong>le genti dei casalilimitrofi per sottrarsi agli attacchi che interessavano lecampagne, il tutto accompagnato da un rinnovato fervoreartistico ed architettonico al tempo stesso.È ben noto quel momento storico preciso nelquale, secondo quanto stabilito in un convegno tenutosinel 1042 a Melfi 17 , i dodici più valorosi maggiorentinormanni, riunendosi, stabilirono strategicamenteun piano di conquista <strong>del</strong>la regione, le suddivisioni diterritori da assoggettare e le concessioni di terre daelargire ai capitani.Trani, eretta contea, era, come detto, ancora controllatada presidi bizantini ma, allo stesso tempo, fuassegnata in feudo al potente Pietro, figlio di Amico,consanguineo degli Hauteville, il quale, dopo averlaattaccata, ma non espugnata, si concentrerà, come giàanticipato, nella fortificazione di villaggi già esistenti enella fondazione di altri ex novo 18 .Correva l’anno <strong>del</strong> Signore 1046, data di fondazione<strong>del</strong> locus di Bisceglie, quando, probabilmente, PietroI diede inizio alla costruzione <strong>del</strong> primo nucleo dimura 19 . Alla sua morte, avvenuta forse nel 1063 20 , è ilFig. 2 - Bisceglie, Chiesa di S. Matteo. Facciata.Fig. 3 - Salerno, Duomo di San Matteo.- 133 -
SALTERNUMsuo secondogenito Goffredo a reggere il feudo, e probabilmentedurante il suo dominio si costruì la chiesadi S. Adoeno, terminata, però, nel 1074, quandoBisceglie e l’intera contea passarono al fratello PietroII, presumibile fondatore <strong>del</strong>la cattedrale, iniziata apartire dal 1073 21 .Scarse sono le notizie riguardanti la fondazione<strong>del</strong>la chiesa di S. Matteo, ma possiamo farla risalire agliinizi <strong>del</strong> nono decennio <strong>del</strong> Mille, quando, già morto ilGuiscardo nel 1085, il ducato di Puglia apparteneva aRuggero Borsa, nato dalle seconde nozze con la principessadi Salerno, la longobarda Sichelgaita, a scapito<strong>del</strong> primo figlio Boemondo.È la stessa dedicazione <strong>del</strong>la chiesetta biscegliese aSan Matteo, a connotarla come una eco <strong>del</strong>laCattedrale di Salerno, dedicata anch’essa al medesimoApostolo, tra l’altro patrono <strong>del</strong>la città campana.Quest’ultima venne però fondata per volere diRoberto il Guiscardo dopo la conquista di Salerno nel1076 e, quindi, contrariamente alla forte riconducibilità<strong>del</strong>la nascita <strong>del</strong>la chiesa biscegliese alle vicende deicasalini, essa sembrerebbe avere, invece, un’ascendenzapiù aulica in quanto associabile alla famiglia degliHauteville.A. D. Rana- 134 -
AURELIA DANIELA RANA - CLAUDIO ARMENISENote1MARTIN 1999, p. 10.2ID., Ibidem, p. 10.3LA NOTTE 1991.4COSMAI 2003, p. 33.5ID., Ibidem.6Secondo il Chronicon Vulturense, prima <strong>del</strong>l’arrivodei Normanni in Puglia, questaregione poteva contare solo rarissimi esempidi castelli, a dispetto, invece, di un nutritonumero di masserie e chiese rurali. Conl’arrivo di Roberto il Guiscardo iniziò adimporsi quella moda secondo la quale ognicittà da lui espugnata doveva essere protettada torri e castelli. Ma il primo passo versoquesto nuovo assetto costruttivo fu quellodi costruire torri isolate, come esplicitano icasi dei donjon di Bisceglie e Rutigliano.Questo tipo di torri vengono definite donjonpatri, ossia torri che si ergono su una basepiramidale (WILLEMSEN - ODENTHAL 1966,p. 54).7Andando a visitare la cripta <strong>del</strong>laCattedrale è possibile leggere nella conformazione<strong>del</strong>le murature interne una sporgenzache, a tutti gli effetti, può esserericondotta ad una antica torre <strong>del</strong> casaleVigiliae.8Furono certamente i Normanni, con lacostruzione di mura, torri e castelli, i precursoridi una nuova abilità costruttiva che,a partire da Roberto il Guiscardo, poi conre Ruggero II, culminerà nell’architetturafedericiana (HAESELOFF 1992, p. 14).9LICINIO 1994.10Non è questa l’unica chiesa in Italia adessere stata dedicata al Santo straniero.L’altra prova è la chiesa di S. Eudeno, situataad Aversa, uno tra i primi centri normannicreati in Italia meridionale. Questa intitolazioneè un’altra mutazione <strong>del</strong> nome di unSanto che doveva sembrare strano da pronunciarsiper quegli abitanti <strong>del</strong> Meridioneche adattavano i nomi stranieri alla manieraper loro più facile da pronunciare (GALLO1938).11Come sostiene M. Pasquale, a questaAbbazia sarebbe riferito il più antico documentosino ad oggi studiato inerente la cittàdi Bisceglie, che riporta come data di stesurail 21 gennaio 1074. Si tratta di una concessionedi privilegi all’Abbazia di SaintOuen, che in quell’anno risulta essere completata(PASQUALE 1996, p. 65).12TODISCO - LAGANARA - TOCCI 1985, p. 16.13COSMAI 2003, p. 38.14A Rouen, nel 912, il capo normannoRollone si convertì al Cristianesimo e ricevetteil battesimo (PASQUALE 1996, p. 70).15 DE BARTHOLOMEIS 1935.16Nel 1010 truppe normanne furono richiamatedal principe di Capua, dagli abati diMontecassino e di San Vincenzo alVolturno; nel 1017 furono assoldati daMelo da Bari contro i Bizantini; nel 1030 ilduca di Napoli stabilì un presidio normannonella città appena fondata di Aversa(MARTIN 1999, p. 9).17Per nozioni più dettagliate in merito allastoria dei Normanni in Puglia cfr. MUSCA1979, pp. 237-255.18Si pensi, per esempio, che l’odierna cittàdi Barletta, fiorente in età classica, fu riedificatada Pietro I, mentre, nel caso diBisceglie (sulla costa), Andria e Corato (nell’entroterra),egli procedette ad una operazionedi fondazione di nuovi borghi fortificati.19Durante i recenti lavori di manutenzione<strong>del</strong>le condutture idriche e fognarie, tenutisinelle zone limitrofe al donjon, in particolarein via Cristoforo Colombo, si sono scopertii camminamenti <strong>del</strong>le vecchie mura normanne,di esse è stata lasciata traccia, dopola risistemazione <strong>del</strong>la pavimentazione stradale,attraverso una tecnica di diversa disposizionee colorazione <strong>del</strong>le cianche proprioin corrispondenza <strong>del</strong>le antiche mura e pertutto il tragitto in cui esse sono state ritrovate.20COSMAI 2003, p. 39.21ID., Ibidem, p. 37.- 135 -
SALTERNUMBibliografiaDE BARTHOLOMEIS V. 1935, Storia de’Normanni di Amato di Montecassino, Roma.COSMAI M. 2003, Bisceglie nella storia e nell’arte.Vita di un comune pugliese, Bisceglie.GALLO A. 1938, Aversa Normanna, Napoli.HAESELOFF A. 1992, Architettura svevanell’Italia meridionale, Bari.LA NOTTE G. 1991, Bisceglie. Insediamenti culturali,Bari.LICINIO R. 1994, Castelli medievali. Puglia eBasilicata: dai Normanni a Federico II e Carlo Id’Angiò, Bari.MARTIN J. - M. 1999, Perché i Normanninell’Italia meridionale?, in Normanni <strong>del</strong> Sud.Salerno- Bari 999-1999, Bari, pp. 9-13.MUSCA G. 1979, Storia <strong>del</strong>la Puglia, vol. I,Bari.PASQUALE M. 1996, Note sulla scultura romanicanell’Abbazia di S. Adoeno in Bisceglie, in‘Studi Bitontini’, 61, pp. 65-91.TODISCO L. - LAGANARA C. - TOCCI M.1985, Bisceglie vecchia, Fasano.WILLEMSEN C. A. – ODENTHAL D. 1966,Puglia. Terra dei Normanni e degli Svevi, Bari.- 136 -
AURELIA DANIELA RANA - CLAUDIO ARMENISEL’impianto architettonico: ipotesi di ricostruzionePer come si presenta oggi, la chiesa di SanMatteo in Bisceglie non evoca nella mentedi chi la guarda la sua forma originaria. Perimmaginarla nella sua primitiva conformazioneoccorre ‘spogliarla’ <strong>del</strong>la costruzione addossata allafacciata principale, in cui è situato il portale d’ingresso<strong>del</strong>l’edificio sacro. Compiuta questa operazione ‘virtuale’l’edificio presenta forme tipicamente romaniche,con un assetto semplice, sobrio nelle forme, contipica copertura a capanna che definisce la facciata acuspide; una conformazione, questa, tutt’ora visibile.Dell’abside romanica, che probabilmente definivail vano presbiteriale, non è rimasta traccia, tuttavia, seprendiamo in considerazione la possibilità che un’absidecentrale dovesse esserci, rimane critico stabilire seessa potesse avere un estradosso chiaramente esplicito,oppure se questo potesse essere mascherato da unacompagine muraria rettilinea che ne obliterasse la suaconvessità, come nel caso <strong>del</strong>le vicine Concattedrale diS. Pietro e chiesa di S. Adoeno, o come altri esempiriscontrabili nell’intero territorio pugliese, secondo unmagistero costruttivo ben consolidato. Attualmente,all’interno <strong>del</strong>la chiesetta, come già anticipato, non sitrova alcuna traccia di questa presumibile conformazionestrutturale, bensì vi è una parete rettilinea ove sierge un maestoso altare maggiore.Tornando al vestibolo ‘architettonicamente introduttivo’,esso appare come una sorta di preambolo<strong>del</strong>la chiesetta, un elemento che richiama alla menteforme sintetiche a partire dalla cuspide collocata alculmine <strong>del</strong> settore centrale, dove si trovano il portaleprincipale ed un timpano semicircolare, per giungereai settori laterali con spioventi. Questo avancorpo,probabilmente risalente all’Ottocento, oblitera lasuperficie <strong>del</strong>la facciata, ricostruita insieme all’interoedificio sacro attorno al 1628, a seguito di un incendiodivampatovi all’interno all’inizio <strong>del</strong> ‘600 1 .L’intervento condotto sulla struttura, per ripristinarlaall’uso, tese a risanare le fratture derivanti da questoepisodio, ma, allo stesso modo, ne ha cancellato latraccia medievale. Di quell’epoca rimane, però, unafinestrella gnomonica visibile in controfacciata, lasciatain evidenza nella fase di ristrutturazione per rispetto<strong>del</strong> passato; come una stretta feritoia si inseriscenell’apparecchiatura muraria ed è posta decentratarispetto all’asse <strong>del</strong> portale. La sua collocazione non ècasuale poiché avrebbe dovuto sfruttare, secondo leconsuetudini <strong>del</strong>l’epoca, la luce <strong>del</strong> sole che direttamenteavrebbe illuminato l’interno, forse l’altare, nelgiorno <strong>del</strong> santo Matteo, coincidente con il periodoequinoziale. L’esterno si presenta con forme semplicied essenziali, una scatola rettangolare che termina sullato est, quello <strong>del</strong> coro, con un muro rettilineo chechiude una massa volumetrica non dinamica: è il solopronao a dare, con estremo nitore, lo scatto verso unatensione di movimento bloccato; le superfici esternesono impreziosite agli angoli da maschere scultoree,forse antiche tracce <strong>del</strong>la medievale architettura romanica,sopravvissute testimonianze di un complesso linguaggiofigurativo che esprime nitidezza e sinteticitàformale. L’interno si esplicita in una pianta ad unicanavata ricoperta da un soffitto a botte unghiata chedovrebbe aver sostituito un soffitto con capriatelignee disposte secondo spioventi. La suddetta coperturaè il risultato di una ristrutturazione e di un ammodernamentoin chiave barocca, espressi da leggiadredecorazioni a stucco che listano ed ornano l’interno,con un intento persuasivo tale da catturare l’occhio:l’effetto è sì scenografico, ma modulato da una sobrietàpriva di quelle soluzioni spumeggianti di decorativismopieno e affollato <strong>del</strong> linguaggio seicentesco. Ilbianco candore degli stucchi costella con moderazionele unghie <strong>del</strong>la volta e il sommo <strong>del</strong>la stessa. Le cornici,fortemente aggettanti, hanno modanature a den-- 137 -
SALTERNUMtelli che corrono con ovvie cadenze ritmichelungo tutto l’asse laterale, intervallato,a sua volta, da appiombi costituitida paraste, parti essenziali di congegnistrutturali sfocianti in un ordinedi cinque arconi a tutto sesto suentrambi i muri perimetrali. Al di sottodi questi ultimi si definiscono dei vanipiù o meno profondi che custodisconoFig. 4 Montecorvino Rovella, chiesa diS. Ambrogio alla Rienna.facciata, dando all’insieme animazioneritmica ed esaltazione plastica. Gliarchetti ciechi, emergenze esornativediffuse anche nel romanico lombardo,probabilmente non dovevano arricchirela facciata di S. Matteo, se si considerache San Giovanni in Castrum è databilealla prima età angioina 3 , e la Chiesa di S.Margherita, ove è possibile ammirarli,ora altari votivi e lapidi sepolcrali, ora statue di Santi,busti ritratto e dipinti. Tali piccole cappelle furonorealizzate per adempiere ad una funzione decorativa ditipica declinazione barocca, come in altre chiese biscegliesi,arricchite e ampliate tra il XVII e il XVIII secolo,ma soprattutto per aumentare lo spessore dei pilastri<strong>del</strong>le pareti laterali, atti a ricevere la nuova voltacostruita in muratura che avrebbe esercitato una notevolespinta su muri sottili, idonei a sostenere coperturepiù leggere, in capriate lignee.L’antica fabbrica romanica doveva assumere conformazionee dimensioni diverse dall’attuale, forse piùridotta, ma queste sono congetture non suffragate dareali analisi sulle sottostanti fondazioni. Si potrebbeallora prendere in considerazione, per eventuali confronti,la più antica chiesa biscegliese di S. Adoeno,primissimo esemplare di origine romanica, forse laprima fabbrica costruita nella cittadina pugliese nellaseconda metà <strong>del</strong>l’XI secolo, ad opera dei Casalini,ormai inurbati 2 .Del probabile originario profilo a capanna, conpiccole aperture, tipico degli edifici di culto di etàromanica, i costruttori <strong>del</strong>la chiesetta dovevano tenerpresente, come mo<strong>del</strong>lo, la vicina chiesa di S. Adoeno,il cui impianto medievale presentava una pianta a trenavate, un transetto non sporgente, copertura acapriate lignee e, come nella cattedrale, un’unica absidecoperta all’esterno da una parete rettilinea. Per lesue ridotte dimensioni, è possibile che S. Matteo fossearticolata in un’unica navata, senza navatelle e che presentasse,quindi, una sola abside, forse anch’essamascherata da una parete rettilinea ad Est. A Bisceglieun esempio di chiesa romanica ad unica sala, concopertura a due falde e profilo di facciata a capanna èla misteriosa chiesa S. Giovanni in Castrum, ubicataall’interno <strong>del</strong> cortile <strong>del</strong> castello. Questa esibisce,lungo i salienti <strong>del</strong>la cuspide, i tipici archetti pensili,atti ad ornare la misurata e sobria composizione dirisale al 1197.La chiesa di San Matteo dovette forse rifarsi, almenoin facciata, a S. Adoeno, questa, peraltro, impreziositada una fascia ornamentale a denti di sega, tributariadi apporti di componenti decorative <strong>del</strong>le vicinechiesette <strong>del</strong>l’agro, gemme solitarie dei casali sparsi ingrande quantità in Bisceglie e nel circondario. SanMatteo fu concessa dal vescovo Stefano alle genti deicasali di Giano e Sagina, nell’agro di Bisceglie, e daquesti probabilmente realizzata.A questo punto, si potrebbe pensare alle stessechiese rurali come mo<strong>del</strong>li di riferimento, per gliaspetti decorativi e gli elementi strutturali e morfologici.Tra i riferimenti, si pensi alla chiesa di Ognissanti,ubicata nel casale di Pacciano, appartente, tra le altredislocate nell’agro biscegliese, ad una tipologia architettonicacostituita da un’unica sala a cupola, moltodiffusa tra gli edifici di culto dei casali sparsi nelle campagnepugliesi, in particolare in quelle di Terra di Bari 4 .In questo caso, la chiesa di San Matteo avrebbe ripresola stessa pianta, ad unica navata, con copertura acupola e ad abside sporgente o avrebbe potuto rifarsialla chiesa di S. Maria <strong>del</strong> casale di Zappino, più simileper tipologia alla già citata chiesetta di San Giovanniin Castrum nel castello di Bisceglie, priva di copertura acupola, con tetto a due falde e profilo a capanna. Aquesta tipologia morfologica si rifà la chiesa di S.Ambrogio alla Rienna di Montecorvino Rovella, inprovincia di Salerno, preziosa testimonianza <strong>del</strong>l’architetturalongobardo-campana, databile al IX-Xsecolo, la cui pianta rettangolare ad unica navata absidatacostituisce un mo<strong>del</strong>lo preromanico riconducibilealla robusta azione svolta nelle campagne dai monacibenedettini (fig. 4). È un gusto architettonico tuttolongobardo, che si perpetua nei secoli successivi, incui nuove sperimentazioni portano a esiti non dissimili,ma rimodulati e sfumati attraverso accenti di unnuovo indirizzo.C. Armenise- 138 -
AURELIA DANIELA RANA - CLAUDIO ARMENISETestimonianze pittoricheMadonna con Bambino e Santi (bottega <strong>del</strong> Giaquinto - NicolaPorta?)La chiesa di S. Matteo custodisce in controfacciataun pezzo pregiato <strong>del</strong>la pittura settecentesca pugliese,un olio su tela di notevoli dimensioni (225 x 315 cm),raffigurante la Madonna con Bambino e Santi, di incertaattribuzione, ma certamente riconducibile, per cifralinguistica, ai modi di Corrado Giaquinto.Alcuni studiosi 5 , basandosi su notizie ricavate daschede di catalogo che fanno capo allaSoprintendenza ai Beni AA.AA.AA.SS. di Puglia, consede a Bari, non citano nessuno specifico autore, maindicano la bottega <strong>del</strong> Giaquinto quale ambito nelquale fu eseguito il dipinto. Dalla stessa fonte si sa chela tela era ubicata originariamente sull’altare maggiore<strong>del</strong>la chiesetta, per il quale era stata realizzata, e inseguito fu collocata e conservata in sagrestia, per poiessere posta sulla parete di controfacciata, dove oraviene ammirata.Stando però a quanto sostiene il d’Orsi 6 , la telapotrebbe essere opera di quel Nicola Porta, allievoprediletto <strong>del</strong> Giaquinto, che in Bisceglie ha lasciatoun patrimonio pittorico di notevole livello qualitativo.Nicola nacque a Molfetta nel 1710 7 , discendente diuna famiglia di fecondi pittori molfettesi. Nella bottega<strong>del</strong> padre, Saverio Porta, operante in Puglia, fu attivoil giovanissimo Corrado che da questo felice periododi formazione trasse i primi frutti vitali per la suasensibilità pittorica; lo stesso Giuseppe Porta, facenteanch’esso parte <strong>del</strong>la bottega e cugino di Nicola, fudeterminante fin dalle prime fasi formative per leinclinazioni di quest’ultimo, il che valorizza maggiormentel’attività dei Porta sia in ambito locale cheregionale. Nella fase matura <strong>del</strong> suo percorso artistico,Nicola Porta si recò nel 1739 a Roma al seguito <strong>del</strong>Giaquinto, di cui fu allievo e discepolo, e nella cui bottegaoperò per circa otto anni: con ogni probabilità fuattivo con il grande maestro nelle imprese decorativeromane per la chiesa di San Giovanni Calibita (1741)e per quelle di Santa Croce in Gerusalemme (1744) edi S. Nicola dei Lorenesi (1746). Queste esperienzesaranno basilari per il Porta, il quale, facendo ritorno aMolfetta, portò con sé spolveri e schemi <strong>del</strong>Giaquinto, assimilandovi le tecniche e le sofisticatamenteleggiadre invenzioni disegnative di gusto rocaille;lo stesso virtuosismo <strong>del</strong>le raffinate modulazionicoloristiche è frutto di meditazione ed è appresoappieno, sia per le soluzioni di accostamento e di conseguentedialogo armonico tra le tinte, sia per il mododi chiaroscurare con gradazioni di tono, in una mellifluaondulazione arabescante di linee di pieno gustosettecentesco. Su questo articolato registro tecnico,egli innesta le sue più franche vibrazioni disegnativo-Fig. 1 - Bisceglie, chiesa di S. Matteo. Nicola Porta (?), Madonna con Bambino e Santi(olio su tela, 225 x 315 cm), seconda metà XVIII sec.- 139 -
SALTERNUMte le distanze e le figure in un gioco complicato di corrispondenze.La scena rappresenterebbe un’apparizione divina,un’apoteosi celeste, in una massa aerea ed eterea dinuvole, tra larvali evanescenze di angeli e luce diafana.La Madonna è detta <strong>del</strong> Rosario, poiché ha nella manosinistra il Rosario che cede con gesto dolcemente raffinatoa San Domenico. I primi storici <strong>del</strong>l’Ordine domenicanoattribuirono l’invenzione <strong>del</strong> Rosario a SanDomenico (1170-1222) 8 e descrissero come la Vergineapparve al Santo, al quale donò una coroncina da luichiamata ‘Corona di rose di Nostra Signora’. Il culto <strong>del</strong>Rosario acquisì diffusa notorietà, tanto da divenire simbolodi numerosi ordini religiosi e laici e ad esso venneattribuita una forza miracolosa, quale quella di sconfiggerel’Islam e le eresie protestanti.L’iconografia <strong>del</strong>la Madonna <strong>del</strong> Rosario compareper la prima volta verso la fine <strong>del</strong> XV secolo, con laVergine inserita in una mandorla formata da rose che,come la corona <strong>del</strong> Rosario, esibisce una rosa piùgrande ogni dieci. Dal XVI secolo, invece, nella iconografia<strong>del</strong>la Madonna <strong>del</strong> Rosario compare il tema<strong>del</strong>la Visione di San Domenico, raffigurato in operecommissionate dall’Ordine. San Domenico è ritrattoin atto di ricevere il prezioso dono dalla Madonna, inun atteggiamento di ossequiosa riconoscenza, con lamano sinistra sul petto e il viso scorciato verso l’alto.Indossa l’abito <strong>del</strong>l’Ordine da lui fondato: tonaca escapolare bianchi e cappuccio nero. Il Rosario chericeve dalla Vergine si riferisce alla pratica da lui istituitaed è una variante rappresentativa <strong>del</strong> tema che sostituiscequella in cui il Santo lo ottiene dal BambinoGesù o lo regge tra le sue mani; è assente, oltremodo,il cane bianco che accompagna spesso la figura di SanDomenico con una torcia accesa in bocca, un riferimento,questo, al sogno <strong>del</strong>la madre <strong>del</strong> Santo, nelquale le fu preannunciata la nascita <strong>del</strong> futuro fondatore<strong>del</strong>l’Ordine.In primo piano, San Nicola si rivolge verso lo spettatorecon un gesto deciso e fiero, in atto di presentazione,con il braccio sinistro diretto in alto ad indicarel’apparizione divina e con il braccio destro spalancato edisteso in opposta direzione. Rappresentato con barbabianca e il capo scoperto per evidenziarne l’età matura,egli ha indosso paramenti sacri: il piviale, la dalmatica, lamitra e il pastorale. La mitra, il copricapo da cerimonia,riservato alle più alte cariche ecclesiastiche, è posta interra, mentre il pastorale è retto da un grazioso angioformaliche si estrinsecano in un fare più sbrigativo edisinvolto, rapido e a tratti sommario, dove il contenutodiventa più importante di ogni elemento espressivo;questa condotta, però, non ha una durata illimitata,poiché deve fare i conti col ritorno di quel fraseggiareestremamente elegante di chiara matrice giaquintesca,nel quale il disegno si risolve in preziosità formali cherendono morbida la figura, <strong>del</strong>icata nei gesti, illeggiadritain soffice ariosità dagli svolazzanti tessuti <strong>del</strong>levesti, accordata ad una sostanza luministica che si fatempesta di tocchi gemmanti in amistà con un gammadi squisiti colori.Di questo secondo indirizzo di stile la tela biscegliesesi fa preziosa testimonianza. Si complica il suoschema compositivo, dove figure e colori si contrappongonoin sofisticate interrelazioni: sei figure, le piùimportanti, si dividono l’ingombro scenico, tra cui laMadonna <strong>del</strong> Rosario col Bambino, San Matteo, SanDomenico, San Nicola e Sant’Antonio da Padova. Gliangioletti e le tre silhouettes dei santi patroni diBisceglie sono figure secondarie al quadro. Lo spaziosi dispiega in tre piani ravvicinati poco profondi, poichéle figure dei santi si accalcano ravvicinate e compatteverso la Madonna col Bambino, fulcro generatoredi una tensione dinamica di moti e di gesti.L’impianto appare asimmetrico nella dislocazione deipersonaggi, i quali sembrano porsi su linee diagonaliformanti un rombo che, se girato in senso orario, consentirebbealla scena di prestarsi ad una visione ordinatae simmetrica. In primo piano, spostato leggermentesulla sinistra in collocazione aurea, è la figura diSan Nicola a catturare il peso percettivo, rivolto di trequarti, genuflesso e con lo sguardo fisso verso lo spettatore;in secondo piano sull’estrema sinistra, SanMatteo, in piedi eretto su un piano di posa indefinito,si volge verso la santa epifania; posto al centro, versol’ultimo piano di profondità, Sant’Antonio da Padovarisulta essere il personaggio che sta in mezzo, mentreSan Domenico è rappresentato a destra, in contrapposizionea San Matteo sulla sinistra; verso l’alto, invece,sull’angolo destro, il gruppo <strong>del</strong>la Madonna colBambino campeggia solenne circondato da angioletti,rinserrando la composizione. Il pastorale tenuto indiagonale da un angelo con le ali spiegate, dislocatoalle spalle di San Nicola, dà vita a linee compositiveche uniscono la testa di quest’ultimo col quelle di SanDomenico, di San Matteo e <strong>del</strong>la Madonna, e viadiscorrendo, in un impianto che regola reciprocamen-- 140 -
AURELIA DANIELA RANA - CLAUDIO ARMENISEletto ad ali spiegate, che spunta all’improvviso dietro ilSanto; le tre palle, suo attributo iconografico per eccellenza,sono collocate ai piedi <strong>del</strong>la sua bianca veste,accanto ad un libro chiuso; il Santo è spogliato, per unmomento, di tutti i suoi paramenti, per dedicarsi completamenteal celeste evento, ossia all’apparizione incantevole<strong>del</strong>la Vergine col Bambino Gesù. San Nicolanacque in Licia e fu vescovo di Mira nella prima metà<strong>del</strong> IV secolo d. C. 9 E’ un santo molto popolare sia nellachiesa greca e sia in quella latina. La leggenda impreziosìla sua vita di aneddoti particolari ed eventi miracolosi(le tre sorelle salvate dal disonore, la tempesta domata,i tre ufficiali <strong>del</strong>l’esercito di Costantino liberati dapericolo mortale), mentre gli agiografi lo confusero conun altro Nicola, il Sionita, vissuto nel VI secolo, fondatoredi un monastero a Sion, presso Mira, poi vescovodi Pinara, in Licia.Nell’opera in esame risplendono i colori rifulgenti<strong>del</strong>l’oro <strong>del</strong>la dalmatica, <strong>del</strong>la mitra e <strong>del</strong>la parte terminale<strong>del</strong> pastorale, così come si accende il bianco candore<strong>del</strong>la sottoveste.Immediatamente collocato alle sue spalle, SanMatteo 10 si erge in una posa plastica, simulante un’anticastatua, con un panneggio di un vivido rosso rilucentemente,mentre l’attitudine sua si rinserra in dolceadorazione.Figura sostanziata in forbito tratto, di chiaraimpronta giaquintesca, è Sant’Antonio da Padova 11 ,che bacia <strong>del</strong>icatamente il piedino <strong>del</strong> Bambino Gesù;è abbigliato con il tipico saio francescano dalla tonalitàmarrone, da cui appare un giglio bianco, suo tipicoattributo iconografico; il capo è tonsurato secondo lepiù rigide consuetudini francescane. Nel dipinto è ilpersonaggio che sta al centro atteggiandosi in unaposa che esprime dolci sentimentalismi in un muto,ma espressivo dialogo con la Divinità. Penetrate conacutezza d’introspezione psicologica, tutte le figurepartecipano con pose e gesti spontanei al lieto eventoche si fa apparizione trascendentale, quasi un’estasiimprovvisa in sereno idillio, da trascorrere tra patetismie flautate effusioni.Il peso percettivo <strong>del</strong>l’opera si concentra sul gruppo<strong>del</strong>la Madonna col Bambino, da cui scaturisconolanguidi sguardi, le cui direzioni legano i diversi elementifigurativi in un dialogo sottile, ma penetrante.San Matteo e Sant’Antonio da Padova si rivolgonoammaliati al Bambino Gesù, mentre San Domenicosembra intento a ricevere dalle sante mani <strong>del</strong>laFig. 2- Bisceglie, chiesa di S.Matteo. Interno.Vergine il Rosario da lui fatto oggetto di culto. I movimentie i gesti <strong>del</strong>le mani e degli sguardi sono controllatie leggeri, studiati per esibire accordature e calcolatiritmi.San Nicola appare l’unico personaggio estraneo,apparentemente, a tale modulazione dinamica, ma ilsuo volgersi frontalmente con le braccia spalancate,indica presentazione di un accadimento e si inseriscepienamente in quel circuito di reciprocità di rapporticon le figure protagoniste. Varietà e accordo nella sintassiesecutiva sono ostentate con singolarità di risultati,in un vorticare di linee curve e ondulate, angolosee oblique. Il manto <strong>del</strong>la Vergine è distribuitosecondo una linea sinuosa e fluttuante, così come l’orlomerlettato <strong>del</strong>la sottoveste bianca di San Nicola,mentre curvature si <strong>del</strong>ineano attraverso la dalmaticadorata <strong>del</strong>lo stesso, insieme a scattanti svirgolature <strong>del</strong>manto rosso di San Matteo. Angoli e rigidi spigoli dilinee si accavallano nella veste di Sant’Antonio e incerte pieghettature <strong>del</strong> saio di San Domenico, irrigidendola condotta disegnativa, mentre tratti più stiratiproducono effetti pacati che rilassano la vibratilitàd’insieme. Lo stesso asse vorticante <strong>del</strong>la Vergineimprime slancio e accelerazioni ritmiche alla composizione,secondo i più tipici timbri barocchi. Ed è sensazionesquisita di vicende luministiche, dove ognidettaglio viene perseguito entro il restringersi <strong>del</strong>lazona di luce. Da sinistra un fiotto effusivo di lumepenetra addensandosi sulle due figure di San Matteo eSan Nicola, alonando parte <strong>del</strong>le vesti, poste in unaimmersione di penombra sull’altra metà: una virata diluce ferma e più tepida risalta sulla testa di San Nicolaed enuclea braccio e avambraccio <strong>del</strong> San Matteo, rinchiusonell’oscurità nella zona alta <strong>del</strong> corpo.- 141 -
SALTERNUMSoluzioni di controluce svarianorotondeggiante e piegata in <strong>del</strong>icatagrazia, così come la posizione, ilsul manto celeste <strong>del</strong>la Vergine,masse evanescenti di nuvole illuminaterestituiscono chiarore edsinistro, coperto da una manicamovimento e la fattura <strong>del</strong> braccioeterea atmosfericità alla scena chegonfia e turgida.si fa palpitante nella zona di luceNella veste <strong>del</strong>la Vergine <strong>del</strong>divina emanata dal BambinoPorta si ripete anche lo stessoGesù, come squarcio improvvisoaccostamento di colori, rosa e blu,di bagliori, da scorrere tra corpi edalla medesima ricchezza dicose. La superficie pittorica appareincorporea, come ben si addice<strong>del</strong>la mano destra <strong>del</strong> San Nicola eFig. 3 - Bisceglie, chiesa di S. Giovanni in Castrum. Facciata.modulazione. La stessa esecuzionead una apparizione celeste, labile eil gesto di aprire il braccio destro,vaga nell’ammasso di nuvolaglia, da cui larvali figurettedi teneri angioletti vagolano, con evidenza bozzetti-San Domenico nella Madonna <strong>del</strong> Rosario <strong>del</strong> Giaquinto,stendendolo verso il basso, risultano simili a quelli <strong>del</strong>stica, tra le fragili agitazioni <strong>del</strong> manto <strong>del</strong>la Madonna. tela conservata nella chiesa di San Domenico diDi dovizia cromatica incantevole, il dipinto esibisceaccordi rari, di una sensibile preziosità: risaltano i romano, precedente i dipinti di San Giovanni Calibita,Molfetta 13 , rientrante nella produzione <strong>del</strong> periodotoni <strong>del</strong> rosso, vermiglione nella veste di San Matteo, avvicinandosi, dunque, al 1739, datazione corrispondentea quella <strong>del</strong>la consacrazione <strong>del</strong>l’altare <strong>del</strong>lamodulandosi poi nel rosa pallido <strong>del</strong>la sottoveste <strong>del</strong>laVergine che diventa rosa scuro nella parte inferiore; i chiesa molfettese che la ospita. La suddetta operatoni terrosi, dal marrone al beige, all’ocra gialla, si lasciò una notevole impronta in Terra di Bari per laaccostano al dorato finissimo <strong>del</strong>la veste di San «dolcezza quasi idilliaca <strong>del</strong>la scena» 14 . A partire dalNicola, formando un chiasmo nella contrapposizione quarto decennio <strong>del</strong> Settecento questa tela fu replicatafe<strong>del</strong>mente, come nella Madonna <strong>del</strong> Rosario <strong>del</strong>lodialettica dei colori, in cui il rosso si armonizza con isuoi toni in chiaro (le gradazioni <strong>del</strong> rosa), e il giallo stesso Nicola Porta nella chiesa <strong>del</strong>la Purità didorato con i toni in scuro (toni terrosi). Gli unici coloriche spezzano l’armonia d’insieme sono il nero <strong>del</strong> secolo 15 . Questa tela risulta essere una copia <strong>del</strong>la telaModugno, datata attorno al quinto-sesto decennio <strong>del</strong>saio di San Domenico, il blu <strong>del</strong> manto <strong>del</strong>la giaquintesca, dimostrando quanto schemi, disegni oMadonna, quest’ultimo peraltro variato in gradazione bozzetti di Corrado fossero usati dai suoi allievi ocromatica, in cui risplende anche l’azzurro <strong>del</strong> cielo, e discepoli con una disinvoltura sconcertante, diffondendonei modi e i temi in gran parte <strong>del</strong>la Puglia.il bianco <strong>del</strong>la sottoveste di San Nicola.Accogliendo l’attribuzione <strong>del</strong> d’Orsi a Nicola La tela biscegliese è fortemente debitrice di formePorta, basterebbe qui evidenziare quanto accomuna la e schemi giaquintesci, soprattutto se ci si soffermatela biscegliese alle caratteristiche tecniche <strong>del</strong> linguaggiopittorico di Corrado Giaquinto. Nello schema Sant’Antonio, i cui tratti fisionomici ricalcano alla per-sulla redazione sommaria e rapida <strong>del</strong> volto dicompositivo le desunzioni da Corrado sono particolarmenteevidenti, come la scelta di porre la figura a sua volta, di soluzioni solimenesche e giordanesche.fezione la condotta abbreviata <strong>del</strong> Maestro, tributario,<strong>del</strong>la Madonna seduta e sospesa su un trono di nuvole,con in braccio il Bambino Gesù su di una gamba, giocate sulle gradazioni di tono che, come una pro-Il dipinto di San Matteo ostenta preziosissime tinte,come appare quasi pedissequo nella Madonna col spettiva cromatica, risuonano in primo piano illeggiadrendotessuti, corpi e cose, via via sfumando neiBambino nella tela <strong>del</strong> Museo Diocesano di Molfettacon la Madonna col Bambino, Arcangelo Raffaele e Tobiolo 12 , secondi piani e raggiungendo colorazioni monocromate,fino ad impalpabili sostanze di materia labilmen-nella quale le figure secondarie sono poste in basso ele figure di angioletti gravitano leggere attorno alla te inconsistente. In questo sta l’impressione linguisticaVergine. In questo dipinto ci si avvede, inoltre, di particolarigrafico-disegnativi che ritornano nella tela allievo e discepolo fe<strong>del</strong>e.da Corrado Giaquinto, da parte di Nicola Porta, di luibiscegliese, come la mano sinistra <strong>del</strong>la Madonna,C. Armenise- 142 -
AURELIA DANIELA RANA - CLAUDIO ARMENISENote1LOSCIALE 2000, p. 39.2BRUSA 1985, pp. 131-144.3TESEO 1999, p. 105.4SEMERARI 1980, pp. 305-312.5LOSCIALE 2000, p. 40.6 D’ ORSI 1958, p. 136.7AMATO - BELLIFEMINE 1969, pp. 69-86.8Durante la Controriforma il Rosario ebbeun’importanza straordinaria per contrastarele dottrine protestanti, mentre dopo la vittoriadei Cristiani sui Turchi a Lepanto, nel1571, il culto <strong>del</strong>la Madonna <strong>del</strong> Rosario sidiffuse ampiamente, poiché si credeva avesseavuto un ruolo decisivo nella sconfittadegli infe<strong>del</strong>i (VICAIRE 1983).9In Europa il suo culto si diffuse da quando,nel 1087, le sue reliquie furono trasportatea Bari, dove gli fu eretta una basilica. InOccidente il suo culto fu promosso all’epocadi Ottone II, la cui moglie Teofane era diorigine bizantina; in seguito si concentrò inSvizzera, in Belgio, in Olanda; in Oriente sidiffuse anche nelle chiese dissidenti fraGreci, Russi, Bulgari, Serbi, Croati, Slavi(SGARBOSSA -GIOVANNINI 1979).10Santo, Apostolo ed Evangelista, la suabiografia si basa su dati scarsissimi: il suonome, che è un’abbreviazione di Mattia oMatania, vuol dire ‘dono di Dio’. Prima diessere chiamato a seguire Gesù, San Matteoera doganiere o esattore di imposte aCafarnao. Il Vangelo di Matteo è il Vangelo<strong>del</strong> Regno dei Cieli o <strong>del</strong>la Chiesa, poiché inlui, diversamente dagli altri Evangelisti, è<strong>del</strong>ineata così bene la Chiesa, fondata suPietro, quale forma visibile in terra <strong>del</strong>Regno dei Cieli. É, inoltre, un Vangelopolemico, che si caratterizza per il dissensodeciso al fariseismo e alla sinagoga, ma chesa far uso di argomentazioni capaci di suggestionareil mondo giudaico attraverso ilracconto di miracoli e profezie per accertarela messianità di Gesù (MATEOS -CAMACHO 1986).11Il Santo nacque a Lisbona nel 1191 o1195 (il suo nome di battesimo eraFernando). Egli è chiamato ‘da Padova’ peraver svolto in quella città la parte precipua<strong>del</strong>la sua attività e aver vissuto gli ultimianni <strong>del</strong>la sua vita. Entrò nel 1210 fra iCanonici regolari di San Vincenzo, pressoLisbona, e in seguito tra quelli di S. Croce aCoimbra. Nel 1221 si recò ad Assisi, pressoil Capitolo generale <strong>del</strong>l’Ordine francescano,dove incontrò San Francesco e venneassegnato all’eremo di Montepaolo (Forlì).Iniziò le sue predicazioni nell’Italia settentrionalee di qui nella Francia meridionale.Morì nel 1231 presso il Convento <strong>del</strong>leClarisse <strong>del</strong>l’Arcella, vicino a Padova(POZZA 1984).12DI CAPUA 1993 b , p. 150.13ID. 1993 c , p. 132.14 D’ ORSI 1958, p. 135.15DI CAPUA 1993 a , p. 78.- 143 -
SALTERNUMBibliografiaAMATO P. – BELLIFEMINE G. 1969, Pittorimolfettesi <strong>del</strong> XVII-XVIII secolo, Molfetta.BELLONI E. 1993 (a cura di), Giaquinto.Capolavori dalle corti in Europa. Catalogo <strong>del</strong>laMostra, Bari, Castello Svevo (23 aprile – 20giugno 1993), Bari.BRUSA A. 1985, Bisceglie, in Itinerario normannoin Terra di Bari. I centri costieri, Bari, pp.131-144.D’ ORSI M. 1958, Corrado Giaquinto, Roma.DI CAPUA M. G. 1993 a , ConradusGiaquintus Melphicti Pictor, in BELLONI1993, pp. 67-102.DI CAPUA M. G. 1993 b , Madonna <strong>del</strong> Rosario,in BELLONI 1993, p. 132.DI CAPUA M. G. 1993 c , Madonna conBambino, arcangelo Raffaele e Tobiolo, inBELLONI 1993, p. 150.LOSCIALE A. 2000, La cultura figurativa aBisceglie tra Sei e Settecento, Catanzaro.MATEOS J. – CAMACHO F. 1986, Il Vangelo diMatteo, Assisi.POZZA N. 1984, Vita di Antonio, il Santo diPadova, Milano.SEMERARI L. 1980, La chiesa di Ognissanti inlocalità Pacciano (Bisceglie), in Insediamenti benedettiniin Puglia. Per una storia <strong>del</strong>l’arte dall’XI alXVIII secolo, Catalogo <strong>del</strong>la Mostra, a curadi M. S. CALÒ MARIANI, Bari, II voll.SGARBOSSA M. – GIOVANNINI L. 1979, Ilsanto <strong>del</strong> giorno, Roma.TESEO G. 1999, Bisceglie. Il castello: i restauri,in Castelli e cattedrali di Puglia. A cent’annidall’Esposizione Nazionale di Torino, Catalogo<strong>del</strong>la Mostra, a cura di C. GELAO - G. M.JACOBITTI, Bari.VICAIRE H. 1983, Storia di San Domenico,Torino.- 144 -
TIZIANA MANCINIL’Italia dei piccoli tesori:per un dipinto inaspettatamente ritrovatoSe è vero, com’è vero, che inItalia ogni villaggio ed ogniborgo racchiudono e conservanola propria memoria storica attraversomanufatti artistici, anche Sicignano,ameno paese alle falde <strong>del</strong>la catenaappenninica campana degli Alburni, nonsfugge a questa regola. Al di là di pregevolitestimonianze che la pittura e la scultura,‘locale’ e non, hanno lasciato, custoditenella parrocchiale di S. Matteo e S.Margherita e che per il momento nonsono oggetto di codesta trattazione (malo meriterebbero!), la nostra attenzione sifocalizza su di un rinvenimento fortuitoavvenuto qualche anno fa all’interno <strong>del</strong>complesso conventuale dei Cappuccini(fig. 1). Tale complesso 1 , fondato nel1572, ha rivestito una certa importanzaterritoriale se è vero che il suo ‘studium’ harappresentato per anni un riferimentoculturale per serietà ed autorevolezza 2 . Tuttavia col passare<strong>del</strong> tempo e con il nascere di nuove esigenze e ditendenze coincidenti con la crisi di valori e di vocazioni,il Convento progressivamente si depaupera e cominciauna fase di lento declino ed abbandono che lo portaad un totale disfacimento con razzie vandaliche.E’ di qualche anno fa il recupero da parte <strong>del</strong>lalocale Soprintendenza <strong>del</strong>l’intero apparato monumentaleed in tale circostanza, nell’ambito <strong>del</strong>la tutela <strong>del</strong>poco che si poteva salvare, si è verificata la scoperta, aldi sotto <strong>del</strong>la tela che troneggiava sull’altare maggiore,di un dipinto, molto più antico, in discreto stato diconservazione. E’ molto probabile che per ragionilegate ad esigenze economiche e per ottemperare ainuovi dettami cultuali, determinati dalla promulgazione<strong>del</strong> dogma sull’Immacolata Concezione, ratificatoFig. 1a - 1b - Sicignano degli Alburni,Convento dei Cappuccini.nel 1854 da Pio IX, sia stato ritenutonecessario sostituire la precedenteimmagine <strong>del</strong>la Vergine (fig. 2) con quellache La rappresentasse nel suo nuovostatus 3 , come testimonia la data appostain margine alla tela, che si riferisce aglianni Sessanta <strong>del</strong>l’Ottocento. Dunqueun caso di sostituzione abbastanza rapida,che ha celato agli occhi dei devoti didue secoli fa la precedente iconografia<strong>del</strong>la ‘Madonna <strong>del</strong> soccorso’; la stessache al contrario e con sorpresa si è rivelataoggi essere un’opera di pregevolefattura, anche se ha patito i danni <strong>del</strong>tempo, perché presenta nella parte inferioreuna fascia rovinata da cadute elacune cromatiche.Il dipinto recuperato (fig. 3), realizzatosu legno, attualmente custodito pressola Parrocchiale, presenta alcune particolaritàche lo rendono interessante.Innanzitutto mi sembra cronologicamente ascrivibilealla seconda metà <strong>del</strong> ’500 e dunque probabilmentecoevo alla fondazione <strong>del</strong> Convento sicignanese,anche se non abbiamo certezze in merito, perchépotrebbe pure essere stato inviato in un secondomomento in loco e dunque non necessariamente pensatoo commissionato ad hoc. L’iconografia - la Vergineche ran<strong>del</strong>la il maligno, accogliendo sotto la sua protezioneuna giovane donna che presenta un adolescente,la ‘Madonna <strong>del</strong> soccorso’ per l’appunto - è abbastanzanota, diffusa già a partire dalla fine <strong>del</strong> ’300 in Italiacentrale, soprattutto ad opera dei Frati Agostiniani, inriferimento all’Onnipotenza Divina di cui Maria èInterceditrice.Stilisticamente ci troviamo inequivocabilmente difronte ad un’opera di matrice pietistico-devozionale,- 145 -
SALTERNUMtipica <strong>del</strong>la cultura figurativa napoletana degli ultimidecenni <strong>del</strong> secolo XVI. Nel corso degli anniQuaranta e Cinquanta a Napoli avvenimenti fondamentalicome l’introduzione <strong>del</strong>l’Inquisizione romana(1547) o la nomina all’Arcivescovado napoletano <strong>del</strong>teatino Gianpietro Carafa (futuro papa Paolo IV), ol’arrivo in città di forze gesuitiche, determinano unclima fortemente reazionario di ritorno al ‘tridentinismo’.Infatti, dopo un periodo contraddistinto dagrandi figure riformatrici come Ochino, Vermigli,Valdès, la città subisce una brusca sterzata ed i tentatividi una ‘riforma illuminata’ sono soffocati e sfocianoaddirittura nella violenza, per esempio, <strong>del</strong>la strage deiValdesi di Calabria nel 1561.Tutto ciò determina la nascita a Napoli e nei territori<strong>del</strong> Viceregno di un nuovo modo di dipingere,indirizzato verso una sorta di realismo atto a destaresentimenti di commozione e di forte devozione, inbase all’obbedienza tridentina sancita dai Sinodi locali.Due sono i poli che tra gli anni Sessanta e Settanta<strong>del</strong> XVI secolo si consolidano in questo senso nelpanorama <strong>del</strong>la Capitale: la scuola di Giovan BernardoLama e Silvestro Buono, connotata da qualità legatealla resa cromatica ed al segno derivati dallo studio <strong>del</strong>realismo devozionale dei Fiamminghi, l’altra legata allafigura <strong>del</strong> senese Marco Pino, fondata sul disegno e suicontrasti chiaroscurali, eredità <strong>del</strong>le tendenze manieristedi stampo polidoriano o periziano 4 .Il nostro dipinto si presenta con un ‘ductus’ di grandecura e resa ed una certa sapienza nell’uso <strong>del</strong>le cromiecontrastanti. Credo che la matrice culturale sia daascriversi alla corrente che fa capo al Lama ed alBuono, perché l’espressività addolcita ma compuntaed umile che traspare dal volto <strong>del</strong>la Vergine mi fapensare a certi visi più vicini ai modi <strong>del</strong> Buono (peresempio la Madonna <strong>del</strong> dipinto <strong>del</strong> Duomo diSorrento) piuttosto che <strong>del</strong> Lama; nel contempo c’èquasi un’eleganza nel gesto <strong>del</strong>la Madonna che attutiscel’atto <strong>del</strong> brandire, rilevandone la funzione diMadre Misericordiosa cui l’adolescente, in basso asinistra di chi guarda, si rivolge fiducioso (figg. 3-4). IlDiavolo, in basso a destra, sembra atterrito. Ha unpaio di ali molto singolare, contraddistinte da macchieocellate come quelle <strong>del</strong>le code dei pavoni, forserispondenti ad una prassi codificata, legata anche allaFig. 2 - Sicignano degli Alburni (SA), Collegiata dei SS. Matteo e Margherita.Immacolata Concezione.Fig. 3 - Sicignano degli Alburni (SA), Collegiata dei SS. Matteo e Margherita. Madonna<strong>del</strong> Soccorso.- 146 -
TIZIANA MANCINIFig. 4 - Sicignano degli Alburni (SA), Collegiata dei SS. Matteo e Margherita. Particolare.Fig. 5 - Sicignano degli Alburni (SA), Collegiata dei SS. Matteo e Margherita. Particolare.grande diffusione di cartoni o disegni di bottega, enon, che all’epoca dovevano circolare.I putti-angeli che sorreggono la corona hanno lastessa definizione allungata ed elegante <strong>del</strong> piccoloGesù che, sorretto con maestria ed equilibrio dallamano <strong>del</strong>la Madre, mostra gambine tornite sotto l’impalpabilemanto che Lo ricopre (fig. 5). Si potrebbe aquesto punto proporre una paternità, attribuendo ildipinto ai modi di un pittore piuttosto controverso, lacui attività, modesta ma lunga e prolifica, oscilla tra ilrealismo devozionale di un Buono e di un Lama ed ilsegno incisivo di un Marco Pino, riscuotendo un certoconsenso nel corso <strong>del</strong> terzo quarto <strong>del</strong> secolo. Miriferisco a Decio Tramontano. Infatti il modo di renderei capelli riccioluti dei putti, l’attaccatura <strong>del</strong>lecapigliature, i profili, gli incarnati, la fisionomia <strong>del</strong>maligno rivelano analogie ed affinità con alcune <strong>del</strong>leopere accertate come, ad esempio, la Pala centinata<strong>del</strong>la Cattedrale di Caserta. Che la sua sia stata un’attivitàaltalenante lo prova anche l’esistenza di un’operacon il medesimo soggetto, la Madonna <strong>del</strong> soccorso,un tempo nella cappella <strong>del</strong> Monte di CiarlettaCaracciolo nel Duomo a Napoli ed ora in S. Maria <strong>del</strong>Buonconsiglio, sempre a Napoli. Si tratta di un dipintoqualitativamente inferiore a quello di Sicignano dicui potrebbe essere una replica fatta in tono minore,con una componente devozionale forse preminente eche ne inficia la qualità espressiva. Al contrario, credoche la nostra pala possa risalire agli anni tra il Sessantae il Settanta, quando i suoi mo<strong>del</strong>li, pur nell’alveo diun realismo pietistico, hanno ancora la forza <strong>del</strong> disegnoe <strong>del</strong> colore e la dolcezza <strong>del</strong>le immagini.- 147 -
SALTERNUMNote1Sul convento, cfr. PASTORE 1974.2Il poeta e scrittore lucano RoccoScotellaro ha compiuto i suoi studi presso ilConvento di Sicignano, perché tra il 1890 eil 1904 lo frequentavano gli Studenti <strong>del</strong>Ginnasio superiore e <strong>del</strong> Liceo.3Occorre sottolineare che l’iconografia<strong>del</strong>l’Immacolata Concezione esisteva già apartire dalla fine <strong>del</strong> Cinquecento e cioèmolto prima che il dogma venisse ratificato,testimonianza di quanto la fede popolarefosse preveggente.4Questi problemi sono stati per la primavolta affrontati in PREVITALI 1978 e poitrattati in modo esauriente in LEONE DECASTRIS 1996 e ID. 1998.BibliografiaPASTORE F. 1974, A Sicignano degli Alburni, inun luogo di pace. Il convento dei Padri Cappuccini,in ‘Il Postiglione’, a. VI, n.7, pp. 213-215.PREVITALI G. 1978, La pittura <strong>del</strong> Cinquecentoa Napoli e nel Vicereame, Torino.LEONE DE CASTRIS P. 1996, Pittura <strong>del</strong>Cinquecento a Napoli, 1540-1573. Fasto e devozione,Napoli.LEONE DE CASTRIS P. 1998, La pittura <strong>del</strong>Cinquecento in Italia Meridionale, in La pitturain Italia. Il Cinquecento, a cura di BRIGANTIG., Milano, t. II, pp. 472-514.- 148 -
GIUSEPPE LAURIELLOLa cassetta <strong>del</strong> tonsor cerusicusLo spunto per questo articolo nasce dall’osservazionedi una cassetta portatile di barbierechirurgo itinerante, databile alla metà<strong>del</strong>l’ ‘800, conservata presso il Museo <strong>del</strong>lo strumentariomedico ‘Roberto Papi’ di Salerno: un cofanettoin legno di modeste dimensioni contenente sia gliattrezzi <strong>del</strong> mestiere utilizzati per radere e tagliare icapelli, sia una serie di strumenti atti all’estrazionedentaria e all’esecuzione <strong>del</strong>la piccola chirurgia esterna.Il reperto è di estremo interesse, essendone documentatipochi esemplari in ambito mondiale, sparsinei vari Musei di storia <strong>del</strong>la medicina.La cassetta, Mappin Web di Birmigham 1 , misura cm21,5 x 12 x 8 (fig. 1). E’ divisa in due scomparti diuguali dimensioni, di cui uno è provvisto di una coperturaapribile, dove sono allocati gli strumenti propri<strong>del</strong> barbiere: un rasoio ‘Crown and Castle’ con lamad’acciaio e manico corneo, una forbice dritta Rudolph-Shmidt Solingen, una forbice dentata Adler, unpettine in avorio. Il comparto sottostantecontiene un ‘pellicano’ 2 per il 4°, 7° e 8° elementodentario, due pinze da estrazione,una per gli incisivi, l’altra per i molari, treablatori di tartaro con impugnatura inebano, un otturatore per amalgami e oro.Nell’altro scomparto, a sua volta diviso inalloggiamenti: un supporto in pietra d’Indiaper l’affilo <strong>del</strong> rasoio, un contenitore rotondodi vetro per il sapone da barba e due piùpiccoli in metallo per unguenti vulnerari,una bottiglietta per liquido disinfettante,una limetta per levigare la superficie deidenti, una lancetta da salasso in tartaruga eacciaio e un piccolo bisturi reniforme <strong>del</strong>lostesso materiale.Sin da tempi remoti la chirurgia è stata affrontata,oltre che da medici professionisti famosi (pochi),anche da praticanti empirici (molti), anzi è abbastanzaprobabile che la maggioranza di quei medici cosiddettiperiodeuti <strong>del</strong>l’antica Grecia siano stati in realtà degliempirici, provvisti certamente di vasta esperienza,acuto ingegno ed abile manualità tecnica, ma altrettantocertamente privi di dottrina. La stessa cosiddetta‘scuola empirica’ romana dei primi secoli dopo Cristo,fondata da Serapione 3 , dovette essere costituita in granparte da artigiani <strong>del</strong>la chirurgia, medicastri venutidalla Grecia, molti dei quali ebbero a demeritare perpalese imperizia ed immoralità. Oltre Ippocrate eGaleno, di chirurghi professionisti, dei quali siano statitramandati i nomi, il gruppo è davvero sparuto:Megete di Sidone 4 , Rufo d’Efeso 5 , Cornelio Celso 6 ,Marino 7 , Archigene d’Apamea 8 , Eliodoro 9 , Antillo 10 ,Sorano d’Efeso 11 e qualche altro. Il resto fu indubbia-Fig. 1 - Cassetta <strong>del</strong> ‘barbiere cavadenti’ (Salerno, Museo Roberto Papi).- 149 -
SALTERNUMmente rappresentato da praticoni, rozzi esercenti dimedicina operatoria, caduti ben presto nell’anonimato.Ma la vera bassa chirurgia itinerante, condotta daempirici illetterati, appare in auge soprattutto nelMedioevo, allorchè la disciplina diventa dominio dimestieranti, che trasmettono in tutta segretezza dapadre in figlio le diverse procedure tecniche, certamenteabili ed ingegnose, ma prive di qualsiasi connotatoscientifico, contribuendo così a un immeritatosvilimento professionale <strong>del</strong>l’arte.L’apogeo di tale chirurgia si ha tra l’XI e il XII sec.,allorchè viene meno la medicina monastica, che neisecoli precedenti aveva soppiantato quella laica 12 , inseguito ai ripetuti divieti all’esercizio pratico impostidai vertici ecclesiastici e dalle pronunce conciliari. Unintervento legato alla sempre più dilagante constatazione<strong>del</strong>l’allontanamento dei frati dal convento, spessoper più giorni, giustificato dal soccorso all’ammalatobisognoso, ma anche causa di disattenzione verso iprioritari doveri spirituali, un allentamento peraltroreso ancor più inaccettabile dal consolidamento <strong>del</strong>laRiforma Gregoriana avutasi nella seconda metà<strong>del</strong>l’XI sec. 13La chirurgia quindi, privata <strong>del</strong>l’efficiente sostegno<strong>del</strong>le infermerie claustrali, è abbandonata ai barbieri,cui resta affidato l’intero coacervo di quella patologiarifiutata dai medici già dai tempi di Ippocrate. IlGiuramento 14 , vincolo ad alta sacralità, vieta infatti l’esecuzionedi incisioni in coloro che soffrono di calcolosi(‘mal <strong>del</strong>la pietra’), anzi esorta a lasciare tale operazioneagli esperti: è un rifiuto riferito a una singolamalattia, ma che testimonia la rinuncia a praticarequalsiasi procedura a connotazione chirurgica.Altro motivo di allontanamento dalle pratiche operatorieè la proibizione di esercitare sul corpo atti cheprevedano versamento di sangue: «ecclesia abhorret a sanguine»,una frase attribuita ora al Concilio di Tours <strong>del</strong>1163, ora al Concilio Lateranense <strong>del</strong> 1215, ma che,anche se mai pronunciata, in realtà esprime l’effettivae decisa ripulsa <strong>del</strong>la Chiesa per qualsiasi manovracruenta su esseri umani, sia per l’atto in se stesso cheper le sofferenze procurate dall’intervento, spesso adalta mortalità 15 .Emergono quindi i barbieri cerusici, i tonsores omeglio i barbitonsores, in un certo senso allievi deimonaci per antica dimestichezza (al barbiere <strong>del</strong> conventoinfatti era devoluta l’esecuzione <strong>del</strong>la tonsura eil salasso dei frati: ‘tonsor et minutor’ 16 ), ma si segnalanoanche altre figure ambulanti, i circulatores, che proprionelle infermerie claustrali apprendono i primi rudimentidi chirurgia parietale. Percorrono il territorio,attraversando villaggi e campagne, spostandosi dacastello in castello, fino a raggiungere paesi e città lontane,dovunque proponendo e praticando l’arte ‘meccanica’,ritenuta riprovevole in mani ecclesiastiche.Decisamente privi di una elementare educazione sanitaria,digiuni di conoscenze umanistiche, anzi praticamenteanalfabeti (ignorano il latino e quindi è preclusoloro l’accesso allo studio dei libri di medicina e, nonsapendo di filosofia, sono <strong>del</strong> tutto carenti di teoreticamedica), basano le proprie cognizioni su una superficialeosservazione anatomica, anche se non avulsa dauna solida esperienza personale 17 . Sono i <strong>del</strong>egati <strong>del</strong>lachirurgia conventuale, che non potendo essere piùesercitata nei monasteri, si sviluppa nelle mani dicostoro, che arditamente e spesso con inusitata periziaeseguono salassi, estrazioni dentarie, incisioni di ascessi,medicazioni di ferite, riduzioni di fratture e lussazioni.Secondo quanto riportato da Pietro Ispano nel suoThesaurus pauperum <strong>del</strong> XII sec. 18 , sembra che GiovanniPlateario, il celebre medico salernitano 19 , abbiacomunque condiviso che l’estrazione dentaria fosseaffidata ad un imperitus artifex, cioè ad un artigiano.L’ulteriore frattura tra scienza e tecnica operatoriasi verifica nel XIII sec. allorchè il medico ‘fisico’ sirifiuterà di prestare la propria attività terapeuticamanualmente, accentuando la separazione tra medicinae chirurgia. Tale situazione è bene sintetizzata daContieri 20 il quale, riferendosi all’epoca, scrive: «Le cattedreuniversitarie snobbano la patologia chirurgica,che viene abbandonata ai barbieri, che restano padroni<strong>del</strong> campo e non solo per quella patologia affidataloro sin dalla lontana tradizione ippocratica (cataratta,ernia, operazione <strong>del</strong>la pietra, ecc.)». Tale diniegoinfatti viene a creare <strong>del</strong>le classi separate di terapeuti,suddivise in distinti comparti e cioè: da un lato i mediciassociati alle Facoltà di Medicina <strong>del</strong>le Universitàcon ruoli gerarchici ben definiti; dall’altro i chirurghiprofessionisti, organizzati in corporazioni con regolarigradi e licenze, e, per ultimo, infimo rango, i barbitonsoresassegnatari <strong>del</strong>la bassa chirurgia: salassi, medicazioni,incisioni, estrazioni dentarie ed altro. La separazionetra le prime due categorie, in tenace lotta traloro, avviene soprattutto, come scrive Fauvet, perché- 150 -
GIUSEPPE LAURIELLO«la scienza <strong>del</strong>l’epoca, preferendo le discussioni scolastichee l’uso potente <strong>del</strong>la parola e <strong>del</strong> sillogismo,nutre un grande disprezzo per l’attività manuale» 21 , cheè opera di fatti, non di parole. La dicotomia all’internodei chirurghi invece, specialmente rimarcata inFrancia, si consolida soprattutto per la palese ignoranzadei tonsores, tanto che i chirurghi ‘letterati’ se neallontanano, associandosi in una potente corporazione,detta di San Cosma e Damiano, iscrivendosi nelLibro dei Mestieri <strong>del</strong> Prevosto di Parigi e integrandosicon l’Università. Si staccano e si differenziano daichirurghi barbieri, che peraltro detestano, anche nellalunghezza <strong>del</strong>l’abito: i primi infatti saranno ‘quelli dallalunga veste’, i secondi ‘dalla corta veste’.Nonostante siano molto attivi nei loro compiti operatori,i barbieri purtroppo non godono di buona famaanche per i molti danni che procurano. Si vuole che una<strong>del</strong>le motivazioni che abbiano indotto Federico II apromulgare una definitiva regolamentazione <strong>del</strong>lamedicina attraverso le Constitutiones 22 sia stato proprioil ‘grido di dolore’ che si levava tra i sudditi contro i chirurghiempirici. Scrive Pazzini, riportando il pensiero diGuy de Chauliac 23 e di Lanfranco 24 , che addirittura moltichirurghi aulici lasciavano di proposito alcuni interventigiudicati pericolosi nelle mani di questi ambulanti eciarlatani avidi di guadagno 25 per non mettere a repentagliola propria reputazione. L’arabo Albucasi 26 infattiinveisce contro costoro per i danni causati dalla loroignoranza 27 , che pone in cattiva luce anche la partenobile <strong>del</strong>la branca. E tale è il rammarico di Bruno daLongobucco 28 : «Ac operationes sacrificationis et flebotomiaenoluerunt medici propter indecentiam exercere, sed illam berberiorumin manibus relinquerunt» 29 e lo stesso Lanfranco silamenta <strong>del</strong>l’abbandono di tale disciplina in mano aimestieranti, accusando i medici fisici di averla relegatanel più completo degrado a causa <strong>del</strong> loro disdegno apraticarla, ritenendola indegna per un professionista 30 .Identiche conclusioni sono espresse anche dall’ingleseGiovanni di Mirfield: «Se non vado errato, i medici untempo praticavano la chirurgia; oggi invece esiste unadistinzione tra medici e chirurghi. Io temo che tuttoquesto sia da attribuire all’orgoglio, poiché è noto che imedici disprezzano lavorare con le mani, anche se ho ilsospetto che questo dipenda dal fatto che non conosconola tecnica operatoria. La conseguenza è che oggi lepersone credono che un individuo non possa praticareentrambe le specialità, ma le persone bene informatesanno che nessuno può dirsi un buon medico, se trascuracompletamente la chirurgia e, d’altro canto, un chirurgovale ben poco se ignora la medicina» 31 . Stesseconsiderazioni esprime Enrico de Mondeville 32 , il grandechirurgo francese, che esclama: «Da tempo i medicihanno lasciato il salasso ai chirurghi, perché indegno diloro; poi i chirurghi hanno ceduto l’operazione ai barbieri»33 , sottolineando come l’attività dei barbieri sia unlavoro puramente meccanico, paragonabile a quello deisarti, dei pellettieri e di altri artigiani rozzi e illetterati,appreso semplicemente guardando fare, e come questiilletterati si vantino poi di detenere nell’operazionemanuale un patrimonio di conoscenze innato ed ereditario34 .La rinascita <strong>del</strong>la chirurgia scientifica con i Maestri<strong>del</strong>la Scuola medica di Salerno quali Ruggiero 35 eRolando 36 , il segnalarsi di alcuni illustri operatori comeLanfranco, Henry de Mondeville e Teodorico de’Borgognoni 37 , il diffondersi <strong>del</strong>le Università nel XIII eXIV sec. e conseguentemente <strong>del</strong>le Scuole di medicina,contribuisce ad arginare il fenomeno <strong>del</strong>l’empirismo e<strong>del</strong>la ciarlataneria, ma la presenza e l’attività dei barbierichirurghi comunque sopravvivono. Sopravvivonoperfezionandosi e spesso raggiungendo un alto gradodi perizia nella pratica quotidiana (pure se a volte ailimiti <strong>del</strong>l’illegalità), tanto che viene loro riconosciutoil diritto di praticare la chirurgia esterna, anche se conil divieto tassativo di somministrare medicamenti 38 . Eproprio nell’ambito di questa categoria tra ‘400 e ‘500compaiono figure di spicco, che fanno dei barbieri edegli incisori, a dirla con il Malgaigne 39 , dei veri innovatori<strong>del</strong>la chirurgia. Tra queste vanno ricordatiPierre Franco 40 , Ambrogio Parè 41 e Felice Wuertz 42 , ilprimo, inventore <strong>del</strong>la litotomia sovrapubica 43 , ilsecondo, padre <strong>del</strong>la chirurgia moderna e soprattuttonoto per aver trattato le ferite con astringenti e cicatrizzanti,abolendo il cauterio così caro ai chirurghiarabi, il terzo per la svolta data al trattamento <strong>del</strong>lefratture e <strong>del</strong>le lussazioni.Intere famiglie di barbieri itineranti conseguonoquindi meritata fama per le loro audaci e (bisognaammetterlo) eccellenti tecniche innovative. Di questiricordiamo tra gli italiani i Branca 44 e i Vianeo 45 , nonchèi Norcini, i Preciani e i Cerretani. I Branca di Catania ei Vianeo di Tropea, in Calabria, acquisiscono vasta famasoprattutto per la loro abilità negli interventi di ricostruzionenasale, ovvero di rinoplastica, seguendo il metodocelsiano <strong>del</strong>la sutura dei lembi e utilizzando frammentidi pelle asportati dall’avambraccio 46 .- 151 -
SALTERNUMDegni di menzione alcune famiglie di centri umbridivenuti celebri come Norcia, Preci e Cerreto diSpoleto 47 . Sono dinastie di ‘Asclepiadi’, evoluti neltempo da grossolani ‘empirici’ a medici fisici dotati dititoli accademici, creatori di originali strumenti chirurgicied estensori di testi e trattati di tecniche operatoriepubblicati e accolti con generale consenso. I Norcinisono chirurghi empirici, personaggi girovaghi, grossolaninelle maniere e nel linguaggio, privi di preparazioneuniversitaria, ma ben dotati di esperienza pratica. Sivuole la loro manualità legata all’antica esperienza dimanipolazione <strong>del</strong>le carni suine e alla tecnica di castrazionedegli animali.Per quanto riguarda poi la perizia dei Preciani, essaè annodata alla presenza <strong>del</strong>la vicina Abbazia benedettinadi S. Eutizio a Piedivalle di Preci, noto centro diattività chirurgica nel Medioevo 48 , dove i monaci, nonpotendo più esercitarla personalmente, si vuole abbianoistruito gli abitanti <strong>del</strong> luogo 49 e che questi abbianopoi tramandato le tecniche da padre in figlio. Allostesso modo i Cerretani, guaritori chirurghi e spacciatoridi unguenti, al cui nome si vuole associata la parola‘ciarlatano’. Ai chirurghi norcini era attribuita particolareabilità negli interventi di rimozione di cataratta,nelle litotomie vescicali e, purtroppo, anche nella evirazionedei bambini ai fini di procurare voci biancheper i cori <strong>del</strong>le chiese. Anche ai Preciani furono attribuitigli stessi meriti, mentre i Cerretani erano notisoprattutto come cavadenti.Degni di menzione, in quanto espressione di questoprocesso evolutivo da empirismo tecnico ad applicazionescientifica e quindi di passaggio alla chirurgiaprofessionale, sono il norcino Benedetto Riguardati 50 ,chirurgo di Sisto IV e di Francesco Sforza, e, tra iPreciani, Durante Scacchi 51 , operatore di cataratta<strong>del</strong>la regina Elisabetta d’Inghilterra, Alessandro eOrazio Catani, operatori di ernie (Alessandro, «medicocerusico di Camera <strong>del</strong> Re <strong>del</strong>le due Sicilie,Ferdinando IV di Borbone» e Orazio, medico <strong>del</strong>Sultano Murad I nel 1660), Sigismondo Carocci 52 , operatoredi cataratta di Eleonora Gonzaga.Accanto a questi, vanno richiamati anche altrinomi di chirurghi, che pur provenendo da famiglie disemplici empirici circulatores, seppero elevare l’arte,affinando il proprio livello intellettuale, la tecnica el’ingegno, sì da raggiungere consistenti traguardi nellascala scientifica e sociale: Girolamo Accoramboni 53 daGubbio, Lettore di Chirurgia a Perugia; GiuseppeMaria Bacchettoni 54 , litotomo a Bologna, DiomedeAmici, operatore a Piacenza, Arcangelo Censurati, alservizio <strong>del</strong>l’Arciduca d’Austria, Bartolomeo Bittozzi 55ed ancora i Lapi, famosi litotomi, i Serrantoni e altri 56 .Si vuole che circa trenta famiglie dei territoriumbro-marchigiani abbiano praticato tale chirurgia ditradizione, trasmettendosi le tecniche da padre infiglio e che i trattamenti siano stati dei più eterogenei:dai clisteri, salassi e coppettazioni, alle medicazioni diferite e di piaghe, alla cauterizzazione, all’applicazionedi unguenti ed impiastri e via via ai procedimenti piùimpegnativi: incisioni di ascessi, estrazioni di denti, dicalcoli vescicali, dilatazioni di stenosi uretrali, erniotomie,rimozioni di cataratte.Di particolare rinomanza sono gli interventi dicataratta e di litotomia 57 . L’estrazione <strong>del</strong>la cataratta,malattia caratterizzata da un offuscamento progressivo<strong>del</strong> cristallino, che, se non curata, porta alla cecità,è trattata secondo il metodo celsiano 58 . Essa consistenella dilatazione <strong>del</strong>la pupilla con uno strumento specialedetto ‘onerino’, cui segue la rotazione e l’abbassamento<strong>del</strong> cristallino sotto la pupilla mediante unapposito ago, introdotto nel bulbo oculare, ed infine iltrattamento conclusivo con colliri applicati medianteun particolare instillatore.Il termine ‘litotomia’ invece è riferito alla tecnica diestrazione dei calcoli dalla vescica, concrezioni strettamentelegate ad un’alimentazione abnorme, ricca diossalati e urati di calcio 59 . L’intervento eseguito dagliempirici per via perineale è condotto essenzialmentecon due strumenti: il ‘tenacolo litotritore’ per romperela pietra e l’‘alfonsino’ per dilatare la breccia operatoriae raccogliere i frammenti <strong>del</strong> calcolo (il cosiddetto‘piccolo apparato’) 60 . L’emostasi è ottenuta per cauterizzazionead incandescenza con appositi ‘candendi’.L’attività dei barbieri chirurghi girovaghi riconosceuna rifioritura nei secoli XVI-XVII, che dura fino atutto il XVIII sec. Scrive di costoro LeonardoFioravanti, chirurgo <strong>del</strong> XVI sec. e grande fautore diParacelso: «…servono per cavar sangue agli ammalati,tanto dalle vene tanto con ventose. Medicano i feriti egli fanno le stoppate…Cavano i denti e fanno altrimille servizi» 61 . Ma ancora una volta queste personesembra non incontrino il favore dei cattedratici, che lidefiniscono: «lacchè ripuliti, vera razza di perfidi brigantimuniti di baffi e rasoi, una miserabile genia» 62 .Sono infatti equiparati ai fornai, ai birrai e ad altri lavoratoriconsimili. Sorprendentemente però il veneziano- 152 -
GIUSEPPE LAURIELLOmedico fisico Giovanni Marinello (XVsec.), eclettico e colto umanista, nel mentre,condividendo il parere comune, liconsidera responsabili <strong>del</strong> degrado <strong>del</strong>lachirurgia: «l’arte <strong>del</strong>la cirugia è così benstrapazzata e data quasi in preda ai barbieriche mai ai suoi giorni fu peggio» 63 , ècostretto a rendersi conto ed ammettereche egli stesso come gli altri ‘addottorati’suoi colleghi siano, è vero, ferrati in culturafilosofica e preparazione teorica, manello stesso tempo digiuni in manualitàpratiche. E quindi, pur deplorando i barbierie la loro chirurgia, ritenuta avventatae pericolosa, non si fa scrupolo difronte ad un parto cesareo di suggerirnel’intervento per pungere l’amnios, in casodi riluttanza <strong>del</strong>la levatrice, presentandolocome atto di poco conto: «Quandoperò alla commare non bastasse l’animodi fare questo officio, si potrà adoperareogni barbiere, chè ad opra tale pocaindustria vi vuole, e bisogna solo avvertiredi non passare troppo avanti col ferroper non ferire la creatura» 64 . In un certosenso lo conferma l’anatomista e chirurgo GabrieleFalloppia 65 , luminare <strong>del</strong>la medicina patavina rinascimentale,quando, nell’introduzione al suo testo di chirurgia,specifica che il suo trattato non solo potrà essereutile ai medici, ma anche ai barbieri e a chiunqueintenda praticare la chirurgia 66 . Allo stesso modo ilcerusico napoletano di Montesarchio Tiberio Malfinel suo manuale Il barbiere 67 riconosce nei colleghi lafunzione di ‘vicari <strong>del</strong> medico’, apprezzandone la validità<strong>del</strong>le prestazioni (fig. 2).Tra questi empirici girovaghi si distinguono iCerretani, da Cerreto di Spoleto, patria di guaritori,chirurghi barbieri e spacciatori di farmaci miracolosi;molti sono cavadenti, una specialità che appare loroconnaturata 68 . La carie e i denti guasti sono osservazionedi diffuso rilievo nei secoli XV-XVII, lesioniprobabilmente dovute ad alimentazione incongrua esquilibrata, carente di vitamine e di sali minerali, masoprattutto conseguente a una scarsa o nulla igieneorale. La cura <strong>del</strong>l’odontalgia, ovvero <strong>del</strong> mal di denti,è una loro prerogativa anche per gli indiscutibili successi,legati alla particolare destrezza nell’estrarre conrapidità l’elemento malato, che compensa in certo qualFig. 2 - Tiberio Malfi di Montesarchio,autore <strong>del</strong> manuale Il barbiere (Napoli,1626).Fig. 3 - ‘Il cavadenti’ di Jan Steen, 1651.Aia Mauritshuis.modo la carenza di cognizioni mediche edi anatomia topografica. Ma la celerità,requisito obbligato dal momento chenon si conosce alcuna anestesia, comportaanche un maggiore rischio di danniiatrogeni. Tali effetti collaterali, purtropponon rari, unitamente alla proverbialeciarlataneria 69 provocano nei riguardidegli esecutori una ironia graffiante daparte di epigrammisti e di pittori. Artisticome Pietro Longhi 70 , Franz van Mieris 71 ,Jan Steen 72 , così attenti nell’osservazioneacuta <strong>del</strong>la vita quotidiana <strong>del</strong>la gente etanto spiritosi nel coglierne le situazionipiù bizzarre e divertenti, non si lascianosfuggire questi personaggi così stravagantie truculenti, emblematici e onnipresentinelle piazze e nelle fiere con laloro variopinta teatralità (figg. 3-4-5). Livedi agitarsi immaginosi, allegri, pieni dispirito, sciorinare finti diplomi di laurea eattestati, nel mezzo di uno stuolo di figureeterogenee: saltimbanchi, suonatori ditromba, strilloni, domatori, circondati dauna folla chiassosa di curiosi e di sfaccendatiche smorzano con il loro clamore le urla dei malcapitatidi turno 73 . L’estrazione dentaria in fondo èanche un’attrazione, uno spettacolo tanto più avvincentequanto più è drammatico, quanto più è spietato.E osservare questo signore sul palco, vestito in abitoricercato, mentre si dimena con atteggiamenti istrioneschie trancia in aria quell’orribile tenaglia demolitriceFig. 4 - ‘Il cavadenti’ di Pietro Longhi (1702-1785). Milano, Museo Brera.- 153 -
SALTERNUMche è il ‘pellicano’, è scena di forte emozione.Omodei Zorini cita la descrizione<strong>del</strong>la scena che ne fa Aulizio <strong>del</strong> momentoin cui la vittima è nelle grinfie <strong>del</strong>cavadenti: «La testa <strong>del</strong>l’operando poggiasull’addome <strong>del</strong> dentista, mentre legambe penzolano fuori; una posizionevoluta dal dentista per evitare che ilpaziente per il dolore punti i piedi, rovesciandoindietro la sedia su cui è sedutoe provocando la perdita <strong>del</strong>la presa daparte <strong>del</strong> ‘pellicano’ e il conficcamento diquesto nella guancia» 74 . E piace ancoraimmaginare tale personaggio, mentreimbonisce il pubblico vantando diplomi e onorificenze:«Favorisca chi vuol cavarsi i denti. Sarà servito abuon prezzo: mezzo scudo a dente e chi ne caveràdieci, avrà l’undicesimo gratis».Il termine ‘dentista’ in latino compare la primavolta nel 1363 nella Chirurgia magna di Guy deChauliac 75 , mentre in italiano compare in una incisione<strong>del</strong> 1731 riferita a tale G. Battista Grimaldi (fig. 6).Il barbiere cerusico quindi resta una figura beninserita nella società ed il più <strong>del</strong>le volte regolarmenteautorizzato ad esercitare la propria arte 76 . In moltesituazioni si presenta effettivamente nelle vesti di vicario<strong>del</strong> medico, come nei tanti sperduti villaggi e nellecampagne, dove è difficile trovare un medico professionistadisposto ad aprire un ambulatorio, a parte poila considerazione <strong>del</strong>la relativa rarità di questi ultimi neisecoli scorsi. In molti casi quindi il barbiere rappresentadavvero e a tutti gli effetti il medico condotto e la suabottega è ben individuabile attraverso l’insegna sull’ingresso<strong>del</strong>le tre bacinelle o <strong>del</strong>la colonnina a fasce rossee bianche, emblema <strong>del</strong> sangue e <strong>del</strong>le bende.A conclusione di quanto sopra e a maggior completezzami piace aggiungere qualche considerazionesullo stato <strong>del</strong>l’arte nel nostro territorio, anche in epocherelativamente recenti. Ricordano infatti. ManòInfante e Pasquale Natella 77 in un loro saggio riguardanteil culto di S. Gennaro di Gorga (paesino <strong>del</strong>Cilento), visto nel contesto sociale <strong>del</strong>la sua venerazione,che in questo borgo operava «la figura di un certoGiovanNicola de Consilio, medicus cerusicus, personaggioa metà tra l’artigiano e il professionista, una sortadi barbiere abile nel cavare i denti, fare piccoli interventichirurgici e medicare le ferite». Siamo sul cadereFig. 5 - ‘Il ciarlatano olandese’ di Franz vanMieris il Vecchio (1635-1681). Firenze,Uffizi.<strong>del</strong> secolo XVI, quindi nihil sub sole novi,ma Infante e Natella ci raccontano,ovviamente documentandolo, come, perla constatata utilità pubblica <strong>del</strong> suomestiere, il de Consilio fu esentato dalletasse dalla Regia Sommaria in cambio<strong>del</strong>la promessa «de servire ad insagnare tuttie qualsivoglia homini et cittadini de ditto casaledi Gorga et loro famiglie gratis et servire in dettoservitio de insagnare con la debita diligentia» 78 .Nello stesso tempo, offerta daRoberto Marino, leggiamo un’impietosarelazione sullo stato <strong>del</strong>la salute nelPrincipato Citra (leggi provincia diSalerno) nella prima metà <strong>del</strong> XIX secolo, quando oramaila medicina scientifica sta avanzando a grandipassi 79 , indagine svolta sulla situazione sanitaria nelRegno di Napoli durante il cinquantennio precedentel’Unità d’Italia: un degrado terrificante, culturale,scientifico e organizzativo, sul quale è meglio sorvolare.Dal rapporto si evince la povertà <strong>del</strong>la popolazione,stanziata soprattutto nelle aree rurali e, contestualmente,l’arretratezza <strong>del</strong>l’intervento terapeutico, cuicorrisponde una rilevante incidenza di stati di malattiaa prognosi severa, spesso a carattere epidemico, lamaggior parte incurabili. Nello stesso tempo le condottesono vacanti per la scarsa presenza di medici sulterritorio (nel 1812 sono censiti in provincia appena164 medici, un numero, che anche per la loro irregolaredistribuzione, è largamente inferiore ai reali bisogni<strong>del</strong> circondario), medici, peraltro, la maggior partedei quali sono sprovvisti di una adeguata preparazioneprofessionale: una condizione che definire sconcertanteè un eufemismo. Questo documento evidenziatra l’altro la sussistenza di un largo numero di ‘salassatori’,cioè di barbieri chirurghi, a fronte di una sparutapresenza di medici. «Un ruolo di un certo rilievo -sottolinea l’Autore - è tenuto dai salassatori, sia perchéil salasso è largamente praticato, sia perché in moltipaesi sono gli unici ad esercitare l’arte salutare.Esigendo peraltro compensi relativamente modesti,sono le uniche persone di cui può servirsi la poveragente. Questi salassatori non si limitano alla sola praticadi cavare sangue agli ammalati, ma curano fratture,causticano morsicature di animali ed insetti velenosi,incidono ascessi, estirpano i denti» 80 . La maggiorparte di essi esercita senza autorizzazione, ma anchequelli che hanno sostenuto appositi esami orali presso- 154 -
GIUSEPPE LAURIELLOle Autorità accademiche diNapoli, si presentano «di infimolivello culturale, quasi tutti barbierie qualcuno macellaio, senzasperanze di arricchimento scientificoper la loro professione» 81 .Una lettera <strong>del</strong> 1817 <strong>del</strong> sindacodi Pagani inviata all’Intendente<strong>del</strong>la provincia di Salerno eriportata dal Marino, rivelacome questi artigiani siano inrealtà dei poveri diavoli: «…lanecessità li ha fatti istradare nell’artedei salassatori e apprestanoall’occorrenza quell’aiuto,riprendendone come mercedegrani due e mezzo. Non hannoalcuna autorizzazione e sonoinabilitati a provvedersi per la miseria» 82 . Con il passardegli anni e con il perfezionarsi <strong>del</strong>le condotte neiComuni <strong>del</strong>la Provincia, anche la presenza di questipersonaggi tende a dileguarsi. Scrive il Marino: «manoa mano che i comuni andavano assumendo dei medicicondotti per i poveri, la figura <strong>del</strong> salassatore, semprepiù arretrato rispetto ai progressi <strong>del</strong>la scienzamedica, tende a scomparire» 83 .Nel Medioevo, ed anche in età più tarda, la valigettache accompagnava il barbiere chirurgo doveva prevedereobbligatoriamente alcuni strumenti imprescindibiliper l’attività ‘meccanica’ <strong>del</strong>l’operatore, e, precisamente,una pinza, un rasoio, una sonda, <strong>del</strong>le lancette,degli aghi e cinque unguenti ad azione maturativa,astringente e cicatrizzante: l’unguento ‘apostolico’,l’unguento ‘aureo’, l’unguento ‘basilico’, l’unguento‘bianco’ e l’unguento ‘di altea’ 84 .L’unguento ‘apostolico’ era così detto per la presenzanel preparato di dodici ingredienti: pece greca,pece navale, gomma ammoniaca, terebintina, olibano,galbano, opoponace, b<strong>del</strong>lio, mirra, aristolochia rotonda,litargirio e verderame, oltre agli eccipienti grassiper il confezionamento: cera gialla e/o l’olio di lauro.I primi nove ingredienti sono <strong>del</strong>le gommoresine.Queste agiscono localmente formando uno strato diFig. 6 - Giovan Battista Grimaldi.protezione atto a rafforzare ladifesa verso stimoli e insultiesterni. Altre proprietà collateralisono l’incremento <strong>del</strong>la morbidezzae <strong>del</strong>l’elasticità dei tessuti(azione emolliente); la riduzione<strong>del</strong> turgore (azione demulgente),la creazione di una barriera didifesa dagli stimoli irritativiambientali (azione lenitiva), edinfine, in caso di discontinuitàtessutale per ferite, ulcerazioni oaltro, l’agevolazione dei processiriparativi (azione cicatrizzante).Gli ultimi tre ingredienti invecepresentano un’azione astringente,nel senso che riducono l’infiammazione,la sensibilità dolorificae l’intumescenza dei tessuti lesi. L’eventuale presenzadi olio di lauro conferisce al preparato ancheuna certa azione maturativa.L’unguento ‘aureo’ è composto a sua volta da terebintina,pece greca (‘colofonia’ 85 ), incenso, mastice diChio 86 e zafferano. L’azione <strong>del</strong> medicamento è prevalentementeprotettiva e cicatrizzante; la presenza dicera gialla le dà il colore dorato, da cui il nome.L’unguento ‘basilico’ ha come ingredienti la trementina,l’incenso, la mirra e la pece. Agisce fondamentalmentecome revulsivo (maturativo).L’unguento ‘bianco’ è preparato con cerussa, oliorosato e canfora. Azione protettiva e astringente. Ilnome è legato al colore datogli dalla cera bianca.L’unguento di radici di altea, ricco di mucillagini,presenta a sua volta proprietà demulgenti e protettive.Le conquiste <strong>del</strong>la medicina scientifica e soprattutto<strong>del</strong>la chirurgia nel XIX secolo, unitamente ai progressi<strong>del</strong>l’organizzazione sanitaria accelerano la rarefazionedi queste figure singolari e stravaganti <strong>del</strong>lastoria <strong>del</strong>l’arte salutare; stravaganti, ma a volte anchebenemerite nei momenti più oscuri <strong>del</strong> percorso evolutivo<strong>del</strong>l’umana società. Nel luminoso cammino<strong>del</strong>la storia <strong>del</strong>la medicina non resta oggi che una pallidatraccia <strong>del</strong> loro passaggio.- 155 -
SALTERNUMNote1Casa costruttrice citata da BELLION 1986,p. 314.2Il pellicano, utilizzato per l’estrazione dentaria,è uno strumento storico nell’evoluzionetecnologica <strong>del</strong>l’odontoiatria. Deriva il suonome dalla supposta rassomiglianza con ilbecco <strong>del</strong> pellicano ed era costruito, provvistodi un gancio e di uno stelo, in varia foggiacon parti intercambiabili. Applicatosulla corona <strong>del</strong> dente e sull’esterno <strong>del</strong>lagengiva, con una apposita manovra rotatoria,brutale e non priva di rischi, consentival’estrazione <strong>del</strong> dente dal suo alveolo. Laprima illustrazione è <strong>del</strong> 1483 nella Practicadi Giovanni d’Arcoli (1412 – 1484), professoredi chirurgia a Bologna e a Padova.Divulgato successivamente da W. H. Ryff(1500? – 1562) con la pubblicazione <strong>del</strong>laChirurgia magna, (Strasburgo 1545), divienepopolare intorno alla metà <strong>del</strong> XVI sec. Neltempo lo strumento ha subito modifiche eadeguamenti tecnici, di cui di volta in voltasono stati autori Lorenz Heister (1683-1758), René Jacques Garengeot (1688-1759), nonché gli italiani Mauro Soldo(XVIII sec.), Antonio Campani (XVIIIsec.) e altri. Rimane in uso fino alla metà <strong>del</strong>XIX sec3Nato ad Alessandria ed attivo nel II sec.; lasua dottrina era basata sull’osservazione <strong>del</strong>malato e sull’esperienza <strong>del</strong> medico.4Nato a Sidone in Libano e attivo a Romanel I sec., fu inventore di un particolarelitotomo per l’asportazione dei calcolivescicali, spesso citato da Celso nel De medicina.5Chirurgo vissuto a Roma ai tempi diTraiano (tra il I e II sec. d.C.). Scrisse unlibro di anatomia, rilevando le propriecognizioni da dissezioni condotte su animali.Tra le sue osservazioni la descrizione deinervi ottici e <strong>del</strong> cristallino.6Medico enciclopedista romano operante aitempi di Augusto e Tiberio, autore di uncelebre testo di medicina: De re medica inotto libri, prima opera scientifica scritta inlatino, un ottimo latino classico, comprendentel’intero scibile medico conosciutoall’epoca. Probabile lavoro di compilazioneda opere greche con proprie terminologietecniche, che nel Rinascimento valsero asostituire quelle arabe.7Anatomico romano <strong>del</strong> I sec., <strong>del</strong> quale sihanno solo menzioni indirette e da cuiGaleno sembra abbia appreso molte <strong>del</strong>lecognizioni riportate nei suoi libri. Descrissei nervi periferici e la loro funzione. Si vuoleabbia scoperto il nervo glossofaringeo.8Chirurgo di scuola pneumatica, nato adApamea, città <strong>del</strong>l’Asia minore (oggi rovinein Siria), ma vissuto a Roma nel II sec.; abilee innovativo, di lui si ricordano la legaturadei vasi sanguigni e le amputazioni.9Vissuto sotto Traiano nella prima metà <strong>del</strong>II sec., si distinse nella traumatologia cranicae nelle trapanazioni. Giovenale lo ricordacome castratore di schiavi nella satira VI<strong>del</strong>la sua raccolta poetica: «Ergo expectatos aciussos crescere primum / testiculos, postquam coeperuntesse bilibres / tonsoris tantum damno rapitHeliodorus» (Sat. VI, 371-373).10Di scuola metodica, attivo nel II sec., conseguìvasta fama come operatore. Restanodei suoi scritti numerosi frammenti, raccoltie pubblicati nel 1799 dal chirurgo tedescoCurzio Sprengel, estensore <strong>del</strong>la prima storia<strong>del</strong>la medicina edita a stampa: Storiaprammatica <strong>del</strong>la medicina.11Vissuto ai tempi di Traiano e Adriano, èricordato soprattutto come ginecologo.Formatosi in Alessandria presso la scuolaempirica, venne a Roma, dove svolse la propriaattività professionale, scrivendo untrattato: Le malattie <strong>del</strong>le donne. Di questo l’originalegreco è perduto, ma ci resta una traduzionedi Moschione <strong>del</strong> V-VI sec., unicotesto di ginecologia in circolazione prima<strong>del</strong> De mulierum passionibus di Trotula.12La medicina medievale dal VI sec. è appannaggiopressoché esclusivo dei monasteri,specialmente benedettini, o comunque difigure ecclesiastiche, e raggiunge l’apogeonell’XI. Nelle infermerie claustrali è praticatasia la medicina che la piccola chirurgia:non a caso i primi farmaci anestetici hannoapplicazione proprio in ambito conventuale.Cfr: CAPREZ 1952; PENCO 1961; CRISCIANI;LAURIELLO 2005.13POUCHELLE 1983, p. 33. Cfr. anche WALSH1908.14Il cosiddetto Giuramento ippocratico è untesto attribuito ad epoca anteriore adIppocrate e documenta la presenza di unaclasse medica organizzata antecedente laScuola di Coo e già disciplinata da leggi cheescludevano almeno in parte l’attività chirurgica.15La frase, più volte impropriamente ripetutae attribuita a pronunce conciliari, è statafonte di una fitta e prolungata diatriba tragli storici. In realtà la citazione appare per laprima volta nell’opera: Recherches critiques ethistoriques sur l’origine, sur les diverses etats et surle progrès de la chirurgie en France, scritta dalchirurgo e storico medico franceseFrançois Quesnay e pubblicata nel 1774.L’espressione in effetti non è che la traduzionelatina fatta dall’Autore di un passo diEtienne Pasquier in Recherches sur la France<strong>del</strong> 1550: «…et comme l’eglise n’abhorre rien tantque le sang».16Il salasso periodico nella comunità claustraleera previsto e opportunamente regolamentatoin ossequio alla teoria ippocraticadi depurazione organica.17CORSINI 1922; PAZZINI 1980.18Pietro Ispano, ovvero Pietro Giuliano,nato a Lisbona nel 1226, fu eletto papa nel1276 con il nome di Giovanni XXI. Morì aViterbo otto mesi dopo l’elezione, in seguitoa un grave incidente. Ebbe fama di medicooculista e scrisse molti libri di argomentosanitario, dei quali celebre è il Thesauruspauperum, un libro di terapia molto in voganel passato. Stampato per la prima volta aVenezia nel 1494, riguarda prescrizionimediche ad uso <strong>del</strong>la povera gente, di colorocioè che non potevano permettersi farmacicostosi allora molto richiesti. Il libroebbe ottantuno edizioni e numerose traduzioni,tra cui una in occitanico e un’altra insiciliano.19Attivo tra l’XI e il XII secolo.20CONTIERI 1990, p. 46.21FAUVET 1955, p. 49. Scrive Mondeville: «Imedici non sanno nulla e altro non fanno aimalati che parlar loro, e tutti, indifferente-- 156 -
GIUSEPPE LAURIELLOmente, che il caso lo esiga o no, fanno andardi corpo. Se si chiama il medico, questivorrà per prima cosa purgare il paziente,che forse non ha bisogno di evacuare»’(NICAISE 1893 p. 100).22Le Constitutiones Augustales promulgate daFederico II a Melfi nel 1231 e fondate suldiritto romano e normanno, nascono comeorganico ordinamento legislativo per ilregno di Sicilia. Tali disposizioni prevedonotra l’altro anche una regolamentazione deglistudi e <strong>del</strong>l’esercizio <strong>del</strong>la medicina. E’ fattoobbligo infatti a chi vuole professare l’artemedica di sostenere un esame di verifica <strong>del</strong>proprio sapere presso i Maestri <strong>del</strong>la Scuoladi Salerno, previo un corso di studi quinquennaleprestabilito (ZECCHINO 2002).23Guy de Chauliac (1300-1370) fu uno deipiù illustri chirurghi francesi <strong>del</strong> medioevo,formatosi a Montpellier e poi a Bologna; fuarchiatra di papa Clemente VI ad Avignone,dove si scontrò con il Petrarca in una acerrima,lunghissima disputa. Scrisse laChirurgia magna, un classico per l’epoca, tradottoin francese e stampato nel 1478.24Guido Lanfranchi (? – 1306), milanese,costretto da Matteo Visconti a lasciare lasua città nel 1290, riparò a Parigi, doveassurse a grande fama, tanto da divenire ilcapostipite <strong>del</strong>la chirurgia francese. ScrisseLa grande chirurgia, che fu testo di enormeprestigio. Celebre è la sua affermazione:«Non si può essere buon medico, se si ignoranole operazioni chirurgiche, né si puòoperare, se non si conosce la medicina»,mostrando in tal modo la propria convintaavversione per l’operato dei barbieri.25PAZZINI 1947, vol. I, p. 507.26Chirurgo moresco operante a Cordovaintorno al 1000, autore <strong>del</strong>l’unica opera dichirurgia araba a noi nota: Kitab al Tesrif, in30 libri, in cui è sottolineata tra l’altro, invece<strong>del</strong> coltello, una decisa predilezione per ilcauterio negli interventi chirurgici.27Albucasi 1992, p. 5.28Chirurgo calabrese, formatosi a Bologna eoperante a Padova nel XIII sec. Scrisse dueopere di chirurgia stampate a Venezia nel1519.29Cit. da CASTIGLIONI 1948, p. 346.30«…i fisici hanno abbandonato ai laici leoperazioni, sia perché disdegnano, comedice qualcuno, l’opera manuale, o piuttosto,come io penso, perché ignorano il modo difare gli interventi…» (Chir. magna, f. 249).31HAEGER 1989, pp. 90-91.32Enrico de Mondeville (1260? – 1320?),chirurgo normanno, allievo di Teodoricode’ Borgognoni di Lucca, fu maestro di chirurgiaa Montpellier e poi a Parigi. Chirurgopersonale di Filippo il Bello, di grande levaturaintellettuale, scrisse un libro di chirurgiadi vasta rinomanza e diffusione, tradottoin francese da E. Nicaise nel 1893(NICAISE 1893). Sostenne la necessità per ilchirurgo di conoscere preventivamente l’anatomia.33NICAISE 1893, p.4.34ID., Ibidem, pp.197-198.35Ruggiero di Frugardo o di Fugaldo, chirurgosalernitano attivo tra il XII e il XIII.Scrisse nel 1180 un libro di chirurgia notocome Post mundi fabricam o Practica Chirurgiae,primo testo chirurgico redatto nell’Occidentecristiano in età medievale.36Rolando de’ Capezzuti da Parma, allievo diRuggiero. Scrisse una Chirurgia intorno al1250, riportando le idee <strong>del</strong> maestro, chiosandolee aggiornandole.37Teodorico de’ Borgognoni (1205 – 1298),nato a Lucca, ecclesiastico ed esperto nell’artechirurgica, scrisse un libro di chirurgia,in cui, specialmente nel campo <strong>del</strong>lemedicazioni <strong>del</strong>le ferite, in netta contrapposizionecon la prassi salernitana, consiglia ditrattare le stesse con abluzioni di vino efasciature pulite e non di favorire la suppurazionecome suggerito da Ruggiero.38«…sono dei pratici, ai quali manca di solitoogni fondamento di studio, ma ciò nontoglie che talora questi uomini abbianooccupato un posto onorevolissimo nellastoria <strong>del</strong>la chirurgia per la grande periziatecnica con la quale eseguirono le operazionipiù ardite» (CASTIGLIONI 1948, p. 494).39Il francese Giuseppe Francesco Malgaigne(1806-1865), oltre che maestro versato inanatomia chirurgica, fu eccellente storico<strong>del</strong>la chirurgia. Curò, fra l’altro, l’edizione<strong>del</strong>le opere di Ambrogio Parè, padre <strong>del</strong>lachirurgia francese, pubblicate nel 1840 conun ampia biografia e una dotta introduzione.40Pietro Franco (1500 – 1561), detto ilProvenzale, perché nato in Provenza, fuchirurgo empirico di grande abilità, rivalutatosoltanto in tempi moderni; ebbe unavita assai movimentata a causa <strong>del</strong>le guerredi religione che agitavano la Francia. Fuappellato ‘tagliatore di vescica, di ernie eoperatore di cataratta’ per la genialità e laperizia applicata agli interventi. Scrisse unPetit Traité, pubblicato nel 1556, dove risaltail grado di avanzamento tecnico applicatoalla sua attività chirurgica.41Il francese Ambrogio Parè (1510-1590)rappresenta la massima espressione <strong>del</strong>larinascita <strong>del</strong>la chirurgia francese e <strong>del</strong>la chirurgiain generale. Vissuto nel XVI sec. iniziòla sua attività come barbiere infermierepresso l’ospedale Hotel Dieu di Parigi, poifu barbiere chirurgo traumatologo nell’armata<strong>del</strong> maresciallo Montjean nella campagnad’Italia, per concludere infine la suacarriera come primario chirurgo nell’HotelDieu. Scrisse numerosi libri sul trattamento<strong>del</strong>le ferite, ma la fama gli giunse dallaprima pubblicazione in assoluto sulla cura<strong>del</strong>le lesioni da armi da fuoco: Mèthode detraicter les playes par arquebuses et autres bastonsa feu, pubblicato nel 1545.42Barbiere chirurgo svizzero di Zurigo, vissutonel XVI sec., fu autore <strong>del</strong> libro Praticanella cura <strong>del</strong>le ferite.43La litotomia sovrapubica è l’intervento diasportazione dei calcoli vescicali per viaaddominale, tecnica che venne a soppiantarel’estrazione per via perineale, descrittadai chirurghi salernitani e prima ancora daCelso (sectio celsiana) molto più cruenta epericolosa. Da sottolineare come il chirurgoMarino Santo da Barletta (XVI sec.), unodei più celebri chirurghi <strong>del</strong> suo tempo,abbia perfezionato il taglio perineale laterale,già ideato nel 1523 da Giovanni DeRomanis da Casalmaggiore (Cremona),adottando un maggior numero di strumen-- 157 -
SALTERNUMti (‘metodo mariano’ o apparatus maior),metodo descritto nel suo libro De lapide exvesica per incisionem estraendo, Roma, 1522. Ilvecchio metodo <strong>del</strong> taglio mediano diIppocrate e Celso rimase ai chirurghi ambulanti(apparatus minor).44Dei Branca si ricordano soprattuttoGustavo e Antonio Branca, rispettivamentepadre e figlio operanti nel XVI sec.45Dei Vianeo di Maida, abili e celebri i fratelliVincenzo, Pietro e Paolo Vianeo, operantitra la fine <strong>del</strong> XV e gli inizi <strong>del</strong> XVIsec. Il loro intervento era indicato comeMagia tropoesiarium.46A portare l’intervento di rinoplastica alivello scientifico si vuole sia stato GaspareTagliacozzi (1546-1599), lettore di chirurgianell’Università di Bologna. La tecnica <strong>del</strong>l’intervento(prendere un lembo di pelle dalbraccio e tenere il braccio legato al nasofino all’adesione <strong>del</strong> lembo) è pressochésovrapponibile a quella adottata dai Vianeodi Tropea, da cui una feroce critica di plagioe molti dubbi sulla priorità. In realtà la procedura<strong>del</strong> Tagliacozzi è molto più accuratae lo strumentario più complesso. Pur avendointrodotto la novità <strong>del</strong> trapianto attuabileda persona a persona e quindi la possibilepartecipazione di un donatore, l’innovazionecreò un mercimonio di organi inaccettabile.La durezza <strong>del</strong>la diatriba sfociònell’abolizione e messa al bando <strong>del</strong>la chirurgiaplastica. La rinoplastica celsiana èdescritta da Celso nel De medicina, VII, 9.47CRUCIANI 1999.48PIRRI 1960.49FABBRI 1974. Secondo altra tradizione letecniche chirurgiche furono trasferite agliempirici da monaci basiliani e nestorianivenuti dalla Siria nelle valli umbre intorno al1200.50‘Medicus tota Italia celeberrimus’, pur iniziandola sua carriera come empirico itinerante,divenne lettore di medicina a Perugia. Curòla sterilità di Bianca Maria Sforza e scrisseun Libellus de conservatione sanitatis (Cfr.PIZZONI 1950, p. 198 ss.; DE’ REGUARDATI1977).51Scrisse il Subsidium Medicinae, in cui èdescritta la tecnica <strong>del</strong>la litotomia vescicale.Nel Museo <strong>del</strong>l’Abbazia di Sant’Eutizio,vicino Preci, sono conservati disegni distrumenti chirurgici preparati dallo Scacchi.Alcuni di questi strumenti sono conservatipresso il Museo di Storia <strong>del</strong>la Medicina diRoma e il Museo Storico Nazionale<strong>del</strong>l’Arte Sanitaria di Roma. Pinze a cucchiaioper litotomia, sonde uretrali per l’esplorazione<strong>del</strong> condotto uretrale e per l’estrazionedi calcoli, uretrotomi, apertoria vesicae,ovvero dilatatori per tenere aperta labreccia perineale, cucchiai raschiatoi percalcoli ed altro.52La famiglia Carocci vantò numerosi personaggidistintisi in medicina, tra cuiCaterino, Giuseppe Maria e Tommaso.Sigismondo, il più illustre, prestò per varianni la propria opera presso la corte diFerdinando III d’Austria.53Girolamo Accoramboni (1469-1537), fulettore di medicina a Padova e a Perugia,archiatra pontificio di Leone X, ClementeVII e Paolo III. Scrisse vari libri tra cui: Delacte, De putredine e De catharro.54La famiglia Bacchettoni vantò numerosichirurghi oltre che nel campo <strong>del</strong>la litotomia,anche in quello <strong>del</strong>l’oculistica. Si ricordanoGiovanni, Giovancarlo, Girolamo eLeopoldo.55Altri abili cerusici <strong>del</strong>la famiglia Bittozzifurono Fulvio, Alessandro, Lorenzo,Francesco, Antonio e Gaetano.56Per una più approfondita trattazione <strong>del</strong>letradizioni chirurgiche di Preci e di Norcia e<strong>del</strong>le famiglie interessate a questa attività,cfr. FABBI 1972, pp. 67-89.57PAPPALARDO 1963.58Celso così descrive l’operazione di cataratta:«…tum acus admovenda est, acuta sic ut foret,eaque demittenda recta est per summas duas tunicasmedio loco inter oculi nigrum et angulum temporipropiorem, e regione mediae suffusionis …Ubieo ventum est, inclinando acus ad ipsam suffusionemest, leniterque ibi verti, et paulatim eam deduceteinfra regionem pupillae, debet; ubi deinde eamtransiti, vehementius imprimi, ut inferiori partiinsidat. Si haesit, curatio espleta est» (Cel., Demedicina, VII, 7, 14).59Noto in proposito l’adagio che vuole lacalcolosi vescicale appannaggio di ‘bambinipoveri e vecchi ricchi’, i primi per un’alimentazioneprevalentemente lattea (ossalatidi calcio), i secondi per un regime eccessivamentericco di carne (urati di calcio).60Anche in questo caso il metodo è sostanzialmentequello celsiano. L’Autore romanoinfatti così si esprime: «Medicus … unctaquesinistra manu, duos eius digitos indicem et medium- 158 -
GIUSEPPE LAURIELLOleniter, prius unum abdomen leniter anum eiusdemittit; dextraeque digitos super imum abdomenleniter imponi…Ac primum circa cervicem quaeriturcalculus; ubi repertus, minore negozio expellitur;…Atqueubi repertus est calculus…sinistraedigiti deorsum eum compellunt, donec ad cervicempervenitur…Quum iam eo venit, incidi iuxtaanum cutis plaga lunata usque ad cervicem vesicaedebet…» (Cel., De medicina, VII, 26, 2).61FIORAVANTI 1660, I, 28.62CONTIERI 1990, p. 48.63MARINELLO 1563, II, cap. 29.64ID., Ibidem.65Gabriele Falloppia (1523 – 1562) fu unodei più illustri anatomici italiani <strong>del</strong> ‘500;insegnò a Ferrara, Pisa e Padova; studiò inmodo particolare l’anatomia <strong>del</strong>l’orecchio edescrisse le salpingi, conosciute appuntocome ‘tube di Falloppia’. L’opera sua piùimportante sono le Observationes anatomicae,pubblicate a Venezia nel 1561.66FALLOPPIA 1571.67MALFI 1626.68COSMACINI 1998; ID. 2001.69Il ciarlatano, voce derivata da ‘cerretano’,è definito dall’Accademia <strong>del</strong>la Crusca:«Colui che per le piazze spaccia unguenti ealtre medicine, cava i denti e fa giochi dimano e con abbondanza di parole artificiosee vanterie cerca di spacciare il falso pervero, traendo profitto <strong>del</strong>l’altrui credulità».70Pietro Longhi, detto ‘il Falca’ (1702-1785),pittore veneziano, autore di gustose scenedi vita quotidiana. Tra le sue composizioni,Il cavadenti, conservato al Museo Brera diMilano.71Franz van Mieris il Vecchio (1635-1681),di Leida, brillante pittore <strong>del</strong>la società borghese.Tra le sue creazioni, Il ciarlatano olandese,conservato agli Uffizi di Firenze.72Jan Steen (1626-1679), pittore olandese diLeida. Lavorò a l’Aia e a Delft, producendoun eccezionale numero di opere tutte digrande valore artistico. E’ meritatamenteconsiderato tra i più grandi pittori <strong>del</strong> suoPaese. Acuto osservatore <strong>del</strong>la sua gente,rivela spesso nelle sue composizioni unadivertita ironia. Tra i capolavori è Il cavadenti,dipinto seguito nel 1651 e conservato alMauritshuis <strong>del</strong>l’Aia.73BENEDICENTI 1951, p. 902.74OMODEI ZORINI 1991, II, 5.75«iste operationes sunt particulares maxime appropriatebarbitonsoribus et dentatoribus…oportetdentistas esse munitus de aptis instrumentis» (DECHAULIAC G., Chirurgia magna, VI, 2, 2, 5).76In un documento riportato, tra gli altri, inRUSSO 1966, p. 70 si evince come i barbieridebbano essere muniti di apposita licenza,debbano sottostare al controllo <strong>del</strong>Protomedico e sia prescritta la verificaperiodica <strong>del</strong>le loro conoscenze sanitarie:«…qualsivoglia persona soggetta all’officio<strong>del</strong> Protomedico, deve comparire davanti alsostituto Protomedico fra certotermine…Si fanno chiamare li fisici nongraduati e li chirurgici e, viste le loro licenze,l’esaminano privatamente in quell’officioche s’esercitano per vedere se l’esercizioè bene o malo, si fossero scordati … parimentisi esaminano li conciatori, le mammanee gli altri… ultimamente vengono allibarbieri alli quali dimandano se conoscanole vene, dove stanno, come sagnano e ultimamenteli danno giuramento di nonsagnare se non per ordine di Medico…» esolo dopo avere superato l’esame confermarela licenza e l’autorizzazione a salassare.77INFANTE - NATELLA 2008, p. 130.78IID., Ibidem. Gli Autori annotano che ‘iltermine insagnare-sagnare sta per ‘far sanguinare,salassare’ e che il de Consilio era unflebotomo, cioè uno esperto di salassi, praticache nel Medioevo era ritenuta una sortadi panacea per tutti i malanni. Il medicus cerusicuseseguiva anche piccole operazioni chirurgiche,estrazioni di denti, toilette chirurgica<strong>del</strong>le ferite e cose simili in base a sempliceesperienza manuale’.79MARINO 1984.80ID., Ibid., p. 34.81ID., Ibid., p. 27.82ID., Ibid.83ID., Ibid., p. 35.84Quanto sopra è riferito a Guy de Chauliacin HAEGER 1989, p. 87.85Altro termine per indicare la ‘pece greca’,così detta, perché originaria da Colofone,città <strong>del</strong>la Lidia in Asia minore.86Resina <strong>del</strong>la Pistacia lentiscus, una anacardiacea.Particolarmente rinomata quella <strong>del</strong>l’isoladi Chio, elemento base <strong>del</strong>le chewinggums.- 159 -
SALTERNUMBibliografiaAlbucasi 1992, Chirurgia (Riproduzione diuna versione occitanica a cura di M. S.ELSCHEICK), Firenze.BELLION E. 1986, Antique dental Instruments,New York.BENEDICENTI A. 1951, Malati, medici e farmacisti,Milano.CAPREZ H. 1952, Medicina monastica, in‘Rivista CIBA’, VI, 34.CASTIGLIONI A. 1948, Storia <strong>del</strong>la medicina,Milano.CONTIERI E. 1990, Storia <strong>del</strong>la Chirurgia,Napoli.CORSINI A. 1922, Medici ciarlatani e ciarlatanimedici, Bologna.COSMACINI G. 1998, Ciarlataneria e medicina,Milano.COSMACINI G. 2001, Il medico ciarlatano. Vitainimitabile di un europeo nel Seicento, Milano.CRISCIANI C. anno, Il medico cristiano nelMedioevo, in ‘Kos’, n.s., 57.CRUCIANI G. F. 1999, Cerusici e fisici, precianie nursini dal XIV al XVIII secolo, Norcia.DE’ REGUARDATI F. M. 1977, Benedetto de’Riguardati da Norcia, ‘Medicus tota Italiaceleberrimus’, Trieste.FABBI A. 1972, The norcini and their families, inMedicina nei secoli, vol. IX.FABBRI A. 1974, La Scuola chirurgica di Preci,Preci.FALLOPPIA G. 1571, De parte medicinae quaechirurgia nuncupatur, Venezia.FAUVET J. 1955, Le tappe <strong>del</strong>la medicina,Milano.FIORAVANTI L. 1660, Dello specchio di scientiauniversale libri tre,Venezia.HAEGER K. 1989, Storia <strong>del</strong>la chirurgia,Roma.INFANTE M. - NATELLA P. 2008 (a cura di),San Gennaro di Gorga: modi e presenze <strong>del</strong> santonapoletano in terra salernitana, Gorga.LAURIELLO G. 2005, Monachesimo occidentale eScuola medica salernitana, in ‘Discorsi sullaScuola medica salernitana’, Salerno.MALFI T. 1626, Il barbiere libri tre, nei quali siragiona <strong>del</strong>l’eccellenza <strong>del</strong>l’Arte e dei suoi precetti.Delle vene e regole d’aprirle. Dell’applicazione de’remedi chirurgici appartenenti al mestiere. Configure anatomiche e di nuovi strumenti, Napoli.MARINELLO G. 1563, Medicine partenenti alleinfermità <strong>del</strong>le donne, Venezia.MARINO R. 1984, Lo ‘stato <strong>del</strong>la salute’ nelPrincipato Citra (1806-1860), Salerno.NICAISE E. 1893 (ed.), Chirurgie de maîtreHenri de Mondeville, chirurgien de Philippe le Bel,roi de France, composée de 1306 à 1320, Paris.OMODEI ZORINI G. V. 1991, I medici ambulanti,in ‘Caleidoscopio letterario’, II, 5.PAPPALARDO I. 1963, Litotomi e oculisti precianie norcini, Roma.PAZZINI A. 1947, Storia <strong>del</strong>la medicina,Milano.PAZZINI A. 1980, Storia, tradizioni e leggende<strong>del</strong>la medicina popolare, Milano.PENCO G. 1961, Storia <strong>del</strong> monachesimo inItalia dalle origini alla fine <strong>del</strong> Medioevo, Roma.PIRRI P. 1960, L’Abbazia di Sant’Eutizio inVal Castoriana presso Norcia e le chiese dipendenti,Roma.PIZZONI P. 1950, I medici umbri lettori pressol’Università di Perugina, in ‘Boll. Deput. Storiapatria per l’Umbria’, 47.POUCHELLE M. C. 1983, Corpo e chirurgiaall’apogeo <strong>del</strong> medioevo, Genova.RUSSO A. 1966, L’arte degli speziali in Napoli,Napoli.ZECCHINO O. 2002, Medicina e Sanità nelleCostituzioni di Federico II di Svevia, Castel diSerra.WALSH J. J. 1908, The popes and science: the historyof the papal relations to science during themiddle ages and down to our own time, NewYork.- 160 -
VITTORIA BONANILa Biblioteca Provinciale di Salernoal servizio <strong>del</strong>la Comunità locale e nazionaleRiceviamo dal Direttore <strong>del</strong>la Biblioteca Provinciale di Salerno, e volentieri pubblichiamo,questo ‘manifesto’ sul Patrimonio e le attività <strong>del</strong>l’antica e prestigiosa Istituzione.La Biblioteca Provinciale di Salerno è uncentro di diffusione <strong>del</strong>la cultura, <strong>del</strong>leinformazioni e <strong>del</strong> sapere al servizio di tuttii cittadini, di qualsiasi provenienza - italiani e stranieri- e di qualsiasi fascia d’età, adulti, ragazzi e bambini.È la biblioteca di tutti e per tutti, luogo di lettura,studio e ricerca e al tempo stesso spazio <strong>del</strong>laComunità, multiforme e multifunzionale, dove è possibileincontrarsi, fermarsi, leggere, acquisire notiziesu ogni aspetto legato al territorio ed alla vita quotidiana,navigare su Internet, trovare e approfondire ognitematica d’interesse, richiedere pubblicazioni in prestitoprovenienti da altre Biblioteche nazionali o consultarelibri antichi e manoscritti.Un centro culturale da vivere pienamente ancheattraverso la partecipazione ad eventi, mostre, convegni,presentazioni di libri e recensioni divulgate su ‘Proposte dilettura’, al link <strong>del</strong>l’Istituzione: http://www.bibliotecaprovincialedisalerno.com/proposta_new.htm.L’accesso alla Biblioteca (oltre 350.000 documentifra libri, riviste di varia attualità e specializzate, e giornali)e ai suoi servizi è libero e gratuito; gran parte <strong>del</strong>suo patrimonio è disponibile alla fruizione degli utentie può essere chiesto liberamente in consultazione.Ben quattro sono le sale in cui è possibile trovarepostazioni accoglienti di lettura e di studio, in cuipoter richiedere un servizio di assistenza utile a favorirenuove ricerche oppure ad orientare il pubblico allascoperta e all’uso <strong>del</strong>le diverse opportunità offerte dall’anticoIstituto culturale di via Laspro. La Bibliotecainfatti, oltre a possedere un consistente catalogo <strong>del</strong>lenuove accessioni, conserva fondi antichi e raccoltespeciali legate a particolari discipline - come la storia,la letteratura italiana, la religione e le scienze - che consentonol’indagine e l’approfondimento di particolaritemi e settori, come quello storico-geografico dei 158comuni <strong>del</strong> <strong>Salernitano</strong>, dei moti rivoluzionari e <strong>del</strong>Risorgimento, <strong>del</strong>la liberazione e <strong>del</strong>lo sbarco aSalerno, ecc.Oggi la Biblioteca, istituita con atto <strong>del</strong>iberativo<strong>del</strong>la Deputazione provinciale nel lontano febbraio1843 (ratificato con regio rescritto <strong>del</strong> 1844), simboleggia,attraverso la ‘Divisione Salernitana’ e i suoifondi antichi rari e di pregio la ‘Memoria storica locale’,costituendo di fatto per l’intera comunità locale lafondamentale fonte <strong>del</strong>la sua storia, oltre che il centropiù rappresentativo di raccolta e conservazione <strong>del</strong>leaccessioni documentarie.L’Istituto provinciale più antico d’Italia ha compiuto168 anni dalla sua fondazione, un numero di anniveramente ragguardevole se ne consideriamo la presenzacronologica nel contesto cittadino e territoriale,Fig. 1 - La Biblioteca provinciale.Fig. 2 - Sala di consultazione.- 161 -
SALTERNUMma sicuramente irrisorio se ne valutiamo la funzionedi servizio di pubblica utilità. Da questo punto di vistasi può affermare che la Biblioteca si è imposta all’attenzione<strong>del</strong> pubblico soltanto dal 2000, anno in cuimi è stata affidata dall’Amministrazione la guida <strong>del</strong>l’istituzione,perseguendo in breve tempo lusinghieriapprezzamenti, riconoscimenti e consensi per la qualitàdei servizi erogati e per la capacità progettuale cheriusciva nel concreto ad ideare e realizzare.Le scelte programmate e gli interventi si sono collocatinel contesto rappresentato dalla globalizzazione<strong>del</strong>l’economia e dall’innovazione dei servizi destinatialla soddisfazione degli utenti: l’UNESCO ne sottolineavain quegli anni il valore informativo e la forzavitale per l’istruzione e per la conoscenza in forme emodi uguali per tutti - secondo i principi democraticidi uguaglianza, libertà ed accesso - e senza alcunadisparità di trattamento.Tale cambiamento è coinciso con l’inserimento<strong>del</strong>le nuove tecnologie di comunicazione e con la creazionedi una Rete bibliotecaria provinciale, cui hannoaderito molte biblioteche pubbliche, ecclesiastiche eduniversitarie: l’esperimento di gestire e valorizzareattraverso la cooperazione l’immenso patrimonio dirisorse culturali, documentarie e storiche <strong>del</strong> salernitano,partito nel 2002, ha rappresentato una svoltaimportante ed ha significato trasformare la Provincialeda Biblioteca di conservazione in Biblioteca multimediale,in cerniera essenziale tra il mondo <strong>del</strong> libro daun lato e la cultura <strong>del</strong>le reti e la multimedialità diffusadall’altro.Come Biblioteca capofila e polo di raccordo <strong>del</strong>Sistema Bibliotecario Provinciale ‘Bibliorete’, coordinala Rete bibliotecaria con l’obiettivo di sviluppare,Fig. 3 - Postazione di lavoro.attraverso la cooperazione, servizi di lettura, informazionee documentazione sempre più adeguati ai bisognidei cittadini e <strong>del</strong> territorio. In qualità di CentroRete, la Provinciale è impegnata nel coordinamento<strong>del</strong>le biblioteche e dei centri di documentazione <strong>del</strong>territorio salernitano, ai fini <strong>del</strong>l’incremento <strong>del</strong>Catalogo integrato <strong>del</strong>le risorse patrimoniali <strong>del</strong>l’areaprovinciale 1 , <strong>del</strong>la circolazione dei documenti, <strong>del</strong>lavalorizzazione <strong>del</strong> prestito interbibliotecario sia all’interno<strong>del</strong> Sistema ‘Bibliorete’ che nel rapporto con lereti bibliotecarie campane, <strong>del</strong> supporto all’organizzazionee allo sviluppo di biblioteche e centri di documentazione.Uno sviluppo che l’ha resa più dinamica, interattivae ricettiva rispetto al contesto locale e internazionale,avendo assimilato i diversi linguaggi di trasmissionebasati sulle reti informatiche, sugli archivi multimedialie sulle banche dati specializzate che le hanno permessodi offrire in tempo reale servizi più avanzati especializzati (internet e servizio di reference on line, document<strong>del</strong>ivery, proiezione e riproduzione digitale deidocumenti, posta elettronica, numero verde, accessoad Opac e Metaopac).Va necessariamente segnalato l’avvio nel 2004 <strong>del</strong>nostro OPAC - Catalogo collettivo provinciale in rete 2 ,consultabile anche da remoto: una nuova modalità digestione che rappresenta la fonte primaria dei datibibliografici. Una visione diversa <strong>del</strong>la Biblioteca intesacome insieme di valori organizzativi messi incampo per perseguire obiettivi importanti: promuovereil cambiamento sui principi <strong>del</strong>la qualità totale e farcircolare in rete la cultura salernitana, umanistica,scientifica e storica.Altrettanto rilevanti i servizi, come quelli di prestitointerbibliotecario, di informazione bibliografica, e leattività offerte, quale il programma di eventi di promozionee di valorizzazione dei fondi antichi, formatisi aseguito <strong>del</strong>le soppressioni dei monasteri, sia durante laRepubblica Partenopea <strong>del</strong> 1799 3 , sia con le leggi <strong>del</strong>l’eversionee liquidazione <strong>del</strong>l’asse ecclesiastico degliOrdini e <strong>del</strong>le Corporazioni 4 : il Convento <strong>del</strong>la Trinitàdi Baronissi, il Convento di S. Maria <strong>del</strong> Paradiso diOliveto Citra, il Convento dei Cappuccini di Salerno.Alla creazione <strong>del</strong>l’importante collezione ‘storica’<strong>del</strong>la Biblioteca hanno tuttavia contribuito molti privaticittadini: i nomi di uomini illustri quali Pinto,Guariglia, Zottoli, Capasso, Sorrentino, Bosi-Ricciardisono strettamente connessi alla storia di Salerno e- 162 -
VITTORIA BONANI<strong>del</strong>la sua provincia. Attraverso le loro private ‘librarie’possiamo ricomporne gli ambiti ed i settori d’interesse,verificarne il percorso professionale, ricreare ilretroterra culturale e l’ambiente in cui vissero. Per tornareindietro nel tempo è sufficiente sfogliarli, riscontraregli ex libris Francisci Cerenza apposti sulla carta diguardia posteriore dei suoi incunaboli, o le note dipossesso, oppure il timbro a stampa ovale <strong>del</strong> RealLiceo ‘T. Tasso’, prima sede <strong>del</strong>l’antica istituzionesalernitana.Tra le donazioni di maggiore rilevanza, spicca labiblioteca di Alfonso Guariglia (professore di Dirittocommerciale presso l’Università di Napoli), donata il29 giugno 1935 dal figlio Raffaele alla BibliotecaProvinciale (‘Fondo Guariglia’) e composta, scriveAndrea Sinno (primo vincitore <strong>del</strong> concorso diDirettore bandito dalla Provincia), da volumi di «carattereletterario e giuridico, splendidamente rilegati ealcuni di eccezionale rarità. Notevoli fra essi le monografieper la storia dei comuni e <strong>del</strong>le province meridionalid’Italia», che testimoniano la passione <strong>del</strong> professoreGuariglia per le vicende storiche <strong>del</strong> nostroMezzogiorno.Non può essere omesso il nome <strong>del</strong> critico letterarioAngelandrea Zottoli, di cui ci rimangono circa8000 volumi connessi alla storia <strong>del</strong>la Letteratura italianae straniera, con particolare attenzione a quellafrancese, oggetto dei suoi studi, alla Filologia eall’Archeologia classica. Di straordinario valore risultaanche la donazione patrimoniale <strong>del</strong> cavaliereGennaro Pinto, ereditata con testamento olografo <strong>del</strong>19 giugno 1916, grazie alla quale pervennero – oltreallo splendido Palazzo Pinto (seconda sede <strong>del</strong>laBiblioteca) - circa 1000 volumi storico-letterari, 234pergamene, manoscritti salernitani, giornali datatidalla prima metà <strong>del</strong>l’Ottocento in poi, fasci manoscrittiappartenenti alla famiglia, nonché 54 libri astampa <strong>del</strong> secolo XVII.A questi preziosi fondi, fondamentali sia per valorestorico-antiquario sia per consistenza, molti altri sene sono aggiunti dai primi anni Cinquanta <strong>del</strong> XXsecolo fino ai giorni nostri grazie al munifico apportodi illustri cittadini, i quali hanno voluto legare le prezioseraccolte al nome <strong>del</strong>la famiglia: Tesauro,Giannattasio, Colombis, Cappelli, Radice, Mancuso,Bamonte, Servino, Avallone (latinista di fama internazionale)e, tra gli ultimi, l’ammiraglio FrancescoCerenza, pronipote <strong>del</strong> primo bibliotecario.La Divisione antica, che raccoglie libri a stampa apartire dal 1475 5 al 1830 (data convenzionalmenteprescelta come limite massimo per gli esemplari stampaticon la tecnica gutenberghiana), rappresenta una<strong>del</strong>le più importanti collezioni <strong>del</strong>l’Italia meridionalecaratterizzata dalla presenza di edizioni uniche inItalia (si ricorda quella catalana <strong>del</strong> Llibre <strong>del</strong>s angels diFrancisco Ximenes realizzata nel 1494 a Barcellonadallo stampatore Pere Miquel) o rarissime, comel’Esopus moralisatus prodotto a L’Aquila nel 1493 daglistampatori Eusanio de Stella, Jean Picard e Louis deMasson e corredato di splendide xilografie che illustranola vita e la morte di Esopo e che sintetizzanoil soggetto di ogni singola favola; la Divina Commediacommentata in volgare da Cristoforo Landino edarricchita da incisioni di Baccio Baldini (Venezia,Piero di Pasi, 1491). Il trattato <strong>del</strong> medico, filosofo,letterato e priore salernitano Paolo Grisignano,Libellus de pulsibus et urinis, realizzato nella nostra cittàdurante il 1543 ad opera <strong>del</strong>lo stampatore itineranteCilio Alifano (Luigi o Aloisio Acilio, primicerio <strong>del</strong>Fig. 4 - Antonio d'Andrea, Questiones super Metaphysicam Aristotelis, Vicenza, 1477.- 163 -
SALTERNUMcapitolo <strong>del</strong>la cattedrale di Alife), si evidenzia peressere una <strong>del</strong>le poche testimonianze <strong>del</strong>l’attività tipograficaambulante a Salerno.L’elenco <strong>del</strong>le rarità e particolarità presenti inBiblioteca è molto lungo e corposo, anche perché adogni attività di studio e di indagine scientifica condottasugli esemplari per la realizzazione <strong>del</strong>le tante iniziativeculturali corrispondono inattese novità che rendonoil patrimonio ancor di più unico e singolare.Tale eccezionalità ci ha spinto sin dall’inizio nonsolo a volere l’ordinamento <strong>del</strong>le raccolte antiche, maanche a prefiggerci l’obiettivo <strong>del</strong>la promozione e<strong>del</strong>la valorizzazione, in questo scopo sostenuti pienamentedalla Soprintendenza Regionale ai Beni Librari.pubblico i potenti media (telefono, internet, computer,TV, ecc.) che globalizzano le informazioni e i dati, rendendoliimmediatamente trasferibili e condivisibili.Oggi, per tutta la comunità salernitana, laBiblioteca Provinciale è l’edificio, il patrimonio, l’infrastrutturainformativa e tecnologica gratuita e apertaa tutti i cittadini <strong>del</strong> mondo, grazie alla quale emergeun serbatoio di conoscenze e di memorie che necostituiscono l’autentica fisionomia.L’attività svolta in questi anni dunque ha certamenteconsentito un avanzamento in direzione <strong>del</strong>l’ordinamentopatrimoniale e <strong>del</strong>la soddisfazione <strong>del</strong>le esigenzedi documentazione scientifica da parte <strong>del</strong> pubblicoche frequenta la biblioteca, uno sviluppo che èFig. 5 - Guglielmo Peraldo, Summa de virtutibus;Summa de vitiis, Venezia, 1497.Fig. 6 - Marco Fabio Quintiliano, Institutionumoratoriarum ... Basilea, 1529.Fig. 7. Alessandro Alessandri, Genialium dierum.Lione, 1673.I nuovi linguaggi di comunicazione hanno poi consentitol’immissione dei nuovi dati nell’OPAC e l’interazionecon i cittadini <strong>del</strong> mondo, perché non sonomai mancate le capacità professionali e le motivazioni,la passione e la volontà di adeguamento agli standardinternazionali, nell’intento di voler offrire un apportocompetitivo e strategico all’evoluzione sociale ed economica:operare locale è di fatto sinonimo di comunicareglobale, in quanto sono stati messi al servizio <strong>del</strong>stato favorito dallo snellimento <strong>del</strong>le procedure informatichee dalla possibilità molto più ampia di patrimoniobibliografico da cui i bibliotecari hanno potutoattingere per soddisfare i bisogni informativi.Quale potrebbe essere nell’immediato l’obiettivo<strong>del</strong>la Biblioteca Provinciale di Salerno?Senza dubbio continuare ad essere mediatrice <strong>del</strong>l’informazionee custode <strong>del</strong>la cultura, cioè essere ingrado di conservare e rendere fruibile il patrimonio- 164 -
VITTORIA BONANIlibrario <strong>del</strong> proprio ambito, ma anche di quello territoriale,ed in particolare fare in modo che il cuorepulsante <strong>del</strong>l’intero archivio <strong>del</strong>la conoscenza perSalerno e provincia continui ad essere ‘Bibliorete’, ilSistema bibliotecario concepito come centro didocumentazione on line (in cui tutti i bibliotecarisalernitani continueranno a riversare dati culturali) ecome strumento di aggregazione e di ricomposizione<strong>del</strong>le fonti frammentate e disorganiche esistentisul territorio. Il linguaggio multimediale utilizzatodagli operatori le renderà organiche e fruibili, facendoemergere quel serbatoio di conoscenze e dimemorie - che costituiscono la fisionomia sociale,storica e culturale <strong>del</strong> salernitano - da aprire alla consultazioneon line per tutti i cittadini <strong>del</strong> mondo.La Biblioteca Provinciale intende perseguire abreve anche altre importanti finalità legate all’organizzazionee realizzazione <strong>del</strong> Progetto, intitolatoSviluppo di tecnologie per la digitalizzazione e messa in Rete<strong>del</strong>le Biblioteche. Riversamento <strong>del</strong>l’OPAC di Bibliorete inSBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) - POLOCampania, presentato dalla Provincia di Salerno efinanziato dalla Regione Campania per un importo di300.000,00 euro; la Biblioteca Provinciale sarà la protagonistaattiva <strong>del</strong> Progetto che prevede lo svolgimentodi interventi molto articolati, ma tutti fortementeunitari e rivolti a concretizzare una maggiorepartecipazione dei Comuni <strong>del</strong> salernitano a‘Bibliorete’ e a riqualificare la Rete provinciale che saràfinalmente collegata a quella Nazionale SBN.La Provinciale, come Ente Capofila di ‘Bibliorete’,insieme ai Comuni di Altavilla Silentina, Baronissi, Cavade’ Tirreni, Sala Consilina, Siano e ai Dipartimenti diFilosofia e di Scienze Economiche e Statistiche<strong>del</strong>l’Ateneo salernitano che hanno voluto partecipare alprogetto POR, passerà alla fase realizzativa <strong>del</strong>la digitalizzazionedei testi antichi illustrati dei secoli XVII-XVIII, riferiti alle bellezze paesaggistiche, storico-artisticheed architettoniche <strong>del</strong> territorio campano. Taleazione porterà alla costituzione di una consistenteBiblioteca Digitale che, attraverso le ricche immaginidesunte dai libri, permetterà al pubblico di apprezzare ipreziosi volumi e di cogliere la storia evolutiva <strong>del</strong>laRegione Campania e <strong>del</strong> suo territorio, orientando in talmodo il turismo culturale verso le Biblioteche <strong>del</strong><strong>Salernitano</strong>, centri di conoscenza e di cultura.Rientrano nel Progetto altri importanti punti d’arrivo:la creazione di un ‘Portale web’ per l’accesso aivolumi digitalizzati ed ai cataloghi in rete (provincialee nazionale), la costituzione di un Laboratorio di digitalizzazionepresso la Biblioteca Provinciale da riservareall’intero territorio, l’installazione di stazioni(‘touch screen’) multimediali da posizionare in palazzistorici già individuati in fase di progettazione (PalazzoPinto di Salerno; Palazzo Palmieri di Siano; Conventodei Padri Cappuccini di Sala Consilina; Complessomonumentale di S. Maria <strong>del</strong> Rifugio di Cava de’Tirreni), l’organizzazione di una Mostra bibliograficadegli esemplari digitalizzati con la conseguente pubblicazionedi un Catalogo a stampa e la promozione diuna Giornata Nazionale di Studi.La Biblioteca Provinciale di Salerno dunque, nelrispetto <strong>del</strong>le linee guida tracciate dal ManifestoIFLA/UNESCO sulle Biblioteche pubbliche <strong>del</strong>1994, prosegue con un impegno costante e partecipativola sua attività ben determinata a perseguire la crescitaculturale attenta e consapevole <strong>del</strong>la comunitàterritoriale, a garantire l’uso pubblico <strong>del</strong> materialebibliografico e multimediale, a valorizzare la culturalocale e a potenziare le strutture e gli strumenti voltiad accrescere e a ricomporre la cultura, la conoscenzae l’informazione in ogni suo aspetto:«Compito primario <strong>del</strong>la biblioteca pubblicaè offrire risorse e servizi, con unavarietà di mezzi di comunicazione, persoddisfare le esigenze individuali e collettivedi istruzione, informazione e sviluppopersonale, compreso lo svago el’impiego <strong>del</strong> tempo libero. Le bibliotechesvolgono un ruolo importante nellosviluppo e nel consolidamento di unasocietà democratica permettendo a ciascunodi avere accesso a un’ampia evariegata gamma di conoscenze, idee eopinioni».- 165 -
SALTERNUMNote1http://salernobibliorete.online.it/SebinaOpac/Opac.2http://salernobibliorete.online.it/SebinaOpac/Opac.3Il primo atto ufficiale con cui ebbero iniziogli interventi contro i religiosi fu la circolare<strong>del</strong> Ministro <strong>del</strong> Culto Luigi Serra diCassano inviata agli Ordinari il 17 maggio1806, ribadita qualche anno più tardi con ildecreto <strong>del</strong> 21 dicembre 1809, emanato dalMurat.4L. n. 3036 <strong>del</strong> 7 luglio 1866 e n. 3848 <strong>del</strong>15 agosto 1867.5Si cita l’opera di S. Tommaso d’AquinoSumma contra gentiles, impressa il 20 settembrea Roma nell’officina <strong>del</strong> tedescoArnold Pannartz.- 166 -
CHIARA LAMBERTSegnalazioniArcheologia preventiva. Esperienze a confronto. Atti <strong>del</strong>l’incontrodi studio (Salerno, 3 luglio 2009), a cura di M. L. NAVA,Osanna Edizioni, Lavello, 2009, 207 pp., ill. b. e n.; col.Il volume raccoglie i 10 contributidi un Incontro di Studi sul tema<strong>del</strong>l’Archeologia preventiva, promossonel Luglio 2009 dalla dott.ssaMaria Luisa Nava, alloraSoprintendente Archeologo per leProvince di Salerno, Avellino,Benevento e Caserta. Al tavolo deiRelatori, Funzionari diSoprintendenza, Docenti universitari,Archeologi membri diCooperative, competenti, a diversotitolo, per discutere i fondamenti diuna normativa lungamente attesa,divenuta operativa - a quattro annidall’emanazione <strong>del</strong>la Legge (L. 109<strong>del</strong> 25 giugno 2005) - a seguito <strong>del</strong>larecente pubblicazione <strong>del</strong>Regolamento attuativo (D.M. 30 marzo 2009, G.U. 15giugno 2009).I contributi sono preceduti da una breve Introduzionea firma <strong>del</strong> Direttore Generale per le Antichità, dott.Luigi Malnati, che - d’intesa con il Curatore, dott.ssa M.L. Nava - riproduciamo integralmente:«Le tematiche collegate con l’archeologia preventiva,che tengono banco negli ultimi anni in campoarcheologico si arricchiscono di un nuovo importantecontributo che fornisce alcune esemplificazioni moltosignificative di applicazioni concrete di tale metodologiad’intervento specie in Campania, ma anche in altrearee <strong>del</strong>l’Italia centrale.Come sottolinea Francesca Ghedini nel suo contributo,il dibattito successivo alla emanazione <strong>del</strong>laLegge <strong>del</strong> 2005, recepita poi negli artt.95 e 96 <strong>del</strong>laD.L.109 <strong>del</strong> 2006, è stato assai intenso e direi moltofruttuoso, proprio per la portata che ho definito a suotempo ‘rivoluzionaria’ <strong>del</strong>la Leggee <strong>del</strong>l’art. 28 <strong>del</strong> Codice per i BeniCulturali, che la aveva preceduta.Perchè rivoluzionaria? Perchè perla prima volta veniva formalizzata ein parte normata una prassi ormaiconsueta <strong>del</strong>le Soprintendenze per iBeni Archeologici e soprattuttoveniva ‘messo per scritto’ che l’archeologiain Italia, come altrove,non è limitata ad una attività diricerca condotta direttamente dalMinistero o svolta da terzi in concessione,ma è soprattutto attivitàdi tutela e controllo <strong>del</strong> territorio,con scavi svolti per realizzare operediverse e di solito non finanziati dalMinistero per i Beni Culturali o daquello <strong>del</strong>l’Università, ma daglistessi committenti pubblici e privati di opere infrastrutturali,edilizie, di parcheggi interrati, linee metropolitane,cave ecc...In queste condizioni è chiaro che il dibattito sull’archeologiapreventiva si avvia a diventare in realtàun dibattito sull’archeologia in quanto tale, come giàdimostrano gli Atti di questo seminario, dove aldibattito teorico si alternano resoconti di scavo chevanno ben oltre il concetto di relazione preliminaredi valutazione ex-art.95 ed investono anche la parteesecutiva.Esemplare mi sembra da questo punto di vista illavoro svolto dall’Università di Salerno per la realizzazione<strong>del</strong> Termovalorizzatore, lavoro svolto fin dallafase preliminare in piena collaborazione con la- 167 -
SALTERNUMSoprintendenza, come quasi sempre avveniva prima<strong>del</strong>la Legge ed ancora avviene.E’ quindi il momento di una riflessione più generalesu cosa vuol dire fare l’archeologo in Italia, strappandouna volta per tutte l’immagine cara ai media <strong>del</strong>l’archeologocercatore di tesori, ma anche quella, cara adalcuni settori <strong>del</strong>l’accademia e <strong>del</strong>lo stesso Ministero deiBeni Culturali, <strong>del</strong> ricercatore puro o <strong>del</strong>l’‘angelo custode’di una tutela rigida quanto improbabile, due figureche in fondo si assomigliano nella totale inadeguatezzanell’affrontare i problemi reali <strong>del</strong>la conservazione e<strong>del</strong>la conoscenza <strong>del</strong> patrimonio archeologico».Quasi a premessa degli interventi che costituisconola base <strong>del</strong>le ‘esperienze a confronto’ evocate nel sottotitolo,il volume si apre con un contributo (Archeologiapreventiva) di Francesca Ghedini, a suo tempo membrodi una Commissione mista (MiBAC, Infrastrutture),insediata nel 2004, incaricata di «elaborare dei principiguida che potessero poi essere opportunamente tradottiin legge». L’A. illustra con estrema chiarezza ipunti salienti <strong>del</strong>la normativa, sottolineandone gliaspetti di indiscutibile validità generale, ma evidenziandoanche alcune <strong>del</strong>le criticità emerse nel corso deilavori e motivando le scelte operate dallaCommissione, in particolare quella relativa al comma 1<strong>del</strong>l’art. 2 ter, che individua nei Dipartimenti archeologici<strong>del</strong>le Università «i soggetti idonei alla raccolta e<strong>del</strong>aborazione <strong>del</strong>la documentazione da accludere alprogetto preliminare», anche se viene fatta salva la prerogativa<strong>del</strong>le Soprintendenze di intervenire sul progettopreliminare, richiedendo ulteriori approfondimenti,che possono essere affidati agli stessi soggetti o ad altri(comma 1 <strong>del</strong>l’art. 2 quater). Il testo attuativo, riconoscendoa «persone o strutture con competenze specifichee con curricula ben documentati» l’esclusiva <strong>del</strong>laredazione <strong>del</strong>la relazione che deve essere allegata alprogetto preliminare agli interventi sul territorio, sembraescludere di fatto la possibilità di operare da parte<strong>del</strong>le Cooperative di Archeologi, le quali tuttavia vantanotalora competenze ‘sul campo’ maggiori di quellematurate da personale strutturato nell’ambito accademico.L’efficace sintesi <strong>del</strong>la Ghedini chiarisce come laLegge sia finalizzata, su questo punto, ad assicuraredegli standard qualitativi agli interventi di verifica preventiva<strong>del</strong>l’interesse archeologico, definendo peraltroanche gli specifici titoli richiesti agli operatori; talirequisiti, anziché precludere aprioristicamente la partecipazionedi archeologi non strutturati nelle Università,dovrebbero costituire la premessa per l’auspicato riconoscimento<strong>del</strong>la nuova figura professionale<strong>del</strong>l’Archeologo libero professionista.A questo proposito, il lettore di ‘Salternum’ potràtrovare in questo stesso numero <strong>del</strong>la Rivista unimmediato rimando nelle righe <strong>del</strong>l’Editoriale a firma<strong>del</strong> Direttore Scientifico, dott.ssa Gabriella d’Henry enella presentazione <strong>del</strong>la Federazione ArcheologiProfessionisti (FAP), di recentissima istituzione, curatadal suo Presidente, dott.ssa Monica Viscione.Gli Atti <strong>del</strong> Seminario si articolano quindi in unaserie di contributi che illustrano con puntualità esperienzedi archeologia preventiva attuata con validità dimetodo già prima che la Legge divenisse attuativa, adimostrazione <strong>del</strong>la maturità acquisita da tempo daalcuni operatori <strong>del</strong> settore, ma anche <strong>del</strong>la necessitàdi fissare regole certe, da applicare e rispettare nonsolo episodicamente, ma ovunque e con rigore. Ilprimo testo, Dall’archeologia di emergenza alla programmazione<strong>del</strong> l’intervento archeologico nella progettazione di operepubbliche. Esempi nel <strong>Salernitano</strong>, si deve a M. L. Nava,che illustra puntualmente una ricca serie di interventiattuati sotto la sua direzione, che contribuiscono adaccrescere notevolmente il quadro <strong>del</strong>le conoscenzesul territorio e sul contesto urbano di Salerno. Di taliattività la stessa A. aveva dato notizia anche in occasione<strong>del</strong> XIL Convegno di Taranto; una sintesi èstata altresì pubblicata sul n. 24-25, anno 2010, di‘Salternum’ in una specifica Rassegna dal titolo Notiziedagli scavi (pp. 115-179), che ha accolto anche gli scrittidi altri archeologi, molti dei quali ritroviamo, conmaggiore ricchezza di dati e di apparato grafico e fotografico,negli stessi Atti <strong>del</strong> Seminario sull’Archeologiapreventiva: Luca Cerchiai, Amedeo Rossi, AlfonsoSantoriello, Area <strong>del</strong> Termovalorizzatore di Salerno: le indaginidi archeologia preventiva e i ri sultati <strong>del</strong>lo scavo archeologico;Teresa Cinquantaquattro, Montevetrano (Sa). Strutture<strong>del</strong> territorio e popolamento <strong>del</strong>l’agro picentino; MonicaViscione, Salerno, Piazza Sant’Agostino: un caso di archeologiapreventiva in area urbana; Maria Grazia Soldovieri,Aree <strong>del</strong> termovalorizzatore: le indagini non invasive.Un taglio più generale e di carattere anche metodologico,sempre fondato su specifiche esperienze sulcampo, caratterizza i contributi di Stefania QuiliciGigli, Topografia e archeologia preventiva; Anna MariaReggiani, Archeologia preventiva e rischio sismico; MarinaSapelli Ragni, Archeologia preventiva nel Lazio; LuigiFozzati, Archeologia subacquea e archeologia preventiva.- 168 -
ROBERTO CAPRARARecensioniGIULIO MASTRANGELO, La condizione giuridica <strong>del</strong>ladonna nelle leggi longobarde e negli usi matrimoniali in Terrad’Otranto, Antonio Dellisanti Ed., Massafra 2011.Il volume, uscito da pochigiorni, è pubblicizzato come‘opera prima’, e tale è solo se siconsiderano opere in volume,perché è bene ricordare laormai vasta bibliografia di articolidi storia generale e storia<strong>del</strong> diritto riferibili al all’Autore.Anche a volerci limitaresolo a qualcuna <strong>del</strong>le sue operepiù notevoli, dobbiamo citarequelle sulla storia di Massafra,come il Contributo sull’origine deipozzi di uso pubblico: vicende eprimo censimento dei pozzi e <strong>del</strong>lecisterne “universali”<strong>del</strong> territorio diMassafra, ‘Archeogruppo’, 4,Massafra 1997, le Brevi note storichesul Castello, il fossato, le muramedievali, i molini baronali e lachiesa di S. Toma a Massafra, in ‘Archeogruppo’, 5,Massafra 2002, pp. 59-82, e il volumetto La cartografiadi Pietro De Marino e la questione confinaria fra Taranto eMassafra.Gli interessi di studio di Giulio Mastrangelo sugliusi civici occupano un ampio arco di tempo e vannodal contributo Su un’antica servitù di pascere, di legnare edadacquare esercitata dai massafresi sulla Difesa di San Marcodei Lupini in tenimento di Palagiano (in ‘Archeogruppo’, 2,Massafra 1995, pp. 43-64), all’intervento Gli usi civici aMassafra e Martina Franca (in La testa di Medusa. Storia eattualità degli usi civici in Terra d’Otranto, Atti <strong>del</strong>Convegno, Martina Franca, 5 ottobre 2009, in cds). Vanotato che tutti questi contributi sono dotati di appendicicon documenti attestanti la puntualità <strong>del</strong>l’informazione.D’altra parte, l’attenzione al documento èrivelata anche da una recentissima pubblicazionesull’Archivio Capitolare diMassafra.L’attività <strong>del</strong>l’Autore qualestorico <strong>del</strong> diritto, con particolareattenzione a quello longobardo,è attestata da diversicontributi minori, fra i quali èalmeno da ricordare l’interventoTracce di istituti longobardi inTerra d’Otranto, (in La presenzadei Longobardi nelle regioni d’Italia,Atti <strong>del</strong> Convegno, Paestum,21.11.2009, in cds).Nel volume che recensiamo,il primo capitolo parla <strong>del</strong>ladonna nelle Leggi deiLongobardi: l’Autore inizia colpresentare un quadro <strong>del</strong>lasocietà longobarda quale apparenella sua lunga marcia diconquista <strong>del</strong>l’Italia, dal Friuli alla Puglia. La famiglialongobarda è una famiglia allargata: la parentela è sentitacome stretta sino alla settima generazione e vivenella stessa abitazione o in abitazioni contigue, come -annota Mastrangelo - «nelle casegrotte scavate in ununico contesto, all’interno di una ‘vicinanza’, come aMassafra, o all’interno di uno dei tanti villaggi rupestridi Terra Jonica». Situazione determinata anche dalfatto che, per una norma introdotta dal re Grimoaldo,il patrimonio familiare doveva rimanere indiviso finoalla morte <strong>del</strong> capofamiglia.Le donne, all’interno di questa famiglia, erano consideratemarginali, in quanto elemento debole in uncontesto di guerrieri.- 169 -
SALTERNUMEsse erano divise in tre classi: le libere, le semilibere(aldie), le schiave (ancillae), ovviamente con diversilivelli di diritti. Anche fra sorelle, le figlie legittime avevanodiritti maggiori di quelli concessi alle figlie naturali,procreate dallo stesso padre con le serve di casa.Come si vede, la monogamia, dai Patriarchi biblici aiLongobardi, all’Islam, ai Mormoni, è un peso impostosoltanto alla donna, raramente all’uomo.In ogni caso, anche la donna libera, sia figlia legittimache naturale, secondo l’Editto di Rotari è totalmentesoggetta all’uomo - padre, fratello, marito - chene detiene il mundio e non possiede capacità giuridica,in quanto incapace di difesa armata.Ma proprio perché incapace di difesa, la donnalongobarda gode di fortissime protezioni da atti diviolenza o di disonore, e non è mai imputabile o punibile.In cambio, ha una serie di obblighi di comportamentosociale da osservare.La donna nubile era indicata come filia in capillo oin capillis, termine che la designò fino all’Ottocento,perché le ragazze longobarde portavano i capelli sciolti,mentre le maritate li portavano raccolti in una speciedi tuppo.Non entrando nel merito dei diritti di successionespettanti alla donna, si accenna alle fasi che andavanodagli ‘sponsali’ (il fidanzamento) alle nozze.Gli ‘sponsali’ consistevano in un accordo scritto esottoscritto tra la famiglia <strong>del</strong> promesso sposo e quello<strong>del</strong>la ragazza libera, e l’adempimento dei patti iviesposti era garantito dalla prestazione <strong>del</strong>la wadia, unafideiussione prestata da uno dei parenti.Le nozze non seguivano subito, ma entro un periododi due anni.Nel giorno stabilito per le nozze, avveniva la traditio,la ‘consegna’. La donna era una specie di bene, cheveniva consegnato, alla presenza di amici e parenti, dalmundualdo (padre, fratello, zio) allo sposo, che compravail mundio pagando al precedente mundualdo il meffio ometa. Al mattino <strong>del</strong> giorno seguente, lo sposo, semprealla presenza di amici e parenti, consegnava alla moglieil morgengabe, il ‘dono <strong>del</strong> mattino’.Le trasformazioni che il diritto longobardo subìper influsso <strong>del</strong>la Chiesa di Roma sono descritte accuratamentedall’Autore, che continua con l’approfondimentodegli usi in Terra d’Otranto e dedica puntualiparagrafi a Taranto, Massafra e Mottola longobarde,facendo luce su un Medioevo che, fino a qualche annofa, era un indistinto e astorico ‘periodo bizantino’.Quanto al diritto matrimoniale longobardo, essorimase in uso in Terra d’Otranto fino al 1809, vale adire fino alla promulgazione <strong>del</strong> Codice Napoleonico.Il volume, introdotto da una Presentazione <strong>del</strong>prof. Francesco Mastroberti, <strong>del</strong>l’Università di Bari,direttore <strong>del</strong> Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridicied Economici <strong>del</strong> Mediterraneo, è arricchito da unaAppendice di 21 documenti, 15 dei quali inediti, da unglossario dei termini giuridici e da un’opportuna seriedi illustrazioni.- 170 -
FELICE PASTOREIl <strong>Gruppo</strong> <strong>Archeologico</strong> <strong>Salernitano</strong> al 3° Convegno Nazionale‘Le Presenze Longobarde nelle Regioni d’Italia’,Nocera Umbra (PG), 8 - 9 Ottobre 2011Il 3° Convegno Nazionale Le PresenzeLongobarde nelle Regioni d’Italia, tenutosi nellasplendida Sala <strong>del</strong>la Pinacoteca Comunale diNocera Umbra (PG) nei giorni di sabato 8 e domenica9 Ottobre 2011 nell’ambito <strong>del</strong>le Giornate Nazionalidi Archeologia Ritrovata dei Gruppi Archeologici d’Italia,ha offerto anche al <strong>Gruppo</strong> <strong>Archeologico</strong> <strong>Salernitano</strong> l’occasioneper presentare una relazione scientifica.L’epilogo <strong>del</strong> Regno longobardo, fra Pavia, Salerno eBenevento. Una rilettura <strong>del</strong>le fonti per una datazione <strong>del</strong> palatiumlongobardo di Arechi II a Salerno è il titolo <strong>del</strong>lacomunicazione di Pasquale Natella e di chi scrive,intervenuti con un contributo denso di dati storici,epigrafici ed architettonici che, attraverso il riesame<strong>del</strong> ‘caso’ di San Pietro a Corte e <strong>del</strong> semestre a<strong>del</strong>chianoa Salerno (fine anno 774), ha voluto chiarireperché l’esclusione <strong>del</strong> monumento salernitano dalProgetto UNESCO ‘Italia Langobardorum. Centri dipotere e di culto (568-774)’ sia tanto clamorosa.Il termine cronologico finale - come si è avutomodo di esprimere già in diverse altre occasioni - risultal’elemento ‘debole’, sotto il profilo storico, di questoProgetto: se lo si assume infatti come limite <strong>del</strong>l’esistenza<strong>del</strong> Popolo longobardo in Italia, esso si configuracome fortemente riduttivo, in quanto ignora lastrenue resistenza che i Longobardi opposero al poterepapale e franco dopo il 774, e che ebbe fine solo nel1076, allorché l’ultimo Principe longobardo diSalerno, Gisulfo II, cedette il passo alla nuova signoriadei Normanni.La sconfitta alle Chiuse subita dai Longobardi adopera di Carlo Magno, seppure amara, in quanto avevaminato l’identità politica di questa Gens, non ne intralciòtuttavia il modus vivendi. In un celebre passo <strong>del</strong>Codex Legum Langobardorum - «… ducatum tunc Beneventigubernabat Arechis dux per omnia catholicus atque magnificus;qui imitator existens maiorum suae gentis reliquias rexit nobi-liter et honorifice…» 1 -, si evidenzia come Arechi II, generodi Desiderio e cognato di Al<strong>del</strong>chi, allora Duca diBenevento, mise in atto un progetto politico dettatodalla volontà di accogliere a Salerno i superstiti <strong>del</strong> suopopolo (suae gentis reliquias), cioè la vera nobiltà <strong>del</strong>regno longobardo, gli exercitales e gli Arimanni, conferendoloro l’honor <strong>del</strong>la comitiva. Il nobiliter e l’honorificesono due termini giuridici importantissimi, con i qualiArechi II giustificò all’ostile Papato e al cognato larinuncia che fece al titolo di Duca, promuovendosiPrinceps Gentis Langobardorum: non principe diFig. 1 - Nocera Umbra (PG). 3° Convegno Nazionale sulle Presenze longobarde in Italia,manifesto <strong>del</strong>l’iniziativa.- 171 -
SALTERNUMBenevento o di Salerno, ma «campione’ <strong>del</strong>la ‘patrialongobarda’» 2 , in contrapposizione a quella denominazionedi Rex Langobardorum - «misera concessione auna tradizione illustre» 3 -, sottratta da Carlo Magno aDesiderio, catturato e portato in Francia 4 .Una storia che racconta un patto sancito con l’ultimore <strong>del</strong> suo popolo, A<strong>del</strong>chi, per perpetuare la stirpein un territorio che poco importava se fosse alNord o al Sud: «dove siete sarà la vostra Patria ed iosono, da questo momento, il vostro Principe, il prosecutore<strong>del</strong>la nostra nobile stirpe di duchi e di re»Fig. 2 - Nocera Umbra (PG). 3° Convegno Nazionale sulle Presenze longobarde in Italia, intervento <strong>del</strong> dott.Felice Pastore, Direttore <strong>del</strong> <strong>Gruppo</strong> <strong>Archeologico</strong> <strong>Salernitano</strong>.Fig. 3 - Nocera Umbra (PG). 3° Convegno Nazionale sulle Presenze longobarde in Italia. PinacotecaComunale, sede <strong>del</strong> Convegno.(«Stirpe ducum regumque satus») 5 . Questo è il ruolo cheArechi II assunse nell’VIII secolo, regnando sul suoPopolo dal palatium di Salerno.Un disegno strategico che fece salva l’identità storica<strong>del</strong>la Langhibardia megale, la quale continuò ad esisterenonostante la distinzione fatta in seguito dagliStorici bizantini <strong>del</strong> XII sec., i quali vollero chiamaremaior quella <strong>del</strong> Nord dopo la sconfitta <strong>del</strong> 774, incontrapposizione a quella che, formatasi al Sud, diventòminor. In verità, ‘minor’ non lo fu né per estensionedi territorio, né per durata di anni. Infatti, i suoi confiniterritoriali andavano dal fiume Tronto(Marche) fino al fiume Noce (Basilicata) edurò tre secoli più <strong>del</strong>l’altra.Si dava così continuità al sogno iniziatonel 589, allorchè re Autari – stando a quantoscrive Paolo Diacono nell’HistoriaLangobardorum -, dopo aver attraversato conil suo cavallo tutta l’Italia, arrivato a ReggioCalabria e toccata con la sua lancia unacolonna affiorante nel mare <strong>del</strong>lo Stretto,esclamò: «Fin qui i confini dei mieiLongobardi».Tornando all’esclusione di Salerno dal‘Sito seriale’ UNESCO, sulla quale c’è statoun gran ‘vociare’, forse poco è stato dettoda parte degli Studiosi. Tra le varie motivazioniaddotte per il mancato inserimento, lapiù clamorosa viene dai corridoi <strong>del</strong>Ministero dei Beni Culturali: la causa sarebbela datazione post 774 <strong>del</strong>le superstitistrutture arechiane.Saputa questa notizia, i nostri studi e, diconseguenza, il nostro intervento alConvegno di Nocera Umbra si sono indirizzatia demolire l’infondatezza di taleaffermazione.Con la nostra relazione abbiamo dimostratocon solide argomentazioni - suscitandointeresse e apprezzamenti da parte deimaggiori longobardisti presenti in sala - cheil palatium longobardo di Salerno non soloera già esistente nell’anno <strong>del</strong>la sconfitta deiLongobardi (773), ma che accolse tra le suemura, unica dimora rimasta sicura, l’ultimore longobardo, A<strong>del</strong>chi, cum exercitu suo, nelsecondo semestre <strong>del</strong> 774 6 .- 172 -
FELICE PASTOREUna ‘missione compiuta’, quella di rendere notiquesti dati storici, che sarà ufficializzata con la pubblicazione<strong>del</strong> testo negli Atti <strong>del</strong> Convegno. Tutto ilresto non conta: charta canta!. Monumento e documentosono in simbiosi culturale. Il Complesso monumentaledi San Pietro a Corte è l’unico esempio di elevatimurari di età longobarda presente in Europa, el’ha voluto ribadire anche il nostro Sindaco, dott.Vincenzo De Luca, nella lettera fatta pervenire alConvegno e letta prima <strong>del</strong>l’inizio da un Socio <strong>del</strong><strong>Gruppo</strong> <strong>Archeologico</strong> <strong>Salernitano</strong>.Si tratta quindi di un ‘bene eccezionale’, così comerichiede l’UNESCO.In questi anni, grazie all’impegno dei Volontari, èstato anche possibile rendere fruibile al pubblico tutto ilComplesso (ipogeo, aula <strong>del</strong> trono, area <strong>del</strong>l’antica Cortelongobarda). Nei prossimi mesi, primi <strong>del</strong> 2012, cosìcome annunciato dal prof. Paolo Peduto, Ordinario diArcheologia Medievale <strong>del</strong>l’Università degli Studi diSalerno, dovrebbe uscire l’attesa pubblicazione di tutta lastoria archeologica <strong>del</strong> sito. Allora, crediamo, verrannorafforzati in maniera decisiva gli elementi a favore <strong>del</strong>l’inserimentotra i Beni Culturali ‘Patrimonio Mondiale<strong>del</strong>l’Umanità’ <strong>del</strong> Monumento salernitano, che per la suaunicità merita di essere assunto quale emblema di tuttoil Popolo longobardo in Italia.- 173 -
SALTERNUMNote1Leges Langobardorum, ed. F. BEYERLE,Witzenhausen 1962, p. 212.2DELOGU P. 1977, Mito di una città meridionale,Napoli, p. 15.3ID, Ibidem, p. 14.4Agnellus Ravennas, qui et Andreas liberPontificalis ecclesiae Ravennatis, O. Holder-Egger (ed.), in MGH, Scriptores rerumLangobardorum et Italicarum, Hannover 1879,p. 381.5Chronicon Salernitanum, c. 20, v. 7.6Cfr. nota 4.- 174 -
FELICE PASTOREDue premi per la Rivista ‘Salternum’Sabato 9 Luglio, a Santa Maria di Castellabate,nella splendida cornice di Villa Matarazzo, siè inaugurata la XXI Rassegna LibriMeridionali -‘Vetrina <strong>del</strong>l’Editoria <strong>del</strong> Sud’, nell’ambito<strong>del</strong>la quale è stata premiata la rivista ‘Salternum’,Periodico di Informazione storica, culturale e archeologicaa cura <strong>del</strong> <strong>Gruppo</strong> <strong>Archeologico</strong> <strong>Salernitano</strong>.La Rivista, giunta al XV anno di pubblicazione, èdiretta dal dott. Felice Pastore, Responsabile diRedazione e dalla dott.ssa Gabriella d’Henry,Direttore di un Comitato Scientifico formato da illustristudiosi, rappresentanti <strong>del</strong> mondo accademico eistituzionale. Ogni anno, tra i numerosi articoli inviatialla Redazione da Soci e simpatizzanti, ma anche danoti studiosi <strong>del</strong> settore e da giovani esordienti nelcampo <strong>del</strong>la storia e <strong>del</strong>l’archeologia, vengono sceltiquelli più meritevoli di pubblicazione. In linea di principio,vengono privilegiati i contributi che presentinonovità, o riletture, su siti e manufatti o argomenti dirilevante interesse culturale, con un’attenzione specifica,ma non esclusiva, per i contesti <strong>del</strong>la Campania.Dal numero XV, <strong>del</strong> 2011, ‘Salternum’, che soprattuttonegli ultimi cinque anni è cresciuta notevolmente pernumero e qualità dei contributi, è dotata di autorevoliReferee esterni, che con la loro lettura anonima offronouna ulteriore garanzia di imparzialità di giudizio e dicontrollo degli scritti, con validità anche a livello internazionale.Sul piano editoriale, la Rivista è certificatainoltre dal codice ISBN.Fig. 2 - Santa Maria di Castellabate (SA). Premio giornalistico ‘Giuseppe Ripa’. Tavolo<strong>del</strong>la Giuria.Fig. 1 - Santa Maria di Castellabate (SA). Conferimento <strong>del</strong> premio giornalistico ‘Giuseppe Ripa’ al <strong>Gruppo</strong><strong>Archeologico</strong> <strong>Salernitano</strong> per l'impegno profuso nella gestione <strong>del</strong> Complesso Monumentale di San Pietro aCorte fin dall’anno 1991.Il Premio alla Pubblicazione giunge apoca distanza da un altro riconoscimento,attribuito al <strong>Gruppo</strong> <strong>Archeologico</strong> <strong>Salernitano</strong>nel mese di Giugno: il Premio giornalistico-poetico‘Giuseppe Ripa’, conferito «per la ultraventennaleopera di valorizzazione e ditutela <strong>del</strong> Patrimonio Culturale a Salerno eProvincia», nel corso <strong>del</strong>la serata di premiazionetenutasi nell’Auditorium <strong>del</strong>Complesso Ricettivo Santa Scolastica a S.Maria di Castellabate.La motivazione sintetizza il fatto che dal2001 l’Associazione ha in affidamento dalleSoprintendenze B.A.P. e B.S.A.E di Salernoe Avellino, con le quali collabora in manierasempre più proficua, il Complesso- 175 -
SALTERNUMmonumentale di San Pietro a Corte e siadopera per divulgarne l’importanza storico-culturale,promuovendo sul territorionazionale eventi, Convegni e pubblicazioni.I due prestigiosi riconoscimenti confermanola Direzione e i Soci <strong>del</strong> <strong>Gruppo</strong><strong>Archeologico</strong> <strong>Salernitano</strong> <strong>del</strong>la validità <strong>del</strong>l’impegnoassunto e costituiscono un incorag-giamento a continuare le attività finalizzateall’inserimento <strong>del</strong>lo straordinariomonumento salernitano tra i sette siti giàriconosciuti dall’UNESCO ‘PatrimonioMondiale <strong>del</strong>l’Umanità’ nel quadro <strong>del</strong>Sito seriale ‘Italia Langobardorum, centridi potere e di culti (568-774)’.Fig. 1 - Premio Studi Meridionali‘Vetrina per l’Editoria <strong>del</strong> Sud’,conferito dalla Giuria al <strong>Gruppo</strong><strong>Archeologico</strong> <strong>Salernitano</strong> per la Rivista‘Salternum’.- 176 -
FRANCESCO MONTONEUn ricordo di Marcello Gigante(1923-2001)Il 23 novembre 2011 ricorre il decimo anniversario<strong>del</strong>la morte di Marcello Gigante, uno deipiù insigni studiosi <strong>del</strong> mondo antico. Nato aBuccino il 20 gennaio 1923, Gigante conseguì la laureain Lettere Classiche a Napoli nel 1944; dopo un’esperienzadi docenza nelle Scuole, ebbe dal 1953 al1960 la cattedra di Filologia bizantina alla Facoltà diLettere <strong>del</strong>l’Università degli Studi di Napoli; proseguìla carriera universitaria a Trieste, dopo essere risultatosecondo vincitore <strong>del</strong> concorso di Letteratura grecabandito nel 1958 dall’Università degli Studi di Cagliari(Commissione: Vittorio De Falco, Mario Untersteiner,Raffaele Cantarella, Carlo <strong>del</strong> Grande, Carlo Diano).Dal 1968 al 1981 Gigante fu ordinario di GrammaticaGreca e Latina alla ‘Federico II’. Dal 1981 ebbe, pressola medesima Università, la cattedra di LetteraturaGreca. Filologo classico, grecista, papirologo di famainternazionale, membro di numerose e prestigioseAccademie, Presidente <strong>del</strong>l’Associazione Italiana diCultura Classica (AICC) dal 1982 al 1994, direttore diimportanti riviste, Gigante ha rivestito un ruolo di primissimopiano nel promuovere la cultura classica,dando impulso fortissimo, con la fondazione <strong>del</strong>CISPE (Centro Internazionali per lo Studio dei PapiriErcolanesi), allo studio dei papiri <strong>del</strong>la Villa diErcolano. Fu lui stesso ad istituire, nel 1971, la cattedradi Papirologia Ercolanese nell’Ateneo federiciano,ricoprendola fino al 1983, ed a fondare la Rivista‘Cronache Ercolanesi’.Non è possibile, in questa sede, rendere conto deisuoi circa 800 scritti 1 ; ci limiteremo a menzionare alcunisuoi importanti saggi, che ne testimoniano lostraordinario eclettismo, manifesto di una visione unitaria<strong>del</strong>le Scienze <strong>del</strong>l’Antichità (quale era concepitada Wolf e da Comparetti), e l’infaticabile attività dipromozione culturale, che Egli svolgeva anche al difuori <strong>del</strong>l’ambito accademico, tenendo conferenze inmoltissimi licei e associazioni culturali. I suoi volumiRicerche filodemee (Napoli 1969) e Filodemo in Italia(Firenze 1990) hanno contribuito a ridefinire il profilo<strong>del</strong>l’epicureismo in Italia. Il suo capolavoro - NomosBasileus (Napoli 1956) - è una lucida analisi <strong>del</strong>la scopertateoretica, avvenuta in Grecia, <strong>del</strong>la dottrina <strong>del</strong>diritto <strong>del</strong> più forte, quale emerge in particolare inPindaro. In Classico e mediazione (Roma 1989) Giganteripercorre i rapporti tra Wilamowitz e i filologi italiani,la concezione filologica <strong>del</strong> Nietzsche, proponendoanche ritratti acuti di studiosi <strong>del</strong> calibro di Vico,Vitelli e Valgimigli.Mi piace ricordare, infine, due volumetti che testimonianoil grande amore <strong>del</strong>lo Studioso verso la terracampana. Ne Il fungo sul Vesuvio (Roma 1989) Giganteanalizza le epistole VI, 16 e 20 di Plinio il Giovane(scritta l’una per la ‘storia’, l’altra per ‘la cronaca’) dedicateall’eruzione <strong>del</strong> Vesuvio <strong>del</strong> 79 d. C., nella qualelo scrittore latino perse lo zio, Plinio il Vecchio.Nel bellissimo Virgilio e la Campania (Napoli 1984)analizza i passi <strong>del</strong>l’opera <strong>del</strong> poeta mantovano in cuicompaiono i toponimi campani e il manoscrittoNeapolitanus Lat. 6 ex Vindobonensis che contiene leopere di Virgilio, conservato alla Biblioteca Nazionaledi Napoli: «La Campania - scrive Gigante (pp. 7-8) -rivelò al poeta la duplice frontiera <strong>del</strong>la nostra vita e glidonò il privilegio <strong>del</strong>lo sguardo oltre la siepe: non glisquarciò i segreti impenetrabili, ma gli largì l’eternadimensione dei tempi <strong>del</strong>la storia. Qui dove non eranato, ma dove molto vagabondò, Virgilio volle lapausa estrema <strong>del</strong> cammino».Una bibliografia completa <strong>del</strong>le opere di M. Gigante si trova in S. CERASUOLO (a cura di), Mathesis e Mneme. Studi in onore di Marcello Gigante,Napoli 2004, pp. 9-52.Al prof. Marcello Gigante, in data 13 ottobre 2009, è stato intitolato il Museo <strong>Archeologico</strong> Nazionale di Volcei (Buccino).- 177 -
ROSALBA TRUONO IANNONEAppunti di viaggioScoprire il Perù, tra impressionanti necropolie antichi costumi funerariLa necropoli di Chauchilla è un impressionantecimitero archeologico che si estende suun’area desertica <strong>del</strong> Perù a 30 km circa daNazca, località nota per i suoi giganteschi geoglifi zoomorfi,disegnati, non si sa da chi e perché, nella vallatadesertica di El Ingenio.L’area cimiteriale, utilizzata probabilmente inepoca Ico - Chinca (1100 – 1450 d. C.), corrispondenteal Periodo Intermedio Recente <strong>del</strong>la storia <strong>del</strong>le civiltàandine, è alquanto vasta ed interessante non solo perle 12 tombe visitabili, scavate dagli archeologi e ricompostecon i loro contenuti, quanto per quelle numerosissime,che sono ancora sepolte nel terreno desertico,preda dei tombaroli locali - gli ‘huaqueros’ -, che al chiarodi luna, sotto le stelle scavano alla ricerca di preziosicorredi funerari, causando l’irreparabile distruzionedi un enorme patrimonio storico-culturale.Fino a poco tempo fa il luogo si presentava comeun insieme di buchi aperti nella sabbia, da cui emergevanoresti di defunti mummificati, ossa, capelli, tessutie frammenti di ceramiche.Poi tra il 1999 ed il 2000 l’archeologo Miguel Pazosiniziò un’opera di ricostruzione <strong>del</strong>le tombe depredatecon il riposizionamento, all’interno, di ‘fardi’ e di defuntimummificati, in posizione fetale. Egli ricostruì pure icorredi funerari, indicatori <strong>del</strong>lo status sociale <strong>del</strong> morto.La ricostruzione <strong>del</strong>la necropoli di Chauchilla, perquanto criticata dagli studiosi, è affascinante per l’illustrazionedei costumi funerari <strong>del</strong>l’epoca precedenteall’espansione <strong>del</strong>l’Impero Inca. È un vero museo acielo aperto, dove sono riprodotte grandi stanze funerarieipogee, rettangolari o quadrate, tombe collettivecon pareti in adobe, tappate con pali di huarango, alberoautoctono dal legno imputrescibile e resistente all’azionedegli insetti, simile al carrubo.All’interno sono esposti defunti di ogni ceto sociale,intere famiglie i cui corpi venivano mummificati, leossa rotte in modo che assumessero la posizione fetalee rivolti verso Est, verso il Sole, che adoravanocome la Terra e l’Acqua.- 179 -
SALTERNUMIl grande interesse rivestito dai ritrovamenti e dialtre aree non è rappresentato solo dal tipo di sepolturao dai corredi, ma anche dallo stato di conservazionedei cadaveri. Il corpo non è sempre imbalsamato:per la sua conservazione é talvolta semplicemente affidatoal terreno estremamente secco. Cosicché è possibilevedere, posizionate nelle camere funerarie a cieloaperto, mummie dai capelli lunghi, indice <strong>del</strong>l’appartenenzaad un elevato stato sociale, o donne con il fetodal cranio trapanato; in un angolo <strong>del</strong>la tomba n. 10 sivedono i resti di un bambino con il suo pappagallo econ il corredo funerario formato da una ciotola e daun piatto.I corpi sono avvolti da tessuti colorati ed il corredofunerario comprende anche vasellame dipinto a uncolore, foglie di carrubo o di mais.In una di queste tombe sono visibili le mummie diquattro bambini, morti forse di tubercolosi, decapitati,come richiedeva il rituale <strong>del</strong>la cultura Huari.Per quanto riguarda l’imbalsamazione, le tecnicheerano conosciute in Perù come in Cile fin dal 4000 a. C.;essa fu adottata da tutte le culture peruviane fino allacaduta <strong>del</strong>l’Impero Incaico, ma è da ricordare che lamaggior parte <strong>del</strong>le mummie rinvenute incaiche opreincaiche si sono formate secondo processi naturalie che pochi gruppi etnici praticavano l’imbalsamazioneartificiale.Per fare essiccare il corpo per vie naturali si sceglievanoluoghi di sepoltura dal clima secco e terreni <strong>del</strong>tutto privi di umidità, altrimenti si svuotava il corpodai visceri, che venivano sostituiti da conservantivegetali e, infine, lo si cospargeva di particolari resineed unguenti.Il clima arido <strong>del</strong>le regioni di Paracas, Nazca eChancay ha consentito un’ottima conservazione dimateriali organici, dei tessuti decorati a motivi geometricie zoomorfi e di raffinate ceramiche.Le mummie erano avvolte da numerosi strati di tessuto,vivacemente colorati e ricamati, i cosiddetti mantos,simboli di ricchezza e di nobiltà. Le persone di originepiù modesta venivano sepolte dopo essere state avvoltein un tessuto di cotone grossolano ed erano accompagnateda semplici recipienti di terracotta.I benestanti e la classe dominante si riconosconodai numerosi strati di tessuti pregiati in cui sono avvoltisino a formare un ‘fardo’ alto fino a due metri.Tipico <strong>del</strong>le culture costiere <strong>del</strong> Perù, il fardo venivapreparato sistemando il corpo in posizione fetale, dentroun paniere, il tutto avvolto in numerosi strati ditessuto cuciti tra di loro. Spesso il fardo era adorno diuna tunica di piume variopinte, di una mantellina dicuoio o di una maschera funeraria e uno scettro.Il corredo funerario era sontuoso: gioielli, piume,conchiglie vasi e pelli di animali accompagnavano ilfardo.Alcune mummie, specialmente nella necropoli diParacas, presentano le famose teste-trofeo, in riferimentoall’abitudine, che avevano i Nasca, di tagliare leteste dei nemici e di mummificarle, di cucire la boccacon <strong>del</strong>le spine e portarle appese alla cintura per assumerela forza e il coraggio <strong>del</strong> defunto.In tutto il Regno Inca, che i Quechua chiamavanoTahuantinsuyn, i sovrani, i nobili e i capostipiti dei clan -detti ayllu -, dopo essere stati mummificati assumevanoil ruolo di huacas, cioè di idoli sacri, e venivano trasportatiperiodicamente in processione a Cuzcodurante le feste religiose, agghindati e abbigliati, con ilvolto coperto da una maschera, come se fossero invita.- 180 -
ROSALBA TRUONO IANNONEQueste mummie-feticcio non venivano mai sepolte,ma conservate in piccole grotte, che garantivanouna temperatura adatta, e durante l’anno ricevevanoofferte e sacrifici. Questa tradizione si perpetua ancoraoggi nella rituale processione che si tiene a Cuzco,durante il solstizio d’inverno, in occasione <strong>del</strong>la Festa<strong>del</strong> Sole, Inti Raymi, la più sentita dai popoli andini.I popoli antichi, come le genti andine, credevanonella vita ultraterrena e veneravano gli antenati; pertantoera importante offrire al defunto una degna ericca sepoltura, perché nell’Aldilà godesse <strong>del</strong>le gioie edei privilegi <strong>del</strong>la vita terrena.- 181 -
SALTERNUMIndiceSALTERNUM IPremio ‘Nicola Fierro’Concorso bandito dal <strong>Gruppo</strong> <strong>Archeologico</strong> <strong>Salernitano</strong> per il miglior saggio originalesu un tema di archeologia di area campana in età antica o medievale ......................................................................................p. 3Il culto di Mitra in Campania ..........................................................................................................................................p. 7di Giovanni VergineoArcheometria ed epigrafia: applicazioni sperimentali sulle iscrizioni tardoantiche di Abellinum ........................p. 21di Elena GigantinoL’apporto <strong>del</strong>l’archeometria agli studi epigrafici:l’esempio <strong>del</strong>le iscrizioni <strong>del</strong>la basilica paleocristiana di Abellinum - Atripalda (AV) ..........................................p. 29di Marianna MelfiIl Complesso di San Pietro a Corte in Salerno: restituzione in 3D <strong>del</strong>la fase tardoantica ..................................p. 35di Rosanna BaroneLa Piana <strong>del</strong> Sele alla fine <strong>del</strong>l’Età <strong>del</strong> Rame: riflessioni per un inquadramento culturale ..................................p. 43di Gilda NapoliSALTERNUM IIEditorialeVita da … Archeologo....................................................................................................................................................p. 53di Gabriella d’HenryLa Federazione Archeologi Professionisti ..................................................................................................................p. 55di Monica ViscioneLa necropoli di S. Marco di Castellabate......................................................................................................................p. 61di Giuseppina Bisogno - Monica ViscioneImpero e Chiesa da Costantino a Giustiniano ............................................................................................................p. 69di Pietro CrivelliScribo ergo sum.La presenza dei toponimi campani in Sidonio Apollinare, l’ultimo letterato <strong>del</strong>l’Impero romano ..................p. 89di Francesco MontoneNuove ipotesi interpretative per il Battistero paleocristianodi Santa Maria Maggiore in Nocera Superiore ........................................................................................................p. 107di Giuseppina Ambruoso- 183 -
SALTERNUML’affresco di ‘San Nicola e San Giorgio (?)’ <strong>del</strong>l’ambiente ‘ipogeo D’<strong>del</strong>la Chiesa di San Pietro a Corte a Salerno ............................................................................................................p. 115di Mario MolesLa Chiesa di San Matteo in Bisceglie.Le origini normanne di Bisceglie e <strong>del</strong>la chiesa di San Matteo ..............................................................................p. 131L’impianto architettonico: ipotesi di ricostruzione ..................................................................................................p. 137Testimonianze pittoriche ..............................................................................................................................................p. 139di Aurelia Daniela Rana - Claudio ArmeniseL’Italia dei piccoli tesori: per un dipinto inaspettatamente ritrovato ....................................................................p. 145di Tiziana ManciniLa cassetta <strong>del</strong> tonsor cerusicus ........................................................................................................................................p. 149di Giuseppe LaurielloLa Biblioteca Provinciale di Salerno al servizio <strong>del</strong>la Comunità locale e nazionale ..........................................p. 161di Vittoria BonaniSegnalazioniMARIA LUISA NAVA, Archeologia preventiva. Esperienze a confronto.Atti <strong>del</strong>l’incontro di studio (Salerno, 3 luglio 2009) ..........................................................................................................p. 167di Chiara LambertRecensioniGIULIO MASTRANGELO, La condizione giuridica <strong>del</strong>la donna nelle leggilongobarde e negli usi matrimoniali in Terra d’Otranto ......................................................................................................p. 169di Roberto CapraraIl <strong>Gruppo</strong> <strong>Archeologico</strong> <strong>Salernitano</strong>al 3° Convegno Nazionale ‘Le Presenze Longobarde nelle Regioni d’Italia’,Nocera Umbra (PG), 8 - 9 Ottobre 2011 ................................................................................................................ p. 171di Felice PastoreDue premi per la Rivista ‘Salternum’ ........................................................................................................................ p. 175di Felice PastoreUn ricordo di Marcello Gigante (1923-2001) ..........................................................................................................p. 177di Francesco MontoneAppunti di viaggioScoprire il Perù, tra impressionanti necropoli e antichi costumi funerari ............................................................p. 179di Rosalba Truono Iannone- 184 -
Associazione Provinciale di Salerno84123 Salerno – C.so V.Emanuele,75Tel 0892583108 – Fax 0892583165E-mail: segreteria@cna.sa.itInternet: www.cnasalerno.itUNA GRANDE ORGANIZZAZIONE AL SERVIZIO DELLE IMPRESELa CNA, Confederazione Nazionale <strong>del</strong>l’Artigianato e <strong>del</strong>la Piccola e Media Impresa, da oltre sessant’annirappresenta e tutela gli interessi <strong>del</strong>le imprese artigiane, <strong>del</strong>le PMI e di tutte le forme <strong>del</strong> lavoro autonomo.Una realtà che oggi trae forza e peso da circa 670.000 associati in tutta Italia.
Finito di stampareda Arti Grafiche Sud, Salernonel mese di novembre 2011