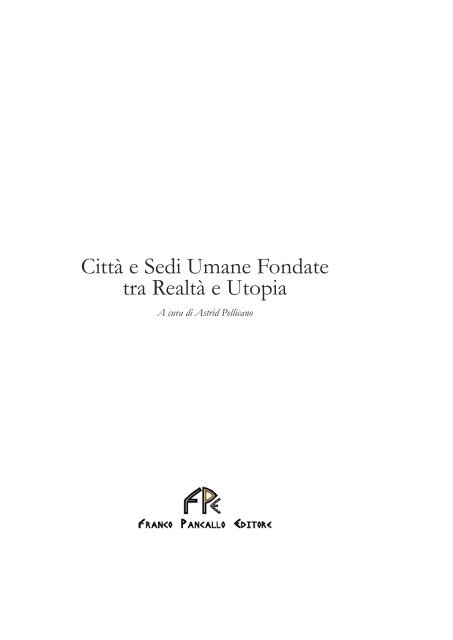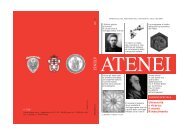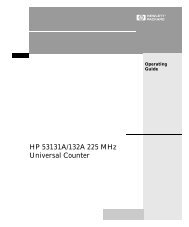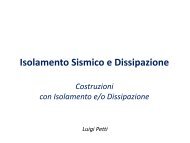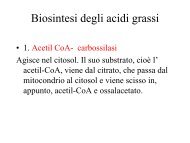La Certosa di Padula... - Università degli Studi di Salerno
La Certosa di Padula... - Università degli Studi di Salerno
La Certosa di Padula... - Università degli Studi di Salerno
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Città e Se<strong>di</strong> Umane Fondate<br />
tra Realtà e Utopia<br />
A cura <strong>di</strong> Astrid Pellicano
Proprietà letteraria riservata<br />
© by Franco Pancallo E<strong>di</strong>tore - Locri - Italy<br />
Via Mercurio/C.so V.Emanuele, 71 - Tel. 0964.29168<br />
e-mail: fpe@francopancalloe<strong>di</strong>tore.it<br />
website: www.francopancalloe<strong>di</strong>tore.it<br />
Stampato in proprio
VInCEnzo AVERSAno<br />
MARIA RoSARIA DE VITA<br />
SILVIA SInISCALChI *<br />
<strong>La</strong> <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong> e il suo territorio:<br />
una “città ideale” riscoperta e in via <strong>di</strong> valorizzazione<br />
<strong>La</strong> <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong>: sette secoli <strong>di</strong> presenza operosa e travagliata<br />
Pitagora <strong>di</strong> Samo, per il quale tutto è numero, saprebbe forse oggi cogliere<br />
un qualche misterioso, mistico legame tra i sette vizi capitali, i sette doni dello<br />
Spirito Santo, le sette lettere dei tre nomi legati alla nascita della <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> San<br />
Lorenzo <strong>di</strong> <strong>Padula</strong> 1 e i sette secoli trascorsi dalla sua e<strong>di</strong>ficazione…<br />
Suggestioni numeriche a parte, geografia, storia, arte e religione sono realmente<br />
chiamate a interagire nel tentativo <strong>di</strong> penetrare i segreti <strong>di</strong> questa magnifica<br />
roccaforte della spiritualità certosina, racchiusi, tra splendori passati e presenti,<br />
nell’imponente e<strong>di</strong>ficio eretto ai pie<strong>di</strong> della collina su cui è ubicato il centro <strong>di</strong><br />
<strong>Padula</strong>, nella sezione sud-orientale del Vallo <strong>di</strong> Diano, in provincia <strong>di</strong> <strong>Salerno</strong>. <strong>La</strong><br />
<strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> San Lorenzo, infatti, nel corso delle sue vicende, tra il rispetto della rigida<br />
regola <strong>di</strong> San Brunone e la costante interazione con il territorio circostante,<br />
nel doppio ruolo <strong>di</strong> realtà mistico-religiosa e politico-sociale, dotata <strong>di</strong> incisiva<br />
forza <strong>di</strong> modellamento spaziale, rappresenta una “città ideale” ante litteram: “civitas<br />
Dei” e polis spirituale, da un lato; dall’altro, istituzione mondana assai potente,<br />
con un patrimonio fon<strong>di</strong>ario spintosi, nella sua costante espansione, ben oltre i<br />
limiti della subregione <strong>di</strong>anense 2 .<br />
<strong>La</strong> posizione geografica <strong>di</strong> quest’ultima – «<strong>di</strong> figura molto simile a una barchetta,<br />
che nel principio e nel fine è stretta e nel mezzo larga» 3 – ne spiega la storica<br />
funzione <strong>di</strong> collegamento tra nord e sud della penisola italiana: non a caso la<br />
Strada Statale n. 19 “delle Calabrie”, l’Autostrada del Sole e la ferrovia che oggi<br />
l’attraversano riprendono, in parte, il tracciato romano dell’antica via Annia, o<br />
Popilia, che si congiungeva nella Campania alla via Appia. non meno “strategica”<br />
era la posizione per quanto riguarda i rapporti trasversali tra i due mari (Tirreno<br />
da una parte e Ionio e Adriatico dall’altra 4 .<br />
Ma, per venire subito all’atto <strong>di</strong> fondazione della <strong>Certosa</strong>, occorre collocarci<br />
nel periodo coevo e successivo alla guerra del Vespro (1282-1302), quando il<br />
controllo del Vallo si rivela <strong>di</strong> vitale importanza per impe<strong>di</strong>re il passaggio dei siculo-aragonesi<br />
verso nord: Tommaso II Sanseverino, conte <strong>di</strong> Marsico e feuda-<br />
675
tario <strong>di</strong> <strong>Padula</strong> dal 1296, aveva infatti ricevuto da Carlo II d’Angiò l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong><br />
fortificare la zona e <strong>di</strong> erigervi un castello 5 ; venne così realizzato un efficace sistema<br />
<strong>di</strong>fensivo, anche grazie anche alla protezione naturale offerta dagli aspri<br />
monti del Cilento 6 .<br />
A guerra conclusa, per riaffermare la propria fedeltà alla <strong>di</strong>nastia angioina e<br />
ingraziarsi ulteriormente il sovrano, Tommaso decise <strong>di</strong> far costruire a <strong>Padula</strong> un<br />
grande monastero, da donare, insieme a una parte dei propri posse<strong>di</strong>menti, ai<br />
certosini, or<strong>di</strong>ne monastico particolarmente caro ai sovrani d’oltralpe, per la comune<br />
origine francese e l’ascendenza colta e aristocratica dei suoi esponenti 7 . A<br />
tale scopo, dopo lunghe trattative, il conte ottenne per permuta dall’Abate Guglielmo<br />
<strong>di</strong> Montevergine un cenobio benedettino trasformato in grancia (una vera<br />
e propria fattoria) con tutti i suoi beni (l’atto è del 14 ottobre 1305), situato presso<br />
<strong>Padula</strong> e de<strong>di</strong>cato a San Lorenzo martire 8 . nel 1306 ne fece dono ai certosini,<br />
con annessi beni e privilegi, a cui aggiunse il «<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> pesca gratuita nelle acque<br />
del Vallo e <strong>di</strong> libero pascolo negli interi posse<strong>di</strong>menti dei Sanseverino» nonché,<br />
nel 1307, un’altra sua proprietà, chiamata «orto grande», situata a sud della grancia<br />
<strong>di</strong> San Lorenzo (SBoRDonE, 1982, p. 159).<br />
In aggiunta ai benefici spirituali (assicurati dalle preghiere dei monaci: VI-<br />
ToLo, 2006, p. 30) e politici, la pro<strong>di</strong>galità del Sanseverino puntava a finalità <strong>di</strong><br />
or<strong>di</strong>ne pratico. Dall’operato monastico egli si attendeva infatti un significativo<br />
contributo al risanamento generale dei suoi posse<strong>di</strong>menti nel Vallo, <strong>di</strong> cui emergevano<br />
con desolante evidenza il degrado e i guasti economici derivanti dai lunghi<br />
anni <strong>di</strong> guerra. Tra immensi spazi vuoti, villaggi <strong>di</strong>strutti o abbandonati 9 e campi<br />
non più coltivati, il preesistente, gravoso problema dell’impaludamento, <strong>di</strong>venuto<br />
cronico, affliggeva l’intera valle, come tuttora testimonia la toponomastica dei<br />
luoghi (<strong>Padula</strong>, richiamante la palude; Buonabitacolo, Casalbuono, Montesano,<br />
Sassano, in<strong>di</strong>canti più salubri con<strong>di</strong>zioni ambientali rispetto al fondovalle) 10 .<br />
Le aspettative <strong>di</strong> Tommaso non sarebbero state deluse: i monaci <strong>di</strong> San Brunone,<br />
trasformata la Grancia in <strong>Certosa</strong> (seguendo il modello della certosa <strong>di</strong> Trisulti,<br />
nel <strong>La</strong>zio, e <strong>di</strong> Grenoble, casa madre dell’or<strong>di</strong>ne) 11 , svolsero successivamente un<br />
ruolo fondamentale nella campagna <strong>di</strong> bonifica intrapresa per il Vallo, plasmandone<br />
e rendendone durevole il paesaggio circostante, giunto sino ai nostri giorni.<br />
ottenuti privilegi economici e giuri<strong>di</strong>ci dai re <strong>di</strong> napoli e ulteriori donazioni<br />
dai nobili del Vallo, i monaci iniziarono ad acquistare altri piccoli territori, fino a<br />
possedere, nel corso dei secoli, zone sempre più <strong>di</strong>stanti da <strong>Padula</strong>. Già nel corso<br />
del ‘400, infatti, la loro giuris<strong>di</strong>zione raggiunse l’attuale Basilicata – attraverso l’acquisizione<br />
del feudo <strong>di</strong> S. Maria <strong>di</strong> Pisticci (esteso fino al mar Ionio) e <strong>di</strong> quello<br />
<strong>di</strong> S. Basilio (che raggiungeva il Golfo <strong>di</strong> Taranto) con tutti i loro beni – per poi<br />
inglobare, nel secolo successivo, una parte dei posse<strong>di</strong>menti dei Sanseverino <strong>di</strong><br />
Marsico, tra cui le <strong>di</strong>fese feudali <strong>di</strong> Mandrano e Mandranello (due depressioni tettoniche<br />
situate presso Marsico nuovo) 12 , alcuni terreni nei pressi <strong>di</strong> Sala Consilina<br />
676
e al <strong>di</strong> fuori del Vallo (Moliterno, S. Chirico Raparo e Saponara [attuale Grumento<br />
nova]). Ancora più importante si rivelò l’acquisizione, tra il 1514 e il 1515, della<br />
Ba<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Santa Maria <strong>di</strong> Cadossa, costituita in <strong>di</strong>ocesi, con i suoi beni (casali <strong>di</strong><br />
Cadossa e Casalnuovo) e altri terreni nella zona <strong>di</strong> Diano (attuale Teggiano), che<br />
aggiungeva una nuova prerogativa alla <strong>di</strong>gnità priorale della <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> San Lorenzo,<br />
arricchendone prestigio e poteri 13 .<br />
Anche gli Aragonesi e le famiglie feudali sostituitesi ai Sanseverino (in <strong>di</strong>sgrazia<br />
dopo la seconda “congiura dei baroni”, prima <strong>di</strong> essere del tutto defenestrati<br />
a metà del ‘500) 14 continuarono a proteggere e favorire l’operato e<br />
l’ampliamento territoriale del monastero 15 , <strong>di</strong>venuto, nel frattempo, tappa <strong>di</strong> soste<br />
quasi obbligate lungo il percorso tra napoli e Reggio Calabria. A riguardo, tra la<br />
visite più celebri, si ricorda quella <strong>di</strong> Carlo V d’Asburgo nel 1535 (al rientro dall’impresa<br />
<strong>di</strong> Tunisi), alla quale si lega l’aneddoto della frittata <strong>di</strong> mille uova (preparata<br />
dai certosini per lui e il suo seguito) che, sebbene frutto <strong>di</strong> fantasia 16 , fa<br />
ben capire <strong>di</strong> quale gran<strong>di</strong>osa fama godesse a quel tempo il sempre più ricco monastero<br />
17 . nel 1636, infatti, entrò a far parte delle sue proprietà anche il feudo <strong>di</strong><br />
Montesano (già dei Sanseverino e, <strong>di</strong> poi, <strong>degli</strong> Ambrosino) 18 , a cui si aggiunsero,<br />
pochi anni dopo, <strong>Padula</strong> con Buonabitacolo, il maggior feudo del Vallo (SBoR-<br />
DonE, 1982, p. 160), <strong>di</strong> cui i certosini controllavano ormai la parte meri<strong>di</strong>onale e<br />
orientale (mentre i rimanenti feu<strong>di</strong> erano <strong>di</strong>visi tra altre potenti famiglie).<br />
Alle acquisizioni territoriali corrisposero le fasi dell’ingran<strong>di</strong>mento e arricchimento<br />
architettonico-artistico del monastero, che, tra il XVIII e XIX secolo,<br />
costituì uno dei maggiori centri d’arte e cultura del Mezzogiorno. Una triste conferma<br />
della sua preziosità sarebbe giunta dalle ra<strong>di</strong>cali spoliazioni subite nel corso<br />
del decennio francese, con la legge <strong>di</strong> eversione della feudalità del 1806 e la soppressione<br />
<strong>degli</strong> or<strong>di</strong>ni religiosi, estesa a benedettini, certosini e cistercensi il 13<br />
febbraio 1807 19 .<br />
Dopo la restaurazione borbonica, il rientro <strong>di</strong> un piccolo numero <strong>di</strong> monaci<br />
nella <strong>Certosa</strong> (dove vivevano oramai miseramente: LénoRMAnT, 1990, p. 111)<br />
durò appena cinquantuno anni: gravemente danneggiata dal terremoto del 1857<br />
(MALLET, 1990, p. 108), definitivamente chiusa a seguito delle leggi eversive del<br />
neogoverno unitario italiano (1866-67), pur <strong>di</strong>chiarata monumento nazionale nel<br />
1882 (su insistenza del Consiglio Provinciale, che volle così evitarne la ven<strong>di</strong>ta e<br />
la demolizione), fu destinata a subire negli anni successivi un degrado crescente,<br />
tra calamità naturali (come la <strong>di</strong>sastrosa alluvione <strong>di</strong> fine ‘800 del fiume Fabbricato,<br />
i cui effetti sono tuttora visibili nel <strong>di</strong>slivello <strong>di</strong> circa 3 metri tra la strada e<br />
il perimetro murario esterno) e storiche (tra cui la sua utilizzazione come campo<br />
<strong>di</strong> concentramento durante la prima e la seconda guerra mon<strong>di</strong>ale, a seguito della<br />
quale l’ultima riportò notevoli danni: SBoRDonE, 1975, pp. 160-161).<br />
orfanotrofio fino al 1956, la <strong>Certosa</strong>, totalmente abbandonata a se stessa e<br />
all’azione devastante <strong>degli</strong> agenti naturali per quasi vent’anni (dalla seconda metà<br />
677
<strong>degli</strong> anni Cinquanta fino agli anni ottanta), nel 1982 fu finalmente affidata alle<br />
cure della Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici<br />
<strong>di</strong> <strong>Salerno</strong>, per essere poi <strong>di</strong>chiarata, <strong>di</strong>eci anni dopo, patrimonio dell’umanità<br />
dall’UnESCo 20 .<br />
678<br />
2. «Felix coeli porta»: il monastero <strong>di</strong> <strong>Padula</strong> e la città ideale<br />
Secondo L. Mumford, i «veri <strong>di</strong>scepoli spirituali <strong>di</strong> Platone arrivarono circa<br />
mille anni dopo e furono i monaci benedettini» (MUMFoRD, 2002, I, p. 237). Difatti,<br />
sotto il profilo ideologico e nel concreto della storia, esistono molteplici<br />
analogie tra le utopie urbanistiche della filosofia occidentale (a partire da Platone<br />
e Aristotele) e le utopie religiose della Città <strong>di</strong> Dio, o dell’anima, proprie del monachesimo<br />
cristiano.<br />
All’indomani della caduta dell’impero romano e della crisi morale, culturale<br />
ed economica conseguitane, il monastero rappresenta infatti un nuovo tipo <strong>di</strong><br />
polis, i cui abitanti sono accomunati da un medesimo scopo: condurre sulla terra<br />
una vita cristiana rivolta unicamente e sinceramente al servizio <strong>di</strong> Dio. <strong>La</strong> colonia<br />
monastica <strong>di</strong>viene così la nuova cittadella dell’anima, allo stesso tempo «l’attuazione<br />
dell’ideale <strong>di</strong> Aristotele: una società <strong>di</strong> eguali che aspiravano a vivere nel<br />
miglior modo possibile […] Qualunque fosse la confusione del mondo esterno,<br />
il monastero era un’isola <strong>di</strong> serenità e or<strong>di</strong>ne» (MUMFoRD, II, p. 319).<br />
Il paragone tra il monastero benedettino e la città ideale, pur non essendo<br />
una novità («basti ricordare il piano ideale dell’abbazia <strong>di</strong> S. Gallo [benedettina,<br />
appunto] che è dell’XI secolo»: Leoncini, 1988, p. 55), <strong>di</strong>viene ancora più significativo<br />
ed emblematico nel caso <strong>di</strong> una certosa, paragonabile a una piccola<br />
città-stato, con dei citta<strong>di</strong>ni che vi risiedono volontariamente, partecipano del<br />
suo governo e sottostanno alle sue regole, visibili nella sua stessa struttura architettonica<br />
21 .<br />
Infatti, poiché la formula originale dell’or<strong>di</strong>ne (unione <strong>di</strong> solitari in una piccola<br />
comunità) esige una rigida separazione <strong>degli</strong> spazi (per l’armonica convivenza,<br />
come in un unico corpo, della preghiera e dell’azione, dell’aspetto<br />
ascetico-contemplativo e <strong>di</strong> quello pratico-operativo) 22 , la <strong>Certosa</strong> è <strong>di</strong>visa in due<br />
parti: “casa alta” (interna), <strong>di</strong>mora dei monaci claustrali (consacrati al silenzio assoluto,<br />
alla preghiera, alla contemplazione e allo stu<strong>di</strong>o) 23 e “casa bassa” (esterna),<br />
sede dei fratelli conversi, certosini anch’essi, ma de<strong>di</strong>ti alle mansioni pratiche per<br />
la cura materiale dell’or<strong>di</strong>ne, tra cui l’amministrazione dei beni (affidata ai padri<br />
procuratori), la sovrintendenza delle attività agricole e artigianali e la cura dei rapporti<br />
con le comunità residenti circostanti 24 .<br />
L’isolamento della casa alta doveva essere assoluto: perciò la <strong>Certosa</strong>, come<br />
previsto dalla regola, è circondata da un grande spazio verde recintato (il cosid-
detto desertum), funzionale anche al sostentamento materiale monastico (era <strong>di</strong>fatti<br />
certamente coltivato), le cui forme rettangolari, scan<strong>di</strong>te, come la pianta dell’e<strong>di</strong>ficio,<br />
da viali ortogonali, richiamano la graticola <strong>di</strong> San Lorenzo (SBoRDonE,<br />
1975, p. 160, DE CUnzo, 1988, p. 21 e WEAVER, 1990, p. 12) 25 .<br />
<strong>La</strong> protezione è tanto più necessaria perché la casa alta, un tempo inaccessibile<br />
agli estranei, è appunto la Civitas Dei: «varcata quella soglia, saremo entrati<br />
nella Gerusalemme Celeste» (DE MARTInI, 1990, p. 85), come preannunciato dal<br />
cartiglio «Felix coeli porta» (visibile sulla grande facciata interna del monastero)<br />
e come confermato dalle impareggiabili bellezze artistiche, dal richiamo all’infinito<br />
<strong>degli</strong> immensi spazi claustrali e delle forme geometriche elicoidali, dagli incroci<br />
ortogonali dei muri, inseriti all’interno <strong>di</strong> un perfetto rettangolo, secondo uno<br />
schema costantemente immutato. Come la «città ideale vive in una “situazione<br />
sotto vetro e nella lontananza nello spazio e nel tempo – con<strong>di</strong>zione fondamentale<br />
del sogno utopistico – […] la certosa “è” il luogo ideale e attuale per il pieno<br />
esercizio della qualità <strong>di</strong> monaco» 26 , dove, come nelle città ideali dei “geometri<br />
sociali” della filosofia classica, rinascimentale e moderna, la regola <strong>di</strong> San Brunone<br />
si trasforma in «un esercizio <strong>di</strong> geometria solida» (MUMFoRD, 2002, I, p. 226) 27 .<br />
nasce così spontaneo l’accostamento «del monastero certosino a quella città<br />
ideale vagheggiata da Leon Battista Alberti e Leonardo, città or<strong>di</strong>nata e felice, che<br />
favorisce il buon governo e l’educazione dei singoli citta<strong>di</strong>ni. <strong>La</strong> certosa, con il<br />
suo silenzio, il mistico raccoglimento e la semplicità delle azioni quoti<strong>di</strong>ane rappresenta<br />
appunto il luogo ideale che agevola il passaggio del monaco dalla vita<br />
terrena alla Gerusalemme celeste»: così Di<strong>di</strong>er (1988, p. 297) riassume il pensiero<br />
<strong>di</strong> Leoncini.<br />
non apparirà allora casuale la concomitanza tra la comparsa delle utopie sulla<br />
città e le fase critiche della civiltà occidentale 28 (a cui non fa eccezione neppure la<br />
<strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong>, costruita proprio all’inizio <strong>di</strong> uno dei perio<strong>di</strong> più bui della<br />
chiesa cattolica) 29 : l’utopica e “apollinea” visione del mondo (in senso nietzscheano)<br />
sembra sorgere infatti dalla necessità <strong>di</strong> arginare il caos <strong>di</strong> una realtà inquietante<br />
attraverso un controllo organizzato dello spazio e del tempo (<strong>di</strong> cui<br />
offrono testimonianza la stabilitas loci e la regolazione delle successioni temporali<br />
dell’ora et labora benedettino) 30 , <strong>di</strong> poi riproposto, in chiave laica, dalle città ideali<br />
dei filosofi rinascimentali e moderni 31 .<br />
Tale controllo è l’in<strong>di</strong>spensabile con<strong>di</strong>zione per il perseguimento <strong>di</strong> un fine<br />
immanente e trascendente, materiale e spirituale (la giustizia e il bene supremo,<br />
platonicamente inteso come idea eterna, immutabile, essere pieno e totale, contrapposto<br />
al male, assenza totale <strong>di</strong> essere) 32 . Per questo la città-certosa deve essere<br />
isolata, autonoma, capace <strong>di</strong> vivere con rigore dei prodotti del proprio suolo, protetta<br />
da confini geografici netti, mura poderose, leggi accorte e regole morali 33 ,<br />
con un numero limitato <strong>di</strong> abitanti, de<strong>di</strong>ti alle attività intellettuali o pratiche 34 . In<br />
tale ottica, la <strong>di</strong>visione dei certosini in due categorie inter<strong>di</strong>pendenti, frutto delle<br />
679
<strong>di</strong>verse attitu<strong>di</strong>ni e capacità (ciascuno svolge il compito corrispondente alla propria<br />
<strong>di</strong>sposizione e natura), garantisce la perfezione della loro funzione in<strong>di</strong>viduale<br />
e “specializzazione professionale” (proverbiale la compiutezza del “lavoro certosino”),<br />
con<strong>di</strong>zione del benessere spirituale e materiale della collettività intera.<br />
L’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> quest’ultima è riflesso da quello temporale (la giornata-tipo del<br />
certosino si svolge secondo una successione prestabilita <strong>di</strong> occupazioni) e spaziale,<br />
grazie alla <strong>di</strong>visione in due parti dell’impianto “graticolare” della <strong>Certosa</strong>. Tale idea<br />
è già presente in Ippodamo <strong>di</strong> Mileto – ideatore del modello urbanistico basato<br />
sull’organizzazione “a griglia” (intersecazione ad angolo retto) delle strade (orientate<br />
nella <strong>di</strong>rezione nord-sud dei car<strong>di</strong>ni e in quella ovest-est dei decumani) e sulla<br />
conseguente scansione regolare <strong>degli</strong> isolati 35 – il quale aveva ben compreso che<br />
la forma <strong>di</strong> una città esprime la forma del suo or<strong>di</strong>ne sociale e che, per riplasmare<br />
la prima, è necessario introdurre adeguate riforme e mo<strong>di</strong>fiche nella seconda 36 .<br />
L’impianto architettonico della <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong>, costruita come un castrum<br />
o una città della Magna Grecia (ve<strong>di</strong> fig. 3), non si limita tuttavia a riflettere l’or<strong>di</strong>ne<br />
razionale in esso sotteso; il lunghissimo percorso rettilineo che ne unisce le<br />
parti bassa e alta, quale «via sacra che dall’esterno conduce, <strong>di</strong> chiostro in chiostro,<br />
<strong>di</strong> corridoio in corridoio, verso ambienti sempre più riservati», fino a raggiungere<br />
lo spettacolare doppio scalone ellittico (attribuito a Gaetano Barba: de Martini,<br />
1988, p. 216 e 1990, p. 94; DE CUnzo, 1990, p. 75), trasmette infatti un messaggio<br />
assoluto e trascendente: il percorso verso Dio è unico, perciò il certosino non<br />
può che avere un’unica strada (DE CUnzo, 1990, p. 41. Cfr. anche nota 27).<br />
Tale impostazione, accentuata nel XVIII secolo – allorché «l’asse rettilineo<br />
era scelta univoca, segno dell’assolutismo, prima della crisi e della rivoluzione, da<br />
Versailles a Caserta e in più piccola scala nelle ville e nei palazzi» (DE CUnzo,<br />
1990, p. 42) – è d’altra parte strettamente connessa alle prescrizioni della regola<br />
certosina, per la quale il monastero non è un rifugio sicuro dalle insi<strong>di</strong>e del<br />
mondo, «ma un luogo ideale e spirituale, segno e anticipazione del para<strong>di</strong>so» 37 .<br />
680<br />
3. Il monastero reale e il territorio: l’incontro-scontro con altri enti laici e religiosi<br />
L’idealità della prospettiva ultraterrena dei certosini padulensi, riflessa dalla<br />
loro nobiltà, gentilezza e generosità (SoAnE, 1990, p. 105 e de SAInT-non, 1990,<br />
p. 106), sulla scia dell’operato dei monaci basiliani e benedettini (“pionieri” nelle<br />
opere <strong>di</strong> trasformazione e “pianificazione” territoriale), era sorretta da un’amministrazione<br />
efficace dei loro estesi posse<strong>di</strong>menti feudali. Ancora oggi è facile immaginare<br />
la “casa bassa” brulicare <strong>di</strong> conta<strong>di</strong>ni, fittavoli, braccianti, giornalieri,<br />
manovali, artigiani, fornitori, pellegrini, postulanti, paesani, che «si svuotava al<br />
tramonto quando si serrava il grande portone <strong>di</strong> accesso alla corte, sorvegliato a<br />
vista dagli armigeri chiusi nella poderosa torre inserita nel muro <strong>di</strong> cinta» (DE
MARTInI, 1990, p. 86).<br />
<strong>La</strong> serie continua <strong>di</strong> offerte e lasciti testamentari a favore della <strong>Certosa</strong> (risalenti<br />
già al 1326) da parte <strong>di</strong> donatori <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zione sociale anche modesta ne testimoniano<br />
infatti il precoce collegamento con la realtà locale e la rapida capacità<br />
<strong>di</strong> rendersi in<strong>di</strong>pendente, «non rimanendo legata né ai destini dei Sanseverino né<br />
a quelli <strong>di</strong> un altro o <strong>di</strong> pochi altri benefattori e impegnandosi subito, vale a <strong>di</strong>re<br />
fin dal 1311, in una attività politica patrimoniale, che porta non solo ad un incremento<br />
continuo dei posse<strong>di</strong>menti, ma anche, grazie alle permute, al loro accorpamento<br />
e quin<strong>di</strong> ad una più razionale conduzione» 38 .<br />
Il rapporto con i suoi vasti territori («tanti corpi complessi, che entrano nel<br />
gran corpo della <strong>Certosa</strong>»: Sacco, cit. da ALLIEGRo, 1941, p. 57) era basato sull’attenta<br />
«organizzazione della proprietà in una serie <strong>di</strong> nuclei sparsi, affidati a fittavoli<br />
e massari senza <strong>di</strong>fferenze significative con la prassi <strong>di</strong> altri enti benedettini<br />
e cistercensi» (VIToLo, 2006, p. 32). Era perciò fitta la rete <strong>di</strong> grange e abbazie<br />
presenti sui territori certosini (è il caso dell’Abbazia <strong>di</strong> S. Maria <strong>di</strong> Cadossa), sottoposti<br />
a un’incessante opera <strong>di</strong> trasformazione dell’ambiente naturale, progressivamente<br />
bonificato, messo a coltura e utilizzato in tutte le sue risorse. Lo<br />
comprovano alcune carte storiche settecentesche, dove, a conferma della grande<br />
attenzione prestata dai certosini ai campi coltivati e ai giar<strong>di</strong>ni 39 , sono ben visibili,<br />
accanto ai corsi d’acqua e alla rete dei collegamenti, i simboli figurativi <strong>di</strong> numerose<br />
attività dei settori primario e secondario (campi coltivati, porcili, mulini, fornaci,<br />
gualchiere, neviere, ecc.), testimoniate altresì dalla toponomastica, evocante<br />
coltivazioni ortofrutticole o la trilogia me<strong>di</strong>terranea (“Giar<strong>di</strong>no”, “Isca delle<br />
Vigne”, “Campo <strong>di</strong> Fusco”, “Aria delli Monaci”, ecc.) 40 .<br />
Tale situazione, «se pure non mancò <strong>di</strong> suscitare la cupi<strong>di</strong>gia <strong>di</strong> signori e proprietari<br />
confinanti, provocando i consueti tentativi <strong>di</strong> usurpazione delle terre monastiche<br />
e i relativi interventi protettivi delle autorità ecclesiastiche e laiche,<br />
nell’insieme non valse a determinare quelle situazioni <strong>di</strong> tensione con le comunità<br />
locali che non <strong>di</strong> rado crearono altrove problemi alle certose, separate dalle prime<br />
da un muro <strong>di</strong> in<strong>di</strong>fferenza […], se non ad<strong>di</strong>rittura <strong>di</strong> ostilità […]» (VIToLo, 2006,<br />
pp. 32-33).<br />
Il buon operato dei monaci nell’amministrazione delle proprie terre, d’altra<br />
parte, era tanto più rilevante in considerazione del coevo degrado <strong>di</strong> altri terreni<br />
del Vallo, non solo a causa <strong>degli</strong> agenti naturali, ma anche del <strong>di</strong>sboscamento operato<br />
dai baroni per accrescere le proprie entrate, nonché dei contrasti tra questi<br />
ultimi e le <strong>Università</strong> e tra le <strong>Università</strong> stesse, «che si traducevano spesso nella<br />
<strong>di</strong>struzione <strong>di</strong> opere idrauliche e nell’allagamento dei seminativi; gli stessi baroni<br />
a più riprese si adoperarono a tener viva la <strong>di</strong>scor<strong>di</strong>a e quin<strong>di</strong> a sabotare i pur<br />
inefficaci progetti <strong>di</strong> bonifica patrocinati dal governo» 41 . <strong>La</strong> comunità certosina<br />
padulense, dunque, pur essendo una piccola società, autonoma, sopranazionale,<br />
autosufficiente e separata dalle collettività locali, attingeva <strong>di</strong> certo alla cultura del<br />
681
territorio su cui insisteva, esercitandovi un’innegabile influenza, dal punto <strong>di</strong> vista<br />
organizzativo, economico e sociale. nel XVI secolo, mentre numerosi casali e<br />
villaggi del Vallo continuano a essere abbandonati, <strong>Padula</strong> rientra infatti tra i quattro<br />
paesi con maggiore concentrazione <strong>di</strong> popolazione (VIToLo, 1982[a], p. 61),<br />
mentre la <strong>Certosa</strong>, grazie a un sempre più esteso patrimonio fon<strong>di</strong>ario, <strong>di</strong>viene<br />
uno dei centri propulsori <strong>di</strong> tutta l’economia del Vallo, frequentato con crescente<br />
intensità da «coloro che avevano interessi economici ed intrattenevano relazioni<br />
finanziarie e commerciali con i certosini» (RoSSI, 1982, p. 110).<br />
Di certo, l’influenza della <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong>venne ancor più decisiva durante e dopo<br />
il Concilio <strong>di</strong> Trento, non solo per la caduta dei Sanseverino <strong>di</strong> Marsico (1552), a<br />
cui i certosini subentrano nell’amministrazione <strong>di</strong> gran parte dei loro feu<strong>di</strong>, ma<br />
per il significato assurto dal monastero agli occhi delle popolazioni locali, quale<br />
importante punto <strong>di</strong> riferimento politico e religioso presente sul territorio. Tale<br />
ruolo è ulteriormente potenziato dall’inesperienza pastorale dell’episcopato del<br />
tempo, non ottemperante all’obbligo della residenza (i vescovi definiscono infatti<br />
«vasta et horrida» la fisionomia geografica del paesaggio e dell’ambiente della<br />
valle) e, dunque, incapace <strong>di</strong> comprendere e interpretare le esigenze del popolo<br />
(VIToLo, 1982[b], p. 153 e RoSSI, 1982, pp. 95-96 e p. 112).<br />
Una società rurale e silvo-pastorale come quella del Vallo <strong>di</strong> Diano si era d’altra<br />
parte secolarmente strutturata attorno agli or<strong>di</strong>ni monastici; tra questi i certosini<br />
– soggetti a una regola rigorosa per la vita claustrale dell’or<strong>di</strong>ne, ma non<br />
per la gestione delle pratiche cultuali della popolazione – si erano rivelati capaci<br />
<strong>di</strong> organizzarne l’esistenza spirituale e materiale e guadagnarsene la fiducia, accogliendone,<br />
al contempo, le particolari forme religiose e cultuali, legate ad abitu<strong>di</strong>ni<br />
e costumi mentali caratteristici della società conta<strong>di</strong>na 42 . <strong>La</strong> religiosità<br />
popolare del Vallo, infatti, profondamente legata alle vicende della terra, ai tempi<br />
del raccolto e a culti propiziatori con forti tendenze magiche, era piuttosto rozza<br />
e non irreggimentata in una <strong>di</strong>sciplina chiaramente formulata: <strong>di</strong> qui, inevitabile,<br />
nasce lo scontro tra il particolarismo religioso e sociale delle collettività locali e<br />
la burocratica autorità della Curia <strong>di</strong>ocesana post-conciliare, che «si faceva sentire<br />
solo me<strong>di</strong>ante decreti e <strong>di</strong>sposizioni restrittive della effervescente pratica liturgica<br />
o per la riscossione <strong>di</strong> decime sacramentarie, censi e canoni enfiteutici. All’insanabile<br />
sutura <strong>di</strong> questo iato è riconducibile la incomprensione del popolo e del<br />
clero ricettizio per la religiosità e la vita tridentina <strong>di</strong> vescovi e preti formatisi in<br />
seminario» (RoSSI, 1982, pp. 96-97). I fedeli, dunque, sempre più ostili nei confronti<br />
dell’istituzione ecclesiastica burocratizzata, continuano a scegliere come<br />
guide spirituali i monaci (fonte <strong>di</strong> aiuti anche materiali), con i loro abati e priori.<br />
Pertanto, dopo il secolare sostegno ricevuto dalle <strong>di</strong>ocesi <strong>di</strong> <strong>Salerno</strong>, Marsico e<br />
Capaccio (in cui sorgeva la <strong>Certosa</strong>), nel corso del Cinquecento si registrano momenti<br />
<strong>di</strong> tensione (VIToLo, 2006, p. 33): i vescovi richiedono infatti il ri<strong>di</strong>mensionamento<br />
dei poteri <strong>degli</strong> or<strong>di</strong>ni monastici, <strong>di</strong> cui la <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong><br />
682
appresenta l’espressione più compiuta.<br />
Esplode così, nella seconda metà del Settecento, il contrasto tra la gerarchia<br />
ufficiale e i certosini <strong>di</strong> San Lorenzo, accentuato dalle tensioni tra questi ultimi e<br />
il fisco borbonico (DE SAInT-non, 1990, p. 106) e proseguito anche dopo il decennio<br />
francese e il ritorno dei Borbone sul trono <strong>di</strong> napoli: i preti or<strong>di</strong>nari erano<br />
infatti incapaci <strong>di</strong> comprendere «che la <strong>Certosa</strong> era il frutto più eclatante della religiosità<br />
<strong>di</strong> una società agraria a prevalente economia silvo-pastorale» (RoSSI, 1982,<br />
pp. 109-110).<br />
L’autonomia e la centralità propulsiva economico-culturale del monastero<br />
traspare, per altro verso, dall’originalità dei suoi elementi artistici e architettonici.<br />
Pur facendo parte del Regno <strong>di</strong> napoli e nonostante i forti legami con i Sanseverino<br />
<strong>di</strong> Marsico, i certosini <strong>di</strong> <strong>Padula</strong> non avevano maturato alcun legame <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>pendenza intellettuale o pratica nei loro confronti, attenti piuttosto a seguire<br />
<strong>di</strong>rettamente i mutamenti del proprio tempo, nel fermento e nell’ansia <strong>di</strong> nuove<br />
esperienze culturali, «tanto da abbandonare un programma per avviarne uno<br />
nuovo, per fare, magari meglio, quello che avevano visto fare in altre certose» 43 .<br />
Anche in tale prospettiva, la <strong>Certosa</strong> ha indubbiamente ricoperto un’importanza<br />
secolare nello sviluppo economico complessivo della zona <strong>di</strong> <strong>Padula</strong> e dei<br />
centri limitrofi: intere generazioni <strong>di</strong> manodopera locale sono state impegnate<br />
nei lavori <strong>di</strong> manutenzione, rifacimento e abbellimento dell’e<strong>di</strong>ficio monastico,<br />
per le quali si ricorreva alla cosiddetta “Pietra <strong>di</strong> <strong>Padula</strong>”, ricavata dai ricchi giacimenti<br />
calcarei del Vallo (MALLET, 1990, p. 108). Le sue stesse imponenti <strong>di</strong>mensioni<br />
trasformavano il complesso in una specie <strong>di</strong> “Fabbrica <strong>di</strong> San Pietro”, un<br />
grande cantiere sempre aperto, dove, in relazione agli eventi e alla <strong>di</strong>sponibilità<br />
economica del momento, ogni opera intrapresa poteva essere interrotta, ripresa<br />
e proseguita, per vario tempo. oltre alle mo<strong>di</strong>fiche messe in atto dai nuovi priori,<br />
«capitava anche, per lavori che duravano così a lungo, che alla fine non piaceva<br />
più quello che si era iniziato. Allora si chiamava un nuovo artista che, con l’aggiunta<br />
<strong>di</strong> altri elementi, cambiava l’aspetto <strong>di</strong> quanto già fatto» (DE CUnzo, 1990,<br />
p. 59). Di qui l’esistenza <strong>di</strong> una vera e propria scuola locale <strong>di</strong> valenti scalpellini<br />
– come testimoniato dai pregiati lavori <strong>di</strong> intarsio e commesso su legno, pietre<br />
dure o marmo policromo, presenti nella Chiesa dei padri e ancora oggi eseguiti<br />
da qualche giovane artigiano <strong>di</strong> <strong>Padula</strong> – costretti a una dolorosa, inevitabile emigrazione<br />
(soprattutto verso il Venezuela: SBoRDonE, 1975, p. 161) negli anni successivi<br />
alla soppressione del Monastero, loro principale committente.<br />
Pertanto, considerando la tangibile concretezza <strong>degli</strong> effetti della <strong>Certosa</strong> sul<br />
territorio del Vallo, l’utopia (“utopia certosina”, nello specifico), quale «esercizio<br />
o gioco sui possibili laterali, che apparterrebbero al campo scientifico», poiché<br />
«si costruisce in funzione delle proprietà possibili dell’oggetto» (RUyER, 1988, p.<br />
9), non ha affatto una natura irreale, bensì “virtuale” (intendendo il termine nel<br />
significato <strong>di</strong> “potenziamento del reale”) 44 e affonda le sue ra<strong>di</strong>ci proprio nella<br />
683
ealtà sociale e storica <strong>di</strong> riferimento. In tal senso, se gli «utopisti, come gli artisti,<br />
sono indubbiamente importanti agenti sociali» (CoLoMBo, 1994, p. 132), i certosini<br />
<strong>di</strong> <strong>Padula</strong> possono essere senz’altro annoverati tra questi ultimi.<br />
684<br />
4. <strong>Certosa</strong> e turismo oggi<br />
Dalla sua fondazione sino agli inizi del secolo XIX, la <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong>, il<br />
cui attuale aspetto architettonico risale in massima parte alla ristrutturazione settecentesca,<br />
è <strong>di</strong>venuta dunque uno dei più gran<strong>di</strong>osi corpi monumentali dell’Italia<br />
Meri<strong>di</strong>onale, per estensione (52.000 mq) e patrimonio artistico. nonostante la<br />
sua maestosità, il monumento, negli anni del degrado e del totale abbandono delle<br />
sue strutture (ulteriormente danneggiate dal violento sisma del 1980), sembrava<br />
condannato a una rovina inesorabile. L’affidamento alle cure della Soprintendenza<br />
BAAAS <strong>di</strong> <strong>Salerno</strong> ha fortunatamente posto fine a questa triste parabola <strong>di</strong>scendente,<br />
restituendogli, per quanto possibile, l’aspetto originario. Al contempo è<br />
stata messa in campo una serie <strong>di</strong> iniziative volte a evidenziarne e sfruttarne le<br />
potenzialità attrattive, quali spinte propulsive per lo sviluppo complessivo del turismo<br />
culturale nel territorio circostante. Questi due aspetti, parafrasando quanto<br />
scritto da L. Benevolo nei suoi stu<strong>di</strong> sulla città, evidenziano dunque il doppio<br />
ruolo della <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong>, “àncora” calata nel passato e potenziale “motore”<br />
<strong>di</strong> sviluppo futuro del territorio.<br />
Sotto il primo aspetto, come osservato dal Turri a proposito delle testimonianze<br />
monumentali in generale, la <strong>Certosa</strong>, icona del paesaggio stratificato del<br />
Vallo, segno della sua identità e del suo carattere proprio, si afferma indubbiamente<br />
quale «suo marchio primo e più autentico […] a <strong>di</strong>mostrare come dopo il<br />
primitivo imprinting territoriale […], la storia successiva abbia continuato a ricalcare<br />
gli originari tracciati […] nel continuo persistere delle attività umane sugli stessi<br />
spazi, nelle reiterate forme <strong>di</strong> sfruttamento <strong>degli</strong> stessi campi, nel seguire le stesse<br />
<strong>di</strong>rettrici viarie […], nell’occupazione più o meno fitta delle stesse aree a seconda<br />
delle risorse […]» (TURRI, 2000, p. 68).<br />
Sotto il secondo aspetto, la <strong>Certosa</strong>, storico attore dello sviluppo del Vallo,<br />
mira a ri<strong>di</strong>ventarne il rinnovato strumento <strong>di</strong> crescita economica e culturale. In<br />
tale <strong>di</strong>rezione, nel corso <strong>degli</strong> ultimi anni, si è mossa la sua valorizzazione, volta<br />
a restituirle il ruolo <strong>di</strong> “città ideale” e <strong>di</strong> polo trainante del territorio, con alcune<br />
positive ricadute economico-sociali sulle aree limitrofe (anche grazie all’istituzione<br />
del Parco nazionale del Cilento e Vallo <strong>di</strong> Diano 45 , <strong>di</strong> cui il comune <strong>di</strong> <strong>Padula</strong> fa<br />
parte), sebbene limitate rispetto alle aspettative. <strong>La</strong> rivalutazione del complesso<br />
certosino, infatti, promossa dalle istituzioni politiche provinciali salernitane, non<br />
è ancora riuscita a creare un effettivo circuito sociale, politico e amministrativoterritoriale.<br />
Le <strong>di</strong>verse iniziative gravitanti attorno all’imponente monastero – dai
congressi alle manifestazioni folcloristiche (tra cui il concorso ippico estivo e l’annuale<br />
preparazione della leggendaria frittata <strong>di</strong> mille uova); dai seminari <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o<br />
alle mostre d’arte 46 ; dalla ripresa <strong>di</strong> antiche attività artigianali all’allestimento del<br />
museo archeologico della Lucania (che raccoglie una collezione <strong>di</strong> reperti provenienti<br />
dagli scavi delle necropoli <strong>di</strong> Sala Consilina e <strong>di</strong> <strong>Padula</strong>, dalla preistoria all’età<br />
ellenistica) – non hanno infatti prodotto i risultati sperati. Pertanto, la<br />
prospettiva <strong>di</strong> riqualificazione, riba<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> recente (SESSA, 2006), rimane una sfida<br />
aperta.<br />
Le ragioni dei mancati obiettivi sono molteplici, ma la principale, probabilmente,<br />
risiede nel fatto che le destinazioni d’uso della <strong>Certosa</strong> non sono state sinora<br />
ricavate dalle esigenze in atto nella società e nel territorio circostanti ma<br />
piuttosto, in assenza <strong>di</strong> un adeguato indotto e <strong>di</strong> un reale bacino <strong>di</strong> utenza del<br />
complesso, da progetti <strong>di</strong> promozione e rilancio fini a se stessi (per lo più a finanziamento<br />
pubblico ed europeo) 47 , da “utopie” pianificatorie, dunque, molto<br />
lontane dallo spirito certosino, e artefici della sempre più concreta e rischiosa trasformazione<br />
della “<strong>Certosa</strong>-città ideale” in “<strong>Certosa</strong>-cattedrale nel deserto”.<br />
In tale prospettiva, sulla scia delle <strong>di</strong>rettive contenute nella Convenzione Europea<br />
del paesaggio 48 , la scelta del monumento per la ratifica della cosiddetta “Carta <strong>di</strong><br />
<strong>Padula</strong>” (2005) 49 e come sede dell’Osservatorio europeo del paesaggio (2008) 50 <strong>di</strong>viene<br />
oggi ancora più emblematica della pericolosa <strong>di</strong>sgiunzione tra piano ideale e reale<br />
della politica territoriale, <strong>di</strong> cui i pesantissimi danni ambientali, paesaggistici ed<br />
economici causati dalla cattiva gestione del problema dei rifiuti in Campania costituisce,<br />
sul piano regionale e nazionale, la punta dell’iceberg 51 .<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista turistico, le numerose visite alla <strong>Certosa</strong> sembrerebbero<br />
contrastare tali analisi, rappresentando piuttosto un positivo fattore <strong>di</strong> sviluppo<br />
economico complessivo. Un più attento esame dei dati <strong>di</strong>sponibili a riguardo mostra,<br />
però, come il numero annuale <strong>di</strong> ingressi gratuiti al monumento superi <strong>di</strong><br />
gran lunga quello <strong>degli</strong> ingressi a pagamento (ve<strong>di</strong> Tab. 1). Le ricadute economiche<br />
effettivamente vantaggiose per il territorio circostante, anche in considerazione<br />
dei costi <strong>di</strong> mantenimento e gestione della immensa struttura, sono dunque<br />
in realtà molto al <strong>di</strong> sotto <strong>di</strong> quanto sembri <strong>di</strong> primo acchito 52 .<br />
<strong>La</strong> prova ulteriore della scarsa incidenza della rivalutazione della <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong><br />
San Lorenzo sullo sviluppo turistico-culturale del territorio negli ultimi anni è<br />
data anche dalle modalità <strong>di</strong> crescita del terziario nel Vallo <strong>di</strong> Diano, caratterizzato<br />
da un forte sviluppo del commercio tra<strong>di</strong>zionale e da uno sviluppo debole delle<br />
strutture ricettive (con un comparto alberghiero al 49% 53 e un comparto extra<br />
alberghiero al 51% sul totale) 54 .<br />
A riguardo è significativo osservare la pressoché sostanziale coincidenza tra<br />
la situazione attuale e quella registrata dal Fabiano negli anni ottanta del secolo<br />
scorso a proposito della crescita della rete <strong>di</strong> connessioni territoriali interne del<br />
Vallo <strong>di</strong> Diano, ritenute più importanti rispetto ai grossi percorsi <strong>di</strong> transito per<br />
685
l’economia e le prospettive del suo sviluppo territoriale, visto che il suo bacino<br />
<strong>di</strong> gravitazione e <strong>di</strong> utenza investiva prevalentemente i rapporti commerciali (prodotti<br />
agricoli, auto, e<strong>di</strong>lizia, attrezzature meccaniche, ecc.), il servizio d’istruzione<br />
secondaria superiore (Sala Consilina) e il servizio ospedaliero (Polla, S. Arsenio).<br />
Al tempo, nonostante il superamento consolidato delle <strong>di</strong>sfunzioni strutturali e<br />
dei caratteri peculiari delle aree economicamente depresse (cause dei noti fenomeni<br />
<strong>di</strong> emigrazione e abbandono dei territori montani, con effetti devastanti,<br />
attenuatisi solo da pochi anni), erano evidenti i ritar<strong>di</strong> e le carenze <strong>di</strong> efficaci interventi<br />
concertati nei settori chiave della sua economia produttiva. Le conseguenze<br />
si avvertono tuttora sul tessuto sociale e sul sistema territoriale del Vallo,<br />
spinto ancora oggi a gravitare (con relativi <strong>di</strong>sagi e svantaggi) nell’orbita della fascia<br />
costiera e nella conurbazione napoli-<strong>Salerno</strong> 55 .<br />
Di qui, alla luce dell’incapacità amministrativa provinciale nel valorizzarne<br />
adeguatamente le risorse territoriali, nasce il senso <strong>di</strong> abbandono e il desiderio,<br />
da parte <strong>di</strong> alcuni comuni della zona, <strong>di</strong> congiungersi ufficialmente alla provincia<br />
<strong>di</strong> Potenza, dando vita alla “Grande Lucania” (frutto dell’aggregazione alla Regione<br />
Basilicata dei territori del Vallo <strong>di</strong> Diano e del Cilento) e sottraendosi così<br />
ai vincoli <strong>di</strong> un’appartenenza amministrativa e culturale non completamente sentita.<br />
Il progetto, dunque, «esprime <strong>di</strong>sagi e <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> intere popolazioni che vogliono<br />
contare <strong>di</strong> più in termini <strong>di</strong> democrazia e <strong>di</strong> valorizzazione e <strong>di</strong>stribuzione<br />
<strong>di</strong> risorse» 56 .<br />
Senza entrare nel merito della questione identitaria del Vallo, ovviamente<br />
problematica, si può auspicare che, nel futuro prossimo, le politiche <strong>di</strong> intervento<br />
per la valorizzazione della <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong> siano più rispondenti alle necessità<br />
effettive del territorio e rientrino in un quadro <strong>di</strong> iniziative coor<strong>di</strong>nate, volte al<br />
recupero complessivo delle risorse presenti nei luoghi limitrofi.<br />
Con ciò non si esclude altresì l’auspicio <strong>di</strong> una più concreta risposta alle esigenze<br />
<strong>di</strong> sviluppo delle comunità locali da parte del mondo delle imprese e dell’iniziativa<br />
privata. nella cooperazione sinergica tra enti pubblici e privati e nella<br />
virtuosa congiunzione tra tutela e riuso dei beni culturali, infatti, anche la <strong>Certosa</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Padula</strong> e il suo territorio, come osservato da un territorialista riguardo al recupero<br />
dei monumenti in generale, potrebbero realmente costituire una preziosa<br />
occasione <strong>di</strong> investimento impren<strong>di</strong>toriale, con i vantaggi insiti «nel minor costo<br />
dell’opera che sfrutta una situazione territoriale già consolidata» (TURRI, 2000,<br />
p. 68).<br />
In tal modo, forse, si raccoglierebbero finalmente i frutti invisibili e più preziosi<br />
dell’ere<strong>di</strong>tà certosina, racchiusi nella profonda cultura geografica dei monaci<br />
e riflessi non solo nella gran<strong>di</strong>osità delle loro architetture monumentali, bensì,<br />
ancor più, nella loro capacità <strong>di</strong> conoscere, pianificare, costruire e amministrare<br />
con competenza e buon senso il proprio territorio <strong>di</strong> riferimento.<br />
686
Tab. 1 – Prospetto riepilogativo dei visitatori e <strong>degli</strong> introiti annuali della <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong> negli<br />
anni 1998-2007. In grassetto l’anno con il maggior numero <strong>di</strong> visite e in grigio i dati riguardanti<br />
gli ingressi gratuiti, <strong>di</strong> numero evidentemente superiore a quello <strong>degli</strong> ingressi a pagamento<br />
Fonte: Soprintendenza B.A.P.S.A.E. <strong>di</strong> <strong>Salerno</strong> e Avellino<br />
note: 2007 (*) aggiornato al 30/03/07<br />
Emergono i dati relativi alla tipologia <strong>di</strong> biglietto (intero, ridotto, speciale o gratuito) <strong>degli</strong> ingressi<br />
in <strong>Certosa</strong>. <strong>La</strong> situazione è indubbiamente altalenante, per cause ancora poco chiare, con una tendenza<br />
negativa negli ultimi anni: dal 2002 al 2006 si registra infatti una me<strong>di</strong>a annua <strong>di</strong> circa 20.000<br />
ingressi in meno, passando dai 132.000 del 2002 (dato più elevato <strong>degli</strong> ultimi 10 anni) ai 118.000<br />
del 2006. Il risultato è tanto più sconfortante in considerazione dei numerosi investimenti compiuti,<br />
proprio nel 2002, dalla Regione Campania e dalla Provincia <strong>di</strong> <strong>Salerno</strong> per la realizzazione<br />
<strong>di</strong> gran<strong>di</strong> eventi riguardanti la <strong>Certosa</strong>. Le informazioni statistiche attualmente <strong>di</strong>sponibili non<br />
permettono <strong>di</strong> comprendere la tipologia e la provenienza dei turisti in visita alla <strong>Certosa</strong>, ma, da<br />
un’indagine parziale ancora in corso (sulla base dei dati gentilmente fornitici dall’Ufficio Turistico<br />
della <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong>), quest’ultima risulta essere varia, pur nell’ovvio primato dei visitatori provenienti<br />
dalla Regione Campania. nel 2006, infatti, i turisti campani in visita guidata alla <strong>Certosa</strong><br />
sono stati 6.430, seguiti da quelli pugliesi (4.008), con maggiore affluenza nei mesi <strong>di</strong> aprile e<br />
maggio (tipici del turismo scolastico). Per quanto riguarda i turisti europei, il 2006 vede in testa i<br />
tedeschi (100 presenze), seguiti da francesi (34 presenze) e austriaci (14). I visitatori extraeuropei,<br />
infine, risultano essere per lo più australiani e statunitensi.<br />
687
Tab. 2 – Incremento <strong>degli</strong> agriturismi <strong>di</strong> <strong>Padula</strong> e dei centri vicini dal 1996 al 2006<br />
Fonte: interviste sul campo a cura delle autrici<br />
Fig. 1 – Andamento della nascita <strong>di</strong> nuovi agriturismi nel Vallo <strong>di</strong> Diano negli anni compresi tra<br />
il 1996 e il 2006<br />
Su un totale complessivo <strong>di</strong> 20 nuovi agriturismi, il grafico mostra come gli anni 1996, 1997, 1999<br />
e 2006 registrino la nascita <strong>di</strong> appena 1 agriturismo. All’incremento registrato dal 1998 (3), con<br />
un picco massimo nel 2000 (5), e una progressiva decrescita nel 2001 (4) e 2002 (2), segue un periodo<br />
<strong>di</strong> stasi <strong>di</strong> tre anni (2003, 2004, 2005).<br />
688
Fig. 2 – <strong>La</strong> <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> San Bartolomeo <strong>di</strong> Trisulti, modello originario per la trasformazione in<br />
<strong>Certosa</strong> della grancia benedettina <strong>di</strong> <strong>Padula</strong><br />
Fonte: da Sacco, Vol. II<br />
689
Fig. 3 – <strong>La</strong> “città ideale” nella pianta della <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> San Lorenzo <strong>di</strong> <strong>Padula</strong> con impianto “graticolare”<br />
Atrio (1), facciata barocca (2), chiostro (3), chiesa (4), sagrestia (5), quattro cappelle intercomunicanti<br />
(6), capitolo dei conversi (7), tesoreria (8), sala del capitolo (9), antico cimitero (10), cappella<br />
e tomba <strong>di</strong> Tommaso II Sanseverino (11), refettorio (12), cucina (13), chiostro delle cucine (14),<br />
scala elicoidale e accesso alla biblioteca (15), chiostro grande (16), cimitero dei monaci (17), celle<br />
(18), scala ellittica (19). Si notino la simmetria tra le celle dei monaci, la ripartizione geometrica<br />
tra il grande chiostro e il cimitero (la cui vista doveva costantemente ricordare al certosino la caducità<br />
dell’esistenza terrena), la perfetta corrispondenza tra la facciata barocca (ingresso) e la scala<br />
ellittica (uscita), idealmente congiunte da uno dei corridoi claustrali. Evidente anche il richiamo<br />
alla graticola <strong>di</strong> San Lorenzo: «[…] il manico è raffigurato dalle due braccia che chiudono l’atrio;<br />
i quartieri dei Certosini attorno al chiostro rappresentano i ferri della graticola, e una grande scala<br />
sporgente a semicerchio e coperta da cupola rappresenta forse il coppino per l’untume».<br />
Fonte: T.C.I. 2005, pp. 631-632<br />
690
Fig. 4 – Dinamica e <strong>di</strong>stribuzione geografica dei possessi materiali e dritti immateriali della <strong>Certosa</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Padula</strong> tra il XIV e il XVII secolo<br />
Fonti: Sacco (cit.), Alliegro (cit.), Vitolo (cit.)<br />
Note<br />
* <strong>La</strong> presente ricerca è stata condotta all’interno del <strong>La</strong>boratorio LA:CAR.ToPon.ST. del<br />
Dip. <strong>di</strong> Teoria e Storia dell’<strong>Università</strong> <strong>degli</strong> Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>Salerno</strong> col coor<strong>di</strong>namento generale del prof.<br />
V. Aversano per quanto attiene a metodo, proce<strong>di</strong>menti e selezione <strong>di</strong> materia bibliografica. <strong>La</strong><br />
stesura del testo, tuttavia, va così attribuita per paragrafi: 1. (V. AVERSAno); 2. e 3. (S. SInISCALChI);<br />
4. (M. R. DE VITA).<br />
1 Ci si riferisce ai nomi <strong>di</strong> S. Brunone <strong>di</strong> Colonia, iniziatore dell’or<strong>di</strong>ne certosino, Tommaso<br />
II <strong>di</strong> Sanseverino, storico fondatore, nel 1306, della <strong>Certosa</strong> padulense, e Lorenzo, il santo martire<br />
cui è de<strong>di</strong>cata.<br />
2 Le corpose testimonianze riguardanti la fondazione e gli ampliamenti della <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong><br />
nel succedersi delle vicende storiche coeve sono state faticosamente recuperate e approfon<strong>di</strong>tamente<br />
stu<strong>di</strong>ate dal sacerdote Antonio Sacco, che, tra gli ultimi anni dell’ottocento e i primi<br />
del novecento, vi de<strong>di</strong>cò gran parte della propria vita (STRoCChIA, 2006, p. 227).<br />
3 L’immagine, tratta dalla Descrizione <strong>di</strong> tutta Italia <strong>di</strong> Leandro Alberti (in AVERSAno, 2003, p.<br />
139), esprime bene la forma del Vallo: una conca a polje, tra le più estese dell’Appennino meri<strong>di</strong>onale,<br />
sorta dal progressivo interrimento <strong>di</strong> un primitivo lago pleistocenico, lunga circa 40 Km<br />
(per un’area <strong>di</strong> 585 kmq, con una larghezza oscillante tra i 2 e i 9 km), percorsa dal fiume Tanagro<br />
691
e delimitata, a nE, dalla continua catena della Maddalena (che, oltre a <strong>di</strong>viderla dalle Valli dell’Agri<br />
e del Melandro, segna pure il confine tra Campania e Basilicata) e, a So, dai massicci dell’Alburno,<br />
del Motola e del Cervati (SoRICILLo, 1979, p. 5; SBoRDonE, 1975, p. 121; FABIAno, 1981, pp. 15-<br />
17). nella descrizione dell’Alberti l’intero «Vallo <strong>di</strong> Diano è l’unica oasi nel grigiore produttivoinse<strong>di</strong>ativo<br />
della B. [Basilicata: <strong>di</strong> cui all’epoca il Vallo <strong>di</strong> Diano era considerato parte], anche<br />
perché sembra che le alture circostanti, ricche <strong>di</strong> sorgenti, non fossero così <strong>di</strong>sboscate come siamo<br />
abituati a vederle oggi e immaginarcele per il passato» (AVERSAno, 2003, p. 139).<br />
4 Per le illuminanti considerazioni sui collegamenti esistenti nel periodo Greco e Lucano fra<br />
il Vallo <strong>di</strong> Diano, la costa Cilentana, la Val d’Agri e tutto l’entroterra Lucano, si vedano SoRICILLo,<br />
1979, pp. 44-46, e FABIAno, 1981, p. 17. Circa l’evoluzione me<strong>di</strong>oevale e successiva della viabilità<br />
nel Vallo, si rimanda a Vultaggio, 1982.<br />
5 Fabiano, 1981, pp. 249-251. Per quanto riguarda la storia <strong>di</strong> Tommaso II Sanseverino <strong>di</strong><br />
Marsico, figlio <strong>di</strong> Ruggero I e <strong>di</strong> Teodora d’Aquino (sorella del celebre San Tommaso), si rimanda<br />
a SACCo: 2004, vol. I, pp. 211-236; SChIAVo, 1940, pp. 5-7. Per un profilo storico la storia dei<br />
Sanseverino <strong>di</strong> Marsico e <strong>di</strong> <strong>Salerno</strong>, si vedano: nATELLA, 1980 e 2006; CoLAPIETRA, 1985.<br />
6 Aversano, 1987[a], pp. 88-89.<br />
7 L’or<strong>di</strong>ne certosino (ma il termine “certosa” sarebbe stato usato tar<strong>di</strong> dall’or<strong>di</strong>ne per definire<br />
i propri monasteri) – così chiamato dal Massiccio della <strong>Certosa</strong> (Massif de la Chartreuse), sulle Alpi<br />
francesi a nord della città <strong>di</strong> Grenoble in val d’Isère, dove San Bruno e sei compagni cercarono<br />
la solitu<strong>di</strong>ne per de<strong>di</strong>carsi alla vita contemplativa –, sin dalla fondazione, «si mantenne sempre<br />
più aristocratico <strong>degli</strong> altri or<strong>di</strong>ni monastici, per quanto fosse sottoposto ad una regola più rigida<br />
e severa. V’entravano per lo più giovani <strong>di</strong> nobile casato che […] si segregavano dal mondo, con<br />
cui non dovevano avere più alcun rapporto» (PESCE, 1916, p. 6). <strong>La</strong> loro espansione, più lenta rispetto<br />
a quella <strong>di</strong> altri or<strong>di</strong>ni coevi (SEREno, 2006), fu sostenuta dai regnanti francesi in Italia Meri<strong>di</strong>onale:<br />
dopo la fondazione della <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong>, infatti, gli angioini favorirono anche quelle<br />
della <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> San Martino, a napoli (1325), e <strong>di</strong> San Giacomo, a Capri (1371). <strong>La</strong> scelta, nel<br />
corso del secolo XIV, <strong>di</strong> fondare i monasteri a ridosso dei centri urbani, in aree non più impervie<br />
e isolate ma dotate <strong>di</strong> patrimoni rilevanti e <strong>di</strong> relazioni più intense che in passato con il secolo,<br />
mostra l’evoluzione della congregazione certosina verso un’osservanza delle norme meno rigida<br />
e più in sintonia con le contemporanee trasformazioni dell’intera societas Christiana, analogamente<br />
a buona parte delle congregazioni religiose del tempo (SEREno, 2006).<br />
8 Per queste notizie, cfr. Sacco, 2004, vol. I, p. 101. Secondo quanto riportato dal medesimo<br />
autore, il cenobio verginiano de<strong>di</strong>cato a S. Lorenzo, non anteriore al XII secolo, sarebbe stato<br />
fondato a sua volta proprio dai primi Sanseverino (SACCo, 2004, vol. I, p. 107).<br />
9 Per i villaggi abbandonati del Vallo cfr. VIToLo, 1982[a] (in particolare la carta a p. 65) e,<br />
più in generale, per i danni devastanti causati dalla Guerra del Vespro al Mezzogiorno continentale,<br />
cfr. Aversano, 1987[a] (con particolare riguardo alle pp. 88-91, alla carta <strong>di</strong> p. 93 e alla p. 94).<br />
10 DE CUnzo, 1990, p. 46. Il toponimo «<strong>Padula</strong>» (derivato, per metatesi, dal latino palus,<br />
palude, significante «palude», «acquitrino»: AA.VV., 2007, sub voce «<strong>Padula</strong>») richiama per l’appunto<br />
gli stagni e le palu<strong>di</strong> che, nel passaggio dall’antichità al me<strong>di</strong>oevo, con l’abbandono dei lavori<br />
idraulici e lo spopolamento <strong>di</strong> città e campagne, conformemente al resto delle gran<strong>di</strong> pianure italiane,<br />
afflissero il Vallo <strong>di</strong> Diano. Di qui, già alla fine del X secolo, con il ripresentarsi del grave<br />
problema del <strong>di</strong>sboscamento, la necessità <strong>di</strong> una nuova leva <strong>di</strong> pionieri per il prosciugamento<br />
delle palu<strong>di</strong> e la costruzione dei ponti. In questo, come in altri settori, un grosso impulso proviene<br />
dagli or<strong>di</strong>ni monastici (innanzitutto dai Basiliani): infatti, la «fondazione <strong>di</strong> una chiesa […], fornendo<br />
ai conta<strong>di</strong>ni un inquadramento religioso, li induceva a fissare la loro residenza nelle vicinanze<br />
delle terre da essi messe a coltura». <strong>La</strong> nascita <strong>di</strong> un abitato intorno alle mura <strong>di</strong> un<br />
monastero rurale, dunque, era frequente (VIToLo, 1982[a], p. 50).<br />
692
11 <strong>La</strong> scelta della <strong>Certosa</strong> laziale <strong>di</strong> Trisulti (fondata nel 1204), piuttosto che <strong>di</strong> quella calabrese<br />
<strong>di</strong> S. Maria della Torre (dove S. Brunone era morto nel 1101), è spiegata da quanto osserva il<br />
Vitolo sulla particolare vicenda <strong>di</strong> quest’ultima. Dopo la morte del santo, in assenza <strong>di</strong> una regola<br />
scritta (le Consuetu<strong>di</strong>ni certosine sono infatti stese tra il 1121 e il 1128 da Guigo, quinto priore<br />
della Chartreuse), l’eremo calabrese era <strong>di</strong>venuto <strong>di</strong> fatto sempre più in<strong>di</strong>pendente, fino ad aderire<br />
all’or<strong>di</strong>ne benedettino e, successivamente, a quello cistercense (sarebbe ritornato certosino nel<br />
1514). <strong>La</strong> conseguenza <strong>di</strong> questa vicenda è che «in Italia meri<strong>di</strong>onale non ci fu alcuna presenza <strong>di</strong><br />
Certosini prima del 1306, anno della fondazione della <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> S. Lorenzo <strong>di</strong> <strong>Padula</strong>, e che la<br />
loro penetrazione nel corso del Trecento è da considerare un fenomeno del tutto nuovo, senza<br />
collegamento <strong>di</strong>retto con l’antecedente della fondazione dell’eremo <strong>di</strong> S. Maria della Torre da<br />
parte <strong>di</strong> Bruno <strong>di</strong> Colonia del 1091» (VIToLo, 2006, pp. 27-34).<br />
12 Cfr. LAURETI, 1976. Sui problemi attuali <strong>di</strong> queste aree, si veda la nota 50.<br />
13 SBoRDonE, 1982, pp. 159-160. Per quanto riguarda la depressione economica <strong>di</strong> S. Maria<br />
<strong>di</strong> Cadossa nel XIV e XV secolo e il crollo demografico del vicino abitato <strong>di</strong> Casalnuovo (oggi<br />
Casalbuono) dopo la peste del 1656 (per cui si rimanda ad AVERSAno, 1987[a], pp. 97 e 111), si<br />
noti come la <strong>Certosa</strong>, a conferma <strong>degli</strong> effetti “terapeutici” della sua presenza nel Vallo, dopo<br />
l’acquisizione <strong>di</strong> questi territori li avesse rivitalizzati. Per un approfon<strong>di</strong>mento dei rapporti tra i<br />
Certosini e i loro feu<strong>di</strong> in età spagnola, si rimanda a Musi, 2006.<br />
14 Per la congiura, or<strong>di</strong>ta tra il 1485 e il 1486 contro il re Ferrante I d’Aragona, si riamanda<br />
a PoRzIo, 1859.<br />
15 Gli ampliamenti più significativi comprendono un considerevole numero <strong>di</strong> oliveti, querceti,<br />
case, mobili e industrie <strong>di</strong> ogni genere <strong>di</strong> cui la <strong>Certosa</strong> entra in possesso a Teggiano, Vibonati<br />
e Policastro, acquisendo inoltre <strong>di</strong>ritti e posse<strong>di</strong>menti nelle Contrade <strong>di</strong> <strong>Padula</strong> (Rofreddo [Riofreddo],<br />
Serra rotonda, Malanotte, il Monastero Benedettino <strong>di</strong> S. nicola delle Donne, <strong>di</strong> origine<br />
basiliana), a Eboli, <strong>Salerno</strong> e napoli (Quartiere del Pen<strong>di</strong>no, Piazza <strong>degli</strong> orefici, ospizio <strong>di</strong> S.<br />
Lorenzo): ALLIEGRo, 1941, pp. 44-45.<br />
16 <strong>La</strong> tra<strong>di</strong>zione è avvalorata anche dallo storico Pacichelli (1703, Parte I, p. 283). Tuttavia,<br />
«Monsignor Sacco non accetta, nella sua poderosa e robusta opera, ciò che per molti secoli fu<br />
credenza comune (ed erroneamente lo è tuttora) intorno a questa visita» (ALLIEGRo, 1941, p. 55).<br />
17 L’aneddoto è probabilmente frutto anche della meraviglia suscitata dalle ingegnose invenzioni<br />
dei certosini: nella cucina della <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong>, per esempio, arrivava il latte <strong>di</strong>rettamente<br />
dal pianalto <strong>di</strong> Mandrano, attraverso un sistema <strong>di</strong> trasporto <strong>di</strong> loro ideazione (PESCE, 1916, p.<br />
6). <strong>La</strong> circostanza conferma quanto osservato dal Mumford sugli or<strong>di</strong>ni monastici in generale, i<br />
quali, proprio «perché tendevano a eliminare le fatiche non necessarie per de<strong>di</strong>care più tempo<br />
allo stu<strong>di</strong>o, alla me<strong>di</strong>tazione e alla preghiera, […] furono i primi a utilizzare fonti meccaniche<br />
d’energia e a inventare congegni atti a far risparmiare fatiche» (MUMFoRD, 2002, II, p. 332).<br />
18 Grazie a questa acquisizione, il priore della <strong>Certosa</strong> ottenne il titolo <strong>di</strong> Barone, aggiungendo<br />
la relativa corona nel proprio stemma.<br />
19 Alisio, 1988. Sulle con<strong>di</strong>zioni del paesaggio e delle strutture socio-economiche del Vallo<br />
nel decennio napoleonico, cfr. il par. 4/f (Vallo <strong>di</strong> Diano e Alburno, regno <strong>di</strong> seminativi e <strong>di</strong> incoltoboscoso)<br />
in AVERSAno, 1987[b], pp. 65-69 e figg. f.t. Cfr. anche AVERSAno 1987[a], pp. 54-63 e figg.<br />
5 e 6.<br />
20 Per le vicende recenti della <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong> si vedano Miccio (2006) e Sessa (2006).<br />
21 Anche alcuni viaggiatori del “Grand Tour” paragonano la <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong> a una vera e<br />
propria città: è il caso del Lenormant («Le sue strutture sono così gran<strong>di</strong> che guardandole dall’alto<br />
della Civita hanno quasi l’aspetto <strong>di</strong> una piccola città»: riportato in Cassa <strong>di</strong> Risp. Salernit., 1990,<br />
p. 111) e dell’Abate <strong>di</strong> Saint-non (questo «convento potrebbe essere considerato una piccola<br />
città, dove sono rappresentati tutti i mestieri. Si contano ottanta religiosi e circa trecento persone<br />
693
tra padroni e servi, che ci vivono tutto l’anno; un chiostro immenso, dei bei giar<strong>di</strong>ni, <strong>degli</strong> alloggi<br />
confortevoli e tutto quello <strong>di</strong> cui c’è bisogno per rendere felice un uomo saggio che decida <strong>di</strong> sacrificare<br />
la propria libertà»: riportato in Cassa <strong>di</strong> Risp. Salernit., 1990, p. 106).<br />
22 Si tratta in sostanza delle due anime della Chiesa cattolica, emblematicamente rappresentate<br />
dalle figure evangeliche delle due sorelle <strong>di</strong> Betania, la contemplativa Maria e l’operosa Marta<br />
(LoREnzI, 1988, p. 29). I monaci, ribaltando il concetto negativo del lavoro elaborato dalla filosofia<br />
greca (soprattutto da Platone), che poneva una cesura tra le attività manuali e quelle dello spirito,<br />
esaltano il lavoro pratico e lo coniugano con la cultura, riunendo così azione e contemplazione.<br />
Pure, secondo alcuni stu<strong>di</strong>osi, la regola certosina sarebbe per certi aspetti più vicina a modelli arcaici<br />
<strong>di</strong> monachesimo cenobitico, come quello <strong>di</strong> San Pacomio, che alla Regola <strong>di</strong> san Benedetto<br />
(SEREno, 2006).<br />
23 Per evitare ogni eventuale, pericolosa “deriva” intellettuale, nel secolo XV «venne proibito<br />
ai certosini lo stu<strong>di</strong>o troppo approfon<strong>di</strong>to del <strong>di</strong>ritto, dell’astronomia, dell’alchimia; nel 1542<br />
[poco prima del Concilio <strong>di</strong> Trento] furono interdetti ai monaci la lettura delle opere <strong>di</strong> Erasmo<br />
e lo stu<strong>di</strong>o del greco e del latino» (de Martini, 1990, p. 92). Perciò tra le scansie della biblioteca <strong>di</strong><br />
<strong>Padula</strong>, una era de<strong>di</strong>cata ai “Libri prohibiti”: era il priore a decidere chi poteva leggere cosa (Weaver,<br />
1990, p. 20), escludendo ogni forma <strong>di</strong> scienza «peregrina ab or<strong>di</strong>ne aliena, inexemplaris et<br />
curiosa» (Vianini, online). Per quanto riguarda i libri esistenti nella <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong> alla fine del<br />
XVI sec., si rimanda a RICCIARDI, 2006.<br />
24 «Gli aggettivi “alto” e “basso” non vanno presi alla lettera, poiché si riferiscono al grado<br />
<strong>di</strong> spiritualità e non a caratteristiche architettoniche o geologiche», WEAVER, 1990, p. 16. Conformemente<br />
a tale <strong>di</strong>visione, nella <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong>, al <strong>di</strong> là dell’ampia corte <strong>di</strong> ingresso antistante<br />
la facciata principale, si incontrano prima gli ambienti <strong>di</strong> rappresentanza e <strong>di</strong> uso comune, poi<br />
quelli <strong>di</strong> stretta clausura. Per una visualizzazione della pianta dell’e<strong>di</strong>ficio, si rimanda alla fig. 3.<br />
25 Irrigare l’orto e i giar<strong>di</strong>ni a<strong>di</strong>acenti alle celle dei padri era molto semplice: la <strong>Certosa</strong>, infatti,<br />
era dotata <strong>di</strong> un acquedotto appositamente costruito ed era «attraversata da un corso d’acqua che,<br />
dopo aver alimentato canali <strong>di</strong> irrigazione, fontane, mulini e fabbriche, usciva all’esterno per la<br />
monumentale bocca <strong>di</strong> un mascherone sul muro <strong>di</strong> cinta». L’acqua non serviva solo per i bisogni<br />
quoti<strong>di</strong>ani, ma aveva un importante valore simbolico, quale fons vitae e manifestazione pura e limpida<br />
«della gioia donata in eterno al certosino» (DE CUnzo, 1990, pp. 44-45).<br />
26 Leoncini, 1988, p. 57. Così lo stesso stu<strong>di</strong>oso sottolinea che la «città ideale vive in una “situazione<br />
sotto vetro e nella lontananza nello spazio e nel tempo – con<strong>di</strong>zione fondamentale del<br />
sogno utopistico” –; la certosa continua la sua esistenza immutata da nove secoli [ossia a partire<br />
dalla fondazione dell’or<strong>di</strong>ne]. Anche l’abbazia cistercense del XII o XIII secolo attuava un modello<br />
ideale, ma nel corso della storia i cistercensi hanno dovuto, o hanno saputo, adattarsi a molte e<br />
<strong>di</strong>verse situazioni contingenti che hanno fatto venir meno la necessità inderogabile per quelle comunità<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre del monastero-tipo. Ciò non si è verificato per i certosini» (1988, p. 57).<br />
27 Per una descrizione puntuale del significato simbolico e ideale <strong>di</strong> alcuni elementi della<br />
<strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong>, si rimanda a FAGIoLo, 1988.<br />
28 è il caso sia delle città ideali <strong>di</strong> Platone e Aristotele (e, ancor prima, della comunità filosofica<br />
<strong>di</strong> Crotone fondata da Pitagora <strong>di</strong> Samo), concepite nel periodo <strong>di</strong> deca<strong>di</strong>mento e <strong>di</strong>ssoluzione<br />
della polis greca (V-IV sec. a.C.), sia della città celeste dei cristiani (concepita da S. Agostino<br />
e S. Benedetto), nuova capitale ideale dell’Europa dopo il tramonto dell’impero romano d’occidente,<br />
sia, infine, dei monasteri dei certosini, fondati in piena lotta per le investiture tra Impero<br />
e Papato.<br />
29 Il riferimento è al periodo della “cattività avignonese” (1305-1377) e al successivo Scisma<br />
d’occidente (1378-1417), durante il quale la <strong>Certosa</strong> padulense si sarebbe ritrovata suo malgrado<br />
coinvolta nel conflitto tra Carlo III <strong>di</strong> Durazzo e Giovanna I d’Angiò, regina <strong>di</strong> napoli.<br />
694
Mentre l’antipapa è sostenuto dagli Angioini (<strong>di</strong> Francia e <strong>di</strong> napoli) e dalla casa madre dei<br />
certosini <strong>di</strong> Grenoble, in Italia l’or<strong>di</strong>ne si schiera al fianco del legittimo pontefice (per questa e<br />
le precedenti notizie storiche, cfr. Sacco, 2004, vol. I, pp. 282-295). <strong>La</strong> spaccatura determina<br />
smarrimento: in alcune Certose, come risulta dalle carthae dei capitoli generali dell’epoca, si rendono<br />
necessari provve<strong>di</strong>menti per rafforzare la <strong>di</strong>sciplina, con relativi trasferimenti o sostituzioni<br />
dei rispettivi priori (cfr. a riguardo hoGG, 2003 e LE BLéVEC, 2003). <strong>La</strong> crisi è comunque<br />
superata, al punto che il Petrarca considera la Cartusia come «la contro-immagine <strong>di</strong> Avignone<br />
e se Avignone equivale all’apocalittica Babilonia, la certosa corrisponde alla celeste Gerusalemme»<br />
(LEonCInI, 1988, p. 53).<br />
30 A tale regola si sarebbero rifatti tutti i gran<strong>di</strong> movimenti monastici del X-XII secolo (Sisinni,<br />
1988, p. 18), così che nel monastero si seguono le leggi «della misura, dell’or<strong>di</strong>ne, della regolarità,<br />
dell’onestà e della <strong>di</strong>sciplina interiore, che sarebbero poi state ere<strong>di</strong>tate dalla città<br />
me<strong>di</strong>oevale e dal successivo capitalismo sotto forma <strong>di</strong> invenzioni e <strong>di</strong> pratiche commerciali: l’orologio,<br />
il libro dei conti e la giornata regolata secondo un orario» (MUMFoRD, 2002, II, p. 319).<br />
31 Al riguardo basti pensare all’Utopia <strong>di</strong> Tommaso Moro (1516) – <strong>di</strong> poco precedente l’affissione<br />
delle 95 Tesi <strong>di</strong> Lutero (1517) – alla Città del Sole <strong>di</strong> Tommaso Campanella (1623) – redatta<br />
durante la sua detenzione nelle carceri napoletane (a seguito <strong>di</strong> una fallita insurrezione antispagnola<br />
da lui stesso promossa) – e alla Nuova Atlantide <strong>di</strong> Francesco Bacone (1627), risalente a uno dei<br />
perio<strong>di</strong> critici della storia inglese, tra contrasti politici e religiosi. Per converso, molti storici si<br />
sono spinti a ricercare nelle opere <strong>di</strong> Platone, Moro, Campanella, Bacone, Fénelon, ecc., i modelli<br />
dai quali i missionari gesuiti del Paraguay avrebbero tratto ispirazione per organizzare la vita<br />
sociale delle Reducciones, da loro fondate nel XVII-XVIII secolo (SPAGnUoLo, 2001-2006, p. 9),<br />
che rappresentarono, nonostante l’impostazione paternalista, un esempio unico <strong>di</strong> rispetto delle<br />
tra<strong>di</strong>zioni autoctone (nello specifico dei Guaraní) ed e<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> una società comunitaria durante<br />
l’epoca coloniale (CASTAGnARo, 2001).<br />
32 Per quanto riguarda la filosofia del bene perfetto ricercato da San Brunone, si rimanda a<br />
SChETTIno, 2006, p. 15.<br />
33 Si noti a riguardo la perfetta corrispondenza tra la pre<strong>di</strong>lezione platonica per i canti dorici,<br />
suscitanti fermezza e sopportazione (al contrario <strong>di</strong> certa musica e poesia atte a rammollire<br />
l’animo) e quella certosina per i canti a cappella (ossia privi <strong>di</strong> qualunque accompagnamento strumentale),<br />
austeri e sobri, secondo le in<strong>di</strong>cazioni della riforma operata da Guigo (Vianini, in rete).<br />
34 Tale separazione, <strong>di</strong> ascendenza platonica, è altresì presente nella società me<strong>di</strong>oevale nel<br />
suo complesso: Adalberone <strong>di</strong> <strong>La</strong>on (950?- 1030) <strong>di</strong>stingue infatti gli oratores, gli uomini <strong>di</strong> preghiera,<br />
monaci e chierici; i bellatores, i combattenti, cioè i signori e i loro uomini d’armi e infine i<br />
laboratores, cioè i coltivatori e gli artigiani (DAVRIL e PALAzzo, 2002).<br />
35 Citato da Aristotele (secondo libro della Politica) come teorico dell’egualitarismo sociale e<br />
inventore della “<strong>di</strong>visione regolare della città”, Ippodamo da Mileto traccia, secondo un <strong>di</strong>segno<br />
geometrico, una regola razionale, applicata dalla scala dell’e<strong>di</strong>ficio alla scala della città, le cui strade,<br />
tracciate ad angolo retto, la <strong>di</strong>vidono in isolati rettangolari e uniformi (variabili in casi concreti <strong>di</strong><br />
adattabilità al terreno). Tale schema sarebbe stato riproposto, in parte, dai romani: sulle <strong>di</strong>fferenze<br />
tra la città ellenistica e la città romana, cfr. MUMFoRD, 2002, I, pp. 270-271.<br />
36 non a caso, quin<strong>di</strong>, la città ippodamea ha un numero limitato <strong>di</strong> abitanti, <strong>di</strong>visi in classi<br />
(guerrieri, artigiani e agricoltori, aventi il compito <strong>di</strong> sostentare le altre due classi) e un territorio<br />
tripartito (parte sacra, per il culto <strong>degli</strong> dei, pubblica, per i guerrieri, e privata, per gli agricoltori).<br />
37 LEonCInI, 1988, p. 49. nella <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong> sono in sintesi ravvisabili tutti i caratteri<br />
principali delle città ideali della filosofia, riassumibili in nove punti essenziali: «1) l’isolamento; 2)<br />
la pretesa <strong>di</strong> completezza (carattere <strong>di</strong> mondo in piccolo) e perciò la tendenza all’autarchia; 3) le<br />
caratteristiche naturali del territorio, non particolarmente favorevoli; 4) il superamento del dettato<br />
695
ambientale grazie ad un intervento umano massiccio e guidato; 5) la tendenza al simbolismo razionalistico:<br />
regolarità, uniformità, geometria delle forme; 6) la completa e razionale utilizzazione<br />
del suolo; 7) l’aspetto statico (carattere antistorico); 8) il capovolgimento della realtà (tendenza a<br />
rifare il mondo); 9) l’urbanesimo, cioè il posto <strong>di</strong> primo piano dato alla città» (DEMATTEIS, 1963,<br />
p. 411).<br />
38 VIToLo, 2006, pp. 31-32. Lo stesso stu<strong>di</strong>oso osserva come il rapporto concreto tra certosini<br />
padulensi e territorio spieghi la lunga durata del loro potere feudale. Infatti, nel periodo del<br />
loro arrivo e della loro <strong>di</strong>ffusione «era in espansione al Sud, per sua capacità intrinseca <strong>di</strong> irra<strong>di</strong>azione,<br />
il movimento dei Celestini, che era impostato, proprio come quello dei Certosini, sulla coesistenza<br />
<strong>di</strong> solitu<strong>di</strong>ne e <strong>di</strong> vita comunitaria, ma che da esso si <strong>di</strong>fferenziava per la forte impronta<br />
pauperistica, per cui non solo non era consentito ai monaci-eremiti possedere alcunché, ma le<br />
stesse risorse del monastero-eremo erano destinate in larghissima parte ad attività assistenziali.<br />
Questo fece sì che, mentre i Celestini poterono contare subito sul favore popolare, i Certosini<br />
ebbero a volte all’inizio non poche <strong>di</strong>fficoltà, che portarono in due casi su sei […] al fallimento<br />
più o meno rapido del progetto» (2006, p. 29).<br />
39 Per quanto riguarda il rapporto tra paesaggi e giar<strong>di</strong>ni nella <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong>, si rimanda<br />
a Capone, 2006.<br />
40 Ci si riferisce alla cartografia del XVII-XIX sec. dei posse<strong>di</strong>menti della <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong>,<br />
allegata ai documenti conservati nel “Fondo Monasteri Soppressi” dell’Archivio nazionale <strong>di</strong><br />
napoli. L’indagine cartografica è stata svolta nell’ambito del programma <strong>di</strong> ricerca nazionale<br />
CARPA (“Cartografia come fonte per la ricostruzione storico-culturale del Paesaggio”), <strong>di</strong>retta<br />
e coor<strong>di</strong>nata, a livello nazionale, dai proff. C. Cerreti (Univ. <strong>di</strong> Roma “<strong>La</strong> Sapienza”) e L. Federzoni<br />
(Univ. <strong>degli</strong> Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Bologna) e, a livello locale, dal prof. V. Aversano (Univ. <strong>degli</strong> Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Salerno</strong>).<br />
41 Il virgolettato è tratto dal Vitolo, (1982[a], pp. 56-57), il quale aggiunge come appaia <strong>di</strong><br />
conseguenza comprensibile il rilievo assunto nel corso del sec. XV dall’allevamento <strong>di</strong> ovini,<br />
bovini e suini nell’economia della valle, «<strong>di</strong>mostrato in<strong>di</strong>rettamente dallo spazio occupato negli<br />
Statuti <strong>di</strong> Diano dalle norme che riguardano la transumanza, per impe<strong>di</strong>re danni ai luoghi coltivati»<br />
(VIToLo, 1982[a], p. 57).<br />
42 In effetti «il fatto che il fondatore dei certosini san Bruno non abbia lasciato una rigida regola<br />
scritta ha favorito le tendenze particolaristiche dei religiosi <strong>di</strong> <strong>Padula</strong>. Il tentativo <strong>di</strong> equilibrare<br />
le esigenze della vita cenobitica con quelle della vita eremitica operato dai certosini <strong>di</strong>venta una<br />
attesa risposta alle istanze <strong>di</strong> religiosità anacoretica propria dei tanti monaci basiliani della zona.<br />
Ebbe perciò facile presa su religiosi e popolazione che trovano nella <strong>Certosa</strong> la garanzia <strong>di</strong> una<br />
sopravvivenza delle proprie forme cultuali contro le ingerenze episcopali» (RoSSI, 1982, p. 109).<br />
43 De Cunzo, 1988, p. 21. Per quanto riguarda le relazioni e le influenze artistiche della <strong>Certosa</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Padula</strong>, si rimanda a BRACA, 2006 e a GALLo, 2006.<br />
44 Il concetto <strong>di</strong> “virtuale”, solitamente impiegato nell’accezione (tratta dall’informatica) <strong>di</strong><br />
realtà formale o <strong>di</strong> simulazione del reale, dal punto <strong>di</strong> vista filosofico denota invece ciò che è potenziale,<br />
ossia ciò che esiste in potenza ma non si è ancora realizzato (Aristotele, Metafisica, 1049a<br />
5-27). In tal senso gli utopisti, intravedendo le potenzialità insite in un determinato contesto del<br />
reale, ne prefigurano lo sviluppo ottimale: <strong>di</strong> qui la loro minuziosa pianificazione <strong>di</strong> tutte le con<strong>di</strong>zioni<br />
e azioni idonee a potenziarne la coerente e organica evoluzione. Da questo punto <strong>di</strong> vista<br />
ogni utopista può essere quin<strong>di</strong> considerato un pianificatore sociale e territoriale ante litteram.<br />
45 Il Parco in parola (PnCVD) è stato istituito nel 1991, con la legge quadro del 6 <strong>di</strong>cembre<br />
n. 394.<br />
46 nelle ventiquattro celle della <strong>Certosa</strong> è raccolta una collezione <strong>di</strong> arte contemporanea permanente,<br />
comprendente circa cento opere tra <strong>di</strong>pinti, sculture, installazioni, fotografie e video,<br />
696
ealizzate dal 2002 al 2004, nell’ambito della manifestazione Le Opere e i Giorni, a cura <strong>di</strong> A. Bonito<br />
oliva. L’iniziativa (che non ha prodotto risultati durevoli sul territorio) ha provocato anche la<br />
reazione negativa <strong>di</strong> alcuni commentatori, che hanno ritenuto poco significative e inutilmente<br />
<strong>di</strong>ssacranti alcune delle opere esposte, in contrasto con il profondo spirito religioso dei certosini<br />
e l’austerità del luogo. A riguardo si ricorda l’esplicita polemica sollevata dall’ex <strong>di</strong>rettrice della<br />
<strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong>, V. de Martini, e sostenuta anche da V. Sgarbi (cfr. Corriere del Mezzogiorno, 24<br />
giugno 2007).<br />
47 Emerge tra questi ultimi il Progetto Integrato “<strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong>”, approvato dalla Giunta<br />
Regionale della Campania nel 2002 con Fondo Sociale Europeo e Fondo Europeo Sviluppo Regionale<br />
(Delibera n. 6201 del 18/12/02:<br />
http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf03/burc04or_03/del6201_02.pdf), e l’assegnazione<br />
<strong>di</strong> ulteriori risorse nel 2006 (Delibera n. 1322 del 15/10/05:<br />
http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf05/burc59or_05/del1322_05.pdf), volto a «integrare<br />
la valorizzazione, la promozione e l’uso innovativo della <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong> in un processo<br />
che trasformi l’intero territorio del Vallo <strong>di</strong> Diano in un sistema culturale turistico. Gli interventi<br />
proposti vanno dal restauro dei beni culturali alla dotazione <strong>di</strong> infrastrutture e servizi, dalla formazione<br />
delle risorse umane al potenziamento del sistema ricettivo» (Cfr. Portale della Regione<br />
Campania, www.regione.campania.it, sezione “PoR → Progetti integrati → I 51 Progetti integrati<br />
→ Progetti”. Consultazione del 15 giugno 2007). Gli esiti tangibili <strong>di</strong> tali interventi sono ancora<br />
da registrare…<br />
4 Si tratta, come noto, <strong>di</strong> un documento adottato dal Comitato dei Ministri della Cultura e<br />
dell’Ambiente del Consiglio d’Europa il 19 luglio 2000. Firmata da ventisette Stati della UE e ratificata<br />
da <strong>di</strong>eci, la Convenzione si applica all’intero territorio <strong>degli</strong> Stati firmatari (art. 2) e ha l’obiettivo<br />
<strong>di</strong> promuovere presso le autorità pubbliche l’adozione <strong>di</strong> politiche <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a, gestione<br />
e pianificazione dei paesaggi (intesi come risorsa per lo sviluppo generale) e <strong>di</strong> organizzare la<br />
cooperazione europea nelle politiche <strong>di</strong> settore.<br />
49 Ci si riferisce al documento <strong>di</strong> intesa della Regione Campania (Delibera n. 1475, 2005:<br />
http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf05/burc62or_05/del1475_05.pdf) ratificato nella<br />
<strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong>, con la sottoscrizione <strong>di</strong> tutti gli enti territoriali interessati della regione, per<br />
l’attuazione dei principi della Convenzione Europea del Paesaggio e la pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> un documento<br />
denominato “Linee Guida per la in<strong>di</strong>viduazione, tutela e valorizzazione dei paesaggi della Campania”.<br />
50 L’osservatorio (con sede <strong>di</strong> rappresentanza presso la <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong> e operativa presso<br />
la Grancia <strong>di</strong> Sala Consilina) controlla le azioni <strong>di</strong> monitoraggio e valorizzazione della Provincia<br />
<strong>di</strong> <strong>Salerno</strong> nei confronti del patrimonio ambientale sotto l’egida UnESCo<br />
(http://www.cilento.it/news/view.asp?ID=6753).<br />
51 Su questo versante sono recentemente stati scoperti dalle forze dell’or<strong>di</strong>ne molti casi <strong>di</strong><br />
smaltimento non autorizzato <strong>di</strong> rifiuti speciali nel Vallo <strong>di</strong> Diano. A tali scoperte si aggiungono<br />
le reazioni del mondo accademico e scientifico contro l’ipotesi <strong>di</strong> aprire <strong>di</strong>scariche in aree con un<br />
assetto geologico assolutamente inadeguato allo scopo, come in quelle dei già citati Mandrano e<br />
Mandranello (ex proprietà della <strong>Certosa</strong>), due bacini <strong>di</strong> origine tettonico-carsica (ubicati alla sommità<br />
dei monti costituiti da rocce calcaree separanti il Vallo <strong>di</strong> Diano dalla Val d’Agri) e importantissimi<br />
serbatoi naturali <strong>di</strong> acqua potabile (alimentanti la Campania, la Basilicata e la Puglia),<br />
caratterizzati da numerosi fenomeni carsici (inghiottitoi). Cfr. a riguardo, oRToLAnI, 2007.<br />
52 Una conferma a tale proposito arriva dai numeri della popolazione residente a <strong>Padula</strong>,<br />
passata dai 9.307 abitanti del 1871 (quando era il centro più <strong>di</strong>namico e popoloso del Vallo), al<br />
pauroso spopolamento <strong>di</strong> inizio novecento (5.114 abitanti nel 1901, dopo la prima emigrazione<br />
nelle Americhe), alle oscillazioni <strong>degli</strong> anni successivi (7.810 residenti nel 1961; 5.941 nel 1971;<br />
697
5.952 nel 1976: per questi e i precedenti dati si veda FABIAno, 1981, p. 251), sino agli attuali 5.368<br />
residenti (Comune <strong>di</strong> <strong>Padula</strong>, dato aggiornato al 2002), a testimonianza dell’ulteriore peggioramento<br />
della situazione e della sostanziale inefficacia dei progetti <strong>di</strong> valorizzazione della zona<br />
sinora attuati.<br />
53 Il settore extra alberghiero comprende tre tipologie <strong>di</strong> operatori: gli agriturismi (ricavati<br />
dalla ristrutturazione <strong>di</strong> case rurali del XIX e inizio XX secolo), i Bed and breakfast e gli affittacamere.<br />
<strong>La</strong> capienza ricettiva dei due comparti è la seguente: 630 camere (<strong>di</strong> cui 527 alberghiere),<br />
per un totale <strong>di</strong> circa 1336 posti letto (<strong>di</strong> cui 1094 alberghieri). <strong>La</strong> maggioranza <strong>degli</strong> alberghi è<br />
concentrata per motivi strategico-logistici lungo l’arteria autostradale A3: ad Atena Lucana (che<br />
detiene il primato assoluto del numero <strong>di</strong> alberghi e <strong>di</strong> alberghi <strong>di</strong> qualità), a <strong>Padula</strong>, Polla, Sala<br />
Consilina. I numeri dell’extra-alberghiero (formula ricettiva non ancora ben <strong>di</strong>ffusa nel Vallo,<br />
contrariamente alla vicina Basilicata; solo 7 i paesi che l’hanno adottata: Montesano sulla Marcellana,<br />
<strong>Padula</strong>, Polla, Sala Consilina, S. Arsenio, S. Rufo e Sanza) sono i seguenti: 103 camere, 242<br />
posti letto, 781 coperti.<br />
54 Il dato è altresì confermato da un’indagine sul campo, a cura delle autrici, dalla quale risulta<br />
la scarsità <strong>di</strong> agriturismi sorti sul territorio del Vallo negli ultimi <strong>di</strong>eci anni (ve<strong>di</strong> Tab. 2). Questo<br />
risultato è tanto più in<strong>di</strong>cativo, in considerazione delle molte leggi <strong>di</strong> finanziamento attualmente<br />
esistenti in Italia per la realizzazione e l’avviamento <strong>di</strong> simili attività.<br />
55 Per queste e le precedenti considerazioni, si veda FABIAno, 1981, pp. 17-18. Per un approfon<strong>di</strong>mento<br />
della problematica sugli squilibri territoriali della Campania in generale, si rimanda<br />
a MAUTonE-SBoRDonE, 1983, e a TALIA, 2007.<br />
56 Associazione Promotore Grande Lucania, 2007 (http://www.grandelucania.it), a cui si rimanda<br />
per un approfon<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> presupposti e obiettivi del progetto sull’istituzione della<br />
Grande Lucania, dettagliatamente illustrati nello “Statuto dell’Associazione Promotore Grande<br />
Lucania” (http://www.grandelucania.it/statuto.php). Fa piacere annotare che, già più <strong>di</strong> un decennio<br />
ad<strong>di</strong>etro, un geografo “coi pie<strong>di</strong> per terra” affrontava queste problematiche e <strong>di</strong>segnava<br />
su carta (PREzIoSI, 1997, fig. 16) il profilo della «istituenda sesta Provincia della Campania», da<br />
imperniare sul Vallo <strong>di</strong> Diano e comprendente altresì il Cilento nonché la porzione tirrenica della<br />
provincia <strong>di</strong> Potenza, annotando che, <strong>di</strong> «buona consistenza demografica (circa 350.000 abitanti),<br />
essa potrebbe risolvere il problema del capoluogo solo adottando la soluzione già sperimentata<br />
in quella <strong>di</strong> Verbano, con una sud<strong>di</strong>visione delle funzioni tra Vallo della Lucania, Sala Consilina<br />
e <strong>La</strong>gonegro, a con<strong>di</strong>zione ovviamente che siano migliorate le comunicazioni tra Vallo e gli altri<br />
due centri» (ivi, pp. 98-99).<br />
Riferimenti Bibliografici e Linkografia<br />
ABATE F., Petit Tour, in Cassa <strong>di</strong> Risp. Salernitana, Milano, Franco Maria Ricci Ed., 1990, «Taccuini<br />
<strong>di</strong> viaggio», pp. 117-121;<br />
ALISIo G., Le vicende delle Certose e dei Conventi soppressi in Campania nel corso dell’Ottocento, in Min.<br />
Beni Cult. ed Ambient.-Soprint. Beni Ambient., Architett. Artist.e St. <strong>di</strong> Sa e Av, Certose e<br />
Certosini in Europa, Atti del Convegno alla <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> San Lorenzo, <strong>Padula</strong> 22, 23, 24 settembre 1988,<br />
napoli, Sergio Civita Ed., Vol. I, pp. 195-200;<br />
ALLIEGRo G., <strong>La</strong> Reggia del Silenzio, Roma, Unione E<strong>di</strong>trice Sindacale Italiana, 1941;<br />
ARISToTELE, Metafisica, Rusconi, Milano, 1994;<br />
AVERSAno V., Villaggi abbandonati e paralisi dello sviluppo per la guerra del Vespro in Campania e Basilicata,<br />
698
in V. Aversano, Geographica salernitana. Letture cronospaziali <strong>di</strong> un territorio provinciale, <strong>Salerno</strong>,<br />
Ed. Salernum S.r.l., 1987, pp. 87-113;<br />
AVERSAno V., Città e campagna nella provincia <strong>di</strong> <strong>Salerno</strong> dal tardo Seicento al primo Novecento: osservazioni<br />
su alcuni documenti cartografici, in V. Aversano, Geographica salernitana. Letture cronospaziali <strong>di</strong> un<br />
territorio provinciale, <strong>Salerno</strong>, Ed. Salernum S.r.l., 1987[a], pp. 45-75;<br />
AVERSAno V., Geografia e catasto napoleonico: analisi territoriale del Principato Citra, napoli, E.S.I.,<br />
1987[b];<br />
AVERSAno V. (2003). Introduzione Basilicata, in AA.VV. Descrittione <strong>di</strong> tutta Italia <strong>di</strong> Leandro Alberti,<br />
pp. 132-138, Bergamo, Lea<strong>di</strong>ng E<strong>di</strong>zioni;<br />
BEnEVoLo L., <strong>La</strong> città nella storia d’Europa, Roma-Bari, Ed. <strong>La</strong>terza, 2004;<br />
BRACA A., Relazioni artistiche della <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong> dalle origini all’età moderna, in C. Carlone (a cura<br />
<strong>di</strong>), Storia arte e me<strong>di</strong>cina nella <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong> (1306-2006), Atti del Convegno <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong> (<strong>Padula</strong>-<br />
Monte San Giacomo, 28-29/01/2006), <strong>Salerno</strong>, P. <strong>La</strong>veglia Ed. (Quad. del Centro Stu<strong>di</strong> e Ricerche<br />
del Vallo <strong>di</strong> Diano “P. <strong>La</strong>veglia”), pp. 153-197;<br />
CAPAno A., I posse<strong>di</strong>menti della <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> S. Lorenzo <strong>di</strong> <strong>Padula</strong> in Campania tra il catasto conciario ed il<br />
catasto murattiano, in C. Carlone (a cura <strong>di</strong>), Storia arte e me<strong>di</strong>cina nella <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong> (1306-<br />
2006), Atti del Convegno <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong> (<strong>Padula</strong>-Monte San Giacomo, 28-29/01/2006), <strong>Salerno</strong>, P. <strong>La</strong>veglia<br />
Ed. (Quad. del Centro Stu<strong>di</strong> e Ricerche del Vallo <strong>di</strong> Diano “P. <strong>La</strong>veglia”), pp. 81-106;<br />
CAPonE P., Paesaggi e giar<strong>di</strong>ni della <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong>, in C. Carlone (a cura <strong>di</strong>), Storia arte e me<strong>di</strong>cina<br />
nella <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong> (1306-2006), Atti del Convegno <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong> (<strong>Padula</strong>-Monte San Giacomo, 28-<br />
29/01/2006), <strong>Salerno</strong>, P. <strong>La</strong>veglia Ed. (Quad. del Centro Stu<strong>di</strong> e Ricerche del Vallo <strong>di</strong> Diano<br />
“P. <strong>La</strong>veglia”), pp. 257-278;<br />
CASTAGnARo M., «Paraguay. <strong>La</strong> Chiesa dell’impegno», in Orizzonti della fede, Dic. 2001, (on line su<br />
Internet: http://www.gesuiti.it/popoli/anno2001/12/ar011206.htm);<br />
CASTIELLo n. (a cura <strong>di</strong>), Atti Giornate <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong>o su Il Turismo Culturale in Campania, in “Quaderni”<br />
dell’Univ. <strong>degli</strong> Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> napoli «Federico II», Dip. <strong>di</strong> Analisi dei processi economico-sociali,<br />
linguistici, produttivi e territoriali, napoli, 2004;<br />
CoLAPIETRA R., I Sanseverino <strong>di</strong> <strong>Salerno</strong>. Mito e realtà del barone ribelle, <strong>Salerno</strong>, P. <strong>La</strong>veglia Ed., S.a.S.,<br />
1985;<br />
CoLoMBo A., Crollo del comunismo sovietico e ripresa dell’utopia, Beatrice Battaglia, 1994;<br />
CoMUnE DI MERCATo SAn SEVERIno (on line su Internet: http://www.comune.mercato-san-severino.sa.it);<br />
CoMUnITà EURoPEA, Convenzione Europea del Paesaggio (on line su Internet:<br />
www.darc.beniculturali.it/ita/normativa/doc/convenz_europ_palombi.doc.);<br />
Corriere del Mezzogiorno del 24 giugno 2007;<br />
DAVRIL A.. e PALAzzo E., I monaci nel mondo religioso me<strong>di</strong>evale, estratto da <strong>La</strong> vita dei monaci al tempo<br />
delle gran<strong>di</strong> abbazie, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2002, (on line su Internet: http://www.oraet-labora.net/davrilpalazzo.html);<br />
DE CUnzo M., <strong>La</strong> <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> S. Lorenzo, in Min. Beni Cult. ed Ambient.-Soprint. Beni Ambient.,<br />
Architett. Artist.e St. <strong>di</strong> Sa e Av, Certose e Certosini in Europa, Atti del Convegno alla <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong><br />
San Lorenzo, <strong>Padula</strong> 22, 23, 24 settembre 1988, napoli, Sergio Civita Ed., Vol. I, pp. 21-22.<br />
DE CUnzo M., <strong>La</strong> <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> San Lorenzo, Cassa <strong>di</strong> Risp. Salernitana, Milano, F. Maria Ricci Ed.,<br />
1990, pp. 37-78;<br />
DE MARTInI V., <strong>La</strong> <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong> nel sistema delle certose meri<strong>di</strong>onali, in Min. Beni Cult. ed Ambient.-Soprint.<br />
Beni Ambient., Architett. Artist.e St. <strong>di</strong> Sa e Av, Certose e Certosini in Europa,<br />
Atti del Convegno alla <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> San Lorenzo, <strong>Padula</strong> 22, 23, 24 settembre 1988, napoli, Sergio<br />
Civita Ed., Vol. II, pp. 207-217;<br />
DE MARTInI V., Itinerarium, Cassa <strong>di</strong> Risp. Salernitana, Milano, F. Maria Ricci Ed., 1990, pp. 85-94;<br />
699
DEMATTEIS G., «L’organizzazione del territorio nelle utopie sociali <strong>di</strong> T. Moro, T. Campanella, F.<br />
Bacone», in Rivista geografica Italiana, LXX, 1963, pp. 395-421;<br />
DE SAInT-non J.C.R., Voyage pittoresque ou Description des Royaumes de Naples et de Sicile [estratto], in<br />
Cassa <strong>di</strong> Risp. Salernitana, Milano, F. Maria Ricci Ed., 1990, «Taccuini <strong>di</strong> viaggio», pp. 105-<br />
115;<br />
DIDIER A., «Certose e Certosini in Europa», Convegno internazionale <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o. <strong>Padula</strong>, <strong>Certosa</strong><br />
<strong>di</strong> S. Lorenzo, 22-24 settembre 1988, in Rassegna Storica Salernitana, n.S., V, 2, 1988, pp. 295-<br />
302;<br />
Dizionario <strong>di</strong> Toponomastica. Storia e significato dei nomi geografici italiani, Torino, Utet, 2007;<br />
GIAnnAnTonI G. (a cura <strong>di</strong>), I Presocratici. Testimonianze e frammenti, Milano, CDE, 1994;<br />
FABIAno P. P., Il Vallo <strong>di</strong> Diano. Assetto territoriale e modello <strong>di</strong> sviluppo, A. G. Boccia Ed., 1981,<br />
FAGIoLo M., L’asse prospettico della <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong>: l’itinerario simbolico dalla facciata allo Scalone-Belvedere,<br />
in Min. Beni Cult. ed Ambient.-Soprint. Beni Ambient., Architett. Artist.e St. <strong>di</strong> Sa e<br />
Av, Certose e Certosini in Europa, Atti del Convegno alla <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> San Lorenzo, <strong>Padula</strong> 22, 23, 24<br />
settembre 1988, napoli, Sergio Civita Ed., Vol. I, pp. 147-164;<br />
FERRARo S., In<strong>di</strong>cazioni bibliografiche sulla <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong>, in C. Carlone (a cura <strong>di</strong>), Storia arte e me<strong>di</strong>cina<br />
nella <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong> (1306-2006), Atti del Convegno <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong> (<strong>Padula</strong>-Monte San Giacomo,<br />
28-29/01/2006), <strong>Salerno</strong>, P. <strong>La</strong>veglia Ed. (Quad. del Centro Stu<strong>di</strong> e Ricerche del Vallo <strong>di</strong><br />
Diano “P. <strong>La</strong>veglia”), pp. 381-388;<br />
GALLo M. C., Influenze artististiche della <strong>Certosa</strong> in età barocca, in C. Carlone (a cura <strong>di</strong>), Storia arte e<br />
me<strong>di</strong>cina nella <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong> (1306-2006), Atti del Convegno <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong> (<strong>Padula</strong>-Monte San Giacomo,<br />
28-29/01/2006), <strong>Salerno</strong>, P. <strong>La</strong>veglia Ed. (Quad. del Centro Stu<strong>di</strong> e Ricerche del Vallo <strong>di</strong><br />
Diano “P. <strong>La</strong>veglia”), pp. 199-255;<br />
hoGG J., L’or<strong>di</strong>ne certosino nel periodo dello Scisma, in P. De Leo (a cura <strong>di</strong>), L’or<strong>di</strong>ne certosino e il papato<br />
dalla fondazione allo Scisma d’Occidente, Soveria Mannelli, Rubbettino Ed., 2004, pp. 157-338.<br />
http://www.cilento.it;<br />
ISTAT, Il Turismo nel 2004 (on line su Internet: http://statistica.regione.campania.it/areeTematiche/Turismo/documenti/RapportiAnnuali/Il_turismo_nel_2004.pdf);<br />
LAURETI L., I piani carsici dei Monti della Maddalena, in M. Fon<strong>di</strong> (a cura <strong>di</strong>), Atti del XXII Congresso<br />
Geografico Italiano, Vol. IV, Tomo I, a c. <strong>di</strong> E. D’Arcangelo e D. Ruocco, Cercola, Ist. Geografico<br />
italiano, 1982, pp. 162-166 (par. 8);<br />
LE BLéVEC D., <strong>La</strong> Papauté d’Avignon et l’ordre des chartreux, in P. De Leo (a cura <strong>di</strong>), L’or<strong>di</strong>ne certosino<br />
e il papato dalla fondazione allo Scisma d’Occidente, Soveria Mannelli, Rubbettino Ed., 2004, pp.<br />
149-156;<br />
LEnoRMAnT F., A travers l’Apulie et la Lucanie, [estratto], in Cassa <strong>di</strong> Risp. Salernit., Milano, F. Maria<br />
Ricci Ed., 1990, «Taccuini <strong>di</strong> viaggio», pp. 105-115;<br />
LEonCInI G., Il monastero certosino: attuazione <strong>di</strong> un ideale, in Min. Beni Cult. ed Ambient.-Soprint.<br />
Beni Ambient., Architett. Artist.e St. <strong>di</strong> Sa e Av, Certose e Certosini in Europa, Atti del Convegno<br />
alla <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> San Lorenzo, <strong>Padula</strong> 22, 23, 24 settembre 1988, napoli, Sergio Civita Ed., Vol. I,<br />
pp. 47-58;<br />
LoREnzI (DoM.) G. M., Finalità e vita quoti<strong>di</strong>ana dei Certosini, in Min. Beni Cult. ed Ambient.-<br />
Soprint. Beni Ambient., Architett. Artist.e St. <strong>di</strong> Sa e Av, Certose e Certosini in Europa, Atti del<br />
Convegno alla <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> San Lorenzo, <strong>Padula</strong> 22, 23, 24 settembre 1988, napoli, Sergio Civita Ed.,<br />
Vol. I, pp. 29-45;<br />
MALLET R., The Neapolitan Earthquake of 1857, [estratto], in Cassa <strong>di</strong> Risp. Salernitana, Milano, F.<br />
Maria Ricci Ed., 1990, «Taccuini <strong>di</strong> viaggio», pp. 105-115;<br />
MAUTonE M. e SBoRDonE L., Città e organizzazione del territorio in Campania: analisi della rete urbana<br />
in una regione squilibrata, napoli, ESI, 1983;<br />
700
MICCIo G., Il recupero della <strong>Certosa</strong> tra passato e futuro, in C. Carlone (a cura <strong>di</strong>), Storia arte e me<strong>di</strong>cina<br />
nella <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong> (1306-2006), Atti del Convegno <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong> (<strong>Padula</strong>-Monte San Giacomo, 28-<br />
29/01/2006), <strong>Salerno</strong>, P. <strong>La</strong>veglia Ed. (Quad. del Centro Stu<strong>di</strong> e Ricerche del Vallo <strong>di</strong> Diano<br />
“P. <strong>La</strong>veglia”), pp. 279-301;<br />
MUMFoRD L., <strong>La</strong> città nella storia, Milano, Bompiani, 2002, 3 voll.;<br />
MUSI A., <strong>La</strong> <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong> e il Principato Citeriore nell’età spagnola, in C. Carlone (a cura <strong>di</strong>), Storia<br />
arte e me<strong>di</strong>cina nella <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong> (1306-2006), Atti del Convegno <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong> (<strong>Padula</strong>-Monte San<br />
Giacomo, 28-29/01/2006), <strong>Salerno</strong>, P. <strong>La</strong>veglia Ed. (Quad. del Centro Stu<strong>di</strong> e Ricerche del<br />
Vallo <strong>di</strong> Diano “P. <strong>La</strong>veglia”), pp. 71-79;<br />
nATELLA P., I Sanseverino <strong>di</strong> Marsico: una terra, un regno, M. S. Severino, Centro <strong>di</strong> servizi culturali,<br />
1980;<br />
nATELLA P., Ascesa e apogeo dei Sanseverino <strong>di</strong> Marsico, in C. Carlone (a cura <strong>di</strong>), Storia arte e me<strong>di</strong>cina<br />
nella <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong> (1306-2006), Atti del Convegno <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong> (<strong>Padula</strong>-Monte San Giacomo, 28-<br />
29/01/2006), <strong>Salerno</strong>, P. <strong>La</strong>veglia Ed. (Quad. del Centro Stu<strong>di</strong> e Ricerche del Vallo <strong>di</strong> Diano<br />
“P. <strong>La</strong>veglia”), pp. 49-69;<br />
oRToLAnI F., Emergenza rifiuti in Campania e tutela delle risorse naturali autoctone <strong>di</strong> importanza strategica<br />
(on line su Internet: http://campania.peacelink.net/rifiuti/articles/art_75.html, 31/12/2007);<br />
PACIChELLI G.B., Il Regno <strong>di</strong> napoli in prospettiva <strong>di</strong>viso in Dodeci Provincie, Parte I e II, napoli,<br />
Stamperia D.A. Parrino, 1703;<br />
PESCE C., Il Vallo <strong>di</strong> Diano e la <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong>, <strong>La</strong>gonegro, tip. Lucana <strong>di</strong> F. Auleta, 1916;<br />
PoRzIo C., <strong>La</strong> congiura de’ Baroni del regno <strong>di</strong> Napoli contra il re Fer<strong>di</strong>nando I <strong>di</strong> Napoli, napoli, Pe’ tipi<br />
del cav. Gaetano nobile, 1859;<br />
PREzIoSI G., <strong>La</strong> territorializzazione <strong>degli</strong> enti pubblici, in AA.VV., <strong>Salerno</strong> Capoluogo e la sua Provincia.<br />
Squilibri geoamministrativi e possibili interventi, a c. <strong>di</strong> V. Aversano, Atti del Convegno nazionale<br />
<strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o, <strong>Salerno</strong> 11 giu. 1996, Cava de’ Tirreni, Avagliano Ed., 1997, pp. 57-100;<br />
REGIonE CAMPAnIA (on line su Internet: http://www.regione.campania.it);<br />
RETE CIVICA CoMUnE DI PADULA (on line su Internet: http://www.comune.padula.sa.it/);<br />
RICCIARDI A., <strong>La</strong> Biblioteca del certosino Domenico Matrella, in C. Carlone (a cura <strong>di</strong>), Storia arte e<br />
me<strong>di</strong>cina nella <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong> (1306-2006), Atti del Convegno <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong> (<strong>Padula</strong>-Monte San Giacomo,<br />
28-29/01/2006), <strong>Salerno</strong>, P. <strong>La</strong>veglia Ed. (Quad. del Centro Stu<strong>di</strong> e Ricerche del Vallo <strong>di</strong><br />
Diano “P. <strong>La</strong>veglia”), pp. 371-376;<br />
RoSSI L., <strong>La</strong> chiesa nel Vallo: organizzazione ecclesiastica, vita ecclesiale e religiosità popolare, in Storia del<br />
Vallo <strong>di</strong> Diano, <strong>Salerno</strong>, P. <strong>La</strong>veglia Ed., 1982, Vol. III, pp. 93-132;<br />
RUyER R., L’utopie et les utopies, Paris, Presses Universitaires de France, 1988;<br />
SACCo A., <strong>La</strong> <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong>, <strong>Salerno</strong>, P. <strong>La</strong>veglia Ed., 2004, vol. I-II;<br />
San Bruno e i Certosini: cammini <strong>di</strong> contemplazione (on line su Internet: http://www.certosini.info/);<br />
SBoRDonE L., I Sanseverino e la <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong>, in M. Fon<strong>di</strong>. (a cura <strong>di</strong>), Atti del XXII Congresso<br />
Geografico Italiano, Vol. IV, Tomo I, a c. <strong>di</strong> E. D’Arcangelo e D. Ruocco, Cercola, Ist. Geografico<br />
italiano, 1982, pp. 158-161;<br />
SBoRDonE L., Guida della escursione nel Vallo <strong>di</strong> Diano, in M. Fon<strong>di</strong> (a cura <strong>di</strong>), Atti del XXII Congresso<br />
Geografico Italiano, Vol. IV, Tomo I, a c. <strong>di</strong> E. D’Arcangelo e D. Ruocco, Cercola, Ist. Geogr.<br />
It., 1982, pp. 121-134 (par. 1, 2, 3);<br />
SChETTIno B., Silenzio e solitu<strong>di</strong>ne, in C. Carlone (a cura <strong>di</strong>), Storia arte e me<strong>di</strong>cina nella <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Padula</strong> (1306-2006), Atti del Convegno <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong> (<strong>Padula</strong>-Monte San Giacomo, 28-29/01/2006), <strong>Salerno</strong>,<br />
P. <strong>La</strong>veglia Ed. (Quad. del Centro Stu<strong>di</strong> e Ricerche del Vallo <strong>di</strong> Diano “P. <strong>La</strong>veglia”),<br />
pp. 13-18;<br />
SChIAVo A., «Fondazione e sviluppi della <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong>», Rassegna Storica Salernitana, anno 2,<br />
nuova Serie, n. 1, pp. 5-18;<br />
701
SCIARELLI F., «Il management dell’arte: <strong>di</strong>ffondere o commercializzare? », in Castiello n. (a cura<br />
<strong>di</strong>), Atti Giornate <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong>o su Il Turismo Culturale in Campania, Dip. <strong>di</strong> Analisi dei processi economico-sociali,<br />
linguistici, produttivi e territoriali, napoli, 2004, pp. 205-214 (collana<br />
“Quad.” dell’Univ. <strong>degli</strong> Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> napoli «Federico II»);<br />
SEREno C., «Certosini e Cistercensi», in Reti Me<strong>di</strong>evali. Iniziative on line per gli stu<strong>di</strong> me<strong>di</strong>evistici, (on<br />
line su Internet: http://www.rm.unina.it/RM-home.htm), 2006, [ISSn 1593-2214];<br />
SESSA M.G., <strong>La</strong> Metamorfosi della <strong>Certosa</strong>: da luogo della memoria a <strong>La</strong>boratorio del presente, in C. Carlone<br />
(a cura <strong>di</strong>), Storia arte e me<strong>di</strong>cina nella <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong> (1306-2006), Atti del Convegno <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong><br />
(<strong>Padula</strong>-Monte San Giacomo, 28-29/01/2006), <strong>Salerno</strong>, P. <strong>La</strong>veglia Ed. (Quad. del Centro Stu<strong>di</strong><br />
e Ricerche del Vallo <strong>di</strong> Diano “P. <strong>La</strong>veglia”), pp. 303-313;<br />
SISInnI F., I Certosini e il monachesimo occidentale, in Min. Beni Cult. ed Ambient.-Soprint. Beni Ambient.,<br />
Architett. Artist.e St. <strong>di</strong> Sa e Av, Certose e Certosini in Europa, Atti del Convegno alla <strong>Certosa</strong><br />
<strong>di</strong> San Lorenzo, <strong>Padula</strong> 22, 23, 24 settembre 1988, napoli, Sergio Civita Ed., Vol. I, pp. 17-20;<br />
SoAnE J., Italian Sketches, 1779, [estratto], in Cassa <strong>di</strong> Risp. Salernit., Milano, F. Maria Ricci Ed.,<br />
1990, «Taccuini <strong>di</strong> viaggio», pp. 105-115;<br />
SoRICILLo M., Il Vallo <strong>di</strong> Diano, napoli, 1979 [Pubblicaz. dell’Ist. <strong>di</strong> Geogr. Econom. dell’Univ.<br />
<strong>di</strong> napoli <strong>di</strong>rette dal prof. D. Ruocco];<br />
SPAGnUoLo E., Le Reducciones dei Gesuiti del Paraguay, 2001-2006 (on line su Internet: http://<br />
www.gesuiti.it/img/second/immagini/reducciones.pdf);<br />
Statuta or<strong>di</strong>nis cartusiensis a donino (|) Guigone priore cartusie e<strong>di</strong>ta, <strong>Certosa</strong> S. Giovanni Battista <strong>di</strong> Friburgo-Amerbach,<br />
Johann & Gesellschafter, 1510;<br />
STRoCChIA T., «Antonio Sacco e i documenti certosini provenienti da Sala Consilina», in Rassegna<br />
Storica Salernitana, 46, n.S., XXIII, 2, <strong>di</strong>c. 2006, pp. 227-233;<br />
TALIA I., Ambiente, uomini, città nell’organizzazione territoriale del Mezzogiorno, napoli, Liguori, 2007.<br />
T.C.I., Città da scoprire. 3. Guida ai centri minori. Italia meri<strong>di</strong>onale e insulare, Milano, Touring Club Italiano,<br />
1985;<br />
T.C.I., Campania, Milano, Touring Ed., 2005 [Collana L’Italia.];<br />
TURRI E., Il paesaggio tra persistenza e trasformazione, in T.C.I., Il Paesaggio italiano, Milano, Touring<br />
Ed., 2000, pp. 63-74;<br />
VIAnInI G., Il canto gregoriano nell’or<strong>di</strong>ne monastico certosino (on line su Internet: http://www.musicasacra.it/Documenti_sulla_Musica_Sacra/Canto_certosino.htm);<br />
VIToLo G., Organizzazione dello spazio e vicende del popolamento, in Storia del Vallo <strong>di</strong> Diano, <strong>Salerno</strong>, P.<br />
<strong>La</strong>veglia Ed., 1982[a], Vol. II, pp. 43-78;<br />
VIToLo G., Dalla pieve rurale alla chiesa ricettizia, in Storia del Vallo <strong>di</strong> Diano, <strong>Salerno</strong>, P. <strong>La</strong>veglia Ed.,<br />
1982[b], Vol. II, pp. 127-158;<br />
VIToLo G., Monachesimo e società, in C. Carlone (a cura <strong>di</strong>), Storia arte e me<strong>di</strong>cina nella <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> <strong>Padula</strong><br />
(1306-2006), Atti del Convegno <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong> (<strong>Padula</strong>-Monte San Giacomo, 28-29/01/2006), <strong>Salerno</strong>, P.<br />
<strong>La</strong>veglia Ed. (Quad. del Centro Stu<strong>di</strong> e Ricerche del Vallo <strong>di</strong> Diano “P. <strong>La</strong>veglia”), pp. 22-<br />
35;<br />
VULTAGGIo C., <strong>La</strong> viabilità, in Storia del Vallo <strong>di</strong> Diano, <strong>Salerno</strong>, P. <strong>La</strong>veglia Ed., 1982, Vol. II, pp.<br />
79-125;<br />
WEAVER W., Et in Italia ego, in AA.VV., <strong>La</strong> <strong>Certosa</strong> <strong>di</strong> San Lorenzo, Cassa <strong>di</strong> Risp. Salernit., Milano,<br />
F. Maria Ricci Ed., 1990, pp. 11-31.<br />
702
Finito <strong>di</strong> stampare nel mese <strong>di</strong> <strong>di</strong>cembre 2009 nel<br />
Centro stampa Franco Pancallo E<strong>di</strong>tore - Locri (RC)<br />
Carta Fedrigoni Arcoprint e<strong>di</strong>zioni da 85 gr. / mq<br />
Copertina carta Fabriano Acquerello da 160 gr. / mq<br />
Printed in Italy<br />
Collaborazione <strong>di</strong> Germana Curulli e Alessandro Origlia