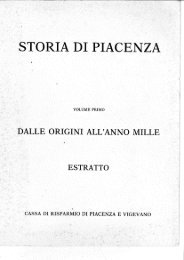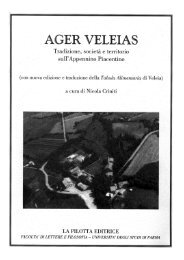Donne, liberti e schiavi nella Roma di Orazio - ager veleias
Donne, liberti e schiavi nella Roma di Orazio - ager veleias
Donne, liberti e schiavi nella Roma di Orazio - ager veleias
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Il princeps coinvolse, inoltre, <strong>schiavi</strong> e <strong>liberti</strong> come ministri annuali nel culto dei Lari<br />
e del Genio dell'imperatore, legando, in un'ottica <strong>di</strong> culto imperiale, un consenso sempre<br />
più ampio attorno al suo programma e riaffermando, nel contempo, il <strong>di</strong>ritto e il dovere <strong>di</strong><br />
controllare <strong>di</strong>rettamente i ceti subalterni, senza lasciarli all'arbitrio dei singoli (dei senatori<br />
in particolare). D'altro canto, la lex Aelia Sentia e la lex Fufia Caninia 2 , stabilendo alcune<br />
limitazioni in materia <strong>di</strong> numero e <strong>di</strong> durata per quanto riguarda le manomissioni <strong>di</strong> <strong>schiavi</strong>,<br />
furono la conferma del timore <strong>di</strong> Augusto <strong>di</strong> perdere il controllo su una quantità notevole <strong>di</strong><br />
<strong>liberti</strong>, i più ricchi dei quali, non a caso, furono da lui stessi iscritti nell'ordo equester, tra i<br />
cavalieri (l'altro influente ceto dell'Urbe).<br />
<strong>Orazio</strong>, padrone romano.<br />
Lo schiavo fedele.<br />
Psicologia ed atteggiamenti <strong>schiavi</strong>li.<br />
Tale società, con i vizi e le virtù degli uomini, con le sue tinte più o meno accese, viene<br />
rappresentata da <strong>Orazio</strong>, che non può esimersi perciò – già dalle prime sue opere (nel<br />
primo e secondo libro delle Satire) – dall'osservazione <strong>di</strong>retta <strong>di</strong> <strong>schiavi</strong> e <strong>liberti</strong>, in<br />
prevalenza maschi, dalla cui analisi onomastica si ricavano nomi che alludono in<br />
maggioranza ad una probabile origine grecanica o semitico-vicino orientale: Hydaspes,<br />
Lyciscus, Phillis, Pythias (<strong>di</strong> con<strong>di</strong>zione <strong>schiavi</strong>le); Hermogenes, Mena, Musa, Myrtale,<br />
Phryne, Tanais, Timagenes (<strong>di</strong> con<strong>di</strong>zione <strong>liberti</strong>na).<br />
Nelle opere successive i toni si smorzano: il poeta venosino matura una concezione<br />
esistenziale sostenuta da speculazioni filosofiche e concettuali; l'interesse del sociale non<br />
è più così <strong>di</strong>rettamente avvertito ed espresso. Le in<strong>di</strong>cazioni, i termini connessi a <strong>schiavi</strong> e<br />
<strong>liberti</strong> <strong>di</strong>minuiscono nel primo libro delle Epistole, nei primi tre libri delle O<strong>di</strong>, pubblicati dal<br />
23 a.C. in poi: decisamente in quantità minori o assenti appaiono le citazioni e i riman<strong>di</strong> al<br />
mal tollerato mondo subalterno, specie <strong>schiavi</strong>le-<strong>liberti</strong>no, nel quarto libro delle O<strong>di</strong>, nel<br />
secondo libro delle Epistole (scritte negli anni attorno al 13 a.C.), negli Epo<strong>di</strong> e nel Carme<br />
secolare.<br />
<strong>Orazio</strong> esprime nei confronti <strong>di</strong> <strong>schiavi</strong> e <strong>liberti</strong> un giu<strong>di</strong>zio praticamente identico e le<br />
medesime considerazioni della mentalità dominante, in una sorta <strong>di</strong> continuità<br />
dell'atteggiamento della comme<strong>di</strong>a greco-ellenistica: ma tale modo <strong>di</strong> pensare è<br />
giustificato, innanzitutto, dal <strong>di</strong>ritto e dalle norme giuri<strong>di</strong>che. Lo schiavo è un bene<br />
patrimoniale, una "cosa" (res), un puro e semplice strumento <strong>di</strong> lavoro dotato <strong>di</strong> voce (un<br />
instrumentum vocale, valutato in termini <strong>di</strong> resa economica da alcuni gran<strong>di</strong> latifon<strong>di</strong>sti,<br />
come Catone il Censore, da Varrone, da Columella, ...), <strong>di</strong> cui il dominus può <strong>di</strong>sporre<br />
incon<strong>di</strong>zionatamente, secondo il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> vita e <strong>di</strong> morte (ius vitae necisque), uno degli<br />
attributi del potere assoluto del padre <strong>di</strong> famiglia, la patria potestas. Tale definizione – in<br />
base alla quale lo schiavo è oggetto del <strong>di</strong>ritto – documenta l'ambiguità dell'istituzione<br />
<strong>schiavi</strong>le all'interno del mondo romano: infatti, dall'impiego dello schiavo, in alcuni settori,<br />
come rappresentante economico del suo padrone o dalla gestione <strong>di</strong> un risparmio<br />
personale (peculium), scaturisce pur sempre la capacità soggettiva dello schiavo,<br />
co<strong>di</strong>ficata del resto dal <strong>di</strong>ritto stesso.<br />
Il servus resta, comunque, un bene prezioso per il padrone e la sua fuga è una<br />
grave per<strong>di</strong>ta per lui: il ritrovamento <strong>di</strong> resti <strong>di</strong> strumenti creati per evitare la fuga servorum<br />
(particolarmente <strong>di</strong>ffusa dalla fine del I sec. a.C.), come catene e collari <strong>di</strong> metallo, oltre<br />
alla figura dell'addetto al ritrovamento dei fuggiaschi (fugitivarius), <strong>di</strong>mostrano l'intenzione<br />
dei domini <strong>di</strong> salvaguardare il possesso dei propri <strong>schiavi</strong>.<br />
Il <strong>di</strong>ritto romano tuttavia contemplava una forma caratteristica, ed unica nel mondo<br />
antico, <strong>di</strong> promozione sociale (e giuri<strong>di</strong>ca) per gli <strong>schiavi</strong>: la manumissio, ossia la<br />
liberazione dello schiavo dalla potestas del dominus, oltre la volontà stessa del padrone <strong>di</strong><br />
3