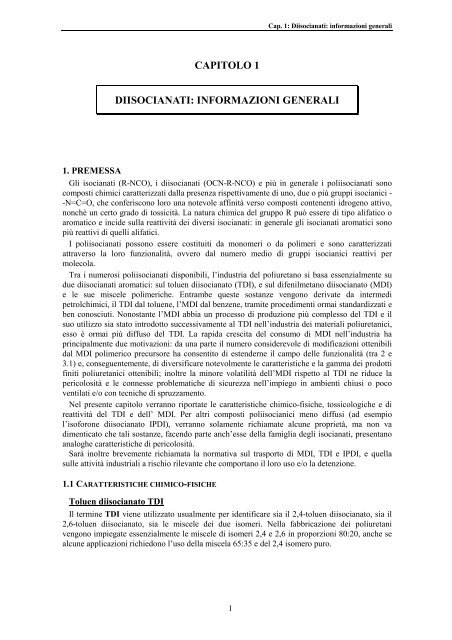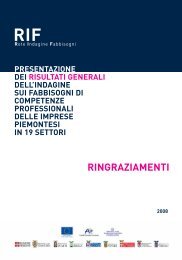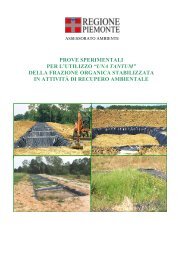capitolo 1 diisocianati - Extranet Regione Piemonte
capitolo 1 diisocianati - Extranet Regione Piemonte
capitolo 1 diisocianati - Extranet Regione Piemonte
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
CAPITOLO 1<br />
1<br />
Cap. 1: Diisocianati: informazioni generali<br />
DIISOCIANATI: INFORMAZIONI GENERALI<br />
1. PREMESSA<br />
Gli isocianati (R-NCO), i <strong>diisocianati</strong> (OCN-R-NCO) e più in generale i poliisocianati sono<br />
composti chimici caratterizzati dalla presenza rispettivamente di uno, due o più gruppi isocianici -<br />
-N=C=O, che conferiscono loro una notevole affinità verso composti contenenti idrogeno attivo,<br />
nonchè un certo grado di tossicità. La natura chimica del gruppo R può essere di tipo alifatico o<br />
aromatico e incide sulla reattività dei diversi isocianati: in generale gli isocianati aromatici sono<br />
più reattivi di quelli alifatici.<br />
I poliisocianati possono essere costituiti da monomeri o da polimeri e sono caratterizzati<br />
attraverso la loro funzionalità, ovvero dal numero medio di gruppi isocianici reattivi per<br />
molecola.<br />
Tra i numerosi poliisocianati disponibili, l’industria del poliuretano si basa essenzialmente su<br />
due <strong>diisocianati</strong> aromatici: sul toluen diisocianato (TDI), e sul difenilmetano diisocianato (MDI)<br />
e le sue miscele polimeriche. Entrambe queste sostanze vengono derivate da intermedi<br />
petrolchimici, il TDI dal toluene, l’MDI dal benzene, tramite procedimenti ormai standardizzati e<br />
ben conosciuti. Nonostante l’MDI abbia un processo di produzione più complesso del TDI e il<br />
suo utilizzo sia stato introdotto successivamente al TDI nell’industria dei materiali poliuretanici,<br />
esso è ormai più diffuso del TDI. La rapida crescita del consumo di MDI nell’industria ha<br />
principalmente due motivazioni: da una parte il numero considerevole di modificazioni ottenibili<br />
dal MDI polimerico precursore ha consentito di estenderne il campo delle funzionalità (tra 2 e<br />
3.1) e, conseguentemente, di diversificare notevolmente le caratteristiche e la gamma dei prodotti<br />
finiti poliuretanici ottenibili; inoltre la minore volatilità dell’MDI rispetto al TDI ne riduce la<br />
pericolosità e le connesse problematiche di sicurezza nell’impiego in ambienti chiusi o poco<br />
ventilati e/o con tecniche di spruzzamento.<br />
Nel presente <strong>capitolo</strong> verranno riportate le caratteristiche chimico-fisiche, tossicologiche e di<br />
reattività del TDI e dell’ MDI. Per altri composti poliisocianici meno diffusi (ad esempio<br />
l’isoforone diisocianato IPDI), verranno solamente richiamate alcune proprietà, ma non va<br />
dimenticato che tali sostanze, facendo parte anch’esse della famiglia degli isocianati, presentano<br />
analoghe caratteristiche di pericolosità.<br />
Sarà inoltre brevemente richiamata la normativa sul trasporto di MDI, TDI e IPDI, e quella<br />
sulle attività industriali a rischio rilevante che comportano il loro uso e/o la detenzione.<br />
1.1 CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE<br />
Toluen diisocianato TDI<br />
Il termine TDI viene utilizzato usualmente per identificare sia il 2,4-toluen diisocianato, sia il<br />
2,6-toluen diisocianato, sia le miscele dei due isomeri. Nella fabbricazione dei poliuretani<br />
vengono impiegate essenzialmente le miscele di isomeri 2,4 e 2,6 in proporzioni 80:20, anche se<br />
alcune applicazioni richiedono l’uso della miscela 65:35 e del 2,4 isomero puro.
I DIISOCIANATI NELLA SINTESI DEI POLIURETANI<br />
CH3<br />
NCO<br />
NCO<br />
2,4 toluen diisocianato. N° CAS: 584-84-9<br />
2<br />
OCN<br />
CH3<br />
NCO<br />
2,6 toluen diisocianato. N° CAS: 91-08-7<br />
Nel seguito con la sigla TDI si indicherà la miscela di 2,4 TDI e 2,6 TDI in proporzione 80:20<br />
(N° CAS: 26471-62-5, N° CEE: 615-006-00-4), sia perchè questa particolare miscela rappresenta<br />
più del 95% del TDI utilizzato dall’industria, sia perchè le principali proprietà non differiscono in<br />
modo significativo al variare della composizione.<br />
Nelle Tabelle 1.1 e 1.2 sono riportate le principali caratteristiche chimico-fisiche del TDI<br />
secondo le fonti più accreditate [riff. 1,4,5].<br />
Tab. 1.1. Proprietà chimico-fisiche di TDI<br />
Proprietà Rapporto isomeri 2,4/2,6 di TDI<br />
100/0 80/20 65/35<br />
Stato fisico a Tambiente liquido incolore o leggermente colorato in giallo pallido<br />
Odore pungente<br />
Miscibilità alcol, benzolo, diglicolmonometiletere, etere, kerosene,<br />
acetone, tetracloruro di carbonio, clorobenzolo<br />
Peso molecolare 174 u.m.a.<br />
Densità del liquido 1.22 g/cm3 a 25°C<br />
Densità relativa dei vapori (aria=1) 6<br />
Densità relativa (aria=1)<br />
1.000025 a 25 °C *<br />
della miscela aria satura di vapori di TDI<br />
1.000152 a 50 °C *<br />
1.003 a 100 °C *<br />
Viscosità 4.3 mPas a 10°C<br />
Tensione di vapore 3.33 Pa a 25°C<br />
Punto di fusione 21.41 °C 14.01 °C 8.51 °C<br />
Punto di ebollizione 251°C a P=1 bar<br />
Temperatura di flash-point 135°C (vaso aperto)<br />
127°C (vaso chiuso)<br />
Temperatura di fire point 143°C (vaso aperto)<br />
Calore specifico 1.565 kJ/kg/°C a 26.5 °C<br />
Limiti di esplosività limite inferiore: 0.9% v/v (T=118°C)<br />
limite superiore: 9.5% v/v (T=150°C)<br />
Temperatura di degradazione termica >250°C<br />
Prodotti di degradazione COx - NOx - HCN - vapori di TDI<br />
Temperatura di autoignizione 620°C<br />
Calore di combustione -23900 kJ/kg<br />
Fumi di combustione COx - NOx - HCN - vapori di TDI<br />
(*)questi valori sono riportati per indicare che, pur essendo il vapore di TDI ben sei volte più pesante<br />
dell’aria, la miscela aria satura di vapori di TDI ha una densità paragonabile a quella della sola aria.
Tab. 1.2 Tensione di vapore TDI in funzione della temperatura<br />
Temperatura Tensione di vapore<br />
3<br />
Cap. 1: Diisocianati: informazioni generali<br />
Concentrazione di vapori saturi in equilibrio con l’aria<br />
(massima concentrazione possibile in un sistema chiuso)<br />
C Pa mm Hg mg/m 3<br />
ppm<br />
-20 0.04 0.00030 3 0.4<br />
0 0.33 0.0025 24 3.3<br />
5 0.55 0.0041 38 5.3<br />
10 0.88 0.0066 60 8.4<br />
15 1.40 0.0105 95 13.0<br />
20 2.10 0.016 140 19.6<br />
25 3.33 0.025 215 30.1<br />
30 5.05 0.038 321 45.0<br />
35 7.45 0.056 466 65.2<br />
40 11.10 0.083 680 95.1<br />
45 16.0 0.12 967 135.4<br />
50 22.6 0.17 1349 188.8<br />
60 45.2 0.34 2616 366.2<br />
70 86.5 0.65 4856 679.8<br />
80 157.0 1.18 8565 1199.1<br />
90 293.0 2.2 15530 2174<br />
100 492 3.7 25419 3559<br />
110 798 6.0 40142 5625<br />
120 1277 9.6 62594 8773<br />
130 2022 15.2 96648 13531<br />
Difenilmetanodiisocianato MDI<br />
Il termine MDI viene usualmente utilizzato per indicare:<br />
L’MDI polimerico o grezzo (PMDI), ossia la miscela di poliisocianati (difenilmetano<br />
diisocianato e polifenilene isocianato) ottenuto dalla reazione di condensazione tra anilina e<br />
formaldeide e dalla successiva fosgenazione della miscela di ammine risultanti;<br />
l’MDI monomero puro (MMDI), ovvero l’MDI ottenuto per distillazione dall’MDI grezzo e<br />
che consiste prevalentemente nell’isomero 4,4’-difenilmetano diisocianato con piccole<br />
quantità dell’isomero 2,4’; l’MMDI è solido fino a 38 C, e quando stoccato liquido sopra i 40<br />
C tende a formare dimeri (vedi anche par. 1.3.2);<br />
l’MDI modificato, ossia quelle modifiche dell’MDI puro che ne permettono lo stoccaggio a<br />
temperatura ambiente allo stato liquido e con ridotta tendenza alla dimerizzazione. L’MDI<br />
modificato può avere caratteristiche e struttura differenti a seconda del metodo di<br />
modificazione effettuato; in generale questi metodi comportano la reazione di una parte<br />
dell’MDI puro con formazione di derivati solubili nel 4,4’ MDI stesso.<br />
OCN<br />
CH 2<br />
NCO<br />
4,4’ difenilmetano diisocianato. N° CAS: 101-68-8<br />
NCO<br />
CH 2<br />
NCO<br />
2,4’ difenilmetano diisocianato. N° CAS: 5873-54-1
I DIISOCIANATI NELLA SINTESI DEI POLIURETANI<br />
Nel seguito MMDI e PMDI saranno distinti ogniqualvolta sarà necessario, mentre dove il<br />
comportamento dei due composti è analogo sarà indicata genericamente la sigla MDI.<br />
Nella Tabella 1.3 sono riportate le principali caratteristiche chimico-fisiche di MMDI e PMDI<br />
secondo le fonti più accreditate [riff. 1,4,6].<br />
Dell’MDI modificato, vista la variabilità delle caratteristiche, non vengono riportate le<br />
proprietà.<br />
Tab. 1.3. Proprietà chimico-fisiche di MDI<br />
PROPRIETA’ MMDI PMDI<br />
Stato fisico a T ambiente solido, bianco-giallo pallido liquido oleoso, colore bruno scuro<br />
Odore leggero odore di muffa muffa<br />
Peso molecolare 250 u.m.a 300500*<br />
Densità del liquido 1.23 g/cm3 a 25°C 1.211.25 g/cm3 a 25°C*<br />
Densità relativa dei vapori 8.5 (aria =1) 8.5 (aria =1)<br />
(aria =1)<br />
Viscosità 4.7 mPas a T=50°C 1002000 mPas*<br />
Tensione di vapore 0.01 Pa a 40C 0.001 Pa a 25C<br />
Punto di fusione 38°C 510°C*<br />
Punto di ebollizione 171°C a P=1.3 3 mbar<br />
210°C a P=7 mbar<br />
314 °C a P=1 bar<br />
(*) grandezza variabile a seconda del produttore<br />
Altri poliisocianati<br />
Le Tab. 1.4 e 1.5 comprendono alcune proprietà dei principali poliisocianati (aromatici ed<br />
alifatici) impiegati come materie prime nella produzione di prodotti poliuretanici; tra questi<br />
ricordiamo l'isoforon diisocianato (IPDI) che possiede caratteristiche analoghe a MDI, fatto salvo<br />
una tensione di vapore leggermente più elevata che lo rende più volatile.<br />
H3C<br />
H3C<br />
H<br />
NCO<br />
H3C CH2 NCO<br />
Isoforon diisocianato. N° CAS: 4098-71-9<br />
4<br />
300°C a P=1bar<br />
(polimerizza a 260C con sviluppo<br />
di CO2)<br />
Temperatura di flash-point 212214°C 210230°C<br />
Temperatura di fire point 232°C 220250°C<br />
Calore specifico 1.38 kJ/kg/C a 40C 1.5 kJ/kg/C tra 10C e 25C<br />
Limiti di esplosività limiti non determinati<br />
Temperatura di degradazione 230°C 230°C<br />
termica<br />
Prodotti di degradazione COx - NOx - HCN - vapori di MDI COx - NOx - HCN - vapori di MDI<br />
Temperatura di autoignizione 600°C >600°C<br />
Fumi di combustione COx - NOx - HCN - vapori di MDI COx - NOx - HCN - vapori di MDI
5<br />
Tab. 1.4: Poliisocianati aromatici [rif. 2]<br />
Nome Sigla Classificazione<br />
(D. M. Sanità<br />
16/2/1993)<br />
1,5-Naftilene<br />
diisocianato<br />
4,4'-Dimetildifenilenediisocianato<br />
NDI Xn R 20-36/37/38-42<br />
Trifenilmetano<br />
triisocianato<br />
Tab. 1.5: Poliisocianati alifatici [rif. 2]<br />
Nome Sigla Classificazione<br />
(D. M. Sanità<br />
16/2/1993)<br />
1,6-Esametilene<br />
diisocianato<br />
Esametilen biureto<br />
triisocianato<br />
4,4'-Dicicloesilmetano<br />
diisocianato<br />
3-Isocianatometil-<br />
3,5,5-Trimetilcicloesil<br />
isocianato<br />
2,2,4- e 2,4,4-<br />
Trimetilesametilene<br />
1,6-diisocianato<br />
Peso<br />
molecolare<br />
[u.m.a.]<br />
T fus.<br />
[°C]<br />
T eb.<br />
[°C]<br />
Densità<br />
liquido<br />
[g/cm3 ]<br />
T f.p.<br />
[°C]<br />
Tensione di<br />
vapore<br />
[Pa]<br />
Stato fisico del prodotto<br />
commerciale<br />
210 128 183 1.425 n.d. 120<br />
solido<br />
(p=13 hPa)<br />
(T=130 C)<br />
TODI N.C. 278.3 70 160170<br />
(p=6.5 hPa)<br />
n.d. 214 n.d. solido<br />
TPI N.C. 367.4 91 n.d. n.d. n.d. n.d. in soluzione al 20% in<br />
CH2Cl2 HDI<br />
Desmodur H<br />
T<br />
R 23-36/37/38-42/43<br />
Peso<br />
molecolare<br />
[u.m.a.]<br />
T fus.<br />
[°C]<br />
T eb.<br />
[°C]<br />
169.19 -67 127<br />
(p=13.3 hPa)<br />
Densità<br />
liquido<br />
[g/cm3 ]<br />
T f.p.<br />
[°C]<br />
Tensione di<br />
vapore<br />
[Pa]<br />
1.046 140 2.7<br />
(T=20°C)<br />
13.3<br />
(T=50C)<br />
Viscosità<br />
[Pas]<br />
Stato fisico del<br />
prodotto<br />
commerciale<br />
n.d. liquido<br />
Desmodur N N.C. 478.60 -19 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. in soluzione al 75%<br />
in etilglicolacetato<br />
HMDI T<br />
262.24 +6071 245 1.029 n.d. n.d. n.d. n.d.<br />
R 23-36/37/38-42/43<br />
(p=72 hPa)<br />
IPDI<br />
Isoforone<br />
diisocianato<br />
T<br />
R 23-36/37/38-42/43<br />
TMDI T<br />
R 23-36/37/38-42<br />
222.3 -60 158<br />
(p=13.3 hPa)<br />
210.3 -80 149<br />
(p=13.3 hPa)<br />
N.C. : sostanza non classificata secondo il D.M. Sanità 16/2/1993 n.d. : dato non disponibile<br />
1.062 142145 0.05<br />
(T= 20°C)<br />
1.2<br />
(T= 53°C)<br />
1.011 148155 0.12<br />
(T=20°C)<br />
2.7<br />
(T= 50°C)<br />
15<br />
(T=20°C)<br />
5<br />
(T=20°C)<br />
liquido incolore<br />
liquido incolore
I DIISOCIANATI NELLA SINTESI DEI POLIURETANI<br />
In Fig. 1.1, è rappresentato l'andamento della tensione di vapore dei tre principali <strong>diisocianati</strong><br />
(TDI, MDI, IPDI) con la temperatura: ricordando che la tensione di vapore è direttamente<br />
proporzionale alla concentrazione dei vapori in equilibrio con l’aria e alla velocità di<br />
evaporazione della sostanza, risulta evidente la maggiore volatilità del TDI rispetto alle altre<br />
sostanze.<br />
Tensione di vapore [Pa]<br />
10000<br />
1000<br />
100<br />
10<br />
1<br />
0,1<br />
IPDI<br />
0,01<br />
25 50 75 100 125 150 175<br />
Temperatura [°C]<br />
1.2 TOSSICOLOGIA [riff. 8,3]<br />
Gli effetti degli isocianati sull’organismo umano sono dovuti in primo luogo all’interazione con<br />
le mucose, verso cui presentano azione fortemente irritante; l’esposizione ai vapori provoca una<br />
reazione rapida degli isocianati con le proteine dei tessuti del tratto respiratorio, tanto veloce e<br />
violenta che, nei casi estremi, può portare alla necrosi immediata. Il danno diretto ai tessuti,<br />
inoltre, crea condizioni favorenti infezioni batteriche e, soprattutto, può formare apteni capaci di<br />
provocare la sensibilizzazione di una proporzione più o meno elevata degli esposti. Può, inoltre,<br />
causare direttamente la liberazione dei mediatori chimici delle reazioni infiammatorie ed<br />
allergiche.<br />
Da un punto di vista strettamente clinico, i meccanismi sopra illustrati possono portare ad<br />
effetti immediati oppure ritardati, anche in funzione dell’intensità dell’esposizione.<br />
Esposizioni acute a concentrazioni elevate causano una netta prevalenza del danno diretto ai<br />
tessuti, con la possibilità di edema polmonare o di polmonite chimica, insorgenti<br />
immediatamente, o al massimo entro poche ore dall’esposizione, e rapidamente letali.<br />
Conseguenze di questo tipo sono estremamente rare, poiché quasi tutti gli isocianati di<br />
importanza commerciale sono sostanze dotate di volatilità bassissima a temperatura e pressione<br />
ambiente; solo condizioni di incidente particolare possono disperderli nelle concentrazioni<br />
richieste per questi effetti. Resta il fatto che uno degli incidenti industriali più drammatici mai<br />
registrati, quello di Bhopal, è stato dovuto alla emissione accidentale di una nube di metilisocianato<br />
1 e che le conseguenze per la popolazione colpita derivarono dall’azione irritante<br />
diretta sulle vie aeree e sulla cornea.<br />
1 Si tratta in effetti dell’isocianato a più basso peso molecolare e a più elevata volatilità.<br />
6<br />
TDI<br />
MDI<br />
Fig. 1.1: Tensione di vapore dei principali isocianati [rif. 2]
7<br />
Cap. 1: Diisocianati: informazioni generali<br />
Esposizioni a basse concentrazioni portano invece alla sensibilizzazione dei tessuti colpiti, che<br />
può tradursi in asma bronchiale o, molto più raramente, in alveolite allergica estrinseca. La<br />
prevalenza di asma tra gli esposti non è mai stata studiata approfonditamente. Sono rarissimi gli<br />
studi che hanno impiegato test diagnostici standardizzati per determinarla, e sono in genere studi<br />
trasversali, soggetti pertanto al vizio di selezione della popolazione in studio: due studi hanno<br />
riportato prevalenze del 10% circa, mentre una survey del NIOSH ha indicato prevalenze<br />
oscillanti dal 5% al 20%, a seconda del settore. E’ difficile trarre da questi dati indicazioni utili a<br />
stimare la concentrazione attesa di sensibilizzati, anche perché non è stato risolto il dubbio se sia<br />
in gioco più spesso un meccanismo di tipo allergico, oppure di tipo irritativo-farmacologico.<br />
Esistono sicuramente soggetti con documentata sensibilizzazione allergica Ig-E mediata,<br />
sviluppanti accessi di asma bronchiale entro pochi minuti dall’inizio dell’esposizione. Esistono<br />
altresì casi documentati di soggetti con accessi di asma bronchiale insorgenti solo dopo una<br />
latenza dall’inizio dell’esposizione, con un andamento di tipo ritardato o semi-ritardato; in questi<br />
casi può essere presente una reazione epicutanea agli isocianati, ma: (i) la sua presenza non<br />
dimostra che l’allergia sia il meccanismo effettivamente in causa nello scatenamento degli accessi<br />
asmatici, (ii) la sua assenza non dimostra tantomeno il contrario. E’ crescente la convinzione che<br />
il meccanismo più spesso implicato nella genesi delle sensibilizzazione agli isocianati non sia di<br />
tipo allergico, ma di tipo irritativo-farmacologico, e in particolare dose-dipendente: a<br />
concentrazione crescente si sensibilizza una proporzione crescente degli esposti, mentre, a parità<br />
di concentrazione, la proporzione di esposti sensibilizzati è proporzionale alla durata<br />
dell’esposizione. In ogni caso, una volta che la sensibilizzazione si è verificata, la risposta<br />
accessionale si verifica anche in presenza di bassissime concentrazioni (dell’ordine di 1 ppb).<br />
Toluen diisocianatoTDI<br />
I limiti di esposizione professionale indicati dalla ACGIH sono:<br />
TLV-STEL e TLV-C: 0.02 ppm (0.14 mg/m 3 ),<br />
TLV-TWA: 0.005 ppm (0.036 mg/m 3 );<br />
IDLH: 2.5 ppm (17.5 mg/m 3 ).<br />
In effetti è correntemente riportato che a concentrazioni pari a 0.05 ppm sono avvertibili i primi<br />
segni di disagio, mentre a partire da 0.5 ppm si manifestano effetti acuti sulle vie aeree di gravità<br />
tale da richiedere l’ospedalizzazione delle persone colpite; a partire da 10 ppm si hanno effetti<br />
letali acuti. La soglia olfattiva varia da persona a persona, da un minimo di 0.05 ppm fino a 0.4<br />
ppm, pertanto può essere sensibilimente più elevata della soglia di tossicità per via aerea.<br />
Si ricorda che il TDI (vedi Tab. 1.2) ha una tensione di vapore tale per cui, a temperatura<br />
ambiente, la concentrazione dei vapori saturi in equilibrio con l’aria è pari a 30 ppm e quindi<br />
decisamente superiore ai valori di TLV e all’IDLH.<br />
Cancerogenicità: Si riportano le conclusioni della IARC “Vi è sufficiente evidenza per la<br />
cancerogenicità del toluen diisocianato nell’animale da esperimento. Vi è inadeguata evidenza<br />
per la cancerogenicità del toluen diisocianato nell’uomo.” (per la rassegna completa si veda il<br />
Volume 39 delle Monografie IARC). Attualmente il TDI è classificato cancerogeno 2B dalla<br />
IARC la sigla significando che l’agente è cancerogeno per l’animale da esperimento, ma che non<br />
sono disponibili dati epidemiologici adatti a valutare direttamente i suoi effetti a lungo termine su<br />
esseri umani. E’ possibile solamente l’estrapolazione dall’animale all’uomo, e per quanto la<br />
legittimità di questa operazione sia frequentemente discussa, l’indicazione della IARC è: (i) che<br />
l’estrapolazione sia scientificamente accettabile su un piano qualitativo, in mancanza di<br />
conoscenze dirette, (ii) che tutti gli agenti cancerogeni per l’animale da esperimento debbano<br />
essere trattati a priori come cancerogeni per l’uomo.<br />
La regolamentazione CEE della classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e<br />
dei preparati, attribuisce al TDI la classificazione “tossico”.
I DIISOCIANATI NELLA SINTESI DEI POLIURETANI<br />
Difenilmetano diisocianato MDI.<br />
I limiti di esposizione professionale indicati dalla ACGIH sono:<br />
TLV-STEL e TLV-C: 0.02 ppm (0.2 mg/m 3 ),<br />
TLV-TWA: 0.005 ppm (0.055 mg/m 3 );<br />
IDLH: 10 ppm (100 mg/m 3 ).<br />
La regolamentazione CEE attribuisce all’MDI la classificazione nocivo per inalazione, irritante<br />
per gli occhi, per le vie respiratorie e per la pelle.<br />
La bassa volatilità ne riduce la pericolosità in rapporto al TDI; il rischio più elevato connesso<br />
con l'utilizzo di MDI consiste nell'inalazione di aerosol dovuti alle tecniche di utilizzo che<br />
implicano spruzzamento.<br />
Isoforon diisocianato IPDI<br />
I limiti di esposizione professionale indicati dalla ACGIH sono:<br />
TLV-STEL e TLV-C: 0.02 ppm (0.18 mg/m 3 ),<br />
TLV-TWA: 0.005 ppm (0.045 mg/m 3 );<br />
La regolamentazione CEE attribuisce all’IPDI la classificazione “tossico”, cioè alla stregua del<br />
TDI e non dell’MDI, a causa della sua volatilità.<br />
Da un punto di vista strettamente tossicologico, a parità di concentrazione raggiunta, gli effetti<br />
dell’IPDI sono sovrapponibili a quelli degli altri isocianati: irritazione per la cute e per le mucose,<br />
soprattutto oculari e delle vie respiratorie, sensibilizzazione bronchiale e cutanea.<br />
1.3 REATTIVITÀ DEGLI ISOCIANATI [riff. 1,2,3,7]<br />
1.3.1 Reazioni dei gruppi isocianici con composti contenenti idrogeno attivo<br />
La principale caratteristica di tutti gli isocianati è l'alto grado di reattività del gruppo isocianico<br />
-NCO con i gruppi contenenti idrogeno attivo con cui formano composti uretanici stabili<br />
attraverso reazioni esotermiche.<br />
Tra i vari isocianati, sicuramente il più reattivo è il TDI ed in particolare il 2,4-TDI, che<br />
presenta reattività superiore a quella del suo 2,6-isomero.<br />
L'ordine di reattività dei composti contenenti idrogeno attivo con l'isocianato aromatico è il<br />
seguente:<br />
AMMINA ALIFATICA > AMMINA AROMATICA > OSSIDRILI PRIMARI > OSSIDRILI<br />
SECONDARI > ACQUA > ACIDO CARBOSSILICO = UREA > URETANO<br />
L'utilizzo di catalizzatori, descritto nel seguito, può sovvertire anche profondamente la<br />
sequenza di reattività indicata.<br />
1.3.1.1 Reazioni con gruppi ossidrilici<br />
La reazione tra un gruppo isocianico e un gruppo ossidrilico è alla base della sintesi dei<br />
poliuretani ed è una semplice reazione di addizione con spostamento di un atomo di idrogeno, il<br />
prodotto della reazione è un uretano (carbammato):<br />
R NCO + R' OH R N<br />
isocianato ossidrile<br />
8<br />
C OR'<br />
H O<br />
uretano (carbammato)<br />
La reazione è esotermica con H -105 kJ/-NCO e Energia di attivazione 42 kJ/moli.<br />
Con gli isocianati i gruppi ossidrilici primari reagiscono più velocemente di quelli secondari, i<br />
fenoli e i gruppi ossidrilici terziari reagiscono ancora più lentamente di quelli secondari.<br />
Le reazioni sono catalizzate da composti organometallici o da ammine terziarie.<br />
Nell’industria dei poliuretani, vengono utilizzati dei composti con più gruppi ossidrilici,<br />
identificati genericamente come polioli.
9<br />
Cap. 1: Diisocianati: informazioni generali<br />
1.3.1.2 Reazioni con gruppi amminici<br />
La reazione tra gruppi isocianici e gruppi amminici porta alla formazione di gruppi urea<br />
sostituiti:<br />
R N C O + R’ NH R N C N R’<br />
isocianato ammina<br />
2<br />
H<br />
O<br />
H<br />
urea disostituita<br />
La reazione è esotermica (la reazione tra fenilisocianato e anilina, C6H5NH2, ha H -140<br />
kJ/gruppo -NCO e può essere sufficiente ad innescare eventuale materiale combustibile presente<br />
nella zona e l’isocianato stesso).<br />
La velocità di reazione aumenta con la basicità delle ammine, le ammine alifatiche reagiscono<br />
più velocemente di quelle aromatiche. La reazione degli isocianati con le ammine primarie, a<br />
temperatura ambiente e senza catalizzatori, è circa 100 1000 volte più veloce di quella con i<br />
gruppi ossidrilici o con l’acqua; non richiede catalizzatori in quanto viene catalizzata dagli stessi<br />
prodotti di reazione (autocatalisi).<br />
Nell’industria dei poliuretani le diammine vengono utilizzate come estensori di catena e come<br />
agenti indurenti: l’effetto delle diammine è infatti l’aumento di reattività della miscela di<br />
reazione, inoltre i segmenti di poliurea che si formano nel polimero ne aumentano il potenziale di<br />
reticolazione.<br />
Le ammine terziarie, poichè non contengono atomi di idrogeno attivo, non reagiscono con gli<br />
isocianati, ma sono potenti catalizzatori sia delle reazioni del gruppo isocianico con l’acqua sia di<br />
quelle degli isocianati con i gruppi ossidrilici (l’effetto catalitico è dovuto alla formazione con i<br />
gruppi isocianici di complessi che reagiscono più facilmente con composti con atomi di idrogeno<br />
attivo).<br />
1.3.1.3 Reazioni con l’acqua<br />
A causa della scarsa solubilità, gli isocianati reagiscono piuttosto lentamente in acqua in<br />
assenza di catalisi ed a temperature inferiori a 50°C; con l’aumento della temperatura la reazione<br />
diventa più rapida fino ad assumere caratteristiche violente.<br />
Con l'acqua, gli isocianati reagiscono secondo i due meccanismi successivi schematizzati in<br />
seguito:<br />
1)<br />
2)<br />
R N C O +H2O<br />
R<br />
isocianato acido carbammico ammina<br />
R N C O + R NH R N<br />
isocianato ammina<br />
2<br />
H<br />
N<br />
H<br />
OH<br />
C<br />
O<br />
C<br />
O<br />
N<br />
H<br />
urea disostituita<br />
R<br />
R<br />
NH<br />
2 +CO2<br />
Il primo stadio (reazione 1) passa attraverso la sintesi di acidi carbammici instabili e porta alla<br />
formazione di ammine ed anidride carbonica. Tale reazione, esotermica, può essere catalizzata da<br />
acidi, basi, ammine terziarie e composti organometallici (contenenti stagno); si osserva che in<br />
caso di competizione ed in assenza di catalisi, l'attacco di un ossidrile alcolico risulta<br />
cineticamente favorito rispetto a quello dell'acqua, probabilmente a causa di effetti<br />
iperconiugativi. Questo risulta vero anche per i fenoli, per i quali vanno comunque considerati gli<br />
ingombri sterici che possono sfavorire la reazione.
I DIISOCIANATI NELLA SINTESI DEI POLIURETANI<br />
In presenza di un eccesso di isocianato, l'idrolisi (reazione 1) è seguita dalla rapida reazione<br />
dell'ammina con il gruppo isocianico appartenente ad un'altra molecola (reazione 2): si producono<br />
uree insolubili variamente sostituite.<br />
La resa sperimentale della reazione complessiva degli isocianati con l’acqua è del 20% in<br />
ammina e dell'80% in urea.<br />
Nella produzione delle schiume poliuretaniche, l’acqua viene utilizzata come “agente<br />
espandente”: si sfrutta la CO2 che si sviluppa nella reazione acqua isocianato come gas<br />
rigonfiante della struttura a celle delle schiume espanse.<br />
La reattività nei confronti dell'acqua può portare a conseguenze pericolose se il contatto<br />
avviene in contenitori chiusi, a causa dell'aumento di pressione dovuto alla produzione di CO2:<br />
l'esotermia di questa reazione (per il fenilisocianato: H=-94.5 kJ/mol), inoltre, può causare una<br />
evaporazione accentuata degli isocianati più volatili come il TDI.<br />
Più frequentemente si possono avere problemi di intasamento ed incrostazioni a causa della<br />
cristallizzazione delle uree derivanti dalla reazione con l’umidità dell’aria.<br />
1.3.1.4 Reazioni con gruppi carbossilici<br />
La reazione di un gruppo isocianico con un gruppo carbossilico è piuttosto lenta, esotermica e<br />
avviene con sviluppo di gas :<br />
R1 NCO + R2 COOH R2 + R1 NH CO CO2<br />
isocianato ac. carbossilico ammide<br />
Cineticamente, in mezzo apolare, l'addizione di un acido carbossilico al gruppo isocianico è<br />
sfavorita rispetto all'addizione di alcol e di acqua.<br />
La reazione è catalizzata da ammine terziarie, alcali e composti organometallici.<br />
Nell’industria questa reazione può avvenire nel caso che residui acidi o impurezze entrino in<br />
contatto con gli isocianati.<br />
In presenza di eccesso di isocianati l’ammide, prodotta dalla reazione tra isocianato e acido<br />
carbossilico, reagisce portando alla formazione di acilurea:<br />
NH<br />
CO<br />
R2 + R1 R3 NCO R1 N CO R2<br />
ammide isocianato acilurea<br />
La reazione è ancora più lenta di quella che porta alla formazione di ammidi, poiché il<br />
nucleofilo è meno efficiente degli acidi. L'esotermia è bassa e l'unica conseguenza è il fuori<br />
standard del prodotto.<br />
10<br />
CO<br />
NH<br />
R3
11<br />
Cap. 1: Diisocianati: informazioni generali<br />
1.3.1.5 Reazione con gruppi urea<br />
La reazione tra isocianati e gruppi urea porta alla formazione di gruppi biureto ramificati o<br />
reticolati:<br />
R NH<br />
R NH<br />
C O+R N C O R N<br />
urea isocianato biureto<br />
La reazione, a temperatura ambiente, procede piuttosto lentamente (anche se è più veloce di<br />
quella tra isocianati e gruppi uretano, vedi par. 1.3.1.6). La reazione è catalizzata da composti<br />
organici di Stagno e Zinco e da trietilendiammina<br />
Nella sintesi dei prodotti poliuretanici, poichè l'addizione nucleofila al carbonio centrale<br />
dell'isocianato è sfavorita nella competizione con i nucleofili più potenti quali gli alcoli stessi,<br />
l'acqua o i fenoli, la formazione di biureto è legata all’esaurimento di tali nucleofili più potenti: la<br />
reazione, quindi avviene solamente in caso di difetto di detti composti.<br />
1.3.1.6 Reazione con gruppi uretanici<br />
La reazione tra isocianati e carbammati (uretani) è, come la precedente, una reazione di<br />
reticolazione e porta alla formazione degli allofanati (prodotti usati in chimica organica per il<br />
riconoscimento degli alcoli):<br />
R N C OR' +R N C O R N C N C O<br />
H<br />
O<br />
carbammato (uretano)<br />
isocianato<br />
H<br />
O<br />
C<br />
C<br />
O<br />
O R OR'<br />
allofanato<br />
A temperatura ambiente, la velocità della reazione è molto bassa, e viene aumentata con potenti<br />
catalizzatori (Pb, Co, Zn, o Sn naftenati).<br />
Rispetto alla reazione tra isocianati e urea, la cinetica della reazione isocianato e carbammato è<br />
più lenta e la temperatura di reazione è superiore.<br />
Nella sintesi dei prodotti poliuretanici, la reazione tra isocianati e carbammati, analogamente a<br />
quella tra isocianati e uree, è sfavorita nella competizione con i nucleofili più potenti quali gli<br />
alcoli stessi, l'acqua o i fenoli; la formazione di allofanato è legata, quindi, all’esaurimento di tali<br />
nucleofili più potenti e avviene solamente in caso di difetto di detti composti.<br />
NH<br />
NH<br />
R<br />
R
I DIISOCIANATI NELLA SINTESI DEI POLIURETANI<br />
1.3.2 Polimerizzazione dei gruppi isocianici<br />
Gli isocianati aromatici, per la loro natura chimica, presentano la caratteristica di reagire<br />
esotermicamente formando dimeri (reazioni 1 e 2) e trimeri (reazione 3).<br />
Le varie reazioni che si verificano sono schematizzabili come segue:<br />
1)<br />
2)<br />
3)<br />
2 R N C O R N<br />
isocianato<br />
O<br />
C<br />
C<br />
12<br />
N<br />
O<br />
uretione<br />
2 R N C O<br />
N C N R<br />
isocianato carbodiimmide<br />
3 R N C O<br />
isocianato<br />
R + CO 2<br />
R<br />
O<br />
N<br />
O<br />
C<br />
C N C<br />
R<br />
N<br />
isocianurato<br />
Normalmente, tali fenomeni sono indesiderati in quanto portano ad una diminuzione della<br />
qualità dell’isocianato; si ricorda tuttavia che le reazioni di dimerizzazione e trimerizzazione<br />
vengono anche sfruttate dal punto di vista produttivo in quanto alcuni di questi composti sono<br />
interessanti intermedi nella sintesi di poliuretani.<br />
MMDI dimerizza facilmente anche in fase di stoccaggio secondo la reazione 1: si evidenzia un<br />
aumento della viscosità e della torbidità del prodotto per la formazione di un dimero poco<br />
solubile nel monomero (uretione) con conseguente precipitazione e formazione di sedimento<br />
cristallino.<br />
Questa reazione è reversibile, esotermica con H=-37 kJ/moli di dimero e influenzata<br />
cineticamente dalla temperatura.<br />
Il grafico in Fig. 1.2 descrive l’andamento della velocità di formazione dell’uretione in funzione<br />
della temperatura di stoccaggio: in base a tale andamento si evidenziano gli intervalli di<br />
temperatura consigliati per lo stoccaggio di MMDI.<br />
R<br />
O<br />
R
2<br />
1 1 2<br />
0 5 15 25 35 45 55 65<br />
Temperatura °C<br />
13<br />
Cap. 1: Diisocianati: informazioni generali<br />
0.08<br />
0.06<br />
0.04<br />
0.02<br />
Velocità di formazione<br />
del dimero %/day<br />
Fig. 1.2. Velocità di formazione del dimero in funzione della temperatura di stoccaggio:<br />
1- intervallo di temperatura consigliabile per lo stoccaggio;<br />
2- intervallo non consigliabile.<br />
La velocità di dimerizzazione è bassa per T
I DIISOCIANATI NELLA SINTESI DEI POLIURETANI<br />
Le reazioni di trimerizzazione (reazione 3) portano alla formazione di anelli isocianurati stabili:<br />
si tratta di reazioni irreversibili, esotermiche, che avvengono in presenza di catalisi basica oppure,<br />
in assenza di catalizzatori, in seguito a forte riscaldamento.<br />
Gli anelli isocianurati sono stabili fino a 150-200°C e, in assenza di tracce di catalizzatore e di<br />
ossigeno, conservano la loro stabilità fino a T>500°C.<br />
Queste reazioni vengono comunemente impiegate per aumentare la funzionalità dei <strong>diisocianati</strong><br />
nella produzione di intermedi.<br />
1.3.3 Reazioni con gomma e plastica<br />
Gli isocianati attaccano e infragiliscono in poco tempo molti materiali plastici e tutte le gomme:<br />
questo fenomeno può portare a rotture di contenitori con conseguenti rilasci di prodotto. I tubi di<br />
materiale sintetico idoneo devono essere esternamente rinforzati con materiali opportuni quando<br />
devono essere impiegati in macchine ad alta pressione.<br />
1.4 RIFERIMENTI NORMATIVI<br />
1.4.1 Norme per il trasporto<br />
Per quanto riguarda il trasporto su strada (regolamentato dalle norme ADR-ONU) e su rotaia<br />
(RID-ONU), gli isocianati sono classificati come segue:<br />
classe: 6.1, 19° B (TDI) e 19° C (MDI, IPDI); etichetta: 6.1;<br />
numero di identificazione del rischio: 60;<br />
numero di identificazione della sostanza (UN): 2078 (TDI), 2489 (MDI), 2290 (IPDI);<br />
1.4.2 Classificazione ed etichettatura<br />
Il Decreto Ministeriale 16 febbraio 1993 del Ministero della Sanità (Modificazioni ed<br />
integrazioni ai decreti ministeriali 3 dicembre 1985 e 20 dicembre 1989 sulla classificazione e la<br />
disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle<br />
direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee) elenca tra le<br />
sostanze pericolose sia il TDI che l’MDI. Nelle Tabelle 1.6 e 1.7 vengono riportate<br />
classificazione e etichettatura degli isomeri e delle loro miscele con le indicazioni di pericolo e i<br />
consigli di prudenza, come dal suddetto Decreto.<br />
14
Tabella 1.6<br />
2,4-toluen diisocianato(1), 2,6-toluen diisocianato(2), miscele di (1) e (2)<br />
Classificazione<br />
T; R23 Xi; R36/37/38 Xn; R42<br />
Etichettatura<br />
T<br />
15<br />
Cap. 1: Diisocianati: informazioni generali<br />
Limite di concentrazione (le concentrazioni degli isocianati rappresentano in percentuale il peso del<br />
monomero libero calcolato in riferimento al peso totale del preparato)<br />
Frasi di rischio<br />
C 20% T; R23- 36/37/38-42<br />
2% C 20 % T; R23-42<br />
0.5 % C 2% Xn; R20-42<br />
R : 23-36/37/38-42<br />
S : 23-26-28-38-44<br />
R20: Nocivo per inalazione<br />
R23: Tossico per inalazione<br />
R36/37/38: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle<br />
R42: Può provocare sensibilizzazione per inalazione<br />
Consigli di prudenza<br />
S23: Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli (termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del<br />
produttore)<br />
S26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare<br />
un medico<br />
S28: In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con..... (prodotti idonei<br />
da indicarsi da parte del fabbricante)<br />
S38: In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratore adatto<br />
S44: In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l’etichetta)
I DIISOCIANATI NELLA SINTESI DEI POLIURETANI<br />
Tabella 1.7<br />
4,4’-difenilmetano diisocianato(1), 2,4’-difenilmetano diisocianato(2), 2,2’-difenilmetano<br />
diisocianato(3), miscele di (1), (2) e (3)<br />
4,4’-difenilmetano diisocianato, isomeri e omologhi, miscela di (a) e (b)<br />
OCN<br />
Classificazione<br />
CH 2<br />
(a)<br />
NCO<br />
Xn; R20-42 Xi; R36/37/38<br />
Etichettatura<br />
Xn<br />
16<br />
NCO NCO NCO<br />
CH2 CH2<br />
(b)<br />
n<br />
n=1-4<br />
Limite di concentrazione (le concentrazioni degli isocianati rappresentano in percentuale il peso del<br />
monomero libero calcolato in riferimento al peso totale del preparato)<br />
Frasi di rischio<br />
C 25% Xn; R20- 36/37/38-42<br />
5% C 25 % Xn; R36/37/38-42<br />
1 % C 5% Xn; R42<br />
R : 20-36/37/38-42<br />
S : 26-28-38-45<br />
R20: Nocivo per inalazione<br />
R36/37/38: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle<br />
R42: Può provocare sensibilizzazione per inalazione<br />
Consigli di prudenza<br />
S26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare<br />
un medico<br />
S28: In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con..... (prodotti idonei<br />
da indicarsi da parte del fabbricante)<br />
S38: In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratore adatto<br />
S45: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli<br />
l’etichetta)
17<br />
Cap. 1: Diisocianati: informazioni generali<br />
1.4.3 Attività industriali a rischio di incidente rilevante<br />
Le attività industriali a rischio di incidente rilevante vengono individuate, nel DPR 175/88,<br />
attraverso un complesso meccanismo che intreccia la tipologia degli impianti, le caratteristiche<br />
delle sostanze pericolose usate, trasportate o depositate e le quantità delle sostanze stesse.<br />
Il fabbricante, cioè il responsabile di un’attività industriale come definita dall’art. 1 comma 2<br />
del DPR 175/88, è tenuto ad analizzare i rischi di incidente rilevante e a prendere tutte le misure<br />
di sicurezza atte a prevenire e a limitare le conseguenze sull’uomo e sull’ambiente.<br />
L’adempimento di tale obbligo deve essere dimostrato ogni qualvolta l’autorità competente lo<br />
richieda, e, qualora i quantitativi delle sostanze pericolose usate, trasportate o detenute superino<br />
determinati valori soglia, deve essere documentato attraverso un rapporto di sicurezza, che il<br />
fabbricante deve far pervenire ai soggetti istituzionali di competenza.<br />
I valori soglia dipendono in genere sia dalla tipologia dell’attività industriale, sia dalle<br />
caratteristiche chimico-fisiche, tossicologiche ed ecotossicologiche delle sostanze utilizzate e<br />
sono specificati nel DPR 175/88 e nei successivi decreti di applicazione, di modificazione e di<br />
integrazione (DPCM 31.3.1989: applicazione dell’art. 12 del DPR 175/88, DM 20.5.1991: modificazioni<br />
ed integrazioni del DPR 175/88 in recepimento alla Direttiva CEE 88/610, Legge n. 137 del 19/5/1997:<br />
sanatoria dei Decreti Legge recanti modifiche al DPR 175/88).<br />
I contenuti e le modalità di compilazione del rapporto di sicurezza sono indicati nel DPCM<br />
31.3.1989 e si differenziano a seconda della soglia superata. In particolare:<br />
al superamento della prima soglia il fabbricante è soggetto all’obbligo di “dichiarazione<br />
leggera”, (cioè deve far pervenire all’autorità competente documentazione dell’analisi di sicurezza<br />
secondo le linee guida dell’All.III, <strong>capitolo</strong> 1 del DPCM 31.3.1989, esclusi i paragrafi 1.3.5. e 1.3.6);<br />
al superamento della seconda soglia il fabbricante è soggetto all’obbligo di “dichiarazione<br />
pesante”, (cioè deve far pervenire all’autorità competente documentazione dell’analisi di sicurezza<br />
secondo le linee guida dell’All.III, <strong>capitolo</strong> 1 e <strong>capitolo</strong> 2 del DPCM 31.3.1989);<br />
al superamento della terza soglia il fabbricante è soggetto all’obbligo di “notifica”, (cioè deve<br />
far pervenire all’autorità competente un rapporto di sicurezza compilato secondo le linee guida dell’All.I<br />
del DPCM 31.3.1989).<br />
Per quanto riguarda i <strong>diisocianati</strong>, le soglie quantitative non dipendono dall’attività industriale,<br />
in quanto non sono nominati nell’All. III del DPR 175/88. Nella Tabella 1.8 vengono riportati i<br />
valori soglia per l’uso o la detenzione di MDI, TDI e IPDI (sostanze pure o preparati) nel caso<br />
dette sostanze siano presenti singolarmente nell’attività industriale.<br />
Si ricorda che, nel caso siano presenti più sostante pericolose, esse vanno sommate insieme per<br />
categorie, come specificato nel DM 20/5/91 All.II, parte seconda, a cui si rimanda anche per i<br />
valori soglia relativi alle varie categorie.<br />
Tabella 1.8: Soglie quantitative di MDI, TDI e IPDI ai fini dell’applicazione del DPR 175/88<br />
Sostanza o<br />
preparato Concentrazione* 1a soglia [t]<br />
(dich. leggera)<br />
2 a soglia [t]<br />
(dich. pesante)<br />
3 a soglia [t]<br />
(notifica)<br />
Note<br />
TDI sostanza pura 10 60 100 sostanza n. 28<br />
(All.I DM. 20/5/91)<br />
2% C 100% 10 120 200 sostanza<br />
Tossica<br />
classificata<br />
MDI sostanza pura 20 120 200<br />
(DM. 16/2/93)<br />
sostanza n. 27<br />
(All.I DM. 20/5/91)<br />
IPDI sostanza pura 10 120 200 sostanza<br />
Tossica<br />
classificata<br />
(DM. 16/2/93)<br />
2% C 100% 10 120 200 sostanza<br />
Tossica<br />
classificata<br />
(DM. 16/2/93)<br />
* le concentrazioni degli isocianati rappresentano la percentuale in peso del monomero libero calcolata in<br />
riferimento al peso totale del preparato