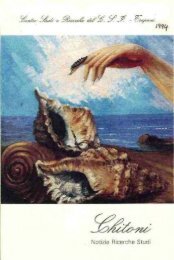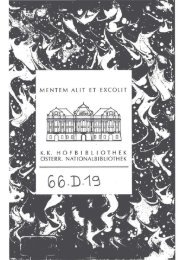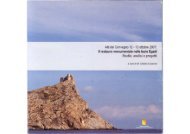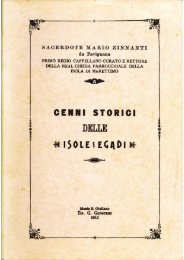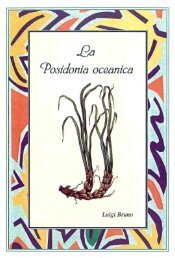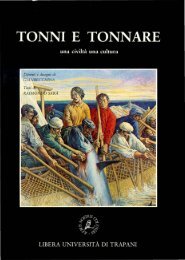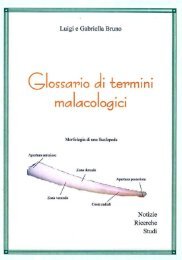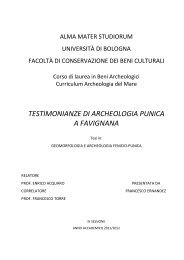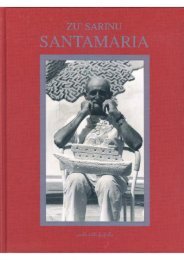Fabio Martini, Domenico Lo Vetro, Silvia Casciarri ... - egadimythos.it
Fabio Martini, Domenico Lo Vetro, Silvia Casciarri ... - egadimythos.it
Fabio Martini, Domenico Lo Vetro, Silvia Casciarri ... - egadimythos.it
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ISTITUTO<br />
ITALIANO DI PREISTORIA<br />
E PROTOSTORIA<br />
ATTI DELLA XLI<br />
RIUNIONE SCIENTIFICA<br />
DAI CICLOPI AGLI ECISTI<br />
SOCIETÀ E TERRITORIO<br />
NELLA SICILIA PREISTORICA<br />
E PROTOSTORICA<br />
San Cipirello (PA), 16-19 novembre 2006<br />
FIRENZE 2012
ENTI PROMOTORI<br />
Ist<strong>it</strong>uto Italiano di Preistoria e Protostoria<br />
Assessorato Regionale dei Beni Culturali Ambientali e P.I.<br />
Comune di San Cipirello<br />
Unione de Comuni Monreale Jetas<br />
Centro Siciliano di Preistoria e Protostoria<br />
Archeoclub di Corleone<br />
COMITATO D’ONORE<br />
A. Butt<strong>it</strong>ta, N. Bonacasa, E. De Miro, S. Lagona, V. La Rosa, G. Rizza, E. Tortorici,<br />
M. Tosi, V. Tusa, G. Voza<br />
CON IL SOSTEGNO DI<br />
Soprintendenza BB CC AA Agrigento<br />
Soprintendenza BB CC AA Caltanissetta<br />
Soprintendenza BB CC AA Catania<br />
Soprintendenza BB CC AA Enna<br />
Soprintendenza BB CC AA Messina<br />
Soprintendenza BB CC AA Palermo<br />
Soprintendenza BB CC AA Ragusa<br />
Soprintendenza BB CC AA Siracusa<br />
Soprintendenza BB CC AA Trapani<br />
Soprintendenza al Museo Nazionale Preistorico Etnografico “L. Pigorini”<br />
Museo Archeologico Regionale, Agrigento<br />
Museo Archeologico Regionale “A. Salinas”, Palermo<br />
Museo Archeologico Regionale “P. Orsi”, Siracusa<br />
Museo “Agostino Pepoli”, Trapani<br />
Museo Archeologico Regionale della Villa del Casale di Piazza Armerina<br />
Museo Archeologico Regionale di Camarina<br />
Museo Archeologico Regionale di Gela<br />
Museo Archeologico Regionale Eoliano “L. Bernabò Brea”<br />
Museo della Ceramica di Caltagirone<br />
Museo di storia naturale e del carretto di Palazzo d’Aumale, Terrasini<br />
Parco Archeologico Regionale di Agrigento<br />
COMITATO SCIENTIFICO<br />
Paleol<strong>it</strong>ico e Mesol<strong>it</strong>ico: M.R. Iovino, F. <strong>Martini</strong><br />
Neol<strong>it</strong>ico: V. Tinè, S. Tusa<br />
Eneol<strong>it</strong>ico: A. Cazzella, D. Cocchi Genik, L. Maniscalco<br />
Età del Bronzo: N. Bruno, M. Cavalier, M.C. Martinelli, F. Nicoletti, E. Procelli, S. Tusa<br />
Età del Ferro: R.M. Albanese Procelli<br />
Interazioni Sicilia - Med<strong>it</strong>erraneo: A.M. Bietti Sestieri, M. Marazzi<br />
Coordinamento: S. Tusa<br />
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA<br />
C. Buccellato, A. Scuderi, A. Vintaloro, E. Viola<br />
REDAZIONE DEGLI ATTI<br />
Enrico Procelli<br />
In copertina: Vaso della cultura di Serrafarlicchio<br />
© Ist<strong>it</strong>uo Italiano di Preistoria e Protostoria, 2012<br />
Via S. Egidio, 21 - 50122 Firenze<br />
tel. 055/2340765 - fax 055/5354821<br />
www.iipp.<strong>it</strong> - e-mail: iipp@iipp.<strong>it</strong>
FABIO MARTINI * - DOMENICO LO VETRO * - SILVIA CASCIARRI * -<br />
ANDRÉ CARLO COLONESE * - ZELIA DI GIUSEPPE * -<br />
ROSSELLA GIGLIO ** - SEBASTIANO TUSA **<br />
Primi risultati della campagna di scavo 2005<br />
a Grotta della Ucceria (Favignana, TP)<br />
IL SITO E LE RICERCHE (D. <strong>Lo</strong> <strong>Vetro</strong>, F. <strong>Martini</strong>)<br />
La grotta si apre sulla parete rocciosa di una rupe calcarea detta “il<br />
Grosso” nei pressi di Punta Faraglione, all’estrem<strong>it</strong>à Nord dell’isola<br />
(quota m 33 slm). Si tratta di un complesso residuale di un’ampia cav<strong>it</strong>à,<br />
in origine articolata in più camere, una delle quali presenta una galleria di<br />
fondo che termina in uno stretto e basso cunicolo (fig. 1). Dopo la prima<br />
segnalazione di G. Dalla Rosa (1870), le ricerche di J. Bovio Marconi<br />
(1952), di A. Malatesta (1957) e di G. Mannino (Bisi 1969) si lim<strong>it</strong>arono a<br />
brevi escursioni e a raccolte di superficie. Il nostro intervento nel 2005 si<br />
inserisce nell’amb<strong>it</strong>o del progetto POR Sicilia 2000-2006 Asse II, Misura<br />
2.0.1. 1 Le nuove ricerche hanno interessato soprattutto il grande ambiente<br />
principale (ambiente B) e il cunicolo di fondo (ambiente D), un saggio<br />
è stato aperto anche in una camera interna (ambiente C). Nell’ambiente<br />
A il piano di calpestio è quasi interamente cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dalla roccia di base.<br />
Come già rilevato dal Dalla Rosa la grotta doveva possedere in origine un<br />
depos<strong>it</strong>o archeologico di circa un metro di spessore, del quale restano<br />
* Dipartimento di Scienze dell’Antich<strong>it</strong>à “G. Pasquali”, Paletnologia, Univers<strong>it</strong>à degli<br />
Studi di Firenze; Museo e Ist<strong>it</strong>uto Fiorentino di Preistoria “P. Graziosi”, Via S. Egidio 21, Firenze;<br />
tel. 055215788; e-mail: fmartini@unifi.<strong>it</strong>.<br />
** Soprintendenza del Mare, Assessorato per i Beni Culturali Ambientali e Pubblica Istruzione<br />
Regione Siciliana, Palazzetto Mirto, Via Lungarini, 9, 90133 Palermo; e-mail:<br />
s.tusa@regione.sicilia.<strong>it</strong>.<br />
*1 L’indagine archeologica è stata realizzata dalla cattedra di Paletnologia del Dipartimento<br />
di Scienze dell’Antich<strong>it</strong>à “G. Pasquali” dell’Univers<strong>it</strong>à degli Studi di Firenze di concerto con il<br />
Museo e Ist<strong>it</strong>uto Fiorentino di Preistoria, su incarico dell’Assessorato regionale per il BB. CC.<br />
AA. e P.I., Area Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Trapani. Ci è grad<strong>it</strong>o ringraziare<br />
il prof. Sebastiano Tusa per averci coinvolto nel progetto e la dott.ssa Rossella Giglio, responsabile<br />
del procedimento al momento delle ricerche.
290 F. MARTINI et alii<br />
tracce a luoghi sulle pareti con molluschi terrestri e marini inglobati in<br />
placche di sedimento concrezionato 2 , riferibile al Paleol<strong>it</strong>ico superiore, al<br />
Mesol<strong>it</strong>ico e al Neol<strong>it</strong>ico. Gli eventi che sono all’origine della demolizione<br />
del depos<strong>it</strong>o originario potrebbero essere dovuti ad uno o verosimilmente<br />
a più ruscellamenti (sifoni) che dal cunicolo di fondo sono fuoriusc<strong>it</strong>i<br />
erodendo un depos<strong>it</strong>o a sabbie rossastre che sopportava la sequenza<br />
sopra detta 3 . Nell’ambiente B e soprattutto nell’ambiente D sono stati risparmiati<br />
lembi di strati concrezionati e lembi osp<strong>it</strong>ati in piccole nicchie<br />
nelle pareti che sono stati oggetto del nostro intervento.<br />
Fig. 1 - Grotta delle Uccerie: pianta della grotta e localizzazione delle trincee di<br />
scavo.<br />
*2 Scrive Dalla Rosa: «… scopersi che tutto il depos<strong>it</strong>o cost<strong>it</strong>uente il prim<strong>it</strong>ivo strato della<br />
grotta era stato levato, e solo ne esisteva una parte all’altezza di circa un metro dal suolo nel<br />
punto estremo di essa. Ve ne erano circa due metri superficiali sostenuti a modo di una tavola<br />
da un sol piede. Con ripetuti colpi potei gran parte infrangerne, ed ottenere così e conchiglie e<br />
ossa, e alcuni denti di animali e selci…».<br />
*3 Questa ricostruzione non esclude l’ipotesi di un successivo intervento ad opera di contadini<br />
locali che in epoca recente avrebbero asportato insieme al letame parte del depos<strong>it</strong>o residuo<br />
per utilizzarlo come concime.
PRIMI RISULTATI DELLA CAMPAGNA DI SCAVO 2005 A GROTTA DELLA UCCERIA 291<br />
La frequentazione della grotta durante la Preistoria e ricostruibile nel<br />
dettaglio mediante la sequenza crono-culturale messa in luce nell’Ambiente<br />
D. La serie stratigrafica giaceva sotto uno strato legato all’impiego<br />
della grotta come ricovero del bestiame sino ad oggi; al di sotto una crosta<br />
calc<strong>it</strong>ica (a) sigillava una massiciata di pietrame di medie dimensioni a<br />
spigoli vivi archeologicamente sterile. Sotto di essa il depos<strong>it</strong>o archeologico<br />
era così articolato:<br />
- strato 1: depos<strong>it</strong>o concrezionato sabbioso argilloso di colore bruno,<br />
con raro scheletro calcareo a spigoli smussati. Neol<strong>it</strong>ico;<br />
- stalagm<strong>it</strong>e b: colata calc<strong>it</strong>ica di esiguo spessore;<br />
- strato 2: depos<strong>it</strong>o concrezionato sabbioso argilloso di colore bruno<br />
scuro; è stato suddiviso in due livelli archeologici, 2A e 2B. Mesol<strong>it</strong>ico;<br />
- strato 3: depos<strong>it</strong>o concrezionato sabbioso argilloso di colore nocciola.<br />
Mesol<strong>it</strong>ico;<br />
- strato 4: depos<strong>it</strong>o concrezionato argilloso sabbioso di colore nocciola<br />
con scheletro calcareo a spigoli smussati; è stato suddiviso in quattro distinti<br />
livelli di frequentazione, 4A, B, C, D. Paleol<strong>it</strong>ico superiore (Epigravettiano<br />
finale);<br />
Sottostante allo strato 4 giaceva uno strato argilloso-limoso di colore<br />
rosso-arancio sterile di evidenze antropiche che rappresenta il tetto di un<br />
depos<strong>it</strong>o a “terre rosse” che si rinviene anche nell’ambiente B dove è stato<br />
indagato in un area di 4 mq all’interno della trincea aperta nell’atrio.<br />
Tale depos<strong>it</strong>o ha rest<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o pochi resti di microfauna e mammalofauna (in<br />
corso di studio).<br />
Alla sequenza descr<strong>it</strong>ta è stato possibile correlare i sondaggi effettuati<br />
in una piccola nicchia prossima la fondo grotta all’interno dello stesso<br />
ambiente D, ma priva di correlazione diretta con la precedente, e in una<br />
seconda nicchia a ridosso della parete Sud dell’ambiente B dove era in<br />
posto solo la porzione basale dello strato epigravettiano. In parete restano<br />
lembi depos<strong>it</strong>o placcato che fu oggetto delle indagini del Dalla Rosa.<br />
ECONOMIA E AMBIENTE (A.C. Colonese, Z. Di Giuseppe)<br />
L’ambiente e lo sfruttamento delle risorse naturali a Grotta delle Uccerie<br />
durante i differenti episodi di occupazione epigravettiana e mesol<strong>it</strong>ica<br />
sono in questa sede desunti dai reperti faunistici. Tuttavia, a causa di fattori<br />
tafonomici, in particolare dovuta all’intensa percolazione di stillicidio,<br />
non è stato possibile ricostruire in dettaglio le dinamiche ambientali<br />
ed culturali sulla base dei reperti stessi. Dal punto di vista economico, sia<br />
negli orizzonti epigravettiani che mesol<strong>it</strong>ici, l’attiv<strong>it</strong>à di caccia, la raccolta
292 F. MARTINI et alii<br />
di molluschi marini e a pesca 4 sono ben rappresentate e cost<strong>it</strong>uiscono, come<br />
in atri giacimenti coevi (<strong>Martini</strong> et alii in questo volume), la base dell’economia<br />
di sussistenza durante tutta la frequentazione della grotta.<br />
<strong>Lo</strong> studio preliminare della composizione faunistica a macromammiferi,<br />
attualmente lim<strong>it</strong>ato ai livelli epigravettiani, ha evidenziato associazioni<br />
simili a quelle rinvenute in s<strong>it</strong>i coevi (<strong>Martini</strong> et alii in questo volume).<br />
Equus hydruntinus, accompagnato da Bos primigenius, con cui condivide<br />
gli stessi hab<strong>it</strong>at aperti a prateria, cost<strong>it</strong>uisce più della metà del campione<br />
osseo indagato. Tali presenze, per il momento, sembrano andare a discap<strong>it</strong>o<br />
dell’associazione faunistica di tipo boschivo cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a da Cervus<br />
elaphus e Sus scrofa.<br />
La raccolta di molluschi marini a scopo alimentare è documentata a<br />
partire dai livelli epigravettiani ma è solo con l’occupazione mesol<strong>it</strong>ica<br />
dello strato 3 che essa è significativamente documentata, per poi ridursi<br />
progressivamente nel corso della deposizione dello strato 2. Tale fenomeno<br />
potrebbe essere legato alla risal<strong>it</strong>a del livello del mare e all’avvicinamento<br />
della linea di costa tra l’Epigravettiano finale e il Mesol<strong>it</strong>ico. La riduzione<br />
della raccolta nello strato 2 potrebbe essere dovuta a differenti<br />
episodi di occupazione della grotta, oltre che a disturbi post-deposizionali<br />
come quelli accennati in precedenza. Le specie raccolte a scopo alimentare<br />
appartengono alla biocenosi delle rocce mesol<strong>it</strong>orali superiori e inferiori,<br />
rappresentate da Trochidae e Patellidae. Osilinus turbinatus è la<br />
specie dominante in tutta la stratigrafia e il suo sfruttamento è attestato in<br />
tutte le stagioni dell’anno, sia nei livelli epigravettiano che mesol<strong>it</strong>ici, suggerendo<br />
in tal modo un occupazione antropica del s<strong>it</strong>o in tutte le stagioni<br />
(Colonese et alii in questo volume).<br />
Come in altri giacimenti paleol<strong>it</strong>ici e mesol<strong>it</strong>ici della Sicilia nord-occidentale<br />
(Colonese in questo volume a, b), nei livelli epigravettiani e mesol<strong>it</strong>ici<br />
di Grotta delle Uccerie sono presenti specie marine di piccola taglia,<br />
non eduli e tipiche delle praterie a Posidonia oceanica (Colonese et alii in<br />
questo volume). La presenza di queste piccole specie potrebbe essere il<br />
risultato dell’introduzione nella grotta, da parte dell’uomo, di piante marine<br />
utilizzate come giacigli, combustibile o per la produzione di manufatti<br />
(es. cordame, reti e ceste). (Vellanoweth 2003)<br />
*4 <strong>Lo</strong> studio dell’<strong>it</strong>tiofauna è attualmente in corso.
PRIMI RISULTATI DELLA CAMPAGNA DI SCAVO 2005 A GROTTA DELLA UCCERIA 293<br />
LE INDUSTRIE LITICHE DELL’EPIGRAVETTIANO E DEL MESOLITICO<br />
(D. <strong>Lo</strong> <strong>Vetro</strong>, F. <strong>Martini</strong>)<br />
I livelli epigravettiani (strato 4)<br />
Per questo studio viene presa come riferimento la sequenza del fondo<br />
grotta, accorpando i materiali degli altri due settori che sono con buona<br />
approssimazione riferibili stratigraficamente agli stessi orizzonti. Nel fondo<br />
grotta lo strato 4 comprende una serie di esigui livelli (da 4A a 4D;<br />
non è stato possibile definire se si tratta o meno di paleosuperfici con<br />
l’esclusione di 4B che conteneva una struttura di combustione) per i quali<br />
sono state ottenute tre misure radiometriche:<br />
4C: 12.958±90 BP (cal 13.750-13.000 a.C.) 5<br />
4D: 13.191±120 BP (cal 14.200-13.200 a.C.)<br />
4E: 12.933±75 BP (cal. 13.700-13.000 a.C.)<br />
I quattro livelli sono stati accorpati in due orizzonti uno superiore (4A,<br />
B, C) e uno inferiore (4D, E) coerentemente con le indicazioni provenienti<br />
dallo studio delle industrie l<strong>it</strong>iche.<br />
<strong>Lo</strong> scavo ha rest<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o alcune centinaia di reperti l<strong>it</strong>ici tra strumenti r<strong>it</strong>occati<br />
(fig. 2), manufatti non r<strong>it</strong>occati, nuclei e scarti di lavorazione. Sotto<br />
l’aspetto tecnologico i due orizzonti si presentano omogenei; i dati preliminari<br />
attestano per entrambi i casi una scheggiatura, abbastanza standardizzata<br />
e poco elaborata, volta alla produzione di supporti laminari<br />
(lame più o meno regolari, sovente larghe, e lamelle) con sfruttamento<br />
prevalente di nuclei prismatici ad un piano di percussione (raramente i<br />
piani sono due) talvolta preparato; è attestata la presenza di nuclei subpiramidali.<br />
La selce è verosimilmente di provenienza locale rappresentata<br />
da diverse varietà, tutte di ottima qual<strong>it</strong>à 6 . È documentato sia lo sfruttamento<br />
di ciottoli sia di noduli e anche probabilmente di blocchi di distacco<br />
da liste. Si nota una differenziazione tra i supporti utilizzati per gli<br />
strumenti comuni, che sono larghi e molto larghi, anche poco regolari,<br />
usati soprattutto per grattatoi e raschiatoi lunghi (in qualche caso sono<br />
utilizzati anche schegge e lame di primo déb<strong>it</strong>age), e quelli destinati a<br />
confezionare i dorsi e alcune troncature per i quali si registra l’utilizzo di<br />
lamelle anche strette a morfologia più regolare e simmetrica, verosimilmente<br />
ottenute durante la fase terminale di sfruttamento dei nuclei. La<br />
*5 Quando non espressamente indicato tutte le date menzionate nel testo sono state calibrate<br />
con deviazione a 2s utilizzando il software OxCal ver. 3.10 basato sui dati atmosferici di<br />
Reimer et alii 2004.<br />
*6 La presenza di selce sulla Montagna Grossa è ben documentata in letteratura (Agnesi et<br />
alii 1993; Malatesta 1957; Carta geologica d’Italia, foglio 256).
294 F. MARTINI et alii<br />
Fig. 2 - Grotta delle Uccerie, industria l<strong>it</strong>ica dello strato 4: 1-6) grattatoi frontali;<br />
7-11) raschiatoi lunghi; 12) troncatura; 13) becco; 14) punta a dorso;<br />
15, 16) frammenti di dorso; 17, 18) geometrici (dis. L. Baglioni).<br />
tecnica del microbulino è documentata da alcuni residui che concernono<br />
sia supporti laminari probabilmente microl<strong>it</strong>ici e stretti sia lame larghe di<br />
taglia maggiore.<br />
Per quanto riguarda gli strumenti l’assetto tipometrico, considerato<br />
nell’insieme dei due orizzonti, è caratterizzato da pezzi di piccole dimensioni<br />
(54,1%) segu<strong>it</strong>i da quelli di medie dimensioni (28,3%), microl<strong>it</strong>i
PRIMI RISULTATI DELLA CAMPAGNA DI SCAVO 2005 A GROTTA DELLA UCCERIA 295<br />
(15,3%) e molto rari ipermicrol<strong>it</strong>i (2,4%). Nel dettaglio, nel passaggio<br />
dall’orizzonte inferiore al superiore si coglie un aumento del microl<strong>it</strong>ismo<br />
in generale (microl<strong>it</strong>i sommati agli ipermicrol<strong>it</strong>i: da 12,1% a 23,2%) a<br />
scap<strong>it</strong>o delle medie dimensioni. L’indice di laminar<strong>it</strong>à complessivo degli<br />
strumenti è alto soprattutto nello strato inferiore (circa 70%), con una<br />
flessione al passaggio all’orizzonte superiore 7 .<br />
L’industria l<strong>it</strong>ica dell’orizzonte inferiore comprende 136 tipi primari.<br />
Dal punto di vista strutturale i caratteri principali sono: il primo rango<br />
del Substrato (42,6%) e al suo interno l’incidenza dei raschiatoi lunghi<br />
che sono dominanti (le modal<strong>it</strong>à di scavo con martello elettrico hanno<br />
portato alla frammentazione di molti manufatti) e di raschiatoi corti e<br />
denticolati molto meno importanti; lo sviluppo degli Erti differenziati, soprattutto<br />
ad opera di troncature e secondariamente di dorsi, mentre i<br />
geometrici sono appena rappresentati; lo sviluppo di grattatoi, soprattutto<br />
lunghi con buona presenza di forme carenate.<br />
I raschiatoi lunghi, che cost<strong>it</strong>uiscono il gruppo strutturalmente più forte,<br />
sono otttenuti su supporti per lo più poco regolari e tendenzialmente<br />
slanciati, alcuni sono larghi e al lim<strong>it</strong>e con le schegge laminari. La lavorazione<br />
è sia periferica sia profonda generalmente parziale; tra i r<strong>it</strong>occhi<br />
profondi si registra una buona percentuale di pezzi a lavorazione accurata,<br />
totale, talora bilaterale. Da segnalare la presenza di punte a lavorazione<br />
accurata e invadente, ben simmetriche anche in associazione con grattatoi.<br />
Le troncature sono soprattutto profonde, sia normali (5,2%) sia<br />
oblique (4,4%), ben sviluppate anche quelle marginali (7,4%). Sono più<br />
spesso accurate, profonde e totali. All’interno di questa lavorazione<br />
profonda va ricordato anche l’analogo stile dei becchi. Le armature comprendono<br />
essenzialmente strumenti a dorso (14,0%), quasi esclusivamente<br />
punte a dorso (5,9%) (molti sono i frammenti indeterminabili) soprattutto<br />
PD4. Si tratta di elementi di dimensioni piccole e più raramente microl<strong>it</strong>iche,<br />
sia larghi sia stretti, sempre slanciati con alto indice di allungamento.<br />
Il r<strong>it</strong>occo e tendenzialmente subrettilineo o a convess<strong>it</strong>à poco accentuata.<br />
L’unico geometrico è un romboide di grossa taglia, ricavato da<br />
frammento di grande lama a lati paralleli, (doppio piquant-triedre) con<br />
due troncature oblique ben marcate. Il gruppo dei grattatoi cost<strong>it</strong>uisce<br />
uno degli elementi distintivi di questa industria; sono caratterizzati da<br />
un’ampia variabil<strong>it</strong>à a livello di tipo secondario, sia in relazione al supporto<br />
(simmetria, laminar<strong>it</strong>à etc.), sia alla morfologia del fronte, sia anco-<br />
*7 Queste osservazioni in senso evolutivo del assetto tipometrico sono da considerarsi indicative<br />
a causa del basso numero di strumenti soprattutto nell’orizzonte superiore.
296 F. MARTINI et alii<br />
ra all’importanza del r<strong>it</strong>occo latrale. Si tratta di forme lunghe ampiamente<br />
prevalenti sulle corte (Gfl/Gfc 8,5), anche su supporto laminare slanciato<br />
tendenzialmente regolari, con fronte sempre accurato, molto convesso o<br />
poco convesso, in asse, i margini sono rettilinei o sinuosi, talora convergenti<br />
alla base, alcuni pezzi carenati, riprendono i caratteri generali di<br />
quelli piatti, non mancano i pezzi composti e quelli multipli. I bulini, di<br />
scarso peso strutturale, vanno ricordati in quanto si allineano con lo stile<br />
generale dell’industria legato alle dimensioni considerevoli, all’utilizzo di<br />
supporti su lama; la lavorazione è più spesso poco elaborata a stacchi unici.<br />
La tecnica del microbulino è documentata da alcuni residui che concernono<br />
sia supporti laminari probabilmente microl<strong>it</strong>ici e stretti sia lame<br />
di taglia maggiore larghe.<br />
L’industria l<strong>it</strong>ica r<strong>it</strong>occata dell’orizzonte superiore comprende 67 tipi<br />
primari, con un assetto che sembrerebbe non molto diverso da quello<br />
dell’orizzonte inferiore. Questa possibile omogene<strong>it</strong>à quant<strong>it</strong>ativa pare<br />
convalidata anche dai caratteri stilistici dei singoli gruppi anche se si ravvisano<br />
alcuni elementi che insieme al dato tipometrico sopra descr<strong>it</strong>to potrebbero<br />
testimoniare una certa dinamica evolutiva. Registriamo un aumento<br />
dei grattatoi corti che tuttavia restano minor<strong>it</strong>ari rispetto ai lunghi,<br />
una degressione dei raschiatoi lunghi e dei denticolati e degli strumenti a<br />
dorso. Tra i reperti più significativi si segnala, un geometrico (Gm5 tendente<br />
a Gm8), microl<strong>it</strong>ico, a lavorazione molto marcata, su porzione di<br />
lama larga e spessa che trova confronti all’Acqua F<strong>it</strong>usa.<br />
I due orizzonti di Uccerie, sostanzialmente omogenei, rappresentano<br />
un’importante nuova acquisizione nell’amb<strong>it</strong>o dell’Epigravettiano finale<br />
siciliano in quanto portano a definire la presenza sull’isola attorno a<br />
13.000 anni orsono (non calibrata) di uno stadio industriale ben defin<strong>it</strong>o,<br />
organico, con aspetti peculiari che lo differenziano da altri stadi più recenti<br />
documentati sia nella Sicilia occidentale sia nella parte orientale<br />
(<strong>Martini</strong> et alii 2007; <strong>Lo</strong> <strong>Vetro</strong> e <strong>Martini</strong> in questo volume).<br />
Sono alcuni caratteri sia quant<strong>it</strong>ativi sia stilistici a creare una fisionomia<br />
specifica: a livello strutturale il Substrato domina sugli Erti differenziati; di<br />
rilievo sono lo scarso sviluppo dei dorsi e la presenza irrilevante di geometrici<br />
rappresentati da forme trapezoidali e romboidali; le punte a dorso sono<br />
microl<strong>it</strong>iche e piccole, su supporto tendenzialmente lamellare e slanciato;<br />
la convess<strong>it</strong>à del dorso è poco accentuata; lo sviluppo dei grattatoi, con<br />
forme lunghe prevalenti, variabili a livello di tipi secondari, e la presenza<br />
significativa di grattatoi spessi; l’alto valore delle lame; la lavorazione accurata<br />
e invadente, che concerne quasi tutti i gruppi tipologici, soprattutto<br />
grattatoi, lame, troncature, punte; l’alta laminar<strong>it</strong>à complessiva che coinvolge<br />
tutti i gruppi tipologici, anche con elementi molto slanciati.
PRIMI RISULTATI DELLA CAMPAGNA DI SCAVO 2005 A GROTTA DELLA UCCERIA 297<br />
I livelli mesol<strong>it</strong>ici (strati 2 e 3)<br />
Gli strati 2 e 3 testimoniano una presenza umana in grotta durante il<br />
Mesol<strong>it</strong>ico; questa fase è documentata in base alle due misure radiometriche,<br />
in quanto il materiale è estremamente scarso.<br />
Come per la fase epigravettiana anche nei livelli mesol<strong>it</strong>ici è attestato<br />
l’utilizzo di diverse varietà di selce locale di buona qual<strong>it</strong>à in forma di<br />
ciottoli, noduli e liste. Dal punto di vista tecnologico registriamo la presenza<br />
di nuclei poliedrici molto sfruttati di dimensioni ridotte e una prevalenza<br />
della componente microl<strong>it</strong>ica su scheggia e su lamella.<br />
<strong>Lo</strong> strato 3, datato a 8.320±85 BP (7.550-7.130 a.C.), ha rest<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o pochi<br />
manufatti tra i quali alcuni r<strong>it</strong>occati; al loro interno emergono alcuni<br />
grattatoi (fig. 3), in due casi di medie dimensioni associati ad elementi<br />
corti di piccole dimensioni di cui uno frontale a morfologia tettiforme<br />
(fig. 3, n. 4) che rimanda a modelli mesol<strong>it</strong>ici peninsulari (cfr. Sauveterriano).<br />
I raschiatoi sono di taglia media e a lavorazione non invadente, un<br />
B6 è microl<strong>it</strong>ico. Si rileva la presenza di un microbulino su microlamella.<br />
<strong>Lo</strong> strato 2, datato a 7.998±80 BP (7.090-6.650 a.C.), è stato altrettanto<br />
avaro di manufatti. Tra i r<strong>it</strong>occati (fig. 4) compaiono alcuni raschiatoi<br />
di piccole dimensioni e un grattatoio corto ma soprattutto va segnalata la<br />
presenza di due frammenti di dorso, uno microl<strong>it</strong>ico spesso e poco accurato<br />
l’altro microl<strong>it</strong>ico stretto.<br />
Il materiale degli strati 2 e 3 non permette una diagnosi esaustiva; possiamo<br />
solo indicare la presenza di alcuni elementi che per i caratteri tecnotipologici<br />
potrebbero rimandare agli insiemi che sono stati attribu<strong>it</strong>i al filone<br />
di tradizione epigravettiana (<strong>Lo</strong> <strong>Vetro</strong> e <strong>Martini</strong> in questo volume).<br />
Fig. 3 - Grotta delle Uccerie, industria l<strong>it</strong>ica dello strato 3: grattatoio frontali lunghi<br />
e corti (foto D. <strong>Lo</strong> <strong>Vetro</strong>).
298 F. MARTINI et alii<br />
Fig. 4 - Grotta delle Uccerie, industria l<strong>it</strong>ica dello strato 2: 1, 2) nuclei; 3, 4) grattatoi;<br />
5, 6) frammenti di dorso. (foto D. <strong>Lo</strong> <strong>Vetro</strong>).<br />
LA FREQUENTAZIONE NEOLITICA (S. <strong>Casciarri</strong>, D. <strong>Lo</strong> <strong>Vetro</strong>)<br />
Le evidenze neol<strong>it</strong>iche sono contenute nello strato 1, per il quale è stata<br />
ottenuta su carbone vegetale la misura radiometrica pari a 5.921±50<br />
BP (4.940-4.690 a.C.). Nell’industria l<strong>it</strong>ica, in ver<strong>it</strong>à poverissima, si registra<br />
come nelle fasi precedenti l’utilizzo di selce locale raccolta in affioramento<br />
e in deposizione secondaria; tra i supporti sono presenti lame e lamelle<br />
molto regolari a sezione triangolare e trapezoidale. Tra i manufatti<br />
r<strong>it</strong>occati (fig. 5), oltre a qualche troncatura, ad alcuni raschiatoi (sia su lama<br />
che su scheggia) e a un denticolato a r<strong>it</strong>occo poco accurato, si segnalano<br />
due grattatoi su supporto massiccio e irregolare e un trapezio ipermicrol<strong>it</strong>ico<br />
di buona fattura.<br />
La ceramica (fig. 6) comprende pochi ma significativi frammenti tra i<br />
quali compaiono alcuni elementi decorati. Gli impasti utilizzati sono di tipo<br />
grossolano e depurato, i primi presentano superfici sommariamente lisciate,<br />
con tracce di lisciatura sulle pareti interne, di colore arancio in superficie<br />
e nero sulle fratture, quelli depurati si distinguono per un aspetto<br />
più compatto, con superfici lisciate di colore grigio-arancio. Tra gli impasti<br />
grossolani, di cui non è stato possibile riconoscere una serie formale di<br />
appartenenza, sono presenti due frammenti a pareti spesse, decorati<br />
esternamente da profonde incisioni. Sul frammento più significativo le incisioni<br />
sono disposte in maniera poco ordinata e seguono un andamento
PRIMI RISULTATI DELLA CAMPAGNA DI SCAVO 2005 A GROTTA DELLA UCCERIA 299<br />
Fig. 5 - Grotta delle Uccerie, industria l<strong>it</strong>ica dello strato 1: 1, 2) grattatoi; 3) troncatura;<br />
4) geometrico; 5) lamella non r<strong>it</strong>occata. (foto D. <strong>Lo</strong> <strong>Vetro</strong>).<br />
Fig. 6 - Grotta delle Uccerie, reperti ceramici decorati dello strato 1: ceramica ad<br />
impasto grossolano con decorazione a solchi profondi; 2-5) ceramica ad<br />
impasto depurato decorata con motivi incisi (dis. S. <strong>Casciarri</strong>).<br />
subparallello, sembrano essere state esegu<strong>it</strong>e con uno strumento a punta<br />
rettangolare o circolare che ha lasciato segni di striature nella solcatura<br />
(fig. 6, n. 1). Tra gli impasti depurati è stato possibile ricostruire una forma<br />
a carena arrotondata (di morfologia globulare schiacciata) di grandi<br />
dimensioni (Ø 340 mm ca), ad orlo non distinto dir<strong>it</strong>to su cui si è conservato<br />
parte dell’attacco dell’ansa a nastro, impostata dall’orlo al punto di<br />
massima curvatura della parete. La decorazione è caratterizzata da linee
300 F. MARTINI et alii<br />
incise con motivi a “chevrons” che partono da una linea orizzontale incisa<br />
poco sotto l’orlo e da motivi angolari paralleli, esegu<strong>it</strong>i sulla parte di<br />
ansa conservata (parte del nastro e punto di imposta inferiore) (fig. 6, n.<br />
5). Altri tre frammenti di parete ad impasto depurato con spessori sottili<br />
si presentano decorati da motivi incisi (fig. 6, nn. 2-4). In due frammenti i<br />
motivi, forse triangolari, sono camp<strong>it</strong>i da linee incise parallele ed angolari<br />
(fig. 6, nn. 3, 4). Per un inquadramento cronologico e culturale dell’industria<br />
ceramica di Grotta delle Uccerie si propone un confronto con il materiale<br />
proveniente dalla Grotta del Kronio di Sciacca (Agrigento), (Tinè<br />
1971; Maggi 1976-77) in particolare con il livelli neol<strong>it</strong>ici (liv. 8-14) della<br />
fase IVb, attribuibilie alla facies “impresse evolute” di stile Kronio classico<br />
(Tinè et alii 1994). Tra le forme tipiche del Kronio classico è ben inseribile<br />
la tazza carenata con ansa a nastro decorata da incisioni di Grotta<br />
delle Uccerie. Risultano inoltre confrontabili i tipi di impasto (grossolano<br />
e depurato) e le decorazioni incise, con bande e motivi triangolari.<br />
L’assenza di ceramica dipinta di stile Capri e Serra d’Alto a Grotta delle<br />
Uccerie, presente invece nello strato IVa di Grotta del Kronio e caratterizzante<br />
lo stile successivo evoluto, può essere una ulteriore conferma per<br />
l’attribuzione del materiale allo stile del Kronio classico 8 .<br />
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI<br />
BISI A. M. 1969, Favignana e Marettimo (Isole Egadi). Ricognizione archeologica,<br />
Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Notizie degli Scavi di Antich<strong>it</strong>à,<br />
serie VIII, vol. XXIII, pp. 316-340.<br />
BOVIO MARCONI J. 1952, Isole Egadi. Esplorazioni archeologiche a Levanzo e Favignana,<br />
Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Notizie degli Scavi di Antich<strong>it</strong>à,<br />
serie VIII, vol. VI, pp. 185-199.<br />
COLONESE A.C. in questo volume-a, Molluschi marini in depos<strong>it</strong>i antropici: il caso<br />
di Grotta d’Oriente (Favignana).<br />
COLONESE A.C. in questo volume-b, <strong>Lo</strong> sfruttamento dei molluschi mesol<strong>it</strong>orali:<br />
evidenze mesol<strong>it</strong>iche a Grotta di Cala Mancina (S. V<strong>it</strong>o lo Capo - Trapani).<br />
COLONESE A.C., ZIVERI P., TROELSTRA S. in questo volume, Primi dati sulla stagional<strong>it</strong>à<br />
di raccolta di Osilinus turbinatus (von Born, 1778; Gastropoda, Prosobranchia)<br />
a Grotta d’Oriente (Favignana), Grotta delle Uccerie (Favignana) e<br />
Grotta di Cala Mancina (S. V<strong>it</strong>o <strong>Lo</strong> Capo).<br />
DALLA ROSA G. 1870, Ricerche Paleotnologiche nel l<strong>it</strong>orale di Trapani, Parma.<br />
*8 Nei paragrafi a più nomi il contributo degli Autori è equivalente.
PRIMI RISULTATI DELLA CAMPAGNA DI SCAVO 2005 A GROTTA DELLA UCCERIA 301<br />
LO VETRO D., MARTINI F., in questo volume, Il Paleol<strong>it</strong>ico e il Mesol<strong>it</strong>ico in<br />
Sicilia.<br />
MAGGI R. 1976-77, Gli scavi nelle Stufe di San Calogero sul Monte Kronio, Kokalos<br />
22-23, pp. 510-518.<br />
MALATESTA A. 1957, Terreni faune e industrie quaternarie nell’Arcipelago delle<br />
Egadi, Quaternaria, IV, pp. 165-257.<br />
MARTINI F., LO VETRO D., COLONESE A. C., DE CURTIS O., DI GIUSEPPE Z., LO-<br />
CATELLI E., SALA B., 2007, L’Epigravettiano finale in Sicilia, Atti della Tavola<br />
rotonda: L’Italia tra 15.000 e 10.000 anni fa. Cosmopol<strong>it</strong>ismo e regional<strong>it</strong>à nel<br />
Tardoglaciale, Firenze 18 Novembre 2005, pp. 209-254.<br />
MARTINI F., LO VETRO D., COLONESE A. C., CILLI C., DE CURTIS O., DI GIUSEP-<br />
PE Z., GIGLIO R., LOCATELLI E., SALA B., TUSA S. in questo volume, Primi risultati<br />
sulle nuove ricerche stratigrafiche a Grotta d’Oriente (Favignana, Trapani).<br />
Scavi 2005.<br />
REIMER P.J., BAILLIE M.G.L., BARD E., BAYLISS A., BECK J.W., BERTRAND C.J.H.,<br />
BLACKWELL P.G., BUCK C.E., BURR G.S., CUTLER K.B., DAMON P.E.,<br />
EDWARDS R.L., FAIRBANKS R.G., FRIEDRICH M., GUILDERSON T.P., HOGG<br />
A.G., HUGHEN K.A., KROMER B., MCCORMAC G., MANNING S., BRONK RAM-<br />
SEY C., REIMER R.W., REMMELE S., SOUTHON J.R., STUIVER M., TALAMO S.,<br />
TAYLOR F.W., VAN DER PLICHT J., WEYHENMEYER C.E. 2004, IntCal04 terrestrial<br />
radiocarbon age calibration, 0-26 cal kyr BP, Radiocarbon, 46 (3), pp.<br />
1029-1058.<br />
TINÈ S. 1971, <strong>Lo</strong> stile Kronio in Sicilia, lo stile di Ghar Dhalam a Malta e la successione<br />
del Neol<strong>it</strong>ico nelle due isole, AttiIIPP XIII, Firenze, pp. 75-88.<br />
TINÈ S., TINÈ V., TRAVERSO A. 1994, La campagna di scavo del 1986 nell’Antro<br />
Fazello del complesso “Stufe di San Calogero” del Monte Kronio di Sciacca<br />
(AG), in TUSA S., a cura di, La Preistoria del basso Belice e della Sicilia meridionale<br />
nel quadro della preistoria siciliana e med<strong>it</strong>erranea, pp. 245-262.<br />
VELLANOWETH R.L., LAMBRIGHT M.R., ERLANDSON J.M., RICK T.C. 2003, Early<br />
New World mar<strong>it</strong>ime technologies: sea grass cordage, shell beads, and a bone<br />
tool from Cave of the Chimneys, San Miguel Island, California, USA, Journal of<br />
Archaeological Science 30, pp. 1161–1173.<br />
RIASSUNTO. - PRIMI RISULTATI DELLA CAMPAGNA DI SCAVO 2005 A GROTTA<br />
DELLE UCCERIE (FAVIGNANA, TP). - Le ricerche nella Grotta delle Uccerie hanno<br />
messo in luce una sequenza stratigrafica con livelli dell’Epigravettiano finale, del<br />
Mesol<strong>it</strong>ico e del Neol<strong>it</strong>ico antico. Dal punto di vista economico, sia negli orizzonti<br />
epigravettiani che mesol<strong>it</strong>ici, l’attiv<strong>it</strong>à di caccia, la raccolta di molluschi marini<br />
e la pesca cost<strong>it</strong>uiscono, come in atri giacimenti coevi, la base dell’economia<br />
di sussistenza. La raccolta di molluschi marini a scopo alimentare diviene significativa<br />
a partire dall’occupazione mesol<strong>it</strong>ica dello strato 3. Il complesso epigravettiano,<br />
datato a circa 13.000 BP, indica una fase originale che potrebbe rappresen-
302 F. MARTINI et alii<br />
tare l’aspetto più antico sinora documentato sull’isola. L’industria mesol<strong>it</strong>ica,<br />
non abbondante, potrebbe riferirsi alla facies di tradizione epigravettiana. La frequentazione<br />
neol<strong>it</strong>ica si riferisce, sulla base dell’indicatore ceramico, alla facies<br />
“impresse evolute” di stile Kronio classico.<br />
RÉSUMÉ. - PREMIERS RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE FOUILLES 2005 DI GROT-<br />
TA DELLE UCCERIE (FAVIGNANA, TP). - Les recherches dans la Grotta delle Uccerie<br />
ont mis en évidence une séquence stratigraphique avec niveaux de<br />
l’Epigravettien final, du Mésol<strong>it</strong>hique et du Néol<strong>it</strong>hique ancien. Au point de vue<br />
de l’économie, dans les horizons so<strong>it</strong> épigravettiens que mésol<strong>it</strong>hiques, la chasse,<br />
la récolte de mollusques marines au but alimentaire et la pêche const<strong>it</strong>uent la base<br />
de l’économie de subsistance, de même que dans d’autres gisements contemporains.<br />
La récolte de mollusques marines au but alimentaire devient significative<br />
seulement avec l’occupation mésol<strong>it</strong>hique di niveau 3. Le complexe épigravettien,<br />
daté d’environ 13.000 ans BP, montre une phase originale qui pourra<strong>it</strong> représenter<br />
l’aspect le plus ancien jusqu’à présent documenté sur l’île. L’industrie<br />
mésol<strong>it</strong>hique, pas abondante, pourra<strong>it</strong> se référer au facies de trad<strong>it</strong>ion épigravettienne.<br />
La fréquentation néol<strong>it</strong>hique se réfère aux facies «imprimés évolués» du<br />
style Kronio chassique, selon les données fournies par la céramique.