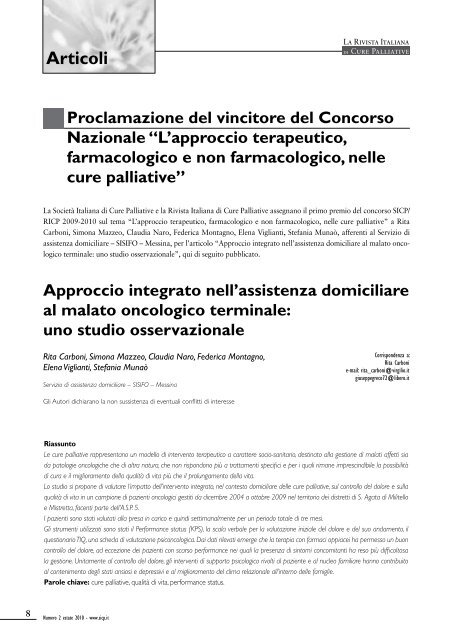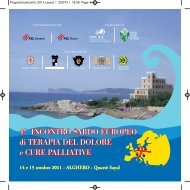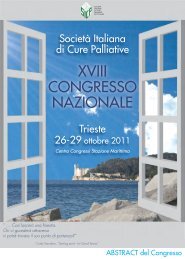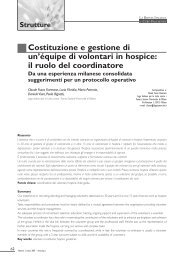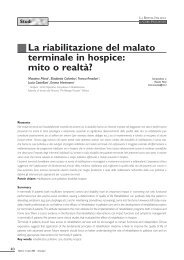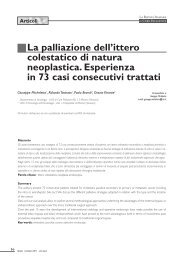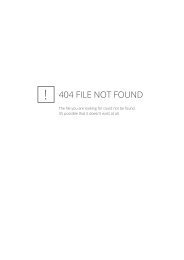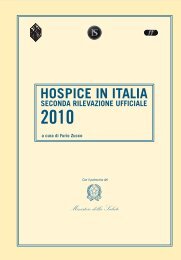Scarica il pdf usando questo link. - SICP
Scarica il pdf usando questo link. - SICP
Scarica il pdf usando questo link. - SICP
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Articoli<br />
La Rivista Italiana<br />
di Cure Palliative<br />
Proclamazione del vincitore del Concorso<br />
Nazionale “L’approccio terapeutico,<br />
farmacologico e non farmacologico, nelle<br />
cure palliative”<br />
La Società Italiana di Cure Palliative e la Rivista Italiana di Cure Palliative assegnano <strong>il</strong> primo premio del concorso <strong>SICP</strong>/<br />
RICP 2009-2010 sul tema “L’approccio terapeutico, farmacologico e non farmacologico, nelle cure palliative” a Rita<br />
Carboni, Simona Mazzeo, Claudia Naro, Federica Montagno, Elena Viglianti, Stefania Munaò, afferenti al Servizio di<br />
assistenza domic<strong>il</strong>iare – SISIFO – Messina, per l’articolo “Approccio integrato nell’assistenza domic<strong>il</strong>iare al malato oncologico<br />
terminale: uno studio osservazionale”, qui di seguito pubblicato.<br />
Approccio integrato nell’assistenza domic<strong>il</strong>iare<br />
al malato oncologico terminale:<br />
uno studio osservazionale<br />
Rita Carboni, Simona Mazzeo, Claudia Naro, Federica Montagno,<br />
Elena Viglianti, Stefania Munaò<br />
Servizio di assistenza domic<strong>il</strong>iare – SISIFO – Messina<br />
Corrispondenza a:<br />
Rita Carboni<br />
e-ma<strong>il</strong>: rita_carboni@virg<strong>il</strong>io.it<br />
giuseppegreco72@libero.it<br />
Gli Autori dichiarano la non sussistenza di eventuali conflitti di interesse<br />
Riassunto<br />
Le cure palliative rappresentano un modello di intervento terapeutico a carattere socio-sanitario, destinato alla gestione di malati affetti sia<br />
da patologie oncologiche che di altra natura, che non rispondono più a trattamenti specifici e per i quali rimane imprescindib<strong>il</strong>e la possib<strong>il</strong>ità<br />
di cura e <strong>il</strong> miglioramento della qualità di vita più che <strong>il</strong> prolungamento della vita.<br />
Lo studio si propone di valutare l’impatto dell’intervento integrato, nel contesto domic<strong>il</strong>iare delle cure palliative, sul controllo del dolore e sulla<br />
qualità di vita in un campione di pazienti oncologici gestiti da dicembre 2004 a ottobre 2009 nel territorio dei distretti di S. Agata di M<strong>il</strong>itello<br />
e Mistretta, facenti parte dell’A.S.P. 5.<br />
I pazienti sono stati valutati alla presa in carico e quindi settimanalmente per un periodo totale di tre mesi.<br />
Gli strumenti ut<strong>il</strong>izzati sono stati <strong>il</strong> Performance status (KPS), la scala verbale per la valutazione iniziale del dolore e del suo andamento, <strong>il</strong><br />
questionario TIQ, una scheda di valutazione psiconcologica. Dai dati r<strong>il</strong>evati emerge che la terapia con farmaci oppiacei ha permesso un buon<br />
controllo del dolore, ad eccezione dei pazienti con scarso performance nei quali la presenza di sintomi concomitanti ha reso più difficoltosa<br />
la gestione. Unitamente al controllo del dolore, gli interventi di supporto psicologico rivolti al paziente e al nucleo fam<strong>il</strong>iare hanno contribuito<br />
al contenimento degli stati ansiosi e depressivi e al miglioramento del clima relazionale all’interno delle famiglie.<br />
Parole chiave: cure palliative, qualità di vita, performance status.<br />
8<br />
Numero 2 estate 2010 - www.sicp.it
La Rivista Italiana<br />
di Cure Palliative<br />
Summary<br />
Palliative care represents a model of therapeutic intervention with social-sanitary nature, intended for the management of patients<br />
with oncological pathologies and other pathologies that don’t respond anymore to specific treatments and for which remain absolute<br />
the possib<strong>il</strong>ity of cure and improvement of quality of life instead of the prolongation of life.<br />
The study intends to evaluate the impact of the integrated intervention, in the domic<strong>il</strong>iary context of palliative cares, on the control<br />
of pain and quality of life in a sample of oncological patients managed in the territory of the districts of S. Agata di M<strong>il</strong>itello and<br />
Mistretta in A.S.P. 5, from December 2004 unt<strong>il</strong> October 2009.<br />
The patients have been evaluated from the beginning and then weekly for a period of three months.<br />
The instruments used have been The Performance status (KPS), scale for evaluation of the pain, TIQ questionnaire, form of psychooncological<br />
valuation. The recent data show that the therapy with opiates drugs permitted a good control of pain, with the exception<br />
of the patients with an insufficient performance where the presence of concomitant symptoms made the management more<br />
difficult. Together with the control of pain, the intervention of psychological support given to patient and to the fam<strong>il</strong>iar nucleus<br />
contributed to the containment of the anxious and depressive status of the patient and to the improvement of the relational climate<br />
into the fam<strong>il</strong>ies.<br />
Key words: palliative care, quality of life, performance status.<br />
INTRODUZIONE<br />
L’assistenza domic<strong>il</strong>iare nelle cure palliative nasce da una<br />
nuova cultura socio-assistenziale, in cui l’ospedale non rappresenta<br />
più l’unico luogo adibito ad affrontare i bisogni<br />
e le problematiche dei pazienti, connesse alla gestione di<br />
una malattia cronico-degenerativa in fase avanzata; in tempi<br />
relativamente recenti, infatti, si è iniziato a valorizzare<br />
maggiormente <strong>il</strong> contesto di vita naturale.<br />
L’aspetto principale del lavoro svolto nell’assistenza domic<strong>il</strong>iare<br />
è riassumib<strong>il</strong>e nell’attenzione posta al benessere<br />
globale dell’individuo, dunque alla cura degli aspetti fisici,<br />
psicologici e sociali connessi al vissuto della condizione di<br />
malattia e che trovano nell’ambiente domestico e fam<strong>il</strong>iare,<br />
più che in ogni altro contesto, <strong>il</strong> luogo di elezione per potenziare<br />
le risorse dell’individuo e della famiglia.<br />
In quest’ottica, le cure palliative in assistenza domic<strong>il</strong>iare<br />
intervengono con <strong>il</strong> passaggio dal Curare al Prendersi cura,<br />
per garantire ai malati terminali la migliore qualità di vita,<br />
individuandone necessità e bisogni. Quando <strong>il</strong> decorso della<br />
malattia oncologica diventa irreversib<strong>il</strong>e e porta in breve<br />
tempo alla morte, si evidenzia spesso un complesso quadro<br />
problematico definito come “dolore totale”. A <strong>questo</strong> afferiscono<br />
le diverse dimensioni del dolore: fisico, emotivo,<br />
psichico, sociale e spirituale. Lo stato di sofferenza della<br />
persona è infatti acuito dalla perdita della posizione sociale<br />
e del proprio ruolo in famiglia, dalla perdita della dignità<br />
del proprio corpo, dalla forzata dipendenza dagli altri, dalla<br />
paura del dolore, della morte e della solitudine (1) .<br />
Il contesto di cura domic<strong>il</strong>iare presuppone una tipologia di<br />
assistenza in cui diviene dunque indispensab<strong>il</strong>e la configurazione<br />
di un intervento multidisciplinare in cui <strong>il</strong> malato<br />
diventi <strong>il</strong> centro attorno a cui ruotano tutte le figure professionali<br />
(medico, infermiere, riab<strong>il</strong>itatore, psicologo, assistente<br />
sociale, OSA). L’intervento integrato ha dunque lo<br />
scopo di migliorare la qualità di vita del paziente, tenendo<br />
sempre conto dei molteplici fattori coinvolti e della valutazione<br />
soggettiva che ogni individuo fa del proprio benessere<br />
psicofisico. Tra gli indicatori più r<strong>il</strong>evanti di una buona<br />
qualità della vita nella fase terminale possiamo annoverare<br />
<strong>il</strong> controllo del dolore e degli altri sintomi invalidanti, la<br />
possib<strong>il</strong>ità per <strong>il</strong> paziente di sentirsi rassicurato e ascoltato,<br />
<strong>il</strong> miglioramento della qualità delle relazioni fam<strong>il</strong>iari o di<br />
quelle affettivamente significative (2-5) .<br />
Lo studio presentato si propone di valutare l’impatto<br />
dell’intervento integrato, nel contesto domic<strong>il</strong>iare delle cure<br />
palliative, sul controllo del dolore e sulla qualità di vita in<br />
un campione di pazienti oncologici gestiti nel territorio dei<br />
Distretti di S. Agata di M<strong>il</strong>itello e Mistretta, facenti parte<br />
dell’A.S.P. 5, da dicembre 2004 a ottobre 2009.<br />
MATERIALI E METODI<br />
Da dicembre 2004 a ottobre 2009 sono stati assistiti 270<br />
pazienti, età media 68 anni (19-83).<br />
Ogni paziente è stato valutato alla presa in carico nonché<br />
Numero 2 estate 2010 - www.sicp.it<br />
9
Articoli<br />
La Rivista Italiana<br />
di Cure Palliative<br />
settimanalmente e a distanza di tre mesi dall’inizio dell’assistenza<br />
secondo <strong>il</strong> Performance status (KPS), la scala verbale<br />
per la valutazione del dolore iniziale e del suo andamento,<br />
<strong>il</strong> questionario TIQ, una scheda psiconcologica.<br />
Il Karnofsky Performance Status (KPS) stab<strong>il</strong>isce un punteggio<br />
riferito alle performance che <strong>il</strong> paziente può compiere<br />
nell’attendere alle sue ordinarie occupazioni; <strong>il</strong> questionario<br />
TIQ è lo strumento standard italiano per la valutazione<br />
della qualità di vita nei trial clinici su pazienti oncologici<br />
in cure palliative. È costituito da 36 item che riguardano<br />
sintomi fisici, psicologici, problemi sociali ed economici,<br />
nonché la soddisfazione per le cure ricevute secondo una<br />
scala di valutazione verbale (6) .<br />
La scheda psiconcologica è stata formulata appositamente<br />
al fine di raccogliere le osservazioni cliniche e monitorare<br />
alcune componenti emotive e relazionali, nell’ottica di una<br />
più generale valutazione della qualità di vita del paziente<br />
e della famiglia: bisogni psicologici del paziente, livello di<br />
informazione, conoscenza, consapevolezza e stati emotivi<br />
prevalenti nel paziente, livello di compliance, clima emotivo<br />
all’interno del nucleo fam<strong>il</strong>iare, risorse e strategie di<br />
coping del paziente e della famiglia. Alla prima valutazione<br />
globale ha fatto seguito l’attuazione di programmi di cura<br />
farmacologici specifici (medico-infermieristici), di interventi<br />
di supporto psicologico e sociale sul malato e sui fam<strong>il</strong>iari<br />
e di sostegno al paziente in risposta ai bisogni fisici (igiene,<br />
riab<strong>il</strong>itazione). Le rivalutazioni settimanali con l’équipe di<br />
assistenza hanno permesso di modulare i piani di cura e le<br />
modalità di approccio, a seconda delle esigenze di volta in<br />
volta presentate dal malato o dalle famiglie.<br />
RISULTATI<br />
È stata condotta un’analisi osservazionale su un campione di<br />
100 pazienti rispetto ai 270 assistiti, scelti secondo i seguenti<br />
criteri: sopravvivenza superiore a tre mesi, discreto livello<br />
di collaborazione. Dei restanti, 132 sono deceduti entro tre<br />
mesi dalla presa in carico, 29 non hanno mostrato una buona<br />
compliance al trattamento terapeutico, 9 hanno rifiutato<br />
<strong>il</strong> supporto psicologico e/o l’intervento di altre figure professionali<br />
facenti parte dell’équipe. Sul campione esaminato,<br />
l’indagine è stata condotta per <strong>il</strong> 65% dei casi direttamente<br />
sul malato e per <strong>il</strong> 35% con <strong>il</strong> supporto dei caregiver.<br />
I pazienti presentavano una distribuzione di malattia come<br />
qui di seguito riportato: 35% tumori del polmone, 23% tumori<br />
del colon, 15% tumori della mammella, 12% tumori<br />
dell’apparato genitourinario, 2% tumori del SNC, 2% tumori<br />
del fegato e delle vie b<strong>il</strong>iari, 1% tumori del pancreas,<br />
1% mieloma multiplo, la restante quota (9%) comprendeva<br />
pazienti con tumore primitivo sconosciuto, tumori cutanei,<br />
delle ghiandole salivari, rabdomiosarcoma a localizzazione<br />
addominale, tumore parotideo (Figura 1).<br />
Figura 1. Distribuzione di malattia.<br />
polmone (35%)<br />
colon (23%)<br />
mammella (15%)<br />
genitourinario (12%)<br />
SNC (2%)<br />
fegato-vie b<strong>il</strong>iari (2%)<br />
pancreas (1%)<br />
mieloma multiplo (1%)<br />
altri (9%)<br />
1%<br />
2%<br />
2%<br />
12%<br />
15%<br />
23%<br />
35%<br />
L’approccio farmacologico affidato al medico ha sempre<br />
visto <strong>il</strong> malato al centro del panorama assistenziale, con la<br />
finalità di gestire la problematica più comune e invalidante,<br />
ovvero <strong>il</strong> controllo del dolore, quale esperienza prevalente<br />
negli ultimi mesi di vita (7) .<br />
Alla presa in carico, <strong>il</strong> KPS dei pazienti variava da 20 a 70, <strong>il</strong><br />
65% dei pazienti riferiva, oltre al dolore, altri sintomi associati<br />
(dispnea, disfagia, fatigue, nausea e vomito). Il dolore si<br />
definiva nel 58% dei casi come viscerale, identificato come<br />
sordo o gravativo oppure lancinante o penetrante a seconda<br />
che fossero interessati un viscere cavo o piuttosto membrane<br />
periviscerali o mesenteri; non era fac<strong>il</strong>mente localizzab<strong>il</strong>e<br />
e a volte riferito in parti del corpo diverse dal punto in cui<br />
originava e valutato come peggiore esperienza dolorosa, di<br />
intensità pressoché costante, sia durante <strong>il</strong> giorno sia nelle<br />
ore notturne. Nel 22% dei pazienti <strong>il</strong> dolore veniva definito<br />
nocicettivo somatico per stimolazione di cute o mucose<br />
(superficiale) e dei tessuti profondi (come l’osso, la pleura);<br />
era fac<strong>il</strong>mente localizzab<strong>il</strong>e ed esacerbato dal movimento,<br />
quindi episodico, discontinuo, nella maggioranza dei casi<br />
più forte durante la notte, di intensità moderata, a tratti<br />
insopportab<strong>il</strong>e. Il 17% dei pazienti definiva <strong>il</strong> dolore come<br />
misto, viscerale e neuropatico per danno o disfunzione del<br />
sistema nervoso periferico o centrale descritto come dolore<br />
spontaneo spesso urente, a scossa elettrica o lancinante, ma<br />
anche crampiforme, profondo a morsa o evocato da stimoli<br />
dolorosi (iperalgesia) e non (allodinia), saltuario, indifferen-<br />
1%<br />
9%<br />
10<br />
Numero 2 estate 2010 - www.sicp.it
La Rivista Italiana<br />
di Cure Palliative<br />
temente presente di giorno come durante la notte. Anche<br />
questa tipologia di dolore veniva identificata come peggiore<br />
esperienza dolorosa possib<strong>il</strong>e. Il 3% dei pazienti ha riferito<br />
un dolore lieve, costante o saltuario.<br />
Complessivamente <strong>il</strong> 75% dei pazienti ha definito alla prima<br />
valutazione <strong>il</strong> dolore come severo e continuo, <strong>il</strong> 22%<br />
moderato continuo o saltuario, solo <strong>il</strong> 3% dolore lieve e<br />
saltuario (8) .<br />
Sul campione dei pazienti esaminati, <strong>il</strong> 25% non aveva mai<br />
assunto stab<strong>il</strong>mente farmaci antidolorifici e su di essi è stato<br />
possib<strong>il</strong>e ab initio impostare un programma di cura che<br />
ha previsto una prima fase di titolazione con l’impiego di<br />
morfina a r<strong>il</strong>ascio immediato per via orale (10 mg ogni 4<br />
ore) e ut<strong>il</strong>izzo di dosi “rescue” con la stessa dose di morfina<br />
orale in caso di breakthrough pain, per poi riadattare<br />
la dose totale in base alla quantità di dosi rescue impiegate.<br />
Successivamente, si è passati all’impiego di fentanyl transdermico<br />
come terapia di mantenimento e morfina a r<strong>il</strong>ascio<br />
rapido per la gestione del dolore incidente. Tutte le possib<strong>il</strong>i<br />
variazioni di dose sono state effettuate tenendo conto della<br />
tollerab<strong>il</strong>ità ai farmaci impiegati nonché della variab<strong>il</strong>ità<br />
giornaliera dell’intensità di dolore. In otto pazienti si è ricorso<br />
all’uso di farmaci adiuvanti, mentre sei pazienti hanno<br />
ut<strong>il</strong>izzato una dose doppia di morfina serale per garantire<br />
un migliore riposo notturno. Il 67% dei pazienti ha usato<br />
la morfina come farmaco di seconda scelta dopo FANS<br />
prescritti dalla struttura ospedaliera di riferimento. Anche<br />
in <strong>questo</strong> caso si è provveduto alla titolazione della<br />
morfina per poi ut<strong>il</strong>izzare <strong>il</strong> sistema transdermico di<br />
somministrazione, con correzione del breakthrough<br />
pain tramite morfina a rapido r<strong>il</strong>ascio (morfina sottocute<br />
o per bocca). È stata ut<strong>il</strong>izzata la via transdermica<br />
di somministrazione, per la semplicità di ut<strong>il</strong>izzo e la<br />
buona compliance da parte del paziente e dei fam<strong>il</strong>iari,<br />
aspetto <strong>questo</strong> r<strong>il</strong>evante in un regime di gestione<br />
al domic<strong>il</strong>io. Solo <strong>il</strong> 3% dei pazienti osservati aveva<br />
impiantato una pompa spinale, contenente morfina e<br />
altre categorie di analgesici e anestetizzanti; <strong>il</strong> 2% ha<br />
ricevuto morfina a infusione continua per via sottocutanea,<br />
tramite pompe per infusione gestite al domic<strong>il</strong>io<br />
dai nostri infermieri; <strong>il</strong> 3% ha eseguito una terapia con<br />
morfina per via endovenosa in infusione continua tramite<br />
accesso venoso centrale.<br />
Nel corso delle valutazioni settimanali e, in ultima analisi,<br />
dopo tre mesi di assistenza si è osservato che <strong>il</strong> controllo del<br />
dolore si è ottenuto nella quasi totalità dei pazienti analizzati,<br />
eccezion fatta per quelli con pompa spinale, pressoché<br />
refrattari alla terapia e nei quali l’intervento terapeutico era<br />
condizionato dalla gestione di tali dispositivi, spesso demandata<br />
alle strutture ospedaliere di riferimento. Una quota di<br />
pazienti con dolore giudicato severo alla prima valutazione<br />
non ha tollerato <strong>il</strong> trattamento con oppioidi per la comparsa<br />
di sintomi collaterali importanti e su di essi è stato possib<strong>il</strong>e<br />
un controllo parziale con l’impiego di FANS e l’aus<strong>il</strong>io di farmaci<br />
sia adiuvanti che per <strong>il</strong> dolore episodico. Nei pazienti<br />
con basso Performance la presenza di altri sintomi correlati<br />
alla malattia oncologica ha reso comunque più diffic<strong>il</strong>e la<br />
gestione del dolore, sebbene <strong>il</strong> trattamento farmacologico<br />
nel complesso abbia fatto registrare, al termine della valutazione,<br />
un lieve innalzamento della soglia del Performance.<br />
Nei pazienti con dolore severo l’intervento terapeutico ha<br />
permesso di raggiungere livelli di dolore lieve nel 36% dei<br />
casi, moderato e discontinuo, controllab<strong>il</strong>e con la terapia<br />
medica al bisogno nel 46%, mentre <strong>il</strong> 18% ha risposto parzialmente<br />
al trattamento. In tutti i pazienti con dolore iniziale<br />
moderato e discontinuo si è ottenuta una remissione<br />
parziale della sintomatologia dolorosa, avvertita meno di<br />
una volta la settimana e comunque, anche in <strong>questo</strong> caso,<br />
controllab<strong>il</strong>e al bisogno e definito lieve, sopportab<strong>il</strong>e. I pazienti<br />
con dolore iniziale lieve hanno avuto una completa<br />
remissione della sintomatologia o comunque hanno manifestato<br />
un dolore lieve ma episodico (Figura 2).<br />
Figura 2. Andamento del dolore.<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
0 1 2 3 4 5 6 7 8<br />
settimane<br />
10 11 12<br />
La somministrazione in infusione continua di morfina<br />
(sottocutanea ed endovenosa), per la semplicità di applicazione<br />
e gestione al domic<strong>il</strong>io e la possib<strong>il</strong>ità di modulare<br />
agevolmente <strong>il</strong> dosaggio dei farmaci, si è associata<br />
a una buona compliance da parte del paziente e ha per-<br />
9<br />
dolore lieve<br />
moderato<br />
severo<br />
Numero 2 estate 2010 - www.sicp.it<br />
11
Articoli<br />
La Rivista Italiana<br />
di Cure Palliative<br />
messo un buon controllo della sintomatologia dolorosa.<br />
L’analisi finale del KPS ha reso ragione di come un buon<br />
controllo del dolore, oltre che degli altri sintomi associati,<br />
possa migliorare i parametri fisici del paziente, consentendo<br />
a questi di rapportarsi più serenamente nei confronti di<br />
una malattia a prognosi comunque infausta (Figura 3).<br />
Figura 3. Variazione del KPS.<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
presa in carico dopo tre mesi<br />
A dare concretezza alla valutazione verbale, si è aggiunta<br />
nel nostro caso una risposta in termini di mob<strong>il</strong>izzazione<br />
dei pazienti allettati con dolore, nei quali la riduzione della<br />
sintomatologia dolorosa ha agevolato, dove possib<strong>il</strong>e, <strong>il</strong><br />
compito del fisioterapista a scopo riab<strong>il</strong>itativo, permettendo<br />
in tal modo al malato di riappropriarsi di una fetta di vita<br />
quotidiana. In conclusione, possiamo affermare che la gestione<br />
del dolore e di eventuali sintomi correlati, nel paziente<br />
oncologico terminale, in presenza di tutte le condizioni favorevoli<br />
al regolare svolgimento di un’assistenza domic<strong>il</strong>iare,<br />
pur nel rispetto degli spazi e dei tempi spesso dettati dal<br />
malato e dalle famiglie, si traduce in una stab<strong>il</strong>izzazione dei<br />
sintomi di una malattia purtroppo inguarib<strong>il</strong>e, ma certamente<br />
curab<strong>il</strong>e. All’intervento farmacologico si è affiancato, in<br />
tutti i casi esaminati, un adeguato supporto psicosociale a<br />
cadenza settimanale, che si è avvalso di alcune valutazioni<br />
essenziali.<br />
L’approccio psicologico ha previsto la presa in carico del<br />
paziente e della famiglia, focalizzandosi soprattutto sulla<br />
valutazione di alcuni aspetti relativi alla globalità del benessere<br />
psicologico ed emotivo dell’intero nucleo fam<strong>il</strong>iare.<br />
Per la r<strong>il</strong>evazione dei dati, nonché per <strong>il</strong> monitoraggio e<br />
la valutazione dell’intervento, è stata ut<strong>il</strong>izzata la scheda<br />
clinica psicologica comp<strong>il</strong>ata nella fase di presa in carico<br />
del paziente e aggiornata durante <strong>il</strong> corso dell’assistenza.<br />
È stato in tal modo possib<strong>il</strong>e evidenziare eventuali modificazioni<br />
dei parametri presi in considerazione, nell’ottica di<br />
una più generale valutazione della qualità di vita. In relazione<br />
alle osservazioni cliniche effettuate nella fase iniziale<br />
dell’assistenza, è emerso che i bisogni psicologici prevalenti<br />
dei pazienti si riferivano principalmente alla necessità di<br />
esprimere ed elaborare i vissuti emotivi (angoscia, tristezza,<br />
rabbia) legati alla condizione di malattia e al dolore fisico<br />
(84%), al bisogno di condividere con i fam<strong>il</strong>iari le paure<br />
connesse alla perdita e alla morte (55%), al bisogno di rassicurazione<br />
e di ascolto (72%) (Figura 4).<br />
Figura 4. Bisogni psicologici dei pazienti.<br />
distribuzione<br />
delle risposte<br />
100<br />
50<br />
0<br />
elaborazione emotiva<br />
condivisione con i fam<strong>il</strong>iari<br />
rassicurazioni e ascolto<br />
1<br />
In merito al livello di informazione, è stato r<strong>il</strong>evato che<br />
solo <strong>il</strong> 28% era informato sulla diagnosi, <strong>il</strong> 72% non aveva<br />
informazioni reali sulla natura della propria patologia e <strong>il</strong><br />
92% non era informato sulla prognosi; <strong>il</strong> 78% dei pazienti<br />
aveva comunque un’alta consapevolezza delle proprie condizioni<br />
cliniche. In relazione agli stati emotivi prevalenti,<br />
sono emersi sentimenti di angoscia, ansia e paura (84%),<br />
tristezza e depressione (73%), senso di perdita della propria<br />
autonomia (56%), rabbia (53%), preoccupazione per<br />
gli effetti della malattia su di sé e sulla famiglia (78%). Nella<br />
quasi totalità del campione riguardo al livello di compliance<br />
nei confronti dell’intervento dell’équipe multidisciplinare,<br />
<strong>il</strong> 12% si è mostrato poco collaborante, <strong>il</strong> 32%<br />
collaborante, <strong>il</strong> 56% molto collaborante.<br />
Il clima emotivo fam<strong>il</strong>iare alla presa in carico era generalmente<br />
caratterizzato da disorientamento rispetto alla<br />
gestione del paziente, da modalità comunicative disfunzionali,<br />
connotate da un reciproco bisogno di protezione<br />
rispetto alla drammaticità dell’evento morte e della sua<br />
rappresentazione, da sentimenti di rabbia e impotenza.<br />
La valutazione delle strategie di coping e delle risorse emotive<br />
del paziente e del contesto fam<strong>il</strong>iare ha permesso di<br />
evidenziare le aree di criticità e i punti di forza di ciascun<br />
nucleo fam<strong>il</strong>iare.<br />
12<br />
Numero 2 estate 2010 - www.sicp.it
La Rivista Italiana<br />
di Cure Palliative<br />
L’intervento di supporto psicologico è stato dunque<br />
attuato su due livelli: <strong>il</strong> supporto al paziente,<br />
finalizzato al contenimento del senso di ansia, di<br />
agitazione e degli stati depressivi (associati nel<br />
48% dei casi alla consapevolezza di una morte<br />
imminente) e al miglioramento dell’impatto psicologico<br />
e sociale della malattia neoplastica, nonché<br />
alla restituzione di un ruolo attivo del paziente<br />
stesso nella gestione della propria condizione<br />
clinica.<br />
Parallelamente sono stati effettuati interventi rivolti<br />
alla famiglia, mirati a valorizzare le risorse<br />
del nucleo fam<strong>il</strong>iare stesso e del contesto, a favorire l’integrazione<br />
della malattia nell’esperienza di vita della famiglia,<br />
tramite percorsi di elaborazione dei vissuti connessi<br />
all’angoscia di morte e al senso di perdita che la malattia<br />
comporta, nonché migliorare la qualità della comunicazione<br />
tra <strong>il</strong> paziente e i fam<strong>il</strong>iari.<br />
Il monitoraggio in itinere degli interventi di supporto effettuati<br />
e dei parametri presi in considerazione ha evidenziato<br />
un generale miglioramento del clima emotivo fam<strong>il</strong>iare, un<br />
decremento di sintomi ansioso-depressivi nei pazienti e un<br />
aumento dei livelli di compliance mostrati dal paziente. Tali<br />
osservazioni, riportate settimanalmente sulla scheda clinica,<br />
sono state confrontate con le risposte fornite dai<br />
pazienti al TIQ e che evidenziano un graduale miglioramento<br />
di alcuni parametri. Nello specifico, è<br />
stata monitorata la variazione delle risposte ad alcuni<br />
item indicativi dello stato emotivo dei pazienti<br />
ed è emersa una riduzione dell’intensità dei sintomi<br />
di depressione e tristezza, nonché degli stati di nervosismo<br />
e ansietà (Figura 5).<br />
un po’<br />
no<br />
Rispetto alla percezione del disaccordo all’interno molto<br />
del nucleo fam<strong>il</strong>iare, si r<strong>il</strong>eva come <strong>questo</strong> dato segua<br />
un andamento variab<strong>il</strong>e, ma con valori maggiormente<br />
distribuiti nelle colonne indicanti “un<br />
po’” e “molto”, che spesso coincide con un senso<br />
di isolamento provato dal paziente (Figura 6).<br />
Dal confronto con le osservazioni cliniche effettuate<br />
emerge una connessione tra questi stati d’animo<br />
e <strong>il</strong> livello di informazione dei pazienti che, laddove<br />
non informati sulla diagnosi o sulla reale pro-<br />
un po’<br />
no<br />
gressione della malattia, costruiscono frequentemente<br />
con i fam<strong>il</strong>iari st<strong>il</strong>i comunicativi forzati. La<br />
molto<br />
tendenza per i fam<strong>il</strong>iari a evitare l’idea della morte<br />
Figura 5. Stato emotivo dei pazienti e risposte al questionario TIQ.<br />
frequenza<br />
risposte<br />
no<br />
un po’<br />
molto<br />
moltissimo<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Triste o depresso<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
somministrazioni<br />
10 11 12<br />
e la loro difficoltà nel gestire la rabbia e la disperazione<br />
del malato, in genere, si accompagnano a un occultamento<br />
della verità al paziente. La non comunicazione esplicita<br />
sulle sue condizioni cliniche contribuisce alla costruzione di<br />
scenari fam<strong>il</strong>iari dominati da quella che in letteratura viene<br />
definita la “congiura del s<strong>il</strong>enzio”. Questa rappresenta una<br />
situazione paradossale, in cui tutti sanno cosa sta accadendo<br />
(spesso anche <strong>il</strong> malato ne è consapevole), ma la natura<br />
della malattia o la gravità della condizione clinica non possono<br />
essere oggetto della comunicazione all’interno delle<br />
relazioni significative del paziente. Questo si traduce in un<br />
incremento del reciproco senso di solitudine, che aumenta<br />
la distanza emotiva all’interno della famiglia (9) . Dalle osser-<br />
Figura 6. Percezione del disaccordo e senso di isolamento del paziente.<br />
frequenza<br />
risposte<br />
moltissimo<br />
frequenza<br />
risposte<br />
moltissimo<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Disaccordo in famiglia<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
somministrazioni<br />
Senso di isolamento<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
somministrazioni<br />
9<br />
9<br />
9<br />
10 11 12<br />
10 11 12<br />
Numero 2 estate 2010 - www.sicp.it<br />
13
Articoli<br />
La Rivista Italiana<br />
di Cure Palliative<br />
vazioni cliniche è emerso che <strong>il</strong> miglioramento dello stato<br />
emotivo dei pazienti e del clima relazionale intrafam<strong>il</strong>iare si<br />
associa al controllo della sintomatologia dolorosa, nonché<br />
all’aumento del Performance status del paziente.<br />
CONCLUSIONI<br />
L’esperienza riportata nello studio effettuato è certamente<br />
limitata da diversi fattori, primo fra tutti <strong>il</strong> numero non<br />
eccessivo dei pazienti, l’eterogeneità dei casi clinici rispetto<br />
alla tipologia dei sintomi riferiti e alle condizioni dei<br />
malati nonché la variab<strong>il</strong>e, pur sempre presente, legata a<br />
un certo livello di autonomia da parte dei pazienti e dei<br />
fam<strong>il</strong>iari nella gestione della terapia medica. Nonostante i<br />
limiti connessi al sistema di ospedalizzazione domic<strong>il</strong>iare,<br />
con la nostra esperienza abbiamo voluto comunque porre<br />
una riflessione su come sia ut<strong>il</strong>e, nella pratica clinica, <strong>il</strong> controllo<br />
del dolore mediante l’uso di oppioidi come farmaci<br />
di prima scelta nei pazienti oncologici terminali, a prescindere<br />
dall’età (10) . In secondo luogo la nostra esperienza ha<br />
suggerito come, diversamente dalla vecchia concezione del<br />
curare la malattia ponendo questa al centro dell’attenzione<br />
medica, piuttosto sia necessario guardare al malato come<br />
al protagonista assoluto e alla malattia come a una parte<br />
di sé, per cui curare <strong>il</strong> malato significa occuparsi non solo<br />
della sua patologia bensì di tutto ciò che esiste attorno a<br />
lui: famiglia, scuola, lavoro. Ciò è reso possib<strong>il</strong>e in maniera<br />
globale attraverso lo strumento dell’ospedalizzazione domic<strong>il</strong>iare.<br />
L’impatto positivo, sulle famiglie e sul malato, di<br />
un’équipe di assistenza attrezzata al domic<strong>il</strong>io, unitamente<br />
alla disponib<strong>il</strong>ità di presidi e farmaci a supporto del trattamento,<br />
rende ragione di come possa essere ut<strong>il</strong>e valorizzare<br />
queste forme di assistenza, per consentire di sv<strong>il</strong>uppare al<br />
meglio un intervento multidisciplinare.<br />
Sebbene la distribuzione geografica dei malati da noi assistiti<br />
sia stata alquanto varia, per cui i pazienti più vicini alle<br />
strutture ospedaliere hanno usufruito anche di <strong>questo</strong> tipo<br />
di supporto nel percorso assistenziale, l’esperienza da noi<br />
condotta ci suggerisce che l’ospedalizzazione domic<strong>il</strong>iare<br />
può rappresentare un ut<strong>il</strong>e strumento per la messa in opera<br />
di un ideale approccio terapeutico integrato al malato oncologico<br />
terminale e alla propria famiglia.<br />
RINGRAZIAMENTI<br />
Si ringraziano per <strong>il</strong> contributo apportato al servizio di assistenza<br />
domic<strong>il</strong>iare tutti gli operatori che nel corso degli<br />
anni si sono alternati nella gestione dei pazienti presi in carico<br />
e delle rispettive famiglie.<br />
Bibliografia<br />
1. Amore, Guida, Martinez, Mazzeo (2006). I servizi domic<strong>il</strong>iari di assistenza<br />
al malato terminale: Congruenze ed incongruenze rispetto al<br />
cambiamento nelle famiglie. Atti Convegno residenziale 2006 Scuola<br />
M<strong>il</strong>anese di Terapia della Famiglia.<br />
2. Paoli F. La valutazione della qualità di vita nella fase terminale. G<br />
Gerontol 2004; 52: 472-474.<br />
3. Jordhoy MS, Fayers PM, Loge JH et al. Quality of life in palliative<br />
cancer care: results from a cluster randomized trial. J Clin Oncol<br />
2001; 19: 3884-3894.<br />
4. Steinhauser KE, Christakis NA, Clipp EC et al. Factors considered<br />
important at the end of life by patients, fam<strong>il</strong>y, physicians, and other<br />
care providers. JAMA. 2000; 284(19): 2476-2482.<br />
5. Alesii A, Fini M, Mastr<strong>il</strong>li F. Cure palliative e qualità della vita. Quali<br />
strumenti? Rivista Italiana di Cure Palliative 2007; 1: 46-50.<br />
6. Paganini G, Bassi M, De Conno F. Valutazione della qualità della vita<br />
e fattori prognostici di sopravvivenza in malati terminali ricoverati in<br />
hospice. Rivista Italiana di Cure Palliative 2008; 4: 21-28.<br />
7. van den Beuken-van Everdingen MHJ, de Rijke JM, Kessel AG et al.<br />
Prevalence of pain in patients with cancer: a systematic review of the<br />
past 40 years. Ann Oncol 2007; 18: 1437-1449.<br />
8. Payne R, Gonzales GR. Pathophysiology of pain in cancer and other<br />
terminal diseases. In: Doyle D, Hanks G, Cherny N, Calman K. eds.<br />
Oxford Textbook of Palliative Medicine (III edition), Oxford University<br />
Press 2004: 288-298.<br />
9. Kubler-Ross E. La morte e <strong>il</strong> morire. Città di Castello: Cittadella Editrice,<br />
1976.<br />
10. Hanks GW, Conno F, Cherny N et al. Morphine and alternative opioids<br />
in cancer pain: The EAPC recommendations. Br J Cancer 2001;<br />
84: 587-593.<br />
Altri Autori:<br />
Fabio Barbagiovanni, Benedetta LoBalbo, Maria Rosa Oddo, Tiziana<br />
Pintaudi, Salvatore Proto, Antonio Ravì, Santo Restifo P<strong>il</strong>ato, Giovanna<br />
Russo Facciazza, Salvatore Smriglio.<br />
Si sono elencati più di sei Autori perché facenti parte tutti della stessa<br />
équipe di assistenza domic<strong>il</strong>iare e che hanno prestato <strong>il</strong> proprio servizio<br />
nel corso di questi anni.<br />
14<br />
Numero 2 estate 2010 - www.sicp.it