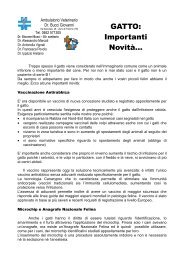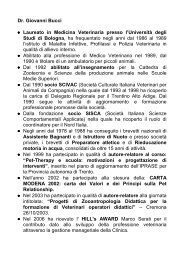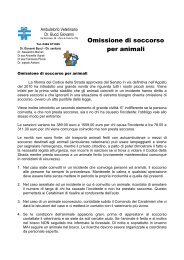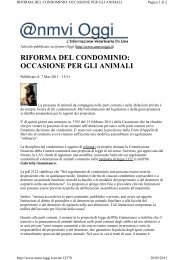pet therapy e autostima a scuola - Ambulatorio Veterinario Bucci
pet therapy e autostima a scuola - Ambulatorio Veterinario Bucci
pet therapy e autostima a scuola - Ambulatorio Veterinario Bucci
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
175<br />
PET THERAPY<br />
E AUTOSTIMA A SCUOLA<br />
di Giovanni <strong>Bucci</strong>, Franca Cicognani<br />
Parole come <strong>autostima</strong>, ottimismo, pensare positivo,<br />
autoefficacia sono diventate, al momento,<br />
anche in Italia, parole d’ordine che rappresentano<br />
la chiave per accedere alla felicità, al benessere e<br />
al successo. Non è quindi da meravigliarsi se, anche<br />
in ambiente scolastico, nonostante alcuni concetti<br />
fossero noti da tempo, viene oggi riservata<br />
sempre maggiore attenzione a questi as<strong>pet</strong>ti della<br />
personalità e alla loro ricaduta sulla vita scolastica<br />
degli alunni.<br />
Si riconosce che l’<strong>autostima</strong> può influire in maniera<br />
determinante sul successo scolastico del<br />
bambino e dell’adolescente e con sempre maggiore<br />
frequenza si assiste alla realizzazione di interventi<br />
volti a migliorare l’<strong>autostima</strong> di singoli alunni,<br />
individuati come elementi bisognosi di sostegno<br />
e/o di intere classi o della <strong>scuola</strong>, per produrre<br />
un positivo senso di appartenenza a un gruppo<br />
privilegiato.<br />
Con questo lavoro desideriamo esporre il nostro<br />
punto di vista sui legami fra <strong>pet</strong> <strong>therapy</strong> e <strong>autostima</strong><br />
scolastica, maturato attraverso un lavoro<br />
decennale di progettazione e realizzazione di corsi<br />
di zooantropologia applicata alla didattica, nelle<br />
classi del primo e secondo ciclo della provincia di<br />
Trento, e attività assistite da animali laddove si<br />
rendono indispensabili specifici interventi di ordine<br />
assistenziale.<br />
Da queste esperienze abbiamo tratto la convinzione<br />
che l’<strong>autostima</strong> è uno degli obiettivi educativi<br />
scolastici che maggiormente può essere influenzato<br />
dalla presenza di un animale a <strong>scuola</strong>.<br />
“………………<br />
……………………<br />
……………………………<br />
Noi riteniamo che un utilizzo consapevole, attento<br />
e finalizzato della relazione bambino-animale<br />
e della referenza animale debba essere considerato<br />
un “mezzo privilegiato” per agire sull’<strong>autostima</strong><br />
in ambito scolastico.<br />
Anche se qualunque progetto educativo, che<br />
preveda la presenza di un animale a <strong>scuola</strong>, può a<br />
volte produrre degli effetti sull’<strong>autostima</strong> degli studenti<br />
sfruttando l’as<strong>pet</strong>to emozionale della relazione<br />
bambino-animale ai fini dell’apprendimento,<br />
deve essere chiaro, e non essere sottovalutato, che<br />
interventi condotti con superficialità o improvvisazione,<br />
senza tenere conto degli as<strong>pet</strong>ti fondanti della<br />
zooantropologia e della didattica, pur potendo,<br />
in maniera del tutto casuale, produrre comunque<br />
effetti positivi sugli alunni più equilibrati e motivati,<br />
possono esporre i soggetti più deboli al rischio<br />
di un danno psicologico o fisico, arrivando non solo<br />
a vanificare l’intervento ma anche a danneggiare<br />
il progetto educativo globale della <strong>scuola</strong>.<br />
Dopo avere esaminato il termine <strong>autostima</strong> nei<br />
suoi as<strong>pet</strong>ti principali e nel contesto scolastico,<br />
esporremo le nostre osservazioni sul legame tra<br />
<strong>pet</strong> <strong>therapy</strong> e <strong>autostima</strong> scolastica illustrando nel<br />
contempo il nostro modo di progettare gli interventi<br />
nella <strong>scuola</strong>.<br />
IL CONCETTO DI AUTOSTIMA<br />
Lo studio psicologico del concetto di Sé e dell’<strong>autostima</strong><br />
ha una lunga storia di elaborazioni<br />
teoriche. Tra le prime definizioni di <strong>autostima</strong> ritroviamo<br />
quella elaborata da W. James: Autostima<br />
= Successo/As<strong>pet</strong>tative. L’<strong>autostima</strong> di una<br />
persona sarebbe quindi il risultato del confronto<br />
fra successi concretamente ottenuti e corrispon-
176 Nuove pros<strong>pet</strong>tive nelle attività e terapie assistite dagli animali<br />
Tabella 1<br />
Definizioni di <strong>autostima</strong><br />
Rapporto fra successo e as<strong>pet</strong>tative di una persona<br />
Rapporto fra i risultati reali e le as<strong>pet</strong>tative ideali di<br />
una persona o anche fra i successi ottenuti e le corrispondenti<br />
as<strong>pet</strong>tative<br />
Insieme di convincimenti circa i propri valori, la<br />
com<strong>pet</strong>enza e le capacità confrontate con quelle di<br />
altri<br />
Abilità dell’individuo di affrancarsi dalle avversità<br />
Autoefficacia: far fronte alle avversità indipendentemente<br />
o ottenendo l’assistenza di persone compatibili,<br />
resilienza<br />
Capacità di confrontarsi con gli stress ambientali<br />
senza perdere l’integrità personale e assumersi le<br />
proprie responsabilità<br />
Istintiva consapevolezza del proprio valore, soddisfazione<br />
di sé, fiducia nella propria capacità di<br />
eseguire un determinato lavoro<br />
Esperienza emozionale suscitata dalla realizzazione<br />
di azioni, da eventi, da comportamenti sostenuti<br />
e dettati dal sistema di valori che l’individuo si è<br />
dato e che la sua appartenenza culturale e la sua<br />
esperienza hanno contribuito a definire<br />
Corretta autopercezione o pieno riconoscimento<br />
dei propri valori o difetti<br />
Giudizio relativo a uno specifico ambito di vita<br />
(scolastico, sociale, lavorativo…)<br />
Schema comportamentale e cognitivo appreso, multidimensionale,<br />
riferito a vari contesti, che si basa<br />
sulla valutazione espressa dall’individuo delle esperienze<br />
e dei comportamenti passati, influenza i suoi<br />
comportamenti attuali e predice quelli futuri<br />
denti as<strong>pet</strong>tative. Tale definizione trascurava però<br />
di prendere in considerazione l’effetto dei fattori<br />
ambientali che contribuiscono a migliorare o a<br />
peggiorare le prestazioni di ogni individuo.<br />
Nel lungo dibattito fra comportamentisti e psicologi<br />
cognitivi, nel tentativo di descrivere l’essenza<br />
profonda dell’individuo, sono state formulate<br />
moltissime definizioni del concetto di Sé e di <strong>autostima</strong><br />
(vedi tabella 1).<br />
In questo contesto abbiamo cercato di utilizzare<br />
ed evidenziare le definizioni che a noi sono<br />
sembrate più adatte a questo lavoro (indirizzato<br />
prevalentemente a veterinari e quindi a non addetti<br />
ai lavori), considerando che approfondire<br />
questo argomento non rientrava comunque nei<br />
nostri scopi.<br />
L’<strong>autostima</strong> può anche essere definita come “la<br />
capacità di confrontarsi con gli stress ambientali<br />
senza perdere l’integrità personale e di assumersi<br />
la responsabilità delle proprie azioni”.<br />
La stima di sé comprende quindi: l’intima consapevolezza<br />
del proprio valore, la soddisfazione di<br />
Sé e la fiducia nella propria capacità di eseguire<br />
un determinato lavoro e può originare dal possesso<br />
di capacità personali innate o acquisite oppure<br />
dal possesso di caratteristiche più o meno apprezzabili<br />
e/o apprezzate da altri (vedi tabella 2).<br />
Se identifichiamo l’<strong>autostima</strong> con il giudizio di<br />
stima di Sé, cioè il fatto di apprezzarsi, piacersi, pensare<br />
di valere, la conseguenza probabilmente più<br />
importante della buona o della cattiva <strong>autostima</strong> riguarda<br />
l’umore: giudizi negativi severi, frequenti e<br />
generalizzati su di Sé portano a sentimenti di tipo<br />
negativo (sconforto, vergogna, colpa, ansia), mentre<br />
giudizi positivi frequenti e generalizzati su di Sé portano<br />
a sentimenti di entusiasmo, vitalità e serenità.<br />
Quando il livello di <strong>autostima</strong> è esageratamente<br />
alto il soggetto ha un’immagine di Sé grandiosa<br />
e onnipotente, mentre nel caso contrario ci troviamo<br />
di fronte alla più completa disistima.<br />
Un adeguato livello di <strong>autostima</strong> implica una<br />
personalità forte e ben strutturata, una sicurezza<br />
di base e un’autonomia psicologica.<br />
In termini generali si può dire che è estremamente difficile<br />
godere di una buona salute psicologica se si è privi di<br />
una buona <strong>autostima</strong> e il benessere, da essa derivato, è associato<br />
spesso con la disponibilità a raffigurarsi realistiche<br />
pros<strong>pet</strong>tive positive.<br />
L’<strong>autostima</strong> non va però intesa come un giudizio<br />
generale che riguarda il Sé globalmente, ma<br />
è piuttosto un giudizio relativo a uno specifico<br />
ambito di vita.<br />
Gli individui misurano il loro valore personale<br />
dal lavoro, dalla vita familiare, dalla vita sociale e di<br />
comunità e dalle attività del tempo libero. Un atleta<br />
può essere orgoglioso dei suoi risultati sportivi ma<br />
insoddisfatto delle sue capacità sociali; un professionista<br />
molto impegnato può avere un’alta stima di Sé<br />
per quanto riguarda il lavoro, non apprezzandosi<br />
nel contempo come genitore o come marito.
Pet <strong>therapy</strong> e <strong>autostima</strong> a <strong>scuola</strong> 177<br />
Tabella 2<br />
Fonti di <strong>autostima</strong><br />
Possesso capacità personali innate o acquisite (com<strong>pet</strong>enze personali)<br />
Giudizio personale<br />
La persona si sente orgogliosa quando raggiunge risultati<br />
che considera pregevoli.<br />
Un individuo è soddisfatto di Sé quando fa bene ciò<br />
che per lui è importante saper fare e, viceversa, è<br />
scontento di Sé quando non riesce a essere all’altezza<br />
del suo standard di merito.<br />
Un modo per mantenere alta l’<strong>autostima</strong> che deriva<br />
dalla com<strong>pet</strong>enza consiste nel coltivare le proprie capacità<br />
negli ambiti di vita a cui si dà personalmente<br />
importanza<br />
Giudizio altrui<br />
La persona si sente approvata per i risultati raggiunti.<br />
Spesso gli individui sono oggetto di critiche e disapprovazione<br />
perché non riescono a essere all’altezza<br />
degli ideali o degli standard di aspirazione imposti da<br />
altri.<br />
Se una persona fa propri degli standard troppo elevati,<br />
proposti o imposti da altri, condanna se stessa a<br />
una bassa <strong>autostima</strong>, poiché non riuscirà mai a essere<br />
abbastanza com<strong>pet</strong>ente<br />
Possesso di caratteristiche più o meno apprezzabili e/o apprezzate da altri<br />
Giudizio personale<br />
L’<strong>autostima</strong> deriva dal giudizio che la persona esprime<br />
su caratteristiche personali che ritiene importanti quali:<br />
l’as<strong>pet</strong>to fisico, lo status sociale, ecc.<br />
L’ambiente sociale e culturale in cui il soggetto si forma<br />
e vive è estremamente importante nella determinazione<br />
dei parametri attraverso cui l’individuo giudica<br />
se stesso.<br />
Il confronto continuo, per esempio, con modelli corporei<br />
proposti dalla pubblicità può condurre a giudizi negativi<br />
sul proprio as<strong>pet</strong>to, sulla propria statura o prestanza<br />
fisica, del tutto ingiustificati seguendo parametri<br />
basati sulla media degli individui<br />
Giudizio altrui<br />
Il senso di valore personale di ognuno di noi tende a<br />
riflettere le valutazioni ricevute da altri, in quanto persone<br />
ritenute importanti o in generale per giudizi basati<br />
su stereotipi culturali e/o sociali.<br />
Spesso le persone vengono classificate in gruppi apprezzati<br />
o disprezzati sulla base della loro etnia, della<br />
razza, dell’orientamento sessuale o delle loro caratteristiche<br />
fisiche e vengono trattate di conseguenza con<br />
l’atteggiamento dettato dallo stereotipo sociale e non<br />
da quello che meriterebbe la loro individualità.<br />
Nelle situazioni in cui viene dato rilievo allo stereotipo,<br />
le persone che possiedono attributi denigrati dalla<br />
società, e che accettano le valutazioni negative, avranno<br />
una bassa stima di sé indipendentemente dal loro<br />
talento<br />
L’analisi dei giudizi sul valore personale di un<br />
individuo relativi ad ambiti di vita specifici permette<br />
di evidenziare e differenziare le aree di <strong>autostima</strong><br />
e quelle di vulnerabilità e denigrazione di Sé.<br />
AUTOSTIMA NEI BAMBINI<br />
E NEGLI ADOLESCENTI<br />
Durante gli anni evolutivi, dalla nascita al diciottesimo<br />
anno circa, il sistema nervoso centrale<br />
viene modellato dall’ambiente, in quanto naturalmente<br />
il cervello tende a formarsi in conformità<br />
con gli stimoli che gli giungono dall’ambiente do-<br />
ve cresce. Una volta adulto, il cervello umano risulterà<br />
essere il più conforme possibile all’ambiente<br />
dove è cresciuto, cioè massimamente adattato a<br />
quell’ambiente.<br />
Si presume che l’<strong>autostima</strong> si sviluppi in un<br />
modo strutturato secondo i principi dell’apprendimento.<br />
I bambini agiscono entro il proprio ambiente<br />
familiare, scolastico e sociale andando incontro<br />
a una progressiva modificazione del comportamento.<br />
L’evoluzione del comportamento avviene<br />
sulla base dei successi e fallimenti, del modo<br />
in cui le persone che li circondano reagiscono alla<br />
loro presenza e al loro modo di agire, e in base al<br />
modo con cui queste persone condizionano i loro
178 Nuove pros<strong>pet</strong>tive nelle attività e terapie assistite dagli animali<br />
comportamenti e manifestano loro as<strong>pet</strong>tative diverse.<br />
Attraverso continui feedback ambientali, diretti<br />
e indiretti, i bambini apprendono schemi di risposta<br />
sia specifici sia generalizzati, che incorporano<br />
le loro passate esperienze e sono coerenti con esse.<br />
Possiamo quindi definire l’<strong>autostima</strong> come un<br />
comportamento appreso che si evolve nei contesti<br />
ambientali in cui i bambini e gli adolescenti si trovano<br />
ad agire.<br />
Gli studi teorici che hanno, tra l’altro, portato<br />
alla formulazione del Test di valutazione Multidimensionale<br />
dell’Autostima (TMA), evidenziano<br />
sei contesti con cui i bambini si confrontano per la<br />
maggior parte del tempo in cui interagiscono con<br />
l’ambiente (stato di veglia):<br />
- le relazioni interpersonali: relazioni con “altre<br />
persone” che possono essere a loro volta distinte<br />
in due gruppi: abituali, cioè persone<br />
che costituiscono l’ambito usuale di relazione<br />
del bambino (familiari, compagni di <strong>scuola</strong>,<br />
insegnanti, ecc.) e occasionali, cioè persone<br />
che attraverso una breve o inas<strong>pet</strong>tata relazione<br />
riescono comunque a modificare lo schema<br />
comportamentale del bambino. L’<strong>autostima</strong><br />
interpersonale dei ragazzi è influenzata<br />
dalle reazioni delle altre persone, dal grado in<br />
cui tali contatti avvengono in modo positivo<br />
e dalla loro capacità di raggiungere obiettivi<br />
attraverso interazioni sociali riuscite;<br />
- la com<strong>pet</strong>enza di controllo dell’ambiente: man mano<br />
che i ragazzi riescono o falliscono nei loro<br />
tentativi di risolvere problemi, raggiungere<br />
obiettivi, migliorare la loro qualità di vita, capiscono<br />
come gli altri reagiscono ai loro sforzi,<br />
valutano l’efficacia delle loro azioni e acquisiscono<br />
informazioni sulla loro com<strong>pet</strong>enza<br />
nei vari ambiti;<br />
- l’emotività: gli schemi di reazione emotiva, diversificati<br />
a seconda che i comportamenti precedenti<br />
siano stati apprezzati o disprezzati, diventano<br />
stabili con l’età e i ragazzi diventano<br />
capaci di conoscere, valutare, descrivere e<br />
controllare le proprie reazioni emotive;<br />
- il successo scolastico: la <strong>scuola</strong> occupa gran parte<br />
della giornata del ragazzo. Seguire le lezioni,<br />
fare i compiti, organizzare il lavoro, operare<br />
delle scelte riguardo alle attività scolastiche e<br />
sportive future, sono ambiti in cui il ragazzo<br />
acquisisce continuamente stimoli e valuta i<br />
suoi successi reali;<br />
- la vita familiare: la famiglia, intesa nel senso di<br />
individui da cui il ragazzo dipende per assistenza,<br />
educazione e sicurezza, costituisce il<br />
centro della vita del ragazzo;<br />
- il vissuto corporeo: poiché quello che gli altri vedono<br />
di noi è, per prima cosa, il nostro corpo.<br />
Il ragazzo, che è in continuo mutamento<br />
fisico, riceve sempre feedback diretti e indiretti<br />
sulla sua condizione corporea e fa continui<br />
confronti tra le sue caratteristiche fisiche e<br />
quelle altrui, costruendosi così l’<strong>autostima</strong><br />
corporea.<br />
Benché l’<strong>autostima</strong> legata a questi ambiti specifici<br />
venga acquisita in ciascuno dei contesti in cui<br />
l’individuo opera, queste autostime specifiche sono<br />
moderatamente intercorrelate. In sintesi le singole<br />
autostime che si sovrappongono rappresentano<br />
l’<strong>autostima</strong> globale.<br />
Il bambino descrive le sue esperienze emozionali<br />
positive, identificabili con l’<strong>autostima</strong>, con parole<br />
quali: essere fiero di sé, orgoglioso, sicuro,<br />
soddisfatto, sentirsi migliore, più serio, più cosciente,<br />
“diverso”, “se stesso”.<br />
Il bambino riconosce la fonte di questa <strong>autostima</strong><br />
sia in situazioni sociali, quali: il successo sportivo,<br />
l’aiuto offerto ad altri, il successo negli scambi<br />
e nelle interazioni sociali, nell’esibizione di abilità<br />
in pubblico (social skills); sia nella possibilità autoriflessiva:<br />
compiacimento per il buon esito nel<br />
compito, per l’affermazione di sé in termini di autonomia<br />
di giudizio e di comportamento, per fedeltà<br />
ai valori etici che ispirano la condotta di ciascuno.<br />
Sembra inoltre che nei maschi l’<strong>autostima</strong> venga<br />
elicitata soprattutto dal successo conseguito in<br />
situazioni pubbliche, confermato in termini di approvazione<br />
sociale, mentre nelle femmine da situazioni<br />
più intime e personali connesse alla propria<br />
autonoma autorealizzazione.<br />
PET RELATIONSHIP E AUTOSTIMA<br />
L’<strong>autostima</strong>, in quanto comportamento appreso,<br />
risente di tutte le variabili ambientali con cui il<br />
soggetto si trova a interagire.<br />
I rapporti con gli animali, siano essi occasionali<br />
(casuali o finalizzati) o stabili (animali di proprietà),<br />
rappresentano senza dubbio una variabile<br />
ambientale importante per i risvolti emotivi e culturali<br />
che comportano.
Pet <strong>therapy</strong> e <strong>autostima</strong> a <strong>scuola</strong> 179<br />
L’interazione con un animale può agire in ciascuno<br />
degli ambiti specifici, visti in precedenza, in<br />
cui l’<strong>autostima</strong> si costruisce e ciò è particolarmente<br />
evidente nei bambini e adolescenti.<br />
Riferendosi a questi ambiti specifici l’interazione<br />
con l’animale, purché corretta, riesce a influire<br />
positivamente su:<br />
- relazioni interpersonali: la presenza di un animale<br />
aumenta le occasioni di socializzazione fornendo<br />
un immediato pretesto e un buon argomento<br />
di conversazione; chiunque è in grado<br />
di riferire un’esperienza con un animale<br />
nel suo vissuto. Diminuisce inoltre lo stress<br />
da “estraneo”, infatti da studi condotti attraverso<br />
test di percezione tematica, è stato evidenziato<br />
che le persone accompagnate da animali<br />
sono percepite come più amichevoli, meno<br />
indisponenti, più felici. Di riflesso anche<br />
chi accompagna l’animale si sente all’interno<br />
di queste categorie. L’animale, spostando l’accento<br />
comunicativo sulla comunicazione non<br />
verbale, facilita i rapporti interpersonali anche<br />
in quei soggetti per cui l’espressione verbale<br />
è difficoltosa o problematica;<br />
- com<strong>pet</strong>enza di controllo dell’ambiente: l’introduzione<br />
di un animale in un ambiente, anche noto,<br />
comporta la necessità di modificare gli schemi<br />
motori che l’individuo utilizza abitualmente.<br />
L’interazione con l’animale determina un aumento<br />
delle attività di esplorazione fornendo<br />
motivazioni e criteri di valutazione dell’ambiente<br />
diversi da quelli umani, consentendo<br />
una conoscenza migliore e una gestione più<br />
efficace dell’ambiente stesso;<br />
- emotività: poiché l’animale non giudica e non<br />
valuta, anche la risposta emotiva è più libera.<br />
Notevolmente diversi sono i parametri per<br />
cui l’animale apprezza o disprezza i comportamenti<br />
umani; opportunità e convenienza lasciano<br />
spesso il posto a spontaneità e immediatezza<br />
anche nell’accettazione o nel rifiuto<br />
dell’interazione stessa;<br />
- successo scolastico: vedremo successivamente come<br />
la presenza di un animale a <strong>scuola</strong> possa<br />
favorire il successo scolastico;<br />
- vita familiare: in questo contesto la presenza di<br />
un animale, ben integrato, favorisce le relazioni<br />
tra familiari e costituisce per il ragazzo<br />
un ulteriore quanto diverso punto di riferimento<br />
emotivo. L’animale può aiutare a superare<br />
più facilmente eventuali distacchi, naturali<br />
o dovuti per esempio a trasferimenti o separazioni.<br />
Con l’animale il bambino può sperimentare<br />
sia il ruolo genitoriale che quello di<br />
educatore migliorando le proprie com<strong>pet</strong>enze<br />
di controllo dell’ambiente e delle emozioni.<br />
L’animale fornisce al bambino un protettore e<br />
un protetto contemporaneamente, lo educa<br />
alla diversità quotidianamente, lo fa sentire<br />
amato indipendentemente dalle proprie prestazioni;<br />
- vissuto corporeo: l’abitudine alla diversità, anche<br />
fisica, indotta dalla relazione con l’animale, riduce<br />
il confronto e la ricerca di omologazione<br />
anche per le caratteristiche fisiche.<br />
Per dovere di sintesi, ci siamo limitati a tratteggiare<br />
alcune delle più evidenti correlazioni fra <strong>pet</strong><br />
relationship e <strong>autostima</strong>, peraltro sufficienti a giustificare<br />
la convinzione che la relazione bambinoanimale<br />
abbia effetti positivi sull’<strong>autostima</strong>.<br />
AUTOSTIMA E SCUOLA<br />
L’<strong>autostima</strong> può essere letta come capacità dell’individuo<br />
di pensare di valere, di raffigurarsi realistiche<br />
pros<strong>pet</strong>tive positive, di affrontare in modo<br />
adeguato le difficoltà e quindi ottenere risultati apprezzabili<br />
in qualsiasi attività decida di intraprendere.<br />
Se si riflette su questo fatto, si può comprendere<br />
come una adeguata <strong>autostima</strong> consenta all’alunno<br />
di affrontare la <strong>scuola</strong> in modo sereno e ottenere<br />
risultati corrispondenti alle proprie as<strong>pet</strong>tative.<br />
Un eccesso di <strong>autostima</strong> può generare frustrazioni,<br />
mentre una carenza di <strong>autostima</strong> può<br />
condurre a evitare gli impegni e a rinforzare ulteriormente<br />
un “cattivo” concetto di sé.<br />
L’<strong>autostima</strong> scolastica, sviluppata attraverso i<br />
propri successi e fallimenti negli ambienti e nelle<br />
attività scolastiche, pur non coincidendo con le capacità<br />
e le modalità di apprendimento, è altamente<br />
predittiva della performance scolastica futura;<br />
questo modo di “vedersi” nella <strong>scuola</strong> finisce con<br />
l’essere una misura verosimile di come effettivamente<br />
si “sarà” a <strong>scuola</strong>.<br />
Bloom (1976) affermava che ai fini pratici il<br />
concetto di Sé scolastico è la più valida delle misure<br />
psicologiche nel predire il successo scolastico<br />
per il fatto che incide per almeno il 25% sulla variazione<br />
del rendimento scolastico.<br />
Poiché il bambino trascorre a <strong>scuola</strong> molte ore<br />
della sua giornata attiva, nell’<strong>autostima</strong> scolastica
180 Nuove pros<strong>pet</strong>tive nelle attività e terapie assistite dagli animali<br />
vengono coinvolti vari as<strong>pet</strong>ti dell’<strong>autostima</strong> globale<br />
dell’individuo, come le com<strong>pet</strong>enze di controllo<br />
dell’ambiente, la capacità di gestire relazioni<br />
interpersonali, il vissuto corporeo. Ognuno di<br />
questi as<strong>pet</strong>ti può contribuire in modo significativo<br />
a decidere del futuro scolastico dell’alunno.<br />
Un bambino che non si sente apprezzato da insegnanti<br />
e compagni, per una sua caratteristica fisica<br />
o per una sua incapacità relazionale, percepirà la<br />
<strong>scuola</strong> in maniera fortemente negativa, al di là<br />
delle sue reali capacità e andrà incontro a esperienze<br />
scolastiche fallimentari.<br />
È dimostrato che queste esperienze possono limitare<br />
le possibilità di sopravvivenza economica e<br />
di sicurezza nel mondo del lavoro di questi studenti.<br />
Esiste infatti un forte legame fra la storia dei<br />
successi e degli insuccessi scolastici di un individuo<br />
e lo sviluppo globale della sua personalità.<br />
In ambito scolastico sono stati fatti molti tentativi<br />
di migliorare le prestazioni migliorando prima<br />
l’<strong>autostima</strong>, ma con risultati abbastanza deludenti.<br />
Migliori risultati si sono ottenuti cercando di modificare<br />
e migliorare ogni singola prestazione, per<br />
fornire al ragazzo una valida e tangibile ragione<br />
per aumentare la propria <strong>autostima</strong>.<br />
COME FAVORIRE L’AUTOSTIMA<br />
IN AMBITO SCOLASTICO<br />
Poiché l’<strong>autostima</strong> deriva da fonti diverse, i<br />
metodi per favorirla sono molteplici.<br />
In accordo con quanto detto, per agire sull’<strong>autostima</strong><br />
scolastica sarà conveniente agire sulle prestazioni<br />
in ambito scolastico, tenendo presente che<br />
sul giudizio di positività di una prestazione possono<br />
influire diversi fattori: personali, ambientali e<br />
oggettivi. Un risultato ottimo per alcuni, è buono<br />
per altri, scadente per altri ancora a seconda degli<br />
standard fissati dal docente e dalla <strong>scuola</strong>, dalle<br />
as<strong>pet</strong>tative dell’alunno, da come si viene giudicati<br />
per quel livello di prestazione.<br />
È evidente che esistono differenze individuali e<br />
che esistono studenti con capacità limitate, ma è<br />
fondamentale ritenere, operando di conseguenza,<br />
che per aiutare uno studente a valutarsi più positivamente<br />
bisogna portarlo a conseguire maggiori<br />
successi.<br />
Per incentivare l’<strong>autostima</strong> in ambito scolastico<br />
possono essere utilizzate strategie rivolte al<br />
singolo individuo, legate a interventi individualizzati,<br />
e strategie collettive rivolte al gruppo classe.<br />
L’intervento collettivo può mirare a intervenire<br />
su aree di <strong>autostima</strong> individuali o a migliorare<br />
l’<strong>autostima</strong> globale del gruppo intesa come patrimonio<br />
collettivo.<br />
Gli interventi individualizzati sull’<strong>autostima</strong><br />
agiscono in due direzioni: una personale, adeguando<br />
le as<strong>pet</strong>tative non realistiche e/o aumentando<br />
il livello delle prestazioni, e una ambientale,<br />
rendendo accettate o accettabili le inevitabili<br />
differenze e quindi anche le prestazioni di livello<br />
inferiore.<br />
Per mutare le percezioni di inadeguatezza può<br />
essere utile chiarire e riformulare le as<strong>pet</strong>tative<br />
personali, soprattutto quando queste sono basate<br />
non sulle proprie capacità ma sul confronto con<br />
gli altri, oppure su standard ideali realmente troppo<br />
elevati. Gli studenti che si autodenigrano perché<br />
si giudicano sulla base di standard troppo elevati<br />
possono essere aiutati ad adottare standard<br />
più modesti.<br />
Il valore dell’intervento sull’<strong>autostima</strong> deriva non solo<br />
dal miglioramento del rendimento scolastico ma dall’aver<br />
portato lo studente a scoprire le sue capacità e caratteristiche<br />
e ad accettarle, poiché un’autoaccettazione positiva è un<br />
orientamento salutare per l’adattamento sociale ed emotivo<br />
dell’individuo.<br />
Nella <strong>scuola</strong>, nel corso degli anni, si è sviluppato<br />
un complesso discorso pedagogico e culturale<br />
diretto soprattutto a risolvere il problema del<br />
recupero delle diversità inteso come minorità. Il<br />
problema è far sì che lo studente non aggravi il<br />
suo ruolo di debole con comportamenti di passività,<br />
atti a difendersi dalla continua verifica di<br />
non riuscire ad apprendere, che producono col<br />
tempo difficoltà relazionali e affettive estremamente<br />
significative.<br />
Molta meno attenzione è riservata ai soggetti<br />
scolastici ad alta abilità in una o più aree disciplinari<br />
che spesso finiscono con il trovarsi anch’essi<br />
in carenza educativa, producendo problemi e<br />
conflitti all’interno delle classi (per esempio opposizione<br />
all’autorità, difficoltà nei rapporti insegnanti-alunni).<br />
Le strategie collettive per il recupero dell’<strong>autostima</strong><br />
sono in genere più mirate a questo secondo<br />
as<strong>pet</strong>to, ma di più difficile utilizzo.<br />
Nella tabella 3 riportiamo alcuni esempi di<br />
strategie individuali e collettive per il miglioramento<br />
dell’<strong>autostima</strong> a <strong>scuola</strong>.
Pet <strong>therapy</strong> e <strong>autostima</strong> a <strong>scuola</strong> 181<br />
Tabella 3<br />
Tecniche di miglioramento dell’<strong>autostima</strong> nella <strong>scuola</strong><br />
Istruzione<br />
Consiste nel trovare e utilizzare correttivi adatti a potenziare le capacità che possono favorire risultati positivi<br />
e, con essi, la soddisfazione di sé quando l’autosvalutazione trae origine dall’incom<strong>pet</strong>enza didattica e/o disciplinare<br />
e/o relazionale. Dal punto di vista sia educativo che didattico/disciplinare è possibile insegnare a<br />
qualsiasi bambino o adolescente modi di agire più efficaci<br />
Modeling (modellamento di comportamenti appropriati)<br />
STRATEGIE INDIVIDUALI<br />
Il modellamento consiste nel far apprendere un comportamento attraverso l’osservazione di un esempio appropriato.<br />
È una procedura molto efficace quando il modello gode di grande valore agli occhi degli osservatori.<br />
I comportamenti modellati possono essere mostrati con diverse metodologie sia dal vivo che con filmati<br />
ad hoc<br />
Shaping (modellaggio o rinforzamento di approssimazioni successive al comportamento adeguato)<br />
In questo processo le azioni del soggetto sono considerate su un continuum che presenta a un estremo il comportamento<br />
desiderato e all’altro il comportamento antitetico a quello desiderato; l’operatore determina in<br />
quale punto del continuum si situa il comportamento tipico del ragazzo. Viene rinforzato ogni comportamento<br />
che risulti essere di avvicinamento a quello desiderato. Il processo di rinforzamento procede fino a che il<br />
comportamento del ragazzo non arriva quasi a coincidere con quello desiderato. L’attenzione in questo caso<br />
è tutta centrata sulla scelta e sulla gestione dei vari rinforzi<br />
Modificazione dell’ambiente<br />
Presenta una vasta gamma di possibilità, dal modificare l’ambiente fisico, al modificare il comportamento degli<br />
altri che in quell’ambiente agiscono, fino all’estrema ratio di allontanare il ragazzo da quell’ambiente.<br />
L’autosvalutazione che dipende da giudizi sociali svilenti richiede un trattamento che riaffermi il valore della<br />
persona. Se l’autosvalutazione è la conseguenza di uno svilimento discriminatorio di attributi personali, può<br />
essere utile coltivare e incentivare un senso di orgoglio per tali attributi<br />
Giochi scolastici<br />
STRATEGIE COLLETTIVE<br />
Si attuano coinvolgendo il gruppo in attività che lo identificano distinguendolo da altri (organizzazione di<br />
s<strong>pet</strong>tacoli, mostre, conferenze, avvenimenti sportivi, ecc.)<br />
Esercizi collettivi basati sull’affettività<br />
Si tratta di strutturare situazioni dove non emerga la grinta individuale ma l’autoconsapevolezza che gli elementi<br />
per “vincere” non sono patrimonio della testa di qualcuno ma diffusi nel gruppo. In questa situazione<br />
deve emergere l’intelligenza emotiva che consente di percepire le emozioni nostre e altrui<br />
Sessioni di studio a piccoli gruppi<br />
In gruppi ben strutturati ogni individuo può far valere le sue specificità, l’ascolto deve essere più importante<br />
dell’intervento, i contrasti devono essere fonti di cambiamento. Le relazioni che si stabiliscono devono essere<br />
produttive per tutti
182 Nuove pros<strong>pet</strong>tive nelle attività e terapie assistite dagli animali<br />
PET THERAPY<br />
E AUTOSTIMA A SCUOLA<br />
Le strategie volte a incentivare l’<strong>autostima</strong> in ambito<br />
scolastico, come abbiamo già visto, possono<br />
essere suddivise in individuali e collettive.<br />
Interventi rivolti al singolo individuo, realizzati<br />
attraverso la <strong>pet</strong> <strong>therapy</strong>, sono frequenti e relativamente<br />
semplici da realizzare in ambito familiare o<br />
in situazioni operative in cui sia possibile lavorare<br />
a livello individuale. Interventi individuali di <strong>pet</strong><br />
<strong>therapy</strong>, condotti esclusivamente all’interno della<br />
struttura scolastica, sono però di difficile e onerosa<br />
realizzazione.<br />
Per incentivare l’<strong>autostima</strong> attraverso strategie<br />
collettive, la referenza animale, ben utilizzata, può<br />
offrire evidenti vantaggi ris<strong>pet</strong>to ad altre forme di<br />
intervento che finiscono spesso per utilizzare contenuti<br />
che si avvicinano o identificano con alcune<br />
materie scolastiche. Musicoterapia e danzaterapia<br />
per esempio possono indurre una reazione di evitamento<br />
con diminuzione dell’<strong>autostima</strong> in quei<br />
soggetti convinti di possedere capacità limitate in<br />
quegli ambiti specifici.<br />
Abbiamo già sottolineato che l’<strong>autostima</strong> deriva<br />
anche dalle com<strong>pet</strong>enze personali e dal successo<br />
che consegue dal loro utilizzo e dunque fra gli<br />
obiettivi degli interventi scolastici mirati ad aumentare<br />
l’<strong>autostima</strong> deve essere incluso il miglioramento<br />
dei processi che favoriscono l’apprendimento.<br />
Vi sono as<strong>pet</strong>ti dell’apprendimento che possono<br />
essere favoriti dalla sola presenza fisica di un<br />
animale in classe, indipendentemente dal contenuto<br />
disciplinare del progetto educativo svolto, ris<strong>pet</strong>to<br />
a una normale lezione.<br />
Dalle nostre esperienze è emerso che la presenza<br />
di un animale in classe:<br />
- è una esperienza motivante: la curiosità destata<br />
dalla presenza dell’animale, la familiarità<br />
legata a una situazione a molti nota ma<br />
anche così diversa e imprevedibile, riesce ad<br />
agire su attenzione e motivazione. Gli insegnanti<br />
evidenziano che nelle attività svolte<br />
con animali in classe si riduce drasticamente<br />
il numero di richieste per uscire dall’aula e<br />
che la capacità di attenzione degli alunni supera<br />
abbondantemente quella delle normali<br />
situazioni di insegnamento. La presenza dell’animale<br />
aiuta a incanalare l’attenzione e<br />
può essere utilizzata per far acquisire agli<br />
alunni la consapevolezza del legame motivazione-attenzione;<br />
- è un’esperienza che coinvolge l’alunno in<br />
modo personale: la situazione di novità, di<br />
esperienza da trasmettere o di paura da vincere,<br />
la rende una situazione emozionalmente<br />
forte e quindi favorente l’apprendimento<br />
e la memorizzazione delle nozioni<br />
trasmesse;<br />
- gli stimoli sono integrabili con la situazione<br />
conoscitiva degli alunni: nei test somministrati<br />
agli alunni durante i nostri corsi il<br />
93% di essi afferma di aver letto almeno un<br />
libro sugli animali e il 100% dichiara comunque<br />
di aver avuto informazioni sugli<br />
animali da varie fonti. Non mancano quindi<br />
numerosi legami con la matrice cognitiva<br />
dell’alunno;<br />
- gli stimoli vengono percepiti come “significativi”:<br />
gli alunni che hanno una organizzazione<br />
cognitiva a livello di schemi sensorio-motori<br />
non percepiscono come “stimolante” uno stimolo<br />
puramente verbale. La presenza in aula<br />
di un animale stimola la gestualità e la comunicazione<br />
consentendo a tutti di esprimersi e<br />
di registrare l’esperienza;<br />
- gli stimoli si dimostrano funzionali a bisogni<br />
profondi: per i bambini e per gli adolescenti<br />
è semplice considerare l’animale come estensione<br />
di loro stessi e usarlo per esprimere<br />
sentimenti o dubbi che non oserebbero fare<br />
in linea diretta: per esempio tutto quello che<br />
riguarda la sfera affettiva e sessuale (sono<br />
frequenti le domande del tipo: i cani fanno<br />
amicizia fra loro?, i cani sentono dolore per<br />
la perdita di un amico?, può un cane di una<br />
razza mettere incinta una cagna di un’altra<br />
razza ?, ecc.);<br />
- la situazione ambientale è percepita come “rilassante”:<br />
la presenza dell’animale colora l’atmosfera<br />
dell’aula di allegria e tranquillità. Nei<br />
test somministrati agli alunni durante i nostri<br />
corsi il 100% degli alunni afferma che agli<br />
animali piace giocare e che con loro è possibile<br />
scherzare e ridere, non si offendono mai;<br />
- la situazione è percepita come positivamente<br />
operativa: l’animale fa sentire gli alunni più<br />
sicuri e più fiduciosi di poter capire e riuscire.<br />
Non è il caso di aver paura di sbagliare,<br />
l’animale non sarà mai critico verso difficoltà<br />
ed errori.
Pet <strong>therapy</strong> e <strong>autostima</strong> a <strong>scuola</strong> 183<br />
Tutte le osservazioni elencate, se lette secondo<br />
Frabboni e la sua teoria dei “saperi caldi e<br />
freddi”, ci possono aiutare a comprendere anche<br />
come la presenza fisica dell’animale in classe<br />
possa migliorare la memorizzazione e l’utilizzo<br />
delle nozioni offerte durante le lezioni, con un<br />
conseguente aumento delle aree di <strong>autostima</strong><br />
correlate.<br />
Frabboni chiama:<br />
- saperi freddi: i saperi indiretti, separati dalla<br />
concretezza della realtà, non correlati con le<br />
conoscenze precedenti (per esempio ai bambini<br />
vengono spiegate le funzioni dei vari<br />
apparati del corpo e poi viene loro chiesto<br />
di descrivere il percorso dell’acqua nell’organismo.<br />
La domanda ha lo scopo di “leggere”<br />
la rappresentazione che essi hanno del<br />
loro corpo e come questa venga influenzata<br />
dalle nozioni somministrate. Molti alunni<br />
tendono a rappresentare l’organismo come<br />
un tubo rispondendo che l’acqua entra dalla<br />
bocca, va nello stomaco…, ed esce dal sedere<br />
(Questa conclusione mostra chiaramente<br />
un divario tra conoscenze scolastiche ed<br />
esperienza quotidiana);<br />
- saperi caldi: le conoscenze dirette, problematiche,<br />
mobili, colte in tempo reale con<br />
linguaggi familiari, corporei, a contatto con<br />
la realtà e che vanno quindi a costruire un<br />
bagaglio culturale integrandosi perfettamente<br />
con le conoscenze pregresse dei ragazzi.<br />
In un processo di apprendimento, l’informazione<br />
viene assunta e utilizzata per operare;<br />
se si rivela funzionale al cambiamento (permette<br />
di attuarlo, lo facilita, lo rende meno gravoso)<br />
essa viene memorizzata ed entra a far parte<br />
delle com<strong>pet</strong>enze della persona con un preciso<br />
riferimento operativo. Se non si rivela funzionale<br />
viene accantonata e col tempo dimenticata<br />
e rimossa.<br />
Si ha apprendimento quando la nuova<br />
informazione-esperienza, inizialmente estranea<br />
al soggetto, si inserisce organicamente nel suo<br />
pensiero personale e, verificata sul piano dell’efficacia,<br />
diventa capacità. Se la conoscenza<br />
rimane a livello di informazione resta estranea<br />
al pensiero personale (o lo deforma o ne resta<br />
deformata) e non si ha apprendimento. Il sapere<br />
sugli animali trasmesso dalla <strong>scuola</strong> sembra<br />
frequentemente relegato in un settore colto,<br />
canonico, “scolastico“ dal quale si attinge<br />
solo per il “maestro/professore”, ma che non è<br />
funzionale al vivere quotidiano. Il sapere<br />
“spontaneo” e il sapere “formale” possono trovare<br />
un luogo di incontro ricco di elementi di<br />
continuità nelle esperienze condotte con animali.<br />
Quanto sopra espresso, se da una lato evidenzia<br />
quanto possa essere preziosa la presenza<br />
di un animale in classe da un punto di vista didattico,<br />
ci aiuta anche a capire perché, a livello<br />
scolastico ed educativo, vengano spesso confusi<br />
con la <strong>pet</strong> <strong>therapy</strong> interventi, più o meno improvvisati,<br />
in cui in aula gli animali vengono utilizzati<br />
da un mero punto di vista performativo,<br />
affidando al caso e alla “bontà” dell’animale il<br />
raggiungimento di un qualsivoglia obiettivo individuato<br />
poi a posteriori.<br />
Le esperienze con gli animali possono rivelarsi<br />
anche disastrose se affrontate da persone senza la<br />
necessaria preparazione ed esperienza. Evoluzioni<br />
spesso impreviste o tragiche, dal punto di vista<br />
emozionale-educativo, possono essere diretta conseguenza:<br />
- della leggerezza con cui alcuni libri di testo<br />
propongono esperienze che coinvolgono gli<br />
animali, senza specificare con precisione<br />
obiettivi, condizioni ambientali e strumentazione<br />
necessari per un esito positivo;<br />
- della inadeguatezza della preparazione in<br />
campo igienico-sanitario, zooantropologico ed<br />
etologico di maestri e insegnanti;<br />
- della scarsa considerazione rivolta alle sensibilità<br />
e reattività di animali posti in condizioni<br />
ambientali a loro sconosciute.<br />
Esempi diseducativi che possono essere riportati<br />
sono: allestimento di un acquario o di un terrario<br />
e successiva morte di tutti gli animali, nascita<br />
da un’incubatrice di pulcini senza che ne sia<br />
stata prevista una successiva destinazione; morso<br />
o graffio da animale domestico non adeguatamente<br />
addestrato.<br />
Se vogliamo che i nostri interventi non si limitino<br />
a cogliere solo alcune delle possibilità offerte<br />
dalla referenza animale, che tutto si svolga<br />
in un clima sereno e sicuro con il fine di raggiungere<br />
obiettivi educativi, didattici e disciplinari<br />
certi e stabili nel tempo, occorre fondare il<br />
lavoro su una attenta progettazione. Riportiamo<br />
in tabella 4 i criteri di progettazione da noi ritenuti<br />
essenziali.
184 Nuove pros<strong>pet</strong>tive nelle attività e terapie assistite dagli animali<br />
Tabella 4<br />
Criteri di progettazione dei corsi<br />
Precisa individuazione degli obiettivi educativi, didattici<br />
e disciplinari e attenta formulazione delle<br />
unità didattiche<br />
Attenta e adeguata collocazione nel contesto didattico<br />
che preveda il consolidamento, a lungo termine,<br />
degli apprendimenti<br />
Equipe formata da professionisti muniti di una comune<br />
piattaforma di conoscenze in campo zooantropologico<br />
Scelta di animali dotati di caratteristiche fisiologiche<br />
e comportamentali compatibili con gli obiettivi<br />
del progetto, in buono stato di salute psicofisico-funzionale<br />
e opportunamente addestrati<br />
Strutturazione dell’intervento in modo da prevedere,<br />
a fronte di una breve durata, un forte impatto<br />
emotivo<br />
Garanzia per ogni alunno di poter godere di un<br />
corretta relazione con l’animale sotto la guida e la<br />
sorveglianza di una persona esperta<br />
Valutazione a breve e lungo termine dei risultati del<br />
corso e degli elaborati prodotti<br />
LA PROGETTAZIONE<br />
DEGLI INTERVENTI<br />
I nostri interventi nella <strong>scuola</strong> sono progettati<br />
per alunni normodotati e strutturati seguendo un<br />
preciso schema di progettazione articolato in 7<br />
punti:<br />
1) incontro con l’insegnante responsabile dei progetti di<br />
educazione alla salute della <strong>scuola</strong> e gli insegnanti che seguiranno<br />
gli alunni durante il corso. Riteniamo che<br />
qualsiasi progetto, per essere produttivo, non possa<br />
essere inserito con leggerezza in un qualunque<br />
curricolo, ma debba avere una adeguata collocazione<br />
in un contesto didattico che preveda il consolidamento,<br />
a lungo termine, degli apprendimenti<br />
avvenuti negli incontri con i membri dell’équipe di<br />
lavoro. La <strong>scuola</strong> deve assicurare il coinvolgimento<br />
e la collaborazione degli insegnanti della classe e<br />
dei membri dei consigli di classe interessati. Vengono<br />
sempre suggeriti degli incontri di preparazione<br />
per predisporre le necessarie condizioni affin-<br />
ché: siano chiare e condivise le motivazioni della<br />
richiesta del corso e gli insegnanti siano in possesso<br />
delle conoscenze necessarie e disponibili a continuare<br />
il lavoro sui temi del corso anche in altri<br />
contesti. Gli insegnanti devono impegnarsi a valorizzare<br />
le esperienze individuali degli alunni con gli<br />
animali, precedenti e successive al corso, e ad aiutare<br />
a trasferire l’attenzione e la considerazione che<br />
gli alunni mostrano spontaneamente all’animale<br />
nel rapporto con gli altri. Nel curricolo scolastico<br />
dovranno essere anche inserite e affrontate le tematiche<br />
riguardanti la protezione e tutela degli animali,<br />
in quanto anelli più deboli della catena sociale,<br />
con il fine di stimolare i ragazzi a trasferire tali<br />
concetti nel rapporto inter-umano. È essenziale anche<br />
che la <strong>scuola</strong> provveda a comunicare per iscritto<br />
ai genitori degli alunni l’effettuazione del corso,<br />
le sue finalità e il periodo di svolgimento, fornisca<br />
numeri e recapiti delle figure professionali coinvolte<br />
e richieda l’autorizzazione firmata alla partecipazione<br />
al corso e soprattutto all’utilizzo da parte sia<br />
della <strong>scuola</strong> che dell’équipe degli elaborati degli<br />
alunni. Il materiale raccolto può essere utilizzato in<br />
modi e contesti diversi a seconda del professionista<br />
che lo valuta e dello scopo per il quale si effettua la<br />
valutazione (per esempio ricerca statistica, valutazione<br />
psicologica del soggetto, ecc.); in particolare<br />
l’utilizzo a scopo clinico degli elaborati da parte<br />
dello psicologo e/o del medico pediatra devono<br />
sottostare a quanto previsto dalla Legge sulla tutela<br />
dei minori, dalla Legge sulla privacy e dalla<br />
Legge sul segreto professionale;<br />
2) individuazione dei soggetti cui il progetto è destinato,<br />
durata del corso, tempi e modi di attuazione. Potranno<br />
essere scelte classi intere o gruppi di alunni di<br />
diverse classi. Agli incontri caratterizzati dalla presenza<br />
di animali riteniamo essenziale prevedere<br />
dei gruppi costituiti al massimo da 12 bambini per<br />
poter assicurare a tutti la possibilità di interagire e<br />
intervenire. Il corso dovrà essere collocato nel periodo<br />
dell’anno più consono agli obiettivi e ai collegamenti<br />
con lo svolgimento del programma scolastico.<br />
L’esperienza ci ha insegnato che lo svolgimento<br />
nel periodo iniziale dell’anno scolastico risulta<br />
più proficuo quando fra gli obiettivi del progetto<br />
sono inseriti l’accoglienza e l’affezione alla<br />
struttura scolastica e la formazione di un reale<br />
gruppo classe, mentre lo svolgimento nel periodo<br />
intermedio-finale risulta particolarmente indicato<br />
per migliorare eventuali situazioni di socializzazione<br />
difficile e di autosvalutazione;
Pet <strong>therapy</strong> e <strong>autostima</strong> a <strong>scuola</strong> 185<br />
3) individuazione degli obiettivi del progetto. Riteniamo<br />
utile distinguere obiettivi educativi (per<br />
esempio rinforzare nei ragazzi sentimenti positivi<br />
di sé, sviluppare atteggiamenti positivi nei<br />
confronti dell’apprendimento, prevenire lo sviluppo<br />
di comportamenti antisociali e a rischio,<br />
ecc.), obiettivi didattici (per esempio favorire<br />
l’attivazione di processi di scelta consapevoli e<br />
autonomi, migliorare la capacità di osservazione,<br />
ecc.), obiettivi emendativi-assistenziali con<br />
interventi specifici su situazioni con deficit di <strong>autostima</strong><br />
e obiettivi disciplinari (per esempio arricchimento<br />
delle nozioni di anatomia e fisiologia<br />
comparate);<br />
4) individuazione dell’équipe di lavoro. In genere<br />
abbiamo sempre previsto la presenza di un insegnante<br />
esperto in zooantropologia ed educazione<br />
alla salute, di un veterinario e di uno psicologo,<br />
e, in qualche caso, di un pediatra. Un insegnante<br />
con una buona conoscenza della zooantropologia<br />
applicata è indispensabile, con funzioni<br />
di consulenza nella progettazione degli interventi<br />
e di coordinatore per assicurare coerenza<br />
con il Piano dell’Offerta Formativa della <strong>scuola</strong><br />
e una adeguata collocazione nel contesto didattico.<br />
Un veterinario, che non solo conosca la<br />
zooantropologia applicata ma che sia anche in<br />
possesso di un’adeguata sensibilità e preparazione<br />
in campo didattico, cui saranno affidati, singolarmente<br />
o in copresenza, gli incontri che prevedono<br />
la presenza in aula di animali. Egli dovrà<br />
essere garante anche della correttezza del<br />
rapporto bambino-animale che si svilupperà durante<br />
le lezioni, dell’efficacia educativa di questo<br />
rapporto, della sicurezza igienico-sanitaria, dell’opportuno<br />
addestramento degli animali coinvolti<br />
e della tutela del loro benessere. Uno psicologo<br />
in quanto figura essenziale per affrontare<br />
al meglio tutte le problematiche emotive e psicologiche<br />
legate allo sviluppo del bambino e dell’adolescente.<br />
A questo professionista viene affidata<br />
anche la valutazione dell’efficacia del corso<br />
riguardo agli obiettivi non disciplinari del corso.<br />
Un pediatra in quanto rappresenta il professionista<br />
più adatto ad affrontare i quesiti inerenti le<br />
tematiche in ambito medico e igienico-sanitario<br />
legate all’età dello sviluppo;<br />
5) progettazione delle unità didattiche. La progettazione<br />
delle UD avviene sulla base degli obiettivi,<br />
educativi, didattici e disciplinari stabiliti,<br />
del numero di ore di lezione e delle com<strong>pet</strong>enze<br />
specifiche di ciascun componente dell’équipe<br />
di lavoro. Ogni as<strong>pet</strong>to deve essere attentamente<br />
valutato al fine di cogliere tutte le valenze offerte<br />
dalla referenza animale (Marchesini,<br />
2000);<br />
6) progettazione dei test di ingresso e di uscita. I nostri<br />
test di ingresso sono costituiti per la maggior<br />
parte da quesiti a scelta multipla, aperta, in modo<br />
da privilegiare semplicità e immediatezza nella<br />
compilazione e la facile tabulazione delle risposte.<br />
Ogni domanda è elaborata con lo scopo di raccogliere<br />
gli elementi necessari a tarare il livello e i<br />
contenuti degli incontri e a valutare eventuali disagi<br />
dell’alunno riguardo all’argomento trattato.<br />
Alla fine del test l’alunno viene invitato a realizzare<br />
un disegno sull’argomento del corso e a scriverne<br />
il titolo. Il test viene somministrato dall’insegnante<br />
responsabile per la classe in modo da<br />
salvaguardare il più possibile spontaneità e individualità<br />
nella esecuzione. Il test dovrà anche permettere<br />
di individuare eventuali alunni allergici<br />
agli animali utilizzati nel corso per poter adottare<br />
le opportune precauzioni o soluzioni (cambio di<br />
animale quando possibile, mascherina con filtro<br />
adatto, cambio di aula, ecc.). Il test di uscita è<br />
strutturato in forma aperta (mappa) e realizzato<br />
con i seguenti obiettivi: far riflettere gli alunni<br />
sulle lezioni svolte, evidenziare gli as<strong>pet</strong>ti positivi<br />
e quindi l’accoglienza riservata dagli alunni al<br />
corso, segnalare gli as<strong>pet</strong>ti negativi o di disagio<br />
del corso al fine di migliorarlo, scoprire eventuali<br />
ulteriori bisogni di qualche alunno, fare emergere<br />
atteggiamenti o convinzioni individuali particolari<br />
e raccogliere eventuali curiosità e/o interrogativi<br />
rimasti ancora senza risposta. Viene inoltre<br />
chiesto a ogni alunno di fare un altro disegno con<br />
titolo, a piacere, sulle cose imparate durante il<br />
corso. Sia il test di ingresso che il test d’uscita riportano,<br />
in calce al foglio, i ringraziamenti per<br />
aver lavorato con l’équipe e i saluti con un arrivederci<br />
a presto;<br />
7) valutazione dei risultati del corso e degli elaborati.<br />
Distinguiamo una valutazione degli elaborati<br />
individuale, immediata e congiunta fra equipe di<br />
lavoro e insegnanti con particolare riguardo al<br />
confronto fra i disegni effettuati all’inizio e alla<br />
fine del corso e dell’impatto emotivo del corso,<br />
ritenendolo un possibile valido indicatore dell’apprendimento.<br />
Altre forme di verifica individuale,<br />
sia orali che scritte (prove oggettive, interrogazioni<br />
o altro), possono essere effettuate
186 Nuove pros<strong>pet</strong>tive nelle attività e terapie assistite dagli animali<br />
Tabella 5<br />
Esempi di altri corsi che hanno evidenziato effetto<br />
nell’incrementare l’<strong>autostima</strong><br />
“E adesso? Resto o scappo?…”<br />
Dal ruolo di osservatore passivo verso la<br />
capacità: di essere d’aiuto, di agire in prima<br />
persona e di assumersi delle responsabilità<br />
Corso basato sulla didattica zooantropologica finalizzato<br />
a incentivare l’iniziativa personale e la cooperazione<br />
responsabile<br />
L’educazione sessuale del bambino attraverso<br />
lo studio degli animali<br />
Corso basato sulla didattica zooantropologica finalizzato<br />
all’educazione sessuale nelle scuole<br />
DIRE, FARE, MANGIARE<br />
L’educazione alimentare del bambino attraverso<br />
lo studio degli animali: un approccio<br />
zooantropologico<br />
Un mondo di Amici<br />
Corso basato sulla didattica zooantropologica finalizzato<br />
a incentivare la curiosità e l’amore verso il<br />
prossimo, gli animali e la natura<br />
dagli insegnanti riguardo agli obiettivi didattici e<br />
disciplinari del corso. La valutazione a lungo<br />
termine degli obiettivi educativi viene demandata<br />
agli insegnanti della classe. Nella nostra esperienza<br />
tale valutazione è sempre risultata positiva,<br />
infatti i progetti continuano a essere richiesti<br />
e attivati nelle scuole in cui sono stati proposti.<br />
Poiché i nostri progetti sono sempre stati attivati<br />
in una zona che, per caratteristiche geografiche<br />
e sociali, presenta scuole “piccole” in cui la presenza<br />
di classi parallele è rara, non è mai stato<br />
possibile creare le condizioni per trasformare gli<br />
interventi in protocolli di ricerca e validare i dati<br />
raccolti con criteri riconosciuti nelle scienze<br />
comportamentali applicate o biomediche o psicosociali.<br />
Nelle nostre prime esperienze (1991-92) alcuni<br />
di questi punti non erano ancora ben definiti<br />
e in particolare non era prevista una équipe di<br />
lavoro allargata oltre la coppia veterinario-insegnante.<br />
Con il diversificarsi delle esperienze, tra<br />
cui l’organizzazione di un corso di aggiornamento<br />
per insegnanti (1998-99), e delle richieste del-<br />
le scuole per ambiti educativi diversi e anche delicati<br />
come l’educazione sessuale e l’educazione<br />
alimentare, la necessità di altre com<strong>pet</strong>enze/figure<br />
professionali è risultata evidente. I buoni risultati<br />
ottenuti con l’équipe allargata hanno avuto<br />
come conseguenza un arricchimento e una<br />
riformulazione dei corsi iniziali.<br />
Anche in altri corsi da noi svolti in cui l’<strong>autostima</strong><br />
non era un obiettivo educativo esplicito<br />
(vedi per esempio tabella 5), risultava comunque<br />
sempre evidente, secondo quanto comunicatoci<br />
dai docenti, un incremento di essa, in<br />
particolare per quegli alunni i cui “risultati”,<br />
nell’attività didattica quotidiana, erano scarsi<br />
e/o discontinui in assenza di specifici deficit di<br />
apprendimento.<br />
Il progetto attuale del corso finalizzato al miglioramento<br />
dell’<strong>autostima</strong> dal titolo: “Meglio<br />
dire… io oppure… io ?” viene presentato nella<br />
tabella 6.<br />
Le unità didattiche di questo corso affidate al<br />
veterinario prevedono in aula di volta in volta: 2<br />
cani, 1 gatto e dei piccoli animali da voliera, gabbia<br />
e acquario e sono così strutturate:<br />
- conoscenza dell’animale: attraverso una carrellata<br />
di diapositive su cani e gatti di razze diverse<br />
e meticci, vengono affrontati i concetti<br />
di specie, razza, selezione naturale e selezione<br />
operata dall’uomo, significato dell’addomesticamento,<br />
intelligenza e sensibilità<br />
degli animali. Ogni diapositiva, opportunamente<br />
scelta, viene accompagnata dal racconto<br />
della storia della razza dell’animale e<br />
da un commento sulle caratteristiche<br />
morfologiche e comportamentali che la contraddistinguono,<br />
specificando i motivi che<br />
hanno guidato l’uomo nella sua selezione<br />
(sono incluse anche diapositive dei 2 cani<br />
presenti in aula);<br />
- conoscenza del cane: attraverso la simulazione<br />
di una visita veterinaria vengono illustrati il<br />
corretto approccio con il cane e alcune nozioni<br />
sul suo linguaggio, dando a ogni alunno<br />
la possibilità di interagire personalmente<br />
con l’animale e di compiere, per imitazione,<br />
una visita. Nell’animale la morfologia, per<br />
selezione, è strettamente correlata alla funzione<br />
e questo permette di affrontare, nel<br />
percorso di conoscenza anatomica, anche il<br />
significato delle differenze individuali di<br />
ogni alunno;
Pet <strong>therapy</strong> e <strong>autostima</strong> a <strong>scuola</strong> 187<br />
Tabella 6<br />
Progetto del corso: “Meglio dire… io oppure… io ?”<br />
Corso basato sulla didattica zooantropologica finalizzato a incentivare l’autoidentificazione,<br />
l’autovalutazione e l’<strong>autostima</strong><br />
Autori ed équipe:<br />
Giovanni <strong>Bucci</strong>, Medico <strong>Veterinario</strong><br />
Massimiliano Deflorian, Psicologo<br />
Franca Cicognani, Insegnante<br />
Destinatari del corso<br />
Il corso è rivolto agli alunni del primo anno del secondo ciclo della <strong>scuola</strong> media inferiore; la scelta degli obiettivi<br />
sarà fatta in coerenza ai curricula formativi già svolti in ogni classe.<br />
Obiettivi educativi<br />
1. Condurre l’alunno a riscoprire la propria individualità fisica come ricchezza cui attingere per l’affermazione di sé<br />
2. Affermare e migliorare negli alunni la consapevolezza di avere, a differenza degli animali, capacità intellettive<br />
tali da superare, con una adeguata progettualità, i limiti imposti dalle caratteristiche fisiche individuali<br />
3. Riconoscere l’individualità come risorsa basilare del gruppo che vive ed evolve sulla ricchezza data dalla comunione<br />
delle doti di ognuno<br />
4. Rinforzare nei ragazzi sentimenti positivi di sé<br />
5. Prevenire lo sviluppo di comportamenti antisociali e a rischio<br />
6. Favorire la nascita di sentimenti positivi e ris<strong>pet</strong>tosi verso gli animali e in genere verso ogni essere vivente e<br />
attenuare la diffidenza verso la diversità<br />
Obiettivi didattici<br />
1. Sviluppare atteggiamenti positivi nei confronti dell’apprendimento<br />
2. Migliorare la capacità di osservazione e descrizione<br />
3. Favorire l’attivazione di processi di scelta consapevoli e autonomi<br />
Obiettivi disciplinari<br />
1. Ripasso e arricchimento delle nozioni di anatomia del corpo umano e introduzione all’anatomia comparata<br />
2. Arricchimento del vocabolario scientifico<br />
3. Introduzione e spiegazione dei concetti di genere, specie, razza, meticcio e ibrido<br />
4. Introduzione e spiegazione dei concetti di evoluzione e di selezione naturale e artificiale<br />
Com<strong>pet</strong>enze veterinario + 2 cani, 1 gatto e piccoli animali da voliera, gabbia e acquario<br />
- Conoscenza dell’animale (con diapositive); concetti di specie, razza, selezione naturale e selezione operata<br />
dall’uomo, significato dell’addomesticamento, intelligenza e sensibilità degli animali<br />
- Conoscenza del cane attraverso la simulazione di una visita veterinaria (anatomia e fisiologia comparate, corretto<br />
approccio con il cane e alcune nozioni sul suo linguaggio)<br />
- Conoscenza del gatto attraverso la simulazione di una visita veterinaria (anatomia e fisiologia comparate, corretto<br />
approccio con il gatto e alcune nozioni sul suo linguaggio)<br />
- La convivenza e la comunicazione fra specie e razze diverse; i segnali universali (pericolo, paura, cibo, ecc.).<br />
L’amicizia e la cooperazione fra specie diverse<br />
- Conoscenza con altri piccoli animali portati dagli alunni e durante la lezione l’alunno proprietario veste, assieme<br />
al veterinario, i panni dell’esperto per rispondere alle domande dei compagni<br />
- Autovisita e autoaiuto<br />
Com<strong>pet</strong>enze Psicologo<br />
- I livelli della motivazione (i riflessi, gli istinti e le pulsioni)<br />
- La personalità e le influenze esercitate dall’ambiente (il carattere e il temperamento)<br />
- Il branco-il gruppo (le reazioni, le relazioni e l’influenza del gruppo), mobbing e bullismo<br />
- Autoefficacia e fiducia nelle proprie capacità (il ruolo delle esperienze positive)<br />
- La percezione di controllo e il concetto di sé<br />
- Autoefficacia e comportamenti a rischio: il ruolo delle convinzioni ottimistiche su di sé nella scelta di comportamenti<br />
a rischio (fumo, alcool, cibo, droga, comportamenti sessuali, ecc.)
188 Nuove pros<strong>pet</strong>tive nelle attività e terapie assistite dagli animali<br />
- conoscenza del gatto: attraverso la simulazione di<br />
una visita veterinaria vengono ripresi e ripassati<br />
i concetti di anatomia e fisiologia introdotti<br />
con il cane. Viene ripreso il vocabolario tecnico<br />
con l’aggiunta di nuovi termini. Vengono<br />
inoltre illustrati il corretto approccio con il gatto<br />
e alcune nozioni sul suo linguaggio;<br />
- convivenza e comunicazione fra specie e razze diverse:<br />
i segnali universali (pericolo, paura, cibo,<br />
ecc.), l’amicizia e la cooperazione fra specie<br />
diverse;<br />
- conoscenza con altri piccoli animali portati dagli alunni:<br />
durante la lezione l’alunno proprietario veste,<br />
assieme al veterinario, i panni dell’esperto per<br />
rispondere alle domande dei compagni. Ogni<br />
piccolo animale richiede, per la sua cura, un<br />
patrimonio di abilità e conoscenze strettamente<br />
legato alla peculiarità della specie.<br />
Le lezioni con il veterinario si concludono con<br />
una “autovisita” in cui l’alunno ri<strong>pet</strong>e i gesti fatti<br />
sul cane (compresa l’auscultazione del cuore) su<br />
sé stesso e individuato un “problema” cerca di<br />
trovare una soluzione (self-help).<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
Bandura A., L’autoefficacia. Teoria e applicazioni, Erickson,<br />
Trento 2000.<br />
Beck A.M., Riflessi del possesso di un animale da compagnia sulla salute<br />
ed il comportamento degli esseri umani, in AA VV, Problemi<br />
comportamentali nei piccoli animali, Edizioni SCIVAC, Cremona<br />
1993.<br />
Bloom B.S., Human Characteristics and School Learning, Mc-<br />
GrawHill, New York 1976.<br />
Boggi Cavallo P., D’Urso V., Autostima ed egopoiesi, Quaderni<br />
del Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università<br />
di Salerno, III, 1/2, 1993, pp. 39-49.<br />
Bracken B.A., Test di valutazione dell’<strong>autostima</strong>, Erickson, Trento<br />
2000.<br />
Frabboni F., Scuola e ambiente, Mondadori, Milano 1980.<br />
Frabboni F., OPPI documenti, 63, 64, 1994.<br />
Friedman E., Quali benefici possono portare gli animali da compagnia<br />
sulla salute umana e come evolverà la <strong>pet</strong>-<strong>therapy</strong>? In “SISCA<br />
Observer”, 1, 1997.<br />
Marchesini R., Lineamenti di zooantropologia, Calderini Edagricole,<br />
Bologna 2000.<br />
Miceli M., L’<strong>autostima</strong>, Il Mulino, Bologna 1998.<br />
Montagner H., Il bambino, l’animale, la <strong>scuola</strong>, Alberto Perdisa<br />
Editore, Bologna 2001.<br />
Quaglino G.P., Psicodinamica della vita organizzativa, Cortina,<br />
Milano 1996.