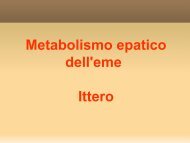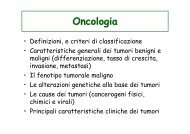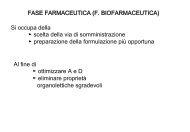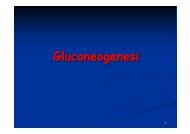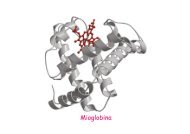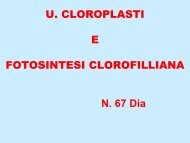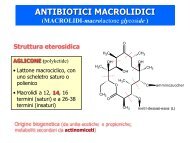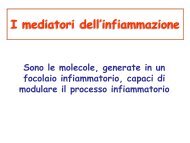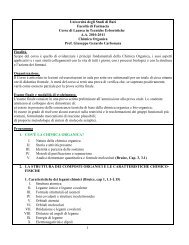12-01-00
12-01-00
12-01-00
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Esercizi proposti<br />
Vengono qui di seguito riportate alcune tracce proposte nel corso dell'anno 2<strong>00</strong>0, corredate di<br />
risoluzione commentata dei quesiti che richiedono calcoli numerici.<br />
(N.B. Nei quesiti che riguardano equilibri in soluzione acquosa, il contributo del solvente alle concentrazioni<br />
delle specie H 3 O + e OH - non viene menzionato nelle situazioni in cui è trascurabile)<br />
<strong>12</strong>/<strong>01</strong>/2<strong>00</strong>0 – I<br />
1 - Dati i seguenti ioni o molecole: ione carbonato, trifluoruro di boro, diossido di carbonio, metano,<br />
pentacloruro di fosforo, indicare per ciascuno di essi: struttura di Lewis, geometria, cariche<br />
formali ed eventuale presenza di un momento di dipolo risultante<br />
2 - a) Pressione osmotica e sue implicazioni.<br />
b) Calcolare la pressione osmotica di una soluzione acquosa preparata, a 25°C, sciogliendo in<br />
un litro d'acqua 1.70 g di nitrato di sodio e 1.80 g di glucosio (C 6 H <strong>12</strong> O 6 ).<br />
3 - Il pH di una soluzione acquosa di un acido organico monoprotico con Ka = 6.5 x 10 -5 è 2.60.<br />
Calcolare la concentrazione molare dell'acido.<br />
Calcolare inoltre il volume d'acqua che si deve aggiungere ad un litro della soluzione iniziale<br />
perché il pH raggiunga il valore di 2.90<br />
4 - Una cella galvanica (che lavora a 25 °C) è costituita : da una semicella in cui una sbarretta di<br />
nichel è immersa in una soluzione di Ni(NO3)2 0.10 M e da una seconda semicella in cui un<br />
elettrodo di platino è immerso in una soluzione acida a pH = 2 che contiene ioni permanganato<br />
in concentrazione 0.0<strong>12</strong> M e ioni Mn 2+ in concentrazione 0.15 M.<br />
Calcolare la forza elettromotrice della cella e scrivere la reazione che ha luogo quando la cella<br />
eroga corrente.<br />
[E°(Ni 2+ /Ni) = -0.26 V; E°(MnO4 - ,H + /Mn 2+ ) = 1.51 V]<br />
5 - Dare una definizione per: (i) elemento dei gruppi principali; (ii) semiconduttore; (iii) elettrolita.
Risoluzione<br />
2.<br />
La relazione che ci permette il calcolo della pressione osmotica è:<br />
π = iMRT (1)<br />
nel caso in questione i soluti sono due di concentrazione e fattore di vant’Hoff diverso, la (1)<br />
diventa:<br />
π = (i1M1 + i2M2)RT<br />
poiché gli effetti dei due soluti sono additivi.<br />
massa soluto (g)<br />
M =<br />
(in questo caso si può considerare V solvente = V soluzione).<br />
- 1<br />
MMsoluto (g mol )<br />
Volume soluzione (l)<br />
‣ NaNO 3 M1 =<br />
‣ glucosio M 2 =<br />
1.70/84.99 moli l -1 = 0.020 M; i1 = 2.<br />
1<br />
1.80/180.16<br />
1<br />
moli l -1 = 0.<strong>01</strong>0 M; i2 = 1.**<br />
π = [(2 · 0.020 + 0.<strong>01</strong>0) 0.082058 · 298.15] atm = 1.22 atm.<br />
3.<br />
Cosideriamo:<br />
+ -<br />
[H3O<br />
][A ]<br />
Ka =<br />
[HA]<br />
il bilancio di carica: [H 3 O + ] = [A - ] + [OH - ], che, essendo la soluzione acida, si riduce a<br />
[H 3 O + ] = [A - ]<br />
e il bilancio di massa: C (concentrazione iniziale dell’acido) = [HA] + [A - ] = [HA] +[H 3 O + ].<br />
+<br />
[H<br />
3O<br />
]<br />
La costante di equilibrio può essere espressa come Ka =<br />
C -[H<br />
3O<br />
se sono noti [H 3 O + ] e Ka si può risalire al valore di C<br />
C = ([H 3 O + ] 2 + Ka[H 3 O + ]) / Ka = [H 3 O + ] 2 / Ka + [H 3 O + ]<br />
[H 3 O + ] = 10 -2.6 = 2.513 x 10 -3<br />
C = 9.95 x 10 -2 M (in pratica 10 -1 M)<br />
2<br />
+<br />
;<br />
]
Per risolvere la seconda parte del problema si deve ripetere lo stesso calcolo per la soluzione diluita,<br />
il nuovo valore di concentrazione C’, essendo [H 3 O + ] = 10 -2.9 = 1.259 x 10 -3 , risulta<br />
C’ = 0.026 M.<br />
Il valore del volume della soluzione diluita si calcola eguagliando, per le due soluzioni il numero n<br />
di moli di acido presente (che è identico nei due casi):<br />
n = concentrazione (moli l -1 ) · volume (l) di soluzione.<br />
Quindi CiVi = C’Vf. Vi = 1 l, Vf = 3.8 l.<br />
Questo significa che l’aggiunta di 2.8 l (3.8 - 1 = 2.8) di acqua alla soluzione iniziale fa salire il pH<br />
di 0.3 unità.<br />
4.<br />
La cella galvanica si basa sulle due semireazioni seguenti:<br />
a) Ni 2+ (aq) + 2e Ni(s) E° = -0.26V<br />
-<br />
b) MnO 4 (aq) + 8H + (aq) +5e Mn 2+ (aq) + 4H 2 O (l) E° = 1.51 V<br />
Il potenziale di b) è di gran lunga più positivo di quello di a) quindi b) rappresenta il processo<br />
catodico, la reazione inversa di a) quello anodico. La reazione globale di cella sarà:<br />
-<br />
2MnO 4 (aq) + 5Ni (s) + 16H + (aq)<br />
2Mn 2+ (aq) + 5Ni 2+ (aq) + 8H 2 O (l)<br />
(la reazione è bilanciata per un totale di 10 e - )<br />
Applicando l’equazione di Nernst e , considerando che Ni (s) e H 2 O (l) si trovano nel loro stato<br />
standard di riferimento con attività = 1, abbiamo:<br />
2+<br />
2 2 5<br />
RT [Mn ] [Ni ]<br />
∆E = (E°catodo – E°anodo) – ln<br />
nF<br />
- 2 + 16<br />
[MnO ] [H ]<br />
4<br />
+<br />
Dando alle costanti R e F i loro valori numerici, a T il valore di 298.15 K, trasformando i logaritmi<br />
naturali in logaritmi decimali<br />
∆E = 1.77 –<br />
2 5<br />
0.0592 (0.15) (0.1)<br />
log<br />
2 16<br />
10 (0.0<strong>12</strong>) (0.<strong>01</strong>)<br />
= 1.77 –<br />
0.0592 log1.5625x10<br />
29<br />
10<br />
= 1.77 –<br />
0.0592 (0.1939 + 29) = 1.60 V<br />
10
<strong>12</strong>/<strong>01</strong>/2<strong>00</strong>0 – II<br />
1 - Che cosa si intende per:<br />
(i) ordine di legame; (ii) legame π; (iii) legame a idrogeno.<br />
2 - a) Un bombola di acciaio, dal volume interno di 20 litri, contiene del gas (azoto) compresso.<br />
Alla temperatura di 20 °C la pressione iniziale del gas nella bombola era pari a 2<strong>00</strong> atm; dopo<br />
che parte del gas è stato consumato per un esperimento di laboratorio, la pressione nella<br />
bombola è scesa a 180 atm. Calcolare la quantità assoluta e in percentuale di azoto consumato<br />
nell'esperimento, ammettendo di potersi valere dell'equazione di stato dei gas ideali.<br />
b) Definire i limiti di validità dell'equazione di stato dei gas ideali.<br />
3 - a) Calcolare il pH della soluzione ottenuta mescolando 1<strong>00</strong> ml di una soluzione di acido formico<br />
0.50 M (l'acido formico è un acido organico monoprotico con Ka = 1.8 x 10 -4 ) con 30 ml di<br />
una soluzione di idrossido di sodio 1.0 M.<br />
b) Calcolare il pH della soluzione ottenuta aggiungendo alla soluzione del punto a) altri 20 ml<br />
di soluzione 1 M di idrossido di sodio.<br />
(Le soluzioni sono tutte soluzioni acquose).<br />
4 - a) Il magnesio è un metallo che si ottiene per elettrolisi del cloruro di magnesio fuso. Calcolare<br />
l'intensità della corrente (in Ampère) che deve passare nella cella elettrolitica perché al catodo<br />
si formino 73 g di magnesio in un'ora.<br />
b) Illustrare in maniera sintetica che cosa si intende per elettrolisi.<br />
5 - Dare una definizione per: (i) alogeno; (ii) idruro; (iii) ossidi acidi e ossidi basici.<br />
Risoluzione<br />
2.<br />
Nell’ipotesi di poter applicare l’equazione di stato dei gas perfetti PV = nRT, le moli di azoto<br />
presenti inizialmente nella bombola sono:<br />
P1V<br />
n1 =<br />
RT<br />
=<br />
2<strong>00</strong> ⋅20<br />
0.08205⋅293.15<br />
atm l<br />
= 166.28 mol ****<br />
- 1 -1<br />
atm l mol K K
le moli rimaste nella bombola dopo l’esperimento sono:<br />
P2V<br />
n2 =<br />
RT<br />
=<br />
180 · 20<br />
0.08205 · 293.15<br />
la quantità di azoto consumata in moli è data da<br />
(n1 – n2) = 16.62 mol ovvero:<br />
atm l<br />
= 149.66 mol<br />
- 1 -1<br />
atm l mol K K<br />
(16.62 · 28)g = 456.36 g (28.<strong>01</strong> g mol -1 = MM di N 2 );<br />
il consumo in % è dato da:<br />
n1-<br />
n<br />
n1<br />
2<br />
· 1<strong>00</strong> = 10%.<br />
In via alternativa il consumo in percentuale può essere calcolato anche sulla base del calo di<br />
pressione. Dal momento che volume e temperatura rimangono costanti, un calo del 10% della<br />
pressione deve corrispondere ad un calo del 10% del numero di moli. La quantità di N2 erogato, in<br />
moli, risulta dal calcolo:<br />
P3V<br />
n3 =<br />
RT<br />
dove P3 deve essere posta pari a 20 atm, cioè pari alla pressione parziale delle moli di N 2 fuoriuscite<br />
dalla bombola.<br />
3.<br />
La reazione che ha luogo con il mescolamento delle due soluzioni è:<br />
HFor (aq) + NaOH (aq)<br />
NaFor (aq) + H 2 O (l)<br />
Le moli di HFor sono date da<br />
n HFor = M HFor V HFor = 5.0 x 10 -2 mol.<br />
Le moli di base forte sono n - OH = M NaOH V NaOH = 3.0 x 10 -2 mol.<br />
Le moli di acido sono in eccesso e la reazione di neutralizzazione è pertanto incompleta. Nella<br />
soluzione risultante sono quindi presenti ioni Na + (spettatori e ininfluenti ai fini del pH), ioni For - ,<br />
ioni H 3 O + , ioni OH - e molecole HFor. Siamo in presenza di una soluzione tampone in cui tutte le<br />
specie ioniche (ad eccezione di Na + ) e HFor devono soggiacere alla legge di azione di massa. In<br />
particolare,<br />
Ka =<br />
+ -<br />
[H3O<br />
][For ]<br />
[HFor]
Nella soluzione si trovano disciolti HFor in una concentrazione pari a:<br />
-2<br />
⎛ 5.0x10 - 3.0x10<br />
[HFor] = (n iniziali di acido - n base aggiunta )/V totale =<br />
⎜<br />
⎝ 0.13<br />
e il suo sale NaFor in quantità pari alla base forte aggiunta con concentrazione<br />
[NaFor] =<br />
3.0x10 -2 mol l -1 = 0.23 M.<br />
0.13<br />
-2<br />
⎟ ⎞<br />
⎠<br />
mol l -1 = 0.15 M<br />
Supponendo che [For - ] e [HFor] all’equilibrio non differiscano in maniera apprezzabile dai loro<br />
valori analitici (delle quantità cioè immesse nella soluzione) possiamo valutare [H 3 O + ] dalla<br />
relazione<br />
[H 3 O + [HFor]<br />
] = Ka<br />
-<br />
[For ]<br />
= 1.8 x 10 -4 0.15 = 1.2 x 10 -4 , pH = 3.92.<br />
0.23<br />
[H 3 O + ] è molto inferiore alla concentrazione analitica di acido presente, l’approssimazione fatta<br />
risulta valida.<br />
Se alla soluzione formata in a) si aggiungono altri 20 ml di soluzione di base forte, è come se<br />
avessimo mescolato 1<strong>00</strong> ml di soluzione di acido formico 0.5 M con 50 ml di soluzione di NaOH<br />
1.0 M, in questo caso<br />
nHFor = nOH - = 5.0x10 -2 mol<br />
Nella reazione l’acido HFor si trasforma completamente nel suo sale sodico (NaFor) e il pH della<br />
soluzione risultante va calcolato considerando che abbiamo 0.15 l di una soluzione in cui è disciolto<br />
il sale NaFor in quantità pari a 5.0x10 -2 mol.<br />
Il sale è ionizzato, Na + è ininfluente ai fini dell’acidità del mezzo, mentre For - si idrolizza secondo<br />
l'equazione:<br />
For - (aq) + H 2 O (l) HFor (aq) + OH - (aq)<br />
La costante che regola questo equilibrio è:<br />
-<br />
Kw [OH ][HFor]<br />
Kb = =<br />
Ka<br />
-<br />
[For ]<br />
consideriamo il bilancio di carica<br />
[Na + ] + [H 3 O + ] = [For - ] + [OH - ];<br />
poichè la soluzione è basica [H 3 O + ] è trascurabile e il bilancio di carica si riduce a<br />
C = [For - ] + [OH - ]<br />
(a [Na + ] è stato sostituito il termine C = concentrazione analitica, o iniziale, di NaFor).<br />
Consideriamo il bilancio di massa:<br />
C = [For - ] + [HFor]
ed eguagliando le due espressioni per C:<br />
[For - ] + [OH - ] = [For - ] + [HFor] si ottiene: [OH - ] = [HFor],<br />
Kb =<br />
- 2<br />
[OH ]<br />
; Kb = 5.56 x 10 -11 ; C =<br />
-<br />
C-[OH ]<br />
−2<br />
5.0x10<br />
0.15<br />
mol l -1 = 3.33 x 10 -1 M.<br />
Dato il valore molto piccolo di Kb e poiché la soluzione non è troppo diluita (~10 -1 M), possiamo<br />
scrivere:<br />
[OH - ]<br />
2<br />
Kb ≈ , e quindi<br />
C<br />
[OH - ] = Kb·C =<br />
5.56x10 -11 · 3.33x10 -1<br />
= 4.3 x 10 -6 ; pOH = 5.37; pH = 8.63.<br />
N.B. [OH - ] = 4.3 x 10 -6