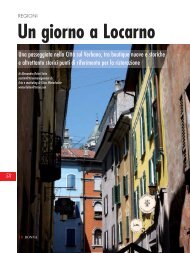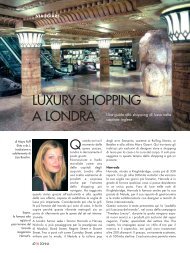Un Ticinese a Castel Nuovo - Ticino Management
Un Ticinese a Castel Nuovo - Ticino Management
Un Ticinese a Castel Nuovo - Ticino Management
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
È fra i monumenti più importanti della città di<br />
Napoli ed è stato testimone delle continue<br />
lotte per la conquista del Regno fin dal XIII<br />
secolo, a part i re dall’arrivo a Napoli di Carlo<br />
d’Angiò, che nel 1279 ne decretò la costru z i one<br />
per farne la sua fastosa residenza sulle rive<br />
del mare .<br />
È il Maschio Angioino, noto anche come il<br />
<strong>Castel</strong> <strong>Nuovo</strong>, la costruzione più pre s t i g i o s a<br />
della civiltà angioina e aragonese e oggi sede<br />
museale, ma anche luogo per le riunioni del<br />
Consiglio del Comune di Napoli. Dell’antica<br />
c o s t ruzione angioina terminata nel 1284 non<br />
resta, però, più nulla se non la Cappella Pala-<br />
*storico dell’arte<br />
1 0 8<br />
di Giorgio Mollisi*<br />
<strong>Un</strong> <strong>Ticinese</strong> a <strong>Castel</strong> <strong>Nuovo</strong><br />
Domenico Gagini da Bissone, scultore<br />
a Napoli sotto Alfonso d’Aragona<br />
tina, perché il castello fu radicalmente modificato<br />
sotto Alfonso d’Aragona nel 1443.<br />
N u m e rosi altri interventi si susseguirono nei<br />
secoli, soprattutto durante il ‘700, ma un<br />
re s t a u ro dei primi del Novecento ha ricondotto<br />
il castello alle forme del periodo aragonese.<br />
Di originale, comunque si è fort u n a t a m e n t e<br />
c o n s e rvato l’arco di trionfo, fatto costru i re dal<br />
re Alfonso d’Aragona all’entrata del castello<br />
per celebrare il suo ingresso trionfale del 1443<br />
nella città di Napoli, un vero capolavoro di<br />
a rte decorativa rinascimentale, sicuramente<br />
una delle opere più importanti dell’Italia meridionale<br />
di quel periodo. E fra gli artisti che
Sopra, l’Arco di trionfo di <strong>Castel</strong> <strong>Nuovo</strong>,<br />
oggi noto come Maschio Angioino (foto<br />
in apertura). Eseguito in marmo per celebrare<br />
l’ingresso trionfale del re Alfonso<br />
d’Aragona in Napoli nel 1443, l’Arco è<br />
opera anche dello scultore ticinese<br />
Domenico Gagini di Bissone<br />
(foto da P.Leone de Castris).<br />
l’hanno realizzato troviamo anche uno scultore<br />
ticinese.<br />
C o s t ruito sull’esempio degli archi trionfali<br />
romani tra il 1453 e il 1468, la porta trionfale,<br />
che è in marmo bianco, è composta da<br />
q u a t t ro parti con un arco a tutto sesto tra<br />
colonne corinzie binate, alla base, con sul<br />
f ronte due leoni che sostengono lo stemma<br />
aragonese e due decorazioni nel sottarco rapp<br />
resentante una la P a rtenza per la guerr a e, la<br />
seconda, il R i e n t ro vittorioso del re. Nella<br />
p a rte centrale, l’attico con l’imponente decorazione<br />
del Trionfo vero e proprio del re<br />
Alfonso d’Aragona ritratto sul carro sotto a<br />
un baldacchino e, nella parte superiore, un<br />
a l t ro arco tra colonne ioniche binate (entro<br />
cui probabilmente doveva essere collocata la<br />
statua del re), che sorregge un altro attico<br />
dove, entro nicchie, sono state poste quattro<br />
statue rappresentanti le quattro virtù, La G i u -<br />
s t i z i a, la Te m p e r a n z a, la F o rt e z z a, e la M a g n a -<br />
n i m i t à. Completa la poderosa macchina decorativa<br />
un coronamento con due Divinità flu -<br />
v i a l i, sempre in marmo, su cui si erge poderosa<br />
la statua di San Michele, pro t e t t o re delle<br />
regioni meridionali.<br />
Sul portale interno dell’arcata inferiore, un<br />
bassorilievo con l’I n c o ronazione di re Ferr a n -<br />
t e eseguita da Pietro da Milano e Francesco<br />
Laurana fra il 1465 e il 1471, in onore del<br />
figlio di Alfonso succeduto al trono di Napoli,<br />
chiude l’impresa scultorea dell’Arco di<br />
<strong>Castel</strong> <strong>Nuovo</strong>.<br />
La parte decorativa più importante è naturalmente<br />
quella dell’attico centrale, su cui è rapp<br />
resentato in bassorilievo il C o rteo re g a l e c o n<br />
suonatori a cavallo in testa, che precedono il<br />
c a rro coperto da baldacchino su cui siede il re ,<br />
accompagnato da dignitari e ambasciatori.<br />
Chi sia stato l’ideatore e progettista di questo<br />
c a p o l a v o ro - che, come dice Francesco Abbate<br />
nella sua Storia dell’arte nell’Italia meridio -<br />
nale. Il sud angioino e aragonese ( A b b a t e ,<br />
1998, p.187), è un adattamento di “ e l e m e n t i<br />
classici allo spirito gotico di fondo del pro g e t -<br />
tista, costretto a piegarsi alla volontà ro m a n i z -<br />
zante del committente” - non è ancora del<br />
tutto chiaro, anche se le antiche fonti napole-<br />
1 0 9
tane pensano ai due principali scultori dell’arco,<br />
e cioè a Pietro da Milano e Francesco Laurana.<br />
La questione è, come detto, ancora<br />
oggetto di disputa tra gli studiosi, soprattutto<br />
r i g u a rdo al disegno attribuito a Pisanello e<br />
c o n s e rvato nel Boymans Museum di Rotterdam,<br />
ritenuto da taluni la prima idea dell’Arco<br />
di Napoli, ma da altri invece lo studio per<br />
la Porta di Federico a Capua, con cui l’Arco di<br />
<strong>Castel</strong> <strong>Nuovo</strong> divide parecchie affinità; ma<br />
sull’intricata questione rimando all’intere s s a nte<br />
articolo di Rosanna di Battista che intro d uce<br />
parecchi spunti di riflessione e di novità (Di<br />
Battista, 2000).<br />
P a re invece chiarita sia dai documenti, ma<br />
soprattutto dall’indagine filologica, la paternità<br />
degli esecutori che vede la presenza, come<br />
detto, anche di uno scultore ticinese, Domenico<br />
Gagini (o Gaggini) da Bissone. Risulta<br />
infatti dai documenti che il Gagini sia giunto a<br />
Napoli e in part i c o l a re nel cantiere di <strong>Castel</strong><br />
<strong>Nuovo</strong> solo nel 1457, quando l’opera era in<br />
p a rte eseguita dagli scultori Laurana e Pietro<br />
1 1 0<br />
da Milano, con la collaborazione<br />
dello scultore romano Piero<br />
Saccone e degli scultori toscani<br />
Antonio di Chellino e Isaia da<br />
Pisa, di Andrea dell’Aquila e<br />
degli scultori catalani Pere Johan<br />
e Guillelmo Sagrera. <strong>Un</strong> valente<br />
g ruppo di artisti chiamati a<br />
Napoli per re a l i z z a re l’opera più<br />
imponente del momento, che il<br />
re avrebbe voluto assegnare al<br />
grande Donatello, mai giunto<br />
però a Napoli per tale impresa.<br />
F o rtunatamente gli ultimi studi<br />
hanno individuato nel complesso<br />
dell’opera la mano di ogni<br />
singolo scultore, assegnando a<br />
Laurana e a Pietro da Milano le<br />
p a rti più significative del<br />
Trionfo e riservando a Domenico<br />
Gagini alcune parti molto<br />
i m p o rtanti, come la scultura<br />
della Te m p e r a n z a, nel gru p p o<br />
delle Vi rtù, e il gruppo dei Suonatori<br />
appiedati che pre c e d o n o<br />
il carro nel fregio del Trionfo, oltre al bassorilievo<br />
del Fiume (quello di destra) sul coro n amento<br />
e lo stemma aragonese sorretto da due<br />
angeli al centro dell’imbotte superiore nel<br />
secondo arco sopra il Trionfo (Leone de<br />
Castris 1990, pp. 45-47; Abbate 1998, p.<br />
190). <strong>Un</strong>a parte consistente, considerando la<br />
sua breve permanenza a Napoli, vista la sua<br />
p a rtenza per la Sicilia subito dopo la morte di<br />
Alfonso d’Aragona, avvenuta nel giugno del<br />
1458.<br />
Domenico Gagini era nato a Bissone, un<br />
comune sulle rive del lago di Lugano, nel terz o<br />
decennio del XV secolo (Bernini, 1998, pp.<br />
235-240). Figlio di Pietro, Domenico doveva<br />
sicuramente far parte di quella nutrita schiera<br />
di architetti e scultori che dal <strong>Ticino</strong> si erano<br />
recati in Italia per lavoro, facendo la spola fra<br />
il Friuli, la Toscana e la Liguria. Suo nonno fu,<br />
infatti, quel Beltrame che era stato nel 1400<br />
a rchitetto del duomo di Sacile nella Livenza,<br />
oggi provincia di Pordenone, e poi attivo nel<br />
duomo di Siena nel 1422, e suo padre Pietro ,
invece, scalpellino, sempre nel 1422, viene<br />
citato in alcuni documenti come incaricato di<br />
“ c a v a re marmo tubertino, (travertino), da<br />
alcune pietre, e di digro s s a re e lavorare di scal -<br />
pello di tutto punto quei marmi che dovevano<br />
s e rv i re per la fabbrica del Duomo di Siena”<br />
( C e rvetto, 1903, p. 35). Suoi zii erano gli scultori<br />
Giovanni e Pace che avevano lasciato,<br />
soprattutto nella città di Genova e in Spagna,<br />
n u m e rose testimonianze della loro abilità. È<br />
naturale quindi che Domenico, al seguito del<br />
p a d re, abbia appreso il mestiere dell’intaglio<br />
della pietra e abbia trascorso la sua giovinezza<br />
tra Siena e Firenze imparando l’arte della<br />
scultura dai maestri toscani.<br />
A fianco, la scultura<br />
rappresentante<br />
la Temperanza,<br />
nel gruppo delle<br />
Virtù poste sotto<br />
al coronamento<br />
dell’Arco (foto da<br />
H.W. Kruft).<br />
Nella pagina<br />
accanto, il gruppo<br />
dei Suonatori<br />
appiedati, eseguiti<br />
nel 1457 dal Gagini<br />
nel bassorilievo<br />
del fregio con il<br />
Trionfo del re<br />
(foto da P.Leone<br />
de Castris). Lo<br />
scultore ticinese<br />
esegue anche la<br />
figura della personificazione<br />
del<br />
Fiume (quella di<br />
destra nel coronamento)<br />
e lo stemma<br />
aragonese sorretto<br />
da due<br />
angeli, al centro<br />
dell’imbotte superiore<br />
del secondo<br />
arco sopra il<br />
Trionfo.<br />
Citato nel Trattato di Architettura di Antonio<br />
Averlino detto il Filerete (1461-1464, p. 172),<br />
tra gli artisti impegnati nella decorazione della<br />
città ideale di Sforzinda, Domenico viene,<br />
infatti, detto “discepolo di Pippo di ser Bru -<br />
n e l l e s c o ”, ed è pertanto presente a Firenze nel<br />
1445 nel momento in cui il Brunelleschi lavora<br />
alla Cappella Pazzi, prima di recarsi a<br />
Genova dove costruirà e decorerà la cappella<br />
di S. Giovanni Battista in Duomo (Alizeri,<br />
1876, pp. 127-129) assieme a Giovanni Gagini<br />
e al nipote Elia, dal 1448 all’inverno del<br />
1456-57 (Kruft, 1971, pp. 20-27).<br />
<strong>Un</strong> capolavoro di architettura e scultura, fru tto<br />
dell’incontro fra la semplicità delle linee<br />
1 1 1
Sopra, il Tabernacolo con la Madonna col<br />
Bambino e donatori, nella Cappella Palatina<br />
di <strong>Castel</strong> <strong>Nuovo</strong>, opera di Domenico<br />
Gaggini (foto da P.Leone de Castris).<br />
1 1 2<br />
a rchitettoniche acquisite dal Brunelleschi con<br />
la ricchezza decorativa tipicamente lombard a<br />
della sua origine, una nuova poetica, quindi,<br />
quella acquisita da Domenico, frutto dell’elaborazione<br />
delle due scuole di pro v e n i e n z a<br />
( B e rnini, 1980).<br />
Domenico Gagini giunge a Napoli da Genova<br />
nel 1457, port a t o re, quindi, di una nuova cultura<br />
artistica sperimentata nella città ligure e<br />
con l’esperienza di un artista aff e rmato. Non<br />
si sa con precisione se lo scultore ticinese sia<br />
stato chiamato per la realizzazione di alcune<br />
s c u l t u re dell’Arco di Trionfo o se invece per<br />
a l t re opere all’interno del castello, come ad<br />
esempio il portale della Sala dei baroni (Kru f t ,<br />
1972, pp. 20-24), sta di fatto che a suggerire<br />
al re di Napoli il nome di Domenico Gagini<br />
per <strong>Castel</strong> <strong>Nuovo</strong> sembra essere stato il Canc<br />
e l l i e re della repubblica di Genova Giacomo<br />
Bracelli, buon conoscente dello scultore e<br />
amico personale del re Alfonso d’Aragona<br />
( B e rnini, 1980).<br />
Come detto, sull’Arco di Trionfo il Gagini<br />
eseguì la statua della Te m p e r a n z a (seconda da<br />
sinistra), la donna che dalla brocca versa<br />
acqua nella brocca sottostante. Elegante nel<br />
suo panneggio stretto, ma morbido a scendere<br />
dolcemente verso il basso e avvolgente la<br />
tunica dalla finissima decorazione sulla manica<br />
destra, la Te m p e r a n z a del Gagini porta a<br />
Napoli la cultura donatelliana della Fire n z e<br />
degli anni Trenta, quella della A n n u n c i a z i o n e<br />
della Basilica di Santa Croce, fatta di un fine<br />
colorismo di luci e ombre e dalla grazia delle<br />
pose. Splendido il volto, preso di tre quart i ,<br />
dal naso affilato e dal sorriso ammiccante,<br />
tipico dei volti del Gagini, ammorbidito dalle<br />
ciocche di capelli sciolti sulle spalle e ferm a t i<br />
da un nastro che, civettuolo, va ad attraversare<br />
la fronte. Le mani affilate, dalle lunghe<br />
dita, comuni a quelle che da lì a poco si<br />
vedranno nelle sue Madonne siciliane, stringono<br />
con grazia i vasi impreziositi dalle decorazioni;<br />
quella grazia e quella eleganza che si<br />
riscontra anche nei S u o n a t o r i d e l l ’ A rco di<br />
trionfo, nei volti ripresi di profilo un po’<br />
schiacciati ma ingentiliti dalle consuete ciocche<br />
di capelli che debordano dai copricapi.
Domenico Gaggini<br />
esegue nel 1457 anche gli<br />
architravi in rilievo<br />
del portale bifronte del<br />
salone dei Baroni in <strong>Castel</strong><br />
<strong>Nuovo</strong> (foto a fianco<br />
tratte da H.W. Kruft).<br />
Eleganza che si riscontra in<br />
un’altra splendida opera di<br />
Domenico posta nella Cappella<br />
Palatina entro un<br />
t a b e rnacolo, la Madonna col<br />
Bambino e donatori, che è<br />
un ulteriore omaggio dello<br />
s c u l t o re ticinese alla cultura<br />
toscana di Bru n e l l e s c h i ,<br />
Donatello o di Ghiberti. A<br />
c o m i n c i a re dalla nicchia<br />
dove le arc h i t e t t u re bru n e l l esche<br />
accolgono la Ve rg i n e<br />
che tiene dolcemente fra le<br />
braccia il Bambino dai lunghi<br />
riccioli, che fanno il pari<br />
con quelli esuberanti della<br />
M a d re, seminascosti da un<br />
l e g g e ro velo coperto dal<br />
manto.<br />
In <strong>Castel</strong> <strong>Nuovo</strong>, comunque,<br />
Domenico Gagini<br />
lavorò non solo all’Arco e<br />
nella Cappella Palatina, ma<br />
anche nella Sala dei baro n i ,<br />
dove eseguì fra l’aprile e<br />
l ’ o t t o b re del 1457 gli arc h itravi<br />
in rilievo del port a l e<br />
b i f ronte, purt roppo oggi<br />
poco leggibili a causa dell’incendio<br />
del 1919, con la<br />
Cavalcata d’ingresso in<br />
Napoli di Alfonso e il C o r -<br />
teo trionfale del re ( L e o n e<br />
de Castris, p. 47).<br />
Nelle sale del museo di<br />
<strong>Castel</strong> <strong>Nuovo</strong> si tro v a ,<br />
p e r a l t ro, un’altra opera di<br />
Domenico Gagini, una<br />
Madonna con Bambino,<br />
1 1 3
p roveniente dalla Real Casa Santa dell’Annunziata.<br />
Anche se molto restaurata e danneggiata<br />
(mancano la mano destra della Madonna<br />
che reggeva probabilmente un uccellino,<br />
mancano la mano destra e il braccio sinistro<br />
del Bambino e anche i piedi), l’opera è di<br />
mano di Domenico, anche se parte della criti-<br />
1 1 4<br />
ca era propensa a ritenerla opera di bottega,<br />
per le affinità con le Madonne con Bambino<br />
realizzate in Sicilia, e in modo part i c o l a re con<br />
la Madonna del 1479 in San Lorenzo ad Agrigento.<br />
Ne è convinto Leone de Castris, che la<br />
ritiene di sicuro di mano del maestro per la<br />
notevole qualità e, per la presenza di elementi
Nella pagina accanto, da sinistra, la<br />
Madonna col Bambino, eseguita da<br />
Domenico Gagini per la Real Casa Santa<br />
dell’Annunziata a Napoli alla fine degli<br />
anni Settanta del Quattrocento e oggi al<br />
Museo di <strong>Castel</strong> <strong>Nuovo</strong>. L’altra Madonna<br />
col Bambino è stata invece eseguita dal<br />
Gagini per la Cripta della chiesa dell’Annunziata<br />
negli anni Cinquanta e presenta<br />
molte affinità con la figura della Tempe -<br />
ranza posta sotto al coronamento dell’Arco<br />
di Trionfo di <strong>Castel</strong> <strong>Nuovo</strong>, in modo<br />
particolare per la posizione del capo reclinato<br />
sulla sinistra (foto sopra), per i lineamenti<br />
dolci del viso e per il vibrato chiaroscuro<br />
del panneggio (Foto da H.W. Kruft).<br />
lauraneschi, data la scultura addirittura alla<br />
fine degli anni Settanta, parlando di una possibile<br />
richiesta al Gagini da parte dei Governatori<br />
dell’Annunziata, allorquando lo scultore<br />
si trovava già in Sicilia. Anche perc h é<br />
Domenico aveva già lavorato per loro mentre<br />
si trovava a Napoli ad un’altra Madonna con<br />
B a m b i n o, esistente nella cripta della Chiesa<br />
dell’Annunziata (Leone de Castris, p. 104).<br />
È una splendida scultura in cui la Madonna,<br />
dal capo reclinato sulla spalla sinistra, sostiene<br />
amorevolmente il Bambino che si appoggia<br />
con il braccio destro sul suo petto. I soliti<br />
capelli sciolti della Ve rgine che si snodano<br />
dolcemente da sotto il velo sul collo e un panneggio<br />
morbido del manto, finemente decorato<br />
e con scritte sul bordo che, fermato da un<br />
medaglione sul petto, casca dolcemente verso<br />
il basso, sono i consueti tratti caratteristici<br />
della scultura del Gagini che, come dice R.<br />
Pane, raggiunge qui una grande “ i n t e n s i t à<br />
e s p re s s i v a ” tale da essere considerata “tra le<br />
o p e re maggiori di Domenico” (Pane 1975, p.<br />
3 0 5 ) .<br />
<strong>Un</strong>a scultura che, al contrario di quanto aff e rmato<br />
da Kruft nella sua monografia sullo<br />
s c u l t o re ticinese, va sicuramente assegnata<br />
totalmente alla mano del Gagini, senza interventi<br />
di bottega, negli anni in cui si trovava a<br />
Napoli per le opere al castello. Anche se si<br />
riscontrano molte analogie con le cosiddette<br />
‘copie’ della Madonna di Tr a p a n i, e in modo<br />
p a rt i c o l a re con quella del duomo di Erice, la<br />
grande statua dell’Annunziata va quindi datata<br />
precedentemente alle Madonne siciliane e<br />
messa in relazione per le molte affinità (non<br />
ultima la posizione del volto reclinato) con la<br />
Te m p e r a n z a d e l l ’ A rco di trionfo del <strong>Castel</strong><br />
<strong>Nuovo</strong>.<br />
P e r a l t ro, lo scultore ticinese pare abbia lavorato<br />
anche in un’altra chiesa napoletana, quella<br />
di S. Domenico Maggiore, dove nel cappellone<br />
del Crocifisso eseguì una A n n u n c i a z i o n e e<br />
alcune sculture per il sepolcro di Diomede<br />
Carafin, opere di cui però non c’è accordo fra<br />
la critica circa la sua paternità (Leone de<br />
Castris, p. 104).<br />
Alla morte di Alfonso, come tutti gli altri scultori<br />
dell’Arco, anche il Gagini lasciò Napoli e<br />
si recò in Sicilia. Lo troviamo a Palermo tra il<br />
1460 e il 1462, dove si dedica al re s t a u ro di<br />
alcuni mosaici bizantini nella Cappella Palatina<br />
in Palazzo dei Normanni (Bernini 1989, p.<br />
236) e dove lascia una testimonianza dell’am-<br />
1 1 5
mirazione verso il suo primo maestro, il Brunelleschi,<br />
introducendo nel mosaico rappresentante<br />
la R e s u rrezione di Ta b i t a la figura<br />
della cupola di Santa Maria del Fiore di Fire nze.<br />
La sua grande aff e rmazione come scultore ,<br />
però, la otterrà nel 1463 per la costruzione del<br />
monumento sepolcrale per Pietro Speciale,<br />
1 1 6<br />
A fianco, l’ancona lapidea<br />
datata 1514 e murata<br />
nel portico del Convento<br />
dei Serviti a Mendrisio<br />
(oggi sede del<br />
museo) con la Madonna<br />
con Bambino, Santa<br />
Caterina e S. Giovanni,<br />
con l’iscrizione riferita ai<br />
donatori Giovanni Gagini<br />
da Bissone (detto il<br />
Genovese) e sua moglie<br />
Lopia. L’opera sembra<br />
più di ambito rodariano<br />
che non gaginesco.<br />
S i g n o re di Alcamo e Calatafimi, nella tribuna<br />
m a g g i o re della chiesa di S. Francesco d’Assisi,<br />
s e m p re a Palermo, di cui oggi resta solo la<br />
p a rte superiore del sarcofago con la figura giacente<br />
di Nicolò Speciale, figlio di Pietro, suff iciente<br />
però per dimostrare come lo scultore<br />
ticinese con questa prima opera determini il<br />
passaggio dal tardogotico al Rinascimento<br />
nella scultura siciliana. Ancora una volta, la<br />
sua formazione fiorentina pre v a rrà sulla tradizione<br />
locale e lo stile classico di Donatello e di<br />
Michelozzo o i modelli di sepolcro monumentale<br />
di Rossellino, in cui architettura e scultura<br />
si fondono a form a re un unico oggetto<br />
secondo i precetti di Leon Battista Albert i ,<br />
v e rranno introdotti e adottati anche in Sicilia<br />
( B e rnini 1989, pp. 236-237). Mentre le sue<br />
s c u l t u re con le Madonne col Bambino, numerose<br />
nelle chiese dell’isola, fors’anche un po’<br />
ripetitive, ma ugualmente suggestive, saranno<br />
un po’ la cifra di uno scultore che aveva con-<br />
A fianco, la Madonna con Bambino, posta<br />
nella conca absidale mediana della Cappella<br />
di Sant’Antonino a Obino, presso<br />
<strong>Castel</strong> San Pietro, di scultore lombardo di<br />
ambito gaginesco.
tribuito a port a re nell’Italia meridionale il<br />
gusto toscano.<br />
Domenico Gagini non tornerà più in Ti c i n o ,<br />
ma a capo di una fiorente bottega e scultore<br />
egemone nell’isola inizierà i suoi figli Giovanni<br />
e Antonello all’arte della scultura. Quest’ultimo<br />
in modo part i c o l a re, che lavorerà con<br />
Michelangelo in San Pietro in Vincoli a Roma<br />
alla tomba di Giulio II, continuerà la tradizione<br />
del padre, che resterà ben salda per tutto il<br />
Cinquecento attraverso l’opera dei suoi numerosi<br />
figli. Purt roppo in <strong>Ticino</strong>, sua patria d’origine,<br />
non si trova traccia alcuna di Domeni-<br />
• F. Alizeri, Notizie dei professori del disegno in Liguria<br />
dalle origini al secolo XVI, I V, Genova 1876, pp. 127-129;<br />
• L. Cervetto, I Gagini da Bissone. Loro opere in Genova<br />
e altrove, Milano 1903;<br />
• H.W Kruft, La decorazione interna della cappella di S.<br />
Giovanni Battista nel duomo di Genova, in: Antichità<br />
viva, X (1971), I, pp. 20-27;<br />
• H.W Kruft, Domenico Gagini und seine We r k s t a t t,<br />
München 1972;<br />
• R. Pane, Il Rinascimento nell’Italia merid., Milano 1975;<br />
• G. Martinola, Inventario d’arte del Mendrisiotto, Bellinzona<br />
1975, pp. 276-280;<br />
• D. Bernini, Gli scultori Gagini, in: Genova e i Genovesi<br />
a Palermo…, Genova 1980, pp. 61-67;<br />
• F. Bologna, L’Arco di Alfonso d’Aragona nel <strong>Castel</strong>nuo -<br />
vo di Napoli, in: L’Arco di trionfo di Alfonso d’Aragona e<br />
il suo restauro, Roma 1987, pp. 13-19;<br />
• P.Leone de Castris (a cura di), Il Museo Civico, Napoli<br />
1 9 9 0 ;<br />
• H.W Kruft, voce in: The dictionary of art, Londra 1996,<br />
pp. 895-899;<br />
• R. Bernini, voce in: Dizionario Biografico degli Italiani,<br />
vol. 51, Catanzaro 1998, pp. 235-240;<br />
• F. Abbate, Storia dell’arte nell’Italia meridionale. Il sud<br />
angioino e aragonese, Roma 1998, pp. 179-203;<br />
• S. Calmieri, Il <strong>Castel</strong>nuovo di Napoli: reggia e fortezza<br />
a n g i o i n a, in: Atti della Accademia Pontaniana, N.S.<br />
47.1998 (1999), Napoli, pp. 501-519;<br />
• R. Di Battista, La porta e l’arco di <strong>Castel</strong>nuovo a Napo -<br />
l i, in: Annali di architettura, 10/11. 1998/1999 (2000),<br />
Vicenza, pp. 7-21.<br />
co, né dei suoi figli, né tantomeno di opere di<br />
ambito gaginesco. Fa eccezione una ancona<br />
lapidea, oggi polittico in tre scomparti posto<br />
sul muro del portico nel chiostro dell’Antico<br />
Convento dei Serviti (oggi sede del Museo di<br />
Mendrisio) e proveniente dalla demolita chiesa<br />
cinquecentesca. Si tratta di una M a d o n n a<br />
con Bambino, Santa Caterina e S. Giovanni<br />
B a t t i s t a, con una iscrizione riferita ai donatori<br />
Giovanni Gagini, detto il “Zenovese”, e sua<br />
moglie Lopia, e datata al 1514 (Mart i n o l a ,<br />
1975, p. 277). Anche se l’opera sembra riferibile<br />
più ad ambito rodariano che gaginesco,<br />
resta ancora da chiarire chi sia veramente il<br />
suo autore e a quale ambito appart e n g a .<br />
Ultimamente mi è stata, inoltre, segnalata<br />
dalla studiosa Lara Calderari, che ringrazio,<br />
una scultura esistente nella conca absidale<br />
mediana della Cappella di Sant’Antonino a<br />
Obino, presso <strong>Castel</strong> San Pietro, che ha qualche<br />
affinità con le opere di Domenico Gagini e<br />
forse, meglio, del figlio Antonello. Si tratta di<br />
una Madonna con Bambino in marmo bianco<br />
con profili dorati (rifatti in epoca re c e n t e )<br />
posta su un basamento con angiolotti (di<br />
epoca posteriore) la cui riproduzione fotografica,<br />
gentilmente concessami dalla Calderari,<br />
a p p a re qui per la prima volta. Il volto della<br />
Ve rgine dal naso affilato e dal sorriso ammiccante,<br />
le dita allungate a sostenere il Bimbo<br />
dalle lunghe braccia un po’ scarne e lo spigolio<br />
del panneggio ricordano molto da vicino le<br />
tipologie delle Madonne con Bambino,<br />
soprattutto palermitane di Domenico Gagini e<br />
di suo figlio Antonello. Persino le dorature ,<br />
che dovevano esistere all’origine, fanno pensare<br />
a una derivazione siciliana della scultura.<br />
Chi sia l’autore è difficile dire, ma è pro b a b i l e<br />
che si tratti di scultore lombardo dei primi del<br />
Cinquecento venuto in contatto con le opere<br />
dei Gagini.<br />
Come detto, Domenico Gagini non torn e r à<br />
più in <strong>Ticino</strong>, ma morirà a Palermo il 29 o il<br />
30 settembre del 1492 e sarà sepolto in S.<br />
Francesco d’Assisi, nella cappella dei SS.<br />
Q u a t t ro Coronati, i quattro scalpellini cristiani<br />
martirizzati da Diocleziano “pro t e t t o r i<br />
degli scultori”.<br />
1 1 7


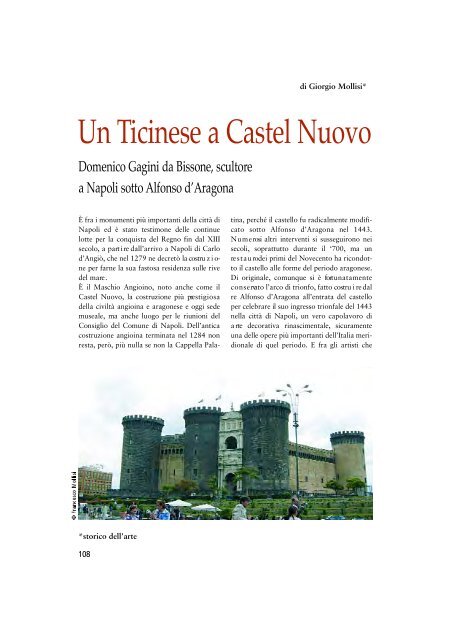
![Biografia [pdf] - Ticino Management](https://img.yumpu.com/27095475/1/178x260/biografia-pdf-ticino-management.jpg?quality=85)