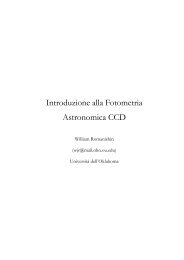Corso di astronomia, Lezione 2, 18/11/2010. Daniele Gasparri.
Corso di astronomia, Lezione 2, 18/11/2010. Daniele Gasparri.
Corso di astronomia, Lezione 2, 18/11/2010. Daniele Gasparri.
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
denominata supernova. Il gas è generalmente scagliato a velocità <strong>di</strong> qualche migliaio <strong>di</strong> km/s e temperature<br />
<strong>di</strong> decine <strong>di</strong> migliaia <strong>di</strong> gra<strong>di</strong>. Al centro della nebulosa resta un oggetto dalle <strong>di</strong>mensioni <strong>di</strong> una decina <strong>di</strong> Km<br />
ma con una massa maggiore <strong>di</strong> 1,5 volte quella solare: si tratta <strong>di</strong> una stella <strong>di</strong> neutroni, o a seconda<br />
dell’orientazione verso il nostro pianeta <strong>di</strong> una pulsar, responsabile della ionizzazione e quin<strong>di</strong> della<br />
luminosità del gas circostante. Nel giro <strong>di</strong> qualche migliaio <strong>di</strong> anni esso si sarà espanso, rarefatto e<br />
raffreddato al punto che non sarà praticamente più visibile: come le nebulose planetarie, anche i resti <strong>di</strong><br />
supernova hanno vita relativamente breve.<br />
Il resto <strong>di</strong> supernova sicuramente più famoso e luminoso è M1, detta nebulosa del granchio, generato<br />
dall’esplosione <strong>di</strong> una stella avvenuta il 4 luglio 1054, alla <strong>di</strong>stanza 6500 anni luce dalla Terra. La luminosità<br />
della supernova in quei giorni aumentò <strong>di</strong> miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> volte, arrivando ad essere visibile anche in pieno giorno<br />
(più luminosa <strong>di</strong> Venere). Il gas espulso alla velocità <strong>di</strong> circa 1000 Km/s e con una massa <strong>di</strong> 0,1 masse solari<br />
è andato a formare la nebulosa che oggi possiamo ammirare. Al centro, nascosta dal gas, resta una stella <strong>di</strong><br />
neutroni che ruota su se stessa 30 volte al secondo ed emette raggi X ed onde ra<strong>di</strong>o (questo tipo <strong>di</strong> stelle è<br />
detto anche pulsar).<br />
M1 è un’eccezione tra questo tipo <strong>di</strong> nebulose. Il cielo è pieno <strong>di</strong> resti <strong>di</strong> antiche supernove che ormai si sono<br />
espansi fino ad occupare un’area <strong>di</strong> svariati gra<strong>di</strong>: questo è il caso della nebulosa Velo nella costellazione del<br />
Cigno o degli immensi resti nella costellazione della Vela, visibili solo dall’emisfero sud e con strumenti <strong>di</strong><br />
almeno 150 mm.<br />
Il resto <strong>di</strong> supernova M1, detto nebulosa del granchio, ciò che resta <strong>di</strong> una stella esplosa nel 1054<br />
Nebulose a riflessione<br />
Sono nubi gassose a temperature interme<strong>di</strong>e tra le regioni HII (circa 10000 K) e le nebulose oscure (7-10 K)<br />
e si rendono visibili attorno a stelle o ammassi stellari.<br />
Sebbene la composizione sia la stessa degli altri tipi, si manifestano nel cielo a seguito <strong>di</strong> processi <strong>di</strong>versi.<br />
Le stelle avvolte in queste nubi non hanno abbastanza energia per ionizzare il gas e quin<strong>di</strong> non possono<br />
accendere l’idrogeno in esse contenuto, ma la loro luce attraversando la nube viene <strong>di</strong>ffusa dalle polveri<br />
presenti, principalmente silicati, nichel, ferro e carbonio (polvere <strong>di</strong> <strong>di</strong>amante) allo stesso modo <strong>di</strong> come la<br />
luce del Sole viene <strong>di</strong>ffusa dall’atmosfera terrestre conferendo al cielo una colorazione azzurra. Il<br />
meccanismo è in effetti del tutto simile: la luce della stella attraversa le polveri che provvedono al processo<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>ffusione, molto più efficiente per la ra<strong>di</strong>azione blu rispetto a quella rossa, conferendo alla nube <strong>di</strong> gas<br />
una tenue colorazione azzurro-blu. La luce della stella (o delle stelle) viene leggermente attenuata e arrossata<br />
mentre la nebulosa tende ad assumere le delicate colorazioni del cielo <strong>di</strong>urno terrestre e lo spettro tipico <strong>di</strong><br />
quello stellare, cioè <strong>di</strong> corpo nero.<br />
14