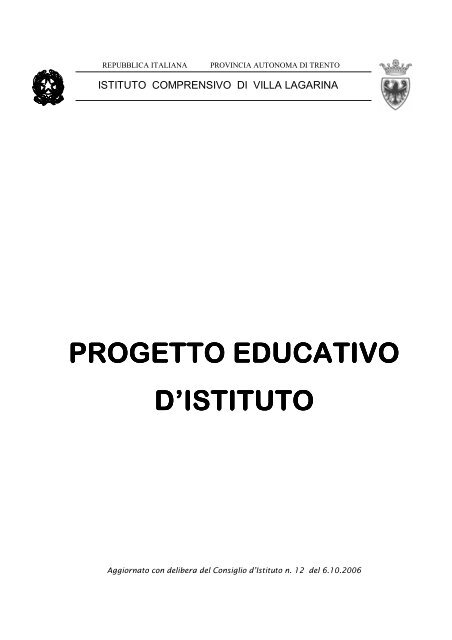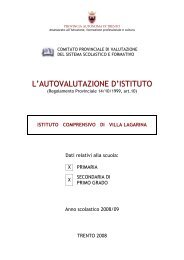Progetto Istituto 2006-07.pdf - Icvillalagarina.it
Progetto Istituto 2006-07.pdf - Icvillalagarina.it
Progetto Istituto 2006-07.pdf - Icvillalagarina.it
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
REPUBBLICA ITALIANA<br />
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO<br />
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA<br />
PROGETTO EDUCATIVO<br />
D’ISTITUTO<br />
Aggiornato con delibera del Consiglio d’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> n. 12 del 6.10.<strong>2006</strong>
LA SCUOLA DI BASE<br />
DELLA DESTRA ADIGE<br />
2
L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA<br />
Dal 1° settembre 2000 le Scuole Primarie di Nogaredo, Villa Lagarina, Pomarolo e Nomi e la Scuola<br />
Secondaria di I° “Anna Frank” cost<strong>it</strong>uiscono l’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> Comprensivo di Villa Lagarina.<br />
1. LA NASCITA DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI<br />
La nasc<strong>it</strong>a degli ist<strong>it</strong>uti comprensivi non risponde a scelte ed esperienze maturate dentro la scuola;<br />
infatti, la legge ist<strong>it</strong>utiva (n. 97/94) riguardava l’organizzazione dei servizi nelle zone montane: gli ist<strong>it</strong>uti<br />
comprensivi rappresentavano la risposta, in s<strong>it</strong>uazioni di calo demografico al bisogno espresso dagli enti<br />
locali di avere comunque sul loro terr<strong>it</strong>orio un’ist<strong>it</strong>uzione scolastica autonoma con i suoi organismi di<br />
partecipazione e di governo (un collegio dei docenti, un consiglio di ist<strong>it</strong>uto, un unico dirigente).<br />
Ma la riflessione intorno alle prime esperienze ha dimostrato che si trattava di una radicale nov<strong>it</strong>à<br />
rispetto all’organizzazione gerarchica degli ordini e dei gradi del nostro sistema scolastico; per questo motivo<br />
gli ist<strong>it</strong>uti comprensivi, successivamente, sono stati estesi a tutto il terr<strong>it</strong>orio nazionale non più come una<br />
necess<strong>it</strong>à dovuta a ragioni demografiche od ambientali ma come una realtà virtuosa in grado di anticipare la<br />
nuova scuola di base così come si andava prefigurando nel dibatt<strong>it</strong>o culturale e nel confronto legislativo.<br />
2. LA SCUOLA DI BASE<br />
Con la legge di riordino dei cicli scolastici (D.Lgs. n. 29 del 5 marzo 2004) viene ridisegnata la struttura<br />
della scuola <strong>it</strong>aliana: il I ciclo di istruzione, di base, ha sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o la scuola elementare e la scuola media<br />
inferiore; seguiranno cinque anni di ciclo secondario superiore. La scuola di base ha quindi una durata di otto<br />
anni, è caratterizzata da un percorso educativo un<strong>it</strong>ario, articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo dei<br />
bambini e dei ragazzi, si raccorderà, da un lato, alla scuola dell’infanzia e, dall’altro, alla scuola secondaria.<br />
3. LE OPPORTUNITÀ DELLA SCUOLA DI BASE<br />
a) La continu<strong>it</strong>à educativa<br />
Poiché oggi il dir<strong>it</strong>to allo studio non si lim<strong>it</strong>a alla sola possibil<strong>it</strong>à di accesso alle strutture formative, la<br />
funzione della scuola si è venuta progressivamente ridefinendo con il superamento della logica selettiva a<br />
favore di quella formativa e orientativa, finalizzata ad individuare il valore di ogni alunno, per aiutarlo a<br />
"collocarsi nel mondo".<br />
La continu<strong>it</strong>à educativa è stata quindi posta come cr<strong>it</strong>erio pedagogico-didattico di riferimento per<br />
realizzare la massima efficacia del percorso formativo.<br />
“In un sistema scolastico articolato per segmenti separati, con storie e caratteristiche specifiche e poco<br />
comunicanti, la ricerca di modal<strong>it</strong>à di raccordo ha maggiormente evidenziato l’esigenza di una<br />
riconsiderazione complessiva della formazione di base finalizzata a recuperare quelle coerenze di sistema che<br />
la trasformazione diacronica e parziale dei diversi livelli scolastici aveva fatto disperdere. L’idea di scuola di<br />
base ha trovato una prima ampia possibil<strong>it</strong>à di realizzazione con l’ist<strong>it</strong>uzione delle scuole comprensive che<br />
hanno avviato l’elaborazione e la prova di fattibil<strong>it</strong>à di curricoli coordinati, finalizzati ad innalzare i livelli di<br />
successo formativo.” (Paolo Calidoni).<br />
b) L’un<strong>it</strong>arietà del curricolo<br />
Il percorso formativo della scuola di base, finalizzato all’accoglienza, alla prima alfabetizzazione e al suo<br />
successivo consolidamento, alla progressiva differenziazione degli strumenti culturali e al primo<br />
orientamento, ev<strong>it</strong>erà la ripetizione di identici programmi in spazi temporali ristretti e consentirà così la<br />
costruzione di percorsi meno compressi, con maggiori possibil<strong>it</strong>à di arricchimenti e approfondimenti.<br />
“Ad esempio, l’insegnamento della storia, nella sua accezione sistematica, inteso cioè come sistemazione<br />
di fatti ed eventi e ricostruzione di quadri di civiltà, potrebbe essere collocato nell’ultima parte del percorso di<br />
base, liberando energie – nei primi anni – per un approccio più attento agli aspetti narrativi, di gusto per le<br />
3
domande da rivolgere al passato, di primo incontro con documenti, storie, rappresentazioni, ecc.” (Giancarlo<br />
Cerini)<br />
c) La scuola del terr<strong>it</strong>orio<br />
Il rapporto scuola-terr<strong>it</strong>orio deve divenire il nodo strategico del processo di autonomia scolastica e di<br />
costruzione della scuola di base.<br />
Già la legge 97/94 relativa alla cost<strong>it</strong>uzione degli ist<strong>it</strong>uti comprensivi nelle zone di montagna si inseriva<br />
nel processo di riconsiderazione del rapporto tra servizi pubblici e dir<strong>it</strong>ti dei c<strong>it</strong>tadini, tra autor<strong>it</strong>à centrale ed<br />
autonomie locali, processo che durante gli anni ’90 ha indotto nel nostro Paese un’ampia produzione<br />
normativa e significativi processi di trasformazione della pubblica amministrazione.<br />
“Anche la scuola, quindi, viene considerata come un fattore di sviluppo terr<strong>it</strong>oriale se contribuisce al<br />
‘progetto’ e si inserisce nella v<strong>it</strong>a di una comun<strong>it</strong>à attraverso una presenza ist<strong>it</strong>uzionale un<strong>it</strong>aria (l’ist<strong>it</strong>uto con<br />
i suoi organismi di partecipazione ed un dirigente) e non solo con l’erogazione dei servizi (scuola materna,<br />
elementare e media) difficilmente coordinati anche perché governati e guidati a distanza. L’integrazione<br />
piena del servizio scolastico nel terr<strong>it</strong>orio, nella rete dei servizi finalizzati alla piena realizzazione dei dir<strong>it</strong>ti<br />
delle persone – in primis la formazione – e quindi come fattore di sviluppo dell’intera comun<strong>it</strong>à, cost<strong>it</strong>uisce<br />
una delle ragioni forti dell’ist<strong>it</strong>uzione di scuole di base un<strong>it</strong>arie”. (Paolo Calidoni).<br />
d) Una gestione un<strong>it</strong>aria<br />
Ogni scuola di base ha un collegio dei docenti un<strong>it</strong>ario, un unico consiglio di ist<strong>it</strong>uto, un medesimo<br />
dirigente.<br />
In questo modo è assicurata una gestione un<strong>it</strong>aria sia sotto il profilo amministrativo sia in ordine agli<br />
organi collegiali di governo della scuola.<br />
4. GLI ISTITUTI COMPRENSIVI: LABORATORIO DELLA SCUOLA DI BASE<br />
La continu<strong>it</strong>à educativa, la realizzazione di una maggiore integrazione scuola-terr<strong>it</strong>orio, l’un<strong>it</strong>arietà del<br />
curricolo sono, contemporaneamente, gli obiettivi centrali della nasc<strong>it</strong>a e dello sviluppo degli ist<strong>it</strong>uti<br />
comprensivi, del processo di autonomia e del riordino dei cicli.<br />
Per questa ragione gli ist<strong>it</strong>uti comprensivi cost<strong>it</strong>uiscono un laboratorio efficace dove si sviluppa una<br />
sperimentazione diffusa intorno ad alcuni nodi strategici che sono anche quelli della scuola di base:<br />
l’elaborazione di curricoli verticali un<strong>it</strong>ari, l’attivazione di anni-ponte nella prospettiva della continu<strong>it</strong>à, il pieno<br />
utilizzo e la più ampia valorizzazione delle risorse del terr<strong>it</strong>orio, i completamenti di cattedra nell’amb<strong>it</strong>o<br />
dell’intero ciclo della scuola dell’obbligo.<br />
5. I REQUISITI<br />
Gli esperti sono concordi nel riconoscere che i requis<strong>it</strong>i essenziali per la cost<strong>it</strong>uzione di un ist<strong>it</strong>uto<br />
comprensivo sono:<br />
un amb<strong>it</strong>o terr<strong>it</strong>oriale sufficientemente integrato sotto il profilo socio-ist<strong>it</strong>uzionale;<br />
la presenza di una scuola media e di alcune scuole primarie;<br />
una sostanziale corrispondenza fra i bacini d’utenza delle scuole primarie e della scuola media;<br />
una dimensione adeguata per quanto riguarda la popolazione scolastica: infatti ist<strong>it</strong>uzioni eccessivamente<br />
sottodimensionate non possono garantire risorse sufficienti di progettual<strong>it</strong>à, di dialettica collegiale e<br />
nemmeno finanziarie; pure ist<strong>it</strong>uzioni scolastiche con un numero troppo alto di alunni e di scuole<br />
compromettono la possibil<strong>it</strong>à di autentica collegial<strong>it</strong>à e piena condivisione e in defin<strong>it</strong>iva la stessa<br />
possibil<strong>it</strong>à di costruire un comune senso di appartenenza;<br />
una condivisione del progetto da parte delle comun<strong>it</strong>à locali interessate che devono cogliere la funzione<br />
pos<strong>it</strong>iva che le scuole comprensive possono svolgere per lo sviluppo della rete dei servizi del terr<strong>it</strong>orio e<br />
la qual<strong>it</strong>à dell’insegnamento-apprendimento.<br />
6. I REQUISITI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA<br />
L’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> Comprensivo di Villa Lagarina presenta tutti i requis<strong>it</strong>i qui evidenziati, infatti:<br />
4
i Comuni di Nogaredo, Villa Lagarina, Pomarolo e Nomi condividono le stese radici storiche, alcuni servizi<br />
e ist<strong>it</strong>uzioni culturali sovracomunali, una sufficiente omogene<strong>it</strong>à sotto il profilo antropologico-sociale;<br />
vi è una piena corrispondenza tra il bacino di utenza delle Scuole Primarie di Nogaredo, Pomarolo, Villa<br />
Lagarina, Nomi e quello della Scuola Media “Anna Frank”;<br />
presenta dimensioni adeguate per quanto riguarda la popolazione scolastica;<br />
il progetto è stato pienamente condiviso da tutte le Amministrazioni comunali che, a larga maggioranza,<br />
hanno espresso il loro parere favorevole in ordine alla cost<strong>it</strong>uzione di un unico ist<strong>it</strong>uto di base.<br />
Per queste ragioni si trova nelle condizioni ottimali per un pos<strong>it</strong>ivo funzionamento.<br />
7. GLI ISTITUTI COMPRENSIVI: UN’OPPORTUNITÀ PER LO SVILUPPO DELL’AUTONOMIA<br />
Il riconoscimento dell’autonomia alle scuole (legge 59/97 e Delibera della G. P. n. 6929 del 14 ottobre<br />
1999) e il suo avvio (1° settembre 2000) si collocano nel più ampio quadro del decentramento e del<br />
trasferimento alla periferia (regioni ed enti locali) di comp<strong>it</strong>i e competenze tradizionalmente assegnati allo<br />
Stato centrale.<br />
Il rapporto scuola-terr<strong>it</strong>orio cost<strong>it</strong>uisce il nodo strategico del processo riformatore; il cuore<br />
dell’autonomia scolastica consiste infatti proprio in questo: la scuola r<strong>it</strong>iene il terr<strong>it</strong>orio risorsa essenziale del<br />
proprio progetto e, nello stesso tempo, considera se stessa risorsa di sviluppo del terr<strong>it</strong>orio.<br />
Per questo, nella definizione dei percorsi formativi, è prevista una quota obbligatoria nazionale e una<br />
quota, sia obbligatoria sia integrativa, lasciata alla scelta delle singole scuole; le scuole, cioè, possono<br />
definire la loro offerta formativa tenendo conto non solo di quanto richiesto a livello nazionale, ma anche di<br />
quanto è richiesto in vario modo dal terr<strong>it</strong>orio di riferimento, dalle famiglie, dagli alunni.<br />
Ora, gli ist<strong>it</strong>uti comprensivi, dal punto di vista dell’organizzazione didattica, risultano essere più motivati<br />
a cogliere le nuove opportun<strong>it</strong>à offerte dall’autonomia scolastica: l’apertura delle classi, l’organizzazione del<br />
lavoro per gruppi e laboratori, il pieno utilizzo e un’ampia valorizzazione delle risorse del terr<strong>it</strong>orio, un uso più<br />
esteso delle competenze presenti nell’un<strong>it</strong>à scolastica attraverso i prest<strong>it</strong>i professionali, gli scambi<br />
temporanei dei docenti, le funzioni di accompagnamento da un livello scolastico all’altro.<br />
5
IL TERRITORIO<br />
In quale contesto sociale, economico e culturale è inser<strong>it</strong>o e opera l’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> Comprensivo? I comuni che<br />
fanno riferimento ad esso sono Nogaredo, Villa Lagarina, Pomarolo, Nomi, con una popolazione complessiva<br />
di 8.879 persone. Si tratta di una conurbazione di paese, estesa in un terr<strong>it</strong>orio abbastanza vasto e<br />
altimetricamente difforme, con una rete viaria e un sistema di trasporti pubblici che riducono di molto le<br />
distanze. Distanze che rimangono semmai sotto forma di un appannato senso di appartenenza ai paesi,<br />
retaggio di un tempo antico, oggi rivivificato – secondo una tendenza diffusa – da feste e sagre e tenzoni<br />
riportate in auge dalle Pro Loco.<br />
La maggioranza della popolazione attiva di questi paesi è occupata nei settori secondario e terziario di<br />
Rovereto e Trento, dando v<strong>it</strong>a in tal modo ad un flusso di spostamento quotidiano verso e dalle c<strong>it</strong>tà molto<br />
consistente.<br />
Per quanto riguarda, invece, la mobil<strong>it</strong>à in entrata (immigrazione) e in usc<strong>it</strong>a (emigrazione), i dati dicono<br />
che la prima prevale nettamente sulla seconda, che il fenomeno è comunque numericamente contenuto, ed<br />
è legato soprattutto a movimenti di popolazione determinati da nuovi insediamenti urbani: nell'anno 2005 i<br />
quattro comuni hanno registrato 301 immigrati contro i 280 emigrati<br />
Anche nel terr<strong>it</strong>orio dei quattro comuni i settori produttivi più frequentati sono il secondario (con alcune<br />
piccole industrie, e molte officine artigianali) e il terziario (commerciale) che ha goduto in tempi recentissimi<br />
della disponibil<strong>it</strong>à di aree di insediamento a minor costo che non a Rovereto e favor<strong>it</strong>e da una buona<br />
accessibil<strong>it</strong>à stradale.<br />
L’agricoltura, fino a qualche decennio fa settore chiave nella formazione del redd<strong>it</strong>o di una società ancora<br />
prevalentemente contadina, oggi è trasformata in un’attiv<strong>it</strong>à molto specializzata, basata su poche colture<br />
(v<strong>it</strong>i, ciliegie, mele) lavorate da pochissimi addetti fissi, in genere proprietari (11 nel comune di Villa), e un<br />
numero più consistente di avventizi (in gran parte parenti o amici dei proprietari) nei momenti di raccolta.<br />
Diffuso è invece il fenomeno del doppio lavoro che vede operai o impiegati lavorare nel tempo libero il piccolo<br />
pezzo di terra adib<strong>it</strong>o all’autoconsumo o poco più.<br />
Ma il vero motore dell’economia locale si è rivelata in questi ultimi vent’anni l’amministrazione pubblica,<br />
sia in quanto produttrice diretta di redd<strong>it</strong>o (attraverso l’impiego di un numero consistente di un<strong>it</strong>à<br />
lavorative), che in quanto promotrice di iniziative di varia natura che hanno dato impulso alla v<strong>it</strong>a economica,<br />
sociale e culturale dei paesi, potendo contare sulla ricca, quasi illim<strong>it</strong>ata, disponibil<strong>it</strong>à finanziaria della<br />
Provincia Autonoma di Trento. È così che in ogni realtà comunale sono sorti centri sportivi molto ben<br />
attrezzati, biblioteche (Villa e Nomi), centri di lettura (Pomarolo, Pedersano, Castellano), nuovi edifici<br />
scolastici, sedi per iniziative culturali, ristrutturati vecchi teatri parrocchiali (Villa, Pedersano, Castellano),<br />
finanziate scuole musicali (Villa, Pomarolo). E di tutte queste strutture l’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> può direttamente o<br />
indirettamente usufruire, trovando all’esterno gli spazi e gli strumenti che mancano all’interno. Così come, va<br />
pur detto, in questi anni le scuole che ora si sono unificate hanno potuto contare su un considerevole apporto<br />
tecnico-finanziario da parte dei comuni che ha permesso loro sia di potenziare le attiv<strong>it</strong>à meramente<br />
scolastiche che di rafforzare la loro presenza sul terr<strong>it</strong>orio con iniziative formativo – culturali rivolte ai<br />
gen<strong>it</strong>ori.<br />
6
L'ORGANIZZAZIONE<br />
7
LA STRUTTURA E L’ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO<br />
Concorrono a definire l’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> Comprensivo di Villa Lagarina le Scuole Primarie di Nogaredo, Villa<br />
Lagarina, Pomarolo e Nomi nonché la Scuola Secondaria di I° “Anna Frank”.<br />
1. LA SCUOLA PRIMARIA DI NOGAREDO<br />
L’AMBIENTE<br />
Nogaredo, a 1, 5 km da Villa Lagarina, comprende le frazioni di Brancolino (km 2), Noarna (km 3), Sasso<br />
(km 3,5), Molini (km 1) e conta una popolazione di 1.847 ab<strong>it</strong>anti. La formazione è assicurata da una scuola<br />
dell’infanzia provinciale e, appunto, dalla scuola primaria; le due ist<strong>it</strong>uzioni sono pressoché contigue.<br />
La periferia è collegata con Nogaredo centro da un servizio di trasporto nell’insieme puntuale e mirato<br />
alle esigenze degli alunni.<br />
L’INTITOLAZIONE<br />
La scuola è denominata “Scuola Primaria di Nogaredo”.<br />
L’ANDAMENTO DEMOGRAFICO E LE ISCRIZIONI<br />
Per il quinquennio è previsto il seguente andamento demografico:<br />
Classi <strong>2006</strong>/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11<br />
1 a 10 24 26 15 23<br />
2 a 10 10 24 26 15<br />
3 a 21 10 10 24 26<br />
4 a 17 21 10 10 24<br />
5 a 12 17 21 10 10<br />
Totale 70 82 91 85 98<br />
L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO<br />
ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO<br />
7.55 – 12.15<br />
12.15 – 14.00<br />
14.00 – 16.00<br />
Mensa<br />
interscuola<br />
Mensa<br />
interscuola<br />
Attiv<strong>it</strong>à<br />
facoltative<br />
Viene impart<strong>it</strong>o l’insegnamento della lingua tedesca, per due ore settimanali in classe prima e per tre<br />
nelle altre classi.<br />
La mensa scolastica è in grado di accogliere fino a 70 alunni, per cui è possibile garantire il servizio a<br />
tutti i potenziali utenti; i pasti vengono preparati in altra sede.<br />
L’organico dei docenti, per l’anno scolastico <strong>2006</strong>/07, risulta defin<strong>it</strong>o in 7, un insegnante di tedesco per<br />
18 ore e uno di religione per 10 ore che completa l’orario a Pomarolo, esperti CONI e dei Comuni per<br />
l’educazione motoria.<br />
Inoltre interviene un esperto per l’informatica.<br />
LA STRUTTURA E LE RISORSE<br />
Nell’insieme l’edificio risponde ai requis<strong>it</strong>i previsti dal D.Lgs. 626 e le operazioni di verifica vengono<br />
effettuate sistematicamente da un tecnico incaricato per l’intero <strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> comprensivo.<br />
8
È stato costru<strong>it</strong>o nel 1975 e successivamente sono state esegu<strong>it</strong>e le operazioni di manutenzione<br />
ordinaria e straordinaria richieste dalla normativa.<br />
Risulta così articolato:<br />
al primo piano: 2 aule, aula insegnanti, atrio, ripostiglio per materiale pulizia e servizi;<br />
<br />
<br />
al secondo piano: 3 aule, atrio e servizi;<br />
al piano terra: mensa, aula informatica, magazzino.<br />
La superficie esterna è sufficiente per il gioco e l’attiv<strong>it</strong>à sportiva.<br />
Sono pressochè conclusi i lavori di costruzione della palestra sul lato sud della scuola a servizio delle<br />
esigenze della scuola e della comun<strong>it</strong>à.<br />
La scuola, infine, è dotata dei sussidi di base nel campo dell’educazione scientifica, all’immagine, al<br />
suono e alla musica.<br />
2. VILLA LAGARINA<br />
L’AMBIENTE<br />
È la sede dell’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> Comprensivo.<br />
Posta a 23 km. da Trento, comprende le frazioni di Castellano (8 km – 594 residenti), Pedersano (3 km –<br />
849 residenti) e Piazzo (0, 6 km – 383 residenti), e conta una popolazione di 1.624 ab<strong>it</strong>anti (3450 per l’intero<br />
comune).<br />
La formazione scolastica è assicurata da tre scuole materne equiparate a Villa Lagarina, Pedersano e<br />
Castellano; una scuola primaria e la scuola media a Villa Lagarina.<br />
Il centro ab<strong>it</strong>ato è facilmente raggiungibile con gli autobus di linea che lo collegano sia con la vicina<br />
Rovereto sia con i paesi lim<strong>it</strong>rofi.<br />
LA SCUOLA PRIMARIA “PARIDE LODRON”<br />
L’INTITOLAZIONE<br />
La Scuola Primaria di Villa Lagarina è int<strong>it</strong>olata a Paride Lodron.<br />
Paride Lodron, nato il 13 febbraio 1586 in Castel Nuovo e cresciuto nel palazzo di Nogaredo, parroco di Villa<br />
Lagarina nel 1612 e principe vescovo di Salisburgo dal 1621 al 1653, condivise pienamente il paradigma<br />
pol<strong>it</strong>ico - teologico del suo tempo, “il tempo del barocco, il tempo del potere, anche religioso, espresso in<br />
assolutismo, in splendore, in grandios<strong>it</strong>à, il tempo della netta separazione tra le classi sociali, tra il clero e i<br />
laici”.<br />
Si tratta quindi di una concezione pol<strong>it</strong>ica e teologica completamente superata grazie al pensiero democraticoliberale,<br />
alla riflessione teologica così come si è andata sintetizzando anche nei testi conciliari.<br />
In questo Paride è figlio del suo tempo e forse non poteva essere diversamente; tuttavia la sua personal<strong>it</strong>à non<br />
si esaurisce in esso. Si tratta di una personal<strong>it</strong>à complessa, di alta levatura, inser<strong>it</strong>a, sia come capo di stato sia<br />
come vescovo, nei drammatici avvenimenti della storia europea per tutta la guerra dei trent’anni, guerra che<br />
cambiò radicalmente il volto pol<strong>it</strong>ico e culturale dell’Europa centro-settentrionale. Dentro questo contesto<br />
Paride fu cattolico determinato, difensore convinto della teologia tridentina contro i protestanti riformisti. Non<br />
fu però un cieco intransigente, tanto che la letteratura protestante posteriore giudicò sempre pos<strong>it</strong>ivamente,<br />
perché tollerante, la sua pol<strong>it</strong>ica religiosa.<br />
Legò pure il suo nome alla costruzione del maestoso duomo di Salisburgo, alla fondazione dell’univers<strong>it</strong>à di<br />
quella c<strong>it</strong>tà dove studiarono molti <strong>it</strong>aliani e tre posti, nei collegi da lui voluti, furono riservati a studenti della<br />
parrocchia di Villa Lagarina.<br />
Possedette anche in campo economico un forte spir<strong>it</strong>o d’impresa che si concretizzò in una molteplic<strong>it</strong>à di<br />
iniziative, alcune delle quali anche in Val Lagarina: così nel 1626 fece costruire un filatoio e una tintoria sul<br />
Cornalè, potenziò gli ist<strong>it</strong>uti di cred<strong>it</strong>o cercando di venire incontro alle necess<strong>it</strong>à della gente, si preoccupò<br />
dell’amministrazione della giustizia creando i Giudici della Pace e della Concordia ev<strong>it</strong>ando, così come si legge<br />
in un documento dell’epoca, che le grosse spese che venivano sostenute nei tribunali rendessero “quasi desolate<br />
le famiglie”.<br />
Infine si interessò anche di scuola garantendo che parte degli interessi della Cappella di S. Ruperto di Villa<br />
Lagarina venissero destinati per pagare le spese per il maestro di scuola, che era il sacerdote primissario.<br />
9
Quindi non solo un uomo del suo tempo ma un uomo capace di operare in esso con intelligenza ed operos<strong>it</strong>à,<br />
attento anche al benessere della gente lagarina.<br />
Da Antonio Passerini - " La nobile pieve di Villa Lagarina" 1994<br />
L’ANDAMENTO DEMOGRAFICO E LE ISCRIZIONI<br />
Il bacino di utenza della scuola corrisponde all’intero comune. Per il quinquennio è previsto il seguente<br />
andamento demografico:<br />
Classi <strong>2006</strong>/07 2007/08 2008/09 2009/10 2009/10<br />
1 a 39 38 44 35 42<br />
2 a 43 39 38 44 35<br />
3 a 53 43 39 38 44<br />
4 a 41 53 43 39 38<br />
5 a 50 41 53 43 39<br />
Totale 226 214 217 199 198<br />
La Giunta Provinciale con delibera n. 530 del 9 marzo 2001 ha disposto, con decorrenza dall'anno<br />
scolastico 2001-2002, la soppressione della scuola elementare di Villa Lagarina-Castellano "in considerazione<br />
dell'esigu<strong>it</strong>à della popolazione scolastica, tale da comportare una difficoltosa articolazione della didattica,<br />
strutturata su pluriclassi, e una scarsa possibil<strong>it</strong>à di socializzazione per gli alunni. Gli alunni della scuola<br />
soppressa di Castellano confluiscono sul plesso di Villa Lagarina; subordinatamente alla possibil<strong>it</strong>à di<br />
realizzare un efficace servizio di trasporto scolastico, a quella di Villa Lagarina potrà essere affiancata come<br />
ulteriore plesso di riferimento la scuola di Nogaredo per il tempo necessario a consentire una proposta<br />
diversificata del tempo scuola nel plesso di Villa Lagarina".<br />
L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO<br />
ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ<br />
8.00 – 12.00<br />
12.00–13.50<br />
Mensa<br />
interscuola<br />
Mensa<br />
interscuola<br />
Mensa<br />
interscuola<br />
Mensa<br />
interscuola<br />
Mensa<br />
interscuola<br />
13.50–15.50<br />
Attiv<strong>it</strong>à<br />
facoltative<br />
È in corso un progetto di sperimentazione della lingua inglese che interessa tutte le classi (2 ore in<br />
classe prima e 3 ore nelle altre classi).<br />
La mensa funziona presso la contigua scuola media; si tratta di una struttura di notevoli dimensioni che<br />
può accogliere, contemporaneamente, fino a 150 utenti; gli alunni della scuola primaria usufruiscono del<br />
servizio in tempi diversi (doppio turno).<br />
L’organico del personale docente risulta defin<strong>it</strong>o in 21 posti, in aggiunta operano un docente a tempo<br />
pieno e un docente a part time per la lingua inglese e un docente di religione, esperti CONI e dei Comuni per<br />
l’educazione motoria.<br />
Inoltre interviene un esperto per l’informatica.<br />
10<br />
LA STRUTTURA E I SUSSIDI<br />
Si tratta di un edificio di recente costruzione (1991-1997), pregevole anche sotto il profilo arch<strong>it</strong>ettonico<br />
e collocato dentro un comparto urbano particolarmente ricco per la storia religiosa e la v<strong>it</strong>a culturale di<br />
questa comun<strong>it</strong>à: accanto alla Chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta, uno dei più insigni monumenti<br />
barocchi del Trentino, troviamo la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola media e il teatro<br />
parrocchiale.<br />
Risulta così articolato:<br />
piano interrato: palestra moderna e attrezzata con relativi servizi;<br />
piano terra: 6 aule normali, un’aula per sostegno/recupero, un laboratorio multimediale (computer<br />
collegati in rete, proiettore), un’interaula, una sala per i docenti;<br />
al primo piano: 5 aule normali, un’interaula, uno spazio per la biblioteca.
L’edificio è circondato da uno spazio molto ampio, in parte asfaltato in parte a verde, sufficiente per tutte<br />
le attiv<strong>it</strong>à ludiche e sportive.<br />
La scuola, inoltre, è dotata dei sussidi di base nel campo dell’educazione scientifica, all’immagine, al<br />
suono e alla musica.<br />
11
2.2 LA SCUOLA SECONDARIA DI I° “ANNA FRANK”<br />
L’INTITOLAZIONE<br />
La Scuola Media di Villa Lagarina è int<strong>it</strong>olata a “Anna Frank”.<br />
Quando la nostra scuola diventò autonoma, decidemmo di darle il nome di Anna Frank, la giovane ebrea<br />
tedesca morta nel lager di Bergen Belsen nel marzo del 1945, che è diventata famosa poi in tutto il mondo<br />
grazie alle straordinarie pagine del suo diario, quel diario che le tenne calda compagnia per due anni<br />
nell’appartamento clandestino dove restò nascosta con la sua famiglia e con altre quattro persone, prima di<br />
essere scoperta, arrestata e deportata.<br />
La scr<strong>it</strong>tura di Anna Frank è uno stimolo forte per la memoria individuale e collettiva, per non dimenticare le<br />
atroc<strong>it</strong>à del secolo XX, ma nello stesso tempo è un concreto, illuminante esempio della forza comunicativa e<br />
dell’energia umana che proprio dalla scr<strong>it</strong>tura promana, resistenza alle difficoltà della v<strong>it</strong>a, aiuto a capire<br />
meglio se stessi e gli altri, fonte di pensieri e di orizzonti che oltrepassano il quotidiano.<br />
"È un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze perché esse sembrano assurde e<br />
inattuabili. Le conservo ancora, nonostante tutto, perché continuo a credere nell’intima bontà dell’uomo. Mi è<br />
impossibile costruire tutto sulla base della morte, della miseria, della confusione. Vedo il mondo mutarsi<br />
lentamente in un deserto, odo sempre più forte l’avvicinarsi del rombo che ucciderà noi pure, partecipo al<br />
dolore di milioni di uomini, eppure, quando guardo il cielo, penso che tutto si volgerà nuovamente al bene, che<br />
anche questa spietata durezza cesserà, che r<strong>it</strong>orneranno l’ordine, la pace e la seren<strong>it</strong>à”.<br />
Anna Frank aveva l’età degli alunni della scuola media: alla sua intelligenza viva, alla sua scr<strong>it</strong>tura semplice e<br />
profonda, alla sua v<strong>it</strong>al<strong>it</strong>à creatrice e generosa abbiamo dedicato la nostra Scuola.<br />
NOTE STORICHE<br />
Dal 1962, anno in cui la scuola media è divenuta obbligatoria, gli alunni della Destra Adige hanno<br />
frequentato la Scuola Media “Paolo Orsi” di Rovereto.<br />
Nel 1980/81 è stato ist<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o per loro un corso staccato, dislocato presso l’edificio dei padri della<br />
Consolata.<br />
Nel 1981/82 tale corso è stato trasfer<strong>it</strong>o nel nuovo edificio di Villa Lagarina, ma amministrativamente la<br />
scuola è rimasta incardinata alla Scuola Media “Paolo Orsi” fino al 1985/86, diventando autonoma solo<br />
nell’anno scolastico 1986/87. Per la sua costruzione e gestione si è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o un Consorzio fra i Comuni di<br />
Villa Lagarina, Nogaredo, Nomi e Pomarolo con sede a Villa Lagarina.<br />
L’ANDAMENTO DEMOGRAFICO E LE ISCRIZIONI<br />
Per il quinquennio è previsto il seguente andamento demografico:<br />
Classi <strong>2006</strong>/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11<br />
1 a 71 102 107 111 89<br />
2 a 78 71 102 107 111<br />
3 a 81 78 71 102 107<br />
Totale 230 251 280 320 307<br />
Gli alunni provengono da Nomi, Pomarolo, Savignano, Pedersano, Castellano, Villa Lagarina, Nogaredo,<br />
Sasso, Noarna, Brancolino.<br />
Queste local<strong>it</strong>à sono collegate con Villa Lagarina da un servizio di trasporto nell’insieme puntuale.<br />
L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO<br />
Tempo scuola di 32 un<strong>it</strong>à orarie settimanali, articolate in 6 mattine e un pomeriggio,<br />
di attiv<strong>it</strong>à curriculare (curricolo di base e opzionale obbligatorio) e 2 un<strong>it</strong>à orarie opzionali facoltative<br />
(curricolo opzionale) con attiv<strong>it</strong>à di laboratorio.<br />
12<br />
ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO<br />
8.00 – 12.45<br />
12.45–13.58<br />
Mensa<br />
interscuola<br />
Mensa<br />
interscuola<br />
Mensa<br />
interscuola<br />
Mensa<br />
interscuola<br />
13.58–15.45 Corso B Corso C Attiv<strong>it</strong>à Attiv<strong>it</strong>à
1 e 2A 3A e 3D facoltative facoltative<br />
L’organico del personale docente è assegnato in base alla normativa vigente.<br />
LA STRUTTURA E LE RISORSE<br />
L’edificio scolastico, costru<strong>it</strong>o nel 1981, si presenta in buone condizioni e nel corso degli anni sono stati<br />
effettuati numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.<br />
Sviluppato su due piani, è a norma per quanto riguarda la sicurezza e l’igiene, il sistema antincendio, il<br />
superamento delle barriere arch<strong>it</strong>ettoniche.<br />
La struttura è articolata in 10 aule normali, ampie e luminose, e in numerosi laboratori dove i ragazzi<br />
trovano strumenti che favoriscono la verifica e l’approfondimento dei saperi proposti nonché la pratica di una<br />
didattica che vede una stretta connessione tra il fare e il sapere.<br />
In particolare ci sono:<br />
n. 2 laboratori di scienze (microscopia e fisica, chimica e biologia) dotati di tavole scientifiche, modelli<br />
anatomici, materiale audiovisivo, microscopi, strumenti per esperimenti di ottica, meccanica e chimica;<br />
n. 2 laboratori di informatica, per lo sviluppo di progetti multidisciplinari attraverso l’utilizzo di supporti<br />
multimediali e informatici;<br />
n. 1 laboratorio per l’educazione artistica dotato di arredi, materiali ed attrezzi per l’apprendimento<br />
delle tecniche artistiche di base;<br />
n. 2 laboratori di educazione tecnica arredati in modo specifico per consentire, in uno, l’attiv<strong>it</strong>à pratica<br />
di falegnameria e di elettrotecnica e, nell’altro, il disegno tecnico con una dotazione di parallelografi e di<br />
modelli di solidi in legno;<br />
n. 1 laboratorio musicale attrezzato per l’ascolto guidato con impianto stereo e numerosi dischi e<br />
cassette, vi sono inoltre strumenti di vario tipo che consentono agli alunni una conoscenza diretta dello<br />
strumento musicale;<br />
n. 1 biblioteca utilizzata soprattutto per attiv<strong>it</strong>à di ricerca, di laboratorio e di consultazione;<br />
n. 1 videoteca cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a da più di circa 800 fra videocassette, CD e DVD che comprendono filmati,<br />
documentari videodidattici e produzioni realizzate dagli stessi alunni;<br />
n. 1 aula video con attrezzatura multimediale;<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
n. 1 aula magna per le attiv<strong>it</strong>à ludiche dei ragazzi durante la pausa pomeridiana e le riunioni collegiali;<br />
n. 1 palestra dotata di attrezzature adeguate per il gioco della pallavolo, della pallamano e della<br />
pallacanestro, nonché di tutte le attrezzature necessarie alla pratica sportiva; in orario non scolastico<br />
viene utilizzata da numerose società sportive;<br />
n. 1 mensa con 150 posti e una cucina dove vengono direttamente preparati i pasti;<br />
n. 1 sala insegnanti, un’aula per i coordinatori e collaboratori del dirigente e 3 uffici per l’attiv<strong>it</strong>à<br />
amministrativa dell’intero <strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong>.<br />
3. LA SCUOLA PRIMARIA DI POMAROLO<br />
A 2 km. da Villa Lagarina, comprende le frazioni di Chiusole (2 km), e Savignano (4 km) e conta una<br />
popolazione di 2.296 ab<strong>it</strong>anti.<br />
La formazione scolastica è assicurata da una scuola materna e, appunto, dalla scuola primaria.<br />
L’INTITOLAZIONE<br />
La Scuola Primaria di Pomarolo è int<strong>it</strong>olata a “Remo Galvagni”.<br />
Remo Galvagni nacque a Rovereto il 13 aprile 1897 da Luigi Galvagni di Chiusole e da Clotilde Ambrosi di<br />
Villa Lagarina.<br />
Nel 1898 la famiglia r<strong>it</strong>ornò a Pomarolo, dove rimase fino al 1905 per poi trasferirsi defin<strong>it</strong>ivamente a<br />
Rovereto.<br />
Frequentò il Ginnasio e successivamente l’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> nautico di Genova.<br />
Scoppiata la prima guerra mondiale, nell’aprile del 1915, attraverso la Vallarsa, raggiunse clandestinamente<br />
l’Italia dove si arruolò volontario. Combatté sul Monte Zugna e, successivamente, sul Monte Baldo dove trovò<br />
la morte nel dicembre del 1915.<br />
13
La scuola venne int<strong>it</strong>olata a Remo Galvagni il 27 ottobre 1929.<br />
Oggi, dopo due guerre mondiali e alla luce di nuovi rapporti di cooperazione tra i popoli, anche<br />
l’int<strong>it</strong>olazione della scuola deve forse essere rivista proponendo ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie modelli<br />
più vicini alla loro sensibil<strong>it</strong>à.<br />
L’ANDAMENTO DEMOGRAFICO E LE ISCRIZIONI<br />
Per il quinquennio è previsto il seguente andamento demografico:<br />
Classi <strong>2006</strong>/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11<br />
1 a 32 31 30 33 22<br />
2 a 32 32 31 30 33<br />
3 a 24 32 32 31 30<br />
4 a 36 24 32 32 31<br />
5 a 28 36 24 32 32<br />
Totale 152 155 149 158 148<br />
L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO<br />
ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ<br />
8.00 – 12.00<br />
12.00 – 14.00<br />
14.00 – 16.00<br />
Mensa<br />
interscuol<br />
a<br />
Mensa<br />
interscuola<br />
Mensa<br />
interscuola<br />
Attiv<strong>it</strong>à<br />
facoltative<br />
Mensa<br />
interscuola<br />
Mensa<br />
interscuola<br />
Viene impart<strong>it</strong>o l’insegnamento della lingua inglese, per due ore in classe prima e per tre nelle rimanenti.<br />
L’organico del personale docente risulta defin<strong>it</strong>o in 15 posti più 9 ore, più un docente di lingua inglese e<br />
un docente di religione in comune con Nomi e uno con Nogaredo.<br />
Inoltre interviene un esperto per l’informatica e le tecnologie multimediali.<br />
LA STRUTTURA E LE RISORSE<br />
L’edificio scolastico è di recente costruzione (ITEA 1988) e risponde ai requis<strong>it</strong>i previsti dal D. Lgs. 626; il<br />
Comune assicura la manutenzione ordinaria e straordinaria.<br />
È articolato su due piani, mentre al piano seminterrato si trovano la palestra (regolare), i relativi servizi,<br />
un ampio atrio da utilizzare per attiv<strong>it</strong>à collettive.<br />
Lo spazio più propriamente di pertinenza della scuola è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o:<br />
al piano rialzato da quattro aule, due interaule e la sala insegnanti;<br />
<br />
<br />
al primo piano da cinque, due interaule, la biblioteca;<br />
al piano interrato l’aula multimediale.<br />
Per l’attiv<strong>it</strong>à ludica e sportiva è disponibile uno spazio esterno, in parte a piastre e in parte a verde che<br />
in segu<strong>it</strong>o alla costruzione dell’asilo nido è stato ridotto.<br />
La mensa scolastica, ubicata presso il vicino Centro civico, osp<strong>it</strong>a fino a 80 alunni per turno; presso il<br />
medesimo Centro si trova pure un’ampia sala che può essere utilizzata anche per le funzioni della scuola.<br />
La scuola, inoltre, è dotata dei sussidi di base nel campo dell’educazione scientifica, all’immagine, al<br />
suono e alla musica.<br />
In relazione all’aumento della popolazione scolastica atteso, il Comune ha programmato un significativo<br />
intervento di ampliamento dell’edificio<br />
14
4. LA SCUOLA PRIMARIA DI NOMI<br />
L’AMBIENTE<br />
A 4 km. da Villa Lagarina conta una popolazione di 1.286 ab<strong>it</strong>anti. La formazione scolastica è assicurata<br />
da una scuola materna e, appunto, dalla scuola primaria.<br />
L’INTITOLAZIONE<br />
La Scuola Primaria è int<strong>it</strong>olata a “Luigi Vicentini”.<br />
La p<strong>it</strong>tura è uno strumento di conoscenza, uno strumento leggero che costruisce visioni per l’occhio e per la<br />
mente. La p<strong>it</strong>tura susc<strong>it</strong>a sensazioni ed emozioni che ci permettono di cogliere aspetti imprevedibili della realtà,<br />
compresa la realtà interiore.<br />
È dunque significativo che una scuola abbia scelto per sé il nome di un p<strong>it</strong>tore come Luigi Vicentini, (1901-<br />
1970) eppure ancora così vivo attraverso i suoi paesaggi, intrisi di caldi colori e di poetiche trasparenze.<br />
Luigi Vicentini dipinse la natura della “sua” Destra Adige e delle montagne trentine con rara partecipazione<br />
lirica e riuscì a far diventare il paesaggio specchio dei sentimenti più segreti e insieme più fecondi. Il lago di<br />
Cei rappresentato dal Nostro, per esempio, non è più soltanto un’affascinante superficie d’acqua circondata dai<br />
boschi, ma una tavolozza che sorprende per le sue variazioni coloristiche legate al volgere delle stagioni e<br />
proprio per questo intrecciate con i mutamenti più intimi dell’animo e dei pensieri.<br />
Luigi Vicentini restò sempre legato alla sua terra, a parte alcune parentesi lagunari venete, e in qualche modo<br />
inseguì tutta la v<strong>it</strong>a il fantasma del genio del luogo interpretando con un colore luminoso il senso v<strong>it</strong>ale delle<br />
sue radici. Il paesaggio di Vicentini è sempre aperto, l’orizzonte spinge sempre oltre lo sguardo; crescere in<br />
questa prospettiva vuol dire conoscere ed amare il proprio ambiente, la sua immagine e la sua storia, ma vuol<br />
dire anche essere capaci di alzare gli occhi e la mente per volare con la fantasia al di là dei lim<strong>it</strong>i del nostro<br />
piccolo mondo.<br />
L’ANDAMENTO DEMOGRAFICO E LE ISCRIZIONI<br />
Per il quinquennio è previsto il seguente andamento demografico:<br />
Classi <strong>2006</strong>/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11<br />
1 a 9 19 13 10 15<br />
2 a 4 9 19 13 10<br />
3 a 13 4 9 19 13<br />
4 a 13 13 4 9 19<br />
5 a 12 13 13 4 9<br />
Totale 51 58 58 55 66<br />
L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO<br />
ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ<br />
8.00 – 12.00<br />
12.00–14.00<br />
14.00–16.00<br />
Mensa<br />
interscuola<br />
Mensa<br />
interscuola<br />
Mensa<br />
interscuola<br />
Attiv<strong>it</strong>à<br />
facoltative<br />
Mensa<br />
interscuola<br />
Mensa<br />
interscuola<br />
Viene impart<strong>it</strong>o l’insegnamento della lingua tedesca, per due ore in classe prima e per tre nelle<br />
rimanenti.<br />
L’organico, per l’anno scolastico corrente, è di 5 docenti più uno a tempo parziale per 15 ore di servizio,<br />
più un insegnante di religione in comune con Pomarolo e un insegnante di tedesco.<br />
15
Inoltre interviene un esperto per l’informatica.<br />
LA STRUTTURA E LE RISORSE<br />
L’edificio è stato interamente ristrutturato ed ampliato secondo i più aggiornati parametri di sicurezza e<br />
vivibil<strong>it</strong>à. Nello stesso edificio, accanto alla scuola sono predisposti i locali per la biblioteca civica che sarà<br />
aperta a breve. Gli arredi sono stati in buona parte rinnovati ed è previsto un completo e qualificato piano di<br />
completamento dell’arredamento.<br />
5. CALENDARIO PER L’ANNO SCOLASTICO <strong>2006</strong>/07<br />
INIZIO DELLE LEZIONI 13 SETTEMBRE <strong>2006</strong><br />
FESTIVITA’ (oltre le domeniche e non ricadenti nei periodi di vacanza):<br />
1 novembre <strong>2006</strong> ognissanti<br />
8 dicembre <strong>2006</strong> festa dell’Immacolata Concezione<br />
25 aprile 2007 festa della liberazione<br />
1 maggio 2007 festa del lavoro<br />
2 giugno 2007 festa della Repubblica<br />
VACANZE:<br />
9 dicembre <strong>2006</strong><br />
Natalizie:<br />
Pasquali:<br />
30 aprile 2007<br />
dal 22 dicembre <strong>2006</strong> al 6 gennaio 2007 compresi<br />
dal 5 al 10 aprile 2007 compresi<br />
VACANZE E ADATTAMENTI DEL CALENDARIO SCOLASTICO<br />
DELIBERATE DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO:<br />
Vacanze:<br />
20 febbraio 2007<br />
4 e 11 aprile 2007<br />
le lezioni avranno luogo solo in orario antimeridiano nei giorni seguenti:<br />
13, 14, 15 e 16 settembre <strong>2006</strong><br />
e 7, 8 e 9 giugno 2007<br />
TERMINE DELLE LEZIONI 9 GIUGNO 2007<br />
Totale dei giorni di Lezione: 203<br />
16
6. ORGANIZZAZIONE DEL COLLEGIO DOCENTI<br />
PRESIDENTE<br />
Dirigente Scolastico Paolo Goffo<br />
COLLABORATRICE DEL DIRIGENTE<br />
Prof. Bianca Stella Moscatelli con incarico di curare l’autovalutazione<br />
Il Collegio Docenti può r<strong>it</strong>rovarsi per sezione delle Scuole Primarie, della Scuola Secondaria o Un<strong>it</strong>ario, a<br />
seconda delle necess<strong>it</strong>à o opportun<strong>it</strong>à.<br />
FUNZIONI STRUMENTALI DEL PROGETTO D’ISTITUTO:<br />
1. area dell’intercultura: segu<strong>it</strong>a dall’Ins. Ancilla Dominici – senza funzione<br />
2. area dei bisogni educativi speciali: ins. Lorena Barberi<br />
3. area dell’informatizzazionedella didattica: prof. Luigi Thiella<br />
4. area dell’orientamento prof. Nicoletta Redolfi<br />
INCARICHI SPECIALI<br />
ο Teresa Rigotti referente per l’educazione alla salute<br />
ο Adelmo Calliari referente per l’educazione alla solidarietà<br />
ο Adelmo Calliari e Daniela Mazzurana referenti per l’educazione stradale<br />
COORDINAMENTO<br />
Bigi Patrizia<br />
Brusco Roberta<br />
Marsili Loredana<br />
Moscadelli Bianca Stella<br />
Parisi Erminia<br />
Rigotti Teresa<br />
Virone Antonino<br />
Zandonai Angela<br />
COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI<br />
Membri effettivi:<br />
Albertini Annalisa<br />
Battistotti Laura<br />
Parisi Agnese<br />
Tamanini Silvano<br />
Membri supplenti:<br />
1. Scottini Cristina<br />
2. Zocchio Carmen<br />
RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE<br />
COMPONENTE DOCENTI<br />
Rigotti Teresa<br />
Spagnolli Gigliola<br />
Vedovi An<strong>it</strong>a<br />
Virone Antonino<br />
Zobele Maria R<strong>it</strong>a<br />
17
QUADRO DEGLI INCARICHI<br />
Sede<br />
Coordinatore<br />
di plesso<br />
Presidente<br />
Consiglio<br />
Interclasse<br />
Stesura verbali<br />
Interclasse<br />
Addetto sicurezza<br />
Antincendio<br />
Primo Soccorso<br />
Rappresentante<br />
Mensa<br />
Responsabile<br />
facile<br />
consumo<br />
Responsabile<br />
sussidi<br />
didattici e<br />
audiovisivi<br />
Responsabile<br />
Biblioteca<br />
Alunni<br />
Responsabile<br />
Biblioteca<br />
Insegnanti e<br />
Videoteca<br />
Responsabile Aula<br />
Informatica<br />
Responsabile<br />
strumenti<br />
musicali<br />
Nogaredo Parisi E. Parisi E. Tamanini S.<br />
Tovazzi M.<br />
Dosso C.<br />
Dosso C. Marzadro B. Fiorazzo I. Parisi F. Tovazzi M.<br />
Parisi F.<br />
Marzadro B.<br />
Villa<br />
Lagarina<br />
Bigi P.<br />
Rigotti T.<br />
Parisi A.<br />
Berlanda M.L.<br />
Scottini P.<br />
Spagnolli G.<br />
Ceschi E.<br />
Campostrini F.<br />
Baldo D.<br />
Battistotti L.<br />
Bettini G.<br />
Prosser M.<br />
Cescotti G.<br />
Scottini C.<br />
Poggi M.<br />
Miorelli S.<br />
Baldo D.<br />
Barberi L.<br />
Gasperotti<br />
G.<br />
Pomarolo Marsili L. Vedovi A. Frizzera G.<br />
Nomi Brusco R.<br />
Scuola<br />
Media<br />
<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong><br />
Pedezini<br />
I.<br />
Manzana G.<br />
Coordinatore di plesso: Virone Antonino<br />
Coordinatori Consigli di Classe<br />
1A Virone A. - 2A Vaia F. – 3 A Redolfi<br />
N. - 1B Costanzino G.– 2B La Montagna<br />
M.C. - 3B Manica I. – 1C Maffei L.- 2C<br />
Stedile M. – 3C Angeli M.. – 3D Armani<br />
G.<br />
Segretari Consigli di Classe<br />
1A Cuel A.M. – 2A Francescani A.M. –<br />
3A Aldrighettoni E. – 1B Rocchi A. – 2B<br />
de Vilos T.. – 3B Mazzurana D. – 1C<br />
Bombacci S. – 2C Angeli G. – 3C<br />
Cavalletti N. – 3D Zocchio C.<br />
Coordinatrice Assistenti Educatori<br />
Zandonai Angela<br />
Poda P.<br />
Marsili L.<br />
Baldo P.<br />
La<strong>it</strong>empergher<br />
R.<br />
Setti A.<br />
Frizzi F.<br />
Virone A.<br />
Calliari A.<br />
Zocchio C.<br />
Marzadro F.<br />
Scarfiello G.<br />
Sinibaldi A.<br />
Stoffella P.<br />
Dominici A.<br />
Rech G.<br />
Dominici A.<br />
Rech G.<br />
Zandonai A.<br />
Potrich G. Pederzini I. Frapporti M. Zobele M.R. Zobele M.R. Potrich G.<br />
Armani G. Virone A. Virone A.<br />
Armani G<br />
Thiella L.<br />
(per DVD)<br />
//<br />
Thiella L.<br />
(informatica)<br />
Aldrighettoni E.<br />
(aula artistica)<br />
Calliari A.<br />
(aula ed. tecnica)<br />
Moscadelli B.<br />
(aula scienze-biologia)<br />
Zocchio C. e<br />
Maffei L.<br />
(aula scienze-fisica)<br />
Chiusole C.<br />
(palestra)<br />
Angeli G.<br />
(aula<br />
musica)<br />
18
COMMISSIONI DEL COLLEGIO DOCENTI<br />
COMMISSIONE<br />
1. Orientamento<br />
2. Commissione Continu<strong>it</strong>à<br />
3. VUC e Informatica<br />
4. Commissione solidarietà<br />
5. Commissione sicurezza<br />
6. Orientamento<br />
7. Commissione Continu<strong>it</strong>à<br />
8. VUC e Informatica<br />
9. Commissione solidarietà<br />
10. Commissione sicurezza<br />
NB. – in neretto le/i coordinatrici/ori<br />
INSEGNANTE<br />
MANICA ILARIA<br />
MAZZURANA DANIELA<br />
REDOLDI NICOLETTA<br />
STEDILE MARZIA<br />
BATTISTOTTI LAURA<br />
MAFFEI LAURA<br />
PARISI FULVIA<br />
PEDERZINI IVA<br />
SCARFIELLO GIULIANA<br />
ARMANI GIANPAOLO<br />
CRISTIANO UMBERTO<br />
FIORAZZO ILARIA<br />
FRIZZI FIORENZA<br />
MANICA GLORIA<br />
THIELLA LUIGI<br />
AMPLAZ DANIELA<br />
BRUSCO ROBERTA<br />
CALLIARI ADELMO<br />
CASARI FIORENZA<br />
MIORELLI SARA<br />
CALLIARI ADELMO<br />
FRAPPORTI MILENA<br />
LAITEMPERGHER ROMANA<br />
MARSILI LOREDANA<br />
PODA PAOLA<br />
SCOTTINI PAOLA<br />
TOVAZZI MORENA<br />
VIRONE ANTONINO<br />
ZOCCHIO CARMEN<br />
MANICA ILARIA<br />
MAZZURANA DANIELA<br />
REDOLDI NICOLETTA<br />
STEDILE MARZIA<br />
BATTISTOTTI LAURA<br />
MAFFEI LAURA<br />
PARISI FULVIA<br />
PEDERZINI IVA<br />
SCARFIELLO GIULIANA<br />
ARMANI GIANPAOLO<br />
CRISTIANO UMBERTO<br />
FIORAZZO ILARIA<br />
FRIZZI FIORENZA<br />
MANICA GLORIA<br />
THIELLA LUIGI<br />
AMPLAZ DANIELA<br />
BRUSCO ROBERTA<br />
CALLIARI ADELMO<br />
CASARI FIORENZA<br />
MIORELLI SARA<br />
CALLIARI ADELMO<br />
FRAPPORTI MILENA<br />
LAITEMPERGHER ROMANA<br />
MARSILI LOREDANA<br />
PODA PAOLA<br />
SCOTTINI PAOLA<br />
TOVAZZI MORENA<br />
VIRONE ANTONINO<br />
ZOCCHIO CARMEN<br />
19
CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE<br />
Dirigente scolastico<br />
GOFFO PAOLO<br />
Rappresentanti gen<strong>it</strong>ori ADAMI ROBERTO Presidente<br />
AGOSTINI BARBARA<br />
BARONI DANIELA Vice Presidente<br />
BENVENUTI GIGLIOLA<br />
DELAITI LODOVICO<br />
SALVADORI LINA<br />
TODESCHI MARCO<br />
ZANDONAI BEATRICE<br />
Rappresentanti docenti DOMINICI ANCILLA<br />
LA MONTAGNA MARIA CAROLINA<br />
MARSILI LOREDANA<br />
MOSCADELLI BIANCA STELLA<br />
PARISI AGNESE<br />
PARISI ERMINIA<br />
PEDERZINI IVA<br />
ZOCCHIO CARMEN<br />
Rappres. pers. non docente CONZATTI EUGENIA<br />
GALVAGNI LUISA<br />
GIUNTA ESECUTIVA<br />
Dirigente Scolastico GOFFO PAOLO Presidente<br />
Funzionaria amm.va CONZATTI EUGENIA<br />
Rappresentanti Gen<strong>it</strong>ori ADAMI ROBERTO<br />
ZANDONAI BEATRICE<br />
Rappresentanti docenti MOSCADELLI BIANCA STELLA<br />
Rappres. pers. non docente GALVAGNI LUISA<br />
COMMISSIONE MENSA<br />
Componente gen<strong>it</strong>ori:<br />
SCUOLA PRIMARIA NOGAREDO 4A FELLER MARIA TERESA<br />
SCUOLA PRIMARIA NOGAREDO 3 e 5A TOMASI CINZIA<br />
SCUOLA PRIMARIA L.VICENTINI NOMI 2A BATTISTOTTI MARINA<br />
SCUOLA PRIMARIA L.VICENTINI NOMI 3A PEZZINI DANIELE<br />
SCUOLA PRIMARIA R.GALVAGNI POMAROLO 1B BORT CINZIA<br />
SCUOLA PRIMARIA VILLA LAGARINA 1A LOSS ANGELINA<br />
SCUOLA MEDIA A.FRANK VILLA LAGARINA 1B AGOSTINI BARBARA<br />
SCUOLA MEDIA A.FRANK VILLA LAGARINA 1A SCRINZI MONICA<br />
Componente docenti:<br />
SCUOLA PRIMARIA NOGAREDO<br />
SCUOLA PRIMARIA L.VICENTINI NOMI<br />
SCUOLA PRIMARIA R.GALVAGNI POMAROLO<br />
SCUOLA PRIMARIA VILLA LAGARINA<br />
SCUOLA MEDIA A.FRANK VILLA LAGARINA<br />
DOSSO CRISTINA<br />
POTRICH GIANNI<br />
MARZADRO FRANCESCA<br />
CAMPOSTRINI FRANCESCA<br />
ARMANI GIAMPAOLO<br />
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE MENSA D’ISTITUTO<br />
1. Per consentire un controllo più accurato del servizio delle mense scolastiche, il Consiglio dell’Ist<strong>it</strong>uzione<br />
designa le Commissioni Mensa per ogni Scuola che abbia il servizio attivo. Esse sono composte da gen<strong>it</strong>ori<br />
e da insegnanti delle rispettive Scuole che prestano la loro opera volontariamente e gratu<strong>it</strong>amente. Le<br />
Commissioni Mensa nel loro insieme cost<strong>it</strong>uiscono la Commissione Mensa dell’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong>.<br />
2. Ciascuna Commissione deve essere composta da almeno due persone, almeno 1 gen<strong>it</strong>ore ed un insegnante<br />
addetto alla sorveglianza durante il servizio mensa, designate dal Consiglio dell’Ist<strong>it</strong>uzione e nominati dal<br />
Presidente del Consiglio dell’Ist<strong>it</strong>uzione, che presiede le sedute della Commissione Mensa d’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong>. La<br />
Commissione viene nominata, di regola, di segu<strong>it</strong>o all’insediamento di ogni rinnovato Consiglio<br />
20
dell’Ist<strong>it</strong>uzione Scolastica, salvo le surroghe di gen<strong>it</strong>ori i cui figli non frequentino più la scuola e di<br />
insegnanti trasfer<strong>it</strong>i o cessati dal servizio.<br />
3. Le Commissioni Mensa di ciascuna Scuola fanno riferimento al Presidente del Consiglio dell’Ist<strong>it</strong>uzione ed al<br />
Dirigente Scolastico per le loro segnalazioni. Il Presidente del Consiglio dell’Ist<strong>it</strong>uzione ed il Dirigente<br />
Scolastico coordinano le loro valutazioni ed azioni a favore della migliore e più efficace collaborazione con il<br />
Comprensorio della Vallagarina nel mer<strong>it</strong>o.<br />
4. La Commissione può verificare: il rispetto della tabella dietetica in vigore (corrispondenza del menù del<br />
giorno, del mese), lo svolgimento generale del servizio, in particolare pulizia del locale refettorio, delle<br />
suppellettili, degli arredi, modal<strong>it</strong>à del servizio di distribuzione pasto, rapporto del personale di cucina con<br />
gli alunni, eventuali modi e orari del servizio; le caratteristiche organolettiche delle pietanze, verifica del<br />
gusto, dell’aspetto, della presentazione del piatto;<br />
5. I sopralluoghi, di norma 1 al mese, devono essere effettuati collegialmente (almeno due componenti)<br />
durante la distribuzione dei pasti, con possibil<strong>it</strong>à di assaggio. Per ulteriori controlli è opportuno concordare<br />
la presenza del Responsabile del Comprensorio. Alle cuoche possono essere richieste spiegazioni relative al<br />
modo individuale di cucinare i cibi e servire le pietanze.<br />
6. Tutti i dati ed i rilievi risultanti dai sopralluoghi verbalizzati nel modulo schema allegato devono essere<br />
inviati per iscr<strong>it</strong>to all’Ufficio di Segreteria dell’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> per la valutazione del Presidente del Consiglio<br />
dell’Ist<strong>it</strong>uzione e del Dirigente Scolastico e comunque una copia deve essere trasmessa al Comprensorio<br />
della Vallagarina.<br />
7. La Commissione può richiedere o convocare incontri con i Responsabili del Comprensorio per eventuali<br />
proposte, segnalazioni o suggerimenti al fine di migliorare il servizio stesso, formulare proposte di<br />
Aggiornamento e di progettazione educativa al Collegio Docenti.<br />
21
LE SCELTE CULTURALI<br />
E PEDAGOGICHE<br />
22
I CARATTERI E I FINI DELLA SCUOLA DI BASE<br />
La Cost<strong>it</strong>uzione <strong>it</strong>aliana sancisce all’art. 34 che "l’istruzione inferiore impart<strong>it</strong>a per almeno otto anni è<br />
obbligatoria e gratu<strong>it</strong>a" e all’art. 3 che "è comp<strong>it</strong>o della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico<br />
e sociale che, lim<strong>it</strong>ando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei c<strong>it</strong>tadini, impediscono il pieno sviluppo della<br />
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione pol<strong>it</strong>ica, economica e sociale<br />
del Paese".<br />
Al raggiungimento di queste final<strong>it</strong>à è diretta e ordinata la scuola di base nella sua impostazione<br />
educativa e didattica, nelle sue strutture, nei suoi contenuti programmatici.<br />
1. LA SCUOLA PRIMARIA.<br />
“La scuola Primaria ha per suo fine quello di promuovere nei fanciulli e nelle fanciulle l’acquisizione di tutti i<br />
tipi di linguaggio e un primo livello di padronanza delle conoscenze e delle abil<strong>it</strong>à…aiutando il passaggio dal<br />
sapere comune al sapere scientifico.E’ il luogo in cui ci si ab<strong>it</strong>ua a radicare le conoscenze (sapere) sulle<br />
esperienze (il fare e l’agire).<br />
La scuola Primaria assicura obbligatoriamente a tutti i fanciulli le condizioni culturali, relazionali, didattiche e<br />
organizzative idonee a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno<br />
sviluppo della persona umana” (art. 3 della Cost<strong>it</strong>uzione). Essa concorre a praticare i valori del reciproco<br />
rispetto, della partecipazione, della collaborazione, dell’impegno competente e responsabile, della<br />
solidarietà; insegna a tutti i fanciulli l’alfabeto dell’integrazione affettiva della personal<strong>it</strong>à e pone le basi per<br />
una immagine realistica ma pos<strong>it</strong>iva di sè.” (Indicazioni Nazionali – Riforma Sistema scolastico - 2003)<br />
QUALE BAMBINO?<br />
La scuola primaria si offre, ai bambini e alle bambine che la frequentano, come luogo dove poter<br />
compiere importanti esperienze di formazione e di apprendimento, e come spazio in cui costruire significative<br />
relazioni di convivenza con gli altri.<br />
Le esperienze che il bambino vivrà quotidianamente nell’ambiente scolastico lo aiuteranno ad essere in<br />
grado di stabilire rapporti affettivi di natura pos<strong>it</strong>iva nei confronti di altri bambini e degli adulti; lo aiuteranno<br />
a superare il proprio egocentrismo per cominciare a comprendere i dir<strong>it</strong>ti e gli interessi degli altri imparando<br />
a tenerne conto, accettandoli e rispettandoli come egli chiede che avvenga per i propri; lo aiuteranno a saper<br />
accettare e rispettare gli altri nella loro divers<strong>it</strong>à, diventando capace via via di ascoltare, aiutare, realizzare<br />
forme di lavoro di gruppo e a confrontarsi con idee e opinioni diverse. Questo bambino imparerà a prendere<br />
l’iniziativa e a compiere scelte con motivazione, potrà diventare consapevole dei propri impegni, ab<strong>it</strong>uarsi a<br />
non dipendere troppo dagli impulsi e anzi a controllarli, imparerà a percepirsi sempre più responsabile delle<br />
proprie azioni e a esaminare ragionevolmente le difficoltà per poterle superare e migliorarsi.<br />
Le attiv<strong>it</strong>à che gli insegnanti della scuola primaria scelgono e predispongono per gli alunni mirano a porre<br />
le basi per la graduale conquista di abil<strong>it</strong>à, concetti e modal<strong>it</strong>à d’indagine essenziali alla cresc<strong>it</strong>a personale e<br />
alla comprensione del mondo, quali: la padronanza di mezzi espressivi e linguistici necessari a capire e a<br />
farsi capire, ad esprimersi e a comunicare; la capac<strong>it</strong>à di osservare e studiare fatti e fenomeni della realtà<br />
attraverso approcci e strumenti di tipo scientifico, logico, matematico; l’opportun<strong>it</strong>à di conoscere e di<br />
esprimersi attraverso la musica, le arti, il movimento, il gioco, la tecnologia e tanto altro ancora.<br />
Bambini e bambine vengono e vivono a scuola con aspettative e bisogni comuni e condivisi, ma anche<br />
precisi e specifici, in ragione dell’età, dell’ambiente di provenienza, della storia e delle caratteristiche<br />
individuali. Di loro si vuole cogliere e promuovere le qual<strong>it</strong>à e la spontane<strong>it</strong>à, insieme esigendo il rispetto<br />
delle persone, delle cose, delle buone regole, del lavoro da svolgere.<br />
A tutti la scuola intende dare l’opportun<strong>it</strong>à di avvicinarsi ai valori della giustizia e della libertà, della<br />
solidarietà e della pace, della natura e della bellezza, chiamando a trasporli in convinzioni e modi di agire<br />
personali.<br />
23
2. LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (MEDIA)<br />
"La scuola media concorre a promuovere la formazione dell’uomo e del c<strong>it</strong>tadino secondo i principi sanc<strong>it</strong>i<br />
dalla Cost<strong>it</strong>uzione e favorisce l’orientamento dei giovani ai fini della scelta dell’attiv<strong>it</strong>à successiva." (Legge n.<br />
1859/62).<br />
La scuola media si caratterizza come:<br />
a) Scuola della formazione dell’uomo e del c<strong>it</strong>tadino.<br />
Per questo:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
si preoccupa di offrire occasioni di sviluppo della personal<strong>it</strong>à in tutte le sue direzioni;<br />
favorisce la conquista di adeguate conoscenze disciplinari, abil<strong>it</strong>à e competenze logiche, scientifiche e<br />
operative.<br />
b) Scuola che colloca nel Mondo.<br />
Per questo:<br />
aiuta l’alunno ad acquisire un’immagine sempre più chiara ed approfond<strong>it</strong>a della realtà sociale,<br />
geografica ed economica.<br />
c) Scuola che orienta<br />
Per questo:<br />
conduce, per gradi, l’alunno ad una sempre più chiara conoscenza di sé, lo guida alla conquista della<br />
propria ident<strong>it</strong>à, lo mette nelle condizioni di operare scelte realistiche nell’immediato e nel futuro;<br />
lavora affinché completi la sua preparazione culturale di base;<br />
pone le premesse per l’ulteriore educazione permanente e per il successivo impegno scolastico.<br />
Quale ragazzo?<br />
Delineare il profilo di un alunno al termine della scuola media è un atto che si presenta al contempo<br />
complesso e rischioso per almeno tre ragioni. Innanz<strong>it</strong>utto perché ciò presuppone la riduzione a norma della<br />
plural<strong>it</strong>à di esperienze attraverso, e mediante, la quale si è formato il ragazzo e delle mille soggettiv<strong>it</strong>à che<br />
entrano ed escono dalle aule; poi perché i tre anni delle medie si configurano non più, come in passato,<br />
come la conclusione di un ciclo, ma come una parentesi breve fra un prima e un dopo molto più lunghi e<br />
dunque, quasi certamente più formanti; infine perché non sempre c’è uniform<strong>it</strong>à di intenti e di vedute fra gli<br />
insegnanti, e fra insegnanti e gen<strong>it</strong>ori.<br />
Ciononostante - e proprio perché in questa fase di rapidi mutamenti fuori e dentro la scuola è bene e<br />
doveroso aprire il confronto fra tutte le componenti che la frequentano - la compless<strong>it</strong>à e il rischio<br />
rappresentano una sfida che va accettata, purché se ne colga poi il risultato come l’avvio di una riflessione<br />
più ampia e duratura.<br />
Immaginiamo dunque come potrebbe essere, all’usc<strong>it</strong>a della nostra scuola media un/a ragazzo/a tipo<br />
che l’abbia vissuta normalmente, sia nel senso della frequenza che dell’impegno di studio (ecco una prima<br />
normalizzazione...) e che non abbia incontrato in questo percorso ostacoli extrascolastici che l’abbiano<br />
fortemente condizionato/a (eccone un’altra…). Il r<strong>it</strong>ratto che ne risulta è ovviamente paradossale, essendo la<br />
somma di tante piccole virtù e att<strong>it</strong>udini e condizioni alle quali ognuno può aspirare ma che giammai<br />
potrebbero trovarsi, mostruosamente, tutte riun<strong>it</strong>e in uno/a. Il ragazzo/a tipo si risolve dunque in un<br />
soggetto collettivo che riassume in sé un’intera comun<strong>it</strong>à di studenti.<br />
Allegro, gioviale, generoso, premuroso verso gli altri, rispettoso di sé, dei suoi prossimi e delle cose che<br />
lo circondano, ha vissuto tre anni in un ambiente sereno e rassicurante, che lo ha fatto crescere e star bene,<br />
senza per questo ignorare le tensioni, i confl<strong>it</strong>ti, il carico di sofferenza che caratterizzano il mondo entro il<br />
quale si muove. Si è formato una forte coscienza pol<strong>it</strong>ica ed ecologica della storia, che gli permette di capire<br />
a sufficienza di appartenere ad una comun<strong>it</strong>à di individui verso la quale si coltivano dir<strong>it</strong>ti e doveri e alla<br />
quale si ridà quanto si riceve; e di muoversi in un contesto naturale al quale si deve rispetto e del quale si<br />
conoscono potenzial<strong>it</strong>à e lim<strong>it</strong>i.<br />
Ha vissuto la scuola come uno spazio per molti versi eccentrico, inattuale, dove ha cominciato a perdere<br />
certezze e ver<strong>it</strong>à e ad apprezzare il dubbio e chi al dubbio l'ha ab<strong>it</strong>uato; dove ha imparato che l’autor<strong>it</strong>à<br />
dell’adulto non risiede nel suo ruolo, ma nel suo sapere, nella capac<strong>it</strong>à che ha di trasmetterglielo, nella<br />
disponibil<strong>it</strong>à ad ascoltarlo e capirlo; dove ha potuto confrontarsi con la plural<strong>it</strong>à del mondo adulto.<br />
Ha inteso che lì ogni affermazione diventa un problema, e che ogni problema può essere affrontato e<br />
(forse) risolto; che il sotterfugio non paga, lo studio è fatica, ma non si è mai soli; che ognuno può trovare il<br />
modo di realizzarsi; infine che il silenzio vale (molto) più del chiasso e che chi grida di più non ha per questo<br />
ragione.<br />
Ha acquis<strong>it</strong>o un buon controllo di sé, conosce il suo corpo e la sua sessual<strong>it</strong>à (rispetto ai quali molti tabù<br />
sono caduti, sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>i da una seria e franca informazione), coltiva i suoi sentimenti liberamente e senza sensi<br />
di colpa, sa cogliere le differenze fra maschile e femminile, sulle quali ha saputo costruire buone amicizie e<br />
qualche amore.<br />
24
Ha fatto esperienza - senza ricavarne frustrazioni o narcisismi - di quanto può fare e dare; ha compreso<br />
che il lavoro manuale può essere ricco di soddisfazioni tanto quanto quello intellettuale - ma anche che l’uno<br />
senza l’altro si perdono; comincia a intravedere quale potrà essere il suo futuro professionale.<br />
Ama il confronto e l’agonismo, ma non l’antagonismo; l’eleganza e il gusto nell’atteggiarsi, ma non<br />
l’apparire.<br />
Ha affinato di molto i suoi sensi e la capac<strong>it</strong>à di apprezzare il bello in tutte le sue espressioni: artistiche,<br />
letterarie, scientifiche, fisiche.<br />
Ha amato la lettura (leggendo o sentendo leggere), lo scrivere (suo o di altri), il cinema e il teatro, la<br />
musica e la danza, il disegno, le tecniche manuali, la capac<strong>it</strong>à di cogliere l’ordine nel disordine (la scienza),<br />
l’estetica dei numeri (la matematica), la geometria dei giochi. Buon conosc<strong>it</strong>ore dei linguaggi, li capisce e li<br />
usa, li smonta e rimonta con abil<strong>it</strong>à.<br />
Ha imparato ad essere creativo ed inventivo nella ricerca delle soluzioni ai problemi suoi, scolastici e<br />
non.<br />
Ha praticato attiv<strong>it</strong>à sportive, tante e diverse, e forse ne ha scelto una che lo aiuterà ad essere più forte<br />
e sicuro di se stesso.<br />
Ha imparato ad usare le nuove tecnologie informatiche, sia per scrivere che per comporre testi, costruire<br />
ipertesti, progettare, navigare in rete senza feticismi o paure, ben sapendo che ciò implica comunque saper<br />
scrivere e leggere bene. Ma sa anche muoversi intelligentemente nel suo piccolo ambiente quotidiano, fatto<br />
di strade, di uffici e negozi, di moduli e pratiche, di campagne e di boschi, di macchine e attrezzi, di chiese e<br />
musei, di persone e animali. È comunque c<strong>it</strong>tadino del mondo, ha fatto l’esperienza del viaggio, conosce<br />
l’importanza delle lingue straniere e si è sforzato di usarle, ama mettersi a confronto con culture diverse dalla<br />
sua, sapendo distinguere, apprezzare, capire, conciliare divers<strong>it</strong>à e solidarietà.<br />
Ha intravisto infine che a scuola - ma forse non solo lì - la qual<strong>it</strong>à è meglio della quant<strong>it</strong>à, avendo avuto<br />
modo di fare (soprattutto nei laboratori) esperienze intense che l’hanno segnato; e a capire che senza la<br />
scuola non è facile acquisire un senso religioso della v<strong>it</strong>a che permetta di trovare la salvezza (cioè la salute)<br />
in quel poco che si fa.<br />
25
IL RUOLO DELLA FAMIGLIA NEL PROGETTO EDUCATIVO DELLA SCUOLA<br />
IL RUOLO DEI GENITORI NEL PROGETTO EDUCATIVO DELLA SCUOLA.<br />
Le/gli insegnanti dell’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong>, consapevoli della necess<strong>it</strong>à di operare in stretta collaborazione con le<br />
famiglie degli alunni, ribadisce che i gen<strong>it</strong>ori sono una componente v<strong>it</strong>ale e preziosa nel processo educativo<br />
che ha come protagonisti i bambini e i ragazzi delle nostre scuole. Sappiamo quanto nei giovani sia grande il<br />
bisogno di essere accompagnati dagli adulti , di essere valorizzati e incoraggiati, ma anche corretti. È per<br />
questo che la nostra scuola vuole porre la giusta attenzione alla collaborazione e al dialogo con i gen<strong>it</strong>ori,<br />
condizione irrinunciabile per realizzare un progetto educativo nel quale i ragazzi possano r<strong>it</strong>rovare accordo e<br />
complementarietà nei messaggi e nei valori proposti in famiglia e a scuola .<br />
Diventa dunque importante il coinvolgimento e la partecipazione non formali, ma sostanziali, dei gen<strong>it</strong>ori.<br />
Perché questo avvenga i docenti si impegnano a:<br />
esprimere la propria offerta formativa;<br />
motivare il proprio intervento didattico;<br />
esplic<strong>it</strong>are le strategie, gli strumenti di verifica, i cr<strong>it</strong>eri di valutazione;<br />
comunicare periodicamente ai gen<strong>it</strong>ori degli alunni gli es<strong>it</strong>i delle principali prove di verifica e i progressi<br />
nei processi di socializzazione e di apprendimento dei loro figli;<br />
confrontarsi con i gen<strong>it</strong>ori nelle attiv<strong>it</strong>à che richiedono la loro collaborazione.<br />
I gen<strong>it</strong>ori si impegnano a:<br />
conoscere l’offerta formativa;<br />
conoscere gli es<strong>it</strong>i delle principali prove di verifica effettuate dai docenti;<br />
conoscere, tram<strong>it</strong>e gli insegnanti e i gen<strong>it</strong>ori rappresentanti, l’andamento complessivo dell’ attiv<strong>it</strong>à<br />
didattico educativa;<br />
esprimere pareri e proposte;<br />
collaborare con la scuola nelle attiv<strong>it</strong>à programmate.<br />
La collaborazione potrà avvenire anche attraverso piccole attenzioni quotidiane, quali:<br />
controllare periodicamente il materiale scolastico degli alunni;<br />
ab<strong>it</strong>uare i bambini a non sprecare le cose proprie e quelle della comun<strong>it</strong>à;<br />
dedicare pochi minuti per sfogliare il libretto delle comunicazioni, da usare anche per informare la scuola<br />
su quanto riguarda i bambini e i ragazzi;<br />
ab<strong>it</strong>uare i bambini e i ragazzi ad arrivare a scuola in orario;<br />
educare all’ascolto e all’esposizione orale;<br />
gratificare i bambini valorizzando il loro lavoro anche attraverso il controllo periodico dei loro quaderni e<br />
dei prodotti scolastici;<br />
aiutare i bambini e i ragazzi seguendoli nello studio a casa, senza però sost<strong>it</strong>uirsi a loro nell’esecuzione<br />
dei comp<strong>it</strong>i;<br />
non far pesare l’errore, ma utilizzarlo come occasione per riflettere e ragionare insieme;<br />
discutere con gli insegnanti, nelle sedi opportune, eventuali incomprensioni o divergenze, senza<br />
coinvolgere i bambini.<br />
L’impegno scolastico comporta un notevole dispendio di energie fisiche, per questo occorre assicurare ai<br />
bambini e ai ragazzi un numero adeguato di ore di riposo.<br />
È importante che le famiglie partecipino agli incontri assembleari, ai periodici colloqui informativi e ai<br />
percorsi di formazione organizzati dalla scuola come occasione di confronto sulle problematiche educative.<br />
I gen<strong>it</strong>ori sono chiamati ad essere protagonisti, in collaborazione con tutti i docenti, nella realizzazione delle<br />
seguenti attiv<strong>it</strong>à:<br />
confronto relativo all’identificazione degli obiettivi formativi per la progettazione del Piano di studio<br />
personalizzato ( occorre condividere i traguardi considerati significativi nel percorso di maturazione del<br />
ragazzo);<br />
compilazione del Portfolio delle competenze individuali: strumento che accompagna il percorso scolastico<br />
di ciascun alunno;<br />
Potranno inoltre essere eletti negli organi collegiali della scuola quali:<br />
consiglio di <strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong>;<br />
consiglio di classe;<br />
consiglio di Interclasse.<br />
26
LE SCELTE PEDAGOGICHE ED ORGANIZZATIVE<br />
1. LA SCUOLA PRIMARIA<br />
Le scuole primarie dell’ist<strong>it</strong>uto si richiamano alle seguenti scelte pedagogiche ed organizzative.<br />
a) La plural<strong>it</strong>à dei docenti<br />
La plural<strong>it</strong>à dei docenti, in quanto risorsa al servizio di un curricolo ricco e articolato, viene confermata<br />
come valore pos<strong>it</strong>ivo e centrale della scuola primaria, ponendo però attenzione:<br />
a contenere entro lim<strong>it</strong>i accettabili il numero degli insegnanti che intervengono nelle classi;<br />
ad estendere la plural<strong>it</strong>à dei docenti con una compless<strong>it</strong>à gradualmente crescente durante l’intero<br />
percorso scolastico;<br />
a garantire l’un<strong>it</strong>arietà dell’insegnamento attraverso una progettazione didattica corresponsabile, con<br />
regole e stili condivisi di relazione educativa.<br />
Il Collegio docenti dell’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> ha scelto di espletare la funzione tutoriale prevista all’art. 7,<br />
comma 5 del D.Lgs. n. 59 del 19 febbraio 2004 affidandola a tutti i docenti del team che<br />
operano sulla classe; essi si faranno carico delle funzioni tutoriali in maniera collegiale e<br />
ciascuno per la propria area disciplinare con condivisione delle responsabil<strong>it</strong>à e della<br />
cont<strong>it</strong>olar<strong>it</strong>à. A loro è affidato il comp<strong>it</strong>o di progettare e coordinare i percorsi formativi degli<br />
alunni, nonché di attivare il confronto e la collaborazione con le famiglie e di mettere a puntoe<br />
curare, poi, la compilazione del Portfolio delle competenze.<br />
b) La qual<strong>it</strong>à dell’offerta formativa<br />
Per arricchire e qualificare l’offerta formativa vengono incentivati progetti di qual<strong>it</strong>à, quali, ad esempio:<br />
alimentare nei bambini il piacere della lettura, con il potenziamento delle biblioteche scolastiche;<br />
educare alla creativ<strong>it</strong>à, con l’allestimento e lo sviluppo di laboratori;<br />
favorire l’incontro con le nuove tecnologie, nei laboratori multimediali;<br />
incrementare l’uso intelligente dei beni culturali, artistici ed ambientali offerti dal terr<strong>it</strong>orio;<br />
attivare progetti e laboratori di educazione musicale e teatrale;<br />
promuovere un percorso integrato nel campo dell’educazione motoria e sportiva.<br />
La qual<strong>it</strong>à degli interventi è garant<strong>it</strong>a attraverso una attenta programmazione che vede i docenti custodi<br />
dell’un<strong>it</strong>arietà del progetto formativo.<br />
c) Il monte orario annuale<br />
Il curricolo di base obbligatorio è di 891 ore per l’intero corso della scuola Primaria, corrispondenti ad<br />
un orario settimanale di 27 ore. La proposta dell’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> prevede 28 ore di curricolo di base uguali per tutti.<br />
Su richiesta delle famiglie è prevista, inoltre, un’offerta opzionale facoltativa aggiuntiva fdi 66 ore annue pari<br />
a due ore settimanali.<br />
d) Curricolo e programmazione disciplinare<br />
Tutti i docenti dell’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> Comprensivo elaborano insieme un CURRICOLO UNITARIO relativamente alle<br />
diverse discipline di insegnamento, un curricolo che indica le capac<strong>it</strong>à, le competenze e le conoscenze di<br />
base in un percorso continuo e progressivo che interessa l’intero corso del I Ciclo di Istruzione (6 – 14 anni).<br />
L’elaborazione del Curricolo un<strong>it</strong>ario d’ <strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> tiene conto delle indicazioni nazionali per i piani di studio<br />
personalizzati con attenzione all’esperienza professionale dei docenti, della realtà terr<strong>it</strong>oriale e della storia<br />
delle scuole, rispettando il grande valore della loro storia e della storia della scuola di base, compresi i suoi<br />
precedenti programmi.<br />
L’elaborazione dellCurricolo Disciplinare d’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> è affidata ai Gruppi di lavoro in corso nel presente<br />
anno scolastico cui va fatto riferimento anche per i piani di lavoro annuali in atto.<br />
Resta un obiettivo di sistema la realizzazione di un clima pos<strong>it</strong>ivo nella v<strong>it</strong>a quotidiana della scuola,<br />
organizzando forme di lavoro di gruppo e di aiuto reciproco e favorendo l’iniziativa, l’autodecisione, la<br />
responsabil<strong>it</strong>à personale degli alunni.<br />
e) La relazione<br />
L’attiv<strong>it</strong>à scolastica è organizzata in modo da dare a ciascun alunno l’opportun<strong>it</strong>à di sperimentare<br />
momenti di socializzazione dentro e oltre la propria classe. A tal fine, oltre ad una attenta organizzazione ed<br />
alla valorizzazione di momenti quali l’accoglienza, la pausa, l’interscuola e la mensa, sono previste attiv<strong>it</strong>à di<br />
27
classi aperte, per gruppi opzionali, attiv<strong>it</strong>à di educazione alla salute, progetti, vis<strong>it</strong>e guidate, giornate<br />
ecologiche, sportive ecc.<br />
I docenti provvedono a gestire in concreto tali attiv<strong>it</strong>à con la migliore utilizzazione delle disponibil<strong>it</strong>à,<br />
delle competenze e delle esperienze, in un quadro di efficace collaborazione professionale.<br />
e) Gli amb<strong>it</strong>i disciplinari<br />
La suddivisione delle discipline in amb<strong>it</strong>i è una logica conseguenza della plural<strong>it</strong>à dei docenti ed è<br />
occasione di arricchimento delle proposte formative e di piena valorizzazione delle competenze professionali<br />
dei docenti<br />
Tuttavia questo può concretamente comportare una gestione affannosa e segmentata del tempo,<br />
un’articolazione degli amb<strong>it</strong>i disciplinari come spazi poco integrati fra loro, una presenza di modelli e di r<strong>it</strong>mi<br />
didattici non sempre adeguati ai bisogni degli alunni.<br />
Per ev<strong>it</strong>are questi pericoli i docenti attivano progetti trasversali alle varie discipline, programmano in<br />
modo un<strong>it</strong>ario l’attiv<strong>it</strong>à formativa, organizzano l’orario in modo da garantire tempi sufficientemente ampi e<br />
non segmentati.<br />
f) La cost<strong>it</strong>uzione degli amb<strong>it</strong>i<br />
Le discipline, di norma, sono aggregate in amb<strong>it</strong>i così articolati:<br />
a) per le classi a modulo:<br />
amb<strong>it</strong>o della lingua <strong>it</strong>aliana;<br />
amb<strong>it</strong>o della matematica e delle scienze;<br />
amb<strong>it</strong>o della storia, della geografia e degli studi sociali.<br />
b) per le classi a tempo pieno:<br />
amb<strong>it</strong>o della lingua <strong>it</strong>aliana, dell’educazione all’immagine, della storia, della geografia e degli<br />
studi sociali;<br />
amb<strong>it</strong>o della matematica e delle scienze.<br />
I docenti possono valutare l’opportun<strong>it</strong>à di aggregare la geografia all’area della matematica e delle<br />
scienze avendo però cura di garantire l’un<strong>it</strong>arietà dell’area antropologica tram<strong>it</strong>e una programmazione<br />
comune.<br />
Allo scopo di articolare in modo equilibrato la plural<strong>it</strong>à dei docenti, nei moduli è possibile assegnare tutti<br />
gli amb<strong>it</strong>i a due insegnanti per classe e suddividere l’area della storia, della geografia e degli studi sociali<br />
come nelle classi a tempo pieno.<br />
L’educazione musicale, l’educazione motoria e l’educazione all’immagine sono aggregate a uno degli<br />
amb<strong>it</strong>i secondo cr<strong>it</strong>eri di affin<strong>it</strong>à epistemologica e efficacia didattica (competenze dei docenti).<br />
g) I tempi delle discipline<br />
discipline/amb<strong>it</strong>i di<br />
insegnamento del<br />
curricolo comune<br />
discipline<br />
monte ore<br />
annuo<br />
articolazione gruppi<br />
alunni<br />
Lingua Italiana 198 Classi<br />
Matematica 165 “<br />
Informatica e tecnologia 33 “<br />
Storia e Geografia 99 “<br />
Scienze 66 “<br />
Musica Motoria Immagine – complessivamente 165 “<br />
Lingua Straniera 99 max * “<br />
Religione Cattolica o Attiv<strong>it</strong>à Alternative 66 “<br />
attiv<strong>it</strong>à<br />
opzional<br />
i<br />
Laboratori di Lingua<br />
33 Gruppi varia comp.<br />
Laboratori di Matematica<br />
Laboratori di Attiv<strong>it</strong>à Espressive o motorie 67 (66) “<br />
L’orario dei docenti, previa programmazione, può essere articolato in maniera flessibile su base<br />
bisettimanale, in misura non eccedente le quattro ore.<br />
28
Nella programmazione dell’orario settimanale o bisettimanale, in presenza di progetti comuni, il tempo di<br />
insegnamento di ciascuna disciplina può essere distribu<strong>it</strong>o con flessibil<strong>it</strong>à nel corso dell’anno purché sia nel<br />
rispetto del monte ore annuo da dedicare alle singole discipline, del relativo piano di lavoro annuale e della<br />
scansione quadrimestrale della valutazione degli alunni.<br />
h) L'organizzazione delle classi e dei moduli<br />
L’orario d’insegnamento per gli insegnanti primaria è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o da 24 ore settimanali di attiv<strong>it</strong>à, di cui 22<br />
ore di insegnamento e due ore dedicate alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei<br />
docenti di ciascun modulo.<br />
La programmazione si propone:<br />
il perseguimento degli obiettivi stabil<strong>it</strong>i, predisponendo un’organizzazione didattica adeguata alle effettive<br />
capac<strong>it</strong>à ed esigenze di apprendimento degli alunni;<br />
<br />
<br />
la verifica e la valutazione dei risultati;<br />
l’un<strong>it</strong>arietà dell’insegnamento.<br />
All’interno dello stesso modulo organizzativo gli insegnanti operano collegialmente e sono cont<strong>it</strong>olari<br />
della classe o delle classi cui il modulo si riferisce.<br />
Gli insegnanti di lingua straniera e di religione assumono la cont<strong>it</strong>olar<strong>it</strong>à delle classi in cui operano; per<br />
questo garantiscono, almeno ogni bimestre e per ciascuna classe, un incontro di programmazione,<br />
valutazione e verifica, congiuntamente con gli altri insegnanti di classe.<br />
Ogni classe avrà inoltre un docente che cost<strong>it</strong>uirà un punto di riferimento e di coordinamento, in<br />
particolare nei rapporti con le famiglie; l’insegnante coordinatore sarà indicato dal gruppo docente.<br />
i) La contemporane<strong>it</strong>à: un’opportun<strong>it</strong>à per tutti<br />
In ciascun plesso scolastico, calcolando la differenza fra le ore di attiv<strong>it</strong>à (compreso il tempo per il pasto<br />
e per la pausa pomeridiana) e le ore di servizio di cui dispongono i docenti, risulta un numero di ore che<br />
cost<strong>it</strong>uisce il tempo di contemporane<strong>it</strong>à che potranno essere assegnate alle classi tenendo conto delle<br />
esigenze emergenti.<br />
Questo tempo viene gest<strong>it</strong>o in termini progettuali per:<br />
favorire l’inserimento degli alunni in s<strong>it</strong>uazione di handicap;<br />
fornire strumenti e contenuti mirati agli alunni che presentano specifiche difficoltà;<br />
favorire il lavoro di gruppo e una didattica attiva, esigenze particolarmente forti in presenza di classi<br />
numerose;<br />
arricchire l’offerta formativa.<br />
2. LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO<br />
LE SCELTE ORGANIZZATIVE<br />
Il Collegio docenti individua, ogni anno, le modal<strong>it</strong>à per un’articolata gestione del tempo scuola.<br />
L’orario delle lezioni deve armonicamente organizzare i curriculi disciplinari, l’utilizzo degli spazi<br />
disponibili nella struttura e la plural<strong>it</strong>à dei docenti.<br />
Il collegio, a questo scopo, adotta soluzioni funzionali quali:<br />
un’attenta distribuzione delle ore d’insegnamento, relative a ciascuna disciplina, nella costruzione<br />
dell’orario settimanale delle lezioni;<br />
l’alternanza, nell’articolazione dell’orario, di attiv<strong>it</strong>à disciplinari diverse affinché le giornate scolastiche<br />
non risultino troppo pesanti, soprattutto nei giorni in cui sono previste lezioni pomeridiane;<br />
la collocazione oraria contemporanea di più discipline per l’organizzazione di laboratori, con lo<br />
svolgimento di attiv<strong>it</strong>à essenzialmente pratiche;<br />
la programmazione settimanale dell’utilizzo, per tutte le classi, delle aule speciali.<br />
L’orario scolastico delle classi è così articolato:<br />
ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO<br />
8.00 – 12.45<br />
12.45–13.58<br />
13.58–15.45<br />
Mensa<br />
interscuola<br />
Corso B<br />
1 e 2A<br />
Mensa<br />
interscuola<br />
Corso C<br />
3A e 3D<br />
Mensa<br />
interscuola<br />
Attiv<strong>it</strong>à<br />
facoltative<br />
Mensa<br />
interscuola<br />
Attiv<strong>it</strong>à<br />
facoltative<br />
29
Le discipline e le ore settimanali d’insegnamento sono:<br />
Attiv<strong>it</strong>à curriculari:<br />
amb<strong>it</strong>i<br />
d’insegnamento<br />
LINGUISTICO –<br />
ESPRESSIVO<br />
ANTROPOLOGICO –<br />
AMBIENTALE<br />
MATEMATICO -<br />
TECNICO<br />
ESPRESSIVO<br />
Attiv<strong>it</strong>à opzionali<br />
obbligatorie<br />
Discipline<br />
Monte ore<br />
settimanali<br />
Monte ore<br />
annuo<br />
Articolazione<br />
gruppi alunni<br />
Italiano 5 165 Classe<br />
Lingua straniera:<br />
tedesco e inglese<br />
3 + 3 99 + 99 Classe<br />
Storia e Geografia 4 132 Classe<br />
Matematica e<br />
scienze<br />
5 165 Classe<br />
Tecnologia e<br />
informatica<br />
2 66 Classe<br />
Educazione<br />
musicale<br />
2 66 Classe<br />
Educazione fisica 2 66 Classe<br />
Religione/attiv<strong>it</strong>à<br />
alternative<br />
1 33 Classe<br />
Italiano-Storia-<br />
Geografia<br />
1 33<br />
Matematica 1 33<br />
Gruppi di varia<br />
composizione<br />
Gruppi di varia<br />
composizione<br />
Informatica 1 33 Classe<br />
2.2 LE SCELTE PEDAGOGICHE<br />
a) La plural<strong>it</strong>à dei docenti<br />
Per tutti i corsi è prevista la presenza di 8 o 9 docenti per le seguenti discipline: <strong>it</strong>aliano, storia e<br />
geografia, lingua straniera tedesco, lingua straniera inglese, scienze e matematica, educazione tecnica,<br />
educazione artistica, educazione musicale, educazione fisica.<br />
Per tutte le classi, ad eccezione degli alunni che, per scelta, non intendono avvalersi di tale<br />
insegnamento, è prevista anche la presenza di un docente di religione.<br />
L’assegnazione dei docenti alle classi tutela la continu<strong>it</strong>à dell’insegnamento e la garantisce, nei lim<strong>it</strong>i del<br />
possibile.<br />
b) La qual<strong>it</strong>à dell’offerta formativa<br />
La scuola pone al centro del contratto formativo i seguenti punti di attenzione:<br />
• qual<strong>it</strong>à della formazione - gli obiettivi alla base della programmazione didattica di ciascuna classe<br />
sono mirati sulle final<strong>it</strong>à di una scuola media che sia al contempo educativa, formativa e orientativa;<br />
• qual<strong>it</strong>à delle relazioni - la collegial<strong>it</strong>à, la collaborazione, la tolleranza, la solidarietà e l’altruismo sono<br />
valori dominanti per creare un clima di benessere caratterizzato dal coinvolgimento e dalla<br />
partecipazione attiva di tutti i soggetti;<br />
• qual<strong>it</strong>à dell’ambiente - l’assunzione di responsabil<strong>it</strong>à e di competenze cost<strong>it</strong>uiscono un presupposto<br />
indispensabile per un maggior rispetto verso se stessi, verso gli altri e verso le strutture con le quali<br />
si interagisce;<br />
L’attiv<strong>it</strong>à didattica e educativa è caratterizzata da una forte attenzione a tutti gli elementi innovativi che<br />
possono essere recep<strong>it</strong>i come stimolo per accrescere la motivazione e l’interesse degli alunni.<br />
In particolare:<br />
• utilizzazione di programmi informatici nell’insegnamento di tutte le discipline;<br />
• incentivazione dell’operativ<strong>it</strong>à nelle attiv<strong>it</strong>à didattiche quale momento fortemente educativo;<br />
30
• programmazione attenta e mirata delle usc<strong>it</strong>e dalla scuola per vis<strong>it</strong>e guidate, viaggi di istruzione,<br />
partecipazioni a spettacoli teatrali e/o musicali;<br />
• ampliamento dell’attiv<strong>it</strong>à sportiva con ore di lezione integrative di sci alpino e nordico, pallavolo,<br />
atletica e altri corsi che variano ogni anni;<br />
• organizzazione di incontri, aperti anche al pubblico, con personaggi significativi, spesso gest<strong>it</strong>i dagli<br />
alunni con un ruolo attivo.<br />
c) I programmi disciplinari<br />
Attraverso la programmazione coordinata del collegio docenti e dei consigli di classe i programmi delle<br />
singole discipline vengono adeguati alle specifiche esigenze ambientali.<br />
Tutte le aree disciplinari hanno formulato un curricolo di studio che prevede la trattazione di vari<br />
contenuti a partire dalla classe prima della scuola primaria fino ad arrivare alla classe terza della scuola<br />
media. I contenuti, concordati dai docenti dei due ordini di scuola, conducono gli alunni a raggiungere<br />
progressivamente le competenze necessarie per il proseguimento degli studi nelle scuole secondarie di<br />
secondo grado. Ciascuna competenza è declinata in termini di conoscenza ed abil<strong>it</strong>à che ciascun docente è<br />
tenuto a verificare nei suoi livelli essenziali.<br />
Ogni anno scolastico il consiglio di classe, esaminata la s<strong>it</strong>uazione iniziale con test d’ingresso di varia<br />
natura, adegua la programmazione curricolare generale delle proprie classi ai bisogni effettivi degli alunni,<br />
evidenzia gli obiettivi, i contenuti, il metodo di lavoro, gli strumenti utilizzati, le modal<strong>it</strong>à di verifica e i cr<strong>it</strong>eri<br />
di valutazione per ciascuna materia. Tale programmazione è parte integrante della documentazione prodotta<br />
da ogni consiglio di classe e, previa richiesta al dirigente scolastico, è disponibile per i gen<strong>it</strong>ori.<br />
La valutazione periodica dell’andamento complessivo dell’azione didattica ne verifica l’efficacia,<br />
proponendo, se necessario, opportune misure e/o modifiche per adeguarla alle diverse esigenze emerse.<br />
Alla base della programmazione educativo-didattica di ciascuna classe sono sempre presenti le mete<br />
formative generali fissate dal collegio dei docenti, mete che si configurano quali obiettivi trasversali per tutte<br />
le materie e verificabili in ogni amb<strong>it</strong>o.<br />
Questi stessi obiettivi, calibrati secondo il processo evolutivo dell’alunno e articolati nell’arco del triennio,<br />
sono riassumibili nei seguenti punti.<br />
31
CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA<br />
Obiettivi intermedi Obiettivi intermedi Obiettivi intermedi<br />
1) conoscere i propri compagni; 1) socializzare ed integrarsi nel gruppo classe/scuola; 1) acquisire la capac<strong>it</strong>à di analizzare il proprio comportamento<br />
ed autocontrollarsi perché responsabili delle proprie azioni;<br />
2) inserirsi attivamente nel nuovo ambiente-scuola; 2) usare struttura e strumenti scolastici con educazione e rispetto; 2) sviluppare le capac<strong>it</strong>à di giudizio, autovalutazione ed<br />
autonomia nel ragionare;<br />
3) curare la propria persona; 3) utilizzare materiale e libri di testo in modo puntuale e 3) essere capaci di motivare le proprie scelte;<br />
funzionale;<br />
4) usare correttamente il diario scolastico e i libri di testo; 4) comportarsi in maniera corretta e responsabile in qualsiasi 4) ab<strong>it</strong>uarsi allo studio sistematico ed approfond<strong>it</strong>o;<br />
momento, verso compagni e personale scolastico;<br />
5) intervenire con ordine durante conversazioni e verifiche orali; 5) gestire, autocontrollati, le attiv<strong>it</strong>à di gruppo. 5) saper analizzare in modo ragionato il percorso del lavoro<br />
svolto;<br />
6) imparare a lavorare con diligenza da soli e assieme agli altri;<br />
7) ab<strong>it</strong>uarsi alla puntual<strong>it</strong>à nel portare tutto il materiale<br />
occorrente e nell’esecuzione del proprio lavoro;<br />
8) servirsi della struttura e degli strumenti scolastici con<br />
educazione e rispetto;<br />
9) comportarsi in modo corretto e responsabile in qualsiasi<br />
momento, verso i compagni e verso il personale della scuola.<br />
Obiettivi finali Obiettivi finali Obiettivi finali<br />
1) sviluppare le capac<strong>it</strong>à di ascolto, attenzione e comprensione; 1) Potenziare le capac<strong>it</strong>à di ascolto, attenzione, comprensione e<br />
logica;<br />
2) sviluppare le capac<strong>it</strong>à di espressione, comunicazione, 2) comprendere e usare linguaggi corretti ed appropriati nelle varie<br />
scr<strong>it</strong>tura, lettura ed iniziare l’uso dei linguaggi specifici;<br />
discipline;<br />
I) servirsi di codici differenziati;<br />
2) sviluppare la capac<strong>it</strong>à espressiva nell’uso di linguaggi<br />
specifici;<br />
3) potenziare le abil<strong>it</strong>à nella manual<strong>it</strong>à e nella pratica sportiva; 3) sviluppare le capac<strong>it</strong>à di osservazione, confronto,<br />
memorizzazione ed astrazione;<br />
3) essere capaci di memorizzare, rielaborare, astrarre,<br />
collegare, sintetizzare, analizzare e cr<strong>it</strong>icare con riferimenti<br />
interdisciplinari;<br />
4) stimolare lo spir<strong>it</strong>o di osservazione e le capac<strong>it</strong>à logiche; 4) organizzarsi in modo autonomo e funzionale; 4) studiare con impegno e continu<strong>it</strong>à;<br />
5) organizzarsi in modo ordinato, preciso e senza continui 5) lavorare con impegno per utilizzare le proprie capac<strong>it</strong>à; 5) acquisire un metodo di lavoro approfond<strong>it</strong>o ed autonomo;<br />
controlli;<br />
6) esprimersi e comportarsi rispettando le regole comuni; 6) esprimersi con adeguatezza e coerenza rispetto alle regole<br />
comuni;<br />
6) esprimersi con adeguatezza e coerenza rispetto alle regole<br />
comuni;<br />
7) educare alla collaborazione, tolleranza e solidarietà e al senso<br />
di responsabil<strong>it</strong>à verso se stessi e verso gli altri;<br />
7) assumere un comportamento di collaborazione, tolleranza,<br />
solidarietà e responsabil<strong>it</strong>à verso se stessi e gli altri;<br />
7) assumere un comportamento di collaborazione, solidarietà e<br />
tolleranza e di responsabil<strong>it</strong>à verso se stessi e gli altri;<br />
8) accettare il diverso da sé; 8) accettare il diverso da sé; 8) accettare il diverso da sé;<br />
9) con la guida dell’insegnante, gestire l’errore per migliorare se 9) gestire l’errore per migliorare se stessi; 9) gestire l’errore per migliorare se stessi;<br />
stessi;<br />
10) conoscere ed aver coscienza di sé (orientamento scolastico). 10) conoscere le proprie att<strong>it</strong>udini, capac<strong>it</strong>à e possibil<strong>it</strong>à 10) essere coscienti della propria ident<strong>it</strong>à personale, delle<br />
(orientamento scolastico)<br />
proprie att<strong>it</strong>udini, capac<strong>it</strong>à e possibil<strong>it</strong>à; essere capaci di<br />
scegliere il proprio futuro in modo ragionato e motivato<br />
(orientamento scolastico).<br />
32
d) Le ore di compresenza<br />
E’ prevista ll’opportun<strong>it</strong>à di utilizzare la contemporanea presenza di più docenti, sullo stesso gruppo<br />
di alunni, nell’orario previsto per le attiv<strong>it</strong>à opzionali obbligatorie.<br />
È il consiglio di classe che elabora all’inizio di ogni anno il piano delle attiv<strong>it</strong>à da svolgere durante<br />
queste ore.<br />
Sol<strong>it</strong>amente le ore vengono dedicate a:<br />
integrazione della normale attiv<strong>it</strong>à didattica con l’approfondimento di particolari tematiche;<br />
interventi differenziati su piccoli gruppi di alunni che necess<strong>it</strong>ano della revisione di taluni<br />
argomenti e ulteriori eserc<strong>it</strong>azioni;<br />
attiv<strong>it</strong>à di carattere interdisciplinare dedicate a iniziative in aree quali il metodo di studio,<br />
l’educazione alimentare, l’educazione sessuale, l’archeologia, l’astronomia, le<br />
tossicodipendenze, lo studio d’ambiente ed altro ancora.<br />
f) Le attiv<strong>it</strong>à di laboratorio<br />
Dall’anno scolastico 1990-91 la Scuola Media ha elaborato all’interno dell’offerta formativa attiv<strong>it</strong>à<br />
laboratoriali proposte nell’orario settimanale.<br />
Attualmente gli iscr<strong>it</strong>ti hanno la possibil<strong>it</strong>à di frequentare in un pomeriggio della settimana altre due<br />
ore, oltre le 32 ore previste dal tempo scuola del curriculo obbligatorio. Chi frequenta può usufruire della<br />
mensa e del trasporto.<br />
Le final<strong>it</strong>à educative generali sono le stesse concordate dal collegio dei docenti per le attiv<strong>it</strong>à<br />
disciplinari:<br />
sviluppare e potenziare la capac<strong>it</strong>à di entrare in rapporto con i compagni e i docenti;<br />
comportarsi responsabilmente nei confronti delle persone e dell’ambiente;<br />
acquisire un metodo di lavoro organizzato e autonomo, preciso e efficace;<br />
sviluppare la capac<strong>it</strong>à di usare linguaggi, strumenti e tecniche delle singole discipline in<br />
modo<br />
appropriato, sicuro e personale.<br />
Non è necessario frequentare per l'intero anno scolastico; resta inteso che, accettata l'iscrizione, la<br />
frequenza è obbligatoria nel periodo programmato per l’attiv<strong>it</strong>à.<br />
A tutti gli alunni vengono proposti dei questionari in cui sono elencati i laboratori attivati e dove<br />
indicano le loro preferenze, soprattutto in relazione ai loro interessi.<br />
L’organizzazione segue una procedura concordata dai docenti nelle riunioni disciplinari e collegiali<br />
del precedente anno scolastico.<br />
L’offerta didattica delle attiv<strong>it</strong>à opzionali<br />
Le attiv<strong>it</strong>à proposte hanno le seguenti caratteristiche comuni:<br />
• sono conformi al piano dell'offerta formativa;<br />
• sono interessanti e motivanti per gli alunni, ma nello stesso tempo richiedono impegno e<br />
sono utili per lo sviluppo cogn<strong>it</strong>ivo, affettivo, relazionale;<br />
• sono considerate importanti sia dalla scuola che dalla famiglia;<br />
• si rivolgono a tutti gli alunni con le loro diverse esigenze, comprendendo sia attiv<strong>it</strong>à di<br />
sviluppo che attiv<strong>it</strong>à di recupero;<br />
• si conciliano con i tempi dei comp<strong>it</strong>i a casa e con altre attiv<strong>it</strong>à frequentate dalla maggioranza<br />
degli alunni;<br />
• arricchiscono la valutazione dell'alunno certificando le sue abil<strong>it</strong>à;<br />
• sono mon<strong>it</strong>orate dai docenti e dagli utenti in <strong>it</strong>inere, per migliorare sempre l’offerta.<br />
Caratteristiche dei gruppi di lavoro e durata delle attiv<strong>it</strong>à<br />
• sono attiv<strong>it</strong>à per classi aperte;<br />
• sono attiv<strong>it</strong>à diversificate per gruppi di alunni coetanei o meno;<br />
• hanno durata bimestrale o quadrimestrale, secondo la tipologia dell’attiv<strong>it</strong>à;<br />
• comportano un impegno settimanale di 2 ore (4 ore se si usa la flessibil<strong>it</strong>à didattica in<br />
regime di autonomia scolastica).<br />
Fasi e cr<strong>it</strong>eri dell’organizzazione<br />
1. Il collegio dei docenti, in relazione all’organico dell’ist<strong>it</strong>uto, stabilisce prior<strong>it</strong>ariamente i cr<strong>it</strong>eri<br />
per:<br />
• l’attivazione del laboratorio: non sono ammessi laboratori con un numero di iscr<strong>it</strong>ti minore di 10;<br />
33
• l’assegnazione del numero dei docenti occupati nell’attiv<strong>it</strong>à : un docente ogni 10 alunni;<br />
• la ripetizione dell’attiv<strong>it</strong>à nel corso dell’anno da 1 a 4 volte per rispondere alle esigenze di<br />
iscrizione;<br />
• il numero di alunni per turno: compreso tra 10 e 15 ( salvo eccezioni con ragionevole<br />
motivazione esplic<strong>it</strong>ata in sede di organizzazione)<br />
2. Presentazione delle attiv<strong>it</strong>à facoltative alle famiglie.<br />
I docenti , nel mese di gennaio, propongono le attiv<strong>it</strong>à per il successivo anno scolastico ed indicano su<br />
un modulo appos<strong>it</strong>amente predisposto:<br />
• il t<strong>it</strong>olo dell’attiv<strong>it</strong>à;<br />
• i prerequis<strong>it</strong>i degli allievi sulla base delle competenze richieste ( I, II o III media);<br />
• il numero degli alunni, minimo/massimo, richiesto per lo svolgimento dell’attiv<strong>it</strong>à;<br />
• la durata dell’attiv<strong>it</strong>à;<br />
• eventuali costi a carico delle famiglie per trasporti, materiali, iscrizione ad esami..;<br />
• sommarie indicazioni delle attiv<strong>it</strong>à programmate...<br />
2. L’alunno compila la richiesta di iscrizione indicando fino ad un massimo di 5 attiv<strong>it</strong>à, senza un’ordine<br />
di preferenza.<br />
• Si ricorda che l’iscrizione è condizionata dall’organico d’ist<strong>it</strong>uto e dal numero totale di iscr<strong>it</strong>ti<br />
a ciascun laboratorio.<br />
• La conferma dell’iscrizione è data alle famiglie entro la fine del mese di giugno dell’anno<br />
scolastico in corso.<br />
3. Il collegio dei docenti, in relazione all’organico dell’ist<strong>it</strong>uto e considerata la numeros<strong>it</strong>à delle iscrizioni<br />
a ciascun laboratorio, decreta:<br />
• l’attivazione del laboratorio;<br />
• l’assegnazione del numero dei docenti occupati nell’attiv<strong>it</strong>à;<br />
• la ripetizione dell’attiv<strong>it</strong>à nel corso dell’anno.<br />
4. Il Consiglio di classe è informato sulle iscrizioni dei propri alunni ( per le classi prime si fa riferimento<br />
ai maestri della scuola primaria di provenienza):<br />
• può esprimere un parere riguardo alle richieste espresse;<br />
• può, se necessario, intervenire presso le famiglie suggerendo modifiche alle richieste di<br />
iscrizione effettuate.<br />
5. I docenti t<strong>it</strong>olari delle attiv<strong>it</strong>à approvate dal Collegio visionano l’elenco degli iscr<strong>it</strong>ti per verificare e<br />
confermare:<br />
• il numero massimo di alunni richiesto per lo svolgimento dell’attiv<strong>it</strong>à e il numero dei turni<br />
sulla base della numeros<strong>it</strong>à degli iscr<strong>it</strong>ti;<br />
• l’eventuale eliminazione di iscrizioni e/o accettazione delle ripetenze;<br />
• il calendario, circa la durata dell’attiv<strong>it</strong>à (inizio e fine di ciascun turno).<br />
6. Segue la compilazione del quadro delle iscrizioni, compreso mensa, trasporti ...<br />
7. Le famiglie, informate dell’avvenuta iscrizione, entro il mese di giugno sono chiamate a confermare<br />
le iscrizioni nel tipo, nel numero e nel periodo indicato loro.<br />
• La conferma comporta la frequenza obbligatoria.<br />
• R<strong>it</strong>iri o cambiamenti sono accettati dal dirigente solo in casi eccezionali e con motivate<br />
ragioni.<br />
Nel corso dell’anno scolastico...<br />
I docenti , t<strong>it</strong>olari dei laboratori :<br />
– adattano e personalizzano la programmazione dei contenuti indicati alle famiglie al<br />
momento dell’iscrizione;<br />
– valutano l’attiv<strong>it</strong>à e certificano le abil<strong>it</strong>à acquis<strong>it</strong>e e gli obiettivi formativi raggiunti.<br />
<br />
Esprimono un consiglio orientativo per validare la scelta fatta o per suggerire ulteriori percorsi o<br />
esperienze formative diverse.<br />
34
L’insieme delle Un<strong>it</strong>à di Apprendimento effettivamente realizzate, con le eventuali<br />
differenziazioni che si fossero rese opportune per singoli alunni, dà origine al Piano di Studio<br />
Personalizzato, che resta a disposizione delle famiglie.<br />
35
Le attiv<strong>it</strong>à opzionali possono variare di anno in anno in relazione alle risorse umane disponibili.<br />
Attualmente per l’anno scolastico <strong>2006</strong>/07 gli amb<strong>it</strong>i proposti sono i seguenti:<br />
AMBITI<br />
ATTIVITÁ<br />
PITTURA SU STOFFA : laboratorio artistico<br />
ARTISTICO<br />
DECORAZIONI DI NATALE: laboratorio artistico<br />
DECORAZIONE SU LEGNO: laboratorio artistico<br />
AEREOMODELLISMO: laboratorio tecnico-pratico<br />
LEGNO: laboratorio tecnico-pratico<br />
TECNICO<br />
E INFORMATICO<br />
FOTO DIGITALE: laboratorio tecnologico-informatico<br />
COSTRUZIONE E PUBBLICAZIONE DI PAGINE WEB: laboratorio<br />
tecnologico-informatico<br />
POWER POINT: laboratorio tecnologico-informatico<br />
PUBLISHER: laboratorio tecnologico-informatico<br />
CHIMICA: laboratorio scientifico pratico<br />
MATEMATICO<br />
E SCIENTIFICO<br />
MICROSCOPIA: laboratorio scientifico pratico<br />
FISICA SPERIMENTALE: laboratorio scientifico pratico<br />
GIOCHI MATEMATICI: laboratorio<br />
ASTRONOMIA: laboratorio scientifico multimediale<br />
SPORTIVO<br />
MOUNTAIN BIKE: laboratorio con attiv<strong>it</strong>à esterna per l’uso della<br />
bicicletta<br />
STEP – DANZA MODERNA: attiv<strong>it</strong>à in palestra<br />
INGLESE CON IL LETTORE: laboratorio di lingua inglese<br />
TEDESCO ATTRAVERSO CANZONI E FILM: laboratorio di lingua tedesca<br />
KEY ENGLISH TEST: laboratorio di lingua inglese con certificazione<br />
LINGUISTICO –<br />
ESPRESSIVO<br />
FIT 2: laboratorio di lingua tedesca con certificazione<br />
VUCUMPRA': il giornale della scuola<br />
GIU’ DAL PALCO: laboratorio espressivo<br />
IL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO: laboratorio linguistico<br />
multimediale<br />
VARIE<br />
VIAGGIARE INFORMATI<br />
36
LABORATORI PER IL RECUPERO DEI DEBITI FORMATIVI<br />
Nell’anno scolastico 2005 il Collegio dei docenti ha revisionato il laboratorio per il recupero disciplinare<br />
“COMPITI” anche alla luce di quanto emerso dalle indagini per l’autovalutazione d’ist<strong>it</strong>uto ed ha proposto<br />
ai Consigli di classe un ampliamento dell’offerta formativa delle Attiv<strong>it</strong>à Opzionali Facoltative che mira<br />
alla personalizzazione del piano di studio individuale.<br />
In particolare sono state considerate le numerose richieste per:<br />
- l’apprendimento e/o il potenziamento del metodo di studio<br />
- il recupero disciplinare per la matematica e le lingue straniere.<br />
Durante l’anno scolastico saranno operativi diversi laboratori progettati per venire incontro alle esigenze<br />
valutazioni espresse dai consigli di classe, confrontate con i gen<strong>it</strong>ori degli alunni.<br />
Le attiv<strong>it</strong>à previste sono:<br />
1. Laboratorio per il METODO DI STUDIO: IMPARARE AD IMPARARE: mira a rafforzare il metodo di<br />
lavoro dell’alunno ed a fornirgli gli strumenti indispensabili per studiare da solo in maniera<br />
proficua;<br />
2. Laboratorio per HELP DI MATEMATICA: riservato agli alunni/e che hanno bisogno di recuperare<br />
deb<strong>it</strong>i formativi significativi nella disciplina;<br />
3. Laboratorio di RECUPERO disciplinare: offerto agli alunni che presentano lacune settoriali, senza<br />
deb<strong>it</strong>i formativi gravi, nella matematica, in tedesco e/o in inglese.<br />
I coordinatori delle classi ed i docenti delle materie indicate propongono i nominativi degli alunni da<br />
considerare per la frequenza dei suddetti laboratori.<br />
La scuola organizza i turni di frequenza dei gruppi di lavoro, tenuto conto anche della iscrizione dei<br />
ragazzi ad altre attiv<strong>it</strong>à facoltative.<br />
I gen<strong>it</strong>ori degli alunni interessati possono valutare l’opportun<strong>it</strong>à offerta e, se concordano con la<br />
proposta, richiedono l’iscrizione nel periodo indicato.<br />
37
PROGETTO DI RECUPERO PER LE DIFFICOLTÀ NELLA MATEMATICA A.S. <strong>2006</strong>/07<br />
fasi operatori tempi metodologia scopi e final<strong>it</strong>à<br />
1. individuazione<br />
degli alunni da<br />
inserire nel progetto<br />
Sono esclusi gli<br />
alunni certificati<br />
che già fruiscono<br />
del sostegno<br />
didattico.<br />
Docente di<br />
classe<br />
e<br />
il Consiglio di<br />
Classe<br />
a. Inizio delle lezioni<br />
b. Primi mesi di scuola<br />
c. Nel corso dell’anno<br />
• valutazioni e segnalazioni precedenti<br />
• risultati dei test d’ingresso<br />
• cr<strong>it</strong>eri indicati dall’ area disciplinare<br />
• osservazioni circostanziali<br />
Attribuzione degli alunni ai gruppi<br />
I gruppo: Alunni con deb<strong>it</strong>i formativi<br />
consolidati, forti e significativi r<strong>it</strong>ardi di<br />
apprendimento nei concetti fondamentali, carenti<br />
abil<strong>it</strong>à di base e/o lacune generalizzate. (max 10<br />
alunni; 2 alunni /classe)<br />
II gruppo: Alunni bisognosi di interventi<br />
lim<strong>it</strong>ati e mirati a contenuti specifici; rinforzo<br />
delle conoscenze incerte apprese in modo<br />
superficiale. (max 15 alunni per turno)<br />
2. sottoscrizione di<br />
un patto formativo<br />
con le famiglie e<br />
condivisione delle<br />
procedure<br />
3. attivazione del<br />
progetto<br />
Docente di<br />
classe<br />
Docenti<br />
incaricati del<br />
progetto<br />
Prima possibile, appena<br />
ultimata la fase 1.<br />
I gruppo: 2 mesi dal<br />
1/02/07 al mese di aprile<br />
2007.<br />
II gruppo: turni di 2<br />
mesi di giovedì per 2 ore<br />
pm secondo quanto<br />
proposto dal docente di<br />
classe e concordato con le<br />
famiglie.<br />
Il docente indicherà per ciascun<br />
alunno final<strong>it</strong>à e obiettivi da<br />
perseguire, regole e comportamenti<br />
da tenersi nello svolgimento<br />
dell’attiv<strong>it</strong>à (frequenza, impegno,<br />
dir<strong>it</strong>ti, doveri...)<br />
Il docente incaricato, tenute presenti<br />
le indicazioni forn<strong>it</strong>e il docente di<br />
classe, seguirà per ciascun alunno<br />
gli obiettivi da raggiungere.<br />
Redigerà, secondo quanto concordato<br />
con il consiglio di classe e la famiglia,<br />
rapporti temporanei per la<br />
valutazione dell’attiv<strong>it</strong>à svolta.<br />
Coinvolgimento responsabile di tutti gli attori per<br />
ottenere il migliore dei risultati possibili.<br />
I gruppo: miglioramento delle abil<strong>it</strong>à di base e<br />
recupero dei saperi essenziali con percorsi<br />
individualizzati e concordati con il docente di<br />
classe; attiv<strong>it</strong>à essenzialmente pratiche e comp<strong>it</strong>i<br />
di realtà.<br />
II gruppo: intervento su concetti incerti e/o<br />
confusi con miglioramento delle competenze su<br />
argomenti specifici e supporto all’esecuzione dei<br />
comp<strong>it</strong>i assegnati.<br />
4. valutazione finale<br />
e certificazione<br />
dell’attiv<strong>it</strong>à svolta<br />
Docenti<br />
incaricati del<br />
progetto e<br />
docente di<br />
classe<br />
Verifica bimestrale al<br />
termine dell’attiv<strong>it</strong>à o<br />
secondo quanto proposto e<br />
concordato con le famiglie.<br />
Il docente che ha segu<strong>it</strong>o l’alunno<br />
indicherà nella certificazione finale il<br />
programma effettivamente svolto,<br />
quali obiettivi sono stati raggiunti,<br />
quali problemi sono eventualmente<br />
emersi...<br />
• mon<strong>it</strong>oraggio dell’attiv<strong>it</strong>à,<br />
• rilevazione dei cambiamenti nell’area logicomatematica,<br />
• indicazioni, suggerimenti per percorsi ulteriori<br />
38
SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE/ABILITA’ DA CONSOLIDARE<br />
NELL’AREA DISCIPLINARE DI MATEMATICA<br />
A.S. 2005/06<br />
Alunno………………………………………………………………………. Classe……………………..<br />
ARITMETICA/ALGEBRA<br />
Segnalare per ogni alunno gli argomenti più urgenti (X)<br />
1. I numeri interi: concetto di addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione (problemi<br />
elementari).<br />
2. Abil<strong>it</strong>à di calcolo con n. interi: addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione (operazioni<br />
elementari).<br />
3. La misura: a. riconoscimento delle un<strong>it</strong>à di misura e uso degli strumenti;<br />
b. trasformazioni elementari nel sistema di misurazione decimale.<br />
4. I numeri decimali: a. valore di posizione (concetti elementari);<br />
b. abil<strong>it</strong>à di calcolo (operazioni elementari).<br />
5. La frazione come operatore: problemi elementari.<br />
6. Le potenze: a. seconda e terza potenza dei numeri interi da 1 a 10 e la radice come operazione<br />
inversa;<br />
b. l’uso delle tavole numeriche per numeri >10.<br />
7. Le frazioni equivalenti:<br />
a. semplici riduzioni e trasformazioni per eseguire le operazioni fondamentali;<br />
b. risoluzione di qualche problema elementare.<br />
8. Il concetto di rapporto e di proporzione:<br />
a) analisi della frazione come rapporto;<br />
b) i rapporti tra grandezze come confronto tra numeri;<br />
c) il rapporto come percentuale.<br />
9. I numeri relativi: a. rappresentazione e confronti;<br />
b. semplici operazioni con n. interi (e frazioni?).<br />
10. Il calcolo con le lettere: a. il linguaggio delle lettere;<br />
b. dai problemi alle equazioni;<br />
c. il significato delle formule.<br />
11. Statistica e grafici:<br />
a) rappresentazioni grafiche di vario tipo (disegno, lettura, interpretazione dei dati);<br />
b) calcolo delle frequenze e della media in un’insieme di dati;<br />
c) funzioni e grafici (rappresentazione di proporzional<strong>it</strong>à diretta/inversa).<br />
GEOMETRIA<br />
(X)<br />
Segnalare per ogni alunno gli argomenti più urgenti<br />
1. Le rappresentazioni grafiche: costruzione e lettura di un grafico (ideogramma, diagramma,<br />
istogramma, areogramma)<br />
2. Le figure piane: identificazione di triangoli e quadrilateri e delle loro proprietà.<br />
3. Metodo di risoluzione grafica dei problemi di geometria: applicazioni al calcolo di perimetri ed aree.<br />
4. Gli angoli: a. identificazione e misura degli angoli;<br />
b. qualche applicazione di calcolo nei problemi.<br />
5. Il piano cartesiano: a. rappresentazione di punti, segmenti e figure nel piano<br />
cartesiano;<br />
b. applicazioni per la risoluzione di problemi su perimetri/aree.<br />
6. Le trasformazioni geometriche: a. traslazioni, rotazioni e simmetrie di semplici figure piane.<br />
7. Il teorema di P<strong>it</strong>agora:<br />
a) applicazioni nel triangolo rettangolo;<br />
b) applicazioni in alcune figure piane (tr. isoscele, rettangolo, rombo, trapezio).<br />
8. Il cerchio: a. caratteristiche e proprietà dei suoi elementi;<br />
b. lunghezza della circonferenza e area del cerchio<br />
9. La simil<strong>it</strong>udine: a. costruzione di figure simili;<br />
b. individuazione del rapporto di simil<strong>it</strong>udine e applicazione a semplici problemi.<br />
10. Le figure solide:<br />
a. identificazione del prisma retto, parallelepipedo, cubo, piramide retta e loro elementi;<br />
b. identificazione del cilindro e del cono e loro elementi;<br />
c. calcolo dell’area della superficie dei solidi c<strong>it</strong>ati (formule dirette)<br />
11. Solidi equivalenti: a. il concetto di volume e sua misura;<br />
b. calcolo del volume dei solidi c<strong>it</strong>ati (formule dirette).<br />
39
ATTUALE DURATA SPORTELLO METODO DI STUDIO/HELP/RECUPERO DISCIPLINARE<br />
(Attiv<strong>it</strong>à opzionali facoltative a. s. <strong>2006</strong>/07)<br />
AMBITO<br />
DISCIPLINARE<br />
DEI DOCENTI<br />
I°BIMESTRE II° BIMESTRE III°BIMESTRE IV° BIMESTRE<br />
21sett-10nov<br />
8 lezioni<br />
16nov-2 feb<br />
8 lezioni<br />
8 feb-30 mar<br />
8 lezioni<br />
12 apr-1giu<br />
8 lezioni<br />
Lettere<br />
Metodo di<br />
Studio<br />
(giovedì)<br />
classi prime<br />
Metodo di<br />
Studio<br />
(giovedì) classi<br />
seconde<br />
Matematica<br />
Studio/recuper<br />
o disciplinare<br />
(giovedì)<br />
Studio/recuper<br />
o disciplinare<br />
(giovedì)<br />
Help Matematica<br />
(giovedì)<br />
classi<br />
prime e seconde<br />
Studio/recupero<br />
disciplinare<br />
(giovedì)<br />
Studio/recupero<br />
disciplinare<br />
(giovedì)<br />
Tedesco<br />
Studio/recuper<br />
o disciplinare<br />
(giovedì)<br />
Studio/recuper<br />
o disciplinare<br />
(giovedì)<br />
Studio/recupero<br />
disciplinare<br />
(giovedì)<br />
Studio/recupero<br />
disciplinare<br />
(giovedì)<br />
Laboratorio “Imparare ad imparare”<br />
riservato solo per le classi prime e seconde<br />
Un passaggio cruciale per l’azione educativa finalizzata alla cresc<strong>it</strong>a della persona in tutte le sue<br />
dimensioni è rappresentato dalle attiv<strong>it</strong>à opzionali facoltative, che la scuola media di Villa Lagarina<br />
offre in forma laboratoriale, come previsto dalla Riforma.<br />
La valorizzazione della persona umana ed il rispetto delle differenze e delle ident<strong>it</strong>à di ciascuno<br />
esige infatti la costruzione di un sistema formativo che tenga conto sul piano didattico delle<br />
caratteristiche del singolo alunno.<br />
In quest’ottica si inserisce il laboratorio: “Imparare ad imparare”: un laboratorio Larsa (di<br />
recupero e sviluppo degli apprendimenti), che vuole essere uno strumento flessibile, al fine di<br />
personalizzare i processi di apprendimento e di maturazione, nella piena consapevolezza che spesso<br />
non è necessario agire sulla quant<strong>it</strong>à delle conoscenze, ma piuttosto sulla loro qual<strong>it</strong>à, insistendo sui<br />
processi di costruzione del sapere, attraverso strategie di tipo metacogn<strong>it</strong>ivo.<br />
I comp<strong>it</strong>i a casa<br />
I docenti assegnano regolarmente agli alunni dei comp<strong>it</strong>i da svolgere a casa affinché:<br />
facciano esercizi di consolidamento e di verifica di quanto appreso a scuola;<br />
acquisiscano familiar<strong>it</strong>à col lavoro personale.<br />
Per raggiungerlo l'alunno deve avere spazi in cui lavora da solo, in gruppo e con l’insegnante.<br />
Di regola i consigli di classe impegnano gli alunni nello studio a casa per un minimo di 10 ore e<br />
un massimo di 15 ore settimanali.<br />
I difetti più frequentemente riscontrati nel modo di affrontare lo studio da parte degli alunni della<br />
scuola media e alcune indicazioni per un loro superamento sono i seguenti:<br />
- sotto l'aspetto quant<strong>it</strong>ativo, l'alunno/a:<br />
1) studia poco (la media tra comp<strong>it</strong>i scr<strong>it</strong>ti e lo studio è di circa un'ora e mezza - due al giorno);<br />
2) studia in modo discontinuo, saltuario.<br />
- sotto l'aspetto qual<strong>it</strong>ativo, l'alunno/a:<br />
3) studia a memoria, senza adeguata comprensione, oppure<br />
40
4) non consolida le conoscenze, si lim<strong>it</strong>a ad intuire, a dare uno letta; capisce, ma non ripete e<br />
quindi il ricordo è imperfetto;<br />
5) non sa esporre quanto studiato.<br />
Alla base di questi lim<strong>it</strong>i c'è:<br />
- scarsa ab<strong>it</strong>udine allo studio (a casa, alla scuola primaria)<br />
- mancanza di motivazione allo studio (le cause sono tante, ad esempio: eccessivo sforzo per<br />
capire, frequenti insuccessi precedenti, non percezione dello scopo di ciò che si deve fare,<br />
mancanza di gratificazione degli sforzi fatti, cattivo adattamento in famiglia o con gli insegnanti<br />
...).<br />
- mancato utilizzo di strategie metacogn<strong>it</strong>ive nelle attiv<strong>it</strong>à finalizzate all’apprendimento<br />
I gen<strong>it</strong>ori possono:<br />
- assieme agli insegnanti identificare i “punti deboli" nel metodo di studio del figlio/a;<br />
- aiutare il figlio/a ad organizzare il tempo a loro disposizione per lo studio<br />
- seguire alcune indicazioni di segu<strong>it</strong>o riportate .<br />
Indicazioni sullo studio a casa<br />
Organizzarsi in modo da:<br />
1. avere l'orario delle lezioni a portata di mano (sul diario e sul tavolo);<br />
2. la cartella la sera e controllare se c'è tutto al mattino (non prepararla all'ultimo momento,<br />
in fretta);<br />
3. scegliere ore favorevoli allo studio: non troppo tardi, quando si è stanchi, dopo ore di<br />
televisione o altre attiv<strong>it</strong>à;<br />
4. fare comp<strong>it</strong>i preferibilmente il giorno in cui vengono assegnati (si ha più fresca in mente la<br />
lezione e si ev<strong>it</strong>ano dimenticanze); se sono molti, i comp<strong>it</strong>i si possono diluire nel giorno<br />
seguente; il giorno precedente la lezione si ripassa;<br />
5. avere l'occorrente a portata di mano (atlante per la geografia, vocabolario per l'<strong>it</strong>aliano e<br />
altre materie, fogli di carta per brutta copia, schizzi, appunti);<br />
6. se si è stati assenti, informarsi da un compagno "diligente";<br />
7. se i comp<strong>it</strong>i si fanno assieme ad un compagno, non copiarli, ma:<br />
- o discutere insieme alcune idee sul come farli e poi ognuno li esegue separatamente,<br />
- o ciascuno li prepara per conto proprio e poi ci si confronta e li si completa a vicenda,<br />
in modo che il comp<strong>it</strong>o finale risulti arricch<strong>it</strong>o;<br />
8. i comp<strong>it</strong>i più impegnativi siano esegu<strong>it</strong>i in ambiente silenzioso, non troppo disturbato<br />
(televisione, chiacchiere ...);<br />
9. le pause, durante lo studio, non devono essere troppo frequenti (tolgono la<br />
concentrazione) né troppo rare ((a mente stanca non rende);<br />
10. nella lettura di testi letterari (<strong>it</strong>aliano, storia, geografia ...) si può in genere procedere ad<br />
una lettura globale e poi rileggere più anal<strong>it</strong>icamente (sottolineando, facendo appunti,<br />
riassumendo, rispondendo a domande date); i testi scientifici vanno cap<strong>it</strong>i bene prima di<br />
procedere ai cap<strong>it</strong>oli successivi (la gerarchia dei concetti è più stretta);<br />
11. fare attenzione alla divisione in paragrafi: ogni paragrafo ha in genere un’idea centrale da<br />
cogliere; attenzione anche alle parole scr<strong>it</strong>te in corsivo o grassetto: sono in genere parole<br />
importanti;<br />
12. in ogni materia ci sono alcuni dati, nomi, conoscenze da memorizzare (avendo cap<strong>it</strong>o a<br />
cosa si riferiscono); bisogna ripetere in modo da “fissare" questi dati;<br />
13. ab<strong>it</strong>uarsi ad esporre oralmente l'argomento, organizzando un piccolo discorso con 3-4<br />
punti chiave;<br />
14. ricordarsi che leggere bene facil<strong>it</strong>a il capire bene, e capire bene facil<strong>it</strong>a il ricordare e<br />
l’esporre (studiare = leggere + capire + ricordare).<br />
Indicazioni sullo studio a scuola<br />
Lettura e comprensione: lettura ad alta voce e silenziosa, libera e guidata: spiegazione da parte<br />
dell'insegnante in continuo colloquio con i ragazzi, conversazioni, uso dei linguaggi non verbali:<br />
gestuali e figurativi.<br />
Parlare e ascoltare: richiedere sempre l'opinione degli alunni, sollec<strong>it</strong>are in continuazione, favorire<br />
conversazioni, discussioni, dialoghi; portare i ragazzi a narrare, descrivere, chiedere chiarimenti,<br />
41
proporre soluzioni, dare spiegazioni del proprio punto di vista, riferire reazioni, sentimenti: analizzare<br />
il proprio comportamento o quanto avviene a scuola.<br />
Lo scrivere: analisi della produzione del ragazzo per rilevare eventuali errori ortografici,<br />
grammaticali e sintattici; correzione collettiva ed esercizi di consolidamento mediante schede<br />
appos<strong>it</strong>amente predisposte; stesura di schemi, questionari che aiutino a sintetizzare un testo, a<br />
rielaborarlo secondo un aspetto particolare; composizioni di testi in base a tracce precedentemente<br />
predisposte per arrivare alla composizione libera; schede di arricchimento e di proprietà lessicale,<br />
uso costante del vocabolario e del dizionario dei sinonimi e dei contrari.<br />
Organizzazione degli alunni per classi parallele<br />
Gli alunni saranno raggruppati in classi parallele ed ognuno potrà partecipare ad un solo turno di<br />
laboratorio. Ogni insegnante di lettere coordinerà e organizzerà il lavoro di ciascun gruppo che avrà<br />
la durata di un bimestre.<br />
42
3. L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE DELL’INSEGNAMENTO DELLA<br />
RELIGIONE CATTOLICA - SCUOLA PRIMARIA E MEDIA<br />
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e<br />
grado, in conform<strong>it</strong>à all’accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense, i gen<strong>it</strong>ori degli alunni (o<br />
chi ne fa le veci) eserc<strong>it</strong>ano la scelta di avvalersi o non avvalersi, per i propri figli, dell’insegnamento della<br />
religione cattolica.<br />
Contestualmente a questa scelta il gen<strong>it</strong>ore che dichiara di non avvalersi, eserc<strong>it</strong>a anche la scelta delle<br />
attiv<strong>it</strong>à alternative all’insegnamento della religione cattolica nell’amb<strong>it</strong>o di queste quattro possibil<strong>it</strong>à:<br />
attiv<strong>it</strong>à didattiche e formative;<br />
attiv<strong>it</strong>à di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente;<br />
libera attiv<strong>it</strong>à di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente (non applicabile alla scuola<br />
primaria o media);<br />
usc<strong>it</strong>a dalla scuola.<br />
In relazione al tipo di scelta operata dalla famiglia la scuola adotta le seguenti soluzioni:<br />
Scelta A: gli insegnanti della classe frequentata dall’alunno "non avvalentesi" elaborano uno<br />
specifico programma di "attiv<strong>it</strong>à didattiche formative" da svolgere con l’alunno stesso durante<br />
l’orario destinato all’insegnamento della religione cattolica. Il piano di lavoro può riferirsi ai principi<br />
e valori universali previste nelle carte delle dichiarazioni dei dir<strong>it</strong>ti dell’uomo e dei bambini, a<br />
percorsi di educazione ambientale e alla solidarietà. Nel caso di alunne/i straniere/i possono essere<br />
defin<strong>it</strong>i piani di lavoro per l’approfondimento della conoscenza della lingua <strong>it</strong>aliana o anche di<br />
approfondimento della cultura di provenienza o della lingua madre.<br />
Scelta B: durante le lezioni di religione, un insegnante della classe (o del plesso) assiste l’alunno<br />
“non avvalentesi” nell’esecuzione di attiv<strong>it</strong>à di studio e/o ricerca individuale.<br />
Scelta D: durante le lezioni di religione l’alunno "non avvalentisi" esce dalla scuola o posticipa<br />
l’entrata secondo indicazioni scr<strong>it</strong>te rilasciate dai gen<strong>it</strong>ori. Per facil<strong>it</strong>are questo tipo di soluzione, la<br />
scuola provvede, nel lim<strong>it</strong>e del possibile, a collocare le lezioni di religione alla prima o all’ultima ora<br />
del turno antimeridiano o pomeridiano.<br />
43
LA PROGRAMMAZIONE<br />
I programmi della scuola elementare del 1985 e quelli della scuola media del 1979 affermano con forza<br />
il valore della programmazione educativa e didattica intese come strumenti per individuare le<br />
caratteristiche del contesto socio-culturale nonché le condizioni di partenza degli alunni.<br />
Ora, poiché gli ist<strong>it</strong>uti comprensivi non sono ancora la scuola di base ma una “federazione” di scuole<br />
che, sia pure in un contesto pedagogico e organizzativo un<strong>it</strong>ario, mantengono le loro specifiche ident<strong>it</strong>à, ne<br />
consegue, per quanto riguarda la programmazione, che i percorsi concreti che i due segmenti dell’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong><br />
(scuola primaria e scuola media) seguono sono parzialmente diversi, almeno sotto il profilo organizzativo.<br />
L’ISTITUTO<br />
Questo livello interessa il collegio dei docenti che può funzionare in modo un<strong>it</strong>ario o articolarsi in<br />
sezioni, dipartimenti disciplinari, commissioni di lavoro.<br />
In particolare:<br />
a) a livello un<strong>it</strong>ario<br />
elabora il progetto di ist<strong>it</strong>uto ed esprime il proprio parere in ordine alla carta dei servizi e al<br />
regolamento<br />
provvede alla scelta dei sussidi (acquis<strong>it</strong>o il parere dei consigli di interclasse della scuola primaria e<br />
della sezione scuola media del collegio dei docenti);<br />
indica, attraverso il progetto di ist<strong>it</strong>uto, i cr<strong>it</strong>eri generali relativi all’esercizio dell’autonomia didattica,<br />
organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;<br />
indica, attraverso il progetto di ist<strong>it</strong>uto, le modal<strong>it</strong>à e i cr<strong>it</strong>eri per la valutazione periodica dei risultati<br />
consegu<strong>it</strong>i, rispetto agli obiettivi prefissati, provvedendo all’analisi dei processi e dei risultati<br />
(autoanalisi di ist<strong>it</strong>uto);<br />
nomina le commissioni e approva, su proposta degli insegnanti coordinatori, il relativo piano di lavoro;<br />
adotta il piano di aggiornamento dell’ist<strong>it</strong>uto;<br />
elegge il com<strong>it</strong>ato di valutazione del servizio;<br />
formula al consiglio di ist<strong>it</strong>uto una proposta per la ripartizione del fondo di ist<strong>it</strong>uto (quota comune,<br />
quota scuola media, quota scuola primaria);<br />
formula i cr<strong>it</strong>eri generali relativi allo svolgimento delle attiv<strong>it</strong>à funzionali all’insegnamento e delle “40<br />
ore” di cui al CCPL;<br />
individua le funzioni obiettivo, le competenze e i requis<strong>it</strong>i per l’accesso, i docenti cui assegnarle, le<br />
modal<strong>it</strong>à di esercizio.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
b) a livello sezione scuola primaria – scuola secondaria di I°<br />
formula proposte in ordine al calendario scolastico, alla formazione e alla composizione delle classi;<br />
definisce l’orario settimanale delle lezioni;<br />
prevede l’articolazione degli impegni annuali (consiglio di classe - interclasse, assemblee di classe,<br />
programmazione di modulo, programmazione disciplinare, piano di utilizzo delle “40 ore” di cui al<br />
C.C.P.L.);<br />
delibera l’utilizzo del fondo di ist<strong>it</strong>uto nell’amb<strong>it</strong>o delle entrate di competenza;<br />
definisce il piano operativo relativo all’utilizzo delle “40 ore”;<br />
organizza i laboratori;<br />
elabora il piano delle attiv<strong>it</strong>à integrative, dei viaggi di istruzione, delle vis<strong>it</strong>e guidate;<br />
attribuisce gli incarichi specifici a livello di plesso o scuola;<br />
cura l’operativ<strong>it</strong>à per l’autoanalisi d’ist<strong>it</strong>uto;<br />
procede all’adozione dei libri di testo.<br />
c) a livello di commissioni di lavoro e gruppi di studio<br />
Le commissioni sono una articolazione del Collegio cui partecipano tutte/i le/i docenti dell’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong>, con<br />
rappresentanza di tutte le Scuole in ogni commissione. Sono cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e su argomenti r<strong>it</strong>enuti di attual<strong>it</strong>à e<br />
44
significato fondamentale nel delineare il profilo formativo da perseguire, sia con la definizione degli<br />
strumenti, sia nel fissare gli obiettivi per il futuro.<br />
Ogni commissione avrà cura di:<br />
- Operare una ricognizione delle azioni in corso e delle attese diffuse;<br />
- Di formulare delle ipotesi di lavoro da confrontare e da valutare;<br />
- Di formulare una proposta articolata di azione e/o metodo da proporre al Collegio.<br />
Alcune commissioni hanno comp<strong>it</strong>i operativi più stringenti con necess<strong>it</strong>à di raccordo e coordinamento<br />
generale delle pol<strong>it</strong>iche dell’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> (<strong>Progetto</strong>, Auto valutazione) per questo dovranno valutare l’opportun<strong>it</strong>à<br />
di cost<strong>it</strong>uire gruppi di lavoro snelli per il raggiungimento degli obiettivi che si daranno.<br />
Altre commissioni (Intercultura, Handicap e disagio) trovano operativ<strong>it</strong>à nelle insegnanti con incarico<br />
funzionale agli obiettivo del progetto di <strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong>.<br />
Le/gli coordinatrici/ori hanno il ruolo di condurre il dibatt<strong>it</strong>o delle commissioni, di redarre il verbale, di<br />
predisporre la relazione finale al collegio docenti, di formulare proposte al dirigente per il buon<br />
funzionamento delle stesse commissioni, di fissare il calendario delle sedute successive alla prima e di<br />
darne avviso alla segreteria per gli aspetti organizzativi conseguenti. Copia del verbale verrà consegnato al<br />
dirigente dopo ogni seduta.<br />
2. LA SCUOLA PRIMARIA<br />
All’attiv<strong>it</strong>à generale del collegio dei docenti seguono altri quattro livelli di programmazione.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
a) La programmazione di plesso.<br />
I docenti definiscono le scelte formative ed organizzative di ciascuna scuola con particolare attenzione:<br />
ai progetti e alle attiv<strong>it</strong>à comuni (percorsi teatrali, musicali, sportivi, vis<strong>it</strong>e guidate e viaggi di istruzione,<br />
iniziative di educazione alla salute, …);<br />
all’utilizzo e alla gestione dei tempi e degli spazi collettivi (accoglienza, sorveglianza, mensa,<br />
interscuola;<br />
al calendario delle attiv<strong>it</strong>à collegiali che interessano l’intera scuola.<br />
b) La programmazione di modulo.<br />
Con scadenza settimanale i docenti dello stesso modulo o classe si confrontano su:<br />
l’un<strong>it</strong>arietà dell’insegnamento;<br />
le attiv<strong>it</strong>à interdisciplinari e trasversali;<br />
l’utilizzo delle ore eccedenti l’insegnamento frontale e il servizio mensa;<br />
gli interventi individualizzati a favore degli alunni portatori di handicap o svantaggiati;<br />
l’adeguamento degli obiettivi stabil<strong>it</strong>i dai programmi alle effettive capac<strong>it</strong>à ed esigenze di<br />
apprendimento degli alunni;<br />
c) La programmazione per amb<strong>it</strong>i disciplinari.<br />
I docenti dello stesso amb<strong>it</strong>o disciplinare dell’intero ist<strong>it</strong>uto (sezione scuola primaria) si riuniscono, di<br />
norma una volta al mese, per uno scambio reciproco di esperienze, informazioni, materiali in ordine alle<br />
singole discipline.<br />
d) La programmazione individuale<br />
Ogni docente adegua alla realtà delle singole classi i percorsi, individua i metodi, i materiali e i sussidi<br />
più adatti, verifica l’azione didattica programmata.<br />
45
3. LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO<br />
Anche per la scuola media all’attiv<strong>it</strong>à generale del collegio dei docenti seguono altri tre livelli di<br />
programmazione.<br />
a) Il consiglio di classe<br />
"Il consiglio di classe cost<strong>it</strong>uisce l’organo competente a realizzare il coordinamento degli interventi delle<br />
singole discipline, concorda ed elabora la programmazione educativa e didattica".<br />
In particolare, per quanto riguarda la programmazione, il consiglio di classe con i soli docenti:<br />
prepara le prove d’ingresso, concordate per aree disciplinari, per la rilevazione delle abil<strong>it</strong>à di base<br />
di ciascun alunno;<br />
analizza la classe utilizzando anche i dati che emergono dalle osservazioni per aree, ne definisce la<br />
s<strong>it</strong>uazione di partenza e ne esplic<strong>it</strong>a i bisogni formativi;<br />
definisce gli obiettivi intermedi e finali, che riguardano le aree cogn<strong>it</strong>ive (contenuti delle singole<br />
discipline), non cogn<strong>it</strong>ive e trasversali (comportamenti e abil<strong>it</strong>à necessari all’apprendimento),<br />
partendo dai cr<strong>it</strong>eri generali prestabil<strong>it</strong>i dal collegio dei docenti;<br />
individua le modal<strong>it</strong>à per eventuali interventi di recupero e/o approfondimento, in relazione anche<br />
alla programmazione disciplinare di ciascun docente;<br />
programma le attiv<strong>it</strong>à integrative con particolare riguardo alle vis<strong>it</strong>e guidate e ai viaggi di<br />
istruzione;<br />
attua il coordinamento didattico, a livello disciplinare e interdisciplinare;<br />
rileva il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e trasversali in relazione alle attiv<strong>it</strong>à programmate<br />
e svolte;<br />
valuta di volta in volta la coerenza della programmazione in base alle risposte della classe;<br />
<br />
<br />
effettua la valutazione periodica e finale degli alunni;<br />
osserva sistematicamente il comportamento scolastico, le att<strong>it</strong>udini e gli interessi degli alunni allo<br />
scopo di orientare adeguatamente la scelta post-obbligo.<br />
Gli elementi che qualificano l’attiv<strong>it</strong>à dei consigli di classe della scuola sono:<br />
la collegial<strong>it</strong>à delle decisioni e delle valutazioni;<br />
la progettual<strong>it</strong>à disciplinare;<br />
l’attenzione ad inserire nella programmazione di classe momenti di forte operativ<strong>it</strong>à;<br />
la rilevanza del dialogo con le famiglie;<br />
la central<strong>it</strong>à della persona “alunno” nell’attiv<strong>it</strong>à educativa;<br />
la qual<strong>it</strong>à delle relazioni.<br />
b) La programmazione per amb<strong>it</strong>i disciplinari<br />
Evidenzia gli obiettivi, i contenuti, il metodo di lavoro, gli strumenti utilizzati, le modal<strong>it</strong>à di verifica e i<br />
cr<strong>it</strong>eri di valutazione. Viene formulata, discussa e condivisa dai docenti di ciascuna disciplina all’inizio di<br />
ogni anno scolastico e verificata in <strong>it</strong>inere.<br />
c) La programmazione individuale<br />
Ogni docente adegua alla realtà delle singole classi i percorsi, individua i metodi, i materiali e i sussidi<br />
più adatti, verifica l’azione didattica programmata.<br />
46
LA VALUTAZIONE<br />
1. COSA SIGNIFICA VALUTARE<br />
La valutazione rappresenta un aspetto fondamentale della professional<strong>it</strong>à docente, da espletare<br />
attraverso la ricerca e la messa a punto di cr<strong>it</strong>eri e di strumenti di verifica.<br />
Nella scuola di base, la valutazione non può avere una connotazione puramente selettiva, ma deve<br />
tendere a giudicare la valid<strong>it</strong>à del percorso compiuto da ogni alunno. Avrà pertanto una valenza formativa<br />
se evidenzia le mete, anche minime, già raggiunte, se valorizza le risorse individuali e indica come<br />
sviluppare le potenzial<strong>it</strong>à, motivando il bambino/ragazzo a costruirsi una immagine pos<strong>it</strong>iva e realistica di<br />
sé.<br />
Al termine del percorso scolastico di base la valutazione potrà assumere anche una funzione<br />
orientativa, in quanto aiuta l’alunno a rilevare att<strong>it</strong>udini e interessi per la successiva scelta scolastica.<br />
Il collegio docenti intende riferirsi ai seguenti punti di attenzione:<br />
la valutazione non è solo misurazione; la valutazione è "dare valore a"…;<br />
la valutazione è un giudizio che investe il lavoro dell'alunno e non la sua persona;<br />
la valutazione è un punto di arrivo e, nello stesso tempo, un punto di partenza, in quanto aiuta a capire<br />
cosa nel percorso è stato raggiunto e cosa va potenziato, modificato o consolidato;<br />
la valutazione serve anche alla famiglia per conoscere i livelli di competenza e di maturazione dei propri<br />
<br />
figli;<br />
la valutazione non è la semplice media ar<strong>it</strong>metica delle prestazioni, ma tiene conto della partecipazione<br />
e del comportamento degli alunni in tutti i momenti della v<strong>it</strong>a scolastica.<br />
R<strong>it</strong>eniamo importante chiarire che verifiche e valutazioni rappresentano due momenti diversi e<br />
conseguenti: la verifica si basa sulla raccolta di dati che derivano dalle eserc<strong>it</strong>azioni e prove somministrate,<br />
la valutazione è un giudizio di accettabil<strong>it</strong>à che interpreta il cammino realizzato dall’alunno.<br />
2. IL DOCUMENTO<br />
La valutazione viene espressa attraverso un documento: la scheda personale di valutazione.<br />
La scheda prevede due tipi di valutazione: quella per discipline e quella sul livello complessivo di<br />
maturazione.<br />
Nella prima parte sono prestampate le materie d’insegnamento e per ognuna di esse vengono riportati<br />
gli indicatori, cioè le conoscenze e le abil<strong>it</strong>à più importanti che l’alunno deve acquisire nel corso dell’anno<br />
scolastico.<br />
La valutazione viene espressa con cinque giudizi sintetici per ogni disciplina: ottimo, distinto, buono,<br />
sufficiente, non sufficiente, che corrispondono al diverso grado di apprendimento delle conoscenze<br />
raggiunte da ogni alunna/o.<br />
È inoltre possibile accompagnare questi giudizi con delle annotazioni scr<strong>it</strong>te per specificare qualche<br />
aspetto significativo relativo ad una certa materia.<br />
Nella seconda parte del documento, gli insegnanti di ogni classe, elaborano collegialmente una<br />
valutazione complessiva riguardante sia gli apprendimenti sia l’autonomia dell’alunno, la sua partecipazione<br />
alla v<strong>it</strong>a scolastica, la sua capac<strong>it</strong>à organizzativa, il suo impegno.<br />
Nella compilazione di questo giudizio si dovrà tener conto delle caratteristiche personali di ogni alunno,<br />
del suo livello di partenza e dei progressi registrati.<br />
Per rendere più omogenei i cr<strong>it</strong>eri della valutazione, per verificare se i risultati che si ottengono sono<br />
sufficientemente validi ed equi per tutti gli alunni e per rendere più chiara la comunicazione alle famiglie,<br />
dopo un accurato lavoro di confronto-dibatt<strong>it</strong>o è stato realizzato un glossario che viene utilizzato da tutti i<br />
Consigli di classe nel momento della stesura del profilo globale.<br />
3. TEMPI<br />
L’atto valutativo formale ha scansione quadrimestrale, è preceduto dagli scrutini che rappresentano un<br />
momento collegiale di confronto e di bilancio.<br />
Durante i colloqui informativi previsti al termine dei due quadrimestri (febbraio-giugno) viene<br />
consegnata ai gen<strong>it</strong>ori una copia integrale delle schede di valutazione. Gli insegnanti illustrano il contenuto<br />
dell’intero documento.<br />
47
La continu<strong>it</strong>à dell’informazione alle famiglie viene assicurata anche con incontri a scadenza bimestrale<br />
per la scuola primaria, orientati allo scambio di informazioni sull’<strong>it</strong>inerario di formazione percorso dall’allievo<br />
fino a quel momento.<br />
Inoltre per la Scuola Media sono previsti colloqui per ogni disciplina con cadenza regolare e<br />
calendarizzati con istema di prenotazione.<br />
4. VALUTAZIONE E ORIENTAMENTO<br />
Lo sforzo dei team docenti deve inoltre cogliere nell’osservazione permanente in collaborazione con i<br />
gen<strong>it</strong>ori,le particolari propensioni degli/le alunni/e, i connotati personali più significativi sia sul piano delle<br />
abil<strong>it</strong>à relazionali che delle abil<strong>it</strong>à intellettive e operative.<br />
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI AUTOVALUTAZIONE<br />
L'attiv<strong>it</strong>à di valutazione dell’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> Comprensivo di Villalagarina si è allineata con quanto proposto<br />
nel documento del Com<strong>it</strong>ato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo ” Strumenti per<br />
l’autovalutazione d’ist<strong>it</strong>uto” e quindi “... non è finalizzata solamente a conoscere la realtà della scuola, ma<br />
cost<strong>it</strong>uisce un passaggio essenziale del processo di gestione strategica della scuola che si realizza<br />
attraverso la definizione di obiettivi e di strategie i cui risultati sono continuamente verificati in funzione<br />
della definizione di nuovi obiettivi...”.<br />
Il processo di gestione strategica dell'ist<strong>it</strong>uto prevede:<br />
• analisi della scuola ed individuazione dei punti di forza e di debolezza,<br />
• definizione di obiettivi di prodotto e di processo nel progetto d’ist<strong>it</strong>uto (in termini osservabili e<br />
misurabili),<br />
• definizione delle strategie (processi) da mettere in atto,<br />
• organizzazione della verifica e valutazione dei risultati,<br />
• revisione degli obiettivi sulla base dei risultati raggiunti e riprogrammazione delle attiv<strong>it</strong>à.<br />
L’autovalutazione di <strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> si è concentrata ancora prior<strong>it</strong>ariamente sulla verifica del<br />
raggiungimento degli obiettivi indicati, in termini operativi, nel <strong>Progetto</strong> d’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong>, come sugger<strong>it</strong>o dal<br />
Com<strong>it</strong>ato. Sono state defin<strong>it</strong>e le seguenti azioni:<br />
- il mon<strong>it</strong>oraggio e valutazione dell’avanzamento del progetto di ist<strong>it</strong>uto e dei risultati<br />
ottenuti; gli indicatori base comuni a tutte le scuole sono inser<strong>it</strong>i direttamente nel programma on line<br />
“strumenti per l’autovalutazione di ist<strong>it</strong>uto”; altri indicatori sono stati defin<strong>it</strong>i nello scorso anno<br />
scolastico dalla precedente commissione e sono registrati più avanti nel documento;<br />
- la somministrazione di un pacchetto di strumenti composto dai test nazionali INVALSI<br />
per la valutazione degli apprendimenti (dicembre 2005). La verifica ha visto la somministrazione di<br />
prove scr<strong>it</strong>te di Italiano, Matematica e Scienze per le classi II e IV primaria e I secondaria;<br />
- l’autosomministrazione del Questionario per le famiglie (giugno <strong>2006</strong>) per attuare<br />
rilevazioni di prof<strong>it</strong>to integrate con l’analisi della soddisfazione dell’utenza; si è utilizzato lo strumento<br />
messo a disposizione l’anno scorso sulla base delle osservazioni pervenute e delle nuove proposte<br />
formative deliberate;<br />
- l’autosomministrazione del Questionario per i docenti (marzo <strong>2006</strong>): è stato previsto<br />
l’utilizzo del modulo preparato dal Com<strong>it</strong>ato di valutazione modificato secondo le indicazioni dei membri<br />
della precedente commissione ;<br />
- l’indagine sul confronto tra la valutazione finale della scuola primaria e quella<br />
iniziale della scuola secondaria: è tra i buoni propos<strong>it</strong>i d’inizio anno, ma non è stato possibile<br />
effettuarla a causa dei troppi impegni che si sono sovrapposti nel corso dell’anno; sarà comunque un<br />
obiettivo futuro da raggiungere;<br />
- il rapporto per i gen<strong>it</strong>ori: sono state previste relazioni ad opera di focus group sulla<br />
base dei dati quant<strong>it</strong>ativi e qual<strong>it</strong>ativi prodotti dalle analisi effettuate, e la loro utilizzazione, in vista della<br />
revisione del <strong>Progetto</strong> di <strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong>, durante incontri con i rappresentanti di classe e le famiglie; gli<br />
incontri si sono svolti ai primi del mese di maggio.<br />
48
- la valutazione esterna: il nostro ist<strong>it</strong>uto ha ader<strong>it</strong>o ad un percorso sperimentale per la<br />
valutazione esterna proposta da Com<strong>it</strong>ato di valutazione a sei scuole trentine. La valutazione ha<br />
segu<strong>it</strong>o un percorso concordato con il team dei valutatori nelle date previste tra il mese di Dicembre<br />
2005 e quello di Marzo <strong>2006</strong>. I report sono stati discussi, approvati e resi pubblici con il consenso del<br />
Collegio Docenti;<br />
- l’orientamento e la dispersione scolastica: la docente referente, Nicoletta Redolfi, che<br />
ha segu<strong>it</strong>o il semestre sabbatico promosso dall’Assessorato provinciale all’Istruzione, ha presentato il<br />
nuovo progetto di orientamento ed ha avviato una collaborazione con il nucleo di autovalutazione; sono<br />
riportate alcune delle indagini svolte in quest’area;<br />
Le funzioni strumentali attivate nell’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> sono state inv<strong>it</strong>ate a presenziare ad alcune riunioni del<br />
nucleo di autovalutazione per avviare attiv<strong>it</strong>à di collaborazione con lo stesso; hanno proceduto quindi a<br />
svolgere attiv<strong>it</strong>à di autovalutazione parallele nelle aree di loro competenza quali:<br />
- area del disagio e dell’handicap: la referente Fiorenza Frizzi ha proceduto anche<br />
quest’anno alla rilevazione sistematica dei casi presenti nell’ist<strong>it</strong>uto e della loro tipologia; sono stati<br />
aggiornati i dati già presenti nella mappa e sono stati preparati fascicoli riservati per ciascun alunno con<br />
eventuali allegati;<br />
- area dell’intercultura : la referente Maura Angeli ha continuato il mon<strong>it</strong>oraggio delle<br />
presenze di alunni stranieri nel nostro ist<strong>it</strong>uto; sono state avviate analisi per individuare e studiare il<br />
successo scolastico di questi alunni;<br />
- area dell’informatizzazione della didattica: il referente Luigi Thiella, considerato che la<br />
maggior parte delle scuole dell’ist<strong>it</strong>uto è ormai in possesso di una buona dotazione, ha avviato una<br />
nuova rilevazione delle competenze dei docenti, al fine di valutare l’attiv<strong>it</strong>à svolta nei corsi di<br />
aggiornamento, ed ha proposto altri corsi sulle pratiche operative necessarie alle competenze richieste<br />
dalla nuova organizzazione (certificazioni delle attiv<strong>it</strong>à laboratoriali ed altro...).<br />
E' possibile consultare e/o scaricare tutti i documenti non espressamente allegati alla presente<br />
relazione sul s<strong>it</strong>o Web dell’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> Comprensivo di Villa Lagarina: http://www.vivoscuola.<strong>it</strong>/us/icvillalagarina/<br />
Allegato: Primo rapporto sull’autovalutazione d’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> relativo all’anno 2005<br />
49
COMPONENTI DEL NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE<br />
Gen<strong>it</strong>ori Rappresentanti<br />
Consiglio d’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong>:<br />
Daniela Baroni<br />
Beatrice Zandonai<br />
Dirigente scolastico<br />
Paolo Goffo<br />
Personale ATA<br />
Ufficio di segreteria: Luisa Galvagni<br />
Personale Ausiliario: Michele Puddu<br />
Docenti Scuola primaria:<br />
Nomi: Alessandra Setti<br />
Nogaredo: Erminia Parisi<br />
Pomarolo: Loredana Marsili<br />
Villa Lagarina: Patrizia Bigi<br />
Docenti Scuola secondaria I°:<br />
M. Carolina La Montagna<br />
Bianca Stella Moscadelli (referente)<br />
AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO <strong>2006</strong>/07<br />
PROGRAMMA di PREVISIONE<br />
Autovalutazione<br />
d’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong><br />
(Com<strong>it</strong>ato provinciale di<br />
valutazione del sistema<br />
scolastico e formativo)<br />
Prove di verifica INVALSI<br />
IEA Timms<br />
(Rilevazione Nazionale<br />
Sistema Istruzione)<br />
Questionario per le<br />
Famiglie 2007<br />
Contesto<br />
Risorse<br />
Processi<br />
Risultati<br />
Prove IPRASE<br />
Scuola Primaria<br />
e<br />
Scuola Secondaria I grado<br />
Confronto delle valutazioni<br />
“ Dalla V elementare<br />
alla I media ”<br />
Orientamento e<br />
dispersione scolastica<br />
Mon<strong>it</strong>oraggio e nuove rilevazioni per le aree<br />
Disagio ed Handicap<br />
Intercultura<br />
Informatica<br />
Presentazione dei risultati dell’autoanalisi ai gen<strong>it</strong>ori<br />
Incontri in ciascun plesso<br />
50
LA CONTINUITÀ EDUCATIVA<br />
1. RAGIONI ED OBIETTIVI DELLA CONTINUITÀ<br />
L’istanza della continu<strong>it</strong>à educativa, affermata nei programmi della scuola primaria, in quelli della<br />
scuola media e negli orientamenti della scuola materna, investe l’intero sistema formativo di base.<br />
La continu<strong>it</strong>à sottolinea il dir<strong>it</strong>to di ogni bambino e di ogni ragazzo a un percorso scolastico un<strong>it</strong>ario,<br />
organico e completo, e si pone l’obiettivo di attenuare le difficoltà che spesso si presentano nel passaggio<br />
tra i diversi ordini di scuola; per questo richiede un percorso coerente che valorizzi le competenze già<br />
acquis<strong>it</strong>e dai bambini e dai ragazzi e riconosca la specific<strong>it</strong>à e la pari dign<strong>it</strong>à educativa di ogni scuola.<br />
2. SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (MEDIA):<br />
UN PROGETTO DI CONTINUITÀ CON RADICI PROFONDE.<br />
La continu<strong>it</strong>à nella nostra realtà ha radici profonde; infatti, già a partire dall’anno scolastico 1990/91, il<br />
collegio dei docenti della scuola primaria e quello della scuola media hanno elaborato il piano annuale della<br />
continu<strong>it</strong>à rivolto ai ragazzi, ai gen<strong>it</strong>ori, ai docenti. Ma la continu<strong>it</strong>à nella nostra realtà, oltre a radici<br />
profonde, ha anche prospettive di sviluppo ulteriore legate alla natura e alle caratteristiche dell’ist<strong>it</strong>uto<br />
comprensivo.<br />
Infatti, il collegio dei docenti un<strong>it</strong>ario è chiamato ad assumersi la responsabil<strong>it</strong>à educativa dell’intero<br />
arco della scuola di base.<br />
Inoltre, i docenti di scuola primaria e media, che operano nell’amb<strong>it</strong>o degli stessi organi collegiali,<br />
hanno maggiori potenzial<strong>it</strong>à per concordare obiettivi cogn<strong>it</strong>ivi di passaggio, coordinare i cr<strong>it</strong>eri valutativi,<br />
comunicare informazioni utili sugli alunni, fino ad arrivare alla progettazione di veri e propri anni ponte che<br />
prevedano attiv<strong>it</strong>à didattiche che attraversino i confini delle diverse scuole.<br />
Oltre a ciò, le possibil<strong>it</strong>à di impiego integrato del personale per la realizzazione di prest<strong>it</strong>i professionali<br />
e la cost<strong>it</strong>uzione di laboratori comuni, così come le iniziative di aggiornamento progettate in modo un<strong>it</strong>ario<br />
cost<strong>it</strong>uiscono esperienze destinate ad avvicinare gli stili educativi e a creare un linguaggio professionale<br />
comune, facendo così diventare la continu<strong>it</strong>à educativa un fatto concreto.<br />
3. TRE POSSIBILI PERCORSI<br />
In primo luogo, continu<strong>it</strong>à significa avviare forme di comunicazione continua tra scuole e tra scuole e<br />
servizi formativi del terr<strong>it</strong>orio. Tra le possibili modal<strong>it</strong>à, particolarmente significativo risulta lo scambio di<br />
informazioni (che riguarda sia gli allievi, sia i modelli educativi ed organizzativi delle scuole e delle agenzie<br />
formative).<br />
In secondo luogo, continu<strong>it</strong>à significa progettare iniziative didattiche congiunte, chiaramente leggibili<br />
nei loro intrecci anche dagli allievi e dalle famiglie. Le forme possibili sono quelle del progetto ponte (che<br />
prevede la possibil<strong>it</strong>à di iniziare in un ordine scolastico particolari percorsi didattici che proseguono<br />
sistematicamente e si concludono nel primo periodo dell’ordine successivo) e del progetto in parallelo (che<br />
coinvolge allievi di ordini scolastici diversi in un unico percorso didattico eventualmente con parti specifiche<br />
e parti comuni, parti da effettuarsi con modal<strong>it</strong>à e sedi separate e parti da svolgersi insieme).<br />
Infine, continu<strong>it</strong>à significa stabilire rapporti pedagogici e non soltanto burocratico-funzionali fra ordini<br />
scolastici diversi e fra scuola ed extrascuola. Questo è possibile se si conducono iniziative volte ad<br />
assicurare la reciproca conoscenza e la possibil<strong>it</strong>à di collegamenti strutturali attraverso il coordinamento dei<br />
rispettivi curricoli e modal<strong>it</strong>à di aggiornamento comune (rispettose delle differenti professional<strong>it</strong>à) tra i<br />
docenti dei diversi ordini scolastici e tra questi e gli operatori dell’extrascuola.<br />
4 . I PIANI OPERATIVI PER PROMUOVERE LA CONTINUITÀ<br />
Per dare concreta attuazione a queste istanze, il collegio dei docenti elabora annualmente il piano delle<br />
attiv<strong>it</strong>à articolato in due percorsi:<br />
il primo “scuola dell’infanzia – scuola primaria” riguarda tutte le scuole primarie dell’ist<strong>it</strong>uto e le scuole<br />
dell’infanzia (provinciali ed equiparate) dei rispettivi bacini di utenza;<br />
51
il secondo “scuola primaria – scuola media” riguarda le scuole primarie e la Scuola Media “Anna Frank”<br />
dove confluisce la quasi total<strong>it</strong>à degli alunni.<br />
A) IL PIANO OPERATIVO SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA<br />
LE AZIONI DEL PIANO: I BAMBINI<br />
Nell’ultimo periodo dell’anno scolastico<br />
i bambini della scuola dell’infanzia vis<strong>it</strong>ano la scuola primaria dove gli insegnanti e gli alunni si<br />
rendono disponibili a presentare il nuovo ambiente, illustrare i materiali prodotti, praticare attiv<strong>it</strong>à<br />
comuni.<br />
Nel primo periodo del nuovo anno scolastico<br />
conoscenza del nuovo ambiente (spazi, tempi, persone, organizzazione);<br />
progettazione degli spazi in modo da richiamare la scuola dell’infanzia (angolo dei giochi, poster<br />
murali);<br />
progettazione di tempi e attiv<strong>it</strong>à adeguati ad un graduale inserimento nella nuova realtà scolastica.<br />
Nel corso dell’anno scolastico<br />
attivazione di “progetti ponte” e “progetti in parallelo”.<br />
LE AZIONI DEL PIANO: I GENITORI<br />
Prima delle iscrizioni alla scuola primaria<br />
incontro presso la scuola primaria con il dirigente scolastico e gli insegnanti per la presentazione<br />
dell’offerta formativa della scuola.<br />
Nei primi giorni di scuola<br />
incontro di accoglienza con i gen<strong>it</strong>ori e gli insegnanti per uno scambio di informazioni.<br />
Le azioni del piano: gli insegnanti<br />
Al termine dell’anno scolastico<br />
consegna delle schede di valutazione al dirigente scolastico dell’ist<strong>it</strong>uto;<br />
presentazione della scuola e del gruppo al dirigente scolastico e agli insegnanti delle future prime;<br />
il dirigente scolastico raccoglie informazioni di massima da utilizzare nella formazione delle classi.<br />
All’inizio dell’anno scolastico successivo<br />
cost<strong>it</strong>uzione di una commissione un<strong>it</strong>aria con il comp<strong>it</strong>o di elaborare e mon<strong>it</strong>orare il piano annuale<br />
delle attiv<strong>it</strong>à;<br />
il dirigente scolastico trasmette le schede degli alunni (di norma verso il 10 di ottobre al fine di<br />
ev<strong>it</strong>are il sorgere di aspettative negative)<br />
incontro successivo degli insegnanti per un confronto tra quanto osservato nelle prime settimane di<br />
scuola e gli elementi raccolti nella scheda.<br />
52
B) IL PIANO OPERATIVO SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I° (MEDIA)<br />
Le azioni del piano: i bambini<br />
Nell’ultimo periodo dell’anno scolastico<br />
giornata della “Scuola aperta”: vis<strong>it</strong>a della scuola media da parte dei ragazzi delle classi quinte<br />
primarie. I compagni della scuola media presentano le strutture, le attiv<strong>it</strong>à, qualche iniziativa<br />
didattica significativa.<br />
Nei primi giorni dell’anno scolastico successivo<br />
presentazione dell’organizzazione della scuola media a cura del coordinatore;<br />
conoscenza degli alunni e del percorso formativo.<br />
Nel corso dell’anno scolastico<br />
progettazione di iniziative e attiv<strong>it</strong>à comuni (laboratori, giornalino, usc<strong>it</strong>e formative).<br />
Le azioni del piano: i gen<strong>it</strong>ori<br />
Prima delle iscrizioni alla scuola media<br />
vis<strong>it</strong>a alla scuola primaria da parte dei docenti della scuola media per un primo approccio con gli<br />
alunni e i gen<strong>it</strong>ori;<br />
incontro presso la scuola media con il dirigente scolastico e i docenti per illustrare le final<strong>it</strong>à e le<br />
modal<strong>it</strong>à di svolgimento delle attiv<strong>it</strong>à.<br />
Nel primo giorno di scuola<br />
momento di accoglienza da parte del dirigente scolastico che saluta i gen<strong>it</strong>ori, presenta i consigli di<br />
classe, i tempi delle attiv<strong>it</strong>à, i servizi.<br />
Le azioni del piano: gli insegnanti<br />
Al termine dell’anno scolastico<br />
scambio di informazioni sul gruppo classe e i singoli alunni anche al fine della formazione delle<br />
classi.<br />
All’inizio dell’anno scolastico successivo<br />
cost<strong>it</strong>uzione di una commissione un<strong>it</strong>aria con il comp<strong>it</strong>o di elaborare e mon<strong>it</strong>orare il piano annuale<br />
delle attiv<strong>it</strong>à.<br />
Nel primo periodo dell’anno scolastico<br />
incontro di verifica tra i docenti della scuola media e delle precedenti classi quinte.<br />
Nel corso dell’anno scolastico<br />
attiv<strong>it</strong>à delle commissioni per l’elaborazione del “curricolo un<strong>it</strong>ario” della scuola di base.<br />
53
L’ORIENTAMENTO<br />
1. PREMESSE CULTURALI<br />
LA SCUOLA CHE ORIENTA PER UNA DEFINIZIONE DI ORIENTAMENTO<br />
La funzione orientativa della scuola secondaria di primo grado (già scuola media), defin<strong>it</strong>a<br />
nella legge ist<strong>it</strong>utiva del 1962, ripresa dai programmai del 1979, è stata ulteriormente sottolineata dalle<br />
ultime Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati, quando si afferma che “la scuola secondaria<br />
di primo grado mira all’orientamento di ciascuno, favorisce l’iniziativa del soggetto per il suo sviluppo fisico,<br />
psichico e intellettuale, lo mette nelle condizioni di definire e conquistare la propria ident<strong>it</strong>à di fronte agli<br />
altri e di rivendicare un proprio ruolo nella realtà sociale, culturale e professionale. ..La possibil<strong>it</strong>à del<br />
preadolescente di operare scelte realistiche nell’immediato e nel futuro, portando avanti lo sviluppo di un<br />
progetto di v<strong>it</strong>a personale, deriva dal consolidamento di competenze decisionali fondate su una verificata<br />
conoscenza di sè e su un intelligente tirocinio educativo che abbia autenticato e continui ad autenticare le<br />
capac<strong>it</strong>à, gli interessi e le att<strong>it</strong>udini di ogni ragazzo. Il carattere orientativo è intrinseco allo studio delle<br />
discipline e alle attiv<strong>it</strong>à inter e transdisciplinari. L’uno e le altre infatti sono svolte alla scoperta di sé...della<br />
cultura, dell’arte, del mondo in generale...della produzione umana in particolare, attraverso l’incontro con i<br />
diversi ambienti della produzione tecnica o intellettuale. Lo studio e le attiv<strong>it</strong>à possono essere amplificate<br />
nella loro efficacia con un impiego accorto dei percorsi formativi facoltativi offerti ai preadolescenti per il<br />
migliore sviluppo delle loro capac<strong>it</strong>à...” Questo viene ancora rimarcato nel Pecup dove si dice che “a<br />
conclusione del primo ciclo di istruzione il ragazzo è in grado di pensare al proprio futuro, dal punto di vista<br />
umano, sociale e professionale . Per questo elabora, esprime, argomenta un proprio progetto di v<strong>it</strong>a che<br />
tiene conto del percorso svolto e si integra nel mondo reale in modo dinamico ed evolutivo. ...interagendo<br />
con i singoli individui e le organizzazioni sociali e terr<strong>it</strong>oriali che posso partecipare alla definizione e<br />
attuazione del proprio progetto di v<strong>it</strong>a, dimostrando disponibil<strong>it</strong>à a verificare con costanza l’adeguatezza<br />
delle decisioni sul proprio futuro scolastico e professionale”<br />
L’orientamento, quindi, altro non è che una complessa “modal<strong>it</strong>à formativa permanente che mira a<br />
far maturare la persona in funzione della scelta professionale e di un inserimento adeguato nella v<strong>it</strong>a<br />
sociale, oppure a facil<strong>it</strong>arne i processi decisionali relativi alle varie transizioni professionali e/o di v<strong>it</strong>a. Si<br />
tratta perciò di un processo continuato, caratterizzato specificatamente all’individuazione e al<br />
potenziamento delle capac<strong>it</strong>à della persona, cosicché questa, realizzando integralmente se stessa, si<br />
inserisca in modo creativo e cr<strong>it</strong>ico nella società in trasformazione” (Pina Del Core in: “Orientare alle<br />
scelte”, COSPES – LAS, Roma)<br />
La scuola che orienta è quindi, in questa prospettiva quella che “coinvolge gli alunni nel processo<br />
formativo, leg<strong>it</strong>timandone il contratto e privilegiando la logica del prodotto... E’ orientativa non solo per<br />
quello che propone di apprendere, ma per come lo propone e per come lo fa apprendere...che passa da un<br />
sapere oggetto dell’apprendimento ad un sapere strumento per l’apprendimento...che coniuga sapere con<br />
agire...cogliendo nelle discipline occasioni per uno sviluppo articolato e ricco di funzioni, conoscenze,<br />
capac<strong>it</strong>à e orientamenti indispensabili alla maturazione di persone responsabili ed in grado di compiere<br />
scelte” (in:AA.VV. <strong>Progetto</strong> Orientamento Miur ’96 – vol.I La formazione orientativa)<br />
La scuola che orienta, infine, dovendo concorrere alla “promozione dell’uomo e del c<strong>it</strong>tadino”<br />
dovrebbe fornire anche le competenze di base per la costruzione di una c<strong>it</strong>tadinanza attiva e<br />
responsabile, e questo propos<strong>it</strong>o può tornare utile una riflessione collegiale e singola di ogni educatore<br />
sulla Mappa del c<strong>it</strong>tadino, inser<strong>it</strong>a del <strong>Progetto</strong> orientamento ministeriale del D.M. 31/10/1996,<br />
recentemente aggiornata dal team di lavoro dei docenti in sabbatico<br />
E’ chiaro che per tradurre in pratica queste essenziali, complesse ma ineludibili linee di principio,<br />
occorre una lunga progettazione, riflessione, aggiornamento condivisi, all’interno e all’esterno della scuola,<br />
che coinvolga in primis la commissione ad hoc e i docenti coordinatori, in rete sia con le primarie del<br />
comprensivo che con le scuole secondarie di secondo grado più vicine e lontane, che ampli, innovi e dia<br />
senso, a piccoli passi, a consuete pratiche orientative, oggi in via di consolidamento. Per fare questo, il<br />
semestre sabbatico sull’orientamento promosso dal Servizio Istruzione provinciale e la neocost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a rete<br />
terr<strong>it</strong>oriale vallagarina per l’orientamento sono ottimi strumenti. E ancora, va riconosciuta e promossa<br />
ulteriormente la sinergia interna tra varie figure di sistema e commissioni che possono concorrere a<br />
migliorare il servizio: si pensi per esempio al gruppo sull’autovalutazione, sulla continu<strong>it</strong>à educativa.<br />
54
E’ oggi più che mai importante, infine, che tutte le agenzie educative siano coinvolte nel<br />
processo di orientamento, attivando relazioni, momenti di riflessione comune che coinvolgano docenti,<br />
gen<strong>it</strong>ori, agenzie formative del terr<strong>it</strong>orio.<br />
2. LE AZIONI FONDAMENTALI<br />
Durante tutto l’arco della scuola primaria e secondaria di primo grado le consuete attiv<strong>it</strong>à disciplinari,<br />
con le proposte interdisciplinari, e le attiv<strong>it</strong>à facoltative concorrono alla definizione dell’ident<strong>it</strong>à,<br />
all’autoverifica di interessi, inclinazioni, competenze dei ragazzi.<br />
Sarebbe utile una riflessione sull’util<strong>it</strong>à di una didattica per progetti o per un<strong>it</strong>à di apprendimento,<br />
fondata su comp<strong>it</strong>i di realtà e sui principi del cooperative learning, che pongono gli alunni al centro del<br />
processo di apprendimento di cui diventano via via sempre più protagonisti attivi e non passivi. Più spazio<br />
andrebbe dato ai piani di studi personalizzati, in cui tempi, contenuti, risultati, strategie siano più flessibili e<br />
adattabili alle singole s<strong>it</strong>uazioni e problematiche, oggi sempre più diffuse e stratificate.<br />
In ogni caso, è utile avere una griglia di riferimento di prassi da consolidare e condividere, quale<br />
quella di attuale riferimento che qui alleghiamo:<br />
Classi prime Classi seconde Classi terze<br />
Vis<strong>it</strong>e e usc<strong>it</strong>e sul terr<strong>it</strong>orio, conoscenza attiv<strong>it</strong>à lavorative artigianali, tipiche, aziendali (a cura<br />
specialmente del docente di tecnica eo di artistica, di lettere)<br />
Somministrazione di test e questionari di autoanalisi (test Ulisse per classi terze, consigliato)<br />
Incontri con esperti sul metodo di<br />
studio<br />
Incontro con psicologo specializzato sull’orientamento: conoscenza<br />
di sè, ricerca del lavoro e del percorso di studio<br />
Incontro (per lo più classi terze) con referente sportello<br />
orientamento provinciale<br />
Possibil<strong>it</strong>à di accedere allo sportello aperto anche ai gen<strong>it</strong>ori (un’ora<br />
alla settimana) gest<strong>it</strong>o dalla referente orientamento<br />
Distribuzione<br />
materiali<br />
informativi dalle varie scuole<br />
secondarie<br />
Distribuzione e presentazione<br />
del cd-rom della provincia “Uno<br />
sguardo verso il futuro”,<br />
consultabile anche in internet<br />
(VivoScuola)<br />
Sportello al mattino delle scuole<br />
superiori con gli studenti<br />
Progetti Ponte di preinserimento<br />
o a carattere orientativo<br />
Percorsi esperienziali nelle<br />
scuole superiori – consent<strong>it</strong>e<br />
due opzioni corrispondenti alle<br />
incertezze<br />
Per le FAMIGLIE: serate di riflessione aperte anche ai gen<strong>it</strong>ori degli alunni di classe seconda, con la<br />
referente dello sportello orientamento provinciale (quali percorsi possibili, quali nov<strong>it</strong>à, come aiutare a<br />
scegliere...); sportello serale delle scuole superiori; incontro con rappresentanti delle categorie: artigiani,<br />
industriali, contadini e coltivatori, commercianti, eventualmente anche con Agenzia del lavoro locale.<br />
Eventuale distribuzione di materiali informativi dal terr<strong>it</strong>orio eo dalla provincia, elaborati interni o del<br />
terr<strong>it</strong>orio come “La valigia del gen<strong>it</strong>ore”<br />
55
DIVERSITÀ E UGUAGLIANZA<br />
Ognuno ha le sue difficoltà, possono essere fisiche o interiori, possono essere passeggere o durature.<br />
Spesso ci illudiamo di annullare queste difficoltà, di farle sparire o di esserne miracolosamente esenti.<br />
La precarietà è il tratto fondamentale della nostra esistenza, ma siamo restii ad ammetterlo, per noi stessi e<br />
per gli altri.<br />
Abbiamo paura delle difficoltà, ancor prima che delle divers<strong>it</strong>à che esse mettono in luce. L’angoscia e il<br />
dolore provocano repulsione, stentiamo a convivere con essi.<br />
Eppure le difficoltà e le divers<strong>it</strong>à portano con sé anche tanti doni.<br />
La divers<strong>it</strong>à ingenera l’ansia di una domanda che l’omologazione, fisica e culturale, sforza di annullare. Se<br />
riusciamo a fermare questo processo, se riusciamo a restare liberi nella relazione e nel giudizio scopriamo un<br />
mondo che non sospettavamo, che non riuscivamo a vedere; un mondo ricco di innumerevoli punti di vista<br />
sulla realtà del singolo e del gruppo. Si può rinascere attraverso il rapporto con la difficoltà e la divers<strong>it</strong>à.<br />
Cominciamo comunque, se vogliamo fare sul serio, da una ripul<strong>it</strong>ura generale del linguaggio mettendo al<br />
bando ogni riferimento al pietismo e alla commiserazione. Scopriamo senza paura la nostra debolezza, prima<br />
di quella degli altri, compresi i cosiddetti diversamente abili, e scopriremo sub<strong>it</strong>o la nostra capac<strong>it</strong>à di<br />
comprendere e di con-dividere. Come premessa creativa lavoriamo sullo sguardo, prima e dopo ogni altra<br />
cosa: lo sguardo è un pozzo profondissimo, immergendosi in esso si trovano tesori imprevisti, squarci di<br />
ver<strong>it</strong>à che ci mettono sulla strada giusta, poi, poi, verrà il resto.<br />
L’esercizio del dir<strong>it</strong>to allo studio nell’amb<strong>it</strong>o della scuola non può essere lim<strong>it</strong>ato dalla presenza di<br />
difficoltà, siano esse riconducibili a divers<strong>it</strong>à culturali, a disagi familiari, a carenze linguistiche, a s<strong>it</strong>uazioni<br />
di scarsa motivazione e insufficiente impegno.<br />
Per questo è dovere della scuola ev<strong>it</strong>are, per quanto possibile, che queste divers<strong>it</strong>à si trasformino in<br />
difficoltà di apprendimento e in problemi di comportamento poiché ciò quasi sempre prelude a fenomeni di<br />
insuccesso e di mortal<strong>it</strong>à scolastica e, conseguentemente, a disuguaglianze sul piano sociale e civile; per<br />
raggiungere questo obiettivo la scuola si pone in una dimensione di accoglienza, di valorizzazione e di<br />
sostegno attivando strategie adeguate sul piano organizzativo, didattico e culturale.<br />
1. LA DIVERSITÀ CULTURALE<br />
Ancor oggi l’arrivo di una ragazza o di un ragazzo stranieri nella scuola rappresenta un momento di<br />
difficoltà che crea incertezza anche se non è più un evento eccezionale. In tutto l’ist<strong>it</strong>uto ci sono<br />
complessivamente 37 stranieri provenienti da diverse nazional<strong>it</strong>à.<br />
Alcuni di loro sono arrivati da poco, con madre e fratelli, per raggiungere il padre che già lavorava nella<br />
nostra zona. Altri si sono trasfer<strong>it</strong>i qui assieme a tutta la famiglia, con i gen<strong>it</strong>ori hanno voluto questo<br />
viaggio, ne hanno accettato i rischi. Diversa, ovviamente, la storia di ognuno; diversa l’origine, la lingua, la<br />
religione. E tuttavia, in mezzo a tante divers<strong>it</strong>à, non sono pochi gli elementi che li accomunano.<br />
Anz<strong>it</strong>utto, inizialmente, la paura. Perché l’ingresso nella scuola è per il nuovo arrivato il momento della<br />
ver<strong>it</strong>à, che segue quello dei sogni; come uno specchio, compagni e insegnanti gli rest<strong>it</strong>uiscono ora una<br />
nuova immagine di sé: quella dell’emigrante senza un retroterra utile, senza strumenti, senza lingua. Per<br />
quanto esplori a palmo a palmo lo spazio che gli sta attorno, riesce in un primo tempo solo a delineare i<br />
confini della sua nuova sol<strong>it</strong>udine.<br />
Quindi, il silenzio – e se per silenzio si intende il non poter esprimere i sentimenti più profondi e le<br />
emozioni nella propria lingua d’origine, quella che da piccolo ti ha costru<strong>it</strong>o il mondo, quella attraverso cui<br />
hai imparato da bambino a conoscere le cose e a dar loro un senso e un valore, si capisce che si tratta di<br />
un silenzio pesante e destinato a durare a lungo. Qui, nella scuola, il ragazzo scopre che la lingua che ha<br />
parlato fino a quel momento non appartiene alla sfera delle lingue dotate di dign<strong>it</strong>à culturale, come il<br />
tedesco o l’inglese, per esempio; la sua ora è solo una lingua da emigrante, buona per l’uso familiare, una<br />
di quelle lingue che nessuno si sognerebbe mai di far studiare ai propri figli a meno di non essere costretto<br />
dal destino. Che magari proprio con quella siano stati scr<strong>it</strong>ti alcuni dei libri più belli della letteratura, lui lo<br />
ignora o, se ne è a conoscenza, non trae grande util<strong>it</strong>à da un’informazione che non può essere condivisa in<br />
56
profond<strong>it</strong>à con chi gli sta accanto. Più importante sembra al momento imparare velocemente l’<strong>it</strong>aliano,<br />
consapevole com’è che senza quello la sua stessa presenza nella scuola viene vanificata.<br />
La sua, la loro presenza: ecco l’elemento determinante. Impaur<strong>it</strong>i, silenziosi, ma presenti. Non lo<br />
sanno, nemmeno lo sospettano, ma nel momento stesso del loro arrivo nella scuola le hanno lanciato una<br />
sfida, proprio sul terreno che alla scuola è più congeniale: quello del senso del sapere, del valore delle<br />
conoscenze, delle forme dell’intelligenza. La scuola che non la raccogliesse, che non accettasse di entrare<br />
proficuamente in crisi davanti a questa provocazione spesso imprevista, sarebbe una scuola che ha perso la<br />
capac<strong>it</strong>à di produrre e trasmettere cultura.<br />
Proviamo allora a immaginare che cosa potrebbe succedere in una classe dove, accanto ai ragazzini di<br />
Nomi, Pomarolo, Nogaredo, Villa Lagarina sedesse uno dei ragazzi marocchini, pachistani, albanesi di cui<br />
abbiamo parlato fino adesso. Alle lingue che già hanno dir<strong>it</strong>to di c<strong>it</strong>tadinanza nella scuola – l’<strong>it</strong>aliano,<br />
ovviamente, l’inglese, il tedesco – se ne aggiunge un’altra, che poco a poco s’inserisce nella quotidian<strong>it</strong>à del<br />
lavoro scolastico. Si scopre la magia di nuovi alfabeti, si esplorano sonor<strong>it</strong>à inusuali, si imparano parole, ci<br />
si confronta con grammatiche tanto complesse da mer<strong>it</strong>arsi la maiuscola. L’approccio col compagno<br />
straniero diventa occasione di scambio tra lingue di pari dign<strong>it</strong>à e il momento in cui si accetta di esporsi al<br />
rischio dell’errore può essere nello stesso tempo divertente e utilmente destabilizzante. Si arriva a scrivere<br />
storie in <strong>it</strong>aliano e arabo, <strong>it</strong>aliano e albanese, si ascoltano canzoni, si imparano poesie.<br />
Immaginiamo che il nostro ragazzino, che nella sua scuola d’origine aveva iniziato a gustare il piacere<br />
della lettura, non sia costretto a rinunciarvi, perché può trovare anche nella biblioteca di classe, la sua<br />
nuova classe <strong>it</strong>aliana, libri per lui, scr<strong>it</strong>ti in arabo, urdu, serbo-croato. Immaginiamo che, accanto a testi di<br />
autori europei o americani, la scuola sia in grado di proporre, a lui e ai suoi compagni, storie scr<strong>it</strong>te da<br />
scr<strong>it</strong>tori della sua nazione, sicuramente meno noti, ma solo a causa della poco illuminata pol<strong>it</strong>ica di molte<br />
delle nostre case ed<strong>it</strong>rici. Immaginiamo che possa anche guardare qualche film prodotto in Marocco o in<br />
Pakistan, magari in lingua originale e sottot<strong>it</strong>olato perché risulti comprensibile ai compagni.<br />
Non c’è dubbio che il repertorio di conoscenze prodotto in questo modo nella classe, accostandosi,<br />
tappa dopo tappa, a questo o a quell’altro aspetto della cultura del ragazzo migrante, senza nascondersi<br />
mai la compless<strong>it</strong>à dell’oggetto e la sua natura di fenomeno in evoluzione, appartenga alla sfera di quegli<br />
apprendimenti “importanti” che segnano la formazione di una persona. Ma allora perché, continuando<br />
nell’esplorazione del possibile, non immaginare che questo sapere possa uscire dalla scuola e coinvolgere la<br />
comun<strong>it</strong>à cui la scuola appartiene? Pensiamo ad un evento – una festa aperta alla c<strong>it</strong>tadinanza, ad esempio<br />
– che rendendo visibili e comprensibili i nostri alunni stranieri e le loro famiglie, cost<strong>it</strong>uisca l’occasione per<br />
un incontro – culinario, musicale, o altro – tra le tante culture presenti sul terr<strong>it</strong>orio.<br />
Alcune di queste cose, negli anni, le abbiamo realizzate. Altre sono ancora in fase di progetto. È questa<br />
comunque la nostra direzione di marcia, l’obiettivo verso il quale muoviamo. Naturalmente il lavoro ha<br />
richiesto, e continuerà a richiedere, un grosso sforzo di rinnovamento: i docenti hanno dovuto aggiornare le<br />
loro competenze e la scuola dotarsi di nuovi strumenti. Tra questi, uno appare importante per l’immediato<br />
futuro: l’individuazione, al nostro interno, di un insegnante che diventi una figura di riferimento per i<br />
ragazzi stranieri; sarà lui che li accoglierà al loro arrivo e ne seguirà l’inserimento nelle classi, curerà i<br />
contatti con le famiglie e sollec<strong>it</strong>erà, se necessario, la collaborazione di operatori in grado di svolgere quegli<br />
interventi di mediazione culturale che la s<strong>it</strong>uazione potrebbe richiedere. Infine raccoglierà e conserverà<br />
tutto il materiale prodotto per e dagli alunni stranieri e dai loro compagni, non solamente per dimostrare<br />
che la loro presenza ha lasciato una traccia – non farà collezione di souvenir – ma per testimoniare le<br />
modal<strong>it</strong>à di un viaggio tra confini in continuo spostamento e tener conto dei punti d’arrivo, per verificare<br />
cioè se la sfida, raccolta, è stata vinta o persa.<br />
2. LO SVANTAGGIO E LE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO.<br />
Le difficoltà di apprendimento possono essere legate a fattori biologici o essere influenzate da disagi<br />
familiari, divari culturali e linguistici, s<strong>it</strong>uazioni di scarsa motivazione e insufficiente impegno.<br />
Queste s<strong>it</strong>uazioni spesso emergono nel corso degli anni e la scuola si deve attivare per realizzare dei<br />
percorsi formativi didattici adeguati.<br />
Le strategie e le risorse della scuola primaria<br />
Partendo dalla consapevolezza che la scuola ha il dovere di ev<strong>it</strong>are che la divers<strong>it</strong>à si trasformi in<br />
disuguaglianza sul piano sociale e civile, la programmazione educativa e didattica si articola e si sviluppa in<br />
modo da prevedere la costruzione e la realizzazione di percorsi individuali di apprendimento che tengano<br />
conto dei livelli di partenza di ogni bambino e che si pongano obiettivi realistici da verificare in <strong>it</strong>inere.<br />
Per l’attivazione di questi interventi la scuola dispone di un insieme di risorse che possono essere così<br />
sintetizzate:<br />
Le compresenze delle insegnanti di classe da utilizzare per interventi individualizzati, per attiv<strong>it</strong>à di<br />
gruppo, per l’arricchimento dell’offerta formativa;<br />
57
le opportun<strong>it</strong>à offerte dal contratto provinciale di lavoro e dal fondo di ist<strong>it</strong>uto.<br />
Le strategie e le risorse della scuola media<br />
Ogni anno alcuni ragazzi manifestano difficoltà, più o meno rilevanti, nel raggiungimento degli obiettivi<br />
stabil<strong>it</strong>i dalla programmazione, a causa:<br />
disturbi specifici di apprendimento;<br />
di lacune nella preparazione di base, incertezze di ordine logico, insufficiente comprensione sul piano<br />
linguistico;<br />
di problemi legati alla motivazione e alle difficoltà emotivo - relazionali (impegno discontinuo,<br />
disinteresse, negligenza).<br />
Per ognuna di queste s<strong>it</strong>uazioni tutto il team docente si attiva per progettare e realizzare un percorso<br />
mirato:<br />
a) Per gli alunni che presentano disturbi specifici di apprendimento devono essere elaborati dei percorsi<br />
educativi personalizzati che prevedono l’utilizzo di strumenti compensativi per far vivere serenamente<br />
l’esperienza scolastica.<br />
b) Per i ragazzi che hanno difficoltà scolastiche l’intervento è indirizzato allo sviluppo delle capac<strong>it</strong>à logiche<br />
e linguistiche, al recupero di conoscenze di base, all’acquisizione di un metodo di studio e di lavoro.<br />
b) Per gli studenti con disagi emotivo – relazionali e di motivazione l’intervento programmato non è<br />
incentrato sulle lacune conosc<strong>it</strong>ive nelle singole materie ma sulla persona. Sono privilegiate le<br />
esperienze volte a soddisfare i bisogni profondi, cioè l’acquisizione della coscienza di sé, la costruzione di<br />
una propria ident<strong>it</strong>à e di rapporti relazionali pos<strong>it</strong>ivi con gli altri e la società.<br />
3. L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI.<br />
PREMESSA<br />
Il dir<strong>it</strong>to all’educazione e all’istruzione degli alunni con bisogni educativi speciali nelle scuole di ogni<br />
ordine e grado è disciplinato dalla Legge-quadro sull’assistenza, l’integrazione sociale e i dir<strong>it</strong>ti delle<br />
persone diversamente abili, legge del 5 febbraio 1992, n° 104. In particolare, l’articolo 12 afferma:<br />
comma 2 - È garant<strong>it</strong>o il dir<strong>it</strong>to all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle classi<br />
comuni delle ist<strong>it</strong>uzioni scolastiche di ogni ordine e grado.<br />
comma 3 - L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzial<strong>it</strong>à della persona<br />
<br />
handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.<br />
comma 4 - L’esercizio del dir<strong>it</strong>to all’educazione e all’istruzione non può essere imped<strong>it</strong>o da difficoltà di<br />
apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabil<strong>it</strong>à connesse all’handicap.<br />
Al fine di rispondere adeguatamente ai principi ispiratori della legge, ovvero il rispetto della dign<strong>it</strong>à<br />
umana e dei dir<strong>it</strong>ti di libertà e autonomia della persona in s<strong>it</strong>uazione di defic<strong>it</strong> e la promozione della sua<br />
integrazione sociale, l’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> uniforma la propria azione educativa ai seguenti cr<strong>it</strong>eri:<br />
I CRITERI<br />
a) La responsabil<strong>it</strong>à educativa della comun<strong>it</strong>à scolastica<br />
La responsabil<strong>it</strong>à dell’integrazione dell’alunno con bisogni educativi speciali e dell’azione educativa nei<br />
suoi confronti è, al medesimo t<strong>it</strong>olo, degli insegnanti di classe, dell’insegnante specializzato sul sostegno,<br />
dell’assistente educatore, della comun<strong>it</strong>à scolastica nel suo insieme.<br />
b) Individualizzazione degli interventi<br />
L’individualizzazione degli interventi educativi è l’unica garanzia di successo nella ricerca di risultati<br />
apprezzabili nell’educazione speciale. Ogni alunno in s<strong>it</strong>uazione con bisogni educativi speciali ha dir<strong>it</strong>to di<br />
ricevere un intervento educativo mirato e calibrato sulle proprie esigenze e potenzial<strong>it</strong>à; la scuola si<br />
adopera in tal senso.<br />
c) Valorizzazione delle potenzial<strong>it</strong>à e successo formativo<br />
La comun<strong>it</strong>à scolastica, già impegnata a riconoscere e valorizzare le divers<strong>it</strong>à di ognuno, promuove in<br />
particolar modo le potenzial<strong>it</strong>à di chi si trova in una s<strong>it</strong>uazione di svantaggio e adotta tutte le iniziative utili<br />
al raggiungimento del suo successo formativo.<br />
d) Flessibil<strong>it</strong>à nell’organizzazione degli interventi<br />
Gli alunni in s<strong>it</strong>uazione di difficoltà pongono l’esigenza di adottare una particolare flessibil<strong>it</strong>à<br />
nell’organizzare un percorso formativo coerente con i loro bisogni. Conseguentemente, la scuola:<br />
individua e adotta metodologie e strumenti specifici;<br />
adegua gli insegnamenti alle esigenze dei singoli alunni al fine di prevenire gli insuccessi;<br />
regola i tempi dell’insegnamento nel modo più adeguato ai loro r<strong>it</strong>mi di apprendimento;<br />
programma attiv<strong>it</strong>à didattiche per gruppi di lavoro o un<strong>it</strong>à di apprendimento;<br />
58
progetta e realizza percorsi che assicurano la continu<strong>it</strong>à didattica e formativa nonché di orientamento<br />
scolastico e professionale, prevedendo anche lo svolgimento di insegnamenti opzionali e facoltativi<br />
mirati in tal senso;<br />
individua percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attiv<strong>it</strong>à.<br />
e) La classe: luogo privilegiato dell’azione educativa<br />
La classe rappresenta il contesto sociale in cui normalmente si svolgono gli interventi in favore degli<br />
alunni in difficoltà. Le attiv<strong>it</strong>à didattiche ed educative dell’alunno svolte fuori dalla classse devono essere<br />
funzionali alle sue esigenze, non possono essere decise in modo unilaterale da un solo insegnante e vanno<br />
concordate in sede di programmazione.<br />
f) Integrazione delle risorse<br />
Tutti coloro che interagiscono con l’alunno in difficoltà lavorano secondo la logica della cooperazione e<br />
della condivisione di intenti.<br />
g) Lim<strong>it</strong>i dell’intervento<br />
Ogni scelta educativa che la scuola effettua è fatta nel rispetto delle persona con bisogni educativi<br />
speciali in collaborazione con la famiglia e quando possibile si prevede il coinvolgimento degli stessi studenti<br />
soprattutto in mer<strong>it</strong>o all’orientamento scolastico o professionale dopo le scuole medie.<br />
LE FIGURE DI RIFERIMENTO<br />
a) Gli insegnanti di classe<br />
Sono corresponsabili della formazione e dell’educazione di tutti gli alunni della classe, pertanto non<br />
devono mai delegare al solo insegnante specializzato sul sostegno o all’assistente educatore quanto<br />
concerne l’alunno in s<strong>it</strong>uazione di svantaggo.<br />
b) L’insegnante specializzato sul sostegno<br />
L’insegnante di sostegno è un insegnante specializzato, previsto fin dalla Legge 517 del 1977, che<br />
viene assegnato alle classi in cui è inser<strong>it</strong>o il soggetto con bisogni educativi speciali, in piena cont<strong>it</strong>olar<strong>it</strong>à<br />
con gli altri docenti, per attuare “forme di integrazione a favore degli alunni in s<strong>it</strong>uazione di defic<strong>it</strong>” e<br />
“realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni”. E’ fondamentale che<br />
l’insegnante di sostegno collabori pienamente con i colleghi nell’impostazione e realizzazione del progetto<br />
educativo –didattico rifer<strong>it</strong>o al bambino in difficoltà, che mette a disposizione le proprie competenze per<br />
organizzare i relativi percorsi; che assuma la corresponsabil<strong>it</strong>à dell’attiv<strong>it</strong>à educativa didattica complessiva<br />
nella sezione, nel modulo o nella classe in cui viene assegnato; che svolga comp<strong>it</strong>i di collaborazione con le<br />
famiglie e le strutture san<strong>it</strong>arie del terr<strong>it</strong>orio.<br />
La quantificazione orario del rapporto fra l’insegnante e l’alunno viene stabil<strong>it</strong>a in base al Piano<br />
dell’Offerta Formativa (POF), in cui vengono considerati i bisogni dei singoli soggetti correlati alle diverse<br />
grav<strong>it</strong>à dei defic<strong>it</strong>.<br />
La sua presenza rappresenta una risorsa qualificata che garantisce il necessario supporto tecnico–<br />
specialistico all’intervento individualizzato e, nel contempo, offre all’intera classe, o modulo, una maggiore<br />
gamma di opportun<strong>it</strong>à. A tal fine possono essere ipotizzate delle variazioni nell’aggregazione degli amb<strong>it</strong>i<br />
con l’affidamento di un’area disciplinare proprio all’insegnante di sostegno.<br />
c) L’assistente educatore<br />
L’assistente educatore è una figura professionalmente preparata che svolge, in collaborazione con il<br />
personale docente, la propria attiv<strong>it</strong>à educativa e di assistenza agli alunni con bisogni educativi speciali e<br />
partecipa con piena t<strong>it</strong>olar<strong>it</strong>à alle attiv<strong>it</strong>à programmate per la realizzazione del <strong>Progetto</strong> di recupero e/o di<br />
sviluppo delle abil<strong>it</strong>à presenti.<br />
Collabora con la famiglia, con gli operatori socio-san<strong>it</strong>ari, con il team docente e collabora alla stesura<br />
del profilo valutativo.<br />
d) L’assistente alla comunicazione<br />
Nei casi di defic<strong>it</strong> sensoriale, ovvero sord<strong>it</strong>à e cec<strong>it</strong>à, è una figura specializzata ad assumere il ruolo di<br />
tram<strong>it</strong>e efficace all’interno della comunicazione che si instaura tra il docente e l’alunno.<br />
LE PROCEDURE<br />
Il complesso di norme che si occupano di handicap nella scuola, ovvero:<br />
la Legge 517 del 1977<br />
la circolare ministeriale n. 258 del 1983<br />
la circolare ministeriale n. 250 del 1985<br />
la Legge 104/’92 e il D.M. del 9.07.1992;<br />
Legge n. 17/1999 e il D.P.C.M. n. 185/<strong>2006</strong>;<br />
l’“Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai comp<strong>it</strong>i delle UU.SS.LL. in materia di alunni portatori di<br />
handicap”, di cui al d.p.r.: 24 febbraio 1994;<br />
59
la Delibera della Giunta Provinciale del 27 gennaio 1995<br />
Accordi di programma<br />
identificano alcuni momenti significativi dell’<strong>it</strong>er finalizzato a una piena integrazione.<br />
a) L’individuazione dell’alunno come persona con bisogni educativi speciali<br />
Nel momento in cui il team docente r<strong>it</strong>enga che uno dei propri alunni potrebbe necess<strong>it</strong>are, a segu<strong>it</strong>o<br />
dell’emergere di difficoltà di apprendimento o della sfera emotivo – relazionale non superabili attraverso i<br />
più adeguati accorgimenti didattici, di una valutazione clinica è fondamentale che, data la delicatezza e la<br />
riservatezza della s<strong>it</strong>uazione, la comunicazione venga resa ufficiale alla famiglia solo previa condivisione con<br />
il Dirigente scolastico da parte degli insegnanti di classe.<br />
Evidenziate le difficoltà emerse nell’alunno alla famiglia, resta a quest’ultima la facoltà di decidere se<br />
far riferimento all’Azienda San<strong>it</strong>aria.<br />
Per i casi di nuova individuazione è opportuno che la richiesta pervenga ai servizi specialistici, ove<br />
possibile, entro la fine del mese di febbraio dell’anno scolastico in corso.<br />
Qualora il minore con bisogni educativi speciali sia segu<strong>it</strong>o da specialista privato, deve essere<br />
presentata attestazione della patologia, comunque convalidata dallo specialista dell’A.P.S.S.<br />
A questo fine la famiglia richiede allo specialista privato la redazione della Diagnosi Funzionale (vedi) e<br />
una dichiarazione in ordine all’assunzione da parte del medesimo dell’impegno a ottemperare ai successivi<br />
adempimenti di legge in materia, vale a dire in particolare l’impegno a partecipare ai lavori dell’Un<strong>it</strong>à<br />
multidisciplinare di cui all’art. 3 del D.P.R. 24.2.’94. Gli oneri relativi alla consulenza prestata dallo<br />
specialista privato restano a carico della famiglia.<br />
Si definisce persona con bisogni educativi speciali “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o<br />
sensoriale che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da<br />
determinare emarginazione o svantaggio sociale”.<br />
b) La definizione della “Diagnosi Funzionale”<br />
Gli operatori dell’A.P.S.S. o lo specialista privato, al momento dell’iscrizione nelle classi prime, primarie<br />
e medie, provvedono per ogni alunno a redigere la diagnosi funzionale, documento che descrive<br />
anal<strong>it</strong>icamente la compromissione funzionale dello stato psicofisico dell’alunno, le difficoltà di<br />
apprendimento conseguenti all’handicap e le capac<strong>it</strong>à / abil<strong>it</strong>à possedute dall’alunno. Negli anni successivi,<br />
tale documento deve essere aggiornato nelle parti che richiedono modifiche rilevanti.<br />
Sulla base di tale certificazione viene assegnato dalla Sovrintendenza Scolastica l’insegnante<br />
specializzato sul sostegno.<br />
La diagnosi funzionale è consegnata dagli operatori san<strong>it</strong>ari alla famiglia (che si incarica di presentarla<br />
al Dirigente scolastico per i provvedimenti necessari) entro il mese di febbraio per gli alunni di nuovo<br />
inserimento e entro il mese di maggio per gli alunni già inser<strong>it</strong>i.<br />
c) La cost<strong>it</strong>uzione del Gruppo di studio e lavoro per l’handicap a livello d’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong><br />
Presso l’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o annualmente il gruppo di studio e di lavoro composto dal dirigente<br />
scolastico e dal coordinatore del gruppo H, l’insegnante con incarico di funzione strumentale al progetto<br />
d’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong>, dai docenti specializzati sul sostegno, dagli assistenti educatori; in caso di specifici problemi può<br />
essere richiesta la consulenza e la collaborazione degli operatori dei servizi e dei gen<strong>it</strong>ori interessati.<br />
Il gruppo:<br />
collabora alla definizione del progetto d’ist<strong>it</strong>uto per la parte relativa all’integrazione scolastica;<br />
formula una proposta complessiva per la collocazione delle risorse;<br />
verifica in <strong>it</strong>inere le iniziative di sostegno programmate dalla scuola;<br />
<br />
<br />
60<br />
elabora specifici progetti;<br />
verifica al termine dell’anno scolastico gli interventi, elabora il piano per l’anno scolastico successivo,<br />
formula una proposta di organico.<br />
Si riunisce periodicamente.<br />
d) La cost<strong>it</strong>uzione del Gruppo di Lavoro per l’handicap (il GLH operativo) per ogni alunno<br />
Per ogni alunno in s<strong>it</strong>uazione di difficoltà, all’inizio dell’anno scolastico viene cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a un’équipe di<br />
lavoro, composta dal Dirigente, da alcuni insegnanti di classe, dall’insegnante di sostegno, dall’assistente<br />
educatore, dagli operatori della USL che si occupano del caso (l’Un<strong>it</strong>à multidisciplinare di cui all’art. 3 D.P.R.<br />
24.2.’94), dai gen<strong>it</strong>ori o dai facenti funzione e da qualunque altra figura significativa che operi nei confronti<br />
dell’alunno.<br />
Il gruppo:<br />
elabora il Profilo Dinamico Funzionale (vedi)<br />
predispone il Piano Educativo Personalizzato o almeno individua e coordina le “linee generali” del PEP;<br />
verifica in <strong>it</strong>inere i risultati e, se necessario, modifica il PEP e/o il PDF<br />
Il Dirigente scolastico:<br />
nomina e presiede il gruppo di lavoro;
individua il coordinatore (di norma l’insegnante specializzato sul sostegno) che ha il comp<strong>it</strong>o di redigere<br />
il verbale delle riunioni, predisporre e tenere aggiornata la documentazione.<br />
In caso di assenza o impedimento, il Dirigente scolastico è sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dal coordinatore del gruppo.<br />
Il GLH operativo si riunisce almeno due volte l’anno. Le riunioni vanno verbalizzate.<br />
e) La predisposizione del “Profilo Dinamico Funzionale”:<br />
Redatto dal GLH operativo, è un documento che, in base alla Diagnosi Funzionale, alle informazioni<br />
raccolte e ad un’attenta osservazione sistematica, indica “le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali e<br />
affettive dell’alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla s<strong>it</strong>uazione di<br />
handicap e le possibil<strong>it</strong>à di recupero, sia le caratteristiche possedute che devono essere sostenute,<br />
sollec<strong>it</strong>ate, progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona<br />
handicappata”.<br />
È elaborato una prima volta in segu<strong>it</strong>o alla prima redazione della Diagnosi Funzionale; in linea di<br />
massima in I primaria e in I media. Viene aggiornato, invece, in II, IV e V primaria e in II e III media, entro<br />
il mese di dicembre di ogni anno, compatibilmente però con le date nelle quali si effettuano gli incontri con i<br />
servizi san<strong>it</strong>ari.<br />
Nota: Affinché sia un documento valido, deve essere redatto tenendo in considerazione le indicazioni<br />
degli operatori della USL.<br />
f) La formulazione del “Piano Educativo Personalizzato”<br />
Partendo dagli elementi base offerti dal PDF, il GLH operativo elabora il Piano educativo personalizzato,<br />
ovvero l’insieme degli interventi educativi e didattici pensati e articolati in funzione della cresc<strong>it</strong>a armonica<br />
complessiva dell’alunno.<br />
Nel PEP sono defin<strong>it</strong>i gli obiettivi, i metodi, le strategie, gli interventi che, tenendo in considerazione le<br />
potenzial<strong>it</strong>à dell’alunno con bisogni educativi speciali, vanno calibrati in base al Profilo Dinamico Funzionale.<br />
Il PEP recepisce, integrandoli, gli eventuali indicazioni di recupero effettuati sull’alunno dagli operatori<br />
san<strong>it</strong>ari nonché gli interventi che la famiglia è chiamata ad adottare, ciò al fine di rendere l’azione educativa<br />
un progetto cooprogettato e corresponsabile tra le varie parti in gioco.<br />
Questo documento è efficace strumento di programmazione che rende concreto e realmente<br />
perseguibile il dir<strong>it</strong>to all’educazione e all’istruzione degli alunni diversamente abili.<br />
g) La valutazione degli interventi realizzati<br />
La valutazione scolastica degli alunni in difficoltà deve essere relativa agli interventi educativi e didattici<br />
svolti sulla base del PEP, e rifer<strong>it</strong>a ai progressi evidenziati in rapporto alle potenzial<strong>it</strong>à e ai livelli di<br />
apprendimento iniziali.<br />
La procedure che riguardano la valutazione sono un momento fondamentale nell’amb<strong>it</strong>o delle attiv<strong>it</strong>à<br />
didattiche che hanno il carattere di sistematic<strong>it</strong>à e di intenzional<strong>it</strong>à.<br />
Essa consente di effettuare un bilancio complessivo, non parziale, dell’attiv<strong>it</strong>à scolastica (scelte<br />
didattiche e metodologiche inser<strong>it</strong>e nella programmazione), e degli apprendimenti da essi favor<strong>it</strong>i negli<br />
studenti (obiettivi raggiunti e abil<strong>it</strong>à di utilizzare le competenze acquis<strong>it</strong>e in differenti contesti), o in una<br />
fase specifica dell’anno scolastico o nell’intero percorso oppure in una particolare disciplina.<br />
Le prove d’esame sono predisposte in corrispondenza degli insegnamenti impart<strong>it</strong>i e devono essere<br />
idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzial<strong>it</strong>à e ai livelli di apprendimento<br />
iniziali.<br />
h) Il “Quaderno Personale”<br />
Per rendere più funzionale la raccolta di tutta la documentazione relativa al processo di integrazione, è<br />
previsto un “quaderno personale” da predisporre per ciascun alunno con bisogni educativi speciali.<br />
Il “quaderno”, con gli aggiornamenti annuali, documenta tutto il percorso del bambino, dal suo<br />
ingresso a scuola fino alla III media.<br />
Il quaderno, che deve restare riservato, documenta e raccoglie:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
la certificazione<br />
la diagnosi funzionale;<br />
il profilo dinamico funzionale e i suoi aggiornamenti;<br />
il PEP con le relative verifiche e le conseguenti integrazioni o variazioni;<br />
i verbali delle riunioni del gruppo di lavoro;<br />
i verbali di eventuali incontri con gli operatori socio san<strong>it</strong>ari<br />
i verbali degli incontri con la famiglia (qualora essi siano considerati di particolare rilevanza).<br />
documentazione (elaborati scr<strong>it</strong>ti, fotografie, resoconti di particolari attiv<strong>it</strong>à,…)<br />
tutto ciò si r<strong>it</strong>enga possa essere utile alla definizione del caso e ai relativi interventi educativi e didattici.<br />
61
4. PROGETTO INTERCULTURA PER L'ANNO SCOLASTICO <strong>2006</strong>/2007<br />
La Commissione per l'accoglienza degli alunni stranieri e le iniziative interculturali è comosta da un<br />
rappresentante delle varie Scuole dell’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> Comprensivo e si assume diversi comp<strong>it</strong>i.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Negli scorsi anni per facil<strong>it</strong>are l’integrazione ha realizzato:<br />
un’aula all’interno della scuola media riservata alle attiv<strong>it</strong>à interculturali (lezioni specifiche, corsi di<br />
lingue);<br />
l'allestimento di uno scaffale interculturale, comprendente testi per insegnanti (di didattica<br />
dell'<strong>it</strong>aliano come L2, di approfondimento di temi interculturali, ecc.), dizionari, libri per ragazzi in<br />
edizione bi- e monolingue;<br />
l'acquisto di materiale didattico (maschere, cartelloni) per l'insegnamento dell'<strong>it</strong>aliano a stranieri;<br />
la stesura di un protocollo d'accoglienza che prevede le procedure da seguire quando arriva un<br />
alunno straniero;<br />
l'esposizione, nell'atrio della scuola media, di un mappamondo che rende visibili gli alunni stranieri<br />
presenti nella scuola e la loro provenienza.<br />
Nell’anno scolastico in corso intende farsi carico dei seguenti impegni:<br />
attivare la procedura del protocollo d’accoglienza nell’eventual<strong>it</strong>à di inserimetno di nuovi alunni<br />
provenienti dall’estero in corso d’anno;<br />
contattare il Dirigente per segnalare la necess<strong>it</strong>à di un mediatore linguistico per facil<strong>it</strong>are il primo<br />
periodo di scuola per questi bambini;<br />
organizzare, su richiesta degli insegnanti delle varie scuole, interventi di mediatori culturali nelle classi<br />
su temi concernenti l’incontro tra culture (alfabeto- numeri – religione – cibo - ecc.):<br />
aggiornare l’elenco dei testi e materiali presenti nella scuola nell’aula riservata alle attiv<strong>it</strong>à interculturali.<br />
In collaborazione col Comune di Villa Lagarina. la commissione organizza da alcuni anni un corso di<br />
<strong>it</strong>aliano per donne straniere, articolato su due livelli: un primo livello per promuovere la comunicazione<br />
di base, un secondo per perfezionare le competenze grammaticali e potenziare il lessico. È uno spazio di<br />
incontro e di apprendimento aperto all’interno dell’ist<strong>it</strong>uto alle madri e alle sorelle degli alunni stranieri, per<br />
soddisfare i loro bisogni di integrazione linguistica, per facil<strong>it</strong>arle nel loro desiderio di seguire il percorso<br />
scolastico del figlio e per creare un ponte fra scuola e famiglia.<br />
Per l’anno in corso e per il successivo è prevista la partecipazione dell’ist<strong>it</strong>uto ad un progetto in<br />
rete con altre scuole di Rovereto (IC Rovereto Est, IC Rovereto Sud, IC Volano – Rovereto Nord) che<br />
intende sviluppare il riconoscimento e l’interazione tra le molteplici ident<strong>it</strong>à culturali presenti nella scuola, e<br />
sviluppare atteggiamenti che favoriscano una più piena interazione tra c<strong>it</strong>tadini all’interno di una realtà<br />
multiculturale. A partire dall’esperienza della scuola, si creeranno quindi occasioni di incontro e di scambio<br />
per gli alunni (di origine <strong>it</strong>aliana e non) e per le loro famiglie.<br />
Attualmente gli alunni stranieri frequentanti l’ist<strong>it</strong>uto sono 37, così distribu<strong>it</strong>i:<br />
N. o alunni Provenienza N. o Sede<br />
5 Albania 1 Sc. Prim. Nogaredo<br />
1 Bosnia-Erzegovina 0 Sc. Prim. Nomi<br />
1 Croazia 8 Sc. Prim. Pomarolo<br />
1 Feder. Russa 14 Sc. Prim. Villa Lagarina<br />
4 India 10 Scuola Media<br />
7 Marocco<br />
3 Moldavia<br />
3 Polonia<br />
1 Romania<br />
4 Serbia e Montenegro<br />
1 Tunisia<br />
2 Ucraina<br />
33 Totale<br />
62
L'AREA DEI PROGETTI<br />
63
L'EDUCAZIONE ALLA SALUTE<br />
“La scuola, in tutte le sue componenti, è chiamata ad operare per prevenire e per combattere, per la<br />
sua parte e con le sue specifiche risorse, il disagio, la demotivazione, la dispersione, la devianza e per<br />
consentire ai giovani livelli il più possibile elevati di benessere psicofisico, di consapevolezza cr<strong>it</strong>ica, di<br />
motivazione ad apprendere, a partecipare, a spendersi per una v<strong>it</strong>a sempre più sana e ricca di valori<br />
personali e sociali” (Ministero della Pubblica Istruzione).<br />
Queste poche righe sintetizzano in modo esemplare la funzione della scuola nel campo dell’educazione<br />
alla salute, una scuola che rivolge la propria attenzione prima ai bambini e ai ragazzi e poi ai programmi;<br />
questo perché è consapevole che non può esserci apprendimento se non attraverso un sapere che risulti<br />
significativo, ossia strumento di comprensione della v<strong>it</strong>a, della realtà, del mondo.<br />
Fondamentale, a tal fine, è anche la realizzazione di una clima sociale pos<strong>it</strong>ivo nella v<strong>it</strong>a quotidiana<br />
della scuola, organizzando forme di lavoro di gruppo e di aiuto reciproco e favorendo l’iniziativa,<br />
l’autodecisione, la responsabil<strong>it</strong>à personale dei bambini e dei ragazzi.<br />
Il nostro <strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> contribuisce a realizzare questi obiettivi anche attraverso il “Piano di educazione alla<br />
salute” articolato in “<strong>Progetto</strong> ragazzi 2000” e “<strong>Progetto</strong> gen<strong>it</strong>ori”.<br />
1. LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:<br />
UNA STORIA DI PROGETTI COMUNI<br />
Ancora a partire dall’anno scolastico 1991/92 i docenti e i gen<strong>it</strong>ori della scuola elementare e della<br />
scuola media hanno iniziato un percorso comune nel campo dell’educazione alla salute.<br />
Nel “<strong>Progetto</strong> ragazzi” sono stati:<br />
proposte ed attuate iniziative di educazione san<strong>it</strong>aria (educazione alimentare, igiene del cavo orale,<br />
educazione affettiva e sessuale, prevenzione delle tossicodipendenze, dell’alcolismo e del tabagismo,<br />
primo soccorso);<br />
progettati interventi educativi diffusi con l’obiettivo di realizzare un clima scolastico pos<strong>it</strong>ivo, di favorire<br />
l’iniziativa e la responsabil<strong>it</strong>à dei bambini e dei ragazzi, di creare occasioni di collaborazione, di lavoro<br />
cooperativo, di vicendevole aiuto e sostegno;<br />
<br />
progettati interventi formativi specifici nel campo dell’attiv<strong>it</strong>à motoria (Giornate sportive, giochi<br />
cooperativi), dell’educazione teatrale, della lettura e della produzione scr<strong>it</strong>ta (“Mostra del libro” che per<br />
alcuni anni ha coinvolto le classi di entrambe le scuole nella lettura e recensione di libri per ragazzi,<br />
negli incontri con autori, nel concorso di scr<strong>it</strong>tura).<br />
Nel “<strong>Progetto</strong> gen<strong>it</strong>ori” sono stati organizzati incontri serali con psicologi ed esperti nel campo<br />
educativo; nel corso degli anni è andato cost<strong>it</strong>uendosi un gruppo di gen<strong>it</strong>ori che si sono resi disponibili a<br />
raccogliere i bisogni diffusi, a collaborare attivamente alla realizzazione dei progetti individuando temi e<br />
relatori.<br />
64<br />
QUESTI I TEMI OGGETTO DI RIFLESSIONE:<br />
1993 Gen<strong>it</strong>ori e figli preadolescenti: quale rapporto?<br />
Famiglia e scuola possono aiutare i ragazzi a conquistare la propria ident<strong>it</strong>à, la matur<strong>it</strong>à e l’equilibrio<br />
personale.<br />
1994 Come aiutare i figli a crescere autonomi e responsabili<br />
Il dialogo tra gen<strong>it</strong>ori e figli, la gestione costruttiva delle difficoltà e dei contrasti della v<strong>it</strong>a<br />
quotidiana.<br />
1995 L’importanza del dialogo in famiglia<br />
Come trasmettere valori educativi e prevenire s<strong>it</strong>uazioni di malessere.<br />
Gen<strong>it</strong>ori, ragazzi, scuola.<br />
Gen<strong>it</strong>ori anni ‘90: riflessioni sul ruolo, i comp<strong>it</strong>i e le competenze dei gen<strong>it</strong>ori.<br />
1996 Libro e televisione. Un rapporto difficile?<br />
La lettura non è un dovere scolastico, ma un’attiv<strong>it</strong>à libera e capace di porre i ragazzi in pos<strong>it</strong>iva<br />
relazione con se stessi e con gli altri.<br />
1997 Gen<strong>it</strong>ori efficaci (metodo Gordon)<br />
Come sviluppare e migliorare la sensibil<strong>it</strong>à e le competenze necessarie per superare le numerose e<br />
complesse difficoltà della v<strong>it</strong>a di famiglia.
1998 L’importanza del dialogo nel rapporto scolastico<br />
Mamma, papà, ho un problema: come accorgersi in tempo? – Educare all’affettiv<strong>it</strong>à per poter vivere<br />
una sessual<strong>it</strong>à piena e gioiosa – Dinamiche affettive e relazionali nella famiglia.<br />
1999 L’età ingrata<br />
Proiezione di film che trattano i problemi relativi al rapporto gen<strong>it</strong>ori e figli e alla divers<strong>it</strong>à.<br />
2000 Nel volo della v<strong>it</strong>a<br />
Comunicazione ed intuizione dei bisogni nella global<strong>it</strong>à dei linguaggi – Sessual<strong>it</strong>à e educazione<br />
sessuale tra infanzia e preadolescenza – Che cos’è l’autostima e come promuoverla.<br />
2001 Nel volo della v<strong>it</strong>a<br />
Mangiare è bello… mangiare giusto è meglio – Gen<strong>it</strong>ori autorevoli: una conquista personale –<br />
Educare alla sessual<strong>it</strong>à: paura e desiderio di ben essere – Rapporti ad alta tensione.<br />
2002 Nel volo della v<strong>it</strong>a<br />
I problemi della colonna vertebrale nell’età evolutiva – La comunicazione non violenta. Linguaggio<br />
Giraffa – Piccolo viaggio cinematografico tra le scuole del mondo: storie di maestri e di scolari – I<br />
gen<strong>it</strong>ori nel cammino scolastico dei figli.<br />
2003 Nel volo della v<strong>it</strong>a<br />
Anch’io per un mondo migliore – Costruttori di speranza – I dir<strong>it</strong>ti dei nostri bambini…, i dir<strong>it</strong>ti di<br />
tutti i bambini – I problemi della colonna vertebrale nell’età evolutiva.<br />
2004 Nel volo della v<strong>it</strong>a<br />
Altrinoi, scuola e comun<strong>it</strong>à – Gestire il tempo con i figli.<br />
2005 Nel volo della v<strong>it</strong>a<br />
Tutti al cinema – La comunicazione educativa – L’uso consapevole e sicuro di internet<br />
<strong>2006</strong> Nel volo della v<strong>it</strong>a<br />
Tutti al cinema – Imparo ad imparare – Il bullismo – Polveri sottili – Orientamento – Primo soccorso<br />
– Tu e i farmaci – Prevenzione delle dipendenze – Giovane consumatore responsabile – Altri noi –<br />
Alimentazione – Alcol e fumo – Stili di v<strong>it</strong>a e cuore – Le vie telematiche regole di viaggio<br />
2. UN IMPEGNO CHE CONTINUA<br />
I progetti nel campo dell’educazione alla salute, forti dell’esperienza degli anni scorsi e delle<br />
opportun<strong>it</strong>à nuove legate alla natura e ai caratteri dell’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> comprensivo, cost<strong>it</strong>uiscono una costante e<br />
un impegno anche per il futuro.<br />
Il Piano delle iniziative di educazione alla salute viene elaborato all’inizio di ogni anno scolastico ed<br />
accoglie le attiv<strong>it</strong>à e le iniziative previste per promuovere lo “star bene” a scuola.<br />
Elementi di fondo del “<strong>Progetto</strong> ragazzi” sono:<br />
la cura della qual<strong>it</strong>à delle relazioni umane nella v<strong>it</strong>a delle classi;<br />
la promozione di iniziative e attiv<strong>it</strong>à che favoriscano il “protagonismo” e la responsabil<strong>it</strong>à degli alunni;<br />
<br />
<br />
l’attenzione alle s<strong>it</strong>uazioni di malessere e disagio;<br />
la progettazione di s<strong>it</strong>uazioni formative finalizzate a creare occasioni di collaborazione, di lavoro<br />
cooperativo, di vicendevole aiuto e sostegno.<br />
Il Piano di educazione alla salute prevede, inoltre, un “<strong>Progetto</strong> Gen<strong>it</strong>ori”, per sviluppare nei gen<strong>it</strong>ori<br />
sensibil<strong>it</strong>à, attenzioni e competenze finalizzate a migliorare i rapporti familiari e la collaborazione tra scuola<br />
e famiglia.<br />
A cavallo dei due progetti esiste dall’anno scolastico 1998/99 uno sportello di consulenza psicologica<br />
denominato “Spazio ascolto” rivolto ai gen<strong>it</strong>ori, ai docenti e alle ragazze/ai ragazzi della Scuola Media.<br />
I gen<strong>it</strong>ori e i docenti, previo appuntamento, possono accedere liberamente al servizio mentre per gli<br />
alunni della scuola è stata individuata una modal<strong>it</strong>à particolare finalizzata a salvaguardare, nel contempo, la<br />
riservatezza delle richieste, l’autonomia dei ragazzi, la responsabil<strong>it</strong>à educativa delle famiglie.<br />
Queste le regole:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
il servizio viene attivato per tutti gli alunni della scuola media;<br />
preventivamente viene inviata una nota a tutte le famiglie con la quale si spiega il senso dell’iniziativa e<br />
si chiede di manifestare il loro eventuale disaccordo nel caso in cui i figli chiedessero di accedere al<br />
servizio;<br />
effettuata questa comunicazione e in assenza di dichiarazione contraria da parte delle famiglie, i<br />
ragazzi, previo appuntamento, possono, in orario scolastico, accedere liberamente al servizio;<br />
la psicologa è tenuta alla riservatezza, fatto salvo il dovere di segnalare alle famiglie o al Servizio<br />
sociale s<strong>it</strong>uazioni di particolare grav<strong>it</strong>à; in questo caso, in linea di massima, ne dà preliminare<br />
comunicazione anche al ragazzo interessato.<br />
65
PIANO DELLE ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE ANNO SCOLASTICO <strong>2006</strong>/07<br />
<strong>Progetto</strong> Destinatari Esperto Sede Incontri A carico di<br />
Spazio ascolto<br />
Gen<strong>it</strong>ori e insegnanti delle<br />
scuole dell’infanzia<br />
elementari/ medie.<br />
Alunne/i della scuola media<br />
Psicologa<br />
d.ssa Paoli Emanuela<br />
Scuola media Comuni<br />
Tutti al cinema<br />
2 film<br />
Altri noi<br />
Imparo ad Imparare:<br />
metodo di studio e<br />
tempo libero o tempo<br />
organizzato<br />
Alcol e fumo<br />
Prevenzione delle<br />
dipendenze<br />
Alimentazione<br />
“Giovane<br />
consumatore<br />
responsabile”<br />
Gen<strong>it</strong>ori, insegnanti, Alunne/i<br />
scuola media<br />
Gen<strong>it</strong>ori, insegnanti<br />
Gen<strong>it</strong>ori, insegnanti - alunne/i<br />
classi V Primarie<br />
Insegnanti di quinta<br />
elementare<br />
Dottor<br />
Pellegrini Luigi<br />
Prof. Rosario Mazzeo<br />
Da individuare 2 serate <strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong><br />
Scuola Primaria di<br />
Pomarolo<br />
Scuole Primarie e<br />
Scuola Media<br />
3 serate x 2 ore APSS<br />
Interventi nelle classi<br />
V (2 ore)<br />
Conferenze per<br />
gen<strong>it</strong>ori e insegnanti<br />
<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong><br />
Dottor Pellegrini Luigi Azienda San<strong>it</strong>aria 2 pomeriggi APSS<br />
Alunne/i di III Media Alcolisti Anonimi/Altri Scuola Media 2 o più ore in classe Alcolisti Anonimi/Altri<br />
Insegnanti di scuola<br />
elementare<br />
Insegnanti e<br />
Alunne/i di seconda media<br />
Nutrizionista Azienda San<strong>it</strong>aria In via di definizione APSS<br />
Esperto di pubblic<strong>it</strong>à Scuola Media 8 ore APSS<br />
Primo soccorso Alunne/i di prima media 118 Scuola Media 2 ore APSS<br />
Tu e i farmaci Alunne/i di seconda media Farmacia di Villa Lagarina Scuola Media 2 ore APSS<br />
Tu e i farmaci Alunni s.e. Pomarolo Farmacie Comunali S.p.a. Scuola P. Pomarolo Comune di Pomarolo<br />
Educazione affettiva<br />
e sessuale<br />
Alunne/i di quinta<br />
elementare, gen<strong>it</strong>ori e<br />
insegnanti<br />
Psicologa<br />
d.ssa Paoli Emanuela<br />
Scuole Primarie<br />
4 ore in classe<br />
Conferenza per<br />
gen<strong>it</strong>ori delle classi<br />
coinvolte<br />
Comuni<br />
67
Educazione affettiva<br />
e sessuale<br />
Le vie telematiche<br />
Regole di viaggio<br />
Alunne/i di terza media,<br />
gen<strong>it</strong>ori e insegnanti<br />
Psicologa<br />
d.ssa Paoli Emanuela<br />
Scuola Media<br />
gen<strong>it</strong>ori e insegnanti d.ssa Anna Maria Maggio Scuola Media<br />
8 ore in classe<br />
Conferenza per<br />
gen<strong>it</strong>ori delle classi<br />
coinvolte<br />
Conferenza<br />
APSS<br />
Polizia Postale<br />
e delle<br />
Telecomunicazioni<br />
Il Bullismo Gen<strong>it</strong>ori prof. Marilina La Montagna Scuola media Conferenza <strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong><br />
Stili di v<strong>it</strong>a e Cuore<br />
Polveri sottili –<br />
pericolo invisibile<br />
Gen<strong>it</strong>ori, insegnanti<br />
Gen<strong>it</strong>ori, insegnanti<br />
A cura dell’ALMC<br />
(Ass. Lotta Malattie<br />
Cardiovascolasr)<br />
Dr Giancarlo Anderle APPA,<br />
dr Dino Sella<br />
Da individuare<br />
Conferenza<br />
Comune di Villa<br />
Lagarina<br />
Da individuare Conferenza Comuni<br />
Orientamento Gen<strong>it</strong>ori dott. Stefania Trentin Scuola Media Conferenza <strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong><br />
Orientamento Alunne/i delle classi II e III dr.a Cristina Simonetti Scuola Media Vari moduli <strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong><br />
68
UNA SCUOLA CHE COLLOCA NEL MONDO:<br />
IL TERRITORIO COME RISORSA FORMATIVA<br />
Richiamando un concetto presente nei programmi della scuola media potremmo dire che la scuola di<br />
base aiuta i ragazzi e le ragazze "ad acquisire progressivamente un’immagine sempre più chiara ed<br />
approfond<strong>it</strong>a della realtà sociale, a riconoscere le attiv<strong>it</strong>à con cui l’uomo provvede alla propria sopravvivenza<br />
e trasforma le proprie condizioni di v<strong>it</strong>a, a comprendere il rapporto che intercorre fra le vicende storiche ed<br />
economiche, le strutture, le aggregazioni sociali e la v<strong>it</strong>a e le decisioni del singolo”.<br />
In questa prospettiva diventano di fondamentale importanza i legami con il terr<strong>it</strong>orio in relazione ai quali<br />
la scuola sottolinea:<br />
la propria responsabil<strong>it</strong>à nel favorire un rapporto di collaborazione con le famiglie e la più vasta comun<strong>it</strong>à<br />
sociale;<br />
la valorizzazione delle risorse formative ;<br />
l’incidenza sempre maggiore sui processi educativi della cultura extrascolastica.<br />
1. SCUOLA E EXTRASCUOLA<br />
La scuola fa parte di un “sistema formativo policentrico” in cui sono presenti molteplici agenzie<br />
educative: la scuola, le famiglie, i mass-media, i servizi culturali, ricreativi e sportivi, le associazioni.<br />
Ma poiché il rapporto con il terr<strong>it</strong>orio non può risolversi in un semplice rapporto di vicinanza, spetta alla<br />
scuola ricomporre in un insieme tutti gli aspetti o gli elementi educativi che offre e programmarli in ordine<br />
agli obiettivi di sviluppo e di formazione dei bambini e dei ragazzi.<br />
In questa direzione la scuola può dare il proprio contributo per la costruzione di un “sistema formativo”<br />
non solo allargato ma integrato con l’extrascuola, trasformandosi da luogo separato a luogo strettamente<br />
correlato con il terr<strong>it</strong>orio.<br />
2. IL TERRITORIO COME RISORSA FORMATIVA E LA SCUOLA COME CENTRO DI CULTURA<br />
Uscire nell’ambiente per utilizzare le molteplici opportun<strong>it</strong>à culturali significa offrire agli alunni occasioni<br />
per arricchire, ampliare, approfondire conoscenze, saperi, linguaggi.<br />
E ancora, se il rapporto della Scuola con il terr<strong>it</strong>orio non è di semplice aggregazione, ma è un rapporto di<br />
integrazione e quindi di scambio, la scuola non può lim<strong>it</strong>arsi a uscire nell’ambiente, ma dovrà a sua volta<br />
trasformarsi in un luogo di ricerca aperto verso l’esterno per socializzare la cultura prodotta al proprio interno<br />
(spettacoli – concerti – video – mostre – giornalini – libri...).<br />
3. IL TERRITORIO DELLA DESTRA ADIGE<br />
Il terr<strong>it</strong>orio della Destra Adige offre numerose risorse che possono agevolare l’azione formativa della<br />
scuola.<br />
Ricordiamo le principali:<br />
Comun Comunale, (pubblicazione periodica);<br />
Biblioteche comunali (Villa Lagarina e Nomi);<br />
Scuola Musicale di Villa Lagarina;<br />
Banda Musicale di Pomarolo;<br />
S<strong>it</strong>i preistorici di Nomi, Isera e Servis;<br />
Villa Romana di Isera;<br />
Arch<strong>it</strong>ettura romanica e medievale (le mura e i castelli di Nomi, Noarna, Pomarolo, Isera; la pieve di San<br />
Martino in Trasiel e di Sant’Antonio di Pomarolo);<br />
Arch<strong>it</strong>ettura barocca religiosa (Chiesa di Villa Lagarina, Brancolino, Chiusole) e civile (Palazzi nobiliari);<br />
Museo Diocesano di Arte Sacra;<br />
Associazioni sportive;<br />
Associazioni culturali;<br />
69
Rete dei teatri parrocchiali e delle sale polivalenti.<br />
A queste si aggiungono le strutture produttive ed economiche (industrie, aziende agricole di<br />
trasformazione, cooperative di consumo e di cred<strong>it</strong>o che continuano la tradizione cooperativistica trentina).<br />
Infine i Comuni, sempre disponibili a sostenere le proposte della scuole, ad aprire gli uffici alla vis<strong>it</strong>a dei<br />
ragazzi, a collaborare alla realizzazione delle attiv<strong>it</strong>à.<br />
4. IL TERRITORIO DEL COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA<br />
Alla ricchezza del terr<strong>it</strong>orio della Destra Adige si aggiunge la ricchezza del terr<strong>it</strong>orio del Comprensorio<br />
della Vallagarina ed in particolare di Rovereto:<br />
la rete museale (MART, Museo civico, Museo storico della Guerra);<br />
le iniziative culturali (teatro per ragazzi, percorsi musicali);<br />
i percorsi di educazione ambientale (A.S.M. – Museo Civico – P.A.T.);<br />
la rete dei castelli (Sabbionara – Besenello).<br />
5. LA DESTRA ADIGE, IL C10 E OLTRE...<br />
La ricchezza del terr<strong>it</strong>orio non si esaurisce dentro i confini della Destra Adige e del C10; per questo la<br />
scuola elabora <strong>it</strong>inerari e percorsi che abbracciano un orizzonte più ampio, fino ad interessare il Mondo,<br />
innanzi tutto con lo studio della storia e della geografia e poi anche con qualche specifico <strong>it</strong>inerario che può<br />
interessare l’intero terr<strong>it</strong>orio nazionale o i paesi dell’Europa.<br />
6. USCITE FORMATIVE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE: ALCUNE<br />
OPPORTUNITÀ PER LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO<br />
La conoscenza del terr<strong>it</strong>orio e del rapporto tra gli uomini e l’ambiente, lo sviluppo delle capac<strong>it</strong>à<br />
descr<strong>it</strong>tive, la promozione dello spir<strong>it</strong>o cr<strong>it</strong>ico sono abil<strong>it</strong>à e competenze che la scuola persegue anche<br />
attraverso le usc<strong>it</strong>e formative, le vis<strong>it</strong>e guidate e i viaggi di istruzione.<br />
Peraltro sono esperienze significative, non solo in ordine allo sviluppo delle conoscenze e dei processi<br />
cogn<strong>it</strong>ivi ma anche in ordine alla qual<strong>it</strong>à delle relazioni interpersonali e alla capac<strong>it</strong>à di sapersi organizzare e<br />
orientare in s<strong>it</strong>uazioni diverse dall’amb<strong>it</strong>o scolastico.<br />
Tutte queste iniziative sono previste dal regolamento di ist<strong>it</strong>uto al quale si rinvia.<br />
In generale è opportuno che alle/gli alunne/i sia proposto un curricolo extrascolastico che<br />
abbia una sua logica costante e progressiva, partendo dall’esplorazione del terr<strong>it</strong>orio circostante<br />
le scuole, considerato in tutti i suoi aspetti, geografici, paesaggistici, artistici, storicoantropologici,<br />
sociali ed economici. Passando poi ad estendere il raggio dei movimenti verso mete<br />
sempre più distanti, fino alle dimensioni nazionale ed europea<br />
Le usc<strong>it</strong>e di più giorni sono da collocarsi in linea di massima una al termine del ciclo della<br />
scuola primaria ed una al termine del ciclo della scuola secondaria di secondo grado (media) e,<br />
comunque, non sono previste più di un’esperienza di soggiorno formativo per ciclo.<br />
Diversa considerazione va fatta per i soggiorni linguistici che l’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> intende proporre come<br />
consuetudine durante tutte le estati, fuori dal calendario dal curricolo scolastico obbligatorio,<br />
come opportun<strong>it</strong>à formativa di valore strategico, tenendo conto di definire proposte accessibili<br />
sootto il profilo economico.<br />
70
L'ATTIVITÀ MOTORIA E L'EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA<br />
NELLA SCUOLA DI BASE<br />
1. PREMESSA<br />
A partire dall’anno scolastico 1999-2000 i docenti della scuola elementare e della scuola media hanno<br />
iniziato un percorso comune nel campo dell’educazione motoria.<br />
Questa scelta, alla luce della normativa sull'ist<strong>it</strong>uzione di un nuovo percorso formativo per la scuola di<br />
base, risulta non solo orientata al futuro ma anche pedagogicamente motivata: l’esperienza conferma infatti<br />
che alcune difficoltà motorie dei ragazzi, la mancanza di autonomia nell'affrontare nuove e più complesse<br />
esperienze, lo scarso interesse a praticare attiv<strong>it</strong>à fisica sono quasi sempre dovute alla carenza di un<br />
intervento mirato durante i primi anni di scuola. Determinati apprendimenti motori, e quindi la strutturazione<br />
dei relativi schemi cogn<strong>it</strong>ivi di riferimento, trovano terreno fertile in una fascia d'età anteriore alla scuola<br />
media. Ignorare questo aspetto e quindi non intervenire con un progetto strutturato e mirato fin dai primi<br />
anni scolastici significa ignorare (oppure delegare a agenzie esterne al mondo della scuola - alle società<br />
sportive o altro) una parte non indifferente dello sviluppo del bambino e del ragazzo. E ignorare questo<br />
aspetto significa pure correre il rischio di causare una sorta di analfabetismo motorio che molto difficilmente<br />
si potrà recuperare successivamente. Essere analfabeti sul piano motorio significa non solo compromettere<br />
apprendimenti motori più complessi, ma anche pregiudicare defin<strong>it</strong>ivamente l'emergere di un corretto<br />
schema corporeo e quindi l'acquisizione di una precisa immagine di sé.<br />
Questo progetto vede i docenti di educazione fisica della scuola media collaborare con i docenti della<br />
scuola primaria nella programmazione didattica degli interventi e, per le sedi di Villa Lagarina e Pomarolo,<br />
anche nella conduzione dell’attiv<strong>it</strong>à didattica in palestra. In prospettiva l’orientamento è quello di allargare<br />
l’iniziativa anche ai plessi di Nomi e di Nogaredo.<br />
2. SCUOLE PRIMARIE<br />
Dall’anno scolastico 2002/03 l’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> ha ader<strong>it</strong>o alla sperimentazione prevista dall’intesa PAT – CONI per<br />
l’insegnamento dell’educazione motoria con l’utilizzazione degli esperti nelle classi I, II e III delle scuole<br />
primarie.<br />
Per le classi IV e V l’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> ha ader<strong>it</strong>o al progetto organizzato e finanziato dai Comuni consorziati<br />
denominato “SCUOLA E SPORT”.<br />
3. SCUOLA SECONDARIA DI I° - MEDIA<br />
L’educazione motoria e sportiva dovrebbe offrire agli alunni un ventaglio, il più ampio possibile, di esperienze<br />
motorie, anche agonistiche, per permettere loro non solo di arricchire il bagaglio tecnico-motorio personale,<br />
ma di acquisire la capac<strong>it</strong>à di mettersi in gioco, di usare le loro risorse migliori in modo corretto, di sapersi<br />
accettare sempre nella v<strong>it</strong>toria come nella sconf<strong>it</strong>ta.<br />
A questo scopo, la nostra scuola intende dare l’opportun<strong>it</strong>à alle ragazze e ai ragazzi di apprendere e<br />
praticare, anche in forma agonistica, alcune discipline sportive, attraverso le attiv<strong>it</strong>à di avviamento alla<br />
pratica sportiva indicate nel “<strong>Progetto</strong> di attiv<strong>it</strong>à sportiva scolastica 2005/06”.<br />
72
PROGETTO PER LE ATTIVITA’ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA<br />
L’educazione motoria e sportiva dovrebbe offrire agli alunni un ventaglio, il più ampio possibile, di esperienze<br />
motorie, anche agonistiche, per permettere loro non solo di arricchire il bagaglio tecnico-motorio personale,<br />
ma di acquisire la capac<strong>it</strong>à di mettersi in gioco, di usare le loro risorse migliori in modo corretto, di sapersi<br />
accettare sempre nella v<strong>it</strong>toria come nella sconf<strong>it</strong>ta.<br />
A questo scopo, la nostra scuola intende dare l’opportun<strong>it</strong>à alle ragazze e ai ragazzi di apprendere e<br />
praticare, anche in forma agonistica, alcune discipline sportive, attraverso le seguenti attiv<strong>it</strong>à di avviamento<br />
alla pratica sportiva.<br />
PROPOSTE ATTIVITA’ SPORTIVA SCOLASTICA <strong>2006</strong>/07<br />
periodo<br />
Avviamento alla<br />
pratica sportiva<br />
Attiv<strong>it</strong>à agonistica<br />
scolastica<br />
Progetti interdisciplinari<br />
Attiv<strong>it</strong>à<br />
opzionali<br />
settembre<br />
ottobre<br />
Eserc<strong>it</strong>azioni,<br />
percorsi, circu<strong>it</strong>i<br />
per lo sviluppo<br />
della capac<strong>it</strong>à di<br />
resistenza in<br />
preparazione alla<br />
corsa campestre di<br />
ist<strong>it</strong>uto e<br />
comprensoriale<br />
Torneo scolastico di<br />
pallapugno cl. II<br />
La capac<strong>it</strong>à di resistenza:<br />
aspetti scientifici e tecnici<br />
cl.III<br />
Elaborazione dei dati “test<br />
Cooper” e “test di<br />
recupero”:<br />
grafici,istogrammi,<br />
aerogrammi.<br />
Mountain bike<br />
novembre<br />
dicembre<br />
gennaio<br />
febbraio<br />
marzo<br />
Preparazione<br />
squadre di<br />
pallavolo femminile<br />
in previsione dei<br />
G.S.S<br />
Preparazione<br />
squadre per i<br />
G.S.S. di<br />
pallatamburello<br />
badminton<br />
Torneo scolastico di<br />
pallacanestro cl. I<br />
Corsa campestre di ist<strong>it</strong>uto<br />
Corsa campestre<br />
comprensoriale e provinciale<br />
G.S.S. di<br />
pallavolo femminile<br />
pallatamburello<br />
sci alpino<br />
Tornei scolastici di:<br />
pallatamburello cl. III e<br />
badminton<br />
Olimpiadi della Danza per la<br />
scuola<br />
“Un altro modo di correre,<br />
un altro modo di vedere”<br />
<strong>Progetto</strong> formativo in<br />
collaborazione con il C.I.P.<br />
(Com<strong>it</strong>ato Italiano<br />
Paralimpico). Percorso di<br />
conoscenza e<br />
sensibilizzazione nei<br />
confronti dello sport per<br />
atleti “diversamente abili”<br />
“I giovani e la montagna”<br />
(trekking con le ciaspole: i<br />
r<strong>it</strong>mi della natura nella<br />
dimensione invernale) cl. I<br />
Danza<br />
Sci alpino e<br />
snow<br />
aprile<br />
maggio<br />
Preparazione<br />
squadre per i<br />
G.S.S. di<br />
pallapugno<br />
Preparazione Palio<br />
di atletica leggera<br />
G.S.S. di<br />
badminton<br />
pallapugno<br />
ciclismo<br />
Palio di atletica leggera<br />
Miglio Lagarino (corsa su<br />
strada)<br />
Mountain-bike<br />
73
LABORATORIO SPORTIVO <strong>2006</strong>/2007<br />
TIPOLOGIA DEL<br />
LABORATORIO<br />
OBBIETTIVI SPECIFICI DI<br />
APPRENDIMENTO<br />
CONTENUTI<br />
COMPETENZE IN USCITA<br />
DANZA / STEP<br />
• miglioramento di capac<strong>it</strong>à coordinative<br />
• sviluppo della percezione r<strong>it</strong>mica<br />
• stimolo alla creativ<strong>it</strong>à collettiva<br />
• i principali passi base, gli approcci<br />
direzionali<br />
• brevi sequenze di passi utilizzando<br />
i diversi approcci direzionali<br />
• brevi coreografie con la musica<br />
• elaborazione di una coreografia<br />
collettiva su base musicale hip-hop<br />
• saper modulare gesti e spostamenti<br />
nello spazio in sintonia con l’elemento<br />
r<strong>it</strong>mico<br />
• saper usare il linguaggio del corpo<br />
utilizzando vari codici espressivi<br />
MOUNTAIN-BIKE<br />
• consolidamento di capac<strong>it</strong>à condizionali<br />
• affinamento di capac<strong>it</strong>à coordinative<br />
• apprendimento di tecniche specifiche<br />
rifer<strong>it</strong>e alla conduzione della MTB<br />
• apprendimento di regole e<br />
comportamenti per muoversi in<br />
sicurezza in ambiente naturale ed<br />
artificiale<br />
• principali elementi di ed. stradale<br />
• caratteristiche e manutenzione<br />
della M.T.B.<br />
• eserc<strong>it</strong>azioni dalle più semplici alle<br />
più complesse su percorsi di abil<strong>it</strong>à<br />
di conduzione<br />
• percorsi in ambiente naturale<br />
• saper modulare gli schemi motori<br />
secondo r<strong>it</strong>mi, spazi ed equilibri specifici<br />
della conduzione della MTB<br />
• saper gestire in modo consapevole<br />
abil<strong>it</strong>à specifiche rifer<strong>it</strong>e a particolari<br />
s<strong>it</strong>uazioni tecniche<br />
• saper mettere in atto comportamenti<br />
sportivi usando razionalmente capac<strong>it</strong>à<br />
e rispettando lim<strong>it</strong>i individuali<br />
ATTIVITA’ INTEGRATIVA SPORTIVA <strong>2006</strong>/2007<br />
TIPOLOGIA DEL<br />
LABORATORIO<br />
OBBIETTIVI SPECIFICI DI<br />
APPRENDIMENTO<br />
CONTENUTI<br />
COMPETENZE IN USCITA<br />
LO SCI<br />
EDUCATIVO<br />
• acquisizione e coordinamento di schemi<br />
motori<br />
• affinamento di capac<strong>it</strong>à coordinative<br />
• apprendimento di tecniche specifiche<br />
dello sci alpino<br />
• apprendimento di regole e<br />
comportamenti per muoversi in<br />
sicurezza sugli sci<br />
• approccio alle prime tecniche dello<br />
sci alpino per principianti<br />
• eserc<strong>it</strong>azioni tecniche specifiche<br />
per il livello superiore<br />
• saper modulare gli schemi motori<br />
secondo r<strong>it</strong>mi, spazi ed equilibri specifici<br />
dello sci alpino<br />
• saper gestire in modo consapevole<br />
abil<strong>it</strong>à specifiche rifer<strong>it</strong>e a particolari<br />
s<strong>it</strong>uazioni tecniche<br />
• saper mettere in atto comportamenti<br />
sportivi usando razionalmente capac<strong>it</strong>à<br />
e rispettando lim<strong>it</strong>i individuali<br />
74
COMPETENZE IN USCITA<br />
- sapere utilizzare efficacemente capac<strong>it</strong>à condizionali e coordinative, secondo i propri livelli di<br />
apprendimento, di maturazione e di sviluppo<br />
- saper gestire in modo consapevole abil<strong>it</strong>à specifiche rifer<strong>it</strong>e a s<strong>it</strong>uazioni tecniche e tattiche negli sport<br />
individuali e di squadra<br />
- saper risolvere in forma creativa e originale, pur nel rispetto delle regole, s<strong>it</strong>uazioni tattiche più o<br />
meno complesse, arricchendo il proprio bagaglio di esperienze motorie e sportive.<br />
- sapersi relazionare pos<strong>it</strong>ivamente con il gruppo rispettando le diverse capac<strong>it</strong>à, le esperienze<br />
pregresse e le caratteristiche personali<br />
- saper mettere in atto comportamenti equilibrati dal punto di vista fisico, emotivo e cogn<strong>it</strong>ivo<br />
- saper rispettare le regole delle discipline sportive praticate, assumendo sempre comportamenti<br />
sportivi adeguati.<br />
76
LE LINGUE STRANIERE<br />
Nelle sedi delle scuole primarie dell’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> Comprensivo di Villa Lagarina è attivato l’insegnamento della<br />
lingua tedesca o inglese: la prima nelle sedi di Nogaredo e Nomi, la seconda nelle sedi di Villa Lagarina e<br />
Pomarolo; nella scuola media vengono insegnate entrambe le lingue.<br />
L’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> è in grado di garantire l’insegnamento di una prima lingua straniera a partire dalla prima classe<br />
primaria e di una seconda lingua straniera a partire dalla prima media, operando per assicurare la continu<strong>it</strong>à<br />
di apprendimento della prima lingua nel corso degli otto anni della scuola dell’obbligo. Per entrambe le<br />
lingue, la continu<strong>it</strong>à di insegnamento nel metodo e nei contenuti è in ogni caso favor<strong>it</strong>a dalla costante<br />
collaborazione tra gli insegnanti dei due ordini di scuola.<br />
LA SCUOLA PRIMARIA<br />
Si segue un approccio di tipo comunicativo, atto a mettere l’alunno in condizione di acquisire modelli di<br />
comportamento linguistico in contesti d’uso, riuscendo così a creare una s<strong>it</strong>uazione di apprendimento<br />
appassionante e coinvolgente che incoraggia negli alunni un atteggiamento pos<strong>it</strong>ivo nei confronti della lingua<br />
straniera. In particolare per i bambini più piccoli vengono scelte attiv<strong>it</strong>à tali da incontrare i loro interessi e<br />
gusti, privilegiando quelle di tipo ludico e motorio, di manipolazione, drammatizzazione, canto e mimo,<br />
sempre tenendo conto delle abil<strong>it</strong>à logico-linguistiche via via in loro possesso. Con gli alunni più esperti si<br />
scelgono attiv<strong>it</strong>à che comportano la comprensione di comandi, esortazioni, conversazioni, narrazioni e<br />
descrizioni orali attraverso media differenti (voce dell’insegnante e di adulti di madre lingua, TV, registratore,<br />
videoregistratore, cd–rom); la lettura di testi in adozione o selezionati dall’insegnante tratti da libri illustrati<br />
per ragazzi, da riviste e quotidiani, dai materiali inviati per corrispondenza ad altre scuole; la partecipazione<br />
a dialoghi e conversazioni guidate, spontanee, preferibilmente a piccoli gruppi; la realizzazione di lettere,<br />
cartelloni, biglietti e registrazioni riferibili a celebrazioni e festiv<strong>it</strong>à e ad altri aspetti di v<strong>it</strong>a quotidiana.<br />
Gli obiettivi linguistici sono elaborati in relazione a funzioni linguistiche di tipo trasversale (identificare,<br />
descrivere, chiedere qualcosa...) che l’alunno usa quotidianamente nella lingua materna, che impiegano un<br />
numero ristretto di strutture linguistiche, presentate in modo ciclico con argomenti diversi, che fanno<br />
riferimento a una gamma di argomenti vicini agli interessi, ai bisogni formativi dell’alunno (propria ident<strong>it</strong>à,<br />
preferenze, azioni, personaggi, sport, attiv<strong>it</strong>à nel tempo libero, ambienti...) e alle curios<strong>it</strong>à verso culture<br />
diverse dalla propria.<br />
Grande importanza viene data agli obiettivi att<strong>it</strong>udinali: le attiv<strong>it</strong>à associate all’uso della lingua straniera<br />
mirano a essere fonte di divertimento e di partecipazione, facendo leva su curios<strong>it</strong>à e aspettative, favorendo<br />
il coinvolgimento diretto di ciascuno e attenuando l’impatto linguistico con opportune strategie visive e<br />
mimico-gestuali allo scopo di favorire la comprensione.<br />
Si vuole stimolare la capac<strong>it</strong>à degli alunni di cogliere il senso del discorso a fronte di risorse linguistiche<br />
ancora lim<strong>it</strong>ate, valorizzando la loro capac<strong>it</strong>à di apprendere in maniera indiretta, l’istinto del gioco e del<br />
divertimento, il ruolo dell’immaginazione, l’istinto di interagire e di parlare. Con il progressivo uso attivo della<br />
lingua straniera nelle s<strong>it</strong>uazioni scolastiche quotidiane (es. comandi e espressioni usati da insegnante e<br />
alunni nel corso delle attiv<strong>it</strong>à) si vuole favorire l’acquisizione graduale di altri elementi linguistici oltre a quelli<br />
direttamente presentati nelle un<strong>it</strong>à didattiche, dando motivazione forte alla comprensione e all’uso della<br />
lingua in contesti significativi collegati ad azioni concrete.<br />
LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - MEDIA<br />
La metodologia che si r<strong>it</strong>iene più valida nell'insegnamento della lingua straniera è una metodologia di<br />
tipo funzionale-comunicativo. In breve: i ragazzi apprendono, prima globalmente, ad esporre in lingua le<br />
varie funzioni linguistiche e, solo in un secondo tempo, ne analizzano gli esponenti linguistici. Apprendono<br />
quindi dei "comportamenti comunicativi" che solo nel momento della riflessione vengono analizzati nei loro<br />
elementi cost<strong>it</strong>utivi. Nel proporre un nuovo argomento si seguono sol<strong>it</strong>amente queste fasi:<br />
Fase di presentazione. Nell'affrontare ogni nuova "s<strong>it</strong>uazione formativa" si devono indicare agli alunni<br />
quale sarà la s<strong>it</strong>uazione comunicativa e le funzioni linguistiche che si stanno per presentare ("Oggi<br />
impareremo a …", "Oggi parleremo di …" ecc.). Questo momento è molto importante in quanto gli alunni<br />
devono sempre sapere che cosa si sta per fare e perché si fa. E' in questa prima fase che l'insegnante<br />
deve attivare la motivazione. Può introdurre brevemente la s<strong>it</strong>uazione in <strong>it</strong>aliano, inv<strong>it</strong>ando gli allievi,<br />
soprattutto ai livelli iniziali, a guardare solo le immagini sul libro di testo e a fare commenti e previsioni<br />
sugli avvenimenti e sui vocaboli ad essi collegati.<br />
Fase di pratica. Dopo il lavoro di comprensione del dialogo iniziale (ascolto con il registratore,<br />
ripetizione, lettura drammatizzata, ecc.), si passa a svolgere le attiv<strong>it</strong>à di riutilizzo immediato delle<br />
77
strutture chiave e delle funzioni linguistiche presentate nel dialogo appena incontrato. Questa fase è in<br />
genere molto 'controllata' in quanto i ragazzi devono eseguire oralmente degli scambi in forma di<br />
dialogo, partendo da un modello forn<strong>it</strong>o. Queste attiv<strong>it</strong>à si possono anche impostare a coppie o a gruppi.<br />
Lavorando in coppia gli alunni si aiutano a vicenda, si elimina il problema dei soggetti timidi oppure<br />
troppo esuberanti e, soprattutto, si dà a tutti l'opportun<strong>it</strong>à di parlare<br />
Fase di reimpiego L'obiettivo dei ragazzi in questa fase deve essere quello di comunicare. Tra le attiv<strong>it</strong>à<br />
orali che si possono proporre c'è la costruzione o il completamento di dialoghi ed il gioco di ruoli.<br />
L'alunno, a questo punto, si troverà più libero di usare la lingua. Le abil<strong>it</strong>à che qui si sviluppano sono sia<br />
orali (nel caso di dialoghi a voce, di brevi presentazioni, ecc.) che scr<strong>it</strong>te (è il caso di brevi composizioni,<br />
di completamento di dialoghi, ecc.)<br />
Riflessione sulla lingua. Viene svolta alla fine di ogni un<strong>it</strong>à in quanto deve essere intesa come un<br />
riepilogo del continuo lavoro di riflessione sul materiale linguistico che viene svolto in classe. Arrivati a<br />
questo punto, la struttura da acquisire è già stata utilizzata dai ragazzi negli esercizi di fissazione e di<br />
reimpiego svolti nelle fasi precedenti. Si tratta ora di riflettere sul suo meccanismo. Si procede pertanto<br />
presentando la grammatica secondo un metodo induttivo in quanto è un punto di arrivo e di conquista<br />
'razionale' dell'allievo. Solo dopo che questa formalizzazione è stata esposta direttamente dai ragazzi, si<br />
può ricorrere a schemi, specchietti, regole.<br />
Per favorire lo studio delle lingue straniere, vengono offerte agli alunni opportun<strong>it</strong>à diversificate:<br />
1. Aula multimediale: il computer permette di mescolare il "lavoro" ed il "gioco" utilizzando le<br />
moderne tecnologie in chiave didattica senza però dimenticare, nello stesso tempo, quella ludica.<br />
2. Videocassette: la visione di contesti reali stimola gli studenti verso la comunicazione in quanto il<br />
materiale proposto è spesso molto interessante e susc<strong>it</strong>a curios<strong>it</strong>à.<br />
3. Materiale autentico: guide turistiche, cartine, giornali, riviste e giornalini adatti ai ragazzi,<br />
vivacizzano le lezioni ed offrono lo stimolo ad interagire in modo attivo, piacevole e divertente.<br />
4. Insegnante di madrelingua: l'opportun<strong>it</strong>à di confrontarsi con un insegnate diverso da quello di<br />
classe e proveniente dal paese della lingua studiata, stimola la curios<strong>it</strong>à degli studenti e favorisce<br />
l'accrescimento del bagaglio lessicale e l'ampliamento delle conoscenze di civiltà. Si valuta quindi<br />
opportuno riproporre tale esperienza nell'amb<strong>it</strong>o delle ore curricolari.<br />
Realizzato a livello sperimentale, l'intervento della madrelingua, valutato estremamente pos<strong>it</strong>ivo,<br />
vuole diventare un progetto a lungo termine. Pertanto si r<strong>it</strong>iene opportuno offrire l'opportun<strong>it</strong>à di un<br />
ampliamento ed approfondimento dello studio della lingua straniera attraverso la realizzazione di<br />
laboratori bimestrali (aperti a tutti gli alunni dell'<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong>) attivati sempre con la collaborazione di un<br />
esperto di madrelingua con il quale l'insegnante di classe studierà un percorso mirato e differenziato<br />
da quello già svolto in classe, così da non penalizzare chi non dovesse partecipare.<br />
5. Certificazioni: la scuola organizza tutti gli anni dei percorsi di preparazione alle certificazioni FIT 1<br />
per la lingua tedesca con Goethe Inst<strong>it</strong>ut e KET per la lingua inglese con l’Univers<strong>it</strong>y of Cambridge.<br />
6. Soggiorni estivi: ogni anno la scuola organizza soggiorni in area linguistica tedesca, al momento,<br />
per alunni dalla classe quarta primaria alla classe terza media.<br />
Pur tenendo in considerazione le necessarie differenze metodologiche e didattiche principalmente legate alle<br />
diverse età evolutive degli alunni, tra la scuola primaria e la scuola media, vengono persegu<strong>it</strong>i in modo<br />
comune alcuni obiettivi fondamentali:<br />
coinvolgere emotivamente e intellettualmente l’alunno nell’apprendimento di un nuovo codice linguistico;<br />
sviluppare curios<strong>it</strong>à nei riguardi di lingue e culture diverse;<br />
<br />
<br />
maturare un atteggiamento di apertura e di rispetto nei confronti della divers<strong>it</strong>à;<br />
cogliere la necess<strong>it</strong>à e l’util<strong>it</strong>à della conoscenza delle lingue straniere, in quanto strumenti di<br />
comunicazione.<br />
RISORSE UMANE<br />
Oltre all'obiettivo generale di garantire la qual<strong>it</strong>à complessiva dei processi di insegnamento-apprendimento<br />
nel campo delle conoscenze delle lingue straniere, l'<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> si propone di assicurare:<br />
la continu<strong>it</strong>à di apprendimento della prima lingua nel corso degli otto anni dell'attuale "scuola di base",<br />
possibilmente anche sotto il profilo organizzativo, attraverso la cost<strong>it</strong>uzione di classi o gruppi omogenei,<br />
almeno nella prima classe della scuola media, in relazione alla lingua studiata nella scuola primaria;<br />
la realizzazione di laboratori linguistici, a cadenza bimestrale, aperti a tutti gli alunni della scuola media e<br />
attivati con la collaborazione di un esperto di madrelingua;<br />
la valorizzazione delle settimane linguistiche e gli scambi culturali, anche attraverso gemellaggi con altre<br />
scuole e l'organizzazione di soggiorni formativi all'estero, oltre che in Alto Adige; per queste iniziative la<br />
scuola potrà avvalersi anche dell'intervento finanziario della Provincia e della Regione.<br />
Per raggiungere questi obiettivi l'<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> deve poter contare sulla presenza di un organico adeguato, nonché<br />
di un adeguato finanziamento sul fondo per il miglioramento della qual<strong>it</strong>à della scuola.<br />
78
I LABORATORI MULTIMEDIALI<br />
PREMESSA<br />
Nella Scuola Media “Anna Frank” e nelle primarie di Villa Lagarina, Pomarolo, Nogaredo e Nomi sono in<br />
funzione dall’anno scolastico 2005/06 e regolarmente utilizzati nelle attiv<strong>it</strong>à didattiche sei laboratori<br />
multimediali, dotati di computer in rete, collegamento Internet, e di opportune attrezzature multimediali5. Si<br />
tratta di spazi e strumenti utilizzati da insegnanti ed alunni in misura sempre più efficace e appropriata,<br />
secondo un orientamento didattico che punta a rinforzare e ad estendere l’alfabetizzazione di base degli<br />
alunni nei confronti dell’impiego del computer e ad un utilizzo ragionato dei linguaggi visivi e sonori associati<br />
ai contenuti delle discipline.<br />
Fin dalla loro prima attivazione, e via via nel corso del tempo, i laboratori multimediali si sono dimostrati<br />
strumenti didattici necessari e irrinunciabili, favorendo importanti processi d’apprendimento, tanto<br />
individualizzato quanto riferibile ad esperienze di lavoro di alunni in gruppo; non secondariamente, essi sono<br />
anche risorse preziose per i docenti dell’intero <strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong>, per le innumerevoli attiv<strong>it</strong>à di produzione,<br />
archiviazione, consultazione e aggiornamento che essi consentono.<br />
Il Collegio dei docenti ha sempre mostrato sensibil<strong>it</strong>à all’innovazione, cogliendo la potenzial<strong>it</strong>à delle<br />
nuove tecnologie nell’attiv<strong>it</strong>à didattica. Negli ultimi anni sono stati attivati corsi di aggiornamento con<br />
l’obiettivo di mettere i docenti in grado di utilizzare in modo adeguato gli strumenti informatici presenti nelle<br />
scuole e di diffonderne l’impiego nella quotidiana pratica didattica. Questo obiettivo è stato in gran parte<br />
raggiunto e un buon numero di docenti, in collaborazione con l’operatore, è oggi in grado di usare con le<br />
classi i laboratori avvalendosi, nella programmazione disciplinare o in progetti interdisciplinari, di pacchetti<br />
informatici a supporto dell'attiv<strong>it</strong>à.<br />
L’uso sempre più esteso dei laboratori d’informatica da parte di insegnanti delle diverse materie e di<br />
alunni di tutte le classi, e la crescente compless<strong>it</strong>à delle attrezzature disponibili, hanno fatto sorgere la<br />
necess<strong>it</strong>à di poter contare sulla presenza costante di operatori esperti o di insegnanti referenti di laboratorio,<br />
in grado di gestire s<strong>it</strong>uazioni oggettivamente sempre più impegnative sotto il profilo tecnico e di offrire<br />
contributi specifici di supporto all’attiv<strong>it</strong>à didattica.<br />
In questo amb<strong>it</strong>o l'operatore tecnologico e l’insegnante referente di laboratorio:<br />
- collaborano con i docenti per individuare diverse strategie di apprendimento e progettare e organizzare<br />
percorsi operativi, utilizzando i linguaggi multimediali e la strumentazione dei laboratori;<br />
- sono presenti durante le attiv<strong>it</strong>à e seguono assieme agli insegnanti di classe quegli alunni che richiedono<br />
un aiuto individualizzato, soprattutto nell’amb<strong>it</strong>o dell’informatica;<br />
- gestiscono e rendono possibile l’utilizzo delle aule multimediali e del laboratorio linguistico,<br />
predisponendo tutte le attrezzature necessarie alle attiv<strong>it</strong>à e controllandone il regolare funzionamento;<br />
- sono responsabili dell’aggiornamento dei programmi informatici in continua evoluzione e così facil<strong>it</strong>ano i<br />
docenti nella scelta delle opzioni più adatte all’insegnamento;<br />
- sono punto di riferimento per i docenti che, non avendo conoscenze specifiche o aggiornate, possono<br />
chiedere chiarificazioni;<br />
- seguono piccoli gruppi o singoli alunni nel recupero o nel potenziamento di specifiche abil<strong>it</strong>à;<br />
- gestiscono e organizzano la biblioteca e la videoteca di <strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> con cr<strong>it</strong>eri di ordinamento e classificazione<br />
informatici;<br />
- coordinano corsi di aggiornamento nell’area informatica, con la possibil<strong>it</strong>à di coinvolgere anche altre<br />
scuole;<br />
- coordinano le attiv<strong>it</strong>à di scambio in rete con altre scuole e la diffusione dei materiali via via prodotti.<br />
L’informatica è diventata per la scuola una risorsa forte. Molti programmi didattici offrono una grafica<br />
stimolante ed utilizzano il gioco come stimolo a nuove conoscenze. L’uso dei software didattici con studenti in<br />
difficoltà d'apprendimento presenta una serie di vantaggi da non trascurare: il primo, e forse più importante,<br />
è quello legato agli aspetti motivazionali del mezzo informatico; il secondo consiste nel fatto che il computer<br />
si presta particolarmente bene all’uso di percorsi didattici molto strutturati; il terzo è legato al forte senso di<br />
autostima che l’impiego di uno strumento comunemente usato da persone adulte e intelligenti può<br />
incrementare nell’alunno.<br />
79
L’utilizzo frequente ed adeguato del laboratorio informatico e multimediale nella pratica didattica<br />
quotidiana permette a ogni alunno di:<br />
- avvicinarsi ad un uso appropriato degli strumenti informatici;<br />
- acquisire competenze disciplinari sperimentando contenuti e percorsi metodologici diversi;<br />
- utilizzare l’informatica per il superamento di difficoltà d'apprendimento;<br />
- ricercare informazioni seguendo percorsi differenziati;<br />
- individuare propri percorsi all’interno di una determinata struttura di dati fino ad arrivare all’informazione<br />
desiderata;<br />
- strutturare gerarchicamente una serie di operazioni per un approccio razionale e produttivo in relazione a<br />
una specifica s<strong>it</strong>uazione problematica;<br />
- seguire proprie intuizioni e non im<strong>it</strong>are sempre le scelte altrui;<br />
- imparare a utilizzare Internet a scopo didattico e di ricerca;<br />
- saper utilizzare nuove tecnologie nella stesura di propri documenti, ipertesti e materiali di varia util<strong>it</strong>à.<br />
I LABORATORI MULTIMEDIALI NELLA SCUOLA PRIMARIA<br />
La comunicazione audiovisiva riveste un ruolo fondamentale nella nostra epoca e nella nostra società,<br />
con profonda incidenza sui comportamenti e sugli aspetti cogn<strong>it</strong>ivi di ciascuno, tanto da ispirare nella scuola<br />
primaria interventi specifici mirati ad avvicinare gli alunni alla lettura, all’approfondimento e alla<br />
contestualizzazione del messaggio audiovisivo e farne oggetto di comprensione e di conoscenza.<br />
Con i bambini più piccoli vengono realizzate esperienze di fruizione collettiva, guidata e ragionata,<br />
frazionabile nel tempo e in sequenze di significato, per imparare a utilizzare il televisore e il videoregistratore<br />
senza sottostare all’invadenza del r<strong>it</strong>mo televisivo; aree tematiche privilegiate sono da sempre quelle<br />
dell’arte, della natura, delle culture dei popoli, così come l’ecologia, le scienze, la geografia e la storia. La<br />
multimedial<strong>it</strong>à legata all’impiego del computer – anche per accedere ad Internet - e del cd-rom riesce ad<br />
estendere ulteriormente i modi di fruizione e comprensione del messaggio audiovisivo: si guarda soprattutto<br />
alla possibil<strong>it</strong>à, per un alunno mediamente esperto, di produrre e interagire con testi, immagini, animazione,<br />
grafica, musica, suoni e video spesso simultaneamente, avendo facilmente disponibili fonti ed opere di<br />
consultazione complete ed aggiornate, aperte ad approcci disciplinari dinamici ed estremamente differenziati.<br />
Non mancano proposte didattiche orientate a una semplice ma effettiva utilizzazione del computer senza<br />
incorrere in inutili esercizi tecnici, che ne permettono un avvicinamento disinvolto e creativo da parte dei<br />
bambini, che hanno esplic<strong>it</strong>e valenze educative pur mantenendo caratteristiche proprie del gioco e che sono<br />
dunque adatte ai tempi e ai modi della scuola primaria.<br />
Le esperienze condotte in questi anni dagli insegnanti che con gli alunni hanno lavorato soprattutto nel<br />
campo della videoscr<strong>it</strong>tura, per svolgere attiv<strong>it</strong>à di raccolta e di archiviazione di immagini e disegni, con la<br />
produzione di stampati, fascicoli, avvisi e manifesti, giornalini, storie e ricerche di argomento disciplinare e<br />
interdisciplinare, e perfino alcuni semplici ipertesti dimostrano che i bambini leggono e scrivono volentieri<br />
utilizzando il computer e che sull’onda di questo piacere è possibile fare in modo che leggano e scrivano di<br />
più e meglio. Soprattutto nella creazione e nel montaggio di storie e nella documentazione di alcune un<strong>it</strong>à<br />
didattiche, il mezzo permette di interagire a vari livelli e per gradi con il testo scr<strong>it</strong>to per trarne significato e<br />
comprensione, consolidando l’idea che è possibile manipolare in modo produttivo e creativo la propria lingua<br />
e distinguere significativamente il modo di parlare rispetto alla pagina stampata.<br />
3. I LABORATORI MULTIMEDIALI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO<br />
Ogni nuovo anno scolastico segna un ulteriore sviluppo delle attiv<strong>it</strong>à informatiche nella scuola,<br />
ampliando e approfondendo i settori di intervento, soprattutto nel campo multimediale. I progetti previsti<br />
nello scorso anno scolastico sono stati puntualmente realizzati; oggi la seconda aula multimediale viene<br />
utilizzata anche per lo studio delle lingue straniere. Dopo una prima fase di prova, sono utilizzati<br />
regolarmente prodotti multimediali sia per il tedesco sia per l'inglese. L'utilizzo delle due aule, anche<br />
contemporaneamente, ha ev<strong>it</strong>ato il problema di sovrapposizione nell’utilizzo dei laboratori, garantendo a<br />
tutte le classi un adeguato numero di ore per operare in tale amb<strong>it</strong>o.<br />
Il buon funzionamento delle reti collegate ai server e l’utilizzo corretto dei laboratori multimediali<br />
richiedono naturalmente la presenza di un insegnante esperto nominato in qual<strong>it</strong>à di operatore tecnologico.<br />
I laboratori di informatica sono utilizzati sia per l’aspetto linguistico sia per quello logico-matematico e<br />
tecnico-scientifico. Con la disponibil<strong>it</strong>à del secondo laboratorio multimediale, viene ora curata con la giusta<br />
attenzione anche la lingua straniera.<br />
80
Si riassumono qui alcune delle attiv<strong>it</strong>à sperimentate nelle scuole che si continueranno anche nei<br />
prossimi anni scolastici:<br />
- costruzione di ipertesti (documenti in html) come modal<strong>it</strong>à didattica per tutte le discipline;<br />
- coordinamento di tutte le attiv<strong>it</strong>à dei vari laboratori presenti in maniera organica;<br />
- supporto ad alunni con handicap con l'utilizzo del computer mediante pacchetti applicativi adeguati: il<br />
recupero con uso di strumenti in possesso della scuola può spaziare dall'area linguistico-espressiva alla<br />
tecnico-scientifica;<br />
- sostegno di iniziative e attiv<strong>it</strong>à atte a sollec<strong>it</strong>are e promuovere la comunicazione degli alunni, mediante<br />
linguaggi multimediali;<br />
- supporto e collaborazione per la gestione di comp<strong>it</strong>i interdisciplinari programmati dai consigli di classe;<br />
- utilizzo, da parte dei docenti e delle classi, delle nuove tecnologie offerte in amb<strong>it</strong>o linguistico, come<br />
elemento fondamentale per l’apprendimento delle lingue straniere;<br />
- collaborazione continua con i docenti della scuola primaria su tematiche di volta in volta oggetto di<br />
collaborazione;<br />
- collegamento in rete con altre scuole per lo scambio di informazioni;<br />
- possibil<strong>it</strong>à per tutti gli alunni, suddivisi in gruppi e a rotazione, di ricevere un approccio con il computer,<br />
non fine a se stesso, ma usato come strumento atto a risolvere e/o facil<strong>it</strong>are e velocizzare la risoluzione<br />
di molte s<strong>it</strong>uazioni problematiche che si manifestano nei vari <strong>it</strong>inerari didattici proposti.<br />
Molti docenti hanno inser<strong>it</strong>o nella loro programmazione l’utilizzo degli strumenti informatici; in<br />
particolare sono stati attivati laboratori specifici nell’attiv<strong>it</strong>à del tempo prolungato.<br />
Nel campo linguistico, dopo l’iniziale alfabetizzazione all’uso del computer, ci si propone soprattutto di:<br />
- coinvolgere le classi nell’attiv<strong>it</strong>à collettiva di immediata gratificazione con assunzione guidata dei ruoli,<br />
divisione dei comp<strong>it</strong>i ed interventi individuali di soluzione di molteplici problemi di ideazione;<br />
- affrontare e analizzare i testi nelle loro componenti lessicali, stilistiche e fonetiche;<br />
- affrontare lo studio della lingua straniera utilizzando le nuove tecnologie multimediali.<br />
Nel campo logico-matematico ci si propone un continuo inserimento nei diversi livelli della dinamica cogn<strong>it</strong>iva<br />
(percezione, rappresentazione, formalizzazione, analisi, sintesi, valutazione ecc.) articolandone il ruolo<br />
reciproco e l’approfondimento in modo adeguato alle competenze e alle capac<strong>it</strong>à degli alunni.<br />
Altri progetti attivati nel corso degli anni riguardano l’adesione al piano di sviluppo delle tecnologie<br />
didattiche della Provincia Autonoma di Trento, le iniziative legate al progetto di educazione alla salute, il<br />
Giornalino "Vucumprà", la creazione di un s<strong>it</strong>o web dell’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong>, la realizzazione di ipertesti e la<br />
partecipazione a concorsi, l’elaborazione e l’analisi dei test di ingresso, la collaborazione didattica tra i due<br />
ordini di scuola.<br />
4. RISORSE UMANE<br />
Dall’anno scolastico 1998-99 il Circolo didattico di Villa Lagarina e la Scuola Media “Anna Frank” (oggi<br />
<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> comprensivo un<strong>it</strong>ario) hanno potuto avvalersi della collaborazione di un operatore tecnologico, di un<br />
tecnico di laboratorio e di alcuni docenti esperti.<br />
La compless<strong>it</strong>à delle conoscenze tecniche richieste, la plural<strong>it</strong>à delle funzioni assolte dalle aule<br />
multimediali nella didattica quotidiana, l’uso sempre più esteso dei laboratori da parte degli insegnanti e<br />
degli alunni di tutte le classi richiedono, anche per i prossimi anni, di poter contare sulla presenza costante e<br />
a tempo pieno di un insegnante che sappia intrecciare competenze didattiche e competenze tecnicoscientifiche<br />
e di uno o due insegnanti referenti di laboratorio (per questi ultimi è forse opportuno pensare ad<br />
una riduzione del loro orario di insegnamento nelle materie curriculari, o comunque a un adeguato<br />
riconoscimento nell’amb<strong>it</strong>o del fondo di <strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong>).<br />
81
DOTAZIONE INFORMATICA DELL’ISTITUTO<br />
SCUOLA MEDIA "A.FRANK"<br />
N. 2 LABORATORI INFORMATICA:<br />
1 Server<br />
Locale in cui si trova: laboratorio di informatica 1<br />
collegamento in rete locale: sì<br />
collegamento in rete pubblica: sì<br />
sistema operativo utilizzato: Windows Server 2003<br />
sistema di protezione del sistema: account con password, AVG Free Antivirus<br />
componenti fondamentali: 2 stampanti laser e 2 deskjet colori in rete, 2 scanner, 2<br />
video proiettori<br />
software: Outlook, I.E. 6, Acrobat Reader, 7–Zip, PDF Creator<br />
29 computer Alunno<br />
Locali in cui si trovano: laboratori di informatica 1 e 2 e aula video<br />
collegamento in rete locale: sì<br />
collegamento in rete pubblica: sì<br />
sistema operativo utilizzato: Windows XP Professional<br />
sistema di protezione del sistema: account con password, AVG, ClamWin Free<br />
Antivirus<br />
componenti fondamentali: stampanti laser e deskjet colori in rete<br />
software: Office XP professional con Frontpage di Microsoft, Outlook, I.E. 6, Acrobat<br />
Reader, WinZip, Cabrì II<br />
1 computer aula video in rete, stessa dotazione alunno<br />
2 computer aula insegnanti in rete, stessa dotazione alunno<br />
1 computer aula coordinatore, stessa dotazione alunno<br />
1 computer aula sostegno, software didattico free, OpenOffice, software di<br />
riconoscimento vocale<br />
Totale computer della scuola media 34 + 1 server<br />
82
SCUOLA PRIMARIA NOGAREDO<br />
N. 1 LABORATORIO INFORMATICA:<br />
1 Server<br />
Locale in cui si trova: laboratorio di informatica<br />
collegamento in rete locale: sì<br />
collegamento in rete pubblica: si<br />
sistema operativo utilizzato: Windows Server 2003<br />
sistema di protezione del sistema: antivirus Symantec<br />
componenti fondamentali: stampanti laser e deskjet colori in rete, scanner, video<br />
proiettore<br />
software: Office 2003 Professional di Microsoft, Outlook, I.E. 6, Acrobat Reader,<br />
WinZip<br />
9 computer Alunno<br />
Locali in cui si trovano: laboratorio di informatica<br />
collegamento in rete locale: sì<br />
collegamento in rete pubblica: si<br />
sistema operativo utilizzato: Windows XP Professional<br />
sistema di protezione del sistema: antivirus Norton Client<br />
componenti fondamentali: 1 stampante laser e 1 deskjet colori in rete<br />
software: Office 2003 professional di Microsoft, Outlook, I.E. 6, A.Reader, WinZip<br />
SCUOLA PRIMARIA NOMI<br />
N. 1 LABORATORIO INFORMATICA:<br />
1 Server<br />
Locale in cui si trova: laboratorio di informatica<br />
collegamento in rete locale: no<br />
collegamento in rete pubblica: si<br />
sistema operativo utilizzato: Windows Server 2003<br />
sistema di protezione del sistema: ClamWin Free Antivirus<br />
componenti fondamentali: 1 stampante laser e 1 deskjet colori in rete<br />
software: Office 2003 Professional di Microsoft, Outlook, I.E. 6, Acrobat Reader,<br />
WinZip<br />
7 computer Alunno<br />
Locali in cui si trovano: laboratorio di informatica<br />
collegamento in rete locale: no<br />
collegamento in rete pubblica: no<br />
sistema operativo utilizzato: 6 Windows XP Professional – 2 Windows 98<br />
sistema di protezione del sistema: ClamWin Free Antivirus<br />
componenti fondamentali: stampanti laser e deskjet colori in rete<br />
software: Office 2003 professional di Microsoft, Outlook, I.E. 6, Acrobat Reader,<br />
WinZip, Software didattico free<br />
83
SCUOLA PRIMARIA POMAROLO<br />
N. 1 LABORATORIO INFORMATICA:<br />
1 Server<br />
Locale in cui si trova: laboratorio di informatica<br />
collegamento in rete locale: sì<br />
collegamento in rete pubblica: si<br />
sistema operativo utilizzato: Windows XP Professional<br />
sistema di protezione del sistema: antivirus Symantec<br />
componenti fondamentali: stampanti laser e deskjet colori in rete<br />
software: Office 2003 Professional di Microsoft, Outlook, I.E. 6, Acrobat Reader,<br />
WinZip, WebCam con MSN<br />
13 computer Alunno<br />
Locali in cui si trovano: laboratorio di informatica<br />
collegamento in rete locale: sì<br />
collegamento in rete pubblica: si<br />
sistema operativo utilizzato: Windows XP Professional<br />
sistema di protezione del sistema: antivirus Norton client<br />
componenti fondamentali: stampanti laser e deskjet colori in rete<br />
software: Office 2003 professional di Microsoft, Outlook, I.E. 6, A.Reader, WinZip<br />
SCUOLA PRIMARIA VILLA LAGARINA<br />
N. 1 LABORATORIO INFORMATICA:<br />
1 Server<br />
Locale in cui si trova: laboratorio di informatica<br />
collegamento in rete locale: sì<br />
collegamento in rete pubblica: si<br />
sistema operativo utilizzato: Windows Server 2003<br />
sistema di protezione del sistema: ClamWin Free Antivirus<br />
componenti fondamentali: 1 stampante laser e 1deskjet colori in rete<br />
software: Office di Microsoft, Outlook, I.E. 6, Acrobat Reader, WinZip, WebCam<br />
12 computer Alunno<br />
Locali in cui si trovano: laboratorio di informatica<br />
collegamento in rete locale: sì<br />
collegamento in rete pubblica: si<br />
sistema operativo utilizzato: Windows XP Professional (6) e Windows 98 SE (6)<br />
sistema di protezione del sistema: ClamWin Free Antivirus<br />
componenti fondamentali: stampanti laser e deskjet colori in rete<br />
software: Office 2000 e 2003 di Microsoft, Outlook, I.E. 6, Acrobat Reader, WinZip<br />
84
Funzione obiettivo: informatizzazione della didattica<br />
MAPPA CONCETTUALE<br />
Corsi Aggiornamento<br />
Corso base<br />
“Il computer e Windows”<br />
“Lavorare con Office”<br />
Corso intermedio<br />
“Internet e posta elettronica”<br />
“Presentazioni PowerPoint e<br />
Frontpage”<br />
Ipertesti<br />
Schede di valutazione<br />
Autoanalisi di <strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong><br />
DPS (Documento<br />
programmatico sicurezza dati)<br />
Supporto a docenti e alunni<br />
Richieste (e_mail) ……<br />
In collaborazione col tecnico<br />
Gestione dir<strong>it</strong>ti di accesso ai dati<br />
(restrizioni livello utente – ogni utente<br />
dispone solo delle risorse a lui<br />
destinate)<br />
Gestione di tutti i laboratori<br />
dell’ist<strong>it</strong>uto: software, aggiornamenti,<br />
installazioni, licenze d’uso, antivirus,<br />
antispy …..<br />
Consulenza e<br />
supporto<br />
Laboratori<br />
Elementari e Medie<br />
6 laboratori<br />
Funzione obiettivo<br />
INFORMATICA<br />
Comunicazione<br />
Informatica<br />
(alunni)<br />
S<strong>it</strong>o Internet<br />
Aumentare l’interattiv<strong>it</strong>à con<br />
pagine dinamiche (ASP)<br />
- Agenda di <strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong><br />
- Udienze<br />
- News ecc…..<br />
Modulistica docenti<br />
Circolari per i gen<strong>it</strong>ori<br />
Risorse per gli alunni<br />
- Ora curriculare<br />
classi II<br />
- 4 laboratori bim.<br />
“Creare pagine web”<br />
“Power Point”<br />
“Publisher”<br />
- 2 laboratori bim Vuc<br />
. redazione<br />
. pubblicazione<br />
85
L'EDUCAZIONE ALLA MONDIALITÀ<br />
Il Trentino si sta confermando ed accentuando come una realtà complessa ove si incontrano culture,<br />
tradizioni culturali, linguistiche e religiose diverse.<br />
Queste presenze pongono alla società problematiche nuove di accoglienza, rispetto e conoscenza<br />
provocando, talvolta, dibatt<strong>it</strong>i pol<strong>it</strong>ici che hanno ripercussioni anche nelle famiglie.<br />
La scuola, quale ente educativo, accogliendo al suo interno giovani di diverse provenienze, è chiamata in<br />
prima persona a dare risposte ed a suggerire modal<strong>it</strong>à d'accoglienza e di inserimento nel rispetto e nel<br />
mantenimento delle lingue e delle culture, valorizzandone le potenzial<strong>it</strong>à e favorendo l'interscambio culturale.<br />
Anche i nuovi programmi pensati per la riforma della scuola di base sottolineano questo bisogno<br />
rec<strong>it</strong>ando:<br />
"Alla scuola spetta il comp<strong>it</strong>o, ricchissimo di valenze formative, di trasferire i nuovi paradigmi della<br />
ricerca geografica in una didattica che consenta alle ragazze e ai ragazzi di sviluppare ed acquisire<br />
competenze spaziali ma anche le irrinunciabili premesse di un atteggiamento di solidarietà, apertura mentale<br />
e disponibil<strong>it</strong>à all'integrazione delle culture e alla cooperazione fra i popoli, proprio attraverso la conoscenza e<br />
il rispetto di ambienti e modi di v<strong>it</strong>a "altri", la salvaguardia e la condivisione dei beni naturali e culturali".<br />
In sintonia con quanto detto, l'attiv<strong>it</strong>à didattica è pertanto finalizzata al conseguimento dei seguenti<br />
obiettivi educativi, trasversali alle singole discipline:<br />
rispetto e consapevolezza della divers<strong>it</strong>à;<br />
apprezzamento del valore e della ricchezza dell'Altro;<br />
consapevolezza dei propri dir<strong>it</strong>ti e dei dir<strong>it</strong>ti altrui;<br />
conoscenza di altre culture;<br />
stimolo alla solidarietà.<br />
Gli obiettivi sono ambiziosi e non facili da perseguire; gli insegnanti cercano di avvicinarsi a questa meta<br />
attraverso un paziente lavoro quotidiano che comincia con l'affiatamento delle classi, partendo dal<br />
riconoscimento dell'Altro da sé. Partendo dalla conoscenza dei propri lim<strong>it</strong>i e dei propri pregi s'intende<br />
arrivare al riconoscimento delle qual<strong>it</strong>à dell'Altro accettandone anche i lim<strong>it</strong>i.<br />
La presenza di alunni stranieri è una ricchezza per la comun<strong>it</strong>à che li accoglie. Si amalgama la classe<br />
rompendo i vecchi schemi associativi e portando i ragazzi ad aggregarsi con compagni con esperienze<br />
scolastiche e di v<strong>it</strong>a diverse. Le tecniche in genere adottate sono i lavori di gruppo, o di coppia, i giochi di<br />
cooperazione, le presentazioni di esperienze e di interessi personali.<br />
Avvalendosi talvolta del mediatore culturale, si propone l'apprendimento di semplici forme comunicative<br />
da parte dell'intera classe, la conoscenza e il confronto di fiabe, racconti, usi e costumi dei paesi di<br />
provenienza, in modo da ev<strong>it</strong>are lo spaesamento e favorire l'inserimento a scuola e nella società.<br />
Nell'eterogene<strong>it</strong>à della classe è norma che esistano problemi relazionali. Il docente cerca di individuare le<br />
cause e, attraverso giochi di ruolo, di modificare gli atteggiamenti e di risolvere le problematiche. Con lo<br />
stesso impegno si affrontano altri tipi di difficoltà, coinvolgendo la classe nel lavoro di valorizzazione e<br />
rafforzamento dell'autostima da parte dei soggetti più deboli.<br />
Periodicamente abbiamo la fortuna di osp<strong>it</strong>are nelle nostre classi ragazzi/e provenienti dalla Bielorussia,<br />
di apprezzare i loro progressi nell'apprendimento della lingua <strong>it</strong>aliana, di cimentare i nostri con l'acquisizione<br />
dell'alfabeto cirillico e di alcune parole comuni.<br />
Gli insegnanti sono anche attenti a cogliere le proposte del terr<strong>it</strong>orio, ad esempio la presenza a<br />
Rovereto, osp<strong>it</strong>i di enti c<strong>it</strong>tadini, di congressisti provenienti da Paesi stranieri, la cui testimonianza diventa<br />
ulteriore fonte di conoscenza delle problematiche pol<strong>it</strong>iche, economiche e culturali studiate sui libri di testo.<br />
Molto spesso il colloquio con queste persone avviene in lingua straniera, diventando così un'opportun<strong>it</strong>à per i<br />
ragazzi di verificare la comprensione e la padronanza delle lingue studiate.<br />
Il Centro Mondial<strong>it</strong>à di Rovereto<br />
Il Centro Mondial<strong>it</strong>à di Rovereto nasce, su iniziativa dell’IC di Villa Lagarina, in rete con altri nove Ist<strong>it</strong>uti del<br />
Comprensorio, per rispondere ad alcune esigenze sorte nella realtà scolastica locale in segu<strong>it</strong>o all’aumento<br />
della presenza di alunni stranieri sul terr<strong>it</strong>orio. In particolare, si vuole fare in modo che le risposte siano il più<br />
possibile condivise dalle diverse scuole, e legate all’attiv<strong>it</strong>à di una struttura permanente: in questo modo si<br />
ev<strong>it</strong>ano interventi effimeri e discordi, si abbandona una pol<strong>it</strong>ica di “risposta all’emergenza” in favore di un<br />
lavoro a lungo termine, articolato su più livelli. La condivisione all’interno delle scuole delle modal<strong>it</strong>à<br />
d’accoglienza, la comunicazione iniziale con gli studenti neo-arrivati, l’insegnamento dell’<strong>it</strong>aliano come L2,<br />
86
con relativo bisogno di formazione (per docenti, facil<strong>it</strong>atori…) sono alcuni dei nuclei fondativi della futura<br />
attiv<strong>it</strong>à del Centro. Si propone inoltre di operare per la realizzazione di materiali per l’apprendimento e il<br />
riconoscimento e mantenimento della lingua madre.<br />
Attiv<strong>it</strong>à del Centro<br />
Le nuove esigenze che emergono nel passaggio da una realtà monoculturale a una realtà multiculturale non<br />
sono circoscrivibili solo all’amb<strong>it</strong>o della scuola. Per essere realmente efficace, l’attiv<strong>it</strong>à del Centro sarà rivolta<br />
a un doppio destinatario: la realtà della scuola, con i suoi bisogni e le sue richieste specifiche, ma anche i<br />
c<strong>it</strong>tadini, di qualunque c<strong>it</strong>tadinanza essi siano.<br />
• Per quanto riguarda le scuole, obbiettivo del Centro è coordinare le attiv<strong>it</strong>à di integrazione degli alunni<br />
stranieri e di educazione interculturale necessarie ai diversi ist<strong>it</strong>uti, in modo da cost<strong>it</strong>uire una vera e<br />
propria rete terr<strong>it</strong>oriale. Ciò verrà realizzato attraverso una continua collaborazione con i referenti per<br />
l’intercultura di ogni ist<strong>it</strong>uto, necessaria all’ascolto e alla conoscenza di bisogni e s<strong>it</strong>uazioni particolari,<br />
alla consulenza e alla pianificazione di interventi. Per lo stesso fine, si mira a cost<strong>it</strong>uire un gruppo<br />
permanente di facil<strong>it</strong>atori linguistici e un gruppo di mediatori culturali. La cost<strong>it</strong>uzione di questi due<br />
gruppi permette, innanz<strong>it</strong>utto, di razionalizzare l’impiego di queste risorse scolastiche, ev<strong>it</strong>ando gli<br />
sprechi e consentendo modal<strong>it</strong>à di assunzione assai più efficaci. Inoltre, il gruppo dei mediatori e il<br />
gruppo dei facil<strong>it</strong>atori diventano, a loro volta, centri di ricerca e progettazione in grado assumere un<br />
ruolo propos<strong>it</strong>ivo e auto-formativo, condividendo al loro interno esperienze, conoscenze, materiali<br />
prodotti etc. In questo modo verrà realizzata una struttura di interazione stabile tra scuole e Centro, che<br />
risponderà ai bisogni di ciascun <strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> relativi all’accoglienza di alunni stranieri, all’insegnamento<br />
dell’<strong>it</strong>aliano come L2 (sia come lingua di comunicazione che come lingua di studio), all’insegnamento e<br />
educazione interculturale relativa alle Lingue e Culture d’Origine, alla formazione e all’aggiornamento dei<br />
docenti, alla disponibil<strong>it</strong>à di materiali didattici idonei, etc.<br />
• Per quanto riguarda l’apertura ai c<strong>it</strong>tadini, funzione del Centro sarà prima di tutto “mettere in rete” tutte<br />
le risorse e le realtà esistenti sul terr<strong>it</strong>orio che rispondano in qualche modo ai bisogni di una società<br />
sempre più multiculturale: dalla Biblioteca Civica di Rovereto (ricca di testi e altro materiale in lingue<br />
europee ed extra-europee), a realtà come C<strong>it</strong>tà Aperta, il Centro Millevoci, il Centro di Educazione<br />
Permanente alla Pace, Atas Cultura, etc. Oltre a svolgere una funzione informativa, il Centro intende<br />
avviare, ove sia possibile, anche una collaborazione con queste diverse realtà, volta all’organizzazione di<br />
eventi e percorsi culturali, alla condivisione di risorse e materiali e alla documentazione delle attiv<strong>it</strong>à<br />
svolte. Per lo stesso fine, il Centro intende stabilire relazioni anche con realtà analoghe presenti sul<br />
terr<strong>it</strong>orio nazionale, per condividere esperienze di educazione e prassi dell’intercultural<strong>it</strong>à che sono in<br />
corso altrove.<br />
In sintesi, gli obbiettivi che ci si pone nella realizzazione del Centro Mondial<strong>it</strong>à sono:<br />
o permettere agli Ist<strong>it</strong>uti coinvolti di avere delle pratiche di accoglienza e di educazione<br />
interculturale condivise e costantemente aggiornate<br />
o<br />
o<br />
cost<strong>it</strong>uire un riferimento stabile e permanente, per uscire dalle pol<strong>it</strong>iche di emergenza<br />
instaurare una relazione di coinvolgimento reciproco con tutti i destinatari (c<strong>it</strong>tadini,<br />
insegnanti, studenti, famiglie), in modo che la funzione propos<strong>it</strong>iva non sia unidirezionale.<br />
87
SOLIDARIETA’: IL TRENTINO IN MOZAMBICO<br />
L’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> Comprensivo di Villa Lagarina propone una educazione alla solidarietà basata principalmente su<br />
due attiv<strong>it</strong>à fondamentali:<br />
- educazione alla conoscenza dell’altro e delle realtà a noi esterne;<br />
- appoggio diretto ad iniziative concrete di progetti al “sud”:<br />
L’educazione alla conoscenza dell’altro e delle realtà esterne si basa essenzialmente su incontri con<br />
persone provenienti da queste realtà, con persone che abbiano maturato una conoscenza del mondo esterno<br />
con presentazione di filmati o documenti su s<strong>it</strong>uazioni al sud, su dibatt<strong>it</strong>i all’interno dei singoli plessi o classi.<br />
Per l’appoggio diretto a progetti al sud l’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> Comprensivo ha deciso per i prossimi anni che tutte le<br />
attiv<strong>it</strong>à siano finalizzate ad appoggiare il progetto della P.A.T. a favore della comun<strong>it</strong>à di Caia in Mozambico,<br />
con una partecipazione diretta al tavolo del coordinamento delle Associazioni per il Mozambico CAM e con<br />
diverse attiv<strong>it</strong>à finalizzate alla raccolta di fondi per la scuola di agronomia che sta nascendo a Caia, con la<br />
quale si instaurerà un rapporto di collaborazione e di scambio.<br />
88
L'EDUCAZIONE AMBIENTALE<br />
In questi ultimi anni l’ambiente è stato messo sempre più spesso al centro di progetti scolastici sia a<br />
livello locale sia in sede nazionale.<br />
Gli interventi educativi hanno le stesse final<strong>it</strong>à e sono riconducibili ad una comune strategia d’interventi<br />
centrati su:<br />
il rafforzamento di conoscenze specifiche sui temi ambientali:<br />
la cresc<strong>it</strong>a complessiva delle sensibil<strong>it</strong>à e consapevolezze individuali e collettive verso l’ambiente;<br />
l’esplic<strong>it</strong>azione di bisogni e di proposte orientate al miglioramento della qual<strong>it</strong>à ambientale anche<br />
<br />
attraverso il cambiamento di comportamenti;<br />
la promozione della partecipazione delle diverse istanze sociali per la realizzazione di uno sviluppo<br />
sostenibile dell’ambiente naturale e sociale.<br />
La Provincia Autonoma di Trento, che attraverso gli "operatori ambientali" ha promosso l’educazione<br />
ambientale, fin dal lontano 1986, ha approvato recentemente il "programma provinciale di educazione,<br />
informazione e sensibilizzazione ambientale 2000/2002"che porterà l’attenzione verso la biodivers<strong>it</strong>à, le<br />
"agende 21"locali, la "cura" del terr<strong>it</strong>orio, il turismo ecocompatibile, le tecnologie "dolci" favorendo la<br />
partecipazione ed il coinvolgimento dei c<strong>it</strong>tadini in tutte le fasce d’età su temi spesso complessi e<br />
controversi: lo scopo è quello di creare una c<strong>it</strong>tadinanza cr<strong>it</strong>ica e responsabile, fautrice di comportamenti<br />
consapevoli per il rispetto dell’ambiente.<br />
Il modello si ispira ai principi dello "sviluppo sostenibile" e l’intenzione è quella di elaborare progetti che,<br />
con l’ausilio di specifiche risorse già esistenti sul terr<strong>it</strong>orio provinciale (strutture museali, scientifiche e<br />
produttive, ambientali e naturali...), promuovono attiv<strong>it</strong>à che abbiano, per quanto possibile, i seguenti<br />
presupposti:<br />
- capac<strong>it</strong>à di coinvolgere soggetti diversi;<br />
- capac<strong>it</strong>à di stabilire interconnessioni della tematica scelta con altre tematiche;<br />
- ricchezza di strumenti e metodologie;<br />
- capac<strong>it</strong>à di utilizzare ed attivare risorse;<br />
- individuazione degli obiettivi, modal<strong>it</strong>à di gestione del progetto, delle ricadute e delle procedure di<br />
valutazione in <strong>it</strong>inere e finale;<br />
- traduzione in azioni pos<strong>it</strong>ive (trasformazione reale di ambienti) e in prodotti (ipertesti, spettacoli teatrali,<br />
mostre...).<br />
La nostra scuola ha nominato appos<strong>it</strong>amente due referenti, uno per la scuola primaria ed uno per la<br />
scuola media, che seguiranno le proposte operative delle classi.<br />
89
L'EDUCAZIONE STRADALE<br />
Ogni anno la Scuola, con la collaborazione della sezione di Polizia Urbana del Comune di Villa Lagarina,<br />
organizza una serie d’incontri, per tutti gli alunni, sul tema dell’educazione stradale.<br />
Le lezioni sono tenute dal Vigile urbano Sign.Baldessarini Vigilio, i contenuti sono inser<strong>it</strong>i nella<br />
programmazione annuale degli insegnanti di ed.tecnica. Sono previsti tre incontri di un’ora per le classi prime<br />
e per le classi seconde, quattro ore di lezione per le classi terze. Gli argomenti sono differenziati per fornire,<br />
nel corso del triennio, conoscenze complete e adeguate all’età e alle esigenze degli alunni.<br />
La collaborazione tra Scuola e Vigili urbani continuerà anche oltre la presente iniziativa con<br />
l’organizzazione dei corsi per il conseguimento del patentino di guida del ciclomotore aperti ai ragazzi<br />
prossimi al compimento dei 14 anni.<br />
OBIETTIVI:<br />
- Acquisire conoscenze specifiche relative alle regole della circolazione stradale, alle segnalazioni, ai<br />
passaggi riservati…;<br />
- Potenziare le capac<strong>it</strong>à operative per comportarsi correttamente secondo le regole del Codice della strada<br />
che deve essere considerato come uno strumento utile per garantire la sicurezza di tutti gli utenti;<br />
- Assumere un comportamento responsabile per non nuocere a se stessi e agli altri.<br />
CONTENUTI:<br />
- Per gli alunni delle classi prime le lezioni avranno per tema IL PEDONE, regole, comportamenti, pericoli,<br />
precauzioni.<br />
- Per gli alunni delle classi seconde: IL CICLISTA, regole, comportamenti, pericoli, spazi riservati, …<br />
- Per gli alunni delle classi terze: IL CICLOMOTORISTA, regole, comportamenti, pericoli, suggerimenti …<br />
I contenuti specifici verranno via via ampliati fornendo conoscenze approfond<strong>it</strong>e e ponendo particolare<br />
attenzione agli aspetti formativi degli interventi.<br />
MODALITA’<br />
Le lezioni saranno impostate in modo da lasciare molto spazio alla conversazione, alle domande e ai dubbi<br />
dei ragazzi, le regole del Codice della Strada saranno comunicate più come suggerimenti per la propria<br />
sicurezza che come obblighi da osservare, la figura del vigile urbano sarà presentata come strumento utile<br />
alla salvaguardia dell’incolum<strong>it</strong>à dei c<strong>it</strong>tadini piuttosto che come soggetto di repressione.<br />
Per questi incontri il Vigile urbano ha predisposto una serie di lucidi da proiettare sulla lavagna luminosa, di<br />
filmati didattici con protagonisti che hanno l’età degli alunni, di articoli presi dai quotidiani e schede a tema.<br />
Durante l’attiv<strong>it</strong>à sarà indispensabile la presenza dell’insegnante che avrà il comp<strong>it</strong>o di “mediatore”<br />
didattico/educativo e potrà, successivamente, riprendere i contenuti e gestirli per approfondimenti su temi<br />
analoghi (comportamento sull’autobus, all’usc<strong>it</strong>a dalla scuola, nel corso delle usc<strong>it</strong>e…)<br />
A conclusione del ciclo, i ragazzi delle classi terze dovranno compilare un test di verifica sia sulle conoscenze<br />
vere e proprie che sui comportamenti acquis<strong>it</strong>i nell’arco del triennio.<br />
90
MUSICA E TEATRO<br />
Le attiv<strong>it</strong>à musicali nella scuola offrono l’opportun<strong>it</strong>à di seguire percorsi formativi che non sono solo<br />
occasione di conoscenza e approfondimento del linguaggio musicale nelle varie forme ed espressioni<br />
(ascolto, uso della voce, produzione strumentale), ma mirano anche allo sviluppo della ricerca<br />
interdisciplinare e della socializzazione. Bambini e ragazzi sono inv<strong>it</strong>ati a far crescere la loro personal<strong>it</strong>à e a<br />
scoprire e coltivare la dimensione creativa che è in ciascuno di loro, intrecciando suono, danza, canto e<br />
immagine.<br />
In questa prospettiva, da alcuni anni sono iniziate e si sono consolidate importanti e significative<br />
collaborazioni didattiche e artistiche tra l’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> comprensivo, la Scuola musicale “Jan Novák” di Villa<br />
Lagarina e la Scuola Musicale della Banda di Pomarolo.<br />
Tra le iniziative più importanti realizzate in tempi recenti si ricordano gli spettacoli musicali “Brundibar, il<br />
suonatore di organetto” e “Africa”, gli spettacoli di musica e poesia “Tutti per uno” in due diverse edizioni, la<br />
fiaba musicale “La barba del conte”, lo spettacolo teatrale “Per chi crede e chi non crede, parleremo delle<br />
streghe”, oltre alle tante iniziative di animazione musicale nei vari momenti dell’anno.<br />
Da alcuni anni anche nella scuola media si sono aperti spazi per esperienze di teatro e teatro-danza<br />
associati alla musica. Singole classi e ragazzi del Laboratorio teatrale hanno potuto così confrontarsi,<br />
arricchirsi e fare esperienze con nuovi linguaggi e tecniche espressive scenico-coreografiche. Nell’anno<br />
scolastico 1998-99 una classe seconda ha allest<strong>it</strong>o nel corso di uno stage di teatro-danza uno spettacolo sullo<br />
schiavismo e sulle musiche neroamericane (“Blood on the Fields”); l’anno seguente la stessa classe ha<br />
prosegu<strong>it</strong>o l’esperienza misurandosi con il musical rock “Tommy”; nel 2000-01, due spettacoli: “Giulietta e<br />
Romeo” messo in scena da una classe terza e “Le stagioni di Giacomo” messo in scena dal Laboratorio<br />
teatrale. Nel corrente anno scolastico sono impegnati su questo terreno il Laboratorio e una classe seconda.<br />
IL GIORNALE “VUCUMPRÀ”<br />
Dal 1993 la Scuola media Anna Frank di Villa Lagarina ha un suo giornale. E’ un progetto nato quasi per<br />
scommessa all’interno di un laboratorio di scr<strong>it</strong>tura del tempo prolungato e divenuto, con il passare del<br />
tempo, la creatura di una redazione nella quale ragazzi/e di tutte le classi e gli insegnanti coordinatori si<br />
confrontano e lavorano insieme tramandandosi "l’arte del mestiere".<br />
Fin da sub<strong>it</strong>o Vucumprà si è caratterizzato per la sua voglia di aprirsi alla realtà circostante, coniugando<br />
tematiche inerenti al mondo della scuola a temi legati alla realtà sociale dei paesi della zona fino ad<br />
argomenti più ampi. Oggi questa sua vocazione è ancor più forte. E cresciuta è anche la sua immagine, al<br />
pari delle tecnologie e delle risorse finanziarie che ha a disposizione: dal piccolo formato riprodotto in<br />
fotocopia per 2-3 numeri l’anno al grande formato a colori stampato tipograficamente in 3 o 4 numeri.<br />
Oggi Vucumprà è nella scuola una presenza fissa, aspettata, mai scontata, che inv<strong>it</strong>a al confronto e alla<br />
polemica, dentro e fuori le mura dell’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong>.<br />
Nel 2001 Vucumprà ha vinto il I° premio al concorso provinciale per giornalini scolastici "Il resto<br />
dell’Euro", promosso dal quotidiano "L’Adige" e dall’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> comprensivo di Taio - un premio in denaro con cui<br />
è stato acquistato un nuovo server per la redazione e l’attiv<strong>it</strong>à di informatica - mentre è del 2002 un altro<br />
riconoscimento, "per il taglio particolare e coraggioso e l’attenzione alle problematiche sociali".<br />
Quest’anno usciranno due numeri del giornale. Ogni edizione ha il suo gruppo di “aspiranti giornalisti”<br />
(12-15 ragazzi/e), coordinati da due insegnanti, Armani (lettere) e Thiella (ed.tecnica) che indirizzano il<br />
91
lavoro sia da un punto di vista dei contenuti che della loro realizzazione. Come redazione utilizziamo l’aula<br />
computer il venerdì pomeriggio in forma di laboratorio.<br />
Le idee nascono dal gruppo degli alunni e degli insegnanti in una specie di brain storming all’inizio di<br />
ogni riunione.<br />
I ragazzi/e si occupano di tutto: fotografie, interviste, videoscr<strong>it</strong>tura, internet, impaginazione. Gli<br />
argomenti vengono scelti in base ai loro interessi e alla loro facile documentazione e realizzazione. Molti dati<br />
sono raccolti dagli alunni durante la settimana e rielaborati nelle ore dell’attiv<strong>it</strong>à del Vucumprà.<br />
Gli “aspiranti giornalisti” cercano di dare il meglio di sé e lo fanno con grande entusiasmo e<br />
partecipazione. Il clima all’interno della redazione è vivace e costruttivo e non mancano momenti giocosi e<br />
divertenti, al punto che molti partecipanti vorrebbero ripetere l’esperienza nello stesso anno scolastico.<br />
Nel numero di dicembre di quest’anno si spazia dai nuovi arrivi (sia nel campo insegnante che degli<br />
alunni) agli addii, dalle poesie ai racconti, dallo sport al tempo libero, dalle g<strong>it</strong>e scolastiche ai ricordi di alunni<br />
ormai grandi, dal cinema all’astronomia.<br />
In conclusione mi sembra interessante riportare ciò che scrive alla nostra redazione un alunno, ormai<br />
grande, che frequentava la scuola media Anna Frank nei primi anni della fondazione del giornale:<br />
Devo dire che nei due anni in cui ho collaborato alla realizzazione del giornale, questo ha spesso assolto<br />
il comp<strong>it</strong>o per cui era stato pensato, quello cioè di raccontare il punto di vista degli adolescenti, prospettiva<br />
che sovente gli adulti pensano di conoscere e saper interpretare, rimanendo poi sorpresi da molte reazioni e<br />
pensieri dei ragazzi che vanno al di là del grado di aspettativa e comprensione dei grandi (per mancanza di<br />
dialogo e la troppa supponenza?!), poi sment<strong>it</strong>i anche alla riprova dei fatti sulla sensibil<strong>it</strong>à e la matur<strong>it</strong>à dei<br />
giovani.<br />
92
I N D I C E<br />
I. La scuola di base della Destra Adige<br />
1. L’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> Comprensivo di Villa Lagarina pag. 02<br />
2. Il terr<strong>it</strong>orio pag. 05<br />
II.<br />
L'organizzazione<br />
La struttura e l’organizzazione dell’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> pag. 07<br />
1. La Scuola Primaria di Nogaredo pag. 07<br />
2. La scuola dell'obbligo di Villa Lagarina: pag. 08<br />
2.1 La Scuola Primaria “Paride Lodron” pag. 08<br />
2.2 La Scuola Secondaria di Primo grado “Anna Frank” pag. 10<br />
3. La Scuola Primaria “Remo Galvagni” di Pomarolo pag. 11<br />
4. La Scuola Primaria “Luigi Vicentini” di Nomi pag. 13<br />
5. Calendario per l’anno scolastico <strong>2006</strong>/07 pag. 14<br />
6. Organizzazione del Collegio docenti pag. 15<br />
Quadro degli incarichi pag. 16<br />
Commissioni del Collegio docenti pag. 17<br />
Consiglio dell’Ist<strong>it</strong>uzione pag. 18<br />
Giunta esecutiva pag. 18<br />
Commissione mensa pag. 18<br />
Regolamento della Commissione mensa d’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> pag. 18<br />
III.<br />
Le scelte culturali e pedagogiche<br />
1. I caratteri e i fini della scuola dell’obbligo pag. 21<br />
1. La scuola Primaria pag. 21<br />
2. La scuola secondaria di I° pag. 22<br />
2. Il ruolo della famiglia nel progetto educativo della scuola pag. 24<br />
3. Le scelte pedagogiche ed organizzative pag. 25<br />
1. La scuola Primaria pag. 25<br />
2. La scuola secondaria di I° pag. 27<br />
2.2 Le scelte pedagogiche pag. 28<br />
L’offerta didattica delle attiv<strong>it</strong>à opzionali pag. 33<br />
Laboratori per il recupero dei deb<strong>it</strong>i formativi pag. 34<br />
<strong>Progetto</strong> di recupero per le difficoltà nella matematica pag. 35<br />
Laboratorio “Imparare ad imparare” pag. 37<br />
3. L'organizzazione delle attiv<strong>it</strong>à alternative dell’insegnamento<br />
della religione cattolica – scuola primaria e media pag. 40<br />
4. La programmazione pag. 41<br />
1. L’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> pag. 41<br />
2. La Scuola Primaria pag. 42<br />
3. La scuola secondaria di I° pag. 43<br />
5. La valutazione pag. 44<br />
1. Cosa significa valutare pag. 44<br />
2. Il documento pag. 44<br />
3. Tempi pag. 44<br />
4. Valutazione e orientamento pag. 45<br />
Presentazione del <strong>Progetto</strong> di autovalutazione pag. 45<br />
6. La continu<strong>it</strong>à educativa pag. 48<br />
1. Ragioni ed obiettivi della continu<strong>it</strong>à pag. 48<br />
2. Scuola primaria e secondaria di I° (media): un progetto di continu<strong>it</strong>à<br />
con radici profonde pag. 48<br />
3. Tre possibili percorsi pag. 48<br />
93
4. I piani operativi per promuovere la continu<strong>it</strong>à pag. 48<br />
7. L’orientamento pag. 51<br />
1. Premesse culturali pag. 52<br />
2. Le azioni fondamentali pag. 52<br />
8. Divers<strong>it</strong>à e uguaglianza pag. 53<br />
1. La divers<strong>it</strong>à culturale pag. 54<br />
2. Lo svantaggio e le difficoltà di apprendimento. pag. 54<br />
3. L'integrazione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali pag. 55<br />
4. <strong>Progetto</strong> intercultura anno scolastico <strong>2006</strong>/2007 pag. 59<br />
IV.<br />
L'area dei progetti<br />
1. L'educazione alla salute pag. 61<br />
1. La scuola primaria e la scuola secondaria di I°: una storia di<br />
progetti comuni pag. 61<br />
2. Un impegno che continua pag. 62<br />
Piano di educazione alla salute per l’anno scolastico <strong>2006</strong>/07 pag. 63<br />
2. Una scuola che colloca nel mondo: il terr<strong>it</strong>orio come risorsa formativa pag. 65<br />
1. Scuola e extrascuola pag. 65<br />
2. Il terr<strong>it</strong>orio come risorsa formativa e la scuola come centro di cultura pag. 65<br />
3. Il terr<strong>it</strong>orio della Destra Adige pag. 65<br />
4. Il terr<strong>it</strong>orio del Comprensorio della Vallagarina pag. 66<br />
5. La Destra Adige, il C10 e oltre... pag. 66<br />
6. Usc<strong>it</strong>e formative, vis<strong>it</strong>e guidate e viaggi di istruzione: alcune<br />
opportun<strong>it</strong>à per la conoscenza del terr<strong>it</strong>orio pag. 66<br />
3. L'attiv<strong>it</strong>à motoria e l'educazione fisica nella scuola di base pag. 67<br />
1. Premessa pag. 67<br />
<strong>Progetto</strong> per le attiv<strong>it</strong>à complementari di educazione fisica pag. 68<br />
Laboratorio sportivo <strong>2006</strong>/07 pag. 69<br />
Competenze in usc<strong>it</strong>a pag. 70<br />
4. Le lingue straniere pag. 71<br />
1. La scuola Primaria pag. 71<br />
2. La scuola secondaria di I° pag. 71<br />
3. Risorse umane pag. 72<br />
5. I laboratori multimediali pag. 73<br />
1. Premessa pag. 73<br />
2. I laboratori multimediali nella scuola Primaria pag. 74<br />
3. I laboratori multimediali nella scuola secondaria di I° pag. 74<br />
4. Risorse umane pag. 75<br />
Dotazione informatica dell’<strong>Ist<strong>it</strong>uto</strong> pag. 76<br />
<strong>Progetto</strong> di informatizzazione della didattica pag. 79<br />
6. L'educazione alla mondial<strong>it</strong>à pag. 80<br />
7. L'educazione ambientale pag. 83<br />
8. L’educazione stradale pag. 84<br />
9. Musica e teatro pag. 85<br />
10. Il Giornale “Vucumprà” pag. 85<br />
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA<br />
Via Stockstadt am Rhein<br />
94
38060 VILLA LAGARINA (TN)<br />
tel. 0464 411312 – fax 0464 462120<br />
segr.ic.villalagarina@scuole.provincia.tn.<strong>it</strong><br />
95