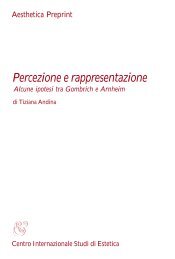Essere qualcosa. Ontologia e psicologia in Wolff - Labont
Essere qualcosa. Ontologia e psicologia in Wolff - Labont
Essere qualcosa. Ontologia e psicologia in Wolff - Labont
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Laboratorio di ontologiaUniversità di Tor<strong>in</strong>o1
<strong>Essere</strong> <strong>qualcosa</strong><strong>Ontologia</strong> e <strong>psicologia</strong><strong>in</strong> <strong>Wolff</strong>diPietro KobauTrauben3
Volume pubblicato con il contributo del M<strong>in</strong>istero dell’Istruzione, dell’Università edella Ricerca.© 2004 Pietro KobauTrauben s.a.s.via Plana 1 – 10123 Tor<strong>in</strong>oISBN 88883985544
IndicePremessa.........................................................................................................7I – Che cosa c’è nell’ontologia di <strong>Wolff</strong> ..................................................131. Res, quatenus est aliquid (ontologie di tipo wolffiano).......................172. Essenza ed esistenza (al marg<strong>in</strong>e dell’ontologia wolffiana)...........24II – Che cosa è un ente? Una questione di pr<strong>in</strong>cipi.................................291. L’argomento preontologico e l’enciclopedia filosofica..................302. Contro Cartesio ...................................................................................373. Ignoranza o <strong>in</strong>sensibilità?...................................................................47III – La <strong>psicologia</strong> che sostiene l’ontologia.............................................531. Utilità e danno della metafisica per la scienza.................................532. Credere per poi correggersi................................................................583. Monadi con f<strong>in</strong>estre............................................................................71IV – Epistemologia o metafisica: l’analogon rationis.................................811. Prevedere non è un miracolo.............................................................822. Come le esperienze ritornano............................................................93V – Fallacie e antifallacie dell’analogon rationis........................................1031. Esperienza delle leggi o leggi dell’esperienza ................................1032. Conoscere significa due cose...........................................................115VI – Significato, essenza, esistenza. I cento talleri di <strong>Wolff</strong>...............1241. Esse, percipi...........................................................................................1252. Esistenze sensibili, essenze ideali....................................................139Conclusioni ................................................................................................151Rimandi bibliografici .....................................................................................155Opere di <strong>Wolff</strong>Altre opereIndice dei nomi ..............................................................................................1675
PremessaLa valutazione complessiva dell’opera di Christian <strong>Wolff</strong> (1679-1754) ha dovuto più volte confrontarsi con un paradosso: quello <strong>in</strong>carnatoda una filosofia conservatrice nel contenuto (specie perquanto riguarda la metafisica, spesso apertamente e tecnicamentescolastica) e, al contempo, quasi ossessionata dalla necessità di darsiuna forma moderna, improntata alla nuova metodologia scientificaconsolidatasi grazie all’impulso cartesiano. Tale problema <strong>in</strong>terpretativosi è sovente tradotto <strong>in</strong> quello, valutativo, della piena e legittimaappartenenza, o meno, di <strong>Wolff</strong> alla filosofia dell’illum<strong>in</strong>ismo.Ed è pure vero che tale problema (ciò che può riuscire solo con iparadossi genu<strong>in</strong>i, mai con i falsi problemi spacciati per tali) lo si èpotuto con successo ridimensionare – riconoscendolo condiviso dagran parte della migliore Aufklärung, addirittura f<strong>in</strong>o all’impresa criticakantiana (cfr. HINSKE 1986: 307). Questo, tuttavia, non toglieche il problema <strong>in</strong> qualche misura rimanga, per quanto tradotto eanalizzato <strong>in</strong> una serie di questioni meglio maneggiabili.Una di queste, e fra le pr<strong>in</strong>cipali di questo tipo, è senz’altro costituitadall’ontologia wolffiana. Né si tratta di un problema circoscrivibileall’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e e alle <strong>in</strong>terpretazioni ristrettamente storiografiche.Se si va ai prolegomeni dell’opera che avvia l’<strong>in</strong>gente (e ancora nonbene valutata) <strong>in</strong>fluenza wolffiana, ossia la cosiddetta Logica tedesca(1713), si trova che l’ultimo dei paragrafi che del<strong>in</strong>eano sistematicamentele parti dell’<strong>in</strong>tera filosofia (cfr. DL “Vorbericht” §§ 10-14)tira le somme nel modo che segue.7
Poiché tutte le cose (D<strong>in</strong>ge) (che si tratti di corpi, oppure di spiriti e anime)si rassomigliano fra loro <strong>in</strong> alcune parti, bisogna pure considerare ciò chepertiene a tutte le cose <strong>in</strong> generale e <strong>in</strong> che cosa si trovi <strong>in</strong> generale unadifferenza tra di esse; e la parte della filosofia <strong>in</strong> cui si tratta della conoscenzagenerale delle cose viene chiamata ontologia, ovvero scienza fondamentale(Grund-Wissenschaft). La scienza fondamentale, la dottr<strong>in</strong>a deglispiriti e la teologia naturale costituiscono la metafisica, ovvero la scienzapr<strong>in</strong>cipale (Haupt-Wissenschaft) (ibidem, § 14).L’ontologia – secondo una concezione che rimarrà stabile nel sistemawolffiano, nonostante tutti i suoi sviluppi, a partire cioè dallacosiddetta Metafisica tedesca (1719) – è qui presentata come la scienzadell’ente <strong>in</strong> generale, ossia di tutto ciò che è (almeno <strong>in</strong> qualche senso,magari anche sotto il solo profilo della concepibilità) <strong>qualcosa</strong>:“Tutto ciò che è, ovvero può venire concepito come tale da poteressere, viene chiamato ‘cosa (res)’, <strong>in</strong> quanto è <strong>qualcosa</strong> (aliquid)”(Ont § 243). Proprio essendo <strong>qualcosa</strong>, ossia qualificato <strong>in</strong> manieram<strong>in</strong>imale e f<strong>in</strong>anco virtuale, l’oggetto dell’ontologia wolffiana risultaconoscibile e dicibile – f<strong>in</strong>o a poter essere adeguatamente def<strong>in</strong>ito:“sicché la ‘cosa’ può venire def<strong>in</strong>ita <strong>in</strong> base al fatto che è <strong>qualcosa</strong>”(ibidem). Ha dunque (sul versante gnoseologico) una propria essenza:“Ciò che <strong>in</strong>nanzitutto può venire pensato di una cosa e <strong>in</strong> cuipuò venire trovata la ragione (Grund) di tutto ciò che le pertiene èchiamato essenza” (DL I, § 48).Si tratta, quanto all’oggetto, di una def<strong>in</strong>izione scolastica e, quantoalla discipl<strong>in</strong>a, tardoscolastica – e poi, grazie soprattutto a <strong>Wolff</strong>,moderna, tanto da poterne r<strong>in</strong>tracciare gli esiti f<strong>in</strong>o alla nostra contemporaneità.La storiografia si è ormai abbondantemente espressasul tratto di questa vicenda che porta da Scoto all’età kantiana (cfr.<strong>in</strong>fra, pp. 15-16); ma anche un semplice censimento della letteraturapuò mostrare quanto ne resti ancora da ricostruire, sia per i suoi antefatticlassici (segnatamente aristotelici), sia per gli esiti “essenzialistici”il cui profilo si stende f<strong>in</strong>o sulla scuola di Brentano e oltre. Aogni modo, nelle def<strong>in</strong>izioni – e di oggetto e di discipl<strong>in</strong>a – consolidatesicon <strong>Wolff</strong> manca un elemento che appare <strong>in</strong>vece <strong>in</strong> posizionecentrale nell’ontologia contemporanea: la questione dell’esistenza.8
Tale discrepanza, come si può <strong>in</strong>tuire, risulterebbe riducibile <strong>in</strong>due modi: mediante un supplemento di <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e storiografica, chericostruisca i passi non ancora evidenziati tramite cui le dottr<strong>in</strong>e metafisichesull’esistenza si sono <strong>in</strong>serite <strong>in</strong> un’ontologia costituitasi<strong>in</strong>nanzitutto come una dottr<strong>in</strong>a delle essenze sommamente generiche;oppure mediante un’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e di tipo teorico sui possibili aggancitra questione dell’esistenza e riflessione sulle proprietà e sullatassonomia più generali degli enti. Restando fermo che, nell’op<strong>in</strong>ionedi chi scrive, queste due vie non si escludono a vicenda, si è sceltodi privilegiare la seconda, <strong>in</strong>centrandola su <strong>Wolff</strong>, valutato comel’autore che meglio ha rappresentato il tipo ideale di un’ontologiaessenzialistica – che assume cioè una posizione realistica circa lostatuto esistenziale delle essenze <strong>in</strong> quanto entità <strong>in</strong>tenzionali. E losi è fatto scommettendo su una tesi: che lo snodo fra una concezionedell’ontologia come dottr<strong>in</strong>a delle entità possibili (cfr. Ont §134), dotate cioè necessariamente di un’essenza, e dottr<strong>in</strong>a dell’esistenzacome “complemento della possibilità” (cfr. Ont § 174) vadaricercato, <strong>in</strong> <strong>Wolff</strong>, <strong>in</strong> una <strong>psicologia</strong> <strong>in</strong>tesa come scienza metafisicacapace di dare ragione delle strutture più elementari dell’esperienza.Enunciando per <strong>in</strong>tero la tesi che guida la presente lettura dell’ontologiawolffiana: producendo una metafisica della mente che muovedall’“immag<strong>in</strong>e manifesta” dell’esperienza umana (e <strong>in</strong>nanzitutto dadue caratteristiche fondamentali di essa, la sua <strong>in</strong>tenzionalità e la suacondivisibilità), è possibile mirare allo scopo complessivo di “comprenderecome le cose, <strong>in</strong>tese nel senso più ampio di questo term<strong>in</strong>e,si connettano a vicenda, <strong>in</strong>tendendo questi term<strong>in</strong>i nel loro sensopiù ampio” (SELLARS 1962: 35). E se nella metafisica complessivache risulta da tale impostazione deve trovare spazio un’ontologiastrettamente essenzialistica, ciò non comporta l’esclusione del problemadell’esistenza. Un simile esito permette, anzi, una formulazionedi tale problema che non rischia di ridurlo a una questione u-nica e univocamente formalizzabile – come sarà, ad esempio, nellaprospettiva qu<strong>in</strong>eana quella dell’uso corretto del quantificatore esistenziale.Richiede, piuttosto, di affrontarlo mediante una chiarificazionedi nozioni diverse, racchiuse nei diversi significati di “esiste-9
e”, che esigono di muovere nuovamente dall’“immag<strong>in</strong>e manifesta”dell’esperienza comune.Desidero esprimere tutta la mia riconoscenza a coloro cui devole diverse occasioni grazie a cui, alla f<strong>in</strong>e, si è concretizzato il presentesaggio: per primo – e per un duplice ord<strong>in</strong>e di motivi – MaurizioFerraris. Nell’ord<strong>in</strong>e dei personali rapporti di amicizia, la suavic<strong>in</strong>anza e la sua competenza mi sono state preziose per la stesuradi due articoli (La fallacia dell’analogon rationis, “Rivista di estetica”,n.s., n. 19 - 2002, pp. 11-35; Esistenza estetica, esistenza concettuale. I centotalleri, ivi, n. 1 - 1996, pp. 83-101) attorno ai cui nuclei tematicisono stati costruiti gli ultimi capitoli (IV, V e VI) del presente lavoro.In veste istituzionale, gli devo la partecipazione alle attività del“Centro Interuniversitario di <strong>Ontologia</strong> Teorica e Applicata”, da luipromosse e coord<strong>in</strong>ate, fra cui rientra la pubblicazione del presentescritto. Sempre riguardo alle attività del Centro, e <strong>in</strong> special modo,mi è obbligo di citare qui l’<strong>in</strong>vito al convegno “Storia dell’ontologia”(Tor<strong>in</strong>o, 5-6 dicembre 2002); fra gli atti pubblicati dalla “Rivistadi estetica” (n.s., n. 22 - 2003) compare <strong>in</strong>fatti il contributo (Che cosaè un ente?, ivi, pp. 23-39) da cui provengono le prime l<strong>in</strong>ee essenzialidi questo libro, consegnate ai capitoli I e II. E, naturalmente,r<strong>in</strong>grazio con ciò tutti coloro che <strong>in</strong> quell’occasione si sono mostratigenerosi nei suggerimenti e nelle critiche.Ancora per gli ambiti istituzionali, sono riconoscente a Sergio C.Mas<strong>in</strong>, cui devo la partecipazione al convegno “I fondamenti dellafenomenologia sperimentale” (Padova, 21-22 febbraio 2002); fra gliatti (pubblicati <strong>in</strong> “Teorie & Modelli. Rivista di storia e metodologiadella <strong>psicologia</strong>”, n.s., VII, 2002, nn. 2-3) compare il contributo(Psychologia empirica, methodo scientifica pertractata: preistoria della fenomenologia?sperimentale?, ivi, pp. 173-187) da cui deriva l’impostazionedel presente capitolo III. Qui, r<strong>in</strong>graziando coloro che anche<strong>in</strong> quest’altra occasione mi hanno elargito pareri e critiche, tengoparticolarmente a ricordare Paolo Bozzi, la cui recente scomparsanon mi è possibile lamentare con parole adeguate.R<strong>in</strong>grazio, <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e, Norbert H<strong>in</strong>ske con cui, nel corso di questedue ultime estati trascorse a Trier, ho avuto modo di discutere di-10
stesamente la circostanza per cui la cognizione istorico-empirica,nella concezione di <strong>Wolff</strong>, condivide con quella scientifica una medesimastruttura esperienziale, passibile di <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e a priori; e Ton<strong>in</strong>oGriffero, ultimo a volermi concedere, nei nostri colloqui, unapossibilità di emendare ancora qualche difetto di questo lavoro,prima che fosse consegnato alla stampa. Gli errori e le <strong>in</strong>sufficienzeche saranno comunque rimasti, nonostante tutto ciò, vanno imputatiunicamente a chi scrive.Tor<strong>in</strong>o, dicembre 200311
.12
I – Che cosa c’è nell’ontologia di <strong>Wolff</strong>Notio entis <strong>in</strong> genere existentiam m<strong>in</strong>ime <strong>in</strong>volvit, sed saltemnon repugnantiam ad existendum, seu, quod per<strong>in</strong>de est, existendipossibilitatem.<strong>Wolff</strong>, <strong>Ontologia</strong> § 134Das erste, was bei der Metaphysik betrachtet wird, ist dasWort Gegenstand, welchem hernach alle andere Begriffe untergeordnets<strong>in</strong>d. Es ist der allgeme<strong>in</strong>e, der höchste Begriff <strong>in</strong> der Ontologie.Er ist möglich oder unmöglich, D<strong>in</strong>g oder Und<strong>in</strong>g.Kant, Metaphysik (Dohna-Wundlacken)Una delle prime storie dell’ontologia può essere <strong>in</strong>contrata, sotto formadi annotazioni sparse ma coerenti, <strong>in</strong> un repertorio di larga e costantediffusione nell’ambito dell’illum<strong>in</strong>ismo tedesco, il PhilosophischesLexicon di Walch (1726), che complessivamente registra (tentando dimediarli) i molti contrasti teorici fra aristotelismo scolastico e cartesianesimo1 . Qui, alla prima voce che <strong>in</strong>teressa, troviamo che “ontologia”significala dottr<strong>in</strong>a dell’ente, ed è una denom<strong>in</strong>azione con cui alcuni nuovi metafisiciconnotano la metafisica, <strong>in</strong>tendendo la scienza che tratta dell’ente <strong>in</strong> generalee delle sue proprietà […] In tempi recenti ci si è limitati a questa dottr<strong>in</strong>a,mentre la dottr<strong>in</strong>a degli spiriti fu assegnata a una nuova discipl<strong>in</strong>a che ricevetteil nome di pneumatica; a ogni modo, ad alcuni il titolo di ontologia piacquepiù di quello di metafisica (WALCH 1726, ad voc. “Ontologie”).Walch esibisce una certa <strong>in</strong>differenza, se non un vero e proprioscetticismo, circa la necessità di una dist<strong>in</strong>zione discipl<strong>in</strong>are tra ontologiae metafisica, almeno laddove quest’ultima venga <strong>in</strong>tesa (come èappunto da “alcuni nuovi metafisici”) nei term<strong>in</strong>i di una scienza“dell’ente <strong>in</strong> generale e delle sue proprietà”. E, <strong>in</strong> effetti, per trovarealtre s<strong>in</strong>tomatiche note sulla storia recente di questa scienza converrà<strong>in</strong>dirizzarsi alla voce “metafisica”. Qui, dopo averne registrato il sen-1 Per un <strong>in</strong>quadramento più dettagliato di Walch cfr. EUCKEN (1879), TONELLI (1971),HENNE, a cura di (1975).13
so em<strong>in</strong>entemente teologico nell’antichità 2 , nonché la decadenza dalpunto di vista del valore scientifico nella scolastica (un regresso unitoperaltro a un’espansione che la rende quasi popolare fra i dotti) 3 , osservache nei tempi modernila parola metafisica ha dovuto sopportare altre e diverse vicissitud<strong>in</strong>i. Molticon essa <strong>in</strong>tendevano la dottr<strong>in</strong>a dell’essenza, o dell’ente e delle sue proprietà,e ne dist<strong>in</strong>guevano la teologia naturale, r<strong>in</strong>viandola a una nuova discipl<strong>in</strong>ache chiamavano pneumatica, o dottr<strong>in</strong>a degli spiriti. Altri l’hanno chiamataontologia, oppure ontosofia, e ugualmente ne hanno dist<strong>in</strong>ta la dottr<strong>in</strong>adegli spiriti. Altri ancora ne hanno ricavato la religione naturale, e alcuni2 “La metafisica non era altro se non la dottr<strong>in</strong>a della conoscenza naturale di Dio, al cui<strong>in</strong>izio compariva generalmente la trattazione della sua essenza e dei suoi attributi, ed eranota tra i filosofi già prima di Aristotele” (WALCH 1726, ad voc. “Metaphysic”). Sulla dist<strong>in</strong>zione,propria dei moderni, tra una “philosophia prima” sviluppata <strong>in</strong> prospettivateologica e una “philosophia generalis” sviluppata, <strong>in</strong>vece, <strong>in</strong> una prospettiva più astrattamenteontologica si tornerà presto. Rimarrà assente <strong>in</strong> simili visioni storiche, e f<strong>in</strong>o <strong>in</strong>età contemporanea, ogni consapevolezza del problema costituito dal significato equivocodel verbo “essere” utilizzato come copula, e specialmente ogni riflessione sulla differenzatra il suo significato esistenziale e altri suoi usi nel giudizio. Sulla trattazione sistematicadi questa differenza a partire dall’opera di Frege e Russell, cfr. HINTIKKA (1986);sull’applicazione storiografico-<strong>in</strong>terpretativa del riconoscimento di questo problema teorico,che <strong>in</strong> special modo ha importato profonde revisioni nella lettura delle teorie logichee ontologiche di Aristotele, cfr., oltre ai saggi contenuti <strong>in</strong> KNUUTILA - HINTIK-KA, a cura di (1986), almeno STERN - HOURANI - BROWN, a cura di (1972), MOREWED-GE, a cura di (1982).3 “Al tempo degli scolastici la metafisica perse talmente tanto della propria essenza, danon comprendere altro che la mera protheoria di Aristotele, e si dovette trasformare <strong>in</strong> unmisero vocabolario. La metafisica scolastica è un lessico filosofico composto di oscuriterm<strong>in</strong>i tecnici, fatto per coloro i quali preferiscono parlare <strong>in</strong> modo oscuro piuttostoche chiaro, e consiste di numerose <strong>in</strong>utili astrazioni che <strong>in</strong> sé e per sé non procurano ilm<strong>in</strong>imo vantaggio. Nel frattempo, i term<strong>in</strong>i metafisici si sono <strong>in</strong>s<strong>in</strong>uati <strong>in</strong> tutte le facoltà[…] e benché la maggioranza dei nuovi filosofi avesse riconosciuto che conteneva moltissimecose <strong>in</strong>utili e sciocche, non ha potuto denunciarle come totalmente <strong>in</strong>utili a motivodei tanti libri <strong>in</strong> cui tali parole compaiono” (WALCH 1726, ad voc. “Metaphysic”).Nei “Prolegomeni” alla propria <strong>Ontologia</strong>, <strong>Wolff</strong> presenterà quest’opera non come unarevoca e sostituzione, bensì come una riforma, posta sotto il segno della “emendatio”,del patrimonio di term<strong>in</strong>i (e di corrispondenti nozioni) contenuto nella “philosophiaprima” degli scolastici, svolta nella scia delle <strong>in</strong>dicazioni metodiche di Cartesio (soprattutto)e di Leibniz (Ont § 7). In tal senso, l’ontologia degli scolastici appare a <strong>Wolff</strong> unpatrimonio di term<strong>in</strong>i e nozioni chiare, benché confuse, al pari dell’ontologia naturalmentedata con i term<strong>in</strong>i del parlare comune (Ont §§ 10 ss.). Sulla collocazione complessivadi <strong>Wolff</strong> rispetto alla metafisica scolastica (compreso il problema della delimitazionewolffiana di quest’ultima) cfr. ÉCOLE (2001a).14
con questa parola <strong>in</strong>tendono una scienza dell’essenza generale di tutte le cosee della differenza fondamentale tra spirito e materia, e ritengono che potrebbevenire chiamata così una conoscenza dell’essenza, dello spirito e dellamateria, <strong>in</strong> accordo con tutto ciò che si può ricavare dalla storia della metafisica(WALCH 1726, ad voc. “Metaphysic”).Walch non fa nomi, ma, guardando alla letteratura storiograficasull’argomento, ormai ben matura, non sarebbe difficile <strong>in</strong>dividuarnei riferimenti impliciti ad autori centrali <strong>in</strong> un doppio sviluppo dellastoria delle idee – la metodizzazione del complesso delle scienze e lacontestuale ridef<strong>in</strong>izione della metafisica – entro cui l’opera cartesianaha funto da catalizzatore. Da questo punto di vista, la nascita discipl<strong>in</strong>aredell’ontologia, che decisamente favorisce l’accoglienza dell’<strong>in</strong>siemedelle proposte cartesiane 4 , appare cioè l’esito di uno svilupposegnato da due componenti: da un lato, i tentativi di sistematizzazioneorganica delle discipl<strong>in</strong>e filosofiche, <strong>in</strong>fluenzati dalla ricercamoderna di un metodo scientifico unico e universale 5 ; dall’altro, la4 Qui l’<strong>in</strong>fluenza di Cartesio va al di là del solo momento metodico e, per la concezionedell’ontologia moderna, ovvero di tipo wolffiano, risulta sostanziale: “Il cartesianesimoebbe <strong>in</strong>fluenza anche sulla nozione di ‘ontologia’. Johannes Clauberg dist<strong>in</strong>gue tre generidi entia: l’essere <strong>in</strong> quanto pensabile (ens cogitabile), l’essere <strong>in</strong> quanto <strong>qualcosa</strong> (aliquid) el’essere <strong>in</strong> quanto cosa, ovvero ente sostanziale (res sive ens substantiale). L’ontologia o ‘ontosofia’tratta dell’essere <strong>in</strong>teso nel terzo senso e presuppone la scienza delle cose pensabili,o, <strong>in</strong> altri term<strong>in</strong>i, la metafisica o ‘filosofia prima’ come è elaborata da Cartesionelle Meditationes (cfr. Clauberg, Metaphysica de Ente, quae rectius Ontosophia, 1664, 1, 1-5)”(FREULER L., ad voc. “Ontology. I: History of ontology”, <strong>in</strong> BURKHARDT - SMITH, a curadi, 1991).5 Si potrebbe, anzi, sostenere che l’istanza metodica così <strong>in</strong>tesa non ha dovuto attendereCartesio per affermarsi come dom<strong>in</strong>ante nella costituzione di una metafisica generale.Da questo punto di vista, prima dell’affermazione del cartesianesimo, risulta centralel’anteriore passaggio – antiscolastico – da un paradigma metodico che privilegia il rapportofra parole e cose a un paradigma che privilegia, <strong>in</strong>vece, il rapporto tra acquisizionedi un sistema delle conoscenze e cose, specie quando riferito al problema dell’acquisizionee della trasmissione di un’enciclopedia dei saperi. E qui appare l’importanza perla storia dell’ontologia moderna di un autore come Johannes Alsted (1588-1638), cuiDiderot, nell’articolo “Leibnitianisme” della Encyclopédie, f<strong>in</strong>irà per riconoscere tale merito(cfr. TEGA 1984: 18). Sul piano metodologico, Alsted si orienta <strong>in</strong>fatti sugli <strong>in</strong>segnamentidi Lullo e di Ramo (cfr. ibidem, 19), specialmente nella promozione di un ord<strong>in</strong>edel sapere che rifletta lo svolgersi naturale del pensiero, dist<strong>in</strong>guendo l’atto conoscitivodalla sua formulazione l<strong>in</strong>guistica, spesso imposta <strong>in</strong> maniere arbitrarie e fuorvianti. Nellasua opera più <strong>in</strong>fluente, la Encyclopaedia septem tomis dist<strong>in</strong>cta (1630), la prima delle scienzeteoretiche – trattate dopo quattro “res praecognoscendae” (ossia gli abiti dell’<strong>in</strong>-15
e<strong>in</strong>terpretazione ultimoscolastica del significato aristotelico della metafisica6 . Ciò che nel Seicento manca alla scienza generale dell’“ens <strong>in</strong>quantumens” – che <strong>in</strong> tale quadro, viene da dire, spontaneamente sicostituisce – è spesso soltanto un nome unico e stabile, che le saràperò attribuito nel volgere di pochi decenni 7 .telletto, le rispettive qualità e l’organizzazione delle discipl<strong>in</strong>e, <strong>in</strong>di i pr<strong>in</strong>cipi e, <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e, iprecetti relativi allo studio di quest’ultime) e sei “artes” (da <strong>in</strong>tendersi come l’<strong>in</strong>siemedelle tecniche del discorso volte a garantirne la perfezione) – è la metafisica, <strong>in</strong>terpretatacome scienza “dell’ente <strong>in</strong> quanto ente” (ALSTED 1630: I, X). Per un più dettagliato <strong>in</strong>quadramentodi Alsted, cfr. SCHMIDT-BIGGEMANN (1983), HOTSON (2000).6 Rispetto a ciò risulta centrale il contributo delle Disputationes metaphysicae (1597) diFrancisco Suárez (1548-1617), con cui risulta pienamente del<strong>in</strong>eata una scienza tematicamenteontologica: è Suárez, <strong>in</strong>fatti, che prepara la decisiva dist<strong>in</strong>zione tra una “metaphysicageneralis” (come scienza dell’“ens <strong>in</strong>quantum ens”, appunto la futura ontologia)e una “metaphysica specialis” (scienza delle diverse specie degli enti). Rispetto a tale esito,vale però sottol<strong>in</strong>eare come già nella lezione aristotelica viga l’ambiguità per cui lametafisica o “filosofia prima” viene determ<strong>in</strong>ata ora come scienza teologica (ovverocome scienza dell’ente sommo), ora come scienza dell’ente <strong>in</strong> generale. Tommaso, a suavolta, <strong>in</strong>tenderà la metafisica, da un lato, come scienza della “ratio entis” <strong>in</strong> quanto “enscommune”, ma dall’altro considererà tale “ens commune” come “ens causatum”, cioèrisultato della creazione. L’“ontologia” di Tommaso si costituisce così come una scienzadell’essere specificamente creaturale, il quale possiede l’essere solo nella misura <strong>in</strong> cuipartecipa dello “ipsum esse subsistens” proprio solamente di dio. Grazie all’<strong>in</strong>fluenza diScoto, la metafisica <strong>in</strong> quanto scienza prima acquisisce però un peculiare carattere noetico,basandosi su un concetto dell’“ens commune” volto a def<strong>in</strong>irne il carattere oggettuale ritrattonella relativa “raepresentatio”. L’ente <strong>in</strong>teso nella sua massima astrazione co<strong>in</strong>cideallora con l’“esse obiectivum”, ovvero “cognitum”, cioè quell’essere che viene adeguatamentepensato e il cui venire pensato non costituisce perciò una determ<strong>in</strong>azione e-str<strong>in</strong>seca rispetto all’oggetto <strong>in</strong> quanto esistente al di là dell’<strong>in</strong>telletto. Con Suárez, dunque,nella l<strong>in</strong>ea di Scoto, la metafisica generale (ormai dist<strong>in</strong>ta da quella scienza assiologicamente“prima” che è la teologia) passa <strong>in</strong> maniera stabile da una def<strong>in</strong>izione ancoraampia e oscillante (scienza dell’essere come totalità dell’ente, ovvero dello “ens commune”)a quella di scienza di ogni oggetto <strong>in</strong> quanto conoscibile, ossia dell’“ens <strong>in</strong> quantumens reale” – dove “ens reale” non <strong>in</strong>dica la cosa <strong>in</strong> quanto “esiste” al di là dell’oggettivazionedell’<strong>in</strong>telletto, ma si riferisce all’essenza di una cosa <strong>in</strong> quanto può essere pensatacome possibile. L’evoluzione filosofica qui sommariamente riassunta risulta stabilmenteconsegnata all’<strong>in</strong>terpretazione storica contemporanea grazie ai lavori di VOLL-RATH (1962), FERRATER MORA (1963), COURTINE (1990), HONNEFELDER (1990),BOULNOIS (1999), CARBONCINI (2001) e, specie rispetto a <strong>Wolff</strong>, ÉCOLE (1990, 2001a,2001b, 2001c).7 Il term<strong>in</strong>e “ontologia” come s<strong>in</strong>onimo di scienza dell’ente (reale e conoscibile, <strong>in</strong>tesonel suo senso sommamente generale) compare nel 1613 come annotazione a marg<strong>in</strong>edell’articolo “Abstractio”, nel Lexicon philosophicum di Goclenio (1517-1628; aristotelico eramista, è pure autore di una Psychologia, 1590). Poi, con Clauberg (1622-1665), anche sesotto un titolo diverso (Ontosophia, 1647; Ontosophia nova, quae vulgo metaphysica, 1660), <strong>in</strong>iziano<strong>in</strong> grande stile i tentativi di conciliazione fra l’ultima dottr<strong>in</strong>a scolastica dell’“ens16
Permane <strong>in</strong> tutto ciò (e rimane irrisolta s<strong>in</strong>o alla nostra contemporaneità)una difformità fondamentale nel modo di <strong>in</strong>tendere l’ontologia– anche una volta circoscritta la “scienza dell’ente <strong>in</strong> quanto ente”.Si tratta della discrepanza tra la def<strong>in</strong>izione moderno-aristotelica discienza delle proprietà più generali che vanno riconosciute all’essere equella che riferisce, <strong>in</strong>vece, l’ontologia a questioni riguardanti il temadell’esistenza, ovvero a domande del tipo “che cosa c’è?”.1. Res, quatenus est aliquid (ontologie di tipo wolffiano)Volendo appoggiarsi alle autorità contemporanee, si possono <strong>in</strong>contrarediverse def<strong>in</strong>izioni medie (o talvolta compromissorie) dell’ontologia,che di norma la riferiscono a un campo specifico e <strong>in</strong>ternoalla metafisica – e che, quando non sono percorse da uno scetticismoanalogo a quello di Walch, si <strong>in</strong>volgono tuttavia <strong>in</strong> alcuni problemipersistenti. Si può, ad esempio, leggere che l’<strong>in</strong>tero della metafisicasi del<strong>in</strong>eerebbe come “l’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e più generale circa la naturadella realtà”, volta alla ricerca di “pr<strong>in</strong>cipi che valgano per ogni cosache sia reale, per tutto ciò che è” (CRAIG E., ad voc. “Metaphysics”, <strong>in</strong>Routledge Encyclopedia of Philosophy, 1998). E se, più strettamente, “dellanatura particolare delle cose esistenti non consideriamo ciò che le dist<strong>in</strong>guel’una dall’altra”, possiamo <strong>in</strong>dagarne la realtà “unicamente <strong>in</strong>virtù del fatto che esistono” (ibidem). In conclusione, il rapporto frametafisica e ontologia si configurerebbe così:la metafisica è strettamente legata all’ontologia, che normalmente si consideracomprendere entrambe le questioni ‘che cos’è l’esistenza (ovverol’essere)?’ e ‘quali tipi (fondamentalmente dist<strong>in</strong>ti) di cose esistono?’ (ibidem).Viste più da vic<strong>in</strong>o, def<strong>in</strong>izioni di questo genere appaiono subitopercorse da una duplice tensione: sia <strong>in</strong>ternamente alla metafisica, rispettoa cui l’ontologia vuole essere def<strong>in</strong>ita, sia <strong>in</strong>ternamente all’oncommune”,di ascendenza ancora aristotelica, e la nuova metafisica cartesiana – nel corsodei quali si metterà via via <strong>in</strong> luce il ruolo problematico della <strong>psicologia</strong> nel determ<strong>in</strong>areil rapporto fra teoria della conoscenza e ontologia.17
tologia, la cui questione centrale non appare affatto univoca. Risultacioè, <strong>in</strong> primo luogo, quantomeno problematico tracciare il conf<strong>in</strong>eche, entro alla metafisica <strong>in</strong> quanto <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e sulla “natura ultima ditutto ciò che esiste” (VARZI 2002: 158), circoscriverebbe l’ontologia<strong>in</strong> quanto discipl<strong>in</strong>amento della questione dell’esistenza. Se l’ontologiasi pone <strong>in</strong>fatti l’obiettivo, prelim<strong>in</strong>are a quello della metafisica, distilare un “<strong>in</strong>ventario del mondo” (ibidem), non sarà difficile cogliere<strong>in</strong> essa una tensione irrisolta: quella fra il compito generico di compilaresemplicemente un simile <strong>in</strong>ventario (“stabilire che cosa esiste”, ibidem)e il compito più specifico di “fissare dei criteri per stabilire checosa sia ragionevole <strong>in</strong>cludere <strong>in</strong> un accurato <strong>in</strong>ventario del mondo”(ibidem). Tale secondo obiettivo, <strong>in</strong> effetti, non pare facilmente conseguibilesenza optare per una qualche epistemologia 8 .Quale sia lo sfondo teorico di una simile lessicografia contemporaneaè presto esplicitabile 9 . Portandosi sui terreni <strong>in</strong> cui simili def<strong>in</strong>izionivengono effettivamente spese, si <strong>in</strong>contrano diverse argomentazionistandard che le giustificano mediante un loro uso più omeno efficace e che, di norma, si orientano sulla posizione assunta daQu<strong>in</strong>e nel rispondere alla questione ontologica “che cosa c’è?” – posizionesecondo cui “essere” <strong>in</strong>teso nel significato di esserci, ovverodi esistere, “è, puramente e semplicemente, essere il valore di una variabile”(QUINE 1948-49: 32). (Allo scopo di renderla più maneggevole,non è parso poi troppo sbagliato tradurre tale formula <strong>in</strong> altre,del tipo di: “esiste ciò di cui può essere detto <strong>qualcosa</strong> di vero” – dove“dire <strong>qualcosa</strong> di vero su <strong>qualcosa</strong>” può comunque assumere sensidiversi, sott<strong>in</strong>tendendo altrettanti problemi metafisici non <strong>in</strong>teramenteriducibili sul piano semantico) 10 . Nello sviluppo delle riflessioni su8 In ciò che segue non verrà seguito l’uso, attuale e sempre più dilatato, di <strong>in</strong>tendere “epistemologia”come calco dell’<strong>in</strong>glese “epistemology”. Si rispetterà, <strong>in</strong>vece, la dist<strong>in</strong>zionetra “gnoseologia” ed “epistemologia”, <strong>in</strong>tendendo la prima come teoria della conoscenza<strong>in</strong> senso lato (riferita al problema di come sia possibile acquisire credenze vere) ela seconda, più specificamente, come teoria della conoscenza scientifica (riferita ai problemidi dist<strong>in</strong>guere le semplici credenze vere dalle conoscenze propriamente scientifiche,nonché di come sia possibile acquisire tali conoscenze).9 Sul processo storico del suo costituirsi nello scorso secolo, cfr. almeno HILL (1991) eDEJNOZKA (1996).10 In questo medesimo scritto, lo stesso QUINE, riconosciuto che tale formula si collocasu un piano strettamente semantico (1948-49: 34), precisa subito che essa è perciò <strong>in</strong>-18
tale formula, si è poi consolidata la concezione per cui l’assumere un“impegno ontologico” verso una qualche entità (un atto di credenzache per Qu<strong>in</strong>e non riguarda affatto il solo discorso scientifico; ibidem,32) ne richiede l’<strong>in</strong>serimento <strong>in</strong> una rete di conoscenze, epistemologicamentequalificabili e giudicabili 11 . Ora, secondo una delle ormaimolte delucidazioni di tale posizione, per Qu<strong>in</strong>e “il problema di decidereche cosa bisogna credere che esista è, molto semplicemente, uncaso speciale del problema di decidere che cosa bisogna credere” <strong>in</strong>generale (INWAGEN 1998: 17). Dunque, andando a un’applicazioneparticolare della prospettiva qu<strong>in</strong>eana, si può dire ad esempio chese vogliamo decidere se credere, o meno, che esistano le proprietà [<strong>in</strong> quantoentità universali], Qu<strong>in</strong>e ci dice che dovremmo esam<strong>in</strong>are le credenze che giàabbiamo, e vedere se qualcuna di esse ci sp<strong>in</strong>ge a impegnarci rispetto all’esistenzadelle proprietà. Se è così, allora abbiamo una ragione per credere nell’esistenzadelle proprietà: si tratta di una qualunque delle ragioni che avevasufficienteallo scopo di prendere positivamente posizione rispetto a un’ontologia fradiverse ontologie concorrenti, <strong>in</strong> quanto serve, piuttosto, a “valutare la conformità diuna determ<strong>in</strong>ata asserzione o dottr<strong>in</strong>a a un precedente criterio ontologico” (ibidem, 34-35). In altri term<strong>in</strong>i: “consideriamo determ<strong>in</strong>ate variabili dipendenti <strong>in</strong> quanto collegate aun’ontologia non per sapere che cosa c’è, bensì per sapere che cosa una determ<strong>in</strong>ataasserzione o dottr<strong>in</strong>a, nostra o di altri, dice che c’è” (ibidem). Sicché, <strong>in</strong> conclusione, perQu<strong>in</strong>e l’accettazione di un’ontologia fra altre è “simile <strong>in</strong> l<strong>in</strong>ea di pr<strong>in</strong>cipio alla nostraaccettazione di una teoria scientifica […]: adottiamo, almeno <strong>in</strong> quanto siamo esseri ragionevoli,lo schema concettuale più semplice <strong>in</strong> cui possano venire <strong>in</strong>seriti e sistemati iframmenti disord<strong>in</strong>ati dell’esperienza grezza” (ibidem).11 La questione della formalizzabilità di tale dottr<strong>in</strong>a, altro lascito qu<strong>in</strong>eano fra i più presenti<strong>in</strong> letteratura, ha più volte suscitato obiezioni circa la pretesa riducibilità delle questioniesistenziali al problema del trattamento logico-formale del “quantificatore esistenziale(∃)” – a sua volta legata al problema semantico della pretesa univocità delle predicazioni(o pseudopredicazioni) esistenziali espresse nelle l<strong>in</strong>gue naturali (cfr. esemplarmentePUTNAM 1992). In proposito, si sceglie qui di assumere, data la sua apertura, laposizione di Inwagen: “La tendenza dei filosofi a collegare al quantificatore esistenzialele questioni relative all’impegno ontologico è (per un verso) del tutto giustificata, ma(per un altro) <strong>in</strong> qualche modo fuorviante. È giustificata, perché ogni formulazione pienamenteadeguata dal punto di vista tecnico delle tesi di Qu<strong>in</strong>e relative all’impegno ontologicodeve servirsi del quantificatore esistenziale e del dispositivo formale a esso correlato delle‘variabili dipendenti’. È fuorviante, perché suggerisce che sia impossibile presentareun resoconto dei problemi filosofici essenziali contenuti <strong>in</strong> tali tesi senza <strong>in</strong>trodurre, ad uncerto punto, il quantificatore esistenziale – e non semplicemente il suo simbolo, mal’apparato tecnico che ne governa l’uso nella logica formale, <strong>in</strong>sieme con le varie disputefilosofiche che sono sorte riguardo alla sua ‘<strong>in</strong>terpretazione’. E questo è falso” (INWAGEN1998: 20-21, n. 6).19
mo per accettare la credenza che ci impegna rispetto all’esistenza delle proprietà– unita alla generale esigenza <strong>in</strong>tellettuale che, se qualcuno si rendeconto che la propria credenza che p lo impegna alla ulteriore credenza che q,allora costui dovrebbe o credere che q, o smettere di credere che p (INWA-GEN 1998: 18).E ancora, <strong>in</strong> un lavoro che (ad esempio) sceglie di sposare la concezionequ<strong>in</strong>eana dell’impegno ontologico e di utilizzarla rispetto aun’entità specifica come è l’opera d’arte, vediamo osservare prelim<strong>in</strong>armenteche nessuna discipl<strong>in</strong>a specifica “<strong>in</strong>izia con l’asserzione ‘xè’ o ‘x ha essere’, dove x è la ‘cosa’ o l’oggetto particolare (qui, l’oggettoartistico) che viene da essa considerato” (PELTZ 1966: 490).D’altro canto, “ogni discipl<strong>in</strong>a presuppone – come dice Aristotele –che quell’asserzione sia vera” (ibidem). E poiché “le asserzioni che unadiscipl<strong>in</strong>a effettivamente avanza circa x e che sono vere suggerisconoquali siano le condizioni che rendono vera ‘x è’”, risulta possibile circoscriverei presupposti esistenziali di ogni s<strong>in</strong>golo discorso scientifico,laddove “la discussione di tali condizioni è il territorio tradizionaledell’ontologia” (ibidem).Def<strong>in</strong>izioni e argomenti di questo tipo, <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e, assumono spesso lafunzione di medio fra due ambiti di ricerca. Collegano cioè, da un lato,gli studi storici, ormai ben consolidati, che ricostruiscono i passaggiattraverso cui nella filosofia moderna si è venuta a costituirel’ontologia come metafisica generale (ovvero come scienza della realtàdegli enti e delle loro proprietà comuni); e, dall’altro, la promozionedei molto più recenti <strong>in</strong>teressi applicativi di cui si è fatta carico unascienza formale della categorizzazione (ovvero della classificazione)degli enti 12 . E qui si <strong>in</strong>contra un primo problema effettivo: quello dell’attualecompresenza di due differenti, quando non discrepanti, determ<strong>in</strong>azionidiscipl<strong>in</strong>ari dell’ontologia – che pure appartengono auna medesima tradizione di ricerca 13 . L’odierna ricerca ontologica, <strong>in</strong>-12 Sull’accezione contemporanea di ontologia come dottr<strong>in</strong>a formale delle categorie cfr.esemplarmente CHISHOLM (1992). Sul percorso che ha portato la scienza e l’<strong>in</strong>gegneriadell’<strong>in</strong>formazione ad avvic<strong>in</strong>arsi a tale accezione di ontologia, cfr. SMITH - WELTY(2001) e, ancor più recentemente, DAVIES, a cura di (2003).13 La formula “tradizione di ricerca” viene qui usata <strong>in</strong> senso tecnico per <strong>in</strong>dicareun’<strong>in</strong>tegrazione, che sia stabile almeno <strong>in</strong> una storia di medio periodo, fra decisioni circal’impegno relativo agli oggetti di <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e propri di una discipl<strong>in</strong>a e decisioni epistemo-20
fatti, oscilla fra due tendenze diverse: la prima (secondo il luogo comunequ<strong>in</strong>eano appena evocato) <strong>in</strong>tende come proprio compito quellodi determ<strong>in</strong>are che cosa propriamente esista, ruotando, <strong>in</strong>somma,per <strong>in</strong>tero attorno al problema dell’“impegno ontologico”. Ma è dallascienza dei predicati sommamente generali che spettano all’ente cheappare piuttosto discendere l’altra def<strong>in</strong>izione contemporanea di ontologia,decl<strong>in</strong>ata come una scienza formale delle categorie. E proprioqui <strong>in</strong>contriamo frequentemente <strong>Wolff</strong>, spesso <strong>in</strong>trodotto nel ruolodi una vera e propria icona 14 .L’ontologia è una parte della metafisica, e se Aristotele non ha mai parlatodi “metafisica”, a maggior ragione non si sarebbe mai sognato di parlare di“ontologia”. Moltissimi secoli dopo, Francisco Suárez (1548-1617) avevamesso un po’ di ord<strong>in</strong>e <strong>in</strong> materia, e l’aveva dist<strong>in</strong>ta <strong>in</strong> una metafisica generale,che tratta dell’ente <strong>in</strong> quanto ente, e <strong>in</strong> una metafisica speciale, che trattadella <strong>psicologia</strong>, della teologia e della cosmologia razionali. Nel 1656, uncartesiano tedesco, Johannes Clauberg, trovò un nome per la scienza dell’ente<strong>in</strong> quanto ente: “ontosofia” (Metaphysica de ente, quae rectius Ontosophia, aliarumDiscipl<strong>in</strong>arum, ipsiusque quoque Jurisprudentiae et Litterarum, studiosis accomodata). Eall’<strong>in</strong>izio del Settecento quell’immenso e candido pedante di Christian <strong>Wolff</strong>cambiò un po’ il nome e dedicò il primo trattato all’argomento, che si <strong>in</strong>titolòPhilosophia prima sive <strong>Ontologia</strong> (1730) (FERRARIS 2001b) 15 .logiche circa il metodo di <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e a essi adeguato (cfr. LAUDAN 1977). Si approfitta diquesta precisazione per <strong>in</strong>trodurne una seconda: <strong>in</strong> tutto ciò che segue non verrà preso<strong>in</strong> esame il caso dell’ermeneutica, ritenendo che senza la posizione di una sferadell’essere autonomo rispetto a ogni considerazione epistemologica (e dunque, a maggiorragione, l<strong>in</strong>guistico-<strong>in</strong>terpretativa), più che di fronte a una soluzione teorica, ancheradicale, collocata entro quella tradizione di ricerca che si denom<strong>in</strong>a, almeno da qualchesecolo, “ontologica”, ci si trova d<strong>in</strong>anzi al suo abbandono.14 Andando al di là del campo più ristretto costituito dall’ontologia, va registrato comeun serio <strong>in</strong>teresse – storico e teorico – per <strong>Wolff</strong> sia maturato solo <strong>in</strong> anni piuttosto recenti.Come rileva Biller, il 60% dei titoli da lui raccolti (e la sua bibliografia si chiude sul1985) sono posteriori al 1960, mentre il restante 40% si distribuisce sui 160 anni precedenti(BILLER 1986: 322). Anche senza voler fornire dati statistici altrettanto precisi, ci sipuò facilmente sp<strong>in</strong>gere ad affermare che dal 1985 ad oggi tale situazione della ricerca èdiventata ancora più evidente.15 Il plot storiografico qui efficacemente accennato su un piano divulgativo viene daFERRARIS utilizzato altrove per appoggiarvi una lettura orig<strong>in</strong>ale del significato discipl<strong>in</strong>aredi “ontologia” (cfr. almeno, ultimamente, 2001a), nonché situato <strong>in</strong> una più ampiae dettagliata ricostruzione storica (2003).21
Però, a questo punto, i conti non sembrano tornare più. Se, <strong>in</strong>fatti,le due questioni fondamentali dell’ontologia contemporanea sonoquella per cui ci si <strong>in</strong>terroga su come vada <strong>in</strong>teso il verbo “esistere” equella per cui ci si chiede “che cosa c’è?”, va registrato come <strong>Wolff</strong>paia metterle fuori gioco, quando afferma che “la nozione di ente <strong>in</strong>generale non comprende affatto l’esistenza, ma soltanto la non <strong>in</strong>compatibilitàcon l’esistenza” (Ont § 134). In altre parole: mentre lanozione di impegno ontologico promossa da Qu<strong>in</strong>e richiede di procederedai contenuti di un sistema di credenze alla credenza, da essigiustificata, nel darsi di entità cui tali credenze sono riferite, la nozioneontologica centrale per <strong>Wolff</strong>, quella di possibilità, richiede <strong>in</strong>vecedi procedere risalendo dalla posizione esistenziale di un’entità qualsiasiall’estensione del catalogo dei predicati più generali che essa, <strong>in</strong>quanto entità possibile, deve poter sostenere 16 . Ovvero, <strong>in</strong> altri term<strong>in</strong>iancora, risulta qui aprirsi uno iato evidente (storico? teorico?) tra lachiarificazione della domanda “che cosa c’è?” (con i relativi tentatividi stilare un “<strong>in</strong>ventario del mondo”), da un lato, e, dall’altro, le <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>idella metafisica generale <strong>in</strong>tesa come scienza dell’ente <strong>in</strong> quantoente – che, almeno nella versione esemplarmente datale da <strong>Wolff</strong>,non appare <strong>in</strong>centrata su questioni esistenziali, comunque <strong>in</strong>tese.Pare allora necessario chiedersi come vada <strong>in</strong>terpretata complessivamentel’ontologia wolffiana: semplicemente come un caso storico,emblematico di una condizione primitiva di questa discipl<strong>in</strong>a, <strong>in</strong> cuicioè la questione dell’esistenza veniva soltanto “prefigurata”, o nonera ancora matura? Oppure come una risposta teorica, <strong>in</strong> sé degna diattenzione, a un problema ontologico che si pretende fondamentale e16 Uno degli elementi metodici centrali dell’ontologia wolffiana consiste nell’applicazionedella regola scolastica (riconosciuta peraltro appartenere alle nozioni di senso comune)secondo cui “ciò che esiste, è possibile” (Ont § 170), mentre “la conclusione dalpoter essere all’essere non è valida, ossia: la conclusione dalla possibilità all’esistenza nonè valida” (Ont § 171). Una conseguenza ne è la radicale dist<strong>in</strong>zione fra le domande circail fondamento della possibilità di un ente (o di uno stato di cose) e le domande circa ilfondamento dell’esistenza di un ente (o di uno stato di cose): “Le due seguenti questionisono molto differenti: ‘perché un tavolo, che prima era di forma quadrata, adesso è diforma rotonda?’ e ‘perché un tavolo, che era di forma quadrata, ha potuto ricevere unaforma rotonda?’. E una sola e medesima risposta non è sufficiente per soddisfare entrambele questioni” (Ont § 172). Sulla dottr<strong>in</strong>a wolffiana dell’esistenza come “complementodella possibilità” <strong>in</strong> quanto <strong>in</strong>serita, a sua volta, <strong>in</strong> una teoria dell’ente come necessariamentepossibile, cfr. HONNEFELDER (1990: 363-371).22
non co<strong>in</strong>cidente con la questione dell’esistenza, o non riducibile a essa,benché quest’ultima abbia f<strong>in</strong>ito per imporsi come una delle formulecentrali della metafisica nello scorso secolo?Per tentare una risposta, occorrerà allora <strong>in</strong>nanzitutto mettere afuoco l’oggetto dell’ontologia di <strong>Wolff</strong>, riservando soltanto per il seguitoun’<strong>in</strong>terrogazione circa la specificità, <strong>in</strong> senso metafisico oppureontologico, della risposta di <strong>Wolff</strong> alla domanda sul “che cos’è” taleoggetto. Nei term<strong>in</strong>i wolffiani – non consonanti con quelli contemporanei– l’oggetto dell’ontologia come metafisica generale è dunquel’“ente <strong>in</strong> generale, ovvero <strong>in</strong> quanto è un ente” (Ont § 1; Disc § 73),dove però l’accento è posto sul carattere generico del suo oggetto, chepermette di trattare scientificamente di “ciò che è comune a tutti gli enti”,ossia delle “affezioni generali degli enti” (Disc § 73). Dal punto divista della genericità dei suoi attributi, allora, la nozione di “ente”, <strong>in</strong>quanto riferita alla sola possibilità della sua esistenza, risulta assorbitada quella di “cosa”, che ne <strong>in</strong>tende <strong>in</strong> primo luogo l’essenza come“quidditas”: “tutto ciò che è o che si può concepire come tale che possaessere viene detto cosa (res), <strong>in</strong> quanto è <strong>qualcosa</strong> (aliquid)” (Ont §243). Per <strong>Wolff</strong>, ogni stessa e medesima cosa – come verrebbe segnalatonella scolastica dalla s<strong>in</strong>onimia tra “essere reale (realitas) e essere<strong>qualcosa</strong> (quidditas)” (ibidem) – ha allora una doppia faccia: ad esempioun albero viene detto sia ‘ente’, sia ‘cosa’: viene detto ‘ente’, cioè, <strong>in</strong> quantose ne consideri l’esistenza, ma viene detto ‘cosa’ <strong>in</strong> quanto se ne consideril’essere <strong>qualcosa</strong>, ovvero <strong>in</strong> quanto è <strong>qualcosa</strong>, o <strong>in</strong> quanto gli corrispondauna qualche nozione determ<strong>in</strong>ata (ibidem).Certo è che, di questi due volti (o due nomi) dell’essente 17 , all’ontologiawolffiana importa il secondo. Da questo punto di vista, unatale ontologia pare scivolare <strong>in</strong> una dottr<strong>in</strong>a del possibile che “offendeil senso estetico” di coloro che, come Qu<strong>in</strong>e, agli universi sovraffollatiprediligono i deserti (QUINE 1948-49: 23) – m<strong>in</strong>acciando diammettere al proprio <strong>in</strong>terno anche “il possibile uomo grasso suquella soglia”, o “il possibile uomo calvo su quella soglia”, e, con ciò,17 HONNEFELDER (1990: 343) adotta per l’appunto <strong>in</strong> modo sistematico “Seiendes”come traducente sopraord<strong>in</strong>ato a entrambi.23
di fare strada a una folla di questioni <strong>in</strong> apparenza poco sensate come“Sono il medesimo uomo possibile, oppure sono due uom<strong>in</strong>i possibili?[…] Quanti uom<strong>in</strong>i possibili stanno su quella soglia? […] Quantidi essi si assomigliano?” (ibidem) 18 . Tuttavia, per quanto possa spiacere,un’ontologia di questo genere ha trovato nell’opera di <strong>Wolff</strong> la configurazionedel proprio tipo ideale. E, d’altro canto, a un’ontologia così<strong>in</strong>tesa si richiama, almeno <strong>in</strong> modo implicito, lo stesso QUINE (1951)quando vuole localizzare discipl<strong>in</strong>armente, cioè all’<strong>in</strong>terno della totalitàdel campo epistemologico, le proposizioni ontologiche <strong>in</strong>tese come leproposizioni teoriche meno legate a riferimenti empirici.2. Essenza ed esistenza (al marg<strong>in</strong>e dell’ontologia wolffiana)La def<strong>in</strong>izione wolffiana della filosofia come “scienza del possibile”(Disc § 29) 19 comprende dunque strettamente quella dell’ontologiacome “scienza dell’ente <strong>in</strong> generale, ovvero <strong>in</strong> quanto è un ente”(Disc § 73): la “filosofia prima” <strong>in</strong>tesa come scienza delle proprietàcomuni a tutti gli enti trova anzi il proprio centro teorico nella nozionedella possibilità di ogni <strong>qualcosa</strong> <strong>in</strong> generale (cfr. Ont Cap. III).Sicché, negli scritti di <strong>Wolff</strong> e della sua scuola sembra manifestarsiuna sorta di espunzione delle questioni propriamente esistenzialidall’ontologia. Ed è una caratteristica sistematica che spicca già a unprimo esame lessicografico. Ad esempio, il lessico di Walch (1726)registra ed esibisce ancora diverse <strong>in</strong>decisioni <strong>in</strong> tal senso.18 Più radicalmente si potrebbe leggere, qui, una contraddizione di Qu<strong>in</strong>e, ossia tra il suosenso estetico che predilige i deserti e il suo rispondere decisamente “tutto” alla domanda“che cosa c’è?” (QUINE 1948-49: 21). Tale contraddizione, <strong>in</strong> effetti, può venireletta come semplicemente apparente, o, piuttosto, come un semplice s<strong>in</strong>tomo del suofondamentale fisicismo (sul quale cfr. DILMAN 1984).19 Nella nota a questo medesimo paragrafo, <strong>Wolff</strong> tiene a sottol<strong>in</strong>eare la precocità con cuigiunse a tale determ<strong>in</strong>azione, ossia “nel 1703, quando mi risolsi a tenere lezioni private difilosofia presso l’Università di Lipsia” (Disc § 29). La prima comparsa di tale def<strong>in</strong>izione <strong>in</strong>una sua opera, come qui denunciato dallo stesso <strong>Wolff</strong>, la si ha nella nota del § 27 degliElementi di aerometria (1709; WGW II, 37) – dunque diversi anni prima della pubblicazionedella Logica tedesca (1713) con cui <strong>in</strong>izia propriamente la carriera del <strong>Wolff</strong> metafisico.24
Viene chiamata [esistenza] la qualità di una cosa data dal fatto che essa è veramentepresente, e nella nostra l<strong>in</strong>gua può venire detta l’essere di una cosa.[…] Altri dicono che sia ciò per cui <strong>qualcosa</strong> non rientra fra le proprie cause,mentre altri affermano che una cosa non rientra fra le proprie cause non,<strong>in</strong>nanzitutto, quanto alla sua esistenza, bensì quanto alla sua produzione, chene precederebbe l’esistenza (WALCH 1726, ad voc. “Existenz”).Dove però Walch non mostra <strong>in</strong>certezze è nell’assumere – <strong>in</strong> mododel tutto analogo a <strong>Wolff</strong> – che essenza ed esistenza siano due latidi una medesima cosa.I metafisici sogliono dire che essenza ed esistenza si dist<strong>in</strong>guerebbero ratione ratioc<strong>in</strong>ata,e che <strong>in</strong> effetti l’esistenza non può darsi mai senza l’essenza, né la secondasenza la prima; […] e <strong>in</strong> effetti è così: benché l’<strong>in</strong>telletto possa rappresentarsi econsiderare il concetto dell’esistenza <strong>in</strong> quanto isolata e separata dall’essenza, eper converso il concetto dell’essenza a presc<strong>in</strong>dere dal concetto dell’esistenza, <strong>in</strong>realtà queste si danno sempre <strong>in</strong>sieme. Soltanto, da ciò non segue che l’idea veradell’esistenza comprenda <strong>in</strong> sé anche un’idea vera dell’essenza (ibidem).Per contro, quello che varrà come il lessico wolffiano standard def<strong>in</strong>iscestrettamente la “cosa (D<strong>in</strong>g)”, cioè l’oggetto della metafisicagenerale, come “tutto ciò che è possibile, sia esso reale, o meno”(MEISSNER 1737, ad voc. “D<strong>in</strong>g”). Vedremo però presto come Meissner,per aderire alla lettera di <strong>Wolff</strong>, sia forse andato oltre le <strong>in</strong>tenzioniteoriche del maestro, meglio descritte – ed è questa una delle tesidi fondo del lavoro che segue – dalla voce di Walch.Non è dunque affatto scontato che un’ontologia “essenzialistica”,come è <strong>in</strong>negabilmente quella wolffiana, non conosca la questionedell’esistenza. Al contrario, proprio tale questione (<strong>in</strong>sieme con unasua soluzione peculiare) potrebbe venire scorta come centrale peruna scienza dell’ente <strong>in</strong> quanto ente, ovvero del necessariamente possibile,e delle sue determ<strong>in</strong>azioni fondamentali – solo, non <strong>in</strong> manierapalese. Innanzitutto, per quanto non appena posto venga subito quasicancellato, il problema dell’esistenza si colloca al centro dell’<strong>Ontologia</strong>– ed è un dato che si può ricavare considerando l’organizzazione deicontenuti di quest’opera. Secondo le sue l<strong>in</strong>ee pr<strong>in</strong>cipali, vi vengono<strong>in</strong>fatti trattati i pr<strong>in</strong>cipi ontologici di certezza, di contraddizione, diragione cui sottostà l’ente; qu<strong>in</strong>di la sua def<strong>in</strong>izione essenzialistica nei25
term<strong>in</strong>i di “tutto ciò che può essere” (DM § 16), ovvero di “ciò chepuò esistere, dunque ciò con cui non è <strong>in</strong>compatibile l’esistenza”(Ont § 134); <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e, i predicati più generali che gli possono spettare.E, producendo la serie di tali predicati, le regioni ontologiche pr<strong>in</strong>cipalisono circoscritte sulla base della più fondamentale partizione traenti semplici e composti (preparata dalle def<strong>in</strong>izioni di genere, speciee <strong>in</strong>dividuo, cfr. DM §§ 177 ss.; Ont P. I, S. 3, C. 3) riferibile complessivamentea una regione dello psicologico-spirituale e a una regionedel fisico 20 . Riducendo a questo schema (anche <strong>in</strong> vista di usifuturi) l’<strong>in</strong>dice dell’<strong>Ontologia</strong> abbiamo così:pr<strong>in</strong>cipi ontologicidottr<strong>in</strong>a della possibilità e def<strong>in</strong>izione di enteproprietà/predicati ontologiciPars I “De notione entis <strong>in</strong> genere, et proprietatibus,quae <strong>in</strong>de consequuntur”- Sect. I “De pr<strong>in</strong>cipiis philosophiae primae”- Cap. I “De pr<strong>in</strong>cipio contradictionis”,Cap. II “De pr<strong>in</strong>cipio rationis sufficientis”Sect. II “De essentia et existentia entis,agnatisque nonnullis notionibus”- Cap. I “De possibili et impossibili”,Cap. II “De determ<strong>in</strong>ato et <strong>in</strong>determ<strong>in</strong>ato”,Cap. III “De notione entis”Sect. III “De generalibus entis affectionibus”- Cap. I “De identitate et similitud<strong>in</strong>e”,Cap. II “De ente s<strong>in</strong>gulari et universali”,Cap. III “De necessario et cont<strong>in</strong>gente”,Cap. IV “De quantitate et agnatis notionibus”,Cap. V “De qualitate et agnatisnotionibus”, Cap. VI “De ord<strong>in</strong>e, veritateet perfectione”20 Da questo punto di vista, alla def<strong>in</strong>izione discipl<strong>in</strong>are wolffiana dell’ontologia comescienza dei predicati sommamente generici delle “cose” si lega <strong>in</strong>timamente il problemadell’<strong>in</strong>dividuazione delle diverse parti della “metafisica speciale” <strong>in</strong> quanto subord<strong>in</strong>ateall’ontologia <strong>in</strong>tesa come “metafisica generale” – posto che l’essenza determ<strong>in</strong>i, oltre allaconoscibilità, la specificazione reale dei diversi enti (DM § 33, Ont § 145). Sorvolandoper ora sulla liceità dell’<strong>in</strong>dividuare, come fa <strong>Wolff</strong>, <strong>in</strong> una “somiglianza di essenza” laragione dell’ord<strong>in</strong>arsi degli enti <strong>in</strong> specie via via più universali (DM § 177, Ont § 233), èpossibile scorgere qui le radici del problema odierno della determ<strong>in</strong>azione delle cosiddette“ontologie regionali” – particolarmente vivo nelle versioni tassonomistiche (spessole più legate a <strong>in</strong>teressi applicativi) dell’ontologia contemporanea.26
egioni ontologichePars II “De speciebus entium et eorumad se <strong>in</strong>vicem respectu”- Sect. I “De ente composito”- Cap. I “De essentia entis compositi”,Cap. II “De extensione, cont<strong>in</strong>uitate, spatioet tempore”, Cap. III “De qualitatibuset magnitud<strong>in</strong>e entis compositi”, Cap. IV“De motu”- Sect. II “De ente simplici”- Cap. I “De differentia entis simplicis etcompositi”, Cap. II “De modificationibusrerum, praesertim simplicium”, Cap. III“De f<strong>in</strong>ito et <strong>in</strong>f<strong>in</strong>ito”- Sect. III “De respectu entium ad se<strong>in</strong>vicem”- Cap. I “De dependentia rerumearumque relatione”, Cap. II “De causis”,Cap. III “De signo”Ma per <strong>in</strong>tendere appieno il ruolo della Sezione II dell’<strong>Ontologia</strong>, <strong>in</strong>quanto esposizione esemplare di un’ontologia del possibile che comprende<strong>in</strong> sé la questione dell’esistenza, conviene uscire da questo <strong>in</strong>dicee muovere dal luogo <strong>in</strong> cui appare <strong>in</strong> modo scoperto quella dimostrazionedi esistenza della “cosa” che fornisce il primo criterio,sia metodico, sia ontologico, su cui si regge l’<strong>in</strong>tera metafisica wolffiana– cioè dal primo paragrafo della Metafisica tedesca.Siamo coscienti di noi e di altre cose, del che non può dubitare nessuno chenon sia completamente privato dei propri sensi, ovvero folle (se<strong>in</strong>er S<strong>in</strong>nenvöllig beraubet) […] Ora, però, chi è cosciente di ciò che nega o di cui dubitaè la medesima persona. E qu<strong>in</strong>di è chiaro che noi siamo (DM § 1).Quello che si è appena citato (e che di qui <strong>in</strong> avanti sarà denom<strong>in</strong>atoargomento preontologico per diverse ragioni, che si spera verrannochiarite man mano) si colloca prelim<strong>in</strong>armente rispetto allo sviluppodi quello che diventerà il corpo dell’<strong>Ontologia</strong> lat<strong>in</strong>a. Si trovacioè collocato anteriormente (ma non del tutto esternamente) 21 al21 <strong>Wolff</strong> varia l’argomento all’<strong>in</strong>izio di ogni capitolo della Metafisica tedesca (lo mette efficacemente<strong>in</strong> luce ARNAUD 2002: 37-44), adeguandolo alla “cosa <strong>in</strong> generale” e poi alle27
corpo della Metafisica tedesca e <strong>in</strong> particolare a quel secondo capitolo(“Dei primi fondamenti della nostra conoscenza e di tutte le cose <strong>in</strong>generale”) che diventerà, appunto, il successivo e ben più ampio manualededicato alla “filosofia prima”. In tal senso, marca uno staccofra il corpo discipl<strong>in</strong>are strettamente ontologico e il suo esterno; tuttavia,è qui che va cercata l’impostazione wolffiana del problemadell’esistenza, <strong>in</strong>sieme alle ragioni per cui tale impostazione generaprecisamente un’ontologia del possibile. Sarà questo l’argomento deicapitoli che seguono – un argomento che verrà <strong>in</strong>dagato <strong>in</strong> base adue tesi <strong>in</strong>terpretative.1) L’argomentazione preontologica di <strong>Wolff</strong> appartiene f<strong>in</strong> dapr<strong>in</strong>cipio a una <strong>psicologia</strong> metafisica costituita su basi osservative.(Può essere considerato come spia dell’evidenza di tale peculiarità teoricagià il fatto che Walch, come si è visto, <strong>in</strong> entrambe le brevi voci“Metafisica” e “<strong>Ontologia</strong>” si senta <strong>in</strong> dovere di accennare all’importanzadi recenti trasformazioni della “pneumatica”; su questo tema siritornerà presto con qualche ampiezza, cfr. <strong>in</strong>fra, cap. III.) In generale,nel sistema di <strong>Wolff</strong> non tanto una metafisica contiene una <strong>psicologia</strong>passibile di verifica empirica a posteriori, quanto piuttosto una<strong>psicologia</strong> essenzialmente empirica risulta <strong>in</strong> grado di generare (almenoparte di) una metafisica – con ricadute decisive per l’impostazionedel problema ontologico.2) L’<strong>in</strong>tera ontologia di <strong>Wolff</strong> riesce a costituirsi come una teoriadelle categorie sommamente generali del possibile, ovvero del reale,<strong>in</strong> quanto il reale vi è <strong>in</strong>teso <strong>in</strong>nanzitutto come concepibile e significabile– e, questo, di nuovo sulla base di una <strong>psicologia</strong> metafisica costituitaosservativamente.“cose” che ricadono negli ambiti speciali della metafisica – derivando <strong>in</strong> tal modo ognivolta un oggetto e circoscrivendogli, correlativamente, un ambito discipl<strong>in</strong>are.28
II – Che cosa è un ente? Una questione di pr<strong>in</strong>cipiThe demand that we should prove the law [of contradiction]argues a lack of education; the educated man knows whatshould be proved and what should not.Aristotele, Metafisica 1006a5-6 (trad. Ross)Sul piano strettamente lessicografico, è certamente utile rilevare il fattoche il “significato di D<strong>in</strong>g si avvic<strong>in</strong>a con <strong>Wolff</strong> a quello del term<strong>in</strong>eGegenstand” (parola che verrà poi preferita da Kant per designarel’oggetto della metafisica), mentre “l’ens scolastico viene ad assumereil significato di res già <strong>in</strong> epoca anteriore”, ossia senz’altro con Clauberg(WILLE 1991: XXI, n. 56). In ogni caso, non si tratta di un merocambiamento di etichette, privo di effetti teorici. Al contrario, se èvero che la “cosa” che viene messa a tema dall’ontologia wolffianacopre <strong>in</strong>nanzitutto il significato del “<strong>qualcosa</strong>” (Ont § 243) <strong>in</strong>tesocome un oggetto di cui risulta possibile dire <strong>in</strong> generale <strong>qualcosa</strong>,prima che di un’entità data “davvero” come presente, occorrerà confrontaresubito tale passaggio con la formula standard che vuolel’ontologia scienza dell’“ente <strong>in</strong> quanto tale”. In particolare, occorreràmuovere dalla centrale osservazione di Honnefelder secondo cui lametafisica di ascendenza scotista <strong>in</strong> generale, e la metafisica entro cui<strong>in</strong> età moderna si sviluppa <strong>in</strong> particolare l’ontologia, non comprende“il massimo, cioè la totalità di ciò che si può conoscere dell’‘essente’,bensì solo il m<strong>in</strong>imo, ossia ciò che è conosciuto dell’‘essente’ e che ècontenuto <strong>in</strong> ogni sapere” (HONNEFELDER 1990: XV). Tale osservazione,<strong>in</strong>fatti, si lega strettamente a quella, decisiva, secondo cui ognimetafisica di questo tipo “è possibile solo <strong>in</strong> quanto dimostrazione aposteriori del quia, e non <strong>in</strong> quanto dimostrazione a priori del propter quid”(ibidem). Al di là della term<strong>in</strong>ologia: la “cosa” wolffiana si determ<strong>in</strong>a <strong>in</strong>l<strong>in</strong>ea di pr<strong>in</strong>cipio come oggetto genericamente dato e, solo <strong>in</strong> quanto tale,oggetto di quel sapere m<strong>in</strong>imo e perciò stesso sommamente genericoraccolto dall’ontologia <strong>in</strong> quanto metafisica generale.29
1. L’argomento preontologico e l’enciclopedia filosoficaMolto si è ormai detto del metodo wolffiano 22 ; meno, <strong>in</strong>vece, delmodo <strong>in</strong> cui <strong>Wolff</strong> determ<strong>in</strong>a a quali oggetti fondamentali si applicanole diverse discipl<strong>in</strong>e del suo sistema. Quanto all’ontologia, converràperciò aggredire subito la celebre formula che la vuole una scienzadell’“ente <strong>in</strong> quanto ente”. È <strong>in</strong>fatti <strong>in</strong>centrandosi su di essa che sisono sviluppate le pr<strong>in</strong>cipali ricostruzioni della nascita dell’ontologiamoderna, le quali pongono <strong>Wolff</strong> al culm<strong>in</strong>e di un processo <strong>in</strong> cui la“filosofia prima” di matrice aristotelica si rende autonoma dalla teologiae qu<strong>in</strong>di, determ<strong>in</strong>atasi come metafisica “generale”, si rende autonomadall’<strong>in</strong>tero della metafisica reale. Qui, il percorso che portaall’<strong>Ontologia</strong> wolffiana, passando attraverso opere che <strong>in</strong>troducono ilterm<strong>in</strong>e e opere che circoscrivono la discipl<strong>in</strong>a, è ormai bene ricostruitodalla storia dei concetti. Tuttavia, la prima prestazione di <strong>Wolff</strong> <strong>in</strong>tal senso non si <strong>in</strong>centra sulla term<strong>in</strong>ologia scolastica dell’“ens”, bensì,se si accetta di <strong>in</strong>dividuarla nella Metafisica tedesca (1719), sul term<strong>in</strong>e“cosa (D<strong>in</strong>g)”, traducente di “res”. Su di esso vanno spese alcune parole,giacché tale scelta term<strong>in</strong>ologica non risulta semplicemente obbligataper l’uso del tedesco, non è cioè dettata unicamente da una strategiavolta alla ricerca di una più ampia risonanza mediante l’uso della22 Sul metodo wolffiano, specialmente <strong>in</strong> quanto analitico, cfr. CORR (1972), TONELLI(1976), ENGFER (1982, 1986). Più <strong>in</strong> generale, vale riferire a <strong>Wolff</strong> le pr<strong>in</strong>cipali notazionidi ARNDT (1971), il quale evidenzia tre motivi pr<strong>in</strong>cipali, anteriori alla sua specificazione<strong>in</strong> senso matematico-geometrico, dello sviluppo del metodo scientifico moderno:1) rispetto alla molteplicità dei metodi (precedentemente def<strong>in</strong>iti su base aristotelicacome metodi dipendenti dall’oggetto) nei secoli XVII e XVIII si impone la tendenza adaffermare l’unicità del metodo scientifico; 2) questo è def<strong>in</strong>ito come un sistema di regole<strong>in</strong>dipendente dalle caratteristiche dagli oggetti di ricerca; prende piede così 3) un’accentuazionedel momento normativo, ossia la conoscenza scientifica si identifica con la applicabilitàuniversale della metodica. Rispetto a queste notazioni di Arndt, si vorrebbe però osservareche, per quanto perfettamente riferibili a <strong>Wolff</strong>, e nonostante il suo essere assurto aicona dell’affermazione della metodica scientifica <strong>in</strong> filosofia, permane evidentementenella sua metafisica la centralità del problema enciclopedico, cioè quello della determ<strong>in</strong>azione(tassonomica e gerarchica) degli oggetti peculiari delle diverse scienze – determ<strong>in</strong>azioneimpostata ancora secondo pr<strong>in</strong>cipi aristotelico-scolastici. Da questo punto divista, <strong>in</strong>oltre, stupisce la valutazione di DIERSE (1977) che nella propria (peraltro dettagliatissima)trattazione del concetto filosofico di enciclopedia assegna a <strong>Wolff</strong> e allascuola wolffiana una posizione del tutto marg<strong>in</strong>ale.30
l<strong>in</strong>gua nazionale 23 , ma riflette ben altri motivi teorici, ossia quelli basilaridella scienza della “cosa (res), <strong>in</strong> quanto è <strong>qualcosa</strong> (aliquid)” (Ont §243), propri di ogni impianto metafisico scotista 24 .Già sul piano della storia del lessico, la elezione wolffiana di“D<strong>in</strong>g” si situa <strong>in</strong> una fase della storia della l<strong>in</strong>gua tedesca che vedequesto vocabolo al centro di un processo di est<strong>in</strong>zione di un primosuo significato, più arcaico, a favore del suo significato moderno. Taleprocesso è, oltretutto, mediato e guidato (caso non affatto raro peril tedesco moderno) da trasformazioni del l<strong>in</strong>guaggio tecnico della filosofia.<strong>Wolff</strong>, cioè, non solo si appoggia a una generale trasformazionel<strong>in</strong>guistica <strong>in</strong> atto, ma anche la asseconda sul piano scientifico.In breve: se per <strong>Wolff</strong> la parola “D<strong>in</strong>g” risponde alla domanda metafisicaprelim<strong>in</strong>are “che cos’è un ente?”, va <strong>in</strong>nanzitutto osservato che,fra i secoli XVII e XVIII, il significato di “D<strong>in</strong>g” più arcaico e concreto(l’assemblea dei deliberanti, ovvero il luogo <strong>in</strong> cui essi si riuniscono)scivola <strong>in</strong> un secondo significato già attestato parallelamenteal primo (cfr. Grimm, ad voc. “D<strong>in</strong>g”). In questo arco di tempo, cioè,prende rapidamente il sopravvento il significato di “oggetto (ancheastratto) di deliberazione”, equivalente al lat<strong>in</strong>o “res”; ma di qui“D<strong>in</strong>g” tende ad assumere a sua volta il senso più concreto di cosamateriale, ovvero di oggetto sensibile e manipolabile – avvic<strong>in</strong>andosial significato che assumerà poi “Gegenstand” nel vocabolario filosoficodel tardo illum<strong>in</strong>ismo e qu<strong>in</strong>di nel l<strong>in</strong>guaggio comune (cfr. ibidem).Si tratta, conviene tornare a sottol<strong>in</strong>earlo, di un’osservazionel<strong>in</strong>guistica, che però autorizza a mettere <strong>in</strong> rilievo il modo peculiare <strong>in</strong>cui è immediatamente presentato il tema della Metafisica tedesca. Nonsolo, <strong>in</strong>fatti, l’ord<strong>in</strong>e degli argomenti di quest’opera, il cui titolo <strong>in</strong> effettisuona Pensieri razionali su Dio, il mondo, l’anima dell’uomo, nonché sututte le cose <strong>in</strong> generale, è complicato e rovesciato rispetto a quello presentatonel titolo, così:Cap. I “Come conosciamo che noi siamo e a che cosa ci serva questaconoscenza”,Cap. II “Sui primi fondamenti (Gründe) della nostra conoscenza e sututte le cose <strong>in</strong> generale”,23 Su cui cfr. RICKEN (1989: 20-25).24 Cfr. HONNEFELDER 1990: IX-XXIII.31
Cap. III “Sull’anima <strong>in</strong> generale, ovvero ciò che esperiamo (wahrnehmen)25 di essa”,Cap. IV “Sul mondo”,Cap. V “Sull’essenza dell’anima e di uno spirito <strong>in</strong> generale”,Cap. VI “Su Dio”.Soprattutto, il primo paragrafo del primo capitolo <strong>in</strong>troduce la “cosa”sia come l’oggetto di cui risulta possibile dire <strong>in</strong> generale <strong>qualcosa</strong>, siacome l’oggetto che <strong>in</strong> primo luogo cade sotto i nostri sensi. E <strong>in</strong> entrambequeste prospettive la propone come l’oggetto della nostra conoscenzapiù normale, di cui si afferma una peculiare evidenza.Siamo coscienti (bewust) di noi e di altre cose, del che non può dubitare(zweiffeln) nessuno che non sia completamente privato dei propri sensi, ov-25 Il term<strong>in</strong>e orig<strong>in</strong>ale wolffiano “wahrnehmen” è qui contestualmente tradotto secondoil significato di “esperire”, per ragioni che dovrebbero apparire meglio giustificate trabreve da ciò che segue. Va <strong>in</strong> ogni caso precisato che la “perceptio” conosce nel l<strong>in</strong>guaggiofilosofico una propria traduzione autonoma nel tedesco “Wahrnehmung” –con cui non viene più <strong>in</strong>teso il significato lato di “osservare”, “rivolgere l'attenzione verso<strong>qualcosa</strong>”, o più semplicemente “cogliere”, f<strong>in</strong>o ad allora consolidato, ma piuttostoquello di “percepire”, nel senso ancor oggi usuale di “percezione sensibile” – soltantosuccessivamente all’età wolffiana. Il Deutsches Wörterbuch dei Grimm registra questa nuovaaccezione del tedesco “Wahrnehmung” e la data <strong>in</strong>torno alla metà del Settecento, apartire cioè da quando con tale term<strong>in</strong>e si <strong>in</strong>tende una “percezione, <strong>in</strong>tuizione o sensazione,unita alla coscienza, e <strong>in</strong>tesa come presupposto sia di una rappresentazione […],sia di ciò che viene <strong>in</strong>tuito o sentito <strong>in</strong> tale maniera” (Grimm, ad voc. “Wahrnehmung”).Questa nuova accezione comporta due specificazioni della precedente “perceptio”: perun verso, la determ<strong>in</strong>azione del suo carattere sensibile (<strong>in</strong> realtà, non del tutto nuova:sempre il Grimm riporta un’anteriore accezione di “Wahrnehmung” come “legata alsenso della vista”, ibidem); per un altro, la sua stretta dipendenza dalla coscienza. Non èun caso che tale significato del term<strong>in</strong>e si consolidi proprio a partire da Kant, cui forsenon sarebbe erroneo attribuire la paternità di questo nuovo term<strong>in</strong>e filosofico – tantopiù che il primo esempio riportato nel Deutsches Wörterbuch è tratto appunto dalla Kritikder re<strong>in</strong>en Vernunft, dove la “percezione (Wahrnehmung)” viene def<strong>in</strong>ita come una “rappresentazioneaccompagnata da una sensazione” (B 147) e come “una sensazione di cuisi abbia coscienza” (B 272; negli scritti dei primi due volumi di Ak, Kant utilizza “Wahrnehmung”con il significato allora ord<strong>in</strong>ario di “constatazione” o “osservazione”). Lostesso Onomasticon Philosophicum registra la corrispondenza di “Wahrnehmung” e “perceptio”e la traduzione di “Wahrnehmung” con “Vorstellung mit Bewußtse<strong>in</strong>” soltanto<strong>in</strong> Kant, riconoscendo <strong>in</strong>vece la s<strong>in</strong>onimia di “repraesentatio” e “perceptio” e la lorounivoca traduzione nel tedesco “Vorstellung” <strong>in</strong> <strong>Wolff</strong>, Baumgarten, Meier, nonché(comprensibilmente) nel leibniziano Eberhard (KEN 1989: 268-269, 326, 758). Per lalessicografia specificamente wolffiana – ancora a uno stadio <strong>in</strong>iziale – cfr. DELFOSSE -KRÄMER - REINARDT (1987) e GAWLICK - KREIMENDAHL (1999).32
vero folle (se<strong>in</strong>er S<strong>in</strong>nen völlig beraubet); e chi volesse negarlo asserirebbe conla bocca cosa diverse da quelle che trova dentro di sé, e potrebbe anche veniresubito conv<strong>in</strong>to che la sua affermazione è assurda. Come, <strong>in</strong>fatti, eglivorrebbe negarmi <strong>qualcosa</strong> o dubitarne, se non fosse cosciente di sé e dialtri enti? Ora, però, chi è cosciente di ciò che nega o di cui dubita è la medesimapersona. E qu<strong>in</strong>di è chiaro che noi siamo (DM § 1).Siamo dunque d<strong>in</strong>anzi a un’esperienza esprimibile e comunicabile, lacui verità è certa, pena la contraddizione nel non volerla riconoscere edesprimere come esperienza comune, e che si presta naturalmente a unamessa <strong>in</strong> forma, come viene presto esplicitato <strong>in</strong> un primo sillogismo:1) Esperiamo (erfahren) <strong>in</strong> modo <strong>in</strong>contestabile (unwidersprechlich) che siamo coscientidi noi e di altre cose (cfr. DM § 1; Log V § 1). 2) Ci è chiaro (klar) che chi ècosciente di sé e di altre cose è. E dunque 3) siamo certi che siamo (DM § 5).Entro le argomentazioni del primo capitolo di quest’opera (preontologiche<strong>in</strong> quanto prelim<strong>in</strong>ari a qualsiasi possibile stesura di un elencodegli esistenti, come pure a un’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e su di essi <strong>in</strong> quanto “res”,ovvero <strong>in</strong> quanto oggetti dotati di un patrimonio m<strong>in</strong>imo di proprietàgenerali), la funzione di questo primo paragrafo consiste <strong>in</strong>nanzituttonell’<strong>in</strong>trodurre – <strong>in</strong> una maniera che non può non rievocare l’argomentocartesiano del “cogito” – il criterio metodico basilare della certezza(DM §§ 3-4), <strong>in</strong>dividuato nel caso <strong>in</strong> cui questa è massima:credo […] che non sia possibile pretendere una certezza maggiore di quellache si ha quando si può dist<strong>in</strong>tamente mostrare che conosciamo <strong>qualcosa</strong> <strong>in</strong>modo tanto certo, quanto il fatto che noi siamo, poiché di questo, <strong>in</strong> verità,nessuno potrà dubitare, anche qualora volesse mettere <strong>in</strong> dubbio tutto il resto(DM2 ad § 1).Dunque, prima ancora che dimostrare l’esistenza dell’io <strong>in</strong>tesocome entità cosciente, considerata un’ovvietà <strong>in</strong>dubitabile (DM § 2) 26 ,26 Nella Logica tedesca (1713), al § 1 del primo capitolo si trova uno spunto analogo, nelladef<strong>in</strong>izione del sentire: “Ognuno si accorge di percepire molte cose mediante i sensi. Maio dico che percepiamo <strong>qualcosa</strong> quando ne siamo attualmente coscienti. Così percepiamoil dolore, il suono, la luce e i nostri pensieri”. Tuttavia, lo scopo dell’<strong>in</strong>troduzionedi questo tema, diversamente che nella Metafisica tedesca, non è quello di fornire un crite-33
assolve implicitamente al compito ancor più basilare di assicurarel’oggetto della metafisica, la “cosa” che – prima ancora di specificars<strong>in</strong>egli oggetti reali della metafisica speciale: l’anima, il mondo, dio –può proporsi all’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e “sui primi pr<strong>in</strong>cipi della nostra conoscenzae su tutte le cose <strong>in</strong> generale”, da cui deriverà la successiva <strong>Ontologia</strong>.In tale prospettiva, l’argomento preontologico si situa entro unimpianto enciclopedico complessivo che lo vede posto alla base diuna metafisica generale, <strong>in</strong>tesa come prima scienza di una filosofiateoretica garantita metodicamente dalla logica – schematizzabile nelmodo seguente :Fig. 1Ma, <strong>in</strong>teso come <strong>in</strong>troduzione o richiamo dei pr<strong>in</strong>cipi di certezza econtraddizione, l’argomento è fatto presente più volte <strong>in</strong> tale impianriodi certezza, bensì quello di poter def<strong>in</strong>ire successivamente il concetto (“ogni rappresentazionedi una cosa nei nostri pensieri”, DL I, § 4) <strong>in</strong>teso come il primo oggetto dellalogica. Sul fatto che la nozione wolffiana di concetto comprenda anche (e anzi <strong>in</strong> primoluogo) la rappresentazione sensitiva si dovrà tornare ancora. Un altro spunto analogo losi ritrova al § 1 del Discursus praelim<strong>in</strong>aris del 1728 (ma non nel “Vorbericht der Welt-Weisheit”, suo omologo nella Logica tedesca), trattato sotto il titolo di uno dei tre tipi fondamentalidi conoscenza, la “istorica”: “Con il beneficio dei sensi conosciamo le cose che sono o chedivengono nel mondo materiale, e la mente è consapevole dei mutamenti che accadono <strong>in</strong> sé. Nessuno loignora, basta che presti attenzione a se stesso”. Al successivo § 2 si precisa <strong>in</strong>fatti: “Anoi adesso basta che non si possano mettere <strong>in</strong> dubbio le cognizioni da noi stessi acquisitemediante i sensi e l’attenzione”. Sulla caratterizzazione complessiva della conoscenza“istorica” fornita <strong>in</strong> quest’opera cfr. <strong>in</strong>fra, p. 57, n. 53.34
to, sia variandolo all’<strong>in</strong>izio di ogni capitolo della Metafisica tedesca, siatrovandogli spazio ancora anteriormente a essa <strong>in</strong> sede di metodologia,nella Logica tedesca – come lo stesso <strong>Wolff</strong> tiene a sottol<strong>in</strong>eare (cfr.DM § 5) 27 per motivi che presto saranno oggetto di apposita considerazione.Tuttavia, non bisogna dare per scontata né la stabilità né (soprattutto)la semplicità di questo impianto. In effetti, nonostante il sistemawolffiano sia stato giudicato come pressoché def<strong>in</strong>itivamente del<strong>in</strong>eatocon la pubblicazione della Logica e della Metafisica tedesche, la produzioneda parte di <strong>Wolff</strong> delle opere lat<strong>in</strong>e corrispondenti alle sue s<strong>in</strong>goleparti (l’“opus metaphysicum”, nella formulazione di ÉCOLE 1990),se opportunamente <strong>in</strong>dagata, oltre ad apparire come una sostanzialeamplificazione dettata da esigenze didattiche (si pensi solo alla produzionedi <strong>Wolff</strong> <strong>in</strong> sede di filosofia pratica), esibisce alcune rettifiche importanti.Nella sua ricostruzione, École si fa guidare da alcune decisioni<strong>in</strong>terpretative di fondo, nonché da diverse circostanze che corroboranotali scelte – fra cui l’assunzione del Discursus praelim<strong>in</strong>aris (1728) comeguida pr<strong>in</strong>cipale per <strong>in</strong>dividuare <strong>in</strong> dettaglio la def<strong>in</strong>izione delle discipl<strong>in</strong>efilosofiche e dei loro rapporti (cfr. ÉCOLE 1990: 63-64), nonchél’accoglimento da parte di <strong>Wolff</strong> delle proposte di rettifica provenientida BILFINGER (1725) e THÜMMIG (1729) 28 che riguardano essenzialmentela progressione delle parti della metafisica speciale. A ogni modo,la struttura def<strong>in</strong>itiva dell’enciclopedia filosofica di <strong>Wolff</strong> – il cu<strong>in</strong>ucleo rimane quello dell’opus logico-metaphysicum pubblicato <strong>in</strong> tedesco –risulta fondata nel suo <strong>in</strong>tero su una metafisica che, <strong>in</strong> ciò garantita dauna epistemologia <strong>in</strong>centrata sul problema metodico, comprende unaparte m<strong>in</strong>imale (l’ontologia, appunto), nonché una serie di ontologieregionali la cui ragion d’essere è data dalla prima. Tutte le discipl<strong>in</strong>e27 <strong>Wolff</strong> r<strong>in</strong>via qui al primo paragrafo del capitolo V della Logica tedesca, <strong>in</strong>titolato“Sull’esperienza (Erfahrung) e su come tramite essa vengano trovati gli assiomi (Sätze)”,dove appunto si tratta del “giudizio fondamentale (Grund-Urtheil)” <strong>in</strong> quanto formulatosulla base dell’esperienza e <strong>in</strong> ciò dist<strong>in</strong>to dal “Nach-Urtheil”, ricavato mediante concatenazionedi giudizi (“Schlüsse”).28 In particolare, nelle Institutiones di Thümmig, a differenza che nelle opere tedesche di<strong>Wolff</strong>, la cosmologia viene trattata prima della <strong>psicologia</strong>, e quest’ultima viene divisa <strong>in</strong>empirica e razionale – suddivisione e dizione poi adottate dallo stesso <strong>Wolff</strong> nelle operelat<strong>in</strong>e.35
metafisiche, a loro volta, conoscono uno svolgimento scientifico <strong>in</strong>senso stretto, ovvero ipotetico-deduttivo, e uno svolgimento sperimentale,ovvero empirico-osservativo – con il caso macroscopicamentedi maggior spicco costituito dalla <strong>psicologia</strong>, suddivisa <strong>in</strong> duetrattazioni dist<strong>in</strong>te ai capitoli III e V della Metafisica tedesca e poi sviluppata<strong>in</strong> due dist<strong>in</strong>te opere lat<strong>in</strong>e, la Psychologia empirica (1732) e la Psychologiarationalis (1734). A questa base, più propriamente teoretica, tengonodietro campi discipl<strong>in</strong>ari più propriamente pratici, ovvero tecnicoapplicativi.Tale quadro complessivo può venire dunque illustrato nelmodo seguente.Fig. 2 – Da ÉCOLE (1990: 63-64), con term<strong>in</strong>ologia modificata 29 . I corsivi nei riquadria destra del diagramma evidenziano le discipl<strong>in</strong>e filosofiche co<strong>in</strong>volte nellaformulazione dell’argomento preontologico.29 Il caso particolare della logica (denom<strong>in</strong>ata nel presente schema “epistemologia” perevidenziarne il ruolo metodico rispetto all’<strong>in</strong>tero della conoscenza scientifica distribuitanelle discipl<strong>in</strong>e via via più particolari, nonché il fatto che nel Discursus praelim<strong>in</strong>aris non siconfiguri più soltanto come una “logica” <strong>in</strong> senso stretto, cioè come una teoria del pen-36
Nell’opus logico-metaphysicum def<strong>in</strong>itivo non ci si trova dunque piùd<strong>in</strong>anzi a una classificazione ad albero, quanto piuttosto a una seriediscendente di discipl<strong>in</strong>e pr<strong>in</strong>cipali fondate secondo rapporti di dipendenza,ognuna delle quali conosce poi specificazioni ulteriori. Lal<strong>in</strong>earità della serie, tuttavia, è tale solo <strong>in</strong> prima approssimazione,giacché su una scala più f<strong>in</strong>e le sue ragioni strutturali cedono a un piùcomplesso <strong>in</strong>treccio tematico – come occorrerà vedere a propositodell’ontologia, già rispetto all’argomento prelim<strong>in</strong>are che ne <strong>in</strong>troduceil tema.2. Contro CartesioNonostante la somiglianza nel ductus, l’argomento preontologicosviluppato da <strong>Wolff</strong> al primo paragrafo della Metafisica tedesca è sololontanamente apparentato con l’argomento cartesiano del “cogito”.Non mira, come si è detto, a determ<strong>in</strong>are un impegno ontologicoparticolare e fondamentale, come è quello relativo alla “sostanza pensante”cartesiana, sicché l’unica aff<strong>in</strong>ità genu<strong>in</strong>a andrà scorta nel temastrettamente metodico della ricerca di un pr<strong>in</strong>cipio di certezza evidenteche si dà a conoscere nel “cogito” come fatto di coscienza.L’evidenza <strong>in</strong> questione, dunque, importa a <strong>Wolff</strong> <strong>in</strong> quanto può venireassunta come il metro ultimo di ogni certezza razionale (DM §§3-4), ossia con un valore normativo e di pr<strong>in</strong>cipio – pur essendo unfatto empirico di cui occorrerà rendere ragione nella sede discipl<strong>in</strong>areappropriata. E, soprattutto, l’essere coscienti di cui ognuno può averetale certezza, pur non avendo alcun oggetto privilegiato, appare semprestrutturalmente riferito a un <strong>qualcosa</strong>. Come tale, esibisce alloraalmeno tre caratteristiche pr<strong>in</strong>cipali.1) È un fatto psicologico – il che non significa però, nella prospettivadi <strong>Wolff</strong>, che sia un fatto privato, valido <strong>in</strong> una prospettiva solipsistica,bensì risulta esperibile da chiunque si trovi <strong>in</strong> condizione di esperirlo(“Siamo coscienti […] qu<strong>in</strong>di è chiaro che noi siamo”, DM § 1; sicché,siero “naturale” volta al f<strong>in</strong>e del suo perfezionamento, ma comprenda anche discipl<strong>in</strong>eessenzialmente “artificiali” come è la “ars <strong>in</strong>veniendi”) verrà toccato fra breve.37
molto felicemente, si è <strong>in</strong> tal senso caratterizzato questo argomento di<strong>Wolff</strong> come argomento del “cogitamus”, cfr. ARNAUD 2002: 44).2) È <strong>in</strong>sieme empirico (è, anzi, dato <strong>in</strong> modo paradigmatico nel casodell’esperienza del sentire: sé “e altre cose”) e logicamente garantito(non ne può dubitare “nessuno che non sia completamente privatodei propri sensi, ovvero folle”) – dove tale garanzia “logica” appareessere quella di una capacità conoscitiva naturale e m<strong>in</strong>ima.3) Ha, soprattutto, una struttura che non sarebbe scorretto def<strong>in</strong>ire<strong>in</strong>tenzionale 30 . Ovvero, <strong>in</strong> altri term<strong>in</strong>i, ciò che fornisce il criteriodell’evidenza <strong>in</strong>controvertibile non è il semplice fatto di essere coscienti,bensì proprio l’essere coscienti “di noi e di altre cose”, ossiauna credenza, che è necessariamente riferita a un <strong>qualcosa</strong> – secondoun’impostazione che riprende per <strong>in</strong>tero la critica leibniziana della“filosofia della mente” di Cartesio 31 .Su queste caratteristiche del “cogitamus” <strong>Wolff</strong> dunque si appoggia,<strong>in</strong> maniera più evidente nella Metafisica tedesca, adeguandolo alla“cosa <strong>in</strong> generale” e poi alle “cose” che ricadono via via negli ambitispeciali della metafisica – derivando <strong>in</strong> tal modo ogni volta un oggettomeno generico e circoscrivendogli, correlativamente, un ambitodiscipl<strong>in</strong>are garantito da un’ontologia regionale. Nel caso del secondocapitolo, che qui più ci <strong>in</strong>teressa, ne troviamo al paragrafo <strong>in</strong>iziale laformulazione più adeguata all’ontologia.Quando ci rendiamo conto di essere consapevoli di noi stessi e di altre cose, elo prendiamo per certo, <strong>in</strong> realtà ciò avviene poiché ci è impossibile pensaredi dover essere contemporaneamente coscienti e non coscienti di noi stessi.Ugualmente <strong>in</strong> tutti gli altri casi troviamo che ci è impossibile pensare che<strong>qualcosa</strong> non sia mentre è. E così ammettiamo <strong>in</strong> via generale, senza bisognodi alcuna riflessione, questa proposizione universale: <strong>qualcosa</strong> non può essere e nonessere nello stesso tempo. Questo pr<strong>in</strong>cipio lo chiamiamo pr<strong>in</strong>cipio di contraddizione; e30 Per un primo orientamento sul dibattito attuale circa la nozione di <strong>in</strong>tenzionalità e, soprattutto,circa il rapporto fra <strong>in</strong>tenzionalità e carattere cosciente dell’esperienza, cfr. rispettivamenteJACOB, ad voc. “Intentionality”; SIEWERT, ad voc. “Consciousness, and <strong>in</strong>tentionality”;LYCAN, ad voc. “Consciousness, representational theories of” (tutti <strong>in</strong> SEPh).31 Il migliore contributo di impostazione storiografico-analitica alla chiarificazione delladifferenza tra teoria della mente “cartesiana” (che considera la coscienza come caratteredist<strong>in</strong>tivo del pensiero) e “leibniziana” (che considera, <strong>in</strong>vece, il carattere rappresentazionalecome dist<strong>in</strong>tivo del mentale) è forse dato attualmente da SIMMONS (2001).38
da esso non soltanto i sillogismi att<strong>in</strong>gono certezza (cfr. Log IV § 5), ma vengonoposte al di fuori di ogni dubbio anche le proposizioni note per esperienza,allo stesso modo <strong>in</strong> cui nel nostro caso esperiamo proprio questo: chesiamo coscienti di noi stessi (DM § 10).E nell’<strong>Ontologia</strong>, al paragrafo omologo, si leggerà che esperiamoche la natura della nostra mente è tale, che quando essa giudica che <strong>qualcosa</strong>è non può giudicare al contempo che la stessa cosa non è. L’esperienzache qui richiamiamo è ovvia, né si può ritenere che ve ne sia altra più ovviadi questa […] Chi <strong>in</strong>fatti ignora che vedendo una cosa qualunque non possiamogiudicare che non la vediamo? (Ont § 27)È questo il modo <strong>in</strong> cui <strong>Wolff</strong> <strong>in</strong>troduce, dopo il criterio della certezza,valido per misurare la consistenza metafisica di ogni “cosa” <strong>in</strong>generale 32 , il pr<strong>in</strong>cipio di contraddizione, secondo il quale “<strong>qualcosa</strong>non può essere e non essere nello stesso tempo” 33 . Sarà bene, allora,soffermarsi subito sul modo <strong>in</strong> cui il pr<strong>in</strong>cipio di contraddizione vieneesibito (e <strong>in</strong> una posizione che è centrale <strong>in</strong> entrambi i passi appenacitati), giacché il suo primo apparire nel fenomeno “mentale” dell’impossibilitàdi giudicare altrimenti quando <strong>in</strong>tratteniamo una credenzacirca l’essere di <strong>qualcosa</strong> sembra violare le consegne dell’ontologia.Tale fenomeno “mentale”, non sta, <strong>in</strong>nanzitutto, semplicementealla base del “concipi posse vel non posse” che Tschirnhaus (autorepiù volte perciò celebrato da <strong>Wolff</strong>) aveva proposto come criteriodella verità (TSCHIRNHAUS 1695: 34-35). Piuttosto, anche come fattopsicologico, e <strong>in</strong>teso come manifestazione di un criterio epistemologico,è riportato da <strong>Wolff</strong> alla nozione untologica di “essenza” come“possibilità <strong>in</strong>terna” dell’oggetto 34 su cui verte una credenza qualsiasi.32 Riferendosi subito dopo alla Logica, <strong>Wolff</strong> r<strong>in</strong>via qui al luogo <strong>in</strong> cui il pr<strong>in</strong>cipio di contraddizioneviene <strong>in</strong>nanzitutto riferito all’esperienza <strong>in</strong> quanto “cognizione che appareevidente per la sola attenzione alle nostre percezioni” (Log § 664).33 Nel primo capitolo dell’<strong>Ontologia</strong>, <strong>in</strong> effetti, <strong>Wolff</strong> <strong>in</strong>troduce di seguito al pr<strong>in</strong>cipio dicontraddizione (§ 27) anche quello di bivalenza, considerandolo il “fondamento” delpr<strong>in</strong>cipio del terzo escluso (§ 52).34 Questo, alla luce della norma che prescrive la ricerca della prima nella seconda, <strong>in</strong>tesacome ciò <strong>in</strong> virtù di cui “non viene ammesso nel primo concetto di una cosa nulla cherisulti contraddittorio” (<strong>Wolff</strong>, Ausführliche Nachricht von se<strong>in</strong>en eigenen Schrifften die er <strong>in</strong>39
In altri term<strong>in</strong>i, asserire la certezza e, dunque, la non controvertibilità(tradotta da <strong>Wolff</strong> <strong>in</strong> non contraddittorietà) di un oggetto di credenzapurchessia non implica soltanto che “dire D<strong>in</strong>g o Gegenstand significa presc<strong>in</strong>deredal Dase<strong>in</strong> (esistenza), non badare al Se<strong>in</strong> o al Nichtse<strong>in</strong> (essere onon essere)” (CAMPO 1938: 162-163). Per poter valere come l’“assiomasommamente generale” (come era <strong>in</strong>fatti nella “filosofia prima” degli“scolastici”, Ont § 29), deve implicare pure la non necessità di applicarsisoltanto all’oggetto di una credenza positivamente vera. E, <strong>in</strong>fatti, quando<strong>Wolff</strong> nell’<strong>Ontologia</strong> decl<strong>in</strong>a quella prima esposizione del pr<strong>in</strong>cipio dicontraddizione nei term<strong>in</strong>i di un argomento antiscettico, rispetto all’argomentocartesiano la valuta nel modo che segue.Gli scettici, <strong>in</strong> realtà, mostrando un’enorme cautela nell’evitare la precipitazionenel giudicare, non negavano tuttavia i fenomeni, come riporta SestoEmpirico, ossia largheggiavano addirittura nell’ammettere di vedere o immag<strong>in</strong>arequesto e quello, e di vederlo così e non altrimenti al tempo stesso.Perciò Cartesio, nel voler conv<strong>in</strong>cere gli scettici nelle Meditazioni […], nonmise affatto <strong>in</strong> dubbio di vedere o immag<strong>in</strong>are tali e tali cose, e di ritenersicerto nel vedere che ad A compete B, ma negò soltanto che, per questa ragione,ci consta <strong>in</strong> modo certo che esistono cose tali, quali noi le vediamo, eche, se esistono, sono tali, quali appaiono, oppure che ad A compete B perchéciò ci sembra certo (Ont § 27).Sarebbe però fuorviante considerare questo come l’unico punto dicontatto (e di divergenza) tra l’argomento del “cogito” e il passaggiowolffiano dall’<strong>in</strong>troduzione dell’argomento preontologico alla posideutscherSprache von den verschiedenen Theilen der Welt-Weißheit herausgegeben, auf Verlangen ansLicht gestellt, Frankfurt 1740, WGW I, 9: § 72). E proprio nel contesto di un’apologia deirealisti scolastici che avevano <strong>in</strong>teso separare essenza ed esistenza, anzi, <strong>Wolff</strong> avevavoluto <strong>in</strong>tendere il criterio di concepibilità non come semplice esperienza della compatibilità,o meno, fra due pensieri, bensì come tale esperienza <strong>in</strong> quanto fondata, o meno,nella non <strong>in</strong>compatibilità di due concetti nel ruolo di soggetto e predicato. Nel farlo osservare,HONNEFELDER (1990: 319-321) si richiama <strong>in</strong> proposito a diversi resocontiautobiografici dello stesso <strong>Wolff</strong>, e <strong>in</strong> particolare al passo <strong>in</strong> cui questi riconosce al propriomaestro Neumann il merito di avere <strong>in</strong>terpretato il criterio wolffiano della concepibilitàcosì <strong>in</strong>teso riportandolo non solo al “posse et non posse concipi” di Tschirnhaus, ma anchealla “clara atque dist<strong>in</strong>cta perceptio” di Cartesio e, soprattutto, alla “predicatio essentialis”degli scolastici (<strong>Wolff</strong>, Ratio praelectionum Wolfianarum [<strong>in</strong>] mathes<strong>in</strong> et philosophiam universamet opus Hugonis Grotii de jure belli et pacis, Halle 1735, WGW 36, II, II: § 19).40
zione dei primi pr<strong>in</strong>cipi dell’ontologia, a com<strong>in</strong>ciare da quelli di certezzae di contraddizione. Di tali punti di contatto (e di divergenza) ve ne sono,<strong>in</strong>fatti, almeno altri due. Soprattutto, entrambi, come il primo, sonocaratterizzati dall’<strong>in</strong>tento di ricavare gli elementi strutturali comuni a ogniesperienza certa, presc<strong>in</strong>dendo cioè da ogni suo contenuto determ<strong>in</strong>atoo privilegiato, compreso il suo riferirsi a degli oggetti esistenti, nonchédal suo essere vera – muovendo dalla nuda esperienza della “cosa” comedel<strong>in</strong>eata nel primo paragrafo della Metafisica tedesca.Sotto tale profilo, pare dunque opportuno avvic<strong>in</strong>are la concezionewolffiana della “cosa” esperibile ad alcuni term<strong>in</strong>i della semiologiaaristotelica, come impostata <strong>in</strong> un celebre passo del De <strong>in</strong>terpretatione,che converrà citare, per poi renderlo <strong>in</strong> uno schema che ne evidenzigli aspetti che qui <strong>in</strong>teressano.I suoni della voce sono simboli delle affezioni che hanno luogo nell’anima (toen tei psychei pathematon) e le lettere scritte sono simboli dei suoni della voce.Allo stesso modo poi che le lettere non sono le medesime per tutti, così neppurei suoni sono i medesimi; tuttavia, suoni e lettere risultano segni, anzitutto,delle affezioni dell’anima, che sono le medesime per tutti e costituisconole immag<strong>in</strong>i (homoiomata) di oggetti (pragmata) già identici per tutti (16a4-8).Fig. 3 – Da WIEDEMANN (2002: 149), modificato. Legenda: kf = oggetto (di norma:entità fisica data) comune (pragmaton); kψ = affezione psichica o immag<strong>in</strong>e comune(pathematon, homoiomaton); sf = simbolo convenzionale (fonico); sg simbolo convenzionale(grafico).41
La “cosa” wolffiana appare qui omologabile al “pragmaton” aristotelico<strong>in</strong> quanto oggetto significabile perché, <strong>in</strong>nanzitutto, corrispondea una rappresentazione che è altrettanto comune, ossia a unevento psichico che universalmente e regolarmente corrisponde a un“<strong>qualcosa</strong>” – paradigmaticamente, a un’entità fisica sensibile, che tuttavianon è necessario sia effettivamente ed attualmente data. Infatti,occorre sottol<strong>in</strong>eare che tale dottr<strong>in</strong>a aristotelica presc<strong>in</strong>de proprio –<strong>in</strong> quanto esplicazione metafisico-psicologica del fatto semantico e-lementare – dalla capacità di predicare il vero o il falso, si <strong>in</strong>centracioè sul significato più semplice di “logos” <strong>in</strong> quanto mera “espressionedotata di senso” 35 , come dimostra il passo del De <strong>in</strong>terpretationeimmediatamente successivo a quello appena citato.D’altro canto, come nell’anima talvolta sussiste una nozione che presc<strong>in</strong>dedal vero e dal falso e talvolta <strong>in</strong>vece sussiste <strong>qualcosa</strong> cui spetta necessariamenteo di essere vero o di essere falso, così avviene pure per quanto sitrova nel suono della voce. […] In sé, i nomi e i verbi assomigliano dunquealle nozioni (noemata) quando queste non siano congiunte a nulla né separateda nulla; essi sono, per esempio, i term<strong>in</strong>i “uomo”, o “bianco”, quandomanchi una qualche precisazione, poiché <strong>in</strong> tal caso non sussiste ancora falsitàné verità. Ciò è provato dal fatto, ad esempio, che il term<strong>in</strong>e “ircocervo”significa bensì <strong>qualcosa</strong>, ma non <strong>in</strong>dica ancora alcunché di vero o difalso, se non è stato aggiunto l’essere oppure il non essere, con una determ<strong>in</strong>azioneassoluta o temporale (16a9-19).Dunque, è anche rispetto a un significato di questo tipo – <strong>in</strong> assenzadi un referente attuale, ossia rispetto a un mero significato virtuale– che la semantica aristotelica vuole (o, meglio, deve poter <strong>in</strong>nanzitutto)funzionare. E la “cosa” che <strong>Wolff</strong> mette a tema nella suaontologia, <strong>in</strong> quanto esperibile e significabile, viene ulteriormente caratterizzatacome necessariamente possibile – e dunque garantita <strong>in</strong>35 A proposito di questo significato di “logos” cfr. RIJK (2002: 45), che commental’argomentazione elenctica <strong>in</strong> Met IV di cui ci si occuperà tra poco (cfr. <strong>in</strong>fra, pp. 50-52).Da questo punto di vista, <strong>in</strong>oltre, la teoria aristotelica del significato, <strong>in</strong> quanto <strong>in</strong>centratasul “noema”, appare nettamente dist<strong>in</strong>ta da una teoria del significato <strong>in</strong>centrata sul“lekton”, come sarà quella stoica (e dunque, secondo WIEDEMANN, anche da quellafregeana, cfr. 2002: 148-151).42
questo suo carattere da circostanze diverse dal suo darsi come presenteai sensi, ovvero dalla sua verità effettiva.Un’ulteriore presa di posizione aristotelica di <strong>Wolff</strong> rispetto alCartesio delle Meditazioni produce, allora, uno dei motivi centrali dellasua metafisica, cioè la nozione di “verità trascendentale” che sta allabase della def<strong>in</strong>izione discipl<strong>in</strong>are della “cosmologia generale” o, appunto,“trascendentale” (Disc § 78) 36 . La nozione di “verità trascendentale”come verità propria di ogni mondo possibile è stata dettagliatamentericondotta alla discussione di un argomento all’epocamolto dibattuto, orig<strong>in</strong>ato dalla trattazione del problema della dist<strong>in</strong>guibilità,o meno, del mondo del sogno rispetto alla realtà – discussioneche provenendo dalla prima Meditazione cartesiana attraversa, <strong>in</strong>realtà, l’<strong>in</strong>tera Aufklärung, arrivando s<strong>in</strong>o a Kant 37 . L’orig<strong>in</strong>e dell’<strong>in</strong>terodibattito sta dunque nel passaggio <strong>in</strong> cui Cartesio ipotizza di sognare,per concludere poi, scetticamente, sulla tesi dell’<strong>in</strong>dist<strong>in</strong>guibilità delmondo reale rispetto al mondo falso e <strong>in</strong>esistente perché sognato.Quante volte mi è accaduto di sognare, la notte, che ero qui, vestito, pressoil fuoco, benché stessi spogliato nel mio letto? È vero che ora mi sembra diguardare questa carta con occhi non addormentati, che questa testa chemuovo non sia assopita, che consapevolmente e deliberatamente stendaquesta mano e la senta […] Però, pensandoci con cura, ricordo di esserestato spesso <strong>in</strong>gannato, mentre dormivo, da simili illusioni. E fermandomisu questo pensiero vedo allora manifestamente che non ci sono <strong>in</strong>dizi concludenti,né segni abbastanza certi per poter dist<strong>in</strong>guere nettamente la vegliadal sonno […] e il mio stupore è tale da essere quasi capace di persuadermiche dormo (CARTESIO 1641: 19-20).36 Cfr. <strong>in</strong> proposito ÉCOLE (1990: 53-54). Sulla mediazione operata da <strong>Wolff</strong> tra il significatodi “trascendentale” <strong>in</strong> tale sua dottr<strong>in</strong>a e nella “transcendentium doctr<strong>in</strong>a” degliscolastici, specie rispetto all’ontologia, cfr. CARBONCINI (1991: 103-112). Sugli sviluppidella questione f<strong>in</strong>o a Tetens e Lambert cfr. KROUGLOV (2003).37 Cfr. CARBONCINI (1991). Un testo fondamentale per gli orientamenti del dibattitoattuale sull’argomento cartesiano dell’illusione rimane la raccolta di MOYAL, a cura di(1991).43
<strong>Wolff</strong> obietta allora a Cartesio di avere mancato di considerare 38 lecaratteristiche salienti (pr<strong>in</strong>cipalmente, l’<strong>in</strong>coerenza) del sogno, chesarebbero <strong>in</strong>vece tali da permettere di dist<strong>in</strong>guerlo da una osservazioneattuale e reale del mondo – o, <strong>in</strong> via più generale, di un mondopossibile.Si supponga che alcune persone si radun<strong>in</strong>o per <strong>in</strong>trattenersi e, dopo unpo’, torn<strong>in</strong>o a separarsi. Se questo è vero, si potrà dire perché ognuno siaqui, come vi sia giunto, perché nelle conversazioni accada questa o quellacosa e perché adesso ci si torni a separare. […] Se, <strong>in</strong>vece, è un sogno,non posso dire perché ognuno sia qui e come vi sia potuto giungere. Sesono il padrone di casa, vedrò ospiti non <strong>in</strong>vitati e, magari, degli estranei;anzi, scorgerò fra loro qualcuno che ho veduto <strong>in</strong> altri momenti <strong>in</strong> luoghimolto lontani, o alcuni che sono pers<strong>in</strong>o morti da lungo tempo e giaccionoputrefatti sottoterra. Nessuno potrà dire perché siano qui. Qualcunopotrà trasformarsi all’istante <strong>in</strong> qualcun altro, senza che si possa dire co-38 <strong>Wolff</strong> imputa qui a Cartesio il “pregiudizio” capitale della “precipitazione” (DM2 ad §43). Nonostante l’<strong>in</strong>terpretazione generale di Schneiders che accusa <strong>Wolff</strong> di avere trascuratodi raccogliere adeguatamente la teoria “logica” del pregiudizio come impostatada Thomasius (SCHNEIDERS 1983: 158-170; ma sulla questione cfr. pure BEETZ 1983),va osservato come l’imputazione wolffiana co<strong>in</strong>cida esattamente con quella thomasiana– come si vedrà fra poco. D’altro canto, questo diventerà un vero luogo comune perl’Aufklärung, particolarmente nella l<strong>in</strong>ea <strong>Wolff</strong>-Baumgarten-Meier: “Si può affermareche Cartesio abbia trovato la giusta via grazie a cui un dotto è <strong>in</strong> grado di preservarsi daogni pregiudizio – ancorché da ciò non si spieghi come mai egli non si sia mantenutostabilmente sulla via scoperta, con quella stessa accortezza con cui vi aveva mosso iprimi passi. Egli voleva riguardarsi da ogni avventatezza nel giudizio. Sgombrò dunque,per così dire, il proprio <strong>in</strong>telletto da tutte le conoscenze e le op<strong>in</strong>ioni. Lo gettò nellacompleta ignoranza e ricom<strong>in</strong>ciò a pensare da capo. Penso, dunque sono: ecco quel cheha ammesso come prima cosa; e così facendo <strong>in</strong>tendeva procedere <strong>in</strong> maniera deduttivaf<strong>in</strong>o ad arrivare a raccogliere un <strong>in</strong>sieme considerevole di conoscenze. È così che deveprocedere qualsiasi erudito che <strong>in</strong>tenda adottare un sistema <strong>in</strong> maniera assolutamentescevra da pregiudizi. Costui deve porre il proprio <strong>in</strong>telletto <strong>in</strong> una condizione di totale<strong>in</strong>differenza rispetto a tutti i pr<strong>in</strong>cipi e le op<strong>in</strong>ioni che rientrano <strong>in</strong> quel sistema; deveatteggiarsi nei loro confronti come se non ne sapesse ancora nulla. A questo punto, deveporre a fondamento un’esperienza non <strong>in</strong>gannevole o una tautologia (leeres Urteil) enon considerare vero o falso nulla che non segua correttamente da tale fondamento,oppure il suo contrario. Si dovrebbe pensare che per un dotto sia facile rivoluzionare un<strong>in</strong>tero sistema percorrendo questa via. Tuttavia può accadere che costui non sopporti lalentezza che ciò richiede, oppure che sopravvaluti la potenza del proprio <strong>in</strong>telletto e,anziché progredire passo a passo, azzardi un salto: d’improvviso accoglie un <strong>qualcosa</strong>per mera avventatezza e <strong>in</strong>corre <strong>in</strong> un pregiudizio. Cartesio ha spesso rappresentato unesempio negativo per la sua stessa regola” (MEIER 1766: 38).44
me. Qualcuno sarà sparito senza essersi allontanato, altri saranno qui senzaesserci venuti. L’<strong>in</strong>tera comitiva si troverà altrove senza che nessuno sisia alzato e allontanato (DM § 143).L’ord<strong>in</strong>e (osservabile) dei fenomeni è dunque per <strong>Wolff</strong> un elementodi cui Cartesio non avrebbe tenuto conto, mentre occorre ammettereche “Nel sogno tutte le cose divengono senza una ragione sufficiente e sidà spazio alla contraddizione, ma nella realtà (<strong>in</strong> veritate rerum) le s<strong>in</strong>gole cosesono e divengono con una ragione sufficiente e non si dà spazio alla contraddizione”(Ont § 493) 39 . Sicché l’ord<strong>in</strong>e che vale nel mondo reale 40 a differenzache <strong>in</strong> un mondo sognato (meglio: l’ord<strong>in</strong>e m<strong>in</strong>imo che devevalere <strong>in</strong> ogni mondo possibile) si determ<strong>in</strong>a come rispetto di entrambii pr<strong>in</strong>cipi ontologici fondamentali, di contraddizione e di ragionsufficiente (Ont §§ 27-78). Soprattutto, la verità trascendentaleche si manifesta nell’“ord<strong>in</strong>e e nella varietà di cose che contemporaneamentesono e che conseguono l’una dall’altra”, <strong>in</strong> quanto “<strong>in</strong>erentealle cose stesse” (Ont § 495), vale a def<strong>in</strong>ire la verità dell’ente “<strong>in</strong>senso assoluto” (Ont § 496), ossia quella verità “metafisica” 41 di cu<strong>in</strong>ella scolastica (compresa quella moderna, specialmente da Suárez aGoclenio) si sarebbe data soltanto una “nozione confusa” nella teoria39 Qui <strong>Wolff</strong> precisa che il sogno di cui si sta trattando va <strong>in</strong>teso <strong>in</strong> senso “oggettivo”(cioè <strong>in</strong> quanto al soggetto che sogna “appaiono delle cose”), e non “soggettivo” (cioè<strong>in</strong> quanto il soggetto che sogna “produce delle idee di cose apparenti” <strong>in</strong> base a sole circostanzepsicologico-biografiche, magari rette da una più o meno peculiare legalità); cfr.Ont § 493. In generale sul costituirsi del significato moderno dell’opposizione “soggettivo/oggettivo”<strong>in</strong> età kantiana cfr. KARSKENS (1992).40 Sulla nozione cosmologica di “mondo” <strong>in</strong> <strong>Wolff</strong> cfr. KIM (2001).41 Rispetto a tale qualificazione della verità trascendentale risultano illum<strong>in</strong>anti, speciedal punto di vista lessicografico, diversi brani del saggio wolffiano Von dem Vergnügenwelches man aus der Erkenntniß der Wahrheit schöpfen kan (<strong>in</strong> Gesammlete kle<strong>in</strong>e philosophischeSchrifften, V, Halle 1740, WGW I, 21.5), ossia della traduzione di G.F. Hagen (svolta sutesto orig<strong>in</strong>ale emendato e provvista di numerosi rimandi all’opus logico-metaphysicum) delprecedente De voluptate ex cognitione veritatis percipienda (contenuto nel primo volume delleHorae Subsecivae Marburgenses, Frankfurt - Leipzig 1729, WGW II, 34.1). In particolare al§ 3, nel contesto di un’esposizione s<strong>in</strong>tetica della propria teoria della verità, <strong>Wolff</strong> affermache la verità “che si dà nelle cose stesse” – “generale (allgeme<strong>in</strong>)” ovvero “transcendentalis”– equivale <strong>in</strong> senso stretto all’“ord<strong>in</strong>e che è <strong>in</strong>sito nella molteplicità diquelle cose che sono contemporaneamente l’una accanto all’altra o che si susseguonol’una all’altra” e fonda perciò la verità “logica”, che si dà quando <strong>in</strong> un giudizio conoscitivoadeguato alle cose stesse “il susseguente (H<strong>in</strong>terglied) si lascia determ<strong>in</strong>are dall’antecedente(Vorderglied)”.45
della convertibilità dei trascendentali (Ont § 502). E, più che salvaretale dottr<strong>in</strong>a propria del tomismo, <strong>Wolff</strong> preferisce derivare la qualificazionedella “bontà” dalla propria concezione della verità trascendentale,<strong>in</strong> quanto <strong>in</strong>terpretabile come “perfezione” (Ont §§ 503 ss.).Se, dunque, può essere reperito <strong>in</strong> <strong>Wolff</strong> più che un vestigio delladottr<strong>in</strong>a della convertibilità dei trascendentali nonostante l’impiantodella sua ontologia sia ben più marcatamente scotista che tomista, taledottr<strong>in</strong>a va scorta non <strong>in</strong> un teorema puntualmente sviluppato, quantopiuttosto nel percorso che dalla determ<strong>in</strong>azione dell’unità dell’ente<strong>in</strong> quanto <strong>in</strong>contraddittorietà del <strong>qualcosa</strong> <strong>in</strong> generale giunge, attraversol’<strong>in</strong>troduzione del pr<strong>in</strong>cipio di ragione allo scopo di determ<strong>in</strong>arnela verità, alla determ<strong>in</strong>azione della sua bontà <strong>in</strong> quanto speciedella perfezione. E la conclusione di tale sviluppo marca <strong>in</strong>fatti l’<strong>in</strong>dicedell’<strong>Ontologia</strong>, che di qui <strong>in</strong> avanti, dopo aver ricavato i predicatigeneralissimi che vanno riconosciuti a ogni cosa <strong>in</strong> generale <strong>in</strong> base aipr<strong>in</strong>cipi che ne sostengono la certezza, prende a svilupparsi come unacategorizzazione di tipo tassonomico, <strong>in</strong>centrata <strong>in</strong>nanzitutto sullapartizione degli enti <strong>in</strong> semplici e composti (cfr. supra, p. 26, n. 20) 42 .42 Quanto alla Metafisica tedesca, si trova che le successive Annotazioni al Cap. II <strong>in</strong>iziano(significativamente) con un’osservazione relativa ai §§ 10 e 30 (dedicati rispettivamenteal pr<strong>in</strong>cipio di contraddizione e al pr<strong>in</strong>cipio di ragion sufficiente) a cui <strong>Wolff</strong> lega la dist<strong>in</strong>zionetra verità necessarie e cont<strong>in</strong>genti, servendosi del medesimo esempio adoperatonella “cosmologia” per argomentare la possibilità di più mondi (cfr. DM § 570): “Se[…] qualcuno a cui mi considero obbligato a manifestare deferenza entra nella stanza <strong>in</strong>cui sono seduto, allora mi alzo; e se qualcuno mi domanda perché mi sono alzato, allorarispondo: perché questa persona è entrata nella stanza e mi ritengo obbligato a mostrarmideferente verso di lei. Chi ascolta questa risposta comprende perché mi sonoalzato e sa che ho avuto sufficiente ragione per farlo, ma non per questo motivo mi sonoalzato necessariamente” (DM2 ad § 10 & § 30). Ne va, <strong>in</strong>somma, della legge per cui“non ogni raison ovvero ogni fondamento (Grund) rende una cosa necessaria” (ibidem). Aogni modo, nel presente contesto, <strong>Wolff</strong> le lega come evidente l’osservazione consegnataal paragrafo successivo: “Def<strong>in</strong>endo qui il possibile per mezzo di ciò che non contiene<strong>in</strong> sé alcuna contraddizione, quod nullam contraditionem <strong>in</strong>volvit, prendo la parola <strong>in</strong> sensolato, <strong>in</strong> modo che essa racchiuda <strong>in</strong> sé anche moltissime cose che non diventano mai reali.E <strong>in</strong> ciò mi allontano da Sp<strong>in</strong>oza e da altri fatalisti, che vogliono riconoscere come possibilesoltanto ciò che diviene reale almeno <strong>in</strong> un caso” (DM2 ad § 12). Sulle cautele avanzate<strong>in</strong> senso generale da <strong>Wolff</strong> circa il significato della dottr<strong>in</strong>a scolastica della necessità essenziale,cfr. ancora <strong>in</strong>fra, pp. 131-133.46
3. Ignoranza o <strong>in</strong>sensibilità?Come si è visto, tuttavia, la variazione dell’argomento preontologicocon cui nella Metafisica tedesca <strong>in</strong>izia a svilupparsi la metafisica generaleriguarda soltanto la posizione del pr<strong>in</strong>cipio di contraddizione,immediatamente legato al criterio della massima certezza. Ma proprioqui si ha ancora un altro punto di contatto (polemico) tra <strong>Wolff</strong> e Cartesio,che va a toccare più a fondo l’argomento del “cogito”. <strong>Wolff</strong>,cioè, <strong>in</strong> tale circostanza non si occupa <strong>in</strong> particolare dell’ipotesi delsogno <strong>in</strong>dist<strong>in</strong>guibile dalla realtà (né <strong>in</strong> generale sullo sviluppo deldubbio radicale) e prende <strong>in</strong>vece di mira la conclusione del “cogitoergo sum” come un argomento fallacemente scettico nei riguardi delleevidenze sensibili, <strong>in</strong> quanto considerate “semplici” oggetti di credenza.Ma di questo tipo di polemica anticartesiana è possibile <strong>in</strong>dividuareun’importante fonte anteriore a <strong>Wolff</strong>, e cioè il capitolo VI dellaPhilosophia aulica (1688) di Thomasius. Il testo che qui <strong>in</strong>teressa parte<strong>in</strong>fatti dal riconoscimento a Cartesio di avere voluto ricercare unprimo pr<strong>in</strong>cipio della conoscenza non <strong>in</strong>ficiato da pregiudizi, e prosegueaccusandolo di una “precipitazione” che lo avrebbe fatto fallirenel suo proposito. Cartesio si sarebbe cioè dimostrato “<strong>in</strong>cauto, poichési è voluto risparmiare di riflettere troppo”, tanto che “non sarebbepotuto cadere <strong>in</strong> modo più precipitoso e rozzo, simile a colui che salendoa cavallo con un grande slancio cade poi dall’altro suo fianco”(ibidem, § 16). E la giustificazione di questa accusa viene poi circostanziatarispetto al caso della conoscenza procurata dai sensi.Infatti, chi dalla circostanza per cui i sensi talvolta hanno dato al giudiziol’occasione di errare <strong>in</strong>ferisce che i sensi errano sempre o possono sempre errare riguardoalle cose poste fuori di noi <strong>in</strong>corre nel pregiudizio della precipitazione(THOMASIUS 1688: § 17).Non si è distanti dal rilievo di <strong>Wolff</strong>, già ricordato, secondo cui glistessi scettici con cui Cartesio compete, per la scrupolosità epistemologicache li contraddist<strong>in</strong>gueva, non si sarebbero mai azzardati amettere <strong>in</strong> dubbio la certezza soggettiva dei “fenomeni”, ma si sarebberolimitati a negare la necessaria e perfetta corrispondenza tra essi ela realtà (Ont § 27). Thomasius, a ogni modo, tiene a osservare che la47
sua critica a Cartesio riguarda <strong>in</strong> primo luogo proprio la certezza relativaa esperienze di tipo sensibile. Nello sgomberare scetticamente ilterreno per l’argomento del “cogito” Cartesio ha <strong>in</strong>fattiriferito la medesima possibilità di errore alla cognizione delle membra del propriocorpo e ha dubitato di avere mani e piedi, concludendone perciò che il primopr<strong>in</strong>cipio della conoscenza è ‘penso, dunque sono’; ma, dato che gli si puòopporre che avrebbe potuto dire con uguale diritto ‘ho mani e piedi, dunquesono’, non ha fatto altro che aver f<strong>in</strong>to s<strong>in</strong> qui di non avere mani e piedi,rendendosi colpevole di entrambi i pregiudizi della precipitazione e degli affetti(THOMASIUS 1688: § 18).L’ultimo paragrafo di questa argomentazione di Thomasius esponequ<strong>in</strong>di, palesemente, <strong>in</strong> forma estesa quello che sarà il richiamo di<strong>Wolff</strong> alla certezza nella cognizione di una “cosa” qualsiasi.Perché è <strong>in</strong>dubbio che se Cartesio portasse la questione d<strong>in</strong>anzi a uno scetticoche nega di pensare lo r<strong>in</strong>vierebbe alla sua propria coscienza e gli imputerebbedi f<strong>in</strong>gere di non averne consapevolezza, e lo allontanerebbe come si allontanaun folle. Ma noi contro la sua f<strong>in</strong>zione di non avere mani e piedi possiamo r<strong>in</strong>viarlocon uguale diritto alla sua propria coscienza di questo fatto. Chiunque, <strong>in</strong>realtà, difficilmente per un vuoto pregiudizio negherà la propria coscienza diavere mani e piedi, tanto quanto quella di pensare (ibidem, § 19).E il passo conclusivo di Thomasius consiste (ciò che farà anche<strong>Wolff</strong> quando trasformerà l’argomento preontologico nell’<strong>in</strong>cipit delsecondo capitolo della Metafisica tedesca e poi dell’<strong>Ontologia</strong>) nel riferiretale pr<strong>in</strong>cipio di certezza al pr<strong>in</strong>cipio di contraddizione.Dunque, lasciato da parte Cartesio, riteniamo che la dottr<strong>in</strong>a dei PERI-PATETICI circa il primo pr<strong>in</strong>cipio della conoscenza non sia ancora statascossa, consistendo appunto nella seguente proposizione: è impossibile che lostesso contemporaneamente sia e non sia (ibidem, § 20).Anche al di là di ulteriori considerazioni di cornice che potrebbero48
venire sviluppate 43 , le analogie con l’argomentazione di <strong>Wolff</strong> (compresol’accenno all’<strong>in</strong>sensatezza, ovvero alla follia di chi dubita “cartesianamente”)44 sono palesi. E se la strategia generale che ha ispiratoa Thomasius questa critica consiste nel cercare una via mediana tra idue pr<strong>in</strong>cipali fronti del dibattito filosofico dell’epoca, non sarebbedifficile mostrare che la strategia del <strong>Wolff</strong> della Metafisica tedesca è lamedesima. In ogni caso, si tratta ora di esam<strong>in</strong>arne più da vic<strong>in</strong>o il richiamoalla tradizione peripatetica.L’argomento preontologico di <strong>Wolff</strong> (così come la critica di Thomasiusall’argomento del “cogito”) non si presenta come una dimostrazione<strong>in</strong> senso stretto, bensì come un’argomentazione di tipo e-lenctico, ovvero come una confutazione <strong>in</strong>diretta. La critica operatada Thomasius e poi ripresa da <strong>Wolff</strong> è cioè non solo anticartesiana,nel senso di rifiutarsi di porre e risolvere il problema della certezzacommisurandolo al criterio di un’argomentazione scettica trascendentale,ma è anche aristotelica <strong>in</strong> quanto sceglie positivamente una diversastrategia argomentativa nel recupero (<strong>in</strong> sede di logica Thomasius,<strong>in</strong> sede di logica e di metafisica <strong>Wolff</strong>) del pr<strong>in</strong>cipio di contraddizione.Già l’eco testuale del libro IV della Metafisica (1005b35-1006a28), cioè del passaggio che <strong>in</strong>troduce la serie delle confutazionidi coloro che affermano “che la stessa cosa può essere e non essere”e “che <strong>in</strong> questo modo si può pensare”, è forte, specie <strong>in</strong> Thomasius– f<strong>in</strong> dal mimare l’irritazione mostrata da Aristotele verso l’“ignoran-43 Le argomentazioni thomasiane si trovano nel capitolo della Philosophia aulica <strong>in</strong>titolato “Depraejudiciis veritatis <strong>in</strong>quisitionem impedientibus, eorumque extirpatione et primis cognoscendipr<strong>in</strong>cipiis”. Qui Thomasius – come non farà più nelle sue opere successive – lega latrattazione dei pregiudizi alla questione del corretto modo di dubitare e, qu<strong>in</strong>di, al problemadella ricerca di pr<strong>in</strong>cipi primi e <strong>in</strong>dubitabili della conoscenza. Ancora, non bisogna trascurareil sottotitolo di quest’opera: L<strong>in</strong>eae primae libri de prudentia cogitandi et ratioc<strong>in</strong>andi, Ubi ostenditurmedia <strong>in</strong>ter praejudicia Cartesianorum & <strong>in</strong>eptias Peripateticorum, veritatem <strong>in</strong>veniendi via.44 Al cap. I della Außübung der Vernunfft-Lehre viene posta da Thomasius la dist<strong>in</strong>zione fondamentaletra “dubbio scettico” e “dogmatico”, secondo cui “dubitare significa: o vacillarenel proprio <strong>in</strong>telletto, o chiedersi se <strong>qualcosa</strong> nel mondo sia vera o falsa” (THOMASIUS 1691:§ 31). Il dubitare genu<strong>in</strong>o va cioè <strong>in</strong>teso come un ragionamento f<strong>in</strong>alizzato e qu<strong>in</strong>di f<strong>in</strong>ito, almeno<strong>in</strong> l<strong>in</strong>ea di pr<strong>in</strong>cipio; altrimenti, qualora tenda <strong>in</strong> modo “dogmatico” a farsi condizionepermanente, co<strong>in</strong>cide con lo stato di follia: esclude dal dialogo (di nuovo secondo la regola:“non si deve mai disputare sulle cose di cui nessun essere umano ha motivo di dubitare”,ibidem, § 86) e conduce lontanissimo dall’obiettivo della rettifica dei pregiudizi.49
te” che chiede <strong>in</strong>vano una dimostrazione del pr<strong>in</strong>cipio <strong>in</strong> esame. Male analogie non si fermano alla superficie testuale.Intanto, va osservato come per Aristotele il pr<strong>in</strong>cipio di contraddizionesia a rigore <strong>in</strong>dimostrabile: ed è questo che l’“ignorante” aristotelico(ovvero, per gli Aufklärer, colui che dubita pregiudizialmente)propriamente non considera – ma lo è per due ragioni che paiono,<strong>in</strong>vece, effettivamente dimostrabili. Innanzitutto, che il pr<strong>in</strong>cipio dicontraddizione sia <strong>in</strong>dimostrabile lo si può provare grazie all’argomentosecondo cui è impossibile fornire dimostrazione di ogni cosa,pena un regresso all’<strong>in</strong>f<strong>in</strong>ito (Met 1006a6-10). L’altro è <strong>in</strong>vece un motivoprocedurale: poiché ogni dimostrazione presuppone la rispondenzaal pr<strong>in</strong>cipio di contraddizione, la dimostrazione di quest’ultimoimplicherebbe <strong>in</strong> modo ovvio una petitio pr<strong>in</strong>cipii. Sicché non resta altravia oltre a quella di una confutazione <strong>in</strong>diretta del suo negatore.Il dimostrare per via di confutazione e il dimostrare semplicemente sonodifferenti, poiché sembrerebbe, se si dimostra, di commettere una petizionedi pr<strong>in</strong>cipio, mentre se il responsabile di tale petizione è un altro si darebbeconfutazione e non dimostrazione. Il punto di partenza per siffatte dimostrazioni[sc. quelle elenctiche] non è pretendere che l’<strong>in</strong>terlocutore dica che<strong>qualcosa</strong> è oppure non è – si potrebbe pensare che questa sia una petizionedi pr<strong>in</strong>cipio –, ma è pretendere che <strong>in</strong>dichi almeno un significato per sé eper gli altri: questo è necessario, se egli dice davvero <strong>qualcosa</strong>. Se non lo fa,per costui non si darebbe alcun ragionamento, né rivolto a se stesso, né rivoltoad altri. Ma se concede questo [sc. se <strong>in</strong>dica almeno un significato], visarà una dimostrazione: <strong>in</strong>fatti, vi sarà già <strong>qualcosa</strong> di def<strong>in</strong>ito. D’altra parte,responsabile [sc. della petizione di pr<strong>in</strong>cipio] non è colui che dimostra, machi richiede una dimostrazione (Met 1006a16-28).Di qui Aristotele svolge una serie di confutazioni degli avversari delpr<strong>in</strong>cipio di contraddizione – senza poter ricorrere a tale pr<strong>in</strong>cipio, némirare a dimostrarlo, ma limitandosi semplicemente a richiedere che ilsuo opponente “dica <strong>qualcosa</strong>” (Met 1006a11). Ora, è l’ottemperare atale richiesta che risulta impossibile agli avversari di Aristotele. Le parolecon cui Reale brevemente commenta il passaggio sono qui caratteristicamenteambigue, e perciò illum<strong>in</strong>anti: “Per essere veramente coerenti,coloro che negano il pr<strong>in</strong>cipio di non-contraddizione dovrebberonon dire nulla, anzi, non pensare nulla. Ma allora, essi diverrebbero50
simili alle piante, e dovrebbero limitarsi a vegetare” (REALE, Met: 714). Ilpunto dirimente, <strong>in</strong>fatti, non è tanto quello dell’<strong>in</strong>coerenza dell’avversariodel pr<strong>in</strong>cipio di contraddizione, quanto piuttosto il rivelarsi dellasua <strong>in</strong>capacità di dire <strong>qualcosa</strong> – come mette fortemente <strong>in</strong> rilievo l’immag<strong>in</strong>earistotelica del “vegetale” (Met 1006a15) 45 , <strong>in</strong>capace di provarequelle affezioni che reggono il fenomeno del significare <strong>qualcosa</strong> (cfr. supra,pp. 41-42). Rispetto a ciò, RIJK (2002: 45) osserva allora come il logosa cui l’opponente del pr<strong>in</strong>cipio di contraddizione viene da Aristotele richiestodi attenersi ha <strong>in</strong> generale un significato doppio: di “argomento”,certo, ma ancor prima di “espressione dotata di senso” – risultando quipiù pert<strong>in</strong>ente e fondamentale il secondo. È dunque sulla capacità di poterdire <strong>qualcosa</strong> – <strong>qualcosa</strong> di sensato, anche se non necessariamentevero – che fa leva l’argomento elenctico, che perciò si caratterizza comela confutazione di una tesi ottenuta “mostrando rispetto a quali caratteristiche(fondamentali) [del discorso] la sua difesa è <strong>in</strong>evitabilmente autodistruttiva”e non semplicemente autocontraddittoria (RIJK 2002: 46).L’avversario di Aristotele si rivela per l’appunto <strong>in</strong>capace di mantenerenel corso della discussione il significato di un’espressione da lui <strong>in</strong>izialmenteproferita e rispetto a cui si richiede di avere un senso – ovvero ditenere fermo un dictum (cfr. ibidem, 43). E nella versione degli Aufklärertale <strong>in</strong>capacità diventa una sorta di confutabilità assoluta.Thomasius 1688: § 19 DM § 1“Se Cartesio portasse la questione d<strong>in</strong>anzi a “Siamo coscienti di noi e di altre cose, del cheuno scettico che nega di pensare, lo r<strong>in</strong>vierebbealla sua propria coscienza e gli imputamenteprivato dei propri sensi, ovvero folle; enon può dubitare nessuno che non sia completerebbedi f<strong>in</strong>gere di non averne consapevolezza,e lo allontanerebbe come si allontana cosa diverse da quelle che trova dentro di sé, echi volesse negarlo asserirebbe con la boccaun folle.”potrebbe anche venire subito conv<strong>in</strong>to che lasua affermazione è assurda.”45 Ross traduce pianamente e rigorosamente: “It is possible to prove the law by refut<strong>in</strong>gour opponent, if he will but say someth<strong>in</strong>g. If he will not, he need not be argued withand is no better than a vegetable” (ROSS, Met 1006a11-15). Curiosamente (o forse no?)nell’enfatica parafrasi del passo data da Łukasiewicz quest’immag<strong>in</strong>e manca, e la si rendenei seguenti term<strong>in</strong>i, più semplici: discutere con un avversario del pr<strong>in</strong>cipio di contraddizionesarebbe ridicolo come il voler parlare con un albero (ŁUKASIEWICZ 1910: 45).Łukasiewicz del resto non giudica troppo significativa l’argomentazione elenctica aristotelicae la ritiene, <strong>in</strong>somma, puramente verbalistica (cfr. ibidem, 63-70; altrove affermeràesplicitamente di non <strong>in</strong>tendere affatto il senso del passo di Met 1006a15-18, cfr. 1960:55). Per una rassegna aggiornata dell’<strong>in</strong>tera questione cfr. WOLEŃSKI (2000).51
Il fatto più fondamentale, però, è che il “vegetale” aristotelico (cosìcome poi il “folle” di Thomasius e l’“<strong>in</strong>sensato” di <strong>Wolff</strong>) appare,nel suo discorrere con altri, <strong>in</strong>capace di avere un’esperienza almenovirtualmente comunicabile – fosse magari banale come è quella di chisa, per sentirli, di avere mani e piedi. Ora, questo fatto non riguardasoltanto una teoria della significazione specificamente l<strong>in</strong>guistica,bensì più estesamente le caratteristiche di una semantica 46 le cui costituentipsicologiche la ancorano a un’esperienza elementare del mondo.Si tratta, <strong>in</strong>somma, dell’esperienza <strong>in</strong>nanzitutto sensibile (e conciò virtualmente significabile) della “cosa” <strong>in</strong> generale, che <strong>Wolff</strong>mette a tema della metafisica e, <strong>in</strong>nanzitutto, dell’ontologia – ma trattabilecome una questione squisitamente psicologica.46 Per Aristotele, cfr. WHEELER (1999: 212-226); per <strong>Wolff</strong>, cfr. RICKEN (1989: 25-41).52
III – La <strong>psicologia</strong> che sostiene l’ontologiaWer irret, der verstehet nicht nur die Sache selbsten nicht,sondern er hält, wie man <strong>in</strong>sgeme<strong>in</strong> sagt, auch den Schattenvor e<strong>in</strong> wahres Bild.<strong>Wolff</strong>, Von dem Vergnügen welches man an der Erkenntnis derWahrheit schöpfen kan § 10Secondo quanto si è cercato di suggerire f<strong>in</strong> qui, il massimo contributoleibniziano all’ontologia di <strong>Wolff</strong> consiste, prima ancora che nell’<strong>in</strong>troduzionedel pr<strong>in</strong>cipio di ragione come unico “nuovo” rispetto alla tradizionescolastica, nella revisione dell’argomento del “cogito” alla luce diuna filosofia della mente che assume come primario il carattere <strong>in</strong>tenzionaledel fatto di coscienza. D’altro canto – come si cercherà di suggerire<strong>in</strong> ciò che segue – se è vero che il punto di massimo distacco di<strong>Wolff</strong> dalla metafisica di Leibniz consiste nel rifiuto della teoria dellemonadi, tale distacco può essere <strong>in</strong>terpretato alla luce di una sempliceformula: le “monadi” di <strong>Wolff</strong> hanno f<strong>in</strong>estre, ossia dispongono di contenutirappresentativi determ<strong>in</strong>ati da leggi che, benché non di tipo causale,vanno <strong>in</strong>tese come ragioni metafisiche necessarie, sicché tali “monadi”si trovano collocate entro un mondo comune, fatto di “cose”. El’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e di tali ragioni, per <strong>Wolff</strong>, è <strong>in</strong>nanzitutto questione legittimadella <strong>psicologia</strong>, che non può dunque limitarsi a essere una scienza dell’anima,ma deve piuttosto <strong>in</strong>tendersi come scienza delle “cose” che sono“possibili mediante le anime” (Disc § 58).1. Utilità e danno della metafisica per la scienzaCiò che si è appena affermato <strong>in</strong>troduttivamente dovrebbe apparirealmeno strano, perché, se fosse vero, si darebbe allora il caso diuna parte speciale della metafisica chiamata a risolvere un problemadi metafisica generale. Di più: anche se non si trattasse di una circolaritàviziosa, essendo proprio la <strong>psicologia</strong> (<strong>in</strong> quanto scienza reale e53
egionale) a venire chiamata a risolvere un problema ontologico,sembrerebbe che la commistione di <strong>psicologia</strong> e metafisica debba perforza risolversi <strong>in</strong> una serie di cattive <strong>in</strong>fluenze reciproche e debba,qu<strong>in</strong>di, nuocere alla scientificità della prima come alla filosoficità dellaseconda. Ma, forse, se a causa di simili sospetti si esita ad ammettereil valore ontologico di alcune tesi psicologiche di <strong>Wolff</strong> è solo peruna storia di parole – dipendente, a sua volta, dalla mera superficiedella storia delle discipl<strong>in</strong>e. Per ridurre tali cattive impressioni, converrà<strong>in</strong>tanto chiedersi se la “<strong>psicologia</strong> empirica” di <strong>Wolff</strong> 47 sia commensurabilecon l’odierna <strong>psicologia</strong> scientifica, domandandosi <strong>in</strong>nanzituttose, come corpi discipl<strong>in</strong>ari, condividano (per lo meno) lamedesima storia – una storia, cioè, relativa a problemi fra loro simili,tematicamente circoscritta e metodicamente omogenea, almeno <strong>in</strong>qualche misura.Interrogando le storie della <strong>psicologia</strong> meglio attestate, si trovaabbastanza facilmente riconosciuto a <strong>Wolff</strong> qualcuno dei meriti chepopolarmente vengono considerati antimetafisici e, per ciò stesso,scientifici. Se non altro, dopo <strong>Wolff</strong> non si parla quasi più di “pneumatica”48 : dove il tema centrale diventa quello dell’anima e, paradig-47 In ciò che segue, piuttosto che alla Psychologia empirica del 1732 (nonché al suo pendant,la Psychologia rationalis del 1734) ci si riferirà soprattutto ai capitoli equipollenti della cosiddettaMetafisica tedesca (1719), corredati dalle relative annotazioni (1724). Questo, perdue motivi pr<strong>in</strong>cipali: 1) le successive psicologie “lat<strong>in</strong>e” ne svolgono essenzialmenteun’amplificazione quantitativa, senza modificarne impianto e argomenti; 2) la stessa presenzadi una <strong>psicologia</strong> empirica nella pr<strong>in</strong>cipale opera wolffiana di metafisica (di cuianzi costituisce il capitolo più ampio, 348 paragrafi su 1089) segnala, come è stato rilevatoda molti <strong>in</strong>terpreti (cfr. ARNAUD 2002), tutta una serie di problemi relativi allo statutofilosofico di questa discipl<strong>in</strong>a.48 Normalmente, prima della ridef<strong>in</strong>izione term<strong>in</strong>ologica (ma <strong>in</strong>nanzitutto discipl<strong>in</strong>are)promossa da <strong>Wolff</strong>, la parte speciale della metafisica dedicata allo studio degli spiriti (ossiaalle entità immateriali dotate di <strong>in</strong>tellezione, e non solo senzienti o semplicementeviventi, cioè alle anime dei bruti o dei vegetali) era normalmente detta “pneumatica”, o“pneumatologia”. Quanto alle sue partizioni <strong>in</strong>terne, si riferiva di norma rispettivamenteagli spiriti <strong>in</strong>creati (alla div<strong>in</strong>ità) e a quelli creati, sviluppandosi così <strong>in</strong> angelologia, demonologiaecc. – nonché <strong>in</strong> <strong>psicologia</strong>, riferita quest’ultima all’anima umana (<strong>in</strong>tesa come<strong>in</strong>dagabile, <strong>in</strong>oltre, nel suo stato di unione oppure separatezza rispetto a un corposemplicemente fisico). Si tratta di una ridef<strong>in</strong>izione che non importa un mero cambiamentodi vocabolario, ma registra i cambiamenti subiti dalla metafisica generale di cui lanuova <strong>psicologia</strong> è parte, <strong>in</strong> primis il suo riferirsi non più <strong>in</strong>nanzitutto a una filosofia primadi impianto teologico creazionistico, bensì a una scienza dell’ente “<strong>in</strong> quanto ente” edelle sue classificazioni, cfr. supra, pp. 25-27. Ciò risulta ben leggibile nello stesso <strong>Wolff</strong>;54
maticamente, dell’anima umana (<strong>in</strong>dagabile però anche <strong>in</strong> manieracomparativa rispetto alle anime create non umane: bruti, angeli e demoniecc.), si parlerà di <strong>psicologia</strong>, mentre la parte della pneumaticariferita allo spirito div<strong>in</strong>o verrà def<strong>in</strong>itivamente consegnata alla teologia.Tuttavia, il nuovo term<strong>in</strong>e discipl<strong>in</strong>are viene esplicitamente adoperatoper designare comunque una delle quattro parti della metafisicaspeciale (la scienza dell’anima, appunto) e tale def<strong>in</strong>izione, <strong>in</strong>siemecon la dist<strong>in</strong>zione metodica tra <strong>psicologia</strong> empirica e razionale, nonostantele successive critiche degli idealisti, rimarrà valida almeno s<strong>in</strong>oagli <strong>in</strong>izi di questo secolo. In tal modo, l’opera di <strong>Wolff</strong> sembra peròresp<strong>in</strong>ta nella preistoria della discipl<strong>in</strong>a che davvero ci <strong>in</strong>teressa. Infatti,quasi <strong>in</strong> ogni storia della <strong>psicologia</strong> che si rispetti, i criteri chesegnano l’<strong>in</strong>izio della “vera” <strong>psicologia</strong> vengono <strong>in</strong>dicati <strong>in</strong> due momentifondativi la cui ostilità alla metafisica è di carattere ben diversoda quello di un congedo della pneumatica di impronta teologica: ilprimo, sarebbe quello settecentesco della restrizione del campo delsapere antropologico <strong>in</strong> senso più specificamente psicologico 49 ; il secondo,quello dell’imporsi <strong>in</strong> tale “nuovo” ambito discipl<strong>in</strong>are, a f<strong>in</strong>eOttocento, di un paradigma sperimentale f<strong>in</strong>almente maturo. Dunque,pur adeguatamente circoscritta una <strong>psicologia</strong> come moderna“scienza dell’uomo”, rimarrebbe vero che “solo nella seconda metàdell’Ottocento […] il term<strong>in</strong>e ‘<strong>psicologia</strong>’ com<strong>in</strong>cerà ad essere utilizzatoper designare una discipl<strong>in</strong>a scientifica autonoma dalla filosofia esv<strong>in</strong>colata da ipoteche metafisiche, con una accezione più o menoanaloga a quella odierna” (LEGRENZI 1980: 30).Ammesso che queste notazioni siano vere, il tarlo, <strong>in</strong>somma, stavanel carattere “speculativo-metafisico” che nella tradizione della psicosiconfront<strong>in</strong>o i due seguenti passi, tratti rispettivamente dalla Logica tedesca e dal Discursuspraelim<strong>in</strong>aris: “Le creature esternano la propria attività o con il movimento, o con i pensieri.Quelle le chiamiamo corpi, e queste spiriti. […] La parte della filosofia <strong>in</strong> cui sispiega ciò che è possibile mediante le forze degli spiriti è chiamata pneumatologia(Pneumatologie), ovvero dottr<strong>in</strong>a degli spiriti (Geister-Lehre); l’altra, <strong>in</strong>vece, <strong>in</strong> cui si mostraciò che è possibile mediante le forze corporee riceve il nome di fisica, ovvero di scienzadella natura, ovvero di dottr<strong>in</strong>a della natura” (DL, “Vorbericht” § 12); “La parte dellafilosofia che tratta dell’anima uso chiamarla <strong>psicologia</strong> (psychologia). Dunque la <strong>psicologia</strong> è lascienza di quelle cose che sono possibili mediante le anime umane” (Disc § 58).49 Cfr. ad es. LEGRENZI, a cura di (1980: 34 ss.). Ma tale assunto si pone sullo sfondo diparecchi <strong>in</strong>fluentissimi lavori di storiografia filosofica: cfr., per tutti, WUNDT (1945).55
logia filosofica avrebbe impedito la formulazione di problemi genu<strong>in</strong>amentescientifici, cioè adeguatamente trattabili mediante un approcciosperimentale 50 . Ma <strong>in</strong> tutto ciò non è difficile riconoscereun’accezione di metafisica banalizzata, equivalente a “teoria cattiva”,le cui ragioni polemiche, storicamente elaborate da un Russell o daun Carnap, paiono ormai circoscritte e non più così ovvie, specie <strong>in</strong>ambito epistemologico. Perciò, e facendo esattamente centro sul casodi <strong>Wolff</strong>, si potrebbe nutrire qualche dubbio circa questa trama, mostrandoanzi come, proprio nella cont<strong>in</strong>uità dell’impianto aristotelicoscolasticoentro cui si iscrive la <strong>psicologia</strong> empirica 51 , si faccia valerel’impegno a edificare una <strong>psicologia</strong> adoperando soltanto materialigenu<strong>in</strong>amente osservativi.Sotto questo rispetto, importerà <strong>in</strong>nanzitutto rimarcare la produzionedi due psicologie, metodicamente dist<strong>in</strong>te, da parte di <strong>Wolff</strong> 52 :una <strong>psicologia</strong>, appunto quella “empirica”, programmaticamente basatasulle sole osservazione, sperimentazione e quantificazione come50 Sicché si conviene normalmente che Mach o Pavlov sono psicologi, a differenza diun Cartesio. A ogni modo, nella storia delle discipl<strong>in</strong>e scientifiche l’<strong>in</strong>treccio tra <strong>psicologia</strong>e antropologia, con il problema del loro carattere antimetafisico, o meno, èsenz’altro più complicato di così. In proposito, ci sembrano condivisibili le valutazionidi FEUERHAHN (2002), secondo cui il processo della autonomizzazione della <strong>psicologia</strong>non è affatto co<strong>in</strong>ciso con quello della sua “scientificizzazione” ed è stato, <strong>in</strong>oltre, almenoagli <strong>in</strong>izi, sostenuto proprio da ragioni di tipo metafisico.51 Azzardando l’uso di una term<strong>in</strong>ologia anacronistica, nella <strong>psicologia</strong> empirica di<strong>Wolff</strong> si potrebbero <strong>in</strong>dividuare almeno tre presupposti “aristotelici”: 1) le sue leggi osservativesi pongono nel contesto di una biologia, cioè di una teoria del comportamento<strong>in</strong>tenzionale del vivente, prima che di una teoria speciale dei fatti e delle entità mentali.2) Le leggi psicologiche, per assumere una funzione esplicativa rispetto al comportarsiproprio di un organismo senziente, vertono su entità e/o eventi <strong>in</strong>terni a ogni s<strong>in</strong>goloorganismo, cioè non (<strong>in</strong>ter)osservabili. 3) Queste ultime, caratterizzate come rappresentazioni,si assumono capaci di istituire nessi <strong>in</strong>tenzionali con oggetti non attualmente odirettamente percepiti e, nell’essere umano dotato di l<strong>in</strong>guaggio, di sostenere nessi disignificazione. Tali presupposti della <strong>psicologia</strong> aristotelica ricevono attualmente grandeattenzione negli studi di impostazione analitica (cfr. per un primo orientamentoSHIELDS, ad voc. “Aristoteles, psychology”, <strong>in</strong> SEPh).52 O, meglio, tre, se si considerano i caratteri “psicologistici” della logica che <strong>Wolff</strong> premettealla propria enciclopedia filosofica <strong>in</strong> funzione di propedeutica e metodologia generale:la logica come “arte” ovvero “scienza” del pensare e dell’argomentare si configura<strong>in</strong>fatti come prescrittiva solo <strong>in</strong> quanto descrizione di un “pensiero naturale” emendato,assunto cioè nella sua idealità di pensiero depurato da fallacie più o meno comuni.56
via legittima della conoscenza di leggi naturali 53 ; e un’altra <strong>psicologia</strong>,quella “razionale”, che si prefigge di trascendere le regolarità e le legg<strong>in</strong>aturali <strong>in</strong>dividuate dalla prima, portandosi a un livello più radicalmenteesplicativo, servendosi massicciamente di pr<strong>in</strong>cipi e leggi stabiliti<strong>in</strong> sede di metafisica generale e, <strong>in</strong>nanzitutto, del pr<strong>in</strong>cipio di ragione.Sicché la differenza tra <strong>psicologia</strong> empirica e razionale sembra<strong>in</strong>terpretabile nei term<strong>in</strong>i di una differenza tra leggi di livello diverso,rispettivamente effettuali-descrittive e ipotetico-esplicative, riferiteperò a un unico dom<strong>in</strong>io reale.Passando sopra agli scivolamenti successivamente deprecati come“metafisici” che si possono comunque ravvisare nella <strong>psicologia</strong> empiricadi <strong>Wolff</strong>, importerà dunque notare come questa si propone essenzialmentedi raccogliere le leggi che regolano la vita psichica osservabile,come si legge nel paragrafo di apertura del terzo capitolo dellaMetafisica tedesca.Qui non pretendo ancora di mostrare che cos’è l’anima e come si verifich<strong>in</strong>o<strong>in</strong> essa le sue modificazioni, ma il mio attuale proposito è soltanto di descrivere(erzehlen) ciò che ne percepiamo per mezzo dell’esperienza quotidiana.E qui non addurrò nient’altro, se non quanto può apprendere ognunoche presti attenzione a se stesso. Questo ci servirà da base per dedurnealtre cose che non ognuno riesce a scorgere subito da se stesso. Ossia, vogliamocercare concetti dist<strong>in</strong>ti di ciò che percepiamo dell’anima e annotaredi quando <strong>in</strong> quando alcune importanti verità che se ne lasciano derivare. E53 Secondo il Discursus praelim<strong>in</strong>aris (1728), al sapere soltanto “istorico” (osservativo, testimoniale,sperimentale, a posteriori…), che consiste nella nuda cognizione di un oggettoo di un evento (§ 3), il sapere filosofico aggiunge la conoscenza della sua possibilità edelle sue ragioni (§ 7); <strong>in</strong>oltre, se la conoscenza istorica può confermare a posteriori quellafilosofica (§ 26), la matematica (<strong>in</strong>tesa come quantificazione dei rapporti che <strong>in</strong>tercorronotra due fatti <strong>in</strong>terconnessi, di cui si conosce così la “ratio”) le aggiunge certezza (§27). Dunque, fra i tre tipi fondamentali di sapere <strong>in</strong>tercorrono diversi rapporti asimmetrici(<strong>in</strong>tesi anche come rapporti gerarchici), ma l’unico autonomo e necessario per glialtri è quello istorico. D’altro canto, quello che si esplica nella <strong>psicologia</strong> empirica non èun mero sapere istorico, bensì filosofico e, anzi, propriamente metafisico: più che damere notizie, è costituito da conoscenze di regolarità e di leggi, né r<strong>in</strong>uncia a specificazionidi tipo quantitativo (cfr. ARNAUD 2002). Il passaggio term<strong>in</strong>ologico dalla qualificazionedi “empirica” a “sperimentale” per la <strong>psicologia</strong> metafisico-osservativa di <strong>Wolff</strong> siavrà, <strong>in</strong>oltre, nel processo della sua rapida diffusione; <strong>in</strong> particolare, va qui tenuto contodella sua “traduzione” francese (cfr. ANONIMO, 1745, <strong>in</strong> WGW III, 46) largamente ripresanegli articoli della Encyclopédie.57
queste verità, che sono confermate da esperienze sicure, sono la base diquelle regole a cui si conformano le forze dell’anima tanto nel conoscerequanto nel volere e nel non volere, e sono qu<strong>in</strong>di la base della logica, dellamorale e della politica (DM § 191).Di questo passaggio – che è la variazione dell’argomento preontologicochiamata a fondare la <strong>psicologia</strong> empirica – converrà sottol<strong>in</strong>earealcuni tratti fondamentali. Intanto, rispetto all’argomento del primoparagrafo della Metafisica tedesca, siamo <strong>in</strong> presenza di una sua applicazioneal territorio specifico della conoscenza empirica, senza checiò tuttavia comporti alcuna deriva di tipo <strong>in</strong>trospezionistico. Comeuna qualsiasi altra “cosa”, cioè, la cosa che noi siamo non è un osservabilemeramente <strong>in</strong>trospettivo (una semplice entità mentale privata):<strong>in</strong> quanto immediatamente collocabile sul piano apofantico, ciò chene cogliamo ha caratteristiche di oggettività, pur non trattandosi di un<strong>in</strong>terosservabile <strong>in</strong> senso proprio 54 .Ma, soprattutto, si dovrà sottol<strong>in</strong>eare la prima conseguenza metodicanegativa del proposito wolffiano: la prescrizione di non ricorrere aentità pseudo-osservative, come sarebbe em<strong>in</strong>entemente quella di unapretesa cognizione diretta dell’<strong>in</strong>flusso causale psicofisico 55 . Ed è taleammonizione – che riteniamo non essere stata colta, nella sua specificità,da parecchie letture che sottol<strong>in</strong>eano il ruolo positivo assegnatoall’“empiria” nel sistema “razionalistico” wolffiano 56 – quella su cui sista per fare leva.2. Credere per poi correggersiSi tratterà ora di istruire un raffronto sufficientemente stretto frala <strong>psicologia</strong> empirica di <strong>Wolff</strong> e un ambito della moderna <strong>psicologia</strong>scientifica con essa comparabile – senz’altro sul piano dei presuppo-54 Il concetto di <strong>in</strong>terosservabilità come qui impiegato si orienta sui due fondamentalisaggi di BOZZI, L’<strong>in</strong>terosservazione come metodo per la fenomenologia sperimentale (<strong>in</strong> ID. 1989:203-216) e “La corrente della coscienza” ossia gli eventi sotto osservazione (ibidem, 235-274).55 Per un panorama sull’ampio dibattito attuale <strong>in</strong> filosofia della mente circa il problemapsicofisico, cfr. ROBB - HEIL, ad voc. “Mental causation”, <strong>in</strong> SEPh (e le voci correlate).56 Cfr. ad es. CATALDI MADONNA (2001).58
sti metodologici e, almeno mediatamente, su quello dei problemi metafisicisottesi. Per motivi che verranno subito giustificati, un tale ambitosi crede di poterlo scorgere nella percettologia di ascendenza gestaltistica,ossia nella fenomenologia sperimentale, di cui andrà cercata<strong>in</strong>nanzitutto una def<strong>in</strong>izione m<strong>in</strong>ima. Di questa, <strong>in</strong>tanto, va registratoche non gode ancora di uno statuto scientifico standardizzato– pur potendo vantare ascendenti storici che affondano le proprie radic<strong>in</strong>egli <strong>in</strong>izi della <strong>psicologia</strong> sperimentale come discipl<strong>in</strong>a che sistava distaccando dall’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e filosofica. Tuttavia, nonostante il dibattito<strong>in</strong> proposito rimanga ancora aperto, è parso possibile registrarnealmeno tre elementi dist<strong>in</strong>tivi di particolare <strong>in</strong>teresse per lapresente <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e, ovvero il suo caratterizzarsi1) per la peculiarità del suo oggetto di studio, che è costituito di fenomenipercettivi anziché di costrutti ipotetici, 2) per la coniugazione del metodo dianalisi fenomenologica con il metodo sperimentale, e 3) per la propria autonomiarispetto alle scienze naturali, dovuta al fatto che lo statuto di realtàdei fenomeni percettivi è diverso dallo statuto di realtà dei fenomeni fisiconeurali(MASIN, “Presentazione”, <strong>in</strong> MASIN, a cura di, 2002, p. 11).Di questi, il punto cruciale è per noi senz’altro il terzo, giacché riguardaprecisamente il problema dello statuto ontologico dei percetti,che la fenomenologia sperimentale si propone di <strong>in</strong>dagare juxta propriapr<strong>in</strong>cipia. In tale prospettiva, la fenomenologia sperimentale potrebbeanche venire presentata dicendo che essa, ponendosi il problemadel “perché le cose ci appaiono come ci appaiono” e ricercandole leggi di tale apparire sul piano dei soli “oggetti fenomenici” 57 ,può poi passare a chiedersi (metafisicamente) che cosa siano tali oggettie qu<strong>in</strong>di (ontologicamente) quale sia il loro statuto di realtà, ovveroil loro modo di esistenza. E tale complesso problematico si rive-57 Risulta qui s<strong>in</strong>tomatica l’osservazione di Koffka, secondo cui la domanda “perché lecose ci appaiono come ci appaiono?” ha due aspetti: “Presa letteralmente, si riferisce acome le cose appaiono, del tutto <strong>in</strong>dipendentemente dalla veridicità del loro apparire[…] <strong>in</strong> questo primo senso, il problema si applicherebbe anche a un mondo di pura illusione.Ma <strong>in</strong> realtà il nostro mondo non è certo illusorio; di regola, le cose appaionocome sono” (KOFFKA 1935: 76) – dove tale secondo aspetto della questione apre naturalmenteil problema metafisico del realismo. Per un <strong>in</strong>quadramento generale diquest’ultimo, cfr. MARSONET (2000).59
la <strong>in</strong>teramente già d<strong>in</strong>anzi al caso delle cosiddette illusioni percettive.Ad esempio, anche d<strong>in</strong>anzi alla semplice e notissima immag<strong>in</strong>e di Jastrow,dove l’“oggetto fenomenico” A appare di dimensioni m<strong>in</strong>oririspetto all’“oggetto fenomenico” B nonostante siano metricamenteidentici, le domande più radicali che si potrà porre un fenomenologosperimentale, dopo avere <strong>in</strong>dividuato le leggi che fanno sì che A appaiapiù piccolo di B, riguarderanno appunto lo statuto di realtà o ilmodo di esistenza di tali oggetti, considerando, ad esempio, il problemadella loro relazione con i corrispondenti oggetti fisici <strong>in</strong>tesicome causa del loro essere percepiti.Fig. 4Sotto questo profilo, Bozzi, <strong>in</strong> un passaggio argomentativo particolarmenteeloquente, oppone l’ontologia propria della fenomenologiasperimentale al “realismo dualistico acritico” di matrice cartesianache starebbe alla base di diversi paradigmi psicologici (ad esempio,quello che considera la percezione come un evento psichico causatoda oggetti ed eventi fisici) <strong>in</strong> quanto espressione, <strong>in</strong>vece, di un “realismomonistico e critico” (BOZZI 1989: 209) disposto a identificare ilpiano fenomenico con il piano della realtà e degli esistenti tout court. Sitratta, certo, di formule molto secche, ma da questa term<strong>in</strong>ologia e-merge già chiaramente il livello su cui si colloca la sua proposta. Bozzi,cioè, <strong>in</strong>tende esplicitare un presupposto che è “ovvio” per loscienziato naturale come per l’<strong>in</strong>dividuo <strong>in</strong>genuo 58 , quello del reali-58 Si veda il prosieguo del passo di Koffka precedentemente citato: “il nostro mondonon è certo illusorio; di regola, le cose appaiono come sono, ossia, detto <strong>in</strong> altra maniera,il modo <strong>in</strong> cui appaiono ci dice quali azioni possiamo compiere con esse” (ibidem).60
smo relativo agli enti osservabili, per poi specificarlo secondo due diverseopposizioni: critico vs acritico (ed è un’evidente proposta metodologicache <strong>in</strong>vita ad abbandonare il piano delle prospettive <strong>in</strong>genue);monismo vs dualismo (e qui la proposta si configura propriamentecome metafisica, e non riguardante più la prospettiva <strong>in</strong>genua).E con ciò pare esprimere la fiducia che dalla critica (metodologica)del dualismo debba emergere, senza altre argomentazioni, una giustificazionedel monismo come migliore posizione realistica – ossia comeposizione metafisica e, più specificamente, ontologica che dovrebbequasi togliere e conservare sul piano scientifico la prospettivadell’<strong>in</strong>dividuo <strong>in</strong>genuo.In effetti, i migliori tentativi di def<strong>in</strong>izione della fenomenologiasperimentale reperibili <strong>in</strong> Bozzi (compresi quelli più <strong>in</strong>formali: “Diomi ha costretto a stare da questa parte, tra i fenomeni; il resto dunqueme lo devo immag<strong>in</strong>are”, BOZZI 1999: 5) paiono sostenere un realismosorretto soltanto dalla critica metodica al dualismo “metafisico”.Ciò lo si legge bene <strong>in</strong> un saggio che da questo punto di vista può assumereun valore canonico, Il metodo fenomenologico nello studio della percezione(<strong>in</strong> BOZZI 1989: 11-81). Il suo movente di fondo è, appunto,metodologico e critico, rimarcando <strong>in</strong>nanzitutto la dist<strong>in</strong>zione tra o-perazioni da svolgersi escludendo “fenomenologicamente” ciò chesappiamo del describendum-explanandum e operazioni esplicative svoltefacendo <strong>in</strong>vece uso di nozioni causali di carattere fisicista, seguendocioè assunti come quelli tipici dello “schema psicofisico” dualistico 59 .Tale separazione risulta decisiva proprio allo scopo della dist<strong>in</strong>zione edel collegamento fra i piani descrittivo ed esplicativo, e dunque – <strong>in</strong>ultima analisi – <strong>in</strong> funzione di una corretta spiegazione dei fenomeni(cfr. ID. 1989: 23-24). Quest’ultima, allora, non potrà essere se nonun reperimento di leggi <strong>in</strong>tese come funzioni monoplanari, che leganocioè condizioni fenomeniche a effetti fenomenici (cfr. ibidem, 27),senza dover co<strong>in</strong>volgere come causalmente determ<strong>in</strong>ante un pianodegli eventi e degli oggetti “transfenomenici” (ibidem, 56).È proprio a questa altezza che sembra possibile istruire un confrontocon <strong>Wolff</strong> psicologo metafisico. Per favorirlo basterà appro-59 Distesamente analizzato e criticato nel saggio Analisi logica dello schema psicofisico (S-D)(<strong>in</strong> ID. 1989: 297-330).61
fondire la questione del rapporto fra le sue <strong>in</strong>dicazioni metodologichenegative (quelle che cioè importano una dist<strong>in</strong>zione fra <strong>psicologia</strong>empirica e <strong>psicologia</strong> razionale) e la loro applicazione, che <strong>in</strong>izia conl’impostazione del problema dello statuto metafisico delle “sensazioni”e f<strong>in</strong>isce per focalizzarsi <strong>in</strong>teramente sul problema psicofisico 60 .La prima <strong>psicologia</strong> razionale di <strong>Wolff</strong>, <strong>in</strong>fatti, dopo averne nuovamenteenunciate le ragioni metodiche 61 , <strong>in</strong>izia variando il solito argomentopreontologico.La prima cosa che abbiamo notato di noi era che siamo coscienti di noi e dialtre cose fuori di noi (cfr. DM § 1), cioè che sappiamo di rappresentarciattualmente molte cose come esterne a noi (cfr. DM § 194). Ad es. so cheadesso vedo lo specchio e la mia figura nello specchio. So che ora tengo <strong>in</strong>mano lo specchio e ora lo ripongo. So che ora afferro il fazzoletto, <strong>in</strong>vecedello specchio, e tolgo la macchia che scorgo sul mio volto [riflesso] nellospecchio (DM § 728).Quello della visione allo specchio, assunto da <strong>Wolff</strong> come caso e-semplare dell’ord<strong>in</strong>e dei fenomeni che si impegna a risolvere, cioè aridurre a ragioni di ord<strong>in</strong>e psicologico, non pare un esempio <strong>in</strong>nocuo:basti ricordare quanto lontana sia l’orig<strong>in</strong>e del discorso platonico chelo vuole emblema degli <strong>in</strong>ganni naturalmente tesi dai sensi alla ragione62 . Ma nelle mani di <strong>Wolff</strong>, a differenza che <strong>in</strong> quelle di Platone, lospecchio non risulta per nulla un oggetto metafisicamente m<strong>in</strong>accio-60 Che andrebbe allora meglio considerato come una famiglia di problemi, per quantostrettamente <strong>in</strong>terconnessi. HAMLYN (1961) ne offre una classica ricognizione dal puntodi vista storiografico, riferita al sottoproblema costituito dal rapporto tra “sensazione” e“percezione”.61 “In verità ho trattato ampiamente già sopra dell’anima, ma solo <strong>in</strong> quanto possiamopercepirne le attività (Würkungen) e conseguirne un concetto dist<strong>in</strong>to (cfr. DM § 191).Ora dobbiamo <strong>in</strong>dagare <strong>in</strong> che cosa consista l’essenza dell’anima e di uno spirito <strong>in</strong> generale,e quali siano <strong>in</strong> essa le ragioni di ciò che ne percepiamo e che sopra abbiamo registrato”(DM § 727).62 Ci si riferisce qui alla dottr<strong>in</strong>a di Platone, che <strong>in</strong> Resp. VI disegna il celebre rapportogeometrico di analogia e differenza tra la percezione di mere immag<strong>in</strong>i e la credenzarelativa agli oggetti come ricalcante l’ambiguo nesso di somiglianza che <strong>in</strong>tercorre fra leimmag<strong>in</strong>i e la realtà (cfr. 509d-510a) – rapporto reduplicato (al modo <strong>in</strong> cui “saprebbe”farlo già uno specchio) dalla mimesis <strong>in</strong> quanto (pseudo)tecnica propria del falso artefice(cfr. Resp. X, 596c-e).62
so. Come circostanza più che normale, l’usare uno specchio comestrumento che ci rivela il darsi <strong>in</strong> natura di immag<strong>in</strong>i 63 che siamo capacidi discrim<strong>in</strong>are manifesta, anzi, il primo spunto su cui andrà costruitala <strong>psicologia</strong> razionale, ossia il criterio fondamentale secondocui “siamo coscienti delle cose (wir s<strong>in</strong>d uns der D<strong>in</strong>ge bewust) quando ledist<strong>in</strong>guiamo l’una dall’altra” (DM § 729). Da questo asserto, <strong>in</strong>fatti,prende avvio l’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e metafisica wolffiana sulla nostra dotazionepsicologica di facoltà “estetiche”, a com<strong>in</strong>ciare da quella del provaresensazioni (“Empf<strong>in</strong>dungen”, DM § 749) 64 . Perciò, al di là di ogni altrasuggestione, sarà <strong>in</strong>teressante vedere come risulti impostato <strong>in</strong><strong>Wolff</strong> il problema costituito dalle cosiddette illusioni percettive – e <strong>in</strong>particolare se queste, come è per Platone (cfr. Resp. X, 602c-d), march<strong>in</strong>o,o meno, un luogo <strong>in</strong> cui si dà uno stacco <strong>in</strong>valicabile tra (pseudo)conoscenzadi mere parvenze e conoscenza genu<strong>in</strong>a che <strong>in</strong>izia adel<strong>in</strong>earsi come credenza vera o falsa.Il concetto generale di illusione (e non <strong>in</strong>nanzitutto di quella percettiva),<strong>in</strong> primo luogo, viene def<strong>in</strong>ito da <strong>Wolff</strong> nei term<strong>in</strong>i di unpossibile difetto del sapere doxastico, ossia del caso del credere (erroneamente)di sapere con giustificata certezza. Ogni illusione sarebbecioè un caso di certezza realmente <strong>in</strong>fondata (e non valutata cometale da parte del soggetto della credenza), situato nel mezzo tra i dueestremi della credenza realmente fondata e certa, ossia il sapere di saperee il sapere di non sapere.63 In sede di teologia, <strong>Wolff</strong> affermerà poi che tutte le creature sono specchi delle perfezionidiv<strong>in</strong>e (DM § 1046).64 La prestazione psicologica m<strong>in</strong>ima per <strong>Wolff</strong> si dà appunto quando ad es. “non soltantodist<strong>in</strong>guo l’una dall’altra le diverse parti che scorgo (wahrnehmen) <strong>in</strong> esso [sc. nellospecchio], ma anche mi rappresento (vorstellen) la differenza stessa tra lo specchio e lealtre cose che o vedo <strong>in</strong>sieme con esso oppure ho visto poco prima” (DM § 729). Dalriconoscimento di tale prestazione <strong>Wolff</strong> ricava qu<strong>in</strong>di la posizione di una fondamentaledifferenza tra corpo materiale e cosa pensante (DM §§ 738 ss.), per giungere così a unadef<strong>in</strong>izione metafisica dell’anima (come ente semplice dotato di forza rappresentativa,DM § 742) e prendere qu<strong>in</strong>di <strong>in</strong> esame le sue facoltà di sentire, immag<strong>in</strong>are ecc. La propostadi basare una “scientia sensitive cognoscendi” denom<strong>in</strong>ata “estetica” sulla <strong>psicologia</strong>della facoltà conoscitive sensitive ovvero “<strong>in</strong>feriori” sarà avanzata <strong>in</strong> sede di metafisicada Baumgarten, su cui cfr. <strong>in</strong>fra, pp. 84 ss. Sulla fortuna di tale proposta f<strong>in</strong>o aBolzano, Eduard von Hartmann e oltre cfr., di recente, WITTE (2000).63
Se di un giudizio non conosciamo la possibilità né mediante l’esperienza némediante la ragione, esso è per noi <strong>in</strong>certo. Qu<strong>in</strong>di l’<strong>in</strong>certezza altro non è senon la conoscenza della mancanza di una rappresentazione della possibilitào della realtà del nostro giudizio. Dico, prudentemente: una conoscenzadella mancanza. Infatti, a volte ci manca la rappresentazione della possibilitàdel nostro giudizio, o essa non mostra ciò che deve mostrare, e tuttavia noipensiamo di essere certi della nostra op<strong>in</strong>ione (DM § 392).Questa op<strong>in</strong>ione <strong>in</strong>fondata <strong>in</strong>torno alla certezza della nostra conoscenza èdetta illusione […] (DM § 393 ).So bene che alcuni considerano identiche l’illusione e l’op<strong>in</strong>ione, ma chi vipresta attenzione noterà bene la differenza. Infatti, chi ha un’op<strong>in</strong>ione riconosceche gli manca ancora <strong>qualcosa</strong> per avere una certezza piena, mentrechi subisce un’illusione non lo riconosce. E dunque è ben vero che ogni illusioneè un’op<strong>in</strong>ione, ma non è vero che ogni op<strong>in</strong>ione sia un’illusione(DM § 394).Così, il tema più specifico dell’illusione percettiva risulterà semplificatoda <strong>Wolff</strong>, <strong>in</strong> maniera caratteristica, nei term<strong>in</strong>i di un errorenecessario (di cui si può avere cognizione, o meno) date le circostanzedel costituirsi di una credenza di tipo percettivo. Sicché l’unicopasso dedicato all’argomento <strong>in</strong> tutta la Metafisica tedesca sta <strong>in</strong> unsolo paragrafo.Tanto l’esperienza quanto la ragione mostrano che negli organi di sensopuò verificarsi una medesima modificazione pur <strong>in</strong> due casi dist<strong>in</strong>ti. Perciòl’anima deve necessariamente rappresentare due cose diverse <strong>in</strong> due casi diversicome se fossero una sola. Ad es., nell’occhio si dip<strong>in</strong>gono tutte le cosefisiche, e cioè vi sono <strong>in</strong>trodotte dai raggi lum<strong>in</strong>osi, e poiché questa è lamodificazione che si verifica <strong>in</strong> esso quando vediamo, allora l’anima, quandovede, non può rappresentarsi queste cose se non <strong>in</strong> conformità a questafigura (Bild) (cfr. DM § 753). Se, ora, un corpo di grandi dimensioni, comeun bue, è molto distante, e uno piccolo, come un vitello, è vic<strong>in</strong>o, nell’occhiosi dip<strong>in</strong>ge una medesima figura, per cui l’anima nei due casi non puòformarsi se non una medesima rappresentazione. E questa è la ragione percui un bue distante appare come un vitello. Certo, è vero che <strong>in</strong> questo modol’anima talvolta si rappresenta erroneamente le cose del mondo, però leregole su cui si basa l’ord<strong>in</strong>e naturale (cfr. DM § 718) non permettono cheaccada diversamente (DM § 793).64
Ma qui – prima di dare seguito all’avvertenza wolffiana secondocui l’<strong>in</strong>tera serie dei paragrafi <strong>in</strong> cui è collocato il 793 r<strong>in</strong>via strettamentealla soluzione del problema psicofisico (DM2 ad §§ 792 ss.) –va considerata più da vic<strong>in</strong>o l’ultima frase. Essa, <strong>in</strong>fatti, implica dueimportanti assunzioni di fondo: 1) se non sapessimo per altra via comestanno le cose nel mondo, non potremmo nemmeno renderciconto del darsi di un’illusione percettiva. Un’illusione puramente percettiva,qu<strong>in</strong>di, non si dà: si possono dare, semmai, casi di certezzam<strong>in</strong>ore o maggiore, e più o meno giustificata, nel giudizio sulla congruenzatra una cognizione sensitiva e un’altra cognizione – anch’essasensitiva, o d’altro tipo. Inoltre 2) l’illusione percettiva si dà necessariamente,poiché vi è un unico piano di legalità sufficienti a rendereragione di ciò che avviene <strong>in</strong> entrambi i dom<strong>in</strong>i metafisici implicati <strong>in</strong>questo problema, cioè quello fisico e quello psicologico. In breve,l’illusione comporta un errore nel giudizio (di secondo grado) circaun’op<strong>in</strong>ione relativa a uno stato di cose – <strong>in</strong>dipendentemente dallaverità o falsità di quest’ultima, ciò che giustifica l’affermazione concui si conclude l’ultimo paragrafo della Metafisica tedesca citato.E dunque è ben vero che ogni illusione è un’op<strong>in</strong>ione, ma non è vero cheogni op<strong>in</strong>ione sia un’illusione. Sicuramente riconoscere che ci manca <strong>qualcosa</strong>per avere una certezza completa è diverso dall’immag<strong>in</strong>are che non cimanca nulla per averla, per quanto <strong>in</strong> effetti spesso manchi ancora moltissimo(DM § 394).In <strong>Wolff</strong>, dunque, così come nel paradigma scientifico che sta allabase della fenomenologia sperimentale, nel caso della cosiddetta illusionepercettiva sembra venire meno la possibilità di applicare la nozione<strong>in</strong>genua di illusione che, detto <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i <strong>in</strong>formali, designa normalmentel’erroneità, o, più <strong>in</strong> generale, la virtuale erroneità (e dunqueil bisogno di emendazione) di una credenza o di un <strong>in</strong>tero tipo di credenze– em<strong>in</strong>entemente, di quelle percettive. Da questo punto di vista,è allora possibile tentare una classificazione delle illusioni utile ai presentiscopi, esemplificata <strong>in</strong>nanzitutto nella tavola seguente.65
Figg. 5-7 – Nell’ord<strong>in</strong>e: José M. Parramón, illustrazione per Así se dibuja, (Madrid1971); Paolo Uccello, Scomposizione geometrica di un calice, penna su reticolo tracciato astilo su carta bianca (1465); illusione di Müller-Lyer.Qui va <strong>in</strong>nanzitutto esplicitato l’elemento comune a tutti e tre i tipidi illusione esemplificati, vale a dire il fatto che è possibile parlare66
di illusione solo quando si dà una qualche discrepanza fra due credenze– discrepanza, poi, variamente verificabile e riducibile a un livelloulteriore, ma che segnala comunque la collocazione sul pianoapofantico (e permette qu<strong>in</strong>di la confrontabilità) di entrambe. Diciamo,cioè, che il cucchiaio immerso nell’acqua appare spezzato al nostroocchio, poiché possiamo s<strong>in</strong>cerarci che <strong>in</strong> effetti non lo è, privilegiandonela cognizione ottenuta mediante un’altra modalità sensoriale(qui, ad esempio, tattile); “vediamo” un calice dotato di tali e talicaratteristiche, che tuttavia sappiamo non esserci realmente; diciamoche le due l<strong>in</strong>ee parallele verticali sembrano di lunghezza differente,mentre siamo <strong>in</strong> grado di misurarle e trovare che sono della medesimadimensione.Tentiamo ora di evidenziare le differenze fra i tre casi. Nella primaillustrazione abbiamo a che fare con un’illusione che potremmo chiamareecologica. Si tratta cioè di uno dei normali “<strong>in</strong>ganni dei sensi”che possiamo <strong>in</strong>contrare nella vita di tutti i giorni, deprecati da Platone:è genu<strong>in</strong>amente percettiva, persistente, <strong>in</strong> qualche misura rettificabilesul piano di credenze (percettive o meno) ulteriormente sviluppate65 .Nel secondo caso, che rispetto al primo si potrebbe qualificarecome illusione artificiale (<strong>in</strong> questo esempio, pittorica), se l’illusioneconsiste nel vedere un calice che non esiste “realmente”, tale illusioneè complessivamente rettificabile – ma non sempre e necessariamentefalliranno dei test di verifica riguardanti s<strong>in</strong>gole proprietà dell’oggettoraffigurato. Le s<strong>in</strong>gole qualità (almeno alcune, e <strong>in</strong> l<strong>in</strong>ea di pr<strong>in</strong>cipioun loro numero a piacere) di un “oggetto virtuale” (GIBSON 1979:423), anche quando sappiamo benissimo che ci si sta riferendo a unoggetto transfenomenico, possono venire trattate conoscitivamentecome qualità genu<strong>in</strong>e. Quanto ad esse, si può allora suggerire che letecniche di raffigurazione, oltre a produrre manufatti che bastano asignificare altri oggetti a scopi comunicativi, secondo dei criteri di65 E questo, si noti, senza bisogno di particolari razioc<strong>in</strong>i: se tocco il cucchiaio, sento chenon è spezzato, come <strong>in</strong>vece appare alla vista. Oltre a tutto ciò, andrebbe poi osservataun’altra sua caratteristica evidenziata dall’illustrazione: è raffigurabile.67
m<strong>in</strong>ima <strong>in</strong>formazione sufficiente a tali scopi 66 , possono anche andareal di là della semplice soddisfazione di quei criteri.Il terzo caso, <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e, lo si vorrebbe chiamare di illusione artificialepura, vale a dire ricavata dai casi di illusione ecologica (ad esempio,avvalendosi di metodi di “spoil<strong>in</strong>g”) a scopi sperimentali, cercando diconservare i soli <strong>in</strong>varianti che determ<strong>in</strong>ano la resa percettiva “illusoria”da esam<strong>in</strong>are e analizzare. Quest’ultimo tipo di illusione, dunque,artificiale quanto il secondo, se ne differenzia non tanto rispetto allecaratteristiche essenziali di illusorietà, quanto per la sua diversa possibileutilizzazione, giacché non co<strong>in</strong>volge, analogamente al primo tipodi illusione, fattori teoreticamente problematici come la “illusionedi realtà”, né alcun “sentimento di somiglianza” 67 . Soprattutto, se la si<strong>in</strong>tende trattare (come sembra opportuno) secondo la metodologiadella fenomenologia sperimentale, troviamo che è improprio e fuorvianteparlare di “illusione” – fuorviante, proprio perché <strong>in</strong> tal modosi alluderebbe allo sdoppiamento del piano apofantico (sul quale è legittimoparlare di non corrispondenza fra ciò che vediamo e ciò chesappiamo) <strong>in</strong> un piano dell’apparenza e <strong>in</strong> un piano della realtà, a-prendo uno spazio tanto largo da dare strada a (quasi) ogni arbitrioontologico.Innanzitutto, allora, ritornando sulla differenza tra illusione ecologicae illusione pittorica, si può dire che: 1) <strong>in</strong> ambo i casi, ci si trovad<strong>in</strong>anzi a un conflitto (riducibile, almeno <strong>in</strong> l<strong>in</strong>ea di pr<strong>in</strong>cipio) fra duediversi tipi di credenza – nei nostri esempi, tra ciò che percepiamodel cucchiaio con due diverse modalità sensoriali, ovvero tra ciò chepercepiamo del calice virtuale (ciò che crediamo di vedere) e il nostro66 A questo proposito, Massironi, nella scia di Gibson, segnala conclusivamente una divergenzatra i concetti di <strong>in</strong>formazione (<strong>in</strong>tesa <strong>in</strong> senso “ecologico”) e comunicazione,da ascriversi ai tre limiti fondamentali della figura – “a) veicola ‘<strong>in</strong>formazione di secondamano’, b) è una percezione ‘impoverita’, c) è costituita da un ‘assetto ottico congelato’” –rispetto al processo normale di “<strong>in</strong>formation pick-up” (MASSIRONI 2000: 160-162). Daquesto punto di vista, “La scelta [sic; forse meglio: ‘differenza’, se per ‘scelta’ si vuole<strong>in</strong>tendere una ‘selezione’] fra <strong>in</strong>formazione <strong>in</strong>clusa nell’immag<strong>in</strong>e ed <strong>in</strong>formazione e-sclusa costituisce l’oggetto e il contenuto della comunicazione per immag<strong>in</strong>i” (ibidem,164).67 Anzi: tanto meglio saranno costruite le situazioni sperimentali che si servono di figuredi questo tipo, tanto meno sarà possibile <strong>in</strong>vocare simili fattori per spiegarle (cfr. BOZZI1989: 45-52).68
sapere della sua (non) esistenza. 2) Nel secondo caso, però, tale situazioneè provocata <strong>in</strong> maniera artificiale, ma soprattutto con la possibilità(almeno teorica) di rendere disponibile all’osservatore una quantitàelevata a piacere di <strong>in</strong>formazioni genu<strong>in</strong>amente percettive relativeall’“oggetto virtuale” significato da una sua raffigurazione. Se ciò èvero, quella del sentimento (illusorio) di somiglianza (trattabile neiterm<strong>in</strong>i dell’errore necessario wolffiano) sarà una questione effettiva,quantitativa ed empirica. Il realizzarsi di tale sentimento illusorio dipenderàdalla quantità di <strong>in</strong>formazioni percettive disponibili circa s<strong>in</strong>goliaspetti dell’oggetto complessivamente significato – <strong>in</strong>formazion<strong>in</strong>on smentite o addirittura non rettificabili <strong>in</strong> l<strong>in</strong>ea di pr<strong>in</strong>cipio permezzo di “test di realtà” (GIBSON 1979: 420) eseguiti sul piano fenomenico.In questa sede, tutto ciò deve rimanere un suggerimento, e tantomenosarà il caso di avanzare illazioni relative al versante empirico esperimentale a cui sembra potersi ridurre il problema che <strong>in</strong>teressava.A ogni modo, da questa sommaria classificazione delle illusioni – sviluppataalla luce delle analogie tra la <strong>psicologia</strong> wolffiana e la fenomenologiasperimentale – è possibile <strong>in</strong>tendere perché il realista<strong>Wolff</strong> non sia affatto imbarazzato dalla strana plausibilità di quel particolaremodello monistico che è l’idealismo 68 , configurabile come l’illusionetotale del solipsismo. La questione viene impostata da <strong>Wolff</strong>così: una volta ammesse delle relazioni di concomitanza regolare tra(classi di) eventi psichici e (classi di) eventi fisici, è possibile <strong>in</strong>dagaretali regolarità effettivamente osservabili, senza impegnarsi circal’esistenza di un mondo esterno? Per <strong>Wolff</strong>, ciò va ammesso.Poiché […] il corpo non contribuisce affatto al darsi di sensazioni nell’anima,queste avrebbero ugualmente luogo tutte quante anche se il mondonon esistesse affatto, ciò che riconoscono anche Cartesio e, ben prima di lui,68 L’ipotesi materialistica (che f<strong>in</strong>isce quasi per prefigurare l’odierno argomento “dellozombie”, su cui cfr. almeno KIRK, ad voc. “Zombies”, <strong>in</strong> SEPh) presenta <strong>in</strong>vece, per<strong>Wolff</strong>, alla luce dell’argomento preontologico, un difetto: “Da ciò risulta chiaro che tuttii movimenti che avvengono nel corpo si manifesterebbero nello stesso modo <strong>in</strong> cui simanifestano adesso, anche se non esistesse alcuna anima […]; soltanto, non saremmocoscienti di ciò che avviene nel nostro corpo (cfr. DM §§ 738 ss.)” (DM § 780). Il che,secondo <strong>Wolff</strong>, viene smentito dall’esperienza.69
gli idealisti, i quali non hanno ammesso nient’altro che le anime e gli spiriti,e al mondo non hanno dato alcuno spazio se non nel pensiero. Anzi, da ciòche è stato dimostrato sopra risulta chiaro che vedremmo, udiremmo e percepiremmoogni cosa come esterna a noi, pur non esistendo oggetti esternia noi (DM § 777).Vale di nuovo, dunque, l’affermazione del tratto fondamentaledell’esperienza di ogni cosa, quello della sua esteriorità rispetto allacoscienza che la esperisce 69 . A questo punto, però, resta da mostrare<strong>in</strong> che modo <strong>Wolff</strong> tratti l’elemento cruciale dell’ipotesi, costituitodall’osservabilità di fenomeni (qui, le sensazioni) che esibiscono unord<strong>in</strong>e o, almeno, caratteristiche costanti <strong>in</strong> ogni mondo possibile,come è appunto il carattere di esteriorità dell’oggetto di esperienza –che tale rimarrebbe anche se valesse il modello idealistico, il quale a-vanza pretese di plausibilità una volta posto che “il corpo non contribuisceaffatto al darsi di sensazioni nell’anima”.69 Il carattere di esteriorità dell’oggetto di esperienza verrà presto sottol<strong>in</strong>eato come crucialenei sistemi dei wolffiani. Nell’“<strong>Ontologia</strong>” contenuta nelle Institutiones di Thümmig,ad es., tale suo carattere viene affermato e riportato al pr<strong>in</strong>cipio di contraddizione: “Ciòche noi pensiamo come differente da noi lo rappresentiamo come sussistente al di fuori d<strong>in</strong>oi. Gli oggetti che dist<strong>in</strong>guiamo gli uni dagli altri sono da noi rappresentati come esistentiseparatamente, <strong>in</strong> virtù del pr<strong>in</strong>cipio di contraddizione” (THÜMMIG 1729: § 49). Per Leibniz,<strong>in</strong>vece, il tratto dell’orig<strong>in</strong>aria esteriorità dell’oggetto di esperienza non compariva nellatrattazione del problema della realtà del cosiddetto “mondo esterno”, bastando a vanificaretale problema adeguate considerazioni epistemologiche relative alla consistenza <strong>in</strong>ternadei fenomeni esperiti (cfr. MUGNAI 2001: 77-80; per un <strong>in</strong>quadramento del problemadell’“esistenza del mondo esterno” sviluppatosi nell’epistemologia moderna econtemporanea cfr. BAUMANN 2002: 19-22). Vale dunque la pena di sottol<strong>in</strong>eare un’osservazionedi <strong>Wolff</strong> <strong>in</strong> proposito: “Che l’anima vedrebbe ogni cosa fuori di sé, anche senon esistesse un mondo, è una conseguenza dei sistemi cartesiano e leibniziano, che perònon si dà certamente nel [sistema] comune [sc. <strong>in</strong>flussionistico]. Perciò non è necessariocitarla <strong>in</strong> particolare come una fallacia: una volta confutati quei sistemi, anch’essa cade da sé.Tuttavia, nemmeno scorgo il m<strong>in</strong>imo pericolo che potrebbe conseguire da tale fallacia.Infatti, anche concedendola, non si concederebbe agli idealisti che il mondo non esiste veramente.È noto a tutti che a posse ad esse non valet consequentia; dal fatto che <strong>qualcosa</strong> possaessere non segue che si dia veramente” (DM2 ad § 777). Di qui anche per <strong>Wolff</strong> la vanità(come m<strong>in</strong>imo) delle dimostrazioni dell’esistenza del “mondo esterno”: “Troviamo cheCartesio nelle sue Meditazioni si è dato pena di dimostrare contro gli idealisti che i corpi esistonodavvero. E Malebranche ha avuto pers<strong>in</strong>o l’idea che non si potrebbe dimostrarlo, percui ha <strong>in</strong>dicato una sorta di rivelazione mediante cui Dio ce ne assicurerebbe” (ibidem).70
3. Monadi con f<strong>in</strong>estreCome si è visto, la <strong>psicologia</strong> razionale di <strong>Wolff</strong> <strong>in</strong>izia riprendendola medesima osservazione <strong>in</strong>iziale della <strong>psicologia</strong> empirica (fissata,ancor prima, nell’argomento preontologico), e cioè ribadendo il fatto<strong>in</strong>controvertibile che “siamo coscienti di noi e di altre cose fuori d<strong>in</strong>oi” (DM § 728). Così, la questione metafisica centrale nella <strong>psicologia</strong>di <strong>Wolff</strong> diventa ora quella di <strong>in</strong>dividuare l’essenza dell’anima nella“forza di rappresentarsi il mondo secondo lo stato del suo corponel mondo” (DM § 753). Su questa base, <strong>in</strong>fatti, <strong>Wolff</strong> è <strong>in</strong> grado digiustificare deduttivamente l’attribuzione di un’anima a ogni esseresenziente (DM §§ 788-789) 70 e di ripercorrere, qu<strong>in</strong>di, <strong>in</strong> sede di <strong>psicologia</strong>razionale l’analisi delle facoltà conoscitive già svolta <strong>in</strong> sede di<strong>psicologia</strong> empirica. Tale serie di facoltà, tuttavia, benché riscontrabilecon certezza e descrivibile non appena si dia a riconoscere il possessom<strong>in</strong>imale delle sole facoltà rappresentative di tipo estetico, nonè per <strong>Wolff</strong> spiegabile rimanendo su un piano puramente osservativoe richiede, <strong>in</strong> ultima analisi, di venire trattata <strong>in</strong> sede di <strong>psicologia</strong> razionale,considerando <strong>in</strong>nanzitutto che lo statuto delle sensazioni nonè affatto semplicemente fisico.Forse alcuni si meraviglieranno del fatto che io annoveri le sensazioni tra ipensieri dell’anima: crederanno <strong>in</strong>fatti che le sensazioni appartengano alcorpo. […] Ma da ciò che precede bisogna <strong>in</strong>tendere che <strong>in</strong> ogni sensazioneavviene tanto che il nostro corpo viene modificato, quanto che siamo coscientidelle cose che causano questa modificazione. […] Benché <strong>in</strong>fatti, ades., nel sonno il suono giunga alle orecchie, o l’odore salga al naso, e perciòle modificazioni si verifich<strong>in</strong>o nell’orecchio o nel naso altrettanto bene che70 L’argomento centrale si trova al § 788: “poiché il mondo si lascia rappresentare daforze f<strong>in</strong>ite <strong>in</strong> tanti modi diversi, quanti sono i corpi dotati di organi di senso che possonocomparire nel mondo (cfr. DM § 785), sono possibili anche altrettante anime”.Nell’annotazione al paragrafo successivo (DM2 ad § 789) si rileva come tale proposizione,il cui corollario afferma “che gli animali abbiano anime”, fosse rimasta pacificamenteaccettata dall’antichità f<strong>in</strong>o alla sua revoca <strong>in</strong> dubbio da parte di Cartesio, sulla basedell’ipotesi di un meccanicismo radicale – rispetto a cui <strong>Wolff</strong> sottol<strong>in</strong>ea giustamente ilcarattere di ipotesi, nonché il fatto che Cartesio considerava semplicemente verosimile(e non affatto dimostrato) che i bruti non possiedano anime. Sul carattere fondamentalmenteipotetico delle affermazioni cartesiane circa il modello dell’“animale-macch<strong>in</strong>a”cfr. SUTTER (1992).71
quando siamo desti, tuttavia non diciamo che udiamo o odoriamo, poichénon siamo coscienti di nulla di ciò […] (DM § 222).La novità nella trattazione del problema rispetto a un Aristotele(ma anche a un Cartesio, cui pure <strong>Wolff</strong> si riferisce, cfr. DM2 ad §222) sta tutta nella consapevolezza delle cautele che vanno qui rispettatenel richiamarsi a determ<strong>in</strong>ate evidenze a scopo esplicativo. A taleproposito, vanno allora considerate le avvertenze epistemologichecon cui <strong>Wolff</strong> chiude la <strong>psicologia</strong> empirica, relative alla prudenza nelragionare sul commercio fra corpo e anima. In base a queste, non èmai possibile richiamarsi all’esperienza per argomentare un rapportodi effettiva causazione tra eventi fisici ed eventi mentali, o viceversa –ciò che <strong>in</strong>teressa <strong>in</strong> primo luogo il darsi della percezione della “cosa”,decl<strong>in</strong>ando nei term<strong>in</strong>i del problema psicofisico postcartesiano il piùclassico problema del rapporto fra sensazione e percezione. Al più,dunque, ciò che è possibile constatare e descrivere non sono dei rapporticausali, ma delle regolarità nel darsi contemporaneo di eventi diord<strong>in</strong>e diverso.Se le cose esterne producono una modificazione negli organi dei nostri sensi,allora nella nostra anima sorgono contemporaneamente delle sensazioni,cioè siamo subito coscienti di cose che sono tali e tali (DM § 528).Occorre però fare molta attenzione a non <strong>in</strong>terpretare oltre il dovuto questaesperienza, per non recare offesa alla verità (cfr. DM § 527). Non esperiamonient’altro che la simultaneità di due cose, ossia di una modificazioneche si verifica negli organi di senso e di un pensiero mediante cui l’anima ècosciente delle cose esterne che causano la modificazione. Ma <strong>in</strong> nessunmodo esperiamo un’azione del corpo sull’anima 71 (DM § 529).È palese come qui <strong>Wolff</strong> tocchi, ma non più su un piano semplicementedescrittivo, lo stesso tema dell’argomento preontologico. Il71 Lo stesso vale, ovviamente, anche per il nesso esperito tra un atto di volizione e unmovimento volontario: “Per converso, notiamo pure che certe modificazioni nel corpoavvengono quando l’anima desidera compiere tali movimenti” (DM § 535); “Se anche<strong>in</strong> questo caso non vogliamo andare oltre a ciò che esperiamo, possiamo soltanto direche certi movimenti del corpo avvengono nel momento <strong>in</strong> cui lo vogliamo, oppure chenon avvengono quando non lo vogliamo” (DM § 536).72
problema è però ora proprio quello del passaggio, ancora <strong>in</strong>terno allametafisica, a un piano esplicativo transfenomenico (ovvero ipotetico,che secondo <strong>Wolff</strong> è proprio di ogni “sistema razionale”; cfr. FEUER-HAHN 2002: 55) – su cui si pone una nuova questione di impegno ontologico.Andando alla soluzione wolffiana, troviamo allora che leprescrizioni negative che delimitano rigorosamente la sfera dell’osservabileconsigliano di rigettare la teoria <strong>in</strong>flussionistica così come quellaoccasionalistica, mentre non vietano l’accettazione della teoria (ugualmentedualistica) dell’armonia prestabilita – senza che questo importil’<strong>in</strong>troduzione di leggi causali ad hoc 72 .In ogni caso, il terreno squisitamente empirico su cui è possibileosservare una corrispondenza secondo leggi fra eventi (esperiti come)psicologici ed eventi (esperiti come) fisici rimane quello più solido, oalmeno l’unico rispetto a cui l’impegno ontologico non va <strong>in</strong>debolito.In proposito le parole di <strong>Wolff</strong> sono chiarissime: “quando si domandaperché una sensazione succeda all’altra, non è possibile <strong>in</strong>dicarenessun’altra ragione se non questa: perché nel mondo subentra un72 Tali leggi andrebbero <strong>in</strong>trodotte di necessità per ovviare, <strong>in</strong>nanzitutto, a un difettodell’<strong>in</strong>flussionismo, cioè la sua <strong>in</strong>capacità di spiegare la relativa autonomia dell’attivitàrappresentativa dell’anima rispetto agli stati effettivi del corpo cui è legata: “Se, <strong>in</strong>fatti,uno sceglie il systema <strong>in</strong>fluxus physici, ossia ammette che corpo e anima agiscono naturalmentel’uno sull’altra <strong>in</strong> modo che la forza dell’anima produce <strong>qualcosa</strong> nel corpo e laforza del corpo produce <strong>qualcosa</strong> nell’anima, allora bisogna concedere che il corpo possadeterm<strong>in</strong>are la forza dell’anima a produrre proprio quella sensazione che essa produce:è certo, <strong>in</strong>fatti, che la forza che l’anima ha di rappresentare il mondo si riferisce a piùcose di quante divengono reali mediante essa” (DM2 ad § 753). L’esempio subito addottoda <strong>Wolff</strong> (forse nell’ansia di mostrare che il problema riguarda sia la direzione delpreteso <strong>in</strong>flusso causale che andrebbe dal fisico allo psichico, em<strong>in</strong>entemente nel casodella percezione sensibile, sia quella che andrebbe dallo psichico al fisico, em<strong>in</strong>entementenel caso della locomozione volontaria) non è però dei più l<strong>in</strong>eari: “Ad es., non è impossibileche ora io parta per recarmi <strong>in</strong> un luogo qui vic<strong>in</strong>o; se ciò accadesse, vedreicose del tutto differenti da quelle che vedo ora, mentre siedo nel mio studio, e ancheriguardo a tutto il resto avrei sensazioni del tutto differenti da ora. Dunque, l’anima puòprodurre con la propria forza sia idee o rappresentazioni diverse [dalle attuali], sia quelleche produce attualmente” (ibidem). In ogni caso, l’esempio salva l’osservazione (qualitativae, almeno grezzamente, quantitativa) ricavata <strong>in</strong> sede di <strong>psicologia</strong> empirica circa ilpotere limitato che possiamo esercitare sulle nostre sensazioni, che appare proporzionalealla “misura <strong>in</strong> cui sta <strong>in</strong> nostro potere di mutare questo stato [sc. del nostro corpo] ealla misura <strong>in</strong> cui possiamo impedire le modificazioni degli organi dei nostri sensi […](cfr. DM § 225). Ma una volta che ci troviamo <strong>in</strong> un luogo dobbiamo guardare con occhiaperti ciò che sta d<strong>in</strong>anzi a noi, vedere come è fatto, e qui non possiamo cambiarenulla a nostro piacimento” (DM § 227).73
diverso stato delle cose fisiche che percepiamo” (DM § 786) 73 . Muovendoperò un ulteriore passo, sempre all’<strong>in</strong>terno della metafisica, dalpiano osservativo a quello esplicativo non sarà legittimo assumere unrapporto di causazione tra evento fisico ed evento mentale, ovvero(esemplarmente) percettivo (come viene illustrato nel modello 1 dellatavola che segue). Sarà, <strong>in</strong>vece, legittimo assumere il darsi di concatenazionicausali, <strong>in</strong> l<strong>in</strong>ea di pr<strong>in</strong>cipio <strong>in</strong>dipendenti, entro ognuna delledue sfere, fisica e mentale, ammettendo <strong>in</strong>oltre delle relazioni di concomitanzaregolare (del tipo condizione-condizionato) tra gli eventiche rientrano rispettivamente <strong>in</strong> esse – cioè eventi mentali come percezionie volizioni, da un lato, ed eventi fisiologici, dall’altro (comeviene illustrato nel modello 2).Fig. 8 – Legenda: 1) Modello dualistico <strong>in</strong>flussionistico della relazione meccanicocausaletra sostanza fisica e sostanza psichica. 2) Modello dualistico wolffiano dellarelazione regolare e osservabile (empirica) di condizionamento relativo fra coppie dimomenti collocati <strong>in</strong> serie genu<strong>in</strong>amente causali (a, b, c… n) ma dist<strong>in</strong>te, ovvero costituiteda stati di entità rispettivamente fisiche e psichiche.73 Perciò, tali regolarità saranno <strong>in</strong>dagabili sperimentalmente qualunque sia l’ipotesi metafisicaadottata: “Chi riflette su queste cose comprenderà subito che gli idealisti, i qual<strong>in</strong>egano la realtà del mondo esterno alla nostra anima, devono necessariamente spiegaregli eventi naturali allo stesso modo <strong>in</strong> cui li spiegano coloro che riconoscono la presenzadel mondo esterno all’anima. Infatti, entrambi <strong>in</strong>dicano la medesima ragione, quando<strong>in</strong>tendano correttamente la cosa (cfr. DM § 786). Qu<strong>in</strong>di, con la loro op<strong>in</strong>ione gli idealist<strong>in</strong>on recano alcun danno alle scienze naturali” (DM § 787).74
Che poi nella dottr<strong>in</strong>a dell’armonia prestabilita queste leggi di corrispondenzavengano accessoriamente garantite dall’esterno (o, meglio,spiegate anche da un punto di vista strettamente genetico) conun <strong>in</strong>iziale <strong>in</strong>tervento div<strong>in</strong>o è una questione ancora ulteriore e, <strong>in</strong>fondo, laterale 74 . Tale tipo di garanzia non vale, <strong>in</strong>fatti, a dirimere laquestione dello statuto del nesso regolare tra eventi fisici e psichici secorrettamente <strong>in</strong>teso, cioè <strong>in</strong> quanto rapporto logicamente descrivibilesolo nei term<strong>in</strong>i di un condizionale generico 75 .Con ciò, tuttavia, la questione non è ancora chiusa. E per <strong>in</strong>tenderloconverrà ritornare sul § 786 della Metafisica tedesca di cui si è appenacommentata l’asserzione centrale, considerandone il prosieguo.Occorre qui osservare <strong>in</strong> generale che, quando si domanda perché una sensazionesucceda all’altra, non è possibile <strong>in</strong>dicare nessun’altra ragione senon questa: perché nel mondo subentra un altro stato delle cose fisiche chepercepiamo. Infatti, le rappresentazioni dell’anima, poiché somigliano allecose fisiche del mondo (cfr. DM § 769), stanno con queste ultime nel medesimorapporto <strong>in</strong> cui un quadro o un’altra immag<strong>in</strong>e sta con la cosa cherappresenta (cfr. DM § 751). […] Qu<strong>in</strong>di, se si domanda perché questo oquell’elemento della nostra percezione sia fatto <strong>in</strong> un certo modo, ugualmentenon si può addurre nessun’altra ragione se non quella a cui ci si richiamad<strong>in</strong>anzi alla domanda del perché questo o quello accada nel mondo(DM § 786).74 Va notato che, dal punto di vista della funzione strettamente esplicativa, l’attuale ricorsoai fattori evolutivi nelle scienze cognitive risponde a un medesimo scopo, lasciandosempre aperta la questione dello statuto metafisico dell’explicandum, cioè della pretesacorrispondenza (veritiera, efficace…) fra rappresentazioni mentali e caratteristiche fisichedell’ambiente proprio di un organismo senziente.75 Rimane cioè vero che per <strong>Wolff</strong> i monisti (l’idealista come il materialista) troverebberole medesime leggi osservative ricavate dal dualista – al solo patto di non violare leregole proprie di ogni buona <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e empirica. <strong>Wolff</strong>, <strong>in</strong>somma, riconosce il carattereirriducibilmente ipotetico di ognuno dei sistemi metafisici presi <strong>in</strong> esame, perfettamentecompatibili con l’esercizio dell’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e empirica, perché epistemologicamente <strong>in</strong>commensurabilicon essa. Solo, si vorrebbe sottol<strong>in</strong>eare circa questo punto, il caso di <strong>Wolff</strong>sembra mettere <strong>in</strong> luce un generale problema (tipicamente “qu<strong>in</strong>eano”) di sottodeterm<strong>in</strong>azionedell’ontologia rispetto a qualsiasi metafisica empirica, ovvero costituita a posteriori.Se è così, risulta giustificata ogni cautela nel voler derivare posizioni ontologicheda considerazioni puramente metodiche – anche nel caso di un’esplicitazione dell’impegnoontologico coerente con la fenomenologia sperimentale quale è quella tentata,come si è visto poco sopra, da Bozzi.75
È notevole, qui, che <strong>Wolff</strong> si senta <strong>in</strong> dovere di ancorare subito lapropria soluzione del problema psicofisico a una concezione pittoricadella rappresentazione. Tale concezione, anzi, ha una funzione digrande rilievo nella <strong>psicologia</strong> razionale wolffiana e viene <strong>in</strong>trodottaimmediatamente con la def<strong>in</strong>izione delle sensazioni come “rappresentazioni(Vorstellungen) del composto nel semplice che si danno <strong>in</strong>occasione dei mutamenti degli organi esterni dei sensi” (DM § 749) edell’immag<strong>in</strong>azione (“E<strong>in</strong>bildung”) di oggetti fisici assenti (o perchési tratta di oggetti non più dati attualmente alla percezione, o perchési tratta di immag<strong>in</strong>i “composte” dall’anima stessa, cfr. DM § 750) 76 .La rappresentazione sensibile di oggetti fisici (sia presenti, come è nelcaso della sensazione, sia assenti, come è nel caso dell’immag<strong>in</strong>azione)rimane dunque <strong>in</strong> ogni modo per <strong>Wolff</strong> una rappresentazione dicorpi che colpiscono (o hanno colpito, o potrebbero colpire) gli organidei nostri sensi, “occasionando” la rappresentazione di un entecomposto <strong>in</strong> un ente semplice (ibidem). E qui viene <strong>in</strong>serito, quasi disoppiatto, il caso chiarificatore delle raffigurazioni “pittoriche” <strong>in</strong>senso stretto.Tanto le sensazioni (Empf<strong>in</strong>dungen) quanto le immag<strong>in</strong>i fantastiche (E<strong>in</strong>bildungen)hanno <strong>in</strong> comune questo con le raffigurazioni (Bilder), come sono ad es.quadri e statue: che sono rappresentazioni (Vorstellungen) di cose composte;e perciò anche le rappresentazioni delle cose fisiche sono chiamate figure(Bilder). Infatti una figura <strong>in</strong> generale è una rappresentazione di una cosacomposta. D’altro canto, le sensazioni e le immag<strong>in</strong>i fantastiche si differenzianodai quadri e dalle statue per il fatto che si realizzano (geschehen) nelsemplice, mentre questi ultimi si realizzano nel composto. Infatti una figuraprodotta dall’arte è una rappresentazione di un composto nel composto; <strong>in</strong>particolare, un dip<strong>in</strong>to è una rappresentazione di un composto su una superficie,mentre una statua, ovvero una figura scolpita o <strong>in</strong> rilievo, è una rappresentazionedi un composto <strong>in</strong> uno spazio corporeo (DM § 751).76 Si tratta, <strong>in</strong> buona sostanza, di una concezione “aristotelica” dell’immag<strong>in</strong>azione comefacoltà psicologica di ritenzione e rielaborazione di tracce sensitive, condivisa a varilivelli f<strong>in</strong>o a tutta l’aetas kantiana (cfr. <strong>in</strong> proposito la prima sezione di FERRARIS 1994b)– e oltre.76
Ora, al di là della determ<strong>in</strong>azione che identifica il fisico con ilcomposto e lo psichico con il semplice e che vale a differenziare il casodell’immag<strong>in</strong>e fisica da quello dell’immag<strong>in</strong>e psichica, ciò che quiconta è proprio il tipo di relazione sostenuta dall’immag<strong>in</strong>e – e <strong>in</strong> entrambii dom<strong>in</strong>i ontologici pr<strong>in</strong>cipali riconosciuti da <strong>Wolff</strong>. F<strong>in</strong> qui,non è tuttavia bene esplicitato quali siano i caratteri di una relazionerappresentativa di questo genere, semplicemente occasionata e noncausata <strong>in</strong> senso stretto, nel caso esemplare della sensazione, dallaconcomitanza di uno stato fisico e di uno stato psichico; per saperlomeglio occorrerà attendere il § 769, <strong>in</strong> cui viene <strong>in</strong>trodotta la nozionedi somiglianza.Poiché […] l’anima ha una forza di rappresentarsi il mondo (cfr. DM §753), le sue rappresentazioni devono <strong>in</strong>oltre avere una somiglianza con lecose che sono nel mondo. Se, <strong>in</strong>fatti, non avessero somiglianza alcuna,l’anima non si rappresenterebbe il mondo, ma qualcos’altro. Una figura chenon somiglia alla cosa che deve rappresentare non è un’immag<strong>in</strong>e di questa,bensì di un’altra cosa (cfr. DM §§ 17-18) (DM § 769).Tale posizione merita per <strong>Wolff</strong> di venire messa ulteriormente <strong>in</strong>rilievo osservando come si opponga a quella cartesiana, ritenuta capacedi sostenere un occasionalismo <strong>in</strong> cui non è prevista la necessitàdelle relazioni di concomitanza tra evento fisico (modificazione dell’organodi senso) ed evento psichico (sensazione) effettivamente riscontrabilisul piano dell’osservazione empirica – <strong>in</strong> cui, cioè, le “immag<strong>in</strong>i”dei sensi non somigl<strong>in</strong>o alle cose come secondo <strong>Wolff</strong> effettivamentesomigliano.La dottr<strong>in</strong>a secondo cui le sensazioni hanno una somiglianza con le coseche sentiamo è opposta a quella delle idee arbitrarie […] Infatti Cartesio e ilcelebre Bayle, <strong>in</strong>sieme ad altri seguaci, ammettono che Dio abbia arbitrariamenteconnesso determ<strong>in</strong>ate sensazioni con determ<strong>in</strong>ate modificazion<strong>in</strong>egli organi di senso, secondo il sistema delle cause occasionali, poiché le sensazioniriposerebbero su una legge arbitraria […] Dunque Egli avrebbe altrettantofacilmente potuto fare sì che l’acido sapesse di dolce e il dolce di acido,che il dolore ci fosse piacevole, e così via, al contrario di ciò che effettivamenteaccade (DM2 ad § 769).77
A ogni modo, al di là di altre precisazioni del significato della somiglianzache <strong>in</strong>tercorrerebbe fra sensazione e oggetto fisico, ciò cheper <strong>Wolff</strong> conta è la somiglianza come rapporto di covariazione – determ<strong>in</strong>atae osservabile – fra serie delle sensazioni e serie degli eventifisici rappresentati. E proprio a ciò si lega il rimando del § 769 ad alcunipassi decisivi del secondo capitolo della Metafisica tedesca, cioèdella futura ontologia, che si situano immediatamente dopo la def<strong>in</strong>izionedella “cosa” nei term<strong>in</strong>i di “tutto ciò che può essere, che sia realmente(würklich) oppure no” (DM § 16). Subito dopo avere postatale def<strong>in</strong>izione, <strong>in</strong>fatti, <strong>Wolff</strong> <strong>in</strong>troduce il primo della serie dei predicatigeneralissimi retti dai tre pr<strong>in</strong>cipi ontologici fondamentali, ossiaquello di identità.Se posso sostituire una cosa A ad una cosa B e tutto rimane come prima,allora A e B sono identiche ovvero dello stesso tipo (e<strong>in</strong>erley). Ad es., se una sferadi piombo e una di pietra sono ugualmente pesanti, allora posso mettere sulpiatto di una bilancia la sfera di pietra al posto di quella di piombo, e la bilanciarimane ferma, o riceve un tracollo uguale a quello di prima, quando vistava sopra la sfera di piombo. Dunque, le due sfere hanno lo stesso peso.In altre parole, qui [sc. nel caso dell’identità del peso] guardiamo soltanto alpeso e non alla grandezza, al tipo di materiale e a quant’altro possiamo <strong>in</strong>contrare[nelle due sfere]. Ma se sostituisco B ad A e non tutto rimane come prima,allora A e B sono cose dist<strong>in</strong>te ovvero differenti (DM § 17).Ci sarebbe, qui, parecchio da osservare, <strong>in</strong>iziando dal fatto chel’identità def<strong>in</strong>ita <strong>in</strong> base al pr<strong>in</strong>cipio di sostituzione configura subito<strong>in</strong> <strong>Wolff</strong> una teoria dell’identità relativa 77 . Tuttavia, l’aspetto più importantedell’argomentazione di <strong>Wolff</strong> consiste nell’assimilare l’identità<strong>in</strong> senso metafisico all’<strong>in</strong>discernibilità <strong>in</strong> senso gnoseologico, dandoun rilievo del tutto particolare al caso <strong>in</strong> cui l’identità <strong>in</strong>tesa come<strong>in</strong>discernibilità si decl<strong>in</strong>a come somiglianza, più o meno perfetta.77 Apparentabile, cioè, alle teorie dell’identità relativa (ovvero non-standard) contemporaneamenteopposte alle teorie dell’identità “assoluta” (ovvero “classica”) di derivazionepiù strettamente leibniziana (cfr. GRIFFIN 1977, Cap. I). Per un quadro delle teorie contemporaneedell’identità relativa, cfr. FORREST, ad voc. “Identity, of <strong>in</strong>discernibles” eDEUTSCH, ad voc. “Identity, relative”, entrambi <strong>in</strong> SEPh.78
Due cose A e B sono reciprocamente somiglianti (ähnlich) se ciò da cui dobbiamoriconoscerle e dist<strong>in</strong>guerle l’una dall’altra, ovvero mediante cui sonodeterm<strong>in</strong>ate nel loro genere, è identico per entrambe; <strong>in</strong>vece, A e B sonocose dissimili se ciò da cui dobbiamo riconoscerle e dist<strong>in</strong>guerle l’una dall’altraè differente per entrambe. Sicché la somiglianza è un accordarsi (Uebere<strong>in</strong>kommen)<strong>in</strong> ciò da cui bisogna riconoscere determ<strong>in</strong>ate cose e dist<strong>in</strong>guerlel’una dall’altra: e si assomigliano le cose che vengono determ<strong>in</strong>ate (determ<strong>in</strong>iren)<strong>in</strong> una stessa maniera (DM § 18).La formulazione è certamente ambigua – come del resto quasi sistematicamenteaccade <strong>in</strong> tutto il secondo capitolo della Metafisica tedesca– nel suo fondere argomentazioni metafisiche e argomentazioniepistemologiche. In ogni caso, l’importanza primaria del risvolto gnoseologico(di quello che però vuole essere <strong>in</strong>nanzitutto un elementoontologico) viene ribadita da <strong>Wolff</strong> nel paragrafo successivo, che comeesempio presenta il caso <strong>in</strong> cuisiano state costruite due case del tutto simili (ähnlich) l’una all’altra. Poniamo,<strong>in</strong>oltre, che qualcuno venga condotto <strong>in</strong> una delle due case con gli occhibendati aff<strong>in</strong>ché non possa vedere il luogo <strong>in</strong> cui si trova e, poi, quandoè dentro la casa e si guarda <strong>in</strong>torno, annoti con la massima diligenza tuttociò vi è possibile percepire. Si ponga, <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e, che, dopo aver completatoquesto compito, venga condotto con gli occhi bendati nell’altra casa, dovecon uguale cura annoterà ciò che è possibile percepirvi. Se ora confronteràciò che ha annotato nelle due case questo sarà identico (e<strong>in</strong>erley) e, dunque,non saprà se sia stato <strong>in</strong> una casa sola, oppure <strong>in</strong> due; e, anzi, chi sapesse chele case sono due non sarà <strong>in</strong> grado di capire, sulla base di quelle annotazioni,che cosa abbia annotato <strong>in</strong> una casa e che cosa, <strong>in</strong>vece, nell’altra (DM § 19).In breve: <strong>Wolff</strong> assume <strong>in</strong> sede ontologica una concezione (<strong>in</strong>genuamenteplatonica) della somiglianza come condivisione di proprietà(<strong>in</strong>tese a loro volta come universali), il cui caso limite è costituitodall’identità. Ma privilegia, <strong>in</strong>oltre, il caso <strong>in</strong> cui le proprietà rispetto acui la somiglianza va riconosciuta siano proprietà conosciute (o almenoconoscibili) – trovando così un metro naturale, psicologico,della somiglianza reale. In questo modo, tuttavia, equivoca il carattererelativo della somiglianza metafisicamente <strong>in</strong>tesa: questa appare, cioè,per un verso, sempre relativa a una o più proprietà realmente condi-79
vise fra due enti; ma, per l’altro, appare relativa alla capacità umana digiudicare rispetto a tale condivisione. Tale capacita umana, <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e –determ<strong>in</strong>ante, poiché su di essa si basa il fatto che “siamo coscientidelle cose (wir s<strong>in</strong>d uns der D<strong>in</strong>ge bewust) quando le dist<strong>in</strong>guiamo l’unadall’altra” (DM § 729) –, viene però re<strong>in</strong>terpretata nei term<strong>in</strong>i di unafondamentale covariazione tra eventi fisici ed eventi mentali, ed e-semplarmente percettivi, la quale fornisce un ancora ulteriore e diversosignificato della nozione di somiglianza.Nelle leggi (empiricamente <strong>in</strong>dagabili) del percepire, dunque, <strong>in</strong>quanto riposano su quest’ultimo significato di somiglianza e sono responsabilidella nostra capacità di avere esperienza (di s<strong>in</strong>gole cose,cioè di oggetti ed eventi, nonché di proprietà e leggi universali cherispettivamente le caratterizzano), si dà per <strong>Wolff</strong> la chiave della duplicitàdi ogni elemento dell’ontologia, che riguarda sempre “tutte lecose <strong>in</strong> generale” ed è sempre, <strong>in</strong>sieme, un “primo fondamento dellanostra conoscenza” – a com<strong>in</strong>ciare dallo stesso concetto di somiglianza,rispetto a cui il caso dell’identità perfetta e reale appare soltantocome un caso limite.80
IV – Epistemologia o metafisica: l’analogon rationisEns dicitur, quod existere potest, consequenter cui existentianon repugnat. […] Si lapis igni vel radiis solis aestivi exponitur,calidus sit. Calor adeo lapidis existere potest, atque adeoens est, non quatenus actu existit, sed quatenus existentia eidemnon repugnat.<strong>Wolff</strong>, <strong>Ontologia</strong> § 134Si è visto, f<strong>in</strong> qui, come per <strong>Wolff</strong> l’esperienza, realizzata già nella piùsemplice delle percezioni sensibili, sia esperienza della cosa “<strong>in</strong> quanto<strong>qualcosa</strong>”, cioè come il contenuto di una credenza che soggiace,m<strong>in</strong>imalmente, ai pr<strong>in</strong>cipi di certezza, contraddizione e ragione. Sicchéla cosa, a partire dalla determ<strong>in</strong>azione della prima qualità universaledegli enti, la loro somiglianza relativa, <strong>in</strong>tesa nel suo duplice versantemetafisico e gnoseologico, diventa un <strong>qualcosa</strong> caratterizzabileda ogni altro possibile attributo. Va tuttavia tenuto presente che lacosa “<strong>in</strong> quanto <strong>qualcosa</strong>” di cui si dà esperienza (<strong>in</strong>nanzitutto <strong>in</strong>quanto oggetto di percezione chiara e cosciente) può ugualmente essereuna cosa s<strong>in</strong>gola, cioè un oggetto o un evento, oppure una proprietào una legge non s<strong>in</strong>golari che, rispettivamente, caratterizzanouna o più cose s<strong>in</strong>gole. Come è nell’esempio di <strong>Wolff</strong>, un ente è purela qualità del calore che viene a caratterizzare un sasso esposto al sole(Ont § 134). Ma l’esempio dell’oggetto che <strong>in</strong> date circostanze si riscalda(esempio le cui varianti ricorrono, come vedremo, frequenti <strong>in</strong>diverse parti dell’opera wolffiana) esibisce ancora altro, oltre al sassocome oggetto, al suo riscaldarsi come evento, al suo calore comeproprietà: esibisce cioè, e sempre già <strong>in</strong> quanto si tratta di una “cosa”immediatamente esperibile, anche la regolarità del verificarsi di unevento particolare. In altri term<strong>in</strong>i: si tratterà di considerare <strong>in</strong> chesenso venga considerato da <strong>Wolff</strong> un “<strong>qualcosa</strong>” anche il fatto esperibileche, ad esempio, se esporrò un sasso al sole questo si riscalderà.E si tratta di una tesi ontologica cruciale, giacché un suo caso particolare– e specialissimo per l’importanza che gli è allegata – è proprio81
quello della covariazione regolare tra eventi fisici ed eventi percettivi,che si è vista ulteriormente <strong>in</strong>terpretata <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i di somiglianza tracose e sensazioni.1. Prevedere non è un miracoloIn quanto tale, la capacità di prevedere il futuro è un fenomenoche nasconde una folla di questioni – anche volendo tralasciarne i casiche al senso comune appaiono miracolosi (presentimenti, profezie)o magari soltanto fuori della sua portata (la previsione scientifica diun’eclissi, o del passaggio di una cometa). Come per me, anche per imiei gatti, ad esempio, è naturale pregustare il pasto, quando se neavvic<strong>in</strong>a il momento quotidiano. Ma anche il caso più ovvio, comepuò essere l’attenderci che i nostri alimenti preferiti saranno sempredisponibili e avranno sempre lo stesso sapore, nasconde presuppostidi cui ci si può meravigliare: una simile previsione, <strong>in</strong>fatti, di primoacchito appare sostenuta (e <strong>in</strong> maniera <strong>in</strong>sc<strong>in</strong>dibile) sia da caratteristicheoggettive del mondo, quali <strong>in</strong>nanzitutto la sua stabilità, sia dallanostra attitud<strong>in</strong>e a coglierle – ciò che vale ugualmente per l’attesa chedomani il sole tornerà a sorgere, o che la legge di gravitazione universalecont<strong>in</strong>uerà sempre a valere.Il presupposto generale – meno ovvio, almeno a uno sguardo filosofico– che sta qu<strong>in</strong>di alla base di ogni capacità di previsione è chel’esperienza del mondo debba avere <strong>in</strong> sé il proprio futuro, che debbaperciò esibire costanze e leggi proprie; o, detto con altre parole ancora,che nell’esperienza si dia (e si debba dare) uniformità nel mutamento.Ma qui proprio il significato di “esperienza” si sc<strong>in</strong>de, o si faambivalente. In particolare, spiegare l’uniformità e la prevedibilità delmondo esperito rimanendo fermi “dalla parte del soggetto” non potràmai apparire del tutto adeguato.La procedura consistente nel mettere un pezzo di formaggio sulla bilancia enello stabilire il prezzo secondo il peso <strong>in</strong>dicato dalla bilancia perderebbeciò che ha di essenziale, se si desse spesso il caso che i pezzi di formaggioaumentassero o dim<strong>in</strong>uissero improvvisamente di volume e di peso senzaalcuna causa evidente (WITTGENSTEIN 1953, n. 142).82
Sicché l’<strong>in</strong>tuizione comune dell’uniformità dell’esperienza ha allestito,forse meglio di qualunque altra, un terreno di scontro per dueontologie opposte (chiamiamole pure rozzamente realistica e idealistica)che la riconducono rispettivamente a caratteristiche <strong>in</strong>variabilidel mondo (che, ad esempio, un’entità mentale dovrà poter afferrare),oppure a strutture <strong>in</strong>variabili dell’esperienza (che un’entità mentaledovrà <strong>in</strong>tendere come oggettive).Oltretutto, quale che sia l’ontologia sottostante, l’uniformità gnoseologicadell’esperienza sembra vada presupposta per ogni essereche è capace di esperire un mondo, quale che ne sia il grado di razionalità– <strong>in</strong> ogni caso, qu<strong>in</strong>di, <strong>in</strong> cui un essere sembra esibire comportamentirazionali, che sempre, almeno <strong>in</strong> qualche misura, implicanouna capacità di previsione relativamente ai fatti del mondo. Da questopunto di vista, la capacità di prevedere diventa un ulteriore bancodi prova per la metafisica: e, di nuovo, per una <strong>psicologia</strong> <strong>in</strong> quantoontologia regionale, ma capace di dare ragione di tratti basilari dellametafisica generale. In term<strong>in</strong>i molto semplificati, si tratta di rendereragione del passaggio, così ovvio sul piano del senso comune, cheporta dall’attribuzione della capacità di previsione a esseri esperiticome più o meno “ragionevoli” all’attribuzione di attività di “pensiero”capaci di cogliere leggi ontologicamente oggettive. In term<strong>in</strong>i unpo’ meno semplificati, siamo <strong>in</strong> presenza di un altro dei capisaldi della<strong>psicologia</strong> “aristotelica” su cui <strong>Wolff</strong> si basa, ovvero di una biologiagenerale che, posta al conf<strong>in</strong>e reciproco tra ontologia e gnoseologia,si <strong>in</strong>carica di produrre una teoria della mente che salvi l’<strong>in</strong>tuizione secondocui il comportamento di ogni vivente è retto da cognizioni,considerate come gli elementi ultimi capaci di costituire un’esperienzauniforme e, <strong>in</strong> quanto tale, “somigliante” al mondo fisico.Storicamente, lo sviluppo di tale presupposto <strong>in</strong> chiave realisticaha generato, nei suoi sviluppi scolastici e tardoscolastici, f<strong>in</strong>o alla lorosistemazione moderna <strong>in</strong> <strong>Wolff</strong>, diverse conseguenze. Tra queste vi èla dottr<strong>in</strong>a secondo cui tra pensiero animale e umano si dà un rapportodi analogia – o, più esattamente, secondo cui gli animali non umani,<strong>in</strong> quanto possiedono soltanto facoltà cognitive “estetiche”, limitatecioè al sentire e all’immag<strong>in</strong>are, esibiscono nei loro comportamentidelle capacità argomentative soltanto apparenti, ovvero risulta-83
no muniti di un “pensiero” dimidiato, ovvero meccanico 78 . In ciò chesegue, si cercherà di illustrare s<strong>in</strong>teticamente tale sistemazione teorica,limitandosi al nucleo problematico costituito dalle capacità di previsioneanimali, <strong>in</strong> modo da poter qu<strong>in</strong>di presentare i motivi per cuiKant ha opposto un rifiuto a tale dottr<strong>in</strong>a, distaccandosi da alcunisuoi basilari presupposti metafisici. Si concluderà, tuttavia, sottol<strong>in</strong>eandocome la critica kantiana non sia riuscita a sostituire def<strong>in</strong>itivamenteil modello wolffiano del “pensiero animale” con un modelloalternativo, e suggerendo che, forse, occorre tornare sulle ragioni delperché una teoria della mente di tipo “aristotelico” tende cont<strong>in</strong>uamentea imporsi, e sempre di nuovo, con tanta forza.Prima di rivolgersi a <strong>Wolff</strong>, converrà tuttavia fornire qualche dettagliosul modo <strong>in</strong> cui il problema che qui <strong>in</strong>teressa f<strong>in</strong>isce per presentarsi<strong>in</strong> Baumgarten (uno dei tramiti pr<strong>in</strong>cipali fra il sistema wolffianoe Kant) come una questione pert<strong>in</strong>ente all’estetica 79 . Al primoparagrafo dell’Estetica (1750-58) Baumgarten dettaglia dunque così icontenuti della “scienza della cognizione sensitiva”: “teoria delle artiliberali, gnoseologia <strong>in</strong>feriore, arte del pensare <strong>in</strong> modo bello, artedell’analogo della ragione”. Nella sua Metafisica (§ 533), l’estetica si articola<strong>in</strong> modo simile <strong>in</strong> “logica della facoltà conoscitiva <strong>in</strong>feriore, filosofiadelle grazie e delle muse, gnoseologia <strong>in</strong>feriore, arte del pensare<strong>in</strong> modo bello, arte dell’analogo della ragione” 80 . Altro però è ildettaglio circa l’estensione dell’estetica che si ricava dalle pag<strong>in</strong>e diun’opera postuma, ossia dal cap. III (“L’oggetto della filosofia”) dellaFilosofia generale (1770). Come nei primi due manuali, Baumgarten lasitua nel campo tradizionale della “logica”, <strong>in</strong>tesa come la dottr<strong>in</strong>a78 Cfr., per un <strong>in</strong>quadramento storico della questione, SUTTER (1992) e FERRARIS(1994a). Per un utilizzo teorico contemporaneo della nozione di “analogon rationis”entro un più ampio progetto di ontologia, cfr. FERRARIS 1997, passim.79 Cfr., a tale proposito, PIMPINELLA (2001).80 Questa def<strong>in</strong>izione della “scientia sensitive cognoscendi & proponendi” (qui trattadall’ed. 1779) rimane pressoché stabile a partire dalla quarta edizione (1750); <strong>in</strong> edizioniprecedenti troviamo: “Scientia sensitive cognoscendi et proponendi est AESTHETI-CA, meditationis et orationis vel m<strong>in</strong>orem <strong>in</strong>tendens perfetionem, RHETORICA, velmaiorem POETICA UNIVERSALIS” (prima ed., 1739, § 533); “Scientia sensitive cognoscendiet proponendi est AESTHETICA (logica facultatis cognoscitivae <strong>in</strong>ferioris)”(seconda ed., 1742, § 533). Per ulteriori dettagli sullo sviluppo della def<strong>in</strong>izione baumgartenianadell’estetica cfr. JÄGER 1980.84
delle capacità conoscitive naturali, del loro perfezionamento, nonchédell’applicazione delle tecniche che ne fanno uso. Tuttavia, pur restandosempre nell’ambito della logica, ovvero della filosofia strumentaleo “organica” trattata nel lunghissimo § 147 81 , la preoccupazionedi Baumgarten rispetto all’estetica è qui di tipo enciclopedico 82 .In tale quadro, della logica sensitiva viene <strong>in</strong>nanzitutto considerato ilperfezionamento strettamente psicologico (mediante tecniche volte aperfezionare le capacità di attenzione, astrazione, immag<strong>in</strong>azione…),e qu<strong>in</strong>di si contemplano nel dettaglio le arti del suo uso complessivo.Incontriamo così un’arte del f<strong>in</strong>gere e una del giudicare, e poi i dueambiti dell’estetica più m<strong>in</strong>utamente analizzati: quello del prevedere edel presagire (la “mantica”) e quello del “segnare” e conoscere mediantesegni 83 .81 Def<strong>in</strong>ita la filosofia come la scienza delle qualità delle cose conoscibili senza fare ricorsoalla fede (ovvero dei possibili, ovvero delle qualità non occulte, ibidem, §§ 141-145), al § 146 afferma: “Le cose, suddivise <strong>in</strong> modo diverso <strong>in</strong> base a fondamenti diversi,produrranno diverse suddivisioni della filosofia (§ 141). La più comune è quella che ladivide così: la filosofia che tratta del conoscere (e dell’esporre), o ORGANICA (sez. II);la filosofia che considera le cose, ma non tratta delle cause impulsive, proprie dell’agire,o TEORETICA (sez. III); la filosofia che tratta dell’appetire, o PRATICA (sez. IV)”. Sitratta di un chiaro ritorno al modello enciclopedico sotteso alla Metafisica tedesca di <strong>Wolff</strong>,cfr. supra, pp. 34-35.82 Il ruolo applicativo della logica viene qui ulteriormente accentuato rispetto alla SciagraphiaEncyclopaediae Philosophicae (1769), senza peraltro che ne risult<strong>in</strong>o novità di rilievonella def<strong>in</strong>izione dell’estetica: “La GNOSEOLOGIA (logica <strong>in</strong> senso lato) è la scienzadella conoscenza, sia pensata, sia espressa, ed è la parte pr<strong>in</strong>cipale della filosofia organica[…] Poiché ogni conoscenza è o sensitiva o <strong>in</strong>tellettuale, si daranno scienze della cognizioneI) sensitiva e II) <strong>in</strong>tellettuale. La prima è l’ESTETICA” (§ 25).83 La mantica speciale, cioè la “critica delle div<strong>in</strong>azioni particolari”, comprende <strong>in</strong>fatti asua volta la “crestomanzia” (riferita agli oracoli di un ampio spettro di religioni, chevanno dallo zoroastrismo, alla religione biblica, a quelle pagane…), ma poi anche unavasta gamma di tecniche predittive profane, ad esempio (limitandoci ai term<strong>in</strong>i che possonorisultare più famigliari al lettore odierno) l’astrologia “naturale e giudiziaria, compreseOROSCOPIA e APOTELESMATICA”, l’onirocritica, la rabdomanzia, la bibliomanzia,la geomanzia, la piromanzia, l’idromanzia, la zooscopia, l’antropomanzia(divisa, questa, <strong>in</strong> fisiognomanzia, chiromanzia, podoscopia, necromanzia…), la litomanzia,la fitomanzia, l’onomatomanzia, l’aritmomanzia… I contenuti della “CARAT-TERISTICA (semiotica, semiologia, simbolica)” destano <strong>in</strong>vece meno sorprese: comprendonola filologia (suddivisa a sua volta <strong>in</strong> lessicografia, grammatica, ortografia, “E-TIMOLOGIA o ANALOGIA UNIVERSALE”, s<strong>in</strong>tassi, grafica, e poi calligrafia, tachigrafia,criptografia, emblematica…), la fisiognomia morale, la cromatocritica, la cosmeticae, <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e, l’oratoria con le sue suddivisioni <strong>in</strong>terne, poetica compresa (cfr. BAUMGARTEN1770: § 147).85
Le due sezioni più ricche dell’estetica sono dunque <strong>in</strong>dividuate daBaumgarten nella “mantica” e nella “caratteristica” – dopo la quale,oltrepassato l’ambito della cognizione sensitiva, si apre lo spazio dellalogica <strong>in</strong>tellettuale, ovvero della logica <strong>in</strong> senso stretto. Ma, mentreper la dottr<strong>in</strong>a della significazione tale <strong>in</strong>teresse non stupisce – vistala def<strong>in</strong>izione <strong>in</strong>tegrale dell’estetica (e anzi dell’<strong>in</strong>tera filosofia organica)come scienza del conoscere e dell’esporre 84 –, l’ampio spazio assegnatoalla mantica pare più bisognoso di chiarimenti. Il primo passoutile <strong>in</strong> tal senso sarà allora constatare (fatto banale soltanto a primavista) che la mantica viene da Baumgarten ben dist<strong>in</strong>ta dalla caratteristica:la capacità naturale di prevedere e qu<strong>in</strong>di le tecniche che lasfruttano non si basano, cioè, <strong>in</strong> modo essenziale sull’uso di segniprognostici. Questa sottopartizione della filosofia strumentale risultaperciò ricalcare strettamente quella della <strong>psicologia</strong> empirica wolffiana,dove la illustrazione della “facoltà di f<strong>in</strong>gere” (facente parte dellefacoltà conoscitive <strong>in</strong>feriori, ossia sensitive) contiene, certo, una dottr<strong>in</strong>adel “significato geroglifico” 85 – collocandosi però su un grad<strong>in</strong>oulteriore rispetto alle più fondamentali capacità di sentire e di immag<strong>in</strong>are.Già alla luce di questo semplice dato, sarà dunque lecito sottol<strong>in</strong>eareche Baumgarten vede le tecniche della “mantica” basarsi unicamentesulle prestazioni dell’“analogon rationis” wolffiano, cioè sullafacoltà di riconoscere casi simili a casi già esperiti nel passato e dianticiparli – capacità spiegata da <strong>Wolff</strong> con il solo possesso delle capacitàestetiche più elementari. Si consideri perciò la seguente tavola(fig. 9), che vale a riassumere la dottr<strong>in</strong>a wolffiana dell’immag<strong>in</strong>azione<strong>in</strong> quanto retta dalla legge fondamentale dell’associazione tra immag<strong>in</strong>i(cfr. PsE §§ Pars I, Sect. II, Cap. III).84 Va oltretutto considerato come precisamente l’<strong>in</strong>clusione della “caratteristica”nell’estetica renda conto della sua sottodef<strong>in</strong>izione nei term<strong>in</strong>i di una “teoria delle artiliberali”, ovvero di una “filosofia delle grazie e delle muse”, valendo a fondare l’altromembro della def<strong>in</strong>izione di questa discipl<strong>in</strong>a come “scientia sensitive cognoscendi &proponendi” (c.vo mio) dove le arti appaiono essere modi di espressione della cognizioneestetica.85 Cfr. UNGEHEUER (1981, 1986).86
Fig. 9Considerando la concezione wolffiana della somiglianza (fra cosee rappresentazioni e fra rappresentazioni e rappresentazioni) comecondivisione di proprietà reali e conoscibili (cfr. supra, pp. 76 ss.) eriferendola, rispettivamente, a degli enti esperibili (lato s<strong>in</strong>istro dellatavola) e alle loro rappresentazioni estetiche (sensazioni e immag<strong>in</strong>imnestiche e fantastiche, lato destro della tavola), si ha che la prestazionedi riconoscimento degli enti si configura come un giudizio circail (ri)presentarsi di una sufficiente quantità di proprietà identiche nellaloro rappresentazione. Nel primo dei due casi illustrati (A), si avrà,così, la percezione di un oggetto dotato di un <strong>in</strong>sieme di determ<strong>in</strong>atecaratteristiche visibili (tessitura, profilo…); nel secondo (B), la percezione(che oggi diremmo attentiva) di una sua s<strong>in</strong>gola proprietà visibile(la tessitura) – a sua volta simile a quelle che contraddist<strong>in</strong>guono(ovvero identicamente condivisa da) un’<strong>in</strong>tera classe di immag<strong>in</strong>i,mnestiche o fantastiche. Ciò che ora importa, tuttavia, è quello che siottiene considerando il funzionamento di tale modello del sentire, basatosu una concezione pittorica della rappresentazione, una volta chevi si applich<strong>in</strong>o delle d<strong>in</strong>amiche di successione temporale nel presentarsidi entità esperibili come più o meno simili fra loro.87
Fig. 10In tal caso (fig. 10), il riconoscimento di una o più proprietà s<strong>in</strong>golepuò servire a rappresentarsi (a un momento t 2 ), mediante una prestazionemnestica ovvero immag<strong>in</strong>ativa, un’associazione tra cose conosciutecome realmente associate fra loro <strong>in</strong> un tempo precedente(t 1 ), ovvero ad attivare associazioni rappresentative fra le proprietàattualmente percepite e altre di cui sia comunque già data la rappresentazione.Seguendo il filo offerto dal parallelismo con la <strong>psicologia</strong>wolffiana, conviene andare allora alla trattazione delle facoltà estetichecome svolta da Baumgarten nella Metafisica. Qui si trova che il fenomenodella “previsione” si caratterizza come speculare rispetto aquello della fantasia <strong>in</strong> quanto facoltà <strong>in</strong>nanzitutto “retrospettiva”, laquale consiste nel darmi una coscienza del mio stato presente checomporta la coscienza di uno stato passato del mondo (BAUMGAR-TEN 1739: § 537) e qu<strong>in</strong>di permette anche una percezione di cose assentiai sensi (ibidem, § 558) 86 . La previsione si configura allora comeuna “rappresentazione dello stato futuro del mondo” (ibidem, § 595),86 Se la prima prestazione della “forza rappresentativa”, quella dei sensi, consiste nelfornire una rappresentazione del “mio stato presente” che è una rappresentazione “dellostato presente del mondo” (ibidem, § 534), quella della fantasia consiste nel darmi unacoscienza del mio stato presente che comporta la coscienza di uno stato passato delmondo (ibidem, § 537) e qu<strong>in</strong>di una percezione di cose assenti ai sensi (ibidem, § 558).88
egolato sempre dalla legge associativa. In base a questa legge “daipercetti della sensazione e dell’immag<strong>in</strong>azione [sc. della rappresentazioneattuale di uno stato passato o futuro] che hanno <strong>in</strong> comune unapercezione parziale deriva una percezione totale dello stato futuro <strong>in</strong>cui si congiungono parti diverse della sensazione e dell’immag<strong>in</strong>azione”e dunque, grazie ad essa, “da un presente reso gravido dal passatonasce un futuro” (ibidem, § 596, orig. <strong>in</strong>teramente <strong>in</strong> c.vo). Rispettandole leggi generali dell’associazione di idee che governano tutte lefunzioni immag<strong>in</strong>ative, il grado di chiarezza della previsione dipenderàallora da quello dei percetti parziali che si immag<strong>in</strong>a ritorneranno,e qu<strong>in</strong>di anche dal loro numero e frequenza presenti e passati, nonchédalla forza associativa che li lega (ibidem, §§ 597 ss.). Sicché la“capacità di presagire”, <strong>in</strong>tesa come prestazione più specifica dellaprevisione, viene def<strong>in</strong>ita come la capacità di rappresentarsi una percezionefutura <strong>in</strong> modo da presagire <strong>in</strong> essa <strong>qualcosa</strong> di già percepito(ibidem, § 610). (Da questo punto di vista possono darsi, per Baumgarten,sia presagi sensitivi, sia <strong>in</strong>tellettuali, però <strong>in</strong> senso stretto vannoconsiderati presagi soltanto i primi, oggetto della “mantica estetica”– ibidem.) Inf<strong>in</strong>e, dopo quella fra immag<strong>in</strong>azione e previsione, laspecularità fra ricordo e presagio viene così sancita nei due paragrafisuccessivi: “se nelle percezioni presenti vengono rappresentate dellepercezioni successive che hanno alcunché di parzialmente <strong>in</strong> comunecon le percezioni antecedenti, questa rappresentazione parziale comuneè rappresentata come contenuta <strong>in</strong> quella antecedente e <strong>in</strong>quella successiva” (orig. <strong>in</strong>teramente <strong>in</strong> c.vo); dunque, la memoria staalla immag<strong>in</strong>azione come il presagire sta alla previsione (ibidem, §611). Complessivamente: “il presagire mediante i sensi è ATTEN-DERSI CASI SIMILI, la cui regola è: O sento, o immag<strong>in</strong>o, o prevedo unA che ha molto <strong>in</strong> comune con un B che pure prevedo, dunque rappresento un Bcome futuro e contemporaneo ad A” (ibidem, § 612). Se siamo <strong>in</strong> presenza diuna riscrittura della <strong>psicologia</strong> empirica wolffiana, come pure accadenella Filosofia generale 87 , sarà allora opportuno rifarsi direttamente a87 Nella Metafisica baumgarteniana seguono, <strong>in</strong>fatti, delle def<strong>in</strong>izioni relative agli abiti costituitida tali facoltà, cfr. § 616: “L’abito di presagire cose notevoli è la FACOLTÀ DI-VINATRICE, vuoi naturale (o <strong>in</strong>nata, o acquisita), vuoi <strong>in</strong>fusa […] Quest’ultima è ilDONO PROFETICO. Il presagire mediante la facoltà div<strong>in</strong>atrice è la DIVINAZIO-NE, il farlo per un dono profetico è il VATICINIO (la profezia).” E, ancora, alcune89
quest’ultima per trovare le basi della dottr<strong>in</strong>a della “mantica estetica”– che, è il caso di sottol<strong>in</strong>earlo <strong>in</strong> anticipo, sono più ampie della semplicelegge della associazione di idee parziali sistematicamente sfruttatada Baumgarten.Nella Metafisica tedesca, <strong>in</strong>tanto, <strong>Wolff</strong> accosta il fenomeno dell’aspettativadi casi simili (trattato al § 331) al problema scolastico dellapossibilità di attribuire agli animali un “analogo della ragione”, affermando(DM § 374) che la capacità psicologica che ne sta alla baseha una somiglianza con la ragione. Infatti, se abbiamo notato che <strong>in</strong> determ<strong>in</strong>atecircostanze è accaduto <strong>qualcosa</strong> e se, scorgendo nuovamente propriole medesime circostanze, contiamo sul fatto che accadrà nuovamente lastessa cosa, allora sembra che qui si abbia <strong>in</strong>telligenza del nesso fra le cose ese ne sappia <strong>in</strong>ferire una dall’altra. Dunque, tale aspettativa è analoga <strong>in</strong><strong>qualcosa</strong> alla ragione (cfr. DM §§ 368 & 18) (DM § 374).Di questo argomento – oltre alle chiare risonanze della presa diposizione leibniziana entro la polemica postcartesiana circa l’animadei bruti 88 – converrà osservare ancora altri aspetti, diversamente rileconsiderazionisulle fallacie dei presagi (cfr. ibidem, §§ 617-618) considerate da Baumgartenriconducibili a confusioni, ossia a errori di giudizio circa le rappresentazioni co<strong>in</strong>volte,oppure circa le loro relazioni. Solo successivamente viene trattata la “facoltà caratteristica”,risolta anch’essa nelle leggi di associazione immag<strong>in</strong>ativa, f<strong>in</strong> dalla sua <strong>in</strong>troduzionenei term<strong>in</strong>i di una percezione congiunta dei segni <strong>in</strong>sieme con i loro “segnati” (ibidem,§ 619).88 Cfr. anche il § 375: “Nella maggior parte delle azioni umane [tale aspettativa] non soltantotiene il luogo della ragione, ma può anche diventare equipollente (cfr. DM § 17) epers<strong>in</strong>o conforme alla ragione (cfr. DM § 369), quando cioè si determ<strong>in</strong>ano con esattezzale circostanze entro cui <strong>qualcosa</strong> avviene. In tal modo, <strong>in</strong>fatti, si sa che il risultato dipendedalle circostanze, benché non si comprenda come ciò accada e qu<strong>in</strong>di non si abbiaalcuna <strong>in</strong>telligenza dist<strong>in</strong>ta del nesso (cfr. DM § 206)”. Per Leibniz, cfr. almeno ilpunto 14 del celebre scritto dedicato all’anima dei bruti (1710): qui si ammette che, se laragione viene <strong>in</strong>tesa come la facoltà di trarre conseguenze, allora anche agli animali nonumani va riconosciuta razionalità – dovendo però precisare subito che “vi sono due tipidi associazione (consecutiones), e del tutto diverse, quelle empiriche e quelle razionali. Leassociazioni empiriche sono comuni a noi e alle bestie e consistono nell’aspettare chequelle cose che altre volte si sono esperite come congiunte lo saranno di nuovo. Così icani che sono stati battuti per aver fatto cose che non dovevano si aspettano di nuovole percosse quando rifanno le stesse cose, e perciò si trattengono dall’azione, ciò chehanno <strong>in</strong> comune con i bamb<strong>in</strong>i. […] Ma poiché spesso accade che tali cose siano congiuntesoltanto <strong>in</strong> maniera accidentale, gli empirici vengono spesso <strong>in</strong>gannati, propriocome gli animali che si aspettano <strong>qualcosa</strong> che poi non accade. […] L’uomo, <strong>in</strong>vece, <strong>in</strong>90
vati (o attenuati) nella ripresa baumgarteniana delle dottr<strong>in</strong>e che qui si<strong>in</strong>trecciano.In primo luogo, la valutazione anticartesiana delle capacità cognitiveanimali da parte di <strong>Wolff</strong> si fa forza, come accennato, della ripresadella dottr<strong>in</strong>a scolastica dell’“analogo della ragione” – mantenendoneperò rigorosamente il valore di semplice analogia: al di là di o-gni cont<strong>in</strong>uismo, <strong>in</strong>fatti, tra una prestazione cognitiva meramente e-stetica e una prestazione genu<strong>in</strong>amente razionale dovrà permanereuna qualche differenza irriducibile. In secondo luogo – e soprattutto– <strong>Wolff</strong> è consapevole che una simile strategia argomentativa puòfunzionare soltanto se, oltre a spiegare identità e differenze tra prestazionicognitive estetiche e <strong>in</strong>tellettuali, risulta possibile dimostrareche le prime riescono comunque a determ<strong>in</strong>are da sole il costituirsi diun’esperienza genu<strong>in</strong>a – ciò che può essere ottenuto solamente superandola prospettiva di una <strong>psicologia</strong> strettamente empirica, come èaccennato alla f<strong>in</strong>e del § 377.Si trova che nella filosofia comune [sc. scolastica] si è negata agli animali laragione: tuttavia, viene loro attribuito <strong>qualcosa</strong> di analogo a essa. Nei nostritempi [questo discorso] lo si è ritenuto <strong>in</strong>comprensibile. Però, se ci si richiamaall’aspettativa di casi simili e si spiega come questa si fondi soltanto neisensi, nell’immag<strong>in</strong>azione e nella memoria (cfr. DM § 376) 89 , allora, a mioavviso, si sarà spiegato <strong>in</strong> modo comprensibile che cosa gli antichi abbiano<strong>in</strong>teso per analogo della ragione (cfr. DM § 206). Tuttavia, se questo sia statoquanto agisce non empiricamente ma razionalmente, non si fida dei soli esperimenti odelle <strong>in</strong>duzioni dai particolari a posteriori, ma procede a priori per ragioni. […] Infatti, anchequando si sono sperimentati molti casi favorevoli, non perciò siamo sicuri del successo<strong>in</strong> perpetuo, a meno che non troviamo ragioni necessarie da cui si possa desumereche le cose non possono stare altrimenti. Pertanto le bestie (per quanto possiamoosservare) non conoscono l’universalità delle proposizioni, perché non conoscono laragione della necessità”.89 Al § 376 della Metafisica tedesca, cui qui r<strong>in</strong>via, <strong>Wolff</strong> sostiene appunto che l’aspettativadi casi simili può darsi “anche <strong>in</strong> totale assenza di ragione”: “<strong>in</strong>fatti, se delle circostanzeda cui un caso risulta determ<strong>in</strong>ato abbiamo solo un concetto chiaro ma confuso (e spessoaddirittura oscuro), e se scorgiamo di nuovo tali circostanze, allora l’immag<strong>in</strong>azioneci rappresenta contemporaneamente anche ciò che era accaduto <strong>in</strong> passato (cfr. DM §238), mentre la memoria ci assicura che le due cose sono state concomitanti (cfr. DM §249): perciò si torna a cercarle adesso [sc. le circostanze e il caso che <strong>in</strong> passato sono statiesperiti come concomitanti]”.91
attribuito [agli animali] a giusto titolo non lo si può ancora decidere <strong>in</strong> questoluogo, ma se ne dirà più avanti (cfr. DM § 872) (DM § 377).E che la posta <strong>in</strong> gioco consista, oltre che nel risolvere il problemadella razionalità degli animali <strong>in</strong> quanto circoscritta alla loro capacitàdi previsione, nel dimostrare più <strong>in</strong> generale che le facoltà estetichepossono dare orig<strong>in</strong>e a un’esperienza pienamente costituita è benchiaro a <strong>Wolff</strong>. Lo ev<strong>in</strong>ce da una nota complessiva ai paragrafi f<strong>in</strong> quipresi <strong>in</strong> considerazione, che converrà qu<strong>in</strong>di citare almeno per unbuon tratto.È una proposizione <strong>in</strong>dubitabilmente certa che, date medesime circostanze,debbano necessariamente verificarsi i medesimi eventi. Se così non fosse,l’esperienza non ci sarebbe granché utile e la maggior parte degli uom<strong>in</strong>i sitroverebbe davvero a mal partito <strong>in</strong> tutte le proprie azioni. Su ciò riposa ilfatto che ci si possa orientare sugli esempi. Solo, si tratta ora di saper giudicarese tutte le circostanze, oppure soltanto la maggior parte, siano le medesime,e nessun’altra venga trovata difforme, benché di qualcuna non si sappiacome sia caratterizzata. Chi bada a questo procede con sicurezza imitandogli altri, e chi non vi bada li segue ciecamente. E questa è la causa percui l’imitazione porta di solito a risultati tanto cattivi: perché si imita ciecamente.Ma si può facilmente prevedere chi siano coloro che dovranno seguireciecamente gli altri, ossia tutti coloro che rimangono attaccati soltantoai propri sensi e alla propria immag<strong>in</strong>azione, senza darsi alcuna pena di portarea dist<strong>in</strong>zione mediante l’<strong>in</strong>telletto i concetti confusi così ricavati (DM2ad §§ 375-576) 90 .Ora, proprio la nozione di “esperienza”, che qui vediamo emergere<strong>in</strong> primo piano, riveste tutt’altro ruolo che <strong>in</strong> Baumgarten, dove lafunzione di ciò che <strong>Wolff</strong> chiama esperienza è retta dal complessodelle cognizioni realizzato <strong>in</strong> un’anima <strong>in</strong> un momento determ<strong>in</strong>ato,ovvero da una sorta di s<strong>in</strong>tassi associativa delle rappresentazioni, cheman mano si complica a partire dalla fondamentale prestazione rappresentativadei sensi. In altri term<strong>in</strong>i, Baumgarten – posto il caratterepsicologico della rappresentazione come determ<strong>in</strong>ato da un’ontologia90 <strong>Wolff</strong> fornisce qui l’esempio di coloro che seguono ciecamente e meccanicamente iformalismi grammaticali e matematici nella conv<strong>in</strong>zione (erronea) di produrre <strong>in</strong> talmodo dimostrazioni logiche genu<strong>in</strong>e (ibidem).92
delle relazioni – riduce <strong>in</strong>teramente a una storia di fatti empirici (regolatida leggi associative) ogni qualità della “percezione totale” realizzatavolta per volta dall’anima come un complesso di rappresentazioni91 . <strong>Wolff</strong> <strong>in</strong>vece (e magari meno coerentemente) <strong>in</strong> sede psicologicaprende <strong>in</strong> conto anche caratteri strutturali dell’esperienza (e <strong>in</strong>nanzituttodi quella sensibile) che non si lasciano catturare da una<strong>psicologia</strong> semplicemente associazionistica.2. Come le esperienze ritornanoIl primo di tali caratteri è quello della “certezza”, che si ritrova appuntonell’esperienza def<strong>in</strong>ita come cognizione empirica 92 , che viene91 Subito al cap. I della “Psicologia” (1739: §§ 504 ss. – e cioè prima ancora di illustrarela dottr<strong>in</strong>a della “facoltà conoscitiva <strong>in</strong>feriore”) Baumgarten determ<strong>in</strong>a non soltanto ladef<strong>in</strong>izione essenziale dell’anima come “forza “ (ibidem, §§ 505-506) capace di fornireuna rappresentazione dello stato del soggetto che corrisponde allo stato del mondo, a<strong>in</strong>iziare dallo stato di quell’ente fisico particolare che è il suo corpo proprio (ibidem, §§508-513), ma anche determ<strong>in</strong>a immediatamente tale facoltà come capace di dare luogoa complessi (che poi potranno diventare serie) di rappresentazioni – nel che vale ladottr<strong>in</strong>a della composizione delle “percezioni parziali” <strong>in</strong> una “percezione totale” (ibidem,§ 514).92 Si potrebbe rilevare che qui <strong>Wolff</strong> non rivolge il proprio <strong>in</strong>teresse <strong>in</strong> primo luogo aun’esperienza naturale e “<strong>in</strong>genua” (cfr. DM § 325: “Siamo soliti chiamare esperienza laconoscenza a cui arriviamo facendo attenzione alle nostre sensazioni e alle modificazionidell’anima”), tanto più che il tema immediatamente focalizzato diventa quello dell’esperimento:“Chiamiamo esperienze comuni quelle <strong>in</strong> cui le sensazioni si danno spontaneamente,e <strong>in</strong>vece esperimenti quelle che conseguiamo mediante il nostro sforzo. Ad es., ilcielo si copre di nuvole senza il nostro <strong>in</strong>tervento, e vediamo queste nubi fosche senzaavere avuto l’<strong>in</strong>tenzione di vederle. Se, dunque, presto attenzione a ciò che vedo e sonocosciente che il cielo è coperto di nubi fosche, questa è un’esperienza comune. Se, <strong>in</strong>vece,da una grande sfera di rame o di vetro estraggo l’aria per vedere se pesa meno diquando è piena d’aria, questo è un esperimento: <strong>in</strong>fatti, giungo a questa conoscenza permezzo del mio sforzo. Senza il nostro <strong>in</strong>tervento non avremmo mai e poi mai la possibilitàdi vedere tali fenomeni, perché la natura non riesce a mettere <strong>in</strong>sieme sfere, pompepneumatiche e bilance, e tantomeno vuota le sfere e le poggia su una bilancia” (ibidem).Nella relativa annotazione il discrim<strong>in</strong>e fra osservazioni ed esperimenti viene cosìs<strong>in</strong>tetizzato: “Nel primo caso, la realtà di ciò che avviene dipende semplicemente dallanatura, mentre nel secondo dall’arte” (DM2 ad § 325). È tuttavia più che plausibile sottol<strong>in</strong>earecome <strong>Wolff</strong> faccia <strong>in</strong> realtà centro su quella che nel Discursus praelim<strong>in</strong>aris verràdef<strong>in</strong>ita “cognizione istorica” (cfr. supra, p. 57, n. 53). Spia del fatto che <strong>in</strong> questi passaggidella Metafisica tedesca <strong>Wolff</strong> si rivolga proprio a questo tipo di sapere è che, dopo avereragionato (e <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i prescrittivi) della perfettibilità scientifica della “esperienza co-93
analizzato al § 330 della Metafisica tedesca – e proprio relativamente alcaso esemplare dell’attesa di casi simili.I concetti sono certi se ne conosciamo la possibilità (cfr. DL IX, § 5). Poiché,ora, l’esperienza ci mostra che ci sono cose di cui essa ci fornisce unconcetto, allora di qui conosciamo anche che [tali cose] sono possibili (cfr.DM § 15). I giudizi sono certi se alle cose conviene o può convenire ciò chenoi attribuiamo loro (cfr. DL IX, § 6). Se, ora, siamo pervenuti a un giudiziomediante l’esperienza, allora da ciò abbiamo appreso che a <strong>qualcosa</strong> èconvenuto questo o quello, e dunque risulta di qui nuovamente chiaro chequesto o quello può convenirle (cfr. DM § 15). Ma poiché nei giudizi tuttoviene detto di <strong>qualcosa</strong> sotto determ<strong>in</strong>ate condizioni (cfr. DL III, § 6), alloranon è certo che <strong>qualcosa</strong> accadrà nuovamente f<strong>in</strong>ché non saranno d<strong>in</strong>uovo presenti le medesime condizioni, cioè <strong>in</strong> casi simili (cfr. DM § 18). Ades., vedo che nella fuc<strong>in</strong>a il ferro diventa <strong>in</strong>candescente se lo si mette neicarboni ardenti, fortemente ventilati da un mantice. Di qui giudico: il ferropuò diventare <strong>in</strong>candescente. Però questo giudizio non è vero <strong>in</strong> senso assoluto.Infatti, non posso nutrire la speranza che ciò accada a meno chenon veda il ferro stare nella brace rovente (DM § 330).Al di là dei riferimenti <strong>in</strong>terni alla Metafisica tedesca, che però valgonoa richiamare alcuni term<strong>in</strong>i centrali del realismo wolffiano 93 , <strong>in</strong>teressanoqui i rimandi (più puntuali) alla logica, e precisamente ad alcuniprecisi capitoli della Logica tedesca. Di tali rimandi, quello al primodei capitoli a venire <strong>in</strong>contrato seguendo l’<strong>in</strong>dice di questo altro manuale(DL III), tuttavia, più che a circostanziare l’affermazione secondocui “nei giudizi tutto viene detto di <strong>qualcosa</strong> sotto determ<strong>in</strong>atecondizioni”, vale a riportare il tema della certezza del giudizio empiricoentro una più complessiva teoria del giudizio 94 . Sarà <strong>in</strong> effetti il camune”f<strong>in</strong>o al § 329, <strong>Wolff</strong> apre il § 330 con la seguente premessa: “Non ho quil’<strong>in</strong>tenzione di supplire alla mancanza f<strong>in</strong>ora patita di un’arte di esperire e sperimentare, madevo piuttosto <strong>in</strong>dicare da dove provenga la certezza dell’esperienza”.93 Sono riferimenti ai primi paragrafi della Metafisica tedesca, dove, sulla base del caratterenecessario delle conclusioni che portano dalla realtà alla possibilità (§ 15), viene fornitala def<strong>in</strong>izione della “cosa”; cfr. supra, pp. 33-34.94 I giudizi qui prevalentemente considerati da <strong>Wolff</strong> sono giudizi di <strong>in</strong>erenza, ovvero didipendenza (soprattutto causale, cfr. DL III, § 1: “Se pensiamo che a <strong>qualcosa</strong> <strong>in</strong>erisca opossa <strong>in</strong>erire <strong>qualcosa</strong>, ovvero che a <strong>qualcosa</strong> non <strong>in</strong>erisca o non possa <strong>in</strong>erire <strong>qualcosa</strong>,ovvero che da <strong>qualcosa</strong> possa derivare <strong>qualcosa</strong>, allora ne giudichiamo”, ad es.: “giudi-94
pitolo VI della Logica tedesca ad analizzare, a tale scopo, il tema della“certezza” dei giudizi a posteriori, fondando gli argomenti dei §§ 5-6del capitolo IX cui <strong>Wolff</strong> si rifà nella Metafisica tedesca – e su questivarrà dunque maggiormente la pena di soffermarsi.Il capitolo VI della Logica tedesca, di primo acchito, si limita a rilevarecome la validità materiale e formale delle argomentazioni siacondizione necessaria della verità dei pensieri, mentre per il restofornisce una serie di avvertenze tecniche rispetto a tipiche fallacie digiudizio. Tuttavia, ciò che importa è che qui il giudizio assunto comeesemplare nello sviluppo dell’<strong>in</strong>tero capitolo – “nella fuc<strong>in</strong>a il ferro siarroventa” – viene esam<strong>in</strong>ato quanto alla sua struttura (rispetto a cuiè appunto possibile dist<strong>in</strong>guere tra validità materiale e formale), laquale appare dunque costituita nella seguente maniera, da due “concetti”così correlati 95 :circostanza (classe di osservabili A) → caso (classe di osservabili B).Le considerazioni cruciali circa tale strutturazione elementare delgiudizio vengono però svolte nel precedente capitolo V della Logica tedesca,dove, <strong>in</strong>trodotta la dist<strong>in</strong>zione tra “giudizio fondamentale (Grund-Urtheil)” e “derivato (Nach-Urtheil)” (basati rispettivamente sull’esperienzaimmediata, <strong>in</strong>nanzitutto quella sensitiva, o sul ragionamento,DL V, § 1), <strong>Wolff</strong> si rivolge al primo, esemplificato da casi del tipo“vedo che, se si accende una candela, ogni cosa <strong>in</strong>torno a me diventachiamo del ferro, se diciamo che il ferro può diventare rovente”), rispetto a cui vienepoi fatta valere la dottr<strong>in</strong>a tradizionale della omologia fra giudizio mentale e proposizione,nonché quella del giudizio come s<strong>in</strong>tesi di concetti.95 Non appare qui problematico – a riprova, se ce ne fosse bisogno, dell’assunzione diuna prospettiva “psicologistica” da parte del <strong>Wolff</strong> logico – che la rappresentazionevenga equiparata a un concetto, capace di <strong>in</strong>tendere una classe di eventi. Si consideri,anzi, come <strong>in</strong> tale prospettiva appaia addirittura <strong>in</strong>differente il dover imputare a unapercezione chiara di somiglianze oppure a una percezione confusa di differenze fra <strong>in</strong>dividuila genesi di una rappresentazione generica. Sarà BAUMGARTEN (cfr. 1739, §§528-530) a tirare le somme di tale impostazione e a voler fondare psicologicamente sullaspecularità delle funzioni attentiva e astrattiva la legge logica del rapporto <strong>in</strong>verso fra<strong>in</strong>tensione e estensione (<strong>in</strong> proposito, mi permetto di r<strong>in</strong>viare a KOBAU 2000, specialmentepp. 36-37). Ancora, Reimarus amplificherà il motivo della rappresentazione confusadi cose ed eventi nel riprendere la spiegazione wolffiana dell’attesa di casi simili <strong>in</strong>quanto capacità psicologica che non necessità dell’esercizio del razioc<strong>in</strong>io (REIMARUS1760, II, §§ 11-31).95
visibile”, “l’acqua rovesciata bagna il tavolo” ecc. (ibidem). Ciò che qui<strong>in</strong>teressa è però un’affermazione chiave: “poiché, ora, abbiamo sensazionesoltanto di cose s<strong>in</strong>gole, anche le esperienze non sono altroche proposizioni circa cose s<strong>in</strong>gole” (ibidem, § 2). È qui, <strong>in</strong>fatti, che<strong>Wolff</strong> attribuisce alla semplice osservazione la capacità di produrreimmediatamente esperienze <strong>in</strong> forma di giudizi, ossia di connessionifra concetti secondo la struttura “circostanza (s<strong>in</strong>golare) → caso (s<strong>in</strong>golare)”.E tale struttura si può specificare per <strong>Wolff</strong> <strong>in</strong> tre manierefondamentali (esperienza di oggetti e dei relativi attributi; dei loromutamenti; dei loro effetti su altri oggetti) cui corrisponderanno trevie per giungere a tre diverse specie di giudizi fondamentali (ibidem, §5). La terza, però, risulta esibire un problema peculiare: i casi di percezionedelle cause di mutamenti (ad esempio: “se espongo al soledella cera <strong>in</strong> una calda giornata d’estate ed essa com<strong>in</strong>cia a sciogliersi,non c’è dubbio che il sole abbia sciolto la cera”, ibidem, § 9) richiedonoparticolari cautele nel verificare la corrispondenza al vero di taliesperienze, poiché non sempre è evidente il carattere percepito dellacausa. Talvolta, <strong>in</strong>fatti, “percepiamo un mutamento, ma le cose chelo producono ci sono nascoste. Vediamo tuttavia che il mutamento èconnesso (o sempre, o molto spesso) con qualcos’altro, ovvero cheuna cosa segue a un’altra” – sicché la natura genu<strong>in</strong>amente causale ditali rapporti di concomitanza o di mera successione diventa dubbiaquando si passa a un livello gnoseologico meno <strong>in</strong>genuo. Ad esempio:“la guardia notturna si aggira sempre per le vie della città, quandodi notte scoppia un <strong>in</strong>cendio, o quando qualcuno viene feritomortalmente. Chi però vorrebbe per questo motivo <strong>in</strong>ferirne che laguardia notturna, poiché si aggira per le vie cittad<strong>in</strong>e, è causa dell’<strong>in</strong>cendioo dell’assass<strong>in</strong>io?” (ibidem, § 11). Valido sul piano strettamenteepistemologico è allora soltanto l’argomento negativo: “se due cosesono spesso collegate fra loro, e trovo che una volta si verifica laprima ma la seconda no, mentre nulla ha potuto ostacolare l’esplicarsidell’effetto della prima, allora è impossibile che la prima sia causa dellaseconda” (ibidem).Propriamente, allora, quando ad esempio osservo come un ferro siarroventa, posso apprendere con certezza, verificando il fenomeno <strong>in</strong>circostanze diverse, soltanto quali circostanze non sono la causa del96
suo arroventarsi. <strong>Wolff</strong> tocca qui il problema reale, quello del passaggiodai giudizi di esperienza alla conoscenza di leggi scientifiche veree proprie – sicché l’<strong>in</strong>dividuazione della causa di un mutamento, def<strong>in</strong>itada una legge positiva, si dovrebbe configurare come una via cheporta (senza poter presc<strong>in</strong>dere da un <strong>in</strong>cremento di conoscenze a posteriori)dal livello dei giudizi di mera concomitanza a quello delle leggidi implicazione propriamente nomologica. Ma non trae da questa osservazionetutte le conseguenze che si potrebbero trarre, e si cura <strong>in</strong>vece,<strong>in</strong> maniera piuttosto ottimistica (oltre che fallace), di argomentare lapossibilità di elevare (mediante un’applicazione ancora <strong>in</strong>genua del metodosperimentale) i giudizi s<strong>in</strong>golari al grado dell’universalità 96 .Altrove – e cioè <strong>in</strong> una sede diversa dalla logica – <strong>Wolff</strong> forniscetuttavia un altro accenno di soluzione che, si può brevemente anticipare,consiste nel sottoporre all’istanza della ragione la capacità, già empirico-osservativa,di ricavare rapporti del tipo “circostanza → caso”;ovvero, nel porre un piano di leggi, ricavabili razionalmente, comegarante dei s<strong>in</strong>goli rapporti di concomitanza correttamente conoscibili<strong>in</strong> maniera osservativa. E il luogo si trova proprio nella ripresa conclusivadella questione dell’“analogon rationis” <strong>in</strong> sede di <strong>psicologia</strong>razionale – l’unica appropriata a tale scopo, come accennava, <strong>in</strong> chiusura,il § 377 della Metafisica tedesca.Converrà ora procedere per alcuni passi successivi e, <strong>in</strong>tanto, dettagliareperché per <strong>Wolff</strong> la capacità di attendersi casi simili a casi giàesperiti (riconoscibile anche agli animali, <strong>in</strong> quanto capaci di avereesperienza del mondo grazie al possesso di facoltà estetiche) è soltantoanaloga alla capacità di svolgere argomentazioni razionali. Rimanendoancora <strong>in</strong> sede di <strong>psicologia</strong> empirica, va detto <strong>in</strong> primo luogoche tale “analogo” non è irrimediabilmente difettivo rispetto alla ra-96 La soluzione complessiva – che palesemente trascende il piano della semplice logica –viene offerta presto (DL V, § 15) ricorrendo al pr<strong>in</strong>cipio (ontologico) di ragione: “Malgradoperò le esperienze siano <strong>in</strong> sé e per sé null’altro che proposizioni circa cose s<strong>in</strong>gole(cfr. DL V, § 3), tuttavia le possiamo trasformare <strong>in</strong> proposizioni universali, purchéabbiamo annotato con esattezza tutte le circostanze sotto cui <strong>qualcosa</strong> è accaduto (cfr.DL III, § 5). Infatti, tutte le cose <strong>in</strong> natura hanno degli effetti e subiscono mutamenti acausa della loro essenza e delle circostanze <strong>in</strong> cui si trovano. Perciò, f<strong>in</strong>ché hanno lamedesima essenza e si trovano nelle medesime circostanze, devono avere <strong>in</strong> parte anchei medesimi effetti e <strong>in</strong> parte subire i medesimi mutamenti”.97
gione, e i giudizi veri che genera possono sempre, <strong>in</strong> l<strong>in</strong>ea di pr<strong>in</strong>cipio,convertirsi <strong>in</strong> verità razionali:coloro i quali badano soltanto all’esperienza conformandosi a essa si aspettanoil verificarsi di casi simili, e l’attesa di casi simili è la ragione di tutte le loroazioni. Se, ora, sapessero dist<strong>in</strong>guere esattamente tali casi, ne avesserocioè almeno un concetto chiaro (cfr. DM § 198), agirebbero con certezza: è<strong>in</strong>fatti vero che <strong>in</strong> casi simili accadono cose dello stesso genere (DM § 331).Ma la ragione permette appunto di cogliere i rapporti tra le s<strong>in</strong>goleverità conoscibili per esperienza 97 , cioè un genere di rapporti diversoda quelli che connettono i term<strong>in</strong>i di un giudizio s<strong>in</strong>golare. In questomodo, vengono riconosciuti due tipi di conoscenza differenti.Abbiamo qu<strong>in</strong>di due vie per cui giungiamo alla conoscenza della verità:l’esperienza e la ragione. Quella si fonda sui sensi (cfr. DM §§ 220, 325),questa <strong>in</strong>vece sull’<strong>in</strong>telletto (cfr. DM §§ 277, 368). Ad es., che il sole torneràa sorgere domatt<strong>in</strong>a, la maggior parte degli uom<strong>in</strong>i lo sa per esperienza (cfr.DM § 338) e non è capace di dire perché ciò accada; <strong>in</strong>vece, un astronomoche <strong>in</strong>tenda la causa dei moti celesti e la connessione fra terra e cielo conosceuna tale cosa mediante la ragione ed è capace di dimostrare che, perchée quando ciò deve necessariamente accadere (DM § 372).La differenza tra esperienza e cognizione razionale è qu<strong>in</strong>di unadifferenza tra due tipi di conoscenza, caratterizzati, sì, da un diversogrado di generalità – ma soprattutto dalla palese differenza qualitativache <strong>in</strong>tercorre tra il “sapere che” e il “sapere perché” 98 , dove quest’ul-97 Si tratta di una ripresa critica (<strong>in</strong> qualche misura) della dottr<strong>in</strong>a leibniziana. Al § 368<strong>Wolff</strong> afferma: “L’arte dell’argomentare mostra che le verità sono connesse fra loro, ciòche andrà dimostrato a suo luogo. L’<strong>in</strong>telligenza del nesso delle verità, ovvero la facoltàdi <strong>in</strong>tendere il nesso delle verità, si chiama ragione”. All’annotazione corrispondente(DM2 ad § 368) ricorda la def<strong>in</strong>izione di ragione data da Leibniz (nella Teodicea) nei term<strong>in</strong>idi una “concatenazione di verità”, e precisa che occorre dist<strong>in</strong>guere tra la “connessionedelle verità” reale e l’<strong>in</strong>telligenza di tale nesso fra verità.98 L’orig<strong>in</strong>e lontana di tale dist<strong>in</strong>zione può essere considerata aristotelica e reperita nellaMetafisica (A, 1), dove si afferma che “il sapere e l’<strong>in</strong>tendere sono propri più all’arte cheall’esperienza”; coloro che possiedono un’arte, <strong>in</strong>fatti, “sanno la causa, mentre gli altr<strong>in</strong>on la sanno. Gli empirici sanno il puro dato di fatto, ma non il suo perché; <strong>in</strong>vece, glialtri conoscono il perché e la causa” (981a 24-30). Tale discorso aristotelico appare <strong>in</strong>fluenteper l’<strong>in</strong>sieme più largo dei temi qui considerati anche per altri motivi: si veda, ad98
timo sapere viene <strong>in</strong>teso da <strong>Wolff</strong> come una conoscenza delle leggiuniversali che determ<strong>in</strong>ano i “che”, ossia i s<strong>in</strong>goli nessi “circostanza ?caso” conoscibili per mera esperienza.Sicché, a questo punto, si pone il problema di determ<strong>in</strong>are non piùla differenza, bensì proprio l’analogia che sussisterebbe fra questi duetipi di conoscenza, basati rispettivamente (dal punto di vista genetico)sui sensi (più l’immag<strong>in</strong>azione) e sull’<strong>in</strong>telletto, e qualificabili (nomologicamente)come doxa ed episteme – problema che percorre l’<strong>in</strong>tera<strong>psicologia</strong> razionale a partire dalla posizione del suo fondamento metafisico,cioè dall’<strong>in</strong>dividuazione dell’essenza naturale dell’anima <strong>in</strong>una “forza di rappresentarsi il mondo secondo lo stato del suo corponel mondo” (DM § 753). È su questa base, <strong>in</strong>fatti, che <strong>Wolff</strong> ripercorre,nella sua prima <strong>psicologia</strong> razionale, l’analisi delle facoltà conoscitivegià svolta <strong>in</strong> sede di <strong>psicologia</strong> empirica, cercando il punto didiscrim<strong>in</strong>e tra quelle sensitive e quelle razionali. Compare qui, allora,una questione ancora oggi “classica” nel dibattito sulla razionalità a-nimale, e cioè quella del rapporto fra razionalità e possesso del l<strong>in</strong>guaggio,che <strong>Wolff</strong> affronta sulla scorta di una concezione puramentestrumentale e comunicativa delle attività l<strong>in</strong>guistiche. In altri term<strong>in</strong>i:per <strong>Wolff</strong> l’uso della ragione viene soltanto agevolato dal l<strong>in</strong>guaggio(DM §§ 865-868), al pari che da altre tecniche, basate magari sull’usodelle sole facoltà estetiche. Sicché non ritiene corretto affermare pregiudizialmenteche gli animali non pensano perché non hanno l<strong>in</strong>guaggio– mentre ritiene corretto affermare che, visto che gli animal<strong>in</strong>on parlano, è possibile <strong>in</strong>ferirne che non pensano <strong>in</strong> senso proprio.E, mettendosi su questa via, allestisce un curioso argomento che negaagli animali una perfezione delle facoltà <strong>in</strong>tellettive sufficiente all’eserciziodella ragione.esempio, la dist<strong>in</strong>zione tra “coloro che hanno la direzione nelle s<strong>in</strong>gole arti” e i semplici“manovali”, che “agiscono, ma senza sapere ciò che fanno, così come agiscono alcuniesseri <strong>in</strong>animati, ad es., così come il fuoco brucia: ciascuno di questi esseri <strong>in</strong>animati agisceper un certo impulso naturale, e i manovali agiscono per abitud<strong>in</strong>e” (981a 31 - 981b5) – che vale a caratterizzare la conoscenza istorica. O, ancora, l’affermazione che “nessunasensazione è sapienza: <strong>in</strong>fatti, se anche le sensazioni sono, per eccellenza, gli strumentidi conoscenza dei particolari, non ci dicono, però, il perché di nulla: non dicono,ad es., perché il fuoco è caldo, ma solamente segnalano il fatto che è caldo” (981b 10-14) – che vale a caratterizzare come estetica la conoscenza istorica.99
Poiché gli animali variano pochissimo le loro voci allo scopo di <strong>in</strong>dicare<strong>qualcosa</strong> che tocchi il loro stato, e anzi non li si possono udire emettere deiveri e propri suoni modulati (Töne) mediante cui siano soliti <strong>in</strong>dicare le coseche si rappresentano, se ne può dedurre che, trovandosi [<strong>in</strong> essi] anima ecorpo <strong>in</strong> un’armonia costante (cfr. DM §§ 765, 789), [gli animali] non riflettonomolto sulle loro sensazioni e immag<strong>in</strong>azioni e non vi prestano grandeattenzione (cfr. DM § 272), per cui manca loro quella dist<strong>in</strong>zione che vienerichiesta per ragionare (cfr. DM §§ 865, 866). Per questo motivo, dunque,non è possibile attribuire loro ragione (DM § 869).In ogni caso, il possesso di immag<strong>in</strong>azione e memoria da parte deglianimali appare una verità garantita dalla certezza delle conoscenzeempiriche.Ad es., se si è bastonato un cane, questo ha veduto il bastone e ha avvertitoil colpo, dunque ha avuto due sensazioni contemporaneamente. Se si tornaad alzare il bastone verso di esso, il cane lo vede, per cui viene nuovamentesuscitata una di quelle medesime sensazioni. Poiché ora prende a guaire e<strong>in</strong>izia a correre, da ciò non è possibile dedurre altro, se non che torna arappresentarsi contemporaneamente i colpi e ricorda di averli avvertiti <strong>in</strong>precedenza (DM § 870).Dal comportamento dell’animale, dunque, è possibile <strong>in</strong>ferire lasua capacità di realizzare connessioni (che sul piano genetico-psicologicosi qualificano come associative) del tipo “circostanza → caso”; asua volta, la capacità di formare i due term<strong>in</strong>i così associati appare riposaresulla sola capacità di percepire e riconoscere, ossia di acquisiresensazioni e immag<strong>in</strong>i fantastiche. Tale possesso delle facoltà esteticheelementari spiega, <strong>in</strong>oltre, il successo delle pratiche di ammaestramentodegli animali a compiere azioni che sembrano necessitaredi <strong>in</strong>telletto – apparenza che è <strong>in</strong> realtà erronea (DM § 871), giustaquesta argomentazione:poiché, ora, la capacità di attendersi casi simili non richiede altro se nonsensi, immag<strong>in</strong>azione e memoria, ma non l’<strong>in</strong>telletto (cfr. DM § 376), è possibileattribuirla anche agli animali (cfr. DM § 870). Ora, essendo tale aspettativaanaloga <strong>in</strong> <strong>qualcosa</strong> alla ragione, gli animali possiedono <strong>qualcosa</strong> dianalogo alla ragione, benché non tutti nello stesso grado, così come pure tra100
gli uom<strong>in</strong>i la ragione non è distribuita <strong>in</strong> modo uniforme. L’esempio del cane,addotto <strong>in</strong> precedenza (cfr. DM § 870), può essere utile anche qui: e nerisulta <strong>in</strong> modo del tutto chiaro che l’aspettativa di casi analoghi è analogaalla ragione. Poiché, ora, la ragione è <strong>in</strong>telligenza del nesso fra le verità (cfr.DM § 368), mentre l’aspettativa di casi simili rappresenta ugualmente alcun<strong>in</strong>essi tra le cose – come è per il cane tra la visione del bastone, i colpi e i doloricausati (cfr. DM § 870) –, [tale aspettativa] è analoga alla ragione sottoquesto rispetto (cfr. DM § 18) ed è, per così dire, il grado <strong>in</strong>fimo della ragione,ovvero il grad<strong>in</strong>o più prossimo sulla scala che porta alla ragione, ovverol’<strong>in</strong>izio della ragione. Tuttavia, poiché gli animali non compiono mai alcunprogresso, rimangono sempre fermi sul grad<strong>in</strong>o più basso (DM § 869).Quel che va però notato è uno slittamento term<strong>in</strong>ologico, cheporta <strong>Wolff</strong> dal negare agli animali la piena ragione al negare lorol’<strong>in</strong>telletto. Tale slittamento non va affatto sottovalutato, e non soloperché sarà solo la tesi della mancanza di ragione che gli permetteràdi negare agli animali il libero arbitrio (DM §§ 888-891), ma soprattuttoperché negare loro precisamente l’<strong>in</strong>telletto gli rende possibile ladef<strong>in</strong>itiva spiegazione della differenza tra razionalità umana e irrazionalitàanimale – fatta salva la spiegazione della capacità di previsionesulla sola base del possesso di facoltà estetiche. Riassumendo <strong>in</strong>fattitutte le analogie e le differenze che <strong>in</strong>tercorrono tra gli animali el’uomo, <strong>Wolff</strong> conclude affermando che “l’anima dell’uomo è differentedall’anima degli animali pr<strong>in</strong>cipalmente per l’<strong>in</strong>telletto, cioè peravere rappresentazioni dist<strong>in</strong>te anche di cose particolari” (DM § 892),ossia quelle implicate nei fenomeni più semplici dell’aspettativa di casisimili. Appare tuttavia dogmatica la successiva affermazione secondocui la dist<strong>in</strong>zione rappresentativa, pur risultando da una crescentechiarezza (DM § 893), sarebbe non solo una differenza di grado,bensì di essenza (DM § 894) – affermazione della cui problematicitàpare accorgersi lo stesso <strong>Wolff</strong> 99 .99 Cfr. DM § 895: “Si potrebbe tuttavia dire che, se la differenza tra i gradi della forzarappresentativa comporta una differenza di essenza, allora anche l’anima di un uomodovrebbe essere essenzialmente diversa dall’anima di un altro uomo, e anzi, <strong>in</strong> tal modo,l’anima di uno stesso uomo a una certa distanza di tempo dovrebbe essere diversa da sestessa” – ma <strong>Wolff</strong> risolve così la questione: “non ogni [differenza di] grado può risultare<strong>in</strong> una differenza essenziale, bensì soltanto un[a differenza di] grado tale da mutarecomplessivamente l’<strong>in</strong>tera forza rappresentativa”. E non si tratta di una questione di101
Ma, soprattutto, non può risultare bene giustificata la totale equiparazionedelle differenze “esperienza / ragione” e “facoltà estetiche/ <strong>in</strong>tellettuali”. Infatti, la differenza “esperienza / ragione” r<strong>in</strong>via auna differenza di livello propriamente epistemologico (qualitativo,cioè, e non solo genetico) fra i nessi rappresentativi rispettivamentecolti dai due tipi di conoscenza. Qui si hanno, da un lato (cioè perl’esperienza, e dunque per il fenomeno dell’attesa di casi simili), s<strong>in</strong>goleverità strutturate secondo il nesso di concomitanza “occasione→ caso”, mentre dall’altro si hanno nessi fra s<strong>in</strong>gole verità, che hannouna funzione di leggi esplicative universali rispetto alle s<strong>in</strong>gole veritàdi esperienza. Invece, la differenza “facoltà estetiche / <strong>in</strong>tellettuali”r<strong>in</strong>via, su un piano metafisico e genetico, a una diversità di dotazionipsicologiche capace di dare ragione (ma quanto problematicamentelo si è appena visto) della prima differenza. Sicché, <strong>in</strong> ultimaistanza, è una circostanza reale, ma di fatto (conoscibile dunque a posteriori,<strong>in</strong> sede di <strong>psicologia</strong> empirica), quella che viene <strong>in</strong>vocata da<strong>Wolff</strong> per dare conto di una dist<strong>in</strong>zione fra due tipi di conoscenza –la quale risulta una dist<strong>in</strong>zione, a sua volta, di fatto e graduale, piuttostoche essenziale e di diritto come vorrebbe. E <strong>in</strong> questa debolezzache riguarda ugualmente l’epistemologia e la metafisica wolffiane affonderannole critiche di molti: <strong>in</strong> primo luogo (primo senz’altro pernotorietà) quelle di Kant.poco conto: su di essa riposa, <strong>in</strong>fatti, la dist<strong>in</strong>zione gerarchica tra anime e spiriti sviluppataai §§ 896-902, che comprende un’aperta critica (§ 898) alla monadologia di Leibniz.102
V – Fallacie e antifallacie dell’analogon rationis[…] la sensazione e l’<strong>in</strong>telligenza non sono la stessa cosa, giacchédi quella partecipano tutti gli animali, e di questa pochi.Quanto al pensiero (che <strong>in</strong>clude quello retto e quello non retto[…]), neppure esso è la stessa cosa che la sensazione. In effettila percezione dei sensibili propri è sempre vera ed appartiene atutti gli animali, mentre si può pensare anche falsamente, ed ilpensiero non si trova se non <strong>in</strong> chi è fornito di ragione.Aristotele, De anima III,427b (trad. Movia)Per <strong>in</strong>contrare un netto rifiuto di ciò che sta alla base della teoriadell’“analogon rationis” non occorre andare molto più <strong>in</strong> là dell’orizzontestorico del wolffismo: come fortunato tentativo di smontarla,sarebbe più che sufficiente citare già la critica di Hume alle ontologierealistiche, <strong>in</strong> quanto legata a doppio filo allo sviluppo di una gnoseologiaradicalmente empiristica. Tuttavia, ancora più <strong>in</strong>teressante apparela critica di Kant, <strong>in</strong> quanto tentativo (ancora più fortunato) di superamento,<strong>in</strong> un colpo solo, sia del “dogmatismo” wolffiano, sia dello“scetticismo” humeano.1. Esperienza delle leggi o leggi dell’esperienzaLa concezione di una capacità semplicemente “estetica” di prevedereeventi futuri – da considerarsi, come tale, condivisa da tutti gli esserisenzienti – non appariva esaurientemente analizzata da <strong>Wolff</strong> e, comesi è visto, conosce grazie a Baumgarten ulteriori e abbondanti sviluppi.Rispetto a essa, Kant argomenterà però il trattarsi non di una facoltàconoscitiva analoga a quelle della conoscenza razionale, bensì di unafalsa apparenza di capacità conoscitiva, giacché ogni capacità di previsione(e a maggior ragione ogni capacità di previsione argomentativa)richiederebbe di necessità l’<strong>in</strong>tervento di facoltà logiche, le quali trascendonoquelle di sentire e di tenere una traccia riconoscibile di ciò103
che è già stato percepito <strong>in</strong> passato. Il punto di attacco della sua criticanon si circoscrive però a una “mantica estetica” come quella previstada Baumgarten 100 : le obiezioni di Kant vanno più <strong>in</strong> profondo eriguardano più <strong>in</strong> generale la nozione di esperienza adottata da <strong>Wolff</strong>,precisamente muovendo dalla necessità di “separare con sicurezzauna conoscenza pura da una conoscenza empirica” (KrV, B 3). PerKant un criterio di tale differenza consiste nel fatto che “l’esperienzaci <strong>in</strong>segna il modo <strong>in</strong> cui una cosa è fatta, ma non che essa non puòessere fatta diversamente” (ibidem). La conoscenza genu<strong>in</strong>a, per Kant– che rigetta <strong>in</strong> tal modo la dist<strong>in</strong>zione e gradazione tra cognizioneempirica e cognizione razionale come posta da <strong>Wolff</strong> –, è sempre caratterizzabile,prima ancora che nei term<strong>in</strong>i di una conoscenza positivadel “perché”, nei term<strong>in</strong>i della sua universalità e necessità (ovveroda una validità a priori): e da questo punto di vista “l’esperienza nonconferisce mai ai suoi giudizi un’universalità autentica e rigorosa, masemplicemente un’universalità presunta e comparativa (per <strong>in</strong>duzio-100 In realtà, nei §§ 35-36 della Antropologia pragmatica (dedicati rispettivamente alla “praevisio”e alla “facultas div<strong>in</strong>atrix”) sarebbe possibile <strong>in</strong>dividuare proprio un attacco diquesto tipo. Mentre <strong>in</strong>fatti la “capacità di prevedere” viene descritta esattamente neiterm<strong>in</strong>i di un “analogon rationis” (“la previsione empirica è l’attesa di casi simili […] e nonha bisogno di alcuna nozione razionale di cause e di effetti, ma solo del ricordo di avvenimentiosservati, come essi comunemente si susseguono”; <strong>in</strong> particolare, l’“anticipazione[praesagitio]” esprime addirittura “una coscienza del futuro prodotta dalla riflessionesulla legge della concatenazione degli avvenimenti fra loro, o della legge della causalità”,ibidem, § 35), quella di un “dono della div<strong>in</strong>azione” viene denunciata come una nozionedel tutto illusoria. Viene, <strong>in</strong>somma, <strong>in</strong>trodotta una dist<strong>in</strong>zione rigorosa tra “prevedere,predire e <strong>in</strong>dov<strong>in</strong>are” (il primo risulta “fondato sulle leggi dell’esperienza”, ma ilsecondo è un “prevedere contrariamente alle leggi note dell’esperienza” e il terzo, addirittura,viene ritenuto “un’ispirazione derivante da una causa diversa dalla natura”, ibidem,§ 36) – sicché “gli astrologi e i cercatori di tesori, a cui si possono aggiungere glialchimisti, fra tutti i quali emergono nell’antichità greca la Pizia e ai nostri tempi il miserabilesciamano della Siberia” (ibidem) vengono piuttosto assimilati al fenomeno dellapossessione entusiastica (su questo tema, mi permetto di rimandare a KOBAU 2001).Tuttavia, data la natura dell’opera, <strong>in</strong> questa sede non viene fornita una critica esaurientealla gnoseologia e, soprattutto, all’ontologia del wolffismo, né tantomeno una teoria aessa alternativa – potendosi anzi rilevare che anche qui, tanto quanto nel § 147 della Filosofiagenerale di Baumgarten (cfr. supra, pp. 84-85), la progressione dei temi ricalca quelladella <strong>psicologia</strong> empirica wolffiana come consegnata alla Metafisica tedesca (posta al § 7l’opposizione tra sensibilità e <strong>in</strong>telletto, Kant procede <strong>in</strong>fatti trattando della sensibilità,dell’immag<strong>in</strong>azione, della capacità di rappresentarsi passato e futuro, della “facultas signatrix”,per passare qu<strong>in</strong>di alle facoltà di conoscere superiori).104
ne), sicché si deve propriamente dire: stando a quanto abbiamo f<strong>in</strong>oraosservato, non risulta alcuna eccezione a questa regola” (B 3-4).L’assunzione della critica humeana alla generalizzazione <strong>in</strong>duttivadi s<strong>in</strong>goli casi sembra però sposarsi <strong>in</strong> Kant con l’osservazione lasciatacadere da <strong>Wolff</strong> nella Logica tedesca (Cap. V, § 11) relativamente allaproblematicità del passaggio dai giudizi di esperienza alla conoscenzadi leggi necessarie (cfr. supra, ppp. 96-97) – e porta così a denunciarel’<strong>in</strong>consistenza della nozione di “universalità empirica”, la quale nonsarebbe altro se non “un’estensione arbitraria <strong>in</strong> fatto di validità, daquella che poggia sul maggior numero di casi a quella che vale <strong>in</strong> ognicaso, come ad esempio nella proposizione ‘tutti i corpi sono pesanti’”(B 4). Al contrario, un giudizio genu<strong>in</strong>amente universale e necessario“sta a manifestare una fonte particolare di conoscenza” (ibidem) – chenon sarà dunque semplicemente sensibile, né meramente esperienziale.F<strong>in</strong> qui, sembra dunque che <strong>Wolff</strong> sia <strong>in</strong> qualche misura adoperatocontro Hume; ma contro Hume varrà poi ancora il fatto positivo che“è facile mostrare che nella conoscenza umana si danno effettivamentesimili giudizi, necessari e universali”, ad esempio nelle proposizionidella matematica, oppure <strong>in</strong> giudizi metafisici del tipo “ognimutamento deve avere una causa” (ibidem). E questa circostanza apparer<strong>in</strong>tracciabile non solo al livello dei giudizi, ma già a quello deis<strong>in</strong>goli concetti (Kant cita qui ad esempio il concetto empirico dicorpo, o quello di oggetto) 101 – ciò che torna però a <strong>in</strong>teressare <strong>in</strong>tegralmentela nozione wolffiana di esperienza, la quale <strong>in</strong> effetti prevede,come si è visto, i tre casi fondamentali del giudizio sugli oggetti(<strong>in</strong> quanto dotati di attributi), sui loro mutamenti e sui loro effetti sopraaltri oggetti (DL V, § 5).Una più abbondante ripresa di analoghi argomenti, svolti <strong>in</strong> chiavepiù esplicitamente antihumeana, è reperibile nei Prolegomeni, <strong>in</strong> particolarenella “Seconda parte della pr<strong>in</strong>cipale questione trascendentale.Come è possibile la scienza pura della natura?”. In tale contesto, al §18 (Ak IV: 297-298), troviamo una classificazione che dist<strong>in</strong>gue <strong>in</strong>-101 Si noti come Kant esegua qui una sorta di applicazione ante litteram del metodo husserlianodella variazione eidetica: nel suo argomento, se si sottraggono da tali concetti lecomponenti empiriche, si trova che rimangono comunque delle componenti logiche emetafisiche <strong>in</strong>elim<strong>in</strong>abili, e dunque a priori (che sono qui, rispettivamente, lo spazio occupatodal corpo e la sostanzialità dell’oggetto, cfr. B 5-6).105
nanzitutto i giudizi empirici da quelli di esperienza 102 , basata sulla dottr<strong>in</strong>adel necessario concorso di fattori estetici e logici per il darsi diun giudizio genu<strong>in</strong>o 103 . Ma ancora al di sotto dei giudizi empirici Kantcolloca qui i “giudizi percettivi (Wahrnehmungsurteile)”.I giudizi empirici, <strong>in</strong> quanto hanno una validità oggettiva, sono giudizi di esperienza;ma quelli che sono validi soltanto soggettivamente io li chiamo semplici giudizipercettivi. Questi ultimi non richiedono alcun concetto puro dell’<strong>in</strong>telletto,ma soltanto la connessione logica delle percezioni <strong>in</strong> un soggetto pensante.I primi richiedono <strong>in</strong>vece sempre, oltre alle rappresentazioni dell’<strong>in</strong>tuizionesensitiva, anche dei peculiari concetti orig<strong>in</strong>ariamente generati nell’<strong>in</strong>telletto,i quali appunto fanno sì che il giudizio di esperienza sia oggettivamente valido(ibidem, 298).Si potrebbe aprire qui la questione del rapporto fra tali “giudizipercettivi” (si noti la stranezza dell’espressione, almeno per un Kant)e la “s<strong>in</strong>tesi dell’apprensione”, come trattata nella “Deduzione deiconcetti puri dell’<strong>in</strong>telletto” svolta nella prima edizione della primaCritica (A 98-100). La “s<strong>in</strong>tesi dell’apprensione” vi è caratterizzata <strong>in</strong>fatticome un’unificazione che deve poter <strong>in</strong>teressare il molteplice <strong>in</strong>tuitivo(ma anche “rappresentazioni che non sono empiriche”, A 99)prima di ogni ulteriore s<strong>in</strong>tesi, <strong>in</strong> modo da costituirlo come “unità assoluta”del molteplice di una rappresentazione contenuta <strong>in</strong> un istantedato – senza di che “non sarebbe possibile avere a priori rappresentazion<strong>in</strong>é dello spazio né del tempo” (ibidem). Soprattutto, essa sostiene(o, meglio, le è “legata <strong>in</strong>sc<strong>in</strong>dibilmente”) la “s<strong>in</strong>tesi della riproduzione”(o “s<strong>in</strong>tesi riproduttiva della immag<strong>in</strong>azione”, o “facoltàtrascendentale dell’immag<strong>in</strong>azione”), la quale costituisce il “fondamentotrascendentale della possibilità di ogni conoscenza <strong>in</strong> generale(non solo delle empiriche, ma anche delle [conoscenze] pure a priori)”102 Contro una delle dottr<strong>in</strong>e basilari di <strong>Wolff</strong> qui pert<strong>in</strong>enti, Kant aveva già affermato:“benché tutti i giudizi di esperienza siano empirici, cioè abbiano il proprio fondamentonella percezione immediata dei sensi, <strong>in</strong>versamente, non tutti i giudizi empirici sono perquesto giudizi di esperienza” (B 297).103 E aggiunge: “all’elemento empirico e <strong>in</strong> generale al dato dell’<strong>in</strong>tuizione sensitiva devonoancora aggiungersi alcuni speciali concetti che hanno la propria orig<strong>in</strong>e <strong>in</strong> mododel tutto a priori nell’<strong>in</strong>telletto puro, ai quali ogni percezione può venire prima sussunta,e poi dunque, per loro mezzo, convertita <strong>in</strong> un’esperienza” (ibidem, 298).106
(A 102). Quanto alle conoscenze empiriche, quest’ultima si <strong>in</strong>carica<strong>in</strong>fatti di regolare nomologicamente le serie delle rappresentazioni <strong>in</strong>quanto, nella loro registrazione e nel loro recupero conoscitivo, taliserie devono poter apparire strutturate – <strong>in</strong> modo tale, fra l’altro, dapoter permettere il fenomeno dell’attesa di casi simili come (<strong>in</strong>sufficientemente)descritto da una <strong>psicologia</strong> associazionistica quale èquella di Baumgarten 104 . La portata della questione è ben <strong>in</strong>tuibile – aogni modo, per gli scopi presenti, ci si accontenterà di rilevare come,secondo uno stile perfettamente idealistico, Kant <strong>in</strong>dividui <strong>in</strong> leggioggettive dell’esperienza ciò che <strong>in</strong> un’ottica realistica apparivano essere(ma troppo problematicamente) leggi oggettive tout court – con il checonverrà ritornare al testo dei Prolegomeni.Solo a partire dai (genu<strong>in</strong>i) giudizi di esperienza, dunque, si ha ache fare con degli oggetti, essendo questi determ<strong>in</strong>ati, precisamente,non da pr<strong>in</strong>cipi e caratterizzazioni ontologiche reperibili <strong>in</strong> ogni sempliceesperienza <strong>in</strong> quanto mera credenza, bensì dal valore universalee necessario dei giudizi che si possono emettere sopra di essi 105 . Conle parole di Kant:104 Ciò risulta <strong>in</strong> un celebre passo della prima Critica: “Certamente non è che una leggeempirica, quella secondo cui le rappresentazioni che si accompagnano o susseguonosovente f<strong>in</strong>iscono per associarsi tra loro, connettendosi <strong>in</strong> modo che, anche quandomanchi l’oggetto, una di queste rappresentazioni fa passare l’animo a un’altra, secondouna regola costante. Ma questa legge della riproduzione presuppone che i fenomenistessi sottostiano effettivamente a una regola del genere e che nel molteplice delle lororappresentazioni si dia una concomitanza o una successione conforme a certe regole; se<strong>in</strong>fatti le cose stessero diversamente, la nostra immag<strong>in</strong>azione empirica non sarebbe maiposta <strong>in</strong> grado di fare alcunché di conforme alle sue capacità e rimarrebbe pertanto nascostanel nostro animo come una potenzialità morta e sconosciuta a noi stessi. Se ilc<strong>in</strong>abro fosse ora rosso e ora nero, ora leggero, e ora pesante; se un uomo si trasformasseora nella figura di un animale, ora <strong>in</strong> quella di un altro […], senza che sussistesse unaregola precisa a cui i fenomeni fossero come tali sottoposti, nessuna s<strong>in</strong>tesi empiricadella riproduzione potrebbe avere luogo. Deve dunque sussistere <strong>qualcosa</strong> che, da partesua, <strong>in</strong> quanto fondamento a priori dell’unità s<strong>in</strong>tetica dell’appercezione, renda possibilequesta riproduzione dei fenomeni” (A 100-101).105 Al successivo § 19 Kant precisa <strong>in</strong>oltre che emettendo un giudizio oggettivo riconosciamoun oggetto “dal valore universale e necessario della connessione fra le percezionidate; e poiché questo è il caso per tutti gli oggetti dei sensi, allora i giudizi di esperienzaricaveranno la loro validità oggettiva non dalla conoscenza immediata dell’oggetto (ciòche è impossibile), bensì soltanto dalla condizione del valore universale dei giudizi empirici:che, come si è già detto, non si fonda mai su condizioni empiriche e <strong>in</strong> generalesensibili, bensì su un concetto puro dell’<strong>in</strong>telletto” (ibidem, 298-299).107
Tutti i nostri giudizi sono <strong>in</strong> un primo momento semplici giudizi percettivi:essi valgono soltanto per noi, cioè per noi <strong>in</strong> quanto s<strong>in</strong>goli soggetti, e soltanto<strong>in</strong> seguito assegniamo loro una nuova relazione, quella cioè con unoggetto, e vogliamo qu<strong>in</strong>di che [il primo giudizio] debba essere valido pernoi sempre, nonché per ogni altro uomo; <strong>in</strong>fatti, quando un giudizio si accordacon un oggetto, tutti i giudizi circa il medesimo oggetto devono ancheconcordare tra loro, sicché la validità oggettiva del giudizio di esperienza nonsignifica altro se non la sua validità necessaria e universale (Ak IV: 298).E qui Kant fa cadere il primo di una serie di ulteriori chiarimentidecisivi per la nostra questione.Che la stanza sia calda, lo zucchero dolce, l’assenzio disgustoso, sono giudizivalidi soltanto soggettivamente, giacché io non pretendo di doverli riteneresempre veri e che ogni altro li debba ritenere tali, ma esprimono soltantouna relazione fra due sensazioni per un medesimo soggetto, cioè per mestesso nel mio attuale stato percettivo, e non devono perciò valere ancheper l’oggetto: tali giudizi io li chiamo percettivi (ibidem, 299).Gli esempi qui <strong>in</strong>vocati presentano di certo alcune difficoltà 106 . Aogni modo, a Kant tali esempi sembrano bastanti per sostenere chenel giudizio di esperienza le cose stanno <strong>in</strong> modo affatto diverso. Ciò chel’esperienza mi <strong>in</strong>segna <strong>in</strong> certe circostanze, deve <strong>in</strong>segnarlo sempre, a me ead ogni altro […] quando p. es. dico: “l’aria è elastica”, <strong>in</strong> un primo momentoquesto giudizio è soltanto percettivo, cioè mi limito a riferire l’una all’altradue impressioni che ho presenti ai miei sensi. Ma se voglio che venga chiamatogiudizio di esperienza, pretendo <strong>in</strong>oltre che questa connessione siasottoposta a una condizione tale da renderlo valido universalmente (ibidem).106 Di cui pare ben consapevole lo stesso Kant, che precisa <strong>in</strong> una nota: “Ammetto volentieriche questi esempi non rappresentano giudizi percettivi che potrebbero mai diventaregiudizi di esperienza, anche qualora vi si aggiungesse un concetto <strong>in</strong>tellettivo;<strong>in</strong>fatti, si riferiscono soltanto al sentimento, di cui ognuno riconosce il carattere meramentesoggettivo e che qu<strong>in</strong>di non può mai venire riferito all’oggetto, e dunque nonpossono mai diventare oggettivi […] Un esempio di giudizi percettivi che diventanogiudizi di esperienza mediante l’aggiungersi di un concetto <strong>in</strong>tellettivo seguirà nella prossimanota” (ibidem). E si osservi, oltretutto, come tale tipo di giudizi presenti caratteristicheproprie del giudizio estetico, come del<strong>in</strong>eate nella terza Critica.108
Su queste basi, al § 20 dei Prolegomeni viene offerta un’ulterioreanalisi della “esperienza <strong>in</strong> generale” (ibidem, 300), <strong>in</strong> cui emerge ancormeglio il ruolo universalizzante della coscienza – o, meglio, dell’attribuzionedel giudizio a una possibile coscienza <strong>in</strong> generale – per laformulazione di un giudizio di esperienza genu<strong>in</strong>o. Ciò permette aKant di rilevare che “per avere un’esperienza non è sufficiente, comecomunemente si immag<strong>in</strong>a, confrontare delle percezioni e collegarle <strong>in</strong>una coscienza per mezzo del giudizio” (ibidem), per poi concludere cheprima che dalla percezione possa nascere l’esperienza, occorre ancora ungiudizio di tutt’altro tipo. L’<strong>in</strong>tuizione data deve venire sussunta sotto unconcetto, il quale determ<strong>in</strong>a la forma del giudicare <strong>in</strong> generale rispettoall’<strong>in</strong>tuizione, collega la coscienza empirica di quest’ultima a una coscienza<strong>in</strong> generale e, così, conferisce validità universale ai giudizi empirici; tale concettoè un concetto puro dell’<strong>in</strong>telletto, a priori, un concetto che non servead altro se non a determ<strong>in</strong>are <strong>in</strong> generale, per un’<strong>in</strong>tuizione, il modo <strong>in</strong> cuiquesta possa venire impiegata nei giudizi (ibidem).Segue poi un’esemplificazione svolta rispetto al concetto di causa,<strong>in</strong> quanto utilizzato <strong>in</strong> un giudizio come “l’aria è elastica” – ma, <strong>in</strong>una nota, Kant aggiunge un ulteriore esempio, dichiarando di volereaddurre un caso “più facile a comprendersi” del precedente 107 . Si tratta,<strong>in</strong> effetti, di un esempio del tutto simile a quelli tipicamente addottida <strong>Wolff</strong>, e che tende a chiarire meglio il ruolo della differenza trarapporti di associazione psicologica, successione percepibile e relazionecausale <strong>in</strong>tesa <strong>in</strong> senso proprio.Quando il sole irradia la pietra, questa diventa calda. Questo è un puro giudiziopercettivo e non contiene alcuna necessità, per quanto spesso io (emagari con me altri <strong>in</strong>dividui ancora) abbia percepito la stessa cosa; tali percezionisi trovano connesse così <strong>in</strong> maniera soltanto abituale. Ma quandodico: Il sole riscalda la pietra, alla percezione si aggiunge il concetto <strong>in</strong>tellettivodi causa che connette mediante un legame necessario il concetto del calorecon quello del chiarore solare; il giudizio s<strong>in</strong>tetico diventa così necessa-107 Facendo seguito, <strong>in</strong> realtà, a una diversa promessa, data nella nota al § 19 appena citata(cfr. supra, la nota immediatamente precedente a questa).109
iamente universale, e di conseguenza oggettivo, e si trasforma da una percezione<strong>in</strong> un’esperienza (ibidem, 301).Si osservi, allora, come la formula “per abitud<strong>in</strong>e” riferita alla(pseudo)conoscenza del giudizio percettivo valga qui come un “difatto” – ovvero un “doxasticamente” – laddove il richiamo all’oggettivitàpropria del giudizio di esperienza genu<strong>in</strong>o sostituisce e assorbela teoria wolffiana della conoscenza razionale, già dist<strong>in</strong>ta da quellaempirica. E questo giustifica, al successivo § 21, la nuda esposizionedelle tre tavole con cui Kant <strong>in</strong>tende presentare <strong>in</strong> modo completo“ciò che pertiene al giudicare <strong>in</strong> generale” (ibidem, 302). Di queste, lapiù <strong>in</strong>teressante è per noi la terza, che succede alla “Tavola logica deigiudizi” e alla “Tavola trascendentale dei concetti <strong>in</strong>tellettivi”, ossia la“Tavola fisiologica pura dei pr<strong>in</strong>cipi universali della scienza della natura”(ibidem, 303).anticipazioni dellapercezioneassiomi dell’<strong>in</strong>tuizionepostulati del pensieroempirico <strong>in</strong> generale110analogiedell’esperienzaQuesta tavola si limita a r<strong>in</strong>viare direttamente alla Sezione III delCapitolo II (“Sistema di tutti i pr<strong>in</strong>cipi dell’<strong>in</strong>telletto puro”) della“Dottr<strong>in</strong>a trascendentale degli elementi”, dedicata alla “Rappresentazionesistematica di tutti i pr<strong>in</strong>cipi s<strong>in</strong>tetici dell’<strong>in</strong>telletto puro” (KrV,A 159ss. / B 198ss.). Di essa, per la nostra questione importerannoparticolarmente le tre “Analogie dell’esperienza” e, più <strong>in</strong> particolareancora, dato il suo valore s<strong>in</strong>tomatico, la seconda, dedicata al pr<strong>in</strong>cipiodi causalità 108 . In base a tale pr<strong>in</strong>cipio, perché si dia esperienzadobbiamo presupporre che ogni evento sia determ<strong>in</strong>ato da un eventoche lo precede <strong>in</strong> base a una legge causale.108 In realtà, rispetto al tema della critica della nozione wolffiana di esperienza, sonocentrali tutte e tre queste “analogie” – la prima è <strong>in</strong>fatti dedicata al problema della persistenzadella sostanza soggiacente al mutamento fenomenico, la terza a quello dell’universalitàdel rapporto di azione reciproca fra le sostanze –, se si considera appunto comei giudizi di esperienza si applich<strong>in</strong>o per <strong>Wolff</strong> <strong>in</strong>nanzitutto agli “oggetti”, qu<strong>in</strong>di ailoro mutamenti e, <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e, agli effetti che essi esplicano vicendevolmente l’uno sull’altro(DL V, § 5).
Ma si badi: per Kant, non tanto occorre determ<strong>in</strong>are causalmentel’ord<strong>in</strong>e temporale di una s<strong>in</strong>gola serie di rappresentazioni per poterpercepire un s<strong>in</strong>golo evento come tale (ad esempio, posso bene limitarmia immag<strong>in</strong>are un evento causalmente determ<strong>in</strong>ato), bensì occorreapplicare lo schema causale alla totalità degli eventi, cioè <strong>in</strong>serireogni s<strong>in</strong>golo evento all’<strong>in</strong>terno di una legge di determ<strong>in</strong>azione universalee necessaria. Solo <strong>in</strong> questo modo è possibile dist<strong>in</strong>guereun’esperienza reale da un mero fenomeno, che potrebbe come talefar parte anche di un mondo di illusioni o di sogni. In assenza dellaseconda analogia, dunque, non tanto saremmo abbandonati a unmondo di fenomeni caotico e <strong>in</strong>forme (ad esempio, non è necessariamentetale un mondo semplicemente immag<strong>in</strong>ario, <strong>in</strong> cui possonovalere benissimo s<strong>in</strong>goli rapporti di dipendenza causale), quanto piuttostonon esperiremmo propriamente un mondo 109 .Ma questo, soprattutto, va <strong>in</strong>teso per Kant nel senso che il bisognodi presupporre la determ<strong>in</strong>azione causale di ogni evento riposa, asua volta, sul bisogno di imporre epistemologicamente un ord<strong>in</strong>etemporale necessario e irreversibile alle diverse rappresentazioni deglistati degli oggetti – un ord<strong>in</strong>e sensibile, dunque, che può ricevere formaoggettiva soltanto da una determ<strong>in</strong>azione <strong>in</strong>tellettiva. Kant fornisceallora un argomento composto di due passi dist<strong>in</strong>ti: 1) la percezionedi un mutamento oggettivo richiederebbe la percezione di duefenomeni diversi <strong>in</strong> una successione necessaria, ma è possibile rappresentarsidue fenomeni diversi secondo un ord<strong>in</strong>e arbitrario, né iltrascorrere del tempo viene percepito per se stesso come oggettivo.Dunque, è erroneo il vocabolario che consente di parlare della “percezione”di un mutamento oggettivo. Tuttavia 2) una relazione temporaleoggettiva può essere effettivamente conosciuta, purché io pensiche due eventi si susseguono <strong>in</strong> maniera necessaria 110 .109 Cfr., <strong>in</strong> proposito, le precisazioni anteposte (A 189-190 / B 234-235) all’<strong>in</strong>troduzionedel celebre esempio della casa di cui si possono rappresentare le s<strong>in</strong>gole parti secondouna successione non determ<strong>in</strong>ata da alcuna regola v<strong>in</strong>colante.110 Questo capitolo centrale della prima Critica presenta, chiaramente, diversi lati problematici,la cui trattazione <strong>in</strong> chiave analitica è matura già da parecchi anni; per una rassegna,cfr. CLEVE (1973), DRYER (1984). In particolare, sul problema del riferirsi delleanalogie dell’esperienza alla conoscenza <strong>in</strong> generale oppure a quella scientifica (doxasticao epistemica) cfr. FRIEDMAN (1994); sul loro rapporto con la deduzione trascendentalecfr. THÖLE (1991).111
Come allora mette <strong>in</strong> luce (tra i tanti) R.P. WOLFF (1963: 264-68),l’argomento kantiano complessivo si basa sulla differenza tra un ord<strong>in</strong>eoggettivo (logico-causale) delle rappresentazioni e un qualsiasiloro ord<strong>in</strong>e soggettivo (o di mera successione, quale è generabile <strong>in</strong>modo arbitrario dalla facoltà dell’immag<strong>in</strong>azione). Andando più dappressoal testo kantiano si trovano, però, diverse oscillazioni nella dist<strong>in</strong>zionetra ord<strong>in</strong>e della successione temporale e ord<strong>in</strong>e della dipendenzacausale 111 – delle quali una è per noi di particolare <strong>in</strong>teresse. Lasi trova quando Kant precisa che non appena “percepisco, o presumo”che nella successione delle rappresentazioni ha luogo “un rapportocon uno stato precedente, tale che da esso derivi la rappresentazionesecondo una regola, allora <strong>qualcosa</strong> viene rappresentato comeun evento” (A 198 / B 243). La spia verbale del problema sta <strong>in</strong> quel“non appena scorgo, ovvero presumo (so bald ich wahrnehme oder vorausannehme)” riferito all’atto di <strong>in</strong>tendere il nesso di dipendenza (logicotemporale)tra due eventi. Ecco <strong>in</strong>fatti il punto: un conto è affermareche l’esperienza (genu<strong>in</strong>amente percettiva) di rapporti causali è determ<strong>in</strong>abile<strong>in</strong> term<strong>in</strong>i logici (e questo lo si può fare, come fa <strong>Wolff</strong>,anche presupponendo che la nozione ontologica di evento implichi ilsuo <strong>in</strong>serirsi <strong>in</strong> una connessione causale ed entro una serie temporaleirreversibile); ma altro conto è assumere che, effettivamente, nell’esperienzala percezione di un evento richieda la precognizione diun nesso causale entro un rapporto di successione temporale, che neverrà qu<strong>in</strong>di determ<strong>in</strong>ato come oggettivo. Nel secondo caso, ci si trovapalesemente d<strong>in</strong>anzi a un’affermazione di tutt’altro impegno metafisico,giustificato da motivi strettamente epistemologici, specie rispettoai risvolti psicologici del problema.111 Cfr. (A 199 / B 244): “Ora, se costituisce una legge necessaria della nostra sensibilità,e perciò una condizione formale di tutte le percezioni, il fatto che il tempo precedente [sic!]determ<strong>in</strong>i necessariamente quello che segue […], è anche un’<strong>in</strong>dispensabile legge dellarappresentazione empirica della serie temporale che i fenomeni del tempo passato determ<strong>in</strong><strong>in</strong>oogni esistenza nel tempo successivo e che i fenomeni, come eventi, abbiano luogosoltanto <strong>in</strong> quanto quelli che li precedono determ<strong>in</strong>ano la loro esistenza nel tempo, cioèla stabiliscono <strong>in</strong> base a una regola”. Ma cfr. soprattutto (A 202-203 / B 247-248) ilproblema della possibile simultaneità fra causa ed effetto, risolto da Kant dist<strong>in</strong>guendofra ord<strong>in</strong>e temporale e scorrere del tempo, <strong>in</strong> modo da poter affermare che una relazionetemporale (e causale) si può dare anche senza “scorrimento” temporale.112
A ogni modo, la radicale obiezione kantiana a <strong>Wolff</strong> lascia a suavolta aperto almeno un altro problema, quello cioè da cui si era partiti:come e perché siamo allora disposti a ravvisare (erroneamente, omeno) un’apparenza di pensiero negli animali non umani, ovvero <strong>in</strong>esseri senzienti ma irrazionali? Qui, sarà pert<strong>in</strong>ente andare diritti alragionamento espresso <strong>in</strong> proposito da Kant nella Critica del giudizio(nella nota al § 90, dedicata alla chiarificazione generale del concettodi analogia):confrontando le attività tecniche (Kunsthandlungen) degli animali con quelledell’uomo, pensiamo il fondamento delle prime, che non conosciamo, medianteil fondamento di azioni simili nell’uomo (la ragione), che conosciamo,come un analogon della ragione; e con ciò vogliamo mostrare al contempoche il fondamento dell’<strong>in</strong>dustriosità animale, che va sotto il nome diist<strong>in</strong>to, è <strong>in</strong> realtà diverso dalla ragione, ma ha un rapporto simile con il suoeffetto (come si vede comparando le costruzioni del castoro con quelledell’uomo) (KdU: 449).Sarà utile, allora, sottol<strong>in</strong>eare che la nota qui <strong>in</strong> esame si apre def<strong>in</strong>endol’analogia come “l’identità del rapporto tra ragioni e conseguenze(cause ed effetti) nella misura <strong>in</strong> cui essa ha luogo senza tenerconto della differenza specifica delle cose, o di quelle proprietà <strong>in</strong> sé[…] che contengono la ragione di conseguenze simili” (ibidem, 448) –e prosegue presentando il caso della attribuzione di un “analogo dellaragione” agli animali come caso-tipo del ragionamento analogico che,nella fattispecie, disegna il seguente parallelo:uomo: ragione → azione,animale: ist<strong>in</strong>to → azione.Tale parallelo fra uomo e animale, <strong>in</strong>centrato sull’elemento comunedel loro agire, appare dunque valido – certo, come semplice parallelo– qualora le loro azioni osservabili appaiano f<strong>in</strong>alizzate. Ora, però,per come viene caratterizzato tale ragionamento analogico (cioècome un giudizio di esperienza genu<strong>in</strong>o quanto alla forma, benchéimperfetto quanto ai contenuti), si dovrebbe ricavare immediatamenteche l’attribuzione di facoltà analoghe alla ragione è prerogativa e-113
sclusiva di esseri effettivamente razionali 112 . Kant, poi, <strong>in</strong>tende mettere<strong>in</strong> luce – secondo gli scopi generali della terza Critica – un altro limitedel ragionamento analogico che sarebbe sotteso <strong>in</strong> tali casi, iquali comportano che, pur essendo vietata l’attribuzione positiva diuna ragione agli animali, rimane tuttavia lecito classificare <strong>in</strong>sieme a-nimali e uom<strong>in</strong>i come viventi, dist<strong>in</strong>guendoli dai non viventi, giacchéle loro operazioni osservabili appaiono ugualmente f<strong>in</strong>alizzate <strong>in</strong>quanto guidate da rappresentazioni 113 . Kant prosegue dunque nellanota obiettando chedal fatto che l’uomo per realizzare le proprie costruzioni si serve della ragionenon posso concludere che anche il castoro debba avere una facoltà simile,e chiamare questa una conclusione per analogia. Comparando però le azionidegli animali (di cui non possiamo percepire immediatamente il pr<strong>in</strong>cipio)con quelle simili dell’uomo (di cui siamo immediatamente coscienti)possiamo con tutta esattezza concludere per analogia che anche gli animaliagiscono <strong>in</strong> base a rappresentazioni (non sono macch<strong>in</strong>e, come vuole Cartesio)e, nonostante la differenza specifica, sono identici all’uomo riguardo algenere (<strong>in</strong> quanto esseri viventi) (ibidem, 449).Si osservi, comunque, che tale soluzione (proprio perché basata suun “argomento” analogico) non esclude (non almeno <strong>in</strong> modo deltutto ovvio e l<strong>in</strong>eare) la possibilità di imputare il controllo del comportamentoanimale non a un sistema di rappresentazioni coscienti,elaborate magari <strong>in</strong> maniera “spontanea”, bensì a un sistema di impulsi,congeniti e soprattutto riducibili a circostanze puramente fisi-112 Del medesimo problema, si può ben dire, è tornato ad accorgersi DENNETT (cfr.soprattutto 1978, 1979) non appena imboccata una via per molti versi analoga a quelladi Kant. Ciò potrebbe servire per trovare a Kant una collocazione nel dibattito attualesull’“<strong>in</strong>telligenza animale”, magari svolto alla luce delle teorie della “<strong>psicologia</strong> <strong>in</strong>genua”(<strong>in</strong> proposito, cfr. utilmente GOZZANO, a cura di, 2001; MEINI 2001).113 Si osservi qui la consonanza con Dennett: “Non è che noi attribuiamo (o dovremmoattribuire) credenze o desideri soltanto a cose <strong>in</strong> cui troviamo rappresentazioni <strong>in</strong>terne,ma piuttosto, quando scopriamo un oggetto per il quale funziona la strategia <strong>in</strong>tenzionale,cerchiamo di <strong>in</strong>terpretare alcuni dei suoi stati o processi <strong>in</strong>terni come rappresentazioni<strong>in</strong>terne. Ciò che fa di una caratteristica <strong>in</strong>terna di una cosa una rappresentazionepotrebbe essere solamente il suo ruolo nel regolare il comportamento di un sistema <strong>in</strong>tenzionale”(DENNETT 1979: 53, orig. <strong>in</strong>teramente <strong>in</strong> c.vo). Sulle vicende moderne della<strong>psicologia</strong> motivazionale di impianto aristotelico sottesa a questo modello mi permettodi r<strong>in</strong>viare a KOBAU (2002).114
co-meccaniche 114 . Ma questa è davvero un’altra storia. Ciò che adessobisognerà ancora considerare è se le azioni “guidate da rappresentazioni”,che Kant riconosce agli animali, siano necessariamente, ovvero<strong>in</strong> senso stretto, azioni “guidate da conoscenze”.2. Conoscere significa due coseRispetto a una teoria dell’“analogon rationis” come è quella wolffianarimane dunque da considerare la possibilità di una duplice determ<strong>in</strong>azione,rispettivamente doxastica o epistemica, del fenomenodell’aspettativa di casi simili che essa pretende di spiegare. Ovvero, <strong>in</strong>term<strong>in</strong>i parzialmente equivalenti, si tratta di dist<strong>in</strong>guere fra tale aspettativacome contenuto rappresentativo di una semplice credenza (riferitadunque a una semplice “cosa” dell’ontologia wolffiana) e <strong>in</strong>quanto aspettativa epistemicamente meglio qualificata (caratterizzatacioè nei term<strong>in</strong>i più stretti dell’oggettività kantiana).A tale scopo sembra <strong>in</strong>nanzitutto possibile sfruttare uno spuntoofferto da RYLE (1957), che si misura precisamente con il problemagenerale dello statuto epistemologico delle previsioni. Ryle sottol<strong>in</strong>ea<strong>in</strong>fatti la radicale differenza tra previsioni e <strong>in</strong>ferenze genu<strong>in</strong>e, muovendo<strong>in</strong>nanzitutto dall’osservazione secondo cui non necessariamenteuna previsione è un’<strong>in</strong>ferenza (si pensi a una mera previsione doxastica,non necessariamente vera e non necessariamente giustificatao giustificabile, come ad esempio quella espressa dalla frase “domanipioverà”, se pronunciata quasi a casaccio). D’altro canto, è vero perRyle che non necessariamente un’<strong>in</strong>ferenza è una previsione, essendosufficiente a caratterizzarla il rispetto di criteri epistemologici – e quiviene portato <strong>in</strong> primo piano il caso delle “previsioni” scientifiche 115 .Sul piano strettamente epistemologico, ne deriva allora che non ècompito scientifico quello di prevedere il futuro (tranne che, ma <strong>in</strong>114 Della qual cosa si era già accorto REIMARUS (1760), pur mantenendosi nell’impiantodel wolffismo.115 Queste sono, <strong>in</strong> realtà, comunque <strong>in</strong>ferenze, qualificabili cioè come tali per motivilogico-epistemologici, pur riguardando eventi futuri; la loro unica peculiarità rispetto alle<strong>in</strong>ferenze circa eventi passati o attuali consiste per Ryle nella circostanza della (necessaria)<strong>in</strong>osservabilità del futuro nel presente.115
senso equivoco, per le “scienze applicate”, come ad esempio la meteorologia):le previsioni dello scienziato sono <strong>in</strong> generale previsionipuramente <strong>in</strong>ferenziali del tipo “se → allora”, condizionali e sperimentali,formulate <strong>in</strong> modo neutrale rispetto al tempo – ciò che valeanche quando una teoria appare consolidata e utile a ricavare previsionisfruttabili sul piano tecnico-applicativo.Ryle cont<strong>in</strong>ua poi sviluppando il tema della diversità di previsionie <strong>in</strong>ferenze dal punto di vista dei criteri epistemologici cui le secondedevono necessariamente sottostare a differenza delle prime 116 – dedicandosisempre, <strong>in</strong> primo luogo, al problema della funzione predittivadelle teorie scientifiche. Ciò che a noi <strong>in</strong>teressa, tuttavia, è l’altro voltodi questo problema, non altrettanto dettagliatamente analizzato daRyle, e cioè la possibilità, assunta <strong>in</strong> via prelim<strong>in</strong>are, di considerareriducibili a un livello totalmente doxastico, ossia radicalmente non e-pistemico, le semplici previsioni, pur cont<strong>in</strong>uando a considerarle legittimamentetali.Rispetto al caso della previsione, <strong>in</strong> tal modo, si evidenzia un problemapiù complessivo, che torna cioè a riguardare non il caso specificodelle regolarità esperibili, ma <strong>in</strong>nanzitutto quello della qualità epistemicadi qualsiasi cognizione <strong>in</strong> generale. In tale prospettiva piùampia rientrano svariate discussioni attuali circa il rapporto fra capacitàrappresentative e facoltà di concettualizzazione, spesso <strong>in</strong>centratesul caso del “pensiero animale” – fra cui la meglio riferibile ai term<strong>in</strong>idella critica kantiana a <strong>Wolff</strong> appare quella di Sellars. Come messobene <strong>in</strong> luce da VRIES (1996), nell’ultima fase della sua produzioneSellars <strong>in</strong>troduce <strong>in</strong>fatti una dist<strong>in</strong>zione (tra forma proposizionale e116 In questa prospettiva e dal punto di vista della capacità di previsione, ancora, perRyle è possibile tracciare soltanto una differenza tra teorie “efficienti” (capaci di generare<strong>in</strong>ferenze sperimentali che possono risultare vere) e teorie “vuote” (come ad es. “tuttociò che accade è dovuto al fato”, ibidem). Di conseguenza, sul piano delle s<strong>in</strong>gole previsioni,una mera previsione risulta felice, se semplicemente si rivela vera; mentre si puòdire che un’<strong>in</strong>ferenza formulata mediante un verbo al futuro ha esito positivo – e a treprecise condizioni, cioè se: 1) la conclusione risulta vera, 2) le premesse osservative eranovere, 3) la conclusione tratta da quelle premesse è valida. Si noti però che <strong>in</strong> Ryle il criterio“osservanza / <strong>in</strong>osservanza di criteri epistemologici” non solo si dist<strong>in</strong>gue dalla differenza“successione temporale / consecuzione causale” (lucidamente analizzata negli stessianni, ad es., da AYER, 1956, IV-7), ma <strong>in</strong> qualche maniera la ricomprende – perfettamentenello stile dell’argomento kantiano della seconda “analogia dell’esperienza”.116
forma logica del pensiero) assente nei suoi precedenti lavori dedicatialla critica del comportamentismo, <strong>in</strong> quanto utile a sostenere la possibilitàdi attribuire agli animali un sistema rappresentativo dotato diforma proposizionale. Nei suoi lavori dedicati alle “behavioristics”che vanno dagli anni C<strong>in</strong>quanta ai primi Sessanta, Sellars ritiene <strong>in</strong>fatticomplessivamente che si dia uno strato di attitud<strong>in</strong>i <strong>in</strong>tenzionali,posto fra il livello neurofisiologico e quello comportamentale, <strong>in</strong>dispensabileper la spiegazione del comportamento umano, ma non perquella del comportamento animale, benché un simile modello vengadi fatto adoperato nei ragionamenti di senso comune. E questo lo silegge bene <strong>in</strong> un passo che sembra riprendere esattamente il filo delragionamento kantiano della nota al § 90 della terza Critica.Non solo le <strong>in</strong>gegnose correzioni apportate dagli animali al proprio ambienteci sp<strong>in</strong>gono a dire che essi fanno ciò che fanno perché credono questo, desideranoquello, si aspettano questo e quello ecc., ma siamo anche capaci dispiegare il loro comportamento ascrivendo loro tali credenze, desideri, aspettativeecc. Però – e questo è il punto – ci troviamo sempre a qualificare talispiegazioni <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i che equivarrebbero, nel caso di un soggetto umano,ad ammettere che questi non stava realmente pensando, credendo, desiderandoecc. Infatti, nella spiegazione del comportamento animale la strutturamentalistica viene adoperata come un modello ovvero come un’analogia cheviene modificata e ristretta per adattarsi ai fenomeni che vanno spiegati. Ècome se ci mettessimo a spiegare il comportamento degli oggetti macroscopici,ad es. dei gas, dicendo che sono fatti di m<strong>in</strong>uscole palle da biliardoche rimbalzano l’una sull’altra, e poi ci trovassimo costretti ad aggiungere:“però, ovviamente…” (SELLARS 1957: 527).L’argomentazione di Sellars appare del tutto simile a quelle cheverranno imposte poi da DENNETT (1993) nel dibattito sull’<strong>in</strong>tenzionalità– ma con una differenza importante, che consiste nel conservareuno scarto nel rapporto (e nell’<strong>in</strong>terpretarlo <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i di analogia)fra soggetti umani, che si vivono immediatamente come capaci di cognizionirappresentative che sostengono delle prassi, e menti animali.Tuttavia, qui il passaggio dalla posizione realistica di un meccanismocognitivo analogo alla ragione alla lettura analogica dei comportamentidi esseri non umani “come se” fossero razionali non rilanciasemplicemente l’ultimo problema di Kant: pone, anzi, <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i nuo-117
vi il problema di come <strong>in</strong>tendere l’analogia, dato che per la determ<strong>in</strong>azionedel “pensiero” come suo term<strong>in</strong>e proprio sembra irr<strong>in</strong>unciabileuna sua caratterizzazione <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i logico-l<strong>in</strong>guistici, e non soltantopsicologico-trascendentali (cfr. SELLARS 1967). Più <strong>in</strong> particolare,la “lettura analogica” del comportamento animale che si dà nelsenso comune si presenta <strong>in</strong> realtà, nel primo quadro offerto da SEL-LARS (1956 e 1957), come il risultato di una doppia modellizzazionepsicologica operata su tre livelli:1 – (teoria dei) “pensieri” animali prel<strong>in</strong>guistici, modellata analogicamente su2 – (teoria dei) pensieri umani, modellata su3 – (descrizione metal<strong>in</strong>guistica di) episodi di verbalizzazione esplicita.In tale quadro, però, considerando che gli animali sono di fattoprivi di l<strong>in</strong>guaggio, la precedente modellizzazione sembra per l’ultimoSellars dover essere sostituita da una modellizzazione (del tutto similea quella <strong>in</strong>tesa dalla nota al § 90 della terza Critica) del tipo1 – (teoria dei) “pensieri” animali, modellata su1’ – (teoria dei) pensieri umani, modellata su2 – (descrizione logica di) episodi di comportamento razionale.In altri term<strong>in</strong>i, non volendo più applicare un paradigma rigidamentecomportamentista (che nega il bisogno di <strong>in</strong>trodurre la mediazionedi un sistema rappresentazionale tra livello neurofisiologico elivello del comportamento osservabile), ma sostituendo, nel ruolo dilivello a cui si può attuare una verifica empirica delle aspiranti “teoriedel pensiero”, gli episodi di verbalizzazione esplicita con gli episodi dicomportamento razionale, cade la possibilità di discrim<strong>in</strong>are qualitativamentesul piano psicologico-metafisico tra pensiero animale eumano. Sicché, sotto questo profilo, tale argomentazione tende adassimilarsi a quella wolffiana, <strong>in</strong> cui non appariva pert<strong>in</strong>ente (non,almeno, <strong>in</strong> modo immediato) il classico argomento della mancanza dil<strong>in</strong>guaggio al f<strong>in</strong>e di negare a un vivente la capacità di svilupparecomportamenti razionali (cfr. supra, pp. 99-100).Tuttavia, è lo stesso SELLARS che, <strong>in</strong> Eventi mentali (1981, preparatodal suo decisivo lavoro del 1975 dedicato alla “Struttura della co-118
noscenza”), si propone di <strong>in</strong>dividuare una terza possibilità, tra il riduzionismocomportamentistico e un mentalismo che non assegna unruolo peculiare alle capacità l<strong>in</strong>guistiche dist<strong>in</strong>guendole da quelle cognitive– impegnandosi di conseguenza a caratterizzare il pensiero a-nimale <strong>in</strong> maniera qualitativamente diversa da quello umano. A questoscopo, Sellars <strong>in</strong>troduce il concetto di “forma proposizionale” <strong>in</strong>quanto propria di uno “stato rappresentativo” che “rappresenta undeterm<strong>in</strong>ato oggetto, e lo rappresenta con caratteristiche determ<strong>in</strong>ate”(SELLARS 1981: 336) – proprietà che tuttavia non è una caratteristicaesclusiva delle entità rappresentative l<strong>in</strong>guistiche. Se gli “statirappresentativi” vengono def<strong>in</strong>iti <strong>in</strong> tal modo, cade allora il problemadi poter attribuire legittimamente, o meno, agli animali stati <strong>in</strong>ternidotati di forma proposizionale – purché si tenga presente che i nostriconcetti di simili stati derivano comunque dai nostri concetti semanticidi tipo metal<strong>in</strong>guistico. Soltanto a questo punto Sellars traccia unadifferenza tra animali e uom<strong>in</strong>i: e la sua mossa non consiste nemmenonel discrim<strong>in</strong>are fra sistemi rappresentazionali che, rispettivamente,si servono o non si servono della struttura l<strong>in</strong>guistica soggettopredicato(o simili) per realizzare la funzione più generale del riferirsia oggetti con caratteristiche determ<strong>in</strong>ate entro una “forma proposizionale”.Invece, Sellars dist<strong>in</strong>gue fra sistemi rappresentazionali che“usano” la logica e sistemi rappresentazionali che “sono” semplicementelogici – o, meglio, il cui comportamento osservabile può sostenereuna descrizione che comprende term<strong>in</strong>i logici: “Possiamodunque sezionare la natura lungo le sue stesse giunture, dist<strong>in</strong>guendofra quei sistemi rappresentazionali che contengono elementi rappresentazionaliche funzionano come connettivi e quantificatori logici,che cioè possiedono delle espressioni logiche ‘nel loro vocabolario’, equelli che non le contengono” (ibidem, 341). I sistemi rappresentazionaliche non possiedono elementi che funzionano come operatori logicipossono tuttavia per Sellars “imitare la ragione”, <strong>in</strong> quanto possiedono<strong>in</strong>siemi complessi di disposizioni a cambiare i propri statirappresentazionali, <strong>in</strong> maniere analoghe a quelle di molte connessioni<strong>in</strong>ferenziali proprie di un organismo razioc<strong>in</strong>ante che agisce <strong>in</strong> base apr<strong>in</strong>cipi generali. Più precisamente, Sellars dist<strong>in</strong>gue qui tra <strong>in</strong>ferenzeche procedono da una rappresentazione a un’altra mediante una sorta119
di associazione diretta e <strong>in</strong>ferenze che legano rappresentazioni medianterappresentazioni di connessioni generali o condizionali: “Chiameròdunque la sequenza ‘fumo qui’ - ‘fuoco nei pressi’ un’<strong>in</strong>ferenza‘humeana’, e la opporrò all’<strong>in</strong>ferenza ‘aristotelica’ che <strong>in</strong>clude la premessaquantificata ‘se fumo da qualche parte, allora fuoco <strong>in</strong> queipressi’” (ibidem, 342). In breve: se è privo di connettivi e quantificatorilogici, un sistema rappresentazionale non è <strong>in</strong> grado di formulare o seguire<strong>in</strong> maniera implicita dei pr<strong>in</strong>cipi condizionali del tipo “se A, alloraB”, né di operare generalizzazioni del tipo “tutti i C sono D”, o “ognivolta che E, fai F”. Tuttavia, un simile sistema rappresentazionale puòbenissimo avere disposizioni a rappresentare B se (ovvero ogni voltache) si rappresenta A – esattamente come l’animale wolffiano.In conclusione, per Sellars la differenza significativa tra i sistemirappresentazionali umani e animali consiste nel possesso, o meno, dioperatori logici nel proprio “vocabolario”: solo i sistemi rappresentazionaliche li possiedono paiono a Sellars <strong>in</strong> grado di ragionare nelsenso “classico” (ovvero “aristotelico”) del term<strong>in</strong>e, nonché di agireseguendo pr<strong>in</strong>cipi generali. In questa prospettiva, il problema dell’analogiatra razionalità umana e animale sembra allora derivare daun’equivocità del term<strong>in</strong>e “pensiero”. In quanto cioè gli animali, alpari degli esseri umani, esibiscono nel loro comportamento regolaritàesplicabili ipotizzando il possesso e l’uso di rappresentazioni e <strong>in</strong>ferenze“humeane” (e, a maggior ragione, wolffiane), apparirà plausibileparlare di “pensiero animale”. Ma una specie del genere pensiero,ossia il ragionamento <strong>in</strong> base a pr<strong>in</strong>cipi generali, ossia logici <strong>in</strong> senso“aristotelico” (e, a maggior ragione, kantiano), sembra precluso aglianimali – sicché, se si assume tale specie di pensiero come paradigmatica,apparirà giocoforza fuori luogo affermare che gli animali pensano“propriamente”.In questa prospettiva, la dottr<strong>in</strong>a dell’“analogon rationis”, ancheristretta al problema nucleare della previsione di casi simili (senza,cioè, venire estesa a spiegazione di tutta una serie di capacità paralogicheproprie del senso comune, e tantomeno dell’apparenza di comportamentocomplessivamente razionale degli animali), non paremessa totalmente <strong>in</strong> crisi dagli argomenti di Kant, né dalla denunciadelle <strong>in</strong>sufficienze della <strong>psicologia</strong> associazionistica che stava alla sua120
ase (specie <strong>in</strong> Baumgarten), né (soprattutto) dall’esplicitazione dellecapacità tacitamente logico-epistemologiche (comprese le loro aporie,evidenziate da Hume) che un “analogon rationis” pretesamente basatosu sole capacità “estetiche” dovrebbe implicare. Ne va, piuttosto,dell’<strong>in</strong>commensurabilità fra due significati di “conoscere” <strong>in</strong>vocati giàal livello della semplice descrizione di processi mentali <strong>in</strong> quantochiamati a reggere comportamenti che, a loro volta, reggono la qualificadi “<strong>in</strong>tenzionali” (e, perciò, “razionali”). Nei term<strong>in</strong>i di Sellars, sitratta della differenza tra un significato “humeano” e uno “aristotelico”del conoscere, cui è possibile fare rispettivamente corrispondereil modello epistemologico wolffiano e quello kantiano – a quali corrisponderanno,poi, diversi tipi di impegno ontologico circa le “cose”ovvero gli “oggetti” che sarebbero “possibili mediante le anime”(Disc § 58) 117 .Ma, soprattutto, il fatto che (come fa trasparire la term<strong>in</strong>ologiascelta da Sellars) un’ascendenza aristotelica possa venire <strong>in</strong>vocata <strong>in</strong>realtà da entrambi i modelli pare <strong>in</strong>dicare uno strato del problema ancorapiù profondo. Il modello kantiano, cioè, può essere detto “aristotelico”per il suo rivendicare la necessità di fare <strong>in</strong>tervenire deglielementi logici già al livello della corretta descrizione psicologica di117 Ci si rende conto che questa lettura non si accorda con un filone, precoce e ancora<strong>in</strong>fluente, della storiografia filosofica, secondo cui Kant avrebbe semplicemente ma radicalmenteemendato una fondamentale reificazione che tradizionalmente guastava lametafisica, trasponendo sul piano logico-gnoseologico quelli che erano i contenutidell’ontologia a lui anteriore e consegnatigli dal wolffismo. Negli icastici term<strong>in</strong>i di RO-SENKRANZ, che tuttavia non si limita a ricalcare la formula della “rivoluzione copernicana”:“La cosalità fu quel concetto meraviglioso e proteiforme che la filosofia tedescaelaborò s<strong>in</strong>o a sf<strong>in</strong>irsi – f<strong>in</strong>ché esso sparì, con la comparsa della cosa <strong>in</strong> sé” (1840: 36).In anni relativamente più prossimi, MAUTHNER (che significativamente alla voce “Ontologie”del suo vocabolario si limita a r<strong>in</strong>viare, per la trattazione di questa “vecchia”discipl<strong>in</strong>a, alla voce “Realismus”, cfr. 1923, ad voc.) riporta l’ontologia wolffiana alla dottr<strong>in</strong>adelle idee platonica e poi al “Wortrealismus” scolastico, lodandola (fuorché naturalmentel’“errore fondamentale” del suo “dogmatismo”, consistente nel “non avere<strong>in</strong>dagato più dappresso l’orig<strong>in</strong>e delle rappresentazioni”), ma lodando soprattutto Kant,il quale avrebbe poi “tracciato un conf<strong>in</strong>e netto tra ontologia e metafisica, postol’ontologia come prelim<strong>in</strong>are a una (futura) metafisica e cercato di trasformare l’ontologia<strong>in</strong> filosofia trascendentale, cioè <strong>in</strong> teoria della conoscenza” (cfr. MAUTHNER 1923,ad voc. “Realismus”). In tale <strong>in</strong>terpretazione, Mauthner ricalca esplicitamente il parere diSchopenhauer, secondo cui la Critica della ragion pura avrebbe “trasformato l’ontologia <strong>in</strong>dianoiologia” (ibidem).121
una catena rappresentativa qualificabile come pensiero, restr<strong>in</strong>gendocosì il significato del “conoscere” alle sole concatenazioni rappresentativedescrivibili <strong>in</strong> quanto <strong>in</strong>tr<strong>in</strong>secamente caratterizzate da tali elementilogico-formali. In quanto (diversamente) “aristotelico”, <strong>in</strong>vece,il modello wolffiano riferisce il significato di “conoscere” come legittimoalle catene rappresentative anche quando le loro regolarità nonsiano effettivamente ed <strong>in</strong>tr<strong>in</strong>secamente caratterizzate dalla presenzadi elementi logico-formali, e anche quando non riflettano “tutta” laverità del reale, purché riflettano (“pittoricamente”) le regolarità riscontrabili<strong>in</strong> un’ontologia m<strong>in</strong>ima, quella del possibile. Da questosecondo punto di vista, anche una semplice previsione (nel senso diRyle), pur godendo di un semplice statuto doxastico, risulta allora caratterizzabilecome un’<strong>in</strong>ferenza, benché solo “per analogia” rispettoalle <strong>in</strong>ferenze vere e proprie, ossia pienamente razionali. Al f<strong>in</strong>e dellalegittimità di una simile caratterizzazione, non pare <strong>in</strong>fatti necessarioil suo rispetto di criteri propriamente e strettamente epistemologici,ma è sufficiente che rappresenti determ<strong>in</strong>ate regolarità m<strong>in</strong>imali, lacui descrizione toccherà a un’ontologia di tipo essenzialistico come èquella wolffiana.Tuttavia, contrapponendo la dottr<strong>in</strong>a dell’esperienza wolffiana aquella kantiana come uscite da un simile confronto, trattandosi cioèf<strong>in</strong> qui di un’<strong>in</strong>commensurabilità fra criteri epistemologici adottati perqualificare una credenza come una conoscenza, rimane il fatto che ununiverso “wolffiano” e un universo “kantiano” risulterebbero <strong>in</strong>dist<strong>in</strong>guibilia un osservatore, almeno relativamente alla sua capacità di<strong>in</strong>dividuarvi l’ord<strong>in</strong>e e la legalità m<strong>in</strong>imi che per <strong>Wolff</strong> sono temadell’ontologia. Ciò che rimane costante (o presupposto) <strong>in</strong> entrambi imodelli è <strong>in</strong>fatti il darsi oggettivo di leggi <strong>in</strong> generale 118 – nel caso chequi più specificamente <strong>in</strong>teressava, almeno di quelle che rendono ilmondo prevedibile anche per un animale, sia che (come è per <strong>Wolff</strong>)ciò venga considerato come una legge delle cose, a portata della nostracapacità di conoscerle già esteticamente, sia che (come è perKant) ciò venga considerato <strong>in</strong>vece come una legge immanente a o-118 Per Kant, andrebbe considerata ancora la questione del rapporto fra la dottr<strong>in</strong>a delleanalogie dell’esperienza e il problema, maturato però solo nella terza Critica, dei pr<strong>in</strong>cipicapaci di costituire un’esperienza sistematica.122
gni soggetto capace di esperienza, la quale, mediatamente, avrebbeper effetto il costituirsi di un mondo ord<strong>in</strong>ato. In ogni caso, l’essenzialismopare, f<strong>in</strong> qui, salvo, non pare cioè bisognoso di porsi, a propositodella regolarità del mondo esperito, la questione dello statutoontologico di tale legalità – tantomeno nei term<strong>in</strong>i del darsi di un e-ventuale discrim<strong>in</strong>e fra la sua essenza e la sua esistenza. Semmai, è suun piano diverso da questo che Kant ha f<strong>in</strong>ito per porre tale questione,come cruciale, a ogni ontologia di tipo wolffiano.123
VI – Significato, essenza, esistenza. I cento talleri di <strong>Wolff</strong>Jemand sieht so viele Gegenständedaß ihm die Gegenstände gleichgültig werden –jemand sieht so viele gleichgültige Gegenständedaß er nach und nach sich selber aus dem Bewußtse<strong>in</strong> verliert –dann sieht er e<strong>in</strong>en Gegenstandden er nicht sehen willoder den er gern länger sehen möchteoder den er gern haben möchte[…]und er kommt zu Bewußtse<strong>in</strong> –Peter Handke, Die Innenwelt der Außenwelt der InnenweltL’esistenza, afferma Kant, non è propriamente predicabile. Pure,l’esistenza delle cose viene di fatto, <strong>in</strong> qualche modo, cont<strong>in</strong>uamentee <strong>in</strong>genuamente predicata. Più esattamente: il darsi di ogni conoscenzaautentica è condizionato per Kant dal concorso del sentire e delpensare; e l’assunzione di un impegno ontologico nei confronti di ciòche viene conosciuto è regolata <strong>in</strong>nanzitutto dal sentire. E, qualoranon si consideri questo fatto, si è istigati a predicazioni spurie comeè, esemplarmente, quella su cui conclude la dimostrazione ontologicadell’esistenza di dio.Questo, <strong>in</strong> breve, l’<strong>in</strong>tero compenso ricavato da Kant con la suaconfutazione della prova ontologica. Ma soprattutto, nel caso di questaconfutazione, si è di fronte a uno dei due momenti cruciali (l’altroè l’<strong>in</strong>nesco del dibattito medievale sugli universali) da cui deriva il filonedell’ontologia <strong>in</strong>centrato sulla nozione di esistenza, e dunque diversoda quello <strong>in</strong>centrato sulla nozione generalissima dell’ente come“<strong>qualcosa</strong>” entro cui si colloca, <strong>in</strong>vece, la prestazione wolffiana. Sequesto quadro storico e teorico complessivo risulta accettabile, rimanetuttavia ancora da vedere se e quanto <strong>Wolff</strong> – con la sua def<strong>in</strong>izionedell’esistenza come semplice “complemento della possibilità”(Ont § 174) – sia da giudicare davvero estraneo al filone di riflessioni,ormai vic<strong>in</strong>e allo scenario contemporaneo, che emerge <strong>in</strong> Kant. Anti-124
cipando le prossime conclusioni: una simile estraneità radicale nonpuò essergli imputata; per <strong>Wolff</strong> l’esistenza non è (almeno) un predicatocome gli altri, attorno a essa si costituisce, anzi, un problema lacui collocazione discipl<strong>in</strong>are rientra ancora nell’ontologia <strong>in</strong>tesa comescienza dell’ente “<strong>in</strong> quanto ente”.1. Esse, percipiNel processo mediante cui nella modernità si è costituita discipl<strong>in</strong>armentel’ontologia, non soltanto è risultata centrale la riflessionecomplessiva sui “modi” dell’essere (filo conduttore di HONNEFEL-DER 1990) entro cui spicca la tradizione scotista. A sua volta centrale<strong>in</strong> tale riflessione, e particolarmente ben visibile nella storia della provaontologica, è stato il progressivo dist<strong>in</strong>guere, raccogliendo il lascitodel pensiero aristotelico, tra modalità temporali e causali, da un lato, eun’<strong>in</strong>terpretazione strettamente logica della modalità, dall’altro (cfr.SCRIBANO 1994: 3-26). In tale prospettiva, risulta ancora decisiva laprestazione di Scoto, mediante cui è avvenuto che la celebre formulacon cui Aristotele nel libro III della Fisica (203b30) deduce l’esistenza(attuale e <strong>in</strong> ogni tempo) dell’ente eterno, “grazie all’assunzione dellemodalità logiche per determ<strong>in</strong>are la possibilità”, è divenuta “una provadell’esistenza dell’ente <strong>in</strong>causato a partire dalla non contraddittorietàdella sua def<strong>in</strong>izione” (SCRIBANO 1994: 11) 119 . Di qui <strong>in</strong> avanti,cioè, “il motto aristotelico In aeternis idem esse et posse” si è potuto trasformare<strong>in</strong>una prova di esistenza perché si è com<strong>in</strong>ciato a pensare al possibile logicocome <strong>in</strong>dipendente dall’esistente, ossia perché dell’orig<strong>in</strong>ario pr<strong>in</strong>cipio dipienezza all’<strong>in</strong>terno del quale si sono formate le modalità temporali si è o-bliterata la precedenza dell’esistente sul possibile (ibidem, 17).119 Scribano precisa qui che <strong>in</strong> Scoto si ha uno “slittamento” da una nozione logica auna nozione causale della possibilità riferita all’ente <strong>in</strong>creato e non “una sovrapposizioneo […] una <strong>in</strong>dist<strong>in</strong>zione, come era nella teoria aristotelica delle modalità” (ibidem, 12).125
E con ciò è risultato plausibile avanzare la pretesa dell’argomentoontologico “classico” di Anselmo, poi r<strong>in</strong>novato da Cartesio 120 , basatasulla “riduzione delle modalità alla impossibilità e alla necessità nelcaso di Dio” (ibidem, 19).Quanto alle ricorrenti affermazioni della circostanza per cui s<strong>in</strong>o aCartesio “esistenza” sarebbe valso pr<strong>in</strong>cipalmente a significare l’esserecreaturale <strong>in</strong> quanto derivato, il quadro term<strong>in</strong>ologico che andrebbeconsiderato è, verosimilmente, più complesso di così 121 . In ognicaso, la situazione lessicale registrata <strong>in</strong> area schulphilosophisch da Walchappare quella, già <strong>in</strong>contrata sopra, secondo cui, ormai consolidata unascienza dell’“ente <strong>in</strong> quanto ente”, con il term<strong>in</strong>e “esistenza (Existenz)”viene chiamata “la qualità di una cosa data dal fatto che essa è veramentepresente, e [che] nella nostra l<strong>in</strong>gua può venire detta l’essere diuna cosa” (WALCH 1726, ad voc. “Existenz”). A tale def<strong>in</strong>izione segueun breve rapporto circa i diversi modi di <strong>in</strong>tendere la differenza (e larelazione) fra essenza ed esistenza, f<strong>in</strong>o a sposare come meglio accettabilela tesi secondo cui la loro separazione si dà solo per un atto <strong>in</strong>tellettivo,mentre “<strong>in</strong> realtà queste si danno sempre <strong>in</strong>sieme” (ibidem)– precisando però che da questo “non segue che l’idea vera dell’esistenzacomprenda <strong>in</strong> sé anche un’idea vera dell’essenza” (ibidem). Quest’ultimaaffermazione <strong>in</strong>tende dunque una correlazione reale, ma a-simmetrica, fra i due term<strong>in</strong>i – ed è proprio tale tipo di rapporto che,per quanto problematico, viene affermato correggere la nozione di120 Sul dibattito analitico attuale circa l’argomento ontologico di Cartesio, cfr. NOLAN,ad voc. “Descartes, ontological argument”, <strong>in</strong> SEPh. In generale sul dibattito contemporaneocirca la prova ontologica, cfr. OPPY, ad voc. “Ontological arguments”, <strong>in</strong> SEPh.121 Si è affermato, con maggiore precisione (CATTIN 1986: 79), che già <strong>in</strong> Anselmo, diversamenteche nella tradizione greca, la “veritas” risulta essere fondamento sia dello “idquod”, sia dello “est”, ossia che nell’espressione “vere esse” il “vere” afferma la fondazionedell’essenza così come dell’esistenza nella verità; del resto, all’epoca di Anselmo “existere”non è strettamente s<strong>in</strong>onimo di “esse”: etimologicamente significa essere situato, sussistere,e significa meno il fatto di essere che il fatto di avere un’orig<strong>in</strong>e (“sistere ex alio”: eCatt<strong>in</strong> ricorda qui il lucreziano “vermes de stercore existunt”); e, soprattutto <strong>in</strong> Anselmo,significa un rapporto di orig<strong>in</strong>e riferito alla conoscenza dell’essere (ibidem, 81-2). Così, mentrelo “esse” potrebbe fondarsi nel solo pensiero (e <strong>in</strong>fatti “Anselmo parla di ‘esse <strong>in</strong> <strong>in</strong>tellectu’,mai di ‘existere <strong>in</strong> <strong>in</strong>tellectu’”), proprio la parola “existere” precisa che ci troviamod<strong>in</strong>anzi a un “esse” fondato “<strong>in</strong> re” (ibidem, 82). In breve, secondo Catt<strong>in</strong>, il pensiero diAnselmo non può essere compreso <strong>in</strong> base a una semplice dist<strong>in</strong>zione tra essenza ed esistenza,che si impone ben più tardi (ibidem, 84).126
“sostanza” propria della tradizione scolastica. Alla voce “Essentz” silegge <strong>in</strong>fatti quanto segue.Qui si può guardare o alla dottr<strong>in</strong>a corrente, e <strong>in</strong> particolare a quella degliscolastici, oppure alla cosa stessa. Nelle scuole si adoperava questo vocabolo[sc. essenza] rispettivamente <strong>in</strong> senso ampio o <strong>in</strong> senso stretto: secondo ilprimo, designava non soltanto l’essenza, ma anche l’esistenza delle cose[…] Tuttavia, il secondo è quello più comune […] L’essenza metafisica è unaqualità tale che di una cosa si può dire con certezza che senza di essa unacosa non rimarrebbe ciò che deve essere, per cui bisogna dist<strong>in</strong>guere tra lasostanza e l’essenza, che gli antichi (<strong>in</strong>sieme a parecchi moderni) confondono(WALCH 1726, ad voc. “Essentz”).Come si è potuto apprezzare dalle citazioni, con la sostituzionedella teoria dell’essenza alla metafisica della sostanza, nell’ontologiapostcartesiana tratteggiata da Walch il centro del problema diventaquello della riducibilità del significato dell’esistenza a quello di uncorrelato dell’essenza – al punto che, <strong>in</strong> tale prospettiva, a secondacioè che l’ontologia voglia partire, o meno, dal dato irriducibiledell’esistenza, il significato di “ente” si sdoppia <strong>in</strong> modo netto.La parola ente viene adoperata <strong>in</strong> un senso amplissimo e <strong>in</strong> un senso ristretto.Secondo il primo, si <strong>in</strong>tende ogni cosa, che esista realmente o che sia soltantopossibile, e anche <strong>qualcosa</strong> di impossibile, purché si possa rappresentarlo nelpensiero, o <strong>qualcosa</strong> che è futuro. In senso stretto, ente significa una cosa taleche esista realmente, nonché abbia la sua propria essenza, e questo è il significatoproprio, che si usa chiamare anche metafisico (WALCH 1726, ad voc.“Ens”).Questa spaccatura è stata chiusa da <strong>Wolff</strong>, come si è visto, optandoper una concezione dell’ontologia entro cui il significato dell’esistenzaappare perfettamente riducibile a quello della realizzazionedella possibilità <strong>in</strong>tr<strong>in</strong>seca all’ente, <strong>in</strong>teso nel primo dei due sensi,quello “amplissimo”, registrato da Walch. Ma il problema si ripercuoteràanche sul momento più specifico <strong>in</strong> cui occorrerà fare i conti conla prova ontologica – di cui conviene dunque elencare <strong>in</strong> modo sommariole costanti pr<strong>in</strong>cipali, tenendo conto <strong>in</strong> primo luogo delle <strong>in</strong>dicazioniprovenienti da Scribano. Tali costanti si fissano già, si può di-127
e, nella polemica tra Anselmo e Gaunilone; per l’argomento probatorio,nei due punti che seguono.1) L’ente sommo di cui va provata l’esistenza è <strong>in</strong>nanzitutto dato<strong>in</strong> modo <strong>in</strong>dubbio <strong>in</strong> quanto significabile. Anselmo afferma: se pronunciole parole “<strong>qualcosa</strong> di cui nulla può pensarsi di maggiore (aliquidquo maius nihil cogitari potest)”, anche lo “stolto (<strong>in</strong>sipiens)” che negadio capisce queste parole (Proslogion, II: 101). Ciò di cui discutiamoha, <strong>in</strong>somma, una sorta di evidenza semantica – del tutto simile all’evidenzaposseduta dal pr<strong>in</strong>cipio di contraddizione <strong>in</strong> quanto difendibilecon un’argomentazione elenctica.2) Per motivi logici (per evitare contraddizioni), a questo ente, datii suoi attributi essenziali, bisogna necessariamente riconoscere l’esistenzatout court. Sempre secondo Anselmo, se lo stolto dice che l’enteperfettissimo esiste soltanto nel suo <strong>in</strong>telletto, allora si contraddice,perché si afferma <strong>in</strong> grado di pensare <strong>qualcosa</strong> di perfettissimo e diesistente “<strong>in</strong> re”, che però sarebbe allora più perfetto del perfettissimosolo pensabile 122 – ciò che non è analiticamente ammissibile. Dunque,a una (ad almeno una, o soltanto a una peculiare) entità concettualecompeterebbe immediatamente, data la sua essenza, l’esistenzareale.Quanto alle obiezioni, già <strong>in</strong> Gaunilone disegnano il seguente contrappunto.1) È possibile negare, <strong>in</strong>nanzitutto, che l’ente concettuale <strong>in</strong> questioneabbia evidenza, e qu<strong>in</strong>di piena esistenza, già “<strong>in</strong> <strong>in</strong>tellectu”, ossianell’ord<strong>in</strong>e conoscitivo, ovvero <strong>in</strong> quanto significato 123 .122 Il passo pert<strong>in</strong>ente suona nell’orig<strong>in</strong>ale: “si id quo maius nequit cogitari, potest cogitar<strong>in</strong>on esse: id ipsum quo maius cogitari nequit, non est id quo maius cogitari nequit”(ibidem, 102).123 È da notare come proprio su questo punto i fronti si preciseranno successivamentesecondo l’opposizione tra <strong>in</strong>natisti (favorevoli all’argomento) e anti-<strong>in</strong>natisti contrari, erispettivamente platonici (ad es. Alessandro di Hales, Bonaventura) e aristotelici (Tommaso).Ma già lo stesso Anselmo si era affaticato sul problema dell’<strong>in</strong>soddisfazione dataglidalla sua prova <strong>in</strong> quanto prova meramente <strong>in</strong>tellettuale, tanto che il cap. IV delProslogion viene devoluto all’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e della questione “Quomodo <strong>in</strong>sipiens dixit <strong>in</strong> corde,quod cogitari non potest”). E si veda anche il cap. XIV (“Quomodo et cur videtur etnon videtur deus a querentibus eum”), dove si adduce il fatto che l’anima che cerca etrova dio è comunque, <strong>in</strong>sieme, ottenebrata <strong>in</strong> se stessa e abbagliata da dio. Circa il dibattitopoi sorto sulla differenza tra <strong>in</strong><strong>in</strong>telligibilità e impensabilità, cfr. MOREAU (1981).128
2) Rispetto all’ord<strong>in</strong>e logico (ovvero conoscitivo), <strong>in</strong>oltre, l’ord<strong>in</strong>eontologico è comunque nettamente dist<strong>in</strong>to: posso magari formarmiil concetto di un ente che per essenza è dotato di qualsivoglia perfezione,ma non c’è motivo perché gli debba corrispondere un’entitàesistente 124 .Con ciò, semplificando, il capitale argomentativo dei successividibattiti sulla prova ontologica è completo: il Cartesio della qu<strong>in</strong>taMeditazione non fa che appropriarsene, schierandosi con i favorevoli125 . Kant, per parte sua, si assesterà sempre <strong>in</strong> tale quadro, schierandosi,come si dice, con i contrari, e ponendosi <strong>in</strong>oltre nella scia diHume – muovendo cioè una critica alla legittimità dell’uso predicativodel verbo esistere.In questo quadro, però, la collocazione di <strong>Wolff</strong> risulta meno ovviadi quanto appaia dalle ricostruzioni che semplicemente lo situanotra i favorevoli. In effetti, se si considerano le s<strong>in</strong>gole valutazioni wolffianedelle diverse prove dell’esistenza di dio fornite dalla tradizionescolastica, non si trova soltanto che, a fronte della prem<strong>in</strong>enza dataalla prova ontologica, la sua versione di essa risente della dist<strong>in</strong>zionetra essenza ed esistenza come <strong>in</strong>terpretata alla luce di un’ontologia <strong>in</strong>centratasulla formula dell’“ente <strong>in</strong> quanto ente” e, dunque, ormai liberadal presupposto creazionistico della separatezza ed em<strong>in</strong>enza124 Solo qui cade il celebre esempio dell’“isola perduta” (perfettamente pensabile, manon per questo esistente) avanzato da Gaunilone. A proposito della risposta di Anselmo,CATTIN (1986: 80-81) legge: “Lo ‘esse <strong>in</strong> <strong>in</strong>tellectu’ riveste il senso def<strong>in</strong>itivo cheacquisterà la parola ‘essentia’, di pr<strong>in</strong>cipio di <strong>in</strong>telligibilità, mentre lo ‘esse <strong>in</strong> re’ rimandaa una ‘esistenza’ esterna al pensiero, fondata su una ‘res’ e dunque sulla ‘veritas’. Perciòl’argomento scoperto da Anselmo ha come funzione pr<strong>in</strong>cipale quella di dimostrare chelo ‘id quo maius…’ non può essere una pura ‘essentia’, bensì, per la sua struttura <strong>in</strong>terna,deve essere uno ‘esse <strong>in</strong> re’. Non è dunque <strong>in</strong> quanto ‘essentia’ che lo ‘id quomaius…’ è la prova dell’esistenza di Dio, ma piuttosto può essere ‘essentia’ (e <strong>in</strong>fatt<strong>in</strong>ulla ci dice che questa ‘essentia’ possa mai risultare pienamente <strong>in</strong>telligibile) solo <strong>in</strong>quanto è ‘esse <strong>in</strong> re’”.125 Rispetto a Cartesio, Barnes rimarca <strong>in</strong>nanzitutto come l’argomento ontologico risult<strong>in</strong>ecessario <strong>in</strong> mancanza dell’<strong>in</strong>tuizione diretta del fatto che nel caso di dio l’esistenzanon possa venire separata dalla sua essenza (BARNES 1972: 15-18). Inoltre, la versionecartesiana della prova ontologica data nella qu<strong>in</strong>ta Meditazione (sunteggiata da Barnescome: 1 un dio è perfetto, 2 tutto ciò che è perfetto esiste, 3 dio esiste) attuerebbe rispettoall’argomento orig<strong>in</strong>ale anselmiano due semplificazioni pr<strong>in</strong>cipali: l’elim<strong>in</strong>azionedella complessa reductio ad absurdum e l’ignoranza della modalizzazione (benché il secondosia un punto ben più complesso; cfr. ibidem, 18-26).129
dell’ente sommo. Si trova, pure, che la sua versione sfugge al problemaposto come centrale f<strong>in</strong> dall’orig<strong>in</strong>e, cioè quello della corrispondenzareale tra ord<strong>in</strong>e della predicazione (<strong>in</strong> cui dunque ricade l’essenzialitàdi ogni ente <strong>in</strong> generale) e ord<strong>in</strong>e dell’esistenza come presenzao datità della cosa a un soggetto chiamato a giudicarla.Andando ai testi, si trova <strong>in</strong>nanzitutto che la dimostrazione dell’esistenzadi dio come svolta già nella Metafisica tedesca si articola <strong>in</strong>due parti. Nella prima si imposta un argomento a posteriori: muovendodall’esito dell’argomento preontologico (“Noi siamo, cfr. DM § 1”,DM § 928) si fa valere <strong>in</strong>nanzitutto il pr<strong>in</strong>cipio di ragione (“Tutto ciòche è ha la propria ragione [Grund] sufficiente del perché è piuttostoche non essere, cfr. DM § 30”, ibidem) per giustificare la ricerca di unente che, a differenza del “noi”, abbia <strong>in</strong> sé la propria ragion d’essere126 . E ora, poiché la necessità di quest’ultimo appare così dimostrata,<strong>Wolff</strong> <strong>in</strong>izia a riconoscerne e <strong>in</strong>dagarne gli attributi, allo scopodi “vedere se convengano, o meno, alla nostra anima” (ibidem) 127 . Sitratta, complessivamente, di un’argomentazione <strong>in</strong> tre fasi: discensiva,ascensiva e nuovamente discensiva; <strong>in</strong>dividuato l’ente che è il nostrofondamento, si tratterà cioè di analizzarlo <strong>in</strong> quanto fondamento disé, slegandolo via via dal rapporto con il nostro essere cont<strong>in</strong>gente,per poi ritornare a noi <strong>in</strong> quanto fondati da esso.L’argomento ontologico vero e proprio, <strong>in</strong> quanto argomento apriori, si trova annidato nella seconda fase della struttura complessivadella prima teologia wolffiana. Sicché, muovendo dal § 928 sopra citato,viene così estratto come argomento autonomo nel paragrafosuccessivo: “Quella cosa che ha <strong>in</strong> sé la ragione della propria realtà126 Varrà, allora, per questa l<strong>in</strong>ea argomentativa wolffiana l’avvertenza di SCRIBANO:“Chi […] ritenga di aver provato l’esistenza di un ente a partire dalla sua eternità o dalla<strong>in</strong>causabilità contenuta nella sua def<strong>in</strong>izione avrà sicuramente operato ad un qualchelivello della dimostrazione uno slittamento da modalità logiche a modalità temporali ocausali” (1994: 18). Dunque, <strong>Wolff</strong> non segue qui la formulazione leibniziana, ma simuove ancora su un terreno più strettamente “scotista” e non “classico”.127 L’elenco degli attributi div<strong>in</strong>i (eternità, immensità, <strong>in</strong>corruttibilità, <strong>in</strong>corporeità, semplicità…cfr. DM § 931ss.) è brevemente sunteggiato al § 947, per passare qu<strong>in</strong>di alladeterm<strong>in</strong>azione degli attributi di dio <strong>in</strong> quanto spirito, a com<strong>in</strong>ciare da quello della capacitàdi rappresentarsi tutti i mondi possibili (§ 952), e concludere con la teoria di un diocreatore del mondo attuale, strettamente connessa con i problemi del rapporto tra ragionee rivelazione, nonché della teodicea.130
(Würcklichkeit) e che, qu<strong>in</strong>di, è tale che è impossibile che non possaessere, viene chiamata entità ovvero essenza autonoma (selbständiges Wesen)”(DM § 929).Le precisazioni che fanno di questo argomento la versione wolffianadella prova ontologica “classica” si lasciano poi agevolmenteleggere – al di là della sua concisa riformulazione nell’<strong>Ontologia</strong> 128 –nella parte a priori, la seconda, della Teologia naturale 129 . Qui, evocata lanozione di compossibilità (TN2 § 1) e <strong>in</strong>vocata la legge ontologicasecondo cui <strong>in</strong> un ente sono compossibili le sue determ<strong>in</strong>azioni essenziali,nonché i suoi attributi e modi (TN2 §§ 2-3), si def<strong>in</strong>isce comeente perfettissimo quello <strong>in</strong> cui tutte le realtà compossibili si danno<strong>in</strong> un grado assolutamente sommo (TN2 § 6), il quale è illimitatopoiché “è impossibile concepirne uno maggiore (majus eodem concip<strong>in</strong>equit)” (TN2 § 7). Incorporata così la formulazione anselmiana, conun chiaro scivolamento dalla modalizzazione statistica alla modalizzazionelogica, si procede f<strong>in</strong>o a concludere che, poiché dio contiene<strong>in</strong> sé tutte le realtà compossibili nel loro grado assolutamente sommo(TN2 § 15), essendo l’esistenza una realtà compossibile ed essendonel’esistenza necessaria il grado assolutamente sommo, a dio competel’esistenza necessaria, ovvero dio esiste necessariamente (TN2 § 21).È palese come questa argomentazione si basi sul presupposto ontologicosecondo cui “Se la ragione sufficiente dell’esistenza è contenutanell’essenza di un ente, tale ente esiste <strong>in</strong> modo necessario” (Ont§ 308), a sua volta legato alla concezione per cui l’essenza, da cui dipende<strong>in</strong>nanzitutto la possibilità di un ente 130 , può comprendere fra i128 “L’ente necessario è quello la cui esistenza è assolutamente necessaria, ovvero, ciò che èlo stesso (cfr. Ont § 308), quello che ha la ragion sufficiente della propria esistenza nellapropria essenza” (Ont § 309).129 La Theologia naturalis (1736-37) è suddivisa <strong>in</strong> una Pars prior, <strong>in</strong>tegrum systema complectens,qua existentia et attributa Dei a posteriori demonstrantur e una Pars posterior, qua existentia et attributaDei ex notione entis perfectissimi et natura animae demonstrantur, et atheismi, deismi, fatalismi,naturalismi, sp<strong>in</strong>ozismi aliorumque de Deo errorum fundamenta subvertuntur. Tale divisione nonsoltanto articola meglio quella già presente nella Metafisica tedesca, ma sistematizza <strong>in</strong>oltrele abbondanti osservazioni sparse di ord<strong>in</strong>e teologico svolte <strong>in</strong> DM2 per lo più a f<strong>in</strong>i diautodifesa, susseguentemente alle accuse di determ<strong>in</strong>ismo e fatalismo ricevute soprattuttoa partire dal 1723.130 “L’ente è possibile per essenza” (Ont § 153): poiché, <strong>in</strong>fatti, l’essenza di un ente ècostituita dalle determ<strong>in</strong>azioni fra loro compossibili e <strong>in</strong>dipendenti che vi sono contenute,con essa è data la non contraddittorietà dell’ente cui compete – nei term<strong>in</strong>i cioè di131
vari attributi necessari 131 anche quello dell’esistenza. Che anche quellodell’esistenza sia qui un attributo essenziale, e che dunque soggiacciaalla legge della necessità assoluta delle essenze 132 , non è <strong>in</strong>fatti per<strong>Wolff</strong> da mettersi <strong>in</strong> questione – una volta, almeno, che sia evitato ilrischio di un grave equivoco circa il significato di “necessità assoluta”.Occorre <strong>in</strong>vero guardarsi dal prendere il term<strong>in</strong>e ‘essenza’ secondo un significatodiverso da quello che gli è stato da noi attribuito <strong>in</strong> precedenza (cfr.Ont § 143). Infatti, quando alcuni scolastici si erano risolti a concepire l’essenza<strong>in</strong> modo tale che le pert<strong>in</strong>esse l’esistenza, quella necessità assoluta delleessenze che noi immediatamente le neghiamo fu considerata giustamentepericolosa. Dunque, nelle loro argomentazioni l’essenza assolutamente necessariaimplica anche l’atto di esistere come assolutamente necessario; maper le nostre concezioni è assolutamente necessario […] soltanto ciò che èuna “possibilità <strong>in</strong>tr<strong>in</strong>seca” (Ont § 154). La def<strong>in</strong>izione delle determ<strong>in</strong>azioni essenzialiera stata data così <strong>in</strong> precedenza: “Quelli che <strong>in</strong> un ente non si escludono a vicenda, né avicenda si determ<strong>in</strong>ano, si dicono [attributi] essenziali e costituiscono l’essenza di un ente”;ad es.: “il numero di tre e l’uguaglianza dei lati sono gli attributi essenziali del triangolo equilatero:<strong>in</strong>fatti, né l’uguaglianza dei lati ne esclude il numero di tre […], né l’uguaglianza dei lativiene determ<strong>in</strong>ata dal loro numero di tre” (Ont § 143).131 Posta <strong>in</strong>fatti l’essenza di un ente, ne risultano dati gli attributi, ovvero le determ<strong>in</strong>azioniessenziali <strong>in</strong>sieme alle loro ragioni sufficienti – ma non una loro ragione <strong>in</strong>tr<strong>in</strong>seca(Ont §§ 156 ss.). <strong>Wolff</strong> chiarifica tale dottr<strong>in</strong>a seguendo il filo di questa esemplificazione:“non c’è alcuna ragione <strong>in</strong>tr<strong>in</strong>seca per cui il triangolo equilatero abbia tre lati uguali”(Ont § 156); dati però i tre lati uguali come suoi attributi essenziali, si ha: “la ragione sufficientedell’uguaglianza degli angoli <strong>in</strong> un triangolo equilatero è l’uguaglianza dei lati,poiché <strong>in</strong> base alla sola assunzione di questa è possibile dimostrare che gli angoli di untriangolo equilatero devono essere uguali” (Ont § 157); poi, per gli attributi comuni: “ilnumero di tre delle l<strong>in</strong>ee di cui consiste il triangolo equilatero è la ragione sufficiente delnumero di tre degli angoli […] <strong>in</strong>fatti il numero di tre dei lati sta fra gli attributi essenzialidel triangolo equilatero, ma il loro numero non basta aff<strong>in</strong>ché vi sia fra essi anchel’uguaglianza dei lati” (Ont § 158); <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e, per gli attributi propri: “un attributo propriodel triangolo equilatero è che abbia tre angoli uguali fra loro […] la sua ragione sufficienteè contenuta nel numero di tre e nell’uguaglianza dei lati […] e dunque nella totalitàdei suoi attributi essenziali” (Ont § 159).132 Le essenze delle cose sono necessarie <strong>in</strong> modo assoluto (Ont §§ 303-304): ad es. “èassolutamente necessario che tre l<strong>in</strong>ee rette possano venire congiunte <strong>in</strong> modo tale checomprendano uno spazio e che qu<strong>in</strong>di due di esse, prese <strong>in</strong>sieme, siano maggiori dellaterza: <strong>in</strong>fatti qui non viene presupposto nulla aff<strong>in</strong>ché si comprenda che appunto ciò siapossibile prima [di porre le tre l<strong>in</strong>ee rette congiunte <strong>in</strong> modo tale che comprendano unospazio]” (Ont § 303). Alla serie degli esempi <strong>Wolff</strong> aggiunge qui l’annotazione term<strong>in</strong>ologicasecondo cui la “necessità assoluta” viene detta pure “necessità geometrica”, oltre che“necessità metafisica” (Ont § 304).132
tale da essere possibile anche quando non è necessario che sia <strong>in</strong> atto perqualche determ<strong>in</strong>ata circostanza (Ont § 303).Per <strong>Wolff</strong>, dunque, il carattere necessario delle essenze non deveriguardare quella particolare determ<strong>in</strong>azione che è il “complementodella possibilità”, ossia l’esistenza <strong>in</strong> quanto “attualità” (Ont § 174) –tranne che per l’unico ente perfettissimo, causa di se stesso: sicchél’esistenza <strong>in</strong> atto viene per forza esclusa dal novero dei predicati generalidi cui tratta l’ontologia 133 .Proprio questo aspetto della dimostrazione wolffiana getta una luceparticolare sulla confutazione kantiana della prova ontologica – eviceversa. Kant, <strong>in</strong> altri term<strong>in</strong>i, come si proverà a mostrare <strong>in</strong> ciò chesegue, non si limita a prendere semplicemente posizione circa l’argomentodella prova all’<strong>in</strong>terno di un vocabolario moderno – determ<strong>in</strong>ato,cioè, dallo stabilizzarsi dell’ontologia come scienza dell’“ente <strong>in</strong>quanto ente” e, specialmente, della sua versione wolffiana, pienamenteessenzialistica. Per vederlo, dovrebbe servire <strong>in</strong>nanzitutto la seguenteconstatazione: la riforma kantiana del vocabolario razionalisticonon poteva evitare il problema (che può essere reperito già nelpunto di attacco della prima obiezione di Gaunilone ad Anselmo)dell’equivalenza tra “possedere ogni perfezione” e “essere ciò che dipiù perfetto possiamo concepire” – equivalenza che Cartesio assumecome implicita e basilare e che viene, poi, ribadita sempre di nuovodai suoi successori. Ma proprio questa equivalenza o specularità frapiano esperienziale e piano ontologico non viene quasi più consideratanel dibattito sull’argomento ontologico a partire dalla confutazionekantiana 134 . E tutto ciò avviene dacché proprio il problema dell’equivalenzatra (perfezione) reale e (perfezione) conoscibile viene sostituitoda Kant con un altro problema, formulabile soltanto nell’ottica fenomenisticamaturata <strong>in</strong> età postcartesiana. Sotto tale profilo, si vuol dire,133 <strong>Wolff</strong> rimanda, quanto alla trattazione delle diverse circostanze per cui un ente passadallo “stato di possibilità” a quello di attualità, alle diverse parti speciali della metafisica(alla teologia naturale per la “ratio” dell’esistenza di dio, alla cosmologia per l’esistenzadei cont<strong>in</strong>genti, alla <strong>psicologia</strong> per il peculiare passaggio dalla possibilità all’atto che haluogo “nella mente umana”), sottol<strong>in</strong>eando poi l’utilità pratico-applicativa di tali considerazioni<strong>in</strong> sede di fisica, di filosofia morale e politica ecc. (ibidem).134 Cfr. BARNES (1972: 17 e 67 ss.).133
l’<strong>in</strong>terpretazione kantiana della prova ontologica “classica” assume unvalore del tutto speciale, poiché avviene all’<strong>in</strong>terno della nuova problematizzazioneontologica procurata dai sistemi del fenomenismo –sistemi che, si vorrebbe ancora sostenere, comprendono ciò che nellastoriografia viene comunemente detto razionalismo come pure ciòche viene detto empirismo, una volta che si assuma come centraleper entrambi l’“errore” di affermare la cont<strong>in</strong>uità tra ambito del sensibilee ambito dell’<strong>in</strong>tellettuale 135 .Converrà verificare questo <strong>in</strong>tero nodo problematico con un m<strong>in</strong>imodi dettaglio, <strong>in</strong>iziando con il Kant precritico che, come subito sivedrà, rispetto a quell’esperimento cruciale che è l’argomento ontologicodice di più (mette un più forte accento sul ruolo della modalizzazionelogica nel costituirsi della nostra conoscenza) e di meno (nonsviluppa sistematicamente le implicazioni di una dist<strong>in</strong>zione reale traestetico e logico per la def<strong>in</strong>izione gnoseologica dell’esistenza) chenelle pag<strong>in</strong>e corrispondenti della prima Critica 136 .Il primo scritto kantiano di rilievo per la questione che qui <strong>in</strong>teressaè quello dedicato all’Unico argomento possibile per l’esistenza di Dio(1763, Ak II: 63-163), la cui “Considerazione prima” si dedica allaquestione dell’esistenza <strong>in</strong> generale, per affermare <strong>in</strong>nanzitutto chequello di “esistente” non è un predicato, poiché già a un ente possibilequalsiasi non difetta alcuna determ<strong>in</strong>azione e, dunque, alcun predicato(ibidem, § 1) 137 . E aggiunge:pure, noi ci serviamo dell’espressione ‘esistenza’ come di un predicato; equesto si può fare sicuramente e senza <strong>in</strong>quietanti errori, purché non ci sia135 Si acconsente qui alla tesi storiografica di BENNETT (1974).136 Scribano rileva, nel transito dal saggio sull’Unico argomento alla prima Critica, essenzialmenteuna doppia amplificazione: “lo schema disegnato nello scritto precritico siamplifica e si complica per il darsi di due circostanze: 1) l’ente materialmente necessariodell’Unico argomento è diventato l’ideale trascendentale, ossia il deposito di tutti i predicatipossibili che consentono la determ<strong>in</strong>azione completa di ogni concetto […]; 2) oltre chedescrivere una situazione, Kant mira a spiegarne la genesi attraverso le esigenze e le tentazioni<strong>in</strong>evitabili della ragione” (SCRIBANO 1994: 214).137 In tale posizione kantiana si scorge normalmente un’eco di HUME: “Non c’è differenzatra riflettere sopra una cosa semplicemente e riflettere su di essa <strong>in</strong> quanto esistente:quell’idea, unita all’idea di un oggetto, non aggiunge niente […] Ogni idea che ciformiamo, è l’idea di un essere; e l’idea di un essere è ogni idea che ci piaccia formare”(1739-40 I, II, 6).134
pericolo di voler dedurre l’esistenza da concetti semplicemente possibili,come si suol fare quando si vuole provare l’esistenza assolutamente necessaria(ibidem).Invalidata così la versione wolffiana della prova ontologica, ossianegata ogni eccezione all’avvertenza dello stesso <strong>Wolff</strong> circa il mododi <strong>in</strong>tendere la “necessità assoluta” delle essenze, rimane però accettatoil fatto che l’esistenza la si predichi normalmente. E ciò viene così<strong>in</strong>terpretato da Kant: “Nei casi […] <strong>in</strong> cui l’esistenza si presenta comeun predicato nel parlare comune, essa non è tanto un predicato dellacosa, quanto piuttosto del pensiero che se ne ha”; ad esempio: “alliocorno di mare (Seee<strong>in</strong>horn = narvalo) spetta l’esistenza, a quello diterra (Lande<strong>in</strong>horn) no” (ibidem). Ossia, quasi <strong>in</strong>crociando Locke 138 conHume:<strong>in</strong> questa affermazione circa l’esistenza di una tal cosa, per dimostrarnel’esistenza non si <strong>in</strong>daga il concetto del soggetto, poiché <strong>in</strong> esso si trovanosoltanto predicati relativi alla sua possibilità, bensì l’orig<strong>in</strong>e della conoscenzache ho della cosa. Si dice: l’ho vista […] Perciò non si parla del tutto esattamentequando si dice: il liocorno mar<strong>in</strong>o è un animale esistente; [va detto]138 Nel libro IV del Saggio (1700 4 ), al capitolo II (“Dei gradi della nostra conoscenza”),LOCKE formula un problema dell’esistenza ormai <strong>in</strong>quadrato <strong>in</strong> quello della realtà del“mondo esterno”, quando si trova costretto ad ammettere che oltre a <strong>in</strong>tuizione e dimostrazione(nonché a fede e op<strong>in</strong>ione, che non raggiungono il grado di certezza delleprecedenti) si dà “un’altra percezione (Perception) della mente che si esercita <strong>in</strong>torno allaparticolare esistenza degli esseri f<strong>in</strong>iti fuori di noi e che […] va sotto il nome di conoscenza”(§ 14). Rispetto al problema della realtà di tali esseri, Locke ha una risposta perfettamentel<strong>in</strong>eare: “credo ci sia dato un elemento di prova che ci libera da qualunquedubbio. Chiedo <strong>in</strong>fatti a chiunque se non sia <strong>in</strong>v<strong>in</strong>cibilmente consapevole di fronte a sestesso di una percezione diversa quando guarda il sole di giorno e quando vi ripensa d<strong>in</strong>otte; quando di fatto gusta l’assenzio o fiuta una rosa, oppure pensa a quel sapore o aquell’odore. Troviamo <strong>in</strong> modo altrettanto facile la differenza che c’è fra un’idea qualunquerisvegliata nella mente dalla nostra memoria e quella che di fatto ci viene nellamente per il tramite dei sensi, quanto la differenza che c’è fra due qualunque idee dist<strong>in</strong>te”(ibidem). Sicché, <strong>in</strong> conclusione, possediamo “tre gradi della conoscenza: <strong>in</strong>tuitivo,dimostrativo e sensorio (<strong>in</strong>tuitive, demonstrative, and sensitive)” (§ 14). Locke preciserà ancorache quanto alla conoscenza “dell’esistenza reale e attuale delle cose, abbiamo una conoscenza<strong>in</strong>tuitiva della nostra propria esistenza, e una conoscenza dimostrativadell’esistenza di Dio; dell’esistenza di qualunque altra cosa non abbiamo che una conoscenzasensoria, che non si estende al di là degli oggetti presenti ai nostri sensi” (ibidemIV, III, § 21).135
<strong>in</strong>vece: a un certo animale esistente spettano i predicati che io penso complessivamente[nel concetto di] un liocorno (ibidem).Se non è una predicazione genu<strong>in</strong>a, dunque, l’affermazione dell’esistenzadi <strong>qualcosa</strong> ne sarà la mera attestazione empirica; e quello di“esistere” si dist<strong>in</strong>guerà come tale da ogni altro predicato, che si riferisceessenzialmente a un ente possibile. A questo punto, Kant non fache riapplicare l’analisi dell’asserzione “il liocorno mar<strong>in</strong>o è un animaleesistente” al caso della prova ontologica.Quando dico: Dio è una cosa esistente, pare che esprima la relazione di unpredicato con un soggetto. Ma <strong>in</strong> verità c’è un’<strong>in</strong>esattezza <strong>in</strong> questa espressione.A parlare correttamente, si dovrebbe dire: <strong>qualcosa</strong> di esistente èDio; ovvero: a una cosa esistente spettano quei predicati che complessivamentecontrassegniamo con l’espressione ‘Dio’ (ibidem, § 2).Lette queste ultime precisazioni, viene da dire che, mentre per<strong>Wolff</strong> l’esperienza, come posta alla base dell’argomento preontologico,è <strong>in</strong>nanzitutto esperienza di un <strong>qualcosa</strong> di esistente come di unacosa possibile (e dunque rappresentabile, significabile ecc.), per Kantl’esperienza è <strong>in</strong>nanzitutto il darsi attestabile di un <strong>qualcosa</strong> <strong>in</strong> quantoesistente, cui potranno poi accordarsi, o meno, dei predicati che sicollocano <strong>in</strong> una sfera diversa da quella dell’attestabilità: una sfera,cioè, logico-concettuale, ovvero del possibile. Formulata così unaconcezione dell’esistenza assai prossima a quella qu<strong>in</strong>eana (“essere ilvalore di una variabile”), Kant giunge allora a prefigurare (benché <strong>in</strong>modo ancora imperfetto) l’argomento dei cento talleri svolto nellaprima Critica, chiedendosi, di nuovo nella scia di Hume, se sia lecitodire che nell’esistenza di una cosa vi sia più che nella sua semplicepossibilità. E risponde di no – ma solo per quanto riguarda il quid: <strong>in</strong>fatti“per quanto riguarda il modo, dalla realtà è sicuramente posto dipiù” (ibidem, § 3). In altre parole: “<strong>in</strong> un esistente non è posto nullapiù che <strong>in</strong> un puro possibile” (i predicati rimangono i medesimi), “mada <strong>qualcosa</strong> di esistente è posto più che da un puro possibile” (ibidem).Dunque, è <strong>in</strong> quanto riguarda soltanto il momento della posizione assoluta(cioè la “realtà”) di un <strong>qualcosa</strong> che l’esistenza risulta non predicabile<strong>in</strong> senso proprio, <strong>in</strong> quanto cioè volesse riguardare il quid di136
un <strong>qualcosa</strong>, perché il quid predicabile è <strong>in</strong>teramente compreso giàdallo stesso <strong>qualcosa</strong> concepito come possibile.Il compito di precisare quali siano le condizioni dell’attestabilità,ovvero della “posizione” che f<strong>in</strong> qui valeva a caratterizzare il significatodi “esistenza”, com<strong>in</strong>cia a essere svolto <strong>in</strong> maniera orig<strong>in</strong>ale daKant nell’altro scritto qui decisivo, cioè nella dissertazione su La formadel mondo sensibile e del mondo <strong>in</strong>telligibile e i suoi pr<strong>in</strong>cipi (1770) 139 , di cuiimporterà <strong>in</strong>nanzitutto la seconda sezione, dedicata alla differenza trasensibili e <strong>in</strong>telligibili <strong>in</strong> generale. Kant, <strong>in</strong> questa sede, dopo averetracciato la dist<strong>in</strong>zione tra sensibile e <strong>in</strong>telligibile 140 , avanza due osservazionicruciali. Rileva <strong>in</strong>fatti, <strong>in</strong> primo luogo, che “le cognizioni devonocont<strong>in</strong>uare a essere considerate sensitive per quanto grande siastata la funzione logica esercitata attorno ad esse dall’<strong>in</strong>telletto” (e fal’esempio delle conoscenze geometriche; ibidem, § 5); e, d’altra parte,ammette che si danno <strong>in</strong>telligibili <strong>in</strong> senso stretto, ovvero concetti dioggetti e relazioni non astratti da alcun uso dei sensi (idee pure, cioè,da non confondersi con i concetti astratti, dati solo empiricamente;ibidem, § 6). Da tutto ciò non verrà solo la nota critica al cont<strong>in</strong>uismodelle gnoseologie di impianto wolffiano (espressa nel successivo §7) 141 , ma verranno anche le basi della sezione qu<strong>in</strong>ta, che illustra il139 Ci si discosta qui, per motivi sostanziali, dalla versione italiana del titolo di quest’operache è stata canonica f<strong>in</strong>o agli ultimi anni, condividendo la scelta <strong>in</strong>terpretativaoperata da H<strong>in</strong>ske nella sua edizione tedesca. L’autore della più recente traduzione italiana,Ciafardone, fa lo stesso, sempre sulla base di un preciso motivo teorico: “lo scritto<strong>in</strong>daga i pr<strong>in</strong>cipi non del mondo sensibile, bensì della forma di esso (l’uomo <strong>in</strong> quantoessere sensibile con le sue forme <strong>in</strong>tuitive pure dello spazio e del tempo), e il pr<strong>in</strong>cipionon del mondo <strong>in</strong>telligibile, bensì della sua forma (Dio <strong>in</strong> quanto ‘architetto’ e ‘creatore’del mondo), come mostrano chiaramente i titoli delle sezioni III (De pr<strong>in</strong>cipiis formaemundi sensibilis) e IV (De pr<strong>in</strong>cipio formae mundi <strong>in</strong>telligibilis)” (cfr. KANT 1763, trad. it., “Note”:73).140 Si noti che Kant traccia <strong>in</strong> realtà due dist<strong>in</strong>zioni, ponendole come equipollenti: quellatra sensibile e <strong>in</strong>telligibile (ibidem, § 3) e quella tra materia e forma (ibidem, §§ 4 ss.), su cuibasa la differenza tra uso reale e uso logico dell’<strong>in</strong>telletto.141 Kant vi ribadisce la tesi di una differenza reale (e non meramente logica) tra esteticoe <strong>in</strong>tellettuale, ma fornendone <strong>in</strong>nanzitutto una fondazione psicologico-empirica, affermandocioè che i dati sensitivi possono essere dist<strong>in</strong>ti e quelli <strong>in</strong>tellettuali confusi, comeavviene ad es., rispettivamente, nella geometria e nella metafisica. Tale argomento permarràcostante nella produzione kantiana; ancora nella Logica Jäsche (al cap. V dell’“Introduzione”,Ak IX: 33-39) troviamo quella che forse è una delle ultime revisioni dellaterm<strong>in</strong>ologia leibniziana del chiaro e del dist<strong>in</strong>to, dove Kant fa dipendere, rispettivamente,la chiarezza o l’oscurità di una conoscenza dalla conoscenza che l’accompagna; e137
“Metodo riguardo all’elemento sensitivo e all’elemento <strong>in</strong>tellettuale <strong>in</strong>questioni metafisiche”, vero punto di snodo per l’elaborazione dellaprospettiva critica della maturità. In queste pag<strong>in</strong>e, Kant afferma che<strong>in</strong> metafisica, la quale non ha pr<strong>in</strong>cipi dati <strong>in</strong>tuitivamente, non l’usodetta il metodo, né l’uso dell’<strong>in</strong>telletto è solo logico, bensì l’usodell’<strong>in</strong>telletto circa i pr<strong>in</strong>cipi è reale (il retto uso della ragione costituiscegli stessi pr<strong>in</strong>cipi): <strong>in</strong>somma, il metodo così <strong>in</strong>teso precede ogniscienza (ibidem, § 23). Ma la precede <strong>in</strong>nanzitutto negativamente: propriole vie di una conoscenza metafisica aprioristica vengono cosìsbarrate, se si <strong>in</strong>tavola un discorso metodico volto <strong>in</strong> primo luogo aprevenire quel “contagio tra cognizione sensitiva e cognizione <strong>in</strong>tellettuale”(ibidem) che, <strong>in</strong> virtù di presupposti che non avevano fattopienamente i conti con il fenomenismo, vizia per forza la metafisicawolffiana.I due scritti appena ricordati sono certo diversi quanto a obiettivie a orig<strong>in</strong>alità: <strong>in</strong> ogni caso, una volta stabilito perché quello di “esistere”non è un predicato e una volta resp<strong>in</strong>to quel modello metafisicoe gnoseologico che permette la contam<strong>in</strong>azione tra cognizionesensitiva e cognizione <strong>in</strong>tellettuale, sono raccolti ormai tutti gli elementiutili a confutare la prova ontologica che passeranno nella primaCritica. Ma, soprattutto, è ormai ben visibile come l’erroneità di taleprova risulti per Kant argomentabile assumendo che alla sua base stiaun significato scorretto della nozione di esperienza. Resta tuttavia a-perta una questione che riceverà piena risposta solamente dal Kantcritico; e cioè: che significato ha ammettere come naturale la possibilitàdi una simile contam<strong>in</strong>azione tra sensitivo e <strong>in</strong>tellettuale?la dist<strong>in</strong>zione dalla consapevolezza “del molteplice che <strong>in</strong> essa è contenuto”. Soprattutto,Kant vi discrim<strong>in</strong>a tra una “dist<strong>in</strong>zione sensibile” e una “dist<strong>in</strong>zione <strong>in</strong>tellettuale”.Ecco l’esempio della prima: vedo “la via lattea come una banda biancastra; i raggi lum<strong>in</strong>osidelle s<strong>in</strong>gole stelle che vi si trovano devono necessariamente essere pervenuti almio occhio. Ma la rappresentazione che ne avevo non era chiara e diventa dist<strong>in</strong>ta solocol telescopio, perché adesso scorgo le s<strong>in</strong>gole stelle contenute <strong>in</strong> quella banda colorlatte”. Ed ecco l’esempio della seconda: il rendersi conto che il concetto di virtù contienecome sue note “1) il concetto della libertà, 2) il concetto dell’adesione a regole (il dovere),3) il concetto del predom<strong>in</strong>io sulla forza delle <strong>in</strong>cl<strong>in</strong>azioni, <strong>in</strong> quanto esse si oppongonoa quelle regole”. A tale differenziazione fa da riscontro quella tra “perfezioneestetica” e “logica”: mentre la seconda si fonda sull’accordo della conoscenza conl’oggetto, la prima “consiste nell’accordo della conoscenza col soggetto e si fonda sullaparticolare sensibilità dell’uomo”.138
2. Esistenze sensibili, essenze idealiSi è r<strong>in</strong>viati, a questo punto, decisamente alla confutazione dell’argomentoontologico come svolta nella “Dialettica trascendentale”. Sitratta di uno dei brani della prima Critica più difficilmente segmentabili,per cui varrà la pena di provare <strong>in</strong>nanzitutto a isolarne <strong>in</strong> modoschematico gli snodi pr<strong>in</strong>cipali. Dunque, va subito detto che Kantpresenta l’argomento “classico”, nella sua versione <strong>in</strong>teramente modalizzata,impostando cioè la discussione sullo statuto ontologico diun’“entità (Wesen) assolutamente necessaria” (A 592 / B 620). Postele cose <strong>in</strong> questo modo, la soluzione, a questa altezza della prima Critica,parrebbe presto data: abbiamo di fronte una “semplice idea”, perquanto necessaria alla ragione, e necessaria <strong>in</strong> un duplice senso, regolativoe negativo – ciò che però non ne può dimostrare affatto la “realtàoggettiva” (ibidem) 142 . Il problema – anzi, ciò che pare “uno stranocontrosenso (befremdlich und widers<strong>in</strong>nlich)” – sta però qui:l’argomentazione che porta da un esistente (Dase<strong>in</strong>) <strong>in</strong> generale a un esistenteassolutamente necessario sembra pressante (dr<strong>in</strong>gend) e corretta, ma alcontempo ha contro di sé tutte le condizioni dell’<strong>in</strong>telletto per elaborare unconcetto di una siffatta necessità (ibidem).Il passo appena citato, solo <strong>in</strong> apparenza facile, presenta forse delledifficoltà che non conviene ascrivere semplicemente a trascuratezzastilistica. Invece, vanno isolati f<strong>in</strong> da subito due nuclei problematicidi ord<strong>in</strong>e piuttosto generale e non immediatamente ricavabili dalleparole di Kant appena citate, ma che evidentemente forniscono le l<strong>in</strong>eeguida delle argomentazioni messe <strong>in</strong> campo nel prosieguo dellasezione. Che sono: 1) il problema del passaggio da un genere (ovvero142 Basterebbe <strong>in</strong>fatti rimandare all’affermazione contenuta nelle primissime pag<strong>in</strong>edell’“Analitica”, secondo cui “la modalità dei giudizi è una loro funzione del tutto particolare,caratterizzata dal non contribuire <strong>in</strong> nulla al contenuto del giudizio […] ma diconcernere soltanto il valore della copula <strong>in</strong> rapporto con il pensiero <strong>in</strong> generale” (A 74/ B 99-100) – una dottr<strong>in</strong>a già estesa <strong>in</strong> quella dei “Postulati del pensiero empirico”, dovela confutazione dell’argomento ontologico (<strong>in</strong> forma modalizzata) come svolta nella“Dialettica” è prefigurata pienamente, <strong>in</strong>cluse le precisazioni <strong>in</strong>torno alla necessità che,<strong>in</strong> un uso empirico delle categorie (l’unico peraltro ammissibile nel conoscere genu<strong>in</strong>o),le categorie vengano riferite all’esperienza possibile.139
da un modo) di esistenza a un altro (nel brano precedente, da un’esistenza“<strong>in</strong> generale” a una s<strong>in</strong>gola esistenza necessaria) come passaggio<strong>in</strong> qualche maniera naturalmente forzato; e, <strong>in</strong> subord<strong>in</strong>e al primoproblema, quello 2) di precisare quali siano le difficoltà per l’<strong>in</strong>tellettonell’affrontare un simile passaggio.Ora, nell’ord<strong>in</strong>e testuale, il primo problema affrontato da Kant è,dei due, quello che appare il subord<strong>in</strong>ato. Kant rileva <strong>in</strong>fatti subitocome “<strong>in</strong> ogni tempo” rispetto all’ente assolutamente necessario “piùche preoccuparsi di stabilire se e come sia possibile anche soltantoconcepire <strong>qualcosa</strong> del genere, ci si è dedicati a dimostrarne l’esistenza”(ibidem), rileva cioè come quel passaggio così “strano” dall’esperirel’esistenza delle cose comuni ad argomentare circa l’esistenza necessariasia stato, di fatto, cont<strong>in</strong>uamente praticato. E va notato comeproprio nel separare la facilissima def<strong>in</strong>izione verbale di quest’ultimoconcetto dalla sua ben più problematica pensabilità (più esattamente,aggredendo <strong>in</strong> quanto solo verbale la nozione dell’assoluta impensabilitàdel non essere di una cosa) Kant traduca la def<strong>in</strong>izione di enteassolutamente necessario <strong>in</strong> quella di “<strong>qualcosa</strong> il cui non essere è impossibile”(ibidem) 143 . La mossa appare <strong>in</strong>fatti calcolata: così facendo,Kant <strong>in</strong>izia a spostarsi verso il primo e il pr<strong>in</strong>cipale dei due problemi,ossia <strong>in</strong>izia a <strong>in</strong>trodurre il tema della esemplificabilità di un simile entenell’esperienza conoscitiva – riuscendo a portare <strong>in</strong> campo tutti glistrumenti di cui si era munito nell’ultimo capitolo dell’ “Analitica”(“Sul fondamento della dist<strong>in</strong>zione di tutti gli oggetti <strong>in</strong> generale <strong>in</strong>Phaenomena e Noumena”). E, nella fattispecie, adduce <strong>in</strong>nanzitutto ilcaso degli enti geometrici (esemplificati, come già <strong>in</strong> <strong>Wolff</strong>, dal trian-143 Per una più dettagliata delucidazione di questo passaggio, cfr. JOHNSON (1981: 724-737). Per una valutazione critica del modo <strong>in</strong> cui MALCOLM (1960) <strong>in</strong>terpreta il rapportoche si dà nella prova ontologica “classica” tra le formule di “esistenza (logicamente) necessaria”e di “impossibilità (logica) della non esistenza”, cfr. SCRIBANO (1994: 20-26).Va osservato, ancora, che la pregevole discussione svolta da Bennett considerando traducibiligli argomenti kantiani <strong>in</strong> quelli di MALCOLM (1960), relativi alla sola esistenzanecessaria (BENNETT 1974: 232-237), non pare del tutto pert<strong>in</strong>ente: come si vedrà, aKant non preme <strong>in</strong>fatti giungere alla conclusione di Malcolm ripresa da Bennett, secondocui “poiché ‘esistente’ non dovrebbe apparire <strong>in</strong> alcun term<strong>in</strong>e def<strong>in</strong>itorio, ‘esistente<strong>in</strong> modo necessario’ non dovrebbe figurare affatto” (ibidem, 236); piuttosto, a Kant importeràconcludere su un’affermazione del tipo “‘<strong>qualcosa</strong> di necessariamente esistente’non è un oggetto genu<strong>in</strong>o”.140
golo fornito delle sue proprietà essenziali) <strong>in</strong> quanto le proposizioniche vi si riferiscono sono assolutamente necessarie. Ora, proprio quisi colloca il primo vero argomento kantiano radicalmente negativo sulpiano ontologico: “Tutti gli esempi addotti <strong>in</strong> proposito, senza eccezione,sono tratti soltanto da giudizi, mai da cose e dalla loro esistenza”(A 593 / B 621). Da questo momento <strong>in</strong> poi, <strong>in</strong>trodotta cioè la separazionetra sfera logica e sfera del reale, il discorso di Kant può svilupparsiper confutazioni successive che lo portano verso l’atto conclusivo,vale a dire la ripresa dell’argomento precritico della surrezione,applicato alla questione dello statuto esistenziale di cento ipoteticitalleri rispettivamente solo concepiti oppure effettivamente percepibili.Più <strong>in</strong> dettaglio, nel discorso kantiano si possono isolare qui c<strong>in</strong>quepassaggi.1) Si torna <strong>in</strong>nanzitutto a mettere <strong>in</strong> campo la dist<strong>in</strong>zione, già <strong>in</strong>vocata,fra “giudizi” e “cose”.Se <strong>in</strong> un giudizio identico nego il predicato e mantengo il soggetto, ne risultauna contraddizione; io dico perciò che quel predicato spetta necessariamentea questo soggetto. Ma se nego il soggetto assieme al predicato, nonsorge nessuna contraddizione, visto che non c’è più nulla con cui si possa entrare<strong>in</strong> contraddizione (A 594 / B 622).Torna così l’esempio geometrico (è contraddittorio porre untriangolo e negarne i tre angoli, mentre non lo è negare il darsi di untriangolo) utilizzato per dimostrare che lo stesso vale anche per l’enteassolutamente necessario (posto dio, è contraddittorio negarne l’onnipotenza,ma nel negare dio non è <strong>in</strong>sita alcuna contraddizione; A595 / B 623).2) Si passa qu<strong>in</strong>di a smascherare una possibile petitio pr<strong>in</strong>cipii.Non rimane dunque alcun’altra via di scampo se non quella di dire: si dannosoggetti che non possono assolutamente venire negati […] Ma ciò equivarrebbea dire: si danno soggetti assolutamente necessari; un presupposto,questo, la cui legittimità è appunto qui messa <strong>in</strong> questione e la cui possibilitàva provata (ibidem).141
3) Nello stesso giro di questo capoverso, tuttavia, Kant rileva comela petitio pr<strong>in</strong>cipii non riposi su una tautologia semplice. Ribadendo<strong>in</strong>fatti che è impossibile formarsi il concetto di una cosa “che, unavolta negata <strong>in</strong>sieme a tutti i suoi predicati, farebbe <strong>in</strong>sorgere unacontraddizione”, Kant ricorda che senza contraddizione è peraltroimpossibile avere “mediante semplici concetti puri a priori” un qualchecriterio di impossibilità (A 595-6 / B 623-4).4) Si affaccia così l’ultimo sottoargomento a favore, e cioè quellodell’unicità del concetto del più reale fra gli enti. Che si articola, deltutto nella scia dell’argomento “classico” di Anselmo (e della prova apriori di <strong>Wolff</strong>), nell’affermazione della possibilità di tale ente <strong>in</strong> quantopensabile, nella deduzione dell’esistenza dalle sue proprietà e nellareductio ad absurdum della sua negazione (negando la cosa, si negherebbe<strong>in</strong> questo caso la possibilità <strong>in</strong>terna della cosa, cioè la sua essenza).Kant svolge allora due controargomentazioni. La prima, sviluppata <strong>in</strong>sord<strong>in</strong>a (<strong>in</strong> una nota), non viene sfruttata appieno da Kant – moltoverosimilmente poiché co<strong>in</strong>volge f<strong>in</strong> da subito opzioni epistemologichetroppo pesanti, che ricompariranno comunque <strong>in</strong> maniera piùgraduale nello sviluppo della seconda 144 . La seconda controargomentazioneè <strong>in</strong>vece quella che porta al caso dei cento talleri, denunciandocome fallace l’<strong>in</strong>trodurre la nozione di esistenza nel concetto diuna cosa. Questa si svolge <strong>in</strong> due fasi, muovendo dalla questione seuna predicazione di esistenza sia analitica oppure s<strong>in</strong>tetica.5.1) Prima opzione: la predicazione di esistenza è analitica. Ma <strong>in</strong>questo caso l’esistenza della cosa non aggiunge nulla al “pensiero dellacosa”: e allora, o si tratta di un’entità puramente mentale (“il pensieroche è <strong>in</strong> voi dovrebbe essere la cosa stessa”), o si ricade nella petitiopr<strong>in</strong>cipii (“avete presupposto un’esistenza come appartenente alla144 Kant ammonisce che “il concetto che non contraddice a se stesso” è “ben lungi daldimostrare la possibilità dell’oggetto”, giacché occorre dist<strong>in</strong>guere tra “possibilità deiconcetti (logica)” e “possibilità delle cose (reale)”: <strong>in</strong>fatti, <strong>in</strong> base al criterio logico dellapossibilità, un concetto è possibile se non è autocontraddittorio, ma può comunque risultarevuoto, quando cioè “non si provi dist<strong>in</strong>tamente la realtà oggettiva della s<strong>in</strong>tesionde il concetto è prodotto” (A 596 / B 624, nota). L’opzione epistemologica forte <strong>in</strong>questione è quella che pretende una genesi realmente s<strong>in</strong>tetica aff<strong>in</strong>ché un concetto siasicuramente non-vuoto.142
possibilità, dando poi a vedere di ricavare l’esistenza dalla possibilità<strong>in</strong>terna”; A 597 / B 625).5.2) Seconda opzione: si assume che la predicazione di esistenza(“com’è giusto che faccia ogni uomo ragionevole”) sia s<strong>in</strong>tetica (A598 / B 626). In tal caso, però, il predicato (o pseudopredicato) di e-sistenza può essere negato senza contraddizione, visti gli argomentigià considerati (cfr. A 595 / B 623).A questo punto, Kant tira le somme. Il pervicace tentativo dimantenere la validità dell’argomento ontologico sarebbe dovuto auna persistente “illusione”, quella che sorge dallo “scambio di unpredicato logico con un predicato reale (cioè con il predicato che determ<strong>in</strong>auna cosa)”; e mentre da predicato logico può fungere “qualsiasicosa” (pers<strong>in</strong>o il medesimo soggetto, come nelle tautologie), soloil predicato reale “si aggiunge al concetto del soggetto” e “lo accresce”(ibidem). Ma il semplice essere non è un predicato reale, mentrela copula non fa che mettere <strong>in</strong> relazione soggetto e predicato, ossiaoggetto e concetto (A 598-9 / B 626-7).Per comprendere come la “cosa” data nell’esperienza wolffiana risultiqui del tutto dissolta, va tenuto fermo questo passaggio da “soggettoe predicato” a “oggetto e concetto”, e bisogna seguire ancoraKant per un tratto. Se concediamo quanto detto s<strong>in</strong>ora, abbiamo che“oggetto e concetto non possono avere che un contenuto rigorosamenteidentico”, per cui al secondo “nulla può essere aggiunto per ilfatto che il suo oggetto sia pensato come assolutamente dato (mediantel’espressione ‘è’)”; e giacché il concetto “esprime semplicementela possibilità”, “il reale non contiene nulla di più che il semplicementepossibile”. In questo senso, cento talleri reali non “contengono”nulla di più che cento talleri possibili, benché la loro equivalenzanon sia tale “rispetto alle mie disponibilità economiche” – ossia,“riguardo alla realtà”, giacché qui “l’oggetto non è semplicementecontenuto <strong>in</strong> modo analitico nel mio concetto, ma si aggiunge s<strong>in</strong>teticamenteal mio concetto” (A 599 / B 627) 145 . Ed è allora chiaro che145 Qui risulta pert<strong>in</strong>ente la critica di Bennett alla tesi secondo cui una proposizione esistenzialenon aggiunge nulla a una proposizione determ<strong>in</strong>ativa, anche completa; perBennett, al contrario, si può sostenere che “ciò che esiste è sempre ‘più di quanto avevamopensato nel concetto’”, negando la possibilità di una determ<strong>in</strong>azione completa esostenendo che se potessimo davvero “determ<strong>in</strong>are completamente” una cosa nel con-143
la s<strong>in</strong>tesi di cui qui si tratta – fra oggetto e concetto – risulta davverospeciale, e tale da mettere <strong>in</strong> crisi ogni trattazione del problemadell’esistenza da parte di un’ontologia essenzialistica, entro cui unasimile s<strong>in</strong>tesi non ha spazio legittimo.Bisogna ora restare su questo punto, perché è proprio qui cheKant si avvic<strong>in</strong>a (ma <strong>in</strong> maniera ben più meditata che negli scrittiprecritici) al Locke che prevede un’apposita “conoscenza sensoria”dell’esistenza delle cose del “mondo esterno” (cfr. supra, p. 135, n.138). Quando ne va davvero dell’esistenza, <strong>in</strong>fatti, per Kant non nepuò andare semplicemente di un rapporto tra soggetto e predicato<strong>in</strong>tesi come due concetti, bensì <strong>in</strong>nanzitutto della relazione tra oggettoe concetto, la quale si dà quando lo “stato complessivo del miopensiero” sottostà alla condizione per cui la conoscenza dell’oggetto<strong>in</strong>teso risulta “possibile anche a posteriori” (A 600 / B 628). Sicché nelcaso degli oggetti sensibili non è possibile sbagliarsi <strong>in</strong> proposito,scambiando il “mero concetto della cosa” con “l’esistenza della cosa”(ibidem). Sul piano (logico) dell’<strong>in</strong>telletto, <strong>in</strong>vece, non si darà mai alcuncriterio per dist<strong>in</strong>guere tra esistenza e semplice possibilità (A 601 / B629), pur possedendo sempre, come si è visto, il criterio (solo negativo)del pr<strong>in</strong>cipio di contraddizione. Ossia: nel caso di un oggetto genu<strong>in</strong>o,“<strong>in</strong> virtù dell’esistenza” tale oggetto “viene pensato come contenutonel contesto di tutta quanta l’esperienza”, con il che il suoconcetto non si accresce affatto, ma il nostro pensiero riceve “unapercezione possibile <strong>in</strong> più” (A 600-1 / B 628-9). Dobbiamo <strong>in</strong> altreparole (cioè secondo la direzione <strong>in</strong>versa rispetto a quella che portadall’oggetto al concetto) “uscir fuori” da un concetto, se vogliamo“attribuire l’esistenza” al suo oggetto: e ciò può avvenire solo riguardoagli oggetti dei sensi, “mediante la connessione con una determ<strong>in</strong>atapercezione, secondo leggi empiriche” (A 601 / B 629). Insomma,esiste solo ciò che – letteralmente – ha un senso 146 , soltanto ciòcetto “forse questo ci porterebbe automaticamente a pensarla come esistente” (BENNETT1974: 230). L’argomentazione non pare tuttavia esauriente, giacché non tocca l’estensionekantiana dei criteri di predicabilità all’esperienza possibile, ciò che <strong>in</strong> effetti rendesuperflua l’ipotesi di una determ<strong>in</strong>azione (ma anche di una determ<strong>in</strong>abilità) concettualecompleta di un oggetto ai f<strong>in</strong>i di una posizione di realtà.146 Altrove, e cioè sempre nel capitolo conclusivo dell’ “Analitica” dedicato alla dist<strong>in</strong>zionetra fenomeni e noumeni, Kant afferma s<strong>in</strong>tomaticamente che senza rendere sen-144
che potremmo almeno virtualmente collocare nel contesto dei nostripercetti, per quanto possiamo avere un’idea di molti altri enti per iquali è tuttavia impossibile discrim<strong>in</strong>are tra possibilità ed esistenza.Rispetto alla confutazione precritica, a parte gli spostamenti di accento,compaiono allora almeno tre elementi nuovi, tutti relativi, comesi è anticipato, alla riflessione kantiana <strong>in</strong>iziata con la Dissertazionedel 1770 circa la possibilità di una contam<strong>in</strong>azione tra elemento sensitivoed elemento <strong>in</strong>tellettuale.1) L’argomento ontologico riposa su di una illusione logica – enon nel senso poi divenuto triviale di una caratterizzazione della ragioneche, diversa dall’<strong>in</strong>telletto, eroicamente e coattivamente si sp<strong>in</strong>geoltre i propri limiti, bensì nel senso che tale illusione può darsi solosul piano logico, mentre non può darsi nella conoscenza degli oggettigenu<strong>in</strong>i, entità sensibili o esperienze possibili che siano.2) D’altra parte (e si ricordi qui il richiamo alla “connessione conuna determ<strong>in</strong>ata percezione, secondo leggi empiriche”) l’esistenzanon si sente <strong>in</strong> modo immediato, non è un semplice dato dell’aisthesisfra gli altri, ma veramente la si attribuisce mediante un atto s<strong>in</strong>tetico,ossia solamente quando si “esce” da un concetto il cui carattere dipossibilità, come tale, è fuori di ogni spazio e di ogni tempo determ<strong>in</strong>ato147 .3) Per la dist<strong>in</strong>zione reale fra aisthesis e noesis, così come viene precisatanella discussione dell’argomento ontologico, alle rappresentazionipuramente logiche risulta mancare del tutto una qualità chespetta unicamente a quelle estetiche: quella di poter cogliere l’esistenzadei loro oggetti. Il piano logico-concettuale, privo di ogni criterioper dist<strong>in</strong>guere la possibilità dall’esistenza, rispetto a tale dist<strong>in</strong>zioneè del tutto cieco. Ma, viceversa, alle rappresentazioni estetichesibile un concetto astratto, vale a dire senza “mostrare nell’<strong>in</strong>tuizione l’oggetto ad essocorrispondente”, il concetto “rimarrebbe (come si dice) senza senso, cioè senza significato”(A 240 / B 300).147 Barnes, che discutendo delle posizioni assunte sull’argomento ontologico pone Kantfra i rappresentanti della tesi qu<strong>in</strong>eana dell’“esiste tutto”, f<strong>in</strong>isce per richiamarsi a Locke,affermando che “esistere, nel suo senso primario, è essere – non qualche cosa, ma <strong>in</strong>qualche luogo, e dunque <strong>in</strong> qualche tempo” (BARNES 1972: 63). Si vorrebbe solo ricordareche questa def<strong>in</strong>izione si accorda perfettamente con quella kantiana di realtà, fornitanello “Schematismuskapitel” (A 143 / B 182-3).145
manca (e <strong>in</strong> l<strong>in</strong>ea di pr<strong>in</strong>cipio) la possibilità di una piena determ<strong>in</strong>azionequanto al loro quid. In breve: il rapporto fra estetico e logiconon si configura più soltanto come una differenza reale, ed essenzialeper il darsi della conoscenza. Oltre a ciò, il rapporto fra estetico e logicosi configura anche come un chiasma; estetica e logica sono def<strong>in</strong>iteda una deficienza speculare e simmetrica: rispetto alla capacità diattuare una piena determ<strong>in</strong>azione del quid / rispetto alla capacità dicoglierne l’esistenza.Si vorrebbe <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e azzardare un tentativo di chiarimento <strong>in</strong>torno aquest’ultimo problema. Che andrebbe forse riformulato così: postoche la conoscenza riferita a oggetti possa venire spiegata <strong>in</strong>teramentenei term<strong>in</strong>i kantiani di una mediazione fra sensi e <strong>in</strong>telletto, e data i-noltre la carenza speculare di estetica e logica, la quale fa sì che non sidia conoscenza se non di oggetti (magari solo virtualmente esperibili),quale modo c’è per dist<strong>in</strong>guere un mero gioco (solo logico) con lerappresentazioni da un possibile uso legittimo del pensiero <strong>in</strong>oggettuale,come è ad esempio l’impiego delle idee della ragione per scopieuristici? 148 La formulazione che si è appena scelta dovrebbe permetteredi utilizzare ai f<strong>in</strong>i di un chiarimento il brano <strong>in</strong> cui Kant def<strong>in</strong>iscela rappresentazione come il genere di tutti gli atti o manifestazionidel conoscere e passa qu<strong>in</strong>di a elencarne le specie (Dialettica, I, I,“Delle idee <strong>in</strong> generale”; A 312 / B 368 ss.), sunteggiato nella seguentetabella.148 Si è spesso ravvisato (cfr. ad es., di recente, KRINGS 1996) nella dialettica trascendentalenon solo il perseguimento di un f<strong>in</strong>e negativo, ma anche la risposta a una precisadomanda cui non può rispondere l’analitica, ossia: “Come possono le esperienze <strong>in</strong> generale,ovvero gli oggetti <strong>in</strong> generale, costituire un ‘sistema’ empirico […] e non un meroaggregato?” (ibidem, 228). Anche per Kr<strong>in</strong>gs tale risposta consiste nel def<strong>in</strong>ire la funzioneregolativa delle idee <strong>in</strong> quanto differenti dai concetti di oggetti – risposta che siprolungherà poi <strong>in</strong> una terza Critica <strong>in</strong>tesa <strong>in</strong>nanzitutto <strong>in</strong> un senso genu<strong>in</strong>amente epistemologico(ibidem, 229; ma cfr. pure GARRONI 1998).146
Fig. 11Nel brano corrispondente, Kant def<strong>in</strong>isce la rappresentazionecome genere e passa poi a elencarne le specie: ma, più esattamente,147
dopo avere <strong>in</strong>vitato a <strong>in</strong>tendere il term<strong>in</strong>e “idea” nel suo significatoplatonico orig<strong>in</strong>ario (ciò che qui più di tutto gli preme), elenca <strong>in</strong> successionegraduale altri term<strong>in</strong>i, più adatti a significare le altre specie dirappresentazioni, e <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e afferma: “Per chi si sia ormai abituato aquesta dist<strong>in</strong>zione, deve riuscire <strong>in</strong>sopportabile il sentir chiamare ideala rappresentazione del colore rosso” (A 320 / B 377). Quest’ultimafrase sembra denunciare l’obiettivo polemico dell’<strong>in</strong>tero discorso kantiano,e così chiuderlo. Ma il fatto di rilievo è ancora un altro: nellaprogressione che guida questa struttura classificatoria ascendente, eche grosso modo porta dall’estetico al logico e <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e all’ideale, l’<strong>in</strong>teraserie si colloca fra due estremi che segnano, <strong>in</strong>sieme, due limiti; equesto dato saliente non viene che r<strong>in</strong>forzato da due ulteriori osservazioni.1) Benché Kant si serva di questo schema per biasimare l’uso di“idea” per riferirsi al colore rosso, qui il “rosso” <strong>in</strong> realtà può via viaricadere sotto ognuna delle specie della rappresentazione, fuorchésotto le specificazioni del concetto 149 .2) Anche la def<strong>in</strong>izione generica del concetto è <strong>in</strong> qualche modoproblematica <strong>in</strong> se stessa: Kant, quando rammenta che la conoscenzaè <strong>in</strong>tuizione o concetto, precisa: “<strong>in</strong>tuitus vel conceptus” (ibidem). Ora,questo uso del “vel” sembra richiamare l’<strong>in</strong>tero ambito delle questionidispiegate nella confutazione dell’argomento ontologico (e, <strong>in</strong> generale,nella “Dialettica”), ma d’altra parte ancora non <strong>in</strong>terpreta ildarsi di idee <strong>in</strong>tese nel senso orig<strong>in</strong>ario voluto da Kant.Dunque: nello schema <strong>in</strong>terpretativo f<strong>in</strong> qui ricostruito, alla conoscenzaoggettuale (esteticamente) vuota, <strong>in</strong>tesa dalle percezioni senzacoscienza 150 , sembra corrispondere simmetricamente, al grado superiore,la conoscenza non oggettuale (vuota <strong>in</strong> senso assoluto) <strong>in</strong>tesadalle idee. Entrambi questi casi limite della rappresentazione sembrano<strong>in</strong>oltre corrispondere ai rispettivi difetti (<strong>in</strong>capacità di att<strong>in</strong>gerecertezza / <strong>in</strong>capacità di att<strong>in</strong>gere all’esistenza) dell’estetico e del logi-149 Specificazioni che sono però a loro volta problematiche rispetto alla def<strong>in</strong>izione genericadel concetto come cognizione riferita all’oggetto “mediatamente, tramite una nota,che può essere comune a più cose” (A 320 / B 377), giacché tale def<strong>in</strong>izione sembracalzare solo per i concetti empirici.150 Che è parso necessario congetturare al grado <strong>in</strong>feriore delle rappresentazioni, <strong>in</strong>terpolandolesotto il vertice dello schema.148
co. Ma, ciò che più importa, proprio ponendo uno zero di oggettualitàa entrambi i suoi estremi, lo schema disegna una progressione a-scendente delle rappresentazioni che salva sia la dicotomia fondamentaletra estetico e logico (<strong>in</strong>sieme con la dottr<strong>in</strong>a del carattere oggettualedi ogni conoscenza genu<strong>in</strong>a), sia una funzione alle idee <strong>in</strong>teseprecisamente come “archetipi delle cose stesse” (A 313 / B 370) –funzione che, al di là della lettera kantiana, può essere riconosciutaanche nell’“essenza necessaria” di <strong>Wolff</strong>, quando si consideri che, alpari dell’idea platonica, configura una “cosa” che appare vuota soltantorispetto all’esistenza <strong>in</strong> atto e attestata dall’aisthesis, ciò che valea specificarne il senso di “complemento della possibilità”.A questa lettura può essere dato un ulteriore appoggio. Alla lodedi Platone <strong>in</strong>tessuta da Kant nell’<strong>in</strong>torno del brano della prima Criticaappena <strong>in</strong>terpretato fa da riscontro, altrove, l’accusa rivolta a una l<strong>in</strong>eadi pensiero che, <strong>in</strong>centrata sull’asse Leibniz-<strong>Wolff</strong>, risalirebbeproprio a Platone.Un grande errore della scuola leibniziano-wolffiana fu quello di fare consisterela sensibilità soltanto nelle rappresentazioni <strong>in</strong>dist<strong>in</strong>te, e l’<strong>in</strong>tellettualitànelle dist<strong>in</strong>te, e qu<strong>in</strong>di di vedere una differenza soltanto formale (logica) dellacoscienza, anziché reale (psicologica), riguardante cioè non la forma, ma ancheil contenuto del pensiero. In tal modo si faceva risiedere la sensibilitàsoltanto <strong>in</strong> una mancanza (mancanza di chiarezza delle rappresentazioni parziali),cioè nella mancanza di dist<strong>in</strong>zione, e <strong>in</strong>vece la natura della rappresentazione<strong>in</strong>tellettuale nella dist<strong>in</strong>zione, laddove la sensibilità è <strong>qualcosa</strong> dimolto positivo e costituisce un’aggiunta <strong>in</strong>dispensabile alla rappresentazionedell’<strong>in</strong>telletto per produrre una conoscenza.Leibniz è il vero colpevole. Poiché egli, attaccato alla scuola platonica,ammetteva delle <strong>in</strong>tuizioni <strong>in</strong>tellettuali pure <strong>in</strong>nate, delle idee, le qual<strong>in</strong>ell’animo umano sarebbero attualmente soltanto oscurate e che, analizzatee illum<strong>in</strong>ate dall’attenzione, ci darebbero la conoscenza degli oggetti come sono<strong>in</strong> se stessi (Anthropologie <strong>in</strong> pragmatischer H<strong>in</strong>sicht, Ak VII: 140-1, § 7, nota).Quest’apologia dell’estetica, dunque, fa da pendant alla critica dellalogica, ovvero della metafisica wolffiana che si è letta nella confutazionekantiana della prova ontologica f<strong>in</strong> qui considerata. Con la suaconfutazione della prova ontologica, cioè, Kant sosp<strong>in</strong>ge (e sostanzialmente,non sul solo piano della term<strong>in</strong>ologia discipl<strong>in</strong>are) quella149
che per <strong>Wolff</strong> era un’ontologia sul terreno della logica – su quello,cioè, che anche per <strong>Wolff</strong> era il terreno del concetto – staccato ormaidel tutto, <strong>in</strong> virtù di una dist<strong>in</strong>zione metafisica tra estetico e logico,dal terreno del reale. Resta però da dire che, se <strong>in</strong>terpretata come unconcetto kantiano, l’essenza wolffiana si manifesta con il carattere“pieno”, <strong>in</strong>tenzionale e doxastico, proprio dell’esperienza sensibile –ma f<strong>in</strong>isce tuttavia per porre dei limiti alla sensibilità, al pari dell’istanzakantiana dell’<strong>in</strong>telletto (A 288 / B 344) 151 , <strong>in</strong> quanto le ponecome limite quello del possibile. In tale prospettiva, la concezionewolffiana dell’esistenza come complemento della possibilità – complementosempre possibile per ogni <strong>qualcosa</strong> <strong>in</strong> generale – si rispecchia<strong>in</strong> quella dell’oggetto determ<strong>in</strong>ato soltanto con il pensiero, <strong>in</strong> unmodo cioè che “pur essendo una semplice forma logica senza contenuto,ci sembra <strong>in</strong>vece costituire una modalità di esistenza dell’oggetto<strong>in</strong> sé (noumeno)” (A 289 / B 346).151 Istanza che, per Kant, a questo scopo si costruisce un noumeno: “Il concetto d<strong>in</strong>oumeno non è qu<strong>in</strong>di il concetto di un oggetto, ma il problema, che la nostra sensibilitàporta <strong>in</strong>evitabilmente con sé, se possano sussistere oggetti del tutto <strong>in</strong>dipendentidall’<strong>in</strong>tuizione sensibile. A un problema del genere non è possibile che dare una risposta<strong>in</strong>determ<strong>in</strong>ata, e precisamente quella che segue: dato che l’<strong>in</strong>tuizione sensibile non sirapporta a tutte le cose <strong>in</strong>differentemente, resta un posto vacante per oggetti diversi, iquali pertanto non possono essere negati <strong>in</strong> l<strong>in</strong>ea assoluta, ma neppure possono venireaccolti come oggetti del nostro <strong>in</strong>telletto, mancando nei loro riguardi un oggetto determ<strong>in</strong>ato(visto che ogni categoria è <strong>in</strong>capace di determ<strong>in</strong>arlo)” (A 287-8 / B 344).150
ConclusioniCon <strong>Wolff</strong>, l’ontologia viene a stabilizzarsi e strutturarsi come unadiscipl<strong>in</strong>a posta alla base dell’albero delle scienze filosofiche, e <strong>in</strong> term<strong>in</strong>itali da avere <strong>in</strong>fluenza ben al di là del quadro tardoscolasticoillum<strong>in</strong>istico<strong>in</strong> cui ciò si compie. Lo testimonia già, ad esempio, ladef<strong>in</strong>izione che ne è ripresa nella Encyclopédie.Poiché gli esseri – sia spirituali, sia materiali – hanno alcune proprietà generali(come ad es. l’esistenza, la possibilità, la durata), l’esame di tali proprietà costituisce<strong>in</strong>nanzitutto quel ramo della filosofia da cui tutti gli altri derivano <strong>in</strong>parte i loro pr<strong>in</strong>cipi; e lo si chiama ontologia, o scienza dell’essere, o metafisicagenerale (D’ALEMBERT, <strong>in</strong> Encyclopédie, “Discours prélim<strong>in</strong>aire”: § 71).Ma, con ciò, tale discipl<strong>in</strong>a viene anche a consolidarsi nella formadi un tipo preciso di ontologia, quello <strong>in</strong> cui la scienza dell’“ente <strong>in</strong>quanto tale” viene di fatto ad approssimarsi a una dottr<strong>in</strong>a dei primielementi costitutivi delle essenze delle “cose”, f<strong>in</strong>o a diventarne quasi<strong>in</strong>dist<strong>in</strong>guibile. Le essenze di cui tratta, però, non sono determ<strong>in</strong>ate <strong>in</strong>senso strettamente sostanzialistico – ovvero <strong>in</strong>tese come ciò per cuiuna cosa è quel che è, anziché un’altra cosa, secondo la def<strong>in</strong>izionesem<strong>in</strong>ale di Aristotele (Met Z, 1). Un’ontologia di tipo wolffiano (e,storicamente, la discipl<strong>in</strong>a che per prima <strong>in</strong>contriamo con questonome nelle vicende della filosofia moderna) non risponde cioè alladomanda metafisica sul “che cosa” di un ente qualsiasi, bensì a questastessa domanda focalizzata sul carattere necessariamente possibile diogni <strong>qualcosa</strong>. Di qui la normalità della dottr<strong>in</strong>a che, entro tale ontologia,imposta il problema dell’esistenza come il problema del “complementodella possibilità” – lasciando aperto, come laterale, quellodella legittimità di def<strong>in</strong>ire tale “complemento” nei term<strong>in</strong>i di unaproprietà ascrivibile a questo o a quell’ente.151
Se ciò è vero, e considerando le vicende moderne – non irriducibilil’una all’altra – del sostantivo “ontologia” e dell’aggettivo “ontologico”,sarà allora ragionevole affermare che l’ontologia moderna econtemporanea, che appare <strong>in</strong>vece strettamente <strong>in</strong>centrata sulla questionedell’esistenza, ha le proprie radici storiche non soltanto nellavia per cui si è costituita l’ontologia wolffiana, ma (almeno) anche <strong>in</strong>un’altra, lungo cui tale questione è venuta a chiamarsi, appunto, “ontologica”<strong>in</strong> senso em<strong>in</strong>ente. Questa seconda via, poi, non appare affattounitaria, bensì composta grosso modo da due strade parallele, ovverodalla disputa sugli universali (<strong>in</strong> quanto vertente sul loro statuto“ontologico” – come normalmente si dice oggi) e soprattutto dal dibattitosulla dimostrazione “ontologica” dell’esistenza di dio, entrocui vengono a separarsi il significato <strong>in</strong> senso “logico” e <strong>in</strong> senso“statistico” di esistenza (cfr. supra, cap. VI). Questi due dibattiti hannoa lungo vissuto di una vita propria (e <strong>in</strong>dipendente dagli sviluppiper cui si è a un certo momento creduto necessario istituzionalizzarela metafisica generale sotto il nome di ontologia), tanto che nella nostracontemporaneità esibiscono una ben diversa presenza e vivacità.Ma, con un’evidenza particolare per il secondo, convergono già nell’essenzialismoproprio dell’ontologia di matrice wolffiana, s<strong>in</strong>o acondividere la crisi da essa patita nel momento <strong>in</strong> cui la “rivoluzionecopernicana” viene resa permanente nel kantismo. In altri term<strong>in</strong>i ancora,la questione dell’esistenza, che diventa centrale nell’ontologiapostkantiana e poi contemporanea, risulta <strong>in</strong> effetti un problema autonomo,per quanto trapiantato con esiti problematici su un terrenoparticolarmente fertile quanto equivoco, ossia quel particolare essenzialismoche con <strong>Wolff</strong> ha preso stabilmente il nome di ontologia.E f<strong>in</strong> qui si tratta di una tesi di cornice – storiografica e teorica –riguardante la storia delle idee. Perché essa regga, o cada, non importacioè che vada giudicato come più o meno estr<strong>in</strong>seco ognuno deidiversi motivi per cui la storia dell’ontologia di tipo wolffiano si sarebbedi fatto <strong>in</strong>trecciata strettamente con le due questioni “ontologiche”appena citate. Ma le pag<strong>in</strong>e che precedono sono state guidateanche da una tesi più circoscritta, e più legata a motivi teorici, relativacioè al ruolo di una <strong>psicologia</strong> metafisica che <strong>in</strong> <strong>Wolff</strong> avrebbe presole mosse dalle caratteristiche fondamentali dell’“immag<strong>in</strong>e manifesta”152
dell’esperienza umana, facendo sì che proprio con questo autore lacornice di cui sopra riuscisse a racchiudere un quadro sistematico lacui efficacia appare ancora oggi degna di attenzione. Per quest’ultimatesi resta allora da esplicitare una formula conclusiva – tale, se nonaltro, da renderla più agevolmente impugnabile. Si tenterà di farlo <strong>in</strong>due parole, nella consapevolezza che essa apre, a sua volta, il problemadi esplicitare e analizzare adeguatamente i diversi significati di “esistere”che sono presenti nell’“immag<strong>in</strong>e manifesta” dell’esperienzacomune.Con lo stabilizzarsi di un’ontologia def<strong>in</strong>ita <strong>in</strong> senso essenzialistico,è sembrato naturale che la <strong>psicologia</strong> (<strong>in</strong>tesa come una discipl<strong>in</strong>ametafisica, non importa se svolta <strong>in</strong> maniera “dogmaticamente” realistica)potesse dare una risposta al significato di “esistere”, ovvero di“modo di essere”, riferito alle cose esperibili, ord<strong>in</strong>ate secondo unascala ascendente, ma f<strong>in</strong>ita, di generalità o astrattezza. Questo, forse,perché le “cose” di cui sempre si parla <strong>in</strong> ogni ontologia esibiscono lamedesima “presenza amodale di un pensiero bene articolato un attimoprima che esso si produca <strong>in</strong> parole” (BOZZI 1999: 3).153
154
Rimandi bibliograficiOpere di <strong>Wolff</strong>Le opere di <strong>Wolff</strong> sono citate dalla seguente edizione: <strong>Wolff</strong> Ch., GesammelteWerke, neu herausgegeben und bearbeitet von J. École - H.W.Arndt - Ch.A. Corr - J.E. Hofmann - M. Thomann, Olms, Hildesheim -New York 1964 ss. A tale edizione rimanda la sigla WGW, seguita dall’<strong>in</strong>dicazionedi sezione (I = Deutsche Schriften, II = Late<strong>in</strong>ische Schriften, III= Materialien und Dokumente), volume/i ecc.L’unica eccezione è costituita dalla sola opera disponibile <strong>in</strong> edizione critica,ossia: <strong>Wolff</strong> Ch., Discursus praelim<strong>in</strong>aris de philosophia <strong>in</strong> genere, Frankfurt -Leipzig 1728, ed. critica a cura di G. Gawlick - L. Kreimendahl, Stuttgart-Bad Cannstatt 1996 (FMDA, I, 1)Per quello che si è def<strong>in</strong>ito (cfr. supra, pp. 35-37) opus logico-metaphysicum,si sono adottate le seguenti sigle, correnti <strong>in</strong> letteratura.DL = (1713) Vernünfftige Gedancken Von den Kräfften des menschlichenVerstandes Und Ihrem richtigen Gebrauche <strong>in</strong> Erkäntniss der Wahrheit, Halle(“Deutsche Logik”); riprod. ed. 1751 a cura di H.W. Arndt (WGW I, 1)DM = (1719) Vernünfftige Gedancken Von GOTT, Der Welt und der Seele desMenschen, Auch allen D<strong>in</strong>gen überhaupt, Den Liebhabern der Wahrheit mitgetheilet,Halle (“Deutsche Metaphysik”); riprod. ed. 1751 a cura di Ch.A. Corr(WGW I, 2)DM2 = (1724) Der vernünfftigen Gedancken von GOTT, der Welt und der Seeledes Menschen, auch allen D<strong>in</strong>gen überhaupt, Anderer Theil, bestehend <strong>in</strong> ausführlichenAnmerckungen, und zu besserem Verstande und bequemerem Gebrauche derselbenHerausgegeben, Frankfurt (“Anmerkungen zur deutschen Metaphysik”);riprod. ed. 1740 a cura di Ch.A. Corr (WGW I, 3)Disc = (1728) Discursus praelim<strong>in</strong>aris de philosophia <strong>in</strong> genere, Frankfurt -Leipzig, ed. critica a cura di G. Gawlick - L. Kreimendahl, Stuttgart-BadCannstatt 1996 (FMDA, I, 1)Log = (1728) Philosophia rationalis sive Logica, methodo scientifica pertractata etad usum scientiarum atque vitae aptata, Frankfurt - Leipzig; riprod. ed. 1740 acura di J. École (WGW II, 1)155
Ont = (1729) Philosophia prima, sive <strong>Ontologia</strong>, methodo scientifica pertractata,qua omnis cognitiones humanae pr<strong>in</strong>cipia cont<strong>in</strong>entur, Frankfurt - Leipzig; riprod.ed. 1736 a cura di J. École (WGW II, 3)Cos = (1731) Cosmologia generalis, methodo scientifica pertractata, qua adsolidam, <strong>in</strong>primis Dei atque naturae, cognitionem via sternitur, Frankfurt - Leipzig;riprod. ed. 1737 a cura di J. École (WGW II, 4)PsE = (1732) Psychologia empirica, methodo scientifica pertractata, qua ea, quaede anima humana <strong>in</strong>dubia experientiae fide constant, cont<strong>in</strong>entur et ad solidam universaephilosophiae practicae ac theologiae naturalis tractationem via sternitur, Frankfurt -Leipzig; riprod. ed. 1738 a cura di J. École (WGW II, 5)PsR = (1734) Psychologia rationalis, methodo scientifica pertractata, qua ea, quae deanima humana <strong>in</strong>dubia experientiae fide <strong>in</strong>notescunt, per essentiam et naturam animaeexplicantur, et ad <strong>in</strong>timiorem naturae ejusque auctoris cognitionem pro futura proponentur,Frankfurt - Leipzig; riprod. ed. 1740 a cura di J. École (WGW II, 6)TN1 = (1739) Theologia naturalis methodo scientifica pertractata. Pars prior,<strong>in</strong>tegrum systema complectens, qua existentia et attributa Dei a posteriori demonstrantur,Frankfurt - Leipzig; riprod. a cura di J. École (WGW II, 7)TN2 = (1741 2 ) Theologia naturalis methodo scientifica pertractata. Pars posterior,qua existentia et attributa Dei ex notione entis perfectissimi et natura animaedemonstrantur, et atheismi, deismi, fatalismi, naturalismi, sp<strong>in</strong>ozismi aliorumque de Deoerrorum fundamenta subvertuntur, Halle; riprod. a cura di J. École (WGW II, 8)Si segnala <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e la presenza di traduzioni italiane per le seguenti opere:Logica tedesca, a cura di R. Ciafardone, Bologna 1978;Metafisica tedesca con le Annotazioni alla Metafisica tedesca, a cura di R.Ciafardone, Milano 2003.Le traduzioni dei passi citati sono comunque svolte sulla base del testoorig<strong>in</strong>ale.Altre opereAk = Kant’s gesammelte Schriften, ed. a cura della Königlich PreussischeAkademie der Wissenschaften (e prosecutori), Berl<strong>in</strong> - Leipzig 1900- (nellacitazione delle Critiche si adopereranno i sistemi di abbreviazione <strong>in</strong> uso:KrV A = Kritik der re<strong>in</strong>en Vernunft ed. 1781, KrV B = Kritik der re<strong>in</strong>enVernunft ed. 1787; KpV = Kritik der praktischen Vernunft; KdU = Kritik derUrteilskraft)ALSTED J.H. (1630), Encyclopaedia septem tomis dist<strong>in</strong>cta, Herborn; riprod. acura di W. Schmidt-Biggemann, 4 voll., Stuttgart - Bad Cannstatt156
ANONIMO (1745), Psychologie ou traité sur l’âme, Contenant les Connoissances, quenous en donne l’Experiénce, par M. Wolf, Amsterdam (riprod. WGW III, 46)ANSELMO DA CANTERBURY, Proslogion, <strong>in</strong> A. Anselmi Opera Omnia.Recens. F.S. Schmitt, Stuttgart - Bad Cannstatt 1968, vol. IARNAUD T. (2002), Le critère du métaphysique chez <strong>Wolff</strong>. Pourquoi unePsychologie empirique au se<strong>in</strong> de la métaphysique, “Archives de philosophie ”,LXV, 1, pp. 35-46ARNDT H.W. (1971), Methodo scientifica pertractatum. Mos geometricusund Kalkülbegriff <strong>in</strong> der philosophischen Theoriebildung des 17. und 18.Jahrhunderts, Berl<strong>in</strong> - New YorkAYER A.J. (1956), The Problem of Knowledge, HarmondsworthBARNES J. (1972), The Ontological Argument, London - Bas<strong>in</strong>gstokeBARNES J. - SCHOFIELD M. - SORABJI R., a cura di (1979), Articles onAristotle. 3. Metaphysics, LondonBAUMANN P. (2002), Erkenntnistheorie, Stuttgart - WeimarBAUMGARTEN A.G. (1739), Metaphysica, Halle; riprod. ed. 1779,Hildesheim 1982BAUMGARTEN A.G. (1750-58), Aesthetica, 2 voll., Frankfurt/O; riprod.Hildesheim 1961BAUMGARTEN A.G. (1769), Sciagraphia Encyclopaediae Philosophicae, EdiditJoh. Christian Foerster [1741?], HalleBAUMGARTEN A.G. (1770), Philosophia generalis, Edidit cum dissertationeprooemiali De dubitatione et certitud<strong>in</strong>e Joh. Christian Foerster [1742?],Halle - Magdeburg; riprod. Hildesheim 1968BEETZ M. (1983), Transparent gemachte Vorurteile. Zur Analyse der‘praejudicia auctoritatis et praecipitantiae’ <strong>in</strong> der Frühaufklärung, “Rhetorik”, III,pp. 7-33BENNETT J. (1974), Kant’s Dialectic, CambridgeBILFINGER G.B. (1725), Dilucidationes philosophicae de Deo, anima humana,mundo et generalioribus rerum affectibus, Tüb<strong>in</strong>gen; riprod. Hildesheim 1982BILLER G. (1986), Die <strong>Wolff</strong>-Diskussion 1800 bis 1985. E<strong>in</strong>e Bibliographie,<strong>in</strong> SCHNEIDERS, a cura di (1986), pp. 321-346BOULNOIS O. (1999), Être et représentation. Une généalogie de la métaphysiquemoderne à l’époque de Duns Scot (XIIIe-XIVe siècle), ParisBOZZI P. (1989), Fenomenologia sperimentale, BolognaBOZZI P. (1999), Frammenti da opere perdute, “Rivista di estetica”, n.s., 10,pp. 3-24BURKHARDT H. - SMITH B., a cura di (1991), Handbook of Metaphysics andOntology, MünchenCAMPO M. (1938), Cristiano <strong>Wolff</strong> e il razionalismo precritico, Milano157
CARBONCINI S. (1991), Transzendentale Wahrheit und Traum. Christian<strong>Wolff</strong>s Antwort auf die Herausforderung durch den Cartesianischen Zweifel, Stuttgart-Bad CannstattCARBONCINI S. (2001), L’ontologia di <strong>Wolff</strong> tra scolastica e cartesianismo, <strong>in</strong>École, a cura di (2001), pp. 70-94CARTESIO (1641) = Oeuvres de Descartes, a cura di Ch. Adam e P.Tannery, vol. VII, Meditationes de prima philosophia, ried. a cura del CNRS,Paris 1964CATALDI MADONNA L. (2001), Christian <strong>Wolff</strong> und das System des klassischenRationalismus, Hildesheim - Zürich - New YorkCATTIN Y. (1986), La preuve de Dieu. Introduction à la lecture du Proslogion deAnselme de Canterbury, ParisCHISHOLM R.M. (1992), The basic ontological categories, <strong>in</strong> Mulligan, a curadi (1992), pp. 1-13CLEVE J. VAN (1973), Four Recent Interpretations of Kant’s Second Analogy,“Kant-Studien”, 64, pp. 71-87CORR C.A. (1972), Christian <strong>Wolff</strong>’s Treatment of Scientific Discovery,“Journal of the History of Philosophy”, 10, pp. 323-334COURTINE J.-F. (1990), Suárez et le système de la métaphysique, ParisD’AGOSTINI F. - VASSALLO N., a cura di (2002), Storia della filosofiaanalitica, Tor<strong>in</strong>oDAVIES J., a cura di (2003), Towards the Semantic Web. Ontology-drivenKnowledge Management, ChichesterDEJNOZKA J. (1996), The ontology of the analytic tradition and its orig<strong>in</strong>s:realism and identity <strong>in</strong> Frege, Russell, Wittgenste<strong>in</strong>, and Qu<strong>in</strong>e, LanhamDELFOSSE H.P. - KRÄMER B. - REINARDT E. (1987), Stellen<strong>in</strong>dex undKonkordanz zu Christian <strong>Wolff</strong>s “Deutscher Logik”, Stuttgart-Bad CannstattDENNETT D.C. (1978), Tre tipi di <strong>psicologia</strong> <strong>in</strong>tenzionale, trad. it. di E.Bassato, <strong>in</strong> DENNETT (1993), pp. 67-118DENNETT D.C. (1979), I veri credenti: la strategia <strong>in</strong>tenzionale e perché essafunziona, trad. it. <strong>in</strong> DENNETT (1993), pp. 27-65DENNETT D.C. (1993), L’atteggiamento <strong>in</strong>tenzionale, BolognaDIERSE U. (1977), Enzyklopädie. Zur Geschichte e<strong>in</strong>es philosophischen undwissenschaftstheoretischen Begriffs, BonnDILMAN I. (1984), Qu<strong>in</strong>e on Ontology, Necessity and Esperience. APhilosophical Critique, LondonDRYER D.P. (1984), The Second Analogy, <strong>in</strong> HARPER W. - MEERBOTE R., acura di, Kant on Causality, Freedom, and Objectivity, M<strong>in</strong>neapolis 1984, pp. 58-65ÉCOLE J. (1990), La métaphysique de Christian <strong>Wolff</strong>, 2 voll., Hildesheim -Zürich - New York158
ÉCOLE J. (2001a), Christian <strong>Wolff</strong>s Metaphysik und die Scholastik, <strong>in</strong>OBERHAUSEN - DELFOSSE - POZZO, a cura di (2001), pp. 115-128ÉCOLE J. (2001b), La place de la Metaphysica de ente, quae rectiusontosophia dans l’histoire de l’ontologie et sa réception chez Christian <strong>Wolff</strong>, <strong>in</strong>ÉCOLE, a cura di (2001), pp. 117-130ÉCOLE J. (2001c), Une étape de l’histoire de la métaphysique: l’apparition del’Ontologie comme discipl<strong>in</strong>e séparée, <strong>in</strong> ÉCOLE, a cura di (2001), pp. 95-116ÉCOLE J., a cura di (2001), Autour de la philosophie <strong>Wolff</strong>ienne, Textes deHans Werner Arndt, Sonia Carbonc<strong>in</strong>i-Gavanelli et Jean École, Hildesheim- Zürich - New YorkEncyclopédie = Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et demétiers, par une société de Gens de lettres (mis en ordre et publié par M.Diderot et quant à la partie mathématique, par M. D’Alembert) (28 voll.),Paris 1751-1765ENGFER H.J. (1982), Philosophie als Analysis. Studien zur Entwicklung philosophischerAnalysis-Konzeptionen unter dem E<strong>in</strong>fluß mathematischer Methodemodelleim 17. und frühen 18. Jahrhundert, Stuttgart - Bad CannstattENGFER H.J. (1986), Zur Bedeutung <strong>Wolff</strong>s für die Methodendiskussion derdeutschen Aufklärungsphilosophie: Analytische und synthetische Methode bei <strong>Wolff</strong> undbeim vorkritischen Kant, <strong>in</strong> SCHNEIDERS, a cura di (1986), pp. 48-65EUCKEN R. (1879), Geschichte der philosophischen Term<strong>in</strong>ologie, Leipzig;riprod. Hildesheim 1964FERRARIS M. (1994a), Analogon rationis, “Pratica filosofica”, 6, pp. 5-126FERRARIS M. (1994b), Orig<strong>in</strong>i della immag<strong>in</strong>azione trascendentale, “Annuariofilosofico”, 10, pp. 133-226FERRARIS M. (1997), Estetica razionale, MilanoFERRARIS M. (2001a), Il mondo esterno, MilanoFERRARIS M. (2001b), Un’ontologia per i Boe<strong>in</strong>g. [Un nuovo approccio, legato asituazioni concrete, antitetico allo studio dell'<strong>Essere</strong> della metafisica tradizionale. /Applicazioni utili per i sistemi assicurativi, la medic<strong>in</strong>a, l'<strong>in</strong>dustria, la proprietà<strong>in</strong>tellettuale], “Il Sole 24 Ore”, 18 marzo 2001FERRARIS M. (2003), <strong>Ontologia</strong>, NapoliFERRATER MORA J. (1963), On the early history of 'Ontology', “ Philosophyand Phenomenological Research”, 24, pp. 36-47FEUERHAHN W. (2002), Comment la psychologie empirique est-elle née?,“Archives de philosophie”, LXV, 1, pp. 47-64FRIEDMAN M. (1994), Kant and the Twentieth Century, <strong>in</strong> PARRINI P., acura di, Kant and Contemporary Epistemology, Dordrecht - Boston - London1994, pp. 27-46159
GARRONI E. (1998), Estetica ed epistemologia. Riflessioni sulla “Critica delgiudizio” di Kant, MilanoGAWLICK G. - KREIMENDAHL L. (1999), Stellen<strong>in</strong>dex und Konkordanz zuChristian <strong>Wolff</strong>s “Discursus praelim<strong>in</strong>aris de philosophia <strong>in</strong> genere”. Erstellt <strong>in</strong>Zusammenarbeit mit H.-W. Bartz. Unter Mitwirkung von H.P. Delfosseund K. Weckesser, Stuttgart-Bad CannstattGIBSON J.J. (1979), Un approccio ecologico alla percezione visiva, trad. it. di R.Luccio, con una Introduzione all’ed. it. di P. Bozzi e R. Luccio, Bologna 1999GOZZANO S., a cura di (2001), Mente senza l<strong>in</strong>guaggio. Il pensiero e glianimali, RomaGRIFFIN N. (1977), Relative Identity, OxfordGrimm = Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm,Leipzig -, 1854-1971 / (rielaborazione parz., voci A-F) Deutsches Wörterbuchvon J. Grimm und W. Grimm. Neubearbeitung. Hg. von der Akademie derWissenschaften der DDR <strong>in</strong> Zusammenarbeit mit der Akademie derWissenschaften zu Gött<strong>in</strong>gen, Leipzig 1961- / ed. elettronica a cura delgruppo “DFG-Projekt ‘DWB auf CD-ROM und im Internet’ – UniversitätTrier” (http://www.dwb.uni-trier.de/<strong>in</strong>dex.htm)HAMLYN D.W. (1961), Sensation and Perception. A History of the Philosophy ofPerception, London - New YorkHENNE H., a cura di (1975), Deutsche Wörterbücher des 17. und 18. Jahrhunderts,Hildesheim - New YorkHILL C.O. (1991), Word and object <strong>in</strong> Husserl, Frege, and Russell. The roots oftwentieth-century philosophy, Athens (OH)HINSKE N. (1986), <strong>Wolff</strong>s Stellung <strong>in</strong> der deutschen Aufklärung, <strong>in</strong>SCHNEIDERS, a cura di (1986), pp. 306-319HINTIKKA J. (1986), The Varieties of Be<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Aristotle, <strong>in</strong> KNUUTILA -HINTIKKA, a cura di (1986), pp. 81-114HONNEFELDER L. (1990), Scientia transcendens. Die formale Bestimmungder Seiendheit und Realität <strong>in</strong> der Metaphysik des Mittelalters und der Neuzeit (DunsScotus - Suárez - <strong>Wolff</strong> - Kant - Peirce), HamburgHOTSON H. (2000), Johann He<strong>in</strong>rich Alsted, 1588-1638: between Renaissance,Reformation, and Universal Reform, Oxford - New YorkHUME D. (1739-40), A Treatise on Human Nature: Be<strong>in</strong>g An Attempt to<strong>in</strong>troduce the experimental Method of Reason<strong>in</strong>g <strong>in</strong>to Moral Subjects, London, 3 voll.;ed. a cura di L.A. Selby-Bigge, Oxford 1888; ried. a cura di P.H. Nidditch,Oxford 1978INWAGEN P. VAN (1998), The Nature of Metaphysics, <strong>in</strong> LAURENCE -MACDONALD, a cura di (1998), pp. 11-21160
JÄGER M. (1980), Kommentierende E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong> Baumgartens ‘Ästhetica’,Hildesheim - New YorkJOHNSON H.J. (1981), The ontological argument and the language of “be<strong>in</strong>g”, <strong>in</strong>Sprache und Erkenntnis im Mittelalter. Akten des VI. <strong>in</strong>ternationalen Kongressesfür mittelalterliche Philosophie. Bonn 29. August - 3. September1977, Berl<strong>in</strong> - New York 1981, t. 2, pp. 724-737KANT I. (1763), De mundi sensibilis atque <strong>in</strong>telligibilis forma et pr<strong>in</strong>cipiis; trad. ted.e cura di N. H<strong>in</strong>ske, Von der Form der S<strong>in</strong>nen- und Verstandeswelt und ihren Gründen,<strong>in</strong> I. Kant, Werke <strong>in</strong> sechs Bänden, a cura di W. Weischedel, III, Wiesbaden 1958,1975 5 , pp. 7-107; trad. it. e cura di R. Ciafardone, Roma 2002KARSKENS M. (1992), The development of the opposition subjective versus objective<strong>in</strong> the 18th century, “Archiv für Begriffsgeschichte”, XXV, pp. 214-256KEN A. (1989), Onomasticon philosophicum lat<strong>in</strong>o-teutonicum et teutonicolat<strong>in</strong>um,TokioKIM Ch.W. (2001), Der Begriff der Welt bei <strong>Wolff</strong>, Baumgarten, Crusius undKant. E<strong>in</strong>e Untersuchung zur Vorgeschichte von Kants Weltbegriff von 1770, Trier(Diss.)KNUUTILA S. - HINTIKKA J., a cura di (1986), The Logic of Be<strong>in</strong>g, DordrechtKOBAU P. (2000), Estetica e logica nel razionalismo tedesco, “Rivista diestetica”, n.s., 13, pp. 5-58KOBAU P. (2001), Rischiaramento e iconoclastia. Due figure dell’Aufklärung(Thomasius / Kant), <strong>in</strong> Bett<strong>in</strong>i A. - Parigi S., a cura di, Studi sull’entusiasmo, conuna Prefazione di Paolo Rossi, Milano, pp. 153-181KOBAU P. (2002), Psicologia senza sentimenti: da <strong>Wolff</strong> a Dennett, <strong>in</strong> C.Bazzanella - P. Kobau, a cura di, Passioni, emozioni, affetti, Milano, pp. 37-61KOFFKA K. (1935), Pr<strong>in</strong>ciples of Gestalt Psychology, New YorkKRINGS H. (1996), Funktion und Grenzen der “transzendentalen Dialektik” <strong>in</strong>Kants Kritik der re<strong>in</strong>en Vernunft, <strong>in</strong> Schönrich G. - Kato Y., a cura di, Kant<strong>in</strong> der Diskussion der Moderne, Frankfurt/M 1996, pp. 225-239KROUGLOV A.N. (2003), Der Begriff transzendental bei J.N. Tetens: historischerKontext und H<strong>in</strong>tergründe, “Aufklärung: <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>äres Jahrbuch zur Erforschungdes 18. Jahrhunderts und se<strong>in</strong>er Wirkungsgeschichte”, XV, i.c.p.LAUDAN L. (1977), Il progresso scientifico. Prospettive per una teoria, trad. it.Roma 1979LAURENCE S. - MACDONALD C., a cura di (1998), Contemporary Read<strong>in</strong>gs<strong>in</strong> the Foundations of Metaphysics, OxfordLEGRENZI P., a cura di (1980), Storia della <strong>psicologia</strong>, BolognaLEIBNIZ G.W. (1710) [?, “Sull’anima delle bestie”], <strong>in</strong> Id., Diephilosophischen Schriften, a cura di C.I. Gerhardt, Berl<strong>in</strong> 1875-90, vol. VII, pp.328-332161
LOCKE J. (1700 4 ), An Essay Concern<strong>in</strong>g Human Understand<strong>in</strong>g, London; ed.a cura di P.H. Nidditch, Oxford 1975ŁUKASIEWICZ J. (1910), Über den Satz des Widerspruchs bei Aristoteles, trad.ted. di J. Barski, ried. con prefazione di J.M. Bocheński, Hildesheim -Zürich - New York 1993ŁUKASIEWICZ J. (1960), Aristotle on the Law of Contradiction, <strong>in</strong> BARNES -SCHOFIELD - SORABJI, a cura di (1979), pp. 50-62MALCOLM N. (1960), Anselm’s Ontological Argument, “The PhilosophicalReview”, LXIX, pp. 41-62MARSONET M. (2000), I limiti del realismo. Filosofia, scienza e senso comune,MilanoMASIN S.C., a cura di (2002), I fondamenti della fenomenologia sperimentale(“Teorie & modelli”, n.s., VII)MASSIRONI M. (2000), L’Osteria dei Dadi Truccati. Arte, <strong>psicologia</strong> e d<strong>in</strong>torni,BolognaMAUTHNER F. (1923), Wörterbuch der Philosophie. Neue Beiträge zu e<strong>in</strong>erKritik der Sprache, Leipzig (seconda ed. ampliata, prima ed. München 1910)MEINI C. (2001), La <strong>psicologia</strong> <strong>in</strong>genua. Una teoria evolutiva, MilanoMEIER G.F. (1766), Beiträge zu der Lehre von den Vorurtheilen des menschlichenGeschlechtes, HalleMEISSNER H.A. (1737), Philosophisches Lexicon aus Christian <strong>Wolff</strong>ssämtlichen deutschen Schriften, Bayreuth; riprod. con una Introduzione di L.Geldsetzer, Düsseldorf 1970MOREAU J. (1981), Logique et dialectique dans l’argument du “Proslogion”, <strong>in</strong>Sprache und Erkenntnis im Mittelalter. Akten des VI. <strong>in</strong>ternationalen Kongressesfür mittlealterliche Philosophie. Bonn 29. August - 3. September1977, Berl<strong>in</strong> - New York 1981, t. 2, pp. 718-723MOREWEDGE P., a cura di (1982), Philosophies of Existence. Ancient andMedieval, New YorkMOYAL J.D., a cura di (1991), René Descartes. Critical Assessments. VolumeII: The Meditations and Metaphysics, London - New YorkMUGNAI M. (2001), Introduzione alla filosofia di Leibniz, Tor<strong>in</strong>oMULLIGAN K., a cura di (1992), Language, Truth and Ontology, Dordrecht -Boston - LondonOBERHAUSEN M. - DELFOSSE H.P. - POZZO R., a cura di (2001), Vernunftkritikund Aufklärung. Studien zur Philosophie Kants und se<strong>in</strong>es Jahrhunderts,Stuttgart-Bad CannstattÖFFENBERGER N. - SKARICA M., a cura di (2000), Beiträge zum Satz vomWiderspruch und zur Aristotelischen Prädikationstheorie, Hildesheim - Zürich -New York162
PELTZ R. (1966), Ontology and the Work of Art, “The Journal of Aestheticsand Art Criticism”, 24, pp. 487-499PIMPINELLA P. (2001), Cognitio <strong>in</strong>tuitiva bei <strong>Wolff</strong> und Baumgarten, <strong>in</strong>OBERHAUSEN - DELFOSSE - POZZO, a cura di (2001), pp. 265-294PUTNAM H. (1992), Reply to Conant. The Philosophy of Hilary Putnam,“Philosophical Topics”, 1QUINE W.V.O. (1948-49), On What There Is, “The Review of Metaphysics”,2, pp. 21-38QUINE W.V.O. (1951), Two Dogmas of Empiricism, “The PhilosophicalReview”, 60, pp. 20-43; ed. riv. <strong>in</strong> Id., From a Logical Po<strong>in</strong>t of View. N<strong>in</strong>eLogico-Philosophical Essays, Cambridge (MA) 1961REALE, Met = Aristotele, Metafisica, <strong>in</strong>troduzione, traduzione, note eapparati di G. Reale, appendice bibliografica di R. Radice, Milano 1993REIMARUS H.S. (1760), Allgeme<strong>in</strong>e Betrachtungen über die Triebe der Tiere,hauptsächlich über ihre Kunsttriebe, riprod. a cura di J. von Kempski, Gött<strong>in</strong>gen1982RICKEN U. (1989), Leibniz, <strong>Wolff</strong> und e<strong>in</strong>ige Sprachtheoretische Entwicklungen<strong>in</strong> der deutschen Aufklärung, Berl<strong>in</strong>RIJK L.M. DE (2002), Aristotle. Semantics and Ontology, 2 voll., Leiden -Boston - Köln, vol. II: The Metaphysics: Semantics <strong>in</strong> Aristotle’s strategy ofargumentROSENKRANZ K. (1840), Geschichte der Kant’schen Philosophie, Leipzig; ed.a cura di S. Dietzsch, Berl<strong>in</strong> 1987ROSS, Met = Aristotle’s Metaphysics, vol. I, testo riveduto, <strong>in</strong>trodotto ecommentato da W.D. Ross, Oxford 1924 (rist. 1975)Routledge Encyclopedia of Philosophy, 1998, a cura di E. Craig, LondonRYLE G. (1957), Predict<strong>in</strong>g and <strong>in</strong>ferr<strong>in</strong>g, <strong>in</strong> Körner S., a cura di, Observationand <strong>in</strong>terpretation, London 1957, pp. 165-170SCHMIDT-BIGGEMANN W. (1983), Topica universalis. E<strong>in</strong>e Modellgeschichtehumanistischer und barocker Wissenschaft, HamburgSCHNEIDERS W. (1983), Aufklärung und Vorurteilskritik. Studien zur Geschichteder Vorurteilstheorie, Stuttgart-Bad CannstattSCHNEIDERS W., a cura di (1986), Christian <strong>Wolff</strong> 1679-1754. Interpretationenzu se<strong>in</strong>er Philosophie und deren Wirkung, HamburgSCRIBANO E. (1994), L’esistenza di Dio. Storia della prova ontologica daDescartes a Kant, Roma - BariSELLARS W. (1956), Empiricism and the Philosophy of M<strong>in</strong>d, <strong>in</strong> Feigl H.,Scriven M., a cura di, The Foundations of Science and the Concepts of Psychology andPsychoanalysis (M<strong>in</strong>nesota Studies <strong>in</strong> the Philosophy of Science, I),M<strong>in</strong>neapolis, pp. 253-329163
SELLARS W. (1957), Intentionality and the Mental. A Correspondence withRoderick Chisholm, <strong>in</strong> Feigl H., Scriven M., Maxwell G., a cura di, Concepts,Theories, and the M<strong>in</strong>d-Body Problem (M<strong>in</strong>nesota Studies <strong>in</strong> the Philosophy ofScience, II), M<strong>in</strong>neapolis 1958, pp. 507-539SELLARS W. (1962), Philosophy and the Scientific Image of Man, <strong>in</strong> R.Colodny, a cura di, Frontiers of Science and Philosophy, Pittsburgh 1962SELLARS W. (1967), Science and Metaphysics: Variations on Kantian Themes,LondonSELLARS W. (1975), The Structure of Knowledge: (1) Perception; (2) M<strong>in</strong>ds; (3)Epistemic Pr<strong>in</strong>ciples, <strong>in</strong> Castañeda H.-N., a cura di, Action, Knowledge andReality: Studies <strong>in</strong> Honor of Wilfrid Sellars, Indianapolis, pp. 295-347SELLARS W. (1981), Mental Events, “Philosophical Studies”, 39, pp. 325-345SEPh = The Stanford Encyclopedia of Philosophy (W<strong>in</strong>ter 2003 Edition), acura di E.N. Zalta, URL = http://plato.stanford.eduSIMMONS A. (2001), Chang<strong>in</strong>g the Cartesian M<strong>in</strong>d: Leibniz on Sensation,Representation and Consciousness, “The Philosophical Review”, 110, pp. 31-75SMITH B. - WELTY Ch. (2001), Ontology: Towards a New Synthesis, NewYorkSTERN S.M. - HOURANI A. - BROWN V., a cura di (1972), Islamicphilosophy and the classical tradition. Essays presented by his friends and pupils toRichard Walzer on his seventieth birthday, LondonSUTTER A. (1992), Göttliche Masch<strong>in</strong>en, Frankfurt/MTEGA W. (1984), Arbor scientiarum. Enciclopedie e sistemi <strong>in</strong> Francia daDiderot a Comte, BolognaTHÖLE B. (1991), Kant und das Problem der Gesetzmäßigkeit der Natur,Berl<strong>in</strong>THOMASIUS Ch. (1688), Introductio ad philosophiam aulicam, seu L<strong>in</strong>eaeprimae libri de prudentia cogitandi et ratioc<strong>in</strong>andi, Ubi ostenditur media <strong>in</strong>terpraejudicia Cartesianorum & <strong>in</strong>eptias Peripateticorum, veritatem <strong>in</strong>veniendi via. Additaest Ulrici Huberi JCti Franequerani Oratio De Paedantismo, Leipzig; riprod.con prefazione di W. Schneiders e <strong>in</strong>dici di M. Schewe, Hildesheim -Zürich - New York 1993THOMASIUS Ch. (1691), Außübung der Vernunfft-Lehre, Oder: Kurtze,deutsche und wohlgegründete Handgriffe, wie man <strong>in</strong> se<strong>in</strong>en Kopffe aufräumen und sichdie Erforschung der Wahrheit geschickt machen; die erkandte Wahrheit andernbeybr<strong>in</strong>gen; andere verstehen und auslegen; von anderer ihren Me<strong>in</strong>ungen urtheilen, unddie Irrthümer geschicklich widerlegen solle. Wor<strong>in</strong>nen allenthalben viel allgeme<strong>in</strong>e heut zuTage <strong>in</strong> Schwang gehende Irrthümer angezeiget, und deutlich beantwortet werden, Halle;riprod. con prefaz. di W. Schneiders, Hildesheim 1968164
THÜMMIG L.Ph. (1729), Institutiones philosophiae wolfianae, <strong>in</strong> usus academicosadornatae. Editio nova, 2 voll., Frankfurt - Leipzig; riprod. con prefazione di J.École, Hildesheim - Zürich - New York 1982TONELLI G. (1971), A Short-title List of Subject Dictionaries of the Sixteenth,Seventeenth and Eighteenth Centuries as Aids to the History of Ideas, LondonTONELLI G. (1976), Analysis und Synthesis <strong>in</strong> XVIIIth Century PhilosophyPrior to Kant, “Archiv für Begriffsgeschichte”, 20, pp. 178-193TSCHIRNHAUS E.W. (1695 2 ), Medic<strong>in</strong>a mentis, sive Tentamen genu<strong>in</strong>aeLogicae, <strong>in</strong> qua disseritur de methodo detegendi <strong>in</strong>cognitas veritates, Leipzig; riprod.Hildesheim 1964UNGEHEUER G. (1981), De Wolfii Significatu Hieroglyphico, <strong>in</strong> Trabant J., acura di, Logos Semantikos I. Geschichte der Sprachphilosophie und der Sprachwissenschaft,Berl<strong>in</strong> - New York - Madrid, pp. 57-67UNGEHEUER G. (1986), Sprache und symbolische Erkenntnis bei <strong>Wolff</strong>, <strong>in</strong>SCHNEIDERS W., a cura di (1986), pp. 89-120VARZI A.C. (2002), <strong>Ontologia</strong> e metafisica, <strong>in</strong> D’AGOSTINI - VASSALLO, acura di (2002), pp. 157-193VOLLRATH E. (1962), Die Gliederung der Metaphysik <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e MetaphysicaGeneralis und e<strong>in</strong>e Metaphysica Specialis, “Zeitschrift für PhilosophischeForschung”, XVI, 2, pp. 265-266VRIES W. DE (1996), Sellars, Animals, and Thought, “Digital TextInternational”, http://www.ditext.com/devries/sellanim.htmlWALCH J.G. (1726), Philosophisches Lexicon, Leipzig; ed. curata e ampliatada J.C. Henn<strong>in</strong>gs, Leipzig 1775 3 , riprod. Hildesheim 1968WEINGARTNER P. - MORSCHER E., a cura di (1979), Ontologie und Logik/ Ontology and Logic. Vorträge und Diskussionen e<strong>in</strong>es InternationalenKolloquiums / Proceed<strong>in</strong>gs of an International Colloquium (Salzburg, 21.-24. September 1976), Berl<strong>in</strong>WHEELER M. (1999), Semantics <strong>in</strong> Aristotle’s Organon, “Journal of theHistory of Philosophy”, XXXVII, 2, pp. 191-226WIEDEMANN H. (2002), Aristoteles. Peri Hermeneias, trad. commentata(ed. riv.), Berl<strong>in</strong>WILLE D. v. (1991), Lessico filosofico della Frühaufklärung. ChristianThomasius, Christian <strong>Wolff</strong>, Johann Georg Walch, RomaWITTE E. (2000), Logik ohne Dornen. Die Rezeption von A.G. BaumgartensÄsthetik im Spannungsfeld von logischem Begriff und ästhetischer Anschauung,Hildesheim - Zürich - New YorkWITTGENSTEIN L. (1953), Philosophische Untersuchungen, a cura di G.E.M.Anscombe - G.H. von Wright, Oxford165
WOLEŃSKI J. (2000), Jan Łukasiewicz und der Satz vom Widerspruch, <strong>in</strong>ÖFFENBERGER - SKARICA, a cura di (2000), pp. 1-42WOLFF R.P. (1963), Kants Theory of Mental Activity, Cambridge (MA)WUNDT M. (1945 2 ), Die deutsche Schulphilosophie im Zeitalter der Aufklärung,Tüb<strong>in</strong>gen; riprod. Hildesheim - Zürich - New York 1992166
Indice dei nomiIn corsivo sono <strong>in</strong>dicate le pag<strong>in</strong>e <strong>in</strong> cui il riferimento agli autori citati è collocato <strong>in</strong> nota.Alembert, J.-B. Le Ronde d’ - 151Alessandro di Hales - 128Alsted, J.H. - 15, 16Anselmo di Canterbury (Anselmod’Aosta) - 126, 128, 133, 142 / 129Aristotele - 20-21, 29, 41-43, 49-51,72, 103, 120-121, 125, 151 / 14, 98Arnaud, T. - 38 / 27, 54, 57Arndt, H.W. - 30Ayer, A.J. - 116Barnes, J. - 129, 133, 145Baumann, P. - 70Baumgarten, A.G. - 84-86, 88-90, 92,103-104, 121 / 32, 44, 63, 93, 95Bayle, P. - 77Beetz, M. - 44Bennett, J. - 134, 140, 143Bilf<strong>in</strong>ger, G.B. - 35Biller, G. - 21Bolzano, B. - 63Bonaventura da Bagnoregio - 128Boulnois, O. - 16Bozzi, P. - 60-61, 153 / 58, 68, 75Brentano, F. - 8Brown, V. - 14Burkhardt, H. - 15Campo, M. - 40Carbonc<strong>in</strong>i, S. - 16, 43Carnap, R. - 56Cartesio (R. Descartes) - 38, 40, 43-45, 47-48, 51, 69, 72, 77, 126, 129 /14, 15, 56, 70, 71Cataldi Madonna, L. - 58Catt<strong>in</strong>, Y. - 126, 129Chisholm, R.M. - 20Ciafardone, R. - 137Cleve, J. van - 111Clauberg, J. - 21, 29 / 15, 16Corr, C.A. - 30Court<strong>in</strong>e, J.-F. - 16Craig, E. - 17Davies, J. - 20Dejnozka, J. - 18Delfosse, H.P. - 32Dennett, D.C. - 117 / 114Deutsch, H. - 78Diderot, D. - 15Dierse, U. - 30Dilman, I. - 24Dryer, D.P. - 111Eberhard, J.A. - 32École, J. - 35-36 / 14, 16, 43Engfer, H.J. - 30Eucken, R. - 13Ferraris, M. - 21 / 76, 84Ferrater Mora, J. - 16Feuerhahn, W. - 73 / 56Forrest, P. - 78Frege, F.L.G. - 14Freuler, L. - 15Friedman, M. - 111Garroni, E. - 146Gaunilone - 128, 133 / 129Gawlick, G. - 32Gibson, J.J. - 67, 69 / 68Goclenio (R. Göckel) - 45 / 16Gozzano, S. - 114Griff<strong>in</strong>, N. - 78Grozio (H. van Groot) - 40Hagen, G.F. - 45Hamlyn, D.W. - 62Handke, P. - 124Hartmann, E. von - 63Heil, J. - 58Henne, H. - 13Hill, C.O. - 18H<strong>in</strong>ske, N. - 7 / 137H<strong>in</strong>tikka, J. - 14167
Honnefelder, L. - 29, 125 / 16, 22,23, 30, 40Hotson, H. - 16Hourani, A. - 14Hume, D. - 103, 105, 120-121, 129,135-136 / 134Inwagen, P. van - 19-20Jacob, P. - 38Jäger, M. - 84Jastrow, J. - 60Johnson, H.J. - 140Kant, I. - 13, 29, 43, 84, 102, 103-115,117, 120, 123, 124, 129, 133-150 / 32,121, 122Karskens, M. - 45Ken, A. - 32Kim, C.W. - 45Kirk, R. - 69Knuutila, S. - 14Kobau, P. - 95, 104, 114Koffka, K. - 59 / 60Krämer, B. - 32Kreimendahl, L. - 32Kr<strong>in</strong>gs, H. - 146Krouglov, A.N. - 43Laudan, L. - 21Legrenzi, P. - 55Leibniz, G.W. - 53, 149 / 14, 70, 90,98, 102Locke, J. - 135, 144 / 145Lullo (R. Llull) - 15Lycan, W. - 38Łukasiewicz, J. - 51Mach, E. - 56Malcolm, N. - 140Malebranche, N. - 70Marsonet, M. - 59Mas<strong>in</strong>, S.C. - 59Massironi, M. - 68Mauthner, F. - 121Meier, G.F. - 32, 44Me<strong>in</strong>i, C. - 114Meissner, H.A. - 25Moreau, J. - 128Morewedge, P. - 14Moyal, J.D. - 43Mugnai, M. - 70Müller-Lyer, F.C. - 66Neumann, F. - 40Oppy, C. - 126Paolo Uccello - 66Parramón, J.M. - 66Pavlov, I.P. - 56Peltz, R. - 20Pimp<strong>in</strong>ella, P. - 84Platone - 62-63, 67, 149Putnam, H. - 19Qu<strong>in</strong>e, W.V.O. - 18-19, 23-24Ramo (P. de la Ramée) - 15Reale, G. - 51Reimarus, H.S. - 95, 115Re<strong>in</strong>ardt, E. - 32Ricken, U. - 30, 52Rijk, L.M. de - 51 / 42Robb, D. - 58Rosenkranz, K. - 121Ross, W.D. - 51Russell, B.A.W. - 56 / 14Ryle, G. - 115-116, 122Schmidt-Biggemann, W. - 16Schneiders, W. - 44Schopenhauer, A. - 121Scoto (Duns Scoto) - 8, 125 / 16Scribano, E. - 125, 127 / 130, 134, 140Sellars, W. - 9, 116-121Sesto Empirico - 40Shields, C. - 56Siewert, C. - 38Simmons, A. - 38Smith, B. - 15, 20Sp<strong>in</strong>oza, B. - 46Stern, S.M. - 14Suárez F. - 21, 45 / 16Sutter, A. - 71, 84Tega, W. - 15Thöle, B. - 111Thomasius, C. - 47-49, 52 / 44Thümmig, L.P.ý - 35 / 70168
Tommaso d’Aqu<strong>in</strong>o - 16, 128Tonelli, G. - 13, 30Tschirnhaus, E.W. - 39 / 40Ungeheuer, G. - 86Varzi, A.C. - 18Vollrath, E. - 16Vries, W. de - 116Walch, J.G. - 13-15, 17, 24-25, 28,126-127Welty, C. - 20Wheeler, M. - 52Wiedemann, H. - 41 / 42Wille, D. von - 29Witte, E. - 63Wittgenste<strong>in</strong>, L. - 82Woleński, J. - 51<strong>Wolff</strong>, R.P. - 112Wundt, M. - 55169
Stampato per Traubenpresso Viva s.r.l. - Tor<strong>in</strong>o170