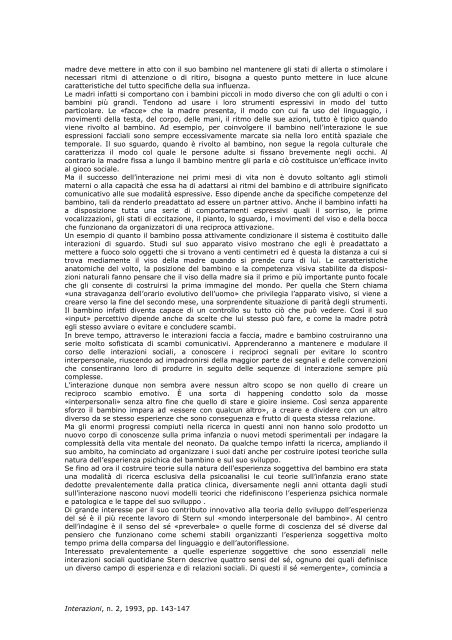Interazione nella psicologia dello sviluppo A ... - Rivista Interazioni
Interazione nella psicologia dello sviluppo A ... - Rivista Interazioni
Interazione nella psicologia dello sviluppo A ... - Rivista Interazioni
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
madre deve mettere in atto con il suo bambino nel mantenere gli stati di allerta o stimolare inecessari ritmi di attenzione o di ritiro, bisogna a questo punto mettere in luce alcunecaratteristiche del tutto specifiche della sua influenza.Le madri infatti si comportano con i bambini piccoli in modo diverso che con gli adulti o con ibambini più grandi. Tendono ad usare i loro strumenti espressivi in modo del tuttoparticolare. Le «facce» che la madre presenta, il modo con cui fa uso del linguaggio, imovimenti della testa, del corpo, delle mani, il ritmo delle sue azioni, tutto è tipico quandoviene rivolto al bambino. Ad esempio, per coinvolgere il bambino nell’interazione le sueespressioni facciali sono sempre eccessivamente marcate sia <strong>nella</strong> loro entità spaziale chetemporale. Il suo sguardo, quando è rivolto al bambino, non segue la regola culturale checaratterizza il modo col quale le persone adulte si fissano brevemente negli occhi. Alcontrario la madre fissa a lungo il bambino mentre gli parla e ciò costituisce un’efficace invitoal gioco sociale.Ma il successo dell’interazione nei primi mesi di vita non è dovuto soltanto agli stimolimaterni o alla capacità che essa ha di adattarsi ai ritmi del bambino e di attribuire significatocomunicativo alle sue modalità espressive. Esso dipende anche da specifiche competenze delbambino, tali da renderlo preadattato ad essere un partner attivo. Anche il bambino infatti haa disposizione tutta una serie di comportamenti espressivi quali il sorriso, le primevocalizzazioni, gli stati di eccitazione, il pianto, lo sguardo, i movimenti del viso e della boccache funzionano da organizzatori di una reciproca attivazione.Un esempio di quanto il bambino possa attivamente condizionare il sistema è costituito dalleinterazioni di sguardo. Studi sul suo apparato visivo mostrano che egli è preadattato amettere a fuoco solo oggetti che si trovano a venti centimetri ed è questa la distanza a cui sitrova mediamente il viso della madre quando si prende cura di lui. Le caratteristicheanatomiche del volto, la posizione del bambino e la competenza visiva stabilite da disposizioninaturali fanno pensare che il viso della madre sia il primo e più importante punto focaleche gli consente di costruirsi la prima immagine del mondo. Per quella che Stern chiama«una stravaganza dell’orario evolutivo dell’uomo» che privilegia l’apparato visivo, si viene acreare verso la fine del secondo mese, una sorprendente situazione di parità degli strumenti.Il bambino infatti diventa capace di un controllo su tutto ciò che può vedere. Così il suo«input» percettivo dipende anche da scelte che lui stesso può fare, e come la madre potràegli stesso avviare o evitare e concludere scambi.In breve tempo, attraverso le interazioni faccia a faccia, madre e bambino costruiranno unaserie molto sofisticata di scambi comunicativi. Apprenderanno a mantenere e modulare ilcorso delle interazioni sociali, a conoscere i reciproci segnali per evitare lo scontrointerpersonale, riuscendo ad impadronirsi della maggior parte dei segnali e delle convenzioniche consentiranno loro di produrre in seguito delle sequenze di interazione sempre piùcomplesse.L’interazione dunque non sembra avere nessun altro scopo se non quello di creare unreciproco scambio emotivo. È una sorta di happening condotto solo da mosse«interpersonali» senza altro fine che quello di stare e gioire insieme. Così senza apparentesforzo il bambino impara ad «essere con qualcun altro», a creare e dividere con un altrodiverso da se stesso esperienze che sono conseguenza e frutto di questa stessa relazione.Ma gli enormi progressi compiuti <strong>nella</strong> ricerca in questi anni non hanno solo prodotto unnuovo corpo di conoscenze sulla prima infanzia o nuovi metodi sperimentali per indagare lacomplessità della vita mentale del neonato. Da qualche tempo infatti la ricerca, ampliando ilsuo ambito, ha cominciato ad organizzare i suoi dati anche per costruire ipotesi teoriche sullanatura dell’esperienza psichica del bambino e sul suo <strong>sviluppo</strong>.Se fino ad ora il costruire teorie sulla natura dell’esperienza soggettiva del bambino era statauna modalità di ricerca esclusiva della psicoanalisi le cui teorie sull’infanzia erano statededotte prevalentemente dalla pratica clinica, diversamente negli anni ottanta dagli studisull’interazione nascono nuovi modelli teorici che ridefiniscono l’esperienza psichica normalee patologica e le tappe del suo <strong>sviluppo</strong> .Di grande interesse per il suo contributo innovativo alla teoria <strong>dello</strong> <strong>sviluppo</strong> dell’esperienzadel sé è il più recente lavoro di Stern sul «mondo interpersonale del bambino». Al centrodell’indagine è il senso del sé «preverbale» o quelle forme di coscienza del sé diverse dalpensiero che funzionano come schemi stabili organizzanti l’esperienza soggettiva moltotempo prima della comparsa del linguaggio e dell’autoriflessione.Interessato prevalentemente a quelle esperienze soggettive che sono essenziali nelleinterazioni sociali quotidiane Stern descrive quattro sensi del sé, ognuno dei quali definisceun diverso campo di esperienza e di relazioni sociali. Di questi il sé «emergente», comincia a<strong>Interazioni</strong>, n. 2, 1993, pp. 143-147