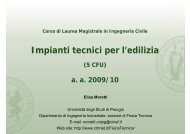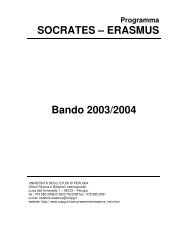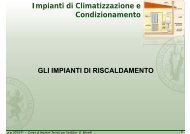comfort termoigrometrico in ambienti interni: correlazioni tra valori ...
comfort termoigrometrico in ambienti interni: correlazioni tra valori ...
comfort termoigrometrico in ambienti interni: correlazioni tra valori ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
conseguenza la differenza T eu - T u rappresenta una misuradella distanza dalle condizioni di <strong>comfort</strong> per l’ambiente realeconsiderato.Il modello proposto da Wray può essere rappresentatograficamente <strong>in</strong> uno spazio T a - T mr (Fig. 1), del quale la l<strong>in</strong>eadella temperatura uniforme è la bisettrice (T mr =T a ).Dall’equazione l<strong>in</strong>earizzata di Fanger è possibile ricavare tuttele comb<strong>in</strong>azioni di T a e T mr che determ<strong>in</strong>ano il livello ottimaledi <strong>comfort</strong> (L=0): tutte queste comb<strong>in</strong>azioni sonorappresentate <strong>in</strong> tale spazio da una retta con pendenza negativas, che prende il nome di l<strong>in</strong>ea del <strong>comfort</strong>. L’<strong>in</strong>tersezione <strong>tra</strong>questa retta e quella della temperatura uniforme rappresentaproprio T u . Un ambiente reale qualsiasi, termicamente nonuniforme, è rappresentato nel piano da un punto, <strong>in</strong>dividuatodalle sue temperature T a * e T mr * : <strong>tra</strong>cciando da questo punto laparallela alla l<strong>in</strong>ea del <strong>comfort</strong>, l’<strong>in</strong>tersezione con la retta dellatemperatura uniforme <strong>in</strong>dividua <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e T eu . Per mezzo disemplici relazioni geometriche, quest’ultima può esserecalcolata come segue:Teudove <strong>in</strong> generale s = s (A, I cl , f cl , h c , φ).T mr[K]45°⎛ 1 ⎞ * ⎛ s ⎞ *= ⎜ ⎟ Tmr+ ⎜ ⎟ Ta(2)⎝1−s ⎠ ⎝ s −1⎠(T a*, T mr * )T usFig. 1: rappresentazione grafica della relazione <strong>tra</strong> iparametri di temperatura e la l<strong>in</strong>ea del <strong>comfort</strong> [8].3.2 Applicazione del modello di Wray ai dati sperimentaliL’applicazione del modello di Wray ha <strong>in</strong>izio con ladeterm<strong>in</strong>azione della T u , temperatura da raggiungere perottenere le condizioni ottimali di <strong>comfort</strong>. Per risolvere l’Eq.(1) sotto le ipotesi elencate al paragrafo precedente, occorreassegnare un valore alle grandezze che <strong>in</strong> essa compaiono (A,φ, T cl , f cl , h c ). Dall’analisi dei dati personali raccolti neiquestionari è possibile ricavare il numero di uom<strong>in</strong>i e di donnepresenti durante le misure; fissando i <strong>valori</strong> di metabolismoper en<strong>tra</strong>mbi i sessi è stata ricavata la media pesata dei <strong>valori</strong>di attività (A). Considerata la sedentarietà del compito svoltodagli studenti che seguono le lezioni universitarie, si sonofissati dei <strong>valori</strong> pari a 72 e 69 W/m 2 rispettivamente per gliuom<strong>in</strong>i e le donne. Analizzando <strong>in</strong>vece la parte termica deiT eusL<strong>in</strong>ea del ComfortL<strong>in</strong>ea dellatemperaturauniformeT a [K]questionari, si può ricavare per ciascun <strong>in</strong>dividuo lacomposizione dell’abbigliamento. Attribuendo agli abiti i<strong>valori</strong> di resistenza termica riportati nell’Appendice C della[1], si è calcolato per ogni giornata di misura il valore mediodi isolamento termico del vestiario degli occupanti (I cl,med ),oltre ai <strong>valori</strong> massimo e m<strong>in</strong>imo (I cl,max , I cl,m<strong>in</strong> ), rappresentativirispettivamente dell’<strong>in</strong>dividuo più vestito e di quello menovestito, <strong>in</strong>dipendentemente dal sesso. Il valore dell’isolamentotermico del vestiario non figura esplicitamente nell’Eq. (1), maè <strong>in</strong>dispensabile per ricavare gli altri parametri T cl , f cl , h c adesso associati. Per far ciò ci si avvale del programma<strong>in</strong>formatico proposto nell’Appendice D della [1] per il calcolodegli <strong>in</strong>dici PMV (Predicted Mean Vote) e PPD (PredictedPercentage of Dissatisfied), implementato <strong>tra</strong>mite l<strong>in</strong>guaggioVisual Basic, dal quale sono es<strong>tra</strong>polati i coefficienti suddetti,ricavati sempre <strong>in</strong> corrispondenza di I cl,med , I cl,m<strong>in</strong> , I cl,max . I<strong>valori</strong> della temperatura dell’aria T a , della temperatura mediaradiante T mr e della velocità dell’aria relativa al corpo umanov ar sono ricavati dai rilievi sperimentali, così come il valoredell’umidità relativa φ.Facendo uso dei parametri così ottenuti sono state calcolatele T u , sempre <strong>in</strong> corrispondenza dei <strong>valori</strong> m<strong>in</strong>imo, medio emassimo di resistenza termica del vestiario.Utilizzando gli stessi parametri, sono state calcolate le T euassociate all’aula considerata, per mezzo dell’Eq. (2). I <strong>valori</strong>di s sono stati ricavati dai grafici contenuti <strong>in</strong> [7], <strong>tra</strong>cciati daWray per <strong>valori</strong> medi prefissati di f cl , h c , v ar (f cl =1.15, h c =2.83W/m 2 K, v ar =0.1 m/s) e <strong>in</strong>terpolando <strong>in</strong> base ai <strong>valori</strong> di A, φ eI cl considerati. L’accuratezza del risultato ottenuto utilizzandotale metodo grafico è garantita dalla scarsa sensibilità della T eurispetto ad s: variando tale parametro di quantità maggioridell’approssimazione <strong>in</strong>trodotta, si ottiene una corrispondenteoscillazione della T eu di circa 0,1-0,2 °C, cosicché l’<strong>in</strong>certezzadel risultato f<strong>in</strong>ale può dirsi di gran lunga compresa entroquesti limiti. Di conseguenza, non appare giustificato il ricorsoal metodo analitico per la determ<strong>in</strong>azione di s, che comportaun <strong>in</strong>gente aumento del tempo di elaborazione dei dati.I calcoli sono stati ripetuti per ogni s<strong>in</strong>golo rilievoeffettuato, <strong>in</strong> modo consecutivo durante le giornate di misura.Nel corso della stessa giornata, mantenendosi <strong>in</strong>variato ilcampione di studenti all’<strong>in</strong>terno delle aule, rimangono costantii <strong>valori</strong> medi di metabolismo e di isolamento termico delvestiario, mentre variano tutte le altre grandezze di <strong>in</strong>teresse.Per quanto riguarda l’Aula 8 di Pavia, i rilievi sono statieffettuati sia al matt<strong>in</strong>o che al pomeriggio, <strong>in</strong>terrotti durante lapausa pranzo che separa i due cicli di lezioni. Il campione distudenti non è pertanto lo stesso nel corso dell’<strong>in</strong>tera giornatae si considerano il matt<strong>in</strong>o e il pomeriggio come due giornatedist<strong>in</strong>te di misura, ad ognuna delle quali sono associati <strong>valori</strong>diversi di attività metabolica e isolamento termico delvestiario.Parallelamente a T u e T eu sono stati calcolati anche gli <strong>in</strong>dici<strong>tra</strong>dizionali di Fanger PMV e PPD, facendo sempre uso delprogramma di calcolo riportato nella [1].3.3 Confronto <strong>tra</strong> l’approccio di Wray e quello di FangerDai <strong>valori</strong> di T u e T eu di ogni s<strong>in</strong>golo rilievo si sonocalcolate le differenze T eu - T u e |T eu - T u |, al f<strong>in</strong>e di effettuareun confronto con gli <strong>in</strong>dici di Fanger, PMV e PPD. Peren<strong>tra</strong>mbe le differenze, un valore nullo determ<strong>in</strong>a laco<strong>in</strong>cidenza <strong>tra</strong> temperatura uniforme di <strong>comfort</strong> e temperaturaequivalente uniforme (T u =T eu ) e corrisponde alle condizioni dibenessere <strong>termoigrometrico</strong>. La |T eu - T u | esprime per mezzo diun unico valore la distanza dalle condizioni di <strong>comfort</strong>: più il