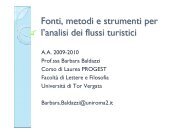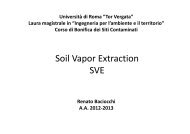Page 1 GIOVAN BATTISTA PIRANESI DELLA MAGNIFICENZA ED ...
Page 1 GIOVAN BATTISTA PIRANESI DELLA MAGNIFICENZA ED ...
Page 1 GIOVAN BATTISTA PIRANESI DELLA MAGNIFICENZA ED ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
sculture de’ tempi bassi, rozze sì, o siano immaginette, o leoncini, o altre cose di simil genere, ma nondimeno bastanti a far conoscere che la scultura non era altrimenti vietata a’ Cristiani. In quanto all’architettura, l’Investigatore confessa che la militare a que’ tempi era usata ne’ castelli de’ gentiluomini privati, e che la civile si vedeva solamente nelle chiese de’ Cristiani, e ne’ chiostri de’ Monaci; onde incolpar non si dee la Chiesa, quasi ch’ella avesse abbattute le armi, ma dobbiamo anzi restar a lei obbligati d’averle mantenute. Che se poi nelle opere di que’ tempi v’era del rozzo e del barbaro, non è da maravigliarsene: imperocché siccome quei che soffrono lunghe infermità, non subito rinvigoriscono, benché ne siano guariti […]. XLIX. Non pochi di questi pittori Greci se n’erano venuti in Italia molto prima, cioè nel secolo ottavo, e sul principio del nono, allora che l’Oriente era perseguitato dal furore degl’Iconomachi; e seco loro se n’era venuto altresì un gran numero di Monaci, che vi portarono molte sacre immagini, involate da quell’incendio; ne vennero poscia degli altri circa l’anno MCCCXL in compagnia de’ Vescovi orientali, e dell’Imperador Giovanni Paleologo, allora che si trasferirono al Concilio Fiorentino; alcuni de’ quali, fermatisi in quella città, furono i maestri di Cimabue, che di quel tempo era fanciullo; ma la loro maniera di dipignere era per altro cattiva e disadatta, come ben confessa l’Investigatore: sicché a nulla giovò, ch’eglino spargessero i semi di ques’arte, da’ quali né essi, né altri sarebbono potuti giungere a raccorre il frutto desiderato, se Cimabue non avesse avuto il talento d’imparare da se quel che non gli era stato insegnato da que’ maestri Greci; non potendosi dire ch’ei si facesse abile colla lettura de’ libri, se pur ve ne sono che trattino di ques’arte, giacché, avuto appena i primi principi della gramatica, si diede tutto allo studio della pittura. Laonde per mezzo di questo idiota italiano la pittura risorse, prima che si fosse dileguata circa il secolo XIV quella nuvola d’ignoranza, che si obbietta dall’Investigatore. Qual poi sia stata questa nuvola, confesso di non saperlo; giacché a que’ tempi le scienze di maggior importanza erano nel loro pregio, e la dottrina della Chiesa, la quale è veramente scienza, e la più necessaria di tutte, era nel suo pieno vigore. […] LI. Ancor da questo adunque egli apprenda a suo dispetto, che nel grembo della Chiesa non solamente sono stati fomentati gli studi di maggiore importanza, ma che vi furono eziandio fatte risorgere le arti liberali di sopra narrate. Sebbene, per farle risorgere, che bisogno vi fu della zappa, o d’una ricerca di libri cotanto esatta? So che giovano molto nelle arti gl’insegnamenti; ma so altresì che giovano poco o nulla, se non vi cooperi la natura. Ma veggiamo quali sono stati queti libri Latini e Greci. Tra’ Greci poi non saprei dire quali siano quei che danno le regole di queste arti. Ma via ve ne siano stati alcuni. Oltre Cimabue pittore di sopra nominato, il quale fu senza letteratura, fiorì nello stesso secolo XIII Giotto, altro pittore ed architetto in vero eccellente. Si vede una delle di lui opere in musaico in Roma nel portico della Basilica di S. Pietro, essendo egli stato eccellentissimo anche in tal sorta di lavori, di cui così si legge nel libro delle Grotte Vaticane: Jacopo Gaetani degli Stefaneschi, Diacono Cardinal di S. Giorgio… fece fare l’anno 1298 in un bellissimo musaico la navicella di S. Pietro per mano di Giotto, pittore celeberrimo 3 . Furono dipinti dal medesimo de’ quadri in Assisi, in Pisa ed in Firenze, ove si vede la bella torre di marmo, presso la Metropolitana di S. Maria, alta CXLIV cubiti, opera del medesimo, celebrata anche a’ dì nostri. Costui, mentr’era fanciullo e pastor di pecore della campagna di Firenze, fu preso in casa ed ammaestrato da Cimabue. Or se tutt’e due erano idioti, e nondimeno l’uno e l’altro fu eccellente nella pittura, e di più il secondo lo fu anche nell’architettura; e s’e’ non videro tal sorta di libri, egli è certo che non deesi attribuire alla loro lezione il rinnovamento di queste arti, il quale accadde prima che cotali libri si ricercassero: se poi li videro, non v’era bisogno di levarli dalle biblioteche; imperocché si avevano per le mani; né dee dirsi che i Greci fossero stati i primi a portarli in Italia dopo la caduta di Costantinopoli in man de’ Turchi; il che avvenne l’anno MCCCCLIII ma o che vi fossero stati portati nel secolo ottavo e nono dai Monaci, che fuggirono dalla persecuzione degl’Iconomachi, e che in gran numero furono in Roma, fino a tanto che Giovanni Paelologo ne ricondusse seco molti in Costantinopoli; ovvero che vi fossero stati portati dalla Magna Grecia, o dalla Grecia stessa, quando i Latini s’impadronirono dell’imperio d’Oriente. E perciò, comunque sia andata la cosa, il rinnovamento delle arti e degli studi non si dee per alcun modo attribuire a quello scrutinio, e a quelle rivoluzioni, delle quali o parla, o fa mostra di voler parlare l’Investigatore, e che accaddero tanto tempo dopo, cioè nel principio del secolo XVI e di poi ancora […]. Che se taluno desiderasse nel principio di quel rinnovamento qualche cosa di più perfetto, si ricordi primieramente di quel detto d’Orazio: chi incomincia è alla metà dell’opra; e poi consideri chi sono stati quei che le hanno 3 Filippo Baldinucci, Notizie dei professori del disegno, 1681-‐1728, libro I [n.d.a.].





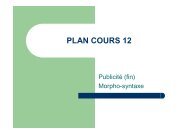

![Guinizzelli praised and explained (da [O] caro padre meo al XXVI ...](https://img.yumpu.com/50855933/1/185x260/guinizzelli-praised-and-explained-da-o-caro-padre-meo-al-xxvi-.jpg?quality=85)