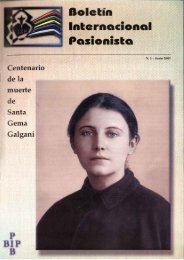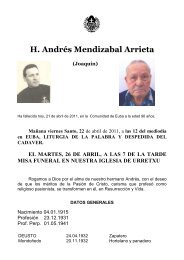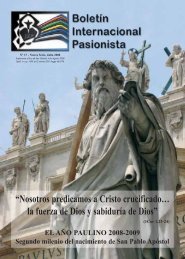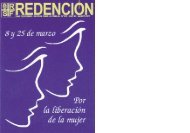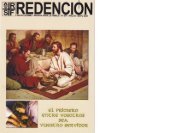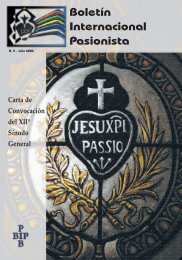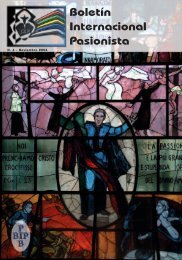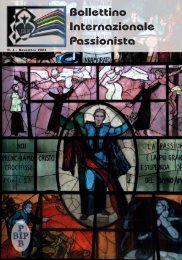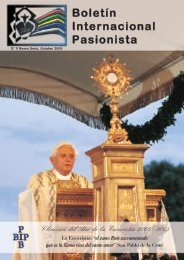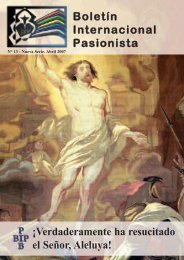Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
LA<br />
Rivista trimestrale di cultura e spiritualità della <strong>Passio</strong>ne a cura<br />
dei <strong>Passio</strong>nisti italiani e della Cattedra Gloria Crucis della<br />
Pontificia Università Lateranense<br />
SAPIENZA<br />
della<br />
CROCE<br />
ANNO XXIV - NN. 1-2<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
EDITORIALE<br />
Continuità e rottura, radicamento e sradicamento,<br />
riscoperta e riappropriazione delle radici<br />
di ADOLFO LIPPI C.P.<br />
SACRA SCRITTURA e TEOLOGIA<br />
Il movimento patripassiano: istanze positive<br />
per l’elaborazione del concetto cristiano di Dio<br />
di GIANNI SGREVA C.P.<br />
La <strong>Passio</strong>ne di Cristo in Kierkegaard.<br />
Note e ricerche (seconda parte)<br />
di MARIO CEMPANARI<br />
PASTORALE e SPIRITUALITÀ<br />
Il Cammino neocatecumenale<br />
alla luce del Concilio Vaticano II<br />
di MAURIZIO BUONI C.P.<br />
Evangelizzare partendo dalla “kenosi”<br />
di FERNANDO GUILLEN PRECKLER SCH.P.<br />
L’esperienza mistica di San Gabriele a Spoleto<br />
di ANTONIO ARTOLA C.P.<br />
SALVEZZA e CULTURE<br />
Il valore di una profezia<br />
di TITO AMODEI<br />
La Carrozza d’oro di Anna Magnani<br />
di ELISABETTA VALGIUSTI<br />
RIVISTA DELLA STAMPA<br />
Una demitizzazione ebraica<br />
della memoria dell’Olocausto<br />
di ADOLFO LIPPI C.P.<br />
RECENSIONI<br />
SCHEDE BIBLIOGRAFICHE<br />
Direttore responsabile<br />
Adolfo Lippi c. p.<br />
Direttore amministrativo<br />
Vincenzo Fabri c. p.<br />
Cattedra Gloria Crucis<br />
Comitato scientifico<br />
Fernando Taccone c. p. - Piero Coda<br />
Antonio Livi - Denis Biju-Duval<br />
Adolfo Lippi c. p. - Gianni Sgreva c. p.<br />
A. Maria Lupo c. p.<br />
Segretari di redazione<br />
Carlo Baldini c. p. - Gianni Sgreva c. p.<br />
A. Maria Lupo c. p. - Franco Nicolò<br />
Lucia Ulivi<br />
Collaboratori<br />
Tito Amodei - Max Anselmi - Carlo Baldini<br />
Vincenzo Battaglia - Luigi Borriello<br />
Maurizio Buioni - Giuseppe Comparelli<br />
Massimo Pasqualato - G. Marco Salvati<br />
Salvatore Spera - Flavio Toniolo<br />
Gianni Trumello - Tito Zecca<br />
Redazione:<br />
La Sapienza della Croce<br />
Piazza SS. Giovanni e Paolo, 13<br />
00184 Roma<br />
Tel. (06)77.27.14.74<br />
Fax 700.80.12<br />
e-mail: sapienzadellacroce@ tiscali.it<br />
http./www.passionisti.it<br />
Abbonamento annuale<br />
Italia € 20,00, Estero $ 30<br />
Fuori Europa (via aerea) $ 38<br />
Singolo numero € 5,00<br />
C.C.P. CIPI n. 50192004 - Roma<br />
Finito di stampare giugno 2009<br />
Stampa:<br />
Editoriale Eco srl - San Gabriele (Te)<br />
Progetto grafico: Filomena Di Camillo<br />
Impaginazione: Florideo D’Ignazio<br />
ISSN 1120-7825<br />
Autorizzazione del tribunale di Roma n. 512/85, del 13 novembre 1985 Sped. in abbon. post. Comma 20/c art 2<br />
Legge 662/96 - Filiale di Roma<br />
3-7<br />
9-39<br />
41-68<br />
69-122<br />
123-131<br />
133-154<br />
155-161<br />
163-168<br />
169-175<br />
177<br />
189
Avvertenza<br />
Il terremoto che ha colpito l’Abruzzo nei mesi scorsi ha<br />
danneggiato, purtroppo, anche la tipografia dell’Editoriale Eco, di<br />
San Gabriele-Colledara, nella quale si stampa la nostra rivista.<br />
Ci uniamo a tutti coloro che sono stati sensibili a questa grande<br />
sofferenza che ha colpito i fratelli abruzzesi, tanto cari a noi<br />
passionisti particolarmente per tutto ciò che San Gabriele significa<br />
per loro.<br />
Ci sono stati dei comprensibili ritardi prima che le strutture<br />
della tipografia fossero dichiarate agibili. Ce ne scusiamo con gli<br />
abbonati. In conseguenza di ciò, abbiamo creduto bene cominciare<br />
l’annata XXIV (2009) con un numero doppio, comprendente gli<br />
studi dei quali era prevista la pubblicazione nei due primi trimestri<br />
dell’anno.<br />
La Direzione
di ADOLFO LIPPI C.P.<br />
Forse non siamo mai stati in una condizione tanto<br />
buona quanto nel nostro<br />
tempo per riflettere sulla<br />
continuità e la rottura, il<br />
radicamento e lo sradicamento,<br />
la riscoperta e la<br />
riappropriazione delle<br />
radici. Fondamentalmente questa capacità<br />
ci viene dalla crisi delle ideologie che<br />
hanno devastato il secolo appena concluso.<br />
L’idea rompe perché è astratta, non matura<br />
con la vita, ma, semmai, si sovrappone dall’esterno<br />
alla vita sfruttando il risentimento.<br />
L’idea corrisponde alla definizione,<br />
che, appunto, intende chiudere dentro limi-<br />
ti e confini, in modo che anche le realtà della vita, come gli oggetti<br />
della matematica, risultino “chiare e distinte”, senza preoccuparsi<br />
del fatto che così siano anche taglienti.<br />
Si discute sulla continuità e la rottura in rapporto al Concilio<br />
Vaticano II. E’ esso da assumere come un taglio, un rinnovamento<br />
che deve rompere con tutto il passato, oppure come uno sviluppo,<br />
una crescita vitale, un’evoluzione che parte dalle radici e da esse<br />
riceve la sua forza? Probabilmente all’inizio prevalse l’idea della<br />
rottura. Era anche un’epoca portata, si può dire biologicamente, al<br />
rinnovamento. Accedeva alle università, quindi alla vita, la valanga<br />
dei giovani nati nel baby-boom succeduto alla seconda guerra mondiale.<br />
A differenza di quanto accade oggi nei paesi economicamente<br />
sviluppati, i giovani erano tanti, erano forti perché usufruivano<br />
della ripresa del dopoguerra, erano per la prima volta ben nutriti.<br />
Fenomeni quali la riforma liturgica, forse di importanza minore<br />
editoriale<br />
CONTINUITÀ<br />
E ROTTURA,<br />
RADICAMENTO<br />
E SRADICAMENTO,<br />
RISCOPERTA<br />
E RIAPPROPRIAZIONE<br />
DELLE RADICI<br />
Continuità e rottura,<br />
radicamento e sradicamento<br />
riscoperta e riappropriazione<br />
delle proprie radici<br />
pag. 3-7<br />
editoriale<br />
3
editoriale<br />
ADOLFO LIPPI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
editoriale<br />
4<br />
rispetto a problema quali la pace, la giustizia, l’attenzione all’ambiente<br />
vitale, ma dei quali era immediatamente percepibile a largo<br />
raggio la novità dirompente, furono visti come una novità assoluta.<br />
Oggi ci rendiamo conto che il Movimento liturgico, come quello<br />
biblico o ecumenico esistevano nella Chiesa da almeno un secolo,<br />
che importanti riforme della pratica liturgica erano state attuate da<br />
San Pio X con la rivalutazione della messa e della comunione e<br />
soprattutto da Pio XII con l’abolizione di quell’autentico tabù che<br />
era diventato nella coscienza di molti il digiuno eucaristico e più<br />
ancora con la restaurazione della veglia pasquale, centro e fonte di<br />
tutto l’anno liturgico. I cambiamenti introdotti da Pio XII, inoltre,<br />
facevano sorgere una domanda che aveva sempre terrorizzato i conservatori<br />
ad oltranza: se si sono attuate queste riforme, perché non<br />
farne altre assai urgenti come il rendere la Parola che si legge nella<br />
liturgia accessibile al popolo?<br />
Ho presentato la liturgia come meno importante rispetto a temi<br />
come la giustizia, la pace e l’integrità del creato. D’altra parte, però,<br />
il credente sa che questi valori non saranno promossi da un’etica<br />
antropologica autonoma, ma soltanto dal dono di Dio che si riceve<br />
appunto attraverso la comunione con Lui, la liturgia, la preghiera.<br />
La forza dello Spirito, della Ruach che aleggia sul nostro caos e lo<br />
fa evolvere verso una nuova creazione, viene a noi attraverso la preghiera<br />
comunitaria e personale.<br />
Nessuna riforma liturgica è stata uno sradicamento dalla liturgia<br />
precedente. Non lo è stata, in particolare, quella succeduta al<br />
Concilio Vaticano II. Fondamentalmente c’è stata una continuazione<br />
e, magari, la ripresa di forme precedenti, già abbandonate per<br />
qualche motivo contingente, ma che ora era possibile e utile ricuperare.<br />
Cambiamenti che impressionarono molto, come quello della<br />
lingua, sono, in fondo, chiaramente accidentali e nemmeno nuovi<br />
nella storia della Chiesa.<br />
Qui si vede come la vita della Comunità credente condizioni e<br />
conduca la vita dell’intera umanità. Si scrive, di solito, la storia della<br />
Chiesa alla stregua delle sensibilità e dei paradigmi in uso nella storiografia<br />
profana, introdotti in particolare dai grandi storiografi<br />
greci. Al più si aggiungono come corollari o appendici le note<br />
riguardanti la santità, la mistica, la liturgia, la teologia spirituale.<br />
Quando si scriverà una storia della Chiesa che parta dal discernimento<br />
di ciò che lo Spirito opera nella Chiesa? Giuseppe Flavio<br />
faceva osservare che tra gli ebrei toccava ai profeti scrivere la storia
del popolo di Dio 1 . Questo rilievo di Giusepe Flavio, assai dimenticato,<br />
è d’importanza fondamentale per la storia della Chiesa (come<br />
dell’odierno ebraismo), cioè del popolo di Dio del nostro tempo. La<br />
storia di Dio nel mondo chi la può scrive se non chi ha il discernimento<br />
dello Spirito di Dio e di ciò che Lui opera?<br />
I Concili sono la più grande profezia che risuona nella Chiesa.<br />
E’ chiaro che, se si crede a questo, ha poco senso mettere un<br />
Concilio contro l’altro, supporre ad esempio che il Vaticano II<br />
annulli il Tridentino. Ma poiché la Chiesa è una realtà vivente e<br />
continuamente nuova avrebbe poco senso anche voler riassorbire<br />
un Concilio nell’altro, il Vaticano II dentro le strutture mentali e i<br />
paradigmi del Tridentino. Il Concilio Tridentino ha indicato la via<br />
da percorrere alla Chiesa per i prossimi secoli. Questo non significa<br />
che esso sia stato attuato perfettamente fin dall’inizio. Le resistenze<br />
furono grandi. Oggi siamo in grado di vedere i condizionamenti<br />
delle resistenze e di riconoscere che il senso della storia non<br />
era in esse, ma nelle indicazioni del Concilio che intendeva purificare<br />
e liberare la Chiesa dalle incrostazioni dei secoli. Oggi si vede<br />
bene che le resistenze derivanti da vescovi e cardinali che pensavano<br />
se stessi alla stregua di principi del Rinascimento, nepotisti,<br />
mondani, erano resistenze allo Spirito non giustificabili con la<br />
scusa della difesa della Chiesa e dei suoi beni. Questa riflessione,<br />
però non vale solo per il passato. Ci possiamo domandare che cosa<br />
essa ci insegni a proposito delle resistenze al Vaticano II, delle<br />
nostalgie e dei ritorni. Ciò che è di Dio è dello Spirito, è della Verità<br />
e della Vita.<br />
Il Concilio Vaticano I, troppo facilmente dimenticato, da una<br />
parte raccolse l’eredità di una serie di pontefici che avevano veramente<br />
liberato l’immagine del papato dai condizionamenti mondani,<br />
sviluppandone gli aspetti più spirituali, specialmente l’eredità di<br />
papi martiri quali l’ultimo Pio VI e Pio VII. Dall’altra rilanciò il<br />
ministero petrino, arricchito dell’amore e della preghiera di innumerevoli<br />
santi, verso il futuro di un’umanità che si stava mettendo in<br />
balia di poteri che avevano perso ogni legame con la sacralità del<br />
governare e cadevano in preda di ideologie demagogiche.<br />
Queste esperienze di Chiesa ci insegnano a valutare criticamente<br />
anche il cammino dell’umanità e il suo progresso. Ci si può doman-<br />
1 Contro Apione, 1, 37.<br />
editoriale<br />
Continuità e rottura,<br />
radicamento e sradicamento<br />
riscoperta e riappropriazione<br />
delle proprie radici<br />
pag. 3-7<br />
editoriale<br />
5
editoriale<br />
ADOLFO LIPPI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
editoriale<br />
6<br />
dare se quelle rivoluzioni che hanno inteso sradicare popoli e culture<br />
da tutto ciò che c’era prima, siano state un fenomeno di crescita<br />
vitale, oppure un’operazione chirurgica fatta in modo sbagliato,<br />
oppure fatta su un organismo incapace di sostenerla. La Riforma<br />
luterana è stata la prima e l’esemplare di tali rivoluzioni. Ha prodotto<br />
uno strappo nella tunica inconsutile della Chiesa che, nonostante<br />
tutti gli sforzi che si fanno, nonostante il desiderio e la preghiera di<br />
tanti, non si riesce a ricucire. Certo, la Chiesa aveva bisogno di riforme,<br />
ma altri si adoperavano con tutte le forze senza distruggere<br />
l’unità. Si sono ispirate ad essa le rivoluzioni borghesi e proletarie,<br />
populiste e fasciste.<br />
E’ comune alle dittature, sia di destra che di sinistra, lo sradicamento<br />
e l’imposizione di un’ideologia che serva da struttura mentale<br />
in cui costringere le masse ad inserirsi. Oggi siamo in grado di<br />
misurare meglio ciò che si guadagna e ciò che si perde in tali sradicamenti.<br />
Si può pesare il cumulo di sofferenze, di infelicità, di stragi<br />
che una rivoluzione cruenta comporta. La Rivoluzione francese<br />
(Libertà, quanti delitti in tuo nome!), oltre agli orrendi delitti del<br />
Terrore, si adagiò dapprima nella forma della società napoleonica, a<br />
proposito della quale ci si può oggettivamente interrogare su quanto<br />
corrispondesse agli ideali rivoluzionari, e produsse poi una serie<br />
di reazioni e controreazioni che afflissero interi popoli. Si può dire,<br />
accettando almeno implicitamente il principio di Machiavelli<br />
secondo il quale: il fine giustifica i mezzi, che attraverso questo<br />
sommovimenti e queste tragedie un certo progresso si è prodotto.<br />
Ma oggi ci si domanda: era proprio necessario? L’umanità doveva<br />
proprio passare per lo sterminio della campagna di Russia di<br />
Napoleone e poi della campagna di Russia di Hitler? Ma più ancora<br />
ci domandiamo: col grado di consapevolezza che oggi si ha, è proprio<br />
necessario riprodurre fatalisticamente quei conflitti che, per<br />
giunta, a causa dello sviluppo degli armamenti, possono risultare<br />
oggi fatali per l’intera umanità e per l’ambiente vitale?<br />
Simultaneamente, poiché la vita è dinamica e fluida, non statica<br />
come le ideologie, ci si può domandare se l’eccessiva pressione a<br />
favore della continuità non costringa i gruppi umani a ricorrere agli<br />
sradicamenti. Il principio-responsabilità è tremendamente serio: non<br />
conosce scuse.<br />
Giovanni Paolo II ha osato gridare: mai più guerre. Sembra<br />
un’utopia, le guerre ci sono sempre state. Oggi abbiamo la responsabilità<br />
di tradurre in fatti questa utopia.
A questo punto si può valutare anche l’importanza del ritrovare<br />
le radici, del ricollegarsi con le radici. Negli istituti religiosi si<br />
è sentita fortemente la necessità, in questi ultimi anni, di riscoprire<br />
il carisma fondante e di ricollegarsi ad esso. Non è facile valutare<br />
l’importanza delle radici. Abbastanza superficialmente in un albero<br />
si è portati ad apprezzare il tronco, i rami, le foglie, i fiori e,<br />
soprattutto, i frutti. Ma tutto questo può durare senza le radici?<br />
Un’altra (non ultima) riflessione su questo argomento riguarda la<br />
conversione. In fondo le religioni favorivano le conversioni come<br />
uno sradicamento dal passato che, quanto più risultava radicale,<br />
tanto meglio era, proprio per evitare nostalgie e ritorni. Un romanzo<br />
di un grande convertito - Loss and Gain - del Newman, metteva in<br />
evidenza, già nell’Ottocento, quanto di traumatico c’era in questi<br />
passaggi 2 . Nel nostro secolo sono stati soprattutto illustri convertiti<br />
dall’ebraismo che hanno dichiarato di non essere soddisfatti con<br />
questa idea di conversione, sentendo di non aver voluto negare, passando<br />
al cristianesimo, la loro identità ebraica. Potremmo ricordare<br />
Edith Stein, il cardinal Lustiger, ma anche il rabbino Eugenio Zolli.<br />
Per accogliere una rivelazione che si riconosce come definitiva,<br />
bisogna proprio rinnegare quanto di valido c’era in un’esperienza<br />
precedente vissuta con convinzione e magari anche con devozione?<br />
Come si vede, il discorso sulla rottura o continuità non è un<br />
discorso che si può fare a cuor leggero, difendendo ognuno la posizione<br />
nella quale si sente più a proprio agio. Esso tocca problemi<br />
psicologici e sociali di primaria importanza, che non possono essere<br />
trascurati o dimenticati. Le posizioni di papa Ratzinger mi sembrano<br />
a questo proprio estremamente lucide ed equilibrate, dell’equilibrio<br />
della vita, non dei compromessi. Sono posizioni che,<br />
come è stato detto di pensatori quali Balthasar o Lévinas, non possono<br />
essere superficialmente collocate nelle categorie della cultura<br />
dominante: destra o sinistra, conservatorismo o progressismo.<br />
Debbono essere riconosciute, semmai, come frutto di un atteggiamento<br />
di ascolto della realtà, che evita ogni sovrapposizione.<br />
2 Traduzione italiana di B. Gallo, Jaca Book, MIlano, 1996. Cf. la mia<br />
recensione in Sap Cr, 12 (1997), pp. 181-182.<br />
editoriale<br />
Continuità e rottura,<br />
radicamento e sradicamento<br />
riscoperta e riappropriazione<br />
delle proprie radici<br />
pag. 3-7<br />
editoriale<br />
7
di GIANNI SGREVA C.P.<br />
Nella ricerca che la cattedra Gloria Crucis e questa rivista<br />
stanno portando avanti sulla Croce e la nuova immagine di<br />
Dio, giova molto risalire alle origini dell’inculturazione della<br />
fede nel pensiero. Questo studio di Gianni Sgreva, docente<br />
nello STJ di Gerusalemme e nella UCAC (Université Catholique<br />
Afrique Centrale), mette bene in<br />
evidenza la fatica fatta nel trovare<br />
delle categorie di pensiero che<br />
soddisfacessero la fede e la pre-<br />
ghiera. Al tempo stesso si evidenzia<br />
il peso che le strutture greche<br />
del pensiero hanno avuto sulla formulazione<br />
della fede, costringendo<br />
ad accantonare il problema del<br />
pathos divino, cui erano sensibili<br />
non soltanto i patripassiani, ma<br />
anche Origene e Gregorio il<br />
Taumaturgo.<br />
Ènecessario ricostruire la storia della dottrina della<br />
Trinità, scoprendo nelle tracce delle prime elaborazioni<br />
del concetto cristiano di Dio ciò che specifica<br />
in modo esclusivo l’aggancio della rivelazione<br />
di Dio, del Dio Trinità, con la croce. Dalla<br />
chiarificazione dell’identità del Dio cristiano<br />
discendono delle conseguenze rivoluzionarie sul<br />
piano, non solo teologico, ma anche antropologico ed etico 1 .<br />
1 Il prof. Basil Studer in una sua relazione tenuta nel 1982 alla facoltà teologica<br />
di Freiburg im Breisgau faceva sua la preoccupazione espressa nell’articolo<br />
di U. Ruh, “Das unterscheidend Christliche in der Gottesfrage”, secondo<br />
cui: “...ohne die Trinitätslehre keine vollgültige christliche Antwort auf die alle<br />
Menschen so brennende Gottesfrage geben können”: cf B. STUDER, Zur<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
IL MOVIMENTO<br />
PATRIPASSIANO:<br />
ISTANZE POSITIVE<br />
PER<br />
L’ELABORAZIONE<br />
DEL CONCETTO<br />
CRISTIANO DI DIO<br />
Il movimento patripassiano:<br />
istanze positive<br />
per l’elaborazione<br />
del concetto cristiano di Dio<br />
9-39<br />
teologia<br />
9
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
GIANNI SGREVA<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
teologia<br />
10<br />
Evidentemente questo rapporto Dio-croce richiama un fondamentale<br />
problema che emerge nella ricostruzione delle varie posizioni<br />
assunte nella storia del pensiero cristiano là dove esso ha dovuto<br />
esprimersi sul cosiddetto teopaschismo.<br />
Sia da parte di coloro che difendono l’impassibilità di Dio come<br />
di coloro che si interrogano sulla specificità del concetto di Dio cristiano,<br />
che in un modo o nell’altro, non può essere dissociato dalla<br />
rivelazione della croce, ci sono coloro che ritengono che i Padri, trovandosi<br />
di fronte alla scelta di essere fedeli alla Scrittura e di esprimere<br />
la Scrittura con il linguaggio mutuato dalla filosofia greca,<br />
sarebbero caduti sotto il dominio del concetto greco di Dio ritenuto<br />
impassibile.<br />
Inoltre lo studioso americano Thomas G. Weinandy 2 , che non<br />
ritiene che i Padri abbiano ceduto alla preminenza del linguaggio<br />
filosofico greco, ricorda che a proposito dell’impassibilità divina c’è<br />
differenza tra l’idea di impassibilità divina secondo la filosofia<br />
greca, per la quale Dio è “in-simpatico”, cioè incapace di con-soffrire,<br />
apatetico e statico, e il concetto giudeo-cristiano dell’impassibilità<br />
di Dio, il quale resta sempre vivo ed attivo.<br />
La controversia originata dal patripassianesimo si pone agli inizi<br />
di questo dibattito sulla passibilità o impassibilità di Dio e di riflesso<br />
sulla presa di posizione dei pensatori cristiani di inizio secolo III<br />
sul come coniugare la rivelazione giudeo-cristiana con gli strumenti<br />
ermeneutici-filosofici allora a disposizione.<br />
Ci sembra, infatti, che più che essere un dibattito di linguaggio<br />
strettamente trinitario, riguardante l’egualitarismo divino in rapporto<br />
Entwicklung der patristischen Trinitätslehre. Die äussere Faktoren in der<br />
Geschichte der frühkirchlichen Lehre von der Dreifaltigkeit, in „Theologie und<br />
Glaube“, 1984, 81.<br />
Studer si riferisce a U.RUH, Das unterscheidend Christliche in der<br />
Gottesfrage, in “Herder Korrespondenz“, 36/4, 1982, 187-192.<br />
2 Th.WEINANDY, Does God suffer?, Edinburgh-Notre Dame 2000, 83 n.2.<br />
L’autore cita due teologi, favorevoli all’idea della passibilità di Dio: F. SAROT,<br />
God, Passibility and Corporeality, 44-48 e id., Divine Suffering: Continuity and<br />
Discontinuity with Tradition, in “Anglican Theological Revew”, 78/2 (1996),<br />
226 e F.J. van Beeck (in This Weakness of God is stronger, 18 e un altro,<br />
G.HANRATTY, che insiste sull’impassibilità di Dio, i quali ritengono che sia<br />
superficiale affermare che la maggioranza dei padri abbia sposato la causa<br />
della filosofia greca (Divine Immutability and Impassibility revisited in At the<br />
Heart of the Real, ed. F.O’Rourke, Dublin 1992, 146-148).
alla considerazione del come individuare con linguaggio adeguato le<br />
tre soggettività divine di Padre e Figlio e Spirito Santo, la controversia<br />
monarchiana modalista sia stata, di fatto, un dibattito tra i fautori<br />
della impassibilità di Dio, che si fondavano evidentemente sull’idea<br />
ebraica di impassibilità divina suffragata dalla concezione statica<br />
delle varie teodicee elleniste e quanti sentivano che il Dio cristiano<br />
era irrevocabilmente compromesso con il Dio crocifisso delle<br />
Scritture del Nuovo Testamento.<br />
L’allarme da parte degli antimonarchiani, infatti, è scattato<br />
quando i monarchiani in modo disinvolto hanno applicato al Padre<br />
la passibilità del Figlio incarnato.<br />
Evidentemente è interessante individuare quale concezione di<br />
passibilità, più che di impassibilità, stava sotto al dibattito. Se per la<br />
filosofia greca l’idea della passibilità divina era tabù 3 , il Dio della<br />
teologia ebraica, invece, è un Dio attivo, in movimento, storico, che<br />
ama, che mostra sentimenti “umani”, come del tutto umani sono i<br />
linguaggi che le Scritture ebraiche gli assegnano. L’Antico<br />
Testamento, infatti, dal punto di vista del linguaggio teo-logico è la<br />
preistoria di un Dio destinato ad incarnarsi, e che, in vista di farsi<br />
uomo, parla e si comporta da uomo. Il Dio biblico non è mai presentato<br />
come un Dio apathès 4 .<br />
Quella che la storia della teologia ci segnala a proposito della<br />
controversia monarchiana di fine II e inizio III secolo (tra il 200 e il<br />
235 ca. 5 ), al di là dell’urto di posizioni opposte e, se vogliamo,<br />
deviate, e in ogni caso, sia da una parte sia dall’altra, ancora embrionali<br />
e primitive, è una fondamentale preoccupazione che mette in<br />
luce delle istanze positive in vista dell’elaborazione del concetto<br />
3 W.A. WOLFSON, La filosofia dei Padri della Chiesa, Paideia, Brescia<br />
1978. E M.SPANNEUT, L’«apatheia» chrétienne aux quatre premiers siècles, in<br />
«Proche-Orient Chrétien», 52/ 3-4 (2002), 165-302. In particolare a p. 168,<br />
dopo aver esaminato il concetto di apatheia nella cultura pagana, Spanneut<br />
può con sicurezza affermare: “L’apatheia divine, malgré les fantaisies de la<br />
mythologie, fait l’unanimité des penseurs”.<br />
4 Cf ancora M. SPANNEUT, L’ «apatheia» chrétienne aux quatre premiers<br />
siècles, in «Proche-Orient Chrétien», 52/3-4 (2002), 165-302. In particolare a<br />
p. 171. M.FIGURA, The suffering of God in patristic theology, in “Communio-<br />
International catholic Review”, 30 (2003), 366-369.<br />
5 M. SIMONETTI, Monarchia e Trinità. Alcune osservazioni su un libro<br />
recente, in “RSLR” 1997/3, 626.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
Il movimento patripassiano:<br />
istanze positive<br />
per l’elaborazione<br />
del concetto cristiano di Dio<br />
9-39<br />
teologia<br />
11
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
GIANNI SGREVA<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
teologia<br />
12<br />
cristiano di Dio, secondo cui il Dio-Trinità non può essere pensato,<br />
cristianamente parlando, estraneo alla rivelazione della croce.<br />
La storia della formulazione teologica del concetto del Dio cristiano<br />
ha a che fare con il fatto che i cristiani hanno dovuto progressivamente<br />
prendere posizione rispetto alla teologia ebraica e al politeismo<br />
della cultura pagana e nello stesso tempo mantenere inalterato<br />
nella teo-logia cristiana il monoteismo ebraico e ricorrere alla cultura<br />
ellenista per l’adozione di un linguaggio che fosse capace di<br />
esprimere il novum cristiano, senza per altro che questo ne uscisse<br />
compromesso.<br />
L’impegno della comunità cristiana verso il mondo, è stato, infatti,<br />
quello di difendere l’unità divina contro il politeismo pagano;<br />
mentre, al suo interno, lo sforzo teoretico dei primi pensatori cristiani<br />
si è espresso nel tentativo di chiarire il rapporto tra il monoteismo<br />
ebraico-cristiano e la lex orandi che celebrava la fede in un Dio che<br />
è nello stesso tempo unità differenziata di Padre e Figlio e Spirito<br />
Santo. Sappiamo che la corrente ebionita, giudeo cristiana, che risolveva<br />
il problema dell’identità di Cristo salvando pienamente l’esclusivo<br />
monoteismo ebraico, negava la novità della lex orandi cristiana<br />
che pregava il Figlio collocandolo sullo stesso piano del Padre.<br />
Per gli adozionisti, il Figlio, Cristo, è puro uomo. Papa Vittore (189-<br />
199) condannò Teodoto di Bisanzio, detto il Cuoiaio, il cui pensiero<br />
è riferito dall’autore romano dell’Elenchos 6 , e con lui anche il discepolo<br />
Teodoto il Banchiere 7 .<br />
Tra l’altro una segnalazione tardiva di uno scritto romano della<br />
metà del secolo III, il De Trinitate di Novaziano, che polemizzò fortemente<br />
non solo contro i monarchiani modalisti, ma anche contro<br />
i monarchiani adozionisti, a proposito di questi ultimi ci informa che<br />
uno dei ragionamenti fatti dagli adozionisti per non accettare la divinità<br />
del Figlio, di Cristo, era proprio il fatto che il Cristo è morto per<br />
noi, come dicono le Scritture: se Cristo muore, allora non è Dio, a<br />
meno che le Scritture non insegnino che Dio è morto 8 . Ci saremmo<br />
6 Philos VII,35; X,23.<br />
7 Eusebio HE V,28,6.; Philos VII,36; X 24. Cf M. SIMONETTI, Il problema<br />
dell’unità di Dio a Roma da Clemente a Dionigi, in “RSLR” 20 (1986), 190-<br />
193.<br />
8 Novaziano, De Trinitate 25,141 (ed. A.LOI, Novaziano. La Trinità, SEI,<br />
Torino 1975, 156-157: “Ergo, inquiunt, si Christus non homo est tantum, sed et<br />
deus, Christum autem refert scriptura mortuum pro nobis et resuscitatum, iam
aspettati anche un accenno al modalismo in chiave patripassiana,<br />
invece Novaziano non menziona la problematica della passibilità<br />
divina a proposito di Noeto e di Sabellio.<br />
Come si vede, il patripassianesimo come espressione del monarchianismo<br />
modalista, ma non da identificarsi con esso 9 , si rafforza<br />
anche come polemica tra le due correnti teologiche che hanno di<br />
mira la salvaguardia del monoteismo ebraico. Il monarchianesimo<br />
adozionista fa della passibilità un motivo per negare la divinità di<br />
Cristo, mentre i monarchiani modalisti sostengono la passibilità<br />
divina proprio per salvare il monoteismo ebraico-cristiano, con l’inclusione<br />
di Cristo-Dio. Questo valga a dire come il modalismo patripassiano<br />
segni un capitolo assai interessante in questo percorso della<br />
chiarificazione teo-logica sulla natura di Dio, basata sul monoteismo<br />
ebraico-cristiano (unità di Dio), sul monoteismo cristiano per il<br />
quale l’unicità divina implica due e poi tre individualità (distinzione),<br />
e sulla “passibilità” divina o, come dirà Origene, sulla passibilità<br />
del Dio-amore 10 .<br />
docet nos scriptura credere deum mortum. Aut si deus non moritur, Christus<br />
autem mortuus est refertur, non erit Christus deus, quoniam deus non potest accipi<br />
mortuus”.<br />
Novaziano nel polemizzare con gli adozionismi a proposito della morte di<br />
Dio, tiene ovviamente presente solo la questione della morte fisica che, in quanto<br />
tale, non è applicabile alla dimensione divina (Trin 25,142-144). Anche la<br />
sua obiezione è ancora lontana dal tenere presente l’intuizione della cristologia<br />
efesina e calcedonese, che, cioè, a morire è la Persona del Logos, per cui<br />
per la communicatio idiomatum, è Dio che muore.<br />
9 M. SLUSSER, The scope of Patripassianism, in SP XVII,1, Oxford 1982,<br />
169-175: Slusser mette in guardia dal confondere patripassianesimo con<br />
monarchianesimo o sabellianesimo. Il patripassianesimo fondamentalmente corrisponde<br />
all’affermazione: “The Father suffered and died on the cross” (p.169).<br />
Nel suo articolo Slusser ricostruisce la presenza di questa affermazione nella<br />
teologia dei primi secoli, orientale ed occidentale, e dopo aver constatato che<br />
il patripassianesimo ha avuto una debole udienza presso i padri della chiesa e<br />
gli antichi scrittori cristiani, conclude affermando che si deve limitare il tempo<br />
degli enunciati patripassiani esclusivamente alla prima metà del secolo III.<br />
Continua: “Patripassianism was a rather crude but very moving attempt to<br />
evoke the greatness of the divine love which is revealed in Christ, an attempt<br />
which was in vogue among some elements of the Roman church between about<br />
200 and 220 A.D.”. Cf M. SIMONETTI, Patripassiani, in “DPAC” 2705.<br />
10 Origene, In Ez 6,6 (GCS VIII, 384-385; Sch 352, 229s): “…quae est<br />
ista, quam pro nobis passus est? Caritatis est passio. Pater quoque ipse et Deus<br />
universitatis, longanimis et multum misericors et miserator, nonne quodadmod-<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
Il movimento patripassiano:<br />
istanze positive<br />
per l’elaborazione<br />
del concetto cristiano di Dio<br />
9-39<br />
teologia<br />
13
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
GIANNI SGREVA<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
teologia<br />
14<br />
Infatti, non c’era solo il problema del rapporto tra ciò che è singolare<br />
e ciò che è plurale in Dio, cioè la simultaneità dell’unità e<br />
della pluralità divina, ma anche il concetto stesso di Dio in sé, la sua<br />
identità metafisica, il suo volto. La teologia cristiana non metteva<br />
forse in crisi la teodicea ellenista? 11 . Il tema della passibilità divina,<br />
al di là dei termini imbarazzanti usati dal monarchianesimo, non tentava<br />
forse pur con terminologia inadeguata di descrivere la qualità<br />
del Dio cristiano?<br />
Ci sembra, infatti, che la controversia monarchiana sia stata vissuta<br />
da parte dei teologi del Logos solo in termini di “quantità” divina,<br />
essi cioè si sono semplicemente interrogati sulla questione<br />
numerica del Dio cristiano, se esso sia uno o due o tre, rimanendo<br />
uno. Anche oggi si rischia di analizzare la controversia monarchiana<br />
e patripassiana con gli stessi criteri quantitativi-numerici dei teologi<br />
del Logos. Ma “quale” Dio era il Dio cristiano? Una copia del<br />
concetto del dio greco-romano, o ellenista, o una mera riproduzione<br />
di un Dio ebraico? Qual è invece la qualità del Dio cristiano?<br />
C’è una geometria di Dio, uno in tre! Ma sotto la controversia che<br />
riscaldò il dibattito teologico negli ultimi anni del II secolo e i primi<br />
del III secolo c’erano i tentativi di una ricerca sulla identità qualitativa<br />
del Dio cristiano che, distanziandosi dalla fissità e immobilità<br />
del concetto di Dio delle filosofie elleniste che aborrivano la passibilità,<br />
aprivano il varco all’accoglienza e alla teorizzazione di un<br />
concetto di Dio che, ereditando la dimensione di mobilità storica<br />
delle radici della teologia ebraica, assumeva sempre più il suo specifico<br />
“cristiano” dal confronto inevitabile con la croce del Figlio.<br />
Passerà molta acqua per giungere ad affermare che “Unus de<br />
Trinitate passus est” 12 , uno, nel senso di uno che condivideva con il<br />
um patitur ?...Ipse Pater non est impassibilis ». H. CROUZEL, Origène et la<br />
connaissance mystique, Paris 1961, 261: Crouzel afferma che qui Origene<br />
esprime il misterioso paradosso per cui Dio è sia impassibile sia passibile.<br />
11 Cf J-P. BATUT, Does the Father suffer?, in “Communio-International catholic<br />
Review”, 30 (2003), 389-390: “What we are dealing with, then, is not a<br />
“Hellenization” of <strong>Christi</strong>anity, but the resolute acceptance of the <strong>Christi</strong>an paradox,<br />
the lectio difficilior of the <strong>Christi</strong>an faith”. M. FIGURA, The suffering of God in<br />
patristic theology, in “Communio- International Catholic Review”, 30 (2003), 369.<br />
12 Formula attribuita a Proclo di Costantinopoli, Ep.4 (Unus de Trinitate<br />
passus est in carne) in base anche all’espressione che si trova nel Tomus<br />
ad Armenios del medesimo autore, “Uno della Trinità si è incarnato”
Padre e il Figlio la natura divina. Quindi il Figlio, in quanto Cristo,<br />
ha rivelato il divino come “passibile”. Questa natura divina del<br />
Figlio, della persona del Figlio, è la stessa natura divina in comune<br />
con il Padre e con lo Spirito.<br />
Il monarchianismo patripassiano, se da una parte ha prodotto una<br />
violenta opposizione teologica per quanto riguardava l’esigenza<br />
insopprimibile di fare di Padre, Figlio e Spirito Santo tre soggetti<br />
distinti nell’unico substrato divino, (e questo è stato il motivo per<br />
cui è stato combattuto e penalizzato, così che adesso noi non siamo<br />
in possesso degli scritti originali), ha però il merito di aver acceso<br />
una spia nella storia del pensiero trinitario. Non basta che il concilio<br />
di Nicea abbia coronato gli sforzi, e anch’esso in termini rischiosi<br />
e problematici 13 , per affermare la divinità del Figlio in unità<br />
distinta con il Padre. Sarà, in seguito, il dibattito cristologico a proiettare<br />
la sua luce sul mistero trinitario. La cristologia obbligherà ad<br />
interrogarsi sul Dio che è stato rivelato da Gesù Cristo.<br />
La controversia monarchiana si colloca cronologicamente alla<br />
fine dell’elaborazione della teologia trinitaria di Ireneo e prima delle<br />
sintesi trinitarie di Origene, di Tertulliano e poi di Novaziano, e<br />
quindi essa si pone all’inizio del secolo III come occasione provocante<br />
la ricerca di linguaggi adeguati ad esprimere la complementarietà<br />
di unità e di distinzione nel Dio Uno-Trino cristiano (si pensi<br />
alla stessa introduzione, da parte dei vari teologi della Logos-theologie,<br />
del termine prosopon e persona nel linguaggio teologico per<br />
spiegare in polemica antimonarchiana la distinzione delle individualità<br />
divine) 14 . Tuttavia ci sembra che il cuore e la finalità della opposizione<br />
antimonarchiana sia stata, di fatto, la provocazione della<br />
possibilità di presentare il concetto di Dio in modo teopaschita.<br />
(PG 65,865D). Cf M. RICHARD, Procle de Constantinople et le Théopaschisme,<br />
in “Revue d’Histoire Ecclésiastique”, 38 (1942), 303-331 e W. ELERT, Die theopaschitische<br />
Formel, in “ThLZ” 75 (1950), 193-206.<br />
13 Di Nicea non dimentichiamo l’identificazione fatta dal secondo anatematismo<br />
tra ousia e ipostasis: cf Conciliorum Oecumenicorum Decreta, (curantibus<br />
J.Alberigo, J.A.Dossetti-P.J.C.Leonardi-P.Prodi, Bologna 1973, p.5 o DENZIN-<br />
GER-SCHÖNMETZER, Enchiridion Symbolorum-Definitionum-Declarationum de<br />
rebus fidei et morum, Herder, Barcinone. Friburgi Brisgoviae- Romae-Neo-<br />
Eboraci, MCMLXV, n.126.<br />
14 Cf B. STUDER, Der Person-Begriff in der frühen kirchenamtlichen<br />
Trinitätslehre, in „Theologie und Philosophie“ 57 (1982), 161s.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
Il movimento patripassiano:<br />
istanze positive<br />
per l’elaborazione<br />
del concetto cristiano di Dio<br />
9-39<br />
teologia<br />
15
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
GIANNI SGREVA<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
teologia<br />
16<br />
I teologi della monarchia divina, in effetti, non ebbero nessuno scrupolo<br />
di essere monarchiani-modalisti al fine, ci sembra di dover<br />
dire, di essere patripassiani 15 , ossia allo scopo di affermare la passibilità<br />
di Dio come dimensione essenzialmente cristiana del concetto<br />
di Dio: se Cristo che soffre è Dio, e il Padre è Dio, allora Dio Padre<br />
è coinvolto nella passibilità del Cristo-Figlio, e quindi Lui stesso<br />
soffre. Il nodo problematico in tutto questo passaggio dalla sofferenza<br />
del Figlio alla sofferenza del Padre è dato dall’identificazione del<br />
Figlio con il Padre. Quella che ne derivò fu una identificazione<br />
numerica di Padre e Figlio. Probabilmente, invece, l’intenzione era<br />
quella dell’identificazione di qualità di Padre e Figlio. Se Dio Figlio<br />
soffre, soffre anche a suo modo Dio Padre. Vedremo che Tertulliano,<br />
antimonarchiano, antiprassiano, indulgerà su questa riflessione nel<br />
suo Adversus Marcionem e non sfuggirà all’esigenza di trattare della<br />
passibilità di Dio. Così pure Origene, chiaramente antimonarchiano,<br />
si aprirà a questa lettura della “qualità” del concetto del Dio cristiano<br />
nella sua Omelia sesta su Ezechiele, invocando la “passione dell’amore”.<br />
L’ultima formulazione di tutta la vicenda monarchiana e patripassiana<br />
dei primi anni del secolo III, che l’autore dell’Elenchos, attribuisce<br />
a Callisto, e quindi alla Chiesa ufficiale, è di fatto una formula<br />
di compromesso tra la teologia monarchiana e la teologia del<br />
Logos, una formula incontestabile da parte di chi ritiene la passibilità<br />
divina elemento specificante della teologia cristiana: “kaã<br />
o·twj tÿn patûra sumpeponqûuai t¸ uܸ”? 16 .<br />
15 Simonetti nella sintesi della storia della teologia trinitaria che egli premette<br />
alla sua monumentale ricostruzione della controversia ariana, La controversia<br />
ariana, Istituto Patristico Augustinianum, Roma 1985, 7-8, ricorda che il<br />
monarchianismo era denominato nell’antichità patripassianesimo in Occidente<br />
e sabellianesimo in Oriente, mentre il termine modalismo è quello seguito dai<br />
moderni. M. SIMONETTI, Studi sulla cristologia del II e III secolo (Studia<br />
Ephemerides Augustinianum, 44), Roma 1993, 217.<br />
16 Philos IX, 12: M. MARCOVICH, Hippolytus. Refutatio omnium haeresium,<br />
(Patristische Texte und Studien 25), Berlin, W. de Gruyter, 1986, 354.<br />
Callisto invece esprimerà questa formula per trovare una via di mezzo tra<br />
le formulazioni monarchiane di Cleomene e di Sabellio e quelle provenienti<br />
dalla teologia del Logos espresse dall’autore dell’Elenchos. Per Callisto il Padre<br />
non ha patito in figura del Figlio ma ha patito insieme (sumpeponqûuai) con il<br />
Figlio: cf Philos IX,11-12.<br />
Questa formula assume un rilievo notevole, perché essendo una formula<br />
che prende le distanze sia dai teologi del Logos sia dai sabelliani, e per di più
Pare che la vicenda del patripassianesimo che nel III secolo è<br />
stata messa a tacere proprio per le sue conseguenze sul linguaggio<br />
trinitario non sia stata più riaperta e riaffrontata in altri termini, quelli<br />
appunto riguardanti il concetto stesso del Dio, che senza cessare<br />
di essere ebraico, è diventato soprattutto cristiano 17 . Ci sembra,<br />
infatti, che sia stato proprio per difendere la concezione specificatamente<br />
cristiana della passibilità di Dio che i monarchiani siano stati<br />
costretti a insistere sulla dimensione prioritaria dell’unità di Dio, a<br />
scapito del linguaggio della distinzione. D’altronde la sottolineatura<br />
prioritaria dell’unità di Dio che si sviluppò in Asia Minore e che<br />
costituirà un elemento fondamentale nella controversia ariana e<br />
nello stesso linguaggio niceno 18 , rimanendo come indirizzo e orientamento<br />
teologico a Roma e a Cartagine, e in genere in occidente<br />
fino al sinodo di Serdica 19 , sia indicatrice di una tendenza favorita<br />
dall’insistenza monarchiana 20 , a differenza della teologia della<br />
distinzione alessandrina e cappadoce.<br />
pronunciata da chi molto verosimilmente era diventato vescovo di Roma, acquista<br />
il valore di formula dottrinale, rappresentativa della fede della Chiesa di<br />
Roma. Cf M. SIMONETTI, Monarchia e Trinità. Alcune osservazioni su un libro<br />
recente, in “RSLR” 1997/3, 637-38. L’Uribarri (G. URIBARRI, Monarquia y<br />
Trinidad. El concepto teológico “Monarchia” en la controversia “monarquiana”,<br />
UPCO-Madrid 1996 (Publicaciones de la Universidad Pontificia Comillas,<br />
Madrid), XXV-588), cui fa riferimento Simonetti nella sua recensione, Monarchia<br />
e Trinità..., dà a questa formula di Callisto l’appellativo di “filiopaterismo”.<br />
17 Leggendo le varie monografie che recentemente riprendono il tema della<br />
passibilità di Dio notiamo con sorpresa che appare del tutto assente o marginale<br />
il capitolo o semplicemente l’allusione al monarchianesimo patripassiano:<br />
Cf J.M. HALLMAN, The descent of God: Divine Suffering in History and<br />
Theology, Minneapolis: Fortress, 1991. Th. WEINANDY, Does God suffer?,<br />
Edinburgh-Notre Dame 2000. E. MÜHLENBERG, Der leindende Gott in der<br />
altkirchlichen Theologie, in Der leidende Gott, ed. P. Koslowki e F. Hermanni,<br />
München 2001, 73-86.<br />
18 Lo stesso “consostanziale” di Nicea era considerato un termine passibile<br />
di significazione sabelliana, ma non di matrice sabelliana. Cf M. SIMONETTI,<br />
Studi sulla cristologia del II e III secolo (Studia Ephemerides Augustinianum, 44),<br />
Roma 1993, 218-219.222.223 e M. SIMONETTI, La controversia ariana,<br />
Istituto Patristico Augustinianum, Roma 1975, 100ss.<br />
19 M. SIMONETTI, Studi sulla cristologia del II e III secolo (Studia<br />
Ephemerides Augustinianum, 44), Roma 1993, 236-237.<br />
20 Cf R. M. HÜBNER, Der antivalentinianischen Charakter der Theologie des<br />
Noet von Smyrna, in Logos. Festschrift L. Abramowski, Berlin 1993, 57-86 e<br />
R.M. HÜBNER, Melito von Sardes und Noët von Smirna, in Oecumenica et<br />
patristica. Festschrift für Wilhelm Schneemelcher, Köln 1989, 219s.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
Il movimento patripassiano:<br />
istanze positive<br />
per l’elaborazione<br />
del concetto cristiano di Dio<br />
9-39<br />
teologia<br />
17
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
GIANNI SGREVA<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
teologia<br />
18<br />
Trattando del patripassianesimo sappiamo di inoltrarci in una<br />
vexata quaestio che nella storia dell’elaborazione della teologia trinitaria<br />
è stata in qualche modo confinata semplicemente nell’area<br />
dell’eresia, la cui causa per l’autore del Contra Noetum è anzitutto<br />
l’orgoglio 21 , o la filosofia e il diavolo per l’autore dell’Elenchos 22 .<br />
La causa del monarchianismo è il diavolo anche per il Tertulliano<br />
dell’Adversus Praxean 23 , il quale non ha risparmiato pure di identificare<br />
in Prassea un nemico del montanismo 24 , dato che il retore africano<br />
scrive la sua opera antimonarchiana nella fase montanista della<br />
sua vita.<br />
Se è vero che ogni airesis nasconde o fa intravedere qualcosa che<br />
è vero, se l’airesis significa soffermarsi sul particolare staccato dall’universale,<br />
riteniamo che il patripassianesimo vada considerato<br />
non solo come una delle eresie presentate dall’autore dell’Elenchos<br />
al IX libro o da Epifanio nel suo Panarion, ma anche come un movimento<br />
di ricerca che, oltre a perseguire la soluzione del problema<br />
della concettualizzazione del Dio cristiano, in modo da distinguerlo<br />
dalle radici ebraiche avvalendosi dell’impianto delle filosofie elleniste,<br />
platonismo e stoicismo, almeno indirettamente toccava le corde<br />
più profonde della radicale diversità della teologia cristiana a partire<br />
dallo stesso concetto di Dio, rispetto sia al giudaismo, sia all’ellenismo.<br />
Dall’analisi delle sue tesi e soprattutto delle sue motivazioni, il<br />
patripassianesimo si rivela come un movimento di ricerca dell’identità<br />
del Dio cristiano, la cui descrizione è stata determinata dalla<br />
croce di Cristo.<br />
Analizzeremo i testi esplicitamente passiologici che ci presentano<br />
le tesi patripassiane alla luce dei contesti polemici che ce li hanno<br />
21 Contra Noetum I,3: in P. NAUTIN, Hippolyte. Contre les heresies.<br />
Fragment, étude et édition critique, Paris 1949. Nautin, 234-235.<br />
22 Philos X : la filosofia è la causa e matrice delle eresie. Cf J. FRICKEL,<br />
Hippolyt von Rom, kirchliches Credo oder Glaubenserweis für Heiden (El X 30-<br />
34), in „ ZKTh“ 110 (1988), 129-138.<br />
23 Tertulliano, Adversus Praxean 1,1: CCL 2, 1160: “Unicum Dominum, vindicat<br />
(diabolus) omnipotentem mundi conditorem ut et de unico haeresin faciat.<br />
Ipsum dicit Patrem descendisse in virginem, ipsum ex ea natum, ipsum passum,<br />
denique ipsum esse Iesum Christum”.<br />
24 L’Adversus Praxean fu scritto da Tertulliano montanista, staccato dagli psichici-cattolici:<br />
Adversus Praxean 1,5: “Paracletum fugavit et Patrem crucifixit”.
tramandati. Purtroppo, come era una pratica invalsa nell’antichità<br />
cristiana, tutto ciò che non veniva trovato in linea con il linguaggio<br />
della Regula Fidei della Chiesa 25 , a causa delle ripetute condanne<br />
veniva distrutto, e comunque non ci risulta tramandato in modo originale.<br />
Il movimento patripassiano è ricostruibile, infatti, solo attraverso<br />
le citazioni e le argomentazioni addotte dai polemisti.<br />
Evidenzieremo le argomentazioni addotte contro le tesi patripassiane<br />
per far emergere i termini del dibattito e per rilevare alla fine<br />
il potenziale di teologia trinitaria passiologica che emerge nello<br />
scontro tra i due schieramenti opposti in vista della ricerca della formulazione<br />
specifica del Dio cristiano che, essendo Dio-Trinità, è<br />
determinato non solo cristologicamente, ma anche trinitariamente<br />
dalla Croce del Figlio 26 .<br />
Parte prima:<br />
I punti di riferimento<br />
del movimento patripassiano<br />
Si tratta di Noeto<br />
del Contra<br />
Noetum dell’Ippolito<br />
asiatico, e delle<br />
notizie che di Noeto<br />
danno l’autore romano<br />
dell’Elenchos. L’Elenchos ci parla anche di Epigono, di Zefirino, di<br />
Cleomene, di Sabellio e di Callisto. La nostra analisi vuole restare<br />
nei confini della letteratura antieretica degli inizi del secolo III.<br />
Tertulliano, invece, nel suo Adversus Praxean ci informa sul monarchianesimo-patripassianesimo<br />
sbarcato in Africa e passato sotto il<br />
nome di un forse fantomatico divulgatore di nome Prassea. Delle<br />
fonti successive a questa epoca iniziale della controversia terremo<br />
presente solo il Panarion di Epifanio. Essendo diversi i punti di<br />
vista, tratti dall’analisi degli elementi teologici che potrebbero<br />
in qualche modo indicarci come ricostruire la cronologia dei vari<br />
25 Sia l’Ippolito del Contra Noetum ci riporta la sua formula di fede “cattolica”<br />
(CN I, 18-22: Nautin 234237), sia Tertulliano nell’Adversus Praxean (AP<br />
II,1:CCL 2, 1160).<br />
26 Cf Presentazione del teopaschismo nei padri: J. GALOT, Le Dieu Trinitaire<br />
et la <strong>Passio</strong>n de Christ, in: “NRT” 114 (1982) 70-87. J. M. HALLMAN, The<br />
descent of God: Divine Suffering in History and Theology, Minneapolis:<br />
Fortress, 1991 e Th. WEINANDY, Does God suffer?, Edinburgh-Notre Dame<br />
2000.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
Il movimento patripassiano:<br />
istanze positive<br />
per l’elaborazione<br />
del concetto cristiano di Dio<br />
9-39<br />
teologia<br />
19
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
GIANNI SGREVA<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
teologia<br />
20<br />
documenti antimonarchiani della prima metà del secolo III, preferiamo<br />
seguire uno schema geografico: Asia, Africa, Roma.<br />
Analizzeremo i testi esplicitamente passiologici che ci presentano<br />
le tesi patripassiane alla luce dei contesti polemici che ce li hanno<br />
tramandati.<br />
Una premessa a proposito di Ippolito<br />
Dopo la giornata di studio dedicata alla questione ippolitiana<br />
all’Istituto Patristico Augustinianum di Roma il 23 ottobre 1976 27 , e<br />
le cui conclusioni erano a favore della tesi divisionista, sulla scia del<br />
primo studio condotto nel 1947 da P. Nautin 28 , rispettivamente per<br />
un Ippolito asiatico come autore del Contra Noetum e un Ippolito<br />
romano come autore delle Elenchos 29 , J. Frickel torna alla tesi dell’unico<br />
Ippolito del Contra Noetum e dell’Elenchos 30 . Simonetti,<br />
27 Gli atti del convegno sono stati pubblicati in AV, Ricerche su Ippolito<br />
(Studia Ephemeridis “Augustinianum” 13, Roma 1977.<br />
28 P. NAUTIN, Hippolyte et Josipe. Contribution à l’histoire de la littérature<br />
chrétienne du troisième siècle, Études et Textes pour l’Histoire du Dogme de la<br />
Trinité I, Paris, 1947.<br />
Nautin non attribuisce i Qilosofo„mena né ad Origene, né ad Ippolito, ma<br />
ad un certo Giosippo, ritenendoli anteriori al Contra Noetum. Cf anche<br />
Hippolyte, Contre les hérésies, ed. P. Nautin, Paris 1949, e ancora P. NAUTIN,<br />
La controverse sur l’auteur de l’Elenchos, in «(1952), 5-43. P. NAUTIN, Ippolito,<br />
in “DPAC” 1793-1795.<br />
Per la ricostruzione di tutta la problematica ippolitiana, autore ed opere,<br />
rimandiamo allo studio presentato nella giornata di studio del 23 ottobre 1976<br />
a Roma, all’Augustinianum, da A. LOI, La problematica storico-letteraria su<br />
Ippolito di Roma, in AV, Ricerche su Ippolito, (Studia Ephemeridis<br />
Augustinianum, 13), Roma 1977, 9-16.<br />
29 M. SIMONETTI, Due note su Ippolito, in AV, Ricerche su Ippolito, (Studia<br />
Ephemeridis Augustinianum, 13), Roma 1977, 121-136.<br />
30 J. FRICKEL, Das Dunkel um Hippolyt von Rom. Ein Lösungsversucht: Die<br />
Schriften Elenchos und Contra Noetum, in Grazer Theologische Studien 13,<br />
Graz 1988.<br />
J. FRICKEL, Ippolito di Roma, scrittore e martire, in AV, Nuove ricerche su<br />
Ippolito, (Studia Ephemeridis Augustinianum 30), Roma 1989, 23-41. Cf p.40:<br />
“La struttura teologica comune alle due opere cui abbiamo brevemente accennato<br />
è una novità teologica caratteristica di Ippolito, indizio sicuro, a mio parere,<br />
che l’El ed il Cn non solo rappresentino una medesima teologia del Logos<br />
ma che anche siano opere di un medesimo autore”.
dopo aver preso in considerazione la presa di posizione unionista di<br />
Frickel, ribadisce la sua posizione divisionista. La vexata quaestio<br />
parrebbe per ora chiusa 31 .<br />
Non è intenzione di questo studio proseguire, anche indirettamente,<br />
nel dibattito circa il problema dell’identità dell’autore del<br />
Contra Noetum e dell’Elenchos. Anzi, stiamo alle indicazioni di<br />
Simonetti il quale, oltre a ritenere che abbiamo a che fare con due<br />
autori diversi, un Ippolito asiatico per il Contra Noetum e un<br />
Ippolito romano per l’Elenchos, tenta anche di proporre una<br />
31 Scrive Simonetti (M. SIMONETTI, Aggiornamento su Ippolito, in AV,<br />
Nuove ricerche su Ippolito, (Studia Ephemeridis Augustinianum 30), Roma<br />
1989, 96): “Lo studio di Frickel rappresenta un tentativo veramente notevole di<br />
dimostrare la tesi tradizionale dell’unico Ippolito sulla base di un riesame fondamentale<br />
del rapporto CN/El, considerato il nodo della questione. In realtà<br />
nella questione ippolitiana i nodi sono tanti, e qualcuno ben più aggrovigliato<br />
di quello che pertiene al rapporto delle nostre due opere. Comunque, neanche<br />
in questo ristretto ambito l’ipotesi di soluzione proposta da Frickel ci è sembrata<br />
convincente”. In particolare Simonetti porta un’argomentazione teologica: la<br />
teologia romana dell’El è binitaria, mentre quella asiatica del CN è trinitaria,<br />
includente lo Spirito Santo: Cf l’analisi di Simonetti alle pp 95-96.<br />
Sennonché in un successivo intervento del 1993 lo stesso J. FRICKEL in<br />
Hippolyts Schrift Contra Noetum: ein Pseudo-Hyippolyt, in Logos. Festschrift für<br />
Luise Abramowski, Berlin-New York 1993, 87-123) passa ad accettare la tesi<br />
dei due autori rispettivamente del Contra Noetum e dell’Elenchos.<br />
Ricordiamo che M.-Y Perrin nell’Histoire du <strong>Christi</strong>anisme (dir. Mayeur-Pietri-<br />
Vauchez-Venard),I, “Le nouveau peuple“, 650, n.160, presenta il Contra<br />
Noetum e l’Elenchos come appartenenti a due autori diversi.<br />
Cf anche M. SIMONETTI, Ippolito. Contro Noeto, Roma 2000, cf introduzione<br />
17-146, specialmente la conclusione 127-139, in cui Simonetti, sintetizzando<br />
tutta la vexata quaestio ippolitiana opta definitivamente per i due autori<br />
distinti.<br />
Ai fini del nostro studio non interessa la discussa identificazione dell’autore<br />
romano dell’Elenchos con il presbitero scismatico riscattato dal suo martirio,<br />
secondo l’epigramma di papa Damaso, come invece ci viene proposto ultimamente,<br />
e con linguaggio che ha l’intento di chiudere la questione aperta da<br />
Nautin nel 1947, da Cl. PIERANTONI, El enigma de los dos Hipólitos, in<br />
“Teologia y Vida” 47 (2006), 55-75.<br />
Lo studioso cileno, infatti, ritiene che sia giunto il tempo di concludere la<br />
questione ippolitiana individuando definitivamente due autori distinti per il<br />
Contra Noetum e per l’Elenchos, un Ippolito asiatico, capo di una Chiesa<br />
d’oriente non identificata, come autore antimonarchiano del Contra Noetum,<br />
mentre l’autore dell’Elenchos sarebbe l’Ippolito romano, prete scismatico e poi<br />
riconciliato e identificato con l’omonimo martire che la tradizione romana fa<br />
morire con papa Ponziano in Sardegna sotto Massimino Trace nel 235.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
Il movimento patripassiano:<br />
istanze positive<br />
per l’elaborazione<br />
del concetto cristiano di Dio<br />
9-39<br />
teologia<br />
21
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
GIANNI SGREVA<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
teologia<br />
22<br />
cronologia di questi testi in relazione anche con l’Adversus Praxean<br />
di Tertulliano.<br />
Il Contra Noetum si situerebbe tra la fine del II e gli inizi del III<br />
secolo, dopo l’Adversus Haereses di Ireneo, in quanto Ippolito<br />
dimostra di conoscerlo, e prima del 213, cioè prima dell’Adversus<br />
Praxean di Tertulliano 32 . Ma anche l’Elenchos che Simonetti, invece,<br />
attribuisce ad un Ippolito romano verrebbe non solo dopo il<br />
Contra Noetum dell’Ippolito asiatico 33 , ma forse anche dopo<br />
l’Adversus Praxean di Tertulliano 34 .<br />
32 M. SIMONETTI, Due note su Ippolito, in AV, Ricerche su Ippolito, (Studia<br />
Ephemeridis Augustinianum, 13), Roma 1977, 126-129.136, in quanto<br />
“Tertulliano avrebbe conosciuto la dottrina monarchiana in uno stadio più evoluto<br />
di quello che Ippolito dimostra di aver conosciuto nel Contra Noetum”<br />
(p.129).<br />
33 Anche lo Scarpat ritiene l’Elenchos posteriore al Contra Noetum: G.<br />
SCARPAT , Tertulliano. Adversus Praxean, Introd., testo critico, trad. e comm.,<br />
Corona Patrum. Series Latina, Torino 1984, p.XXIV.<br />
34 Così M. SIMONETTI M, Tra Noeto, Ippolito e Melitone, in “RSLR” 31<br />
(1995/3), 393-414, in particolare p. 393 nota 1, in cui Simonetti sintetizza il<br />
suo pensiero: “ ...io considero il Contra Noeto e l’Elenchos composti da due<br />
autori diversi, CN da un Ippolito orientale, probabilmente asiatico, attivo tra la<br />
fine del II e l’inizio del III secolo, l’Elenchos da uno scrittore romano, forse<br />
anch’egli di nome Ippolito, attivo a Roma negli anni 20-30 del III secolo, che<br />
talvolta per comodità definisco Ps-Ippolito”.<br />
Ancora Simonetti in Monarchia e Trinità. Alcune osservazioni su un libro<br />
recente, in “RSLR” 1997/3, 625, ribadisce la sequenza cronologica: Contra<br />
Noetum, Adversus Praxean, Elenchos.<br />
Tuttavia lo stesso Simonetti, pensando all’affermazione riportata dall’autore<br />
dell’Elenchos, secondo cui Callisto avrebbe affermato che: “il Padre ha patito<br />
insieme con il Figlio”, e che Tertulliano attribuisce in modo anonimo ai monarchiani<br />
(Adversus Praxean XXIX, 5: Ergo nec compassus est Pater Filio. Scilicet<br />
directam blasphemiam in Patrem veriti, diminui eam hoc modo sperant, concedentes<br />
iam Patrem et Filium duos esse, si Filius quidem patitur, Pater vero compatitur,<br />
stulti et in hoc. Quid est enim compati quam cum alio pati?», qualora<br />
Tertulliano avesse conosciuto questa affermazione come di Callisto, riportata<br />
dall’Elenchos, allora si dovrebbe concludere che l’Adversus Praxean viene<br />
dopo l’Elenchos. Cf M. SIMONETTI, Studi sulla cristologia del II e III secolo<br />
(Studia Ephemeridis Augustinianum, 44), Roma 1993, 199. 201.<br />
Inoltre M. SIMONETTI , Una nuova proposta su Ippolito, in “Aug” 36/1<br />
(1996) , 13-46, specialmente 28-29. Nella conclusione di questo articolo,<br />
dopo aver criticato le posizioni A. Brent, Hippolytus and the Roman Church in<br />
the third century. Communities in tension before the emergence of a monarchbishop<br />
(Supplementum to Vigiliae <strong>Christi</strong>anae 319, Leiden, E.J. Brill, 1995),
I.1: In Asia, il Contra Noetum 35<br />
Presentiamo le formulazioni patripassiane di Noeto così come<br />
esse sono riferite e contestate dal Contra Noetum dell’Ippolito asiatico<br />
36 , non possedendo nulla della fonte diretta ma solo quanto è<br />
stato riportato e reso oggetto di esame da parte del polemista. Nel<br />
Contra Noetum l’Ippolito asiatico ci informa che Noeto di Smirne,<br />
convocato a Smirne dai beati presbiteri, in un primo momento ritrasse<br />
le sue idee e quindi non fu condannato.<br />
Noeto aveva affermato che se Cristo è Dio, come è preteso dalla<br />
fede cristiana, allora egli deve essere identificato con il Padre<br />
secondo cui il Contra Noetum dovrebbe essere posticipato all’Elenchos,<br />
Simonetti abbozza una nuova ulteriore ipotesi: “Ora, valorizzando l’osservazione<br />
di Brent e il concetto di comunità ippolitiana da lui proposto in piena<br />
luce, si prospetta la possibilità di una ulteriore ipotesi che tenga debito conto<br />
delle varie che sono state finora proposte: Ippolito, di formazione dottrinale esegetica<br />
e retorica asiatica, ancora in giovane età si trasferisce nella Roma di<br />
Zefirino e di Callisto: la composizione di CN si può collocare o ancora in Asia<br />
o appena lui giunto a Roma. Qui in presenza delle polemiche dottrinali che<br />
laceravano quella comunità, egli in quanto aderente alla dottrina del Logos,<br />
prende parte per l’autore di El, da cui è letto e apprezzato, e lo segue, in qualità<br />
di presbitero, quando quello si distacca dalla comunione della comunità<br />
diretta da Callisto e forma una comunità separata. Successivamente, usciti dalla<br />
scena prima Callisto e poi l’autore di El, egli prende le redini della sua comunità<br />
e la riappacifica con la comunità romana diretta da Ponziano, insieme col<br />
quale condivide l’esilio in Sardegna sotto Massimino (235)” (p.45).<br />
35 Si tratta di un ampio frammento dal titolo: “Omilàa Üppolàtou rciepisk’pou<br />
`R’mhj kaã mßrturoj eáj t¬n aâresin Noøtou tin’j” (dal cod. Vat.<br />
Graec 1431, saec. XI-XII). P.Nautin, Hippolyte. Contre les hérésies. Fragment,<br />
étude et édition critique, Paris 1949. Nautin ritiene Ippolito autore del Contra<br />
Noetum, come ultima parte del Syngtagma contro tutte le eresie, perduto, di<br />
Ippolito, di cui parlava Fozio in Bibliotheca 121 (PG 103,401D-404B). Cf<br />
NAUTIN P., Ippolito, in DPAC 1793-1795. Cf anche l’edizione: Hippolytus of<br />
Rome, Contra Noetum, by Robert Butterwoth, Heytrop Monographa, London<br />
1977. Hippolytus Werke, GCS I/2, 241s. M. SIMONETTI, Contro Noeto,<br />
Bologna 2000, 130ss, in cui Simonetti propende a considerare il Contra<br />
Noetum una omelia. (pp.27-33).<br />
36 L’autore del Contra Noetum sarebbe lo scrittore ricordato da Eusebio<br />
(Eusebio, Historia Ecclesiastica VI,20.2: si parla di un Ippolito capo di un’altra<br />
Chiesa, la cui sede resta sconosciuta e in EH VI,20, 2.22 si dà il nome di<br />
alcuni scritti attribuiti a Ippolito, tra i quali Eusebio non elenca il Contra Noetum<br />
e l’Elenchos: cf Sch 41,119-122 (G.Bardy)), e da Girolamo (Girolamo, De viris<br />
illustribus 61: per Girolamo Ippolito è vescovo), vescovo di una qualche sede<br />
asiatica.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
Il movimento patripassiano:<br />
istanze positive<br />
per l’elaborazione<br />
del concetto cristiano di Dio<br />
9-39<br />
teologia<br />
23
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
GIANNI SGREVA<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
teologia<br />
24<br />
che è Dio. Diversamente non potrebbe essere Dio, per cui al Padre<br />
vengono attribuite le stesse manifestazioni del Figlio incarnato:<br />
nascita, passione e morte.<br />
“Egli disse: Cristo è lo stesso Padre e lo stesso Padre è stato generato<br />
e ha patito ed è morto” (†fh tÿn cristÿn a‹tÿn eênai<br />
tÿn patûra, kaã a‹tÿn tÿn patûra gegenn≈sqai kaã<br />
peponqûnai kaã poteqnhkûnai) 37 . Di fronte, poi, ai presbiteri<br />
che lo convocarono una seconda volta, Noeto insiste sull’unicità di<br />
Dio: “Che male faccio confessando (“un solo Dio 38 ”) il Cristo e “<br />
nessun altro al di fuori di lui 39 ”, che fu generato, che ha patito e<br />
che è morto?”. (Tã oÂn kakÿn poiÒ -üna qeÿndoxßzwn tÿn<br />
crist’n -kaã o‹k ©llon pl¬n a‹to„, gennhqûnpa<br />
paq’nta poqan’nta?) 40 .<br />
La risposta dei presbiteri si appellava alla tradizione (principio di<br />
autorità) senza pretendere una chiarificazione teoretica dell’unica<br />
natura divina (üna Qeÿn doxßzomen) e Cristo, figlio di Dio che<br />
ha sofferto, come ha sofferto, è morto come è morto...” 41 . La<br />
conclusione fu che Noeto fu cacciato dalla Chiesa di Smirne intorno<br />
al 200.<br />
L’autore del Contra Noetum ricorda i passi su cui Noeto faceva<br />
leva per sostenere la tesi dell’unicità divina e l’identificazione di<br />
Dio con il Cristo sofferente, in particolare Es 3,6; Es 20,3 e Is 44,6,<br />
per confessare: “… che se Cristo è Dio, allora egli stesso è il Padre,<br />
infatti Dio è uno solo (oppure, se infatti è Dio) 42 . Patì dunque il<br />
37 Contra Noetum I,4: P. Nautin, Hippolyte. Contre les hérésies. Fragment,<br />
étude et édition critique, Paris 1949, 234-235. Ed. M. Simonetti, Contro<br />
Noeto, Bologna 2000: CN 1,2.<br />
38 ¢na Qe’n, aggiunta fatta dall’editore Nautin e presa da Epifanio, Pan<br />
57,1: GCS 31, 343-344 (1922) (K.Holl-P.Wendland).<br />
39 Kaì o‹k©llon pl¬n a‹to„, aggiunta fatta dall’editore Nautin e presa<br />
anch’essa da Epifanio Pan 57,1: GCS 31, 343.<br />
40 Contra Noetum I,16-18: Nautin 234-235. Simonetti CN 1,6: preferisce<br />
solo il testo: Tã oÂn kakÿn poiÒ doxßzwn tÿn crist’n… senza altre<br />
aggiunte, pur comprensibili alla luce dell’amplificazione che sarà fatta da<br />
Epifanio.<br />
41 Contra Noetum I, 18-20: Nautin 234-235; Simonetti CN 1,6.<br />
42 Questa è la congettura di Nautin “eèj gr ùstãn ” qe’j”, mentre in<br />
V c’è eá. In questo caso, la frase non suona più “uno infatti è Dio”, bensì “se<br />
infatti è Dio”.
Cristo, essendo lo stesso Dio. Dunque patì il Padre, (il Padre) 43<br />
infatti è lo stesso” (Eá oÂn cristÿn ”mologÒ qe’n, a‹tÿj ©ra<br />
ùstãn ” patør, eèj (o eá) gr ùstãn ” qe’$. †paqen d°<br />
cristÿj a‹tÿj applen Qe’j . ÇAra oÂn †paqen patør, -patørgßr<br />
a‹tÿj «n) 44 .<br />
Dalla tesi noetiana emerge una necessaria communicatio idiomatum<br />
tra Padre e Figlio: se la divinità del Figlio è numericamente la<br />
stessa divinità del Padre, allora mentre il Figlio riceve e condivide<br />
la divinità del Padre, contemporaneamente Egli dà al Padre l’attribuzione<br />
della passibilità. Così il Padre assicura la divinità al Figlio,<br />
mentre il Figlio assicura al Padre la passibilità, sciogliendo l’identità<br />
del Padre da una lettura statica e fissista propria della filosofia<br />
ellenista. E mentre per i teologi del Logos le teofanie dell’Antico<br />
Testamento giocano a favore della distinzione, Noeto identifica<br />
nel soggetto delle teofanie divine l’unico Dio che si rende anche<br />
visibile, ad esempio secondo Bar 3,36-38: “Lo stesso è il Dio<br />
unico che poi apparve e dimorò tra gli uomini” (÷ti o‰toj ùstãn<br />
” Qeÿj ” m’noj Ìn kaã fisteron ‘fqeãj kaã toéj<br />
nqrÎpoij) 45 .<br />
Emerge il problema sollevato dai teologi del Logos: Padre e<br />
Figlio sono due o sono uno? In base a Is 45,14-15, Noeto risponde<br />
sostenendo che le Scritture annunciano che “uno è Dio e lo mostrano<br />
visibile”. (üna Qeÿn khr›ssousin aÜ grafaã, to›tou<br />
ùmfano„j deiknumûnou) 46 .<br />
Se pertanto Dio è incontestabilmente uno solo secondo la testimonianza<br />
delle Scritture ebraiche-cristiane, Noeto conclude:<br />
“Allora bisogna che io lo sottometta alla passione (únÿj<br />
-Qeo„- ”mologoumûnou, to„ton (=üna Qe’n) ¤pÿ pßqoj<br />
fûrein). Cristo, infatti, era Dio e ha patito per noi, essendo egli<br />
Padre, affinché potesse pure salvarci”, (cristÿj gr «n Qeÿj<br />
kaã †pascen di>Ωm≠j a‹tÿj applen patør, âna kaã sÒsai<br />
43 Patør, è un’aggiunta di Fabricius, annota l’editore Nautin.<br />
44 Contra Noetum II, 8-10: Nautin 236-237. Ed.Simonetti CN 2,3: Eá oÂn<br />
cristÿn ”mologÒ qe’n, a‹tÿj ©ra ùstãn ” patør, eèj gr ùstãn ” Qe’j.<br />
†paqen d° crist’j, a‹tÿj applen Qe’j .Ara oÂn †paqen patør, -patør- gr<br />
a‹tÿj «n.<br />
45 Contra Noetum II,17: Nautin 236-237.<br />
46 Contra Noetum II, 25-26: Nautin 236-237. Ed. Simonetti CN 2,6.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
Il movimento patripassiano:<br />
istanze positive<br />
per l’elaborazione<br />
del concetto cristiano di Dio<br />
9-39<br />
teologia<br />
25
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
GIANNI SGREVA<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
teologia<br />
26<br />
Ωm≠j dunhq≈) 47 . Noeto adduce anche la motivazione soteriologica<br />
che esige la divinità del Figlio e di conseguenza la sua identificazione<br />
con il Padre, perché la sua sofferenza e la sua morte diversamente<br />
non potrebbero essere salvifiche. In questo Noeto implicitamente<br />
contesta una lettura moraleggiante della <strong>Passio</strong>ne e della<br />
Morte di Cristo che correvano il rischio di produrre i teologi del<br />
Logos. Il dossier scritturistico che Ippolito asiatico menziona di<br />
Noeto include anche alcuni testi del Nuovo Testamento per confermare<br />
l’unicità divina applicata a Cristo. Il primo è tratto da Paolo<br />
(Rom 9,5): “I padri dai quali (proviene) il Cristo secondo la carne,<br />
lui che è il Dio di tutte le cose, benedetto nei secoli”. (Ún oÜ<br />
patûre$, ùx Ún ” cristÿ$ tÿ kat sßrka, ” applen ùpã<br />
pßntwn Qeÿ$ e‹loghtÿ$ eá$ to‡$ aáÒna$) 48 . In questo<br />
modo le Scritture cristiane sono in sintonia con le Scritture ebraiche.<br />
Più avanti, nel corso della ricostituzione della dottrina trinitaria<br />
secondo i moduli della teologia del Logos, l’Ippolito del<br />
Contra Noetum menziona altri due passi del Nuovo Testamento<br />
piegati da Noeto a favore della sua tesi: Gv 10, 30 e Gv 1,1. Gv<br />
10,30 sarebbe stato utilizzato da Noeto con la seguente interpretazione:<br />
“Io e il Padre sono (eámà) uno (ün)”, invece di “siamo”<br />
(ùsmûn). È in questo medesimo contesto dell’esegesi di Gv 10,30<br />
che Ippolito asiatico detta la sua formulazione secondo l’economia<br />
49 della teologia del Logos: “`d›o pr’swpa †deixen,<br />
d›namin d° màan”, cioè a Noeto è contrapposta, e per la prima<br />
volta ricorrendo al termine “prosopon”, la formula per cui “Padre<br />
e Figlio sono due prosopa e una sola dynamis” 50 , a scanso di ogni<br />
loro identificazione.<br />
A proposito di Gv 1,1 Noeto per evitare la distinzione tra Dio e<br />
Logos avrebbe parlato semplicemente di una distinzione allegorica<br />
tra i due 51 .<br />
47 Contra Noetum II, 27-32: Nautin 236-237. Ed. Simonetti CN 2,7.<br />
48 Contra Noetum II, 30-32: Nautin 236-239. Ed. Simonetti CN 2,8.<br />
49 Economia è il termine che Ippolito contrappone a monarchia: Contra<br />
Noetum III, 8; IV, 12.23-25; VIII, 1-7.<br />
50 Contra Noetum VII, 1-4: Nautin 246-247.<br />
51 Contra Noetum XV, 2-3: Nautin 256-257: “ Giovanni parla infatti di<br />
Logos, ma egli non fa altro che allegorizzare”.
L’autore del Contra Noetum tira la conclusione delle tesi di<br />
Noeto per preparare poi la contestazione e l’esposizione della sua<br />
teologia trinitaria in vista di distinguere il Padre dal Figlio-Cristo<br />
grazie alla categoria del Logos e al ricorso al termine prosopon:<br />
“Lo stesso Cristo è il Padre, lo stesso è il Figlio, lo stesso fu generato,<br />
lo stesso patì e lo stesso risuscitò se stesso (A‹tÿ$ ùstã cristÿ$<br />
” patør, a‹tÿ$ uÜ’$, a‹tÿ$ ùgennøqe, a‹tÿ$ †paqen,<br />
a‹tÿ$ úautÿn ¡geiren)” 52 .<br />
Vedendo il Padre e il Figlio l’uno di fronte all’altro, Ippolito non<br />
intende cadere nel diteismo: “E così un altro si pone di fronte a sé,<br />
dicendo un altro non dico due dei, ma come la luce dalla luce o come<br />
l’acqua dalla fonte o come il raggio dal sole. Una sola è la d›namij,<br />
quella che viene dal tutto. Il tutto è il Padre, dal quale la d›namij,<br />
il Logos. Che è il no„j, che entrato nel cosmo si mostrò Figlio di<br />
Dio: tutto da lui, ma solo lui dal Padre…” 53 .<br />
Ippolito legge le Scritture a favore della distinzione dell’oákonomàa.<br />
A proposito di Gv 1, 1 egli sostiene: “Non dico due dei ma uno<br />
e due pr’swpa secondo l’economia; e come terza la grazia<br />
(cßrin) dello Spirito Santo. Il Padre, infatti, è uno, ma i pr’swpa<br />
sono due, perché c’è anche il Figlio e lo Spirito Santo. Il Padre<br />
comanda, il Figlio realizza, mentre il Figlio è mostrato e per mezzo<br />
del quale il Padre è creduto 54 .<br />
Senonché, sebbene questa formulazione fosse assai chiara per<br />
salvare l’unità divina e la distinzione, la teologia del Logos dal<br />
punto di vista della terminologia realmente non riusciva a salvare<br />
l’unità divina, come i monarchiani patripassiani non riuscivano a<br />
teorizzare la distinzione.<br />
Ippolito, infatti, inserisce una rottura cronologica e subordinazionista<br />
nella generazione del Logos dal Padre: “Quando volle, come<br />
volle generò il suo Logos-Sapienza in vista della creazione” 55 .<br />
Ci sono, cioè, dei punti fortemente deboli da entrambe le parti,<br />
come da entrambe le parti sono evidenziati degli apporti positivi.<br />
I monarchiani puntano forte sull’unità divina e, in quanto patripas-<br />
52 Contra Noetum III, 8-9: Nautin 238-239. Ed. Simonetti CN 3,2.<br />
53 Contra Noetum XI, 1-5: Nautin 252-253. Ed. Simonetti CN 11,1.<br />
54 Contra Noetum XIV, 1ss: Nautin 254-257. Ed. Simonetti CN 14,1-4.<br />
55 Contra Noetum X, 3ss: Nautin 250-253. Ed. Simonetti CN 10,3-4.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
Il movimento patripassiano:<br />
istanze positive<br />
per l’elaborazione<br />
del concetto cristiano di Dio<br />
9-39<br />
teologia<br />
27
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
GIANNI SGREVA<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
teologia<br />
28<br />
siani, non dissociano il Padre dalla sofferenza del Figlio, a scapito<br />
della distinzione dei due. L’Ippolito asiatico, tra i teologi del<br />
Logos, evidenzia la distinzione, ma sottoponendo l’esistenza del<br />
Figlio-Logos alla volontà cronologica del Padre. E quindi, ultimamente,<br />
il Logos rischia, per lo meno terminologicamente, di non<br />
essere più Dio.<br />
Ippolito, volendo comunque parare l’obiezione che poteva essere<br />
fatta alla sua affermazione secondo cui il Padre generò il Logos<br />
quando volle e come volle, recupera la convinzione che “Il Logos di<br />
Dio era fin dall’inizio e che è stato inviato adesso” 56 per l’incarnazione.<br />
Per sostenere la sua tesi egli ricorre ad Apoc 19,11-13, dove<br />
si mostra che il Logos di Dio è dall’inizio e ora fu inviato e discese:<br />
il mantello di sangue è simbolo della carne del Logos, per mezzo<br />
della quale l’impassibile Logos di Dio venne nella <strong>Passio</strong>ne (di> >∆j<br />
kaã ¤pÿ pßqoj «lqen ” paq¬j to„ Qeo„ l’goj) 57 . Ippolito<br />
conferma Apoc 19,11-13 con Mi 2,7-8 per asserire che il Logos sofferse<br />
nella carne (to„t> £stin tÿ sarkã paqeén a‹t’n).<br />
Ai monarchiani, che quanto all’incarnazione erano doceti, perché<br />
per loro Gesù resta uomo rivestito d’una potenza divina, Ippolito<br />
ribatte che si tratta invece di vera incarnazione del Logos in vista<br />
della <strong>Passio</strong>ne e che il soggetto dell’incarnazione è il Logos.<br />
Tuttavia, nello stesso tempo esprime la sua preoccupazione contro la<br />
passibilità divina: il Logos impassibile divenne passibile nel “mantello<br />
di sangue”, simbolo della sua carne. In base a Gv 16,27 è confermata<br />
l’incarnazione del Logos: “La d›namij paterna, cioè il<br />
Logos, scese dal cielo e non lo stesso Padre…e solo il Logos è uscito<br />
dal Padre” 58 . E ancora si chiede in termini di chiara cristologia<br />
pneumatica, secondo l’identificazione stoica: “Chi fu il generato da<br />
lui, se non lo spirito, cioè il Logos?” 59 . La conclusione del trattatello<br />
di Ippolito è una sintesi della economia divina, dove è ribadita la<br />
56 Contra Noetum XV, 4: Nautin 256-257. Ed. Simonetti CN 15,6-7.<br />
57 Contra Noetum XV, 3ss: Nautin 256-259. Ed. Simonetti CN 15,3.<br />
58 Contra Noetum XVI, 1-5: Nautin 258-259. Gv 16,27: “Io uscii dal Padre<br />
e vengo”. Ed. Simonetti CN 16,1.<br />
59 Contra Noetum XVI, 6-7:Nautin 258-259; Ed. Simonetti CN 16,2-3. Si<br />
tratta dell’uso di “spirito” non solo per indicare genericamente la natura divina,<br />
ma come altro modo di indicare il Logos: cf M. SIMONETTI, Note di cristologia<br />
pneumatica, in “Aug” 12 (1972), 203s.
distinzione del Padre e del Logos, unito al Padre e inviato da lui per<br />
l’incarnazione e la salvezza grazie alla <strong>Passio</strong>ne e Resurrezione,<br />
descritte in termini marcatamente antidoceti 60 .<br />
La notizia di Epifanio su Noeto<br />
Epifanio in Pan 57 61 a proposito di Noeto riprende e sintetizza,<br />
confermando sostanzialmente le notizie già incontrate nel Contra<br />
Noetum.<br />
Di propria autorità ed orgoglio 62 ha osato dire che il Padre ha sofferto<br />
(tÿn patûra peponqûnai). Convocato dai beati presbiteri,<br />
fu interrogato su tutte queste cose e sulla bestemmia relativa al<br />
Padre. La prima volta davanti al presbiterio negò...Ma dopo aver<br />
infettato altri...cominciò a insegnare apertamente...Allora gli stessi<br />
presbiteri lo convocarono di nuovo. Questa volta lui con i suoi adepti<br />
apertamente entrò in urto: “Che male ho fatto perché confesso<br />
un solo Dio? Io conosco un solo Dio e nessun altro accanto a lui,<br />
ed egli è nato, ha sofferto ed è morto (tã gr kakÿn pepoàhka<br />
÷ti üna Qeÿn doxßzw; üna Qeÿn ùpàstamai kaã o‹k<br />
©llov pl¬n uto„ gennhqûnta peponq’ta poqan’nta).<br />
60 Contra Noetum XVII: Nautin 262-265; Ed. Simonetti CN 17,3s: “…Uno<br />
è il Padre, presso il quale sta il Logos, per mezzo del quale fece tutte le cose,<br />
e che negli ultimi tempi, come abbiamo detto sopra, il Padre inviò per la salvezza<br />
degli uomini. Questi fu annunciato dalla Legge e dai Profeti come veniente<br />
nel mondo. Nel modo in cui fu annunciato apparve e manifestò se stesso.<br />
Diventato uomo nuovo dalla Vergine e dallo Spirito Santo, avendo ciò che è<br />
celeste dal Padre come Logos, mentre quello che è terrestre dal vecchio Adamo<br />
incarnandosi nella Vergine. Il medesimo entrando nel mondo apparve Dio<br />
incorporato (ùnsÎmatoj), entrando come uomo perfetto, non per fantasia o per<br />
modo di dire, ma veramente fattosi uomo. Così dunque non rifiuta di presentare<br />
le sue qualità umane essendo Dio…”.<br />
61 Epifanio Pan 57,1,1-8: GCS 31, 343-344 (1922) (K. Holl-P. Wendland).<br />
Di suo Epifanio afferma che Noeto, asiatico, è di Efeso. Preso da un altro spirito<br />
che non è quello dei profeti e degli apostoli ha proclamato quello che non<br />
è mai stato l’insegnamento della Chiesa.<br />
62 Epifanio (Pan 57,1,1) aggiunge anche la notizia, conforme al Contra<br />
Noetum, dell’autoidentificazione di Noeto con Mosè ed Aronne: CN 1,11:<br />
Nautin 234-235.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
Il movimento patripassiano:<br />
istanze positive<br />
per l’elaborazione<br />
del concetto cristiano di Dio<br />
9-39<br />
teologia<br />
29
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
GIANNI SGREVA<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
teologia<br />
30<br />
Allora espulsero dalla Chiesa lui e gli uomini che aveva istruito<br />
nella sua dottrina...”.<br />
I. 2: In Africa, l’Adversus Praxean 63 di Tertulliano<br />
Prassea è un fantomatico personaggio conosciuto solo da<br />
Tertulliano 64 . Il diavolo trapiantò questa aberrazione dall’Asia a<br />
Roma 65 , dove Prassea diffuse la sua eresia al tempo in cui il vescovo<br />
di Roma stava riconoscendo Montano, prophetiam expulit et<br />
haeresin intulit, Paracletum fugavit et Patrem crucifixit” 66 .<br />
Riportiamo quello che Tertulliano ha colto del patripassianesimo<br />
di Prassea.<br />
Anzitutto Prassea trae un’eresia dalla verità dell’unicità di Dio, in<br />
quanto il Padre stesso è il soggetto dell’incarnazione e della passione,<br />
in forza della pretesa identità di Padre e Gesù Cristo:<br />
“Unicum Dominum, vindicat (diabolus) omnipotentem mundi<br />
conditorem ut et de unico haeresin faciat. Ipsum dicit Patrem<br />
descendisse in virginem, ipsum ex ea natum, ipsum passum, denique<br />
62 Epifanio (Pan 57,1,1) aggiunge anche la notizia, conforme al Contra<br />
Noetum, dell’autoidentificazione di Noeto con Mosè ed Aronne: CN 1,11:<br />
Nautin 234-235.<br />
63 E. EVANS, Tertullian’s Treatise against Praxean, London 1948.: CCL 2,<br />
1157-1205.<br />
G. SCARPAT, Tertulliano. Adversus Praxean, Introd., testo critico, trad. e<br />
comm., Corona Patrum. Series Latina, Torino 1984.<br />
64 L’unica notizia e citazione di Prassea sta solo nell’Adversus Praxean di<br />
Tertulliano. Se fosse reale questo personaggio, come fu possibile che non fosse<br />
citato da nessun contemporaneo? Pare che si tratti semplicemente di un nomignolo.<br />
Prassea deriva da prßssw, colui che si dà da fare, intrigante. M.<br />
SIMONETTI, comunque, alla voce Prassea in DPAC II, 2286 ricorda che “Oggi<br />
si tende a considerare Prassea come il vero nome di un eretico non altrimenti<br />
noto e distinto rispetto agli altri conosciuti da altra fonte”. Cf anche R. CANTA-<br />
LAMESSA, Prassea e l’eresia monarchiana, in “SC” 90 (1962), 28-50.<br />
L’Adversus Praxean fu scritto da Tertulliano montanista, dopo che si era staccato<br />
dagli psichici-cattolici. Siamo dopo il 213. Così pensa E. EVANS,<br />
Tertullian’s Treatise against Praxean, London 1948, 18; M. SIMONETTI, Due<br />
note su Ippolito, in AV, Ricerche su Ippolito, (Studia Ephemeridis<br />
Augustinianum, 13), Roma 1977, 126.<br />
65 Tertulliano, Adversus Praxean I , 4: CCL 2, 1159.<br />
66 Tertulliano, Adversus Praxean I, 5: CCL 2, 1159-1160.
ipsum esse Iesum Christum” 67 . E anche: “Itaque post tempus Pater<br />
natus et Pater passus, ipse Deus dominus omnipotens Iesus Christus<br />
praedicatur” 68 . Per cui il Tertulliano montanista rimprovera Prassea<br />
d’aver messo in fuga il Paraclito e di avere crocifisso il Padre:<br />
“Paracletum fugavit et Patrem crucifixit” 69 .<br />
Tertulliano ritiene Prassea un innovatore di ieri 70 che pretende<br />
difendere l’unità divina contro il diteismo 71 o il triteismo, che include<br />
lo Spirito 72 .<br />
Tertulliano, inoltre, rivendica la praescriptio della Regula fidei<br />
cristiana sopra l’eresia che è recente. Poi, affinché non sembri che<br />
non si sia esaminata l’eresia, per non essere condannata senza essere<br />
stata giudicata ed esaminata 73 , passa ad esporre la sua teologia trinitaria.<br />
Dichiara anzitutto di adottare il termine “monarchia”, che<br />
esprime l’unico comando divino 74 . Ora poiché i monarchiani sostengono<br />
che i due soggetti divini, Padre e Figlio, sono lo stesso (Sed<br />
quia duos unum volunt esse ut idem Pater et Filius habeatur 75 ),<br />
Tertulliano intende esaminare la loro tesi alla luce delle Scritture e<br />
alla luce delle interpretazioni date alle Scritture.<br />
Tertulliano contesta la solitudine divina rivendicata dai monarchiani,<br />
in quanto il Deus rationalis ha sempre avuto con sé la sua<br />
“ratio”, il sermo o il Logos greco 76 .<br />
67 Tertulliano, Adversus Praxean I, 1: CCL 2, 1159.<br />
68 Tertulliano, Adversus Praxean II, 1: CCL 2, 1160.<br />
69 Tertulliano, Adversus Praxean I, 5: CCL 2, 1160.<br />
70 Tertulliano, Adversus Praxean II, 2: CCL 2, 1160.<br />
71 Tertulliano, Adversus Praxean XIII, 2: CCL 2, 1174 e XIII, 6: CCL 2,<br />
1175.<br />
72 Tertulliano, Adversus Praxean XIII, 5: CCL 2, 1175.<br />
73 Tertulliano, Adversus Praxean II, 2: CCL 2, 1160.<br />
74 Tertulliano, Adversus Praxean III, 2: CCL 2, 1161:“Monarchiam, inquit,<br />
tenemus...monarchiam nihil aliud significare scio quam singulare et unicum<br />
imperium”.<br />
75 Tertulliano Adversus Praxean V, 1: CCL 2, 1163: “Sed quia duos unum<br />
volunt esse ut idem Pater et Filius habeatur, oportet et totum de Filio examinari,<br />
an sit et qui sit et quomodo sit et ita res ipsa formam suam scripturis et interpretationibus<br />
earum patrocinantibus indicabit”.<br />
76 Tertulliano Adversus Praxean V, 2-3: CCL 2, 1163: “Ceterum ne tunc quidem<br />
solus; habebat enim secum quam habebat in semetipso, rationem suam scilicet.<br />
Rationalis enim Deus et ratio in(tra) ipsum prius et ita ab ipso omnia. Quae<br />
ratio sensus ipsius est. Hanc Graeci l’gon dicunt...” e che Tertulliano traduce<br />
in latino con il termine sermo.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
Il movimento patripassiano:<br />
istanze positive<br />
per l’elaborazione<br />
del concetto cristiano di Dio<br />
9-39<br />
teologia<br />
31
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
GIANNI SGREVA<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
teologia<br />
32<br />
Tertulliano menziona anche la convinzione dei monarchiani<br />
secondo cui il Padre s’è fatto Figlio di se stesso…Ipse se - inquiunt,<br />
filium se fecit 77 . Per i monarchiani, infatti, riferendosi a Lc 18,27; Mt<br />
19,26.35 e 1 Cor 1,27 non fu difficile per Dio fare da Padre e da<br />
Figlio nello stesso tempo, contrariamente alla consuetudine delle<br />
cose umane. Infatti, non fu difficile per Dio che anche una sterile e<br />
una vergine partorissero contro natura 78 .<br />
Tertulliano obietta che non è possibile la coincidenza di Padre e<br />
di Figlio, perché è il padre che fa il figlio e il figlio fa essere padre<br />
il padre 79 . E se i monarchiani insistono nell’affermare la possibilità<br />
della coincidenza di Padre e Figlio, perché nulla è impossibile a Dio,<br />
allora, si può pure affermare in modo ironico che era opportuno che<br />
il Padre fosse crocifisso: “oportebat et Patrem crucifigi” 80 . Contro<br />
la tesi monarchiana “ne, ut vestra perversitas infert, Pater ipse<br />
credatur natus et passus”, dell’identità Padre-Figlio Tertulliano<br />
porta i passi di Ps 44,2; Ps 109,3; Pr 8,22; Is 42,1; Is 61,1 per<br />
sostenere che Padre, Figlio e Spirito Santo sono tre 81 , mentre Padre<br />
e Figlio non sono due dei 82 .<br />
Rimprovera ai monarchiani di scartare tutto l’ordinamento della<br />
disposizione divina che fin dall’inizio includeva il Figlio, per<br />
affermare che ogni forma di visibilità, incarnazione e sofferenza di<br />
Dio era da attribuirsi al Padre: “ipsum credunt Patrem et visum et<br />
77 Tertulliano Adversus Praxean X, 1: CCL 2, 1169. Cf anche Adversus<br />
Praxean XI,1 : CCL 2, 1170 « Porro qui eundem Patrem dicis et Filium, eundem<br />
et protulisse ex semetipso facis et prodisse ».<br />
78 Tertulliano Adversus Praxean X, 7: CCL 2, 1170: “Ergo-inquiunt- difficile<br />
non fuit Deo ipsum se et patrem et filium facere adversus traditam formam humanis<br />
rebus. Nam et sterilem parere contra naturam difficile Deo non fuit, sicut nec<br />
virginem”.<br />
79 Tertulliano, Adversus Praxean X, 2-6: CCL 2, 1169: “At quin pater filium<br />
facit et patrem filius et qui ex alterutro fiunt a semetipsis sibi fieri nullo modo<br />
possunt, ut pater se sibi filium faciat et filius se sibi patrem praestet”.<br />
80 Tertulliano, Adversus Praxean X, 8 : CCL 2, 1170.<br />
81 Tertulliano Adversus Praxean XIII, 5: CCL 2, 1175: “Absit. Nos enim qui<br />
et tempora et causas scripturarum per Dei gratiam inspicimus, maxime<br />
Paracleti, non hominum discipuli, duos quidem definimus, Patrem et Filium et<br />
iam tres cum Spiritu sancto secundum rationem oikonomiae, quae facit<br />
numerum, ne, ut vestra perversitas infert, Pater ipse credatur natus et passus,<br />
quod non licet credi quoniam non iota traditum est”.<br />
82 Tertulliano Adversus Praxean XIII, 6-10: CCL 2, 1175-1176.
congressum et operatum et sitim et esuriem passum” 83 . Per<br />
Tertulliano, invece, secondo Is 40, 28 Dio non ha fame né sete 84 .<br />
Se Gv 10, 15.17.24 parla di tradimento di Gesù, in effetti i<br />
monarchiani parlano di tradimento del Padre 85 .<br />
A questo punto, Tertulliano ricorda che anche i monarchiani<br />
affermerebbero la distinzione di Padre e Figlio, ma nel senso che<br />
nella medesima persona distinguono la componente divina, cioè il<br />
Padre, lo spirito, cioè Dio, cioè Cristo, mentre la componente umana<br />
è data dal Figlio, che è la carne, l’uomo, Gesù: “In una persona<br />
utrumque distinguant, Patrem et Filium, dicentes Filium carnem<br />
esse, id est hominem, id est Iesum, Patrem autem Spiritum, id est<br />
Deum, id est Christum” 86 .<br />
Tertulliano pensa che i monarchiani abbiano attinto questo linguaggio<br />
dagli gnostici valentiniani, i quali fanno due di Gesù e di<br />
Cristo, del Figlio e del Padre 87 . Tertulliano, in base a Lc 1,35, e<br />
seguendo pure lui l’impostazione della cristologia pneumatica ritiene<br />
invece che si deve distinguere nel Figlio il Sermo o lo spirito e la<br />
carne di cui lo spirito si è rivestito nell’incarnazione (Sermo et<br />
Spiritus qui cum sermone de Patre voluntate natus est. Igitur sermo<br />
in carne…” 88 ), e non si deve confondere la carne con lo spirito<br />
facendo di essi le due componenti, umana e divina, dell’unica persona,<br />
bensì le componenti divina e umana del Figlio (Neque caro<br />
Spiritus fit neque Spiritus caro. In uno plane esse possunt. Ex his<br />
Iesus constitit, ex carne homo, ex Spiritu Deus” 89 ).<br />
La tesi, poi, che fa di Cristo il Padre (Itaque Christum facis<br />
Patrem...) è respinta da Tertulliano in forza del significato stesso del<br />
83 Tertulliano Adversus Praxean XVI, 7: CCL 2, 1182: “Hinc igitur apparet<br />
error illorum. Ignorantes enim a primordio omnem ordinem divinae dispositionis<br />
per Filium decurrisse, ipsum credunt Patrem et visum et congressum et operatum<br />
et sitim et esuriem passum”.<br />
84 Tertulliano Adversus Praxean XVI, 7: CCL 2, 1182.<br />
85 Tertulliano Adversus Praxean XXIII, 11: CCL 2, 1193: “Sed Praxeas ipsum<br />
vult Patrem de semetipso exisse et ad semetipsum abisse ut diabolus in cor<br />
Iudae non Filii traditionem sed Patris ipsius inmiserit. Nec diabolo bene nec haeretico,<br />
quia nec in Filio bono suo diabolus operatus est traditionem”.<br />
86 Tertulliano Adversus Praxean XXVII, 1-2: CCL 2, 1198.<br />
87 Tertulliano, Adversus Praxean XXVII, 2: : CCL 2, 1198.<br />
88 Tertulliano Adversus Praxean XXVII, 6: CCL 2, 1199.<br />
89 Tertulliano Adversus Praxean XXVII, 14: CCL 2, 1200.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
Il movimento patripassiano:<br />
istanze positive<br />
per l’elaborazione<br />
del concetto cristiano di Dio<br />
9-39<br />
teologia<br />
33
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
GIANNI SGREVA<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
teologia<br />
34<br />
termine Cristo, cioè “unto”. Se il Padre fosse l’“unto”, da chi sarebbe<br />
unto 90 ?<br />
I monarchiani di Prassea, secondo Tertulliano, affermano che se<br />
nel Cristo incarnato la componente divina rappresenta il Padre e la<br />
componente umana il Figlio, a patire sulla croce fu la componente<br />
umana del Figlio e non il Padre: “Ergo, inquis et nos eadem ratione<br />
(Patrem mortuum 91 ) dicentes qua vos Filium, non blasphemamus in<br />
Dominum Deum, non enim ex divina sed ex humana substantia<br />
mortuum dicimus. Atquin blasphematis, non tantum quia mortuum<br />
dicitis Patrem, sed et quia crucifixum” 92 . Quindi Tertulliano,<br />
appellandosi a Gal 3,13, contesta che il Padre possa essere stato<br />
appeso alla maledizione del legno, a causa del suo scambio con<br />
Cristo: “Maledictio enim crucifixi ex lege in Filium competit, quia<br />
Christus pro nobis maledictio factus est (Gal 3,13), non Pater.<br />
Christum in Patrem convertentes, in Patrem blasphematis” 93 .<br />
Quindi Tertulliano ricorda come i monarchiani avessero in qualche<br />
modo corretto il tiro, per cui invece di parlare di passibilità<br />
diretta del Padre Prassea avrebbe ripiegato sulla compassibilità del<br />
Padre con il Figlio: “Ergo nec compassus est Pater Filio 94 . Scilicet<br />
directam blasphemiam in Patrem veriti, diminui eam hoc modo<br />
sperant, concedentes iam Patrem et Filium duos esse, si Filius<br />
quidem patitur, Pater vero compatitur, stulti et in hoc. Quid est enim<br />
90 Tertulliano, Adversus Praxean XXVIII, 1: CCL 2, 1200.<br />
91 Evans in CCL 2 non fa questa aggiunta “patrem mortuum”, ma si attiene<br />
al testo trovato.<br />
92 Tertulliano, Adversus Praxean XXIX,3: CCL 2, 1206.<br />
93 Tertulliano, Adversus Praxean XXIX, 3: CCL 2, 1206. Tertulliano afferma<br />
invece che in base a Gal 3,13 “Nos autem dicentes Christum crucifixum, non<br />
maledicimus illum, sed maledictum legis referimus, quia nec apostolus hoc<br />
dicens blasphemavit..”. (Adversus Praxean XXIX, 4: CCL 2, 1202).<br />
94 Callisto invece esprimerà questa formula per trovare una via di mezzo tra<br />
le formulazioni monarchiane di Cleomene e di Sabellio e quelle provenienti<br />
dalla teologia del Logos espresse dall’autore dell’Elenchos. Per Callisto il Padre<br />
non ha patito in figura del Figlio ma ha patito insieme (Û ÌappleÂappleÔÓıÂ,Ó·È)<br />
con il Figlio: cf Philos IX,11-12.<br />
Questa formula assume un rilievo notevole, perché essendo una formula che<br />
prende le distanze sia dai teologi del Logos sia dai sabelliani, e per di più<br />
pronunciata da chi molto verosimilmente era diventato vescovo di Roma,<br />
acquista il valore di formula dottrinale, rappresentativa della fede della Chiesa<br />
di Roma. Cf SIMONETTI M., Monarchia e Trinità. Alcune osservazioni su un<br />
libro recente, in “RSLR”, 1997/3, 637.
compati quam cum alio pati? Porro si impassibilis Pater, utique et<br />
incompassibilis; aut si compassibilis, utique passibilis...» 95 .<br />
Tertulliano solleva a Prassea l’obiezione secondo cui per il timore<br />
di parlare di passibilità sostituisce il termine passibile con quello<br />
di compassibile. Ora il Padre è incompassibile nella stessa maniera<br />
che anche il Figlio è impassibile qua Deus. Se invece il Figlio ha<br />
patito come può non aver compatito anche il Padre con lui? 96 , insiste<br />
Tertulliano.<br />
A questo punto Tertulliano, per distinguere il Padre dal Figlio, e<br />
affermare che se quest’ultimo ha sofferto non significa che anche il<br />
Padre abbia sofferto, usa l’immagine della fonte e del fiume, per dire<br />
che se il fiume si inquina, pur appartenendo alla sorgente, questa non<br />
viene inquinata per il fatto che il fiume è inquinato. Così sul piano<br />
divino, se il Figlio soffre, questo non significa che soffra il Padre 97 .<br />
Segue una obiezione che nel testo di Tertulliano che ci è pervenuto<br />
presenta una notevole difficoltà di interpretazione. Se lo Spirito<br />
di Dio, inteso come natura divina alla maniera stoica, ma anche<br />
secondo Rom 1, 4, potesse patire nel Figlio e non nel Padre, non<br />
dovrebbe patire anche il Padre? È sufficiente affermare che la natura<br />
divina (lo Spirito) non patì in se stessa, perché se il Padre patì<br />
qualcosa, patì nel Figlio, col Figlio, cioè nella carne.<br />
Anche nel credente accade qualcosa di analogo. Non si può patire<br />
per Dio se non abita in noi lo Spirito di Dio. Non è lo Spirito che<br />
patisce, ma lo Spirito dà la possibilità di patire 98 .<br />
95 Tertulliano Adversus Praxean XXIX, 5 : CCL 2, 1203.<br />
96 Tertulliano Adversus Praxean XXIX, 6: CCL 2, 1203: “Times dicere passibilem<br />
quem dicis compassibilem. Tam autem (in)compassibilis Pater est quam<br />
impassibilis etiam Filius ex ea condicione qua Deus est. Sed quomodo Filius<br />
passus est, si non compassus est et Pater? Separatur a Filio, non a Deo”.<br />
Tertulliano è colui che introduce nel latino cristiano il termine impassibilis<br />
opposto a passibilis: Cf BRAUN R., ‘Deus <strong>Christi</strong>anorum’. Recherches sur le<br />
vocabulaire doctrinal de Tertullien, Paris 1962, 63-65. E il termine impassibilis<br />
tornerà solo con Girolamo ed Agostino.<br />
97 Tertulliano Adversus Praxean XXIX, 6: CCL 2, 1203: “Nam et fluvius si aliqua<br />
turbulentia contaminatur, quamquam una substantia de fonte decurrat nec<br />
secernatur a fonte, tamen fluvii iniuria non pertinebit ad fontem; et licet aqua<br />
fontis sit quae patiatur in fluvio, dum non in fonte patitur sed in fluvio, non fons<br />
patitur, sed fluvius qui ex fonte est”.<br />
98 Tertulliano Adversus Praxean XXIX, 7: CCL 2, 1203: “Ita et Spiritus Dei<br />
qui pati possit in Filio. Quia non in Patre pateretur sed in Filio, Pater passus non<br />
vide(re)tur? Sed sufficit nihil Spiritum Dei passum suo nomine, quia, si quid passus<br />
est, in Filio quidem erat ut Pater cum Filio pateretur in carne. Quia hoc<br />
retractatum, nec quisquam negabit, quando nec nos pati pro Deo possumus nisi<br />
Spiritus Dei sit in nobis qui et loquitur de nobis quae sunt confessionis, non ipse<br />
tamen patiens sed pati posse praestans”.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
Il movimento patripassiano:<br />
istanze positive<br />
per l’elaborazione<br />
del concetto cristiano di Dio<br />
9-39<br />
teologia<br />
35
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
GIANNI SGREVA<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
teologia<br />
36<br />
Quindi, fondandosi su Mt 27,46: “Deus meus, Deus meus, ut quid<br />
me dereliquisti”, Tertulliano obietta a Prassea che si possono dare<br />
due possibilità, o è il Figlio ad essere abbandonato o, se era il Padre<br />
a soffrire, verso quale Dio egli si rivolgeva? La conclusione è che la<br />
voce che grida sulla croce è la voce dell’umanità del Figlio, della<br />
sua carne e della sua anima, non quella del “Sermo” o dello Spirito,<br />
cioè non poteva essere la voce di Dio, e la voce fu emessa per<br />
mostrare che Dio è invece impassibile 99 . L’obiezione di Tertulliano<br />
a Prassea si fonda anche su Rm 8,32 : “Se il Padre non risparmiò il<br />
Figlio” e Is 53,6 : “E il Signore lo consegnò per i nostri delitti”. Il<br />
Padre non abbandonò il Figlio nelle cui mani aveva posto il suo spirito.<br />
La morte avvenne quando il Figlio depose lo spirito, perché finché<br />
lo spirito resta nella carne non si può morire. La morte del Figlio<br />
avvenne quando fu lasciato dal Padre. È il Figlio dunque che muore<br />
ed è risuscitato dal Padre 100 .<br />
Tertulliano conclude sottolineando l’allineamento al monoteismo<br />
ebraico del monarchianesimo di Prassea, il quale, identificando<br />
numericamente Padre, Figlio e Spirito Santo, esclude ogni differenza<br />
tra ebrei e cristiani e vanifica la necessità del Vangelo, sostanza<br />
del Nuovo Testamento che conserva la legge e i profeti fino a<br />
Giovanni, qualora non fosse accolta nell’unicità divina la compresenza<br />
di tre soggetti, Padre e Figlio e Spirito Santo 101 .<br />
Nel Nuovo Testamento Dio volle rinnovare la presentazione della<br />
dottrina: Dio, infatti, è creduto uno attraverso il Figlio e lo Spirito,<br />
in modo tale che ora si ha la conoscenza di Dio, dei suoi attributi e<br />
99 Tertulliano Adversus Praxean XXX, 1-2: CCL 2, 1203: “Ergo aut Filius<br />
dereliquit; aut si Pater erat qui patiebatur, ad quem deum exclamabat ? Sed<br />
haec vox carnis et animae, id est hominis, non Sermonis nec Spiritus, id est non<br />
Dei, propterea emissa est ut impassibilem deum ostenderet in mortem».<br />
100 Tertulliano Adversus Praxean XXX, 3 : CCL 2, 1203 : “Ceterum non reliquit<br />
Pater Filium in cuius manibus Filium spiritum suum posuit. Denique posuit et<br />
statim obiit, spiritu enim manente in carne caro omnino mori non potest. Ita<br />
relinqui a Patre mori fuit Filio. Filius igitur et moritur et resuscitatur a Patre secundum<br />
Scripturas…».<br />
101 Adversus Praxean XXXI, 1: CCL 2,1203: «Ceterum iudaicae fidei ista<br />
res, sic unum Deum credere, ut Filium adnumerare ei nolis et post Filium<br />
Spiritum. Quid enim inter nos et illos nisi differentia ista? Quod opus evangelii,<br />
quae est substantia novi testamenti statuens legem et prophetas usque ad<br />
Iohannem, si non exinde Pater et Filius et Spiritus, tres crediti, unum Deum<br />
sistunt?».
delle sue persone, mentre nel passato quando egli parlava attraverso<br />
il Figlio e lo Spirito non lo si capiva 102 .<br />
Ai monarchiani, considerati degli anticristi, il teologo di<br />
Cartagine rimprovera pertanto di negare sia il Padre sia il Figlio.<br />
Negano, infatti, il Padre quando affermano il Figlio e negano il<br />
Figlio mentre credono nel Padre, attribuendo loro quello che non<br />
spetta loro o togliendo loro quello che spetta alla loro identità 103 .<br />
Tertulliano si appella a 1 Gv 4,15, (Qui vero confessus fuerit<br />
Christum Filium Dei) e a 1 Gv 5,10.12 (Qui Filium non habet nec<br />
vitam habet), per ribadire contro i monarchiani e i patripassiani che<br />
Cristo è il Figlio di Dio, non il Padre, cosicché non possiede il Figlio<br />
chi lo crede diverso da quello che il Figlio è 104 .<br />
(continua)<br />
ENG<br />
THE PATRIPASSIAN MOVEMENT:<br />
POSITIVE EXAMPLES FOR ILLUSTRATING THE<br />
CHRISTIAN CONCEPT OF GOD<br />
By Gianni Sgreva, C.P.<br />
In the course of the research which this journal is undertaking on<br />
the Cross and the new image of God, it helps to go back to origins<br />
of the enculturation of faith in thought. This study by Gianni Sgreva,<br />
who teaches at the Franciscan Theological Institute in Jerusalem,<br />
illustrates the difficulty in trying to come across thought categories<br />
which square-up with faith and prayer. At the same time it shows the<br />
extent to which Greek thought structure has influenced the formulation<br />
of faith, forcing the issue of divine pathos to be set on one side,<br />
something which not only the Patripassians, but also Origen and<br />
Gregory the Thaumaturge were sensitive to.<br />
102 Tertulliano Adversus Praxean XXXI, 2: CCL 2, 1204 : «Sic Deus voluit<br />
novare sacramentum, ut nove unus crederetur per Filium et Spiritum, ut coram<br />
iam Deus in suis propriis nominibus et personis cognosceretur qui et retro per<br />
Filium et Spiritum praedicatus non intellegebatur».<br />
103 Tertulliano Adversus Praxean XXXI, 3: CCL 2, 204: «Viderint igitur antichristi<br />
qui negant Patrem et Filium. Negant enim Patrem dum eundem Patrem<br />
credunt, dando illis quae non sunt, auferendo quae sunt.<br />
104 Tertulliano Adversus Praxean XXXI, 3: CCL 2,: «Non habet autem Filium<br />
qui eum alium quam Filium credit».<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
Il movimento patripassiano:<br />
istanze positive<br />
per l’elaborazione<br />
del concetto cristiano di Dio<br />
9-39<br />
teologia<br />
37
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
GIANNI SGREVA<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
teologia<br />
38<br />
LE MOUVEMENT PATRIPASSIEN:<br />
INSTANCES POSITIVES POUR L’ÉLABORATION<br />
DU CONCEPT CHRÉTIEN DE DIEU<br />
Par Gianni Sgreva c.p.<br />
Dans la recherche que la chaire « Gloria Crucis » et notre revue<br />
poursuivent sur la Croix et la nouvelle image de Dieu, il nous est<br />
agréable de revenir aux origines de l’inculturation de la foi dans la<br />
pensée. Cette étude de Gianni Sgreva, professeur au Centre d’études<br />
théologiques franciscaines de Jérusalem, met bien en évidence<br />
la difficulté inhérente à la recherche des catégories de pensée qui<br />
pourraient satisfaire la foi et la prière. Du même coup apparaît<br />
clairement l’influence que les structures grecques de la pensée ont<br />
eue sur la formulation de la foi, contraignant à approcher le<br />
problème du pathos divin, auquel étaient sensibles, non seulement<br />
les patripassiens, mais aussi Origène et Grégoire le thaumaturge.<br />
EL MOVIMIENTO PATRIPASIANO:<br />
ELEMENTOS POSITIVOS PARA LA ELOBORACIÓN<br />
DEL CONCEPTO CRISTIANO DE DIOS<br />
Por Gianni Sgreva, c.p.<br />
FRA<br />
ESP<br />
Dentro del trabajo que la cátedra Gloria Crucis y esta revista están<br />
desarrollando acerca de la Cruz y de la nueva imagen de Dios,<br />
ayuda mucho el remontarse a los orígenes de la inculturación de la<br />
fe en el ámbito del pensamiento. Este trabajo de Gianni Sgrava,<br />
profesor en el Centro Teológico Franciscano de Jerusalén, ilumina<br />
el esfuerzo que hay que hacer para encontrar categorías de<br />
pensamiento que satisfagan a la fe y a la oración. Y al mismo<br />
tiempo destaca el peso que las estructuras del pensaniento griego<br />
han tenido en la formulación de la fe, obligando a aislar el<br />
problema del “pathos” divino, al que eran muy sensibles no sólo los<br />
llamados “patripasianos”, sino también Orígenes y Gregorio el<br />
Traumaturgo.
GER<br />
DIE MONARCHIANISMUS-BEWEGUNG:<br />
BRAUCHBARE SCHRITTE AUF DEM WEG ZU<br />
EINEM CHRISTLICHEN GOTTESBEGRIFF.<br />
Von Gianni Sgreva CP<br />
Für die wissenschaftliche Studie: Kreuz und neues Gottesbild, die<br />
der Lehrstuhl „Gloria Crucis” zusammen mit dieser Zeitschrift<br />
durchführt, ist es notwendig, bis zu den Anfängen der Inkulturation<br />
christlichen Glaubens in menschliches Denken zurückzugehen. Die<br />
vorliegende Untersuchung von Gianni Sgreva, Dozent am Studium<br />
Biblicum Franciscanum in Jerusalem, macht deutlich, welche Mühe<br />
es bereitet hat, passende Denkkategorien für Glauben und Gebet zu<br />
finden. Zugleich wird darin auch die Problematik betont, die griechische<br />
Denkstrukturen für das Formulieren des Glaubens mit sich<br />
brachten. Wie diese nötigten, das Problem des göttlichen<br />
Pathosbeiseite zu lassen. Dessen waren sich nicht nur die<br />
Monarchianisten, sondern auch Origines und Gregorius der<br />
Taumaturg bewusst.<br />
POL<br />
RUCH PATRYPASJAŃSKI:<br />
ELEMENTY POZYTYWNE DO WYPRACOWANIA<br />
CHRZEŚCIJAŃSKIEGO POJĘCIA BOGA<br />
Gianni Sgreva CP<br />
W badaniach nad krzyżem i nad nowym obrazem Boga, które<br />
prowadzà katedra Gloria Crucis oraz to czasopismo (Sapienza della<br />
Croce) jest bardzo pożyteczne si´gnàç do poczàtku inkulturacji<br />
wiary w kategoriach filozoficznych. Ten artykuł o. Gianni Sgreva,<br />
wykładowcy teologicznego studium franciszkaƒskiego w<br />
Jerozolimie, pokazuje wyraênie wysiłek włożony w poszukiwanie<br />
pojęç, które byłyby odpowiednie do wyrażenia treści wiary i do<br />
modlitwy. Jednocześnie podkreśla się wpływ greckich struktur<br />
myślenia na sformułowania wiary, zmuszajàc do zmarginalizowania<br />
problemu Boskiego pathos, na który wrażliwośç zachowali nie tylko<br />
patrypasjanie, ale także Orygenes i Grzegorz Cudotwórca.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
Il movimento patripassiano:<br />
istanze positive<br />
per l’elaborazione<br />
del concetto cristiano di Dio<br />
9-39<br />
teologia<br />
39
di MARIO CEMPANARI C.P.<br />
Seconda parte dell’articolo pubblicato in Sap Cr XXIII-2008,<br />
pp. 429-454.<br />
Già nel lontano 1954, il<br />
compianto e caro<br />
amico Stanislas<br />
Breton C. P., all’epoca<br />
professore alla<br />
Pontificia Università<br />
di Propaganda Fide in<br />
Roma, pubblicava l’originale e sostanzioso<br />
saggio La <strong>Passio</strong>n du Christ et les<br />
Philosophies 1 , in cui, da vero maître à penser,<br />
gettava il primo seme di una serie di<br />
saggi, studi, articoli di analogo argomento<br />
fioriti sulla <strong>Passio</strong>ne di Cristo in varie pub-<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
LA PASSIONE<br />
DI CRISTO<br />
IN<br />
KIERKEGAARD<br />
Note e ricerche<br />
Seconda parte<br />
blicazioni. In quel volume, da autentico pensatore e profondo studioso<br />
della filosofia, rilevava il forte “choc” (Anstoss) esercitato nei<br />
filosofi contemporanei dal fatto che “mieux qu’une vérité abstraite,<br />
la <strong>Passio</strong>n du Christ a fait penser les philosophes”. L’analisi bretoniana<br />
sul mistero della <strong>Passio</strong>ne e della Croce di Cristo, come vista<br />
dai filosofi contemporanei, si limita principalmente ai due grandi<br />
esponenti del pensiero moderno che all’epoca andavano per la maggiore:<br />
Hegel e Nietzsche. Il primo vedeva nella morte di Cristo “il<br />
Venerdì santo speculativo” (“spekulative Karfreitag”) o “la morte<br />
della ragione” e “la rosa nella croce”; il secondo vedeva nella<br />
morte di Cristo “la morte di Dio” e la croce come “l’albero male- La <strong>Passio</strong>ne di Cristo<br />
in Kierkegaard<br />
1 BRETON, La <strong>Passio</strong>n du Christ et les philosophies, Edizioni “Eco”, Teramo<br />
1954.<br />
41-68<br />
teologia<br />
41
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
MARIO CEMPANARI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
teologia<br />
42<br />
detto” al quale è appeso il “Dio morto”, e dunque, se Dio è morto, è<br />
nato l’uomo, il “superuomo” con la sua “volontà di potenza”.<br />
Sfortunatamente, nel suo studio, il Breton non offre le sue originali<br />
e profonde analisi sul pensiero di Kierkegaard. La penna del Breton<br />
ci avrebbe lasciato certamente interessantissime pagine sul mistero<br />
della <strong>Passio</strong>ne come vista e vissuta dal danese.<br />
Senza alcuna pretesa e ben lontano da tali acute analisi bretoniane,<br />
queste mie semplici note vogliono evidenziare i sentimenti e la<br />
profonda differenza tra i due pensatori tedeschi, che hanno svuotato<br />
il mistero della <strong>Passio</strong>ne e della croce del loro valore trascendente e<br />
salvifico per ridurlo ad un puro simbolo laico della razionalità<br />
umana, mentre per il danese esso resta l’unica salvezza data all’uomo<br />
dall’infinito amore di Dio. Le note che presento non sono una<br />
sistematica esposizione del pensiero di Kierkegaard sulla <strong>Passio</strong>ne<br />
di Cristo, ma la lettura di testi e passaggi dalle opere del filosofo<br />
danese, specialmente del voluminoso Diario: si vuole semplicemente<br />
leggere “Kierkegaard con Kierkegaard”.<br />
Ho già rilevato nel numero precedente di questa rivista 2 la qualità<br />
di scrittore e pensatore religioso propria di Kierkegaard, il posto<br />
che Dio occupa nel complesso del suo pensiero 3 e ciò che egli essenzialmente<br />
crede e pensa di Cristo, Uomo-Dio. Il Cristo di<br />
Kierkegaard non si dissolve immanentisticamente in una dottrina<br />
che tenta di armonizzarsi con la pura ragione umana (sul tipo di<br />
Spinoza e di Kant); né la persona dell’Uomo-Dio svanisce nel tipo<br />
ideale dell’unità del divino e dell’umano in eterno divenire (come è<br />
per Fichte, Schelling ed Hegel). Kierkegaard non umanizza Cristo<br />
disancorandolo dal Verbo (sulla scia di Feuerbach o di Nietzsche);<br />
ma si tiene fermo ai principi e ai concetti della teologia dell’incarnazione<br />
e della redenzione 4 .<br />
2 Vedi Sap Cr XXIII, 2009, 4, pp. 429-454.<br />
3 A. MORANT, The place of God in the philosophy of Kierkegaard, in<br />
“Giornale di Metafisica”, VIII (1953), n. 2, pp. 207-221; J. COLLINS, The Mind<br />
of Kierkegaard, Chicago 1953, pp.145 ss.<br />
4 Cf. C, FABRO, Studi kierkegaardiani, Brescia 1953, p. 151 ss. Tutta la<br />
problematica teologica di Kierkegaard sulla figura storica di Cristo e della<br />
nostra “contemporaneità” a Lui, converge in tre momenti distinti, secondo le tre<br />
diverse possibilità di scandalo o paradosso che Cristo presenta al credente<br />
secondo la Sua parola: “Beato chi non si scandalizzerà di me” (Lc 7, 23), culminando<br />
nel paradosso dell-Uomo-Dio della croce.
Ci resta ora da delineare più in particolare la posizione del danese<br />
di fronte al grande mistero della consumazione di tutta l’opera<br />
dell’Uomo-Dio: la sua <strong>Passio</strong>ne e morte. E, di riflesso, il significato<br />
che questo mistero assume per noi. Mi pare che, toccando questo<br />
punto, arriviamo al fondo del pensiero e dell’opera di Kierkegaard.<br />
Dalla prospettiva della croce e della redenzione di Cristo dovrebbe<br />
essere veduta e dimensionata tutta la discussa figura del pensatore<br />
danese 5 . Vedremmo allora che la concezione hegeliana della<br />
“rosa nella croce” 6 e del “Venerdì santo speculativo” 7 , sono ben<br />
diversi dalla concezione di Kierkegaard, che considera “la croce<br />
elemento della stella” 8 ed il vero Venerdì santo del cristiano quello<br />
della “imitazione di Cristo” e il seguirlo “nella via stretta” 9 .<br />
I tre momenti sono:<br />
A. Cristo, uomo comune, nella propria situazione: vissuto cioè in quel determinato<br />
tempo, tra quelle persone e morto in quel determinato modo (Scandalo<br />
negativo del disinteressamento).<br />
B. Cristo, Uomo-Dio, nella situazione dell’elevazione: momento universale<br />
della figura del Cristo, il quale, pur essendo uomo singolo, parla ed opera<br />
come fosse Dio e rivendica per sé la divinità (Scandalo negativo passivo).<br />
C. Cristo, Uomo-Dio, nella situazione dell’abbassamento: altro momento<br />
universale del Cristo, che si presenta come Dio, Unigenito del Padre, ma pure<br />
è uomo umile, povero, sofferente, impotente di fronte alla Sua passione e muore<br />
nella ignominia e nell’abbandono come un criminale (Scandalo positivo della<br />
negazione). Quest’ultima, cristianamente, è la figura e il momento più alto di<br />
Cristo, perché fruttò a Cristo la risurrezione e l’ascensione e il trionfo finale sul<br />
peccato ed a noi la redenzione e l’incorporazione a Lui, sofferente e insieme<br />
glorioso.<br />
5 Si legga il passaggio del “Diario”, vol. I, p. 266, VII A 130; S. SPERA,<br />
Introduzione a Kierkegaard, ed. Laterza, Roma-Bari 1983; 2a ed. Milano<br />
2007; S. SPERA, L’edificante: la speranza della salvezza in Kierkegaard, in<br />
Sap Cr., XXII, 3-4 (2007), pp. 355-362.<br />
6 Cf. HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts, ed. Lasson, Leipzig<br />
1920, tr. it. Messineo,1954, p. 17. Per un esame del pensiero di Nietzsche,<br />
cf. S. BRETON, op. cit., p. 21 ss. Per un approfondimento del pensiero di<br />
Hegel sulla croce e passione di Cristo, cf. K. LOEWITH, Von Hegel bis<br />
Nietzsche, tr. it. Einaudi, 1949, pp. 36 ss. Per conoscere il pensiero teologico,<br />
rimando a HEGEL, Scritti teologici giovanili, a cura di E. MIRRI,<br />
Guida Editori, Napoli 1972.<br />
7 Cf. K. LOEWITH, Da Hegel a Nietzsche, ed. Einaudi 1949, p. 42 s.<br />
8 KIERKEGAARD, Diario 1837, II A 82<br />
9 KIERKEKAARD, Per l’esame di se stessi, 1851, S. W., XII, 394 ss.; Diario<br />
I A 28.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
La <strong>Passio</strong>ne di Cristo<br />
in Kierkegaard<br />
41-68<br />
teologia<br />
43
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
MARIO CEMPANARI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
teologia<br />
44<br />
La <strong>Passio</strong>ne di Cristo<br />
nell’infanzia<br />
di Kierkegaard<br />
Kierkegaard era<br />
certo un filosofo<br />
ed un intellettuale,<br />
ma viveva<br />
anche gli episodi della<br />
sua umana esistenza,<br />
come straordinariamente sapeva ritenere vive in sé, a lungo, le<br />
meno appariscenti, ma non per questo meno intime e più forti<br />
impressioni del suo animo. La <strong>Passio</strong>ne di Cristo è stata appunto una<br />
di quelle intime e profonde impressioni, anche se la meno appariscente,<br />
che sin dalla prima infanzia, lo colpirono e poi lo accompagnarono<br />
per tutta la vita. Egli stesso ce lo fa comprendere, giacché<br />
ci dice che fu educato in una visione tragica della vita e della religione<br />
cristiana 10 ; Cristo non gli fu presentato, a lui fanciullo, nella<br />
poetica e graziosa figura di tenero bambino nel presepio, tra pastori,<br />
agnellini ed angeli osannanti, ma nell’aspetto tremendo del Dio<br />
che gli uomini avevano portato sulla croce.<br />
E’ significativo a questo riguardo il seguente passaggio:<br />
“Vi era una volta un uomo. Egli era stato educato da bambino<br />
severamente nella religione cristiana. Non aveva udito molto di ciò<br />
che i bambini ascoltano di solito, del piccolo bambino Gesù, di<br />
angeli e di altre siffatte cose. Per contro gli era stata rappresentata<br />
di tanto più frequentemente la immagine del Crocifisso, così che<br />
questa immagine era l’unica immagine e la sola impressione che<br />
egli avesse del Salvatore; per quanto egli fosse un bambino, era già<br />
un vecchio come un uomo giunto alla fine della vita. Questa immagine<br />
lo seguì dunque attraverso tutta la sua vita; egli non riconquistò<br />
più la sua giovinezza, “er wurde niemals junger”, e non riuscì<br />
a liberarsi da questa immagine. Come si racconta di un pittore che<br />
nell’angoscia della sua coscienza non potesse tralasciare di riguardare<br />
verso la immagine dell’ucciso, che lo perseguitava: così egli<br />
nel suo amore non riusciva a liberarsi un solo istante da quella<br />
immagine, che insieme lo attraeva a sé. Ciò che egli aveva creduto<br />
pienamente da fanciullo, che i peccati del mondo esigessero questo<br />
sacrificio; ciò che egli aveva da fanciullo inteso in semplicità, che<br />
10 KIERKEGAARD, Der Gesichtspunkt fur meine Wirksamkeit als<br />
Schriftsteller, hsg. von Hirsch, Düsseldorf/Koeln, 1951, bd. 33, p. 75 ss;<br />
Diario 1849, XI A 8, 78; VIII A 499...
la incredulità degli ebrei fosse nelle mani della provvidenza la condizione<br />
perché l’errore e il timore di quella prima esperienza religiosa<br />
potesse venire inculcato: questo egli credeva e intendeva in<br />
modo immutato” 11 .<br />
A questo impersonale racconto autobiografico, Kierkegaard<br />
aggiunge più chiaramente nel Diario:<br />
“Fin da tenero bambino, mi fu raccontato nel modo più solenne<br />
che la folla sputava su Cristo (Mt 27, 30), ed Egli era la Verità (...),<br />
sputò addosso a Lui e bestemmiava contro di Lui. Questa impressione<br />
l’ho conservata profondamente nel mio cuore, perché anche se vi<br />
sono stati momenti, periodi interi, in cui l’abbia quasi dimenticata,<br />
ci sono poi ritornato sempre come al primo pensiero. Per meglio<br />
nasconderlo, l’ho anche celato sotto l’aspetto esteriormente più<br />
opposto; l’ho celato nel più profondo dell’anima mia, perché temevo<br />
mi scivolasse via troppo presto, che me lo togliessero con frode e<br />
diventasse come un colpo a salve. Questo pensiero (...) è la mia vita.<br />
(...) Sputacchiarono Cristo che era le Verità; e anche se tutto dimenticassi,<br />
non dimenticherò mai (come non ho mai dimenticato) quel<br />
che mi dissero quand’ero bambino, nè l’impressione che faceva sul<br />
bambino. Succede alle volte che un infante si è fidanzato fin dalla<br />
culla a chi un giorno sarà sua sposa o suo marito. In senso religioso<br />
io ero fidanzato fin da bambino (...). Fidanzato a quell’Amore che<br />
da principio e fino a questo momento, malgrado i miei molti traviamenti<br />
e peccati ha abbracciato me” 12 .<br />
Kierkegaard sentì dunque di essere sin dalla nascita segnato dalla<br />
croce e ad essa consacrato; e in dedizione di amore l’accettò, non<br />
come inevitabile, ma come la più alta espressione del cristianesimo,<br />
anzi dello stesso sublime Dio che è Amore. In un passo significativo<br />
del Diario dell’11 maggio 1848, Kierkegaard ci fa conoscere la<br />
sua metamorfosi spirituale, che cominciò sin dall’infanzia, e che lo<br />
portò a comprendere il mistero della croce e della sofferenza:<br />
“...Le anime più profonde o quelle che Iddio ha conformate<br />
meglio per le cose eterne, comprendono subito che dovranno soffrire<br />
durante la vita; non osano domandare a Dio un aiuto talmente<br />
straordinario e paradossale. Ma Dio, nonostante tutto, è l’Amore.<br />
11 KIERKEGAARD, Zwo kleine ethisch-religioese Abhandlungen, S. W. ,<br />
1909-22, vol. X, p. 105 tr. it. da F. LOMBARDI, Kierkegaard, cit. p. 64.<br />
12 KIERKEGAARD, Diario 1849, XI A 272, tr. it. vol. II, p. 155 ss.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
La <strong>Passio</strong>ne di Cristo<br />
in Kierkegaard<br />
41-68<br />
teologia<br />
45
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
MARIO CEMPANARI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
teologia<br />
46<br />
Niente di più certo. Quindi si rassegnano. E poichè l’Eterno sta loro<br />
accanto, trovano pace, sempre nella felice certezza che Dio è<br />
amore...<br />
...La maggiore parte degli uomini non arriva affatto alla fede...;<br />
gli individui eccezionali cominciano in un modo tutto opposto: da<br />
bambini dialetticamente, cioè senza immediatezza: cominciano<br />
subito con la riflessione, e vivono così per anni (...); e poi, in età più<br />
matura, intravedono la possibilità della fede. Perché la fede è l’immediatezza<br />
che viene dopo la riflessione.<br />
Le nature eccezionali hanno naturalmente un’infanzia ed una<br />
giovinezza molto infelice, perché dall’essere essenzialmente riflessivi<br />
in quell’età (...) nasce la malinconia più profonda (...). Ma l’infanzia<br />
e la giovinezza infelice delle nature eccezionali si trasfigurano<br />
in spirito” 13 .<br />
Questo passaggio, di chiaro tono autobiografico, si allinea a tanti<br />
altri che ci rivelano un Kierkegaard pensoso sin dalla fanciullezza al<br />
problema del Dio crocifisso, Dio d’amore. Il filosofo ricorda poi<br />
ancora da adulto e con esattezza l’impressione penosa che gli faceva<br />
il Crocifisso, quando, da bambino, uscendo a passeggio col vecchio<br />
padre per le vie della città, lo trovava sempre esposto in una<br />
vetrina di un negozio, messo con gli altri soldatini o pupazzetti di<br />
carta pesta di Norimberga: gli sembrava una profanazione e nello<br />
stesso tempo gli rivelava quanto l’altissimo mistero del Cristo crocifisso<br />
fosse stato imborghesito e camuffato dal cristianesimo superficiale,<br />
“che onora Cristo con il seppellirlo, e sapere con certezza<br />
ch’Egli dunque è morto” e non ci infastidisce con questa morte 14 .<br />
La <strong>Passio</strong>ne di Cristo produsse tale forte impressione in<br />
Kierkegaard, che egli pensò più volte di scriverne un libro ex professo<br />
15 ; tuttavia si può dire che egli ce ne ha dato, qua e là nelle sue<br />
opere, un ampio approfondimento ed una personale meditazione. Il<br />
cristianesimo di Kierkegaard, infatti, ci sarebbe incomprensibile e si<br />
potrebbe fraintendere come una specie di pessimismo della vita;<br />
mentre invece egli muove dalla croce ed attraverso la via della<br />
croce va al Dio che è amore 16 .<br />
13 IDEM, Diario 1848, VIII A 649, tr. it. vol. I, p. 418 s:<br />
14 IDEM, Ibid. 1852, X 4 A 507, II, p. 568.<br />
15 IDEM, Ibid., VIII A 271, 469; XI A 323...<br />
16 IDEM, Ibid., 4 A 624, vol. II, p. 596.
Kierkegaard non si propone di speculare e di “vivere del fatto che<br />
Cristo è stato crocifisso”, non intende la <strong>Passio</strong>ne e la morte del<br />
Redentore come molti gaudenti pastori del suo tempo 17 , ma anela<br />
solo patire per Cristo, imitandolo, perché egli conosce e ricorda la<br />
frase dell’Imitazione di Cristo: “Tota vita <strong>Christi</strong>, crux et martyrium<br />
fuit” 18 . Ed egli, per tutta la sua vita, meditando fra sé il mistero della<br />
croce, voleva svelare a se stesso i recessi di quel cuore divino che ci<br />
redense. Se dobbiamo credere ad un principio di Kierkegaard: “La<br />
saggezza dell’uomo consiste proprio nel giudicare rettamente della<br />
propria infanzia e giovinezza, e nel fatto che la vita esprima veramente<br />
il proprio pensiero” 19 , allora dovremmo concludere che tutta<br />
la saggezza di Kierkegaard viene dall’aver pensato e vissuto la<br />
<strong>Passio</strong>ne di Cristo sin dalla sua infanzia e giovinezza.<br />
Peccato<br />
e redenzione<br />
Il “point de départ”<br />
della soteriologia<br />
kierkegaardiana (e<br />
di tutta la più scottante<br />
problematica del dane-<br />
se) muove dal concetto teologico (e non semplicemente ed ambiguamente<br />
filosofico) del peccato, che trova l’unica soluzione possibile<br />
nella redenzione di Cristo. “Chi, nel rapporto con la colpa, viene<br />
educato dall’angoscia, troverà quiete soltanto nella Redenzione” 20 .<br />
Con questa categorica affermazione di principio termina la profonda<br />
analisi che Kierkegaard fa dell’angoscia, la quale genera la caduta<br />
dell’uomo nel peccato e assieme ne deriva. Il peccato, l’essere nel<br />
peccato, è un elemento essenziale per stabilire un rapporto di opposizione<br />
e di superamento all’elemento cristiano della fede 21 , i quali<br />
due elementi trovano la loro più alta soluzione e valorizzazione<br />
nella redenzione dell’Uomo-Dio.<br />
Il contrasto cristiano peccato-fede porta necessariamente alla<br />
realtà dell’Uomo-Dio redentore. E’ la “coscienza angustiata” dal<br />
17 IDEM, Ibid. 1854, XII A 262, vol. III, p. 147.<br />
18 IDEM, Ibid. 1851, X 4 A 354, vol. II, p. 536...<br />
19 IDEM, Ibid. 1849, X 297, vol. II, p. 254.<br />
20 IDEM, Il concetto dell’angoscia, tr. it. Firenze 1953, p. 202.<br />
21 IDEM, La malattia mortale, tr. it, Milano, p. 366.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
La <strong>Passio</strong>ne di Cristo<br />
in Kierkegaard<br />
41-68<br />
teologia<br />
47
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
MARIO CEMPANARI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
teologia<br />
48<br />
peccato che comprende il valore del cristianesimo. Non si tratta però<br />
solo di una comprensione speculativa:<br />
“...Mi dirai: La Redenzione io non la posso capire”. Qui dovrei<br />
domandarti: In quale senso tu la vuoi capire? Nel senso della<br />
coscienza angustiata o in quello della speculazione indifferente e<br />
oggettiva? Se uno vuol starsene tranquillo e oggettivo al tavolino<br />
a speculare: come potrà capire la necessità della Redenzione?<br />
Una redenzione è necessaria solo per una coscienza angustiata.<br />
Se fosse in potere dell’uomo il vivere senza necessità di mangiare,<br />
come potrebbe comprendere quel bisogno di mangiare che<br />
l’affamato capisce così facilmente? Altrettanto dicasi nel campo<br />
dello spirito” 22 .<br />
Ma non si creda che Kierkegaard voglia naturalizzare e razionalizzare<br />
la redenzione alla stregua della “Versöhnung” hegeliana; ciò<br />
lo possiamo desumere dalla posizione generale di Kierkegaard di<br />
fronte al cristianesimo hegeliano, come pure in particolare dalla<br />
diversa valutazione teologica che il danese fa del mistero dell’incarnazione<br />
e della redenzione: diversità che fa leva, lo ripetiamo, sull’interpretazione<br />
strettamente storico-teologica della vita di Cristo.<br />
Per Hegel Cristo non è assolutamente e semplicemente l’Uomo-Dio:<br />
la Sua vita, <strong>Passio</strong>ne e morte non hanno più il senso della cristologia<br />
di Atanasio d’Alessandria e del concilio di Nicea; il suo Cristo è<br />
assorbito nel generale “divenire” della storia umana, la quale è<br />
insieme “riconciliazione”, “redenzione” (Versöhnung) 23 e giudizio<br />
del mondo (Weltgeschichte als Weltgericht, il giudizio della storia<br />
del mondo come giudizio universale del mondo). Perciò Cristo è al<br />
più un simbolo, non una realtà; un mito, non una persona.<br />
Kierkegaard non può accettare questo panmediazionismo, vuoto di<br />
realtà teologica, e reagisce non solo partendo da principi più generali<br />
24 , ma si determina in particolari posizioni ed atteggiamenti, visibilissimi<br />
ad ogni più elementare raffronto.<br />
Cos’è il peccato per Kierkegaard? Esso non è qualcosa come<br />
l’ignoranza socratica, ma, teologicamente, è qualcosa di più: è<br />
22 IDEM, Diario 1847, VII A 192, tr. it. vol. I, p. 300.<br />
23 HEGEL, Philosophie des Geschichte, ed. Lasson, I, Leipzig 1930, p. 106;<br />
S. BRETON, La <strong>Passio</strong>n du Christ et les philosophies, cit., p. 31 ss.<br />
24 KIERKEGAARD, Diario, III A 1, 391; IX A 112, 16o; X 12 A 203, 436;<br />
Briciole di filosofia. Postilla conclusiva.
colpa 25 ; e non è neppure la soggettività astratta, l’arbitrio, il predominio<br />
del singolo sull’universale hegeliano 26 , ché sarebbe allora<br />
pura negatività; ma il peccato per Kierkegaard è qualcosa che si<br />
afferra ed afferma al di dentro della libertà: è “atto” di libertà, che<br />
si muove verso la propria perdizione, che non riesce a superare lo<br />
“scandalo” che trova nell’Uomo-Dio e nel suo insegnamento, e<br />
quindi viene a perdersi nella finitezza delle cose mondane. Questo<br />
concetto di peccato non è diverso da quello che con altre parole era<br />
stato definito come “aversio a Deo et conversio ad creaturas”.<br />
La redenzione poi è una realtà oggettiva, in stretto rapporto di<br />
fede al peccato originale, “caratterizzato dal fatto che vi è un<br />
Redentore, il quale ha dato soddisfazione per tutto il genere<br />
umano” 27 . Di fronte all’infinita distanza tra Dio e l’uomo, che si<br />
manifesta specialmente con il peccato 28 , non poteva bastare una<br />
redenzione filosofica, la quale non va più là di una redenzione relativa,<br />
“cioè di una redenzione che redima se stessa” 29 , ma è necessaria<br />
una redenzione quale solo Dio poteva concepire; da questo e dai<br />
tormenti che Cristo ha sofferti per redimerci dobbiamo imparare<br />
quale orrore sia il peccato. “Il fatto che Cristo è morto per i miei<br />
peccati, esprime quant’è grande la Grazia; ma nello stesso tempo<br />
anche quanto grandi sono i miei peccati, quanto io sono infinitamente<br />
lontano da Dio. La Redenzione in...senso più profondo<br />
l’“uomo” non potrebbe inventarla, perché nessun uomo potrebbe<br />
da sé concepire una così sublime sublimità di Dio. Solo Iddio sa<br />
quanto infinitamente Egli è” 30 .<br />
...“Il Cristianesimo è l’idea che Dio ha del peccato e della giustizia.<br />
Se mi trascino a casaccio nella mia idea puramente umana<br />
sulla natura del peccato e della divina giustizia, come potrebbe<br />
venirmi in mente che il peccato sia una cosa così tremenda che ci<br />
volle la <strong>Passio</strong>ne e la Morte di Cristo per redimerlo? Questo è il tormento<br />
infinitamente profondo dell’incomprensione della <strong>Passio</strong>ne<br />
25 IDEM, Diario, XII A 371.<br />
26 HEGEL, Enciclopedia filosofica, cit., § 511 s.; tr. it., p. 459: KIERKE-<br />
GAARD, Diario X 2 A.<br />
27 KIERKEGAARD, Diario 1850, X2 A 483, tr. it., vol. II, p. 343.<br />
28 IDEM, Ibid., V A 16.<br />
29 IDEM, Ibid., I A 94, tr. it., vol. I, p. 29 s.<br />
30 IDEM, Ibid. 1849, X2 A 189, tr. it., vol. II, p. 276 s.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
La <strong>Passio</strong>ne di Cristo<br />
in Kierkegaard<br />
41-68<br />
teologia<br />
49
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
MARIO CEMPANARI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
teologia<br />
50<br />
di Cristo. Noi uomini viviamo nelle nostre idee; ci sembra che tutto<br />
vada abbastanza bene e che il peccato non sia poi una cosa così<br />
tremenda. Allora ecco che viene Cristo e vuole salvarci. Egli fa tutto<br />
per amore; è vero; ma pone sempre l’idea divina di quel che è il<br />
peccato” 31 .<br />
La redenzione dunque presuppone il peccato e salva da esso,<br />
svuotandolo della sua virulenza e facendocelo aborrire; ma nè l’una<br />
nè l’altro vengono intesi da Kierkegaard come semplici categorie<br />
della ragione umana, bensì come realtà storiche cristiane che ci possono<br />
venire solo dalla fede 32 .“Il lato storico della Redenzione deve<br />
star saldo ed essere certo come un qualsiasi avvenimento storico,<br />
ma non di più: perché allora le sfere si confondono (...). Il presupposto<br />
storico della Redenzione deve essere mantenuto soltanto come<br />
ogni realtà storica; ma deve sempre la passione della fede decidere<br />
del tutto, come per la Provvidenza. La fede della Redenzione nella<br />
remissione dei peccati toglie al contrito quella determinazione<br />
intermedia della angoscia di pensare che tutto il suo rapporto a Dio<br />
debba andare attraverso la determinazione intermedia della<br />
pena” 33 .<br />
La fede nella redenzione dal peccato supera l’irretimento in esso<br />
e ci porta vicino a Dio 34 , in modo che la nostra libertà, restaurata dal<br />
di dentro viene salvata dalla disperazione: la redenzione “ferma” il<br />
moto della libertà verso “il tutto è perduto!” della disperazione 35 . La<br />
redenzione poi, come fatto dogmatico, si concentra nella morte di<br />
Cristo, la quale è realtà storico-dogmatica: qui Cristo è veramente<br />
Salvatore e non soltanto Modello. E con questi concetti Kierkegaard<br />
vuol precisare anche il senso e la portata della “contemporaneità”<br />
con Cristo, la quale forse, in fondo, non vuol essere altro che una<br />
personale e nuova interpretazione del dogma del “corpo mistico” di<br />
Cristo.<br />
“Se si vuol prendere la contemporaneità con Cristo come criterio<br />
dell’essere cristiani, bisogna però fare una osservazione. Ciò che in<br />
diversi scritti ho svolto sulla “contemporaneità”, che cioè essa<br />
31 IDEM, Ibid. 1851, X4 A 251, tr. it., vol. II, p. 520.<br />
32 IDEM, Ibid., VII A 139, 192...<br />
33 IDEM, Ibid., 1846, VII A 130, tr. it., vol. I, p. 266 s.<br />
34 IDEM, Ibid., 1847, VIII A 284, tr. it., vol. I, p. 366.<br />
35 IDEM, ibid., 1847, VIII A 97, tr. it., vol. I, p. 395.
costituisce il criterio di misura, è assolutamente vero sotto l’aspetto<br />
poetico, storico ed etico, e conserva quindi il suo valore; e in un<br />
certo senso vale anche rispetto a Cristo come persona storica. Ma<br />
Cristo è nello stesso tempo la realtà dogmatica. Qui sta la differenza.<br />
La Sua morte è la Redenzione. Con questo la categoria cambia<br />
qualitativamente. Dalla morte di un testimonio della verità io devo<br />
imparare a morire per la verità, a imitarlo. La morte di Cristo invece<br />
non è compito d’imitazione, ma è la Redenzione. Io non posso<br />
considerare e concepire Cristo come una persona puramente storica.<br />
Considerando la Sua vita e la Sua morte, io considero o devo<br />
considerare d’essere un peccatore” 36 .<br />
La realtà dogmatica di Cristo, il suo atto redentivo, in quanto tale,<br />
è inimitabile: Egli è semplicemente la stessa redenzione 37 , la stessa<br />
vittima personificata. Ecco che è necessaria allora la fede per vedere<br />
ciò nella sua persona storica, e ciò mi porterà a rapportarmi a Lui<br />
come “peccatore”, come “indigenza” di redenzione, e per questo<br />
ad inserirmi necessariamente in Cristo, che è “redenzione dei nostri<br />
peccati”. Da ciò mi pare che anche in Kierkegaard si debba arrivare<br />
ad una concezione del “corpo mistico”, che il danese preferisce<br />
chiamare la “conteporaneità” con Cristo.<br />
Un più puntuale ed approfondito esame della redenzione secondo<br />
il pensiero di Kierkegaard ci porterebbe a considerare dei punti<br />
nevralgici di tutto il suo schieramento filosofico-teologico antihegeliano<br />
e la consistenza stessa di tutto il suo cristianesimo: a considerare<br />
cioè, per esempio, il rapporto esistente tra le nozioni di “trascendenza”<br />
= “esteriorità”, e di “immanenza” = “interiorità”; e<br />
come Kierkegaard possa concepire e conciliare la sua “interiorità”<br />
di fede con la “trascendenza”, che non è “esteriorità” della redenzione<br />
38 . Ma queste analisi esulano dall’intento di queste note e non<br />
trovano la propria sede in queste pagine 39 .<br />
36 IDEM, Ibid., 1849, X1 A 132, tr. it., vol. II, p. 132.<br />
37 IDEM, Ibid., 185o, X2 A 253, tr. it., vol. II, p. 256 s.<br />
38 Il Fabro giustamente lamenta che il valore metafisico e teologico della<br />
Redenzione - “senza dubbio il più importante dal punto di vista polemico come<br />
da quello dottrinale nel pensiero di Kierkegaard - sia raramente appena accennato<br />
e quasi sempre taciuto o ignorato”. Cf. C. FABRO, Storia della filosofia,<br />
Roma 1954, p. 784.<br />
39 Per questi punti accennati, rimando alle più ampie esposizioni già citate,<br />
come per es. P. MESNARD, Le vrai visage de Kierkegaard, cit., p. 341 ss.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
La <strong>Passio</strong>ne di Cristo<br />
in Kierkegaard<br />
41-68<br />
teologia<br />
51
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
MARIO CEMPANARI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
teologia<br />
52<br />
Non ritengo però fuori luogo far notare, di sfuggita, il raffronto<br />
che spesso Kierkegaard fa tra Cristo e Socrate e che culmina appunto<br />
nell’atto redentivo del Cristo. Per Kierkegaard, Socrate rappresenta<br />
il vertice e la figura più espressiva dell’etica greca e semplicemente<br />
umana: egli è il padre dell’interiorità e dell’uomo interiore; il<br />
suo valore si esaurisce però nell’affermazione radicale dell’assoluta<br />
negatività della ragione; la morte di Socrate rivela soltanto che l’anima<br />
ha assunto finalmente il significato di personalità etica. Socrate,<br />
in fondo, è tutto qui.<br />
Ma Cristo è qualche cosa di infinitamente superiore e non soltanto<br />
per quel tanto, e nella linea, di interiorità e di eticità che Socrate<br />
aveva già detto; né solo nella linea di formulazione teoretica del<br />
“regno dei cieli” e della “purità di cuore”, per cui lo stesso Hegel<br />
poté asserire che tra i due v’è “una distanza infinita di profondità”<br />
40 . Cristo ha portato al mondo la redenzione dal peccato, di cui<br />
Socrate neppure aveva l’idea, e questa redenzione si è compiuta con<br />
un atto sublime di amore, con un’opera di amore divino: opera che<br />
solo Dio poteva concepire, non l’uomo:<br />
“Socrate non aveva il vero ideale, non aveva l’idea del peccato,<br />
neppure sapeva che per la salvezza dell’uomo si esigeva un Dio<br />
Crocifisso. La parola d’ordine della sua vita perciò non poteva mai<br />
essere: “Il mondo è per me crocifisso, ed io al mondo” (Gal 6, 14).<br />
Egli mantenne perciò l’ironia, la quale esprime solo la sua superiorità<br />
sopra la nequizia del mondo. Ma per un cristiano l’ironia è<br />
troppo poco; essa non può mai corrispondere all’orrore che per salvare<br />
l’uomo si è voluto un Dio Crocifisso, anche se l’ironia sia un<br />
po’ permessa nella cristianità come risveglio” 41 .<br />
Davanti al mistero della redenzione e della <strong>Passio</strong>ne la mente<br />
umana si sente impotente non solo a comprenderle ma pure ad<br />
immaginarle, e tuttavia Cristo è talmente Dio che riesce a rendere<br />
“il divino del tutto commensurabile con l’uomo comune”, Egli “non<br />
si mette fuori, come oggetto di un pigro e sterile contemplare”, ma<br />
è “l’ideale e lo stimolo eternamente sferzante per spingere gli uomi-<br />
40 Cf. HEGEL, Geschichte der Philosophe, ed. Hoffmeister, I, p. 174.: “Das<br />
Himmelreich und die Reinigkeit des Herzens enthaelt doch eine unendldich<br />
groessere Tiefe als die Innerlicheit des Sokrates”.<br />
41 KIERKEGAARD, Diario 1850, X3 A 254, tr. it., vol. II, p. 413; Briciole di<br />
filosofia, tr. fr., cit., p. 45-66.
ni fuori, allo sbaraglio” 42 , cioè al vivere davvero da cristiani.<br />
Kierkegaard, in un testo già riportato, ha un magnifico raffronto tra<br />
la Provvidenza e la Redenzione: “La Provvidenza, egli dice, non è<br />
più comprensibile della Redenzione, ambedue si possono soltanto<br />
credere”... poi dal raffronto trae una chiara definizione: “La<br />
Redenzione è la Provvidenza continuata” 43 . Ciò significa che per<br />
ogni singolo, in ogni singola circostanza della vita umana, è sempre<br />
la Redenzione che viene a salvare dalla disperazione, cioè dal peccato<br />
e da tutte le sue forme.<br />
Cristo si presenta così, davanti all’uomo peccatore, non come il<br />
Maestro davanti allo scolaro, che qualche volta e in certo qual senso<br />
può fare da maestro, ma solo e semplicemente come il “Salvatore”<br />
e il “Redentore”, nella sua personale irreversibile posizione di unica<br />
salvezza e liberazione dalle catene del peccato e dello stesso egoismo<br />
umano 44 .<br />
Le componenti<br />
nella storia della <strong>Passio</strong>ne<br />
Per Kierkegaard<br />
nella storia della<br />
<strong>Passio</strong>ne concorrono<br />
due componenti<br />
principali e determinan-<br />
ti: il mistero dell’Incarnazione, mistero dell’Uomo-Dio che accetta la<br />
volontà del Padre in un sublime atto di amore; e il mistero dell’iniquità<br />
umana, del peccato, che tenta di schiacciare il Figlio di Dio:<br />
“Si può dire che essa (la storia della <strong>Passio</strong>ne di Cristo) è la<br />
cosa più commovente (quando la si considera in Cristo) e la cosa<br />
più rivoltante (da parte dell’ambiente) che sia mai successa e si<br />
possa immaginare” 45 .<br />
Ma dal punto di vista religioso, la <strong>Passio</strong>ne ci mostra ancora una<br />
duplice componente interna, cioè che “la più grande impotenza è la<br />
massima potenza” ed è proprio di Dio il mostrarsi sovranamente<br />
potente, onnipotente, proprio nelle cose che sembrano le più impotenti<br />
e disprezzabili: questo poi, in fondo, è lo stesso cristianesimo,<br />
che è capace di esaltare gli umili ed abbassare i grandi.<br />
42 IDEM, Diario 1848, IV A 101, vol. II, p. 22<br />
43 IDEM, Ibid. 1846, VII A 130, tr. it., vol. p. 266.<br />
44 IDEM, Briciole di filosofia, cit. p. 56-59.<br />
45 IDEM, Diario 1851, X4 A 208, tr. it., vol. II, p. 512.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
La <strong>Passio</strong>ne di Cristo<br />
in Kierkegaard<br />
41-68<br />
teologia<br />
53
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
MARIO CEMPANARI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
teologia<br />
54<br />
...“Cristo non tiene in mano uno scettro, ma soltanto una canna,<br />
il segno dell’impotenza. Comandare a tutto il mondo con uno<br />
scettro è, quanto a potenza, un nulla in confronto del comandare<br />
ad esso con una canna, cioè con la propria impotenza, cioè religiosamente”<br />
46 .<br />
Da questi fattori si può facilmente rilevare che la morte di Cristo<br />
non fu una cosa fortuita o semplicemente l’episodio storico di un<br />
solo popolo fanatico e capriccioso. No, essa rappresenta “il peso<br />
specifico” che pone per sempre ogni uomo di fronte al suo Dio, al<br />
suo peccato, al suo destino eterno.<br />
“Raramente si cerca di capire con esattezza perché Cristo (la cui<br />
vita in un certo senso non poteva venire in conflitto con alcuno (Egli<br />
non aveva alcuno scopo terreno) finì con l’essere crocifisso (...).La<br />
morte di Cristo è il prodotto di due fattori: la colpa dei Giudei e la<br />
cattiveria del mondo. Poiché Cristo era l’Uomo-Dio, il fatto che<br />
Egli è stato crocifisso non significa che i Giudei per caso quella<br />
volta erano corrotti, o che Egli venne al mondo, per così dire, in un<br />
momento sfortunato. No, la sorte di Cristo è un qualcosa di eterno<br />
e indica il peso specifico dell’umanità: così succederà a Cristo<br />
in ogni tempo. Cristo non può mai esprimere qualcosa di accidentale”<br />
47 .<br />
Il processo storico della redenzione e della passione non si limita<br />
però al solo fatto personale e storico di Cristo: si può dire che esso<br />
si verifica sempre come un perenne processo nella storia della lotta<br />
fra il bene e il male, fra il giusto e il peccatore, nella sostituzione del<br />
male al bene e del bene che soffre come se fosse il male stesso 48 .<br />
Così è stato di Gesù, che essendo il bene e il giusto, soffrì come<br />
se Egli fosse tutto il male e il solo ingiusto; così dovrà essere per<br />
ogni suo vero discepolo, per ogni cristiano, che deve volere il “martirio”<br />
di tutto il suo essere, fisico e morale 49 . Solo così l’uomo, attraverso<br />
la <strong>Passio</strong>ne di Cristo e nella <strong>Passio</strong>ne di Cristo, viene elevato<br />
all’affinità con Dio: è liberato da ogni animalità e reso veramente<br />
spirito 50 .<br />
46 IDEM Ibid., 1851, X4 A 209, tr. it., vol. II, p. 513.<br />
47 IDEM, Ibid., 1847, VIII A 145, tr. it., vol. I, p. 346.<br />
48 IDEM, Ibid., 1848, IX A 141, tr. it., vol. II, p. 28.<br />
49 IDEM, Ibid., X4 A 10; XII A 193.<br />
50 IDEM, Ibid., 1854, XII A 236, tr. it., vol. III, p. 159.
La passione, oggetto di fede,<br />
è dono di grazia<br />
Come l’incarnazione<br />
e la<br />
redenzione, lo<br />
abbiamo già rilevato 51 ,<br />
così anche la <strong>Passio</strong>ne<br />
di Cristo non è qualcosa di puramente umano e storico: essa è oggetto<br />
di fede, in quanto anche in essa si verifica l’unione del divino e<br />
dell’umano che può e deve essere creduta: la <strong>Passio</strong>ne di Cristo<br />
naturalmente non può essere compresa, perché l’unione del divino e<br />
dell’umano in Lui deve “essere creduta”: è oggetto solo di fede. C’è<br />
da riflettere ancora sulla sconcertante “possibilità” che aveva<br />
Cristo, come Dio, di poter liberarsi dalla sofferenza della <strong>Passio</strong>ne<br />
mentre tuttavia Egli “volle” sopportarla: questo ci mette davanti<br />
all’impossibilità di capire tutto il mistero colla ragione, poiché solo<br />
con la fede vediamo Dio nella umiliazione.<br />
In quanto oggetto, e per merito della fede, la passione di Cristo è<br />
divinamente “dono” e “grazia” per la salvezza del mondo. La<br />
<strong>Passio</strong>ne di Cristo è “dono e grazia”, perché mentre Cristo nella sua<br />
vita è il “modello”, è il “contemporaneo” con cui dobbiamo convivere<br />
ed a cui dobbiamo rassomigliare, nella sua passione e morte.<br />
Egli è solo il redentore, il salvatore, colui che si dà, che dà tutto: che<br />
è, in una parola il “dono”, la “grazia” totale di sé nel perdono e nell’amore.<br />
Qui sta tutta la forza di Cristo che ci spinge, ci attira a<br />
“divenire cristiani”: nella duplice tensione di “modello-grazia”,<br />
insita nella “vita-<strong>Passio</strong>ne” di Cristo. Ma la <strong>Passio</strong>ne e morte di<br />
Cristo sono ancora un “dono”, una “grazia” per gli uomini, in<br />
quanto Cristo vuole che il suo atto redentivo non sia di rimprovero<br />
e di colpa per quelli stessi che lo uccidono, secondo la sua stessa<br />
parola: “Non sanno quello che fanno”: tutto deve essere “grazia”,<br />
“dono” totale:<br />
“Come mai avvenne che Cristo poté essere crocifisso ?...Ebbe<br />
Egli colpa se fu condannato a morte ?...In generale si parla soltanto<br />
della purezza e dell’innocenza di Cristo; ma qui vi è un altro problema<br />
che di solito si trascura, perché si può predicare il bene e il<br />
vero, in modo da sforzare gli uomini a perseguitarvi. Prima un<br />
uomo lotta con la persuasione che il mondo sia il più forte; ma<br />
quando ha sentito bene la sua forza, allora sente compassione degli<br />
51 Vedi nel numero precedente della rivista SapCr, pp....<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
La <strong>Passio</strong>ne di Cristo<br />
in Kierkegaard<br />
41-68<br />
teologia<br />
55
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
MARIO CEMPANARI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
teologia<br />
56<br />
uomini che gli fanno torto. Allora deve pensare (non per sé, ma per<br />
loro) se egli tuttavia non alza troppo il prezzo. Si può avere una tale<br />
conoscenza del mondo e degli uomini, che proprio facendo il bene e<br />
il vero si può predire con precisione: io sarò perseguitato. Non è<br />
questa una crudeltà verso gli uomini? A questo modo si potrebbe<br />
quasi addossare alla loro coscienza un omicidio. Non sarebbe una<br />
durezza eccessiva da parte sua verso gli uomini?...<br />
Cristo quindi deve aver avuto in ogni momento la volontà di evitare<br />
la persecuzione (non per Sé, perché era pronto ed era venuto<br />
“per” soffrire), ma per causa degli uomini, onde non fosse Lui a dar<br />
loro occasione di rendersi “colpevoli”... Adesso si spiega la Sua<br />
condotta e verso i potenti (la cricca) e verso gli umili. Con quanta<br />
imprudenza Egli deve aver vissuto! Vi è mai un uomo a cui sia permesso<br />
di sostenere la verità a tal punto da poter prevedere che la<br />
sua uccisone sarà il crimine dei contemporanei? Perché Cristo era<br />
la Verità, perciò non poteva altrimenti; e inoltre la Sua morte porta<br />
la riparazione, poiché è morte redentrice” 52 .<br />
La passione<br />
morale di Cristo<br />
Dove Kierkegaard<br />
più volentieri<br />
si attarda<br />
nelle sue considerazioni<br />
sui dolori del<br />
Cristo, è sulla Sua angosciosa <strong>Passio</strong>ne interiore: quella dell’anima<br />
divina di Cristo, della Sua volontà d’immolazione. Quale mistero<br />
insondabile l’anima di Cristo durante la Sua <strong>Passio</strong>ne! Chi potrà<br />
mai svelare i profondi abissi di dolori, di umiliazioni, di spirituali e<br />
sovrumane ambasce? Chi ne comprenderà e penetrerà mai gli infiniti<br />
recessi di tristezza e di pianto? E Kierkegaard era sempre attento<br />
nelle parole di Cristo a questa <strong>Passio</strong>ne interiore ed alle esplosioni<br />
che volta a volta si sprigionano dalle labbra di Cristo.<br />
“La morte, Cristo l’aveva sempre davanti agli occhi; era venuto<br />
al mondo solo per morire e tutto gli parla sempre di essa. Egli lo sa<br />
e comprende ogni segno esteriore contrariamente alla sua apparenza:<br />
nel piano della sua vita anche l’ingresso in Gerusalemme non fa<br />
che precipitare la catastrofe...; gli altri, vedendo il suo ingresso<br />
52 KIERKEGAARD, Diario 1847, VIII A 271, tr. it., vol.I, p. 364.
trionfale, pensavano: “Ecco il trionfo!” e Lui invece sapeva:“Ecco<br />
la mia fine!”. Questo isolamento appartiene essenzialmente alla<br />
sofferenza di Cristo, come sofferenza dell’anima: questa solitaria<br />
consapevolezza di comprendere tutti i segni contrariamente all’apparenza!<br />
Egli ne parla e lo ribadisce ai discepoli: non serve a<br />
nulla... Soltanto Cristo sente nel giubilo l’inizio della fine” 53 .<br />
La <strong>Passio</strong>ne di Cristo si fa trasparente e culminante nei due<br />
momenti dell’agonia dell’Orto e dell’agonia della croce, quando<br />
esplode in quelle ineffabili angosciate parole: “L’anima mia è triste<br />
fino alla morte!” (Mt 26, 38) e nell’altro grido misterioso e di smisurato<br />
dolore: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”<br />
(Mt 27, 46). In questi due momenti della <strong>Passio</strong>ne morale ed interiore<br />
di Cristo, Kierkegaard persiste ed insiste nelle sue profonde considerazioni<br />
54 . Di questa misteriosa <strong>Passio</strong>ne morale, che è il segreto<br />
della sofferenza di Cristo, Kierkegaard vede i precedenti e le nascoste<br />
fonti nella impossibilità per Cristo di mostrarsi pienamente,<br />
direttamente ed immediatamente agli uomini per quello che Egli è,<br />
il Dio d’Amore:<br />
Dio, il Trascendente, l’Incomprensibile, l’Infinito. In una parola,<br />
ritorna qui, anche nelle sofferenze interiori di Cristo, il sublime nodo<br />
del mistero dell’Incarnazione: il Dio che assume la carne umana e la<br />
agita col suo amore infinito, la Luce che viene ad illuminare la tenebra<br />
e questa non la può contenere né comprendere.<br />
“Specialmente nelle epoche precedenti si è parlato molto e spesso<br />
delle sofferenze di Cristo, degli oltraggi da Lui subiti, della Sua<br />
flagellazione, della Sua crocifissione. Abbandonandosi a queste<br />
considerazioni sembra che si dimentichi un genere tutto diverso di<br />
sofferenze, il tormento interiore, la passione dell’anima, cioè quel<br />
che dovremmo chiamare il segreto delle sofferenze, inseparabile<br />
dalla vita dell’incognito, dal momento che Egli apparve tale sino<br />
alla fine. E’ sempre doloroso essere obbligati a celare la propria<br />
intima natura e ad apparire diversi da quel che si è, anche nella<br />
semplice vita umana. E’ la più gravosa delle nostre sofferenze e chi<br />
la subisce, ahimé! soffre spesso in un sol giorno molto più di tutti i<br />
tormenti fisici riuniti... Il conflitto consiste nell’essere obbligati a<br />
53 IDEM, Ibid., 1849, X2 A 257, tr. it., vol. II, p. 288.<br />
54 IDEM, Ibid., III A 228, VIII A 304; X3 A 76; IX A 11; X3 A 765...;<br />
VIII A 580; IX A103; XII A 115, 202, 285, 374, ; X12 A 434.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
La <strong>Passio</strong>ne di Cristo<br />
in Kierkegaard<br />
41-68<br />
teologia<br />
57
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
MARIO CEMPANARI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
teologia<br />
58<br />
nascondere il proprio intimo mostrandosi diversi da quel che si è,<br />
per amore verso un altro.<br />
I tormenti sono di ordine esclusivamente spirituale, e quanto mai<br />
complessi... Prima sofferenza è il proprio dolore; perché se è dolce<br />
appartenere a un altro essere in un’amicizia o in un amore corrisposto,<br />
è doloroso essere obbligati a tenere per sé questo intimo sentimento.<br />
Seconda sofferenza è quella patita per conto altrui; perché<br />
la sollecitudine dell’amore, il desiderio di fare tutto per l’essere<br />
amato, di sacrificare per esso la propria vita, tutto si esprime in una<br />
sofferenza che assomiglia terribilmente alla più viva crudeltà,<br />
ahimé, eppure è amore. Ultima sofferenza è il tormento della<br />
responsabilità. In breve: si tratta, per amore, di annientare nel<br />
senso immediato il proprio amore pur conservandolo; per amore,<br />
essere crudele verso l’oggetto amato; per amore addossarsi questa<br />
immensa responsabilità.<br />
E allora, l’Uomo-Dio! Il Dio vero non può farsi conoscere direttamente,<br />
ma la conoscibilità diretta è quanto i semplici uomini, per<br />
i quali veniva, chiedevano supplici come indicibile conforto . Ed<br />
Egli diventa uomo per amore! Egli è amore; eppure, ad ogni istante<br />
della vita deve per così dire crocifiggere ogni compassione e sollecitudine<br />
umana, poiché può soltanto divenire oggetto di fede...<br />
Eppure Egli agisce per amore, per salvarci. Nello sgomento di questa<br />
decisione (della fede), Egli deve tener gli uomini lontani da sé,<br />
affinché questi, salvati dalla fede, gli appartengano, ed Egli è<br />
l’amore.<br />
Per amore, Egli vuol fare tutto per gli uomini, anche sacrificare<br />
la sua vita per loro; Egli subisce per loro una morte ignominiosa,<br />
soffre per amor loro quella vita in cui è obbligato a mostrarsi, a<br />
nostro giudizio, così duro nella sua compassione, nella sua misericordia<br />
e nel suo amore divini al confronto dei quali tutta la compassione<br />
umana è nulla. Tutta la sua vita è sofferenza interiore. E quando<br />
l’ultima parte di questa vita incomincia col tradimento nella<br />
notte, Egli prova i dolori fisici e i maltrattamenti; soffre di essere<br />
tradito da un amico; d’essere solo, schernito, insultato, coperto di<br />
sputi, coronato di spine, vestito di porpora, solo con la sua causa<br />
perduta agli occhi degli uomini (“Ecco l’uomo!”). Solo fra i suoi<br />
nemici furiosi (crudele compagnia), abbandonato da tutti gli amici<br />
(tremenda solitudine). Un uomo può tuttavia soffrire così, subire gli<br />
stessi maltrattamenti, l’abbandono del suo migliore amico, ma<br />
senza andare più lontano; per l’uomo, superato quest’ultimo passo,
il calice della sofferenza è vuotato. Ma qui il calice si riempie di<br />
nuovo della più amara bevanda: Cristo soffre affinché la sua sofferenza<br />
possa divenire e divenga occasione di scandalo per i pochi<br />
credenti. Senza dubbio Egli soffre una volta sola; ma non se la cava,<br />
come un uomo qualsiasi, con la prima fase del dolore, Egli prova<br />
invece la pena più grave nella seconda fase, nell’ansia piena di<br />
tristezza, per cui la sua sofferenza è un’occasione di scandalo.<br />
Nessuno può concepire questa sofferenza, ed è temerario pretenderlo”<br />
55 .<br />
Ma più determinatamente la <strong>Passio</strong>ne interiore di Cristo deriva<br />
tutto il suo essere e valore dalla libera scelta che Cristo fece dei suoi<br />
propri dolori: ci fu quindi prima di tutto e soprattutto sofferenza<br />
inaudita nella scelta libera, cosciente, eletta! Di qui l’essenza dei<br />
“dolori mentali” o “sofferenze dell’anima” di Cristo: “Cristo sapeva<br />
fin da principio che doveva patire e morire. Sta in questo la sofferenza<br />
più dura, diversamente da quando simili sofferenze toccano<br />
mentre tuttavia fra poco si spera di evitarle e di lì a poco si freme di<br />
orrore. Questo significa che la sofferenza di Cristo consisteva nella<br />
scelta 56 . La morte (di Cristo) è una morte di redenzione, un sacrificio<br />
che Egli vuol portare 57 .<br />
La <strong>Passio</strong>ne è sofferenza volontaria anche in altro senso che valica<br />
ogni dire umano perché Cristo “prega per i propri nemici..., invece<br />
di pregarli a usare grazia”: Egli prega per loro perché non Lo<br />
risparmino:<br />
“Pertanto la preghiera di Cristo per i suoi nemici fa parte del<br />
Suo sacrificio in ben altro senso: Egli cioè fin da principio ha avuto<br />
i suoi nemici in Suo potere: essi credono di disporre di se stessi,<br />
mentre sono a servizio della Sua volontà. Perciò Egli prega per<br />
essi” 58 .<br />
Giustamente, allora, dice Kierkegaard che “la passione di Cristo<br />
è propriamente sofferenza di anima” 59 e “Cristo non ha parlato a noi<br />
soltanto con la Sua vita, ma ha anche parlato per noi con la Sua<br />
55 IDEM, Scuola di cristianesimo, tr. it., cit., pp. 160-162.<br />
56 IDEM, Diario 1847, VIII A 344, tr. it.,vol. I, p. 373.<br />
57 IDEM, Ibid., VIII A 271, tr.it., vol.I, p. 364.<br />
58 IDEM, Ibid. 1848, IX A 336, tr. it., vol. p. 66.<br />
59 IDEM, Ibid. 1847, VIII A 275, tr. it., vol. I, p. 365; X2 A 257.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
La <strong>Passio</strong>ne di Cristo<br />
in Kierkegaard<br />
41-68<br />
teologia<br />
59
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
MARIO CEMPANARI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
teologia<br />
60<br />
morte” 60 . Egli, nella trasparenza dell’esistenza più vera, che esige di<br />
essere ciò che si insegna, ha mostrato nella Sua acerba passione “di<br />
essere letteralmente un nulla” 61 .<br />
Tuttavia, fra tanta infinita umiliazione e annichilimento interiore<br />
ed esteriore, Cristo in croce rivela anche la sua eccelsa grandezza,<br />
quando, abbandonato persino dal Padre, promette con tono solenne<br />
di autorità al ladrone supplicante l’ingresso immediato in paradiso 62 ,<br />
e quando, alla Sua morte, si oscura il sole, si aprono i sepolcri e si<br />
squarcia il velo del tempio 63 . In Cristo crocifisso e nella Sua passione<br />
si incontra allora l’idealità: Cristo è l’idealità cristiana che coincide<br />
con la storia. E questa “pura idealità” cristiana “spezza tutta<br />
l’esistenza”, in quanto essa trova la sua consistenza cristiana dove<br />
non vige alcuna consistenza terrena: dove è la morte essa trova la<br />
vita.<br />
Questo ci dà motivo di passare a vedere l’ascesi cristiana di fronte<br />
alla passione di Cristo, come l’ha concepita Kierkegaard.<br />
Ascesi cristiana<br />
e passione di Cristo<br />
Riassumo brevemente<br />
alcuni<br />
punti principali<br />
e riporto qualcuno dei<br />
numerosi e densi pas-<br />
saggi di Kierkegaard sull’argomento. Troppo lungo sarebbe esaminare<br />
dettagliatamente il pensiero ed i testi del danese su questo particolare<br />
settore dell’ascesi cristiana 64 . Kierkegaard, il filosofo della<br />
verità esistenziale compresa come soggettività e interiorizzazione a<br />
cui ci si rapporta solo con la sofferenza 65 , il teologo del cristianesi-<br />
60 IDEM, Ibid. 1850, X3 A 354, tr. it., vol.II, p. 426.<br />
61 IDEM, Ibid. 1852, X3 A 542, tr: it., vol II, p. 446.<br />
62 IDEM, Ibid., X5 A 130-131.<br />
63 IDEM, Ibid. 1851, X4 A 208, tr. it., vol. II, p. 512.<br />
64 Per una trattazione più particolare, specialmente del valore ascetico della<br />
sofferenza in Kierkegaard, cf. S. HANSEN, Die Bedeutung des Leidens fur das<br />
Christusbild Soeren Kierkegaards, in “Kerigma und Dogma”, Jhg. “, Heft 1<br />
(Januar 1956), pp. 1-28; W. LINDSTROM, La Théologie de l’Imitation de Jesus-<br />
Christ chez Soeren Kierkegaard,in Revue d’Histoire et de Philos.”, A. 35<br />
(1955), n. 4, Paris, pp. 379 ss.<br />
65 KIERKEGAARD, Diario, X1 A 345; X11 A 359.
mo “in movimento”, concepito come religione della lotta e della<br />
remissione del peccato, della verità che soffre e del Cristo modelloredentore<br />
66 , non poteva considerare la <strong>Passio</strong>ne con un distacco<br />
“oggettivo” indifferente e disinteressato; ma la sofferenza di Cristo<br />
doveva necessariamente essere “il peso specifico” della sofferenza<br />
umana, la norma di tutta la vita morale dell’uomo, il modello e la<br />
vita di cui costantemente alimentarsi.<br />
L’ascesi cristiana in Kierkegaard, perciò, è una necessaria conclusione<br />
della sua originaria posizione di fronte al mistero di Cristo<br />
redentore.<br />
Due principi, che neutralizzano ogni accusa di patente o larvato<br />
fideismo protestante fatta a Kierkegaard, sono alla base di questa<br />
ascetica: quello cioè che “il principio degli atti è più semplice del<br />
principio della fede” 67 , e l’altro principio che “senza ascetica il cristianesimo<br />
è impossibile” 68 , e l’ascetica deve “inculcare il bisogno<br />
della grazia”. Più specificatamente ascetiche sono le altre due<br />
“massime del cristianesimo”, che riguardano la sofferenza e le<br />
prove cui Dio ci sottopone:<br />
“a. Perché sei sofferente, per questo Dio ti ama…<br />
b. Perché Dio ti ama, per questo ti tocca soffrire”.<br />
E Kierkegaard suffraga questo secondo principio (b) con la ragione<br />
che “Dio è spirito; Egli non può esprimere il Suo amore in altro<br />
modo - se tu non vuoi soffrire, è segno che vuoi essere dispensato<br />
dall’amore di Dio”, ed anche con l’altra ragione, contro il peccato,<br />
che: “C’è un Redentore - non è questo di consolazione abbastanza?<br />
non dà Egli soddisfazione per il tuo peccato? Certo, se proprio Lui,<br />
il Redentore, non esigesse l’imitazione” 69 .<br />
Tuttavia, sensatamente, Kierkegaard modera questa alta mira<br />
ascetica del saper soffrire, tenendo conto dell’umana debolezza, perciò<br />
stabilisce:<br />
“1. Non si deve mai domandare la sofferenza, usando prudenza<br />
in questo campo.<br />
66 IDEM, Ibid., IX A 101; X4 A 579; IX A 414; IX A 16, 20... X5 A 45...<br />
67 IDEM, Ibid. 1853, X12 A 301, tr. it., vol. III, p. 368.<br />
68 IDEM, Ibid. 1853, X5 A 89, 99...<br />
69 IDEM, Ibid. 1852, X4 A 593, tr. it., vol. II, p. 590.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
La <strong>Passio</strong>ne di Cristo<br />
in Kierkegaard<br />
41-68<br />
teologia<br />
61
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
MARIO CEMPANARI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
teologia<br />
62<br />
2. La sofferenza non è da sfuggire, ma neppure fare della sofferenza<br />
il supremo ed unico fine (telos), ma soffrire per la causa cristiana,<br />
per Cristo” 70 .<br />
La stessa esistenza cristiana è necessariamente sofferenza, è<br />
“crocifissione” 71 ; non si deve però soffrire costretti dalla necessità,<br />
non è questa la vera sofferenza cristiana. Anche in questa sofferenza<br />
allora si deve prendere per “modello” Cristo, del quale “tutta la<br />
vita è sofferenza volontaria” 72 . Ecco quindi la necessità di rivestirsi<br />
di Cristo “modello-redentore” e trasformare ogni sacrificio, ogni<br />
dolore in sacrificio e dolore volontari 73 .<br />
...”Rivestirsi di Cristo è allora in parte per rispetto alla redenzione,<br />
appropriarsi il suo merito (...); ; in parte nel cercare di rassomigliare<br />
(a Cristo) perché Egli è il Modello e l’esempio. Questa è<br />
una espressione sostanziale dell’interiorizzazione. Come l’espressione<br />
che Egli usa per la sua dottrina, che essa è cibo (Gv 6, 35), è<br />
la più forte per indicare l’appropriazione; così rivestirsi di Cristo è<br />
l’espressione più forte per indicare la rassomiglianza, che deve<br />
essere secondo la più grande misura possibile. Non si dice di Cristo:<br />
Tu devi aspirare a rassomigliarGli (se si dice così, si ammette indirettamente<br />
che i due sono sostanzialmente dissimili); no, tu devi<br />
rivestirti di Lui - come quando uno va in abiti imprestati (questa è<br />
la satisfactio vicaria); rivestirsi di Lui - come quando uno completamente<br />
travestito assomiglia a un altro, non solo aspira a imitarlo,<br />
ma lo rappresenta. Cristo dà a te la sua veste (satisfactio), ed esige<br />
ora che tu rappresenti Lui” 74 .<br />
Quale più diretto rapporto c’è tra Cristo e la sofferenza umana?<br />
“Cristo è l’impeto esistenziale dell’eterno che venne per soffrire e<br />
morire” 75 ; in base a ciò Egli “è venuto al mondo per trasformare<br />
l’uomo” e il suo dolore, “insegnandogli il timore del peccato e la<br />
speranza di una futura felicità”, che fa stimare fanciullaggini tutti i<br />
dolori di questa misera terra 76 .<br />
70 IDEM, Ibid. 1852, X4 A 630, tr. it., vol. II, p. 598.<br />
71 IDEM, Ibid. 1849, X1 A 301, tr.it., vol. II, p. 301.<br />
72 IDEM, Ibid. 185o, X3 A 43, tr. it., vol. II, p. 382; X5 A 45; X11 A 23;<br />
X11 A 327.<br />
73 IDEM, Ibid., X1 A 645; X3 A 43; VIII A 344...<br />
74 IDEM, Ibid. 1849, X2 A 255, tr. it., vol. II, p. 287.<br />
75 IDEM, Ibid. 1851, X4 A 147, tr. it., vol. II, p. 500.<br />
76 IDEM, Ibid. 1848, IX A 147, tr. it., vol. II, p. 30.
Essendo Cristo “tangente del divino e dell’umano”, la sua sofferenza<br />
si inserisce nella nostra, o meglio la nostra nella Sua divina<br />
sofferenza, che poi si espleta in una graduatoria: sofferenza di apostoli,<br />
di martiri, di santi... 77 . Ciò che più urge però, secondo<br />
Kierkegaard, nel campo ascetico è l’“imitazione di Cristo”: essa<br />
costituisce la vera “contemporaneità” con Cristo, in quanto:<br />
a) è confronto fra la mia vita e quella del Cristo-modello 78 ;<br />
b) è necessità di ricorrere a Cristo-grazia per avere aiuto e misericordia<br />
79 .<br />
Più praticamente ed immediatamente questa “imitazione” e questa<br />
“contemporaneità” consistono nel vedere Cristo nei malati, nei<br />
poveri, nelle vittime dell’ingiustizia, nei sofferenti d’ogni genere 80 .<br />
Ed eccoci al vertice dell’ascetica cristiana: solo mediante la sofferenza<br />
l’uomo raggiunge l’affinità con Dio, diventa cioè “spirito”, che<br />
significa vero autentico cristiano 81 . Cos’è dunque amare davvero<br />
Cristo ? Che senso ha il tendere a Lui come a scopo supremo di tutta<br />
la nostra ascesa spirituale? “Cos’è amare ? E’ voler somigliare<br />
all’amato, ovvero uscire dalle proprie cose per entrare in quelle dell’amato<br />
(...). Cristo soffrì e morì per me. Allora, contento che Egli mi<br />
ha riscattato dai miei peccati e guadagnato la vita eterna, io posso<br />
ben godermi la vita, e nello stesso tempo non mi stancherò di ringraziare<br />
Lui! Piano, piano! Ti sembra questo un amare Cristo? No, al<br />
contrario è il più tremendo egoismo. Forse che non so in che modo<br />
Cristo vuole che io esprima la mia gratitudine, cioè con l’imitazione?<br />
Dunque se l’amo, glielo devo esprimere nella Sua lingua e non<br />
scodellarGli delle chiacchiere nella mia propria lingua, pretendendo<br />
che questo significhi il mio grande amore per Lui” 82 .<br />
...“La vita dei veri amanti di Dio esprime che essi dovettero soffrire,<br />
che furon pronti a soffrire, perché capivano ch’era questa la<br />
volontà di Dio. Egli ce l’ha fatto dire, con voce abbastanza solenne<br />
(quella di Cristo); noi dunque lo sappiamo, ma c’induriamo e ci<br />
conformiamo in compagnia degli altri uomini” 83 .<br />
77 IDEM, Ibid., XI A 49, tr. it., vol. II, p. 116; X4 A 108...<br />
78 IDEM, Ibid. 1848, IX A 314.<br />
79 IDEM, Ibid., IX A 153; X1 A 132.<br />
80 IDEM, Ibid. 1850, X2 A 247.<br />
81 IDEM, Ibid. 1851, X4 A 471.<br />
82 IDEM, Ibid. 1852, X4 A 589, tr. it., vol. II, p. 589.<br />
83 IDEM, Ibid. 1852, X5 A 50, tr. it., vol III, p. 19.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
La <strong>Passio</strong>ne di Cristo<br />
in Kierkegaard<br />
41-68<br />
teologia<br />
63
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
MARIO CEMPANARI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
teologia<br />
64<br />
Leggiamo un ultimo significativo passaggio che riassume tutta la<br />
posizione di Kierkegaard di fronte alla <strong>Passio</strong>ne di Cristo sin qui<br />
esposta:<br />
“Cristo è la via: lo ha detto Lui stesso...E questa via è “stretta”:<br />
lo ha detto Lui stesso... E questa via che è Cristo, questa via stretta,<br />
è stretta fin dal suo inizio. Egli nasce in povertà e miseria: quasi si<br />
è tentati di pensare che non sia neppure un uomo chi nasce così.<br />
Nasce in una stalla, è avvolto in pannicelli, deposto in una mangiatoia...<br />
Il tenero bambino è oggetto delle persecuzioni dei potenti...<br />
Egli vive in povertà e abbassamento e non ha dove posare il capo.<br />
Dovrebbe bastare questo, mi sembra, perchè si possa, umanamente<br />
parlando, dire che “la via è stretta”; eppure questo non è che il lato<br />
più facile della “via stretta”. La via è stretta in tutt’altro modo, e fin<br />
da principio. Perché la Sua vita è fin da principio una storia di<br />
tentazioni... la Sua vita (che è anche storia di <strong>Passio</strong>ne) è storia di<br />
tentazione. Egli è tentato in ogni istante della sua vita: cioè Egli ha<br />
in Suo potere questa possibilità che è la libertà di prendere la Sua<br />
missione, il suo compito, invano. Nel deserto è Satana a far da<br />
tentatore, ovvero l’Altro; presto sarà il popolo, presto saranno i<br />
discepoli; forse qualche volta...anche i potenti che hanno cercato<br />
di tentarlo a mondanizzare la sua missione...<br />
La via è stretta fin da principio, perché fin da principio Egli conosce<br />
la sua sorte: che colluvie di sofferenze fin da principio! Cristo<br />
conosceva la Sua sorte fin da principio; la sapeva inevitabile: lo<br />
sapeva, e tuttavia le andò incontro senza battere ciglio. Terribile consapevolezza,<br />
quella di sapere la propria fine fin da principio. Quando<br />
il popolo al principio Lo acclamava, Egli in quel momento sapeva che<br />
era il medesimo popolo che un giorno avrebbe gridato: “Crocifiggilo,<br />
crocifiggilo!”...Si, la via è stretta fin da principio: perché Egli conosce<br />
fin da principio che il suo lavoro lavora contro di Sé. E stretta<br />
sarà certamente la via, anche se ti sarà permesso di usare tutte le<br />
forze per aprirti il passo, per eliminare l’opposizione fuori di te. Ma<br />
quando devi usare le tue forze per combattere te stesso, è ancor poco<br />
il dire che la via è stretta: essa è piuttosto impervia, sbarrata, impossibile,<br />
pazza... Eppure essa è la via di cui nel Vangelo si dice che<br />
“Cristo è la via”: è proprio così che essa è stretta... E questa via che<br />
è Cristo, questa via stretta, diviene nel suo avanzare sempre più stretta<br />
fino alla fine, fino alla morte... Ecco che Egli si è seduto a mensa<br />
con i Suoi discepoli per l’ultima volta, per la Pasqua che tanto ardentemente<br />
aveva bramato di mangiare con loro prima di morire...
Indi si alza da tavaola e s’avvia all’Orto di Getsemani; si sente<br />
venire meno... Oh, magari succedesse presto! Cade affranto in<br />
un’agonia mortale: certo, era Egli più morente in croce che nel<br />
Getsemani? Oh, se la sofferenza della croce era l’agonia della<br />
morte, questa lotta della preghiera era anch’essa l’agonia della vita<br />
e non senza spargimento di sangue perché “Egli sudò come gocce<br />
di sangue che cadevano in terra! Poi si alzò da terra con energia<br />
rinnovata:“Padre celeste, sia fatta la Tua volontà e non la mia!”.<br />
Quindi Giuda lo bacia: hai tu mai sentito qualcosa di simile? E così<br />
Egli è afferrato, accusato, condannato!... Pilato era un uomo colto<br />
e come tale non trascurò la cosa... più importante cioè di “lavarsi<br />
le mani”! Così Gesù fu condannato. Povera giustizia umana!... O<br />
cultura umana, in cosa ti distingui in fondo da ciò che dovresti aborrire<br />
di più, dalla crudeltà e dalla volgarità della folla? Sta il fatto<br />
che ti comporti allo stesso modo, con la sola precauzione di “salvare<br />
la forma”, di non farlo “senza lavarti le mani...”! Povera cultura<br />
umana!<br />
Infine fu confitto alla croce: un sospiro ancora, e la morte.<br />
Ancora un sospiro, il più profondo, il più terrificante: “Mio Dio,<br />
mio Dio, perché mi hai abbandonato?”: Questa umiliazione è il<br />
colmo della sofferenza. Fra coloro che furono Suoi seguaci nel<br />
senso più rigoroso, i martiri, troverai appena qualche debole<br />
accenno di tale tormento... O eccesso di sofferenza sovrumana!<br />
Qualsiasi cuore di uomo si sarebbe spezzato prima: solo l’Uomo-<br />
Dio poté bere il calice della sofferenza fino all’ultima stilla. Così<br />
Egli muore.<br />
Mio ascoltatore: ricorda quel che abbiamo detto al principio:<br />
questa via è stretta. Non lo è forse? Tuttavia proseguiamo: Cristo è<br />
la via... Egli sale sul monte, una nube Lo toglie allo sguardo dei<br />
discepoli... Egli ascende al cielo ed è la via !<br />
Forse dirai: sì, ed era proprio questo l’argomento di cui oggi<br />
dovevi parlarmi e mi hai fatto una predica da Venerdì santo... Oh,<br />
amico mio: sei forse tu di quelli che regolano i propri atteggiamenti<br />
o sentimenti a suon di campana e secondo le indicazioni del calendario?<br />
O non pensi piuttosto d’accordo col cristianesimo, che noi<br />
dobbiamo tener insieme raccolti i diversi aspetti del cristianesimo?<br />
Proprio nel giorno dell’Ascensione si deve allora ricordare che la<br />
via è stretta, altrimenti noi prenderemmo l’Ascensione invano.<br />
Rammenta: la via fu stretta fino alla fine; fino alla morte - che fa da<br />
momento intermedio - poi segue l’Ascensione. Non era mezzanotte<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
La <strong>Passio</strong>ne di Cristo<br />
in Kierkegaard<br />
41-68<br />
teologia<br />
65
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
MARIO CEMPANARI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
teologia<br />
66<br />
quando Egli salì al cielo; ma non fu neppure al termine della “via”,<br />
perché la via terminò sulla croce e nel sepolcro...<br />
Cristo ascende al cielo: nessuno ha mai vinto così! “Una nube<br />
Lo tolse ai loro occhi”: nessun trionfatore è stato sollevato da terra<br />
così. “Essi non lo videro più”. Nessun trionfo ebbe mai un simile<br />
epilogo. “Egli siede alla destra della potenza del Padre!”. Quindi il<br />
trionfo non finisce con l’Ascensione? No, con essa comincia: nessuno<br />
ha mai avuto un simile trionfo. “Egli farà ritorno con le schiere<br />
degli angeli”. Quindi il trionfo non finisce col sedersi alla destra<br />
dell’Onnipotenza del Padre? No, ciò era soltanto la fine del principio.<br />
Eterno vincitore !<br />
Che via segui tu nella tua vita, caro ascoltatore? Ricordati, come<br />
mi ricordo io, che non si uò dire di ogni via angusta che Cristo è<br />
quella via, né che ogni via stretta conduce al cielo. Un uomo pio ha<br />
detto che ci sono altrettante, se non più, difficoltà, per andare all’inferno<br />
che per arrivare in paradiso. Anche la via della perdizione è<br />
dunque stretta; ma Cristo non è questa via che non conduce al cielo.<br />
Vi si trova abbastanza inquietudine,, angoscia e tormento; è in tal<br />
modo veramente stretta questa via della perdizione... Quel che<br />
distingue la via angusta del cristianesimo da una via stretta qualunque<br />
dell’umanità, è il carattere volontario. Cristo non fu un uomo<br />
che desiderò i beni di questo mondo e che dovette accontentarsi<br />
della povertà: no, la scelse. Non fu un uomo che desiderò gli onori,<br />
la fama e che dovette accontentarsi della mediocrità o rassegnarsi<br />
ad essere misconosciuto e calunniato: no, scelse l’avvilimento. Tale<br />
nel suo rigore è la via angusta...<br />
La prova della verità cristiana risiede nell’”imitazione”... Ma<br />
quelli la vita dei quali porta l’impronta dell’“imitazione” non<br />
hanno dubitato dell’Ascensione... Tali furono coloro la cui vita ha il<br />
marchio dell’imitazione: essi ebbero la sicurezza che il loro padrone<br />
e signore è salito in cielo. E quel che li spinge a ciò, fu ancora<br />
l’imitazione...” 84 .<br />
Un esame più approfondito del pensiero di Kierkegaard di fronte<br />
al mistero della passione di Cristo ci porterebbe ad ambientare il<br />
tutto in una più ampia prospettiva dell’insieme di tutto il pensiero<br />
84 KIERKEGAARD, Per l’esame di se stessi, proposto ai contemporanei,<br />
Copenaghen 1851, Discorso II. Ora in “Sam. Vaerker”, 2 ed. Copenaghen<br />
1920, t. XII, pp. 391 ss.; tr. it. in “Lo specchio della parola” a cura di<br />
Valenziani e Fabro, Ed. Fussi, pp. 97-115.
filosofico-teologico del danese e del periodo storico in cui visse,<br />
oltre che dei rapporti che ebbe con le personalità più eminenti del<br />
suo tempo. Allora avremmo un panorama più esatto e completo del<br />
suo pensiero. Quanto detto, però, basti per una ricerca che non ha<br />
uno scopo puramente teoretico e sistematico. Nel qual caso, come<br />
del resto in queste semplici note, avremmo certo riscontrato dei<br />
valori sommamente apprezzabili e positivi, ma avremmo anche<br />
dovuto lamentare la mancanza (o almeno delle gravi lacune) di ciò<br />
che sono i frutti migliori della dottrina, della vita, <strong>Passio</strong>ne e morte<br />
di Cristo: la Sua risurrezione da morte come fatto dogmatico in sé<br />
fondamentale e di valore teologico-ascetico per noi: la Chiesa come<br />
opera del Risuscitato, continuatrice del suo atto redentivo e Suo<br />
corpo mistico, strumento unico di salvezza. Queste gravi lacune<br />
accostano talvolta Kierkegaard alla luterana “Theologia Crucis”.<br />
Per formulare un giudizio complessivo e finale sulla posizione<br />
confessionale di Kierkegaard, possiamo immaginarlo come una<br />
cometa luminosa, solitaria e vagante nel firmamento del cristianesimo<br />
e che si trova fra due sistemi stellari: il cattolicesimo e il protestantesimo:<br />
talvolta si avvicina all’uno, talaltra all’altro. E’ certo,<br />
però, che molte delle sue istanze, anche contro lo stesso cattolicesimo<br />
da lui poco conosciuto, partono da punti di vista cattolici. Per<br />
questo si può asserire che Kierkegaard rientra più spesso nell’orbita<br />
del sistema cattolico che del protestante e la sua anima, sitibonda di<br />
verità e di Cristo, appartiene sicuramente all’anima della Chiesa.<br />
Tutti gli uomini di buona volontà, che hanno il grande dono della<br />
fede, come l’aveva Kierkegaard, potranno pregare con lui:<br />
“Signore Cristo Gesù, Tu che hai conosciuto in precedenza il Tuo<br />
destino, e tuttavia non Ti sei ritirato: Tu che ti sei rassegnato a<br />
nascere nella povertà e nell’abbassamento, anzi in povertà e abbassamento<br />
hai portato il peccato del mondo, come un sofferente, fino<br />
a che odiato, abbandonato, oltraggiato, schernito, sputacchiato e<br />
infine abbandonato da Dio stesso, reclinasti il Tuo capo in ignominiosa<br />
morte, oh, ergilo ancora, Tu eterno vincitore: è vero che non<br />
vincesti in questa vita, ma in morte Tu hai trionfato della morte.<br />
Solleva il Tuo capo, vincitore eterno,Tu che sei asceso al cielo !<br />
Deh, che noi Ti possiamo seguire” 85 .<br />
85 KIERKEGAARD, Per l’esame di se stessi, 1851, in “Preghiere” a cura di<br />
C. FABRO, Morcelliana, Brescia 1950, p. 67.<br />
sacra<br />
scrittura<br />
e<br />
teologia<br />
La <strong>Passio</strong>ne di Cristo<br />
in Kierkegaard<br />
41-68<br />
teologia<br />
67
sacra<br />
scrittura e<br />
teologia<br />
MARIO CEMPANARI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
teologia<br />
68<br />
Dopo la sua breve e sofferta esistenza terrena, a suggello di tutti<br />
i suoi desideri e preghiere, il grande filosofo danese con gioiosa<br />
certezza può lasciare scritto per sempre nel suo epitaffio sopra la<br />
pietra sepolcrale in Copenhagen:<br />
...“Halleluja !... In un giardino di rose, potrò riposare a colloquio<br />
con il mio Gesù” 86 .<br />
THE PASSION OF CHRIST IN KIERKEGAARD<br />
Notes and Research – 2nd ENG<br />
part<br />
By Mario Cempanari<br />
This is the second part of the article printed in Sap Cr XXIII-2008,<br />
pp 429-454.<br />
LA PASSION DE CHRISTE CHEZ KIERKEGAARD FRA<br />
Notes et Recherches – Deuxième partie<br />
Par Mario Cempanari<br />
Deuxième partie de l’article pubbblié dans la Sap Cr XXIII-2008,<br />
pp 429-454.<br />
LA PASIÓN DE CRISTO EN KIERKEGAARD.<br />
ESP<br />
Notas e investigaciones, Segunda Parte,<br />
Por Mario Cempanari<br />
Segunda parte del artículo aparecido en Sap Cr XXIII-2008,<br />
pp. 429-454.<br />
DIE PASSION CHRISTI IN KIERKEGAARD<br />
GER<br />
Anmerkungen und Untersuchungen – Teil 2<br />
Von Mario Cempanari<br />
Der zweite Teil des Artikels wurde publiziert in: Sap Cr. XXIII-2008,<br />
S. 429-454.<br />
MĘKA CHRYSTUSA U KIERKEGAARDA.<br />
POL<br />
Notatki i poszukiwania. Cz. II<br />
Mario Cempanari<br />
Druga częśç artykułu opublikowanego w Sap Cr XXIII-2008,<br />
ss. 429-454.<br />
86 Da H. A. BRORSON, Breve, I, 20, Den danske Salme Bog.
PREMESSA<br />
di MAURIZIO BUIONI C.P.<br />
In occasione dell’approvazione degli Statuti del Cammino<br />
Neocatecumenale da parte della Santa Sede, l’Autore ci<br />
offre una presentazione chiara e stimolante di questa realtà<br />
ecclesiale. Essa mostra come, fin dal principio, il Cammino<br />
fu compreso e accompagnato dalle autorità della Chiesa<br />
come un frutto dello Spirito Santo,<br />
che attuava così, come accaduto<br />
in vari movimenti spirituali sorti<br />
intorno al Concilio Tridentino,<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
IL CAMMINO<br />
NEOCATECUMENALE<br />
ALLA LUCE<br />
DEL CONCILIO<br />
VATICANO<br />
quanto annunciato e promosso<br />
dal Concilio Vaticano II. Come già<br />
è stato evidenziato in un precedente<br />
articolo pubblicato in questa<br />
rivista, la Croce gloriosa è al centro<br />
del Cammino catecumenale, la<br />
Croce che comprende in sé la<br />
risurrezione. Nella morte e nella<br />
risurrezione di Gesù siamo stati<br />
immersi, cioè battezzati (Rom 6, 1-<br />
11). Questo articolo illumina<br />
anche altre prerogative del<br />
Cammino: la sua ecclesialità, in<br />
quanto si attua nella Chiesa locale<br />
e nella parrocchia, l’esperienza<br />
della Chiesa come comunità, l’importanza della liturgia in<br />
quanto strumento di grazia per la Chiesa, la trasmissione<br />
della fede, l’evangelizzazione (seconda parte), l’importanza<br />
dei segni e della loro comprensione.<br />
Il 13 giugno 2008, in una celebrazione di carattere familiare, la<br />
Santa Sede ha consegnato gli Statuti definitivi del Cammino<br />
Neocatecumenale, una delle realtà ecclesiali di maggiore crescita,<br />
nata dopo il Concilio Vaticano II. L’approvazione degli Statuti ha<br />
luogo dopo 5 anni dall’inizio di un periodo ad experimentum.<br />
Il cammino<br />
Neocatecumenale<br />
alla luce del<br />
Concilio Vaticano<br />
69-122<br />
spiritualità<br />
69
pastorale e<br />
spiritualità<br />
MAURIZIO BUIONI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
70<br />
Al termine della cerimonia, che ha avuto luogo nella sede<br />
dell?organismo vaticano preposto al Laicato, il Cardinale Stanisław<br />
Ryłko, presidente del Pontificio Consiglio per i Laici, alla presenza<br />
degli iniziatori del Cammino, Kiko Argüello, Carmen Hernández e<br />
Don Mario Pezzi, ha spiegato l’importanza di questo gesto:<br />
Significa la conferma da parte della Chiesa dell’autenticità, della<br />
genuinità del carisma che sta alla loro origine nella vita e nella missione<br />
della Chiesa.<br />
In modo particolare, questo riguarda il Cammino che ha ormai<br />
lunga storia nella Chiesa, più di 40 anni, e porta nella vita della<br />
Chiesa tanti frutti, tante vite cambiate in profondità, tante famiglie<br />
ricostruite, tante vocazioni religiose, sacerdotali e tanto impegno a<br />
favore della nuova evangelizzazione.<br />
Quindi – ha aggiunto –, un momento di grande gioia per la Chiesa,<br />
un momento di grande gioia per la realtà ecclesiale che riceve questo<br />
riconoscimento.<br />
Nel pomeriggio dello stesso giorno, gli iniziatori del Cammino<br />
hanno offerto nel Centro Neocatecumenale di Roma la loro prima<br />
conferenza stampa per manifestare gratitudine al Santo Padre,<br />
annunciando, poi, come la Santa Sede stia studiando i testi delle<br />
catechesi perché possano essere rese pubbliche e distribuite nelle<br />
Diocesi del mondo.<br />
Criterio fondamentale della Chiesa e nella Chiesa per determinare<br />
l’autenticità di un gruppo o di un movimento è costituito non solo dal<br />
discernimento, da parte dell’autorità, della sua validità o ortodossia, ma<br />
anche dal legame reale con la tradizione, perché si possano cogliere la<br />
continuità e lo sviluppo storico di un fondamento apostolico. Anche<br />
per il Cammino neocatecumenale vale lo stesso criterio. Di fronte ad<br />
una società che determina le proprie scelte di vita, la propria economia,<br />
i propri criteri di relazione, il Cammino si propone come uno strumento<br />
e una sintesi originale di elementi collaudati storicamente, maturata<br />
negli anni del Concilio Vaticano II, quando la Chiesa post-conciliare<br />
registrava, nelle aree tradizionalmente cattoliche, la presenza di grandi<br />
masse sacramentalizzate, ma scarsamente evangelizzate.<br />
Come condurre ad una fede adulta, matura e consapevole coloro,<br />
che pur avendo ricevuto i sacramenti dell’iniziazione cristiana, non<br />
mostrano uno stile di vita cristiano? Come far rivivere i germi di vita<br />
eterna conferiti col battesimo, ma ancora bisognosi di essere formati<br />
e rivitalizzati?
Esso si pone come uno strumento che rende chiaro e intelligibile<br />
l’uomo e la sua storia, il quale comincia a scoprire, pian piano, la<br />
propria vita personale e comunitaria ravvivata dall’esperienza del<br />
testo sacro per riconoscere la presenza di Dio e favorire il servizio,<br />
la conversione personale e comunitaria. Si rende così visibile un<br />
nuovo modo di vivere il Vangelo, rimanendo all’interno delle parrocchie<br />
e tenendo presenti le esigenze degli uomini contemporanei.<br />
Attualmente il Cammino Neocatecumenale è diffuso in 107 Paesi<br />
del mondo. Opera in 20.000 comunità, presenti in 5700 parrocchie.<br />
Oltre 600 famiglie sono partite per evangelizzare le zone più scristianizzate<br />
della terra, andando a vivere soprattutto fra i poveri.<br />
Inoltre, da questa realtà ecclesiale sono sorti 72 seminari diocesani<br />
missionari Redemptoris Mater, che hanno già dato alle varie Diocesi<br />
oltre 1200 presbiteri.<br />
Nel solco<br />
del Concilio Vaticano II<br />
ne definitiva degli Statuti così lo descrive:<br />
Il Cammino Neocatecumenale<br />
è nato<br />
negli anni del Concilio<br />
Vaticano II. Il<br />
Decreto di approvazio-<br />
Il Cammino Neocatecumenale ebbe inizio nel 1964 fra i baraccati<br />
di Palomeras Altas, a Madrid, per opera del Signor Francisco José<br />
(Kiko) Gomez Argüello e della Signorina Carmen Hernández.<br />
Questo nuovo itinerario di iniziazione cristiana, nato nel solco del<br />
rinnovamento suscitato dal Concilio Ecumenico Vaticano II, incontrò<br />
il vivo interesse dell’allora arcivescovo di Madrid, Sua<br />
Eccellenza Monsignor Casimiro Morcillo (1904-1971), che incoraggiò<br />
gli iniziatori del Cammino a portarlo nelle parrocchie che lo<br />
richiedessero. Esso si diffuse così gradualmente nell’arcidiocesi di<br />
Madrid e in altre diocesi spagnole. Nel 1968 gli Iniziatori del<br />
Cammino Neocatecumenale giunsero a Roma e si stabilirono nel<br />
Borghetto Latino. Con il consenso di Sua Eminenza il cardinale<br />
Angelo Dell’Acqua (1903-1972), all’epoca Vicario Generale di Sua<br />
Santità per la Città di Roma e Distretto, si cominciò la prima catechesi<br />
nella parrocchia di Nostra Signora del Santissimo Sacramento<br />
e Santi Martiri Canadesi. A partire da quella data il Cammino si è<br />
andato via via diffondendo in diocesi di tutto il mondo 1 .<br />
1 Decreto di approvazione, Dato in Vaticano l’11 Maggio 2008, Solennità<br />
di Pentecoste.<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
Il cammino<br />
Neocatecumenale<br />
alla luce del<br />
Concilio Vaticano<br />
69-122<br />
spiritualità<br />
71
pastorale e<br />
spiritualità<br />
MAURIZIO BUIONI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
72<br />
Fin dai primi tempi Paolo VI e Giovanni Paolo II hanno più volte<br />
collegato il Cammino Neocatecumenale al rinnovamento del<br />
Concilio Vaticano II. Nella prima udienza ad un gruppo di circa 500<br />
partecipanti tra presbiteri e membri delle comunità, l’8 Maggio<br />
1974, Paolo VI li salutò dicendo:<br />
Salutiamo il gruppo di sacerdoti e di laici che rappresentano il<br />
movimento delle Comunità Neocatecumenali. Ecco i primi frutti del<br />
Concilio Vaticano II. Quanta gioia e quanta speranza ci date con la<br />
vostra presenza e con la vostra attività! Sappiamo che nelle vostre<br />
comunità voi vi adoperate insieme a comprendere e a sviluppare le<br />
ricchezze del vostro Battesimo e le conseguenze della vostra appartenenza<br />
a Cristo. Vivere e promuovere questo risveglio è quanto voi<br />
chiamate una forma di “dopo Battesimo” che potrà rinnovare nelle<br />
odierne comunità cristiane quegli effetti di maturità e di approfondimento,<br />
che nella Chiesa primitiva erano realizzati dal periodo di<br />
preparazione al Battesimo. Voi lo portate dopo: il prima o dopo,<br />
direi, è secondario 2 .<br />
Ricordiamo, inoltre, come a metà del XX secolo, la Chiesa cattolica<br />
registrò un aumento delle conversioni di adulti. Il Concilio<br />
Vaticano II esortò dunque al ripristino di tutti i riti del Catecumenato<br />
che erano stati adottati dalla Chiesa primitiva affinché i cristiani<br />
adulti potessero essere istruiti e costantemente nutriti 3 . Nacque così<br />
il Rito per l’Iniziazione Cristiana degli Adulti (RICA). Esso si compone<br />
di tre periodi di preparazione ai Sacramenti dell’Iniziazione: il<br />
periodo di Evangelizzazione e Precatecumenato; il periodo di<br />
Catecumenato e il periodo di Purificazione e Illuminazione. Infine,<br />
esiste un periodo di Catechesi postbattesimale o Mistagogia. Ecco<br />
gli scopi e i riti principali di questi 4 periodi.<br />
Il primo periodo, di evangelizzazione e di precatecumenato, è<br />
molto importante e non dovrebbe essere omesso. È un tempo di<br />
evangelizzazione: con l’aiuto e la grazia di Dio avviene una prima<br />
conversione, attraverso la quale una persona si sente allontanare dal<br />
peccato e portata verso il mistero dell’amore di Dio. Tutto il periodo<br />
del precatecumenato è finalizzato a questa evangelizzazione<br />
2 PAOLO VI, Udienza agli Iniziatori del Cammino neocatecumenale,<br />
08/05/1974.<br />
3 Cf. Sacrosanctum concilium, nn. 64-70.
affinché possa maturare la volontà autentica di seguire Cristo e di<br />
ricercare il Battesimo 4 .<br />
Il secondo periodo, il Catecumenato, è lungo e inizia con “l’entrata<br />
nell’ordine dei catecumeni”. In questo periodo i candidati ricevono<br />
una formazione pastorale e una disciplina adatta. In tal modo,<br />
maturano le inclinazioni manifestate al momento dell’entrata nel<br />
Catecumenato 5 .<br />
Il terzo periodo, Purificazione e Illuminazione, comincia con<br />
“l’elezione” o “l’arruolamento dei nomi”, che si celebra la prima<br />
domenica di Quaresima. Inizia così un periodo di più intensa preparazione<br />
spirituale che implica più una riflessione interiore che la<br />
catechesi e intende purificare la mente e il cuore dell’eletto per illuminarli<br />
con una conoscenza più profonda di Cristo, il Salvatore.<br />
Questo periodo coincide abitualmente con la Quaresima. Sia per<br />
l’eletto sia per la comunità cristiana locale si tratta di un periodo di<br />
raccoglimento spirituale in vista della celebrazione del mistero<br />
pasquale. In questo periodo, vengono celebrati solennemente tre<br />
scrutini la domenica 6 . I sacramenti del Battesimo, della<br />
Confermazione e dell’Eucaristia, integrati nella Veglia Pasquale,<br />
rappresentano il momento culminante del RICA, ma è errato pensare<br />
che siano anche la sua conclusione.<br />
Il quarto periodo, la catechesi postbattesimale o mistagogia, è il<br />
tempo, in genere pasquale, che segue la celebrazione dell’iniziazione,<br />
durante il quale gli iniziati sperimentano la propria appartenenza<br />
alla comunità cristiana per mezzo di una adeguata catechesi e in<br />
particolare partecipano con tutti i fedeli alla celebrazione eucaristica<br />
domenicale. Il termine mistagogia suggerisce che i neofiti arrivino<br />
ad una comprensione più piena ed efficace dei misteri attraverso<br />
il Vangelo che hanno appreso e soprattutto attraverso l’esperienza<br />
dei Sacramenti che hanno ricevuto. Ne deriva per loro un nuovo<br />
senso della fede, della Chiesa e del mondo 7 .<br />
4 RICA, 1972, nn. 9-10.<br />
5 Ibidem, nn. 14, 19.<br />
6 Ibidem, nn. 22, 25.<br />
7 Ibidem, n. 38. Alcune caratteristiche del RICA sono degne di nota: 1) Si<br />
tratta di una crescita della fede sia per i convertiti adulti sia per chi è già membro<br />
della comunità cristiana; partecipando al rito, tutti i membri della Chiesa<br />
ricevono nutrimento e l’opportunità di crescere. Per questo, il RICA non è qualcosa<br />
che accade davanti ai banchi della chiesa, ma che li include. 2) Il RICA<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
Il cammino<br />
Neocatecumenale<br />
alla luce del<br />
Concilio Vaticano<br />
69-122<br />
spiritualità<br />
73
pastorale e<br />
spiritualità<br />
MAURIZIO BUIONI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
74<br />
La Congregazione del Culto, dopo vari incontri con gli Iniziatori<br />
ed un attento esame del Cammino nella Diocesi di Roma, assieme al<br />
saluto di Paolo VI, pubblicò sulla Rivista ufficiale “Notitiae” la<br />
seguente Nota, sempre facendo riferimento al Concilio:<br />
Tutte le riforme, nella Chiesa, hanno apportato nuovi principi e promosso<br />
nuove norme, che hanno tradotto in pratica gli intenti della<br />
riforma stessa. Così accadde dopo il Concilio di Trento; né poteva<br />
essere diversamente ai giorni nostri. Il rinnovamento liturgico incide<br />
profondamente sulla vita della Chiesa. C’è necessità che la spiritualità<br />
liturgica germini nuovi fiori di santità e di grazia, nonché di<br />
apostolato cristiano più intenso e di azione spirituale. Un modello<br />
eccellente di questo rinnovamento si trova nelle «Comunità neocatecumenali»<br />
che sorsero a Madrid, nel 1964, per iniziativa di<br />
alcuni giovani laici, con il permesso, l’incoraggiamento e la benedizione<br />
dell’eccellentissimo Pastore madrileno, Casimiro Morcillo.<br />
Le comunità hanno lo scopo di rendere visibile nelle parrocchie il<br />
segno della Chiesa Missionaria, e si sforzano di aprire la strada<br />
all’evangelizzazione di coloro che hanno quasi abbandonato la vita<br />
cristiana 8 .<br />
Nella sua pecurialità<br />
e struttura<br />
Con meraviglia<br />
fummo testimoni di<br />
una parola che,<br />
facendosi carne in gente<br />
così povera che l’accoglieva<br />
con gioia, dava luogo<br />
alla nascita di una comunità di preghiera, a una liturgia sorprendente<br />
come era la risposta di tanti fratelli che, pieni di peccati, benedicevano<br />
il Signore che si era ricordato di loro. Così in un periodo di<br />
tre anni, vedemmo apparire davanti ai nostri occhi un vero<br />
Cammino di gestazione alla fede, una specie di catecumenato che<br />
andava creando, a poco a poco, una Chiesa, realizzava una comu-<br />
e i suoi riti liturgici dovrebbero essere in sintonia con lo spirito e il ritmo dell’anno<br />
liturgico della Chiesa; 3) I convertiti adulti affrontano un processo di purificazione<br />
con l’aiuto di riti sacri durante il loro Catecumenato. Per questo, è<br />
necessario prestare cura e attenzione a riti e liturgie ben delineate.<br />
Nell’elaborare l’iniziazione cristiana degli adulti la Chiesa ha ripristinato e preparato<br />
per noi un meraviglioso sistema di Catecumenato, in sintonia con il ritmo<br />
e la struttura dell’anno liturgico della Chiesa.<br />
8 SACRA CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, «Notitiae», organo di detta<br />
Congregazione, n. 95-96 Julio-Augusto 1974, p. 229.
nione fraterna, dava luogo all’amore in una dimensione che stupiva<br />
tutti, perché era quella della morte per il nemico, la dimensione<br />
della Croce 9 .<br />
In queste parole, richiamate dall’iniziatore del Cammino anche<br />
davanti all’assemblea plenaria della Congregazione per<br />
l’Evangelizzazione dei popoli, si possono notare chiaramente un<br />
fatto molto importante, i due passaggi in cui si compie e intuirne un<br />
terzo.<br />
Il fatto è molto semplice ed evidente: al termine del Cammino<br />
Neocatecumenale c’è la nascita, la formazione di una Chiesa; un<br />
evento che Kiko ricorda due volte, la prima usando il termine di<br />
«comunità di preghiera», la seconda parlando di «comunione<br />
fraterna» e di «Chiesa». Si tratta dello scopo del Cammino che,<br />
espresso in diversi modi, resterà sempre, diventandone come<br />
l’orientamento di fondo, chiamandosi ora «ricostruzione» della<br />
Chiesa, ora «rianimazione»; una Chiesa al cui centro c’è la «comunione<br />
fraterna», 1’«amore», 1’«Amore nella dimensione della<br />
Croce» e la «preghiera» 10 .<br />
Più articolato il discorso sull’evoluzione del Cammino, sui passaggi<br />
che esso ha attraversato nei primi tre anni, dopo i quali ha<br />
lasciato Madrid per approdare a Roma. Si tratta di passaggi al cui<br />
interno si possono intravedere delle mediazioni culturali, ma al cui<br />
centro resta l’intensa e semplice esperienza spirituale di chi ha iniziato<br />
il Cammino e delle stesse prime comunità: Dio che ama gratuitamente<br />
ogni uomo e il Crocifisso come sua icona, la Chiesa<br />
come frutto e sacramento di questo amore e la necessità di un itinerario<br />
per scoprirne la presenza nelle acque del proprio battesimo.<br />
Il primo passaggio è quello fondante; avviene a Madrid nel 1964<br />
tra i baraccati di Palomeras Altas, fra povera gente tra cui non mancavano<br />
ladri e assassini. Ebbene, la parola di Dio trasformava quelle<br />
persone riunendole in una fratellanza, in una «comunione», in una<br />
9 Cf. F. ARGÜELLO, Le comunità neocatecumenali, in Rivista di vita spirituale,<br />
2 (1975), pp. 185-197. Analoghe espressioni, con più abbondanza di termini<br />
utili per approfondirne il pensiero, si possono trovare nell’Intervento di K.<br />
Argüello alla plenaria della congregazione per l’evangelizzazione dei popoli<br />
nell’aprile del 1983, in II Cammino neocatecumenale nei discorsi di Paolo VI e<br />
di Giovanni Paolo II, pro ms., presso il Centro neocatecumenale di Roma,<br />
1991.<br />
10 II Cammino neocatecumenale, pp. 86-87.<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
Il cammino<br />
Neocatecumenale<br />
alla luce del<br />
Concilio Vaticano<br />
69-122<br />
spiritualità<br />
75
pastorale e<br />
spiritualità<br />
MAURIZIO BUIONI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
76<br />
«koinonia», in una parola, in una Chiesa. Kiko ricorda l’avvenimento<br />
usando espressioni come «meraviglia», «stupore», «sorpresa».<br />
Sulla scorta di altre fonti non mancano elementi di obiettiva mediazione:<br />
Kiko stesso ricorda l’esperienza di Charles de Foucauld, alcune<br />
espressioni di papa Giovanni XXIII sulla Chiesa dei poveri e<br />
descrive anche lo stile con il quale era andato a vivere nelle baracche,<br />
soltanto con una Bibbia e una chitarra. non per insegnare a leggere<br />
o a scrivere, né per fare assistenza sociale e neppure per predicare<br />
il vangelo, ma per «porsi accanto a Gesù Cristo»; il suo ideale<br />
era la vita nascosta che Gesù aveva vissuto per trent’anni a Nazaret,<br />
senza dire nulla 11 .<br />
Ma dopo quello che era successo, il centro - lo stile - erano ben<br />
altri; nulla era stato preconcepito o preparato, ma tutto era frutto di<br />
un’esperienza vissuta: il fatto che quella gente era come crollata<br />
davanti all’annuncio del servo di Adonaj, di uno che si era caricato<br />
di ogni loro peccato, che era morto al posto loro e per loro e che per<br />
questo Dio aveva risuscitato; per cui «pieni di peccati benedicevano<br />
il Signore». Perché era crollata? perché «erano tanto poveri che non<br />
potevano difendersi davanti alla parola di Dio, perché non avevano<br />
nulla da difendere; erano così poveri - racconta Kiko - che credevano<br />
a tutto ciò che dicevamo, che credevano al vangelo alla lettera,<br />
perché non erano vaccinati; e poiché credevano al vangelo, lo<br />
Spirito operava in loro» 12 .<br />
Un momento, indubbiamente, «fondante», perché in germe c’è<br />
l’inizio e la fine di quello che sarà poi il Cammino: la potenza del<br />
kerygma, che di «relitti di umanità» fa delle creature nuove, e la sua<br />
dinamica: la formazione, la ricostruzione della Chiesa che resterà lo<br />
scopo ultimo del Cammino. Dei poveri e dei peccatori - «gente che<br />
all’apparenza neppure sembravano esseri umani» - in pochissimo<br />
tempo facevano un Cammino enorme, di cui non potevano vantarsi,<br />
perché da attribuire solo all’intervento liberante di Dio: facevano la<br />
Chiesa. È il momento del miracolo, davanti al quale Carmen<br />
Hernàndez, che sopraggiunge durante quelle primissime esperienze,<br />
per poi restare sempre con Kiko, rimaneva più che stupita, essendo<br />
abituata a pensare la comunità in termini ben diversi: di persone per<br />
11 Orientamenti alle équipes dei catechisti per la fase di conversione, pro<br />
ms., presso il Centro neocatecumenale di Roma, pp. 7-8.<br />
12 Orientamenti alle équipes dei catechisti, pp. 10-11.
ene, perfette, che possono stare insieme grazie alle loro qualità e a<br />
un forte sforzo ascetico.<br />
Il secondo passaggio si compie nel giro di tre anni, anche se ciò<br />
che lo caratterizza dovrebbe essere avvenuto poco tempo dopo<br />
l’esperienza nelle baracche, in un lasso di tempo che resta difficile<br />
da precisare. Due fatti ne aprono la strada: il fallimento della predicazione<br />
di Kiko nelle parrocchie di Arguelles dove era stato chiamato<br />
dai rispettivi parroci e invitato dallo stesso vescovo di Madrid,<br />
monsignor Casimiro Morcillo, impressionato da quanto era avvenuto<br />
nelle baracche e, soprattutto, l’intuizione della necessità di un<br />
«Cammino di gestazione alla fede, una specie di catecumenato»,<br />
perché non si poteva trasportare nelle parrocchie il «metodo delle<br />
baracche»; per uomini «vaccinati» - annota Kiko -, abituati a<br />
nascondersi dietro il perbenismo senza neppure accorgersene e a<br />
vivere in «maschera», era necessario un Cammino di conversione<br />
nel quale poter scoprire di essere peccatori, del tutto incapaci di<br />
riconciliarsi con la propria vita e tanto meno di amare il proprio<br />
prossimo 13 .<br />
Per la successiva elaborazione del Cammino questo periodo è<br />
molto importante, anche perché il contatto con la realtà parrocchiale<br />
e il fallimento della predicazione quasi naturalmente portano un<br />
po’ alla volta a galla quelle che si possono considerare le mediazioni<br />
culturali del Cammino, nelle quali si confondono le esperienze<br />
precedenti di Kiko (i Cursillos e la sua conversione) con la preparazione<br />
culturale e la vocazione missionaria di Carmen Hernàndez.<br />
Carmen aveva frequentato la facoltà teologica di Valencia, tramite<br />
Farnes era stata in contatto con l’Istituto di Pastorale Liturgica di<br />
Parigi, in particolare con dom Botte e con L. Bouyer, e, prima di<br />
incontrarsi con Kiko, si era iscritta all’École Biblique di<br />
Gerusalemme, apprendendo, in particolare, lo stile tipicamente<br />
ebraico di vivere liturgicamente la fede 14 .<br />
È in questo passaggio, dunque, che assume particolare importanza,<br />
agli effetti dell’esito finale del Cammino, il contributo di<br />
Carmen; in modo specifico: l’aggancio con la Chiesa istituzionale<br />
che le veniva dalla formazione di Valencia, la centralità del mistero<br />
13 Ivi, pp. 8-9.<br />
14 Cf. Convivenza d’inizio corso 1994-95. Catechesi su «Sono rotti i miei<br />
legami».<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
Il cammino<br />
Neocatecumenale<br />
alla luce del<br />
Concilio Vaticano<br />
69-122<br />
spiritualità<br />
77
pastorale e<br />
spiritualità<br />
MAURIZIO BUIONI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
78<br />
pasquale per la vita cristiana, propria del movimento liturgico, lo<br />
stile liturgico di matrice ebraica nel vivere tutto il Cammino di conversione<br />
e, soprattutto, l’apertura universale proveniente dalla sua<br />
vocazione missionaria la quale non poteva attuarsi se non passando<br />
attraverso Roma, dove Kiko e Carmen fisseranno la loro sede a partire<br />
dal 1968.<br />
Ma quello che sorprende è che tutte queste precedenti preparazioni<br />
culturali o esperienziali, nel momento in cui nasceva il Cammino,<br />
non erano presenti e non si agiva in base ad esse: erano state come<br />
lasciate da parte. Carmen può dire che il Cammino non è stato preconcepito;<br />
perché tutto emergeva all’interno di una nuova esperienza<br />
spirituale: la potenza della parola, il fallimento della predicazione,<br />
l’obbedienza al vescovo di Barcellona che proibiva la celebrazione<br />
eucaristica così come andava elaborandosi nel Cammino.<br />
Dal punto di vista culturale si faceva esperienza che Dio ridona<br />
ciò che l’uomo lascia per suo amore, cento volte tanto. Soltanto<br />
guardando retrospettivamente si possono notare queste lontane preparazioni:<br />
la «cristologia» di Kiko formatasi, sulla scia di Charles de<br />
Foucauld, nel privilegiare i poveri come luogo della manifestazione<br />
di Dio e sperimentando, nella propria conversione, la presenza di<br />
Cristo come servo di Adonaj che prende su di sé i peccati degli<br />
uomini, morendo al posto loro e per loro e rinnovandoli profondamente;<br />
1’ecclesiologia liturgica di Carmen culturalmente ancorata<br />
agli studi di Valencia, ma animatasi nel rinnovamento liturgico<br />
impresso alla Chiesa dal Vaticano II e resa ancor più sensibile dall’esperienza<br />
ebraica che le permetteva di percepire la novità dell’eucaristia<br />
cristiana senza dimenticare le sue radici ebraiche; un’ecclesiologia<br />
che diventava poi «cattolica» per il respiro missionario che<br />
Carmen custodiva in sé fin da ragazza e che si era maturato in una<br />
profonda kenosi, senza dimenticare la solidità «tridentina» della teologia<br />
insegnata a Valencia 15 .<br />
Quando Kiko e Carmen lasciarono Madrid, la struttura del<br />
Cammino si era sostanzialmente formata, articolandosi in precatecumenato,<br />
catecumenato ed elezione; tre tappe nelle quali le persone<br />
avrebbero lentamente imparato a riconoscersi peccatori, scendendo<br />
negli inferi del proprio essere per scoprirsi incapaci di amare e<br />
scoprendo, contestualmente, che proprio là Cristo le stava aspettan-<br />
15 Cf. Catechesi su «Sono rotti i miei legami» (1994).
do, per trasformarle in creature nuove in grado di riconciliarsi con la<br />
propria storia e di amare il nemico, per diventare Chiesa, sacramento<br />
dell’amore di Dio per gli uomini. E tutto questo reso possibile<br />
in piccole comunità, nell’ascolto della parola di Dio e nutrendosi<br />
dei sacramenti della penitenza e dell’eucaristia celebrata ogni<br />
sabato notte, nuova Pasqua del Signore che introduce al riposo<br />
escatologico.<br />
Un vero Cammino di conversione, scandito da precise tappe; da<br />
due scrutini in particolare; il primo nel passaggio dal precatecumenato<br />
al catecumenato, il secondo nel passaggio dal catecumenato<br />
all’elezione, prima che il Cammino si sciolga nella vita comune<br />
della chiesa. Due passaggi salienti nei quali, in modo diverso, si fa<br />
esperienza del rinascere e crescere del battesimo già ricevuto.<br />
Nel primo scrutinio si comincia a vedere la potenza della parola<br />
di Dio che libera dagli idoli e porta i fratelli a mettere Dio al primo<br />
posto e a percepirne la presenza nella Croce, luogo privilegiato dell’incontro<br />
con lui; è un’esperienza decisiva che si continua e si<br />
accresce nella successiva iniziazione alla preghiera, nell’essere poi<br />
inviati nelle case della parrocchia per dare testimonianza di quanto<br />
Dio sta operando nella vita dei fratelli e che si conclude nella consegna<br />
del «Padre nostro». Segue poi il tempo che introduce al secondo<br />
scrutinio, quello dell’elezione, nel quale si comincia a gridare<br />
«Abbà, Padre», per rifiutare il maligno continuamente annidantesi<br />
nell’uomo per essere lui padre nella vita. L’elezione è il tempo della<br />
confidenza in Dio, dell’abbandono alla sua volontà, in cui si offre il<br />
proprio corpo al Padre perché in esso Cristo continui la sua missione<br />
di perdere la vita per gli uomini, amando con esso e come lui i<br />
nemici; un amore - quest’ultimo - che resta il luogo ermeneutico<br />
della più profonda identità cristiana.<br />
Nella prima parte degli anni Settanta, dopo la pubblicazione del<br />
Rito dell’iniziazione cristiana degli adulti, già precedentemente<br />
menzionato, plausibilmente avveniva come una conferma del<br />
Cammino intrapreso e insieme la sua definitiva articolazione, nell’idea<br />
che le tappe del Cammino corrispondevano ai diversi momenti<br />
della celebrazione del battesimo; un sacramento già ricevuto e<br />
ricevuto nel giro di pochi minuti e che nel Cammino riviveva gradualmente,<br />
portando con sé la luce e la grazia di ogni momento; una<br />
luce e una grazia proporzionata alla situazione in cui si trovava chi<br />
ne rinnovava i momenti attraverso una serie di parole e di gesti che<br />
allora venivano fissati per accogliere quelli ricevuti nel primo<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
Il cammino<br />
Neocatecumenale<br />
alla luce del<br />
Concilio Vaticano<br />
69-122<br />
spiritualità<br />
79
pastorale e<br />
spiritualità<br />
MAURIZIO BUIONI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
80<br />
battesimo. La rinnovazione delle promesse battesimali, al termine<br />
del Cammino nella veglia di Pasqua, operativamente segnava la<br />
fine della sua articolazione che assumeva così una connotazione<br />
liturgica ancor più evidente. Si trattava del terzo e definitivo passaggio,<br />
compiuto in coincidenza dell’apertura del Cammino a tutte le<br />
nazioni.<br />
Le dinamiche<br />
del cammino<br />
Si ripete spesso<br />
che nel Cammino<br />
nulla è stato preconcepito,<br />
in quanto<br />
tutto viene da un’espe-<br />
rienza o, meglio, da una serie di esperienze nelle quali coloro che<br />
sono all’inizio del Cammino, Kiko e Carmen in particolare, hanno<br />
visto e vedono un intervento di Dio che ancora una volta libera un<br />
popolo, portandolo dalla schiavitù dei propri idoli (denaro, potere,<br />
sesso, ecc) alla libertà dei figli di Dio, alla capacità di morire per il<br />
nemico. Un fatto o una serie di fatti che si vedono nella storia concreta<br />
di ogni giorno, là dove è dato abitualmente l’incontro vivificante<br />
con il Dio di Gesù Cristo. Parola di Dio, sacramenti, Chiesa<br />
non sono realtà a sé stanti, dei riti magici o dei precetti, ma sono luce<br />
e forza per aiutare a vedere Dio presente nella propria storia, in quella<br />
dei fratelli e nelle vicende del mondo, sapendo cogliere anche in<br />
quelle che il mondo chiama «disgrazie» la presenza di Dio che ama.<br />
O la parola di Dio e i sacramenti producono questo o si è fatto della<br />
chiesa non una missione per il mondo, ma un rifugio nel quale tutti<br />
possono incontrarsi con Dio a un livello religioso-naturale, nel quale<br />
si finisce per giudicare chi non va a messa o chi si comporta «male».<br />
In tale contesto il Cammino non è una tecnica, né una teologia,<br />
né una morale, ma una piccola comunità in cui si può gradualmente<br />
cominciare a sperimentare l’efficacia della Parola in un clima liturgico,<br />
senza per questo essere confermati in grazia. Quattro ci sembrano,<br />
così, le principali dinamiche del Cammino: la comunità, la<br />
gradualità, la liturgia, la conversione.<br />
a) La comunità. - Il caso è serio. Si tratta di fare un salto, di rieducare<br />
al senso della Chiesa, di farne scoprire il mistero, la ricchezza<br />
profonda, spesso nascosta, dal momento che la Chiesa, purtroppo,<br />
viene sempre più identificata come una organizzazione di servi-
zi religiosi e non come una comunità di fratelli. L’esperienza in una<br />
piccola comunità porterà a far crescere un po’ alla volta nel cuore di<br />
ogni fratello la Chiesa come madre, sorella e figlia. Questa è la<br />
meta.<br />
Entra in comunità colui che accoglie nella sua vita il kerygma e<br />
desidera fare un Cammino di conversione. Non vi sono altre condizioni.<br />
Uomini e donne, anziani e giovani, sposati o meno, colti e<br />
analfabeti, ricchi e poveri, preti e suore possono far parte della<br />
comunità. Nessuno è privilegiato. Non si tratta di un gruppo specializzato<br />
del quale si fa parte perché si appartiene allo stesso ambiente<br />
di vita o di lavoro.<br />
La comunità, dal punto di vista sociologico, è uno specchio del<br />
mondo e uno spaccato di Chiesa. Niente è più lontano dal Cammino<br />
che la volontà di concentrarsi su tecniche psicologiche e sociologiche<br />
nella formazione della comunità. La dinamica di gruppo, la strategia<br />
di integrazione personale, la promozione di relazioni credibili,<br />
non sono ricercate direttamente come tali, ma sono frutto di un’altra<br />
cosa; di un mezzo che nessuno sceglierebbe, che anzi tutti vorrebbero<br />
eliminare per creare le condizioni più idonee al crescere di una<br />
comunità: i limiti, i difetti, i peccati dei fratelli, la vita concreta in<br />
tutta la sua realtà bella e brutta. Sono proprio i peccati e i difetti delle<br />
singole persone ad essere un aiuto importante ai fratelli, perché li<br />
costringono quasi a scoprire la propria impotenza ad accogliere l’altro<br />
così come è; l’impossibilità ad assumere dell’altro quello che<br />
distrugge; per cui amare comincia ad apparire come la distruzione<br />
del proprio io, di quanto cioè costituisce la sicurezza di ognuno 16 .<br />
La tragedia dell’uomo è il non volere morire, scoprendo però che<br />
amare diventa sempre più un morire; per cui si è ad una svolta: o si<br />
continua ad amare «fino ad un certo punto», ma allora continua la<br />
vita di prima, oppure, fidandosi della Parola, si rischia di amare<br />
«oltre» e allora si scopre che nella comunità comincia a nascere un<br />
rapporto diverso, frutto dell’azione dello Spirito. Così un po’ alla<br />
volta cominciano a cadere i progetti di comunità che ognuno porta<br />
con sé per lasciare posto alla comunità che va costruendo lo Spirito<br />
di Cristo, rendendoci capaci, al termine del Cammino, di accogliere<br />
il comandamento «Amatevi come io vi ho amato». Così ogni<br />
16 Cf. R. BLASQUEZ, Le comunità neocatecumenali. Discernimento teologico,<br />
Paoline, Milano 1987, pp. 36-51.<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
Il cammino<br />
Neocatecumenale<br />
alla luce del<br />
Concilio Vaticano<br />
69-122<br />
spiritualità<br />
81
pastorale e<br />
spiritualità<br />
MAURIZIO BUIONI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
82<br />
membro della comunità inizia a sperimentare che il cristiano non è<br />
chiamato a farsi amare ma ad amare; impara a dare i primi segni<br />
della fede adulta, a ritenere gli altri superiori a sé, ad essere sottomesso,<br />
a portare i peccati dei fratelli senza giudicarli o mormorare,<br />
ad amare perdendo la vita, ad essere Chiesa. Così l’ecclesialità<br />
costitutiva della vita cristiana passa attraverso la comunità che cresce<br />
in ambito parrocchiale e che un po’ alla volta si scopre parte di<br />
un tutto, dentro una comunità più ampia, sperimentando con forza<br />
che non esiste possibilità di essere cristiani senza la Chiesa, incontrata<br />
concretamente nella vita dei fratelli più vicini.<br />
b) Gradualità. - Anche qui la meta è alta: si tratta di ricucire un<br />
po’ alla volta la frattura tra fede e vita, il fatto cioè che, abitualmente,<br />
la fede non c’entri con la vita; che se anche Dio ci fosse, nulla<br />
avrebbe a che fare con la vita.<br />
Dall’esterno questo è l’aspetto che più colpisce e che rischia di<br />
essere confuso con la lunghezza del Cammino, mentre si tratta di un<br />
vero percorso a tappe, la cui meta è l’ingresso nella Chiesa, attraverso<br />
l’esperienza graduale di ciò che significa essere cristiani sul<br />
piano della dottrina ma soprattutto su quello esistenziale. Non si va<br />
in comunità per imparare qualcosa, ma per vedere che le parole ricevute<br />
di volta in volta, nelle diverse tappe, cominciano a compiersi<br />
nella propria vita, cominciano a trasformare la vita di ognuno, a rendere<br />
più semplici i rapporti con se stessi, con i fratelli e con Dio; un<br />
intreccio di rapporti che si realizzano in diversi momenti, in diversi<br />
modi, in diverse profondità, ma il cui esito è sempre il graduale formarsi<br />
di una comunità di fratelli che prendono sempre più coscienza<br />
di essere peccatori. Pensavano di essere buoni, si accorgono di<br />
essere schiavi di tanti idoli; è il tempo del precatecumenato. Un<br />
tempo in cui alle persone si chiede solo di apprendere il linguaggio<br />
biblico (si imparano le parole: acqua, fuoco, agnello, ecc.) e il modo<br />
di pensare di Dio (attraverso i temi e le figure: alleanza, sacrificio,<br />
Abramo, Mosè, ecc.) lasciandosi giudicare dalla parola di Dio per<br />
scoprirsi peccatori perdonati.<br />
Qualcosa di diverso si prospetta nel secondo tempo: il catecumenato.<br />
Tempo della semplificazione dei rapporti con se stessi, con i<br />
fratelli e con Dio: quindi il tempo della rinuncia agli idoli, a ciò che<br />
impedisce di essere liberi; al denaro, in modo particolare, con dei<br />
gesti eloquenti; tempo per riconciliarsi con la propria storia incominciando<br />
a vedere Dio presente nelle proprie croci; è il tempo della
iniziazione alla preghiera, all’«ufficio» del cristiano; una iniziazione<br />
che si concluderà con la consegna del «Padre nostro», quando<br />
ogni fratello imparerà a vedere chi è l’effettivo padre nella sua vita,<br />
se il maligno o Dio; tempo del primo ingresso nella vita della<br />
Chiesa, nella storia della sua fede attraverso lo studio del «credo»,<br />
con i primi servizi in parrocchia e, soprattutto, attraverso la missione,<br />
due a due, nelle case della parrocchia, per testimoniare al mondo<br />
che Dio è signore di ogni morte e per vedere le sofferenze della<br />
gente, cominciando a portarne i peccati senza giudicare. Il catecumenato<br />
è un tempo di lotta con le tre armi della preghiera, dell’elemosina<br />
e del digiuno: armi che si devono usare insieme, altrimenti<br />
sono inefficaci. Ormai non è più in gioco solo la lotta contro le proprie<br />
passioni, ma anche contro il maligno che vuol impedire la formazione<br />
di una Chiesa e quindi la possibilità dell’evangelizzazione.<br />
Al tempo del catecumenato segue quello della elezione: l’ultima<br />
tappa che termina con un grande scrutinio, per vedere se, come diceva<br />
Giovanni Crisostomo, «la virtù si compie ormai spontaneamente,<br />
senza sforzo», segno di «elezione divina». È un tempo nel quale,<br />
come i tre fanciulli nella fornace, il cristiano non muore là dove gli<br />
altri muoiono, non perché lui sia più bravo, ma perché con lui c’è un<br />
angelo, perché il cristiano è chiamato a «salare» gli altri, ad entrare<br />
nel mondo per dare i segni della fede - quelli che attendono i nuovi<br />
pagani, ormai scettici di fronte ad altre presenze della Chiesa e scandalizzati<br />
di fronte al dolore -, che sono una solidarietà, un amore<br />
spinto fino a dare la vita; come Cristo che non è un eroe morto per<br />
un grande ideale, ma un uomo morto per della povera gente che<br />
nulla meritava. Si tratta di un processo in cui si entra solo se chiamati<br />
da Dio; non quindi reggendosi sulle proprie forze ma sulla<br />
potenza di Dio e quindi capaci di scorgerne l’opera nella propria<br />
vita, in quella dei fratelli e nel mondo.<br />
c) La liturgia. - Anche qui la posta in gioco è grande; compiere la<br />
parola: «in ogni tempo benedite il Signore»; fare della propria vita<br />
una lode a Dio. Si tratta del primo lavoro della Chiesa e del cristiano;<br />
del loro «ufficio», a somiglianza di Cristo che alla destra del<br />
Padre vive in preghiera; una preghiera che ricade sulla Chiesa per<br />
tenerla sveglia in attesa dello sposo e per tenere in piedi il mondo.<br />
La comunità diventa luogo della benedizione ascendente.<br />
Strutturalmente tutto nel Cammino avviene in un clima liturgico:<br />
nella celebrazione dell’eucaristia al sabato; nella celebrazione della<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
Il cammino<br />
Neocatecumenale<br />
alla luce del<br />
Concilio Vaticano<br />
69-122<br />
spiritualità<br />
83
pastorale e<br />
spiritualità<br />
MAURIZIO BUIONI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
84<br />
parola il mercoledì sera; nelle preparazioni domestiche; alla domenica<br />
nella celebrazione familiare delle lodi. In particolare nelle piccole<br />
e grandi convivenze o in qualsiasi riunione dove una o più<br />
comunità vengono riunite: tutto è sempre preceduto dall’invocazione<br />
allo Spirito, cui seguono il canto delle lodi o del vespro, la catechesi,<br />
le notizie, gli avvisi, le preghiere spontanee, l’abbraccio di<br />
pace e la benedizione finale del presbitero. Nulla si fa al di fuori di<br />
una celebrazione liturgica: in essa si discutono i problemi, si fa la<br />
catechesi, si sentono le esperienze dei fratelli, si danno direttive, si<br />
raccolgono aiuti per le diverse necessità.<br />
Liturgia, carità e catechesi, i pilastri su cui si regge la Chiesa, si<br />
fondono così insieme, corrispondendo al tripode del Cammino:<br />
parola, eucaristia e vita di comunità. Catechesi e carità trovano la<br />
loro espressione in un contesto liturgico perché solo lo Spirito apre<br />
le orecchie e solo lo Spirito comunica la forza del perdono reciproco<br />
e solo lui permette di aiutare chi si trova nel bisogno senza condizionarsi<br />
reciprocamente. La carità non si fa mai direttamente da<br />
fratello a fratello, ma passa tramite la comunità perché vi sia libertà<br />
e onore per tutti, davanti al Signore; come nei primi tempi della<br />
chiesa, quando i cristiani si aiutavano per mezzo delle mani del<br />
vescovo, davanti al quale al termine della liturgia i più facoltosi<br />
deponevano i loro beni. La celebrazione liturgica si caratterizza in<br />
modo particolare in occasione delle tappe in preparazione della rinnovazione<br />
delle promesse battesimali: in ognuna di esse attraverso<br />
l’Invocazione dello Spirito, l’imposizione delle mani e gli esorcismi,<br />
il fratello rivive la grazia del battesimo già ricevuta; un’acqua<br />
la cui rivivificazione totale si compirà nella veglia pasquale di fine<br />
Cammino, rinnovando le promesse battesimali. Si può comprendere,<br />
quindi, come la veglia pasquale sia al centro del Cammino, perché<br />
ne conclude il percorso e insieme ne visibilizza lo scopo: la<br />
comunità offerta come corpo alla Chiesa, per continuare nel mondo<br />
la redenzione di Cristo.<br />
d) Conversione. - Anche qui la sfida è molto importante; mai dare<br />
per scontata la propria conversione; per nessuno. Anche se a una<br />
certa tappa del Cammino alcuni peccati sono difficilmente concepibili,<br />
si può sempre contristare lo Spirito. Ogni giorno si è invitati alla<br />
conversione, ricordando che dentro al nostro corpo rimangono come<br />
sette bocche che, se non ci possono uccidere, ci possono mordere,<br />
lasciando delle ferite che solo la grazia di Dio, la connessione
sacramentale può curare. Anche la precarietà spirituale non finisce<br />
mai. Dice Kiko: «Mai nessun miracolo che Dio fa con noi ci condiziona,<br />
ci aliena, ci impedisce di essere liberi. È tutto il contrario.<br />
Ogni volta siamo più liberi: questa è una educazione alla libertà, alla<br />
totale libertà. Ogni amore umano condiziona; non così l’amore di<br />
Dio; ogni giorno siamo più liberi, ogni giorno ci si può giocare tutta<br />
la fede per un nulla». Da qui l’appello alla vigilanza quotidiana: alla<br />
lettura (scrutatio) delle Scritture, per incontrarsi quotidianamente<br />
con Cristo e ricevere il suo Spirito; all’uso delle tre armi: preghiera,<br />
digiuno ed elemosina.<br />
Dopo questa prima analisi addentriamoci nel testo degli Statuti<br />
definitivamente approvati.<br />
Una data storica:<br />
13 giugno 2008<br />
La natura del<br />
Cammino neocatecumenale<br />
è<br />
descritta nell’articolo 1<br />
dello Statuto approvato:<br />
§ 1. La natura del Cammino Neocatecumenale viene definita da S.S.<br />
Giovanni Paolo II quando scrive: «Riconosco il Cammino<br />
Neocatecumenale come un itinerario di formazione cattolica, valida<br />
per la società e per i tempi odierni».<br />
§ 2. Il Cammino Neocatecumenale è al servizio del Vescovo come<br />
una delle modalità di attuazione diocesana dell’iniziazione cristiana<br />
e dell’educazione permanente nella fede.<br />
§ 3. Il Cammino Neocatecumenale, dotato di personalità giuridica<br />
pubblica 17 , consta di un insieme di beni spirituali 18 :<br />
I. il “Neocatecumenato”, o catecumenato post-battesimale, secondo<br />
la modalità di cui al Titolo II;<br />
II. l’educazione permanente della fede, secondo la modalità di cui<br />
al Titolo III;<br />
III.il catecumenato, secondo la modalità di cui al Titolo IV;<br />
IV. il servizio della catechesi, di cui al Titolo V, svolto secondo le<br />
modalità e dalle persone ivi indicate.<br />
Con questo primo articolo dello Statuto, la Chiesa conferma<br />
definitivamente il Cammino neocatecumenale come un itinerario di<br />
17 Statuto del Cammino Neocatecumenale, Roma 11 maggio 2008.<br />
18 Cf. Can. 115 § 3: fondazione autonoma di beni spirituali.<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
Il cammino<br />
Neocatecumenale<br />
alla luce del<br />
Concilio Vaticano<br />
69-122<br />
spiritualità<br />
85
pastorale e<br />
spiritualità<br />
MAURIZIO BUIONI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
86<br />
formazione cattolica valido per la società e per i tempi odierni.<br />
È quanto Giovanni Paolo II aveva già scritto nel 1990:<br />
Ogni qualvolta lo Spirito Santo fa germinare nella Chiesa impulsi di<br />
una maggiore fedeltà al Vangelo, fioriscono nuovi carismi che<br />
manifestano tali realtà e nuove istituzioni che le mettono in pratica.<br />
È stato così dopo il Concilio di Trento e dopo il Concilio Vaticano<br />
II. Tra le realtà generate dallo Spirito ai nostri giorni figurano le<br />
Comunità Neocatecumenali, iniziate dal Signor K. Argüello e dalla<br />
Signora C. Hernández (Madrid, Spagna), la cui efficacia per il rinnovamento<br />
della vita cristiana veniva salutata dal mio predecessore<br />
Paolo VI come frutto del Concilio 19 .<br />
Oltre al riconoscimento dell’origine divina del Cammino<br />
Neocatecumenale per i nostri tempi, nello Statuto definitivo la<br />
Chiesa riconosce una novità rispetto allo Statuto ad experimentum<br />
del 29 Giugno 2002: Il Cammino Neocatecumenale è dotato di personalità<br />
giuridica pubblica, che getta luce nuova sull’insieme di beni<br />
spirituali, propri del Cammino. Secondo il Codice di Diritto<br />
Canonico:<br />
Can. 116 - § 1. Le persone giuridiche pubbliche sono insiemi di persone<br />
o di cose, che vengono costituite dalla competente autorità<br />
ecclesiastica perché, entro i fini ad esse prestabiliti, a nome della<br />
Chiesa compiano, a norma delle disposizioni del diritto, il proprio<br />
compito, loro affidato in vista del bene pubblico; tutte le altre persone<br />
giuridiche sono private.<br />
§ 2. Le persone giuridiche pubbliche vengono dotate di tale personalità<br />
sia per il diritto stesso sia per speciale decreto dell’autorità<br />
competente che la concede espressamente.<br />
Juan Ignacio Arrieta, Segretario del Pontificio Consiglio per i<br />
Testi Legislativi, in alcune Annotazioni canoniche riguardo al<br />
Cammino dotato di personalità giuridica pubblica, commenta:<br />
A differenza del testo del 2002, gli Statuti ora approvati affermano<br />
la personalità giuridica pubblica del Cammino Neocatecumenale<br />
(art 1 § 3), erezione che avvenne per iniziativa del Pontificio<br />
Consiglio per i Laici, con Decreto del 28 ottobre del 2004. Il punto<br />
19 GIOVANNI PAOLO II, Lettera Ogniqualvolta, a Mons. P. J. Cordes, incaricato<br />
ad personam per l’apostolato delle Comunità Neocatecumenali.
è di particolare rilevanza perché ci porta alla vera novità che, qua e<br />
là, emerge dai nuovi Statuti. Quale rilevanza pratica può avere adesso<br />
l’erezione della personalità giuridica pubblica? A mio modo di<br />
vedere, la maggiore conseguenza di questa personalità pubblica,<br />
applicata all’itinerario di formazione neocatecumenale, riguarda la<br />
particolare autorevolezza ecclesiale con la quale, sotto la direzione<br />
dei Vescovi diocesani, s’impartisce finora il Cammino, e nel particolare<br />
impegno che, di conseguenza, si assume perché esso sia proposto<br />
– come risultava prima, ma adesso con rinnovato impegno<br />
giuridico – per mezzo di persone particolarmente selezionate e<br />
appositamente formate.<br />
Riguardo al Cammino che consta di beni spirituali, osserva:<br />
Ciò che in questo caso riceve personalità giuridica pubblica nella<br />
Chiesa è propriamente l’itinerario di formazione cattolica, cioè<br />
il metodo di catecumenato post-battesimale che gli Statuti descrivono…<br />
Si può definire il Cammino come una fondazione di beni<br />
spirituali 20 .<br />
I beni spirituali di cui consta il Cammino Neocatecumenale,<br />
come abbiamo visto sopra, sono: I. il “Neocatecumenato”, o catecumenato<br />
post-battesimale. II. l’educazione permanente della fede. III.<br />
il catecumenato (per pagani) IV. il servizio della catechesi.<br />
Annuncio e nascita<br />
della comunità nelle<br />
Diocesi e nelle parrocchie<br />
L’attuazione del<br />
Cammino,<br />
secondo l’Art. 2,<br />
si attua nelle Diocesi:<br />
sotto la giurisdizione, la direzione del Vescovo diocesano e con l’assistenza,<br />
la guida dell’Équipe Responsabile internazionale del<br />
Cammino, o dell’Équipe responsabile delegata, di cui all’art. 3, 7º;<br />
secondo «le linee proposte dagli iniziatori», contenute nel presente<br />
Statuto e negli Orientamenti alle Équipes di Catechisti.<br />
20 Codice di Diritto Canonico, Can. 115§ 3. L’insieme di cose, ossia la fondazione<br />
autonoma, consta di beni o di cose, sia spirituali sia materiali, e lo dirigono,<br />
a norma del diritto e degli statuti, sia una o più persone fisiche sia un collegio.<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
Il cammino<br />
Neocatecumenale<br />
alla luce del<br />
Concilio Vaticano<br />
69-122<br />
spiritualità<br />
87
pastorale e<br />
spiritualità<br />
MAURIZIO BUIONI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
88<br />
Nella nota a fondo pagina si specifica: «Con le parole direzione<br />
e guida si indicano due funzioni distinte: con il termine direzione si<br />
intende la giurisdizione propria dei ministri ordinati; con il termine<br />
guida si intende la conoscenza tecnica del Cammino secondo le<br />
linee proposte dagli iniziatori» 21 .<br />
Abbiamo qui le due componenti essenziali perché il Cammino<br />
neocatecumenale possa nascere e crescere in una Diocesi: il<br />
Vescovo, che direttamente e attraverso il Parroco accoglie il<br />
Cammino Neocatecumenale e ne garantisce l’ecclesialità e l’autenticità,<br />
e gli Iniziatori, o i catechisti da loro delegati, che garantiscono<br />
che il Cammino si svolga secondo le linee degli iniziatori.<br />
All’interno della Diocesi il Neocatecumenato si attua di norma<br />
nella Parrocchia.<br />
Art. 6 § 1. Il Neocatecumenato, in quanto itinerario di riscoperta<br />
dell’iniziazione cristiana, è attuato di norma nella parrocchia,<br />
«ambito ordinario dove si nasce e si cresce nella fede», luogo privilegiato<br />
in cui la Chiesa, madre e maestra, genera nel fonte battesimale<br />
i figli di Dio e li “gesta” alla vita nuova.<br />
§ 2. Poiché la pastorale di iniziazione cristiana è vitale per la parrocchia,<br />
la realizzazione del Cammino Neocatecumenale va coordinata<br />
con la funzione propria che ha il Parroco in ciascuna comunità<br />
parrocchiale (cfr. can. 519 CIC), esercitando, anche con la collaborazione<br />
di altri presbiteri, la cura pastorale di coloro che lo percorrono.<br />
§ 3. Il Cammino Neocatecumenale mirerà a promuovere nei suoi<br />
destinatari un maturo senso di appartenenza alla parrocchia e a<br />
suscitare rapporti di profonda comunione e collaborazione con tutti<br />
i fedeli e con le altre componenti della comunità parrocchiale.<br />
Tra i frutti dell’itinerario neocatecumenale, descrivendo<br />
l’Educazione permanente della fede come una via di rinnovamento<br />
nella parrocchia al Titolo III, lo Statuto dice:<br />
Art. 23 § 1. In questo modo il Cammino Neocatecumenale contribuisce<br />
al rinnovamento parrocchiale auspicato dal Magistero della<br />
Chiesa di promuovere «nuovi metodi e nuove strutture», che evitino<br />
l’anonimato e la massificazione, e di considerare «la parrocchia<br />
21 Dal testo dello Statuto alla nota n. 8.
come comunità di comunità», che «decentrano e articolano la<br />
comunità parrocchiale».<br />
All’interno della parrocchia il Neocatecumenato è vissuto in piccola<br />
comunità:<br />
Art. 7§ 1. All’interno della parrocchia, il Neocatecumenato è vissuto<br />
in piccola comunità – denominata comunità neocatecumenale –,<br />
dato che la forma completa o comune dell’iniziazione cristiana<br />
degli adulti è quella comunitaria.<br />
§ 2. Modello della comunità neocatecumenale è la Sacra Famiglia<br />
di Nazaret, luogo storico dove il Verbo di Dio, fatto Uomo, si fa<br />
adulto crescendo «in sapienza, età e grazia», stando sottomesso a<br />
Giuseppe e Maria. Nella comunità i neocatecumeni divengono adulti<br />
nella fede, crescendo in umiltà, semplicità e lode, sottomessi alla<br />
Chiesa.<br />
Nella nota a piè di pagina dello Statuto riguardo alla piccola<br />
comunità si specifica: «È importante constatare come Giovanni<br />
Paolo II, in <strong>Christi</strong>fideles laici, n. 61, pone la convenienza delle piccole<br />
comunità ecclesiali nel contesto delle parrocchie e non come un<br />
movimento parallelo che assorbe i suoi membri migliori:<br />
“All’interno poi di talune parrocchie… le piccole comunità ecclesiali<br />
presenti possono essere di notevole aiuto nella formazione dei cristiani,<br />
potendo rendere più capillari e incisive la coscienza e l’esperienza<br />
della comunione e della missione ecclesiale».<br />
Le catechesi del Cammino hanno una loro peculiarità soprattutto<br />
nel taglio esistenziale che con evidenza manifestano; se il loro contenuto<br />
è biblico e teologico, la natura e il metodo privilegiano quello<br />
vitale, senza per questo sminuire il dato dottrinale. Siamo alla presenza<br />
non di un corso biblico né di un insegnamento astratto, ma di<br />
un’iniziazione mistagogica al Dio della storia della salvezza del<br />
quale si va scoprendo ogni giorno la tenerezza e l’amore nella vicenda<br />
stessa dell’esistenza. A tal riguardo lo Statuto ricorda:<br />
Art. 9. Il Neocatecumenato comincia nella parrocchia, su invito del<br />
Parroco, con delle catechesi kerigmatiche, chiamate catechesi iniziali,<br />
contenute negli Orientamenti alle Èquipes di Catechisti. Al<br />
fine di sperimentare il Tripode: Parola, Liturgia, Comunità, su cui si<br />
basa la vita cristiana, le catechesi iniziali sono articolate in tre parti:<br />
1. L’annuncio del kerigma… chiama alla conversione e alla fede,<br />
invita a riconoscersi peccatori, ad accogliere il perdono e l’amore<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
Il cammino<br />
Neocatecumenale<br />
alla luce del<br />
Concilio Vaticano<br />
69-122<br />
spiritualità<br />
89
pastorale e<br />
spiritualità<br />
MAURIZIO BUIONI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
90<br />
gratuito di Dio e a mettersi in Cammino verso la propria trasformazione<br />
in Cristo, per la potenza dello Spirito. La conversione è sigillata<br />
dalla celebrazione della Penitenza. Questo sacramento, celebrato<br />
periodicamente, sosterrà il Cammino di conversione dei singoli e<br />
della comunità.<br />
2. Il kerigma preparato da Dio attraverso la storia della salvezza<br />
(Abramo, Esodo, ecc.): si danno le chiavi ermeneutiche necessarie<br />
per l’ascolto e la comprensione della Sacra Scrittura: vedere in<br />
Gesù Cristo il compimento delle Scritture e mettere i fatti della propria<br />
storia sotto la luce della Parola.<br />
Quest’iniziazione alla Scrittura viene sigillata in una celebrazione<br />
della Parola, in cui i partecipanti ricevono la Bibbia dalle mani del<br />
Vescovo, garante della sua autentica interpretazione, come segno<br />
che la madre Chiesa d’ora innanzi lungo il Cammino li nutrirà settimanalmente<br />
a questa mensa, fonte viva della catechesi.<br />
3. Il kerigma nei sacramenti e nella koinonia: le catechesi culminano<br />
nella convivenza con la celebrazione dell’Eucaristia. Detta celebrazione,<br />
preparata da opportune catechesi, aiuta a riscoprire lo<br />
splendore pasquale messo in risalto dal Concilio Vaticano II e a sperimentare<br />
la comunione tra i fratelli. Infatti «non è possibile che si<br />
formi una comunità cristiana se non avendo come radice e come<br />
cardine la celebrazione della sacra Eucaristia, dalla quale deve quindi<br />
prendere le mosse qualsiasi educazione tendente a formare lo spirito<br />
di comunità». La celebrazione dell’Eucaristia accompagnerà la<br />
comunità durante tutto l’itinerario.<br />
Elementi<br />
Fondamentali<br />
Art. 8 § 2. Le catechesi<br />
iniziali e<br />
l’itinerario neocatecumenale<br />
si basano sui<br />
tre elementi fondamentali<br />
(“tripode”) della vita cri-<br />
stiana, messi in rilievo dal Concilio Vaticano II: Parola di Dio,<br />
Liturgia e Comunità.<br />
Questo tripode della vita cristiana, messo in rilievo dal Concilio<br />
Vaticano II, corrisponde alle tre Costituzioni del Concilio: “Dei<br />
Verbum”: Parola di Dio, “Sacrosanctum Concilium”: Liturgia,<br />
“Lumen Gentium”: Comunità.<br />
Per quanto riguarda la Costituzione pastorale “Gaudium et Spes”<br />
il suo contenuto dottrinale è sotteso ed esplicitato fin dalle Catechesi<br />
iniziali in tutto l’itinerario come pure nella formazione permanente,<br />
soprattutto per quanto riguarda l’antropologia: persona, famiglia,
lavoro e attività umana, società: sempre avendo come riferimento<br />
primo ed ultimo la persona di Gesù Cristo.<br />
L’aspetto più originale<br />
del Cammino<br />
è di essere<br />
un itinerario celebrativo<br />
della Parola di Dio, il<br />
suo primo e fondamentale criterio ermeneutico della Parola di Dio è<br />
la dinamica pasquale che esso privilegia, sia nella celebrazione settimanale<br />
della Parola di Dio, che in quella dell’Eucaristia domenicale,<br />
che nel giorno di “convivenza” mensile. La Parola di Dio non è interpretata<br />
in base ad una spiritualità particolare, ma piuttosto - come<br />
avvenne con il popolo d’Israele e, in seguito, con le prime comunità<br />
cristiane - si tratta di imparare a mettere i passi della propria vita nelle<br />
orme di Cristo: “Lampada ai miei passi è la tua Parola, luce sul mio<br />
cammino” (Sal 119,105), per portare a compimento in noi il mistero<br />
pasquale22 La Parola di Dio<br />
.<br />
Art. 11 § 1. Ciascuna comunità neocatecumenale settimanalmente<br />
ha una celebrazione della Parola di Dio, di norma con quattro letture,<br />
secondo i temi indicati dagli Orientamenti alle Équipes di<br />
Catechisti per ogni tappa.<br />
§ 2. Nella celebrazione della Parola di Dio, prima dell’omelia, il<br />
presbitero invita chi lo desidera tra i presenti ad esprimere brevemente<br />
ciò che la Parola proclamata ha detto alla sua vita.<br />
Nell’omelia, che ha un posto privilegiato nell’istruzione del<br />
Neocatecumenato, il presbitero prolunga la proclamazione della<br />
Parola, interpretandola secondo il Magistero e attualizzandola nell’oggi<br />
del Cammino di fede dei neocatecumeni.<br />
§ 4. Per approfondire la Scrittura «con l’intelligenza ed il cuore della<br />
Chiesa», i neocatecumeni si avvalgono soprattutto della lettura degli<br />
scritti dei Padri, dei documenti del Magistero, in particolare del<br />
Catechismo della Chiesa Cattolica, e di opere di autori spirituali.<br />
La gradualità, propria dell’iniziazione cristiana, diviene così una<br />
vera e propria iniziazione alla Scrittura. Il Cammino, nelle sue varie<br />
tappe verso la rinnovazione delle promesse battesimali, introduce<br />
22 Cf. E. PASOTTI, L’itinerario del Cammino neocatecumenale. La Parola di<br />
Dio celebrata, in Rivista Liturgica, 6 (1997) 853-866.<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
Il cammino<br />
Neocatecumenale<br />
alla luce del<br />
Concilio Vaticano<br />
69-122<br />
spiritualità<br />
91
pastorale e<br />
spiritualità<br />
MAURIZIO BUIONI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
92<br />
progressivamente ed esistenzialmente al linguaggio e ai diversi<br />
sensi della Scrittura. E in questo modo si giunge a quella affinità<br />
vissuta con ciò di cui parla il testo, condizione esigita dalla<br />
Pontificia Commissione Biblica per ogni conoscenza e attualizzazione<br />
propria del testo biblico. Sempre in un clima celebrativo.<br />
Sempre in un itinerario ermeneutico che parte dai cosiddetti libri<br />
storici dell’AT, per passare attraverso i profeti, gli Atti degli<br />
Apostoli, le Lettere, l’Apocalisse e i Vangeli. Con un ritmo di 4 letture,<br />
secondo lo schema già in uso presso la Chiesa siriaca 23 .<br />
Nella prima fase dell’iniziazione neocatecumenale: riscoperta del<br />
precatecumenato.<br />
Art. 19 § 1. Nella prima tappa, che va dalle catechesi iniziali fino al<br />
primo scrutinio, e che dura circa due anni, i neocatecumeni imparano<br />
il linguaggio biblico, celebrando settimanalmente la Parola di<br />
Dio, con temi semplici che percorrono tutta la Scrittura, come:<br />
acqua, roccia, agnello, ecc.<br />
§ 2. Nella seconda tappa, di analoga durata, i neocatecumeni celebrano<br />
le grandi tappe della storia della salvezza: Abramo, Esodo,<br />
Deserto, Terra promessa, ecc., e viene dato loro un tempo perché<br />
provino a se stessi la sincerità dell’intenzione di seguire Gesù<br />
Cristo, alla luce della sua Parola: «Non potete servire a Dio e al<br />
denaro» (Mt 6,24).<br />
Nella celebrazione conclusiva del secondo scrutinio, rinnovano<br />
davanti alla Chiesa la rinuncia al demonio e manifestano la volontà<br />
di servire solo Dio. In seguito studiano e celebrano le principali<br />
figure bibliche: Adamo, Eva, Caino, Abele, Noè, ecc., alla luce di<br />
Cristo.<br />
Nella seconda fase dell’iniziazione neocatecumenale: riscoperta<br />
del catecumenato.<br />
Art. 20. I neocatecumeni, scrutando i salmi in piccoli gruppi, sono iniziati<br />
alla pratica assidua della “lectio divina” o “scrutatio scripturæ”,<br />
«nella quale la Parola di Dio è letta e meditata per trasformarsi in preghiera».<br />
Infatti, l’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo 24 .<br />
23 Ibidem.<br />
24 Cf. S. GIROLAMO, Comm. in Is., Prol; cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II,<br />
Cost. dogm. Dei Verbum, 25; Catechismo della Chiesa Cattolica, 133.
Nella terza fase: riscoperta dell’elezione.<br />
I Neocatecumeni studiano e celebrano i singoli brani del<br />
Sermone della Montagna. Questa tappa è particolarmente intensa<br />
per catechesi profonde e impegnative per una coerenza di vita, dove<br />
le celebrazioni della Parola e le scrutatio illuminano e guidano i<br />
passi personali e comunitari durante la formazione permanente alla<br />
fede. I membri della comunità sono invitati ad esprimere il loro<br />
sacerdozio comune con un culto spirituale, a vivere una spiritualità<br />
del ringraziamento.<br />
Come sappiamo<br />
Carmen venne a<br />
contatto con il<br />
rinnovamento del<br />
Concilio, sia per lo studio<br />
della teologia a Valencia, sia più tardi a Barcellona per il contatto<br />
con Padre Farnes25 La Liturgia<br />
, discepolo di Dom Botte, uno dei padri del rinnovamento<br />
liturgico. Così fin dall’inizio il Cammino poté mettere al<br />
centro il Triduo e la Veglia Pasquale e la riscoperta dell’Eucaristia<br />
con la ricchezza dei segni promossa dalla riforma liturgica. Infatti:<br />
La liturgia è il vero luogo della Parola di Dio, dove la storia dell’uomo<br />
entra nel progetto di Dio, si fa storia della salvezza. Ogni liturgia<br />
celebra la Pasqua del Signore, questo passaggio che libera e<br />
salva. Ogni liturgia celebra la “trasfigurazione” dell’uomo, la sua<br />
“cristificazione”: Cristo, “typos”, “icona” del figlio, è questa forma<br />
vuota (cf Fil 2,6-8) dove ogni uomo - sciolto come cera dall’esperienza<br />
della propria debolezza - può essere versato perché si riproduca<br />
in lui l’immagine del figlio, perché possa essere “secondo<br />
25 Padre Farnes Sherer, non solamente ha trasmesso a Carmen, e attraverso<br />
di lei a Kiko, e quindi al Cammino, il rinnovamento liturgico del Concilio,<br />
ma ha accompagnato di persona lo sviluppo del Cammino offrendo la sua specifica<br />
consulenza soprattutto nel dialogo con la santa Sede. Da anni, nonostante<br />
le difficoltà della età, si sposta in vari seminari Redemptoris Mater per trasmettere<br />
ai seminaristi e ai presbiteri il senso vivo dello spirito della liturgia nella<br />
Tradizione della Chiesa e nel rinnovamento del concilio vaticano II.<br />
Recentemente ha compendiato lo spirito del rinnovamento liturgico del Concilio<br />
Vaticano II, nel libro: P. FARNES SHERER, Vivir la eucaristia que nos mandò celebrar<br />
el Señor, Ed. STJ, Barcelona 2007.<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
Il cammino<br />
Neocatecumenale<br />
alla luce del<br />
Concilio Vaticano<br />
69-122<br />
spiritualità<br />
93
pastorale e<br />
spiritualità<br />
MAURIZIO BUIONI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
94<br />
l’icona”, Cristo. La Parola annuncia quest’opera che la liturgia porta<br />
gradualmente a compimento nella vita del cristiano. È da quest’opera<br />
che nasce l’uomo nuovo, il cristiano, l’uomo della comunione,<br />
l’uomo creato da Dio in Cristo Gesù, come dice S. Paolo, per le<br />
opere buone che Dio ha predisposto perché in esse camminasse (cf<br />
Ef 2,10, il testo greco) 26 .<br />
L’efficacia della Liturgia dipende anche dalla fede. Mentre il<br />
Concilio di Trento aveva messo in luce, nella controversia con i<br />
protestanti l’ex opere operato, il Vaticano II ha messo in luce l’ex<br />
opere operantis. Questo tradotto concretamente vuol dire che i<br />
Sacramenti, pur essendo in sé efficaci per trasmetterci lo Spirito<br />
Santo, la vita stessa di Cristo, non possono però comunicarcela se<br />
non trovano in noi la corrispondenza della fede, che lo stesso<br />
Spirito suscita in noi ma che non si può dare senza il nostro libero<br />
assenso:<br />
Ora qual è la chiave d’ingresso nel catecumenato? È la famosa<br />
domanda, con cui ancora oggi incomincia il grande e consueto rito<br />
battesimale: «Che cosa vuoi tu, che vieni alla soglia della Chiesa di<br />
Dio?» chiede il ministro del battesimo al neo-battezzando.<br />
Risposta: «Chiedo la fede». E il ministro: «Che cosa ti può dare la<br />
fede?»; risposta: «La vita eterna». Nulla di più semplice, e nulla di<br />
più importante di questo fondamentale dialogo: la fede è la chiave<br />
d’ingresso; è la condizione iniziale, indispensabile, per accedere<br />
alla salvezza cristiana. Essere battezzati cioè essere cristiani, esige<br />
la fede, sia soggettiva, risposta personale piena e gioiosa all’Amore<br />
divino, rivelatosi salvifico in Cristo, sorgente di tutta la nostra vita<br />
nuova; sia oggettiva, adesione a una rivelata Parola di Dio, enucleata<br />
in determinate verità, che il carisma docente della Chiesa propone<br />
da credere, senza riserve e senza equivoche interpretazioni 27 .<br />
Capita nella Chiesa quanto accadeva nel ministero pubblico di<br />
Gesù: la potenza che da lui emanava agiva nella misura della fede di<br />
chi lo avvicinava. Ora la stessa potenza che risanava, liberava dai<br />
demoni, risuscitava i morti, è presente nella Chiesa e agisce soprattutto<br />
nei Sacramenti in forza della Parola e dei segni sacramentali,<br />
ma può attuarsi in noi solo nella misura della nostra fede.<br />
26 E. PASOTTI, Op. cit.<br />
27 PAOLO VI, Udienza del Mercoledì, 24 Aprile 1974.
Grazie alla fede che nasce o che si sviluppa poi attraverso un percorso<br />
progressivo e graduale, i Sacramenti vanno comunicando la<br />
forza della vita di Gesù Cristo che poco a poco va liberando dalle<br />
schiavitù, donando discernimento e comunicando la vita stessa di<br />
Cristo: lo Spirito Santo. Possiamo dire che più la fede cresce e più<br />
la partecipazione alla liturgia è viva e attiva.<br />
Ecco perché dall’inizio il Cammino ha vissuto con forza e potenza<br />
la celebrazione del Mistero della morte e risurrezione nel triduo<br />
Pasquale, soprattutto nella Veglia celebrata con tutta la ricchezza dei<br />
segni voluta dal Concilio: rito della luce, proclamazione della Parola<br />
nel quadro della Storia della Salvezza, battesimo dei bambini e rinnovo<br />
delle promesse battesimali, e canto della Eucaristia con la<br />
comunione al corpo e al sangue di Cristo. In questo modo la Liturgia<br />
ha cominciato ad essere la fonte della nostra vita cristiana.<br />
Art. 12 § 1 Cardine e fonte della vita cristiana è il mistero pasquale,<br />
vissuto e celebrato in modo eminente nel Santo Triduo, il cui fulgore<br />
irradia di luce l’intero anno liturgico. Esso costituisce pertanto<br />
il fulcro del Neocatecumenato, in quanto riscoperta dell’iniziazione<br />
cristiana.<br />
§ 2. «La veglia pasquale, centro della liturgia cristiana, e la sua spiritualità<br />
battesimale, sono ispirazione per tutta la catechesi». È per<br />
questo motivo che, durante l’itinerario, i neocatecumeni sono iniziati<br />
gradualmente ad una più perfetta partecipazione a tutto ciò che<br />
la santa notte significa, celebra e realizza.<br />
§ 3. In questo modo il Neocatecumenato stimolerà la parrocchia ad<br />
una celebrazione più ricca della veglia pasquale.<br />
Il Cammino Neocatecumenale fin dagli inizi nelle baracche di<br />
Palomeras (Madrid), grazie a Carmen, che attraverso Padre Farnes<br />
ha comunicato il rinnovamento del Concilio, e grazie a Kiko, che<br />
ha saputo plasmare l’assemblea e mettere in risalto i segni sacramentali,<br />
ha dato grande risalto alla celebrazione del Triduo<br />
Pasquale e al recupero della Veglia Pasquale con tutta la ricchezza<br />
di segni e di Parola durante tutta la notte. È senz’altro merito del<br />
Cammino aver contribuito al recupero della Veglia Pasquale in<br />
molte Parrocchie.<br />
Nella nota a questo Articolo si legge: «Anche oggi, tanti neocatecumeni<br />
provengono dal mondo e da esperienze fuori della Chiesa ed<br />
hanno bisogno di una graduale introduzione ai sacramenti: una propedeutica<br />
sacramentale che Giovanni Paolo II ha definito «laborato-<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
Il cammino<br />
Neocatecumenale<br />
alla luce del<br />
Concilio Vaticano<br />
69-122<br />
spiritualità<br />
95
pastorale e<br />
spiritualità<br />
MAURIZIO BUIONI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
96<br />
rio sacramentale», nel quale i battezzati, ma non iniziati 28 , possono<br />
gradualmente scoprire il fulgore del mistero pasquale.<br />
Per questo affinché il Neocatecumenato possa continuare a servire<br />
da stimolo nelle Parrocchie per una celebrazione più ricca della<br />
veglia pasquale si chiede ai pastori che, specialmente durante i primi<br />
anni del Neocatecumenato, permettano alle comunità più giovani di<br />
poter vivere e sperimentare in tutta la sua pienezza la veglia:<br />
Art. 12 § 1. Cardine e fonte della vita cristiana è il mistero pasquale,<br />
vissuto e celebrato in modo eminente nel Santo Triduo, il cui fulgore<br />
irradia di luce l’intero anno liturgico. Esso costituisce pertanto<br />
il fulcro del Neocatecumenato, in quanto riscoperta dell’iniziazione<br />
cristiana.<br />
§ 2. «La veglia pasquale, centro della liturgia cristiana, e la sua spiritualità<br />
battesimale, sono ispirazione per tutta la catechesi».44 È<br />
per questo motivo che, durante l’itinerario, i neocatecumeni sono<br />
iniziati gradualmente ad una più perfetta partecipazione a tutto ciò<br />
che la santa notte significa, celebra e realizza.<br />
§ 3. In questo modo il Neocatecumenato stimolerà la parrocchia ad<br />
una celebrazione più ricca della veglia pasquale.<br />
Assaporando man mano la Parola, calata nella concreta realtà e<br />
gustando l’Eucaristia, memoriale della passione, morte e risurrezione<br />
del Signore, i neocatecumeni scoprono come l’amore di Dio ha<br />
perdonato i loro peccati, li ha resi figli per l’eternità, dando loro una<br />
nuova natura, lo stesso spirito di Gesù costituto per l’umanità Buon<br />
Pastore, capace di dare la vita a chi è morto nel peccato:<br />
Art. 13 § 1. L’Eucaristia è essenziale al Neocatecumenato, in quanto<br />
catecumenato post-battesimale, vissuto in piccola comunità.<br />
L’Eucaristia infatti completa l’iniziazione cristiana.<br />
§ 2. I neocatecumeni celebrano l’Eucaristia domenicale nella piccola<br />
comunità, dopo i primi vespri della Domenica. Tale celebrazione<br />
ha luogo secondo le disposizioni del Vescovo diocesano. Le celebrazioni<br />
dell’Eucaristia delle comunità neocatecumenali al sabato<br />
sera fanno parte della pastorale liturgica domenicale della parrocchia<br />
e sono aperte anche ad altri fedeli.<br />
28 Cf. KAROL WOJTYLA, Affinché Cristo si serva di noi. Catecumenato del XX<br />
secolo: Znak, Cracovia, n. 34, 1952, pp. 402-413.
§ 3. Nella celebrazione dell’Eucaristia nelle piccole comunità si<br />
seguono i libri liturgici approvati del Rito Romano, fatta eccezione<br />
per le concessioni esplicite della Santa Sede. Per quanto concerne la<br />
distribuzione della Santa Comunione sotto le due specie, i neocatecumeni<br />
la ricevono in piedi, restando al proprio posto.<br />
Benedetto XVI nella Udienza alle Comunità Neocatecumenali<br />
del 12 gennaio 2006 ha confermato l’importanza della Eucaristia<br />
come via privilegiata e indispensabile per costruire comunità cristiane<br />
vive e perseveranti:<br />
L’importanza della liturgia e, in particolare, della Santa Messa nell’evangelizzazione<br />
è stata a più riprese posta in evidenza dai miei<br />
Predecessori, e la vostra lunga esperienza può bene confermare<br />
come la centralità del mistero di Cristo celebrato nei riti liturgici<br />
costituisce una via privilegiata e indispensabile per costruire comunità<br />
cristiane vive e perseveranti 29 .<br />
Lo Statuto, come scritto sopra, riconosce ufficialmente che questa<br />
celebrazione eucaristica fa parte della pastorale liturgica della<br />
Parrocchia assumendo che il Cammino che nasce in seno alla<br />
Parrocchia è in funzione del bene della parrocchia stessa. Si tratta<br />
dunque di una Messa parrocchiale a pieno titolo, il cui scopo è quello<br />
di sostenere e rafforzare un itinerario di iniziazione cristiana,<br />
attento soprattutto ai lontani che tornano alla Chiesa.<br />
Art. 17 § 1. «La<br />
catechesi rende il<br />
Comunità e Missione<br />
cristiano idoneo a<br />
vivere in comunità e a partecipare<br />
attivamente alla<br />
vita e alla missione della<br />
Chiesa». I neocatecumeni sono iniziati a «essere presenti da cristiani<br />
nella società» e «a prestare la loro cooperazione nei differenti servizi<br />
ecclesiali, secondo la vocazione di ciascuno».<br />
§ 2. I neocatecumeni collaborano «attivamente all’evangelizzazione<br />
e all’edificazione della Chiesa» innanzitutto essendo ciò che<br />
sono: il loro proposito di vivere in modo autentico la vocazione cri-<br />
29<br />
BENEDETTO XVI, Udienze alle Comunità Neocatecumenali, 12 gennaio<br />
2006.<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
Il cammino<br />
Neocatecumenale<br />
alla luce del<br />
Concilio Vaticano<br />
69-122<br />
spiritualità<br />
97
pastorale e<br />
spiritualità<br />
MAURIZIO BUIONI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
98<br />
stiana si traduce in una testimonianza efficace per gli altri, in uno<br />
stimolo alla riscoperta di valori cristiani che potrebbero altrimenti<br />
restare quasi nascosti.<br />
Dalla crescita nella fede nell’itinerario neocatecumenale molte le<br />
manifestazioni dello zelo missionario che ha contribuito a dare<br />
forma alla nuova evangelizzazione proclamata da Giovanni Paolo<br />
II: ricordiamo brevemente gli itineranti (coppie, giovani, ragazze,<br />
presbiteri e religiosi), le famiglie e sorelle in missione, i Seminari<br />
missionari diocesani Redemptoris Mater, e ultimamente le “missio<br />
ad gentes”, per non parlare delle missioni popolari, l’annuncio due<br />
a due per le strade, la partecipazione numerosa dei giovani alle<br />
Giornate mondiali della gioventù col Papa. Questo evidenzia come<br />
c’è bisogno di una fede accolta in profondo e ridonata ad altri, perché<br />
la Chiesa è per sua natura e vocazione itinerante verso l’uomo e<br />
non può mai cessare di intraprendere iniziative creative per edificare<br />
la civiltà dell’amore. Per questo la formazione in ordine alla fede<br />
è fondamentale, gli anni di cammino sono indispensabili, l’esperienza<br />
e la riscoperta dell’altro, che non è altro da te, ma con te nella<br />
stessa via verso il Signore, sono necessarie. Ecco la grazia della<br />
riscoperta battesimale quale inserimento vitale in Cristo morto e<br />
risorto in vista di una continua metanoia, che porta a donare la vita<br />
a Cristo.<br />
Dall’ascolto della Parola e dalla Celebrazione Eucaristica (e del<br />
sacramento della Riconciliazione) nasce e cresce la comunione con<br />
i fratelli e progressivamente verso tutti i fedeli e tutti gli uomini:<br />
Art. 15 § 3. La comunità aiuta i neocatecumeni a scoprire il loro<br />
bisogno di conversione e di maturazione nella fede: la diversità, i<br />
difetti, le debolezze mettono in evidenza l’incapacità di amare l’altro<br />
così com’è, distruggono i falsi ideali di comunità e fanno sperimentare<br />
che la comunione (koinonia) è opera dello Spirito Santo.<br />
Art. 16 § 1. Nella misura in cui i neocatecumeni crescono nella<br />
fede, cominciano a manifestarsi i segni della koinonia: il non giudicare,<br />
la non resistenza al malvagio, il perdono e l’amore al nemico.<br />
La koinonia si visibilizza anche nel soccorso ai bisognosi, nella sollecitudine<br />
per i malati, per i sofferenti e per gli anziani e nel sostegno,<br />
per quanto possibile, di coloro che sono in missione, secondo<br />
quanto indicato negli Orientamenti alle Équipes di Catechisti. I neocatecumeni<br />
vengono gradualmente formati a un sempre più profondo<br />
spirito di comunione e di aiuto reciproco”.<br />
§ 2. Il Neocatecumenato forma così progressivamente nella parroc-
chia un insieme di comunità che rendono visibili i segni dell’amore<br />
nella dimensione della croce e della perfetta unità, e in tal modo<br />
chiamano alla fede i lontani e preparano i non cristiani a ricevere<br />
l’annuncio del Vangelo.<br />
§ 3. Il Cammino Neocatecumenale è offerto quindi come strumento<br />
atto ad aiutare la parrocchia a compiere sempre più la missione<br />
ecclesiale di essere sale, luce e lievito del mondo, e a risplendere<br />
davanti agli uomini come Corpo visibile di Gesù Cristo risorto,<br />
sacramento universale di salvezza.<br />
L’itinerario neocatecumenale<br />
come educazione permanente<br />
alla fede<br />
Il segreto del<br />
Cammino è stata la<br />
riscoperta della iniziazione<br />
cristiana. Con<br />
sguardo retrospettivo<br />
dopo quaranta anni<br />
possiamo dire che il segreto del Cammino è stata la riscoperta della<br />
iniziazione cristiana come disse Giovanni Paolo II:<br />
Il Cammino del Battesimo riscoperto… Cammino dell’uomo<br />
nuovo. Fede radicale; “Questo Cammino, Cammino della fede,<br />
Cammino del Battesimo riscoperto, deve essere un Cammino dell’uomo<br />
nuovo. Noi, carissimi, viviamo in un periodo in cui si sente,<br />
si fa l’esperienza di un confronto radicale- e io lo dico, perché questa<br />
è anche la mia esperienza di tanti anni -, di un confronto radicale<br />
che si impone dappertutto. Non ve n’è un’unica edizione, ve ne<br />
sono diverse nel mondo; fede e antifede, Vangelo e antivangelo,<br />
Chiesa e anti-Chiesa, Dio e antidio. Ecco, noi viviamo questa esperienza<br />
storica, e più che nelle epoche precedenti. In questa nostra<br />
epoca abbiamo bisogno di riscoprire una fede radicale, radicalmente<br />
compresa, radicalmente vissuta e radicalmente realizzata. Noi<br />
abbiamo bisogno di una tale fede. lo spero che la vostra esperienza<br />
sia nata in tale prospettiva e possa guidare verso una sana radicalizzazione<br />
del nostro cristianesimo, della nostra fede, verso un autentico<br />
radicalismo evangelico 30 .<br />
30 GIOVANNI PAOLO II, Discorso alle comunità Neocatecumenali della<br />
Parrocchia dei Martiri Canadesi, Roma 2 Novembre 1980.<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
Il cammino<br />
Neocatecumenale<br />
alla luce del<br />
Concilio Vaticano<br />
69-122<br />
spiritualità<br />
99
pastorale e<br />
spiritualità<br />
MAURIZIO BUIONI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
100<br />
Sempre Giovanni Paolo II sottolineando la forza del catecumenato<br />
nella Chiesa primitiva ebbe a dire:<br />
II Battesimo è il sacramento degli inizi e del fondamento e sappiamo<br />
bene che un edificio cresce su quello che è il suo fondamento.<br />
Io vedo così la genesi del neocatecumenato, del suo<br />
Cammino: uno - non so se Kiko o altri - si è interrogato: da dove<br />
veniva la forza della Chiesa primitiva? e da dove viene la debolezza<br />
della Chiesa, molto più numerosa, di oggi? E io credo che<br />
abbia trovato la risposta nel catecumenato, in questo Cammino.<br />
Ecco è questo quanto io sento vivendo con voi alcuni momenti.<br />
Io vi auguro tutti questi frutti in questa parrocchia, che mi sembra<br />
basata sull’esperienza Neocatecumenale 31 .<br />
Questa riscoperta ci dà la misura della freschezza e della vitalità<br />
che c’è nella res (Parola) che divine Sacramento, meglio ancora,<br />
nella Parola che porta a celebrare e gustare il sacramento nella sua<br />
verità essenziale. Siamo alla presenza del segno fontale da cui non<br />
si può non partire per rigenerare il tessuto cristiano, che mette il luce<br />
la dynamis battesimale:<br />
Io mi domando dove sta il nucleo di questo processo che attraverso<br />
il Cammino neocatecumenale, attraverso diverse persone,<br />
attraverso diverse circostanze, produce, suscita, ispira vocazioni<br />
sacerdotali, alla vita consacrata, religiosa. Sono convinto che il<br />
punctum saliens, il punto di partenza di tutto questo è la scoperta<br />
della ricchezza, della profondità divina, sacramentale del<br />
Battesimo. Qui si capisce il senso della denominazione:<br />
Cammino neocatecumenale. C’era il catecumenato tradizionale<br />
nei primi secoli della Chiesa e c’è ancora nei Paesi di missione e<br />
fa tanto bene alla Chiesa. Voi siete stati battezzati nella vostra<br />
infanzia, forse nei primi giorni della vostra vita. II catecumenato<br />
deve venire dopo per la scoperta delle ricchezze del santo<br />
Battesimo, di queste ricchezze divine e anche umane, che sono<br />
tante. Sono ricchezze divine e umane insieme. Una di queste ricchezze<br />
è appunto che il Battesimo non è statico. Si potrebbe<br />
andare una volta e basta. Si va in un momento della vita, e poi<br />
basta. Si registra nei libri parrocchiali, e basta. Invece no, non è<br />
31 Ibidem, Discorso alle comunità Neocatecumenali della parrocchia di<br />
Santa Maria Goretti, 31 Gennaio 1988.
statico, è dinamico: provoca, appunto, un Cammino della vita<br />
cristiana 32 .<br />
Paolo VI dedicò al Cammino Neocatecumenale l’allocuzione<br />
dell’Udienza del mercoledì, 12 Gennaio 1977:<br />
II sacramento della rigenerazione cristiana deve ritornare ad<br />
essere ciò che era nella coscienza e nel costume delle prime<br />
generazioni del cristianesimo. Il Catecumenato: preparazione al<br />
Battesimo. Il Neocatecumenato “dopo il Battesimo”. Questo il<br />
segreto della vostra formula… un metodo di evangelizzazione<br />
graduale e intensivo che ricorda e rinnova in certo modo il catecumenato<br />
d’altri tempi. Chi è stato battezzato ha bisogno di capire,<br />
di ripensare, di apprezzare, di assecondare l’inestimabile fortuna<br />
del Sacramento ricevuto. per mezzo di una evangelizzazione<br />
graduale e intensiva. E noi siamo lieti di vedere che questo<br />
bisogno oggi è compreso dalle strutture ecclesiastiche istituzionali,<br />
le parrocchie, le Diocesi specialmente, e poi tutte le altre<br />
famiglie religiose; e sono fondamentali in questo campo strutturale,<br />
come ho detto, le parrocchie. Tanta gente si polarizza verso<br />
queste comunità neocatecumenali perché vede che lì c’è una sincerità,<br />
c’è una verità, c’è qualche cosa di vivo e di autentico: c’è<br />
Cristo che vive nel mondo. E questo avvenga con la Nostra apostolica<br />
benedizione.<br />
M. Dujarier, uno dei più grandi studiosi del Catecumenato nella<br />
Chiesa primitiva, afferma:<br />
Prima di educare la fede, bisogna farla innanzitutto nascere. È la<br />
finalità del primo periodo della iniziazione che è chiamato precatecumenato.<br />
Questo periodo è particolarmente importante e<br />
non dovrebbe essere omesso, perché è quello che, con l’aiuto<br />
dello Spirito, permette alla fede iniziale di germogliare in un<br />
principio di conversione... Solamente quando la fede è nata si<br />
può educare ed alimentare 33 .<br />
32 Ibidem, Discorso ai giovani del Cammino Neocatecumenale in preparazione<br />
alla Giornata Mondiale della Gioventù a Denver, Roma 28 Marzo 1993.<br />
33 M. DUJARIER, Iniciaciòn Cristiana de Adultos, Desclèe de Brower 1986<br />
(Ottimo testo di commento storico e pastorale dell’Ordo Initiationis <strong>Christi</strong>anae<br />
Adultorum). Del medesimo autore da segnalare: Breve storia del catecumenato,<br />
Elle Di Ci, Torino-Leumann 1984.<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
Il cammino<br />
Neocatecumenale<br />
alla luce del<br />
Concilio Vaticano<br />
69-122<br />
spiritualità<br />
101
pastorale e<br />
spiritualità<br />
MAURIZIO BUIONI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
102<br />
L’immagine della gestazione è la più diffusa perché si fonda sulla<br />
nozione tradizionale della Chiesa Sposa e Madre. La nascita di un<br />
bambino non è questione di un solo giorno. L’applicazione di questa<br />
immagine vitale all’iniziazione catecumenale può comprendersi<br />
molto facilmente, dato che il battesimo è presentato da Gesù come<br />
una nuova nascita. L’entrata nel catecumenato corrisponde al concepimento,<br />
quando la Parola di Dio è seminata nel cuore del convertito<br />
ed accolta da lui, è il principio della vita: la Chiesa concepisce un<br />
nuovo cristiano nel suo seno. Durante il tempo del catecumenato lo<br />
nutre coi suoi insegnamenti e con le sue azioni liturgiche, come un<br />
embrione che cresce, il catecumeno si prepara a poco a poco a venire<br />
al mondo. Il battesimo è la nascita del fedele che nasce alla vita<br />
di Dio.<br />
L’interesse di questa immagine consiste nel mostrare che l’iniziazione<br />
cristiana non è un’educazione di tipo scolare (dottrinale,<br />
nozionistica), ma una crescita vitale e che si realizza in seno a una<br />
comunità cristiana che deve svolgere il ruolo di ambiente vitale per<br />
la crescita 34 .<br />
Il Neocatecumenato è come l’apprendistato della vita della fede<br />
(catecumenato), una volta terminato con la solenne rinnovazione<br />
delle Promesse Battesimali viene l’esercizio della vita cristiana,<br />
esercizio quotidiano che termina solo con la morte, il “dies natalis”<br />
al Cielo. Come abbiamo ascoltato più volte nelle catechesi, la nostra<br />
fede deve essere purificata, come l’oro al crogiolo, attraverso tre<br />
passaggi che ci attendono: la malattia, la vecchiaia e la morte.<br />
Sarebbe assurdo aver intrapreso un Cammino per giungere a dare<br />
i segni dell’Amore e della Unità, come viene esposto nelle catechesi<br />
iniziali, e poi quando si è giunti dopo tanti anni ad una certa maturità<br />
di fede in cui si comincia a dare una vera e profonda comunione<br />
tra i fratelli, e a dare i segni dell’amore e della unità che attirano<br />
i pagani, queste comunità si dovessero sciogliere.<br />
È chiaro che in una società secolarizzata e pagana come la nostra<br />
vivere e perseverare nella fede di fronte ad un mondo ostile necessita<br />
del supporto costante della comunità per essere costantemente<br />
alimentati dalla Parola di Dio, dalla Eucaristia crescendo nell’amore<br />
a Dio e nella comunione reciproca.<br />
34 Cf. Ibidem, Iniciación cristiana..., pag 76-77.
Art. 22 § 1. La comunità Neocatecumenale, dopo aver compiuto<br />
l’itinerario di riscoperta dell’iniziazione cristiana, entra nel processo<br />
di educazione permanente della fede: perseverando nella<br />
celebrazione settimanale della Parola e dell’Eucaristia domenicale<br />
e nella comunione fraterna, attivamente inseriti nella pastorale<br />
della comunità parrocchiale, per dare i segni dell’amore e<br />
dell’unità, che chiamano l’uomo contemporaneo alla fede.<br />
§ 2. Il Cammino Neocatecumenale è così uno strumento al servizio<br />
dei Vescovi per attuare il processo di educazione permanente<br />
della fede richiesto dalla Chiesa: l’iniziazione cristiana,<br />
come ribadisce il Direttorio generale per la Catechesi, «non è il<br />
punto finale nel processo permanente di conversione. La professione<br />
di fede battesimale si pone a fondamento di un edificio<br />
spirituale destinato a crescere»; «l’adesione a Gesù Cristo,<br />
infatti, avvia un processo di conversione permanente, che dura<br />
tutta la vita».<br />
Si realizza così quanto detto da Kiko nel suo intervento il 28<br />
Giugno 2002, giorno della prima approvazione degli Statuti:<br />
Non possiamo che ringraziare la Santa Vergine Maria che ha<br />
ispirato questo Cammino, facendoci fare comunità come la<br />
Santa Famiglia di Nazareth, che vivano in umiltà, semplicità e<br />
lode, dove l’altro è Cristo. Ecco il passaggio dalla pastorale della<br />
cristianità, possiamo dire, del tempio, alla pastorale della comunità,<br />
come corpo di Cristo risorto.<br />
Modalità del servizio della catechesi<br />
Si parla di “modalità” del servizio della catechesi. Perché si parla<br />
di modalità e non delle persone che portano avanti il Cammino<br />
Neocatecumenale?<br />
Se si fosse parlato delle persone, automaticamente il Cammino<br />
Neocatecumenale sarebbe stato riconosciuto come una associazione<br />
o un movimento, portato avanti da persone strutturate con un tipo<br />
di gerarchia, e conseguentemente legati da vincoli come diritti e<br />
doveri.<br />
Ma essendo il Cammino Neocatecumenale riconosciuto come<br />
una modalità di iniziazione cristiana, sia le persone implicate nel<br />
condurlo che le persone che ne usufruiscono sono fondamentalmente<br />
dei cristiani, sia Presbiteri che laici, e come tali con la configura-<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
Il cammino<br />
Neocatecumenale<br />
alla luce del<br />
Concilio Vaticano<br />
69-122<br />
spiritualità<br />
103
pastorale e<br />
spiritualità<br />
MAURIZIO BUIONI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
104<br />
zione giuridica propria dei fedeli definita nel Codice di Diritto<br />
Canonico.<br />
Nel Titolo V degli Statuti perciò non si parla direttamente delle<br />
persone, ma dei ruoli dei vari soggetti da cui dipende la modalità<br />
di attuazione del Cammino Neocatecumenale nella Diocesi e nella<br />
parrocchia.<br />
Giovanni Paolo<br />
II e Benedetto<br />
Il Vescovo<br />
XVI invitano i<br />
Vescovi ad appoggiare<br />
le nuove realtà sorte<br />
attorno al Concilio. Citiamo qui un passaggio della Lettera<br />
Ogniqualvolta di Giovanni Paolo II e un passo dell’ultimo discorso<br />
di Benedetto XVI ai vescovi sui carismi sorti dopo il Concilio, animandoli<br />
a non temerli, ma ad accoglierli e appoggiarli.<br />
Auspico, pertanto, che i Fratelli nell’Episcopato valorizzino e<br />
aiutino - insieme con i loro presbiteri - quest’opera per la nuova<br />
evangelizzazione, perché essa si realizzi secondo le linee proposte<br />
dagli iniziatori, nello spirito di servizio all’Ordinario del<br />
luogo e di comunione con lui e nel contesto dell’ unità della<br />
Chiesa particolare con la Chiesa universale 35 .<br />
Ho molto apprezzato che sia stata scelta, come traccia del<br />
Seminario, l’esortazione da me rivolta a un gruppo di Vescovi tedeschi<br />
in visita ad limina, che oggi senz’altro ripropongo a tutti voi,<br />
Pastori di tante chiese particolari: ‘Vi chiedo di andare incontro<br />
ai movimenti con molto amore (18 novembre 2006). Potrei quasi<br />
dire di non aver altro da aggiungere! La carità è il segno distintivo<br />
del Buon Pastore: essa rende autorevole ed efficace l’esercizio<br />
del ministero che ci è stato affidato. Andare incontro con<br />
molto amore ai movimenti e alle nuove comunità ci spinge a<br />
conoscere adeguatamente la loro realtà, senza impressioni superficiali<br />
o giudizi riduttivi. Ci aiuta anche a comprendere che i<br />
movimenti ecclesiali e le nuove comunità non sono un problema<br />
o un rischio in più, che si assomma alle nostre già gravose<br />
incombenze. No! Sono un dono del Signore, una risorsa prezio-<br />
35<br />
GIOVANNI PAOLO II, Lettera Ogniqualvolta, a Monsignor Paul Josef<br />
Cordess, Roma 1990.
sa per arricchire con i loro carismi tutta la comunità cristiana.<br />
Perciò non deve mancare una fiduciosa accoglienza che dia loro<br />
spazi e valorizzi i loro contributi nella vita delle Chiese locali.<br />
Difficoltà o incomprensioni su questioni particolari non autorizzano<br />
alla chiusura. Il “molto amore” ispiri prudenza e pazienza 36 .<br />
Dagli Statuti risulta chiaro, come affermano tutti i documenti<br />
della Chiesa, che il Vescovo è il responsabile del catecumenato e<br />
della evangelizzazione nella sua Diocesi, e che in questa missione<br />
fondamentale è coadiuvato dal suo Presbiterio: Parroci e Presbiteri.<br />
Anche se la missione e la responsabilità di evangelizzare e di cooperare<br />
al Catecumenato riguarda tutti i fedeli, la comunità cristiana.<br />
Fondamentale dunque e sempre da cercare e perseguire con umiltà<br />
e amore la comunione dei Catechisti con il Vescovo Ordinario.<br />
La cura pastorale<br />
dei Parroci e Presbiteri<br />
La Santa Sede si è<br />
anche preoccupata<br />
di precisare<br />
negli Statuti il peso da<br />
dare alla figura del par-<br />
roco, nonché di valorizzare la presenza, nella Comunità neocatecumenale,<br />
del presbitero e del suo compito di governo, di insegnamento<br />
e di santificazione; così come di porre l’accento sul rispetto dovuto<br />
alla vocazione dei chierici e alla disciplina dei religiosi che percorrono<br />
il Cammino 37 .<br />
Del resto perché possa nascere una comunità neocatecumenale e<br />
poi possa seguire l’iter stabilito fino al rinnovamento solenne delle<br />
promesse battesimali, e inaugurare una pastorale di continua evangelizzazione<br />
nella parrocchia, è essenziale almeno l’assenso ma preferibilmente<br />
l’approvazione e l’accoglienza del Cammino non solo<br />
da parte del Vescovo, ma anche del parroco o del presbitero da questi<br />
delegato.<br />
Lo sviluppo del Cammino, cioè l’accoglienza di molti lontani che<br />
sono richiamati in seno alla Chiesa e che possono essere ricostruiti<br />
36<br />
BENEDETTO XVI, Ai Vescovi partecipanti al Seminario di studi promosso dal<br />
Pontificio Consiglio per i Laici, 17 maggio 2008.<br />
37 J. F. CARD. STAFFORD, Discorso agli Iniziatori del Cammino e agli Itineranti,<br />
Porto San Giorgio 30 giugno 2002.<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
Il cammino<br />
Neocatecumenale<br />
alla luce del<br />
Concilio Vaticano<br />
69-122<br />
spiritualità<br />
105
pastorale e<br />
spiritualità<br />
MAURIZIO BUIONI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
106<br />
e salvati, dipende fondamentalmente dalla accoglienza del<br />
Cammino da parte del Vescovo e del parroco. Infatti, è a Pietro, e<br />
quindi agli appostoli, che Gesù ha dato il potere di aprire le porte<br />
attraverso le quali possano ritornare i lontani all’ovile di Cristo<br />
Buon Pastore, o di chiuderle impedendo l’accesso alle più bisognose<br />
e disperse.<br />
Va qui sottolineato che, data la centralità della Parola come elemento<br />
formativo per la nascita e la crescita nella fede: ”Essendo<br />
stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma immortale, cioè<br />
dalla parola di Dio viva ed eterna” (1 Pt. 1, 23), la missione del presbitero<br />
che presiede le celebrazioni è fondamentale.<br />
Infatti dopo il periodo delle prime catechesi, i catechisti lasciano<br />
la comunità, per ritornare una volta all’anno per delle visite o convivenze<br />
o per i passaggi delle diverse tappe del neocatecumenato,<br />
ma durante tutto il resto del tempo dell’iniziazione cristiana e più<br />
ancora nel tempo poi della formazione permanente, il parroco o presbitero,<br />
come Pastore, oltre a confermare e integrare la predicazione<br />
dei catechisti, spiega la Parola di Dio ai fratelli due volte alla settimana.<br />
In questo senso i membri del Cammino sono realmente affidati<br />
alla cura pastorale del parroco o del presbitero da lui delegato,<br />
sono questi che con la Parola e i Sacramenti alimentano la vita spirituale<br />
della comunità.<br />
In tal modo il parroco e i presbiteri esercitano realmente ed efficacemente<br />
il “munus docendi, sanctificandi et gubernandi” conferito<br />
loro dal Sacramento dell’Ordine, in stretta collaborazione con il<br />
Vescovo.<br />
Ovviamente qui parliamo del parroco e del presbitero in rapporto<br />
alle comunità del Cammino neocatecumenale, supponendo che<br />
ogni parroco e presbitero eserciti il suo ministero in funzione del<br />
bene di tutti i fedeli loro affidati, non solo delle Comunità neocatecumenali.<br />
Attraverso la spiegazione della Parola di Dio, normalmente dopo<br />
aver ascoltato alcune risonanze in cui dei fratelli esprimono cosa<br />
dice concretamente alla loro vita la Parola proclamata in quella celebrazione,<br />
nella omelia è il presbitero che illumina, con forza profetica,<br />
il Cammino di fede dei fratelli, indicando e manifestando<br />
costantemente il messaggio di salvezza che ogni Parola di Dio racchiude,<br />
illuminando, incoraggiando e sostenendo il Cammino dei<br />
singoli fratelli e della comunità. Da qui la necessità di presbiteri<br />
immersi nella Parola di Dio, pieni della sapienza che deriva dalla
conoscenza delle Scritture, della Tradizione e dei Padri, della vita<br />
dei Santi, del Magistero della Chiesa.<br />
Il ministero del presbitero all’interno delle Comunità neocatecumenali<br />
è essenziale e di fondamentale importanza, da lui dipende<br />
molto spesso che dei fratelli in crisi siano aiutati a perseverare o che<br />
altri invece se ne vadano dalla Comunità e talora dalla Chiesa.<br />
È chiaro che il presbitero si senta anzitutto fratello tra i fratelli,<br />
unito a tutti nel Cammino di conversione quotidiana, ma come<br />
Pastore senta amore e interessamento vero al bene di ogni singolo<br />
fratello.<br />
È il parroco o presbitero che ai fratelli che progredendo nel<br />
Cammino e alla luce della Parola e della forza della Predicazione<br />
scoprono sempre più a fondo i propri peccati, dona loro il perdono<br />
sia nelle Celebrazioni Penitenziali, sia comunitarie (con confessioni<br />
individuali) che in quelle individuali.<br />
È il parroco o il presbitero che settimanalmente presiede la<br />
Celebrazione Eucaristica, quando possibile in piccola comunità, o<br />
con più comunità, facendo presente nel Giorno del Signore il mistero<br />
della Pasqua del Signore, coinvolgendo sempre più i fratelli, l’assemblea,<br />
nella partecipazione alla Pasqua del Signore.<br />
Nel Cammino<br />
neocatecume-<br />
I catechisti<br />
nale appare<br />
una figura nuova<br />
rispetto al contesto<br />
ecclesiale di oggi, almeno per i paesi di vecchia tradizione cristiana:<br />
la figura dell’équipe di catechisti.<br />
L’équipe dei catechisti nel Cammino neocatecumenale è fondamentale:<br />
perché è dalla loro testimonianza di vita, e dalla loro predicazione<br />
che nelle Parrocchie nascono e crescono le comunità neocatecumenali.<br />
Sono i catechisti che con la costituzione di una comunità in una<br />
parrocchia si assumono l’impegno, sempre in comunione con il<br />
parroco, a seguire e condurre avanti in questo itinerario graduale e<br />
progressivo i fratelli di quella comunità, fino ad una maturazione<br />
della fede che permetta loro di poter rinnovare solennemente<br />
le Promesse battesimali davanti al Vescovo o all’Ordinario della<br />
diocesi.<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
Il cammino<br />
Neocatecumenale<br />
alla luce del<br />
Concilio Vaticano<br />
69-122<br />
spiritualità<br />
107
pastorale e<br />
spiritualità<br />
MAURIZIO BUIONI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
108<br />
Tale autorità dei catechisti, sempre sottomessa all’approvazione e<br />
al mandato del Vescovo e del parroco, è fondamentale perché senza<br />
obbedienza non esiste Cammino di fede. Essi trasmettono gratuitamente<br />
quello che a loro volta gratuitamente hanno ricevuto e sono<br />
testimoni della potenza della Parola di Dio e della forza dei sacramenti<br />
che nel Cammino di fede loro stessi hanno sperimentato nella<br />
propria vita.<br />
È chiaro che i catechisti pur nella loro povertà sono chiamati a<br />
vivere essi stessi il Cammino di conversione giorno per giorno, per<br />
poter essere testimoni credibili dell’Annuncio di salvezza che portano.<br />
Per questo gli statuti stabiliscono che possano essere catechisti<br />
solo coloro che la comunità nomina, riconoscendo in loro il dono<br />
della predicazione e della testimonianza, in accordo con il parroco e<br />
i catechisti della loro comunità, solo dopo il secondo scrutinio,<br />
quando cioè hanno già cominciato ad esperimentare la potenza di<br />
Gesù Cristo nel salvare la propria vita.<br />
La loro formazione è poi completata negli incontri al Centro<br />
Neocatecumenale, nel partecipare prima a catechesi o agli scrutini<br />
portati avanti dai loro Catechisti per apprendere da loro la tradizione<br />
orale, e poi andando ad evangelizzare confidando nella potenza<br />
del Signore che sempre li precede.<br />
In alcune Diocesi si è creato il costume che i catechisti all’inizio<br />
dell’anno pastorale, sono inviati alla loro missione dal Vescovo, il<br />
quale poi al termine li accoglie per ascoltare le loro testimonianze<br />
sulla evangelizzazione.<br />
La cura dei catechisti, specie da parte delle équipes delle nazioni<br />
e dei Centri Neocatecumenali, deve essere particolare, per correggere<br />
deviazioni rispetto alla prassi del Cammino, soprattutto per gli<br />
scrutini, per aiutare le équipes che hanno meno esperienza.<br />
Quando si parla di catechisti negli Statuti (Artt. 28-31), si fa sempre<br />
riferimento all’équipe della quale normalmente fa parte un presbitero<br />
o il parroco stesso: questo è molto importante, perché la conduzione<br />
del Cammino è fatta da tutta l’équipe e in forma comunitaria:<br />
queste due caratteristiche sono da salvaguardare come fondamentali.<br />
Essendo il Cammino neocatecumenale un itinerario di formazione<br />
cattolica, valida per la società e per i tempi odierni, ha una sua<br />
pedagogia ben precisa nel condurre il Cammino di fede in forma<br />
graduale e progressiva mediante gli strumenti di cui abbiamo parlato<br />
prima: Celebrazione della Parola, Liturgia e Comunità attraverso
le varie tappe dell’itinerario neocatecumenale, marcate dai Passaggi<br />
e Scrutini.<br />
Per questo motivo i fratelli che si sentono chiamati a percorrere<br />
l’itinerario del Neocatecumenato sono invitati ad attenersi alle preparazioni,<br />
alle Celebrazioni e ai diversi passaggi, fiduciosi che in<br />
questo modo, in seno alla Chiesa, vengono poco a poco gestati, evidentemente<br />
con la corrispondenza della propria libertà, ad una fede<br />
adulta.<br />
Per questo si è creata fin dall’inizio, sull’esempio degli iniziatori,<br />
la prassi di visitare le comunità solo in occasione di convivenze<br />
annuali per fare risuonare costantemente il kerigma, o per i diversi<br />
passaggi, evitando altri tipi di contatto, come colloqui privati, sia<br />
con i singoli che con le comunità. Questa pedagogia che è confermata<br />
dalla tradizione antica della Chiesa, aiuta ciascun fratello a<br />
mettersi poco a poco personalmente davanti a Dio, a lasciarsi interpellare<br />
dalla sua Parola, a ricorrere a lui nella preghiera nei momenti<br />
di bisogno o di crisi, in questo modo impara a crescere e a maturare.<br />
Concludendo<br />
agli Itineranti del Cammino nel 1997:<br />
Aconclusione<br />
faccio presenti<br />
queste parole<br />
che disse Giovanni<br />
Paolo II rivolgendosi<br />
So che venite direttamente dal raduno che avete avuto al Monte<br />
Sinai e sulle sponde del Mar Rosso. Avete voluto in questo<br />
modo commemorare i trent’anni di vita del Cammino. Quanta<br />
strada avete fatto con l’aiuto del Signore! Il Cammino ha visto<br />
in questi anni uno sviluppo e una diffusione nella Chiesa veramente<br />
impressionanti. Iniziato tra i baraccati di Madrid, come<br />
l’evangelico granellino di senapa è diventato, trent’anni dopo,<br />
un grande albero, che s’estende ormai in più di 100 paesi del<br />
mondo, con presenze significative anche tra i cattolici di Chiese<br />
di rito orientale. Come ogni anniversario, anche il vostro, visto<br />
alla luce della fede, si trasforma in occasione di lode e di ringraziamento<br />
per l’abbondanza dei doni che il Signore ha concesso<br />
in questi anni a voi e, per mezzo vostro, a tutta la Chiesa. Per<br />
molti l’esperienza neocatecumenale è stata un Cammino di con-<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
Il cammino<br />
Neocatecumenale<br />
alla luce del<br />
Concilio Vaticano<br />
69-122<br />
spiritualità<br />
109
pastorale e<br />
spiritualità<br />
MAURIZIO BUIONI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
110<br />
versione e di maturazione nella fede attraverso la riscoperta del<br />
battesimo come vera fonte di vita e dell’Eucaristia come<br />
momento culminante nell’esistenza del cristiano: attraverso la<br />
riscoperta della parola di Dio che, spezzata nella comunione fraterna,<br />
diventa luce e guida della vita; attraverso la riscoperta<br />
della Chiesa come autentica comunità missionaria. Quanti giovani<br />
e ragazze grazie al Cammino hanno pure scoperto la propria<br />
vocazione sacerdotale e religiosa! La vostra odierna visita<br />
offre una felice opportunità anche a me per unirmi al vostro<br />
canto di lode e di ringraziamento per le «grandi cose» (magnalia)<br />
che Dio va operando nell’esperienza del Cammino. La sua<br />
storia si iscrive nel contesto di quella fioritura di movimenti e di<br />
aggregazioni ecclesiali che costituisce uno dei frutti più belli del<br />
rinnovamento spirituale avviato dal Concilio Vaticano lI. Tale<br />
fioritura è stata ed è tuttora un grande dono dello Spirito Santo<br />
ed un luminoso segno di speranza alla soglia del Terzo<br />
Millennio… Il Cammino Neocatecumenale compie trent’anni<br />
di vita: l’età direi, di una certa maturità. Il vostro raduno al Sinai<br />
ha aperto davanti a voi in un certo senso una tappa nuova.<br />
Opportunamente, pertanto, avete cercato di rivolgere il vostro<br />
sguardo con spirito di fede non solo verso il passato, ma anche<br />
verso l’avvenire, interrogandovi su quale sia il disegno di Dio<br />
nei confronti del Cammino in questo momento storico. Il<br />
Signore ha messo nelle vostre mani un tesoro prezioso. Come<br />
viverlo in pienezza? Come svilupparlo? Come condividerlo<br />
ancora meglio con gli altri? Come difenderlo da vari pericoli<br />
presenti o futuri? Ecco alcune delle domande che vi siete posti,<br />
come responsabili del Cammino o come itineranti della prima<br />
ora. Per rispondere a queste domande, in un clima di preghiera<br />
e di profonda riflessione, avete iniziato al Sinai il processo della<br />
stesura di uno Statuto del Cammino. È un passo molto importante<br />
che apre la strada verso il suo formale riconoscimento giuridico,<br />
da parte della Chiesa, dando a voi una ulteriore garanzia<br />
dell’autenticità del vostro carisma 38 .<br />
Non c’è dubbio che il Cammino suscita entusiasmo, accoglienza,<br />
critiche, diffidenze, adesioni parziali; nei suoi confronti spesso ci<br />
sono precomprensioni, ignoranza, indifferenza, si arriva ad accusarlo<br />
di eresia, di creare chiese parallele, di essere staccato dalla realtà,<br />
38 GIOVANNI PAOLO II, Discorso agli itineranti, 24 Gennaio 1997.
angelista. Critiche sul piano teologico, pastorale, liturgico, biblico:<br />
non c’è praticamente aspetto su cui non vi siano riserve. Le difficoltà<br />
e le obiezioni ne toccano la struttura, la teologia, la prassi pastorale,<br />
in un intreccio difficilmente districabile.<br />
Potrebbe essere utile ravvisare alcune convergenze tra quanto<br />
oggi è ormai acquisito nella chiesa e alcune intuizioni del Cammino<br />
(il suo venire dai «lontani» e tendere ad essi; gli adulti come scelta<br />
pastorale; la necessità di cammini di fede); come l’individuare alcune<br />
ragionevoli critiche per una più ponderata valutazione (di essere<br />
chiesa parallela, staccato dalla realtà, di rifiutare un approccio storico<br />
alle Scritture, di confondere iniziazione cristiana con cammini di<br />
fede o di non aver chiarito teologicamente il rapporto tra il battesimo<br />
ricevuto e la sua riscoperta).<br />
I problemi cominciano sui modi concreti con cui il Cammino<br />
porta avanti le sue finalità; quando è in gioco il suo specifico carisma.<br />
Per ora ci limitiamo a ricordare un fatto e due criteri: nella storia<br />
della chiesa raramente si spegne direttamente un carisma, più<br />
normalmente si cerca di svuotarlo adattandolo e razionalizzandolo,<br />
inserendolo in piani difficilmente armonizzabili con ciò che di specifico<br />
esprime.<br />
Un primo criterio: in ogni carisma è necessario coniugare due<br />
cose: la sua destinazione alla chiesa, ma anche la sua novità, senza<br />
il cui rispetto e sviluppo la chiesa non ne avrebbe beneficio, ma solo<br />
un problema in più da risolvere.<br />
Secondo: se in un Cammino ci sono degli aspetti che restano in<br />
penombra o sottaciuti, non significa che siano negati ma solo che<br />
non costituiscono il perno della sintesi; nel Cammino c’è un carisma,<br />
non la somma di carismi. Per cui, più che una «risposta» ai singoli<br />
punti, cercherò di dare alcune chiavi di lettura per meglio comprendere<br />
e situare il Cammino e più precisamente le ragioni e le<br />
modalità con le quali in esso si riscopre la fede.<br />
Il punto di partenza è questo: anche il Cammino desidera realizzare<br />
il concilio Vaticano II. Certamente il Cammino nel suo insieme<br />
(celebrazioni liturgiche, ruolo dei laici, missionarietà delle famiglie)<br />
è inconcepibile senza il Vaticano II. Come realizzare il concilio?<br />
Una risposta potrebbe essere questa: coniugando l’orientamento<br />
emerso nella prima sessione su indicazioni dei cardinali Léger,<br />
Suenens e Montini, di un concilio ripensato come concilio per il<br />
mondo, con la sua ratio primigenia, di un concilio, cioè, voluto da<br />
papa Giovanni come «novella Pentecoste» per la Chiesa e quindi per<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
Il cammino<br />
Neocatecumenale<br />
alla luce del<br />
Concilio Vaticano<br />
69-122<br />
spiritualità<br />
111
pastorale e<br />
spiritualità<br />
MAURIZIO BUIONI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
112<br />
l’intera umanità. In questa linea, mi sembra, si muove il Cammino.<br />
Si può dire che il Cammino legge il Vaticano II:<br />
a) alla luce dei contraccolpi che il mondo moderno ha riversato<br />
all’interno della Chiesa;<br />
b) ricentrando il Vaticano II sulla ispirazione giovannea: una<br />
novella pentecoste;<br />
c) alla luce di un rinnovato rapporto tra Chiesa e mondo. Una lettura<br />
che riflette i cambiamenti avvenuti fuori e dentro la chiesa a<br />
partire dalla fine degli anni Sessanta.<br />
a) L’analisi e il giudizio su questi contraccolpi sono duri e talora<br />
possono sorprendere e irritare. Il mondo si è infiltrato nella chiesa:<br />
la chiesa volendo evangelizzarlo è spesso rimasta pastoralmente<br />
come prigioniera - ovviamente in modo inconscio - dei metodi del<br />
mondo, dimenticando che ciò che aliena l’uomo non è principalmente<br />
la realtà socio-economica o quella psichica (i complessi<br />
paterni o materni), ma il peccato, i suoi peccati; per cui serve a ben<br />
poco o a nulla cambiare le strutture se non si cambia il cuore dell’uomo.<br />
Altrimenti l’uomo rischia di essere lasciato in balia delle<br />
tentazioni del maligno che, come ad Eva, suggerisce di non fidarsi<br />
di Dio, perché «Dio non ama l’uomo», perché anche se Dio ci fosse<br />
non c’entra con la vita concreta dell’uomo, per cui egli deve provvedere<br />
a se stesso, costruirsi la sua città: Dio non c’entra con la salute,<br />
con il lavoro, con la povertà o la ricchezza, con gli affetti, con la<br />
storia quotidiana.<br />
Con un’altra possibile conseguenza: di spingere l’uomo a rifugiarsi<br />
nella religiosità naturale, nella quale egli è portato a servirsi di<br />
Dio più che a servire Dio, in fondo perché ancora immerso nella<br />
paura di Dio. «Io non ho mai incontrato un cristiano - ripete Kiko -<br />
che dica “mio Padre” riferendosi a Dio». Da qui una crisi di fede diffusa,<br />
perché mancano i segni della fede; perché non ci può essere un<br />
cristiano che prima non abbia visto un altro cristiano; perché il cristianesimo<br />
non si dimostra ma si mostra. Se oggi esistono singoli<br />
cristiani o famiglie cristiane o delle comunità cristiane, di solito<br />
nelle parrocchie non si trovano comunità che nel loro insieme e abitualmente<br />
(almeno come tensione) diano visibilmente i segni della<br />
fede; comunità, cioè, in cui i cristiani siano adulti nella fede: sottomessi<br />
gli uni agli altri, ritenendosi ciascuno inferiore all’altro; capaci<br />
di portare gli uni i pesi - i peccati, che sono il peso più grande -
degli altri; capaci di perdonare il nemico; di amarsi, insomma, nella<br />
dimensione della croce 39 .<br />
Questi dati confermano la sensazione che occorre “ri-evangelizzare”<br />
la religiosità degli adulti annunciando loro un Dio dal volto<br />
storico, relazionale e comunitario 40 .<br />
Ciò che caratterizza la Rivelazione cristiana è il fatto che Dio si<br />
rivela e si dona in una storia intessuta di avvenimenti e di parole.<br />
Una ricerca di Dio come essere trascendente fuori del tempo strappa<br />
l’uomo dalla concretezza della sua vicenda storica, lo fa evadere<br />
dalla sua avventura umana. L’annuncio di un Dio che si fa uomo rinvia<br />
l’uomo dentro la sua ferialità e quotidianità, rendendolo capace<br />
di impegnarsi per la propria umanizzazione e quella del mondo.<br />
Contro le alienazioni di ogni forma di spiritualismo e di ogni fuga<br />
dalla storia è urgente che torni a risuonare l’annuncio di un Dio che<br />
si è fatto uomo e dentro la storia ha tracciato la possibilità di un itinerario<br />
umano e fraterno per tutti. Sta qui un primo compito dell’annuncio:<br />
ancorarlo a quell’evento storico e metastorico che è la<br />
Pasqua del Signore Gesù. In tal mondo, più che come ricerca dell’uomo,<br />
la fede si presenta come accoglienza di un’irruzione di Dio<br />
nella storia, che chiede disponibilità.<br />
La ricerca di religioso che si perde in un vago senso dell’assoluto<br />
o che si dissolve nel movimento senza volto della natura lascia<br />
l’uomo nella sua solitudine. La fede cristiana, nel suo primo e nel<br />
suo definitivo Testamento (la prima e la nuova Alleanza), annuncia<br />
il volto di un Dio che si lega all’uomo, di un Tu che prende volto<br />
umano e sollecita ciascuno a entrare in relazione libera con Lui.<br />
39 Cf. Orientamenti alle équipes dei catechisti, pp. 36-68. Cf. anche A. LIPPI,<br />
La Croce gloriosa nel Cammino neocatecumenale, in La Sapienza delle Croce 5<br />
(1990), 195-210. In questo articolo l’autore presenta il Cammino neocatecumenale<br />
come un carisma e un dono di Dio per la Chiesa del nostro tempo. Il neocatecumenato<br />
è fondato sul sacramento del battesimo, tutto da vivere e da interiorizzare<br />
nei suoi vari momenti, e incentrato sulla Parola di Dio, a cui si accede<br />
a livello di vita ecclesiale più che di riflessione teologica. È prospettata una<br />
mentalità cristiana, non semplicemente etica in cui la croce è il criterio di identificazione<br />
di ciò che è autenticamente cristiano. La croce non è sottomissione rassegnata<br />
al Dio legislatore, non è morte, ma gloria che fa vedere il volto di Dio.<br />
40 Queste dimensioni dell’educazione della religiosità emergono soprattutto<br />
da un’analisi attenta del catechismo degli adulti La Verità vi farà liberi. Si veda<br />
anche: E. BIEMMI-G. LAITI, Conoscere il Catechismo degli adulti, ElleDiCi, Torino-<br />
Leumann 1995.<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
Il cammino<br />
Neocatecumenale<br />
alla luce del<br />
Concilio Vaticano<br />
69-122<br />
spiritualità<br />
113
pastorale e<br />
spiritualità<br />
MAURIZIO BUIONI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
114<br />
Nella percezione della presenza di questo Tu e nella risposta libera<br />
a Lui la persona nasce a se stessa, impara il proprio nome e scopre<br />
il senso della sua vita. Il Dio di Gesù Cristo, proprio in quanto figlio<br />
di Dio fatto umano dentro la storia, pone ciascuno come altro da sé<br />
davanti a sé, chiamando non al mistico naufragio in Lui, fagocitati<br />
come una goccia nell’oceano, ma ad un rapporto libero e responsabile.<br />
È proprio dell’annuncio evangelico provocare ad una relazione<br />
storica e adulta sottratta sia allo smarrimento nel Tu divino che allo<br />
smarrimento del Tu divino.<br />
L’altra dimensione propria del cristianesimo e idonea a rievangelizzare<br />
la ricerca religiosa contemporanea è quella comunitaria. Il<br />
Dio di Gesù Cristo che viene incontro all’uomo dentro la storia e ne<br />
provoca la libera e responsabile risposta si lascia incontrare dentro<br />
la comunità ecclesiale e crea comunità. La struttura sacramentale<br />
della fede cristiana, il suo darsi all’interno di mediazioni e in particolare<br />
di una comunità che ascolta la Parola, la celebra nei riti della<br />
fede e la vive nella diaconia e nella carità, sono conseguenze dell’incarnazione,<br />
intesa in senso globale di incarnazione e Pasqua del<br />
Signore.<br />
Così, di fronte a una religiosità viva ma evanescente, disciogliente<br />
e ultimamente soggettiva la comunità cristiana vede riaprirsi il<br />
compito di annunciare all’uomo postmoderno un Dio che comunicandosi<br />
senza riserve e rimanendo se stesso provoca a un rapporto<br />
storico, responsabile e fraterno.<br />
In questo processo di educazione in senso evangelico della religiosità<br />
degli adulti, occorre rispettare il dinamismo proprio del<br />
nascere e del crescere della fede. Lungo tutta la tradizione, partendo<br />
dalla testimonianza biblica, la comunità ecclesiale ha messo a punto<br />
e mai abbandonato un processo di annuncio e di accoglienza della<br />
fede che ha espresso nei termini della traditio, receptio e redditio<br />
fidei.<br />
La fede richiede una traditio, come iniziativa di Dio che precede<br />
l’uomo sulle strade del suo desiderio. La fede per nessuno è un dono<br />
diretto e suppone una comunità che se ne faccia portatrice e mediatrice.<br />
Il fonte battesimale è considerato nelle catechesi patristiche il<br />
grembo materno della Chiesa che genera la fede. La prima faccia del<br />
credere è una passività, intesa come disponibilità ad accogliere ciò<br />
che gratuitamente viene offerto. Il termine traditio può trarre in<br />
inganno: fa pensare, nel linguaggio comune, a usanze che si conservano<br />
e si riproducono senza cambiare nulla. Di fatto il contenuto
dell’atto del trasmettere è un messaggio sempre nuovo, una buona<br />
notizia, una parola che fa vivere 41 .<br />
La fede suppone una receptio, l’accoglienza e l’interiorizzazione<br />
libera di quanto viene offerto. Il termine receptio è l’espressione<br />
attiva della passività della fede. Richiama un ricevimento, e quindi<br />
una festa. L’accoglienza della Buona Novella suppone un atteggiamento<br />
attivo. Ognuno accoglie a modo suo con tutto ciò che è, con<br />
la sua storia, mentalità, lingua, cultura.<br />
La redditio è la fecondità della fede. Evoca la restituzione, la<br />
necessità di rispondere all’appello di Dio attraverso una fede che<br />
opera nella carità. E’ la fede che prende volto nel celebrare, nel testimoniare,<br />
nel servire 42 .<br />
La fede è un fatto relazionale, nasce e si sviluppa nella libertà,<br />
chiede l’iniziativa gratuita di Dio e la vulnerabilità di persone disponibili<br />
e recettive. Fuori di questo dinamismo non c’è fede, anche se<br />
ci può essere istruzione o socializzazione religiosa.<br />
In questo contesto si capisce come il Cammino ponga la necessità<br />
di itinerari di fede per arrivare alla formazione di comunità cristiane<br />
capaci di dare questi segni della fede, ritenendoli segni evangelici<br />
ed eloquenti per richiamare alla vita eterna i nuovi pagani, insensibili<br />
ad altre voci del cristianesimo e scandalizzati dal dolore del<br />
mondo.<br />
Una scelta che trova conferma nel magistero di Paolo VI che già<br />
a partire dal 1972 e, in particolare, per tutto un mese del 1977 aveva<br />
41 Cf. Tabor. Encicolopedia dei catechisti, Edizioni Paoline 1995, 116-117.<br />
42 Il movimento della traditio/receptio/redditio è rimasto costante nella vita<br />
della Chiesa, anche se a livello catechistico si è sbiadito con la nascita dei catechismi<br />
(a partire dal 1500, ma con accentuazioni notevoli nei secoli successivi,<br />
per le contaminazioni di tipo illuministico e neoscolastico), a favore di un<br />
annuncio ritmato sulla domanda e risposta tra insegnante ed alunno. Può essere<br />
utile, a questo proposito, far notare che il procedimento domanda/risposta<br />
proprio del catechismo di Pio X non era che il “residuo” di quel movimento di<br />
offerta/accoglienza che in maniera più lucida era salvaguardato e segnalato,<br />
ad esempio, dall’impianto iniziatico del catecumenato. Il dialogo che avveniva<br />
nella notte di Pasqua, nel fonte battesimale, tra la Chiesa e il catecumeno rappresentava<br />
il dinamismo della fede: “Credi in Gesù Cristo?” – “Credo!”. Così,<br />
per uno slittamento inconsapevole ma dalle conseguenze importanti ciò che<br />
significava e favoriva la struttura dialogale del credere, come offerta e accoglienza<br />
di una relazione, si è ridotto nel sistema della domanda/risposta dei<br />
catechismi a verificare la corrispondenza tra un contenuto trasmesso e la sua<br />
memorizzazione.<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
Il cammino<br />
Neocatecumenale<br />
alla luce del<br />
Concilio Vaticano<br />
69-122<br />
spiritualità<br />
115
pastorale e<br />
spiritualità<br />
MAURIZIO BUIONI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
116<br />
parlato della necessità di «ricostruire» la chiesa, gioendo di vederne<br />
un’espressione proprio nelle comunità neocatecumenali 43 . E ancora<br />
più significativo appare quanto scritto, da Giovanni Paolo II, nella<br />
<strong>Christi</strong>fideles laici, dove non solo si parla della necessità di rifare<br />
daccapo il tessuto cristiano delle comunità ecclesiali - come premessa<br />
previa alla nuova evangelizzazione - ma si pone come condizione<br />
del rinnovamento della chiesa la creazione di piccole comunità<br />
cristiane 44 .<br />
b) Il compito della comunità cristiana è quello di essere luogo di<br />
«gestazione della fede» fino alla sua maturità. Una necessità avvertita<br />
da Paolo VI, neppure due anni dopo la chiusura del concilio, con<br />
la proclamazione del «Credo del popolo di Dio» e passando, nel<br />
corso degli anni Settanta, dalla domanda «Chiesa di Gesù Cristo<br />
cosa dici di te stessa?», all’altra: «Chiesa di Gesù Cristo cosa dici<br />
del tuo Dio?». Proprio nello stesso torno di tempo J. Maritain scriveva<br />
che la crisi di fede del periodo modernistico era un colpo di raffreddore<br />
in confronto a quella in cui stava entrando la chiesa del<br />
dopo concilio 45 . L’apertura al mondo rischiava di svuotare il messaggio<br />
cristiano.<br />
Il Cammino si muove nella medesima direzione. Anche per esso<br />
la riforma della Chiesa non è fine a se stessa, ma per introdurre nell’uomo<br />
moderno la forza vitale del vangelo: la fede. Qui sta la «ratio<br />
primigenia» del Cammino, la sua domanda di fondo - non tematizzata,<br />
ma reale e profonda -: dove trovare nella chiesa di oggi luoghi<br />
per essere iniziati alla fede, alla vita cristiana, alla chiesa come<br />
popolo di Dio e corpo di Cristo? Se nella Chiesa vi sono molti spazi<br />
per introdurre alle forme specifiche dell’esistenza cristiana, sono<br />
insufficienti i luoghi in cui generare alla fede; donde la necessità di<br />
ricreare un catecumentato per giovani e adulti 46 . Questo il carisma<br />
43 Cf. Udienza del 12 gennaio 1977.<br />
44 Cf. <strong>Christi</strong>fideles laici nn. 26, 34.<br />
45 J. MARITAIN, Le paysan de la Garonne, Bruges-Paris 1967.<br />
46 I più recenti Documenti della C.E.I. propongono di ispirarsi al paradigma<br />
catecumenale anche per realizzare itinerari di Iniziazione cristiana che tengono<br />
conto della nuova situazione, sia della società, sia della famiglia, e di prevedere<br />
un Cammino a tappe, con corrispondenti verifiche: “Al centro di tale rinnovamento<br />
[pastorale] va collocata la scelta di configurare la pastorale secondo<br />
il modello della Iniziazione cristiana, che – intessendo tra loro testimonianza<br />
e annuncio, itinerario catecumenale, sostegno permanente della fede
del Cammino: percorsi comunitari di gestazione alla fede. Allora nel<br />
seno di ogni comunità cristiana si manifesteranno i carismi, le diverse<br />
vocazioni peculiari: matrimonio, verginità, ministero ordinato,<br />
testimonianze evangeliche nei diversi ambiti. Per questo bisogna<br />
ritornare dagli ambienti alle comunità; dalle specializzazioni apostoliche<br />
alla loro fonte che è la fede 47 .<br />
In tale contesto si può vedere il modo diverso di intendere la figura<br />
del laico nel Cammino: mentre di solito si sottolinea la responsabilità<br />
secolare del laico, la sua autonomia e il suo ruolo nella chiesa,<br />
questi aspetti nel Cammino non sono negati, ma spostati in un<br />
secondo momento, essendo necessario, prima, un autentico ritorno<br />
alla fede. Soltanto dopo quegli aspetti potranno essere come riscoperti<br />
e messi a frutto cristianamente. L’accento insomma ritorna<br />
sulla fede; perché la chiesa sia nel mondo cristianamente, deve essere<br />
fedele.<br />
c) Un rinnovato rapporto della Chiesa con il mondo. La Chiesa<br />
non è una luce in più; una camminatrice in più. Ma la Chiesa è la<br />
luce, la via: «Voi siete la luce del mondo»; «Andando in tutto il<br />
mediante la catechesi, vita sacramentale, mistagogia e testimonianza della carità<br />
– permette di dare unità alla vita della Comunità e di aprirsi alle diverse situazioni<br />
spirituali dei non credenti, degli indifferenti, di quanti si accostano o si<br />
riaccostano al Vangelo, di coloro che cercano alimento per il loro impegno cristiano”.<br />
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Comunicare il Vangelo in un<br />
mondo che cambia. Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano per il primo<br />
decennio del 2000, 29 giugno 2001, n. 59.<br />
47 Si tratta di un processo formativo all’esperienza di vita cristiana che<br />
abbraccia quattro aspetti e momenti, strettamente legati tra loro e interdipendenti:<br />
• il primo annuncio di Cristo, Morto e Risorto, per suscitare la fede, quale<br />
adesione a Lui e al suo Messaggio di salvezza nella sua globalità; è fondamentale<br />
che si stabilisca un rapporto con Lui! • la catechesi propriamente detta,<br />
finalizzata all’approfondimento in forma organica del Messaggio stesso in vista<br />
della conversione, cioè del progressivo cambiamento di mentalità e di stile di<br />
vita; in questo entrano anche la formazione morale e il sacramento della<br />
Riconciliazione, come dono da sperimentare; • l’esperienza liturgico-sacramentale,<br />
per educare alla preghiera e realizzare il pieno inserimento nel Mistero<br />
pasquale di Cristo e nella vita della Chiesa, anzitutto attraverso la partecipazione<br />
attiva all’Eucaristia domenicale; •l’impegno della testimonianza e del servizio,<br />
per una partecipazione corresponsabile nella vita della Comunità ecclesiale<br />
e nella missione, cf. CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE DELLA CEI,<br />
L’iniziazione cristiana. 1. Orientamenti per il catecumenato degli adulti, 30<br />
marzo 1997. Premessa.<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
Il cammino<br />
Neocatecumenale<br />
alla luce del<br />
Concilio Vaticano<br />
69-122<br />
spiritualità<br />
117
pastorale e<br />
spiritualità<br />
MAURIZIO BUIONI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
118<br />
mondo». Gesù Cristo non è inferiore o superiore a qualche altro profeta,<br />
Cristo è l’unico Salvatore e la sua unicità, misteriosamente,<br />
ricade sulla Chiesa. È l’unità indissolubile tra l’essere comunità e<br />
mezzo di salvezza che costituisce la Chiesa come sacramento di salvezza;<br />
e questo non per escludere qualcuno dalla salvezza e condannarlo<br />
alla perdizione, ma per chiamare ogni uomo.<br />
Tutti sono chiamati ad essere evangelizzati: ad essere «illuminati»,<br />
ad essere «salati», ad essere «lievitati»; ma non tutti sono chiamati<br />
ad essere «luce», «sale» e «lievito»: solo quelli che il Signore<br />
chiama e che la Chiesa, in cammini di iniziazione alla fede, deve<br />
discernere per trasmettere loro la missione di Cristo, per invocare su<br />
di loro lo Spirito. Nessuno può seguire Gesù Cristo semplicemente<br />
perché lo desidera; perché seguire Gesù Cristo vuol dire seguirlo<br />
nella morte a Gerusalemme, per essere uccisi dal mondo. «Non voi<br />
avete scelto me, ma io ho scelto voi».<br />
Quindi non solo tutti non entreranno nella Chiesa, ma anzi in<br />
alcuni fratelli il maligno agisce con una tale forza che neppure riusciranno<br />
ad essere visibilmente illuminati o salati su questa terra;<br />
non perché siano cattivi o ne abbiano una colpa. Nessuno è amato di<br />
meno, ma qualcuno ha una missione in più: quella di Cristo. E chi è<br />
chiamato ad essere Cristo, prima o poi avrà uno che lo tradirà.<br />
Ebbene, l’unico modo che hanno questi fratelli che tradiscono di<br />
essere salvati è che la Chiesa dia il suo sangue per loro; il sangue dei<br />
cristiani è il sangue di Cristo. Salva! Ci saranno dunque delle persone<br />
che uccideranno i cristiani e cristiani che daranno il loro sangue<br />
per esse; come fece Stefano per coloro che lo lapidavano e come<br />
hanno fatto in questi anni postconciliari quasi mille missionari. La<br />
Chiesa, che è madre, non condanna nessuno all’inferno, ma dà ogni<br />
giorno la sua vita per tutti coloro che lo Spirito riempie, perché nel<br />
mondo possa continuare la vita di Cristo e in lui l’amore al nemico:<br />
il luogo ermeneutico - su questa terra - della più intima identità cristiana.<br />
L’approvazione definitiva degli Statuti, pertanto, è motivo di<br />
grande gioia e di conferma da parte di Pietro per il Cammino.<br />
Kerygma, itinerari di fede, piccole comunità sono la caratteristica<br />
del Cammino, il cui approdo è la Chiesa. L’approdo del Cammino è<br />
solo e unicamente nella Chiesa; operativamente nella parrocchia.<br />
Indipendentemente da tutto, dai limiti, dai peccati, dalle particolari<br />
prospettive o modelli pastorali, la struttura del Cammino porta alla<br />
Chiesa. Questo è il centro del discorso.
Il rifluire nella parrocchia di un gruppo di persone che, almeno<br />
come tensione, danno i segni della fede, essendosi in essi provati<br />
durante un Cammino di conversione molto lungo; lungo perché si<br />
tratta di contribuire a rifare, come scritto nella <strong>Christi</strong>fideles laici, il<br />
tessuto ecclesiale delle comunità cristiane; lungo perché il salto di<br />
qualità per essere cristiani è molto più esigente di quello per essere<br />
presbiteri. Se rifluisce vuol dire che il Cammino termina; non dura<br />
tutta la vita; per questo non è una congregazione religiosa e neppure<br />
un movimento, ma appunto un percorso di fede inserito nella parrocchia<br />
per contribuire a rigenerare in essa la Chiesa. Un rifluire in<br />
umiltà, semplicità e lode, grati a Dio che continua a scegliersi un<br />
popolo nel quale il Figlio suo può continuare a dare al mondo la vita<br />
eterna.<br />
ENG<br />
THE NEOCATECHUMENAL ROAD IN THE<br />
LIGHT OF THE 2 nd VATICAN COUNCIL<br />
By Maurizio Buioni, C.P.<br />
On the occasion of the approval of the Statutes of the<br />
Neocatechumenal Road by the holy See, the author offers us a clear<br />
and stimulating presentation on this ecclesial reality. We are shown<br />
how, from the very beginning, the Road was embraced and accompanied<br />
by the Church authority as a fruit of the Holy Spirit, who thus<br />
put into effect – as happened with various spiritual movements<br />
which originated after the Council of Trent – what was announced<br />
and promoted by the Second Vatican Council. As was made evident<br />
in preceding article in this journal, the glorious Cross is at the very<br />
center of the catechumenal Road, which Cross included in itself the<br />
Resurrection. We have been immersed – baptized – into the death<br />
and resurrection of Jesus (cf Rm 6: 1-11). This article likewise illustrates<br />
another prerogative of the Road, i.e. its ecclesial nature, in so<br />
far as it is active in the local Church and parish and is conducive to<br />
the experience of the Church as a community, stressing the importance<br />
of the liturgy as an instrument of grace for the Church, the<br />
transmission of the faith, evangelization (2 nd part) and the importance<br />
of signs and an understanding of the same.<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
Il cammino<br />
Neocatecumenale<br />
alla luce del<br />
Concilio Vaticano<br />
69-122<br />
spiritualità<br />
119
pastorale e<br />
spiritualità<br />
MAURIZIO BUIONI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
120<br />
LE CHEMIN NEOCATECHUMENAL A LA LUMIERE<br />
DU CONCILE VATICAN II<br />
Par Maurice Buioni c.p.<br />
L’Auteur nous offre une présentation claire et stimulante de cette<br />
réalité ecclésiale. Il nous montre comment, depuis le début, le<br />
Chemin fut compris et accompagné par l’autorité de l’Eglise<br />
comme un fruit de l’Esprit Saint, qui actualisait ainsi - comme cela<br />
est arrivé en divers mouvements spirituels dans le rayonnement du<br />
Concile de Trente – ce qui a été annoncé et suscité par le Concile<br />
Vatican II. Comme nous l’avons déjà mis en évidence dans un précédent<br />
article publié dans notre revue, la Croix glorieuse est au centre<br />
du Chemin catéchuménal, la Croix qui inclut en elle la résurrection.<br />
Nous avons été immergés, c’est-à-dire baptisés, dans la mort et<br />
dans la résurrection de Jésus (Rm 6,1-11). Cet article éclaire aussi<br />
d’autres valeurs du Chemin : son ecclésialité, en tant qu’il s’actualise<br />
dans l’Eglise locale et dans la paroisse, l’expérience de l’Eglise<br />
comme communauté, l’importance de la liturgie en tant qu’instrument<br />
de grâce pour l’Eglise, la transmission de la foi, l’occasion de<br />
l’approbation des Statuts du Chemin Néocatéchuménal par le Saint<br />
Siège, foi, l’évangélisation (seconde partie), l’importance des<br />
signes et de leur compréhension.<br />
EL CAMINO NEOCATECUMENMAL<br />
A LA LUZ DEL CONCILIO VATICANO II<br />
Por Maurizio Buioni, c.p.<br />
FRA<br />
ESP<br />
Con ocasión de los Estatutos del Camino Neocatecumenal por la<br />
Santa Sede, el autor ofrece una presentación clara y clarificadora<br />
de esta realidad eclesial: demuestra que, desde sus inicios, el<br />
Camino fue aceptado y acompañado por las autoridades de la<br />
Iglesia como un fruto del Espíritu Santo, que cumple así, como ocurriera<br />
con diversos movimientos espirituales nacidos tras el<br />
Concilio de Trento, lo que había anunciado y promovido el Concilio<br />
Vaticano II. Tal como se puso de relieve en otro artículo aparecido<br />
antes en esta revista, la Cruz gloriosa ocupa el centro del Camino<br />
Catecumenal, pues la Cruz incluye el hecho de la Resurrección:<br />
hemos sido sumergidos, o sea, “bautizados” (Rom 6, 1-11) en la
Cruz y en la Resurrección. Este trabajo ilumina igualmente las<br />
características del Camino: eclesialidad en cuanto se mueve en la<br />
Iglesia local y en las parroquias, experiencia de la Iglesia como<br />
comunidad, importancia de la liturgia como instrumento de gracia<br />
para la Iglesia, transmisión de la fe, evangelización (segunda<br />
parte), e importancia de los signos y de su comprensión.<br />
GER<br />
DER NEOKATECHUMENALE WEG IM LICHTE<br />
DES II. VATIKANISCHEN KONZILS<br />
Von Maurizio Buioni CP<br />
Anlässlich der Approbation der Statuten des Neokatechumenalen<br />
Weges von Seiten des Heiligen Stuhles stellt uns der Autor in klarer<br />
und anregender Weise diese neue kirchliche Realität vor. Die Studie<br />
zeigt, dass das kirchliche Amt den Weg von Anfang an als eine<br />
Frucht des heiligen Geistes verstanden und behandelt hat. Auf diese<br />
Weise hat es - ähnlich wie nach dem Konzil von Trient, das ebenfalls<br />
verschiedene geistliche Bewegungen hervorgebracht hat - das<br />
verwirklicht, was im II. Vatikanischen Konzil verkündet und gefordert<br />
worden ist.<br />
In einem früher erschienenen Artikel ist bereits betont worden, dass<br />
im Zentrum des Neokatechumenalen Weges das verherrlichte Kreuz<br />
steht, das die Auferstehung in sich einschließt. In Tod und<br />
Auferstehung <strong>Christi</strong> sind wir eingetaucht – d. h. getauft worden<br />
(Röm 6,1-11). Der vorliegende Artikel beleuchtet darüber hinaus<br />
auch andere Vorzüge des Weges: seine Kirchlichkeit, inwieweit sich<br />
diese in Diözesen und Pfarreien verwirklicht; die Erfahrung von<br />
Kirche als Gemeinschaft; die Bedeutung der Liturgie als<br />
Gnadenvermittlung für die Kirche; die Weitergabe des Glaubens;<br />
die Evangelisierung (Teil 2); die Bedeutung von Symbolen und<br />
deren Verständnis.<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
Il cammino<br />
Neocatecumenale<br />
alla luce del<br />
Concilio Vaticano<br />
69-122<br />
spiritualità<br />
121
pastorale e<br />
spiritualità<br />
MAURIZIO BUIONI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
122<br />
DROGA NEOKATECHUMENALNA W ŚWIETLE<br />
SOBORU WATYKAŃSKIEGO II<br />
MaurizioBuioni CP<br />
POL<br />
Przy okazji zaaprobowania Statutów drogi Neokatechumenalnej<br />
przez Stolicę Świętà Autor prezentuje nam jasne i inspirujàce ujęcie<br />
tej rzeczywistości kościelnej. Pokazuje, jak od poczàtku Droga była<br />
przyjmowana i cieszyła się zainteresowaniem władz kościelnych<br />
jako owoc Ducha Świętego, który wprowadzał w życie, jak miało to<br />
miejsce w różnych epizodach duchowych zwiàzanych z Soborem<br />
Trydenckim, to co głosił i promował Sobór Watykaƒski II. Jak to<br />
zostało ukazane w artykule poprzednio opublikowanym w tym<br />
czasopiśmie, chwalebny Krzyż jest w centrum Drogi<br />
katechumenalnej, Krzyż zawiera w sobie zmartwychwstanie. W<br />
śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa zostaliśmy zanurzeni, czyli<br />
ochrzczeni (Rz 6,1-11). Artykuł ten rzuca też światło na inne<br />
prerogatywy Drogi: jej eklezjalność, bowiem realizuje się w<br />
Kościele lokalnym i w parafii, doświadczenie Kościoła jako<br />
wspólnoty, znaczenie liturgii jako narzędzia łaski dla Kościoła,<br />
przekazywanie wiary, ewangelizacja (część druga), znaczenie<br />
znaków i ich rozumienie.
di FERNANDO GUILLEN PRECKLER SCH.P.<br />
L’autore di questo articolo-testimonianza è missionario in<br />
Africa ed esamina il problema della nuova evangelizzazione<br />
partendo dall’esperienza, oltre che dalle conoscenze storiche.<br />
Oggi più che mai si richiede un’evangelizzazione che ponga la<br />
sua fiducia unicamente in Dio e nella potenza del kerigma, non<br />
negli appoggi del potere o del<br />
denaro.<br />
“Noi invece annunziamo Cristo<br />
crocifisso” (I Cor 1, 23)<br />
Papa Giovanni Paolo II, assumendo<br />
un’espressione in uso nella Chiesa Latinoamericana,<br />
lanciò il progetto di una “nuova<br />
evangelizzazione”, espresso specialmente<br />
nell’Enciclica Redemptoris Missio (n. 33-36), e nei Sinodi continentali<br />
che preparavano il grande evento del Giubileo del 2.000 1 . Porgo<br />
qui una mia breve riflessione sulle caratteristiche di questa “nuova<br />
evangelizzazione” secondo la Bibbia, la storia e l’attualità.<br />
Nuovo Testamento<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
EVANGELIZZARE<br />
PARTENDO<br />
DALLA<br />
“KENOSI”<br />
Nella sua predicazione, Gesù manifesta una singolare autorità nel<br />
rivelare i misteri del Regno e liberare da ogni male. All’inizio del<br />
Vangelo secondo Marco, leggiamo che “la gente che ascoltava era<br />
1 Trovandomi a Yaundé (Camerun), ho potuto collaborare nella Settimana<br />
Teologica de “l’École Théologique Saint-Cyprien” sulla Nuova<br />
Evangelizzazione in Africa. (novembre 1999) E proprio in quel contesto mi è<br />
venuta l’idea dell’evangelizzazione dalla “kenosi”. (Cf. Annales de l’École<br />
Théologique Saint-Cyprien, 5 (2000).<br />
Evangelizzare<br />
partendo<br />
dalla “Kenosi”<br />
123-131<br />
spiritualità<br />
123
pastorale e<br />
spiritualità<br />
GUILLEN PRECKLER<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
124<br />
meravigliata del suo insegnamento: Gesù era diverso dai maestri<br />
della Torà, perchè insegnava come uno che ha piena autorità” (Mc<br />
1, 22). Questa è anche la conclusione del discorso della montagna<br />
secondo Matteo (7, 28). Lui conosce la volontà del Padre ed in mille<br />
forme sa tradurla nel nostro linguaggio umano. Lui ci annuncia il<br />
Regno di Dio in parabole, ci dà la preghiera del Regno, ed espone le<br />
nuove leggi di questo Regno (Mt 13; Mt 6, 5-15; Mt 5, 17-47). Gesù<br />
conosce il Padre come nessun altro lo conosce (Mt 11, 27).<br />
Inoltre, Gesù manifesta la verità della “Buona Notizia” nel<br />
trionfo su tutti i mali. Ancora Marco ci dà la reazione della gente<br />
dopo l’espulsione d’uno spirito immondo: “Tutti i presenti rimasero<br />
sbalorditi e si chiedevano l’un l’altro: Che succede? Questo è<br />
un insegnamento nuovo dato con autorità. Costui comanda<br />
perfino agli spiriti maligni ed essi gli ubbidiscono” (Mc 1, 27). In<br />
pari modo, Gesù libera dalla malattia tutte le persone che glielo<br />
chiedono (Mc 1, 33), ma anche perdona i peccati, suscitando sia<br />
l’ammirazione che lo scandalo nei presenti (Mc 2, 1 s).<br />
Nelle sue parole ed azioni c’è un bagliore iniziale del Regno<br />
(Mt 12, 28), che però non è di questo mondo (Gv 18, 36). Per questo<br />
Gesù rifiuta ogni sorta di potere economico, politico e perfino<br />
culturale. Egli vive poveramente, senza far uso di oggetti costosi<br />
(Mt 8, 20); scappa quando lo vogliono far diventare re (Gv 6, 15);<br />
loda il Padre perchè ha nascosto i misteri del Regno ai sapienti e<br />
agli esperti, e lo ha manifestato ai piccoli (Mt 11, 25).<br />
La sua preghiera nel Getsemani, la condanna religiosa che gli<br />
viene comminata in quanto bestemmiatore, e quella politica che<br />
gli viene comminata in quanto rivoluzionario, e la sua morte in<br />
croce, sono il sigillo di un messaggio unico, vissuto “nelle mani<br />
del Padre” (Lc 23, 46).<br />
La sua risurrezione conferma e fa capire la verità della sua persona<br />
e l’universalità della sua missione. Gesù risorto può proclamare:<br />
“A me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Perciò<br />
andate, fate diventare miei discepoli tutti gli uomini del mondo;<br />
battezzateli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo;<br />
insegnate loro a ubbidire a tutto ciò che io vi ho comandato. E sappiate<br />
che io sarò sempre con voi, tutti i giorni, sino alla fine del<br />
mondo” (Mt 28, 18-20).<br />
I discepoli di Gesù, inviati come suoi apostoli avranno dunque<br />
parte al potere di Gesù, per il fuoco dello Spirito che riceveranno,<br />
come frutto del Mistero Pasquale (At 1, 5). Lo Spirito sarà la forza
interiore per proclamare il Regno di Dio nel Cristo Gesù, e per liberare<br />
da ogni male nel suo Nome, aprendo all’umanità le porte del<br />
Regno eterno.<br />
Un’eco fedele del Maestro è la dichiarazione di Paolo aldilà dei<br />
desideri di forza e sapienza di Giudei e Greci: “Gli Ebrei infatti vorrebbero<br />
miracoli, e i Greci si fidano solo della ragione. Noi invece<br />
annunziamo Cristo crocifisso; per gli Ebrei questo messaggio è<br />
offensivo, mentre per i Greci è assurdo. Ma per quelli che Dio ha<br />
chiamati, siano essi Ebrei o Greci, Cristo è potenza e sapienza di<br />
Dio. Perchè la pazzia di Dio è più sapiente della sapienza degli<br />
uomini, e la debolezza di Dio è più forte della forza degli uomini”<br />
(I Cor 1, 22-25).<br />
Un po’ di storia dell’evangelizzazione<br />
Diamo ora uno sguardo alla storia dell’evangelizzazione.<br />
Il primo annuncio evangelico nell’Impero Romano si fece partendo<br />
da situazioni di povertà, nell’opposizione politica e senza prestigio<br />
culturale. Basta leggere gli Atti degli Apostoli e le Lettere di<br />
Paolo per convincerci di questo. Gli apostoli hanno predicato nella<br />
povertà, in mezzo alle persecuzioni e senza alcuna pretesa filosofica<br />
o letteraria. La sconfitta di Paolo nel magnifico sforzo che fece<br />
nell’Areopago di Atene lo portò alla semplice predicazione del<br />
Crocifisso in mezzo ai poveri di Corinto (At 17, 32-18, 1). La conversione<br />
del mondo greco-romano fu lenta. Durò ben cinque secoli.<br />
Al tempo di San Benedetto, nel secolo VI, c’erano ancora dei<br />
pagani nelle campagne attorno Monte Cassino. Ma il catecumenato<br />
fu efficace e sopratutto nei tre primi secoli, il motivo della conversione<br />
non aveva nessuna pretesa umana o interesse egoistico.<br />
L’evangelizzazione dei popoli germanici, nei secoli V-VIII 2 , e più<br />
tardi dei popoli slavi, nei secoli IX e X 3 , fu più rapida, in parte per<br />
opera dei monaci 4 , ma anche, in alcuni casi 5 , con interventi militari,<br />
2 Da Clodoveo a Carlomagno.<br />
3 Cf. L’enciclica Slavorum apostoli, di Giovanni Paolo II (1985).<br />
4 Si pensi al ben noto invio di Agostino, e dei suoi benedettini in Inghilterra,<br />
ai tempi di Gregorio Magno, nel secolo VI.<br />
5 Pensiamo a Carlomagno, a qualcuna delle sue imprese, ed anche ai cavalieri<br />
teutonici in Polonia...<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
Evangelizzare<br />
partendo<br />
dalla “Kenosi”<br />
123-131<br />
spiritualità<br />
125
pastorale e<br />
spiritualità<br />
GUILLEN PRECKLER<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
126<br />
e con battesimi che incominciavano dall’alto, per i re e i nobili, con<br />
scarsa catechesi 6 . Il radicamento evangelico si sviluppò assai più<br />
tardi, lungo tutto il Medioevo.<br />
Quando l’Europa si lanciò alla scoperta e conquista di altri continenti<br />
il Portogallo e la Spagna (Castiglia) nei secoli XV-XVI,<br />
l’Inghilterra e l’Olanda dal secolo XVII in poi, non mancarono di<br />
inviare missionari dai Patronati Reali 7 verso le nuove terre. La prima<br />
evangelizzazione africana, asiatica ed americana ebbe dunque un<br />
chiaro sigillo coloniale. Benchè i missionari spesso siano stati dei<br />
validissimi testimoni di Cristo 8 , il contesto storico situò questa predicazione<br />
evangelica sotto il segno del potere economico, politico e culturale.<br />
I cristiani si mostrarono superiori a tutti i livelli e le conversioni<br />
ebbero naturalmente anche motivazioni di interesse o di paura 9 .<br />
Quando, dopo la Rivoluzione Francese e con i grandi progressi<br />
tecnici e industriali, l’Europa si lanciò di nuovo alla conquista del<br />
mondo, la Francia, il Belgio, la Germania e l’Italia si aggiunsero a<br />
questa impresa, soprattutto dopo il Congresso di Berlino condotto<br />
dal Bismark nel 1885. Sorse allora una pleiade di nuove<br />
Congregazioni Missionarie 10 che si rese presente in tutti gli angoli<br />
6 Si pensi per esempio a Recaredo, re dei visigoti in Spagna, nel secolo VI,<br />
e a Stefano, il re d’Ungheria, nel secolo X...<br />
7 I Papi, specialmente Alassandro VI, diedero ai re del Portogallo e della<br />
Spagna il privilegio ed anche l’obbligo della propagazione della fede nei territori<br />
da loro scoperti e conquistati: la costa africana, l’India, dove pure c’erano<br />
già i cristiani di San Tommaso, e l’America furono evangelizzate da missionari<br />
inviati e sostenuti dai re; anche i vescovi erano scelti dall’Ordine di Cristo<br />
(Portogallo) o dal Consiglio delle Indie (Spagna).<br />
8 Pensiamo per esempio a quei poverissimi francescani arrivati nel Messico<br />
con Fra Martin de Valencia nel 1524 o alle condizioni precarie di Francesco<br />
Saverio nella costa Sud dell’India.<br />
9 Pensiamo per esempio all’immenso prestigio culturale dei gesuiti nella<br />
corte dell’imperatore della Cina, con la presenza di P. Matteo Ricci (+1610),<br />
ma anche alla protezione dei soldati spagnoli data ai missionari nelle Filippine,<br />
quando andavano nelle regioni pericolose.<br />
N.B. Nel caso dell’Inghilterra e dell’Olanda, furono le Compagnie commerciali<br />
a incominciare lo scambio con le popolazioni indigene. Solo pian piano<br />
si fece presente anche un’intenzione missionaria. Nelle Molucche, gli olandesi<br />
cercavano di convertire al protestantesimo i cattolici dell’epoca portoghese.<br />
10 Per citare soltanto alcuni nomi: Oblati di Maria Immacolata, Spiritani,<br />
Missionari del Sacro Cuore, Preti del Sacro Cuore, Maristi ecc. in Francia;<br />
Verbiti in Germania, Claretiani in Spagna, Comboniani, Saveriani ed anche
dei continenti fino allora sconosciuti, in particolare in Africa, in<br />
molti territori asiatici a in Oceania. L’America ispano-portoghese<br />
era già praticamente cattolica fin dal secolo XVII.<br />
Dalla metà dell’ottocento alla metà del novecento, da Gregorio<br />
XVI (+ 1846) a Pio XII (+ 1958), abbiamo cent’anni di una incredibile<br />
generosità evangelizzatrice. Le attuali giovani Chiese asiatiche<br />
ed africane presenti già nel Concilio ecumenico Vaticano II sono il<br />
frutto di questo “secolo delle missioni” 11 .<br />
Ma dobbiamo anche qui riconoscere l’influenza di quella caratteristica<br />
che era la superiorità economica, politica e culturale dei paesi<br />
da cui provenivano questi missionari, che, peraltro, erano estremamente<br />
dediti al compito dell’evangelizzazione e spesso cadevano<br />
vittime di malattie e persecuzioni 12 . Bisogna pur dire che le metropoli<br />
hanno cercato sempre di avere missionari della propria nazione,<br />
e che spesso c’era una connivenza nazionalistica tra ecclesiastici e<br />
autorità coloniali 13 .<br />
Dopo la seconda guerra mondiale, la raggiunta indipendenza di<br />
tutte le antiche colonie europee e la celebrazione del Concilio<br />
Vaticano II segnano un nuovo periodo nella storia dell’evangelizzazione<br />
14 .<br />
Salesiani in Italia. Ci sono inoltre le Società Missionarie: dopo quella di Parigi<br />
e quella di Lione, Mill Hill in Inghilterra, San Colombano in Irlanda, PIME in<br />
Italia, Misiones extranjeras in Spagna, Maryknoll negli USA... e tanti Istituti<br />
femminili, forme attive degli antichi Ordini (francescane, domenicane, carmelitane,<br />
agostiniane...) o rami delle nuove fondazioni.<br />
11 Nell’America i cattolici sono il 62,53%, nell’Oceania il 26,28%,<br />
nell’Africa il 17,08 % e nell’Asia il 2,96 % (“Annuario Statistico della Chiesa”<br />
2005).<br />
12 Considerando anche solo il Vietnam, durante l’ottocento possiamo parlare<br />
di migliaia di martiri. I cimiteri missionari dell’Africa, a causa della malaria<br />
ed altre infermità tropicali, sono incalcolabili.<br />
13 Benedetto XV richiamò l’attenzione sul pericolo del nazionalismo nelle<br />
missioni nella lettera apostolica Maximum illud (1919). (Cf. MONGO BETI, Le<br />
pauvre Christ de Bomba).<br />
14 L’enciclica Redemptoris missio del 1990, appartiene pienamente a questa<br />
nuova impostazione.<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
Evangelizzare<br />
partendo<br />
dalla “Kenosi”<br />
123-131<br />
spiritualità<br />
127
pastorale e<br />
spiritualità<br />
GUILLEN PRECKLER<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
128<br />
La pratica attuale dell’evangelizzazione<br />
Diamo infine uno sguardo al mondo di oggi.<br />
Ogni lettore dei Fioretti di San Francesco rimane colpito dal<br />
capitolo sulla “perfetta letizia”. Né la scienza, né i più svariati carismi,<br />
né i più grandi successi apostolici costituiscono la “perfetta letizia”.<br />
Questa si trova soltanto nella pazienza, nell’umiltà, nella partecipazione<br />
alla croce di Cristo. Potremmo dire che qui si trova l’autentica<br />
forza evagelizzatrice secondo Francesco, discepolo di Paolo<br />
e soprattutto di Gesù 15 .<br />
Quando oggi, partendo dalla rinnovata coscienza dell’Incarnazione<br />
del Figlio di Dio, frutto del grande Giubileo 2000, ci proponiamo<br />
un nuovo slancio evangelizzatore, quali caratteristiche<br />
potremmo attribuirgli?<br />
Siamo in un mondo politicamente “post-coloniale”, dove però il<br />
dominio economico e tecnico di alcune nazioni è ancore fortissimo.<br />
Ciò si traduce anche nella supremazia militare. In qualche modo, i<br />
mezzi di comunicazione sociale producono anche una certa certa<br />
agressività culturale, che corre parallelamente alla globalizzazione<br />
commerciale. L’idea di utilizzare questi stessi mezzi per l’evangelizzazione<br />
viene spontanea, e non mancano iniziative in questo senso.<br />
Tenendo presente che i contesti culturali sono diversissimi, oserei<br />
però indicare come paradigma della “nuova evangelizzazione”<br />
una presentazione della Buona Notizia di Cristo senza alcuna pretesa<br />
di potere economico, politico o culturale. Noi cristiani non siamo<br />
i più ricchi, non ci appoggiamo alle leggi che ci favoriscono e non<br />
siamo i più sapienti. Nonostante ciò, annunciamo la Parola del<br />
Regno con autorità, come Gesù e in Gesù. È la forza che ci viene<br />
dal poter presentare la speranza del Regno dei Cieli, dei suoi misteri,<br />
della sua bellezza, della sua bontà, della sua verità, a partire da<br />
una iniziale vittoria sopra ogni male.<br />
La missione evangelizzatrice consisterebbe allora soprattutto<br />
nello stimolare l’esperienza di Gesù, pur sapendo che il vero incontro<br />
con Lui è sempre un mistero della grazia. Paolo ci parlava di<br />
“vocazione”. C’è una preghiera per il Regno di Dio oggi, c’è<br />
un’umiltà di cuore per capire le parabole del Regno oggi, c’è una<br />
15 Il capitolo VIII dei Fioretti, cui facciamo riferimento, finisce con una citazione<br />
di Paolo (Gal 6, 14).
comprensione nuova delle leggi del Regno di Dio tra noi qui, c’è una<br />
gioia della comunione ecclesiale adesso, che irradia aldilà di ogni<br />
intenzione propagandistica. Queste cose fanno sentire la sublimità<br />
dell’Amore di Dio e riscoprire la grazia dei Sacramenti<br />
dell’Incarnazione del Verbo.<br />
Questo tipo di testimonianza integrale può purificare dappertutto<br />
le motivazioni della pastorale e della conversione. La trasformazione<br />
che la Fede in Gesù propone e fa sentire è al di sopra di ogni interesse<br />
umano immediato e riduttivo. Questo benché il Signore mostri<br />
di avere molta pazienza con gli itinerari personali, così diversi e<br />
spesso così interessati all’inizio.<br />
Evangelizzare dalla “kenosi” è dunque in primo luogo abbracciare<br />
lo stile di Gesù nella sua missione redentrice, per quanto paradossale<br />
e assurdo possa sembrare. E’ anche la proposta personale e<br />
paziente dell’esperienza ecclesiale di Gesù. E’ infine l’essere disposti<br />
a morire senza vedere niente, a sperare contro ogni speranza, perchè<br />
il Salvatore di tutti è già assiso alla destra del Padre e intercede<br />
per noi. Ricordiamo la morte solitaria del beato Carlo di Foucauld<br />
nel cuore del Sahara.<br />
Vuol dire questo che disprezziamo ogni sorta di mezzi economici,<br />
politici o culturali? Io direi che ce ne serviamo con una suprema<br />
libertà, cioè che non mettiamo in essi né la ragione né lo scopo del<br />
nostro lavoro apostolico. In altri termini, possiamo dire che non ci<br />
scoraggiamo quando vengono a mancare e che nel più profondo del<br />
cuore, noi poniamo la nostra fiducia in altre risorse, che sono scandalo<br />
e sciocchezza agli occhi di quelli che ci stanno attorno, siano<br />
Ebrei o Greci.<br />
Fra tutte le grazie che lo Spirito Santo può concedere ai pastori e<br />
ai fedeli della Chiesa oggi, non ci sarebbe forse il dono di saper<br />
evangelizzare questo mondo, estremamente bramoso di potere economico,<br />
politico e culturale, partendo dalla “kenosi” di Gesù, e dalla<br />
nostra propria “kenosi”, nella potenza del Mistero Pasquale?<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
Evangelizzare<br />
partendo<br />
dalla “Kenosi”<br />
123-131<br />
spiritualità<br />
129
pastorale e<br />
spiritualità<br />
GUILLEN PRECKLER<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
130<br />
EVANGELIZING CENTERED ON THE KENOSIS<br />
By Fernando Guillen Preckler, Sch.P<br />
The author of this witness-article is a missionary in Africa and he<br />
examines the issue of “New Evangelization” based on experience,<br />
not just historical knowledge. Today more than ever what is required<br />
is an evangelization in which trust is solely in God and the power of<br />
the kerygma, rather than on the support of power and money.<br />
EVANGELISER EN PARTANT DE LA «KENOSE»<br />
Par Fernando Guillen Preckler sch.p.<br />
L’auteur de cet article-témoignage est missionnaire en Afrique ; il<br />
examine le problème de la nouvelle évangélisation en partant de<br />
l’expérience, et aussi des connaissances historiques. Aujourd’hui<br />
plus que jamais s’impose une évangélisation qui met sa confiance<br />
uniquement en Dieu et dans la puissance du kérigme, et non dans les<br />
appuis du pouvoir ou de l’argent.<br />
EVANGELIZAR PARTIENDO DE LA “KENOSIS”,<br />
Por Fernando Guillén Preckler, sch.p.<br />
El autor, misionero en Africa, analiza el problema de la nueva evangelización<br />
a partir de la experiencia, sin excluir los conocimientos<br />
históricos. Más que nunca hoy se exige que la evangelización ponga<br />
su confianza únicamente en Dios y en la potencia del “kerigma”, no<br />
en los apoyos procedentes del poder o del dinero.<br />
EVANGELISIEREN AUSGEHEND<br />
VON DER „KENOSIS“<br />
Von Fernando Guillen Preckler Sch.p.<br />
ENG<br />
FRA<br />
ESP<br />
GER<br />
Der Autor ist Afrikamissionar, und geht in seinem zeugnishaften<br />
Artikel dem Problem der Neuevangelisierung nach. Ausgehend von
Erfahrungen und geschichtlichen Hintergründen legt er dar, dass<br />
heute mehr den je eine Evangelisation gefordert ist, die ausschließlich<br />
auf Gott und auf die Kraft des Kerygmas vertraut, und sich<br />
nicht auf die Unterstützung durch Macht und Geld verlässt.<br />
POL<br />
EWANGELIZACJA WYCHODZĄCA OD KENOZY<br />
Fernando Guillen Preckler SchP<br />
Autor tego artykułu-świadectwa jest misjonarzem w Afryce i analizuje<br />
problem nowej ewangelizacji wychodzącej od doświadczenia<br />
oraz od wiedzy historycznej. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek<br />
oczekuje się na ewangelizację, która swą ufność złożyłaby jedynie<br />
w Bogu i w potędze kerygmatu, nie zaś w oparciu o władzę i<br />
pieniądze.<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
Evangelizzare<br />
partendo<br />
dalla “Kenosi”<br />
123-131<br />
spiritualità<br />
131
di ANTONIO ARTOLA C.P.<br />
Tra il 2008 e l’anno corrente si affollano varie date legate alla<br />
figura di san Gabriele Possenti dell’Addolorata (1838-1862).<br />
Nello scorso anno si sono avute varie manifestazioni legate al<br />
centenario della beatificazione del giovane passionista. Tra queste,<br />
la più rilevante dal punto di vista culturale, è rappresentata<br />
dal IV Colloquio “San Gabriele dell’Addolorata e il suo tempo”.<br />
Il convegno si è tenuto presso il Centro di spiritualità del Santuario<br />
di San Gabriele dal 12 al 13 novembre. Gli interventi di qualificati<br />
relatori si sono estesi dall’ambito<br />
storico (De Mattei, Viglione ed<br />
altri) al campo teologico (Artola,<br />
Baldini, Valentini ed altri) ed a quello<br />
pastorale (Orsini ed altri).<br />
In attesa della pubblicazione degli<br />
Atti del IV Colloquio, presentiamo ai<br />
nostri lettori la relazione del prof.<br />
Antonio M. Artola, che approfondisce<br />
la tematica poco studiata della<br />
vita mistica del santo.<br />
Fondamentale per questa rilettura<br />
della spiritualità del santo la locuzione<br />
mariana del 22 agosto 1856<br />
a Spoleto. Gabriele si sente guardato<br />
da Maria, scelto personalmente<br />
con una locuzione chiara che, come<br />
nel caso di Paolo apostolo o di<br />
Paolo della Croce, non si cancellerà<br />
più dalla sua coscienza: tu non sei fatto per il mondo, sei fatto per<br />
Dio, che ti vuole tutto per sé. La potenza della trasformazione<br />
operata da questa esperienza mostra il suo carattere soprannaturale.<br />
E’, oltretutto, l’espressione tipica di un autentico messaggio<br />
vocazionale.<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
L’ESPERIENZA<br />
MISTICA<br />
DI<br />
SAN GABRIELE<br />
A SPOLETO<br />
Nella vita di S. Gabriele c’è un fatto considerato<br />
come “la fonte di tutte le grazie” che il santo<br />
ricevette nella sua vita religiosa e la spiegazione<br />
della sua santità eroica. E’ l’episodio della<br />
chiamata alla vita passionista avuta il<br />
22.08.1856 a Spoleto 1 . Ma questo fatto singolare<br />
offre, fin dal primo colloquio con il diret- L’esperienza<br />
mistica<br />
1 L’episodio non è stato oggetto di uno studio monografico, per quanto ne<br />
possiamo sapere. Per le fonti dello stesso vedere FONTI STORICO – BIOGRA-<br />
di San Gabriele<br />
a Spoleto<br />
133-154<br />
spiritualità<br />
133
pastorale e<br />
spiritualità<br />
ANTONIO ARTOLA<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
134<br />
tore spirituale di Gabriele, P. Bompiani, S. J., svariate interpretazioni,<br />
che non hanno ancora raggiunto un consenso soddisfacente. Tra<br />
i testimoni della santità di S. Gabriele, come nella generalità dei suoi<br />
biografi, c’è una tendenza che riduce al minimo l’influsso sensibileuditivo<br />
della locuzione della Vergine. La maggior parte degli scrittori<br />
narra il fatto pensando che nella locuzione di Spoleto non vi fu<br />
niente che superasse la normalità delle esperienze di religiosità<br />
intensa che sfociano in una decisione vocazionale. In altre parole, la<br />
locuzione di Spoleto non solo non fu accompagnata da nessun epifenomeno<br />
di ascolto straordinario, ma consistette solo in una specie<br />
di forte ispirazione interiore, percepita in tal senso, o, al massimo,<br />
come una semplice locuzione interiore. Questa si può chiamare<br />
interpretazione minimalista che esclude nell’episodio ogni straordinarietà<br />
mistica o psicologica. Questa interpretazione richiede una<br />
revisione. Sarebbe possibile un’alternativa che ammetta, almeno per<br />
ipotesi, nell’episodio di Spoleto, qualcosa di straordinario, almeno<br />
di tipo mistico, se non si vuol parlare di un’esperienza visibile o sensibile?<br />
Se questa interpretazione fosse vera, riterremmo che l’esperienza<br />
di Spoleto fu simile alla locuzione-visione che provocò la<br />
conversione di Andrés Frossard. Questo è il problema alla cui soluzione<br />
desidera contribuire questo studio.<br />
La domanda sulla<br />
natura del fenomeno<br />
di Spoleto<br />
fu posta già dal canonico<br />
Carlo Bonaccia2 I. Lettura critica delle fonti<br />
, ma<br />
egli lasciò la risposta aperta per future investigazioni. La diversità<br />
delle testimonianze processuali è sconcertante. Questo complica la<br />
cosa. Perfino nel P. Norberto si trovano versioni del fatto notevolmente<br />
diverse tra di loro. Questo stato confuso delle fonti esige una<br />
FICHE DI S. GABRIELE DELL’ADDOLORATA, Edizione critica a cura di Natale<br />
Cavatassi c.p e Fabiano Giorgini c.p. Edizioni “Eco” 1969. Questa opera<br />
verrà citata in appresso con la sigla FS. Il P. Franco D’Anastasio ha raccolto con<br />
cura tutti i dettagli del fatto in S. GABRIELE DELL’ADDOLORATA. 100 anni di<br />
ricerche. 1892 – 1992. Editoriale Eco, 1994, pp. 341 – 342.<br />
2 “Se queste fossero voci articolate e sensibili, oppure solamente interiori<br />
non è da me a giudicarlo” (FS p. 307, 27 – 29).
previa lettura critica delle medesime, prima di affrontare la questione<br />
della natura teologica del singolare episodio.<br />
1. I primi testimoni dei fatti<br />
Il primo testimone dell’episodio di Spoleto è il gesuita P. Carlo<br />
Giuseppe Bompiani 3 . Nel pomeriggio di venerdì 22 agosto 1856<br />
Gabriele aveva vissuto una forte esperienza religiosa che volle sottomettere<br />
al discernimento del suo direttore, P. Bompiani. Questi lo<br />
ricevette nelle prime ore del pomeriggio di domenica 24 agosto.<br />
All’inizio la confidenza di Gabriele gli sembrò strana. La superficialità<br />
del giovane Possenti non faceva presagire una decisione tanto<br />
radicale come l’entrata in un convento 4 . Con molta cura gli chiese<br />
chiarimenti sulla “voce” 5 . Si riferiva, senza dubbio, alla chiamata<br />
della Vergine che gli aveva causato un cambiamento così improvviso.<br />
La deposizione del gesuita nel processo di beatificazione, nella<br />
sua brevità, offre già tutti i dati essenziali dell’episodio vocazionale<br />
e delle sue notevoli circostanze. Il P. Bompiani traccia in rapide pennellate<br />
la vita del giovane diretto da lui, menziona le difficoltà interpretative<br />
del fatto della “voce” misteriosa in cui sembra appoggiarsi<br />
l’improvviso cambiamento del giovane Possenti. L’insieme delle<br />
confidenze produsse nel direttore un effetto positivo, motivo per cui<br />
egli approvò la decisione vocazionale che veniva sottomessa al suo<br />
discernimento.<br />
Un punto fermo nella deposizione del P. Bompiani è che tutto il<br />
fatto che provocò l’assorbente decisione vocazionale era dovuto a<br />
una misteriosa voce. Questo primo fatto, riportato nella deposizione<br />
del Bompiani, lo terranno sempre fermo i diversi testimoni che<br />
deporranno nel processo, e lo considereranno come essenziale per<br />
3 Sulle circostanze della deposizione del P. Bompiani vedere la nota introduttiva<br />
di FS p. 289.<br />
4 “Amava i divertimenti, le conversazioni, il teatro, ed il vestire gaio, era di<br />
buon ingegno” (FS p. 290). “Fu proclive alla vanità, amante, come ho detto di<br />
sopra, dei divertimenti, dei teatri, delle conversazioni” (FS p. 290, nota 2).<br />
5 “Nell’estate del 1855 [1856], in domenica, nelle ore pomeridiane il Servo<br />
di Dio mi domandò un abboccamento. Lo condussi alla mia scuola; quivi candidamente<br />
mi aprì l’idea di rendersi religioso <strong>Passio</strong>nista. Io gli rappresentai<br />
quei motivi che chiarissero donde fosse questa voce” (FS p. 291).<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
L’esperienza<br />
mistica<br />
di San Gabriele<br />
a Spoleto<br />
133-154<br />
spiritualità<br />
135
pastorale e<br />
spiritualità<br />
ANTONIO ARTOLA<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
136<br />
tutto l’episodio. Però nella deposizione del gesuita appare ugualmente<br />
chiaro che Gabriele non fu molto esplicito nel riferirgli la natura<br />
concreta della voce. Perciò gli chiese chiarimenti su questo particolare.<br />
Sicuramente il gesuita desiderava sapere se era una voce interiore<br />
- una ispirazione - o una locuzione esteriormente percepibile.<br />
La deposizione assume una grande importanza, poiché si riferisce<br />
al momento storico più vicino al fatto, e rivela già i primi problemi<br />
della sua interpretazione. Per questa interpretazione bisogna<br />
tenere presente che, secondo lo stesso Bompiani, Gabriele era molto<br />
riservato nelle sue cose 6 . Questa riservatezza e timidezza furono<br />
senz’altro la causa per cui il giovane non fu né completo né chiaro<br />
nelle sue confidenze. Queste osservazioni non bastano per iniziare<br />
lo studio. Iniziamo da una domanda fondamentale: chiarì veramente<br />
Gabriele al suo direttore il dettaglio della sua esperienza? Oppure<br />
si rifugiò nella sua riservatezza e si limitò a informare il suo direttore<br />
soltanto dell’essenziale del fatto? E’ probabile che Gabriele abbia<br />
detto soltanto che davanti all’immagine della Vergine si sentì chiamato<br />
a entrare in religione.<br />
Se il primo atteggiamento davanti al direttore fu quello di una<br />
confidenza discreta, ridotta all’essenziale, è lecito pensare che mai<br />
parlò con maggiore chiarezza, e la laconicità delle prime conversazioni<br />
resterà come una fermezza psicologica le cui barriere mai<br />
infranse completamente. Dobbiamo sospettare che questa riservatezza<br />
dei primi giorni immediati all’esperienza spirituale, porterà il<br />
santo a non entrare mai in dettagli intimi nel riferire il fatto misterioso.<br />
Ciò che richiama l’attenzione nel Bompiani è che - sebbene<br />
conoscesse la vita superficiale che Gabriele conduceva 7 e nonostante<br />
che il giovane mai avesse dimostrato propensione alcuna alla vita<br />
religiosa 8 - lo assicura che aveva vocazione 9 . Un altro dettaglio<br />
6 “Era amante di mantenere il segreto sui fatti suoi specialmente sul suo interno”<br />
(FS p. 290, nota 2).<br />
7 “Egli fu contento e superò gran parte delle difficoltà e del padre e delle<br />
altre persone autorevoli che v’interpose. La cosa procedeva, ma l’ultimo colpo<br />
di grazia la SS. Vergine lo riservò a se stessa” (FS p. 291, nota 3).<br />
8 “Francesco Possenti non aveva mai mostrato, che io rammenti, propensione<br />
allo stato religioso” (FS p. 310, 5 – 6).<br />
9 “Considerai alquanto la proposta: vidi che non era né capriccio, né slancio<br />
di fervore fantastico, né ignorava delle difficoltà che quello stato di vita gli<br />
avrebbe opposto; conclusi approvando il suo consiglio: me ne rallegrai e rimisi<br />
la cosa a suo padre, la cui approvazione era necessaria” (FS p. 291, nota 3).
importante è che, narrando retrospettivamente l’episodio nel processo,<br />
lo giudicasse dagli effetti che quella chiamata produsse nell’impegno<br />
di vita che ne seguì. Riferisce, in concreto, che un altro spoletino<br />
entrò con lui nel noviziato di Morrovalle, ma solo Gabriele<br />
perseverò 10 .<br />
Il ciclo dei primi tempi del Bompiani include, in secondo luogo,<br />
Sante Possenti. Scrivendo il padre di Gabriele dopo due giorni dall’avvenimento<br />
a suo nipote, Giovanni Possenti, lo informa della<br />
chiamata avuta da suo figlio di farsi passionista 11 . Sante è seguito dal<br />
fratello di Gabriele, Luigi Tommaso Possenti. E’ il terzo testimone<br />
nell’ordine cronologico del fatti. Parlando della chiamata di suo fratello,<br />
fa menzione dello sguardo del santo all’immagine della<br />
Vergine 12 .<br />
2. Il canonico Paolo Bonaccia<br />
La prima biografia di Gabriele fu opera del canonico Bonaccia.<br />
La sua fonte principale fu un manoscritto che il P. Norberto aveva<br />
composto dopo un mese dalla morte di S. Gabriele (27.03.1862) per<br />
consolare il padre. Il testo fu spedito nell’aprile dello stesso anno 13 .<br />
In questo testo, chiamato Cenni, per la prima volta il direttore del<br />
santo parlò del fatto misterioso della vocazione. Il P. Norberto, nella<br />
relazione della vita del giovane, sembra dominato dal desiderio di<br />
evitare i racconti di cose straordinarie. Sicuramente utilizzò nei<br />
Cenni il metodo biografico che alcuni anni dopo avrebbe consigliato<br />
al canonico Bonaccia per comporre la sua biografia. Doveva<br />
applicare al santo il clichè della vita di S. Francesco di Sales 14 .<br />
Questa narrazione del P. Norberto è di una discrezione estrema sul<br />
10 FS p. 292.<br />
11 FS, p. 343.<br />
12 “Gli parve di osservare nel simulacro della Vergine, portato processionalmente,<br />
di essere da lei chiamato allo stato religioso” (FS p. 269).<br />
13 Storia del testo in FS p. 178. Testo in FS pp. 176 – 219.<br />
14 “L’idea dominante che ha da campeggiare in tutto il lavoro ha da essere<br />
una santità e una virtù sul taglio di S. Francesco di Sales, una santità e virtù<br />
facile, spontanea, dolce, amabile, e nel tempo medesimo intiera, totale, generosa,<br />
forte, costante. Riusciragli alquanto difficile incarnare in tutto il suo lavoro<br />
questo duplice carattere; ma se vuole presentarla originale e genuina, la virtù<br />
di Confr. Gabriele fu tale” (Ulteriori Notizie p. 262).<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
L’esperienza<br />
mistica<br />
di San Gabriele<br />
a Spoleto<br />
133-154<br />
spiritualità<br />
137
pastorale e<br />
spiritualità<br />
ANTONIO ARTOLA<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
138<br />
fatto mariano della vocazione, fino al punto di passare sotto silenzio<br />
tutto ciò che di straordinario sarebbe potuto apparire nell’episodio 15 .<br />
Ecco perché abbiamo chiamato il testo il più minimalista di tutti.<br />
Non appare in esso né lo sguardo, né tanto meno la voce della<br />
Vergine a Gabriele. Appare solo la commozione religiosa che fa scaturire<br />
dal suo intimo alcune riflessioni a mo’ di rimorsi sulla sua vita<br />
nel mondo, perché doveva entrare in religione. Quello che il P.<br />
Norberto sottolinea con interesse è l’effetto della commozione interiore,<br />
cioè il cambiamento completo di vita 16 . Risulta strano che, a<br />
solo sei anni dagli avvenimenti e mentre afferma di conoscere tutto<br />
il mondo interiore di Gabriele, sappia così poche cose sull’evento di<br />
Spoleto 17 . Questa prima relazione dei Cenni il P. Norberto la completò<br />
più tardi con un altro documento chiamato Ulteriori Notizie. In<br />
questo scritto aggiunse un dato che doveva avere una grande importanza<br />
nell’elaborazione dell’episodio della vocazione nella biografia<br />
del Bonaccia. Questo documento puntualizzava che Gabriele, guardando<br />
la Vergine, udì una “interna, efficace locuzione” 18 .<br />
15 “Il nostro defunto vi si portò ma alla sbadata, e più per curiosità che per<br />
altro; ma colà appunto lo aspettava Maria: ché muovendosi la processione<br />
portò lo sguardo sull’immagine della Madonna, e nel mirarla si sentì all’istante<br />
sorgere con vivezza in questi riflessi: Ma io non sono fatto per il mondo; che<br />
pensiero vi faccio io nel mondo? Tu sei fatto per Iddio, Iddio ti vuole tutto per<br />
sé, ti chiama al cielo, presto fatti Religioso!” (FS p. 208).<br />
16 “Da questo punto si sentì mutato nel cuore e nelle inclinazioni, e non<br />
sospirava altro che di effettuare il suo disegno; finché il mise in esecuzione con<br />
risultato tanto felice. E qui devo aggiungere che dopo sentitosi chiamare si sforzava<br />
di non dare a divedere ad alcuno le sue intenzioni, ma, come mi è stato<br />
detto da più d’uno, nol poté fare con tal segretezza da non farne trasparire<br />
qualche indizio” (FS p. 208).<br />
17 L’ipotesi che si può fare è che Gabriele parlò della sua esperienza mariana<br />
con il maestro che lo diresse nel noviziato, P. Raffaele di S. Antonio. In quel<br />
tempo il P. Norberto era solo vice maestro e non stava in contatto intimo con<br />
Gabriele. Quando divenne direttore del giovane professo, le cose di Spoleto<br />
erano ormai lontane, e non fu necessario che Gabriele narrasse in dettaglio le<br />
circostanze di detto avvenimento. Gabriele si limitò a riferirgli genericamente<br />
l’essenziale di tutto quello che era avvenuto.<br />
18 Il documento fu scoperto nel 1982 dal P. Verducci (Cfr. Claudio Verducci<br />
LE CARTE BONACCIA, Manoscritti inediti riguardanti S. Gabriele<br />
dell’Addolorata, in S. GABRIELE DELL’ADDOLORATA E IL SUO TEMPO, Studi –<br />
Ricerche – Documentazione, 2, Edizioni Eco, 1986, pp. 235 – 288). Il testo<br />
che citiamo appare a p. 264. Sebbene dica che si parla di questa voce in<br />
Cenni, il fatto è che nello scritto non si menziona questa locuzione efficace, ma<br />
si parla solo di un soliloquio di Gabriele.
Ritornando alla narrazione di P. Norberto, c’è in essa un giudizio<br />
di valore che domina tutto l’episodio. Fin dal primo momento, il<br />
P. Norberto considera l’evento di Spoleto come la fonte di tutte le<br />
grazie 19 . Per il direttore è la pietra angolare del futuro edificio spirituale<br />
di S. Gabriele. Come nel caso di tutte le conversioni, il primo<br />
momento è il più decisivo di tutta la vita nuova che inizia e a cui<br />
seguirà un cambiamento. Questo basta perché in uno studio della<br />
santità e della mistica del santo, tutto si debba guardare da questo<br />
primo episodio.<br />
Su questo impagabile testo costruì Bonaccia la sua biografia.<br />
L’autore era un compagno di studi del santo 20 . Utilizzò nella sua<br />
opera i Cenni del P. Norberto, completati con le Ulteriori Notizie.<br />
Per offrire una relazione omogenea, modificò il tenore dei Cenni<br />
introducendo due fatti nuovi: lo sguardo della Vergine a Gabriele e<br />
la chiamata vocazionale attribuita direttamente alla voce di Maria.<br />
Per fare questo utilizzò l’informazione del P. Norberto sulla voce<br />
interiore. Per incorniciare la chiamata della Vergine aggiunse lo<br />
sguardo della Vergine a Gabriele. Non solo fece questo, ma per di<br />
più sfumò anche lo sguardo di Gabriele alla Vergine facendolo<br />
incontrare con il sorriso di Maria. Aggiunse solo un verbo per sfumare<br />
la storicità della sua relazione. Aggiunse un verbo dubitativo<br />
per evitare un’affermazione tranciante sulla visione: “gli pare”, cioè<br />
Gabriele crede che la Vergine lo guardi e gli diriga le parole della<br />
chiamata.<br />
La voce interiore menzionata dal P. Norberto 21 ha ispirato al<br />
Bonaccia la classica immagine di Gabriele che fissa gli occhi nella<br />
19 “… questa sola [grazia], che è stata la sorgente di tutte le altre. Questa<br />
grazia la ricevé evidentemente da Maria” (FS p. 208).<br />
20 Vedere i riferimenti alla persona in FS p. 297 – 8.<br />
21 Se è certa questa ipotesi che la modificazione narrativa del Bonaccia<br />
dipende dal P. Norberto, la sua operazione narrativa non sarebbe granché, e<br />
il P. Norberto apparirebbe come il testimone privilegiato di tutto quello che si<br />
sa sull’episodio mariano. Bonaccia aggiunge al chiarimento del P. Norberto il<br />
suo dubbio sulla natura della voce “articolata e sensibile”. E’ curiosa la coincidenza<br />
del P. Norberto in Ulteriori Notizie con la descrizione del Bompiani sulla<br />
“voce”. Si noti il termine “articolato” che apparirà in seguito nel P. Norberto,<br />
in PA, FS p. 29, nota 13. Bonaccia tenne fermo il suo riferimento alla “voce”<br />
in FS p. 309: “Non potea Francesco dimenticare quel luogo dove avea sentito<br />
la voce della sua Madre divina, né potea starle vicino senza sentire una fora<br />
misteriosa che lo attirava”.<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
L’esperienza<br />
mistica<br />
di San Gabriele<br />
a Spoleto<br />
133-154<br />
spiritualità<br />
139
pastorale e<br />
spiritualità<br />
ANTONIO ARTOLA<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
140<br />
Icona 22 e la Vergine che lo guarda e gli parla con una efficace locuzione<br />
interiore. Ma non si azzarda ad affermare che si trattava di una<br />
locuzione sensibile della Vergine 23 . Ricomposto in questo modo il<br />
fatto, Bonaccia trae tutte le conseguenze dalla sua ricostruzione storica,<br />
cioè quanto di virtuoso apparve nella successiva vita di<br />
Gabriele ebbe la sua origine da questa visione 24 . In ragione di questo<br />
principio sviluppa in forma oratoria molto ampia quello che era<br />
contenuto nella fonte dei Cenni. Il primo effetto dell’intervento di<br />
Maria fu come la ferita prodotta da un dardo spirituale che si conficcò<br />
nella sua anima 25 . Per Bonaccia tutti i cambiamenti che avvennero<br />
nella nuova vita di Gabriele avevano la loro origine nell’episodio<br />
della Santa Icona. La Vergine suscitò nel suo cuore la decisione di<br />
lasciare il mondo. Pertanto, in un modo o nell’altro, l’origine di tutto<br />
era nell’incontro con la venerata immagine mariana. Gli fu sufficiente<br />
questo per porre nella bocca della Vergine le parole dell’ammonizione-chiamata.<br />
Gabriele ricordò sempre questa chiamata, fino<br />
alla sua morte 26 . Il Bonaccia presentò i cambiamenti nella vita di<br />
22 “Questi era Francesco Possenti; il quale avvicinandosi alla sua volta la<br />
Icone augusta, leva in alto gli occhi per vagheggiarla. La guarda, e pargli che<br />
la Vergine benedetta lo riguardi a vicenda, gli sembra di vedersi diretta un’occhiata<br />
speciale, dietro lo sguardo risonargli in cuore queste parole: ‘Francesco,<br />
il mondo non è più per te; ti aspetta la religione’” (FS p. 307).<br />
23 Vedere nota 2.<br />
24 Questa chiarificazione del P. Norberto può spiegare la menzione della<br />
voce interiore attribuita alla Vergine, al posto del soliloquio di Cenni. Se è certa<br />
questa ipotesi, la modifica del Bonaccia non sarebbe granché. Si baserebbe in<br />
un chiarimento dello stesso P. Norberto. In FS p. 309, Bonaccia farà espressa<br />
menzione della voce così com’era contenuta in Ulteriori Notizie: “Non potea<br />
Francesco dimenticare quel luogo dove avea sentito la voce della sua Madre divina,<br />
né potea starle vicino senza sentire una forza misteriosa che lo attirava” (FS<br />
p. 309). Con ciò il Padre appare come il testimone privilegiato di tutto quello che<br />
si sa sull’episodio mariano. Il dubbio del Bonaccia era centrato unicamente sul<br />
senso della locuzione “articolata e sensibile”. E’ possibile che il P. Norberto, nella<br />
descrizione in PA, quando definisce la locuzione mariana come articolata, forse<br />
risponde al dubbio del Bonaccia: “Se queste fossero voci articolate e sensibili,<br />
oppure solamente interiori, non è da me a giudicarlo”. Si noti la parola “articolato”,<br />
che apparirà in seguito nel P. Norberto, PAA. In FS p. 309 sarà più categorico<br />
e affermerà senza esitazione la presenza della voce mariana.<br />
25 “Restò egli dunque siccome saettato e la ferita fu così profonda che non<br />
ebbe più pace finché non si raccolse in religione” (FS p. 307).<br />
26 “Ebbe egli a confessare al suo direttore di spirito che soventi volte dopo<br />
quel tempo solea rientrare nei segreti della sua coscienza e dire a se stesso:<br />
“Che fai, o Francesco? Tu non sei più del mondo, il mondo non è più tuo”<br />
(FS p. 307).
Gabriele sulla base di citazioni bibliche 27 e di esempi presi dalla vita<br />
dei santi 28 . Le conseguenze furono soprattutto interiori: nessuno si<br />
rese conto del cambiamento interiore operato dalla chiamata mariana<br />
29 . Tuttavia, già pochi giorni dopo l’avvenimento misterioso, si<br />
notò subito il cambiamento di Gabriele nel modo di comportarsi<br />
nelle feste mondane, specialmente nel teatro 30 . La chiamata che<br />
aveva avuto luogo vicino alla cattedrale gli aveva fatto sorgere<br />
un’attrattiva speciale per il luogo della chiamata 31 .<br />
27 “Esci dalla tua casa e dalla tua patria, vanne dove la voce di Dio ti chiamò.<br />
Il Signore ha chiamato, egli ha risposto al suo invito: se oggi ascolti la chiamata<br />
non voler chiudere gli orecchi [……]. La voce del Signore è una ruota che<br />
passa. Temi Iddio che va oltre e non si rivolge indietro a chiamar due volte.<br />
Ricordati di Matteo che lascia il telonio, di Pietro che getta via le nasse e le reti<br />
e tengono dietro al Signore. Chi pon mano all’aratro e poi ristà non è adatto<br />
pel cielo” (FS pp. 307 – 8).<br />
28 “Con questi pensieri venia Francesco maturando il pensiero di darsi a Dio<br />
nella religione” (FS p. 308).<br />
29 “Ma questo lavorio della grazia si compiva tutto all’interno, poiché nell’esterno<br />
nulla appariva. Intendea bene Francesco quanto sia necessario<br />
nascondere il tesoro celeste, affinché mano profana non istorpi i disegni divini,<br />
così la conchiglia al mattino si schiude per raccogliere la manna del cielo, ma<br />
avutala si racchiude e la serba per formare a tempo la perla, che sarà poi l’ornamento<br />
di corone regali. Pertanto avresti visto questo giovane conservare la<br />
forma ricercata del vestire, il medesimo procedere festoso ed ameno e, quanto<br />
all’apparenza, lo stesso intervenire ai profani spettacoli, alle conversazioni, ai<br />
teatri. Ma se avessi potuto penetrare con l’occhio sotto il suo elegante vestito e<br />
sotto la morbida tela che gli proteggea la vita, avresti con maraviglia ed orrore<br />
veduto una larga cinta di duro cuoio munita di aspre ed acuminate punte di<br />
ferro, la quale correndo in giro ai suoi delicati fianchi, tenea l’ufficio di cilizio;<br />
la qual cosa potrebbe ancor di leggieri attestarsi da coloro i quali coi propri<br />
occhi videro ed ebbero in mano il rigido strumento di penitenza” (FS p. 308).<br />
30 “Quanto poi ai teatri avvenne cosa da essere ricordata; la quale insegna<br />
che altro era il Francesco che appariva altro il Francesco che si nascondeva.<br />
Nel corto tempo che trascorse dalla sua chiamata all’ingresso nella religione,<br />
solea, conforme il costume, frequentare il teatro in compagnia di suo padre.<br />
Questo prendea posto in uno dei palchi signorili per favore e gentilezza di quello<br />
a cui appartenea; ma per l’angustia del luogo, non potendo aversi accanto<br />
il figliuolo Francesco, lo lasciava andare alla loggia superiore in compagnia di<br />
altri suoi conoscenti ed amici. Francesco fingeva d’andarvi ma frattanto se ne<br />
usciva soletto dal teatro e se ne venia chetamene al portico della chiesa cattedrale<br />
contigua (poiché l’antico teatro cittadino distava sol pochi passi) ed ivi<br />
passava in preghiera il tempo del profano divertimento” (FS pp. 308 – 9).<br />
31 Per ordinario solea entrare nella chiesa che di quel tempo teneasi aperta<br />
fino a gran notte per soddisfare alla pietà dei cittadini che accorrevano in calca<br />
a ringraziare la Vergine la quale l’anno innanzi avea liberata la città da morbo<br />
del colera…. Talvolta però trovando le porte chiuse gettavasi ginocchione<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
L’esperienza<br />
mistica<br />
di San Gabriele<br />
a Spoleto<br />
133-154<br />
spiritualità<br />
141
pastorale e<br />
spiritualità<br />
ANTONIO ARTOLA<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
142<br />
Questo discorso e questo ampliamento consistente sull’effetto<br />
della chiamata, avranno un grande influsso nelle dichiarazioni del P.<br />
Norberto nel Processo Ordinario.<br />
3. Il P. Norberto e le sue testimonianze processuali<br />
Il P. Norberto aveva già letto la relazione del Bonaccia quando<br />
fece la sua prima deposizione canonica nel Processo Ordinario. Non<br />
si può negare che la biografia ebbe un grande influsso sul P.<br />
Norberto per comprendere quello che già sapeva sull’episodio<br />
mariano di Spoleto. Vediamolo. In questa relazione il P. Norberto ha<br />
introdotto due cose nuove: prima di tutto la commozione interiore<br />
dovuta allo sguardo della Vergine; in secondo luogo non è Gabriele<br />
colui che riflette dicendosi interiormente le parole sulla fuga dal<br />
mondo, bensì è la stessa Vergine che gliele dirige. E questo con una<br />
locuzione interna distinta, viva ed efficacissima. Questo dettaglio lo<br />
aveva aggiunto ai Cenni in Ulteriori Notizie, come già ho detto.<br />
Continuando sviluppa in forma nuova l’efficacia della voce 32 .<br />
Il P. Norberto tornò a deporre nel Processo Ordinario. Questo è il<br />
testo dove appare meglio profilato il suo pensiero sulla vera natura<br />
del fenomeno spoletino. In primo luogo introducendo lo sguardo<br />
della Vergine al giovane 33 e, con lo sguardo, l’ammonimento sulla<br />
sua vita nel mondo 34 . Però il P. Norberto continua togliendo impor-<br />
nell’atrio e di là facea giungere le sue calde preghiere fino all’altare della<br />
Vergine SS.ma. Non potea Francesco dimenticare quel luogo dove avea sentito<br />
la voce della sua Madre divina, né potea starle vicino senza sentire una<br />
forza misteriosa che lo attirava. Bel contrapposto frattanto vedere quel giovane<br />
col ginocchio sul suolo, coll’occhio al cielo, collo spirito in Dio nell’ora istessa<br />
che nel luogo vicino molti altri giovani pari suoi, immersi in profani piaceri,<br />
ebbri di gioia bugiarda perdevansi avidamente dietro seducenti spettacoli, col<br />
cuore forse piagato e coll’anima contaminata dalla colpa” (FS p. 309).<br />
32 “Questa vista e questa voce lo cambiarono si fattamente nei sentimenti<br />
che senza prender tempo corse immediatamente a consultare l’affare della propria<br />
vocazione col P. Bompiani della Compagnia di Gesù, al quale disse sentirsi<br />
chiamato alla Congregazione dei <strong>Passio</strong>nisti” (FS p. 29).<br />
33 “Giunto presso l’immagine, gli parve che la Madonna lo guardasse con<br />
uno sguardo assai distinto e al tempo stesso sentì nel proprio interno una voce<br />
articolata, distinta, che gli diceva: “Tu non sei fatto per il mondo; presto fatti<br />
religioso” (FS p. 29, nota 13).<br />
34 FS p. 29, nota 13.
tanza alla parte visiva del fenomeno con un “gli parve vedere”, che<br />
mantiene dalla narrazione del Bonaccia. Modifica il sorriso di Maria<br />
sottolineando che si trattò di qualcosa di differente dagli altri sguardi.<br />
La voce stessa è finalmente descritta come “articolata” e distinta,<br />
ma solo interiore 35 .<br />
Questi cambiamenti del pensiero del P. Cassinelli meritano un<br />
esame. Come abbiamo già detto, nei Cenni non c’è niente che vada<br />
al di là di una semplice reazione religiosa di una coscienza inquieta,<br />
mentre Gabriele guarda con amore l’immagine della Vergine, nel<br />
corso di una solenne processione popolare tanto radicata nella città.<br />
Il problema è come P. Norberto passò dalla narrazione tanto minimalista<br />
dei Cenni al Processo Ordinario Spoletino, cambiando il<br />
soggetto stesso della locuzione, dal soliloquio interiore e soggettivo<br />
di Gabriele a una locuzione personalizzata dalla Vergine; e questo,<br />
non sotto la forma di una insinuazione interiore, ma sotto la forma<br />
di una locuzione viva ed efficace.<br />
A mio modo di vedere, intervennero due cose. In primo luogo la<br />
chiarificazione avvenuta nella stessa interiorità di Norberto mentre<br />
componeva le sue Ulteriori Notizie, dove parla di una voce. C’è<br />
stato tutto un lavoro per ricordare i detti di Gabriele. In Cenni l’attenzione<br />
del direttore si concentra sull’accumulo di piccoli dettagli<br />
edificanti, non curando il rapporto e l’importanza degli stessi in relazione<br />
con l’intera vita del santo. Tra i Cenni e il Processo Ordinario<br />
si deve collocare questo lavoro interiore del P. Norberto, che le<br />
Ulteriori Notizie attestano. In secondo luogo, la nuova messa a<br />
fuoco che diede la biografia del Bonaccia a tutto quello che si riferiva<br />
alla locuzione. D’altra parte la vita santa e straordinaria di<br />
Gabriele esigeva un principio intimo di intervento divino di un ordine<br />
superiore ed efficace. Non si può distinguere tra quello che è vero<br />
ricordo e quello che è interpretazione teologica delle cause.<br />
Nel testo del Processo Ordinario Norberto ritoccò letteralmente il<br />
testo di Cenni, mantenendo i dubbi sulla percezione visiva della<br />
Vergine e sottolineando da questa prospettiva la condizione interna<br />
della locuzione.<br />
35 Bonaccia intende “articolato” come sinonimo di acusticamente percepibile.<br />
Norberto lo intende come locuzione formale interiore.<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
L’esperienza<br />
mistica<br />
di San Gabriele<br />
a Spoleto<br />
133-154<br />
spiritualità<br />
143
pastorale e<br />
spiritualità<br />
ANTONIO ARTOLA<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
144<br />
4. Conclusione critica<br />
La conclusione critica che si deduce da questo esame è che il P.<br />
Norberto conservava un ricordo evanescente dell’insieme dell’episodio<br />
mariano di Spoleto. Ricordava solo in maniera confusa che la<br />
decisione vocazionale sorse come una grazia dall’incontro del santo<br />
con l’immagine della Vergine, come risultato di una commozione<br />
interiore che gli procurava la sua vita mondana, la quale esigeva un<br />
cambiamento completo con l’entrata in religione 36 . Il racconto del<br />
Bonaccia lo fece riflettere, e gli fece dare un’espressione differente<br />
all’insieme della relazione, facendo intervenire la Vergine nella<br />
locuzione e abbreviando la locuzione stessa.<br />
Dal ricordo evanescente dei Cenni Bonaccia trasse la sua relazione,<br />
e, da questa, Norberto migliorò la sua. Il risultato fu che lo sguardo<br />
di san Gabriele scopre nel volto della Vergine uno sguardo<br />
sorridente, accompagnato da una locuzione interiore di chiamata<br />
vocazionale.<br />
I tre “logia” della vocazione ricordano il fenomeno dei “logia”<br />
dei Vangeli, trasmessi in forma diversa dagli evangelisti.<br />
Facendo una epurazione critica sembra che nel Bompiani abbiamo<br />
la relazione più arcaica. Questa relazione contiene già la voce. Il fatto<br />
che Bompiani abbia letto il Bonaccia non significa che il gesuita abbia<br />
preso dal canonico la menzione della voce. Poiché il ricordo della<br />
voce appare completato nel ricordo di cui il direttore chiese spiegazioni<br />
rispetto alla stessa. La forma più antica è quella del Bompiani, con<br />
la menzione della voce. Cenni ci dà approssimativamente il tenore di<br />
questa voce, ma a modo di soliloquio di Gabriele. Ulteriori Notizie<br />
introduce una voce interiore efficace. Bonaccia pone sulle labbra della<br />
Vergine le parole, abbreviandole, e Norberto si attiene, nelle sue deposizioni<br />
processuali, al puro tenore del Bonaccia. Questo sembra il<br />
risultato più verosimile della lettura critica delle fonti.<br />
36 Un buon indizio di questa imprecisione dei ricordi è il diverso tenore delle<br />
parole della chiamata. In Cenni scrive: “Ma io non sono fatto per il mondo, che<br />
pensiero vi faccio io nel mondo. Tu sei fatto per Iddio, Iddio ti vuole tutto per<br />
sé, ti chiama al cielo; presto fatti religioso!” (FS p. 208). Nonostante ciò nei<br />
POS le parole sono: “Tu non sei fatto per il mondo, presto fatti religioso”.<br />
Bonaccia riporta: “Francesco, il mondo non è più per te; ti aspetta la religione”<br />
(FS p. 29). Non è azzardato supporre che la citazione più breve del Bonaccia<br />
ha indotto il P. Norberto alla semplificazione.
Per quanto riguarda la testimonianza del Bompiani dobbiamo<br />
riflettere sul carattere riservato di Gabriele, che sicuramente, fin dal<br />
principio, ricusò di fornire dettagli molto personali e straordinari.<br />
Sicuramente fu molto discreto col suo direttore. Più discreto coi suoi<br />
familiari. Con il P. Norberto mantenne la stessa discrezione. Quella<br />
riservatezza iniziale fece trovare a Gabriele qualche formula espressiva<br />
sufficientemente chiara per dar ragione del cambiamento operato<br />
da quell’incontro, ma lo frenò dal dare dei dettagli personali più<br />
intimi che chiarissero le circostanze. L’esperienza di Spoleto fu, con<br />
ogni probabilità, un segreto che il santo si portò nella tomba.<br />
Dalla lettura cri-<br />
II. Lettura teologica<br />
tica delle fonti<br />
si può ritenere<br />
come dato storicamente<br />
certo che a Spoleto Gabriele sentì una locuzione che aveva relazione<br />
con la Santa Icona. Perciò iniziamo la lettura teologica dall’analisi<br />
di questo fatto, così come ce lo narrano le fonti.<br />
1. La locuzione<br />
Essendo il primo elemento certo che abbiamo incontrato nel<br />
Bompiani, vediamo il senso di questo fenomeno. Già il Bompiani<br />
desiderò accertare i dettagli della locuzione. Bonaccia lascia nell’aria<br />
la domanda se fu una mera locuzione interiore o una parola<br />
udita acusticamente.<br />
Iniziamo dalle relazioni più antiche, che sono quelle del P.<br />
Norberto. Secondo il direttore di Gabriele, le parole furono un soliloquio<br />
interiore che il santo fece tra sé e sé. Ma questo soliloquio fu<br />
provocato dall’incontro con la Icona. Questo ci mette sulla pista di<br />
ciò che i mistici chiamano le locuzioni successive. In queste l’elemento<br />
caratteristico è che la locuzione parte da un intervento<br />
soprannaturale di Dio, ma poi il soggetto che l’ha ricevuta la prolunga<br />
con riflessioni proprie a modo di linguaggio interiore 37 .<br />
37 Il maestro più autorizzato che ha scritto sul tema è S. Giovanni della<br />
Croce in Salita del Monte Carmelo, L. II, cap. XXIX, il quale le descrive in questo<br />
modo: “Le parole successive accadono quando lo spirito, essendo raccolto<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
L’esperienza<br />
mistica<br />
di San Gabriele<br />
a Spoleto<br />
133-154<br />
spiritualità<br />
145
pastorale e<br />
spiritualità<br />
ANTONIO ARTOLA<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
146<br />
Nei Cenni il P. Norberto narra che l’impatto dell’incontro di<br />
Gabriele con l’immagine della Vergine suscita nel suo interno un<br />
soliloquio sulla sua vita, con grande disgusto della stessa, e una<br />
opzione per la vita religiosa. Pertanto c’è un intervento forte della<br />
grazia. A questo intervento seguono le riflessioni di Gabriele, suscitate<br />
dall’emozione dell’incontro. Si tratta di una locuzione successiva<br />
all’intervento mariano, le cui parole però si devono al soggetto<br />
stesso colpito dall’incontro personale. La verità del fatto della locuzione<br />
interiore successiva appare garantita dai singolari effetti che<br />
ne seguirono.<br />
e assorto in qualche considerazione, scorre nella materia che pensa da una<br />
cosa all’altra, formando parole e ragioni molto bene appropriate, con molta<br />
facilità e distinzione, discute e scopre cose non mai sapute, tanto da sembrargli<br />
che non è lui che fa tutto ciò, ma che un’altra persona interiormente gli suggerisce<br />
le ragioni, le risposte e gli insegnamenti. Ed invero ha gran motivo di<br />
pensare questo, perché egli stesso ragiona con sé e si risponde come se fosse<br />
una persona con un’altra, e in qualche modo si può dire che sia così. Perché,<br />
quantunque lo spirito umano è quegli che opera, nondimeno molte volte è aiutato<br />
dallo Spirito Santo a produrre e formare quei concetti, parole e ragioni<br />
vere, e quindi parla a se stesso come se fosse terza persona. L’intelletto allora<br />
è raccolto e unito con la verità di ciò che pensa, e anche lo Spirito Divino è<br />
unito con lui in quella verità, come lo è sempre in ogni verità. Per cui ne segue<br />
che l’intelletto, comunicando in tal modo con lo Spirito Divino mediante quella<br />
verità, ne ricava successivamente le altre che hanno attinenza con quella,<br />
aprendogli la porta, per così dire, e infondendogli luce il Celeste Maestro, lo<br />
Spirito Santo, di cui è proprio insegnare anche in questa maniera”.<br />
Le parole successive che descrive il santo sono quelle che avvengono durante<br />
l’orazione. Ma si può dare la successione in un ordine distinto. Questo è il<br />
caso di un intervento divino soprannaturale, che il destinatario della grazia in<br />
questione prolunga mediante l’attività della propria intelligenza. Questo può<br />
essere il caso del soliloquio interiore di S. Gabriele, se diamo come reali e storiche<br />
le parole riferite in Cenni dal P. Norberto. Così il P. ROYO MARIN chiarisce<br />
la natura più generale di queste locuzioni: “A prima vista queste locuzioni<br />
sono puramente umane, giacché il Santo ci dice che lo spirito le va formando<br />
e ragionando. Ma, come spiega in seguito, in realtà procedono dalla luce<br />
divina dello Spirito Santo, che ‘lo aiuta molte volte a produrre e formare quei<br />
concetti, parole e ragioni vere’. Per questo l’anima le va formando con tanta<br />
facilità e perfezione. E’ un’azione combinata dello Spirito Santo e dell’anima,<br />
‘di modo che possiamo dire che la voce è di Giacobbe e le mani sono di Esaù.’<br />
E si chiamano successive perché non si tratta di una luce istantanea e intuitiva,<br />
ma di una luce con cui lo Spirito Santo va istruendo l’anima con ragionamenti<br />
successivi”. (Cfr TEOLOGIA DELLA PERFEZIONE CRISTIANA, BAC, n. 144,<br />
Madrid, 1955, p. 821).
La locuzione attribuita direttamente alla Vergine appartiene a un<br />
altro tipo di locuzioni. Sono quelle chiamate parole formali o locuzioni<br />
formali 38 .<br />
Per determinare il carattere delle parole udite da S. Gabriele,<br />
abbiamo alcune indicazioni convergenti di Norberto e Bonaccia.<br />
Anche il Bonaccia è il primo a segnalare la visione che antecede la<br />
locuzione, sebbene con l’aggiunta che “gli parve” 39 .<br />
2. Lo sguardo della Vergine<br />
Norberto nella deposizione processuale allude - anche se molto<br />
discretamente - a una forma di visione 40 . Il fenomeno che descrive<br />
P. Norberto assomiglia a quello del sorriso della Vergine a Santa<br />
Teresina, che la curò dalla sua terribile infermità infantile.<br />
Queste descrizioni non escludono una discreta presenza dell’elemento<br />
visivo, sebbene non fosse più che sotto la forma di uno sguardo<br />
tenero, distinto da quello che offre la visione materiale dell’immagine<br />
bizantina.<br />
Questi dati ammettono anche la possibilità che in S. Gabriele si<br />
fosse verificato un duplice fenomeno successivo: quello della locuzione<br />
e quello della visione. Nella Bibbia quasi sempre la locuzione<br />
è preceduta o seguita da una visione. Però a volte, come nella vocazione<br />
di Abramo (Gen 12, 1), ci sono locuzioni senza la corrispon-<br />
38 Di queste locuzioni parla S. Giovanni della Croce nella Salita del Monte<br />
Carmelo, L. II, cap. XXX. Il citato P. Royo Marìn le spiega così: “Queste locuzioni<br />
sono quelle che si percepiscono nella conoscenza come provenienti chiaramente<br />
da altro, senza che uno ponga niente da parte sua, sia che lo spirito stia<br />
raccolto sia che stia distratto, a differenza delle successive che si riferiscono<br />
sempre a ciò che lo spirito stava considerando. Per se stesse le parole intellettuali<br />
formali non possono mai indurre ad errore. Il motivo è perché né la conoscenza<br />
pone qualcosa da parte sua, né il demonio ha potere diretto su di essa.<br />
Nonostante questo però la conoscenza può avere illusioni, prendendo per<br />
parole divine gli artifici del demonio sull’immaginazione” (Ibidem, p. 821).<br />
39 “Francesco Possenti [….] il quale avvicinandosi alla sua volta la Icone<br />
augusta, leva in alto gli occhi per vagheggiarla. La guarda, e pargli che la<br />
Vergine benedetta lo riguardi a vicenda, gli sembra di vedersi diretta un’occhiata<br />
speciale” (Fs, p. 307.<br />
40 “Giunto presso l’immagine, gli parve che la Madonna lo guardasse con<br />
uno sguardo assai distinto” (FS p. 29, nota 13).<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
L’esperienza<br />
mistica<br />
di San Gabriele<br />
a Spoleto<br />
133-154<br />
spiritualità<br />
147
pastorale e<br />
spiritualità<br />
ANTONIO ARTOLA<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
148<br />
dente visione. Nella storia dei santi si danno ugualmente casi di<br />
associazione e di dissociazione della locuzione e della visione. S.<br />
Luigi Gonzaga sente, nel palazzo reale di Madrid, la chiamata della<br />
Vergine a entrare nella Compagnia di Gesù. Essa gli proviene da una<br />
immagine della Vergine del Buon Consiglio. Ciononostante in<br />
Andrés Frossard, c’è una locuzione seguita da una visione. Nel caso<br />
di S. Gabriele il problema è se l’analogia più vicina è la vocazione<br />
di S. Luigi o la conversione del Frossard.<br />
Tenendo conto della riservatezza personale di Gabriele, si può<br />
proporre l’ipotesi che a Spoleto sia avvenuta una visione seguita da<br />
una locuzione. Forse quando Bompiani gli chiese chiarimenti sulla<br />
voce, si riferiva a questa connessione o soltanto alla natura della sola<br />
voce. Nel caso della vocazione di Gabriele c’è un duplice segreto.<br />
Vi fu una visione della Vergine, al di là della sobria menzione dello<br />
sguardo di Maria fatta dal Bonaccia e da Norberto? Gabriele parla<br />
qualche volta nella sua vita fornendo tutti i dettagli della sua vocazione?<br />
3. La verifica<br />
Secondo i maestri spirituali mai si sa con certezza se le locuzioni<br />
o le visioni sono di vera origine divina. La controprova è data<br />
dagli effetti. Ed è qui dove tutti i testimoni insistono con fermezza:<br />
in san Gabriele, al di là dell’episodio mariano, avvenne un vero e<br />
profondo cambiamento spirituale. Questo punto merita di essere<br />
ampliato.<br />
Già abbiamo segnalato varie volte l’accordo dei testimoni su questo<br />
particolare. Ora aggiungeremo dei dati nuovi.<br />
Il vero carattere conflittuale di S. Gabriele appare ben documentato<br />
dalla lettera del padre del 1852 41 . In verità questa lettera coinci-<br />
41 “Devo ora incomodarvi per una cosa che molto m’interessa, ed a voi solo<br />
posso affidarne l’esecuzione. Vorrei porre in codesto seminario il mio figlio<br />
Checchino, che è pieno di fuoco, e che non combina affatto cogli altri fratelli e<br />
sorelle, e che non vuol attendere allo studio, quantunque dimostri dei talenti e<br />
qualche propensione per farsi prete. Vorrei pertanto che v’informaste da codesto<br />
signor rettore se vi sia il posto per il medesimo”. Ladislao Ravasi, Paolo<br />
Possenti, in SAN GABRIELE DELL’ADDOLORATA E IL SUO TEMPO, Studi –<br />
Ricerche – Documentazione, 2, Edizioni Eco, 1986, p. 54.
de con l’adolescenza del santo, e la crisi a cui allude Sante potrebbe<br />
essere passata all’epoca della vocazione. Ma l’indicazione del P.<br />
Norberto che Gabriele era molto collerico, induce a pensare che<br />
c’erano componenti della sua personalità che non lo facevano molto<br />
predisposto alla santità. Bonaccia afferma che il suo comportamento<br />
dava a pensare che non era fatto per la vita religiosa.<br />
Il P. Norberto narra un fatto della vita di san Gabriele quando era<br />
già religioso. Trovandosi un giorno in un convento gesuita per alcuni<br />
affari familiari, dopo il colloquio il P. Superiore chiamò a parte P.<br />
Norberto e gli domandò del comportamento di Gabriele. Davanti al<br />
franco elogio del direttore, il gesuita gli disse che tra di loro si aveva<br />
un’altra opinione del giovane religioso 42 . Questo dettaglio corrobora<br />
le condizioni del carattere di Gabriele prima di entrare nella<br />
Congregazione. La grazia di Spoleto lo cambiò profondamente.<br />
Questa controprova dei fatti e la virtù eroica di Gabriele, approvata<br />
dalla Chiesa, dimostrano che l’esperienza di Spoleto fu una vera e<br />
soprannaturale esperienza divina, si tratti di visione o di locuzione.<br />
Vi è nella biografia<br />
di S. Gabriele<br />
un segreto<br />
che ha incuriosito<br />
tutti i biografi. E’ il caso<br />
del suo famoso quadernetto di note personali.<br />
C’è in questo fatto qualche dettaglio degno di menzione. Prima<br />
di tutto era un piccolo quaderno43 che riportava le grazie ricevute<br />
dalla Vergine44 III. Il segreto di San Gabriele<br />
. Secondo i biografi, la grazia più grande fu per il<br />
santo la locuzione mariana che lo convertì e lo chiamò alla vita<br />
religiosa.<br />
42 Cfr. Fs, p. 35.<br />
43 Questo scritto riceve diversi nomi nella dichiarazione processuale di P.<br />
Norberto: “giornaletto”, “un piccolo plico”, “libretto”.<br />
44 “Poco dopo che si fu comunicato, avutomi da solo mi disse: ‘là nel cassetto<br />
sono andato registrando le grazie che conosceva di aver ricevuto dalla<br />
Madonna. Temo che il demonio se ne possa servire per tentarmi di superbia e<br />
di vanagloria. Mi promette di levarlo e di non farlo vedere ad alcuno?’. ‘Glielo<br />
prometto – gli risposi – anzi le prometto di non vederlo neppure io’. ‘Va bene’<br />
replicò. E poi con insistenza e con una grazia indescrivibile aggiunse: ‘Si ricor-<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
L’esperienza<br />
mistica<br />
di San Gabriele<br />
a Spoleto<br />
133-154<br />
spiritualità<br />
149
pastorale e<br />
spiritualità<br />
ANTONIO ARTOLA<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
150<br />
E’ lecito pensare che la prima pagina del quaderno contenesse<br />
questo racconto. Il silenzio assoluto con cui aveva custodito quel<br />
fatto esigette un giorno da lui la necessità di trasportarlo sulla carta.<br />
Non c’è ragione per negare quel che Norberto dice: che conosceva<br />
personalmente tutte le grazie che Gabriele aveva ricevuto da<br />
Maria 45 . Però conosceva egli tutti i particolari di quelle grazie? Non<br />
c’è dubbio che conosceva l’essenziale della grazia di Spoleto 46 . Ma<br />
i dettagli? Sapeva se era una locuzione solo interiore o anche sensibile?<br />
Conosceva il tenore esatto delle parole? Sapeva se le pronunziò<br />
la Vergine o le pronunziò Gabriele a se stesso? Sapeva se la locuzione<br />
fu completata da una visione mariana?<br />
Il timore della vanagloria poteva alimentarsi molto bene del pensiero<br />
che la lettura del suo quaderno avrebbe svelato il segreto del<br />
suo incontro con la Vergine, custodito tanto gelosamente. Lascio al<br />
lettore la risposta a queste interessanti domande. Per me è certo che<br />
lo sguardo speciale fu una “grazia” della Vergine come il sorriso di<br />
Maria per santa Teresina.<br />
La locuzione interiore – secondo le descrizioni dei processi – fu<br />
una locuzione soprannaturale secondo il tipo delle “parole successive”<br />
o delle “parole formali”, ma certamente fu una locuzione misti-<br />
di che ogni promessa è debito’. ‘Stia tranquillo” – gli risposi. Si tranquillizzò né<br />
mai più mi fece parola di tal cosa. Mi pentii e mi pento di essere stato troppo<br />
corrivo e troppo largo in promettere e di aver promesso anche più di ciò che<br />
mi dimandava, e molto più mi pento di aver mantenuto troppo fedelmente e<br />
troppo presto le promesse. Egli non avea difficoltà che vedessi io, a cui nulla<br />
teneva celato, ma voleva che non conoscessero gli altri. Ma conoscendo i tesori<br />
di quell’anima, sapendo quanto con lui l’avesse il demonio, considerando<br />
che un assalto in quel punto poteva distruggere l’opera con tante fatiche compiute<br />
in sei anni, senza tanto riflettere, volli assicurarla anche in questo modo.<br />
E affinché Conf. Gabriele non avesse ragione di sospettare e fosse sicuro del<br />
fatto, andai a prendere il giornaletto, mi recai a distruggerlo e ritornato all’infermo<br />
gli dissi che era già tutto distrutto. Ne mostrò molto contento, e gustosamente<br />
sorridendo mi disse: ‘Va bene’” (FS p. 157).<br />
45 “Del resto io già conoscevo tutto quello che vi era, perché Conf. Gabriele<br />
non aveva segreti per me. Mi interessava solo di rasserenare l’anima di un<br />
morente” (FS p. 157, nota 9).<br />
46 I primi giorni di tutto l’anno del noviziato furono quelli più opportuni perché<br />
Gabriele rivelasse i dettagli della sua vocazione. Ma in quel tempo il P.<br />
Norberto era solo vice – maestro e non aveva una relazione molto personale e<br />
intima con lui. Quando ha parlato col suo direttore di quell’episodio? Quante<br />
cose gli ha riferito?
ca, come lo dimostrò il corso dell’intera vita di Gabriele. Non v’è<br />
dubbio che la vita religiosa di San Gabriele cominciò con una esperienza<br />
mistica mariana. Questa è la grazia dello sguardo della Santa<br />
Icona. Questo è il segreto di S. Gabriele.<br />
ENG<br />
(Traduzione dallo spagnolo di P. Lorenzo Baldella c.p.)<br />
SAINT GABRIEL’S MYSTICAL EXPERIENCE IN<br />
SPOLETO<br />
By Antonio Artola, C.P.<br />
From the year 2008 till the present moment a considerable amount<br />
of data regarding St. Gabriel Possenti of the Sorrowful Virgin<br />
(1838-1862) has come to light. In the course of last year there have<br />
been a number of events connected with the centenary of the young<br />
<strong>Passio</strong>nist’s beatification among the more relevant of which from a<br />
cultural point of view was the 4 th Conference on “St. Gabriel and his<br />
Time.” This was held at the Spirituality Center at St. Gabriel’s<br />
shrine the 13 th – 14 th November 2008. Qualified speakers covered<br />
from the historical field (De Matei, Viglione and others) to the theological<br />
one (Artola, Baldini, Valentini and others) and to the pastoral<br />
one (Orsini and others.)<br />
As we await the publication of the Minutes of the aforementioned<br />
meeting, we offer our readers the talk given by Professor Antonio M.<br />
Artola, C.P. who covered a barely studied topic the mystical life of<br />
the saint. He founded his words largely on the Marian Talks of the<br />
22 nd August 1856 in Spoleto. Gabriel keenly felt Mary gaze upon him<br />
and addressed by clear words – as in the cases of St. Paul the<br />
Apostle and St. Paul of the Cross – which would never leave his<br />
mind: “You were not made for this world, you were made for God<br />
who wants you all for himself.” The very power of the transformation<br />
brought about by this experience points to its supernatural<br />
nature. It was, above all else, the typical expression of an authentic<br />
vocational message.<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
L’esperienza<br />
mistica<br />
di San Gabriele<br />
a Spoleto<br />
133-154<br />
spiritualità<br />
151
pastorale e<br />
spiritualità<br />
ANTONIO ARTOLA<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
152<br />
L’EXPÉRIENCE MYSTIQUE DE SAINT GABRIEL À<br />
SPOLÈTE<br />
Par Antonio Artola c.p.<br />
En 2008 et dans l’année en cours, certaines dates se présentent, qui<br />
sont liées à la figure de saint Gabriel Possenti de l’Addolorata<br />
(1838-1862). L’année dernière, eurent lieu diverses manifestations<br />
liées au centenaire de la béatification du jeune passioniste. Parmi<br />
ces dates, la plus importante du point de vue culturel, est celle du<br />
4 ème Colloque « Saint Gabriel de l’Addolorata et son temps ». Ce<br />
congrès s’est tenu près du Centre de spiritualité du Sanctuaire de<br />
Saint Gabriel, du 12 au 13 novembre. Les conférences d’ intervenants<br />
qualifiés sont parties du contexte historique (De Mattei,<br />
Viglione etc.) pour s’étendre jusqu’au domaine théologique (Artola,<br />
Baldini, Valentini etc.) et à celui de la pastorale (Orisini etc.).<br />
Dans l’attente de la publication des Actes du 4 ème Colloque, nous<br />
présentons à nos lecteurs la conférence du prof. Antonio M. Artola,<br />
qui approfondit la question peu étudiée de la vie mystique du saint.<br />
La parole de Marie du 22 août 1856 à Spolète est fondamentale<br />
pour cette relecture de la spiritualité du saint. Gabriel se sent<br />
regardé par Marie, choisi personnellement par une parole claire<br />
qui, comme dans le cas l’apôtre Paul ou de Paul de la Croix, ne s’effacera<br />
plus de son esprit : tu n’es pas fait pour le monde, tu es fait<br />
pour Dieu, qui te veut tout à lui. La puissance de la transformation<br />
opérée par cette expérience montre son caractère surnaturel. C’est,<br />
par dessus tout, l’expression typique d’un authentique appel à la<br />
vocation.<br />
LA EXPERIENCIA MISTICA DE SAN GABRIEL<br />
EN SPOLETO<br />
Por Antonio Ma. Artola, c.p.<br />
FRA<br />
ESP<br />
En 2008 y 2009 se están acumulando varias fechas vinculadas a la<br />
figura de San Gabriel Possenti de la Dolorosa (1838-1862). Entre<br />
las diversas manifestaciones del año pasado, vinculadas al centenario<br />
de su beatificación, destaca, desde el punto de vista cultural, el<br />
IV Coloquio sobre “San Gabriel de la Dolorosa y su tiempo”, en el<br />
Centro de Espiritualidad del Santuario de San Gabriel los días 12-
13 de noviembre. Las intervenciones de cualificados expositores<br />
han tratado el ambiente histórico (De Mattei, Viglione...), el campo<br />
teológico (Artola, Baldini, Valentini...) y el pastoral (Orsini...).<br />
Mientras se prepara la publicación de las Actas del IV Coloquio,<br />
presentamos la conferencia del prof. Antonio Ma. Artola, sobre un<br />
tema poco estudiado, la vida mística del santo; en este aspecto<br />
ocupa lugar fundamental la “locución” mariana del 22 de agosto<br />
de 1856 en Spoleto. Gabriel se sintió mirado por la Virgen María y<br />
llamado personalmente, mediante una locución clara, que, como<br />
ocurrió en el caso de San Pablo de la Cruz, no se borraría nunca de<br />
su conciencia: Tú no has sido hecho para el mundo, sino para Dios,<br />
que te quiere todo suyo. La transformación notable que esta experiencia<br />
obró en él demuestra su carácter sobrenatural, y es, además,<br />
expresión típica de un auténtico mensaje vocacional.<br />
GER<br />
DIE MYSTISCHE ERFAHRUNG DES HEILIGEN<br />
GABRIEL IN SPOLETO<br />
Von Antonio Artola CP<br />
2008 und 2009 häufen sich verschiedene Termine, die mit dem heiligen<br />
Gabriel Possenti von der Schmerzhaften Mutter (1838-1862)<br />
zusammenhängen. Im vergangenen Jahr fand die Hundertjahrfeier<br />
der Seligsprechung des jungen <strong>Passio</strong>nisten vielfältigen Ausdruck.<br />
Am bedeutendsten war aus kultureller Sicht das IV. Kolloquium:<br />
„Der Heilige Gabriel von der Schmerzhaften Mutter und seine<br />
Zeit“, das vom 12. bis 13. November am Zentrum für Spiritualität<br />
beim Heiligtum San Gabriele veranstaltet worden ist. Die Beiträge<br />
der hoch qualifizierten Vortragenden erstreckten sich über die<br />
Bereiche Geschichte (De Mattei, Viglione, u. a.), Theologie (Artola,<br />
Baldini, Valentini u. a.) und Pastoral (Orsini u. a.).<br />
Während die Publikation der Kolloquiumsbeiträge noch aussteht,<br />
stellen wir unseren Lesern hier das Referat von Prof. Antonio M.<br />
Artola vor. Darin geht er dem noch wenig erforschten mystischen<br />
Leben des Heiligen nach. Das Fundament für seine Untersuchung<br />
bildet die Marienerscheinung vom 22. August 1856 in Spoleto.<br />
Gabriel erfährt die eindeutige Erscheinung, die sich - ähnlich wie<br />
beim heiligen Apostel Paulus oder beim heiligen Paul vom Kreuz –<br />
nicht mehr aus seinem Bewusstsein tilgen lässt, als eine persönliche<br />
pastorale<br />
e<br />
spiritualità<br />
L’esperienza<br />
mistica<br />
di San Gabriele<br />
a Spoleto<br />
133-154<br />
spiritualità<br />
153
pastorale e<br />
spiritualità<br />
ANTONIO ARTOLA<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
spiritualità<br />
154<br />
Zuwendung und Erwählung durch die Maria: Du bist nicht für die<br />
Welt gemacht. Du bist für Gott geschaffen, der dich ganz für sich<br />
haben will. Gerade die transformierende Kraft, die diese Erfahrung<br />
ausübt, zeigt deren übernatürlichen Charakter. Sie ist vor allem der<br />
typische Ausdruck einer echten Berufungsbotschaft.<br />
DOŚWIADCZENIE MISTYCZNE ŚW. GABRIELA W<br />
SPOLETO<br />
Antonio Artola CP<br />
POL<br />
Między rokiem 2008 a rokiem bieżàcym nagromadziło się wiele<br />
rocznic zwiàzanych ze św. Gabrielem od Matki Bożej Bolesnej<br />
(Possenti, 1838-1862). W roku ubiegłym miały miejsce różne<br />
wydarzenia zwiàzane ze stuleciem beatyfikacji młodego pasjonisty.<br />
Wśród nich najbardziej znaczàce z kulturalnego punktu widzenia<br />
było IV Kolokwium „Święty Gabriel od Matki Bożej Bolesnej i jego<br />
czasy”. Miało ono miejsce w Centrum Duchowości przy<br />
Sanktuarium św. Gabriela w dniach 12-13 listopada. Referaty<br />
kompetentnych mówców dotyczyły zwłaszcza problematyki<br />
historycznej (De Mattei, Viglione i in.), teologicznej (Artola,<br />
Baldini, Valentini i in) i pastoralnej (Orsini i in.).<br />
Oczekując na publikację Akt IV Kolokwium przedstawiamy naszym<br />
czytelnikom referat prof. Antonio M. Artoli, który zgłębia temat mało<br />
zbadany z życia mistycznego świętego. Podstawà relektury<br />
duchowości świętego jest maryjna lokucja z 22 sierpnia 1856 r. w<br />
Spoleto. Gabriel czuje, że Maryja patrzy na niego, wybiera go<br />
osobiście poprzez wyraźnà lokucję, która, jak w przypadku św.<br />
Pawła Apostoła i św. Pawła od Krzyża nigdy się już nie zatrze w<br />
jego świadomości: „Ty nie jesteś przeznaczony dla świata. Ty jesteś<br />
przeznaczony dla Boga, który chce Cię w całości dla siebie”. Moc<br />
przemiany dokonanej przy tej okazji pokazuje jej nadprzyrodzony<br />
charakter. Przede wszystkim zaś jest typowym wyrazem<br />
autentyczności przesłania powołaniowego.
di TITO AMODEI C.P.<br />
In memoria di padre Adriano di Bonaventura.<br />
Per venticinque anni il padre Adriano di Bonaventura, passionista<br />
(1934-2008), ha diretto con costanza, sacrifici ed entusiasmo<br />
la Biennale di Arte Sacra di San Gabriele (TE). La<br />
Biennale che egli aveva immaginata e fondata nel 1984 a<br />
Pescara, poi trasferita nel complesso<br />
conventuale del Gran<br />
Sasso.<br />
IL VALORE<br />
DI UNA<br />
PROFEZIA<br />
Se la profezia è un annunzio in<br />
nome di una autorità superiore<br />
è doveroso ritenere che<br />
l’impegno e il lavoro di padre Adriano nella promozione<br />
dell’arte sacra ha avuto tutti i requisiti che la profezia<br />
suppone.<br />
L’appello accorato di Paolo<br />
VI e le indicazioni del Concilio<br />
nella Costituzione Sacrosanctum<br />
Concilium, che rivendicano<br />
all’arte una funzione di supporto<br />
essenziale alla stessa<br />
manifestazione della fede, come<br />
gridava Paolo VI, in questo<br />
lungo lasso di tempo, che ci<br />
separa dal Concilio sono stati<br />
fatti cadere in maniera irresponsabile.<br />
Soprattutto dalla gerarchia<br />
e dalle istituzioni cominciando<br />
da quelle preposte alla<br />
pastorale e alla formazione del<br />
clero e dei fedeli.<br />
salvezza<br />
e<br />
culture<br />
Il valore<br />
di una profezia<br />
155-161<br />
culture<br />
155
salvezza e<br />
culture<br />
TITO AMODEI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
culture<br />
156<br />
Non si è voluto capire quanto l’arte sia formatrice delle coscienze<br />
e crei spazi a quell’amore che è e resta il primo comandamento<br />
per ogni fedele che entri in chiesa. E l’immagine in questione è quella<br />
che nasce qui ed oggi; è quella che ci rappresenta perché testimonia<br />
quello che siamo o quello che dobbiamo essere. Più di qualunque<br />
trattato sociologico, più di qualsiasi analisi e scandaglio psicologico.<br />
A sorpresa questo comando del Concilio e l’appello di Paolo VI<br />
li raccoglie il padre Adriano inventandosi la Biennale di arte sacra.<br />
“Uno sprovveduto”, per sua onesta e disarmante confessione.<br />
Proprio perché tale va incontro alla mole enorme delle difficoltà e<br />
della fatica che una simile impresa, per sua natura, comporta. Egli<br />
viene da una ben diversa formazione. Biblista ed insegnante, dirotta<br />
la sua attenzione sull’arte sacra contemporanea. Con piacevole sorpresa<br />
degli addetti al lavoro.<br />
Egli sa che Cristo “omni modo” deve essere annunziato 1 . E quel<br />
omni modo deve accadere anche con l’arte che nasce dal nostro vissuto<br />
contemporaneo.<br />
Uno specialista del settore lo avrebbe irriso o, ad essere benevoli,<br />
l’avrebbe compatito quando nel 1984 a Pescara, organizzò la 1°<br />
Biennale d’Arte Sacra a carattere nazionale.<br />
Per accreditare la sua iniziativa, parte dal grido dell’Evangelii<br />
Nuntiandi che recita: “La rottura tra Vangelo e cultura è senza dubbio<br />
il dramma del nostro tempo” e che egli pone come esergo alla<br />
sua introduzione al catalogo della 1° Biennale.<br />
Consapevole della estraneità della sua formazione culturale ai<br />
fermenti dell’arte di oggi si premura di affidarne la direzione ai professionisti<br />
del settore che accoglierà, sempre, tra i più noti e qualificati.<br />
Nelle ultime edizioni, i curatori saranno numerosi, perché la<br />
Biennale esibisse uno spettro sempre più vasto della ricerca contemporanea.<br />
Va a suo merito di aver lasciato loro la più assoluta autonomia<br />
nella scelta delle opere da presentare. E suo merito ancora, di<br />
non aver mai guardato alla loro ideologia.<br />
Più curatori, più vasta l’accoglienza di forme espressive e diversificate<br />
e più efficace il sempre misterioso campo degli stimoli del<br />
tema sacro. La differente formazione dei curatori costituiva anche<br />
una non indifferente dialettica tra i concetti che supportavano le<br />
1 Fil. 1, 18.
scelte e risultati delle diverse Biennali tanto da poter affermare che<br />
i cataloghi delle medesime danno un prezioso ed ampio rendiconto<br />
di quanto veniva accadendo nell’evolvere della ricerca artistica<br />
degli ultimi anni.<br />
Questi cataloghi sono anche un’inconfutabile testimonianza della<br />
risposta variegata data da artisti non solo di provenienza diversificata<br />
nei loro linguaggi ma anche, e direi soprattutto, del loro senso del sacro.<br />
Questi cataloghi, attestano ancora che da parte degli organizzatori<br />
non si è mai dato indirizzo vincolante né di stile né di illustrazioni<br />
e attestano inoltre la partecipazione di affermatissimi artisti che<br />
non si sono sottratti a confrontarsi con colleghi meno affermati.<br />
Magari artisti star i quali agli inizi pareva che snobbassero il tema<br />
sacro (del resto indefinibile e irriducibile a canoni precostituiti) o<br />
che si rifiutassero di apparire nella lista che avesse comunque un’<br />
origine ecclesiastica.<br />
Nel 1992 la Biennale da Pescara fu trasferita nel complesso conventuale<br />
di San Gabriele al Gran Sasso (TE) potendo fruire di spazi<br />
più idonei.<br />
La partecipazione si andò sempre più ampliando e fu possibile<br />
dotare la Biennale di una biblioteca sull’arte e via via, creare un<br />
museo sulla <strong>Passio</strong>ne, invitando gli artisti ad esservi presenti con<br />
delle loro opere.<br />
Parallelamente all’impegno della Biennale il padre Adriano crea<br />
dei corsi per la formazione dei giovani artisti al tema sacro; corsi<br />
arrivati alla quinta edizione, e condotti da notissimi maestri. I risultati<br />
hanno convinto della bontà della iniziativa.<br />
Dall’anno 1993 la Biennale si arricchisce dell’apporto culturale,<br />
di grande respiro, del salesiano Don Carlo Chenis, attualmente<br />
vescovo di Tarquinia e Civitavecchia e già Segretario dei Beni<br />
Culturali della Santa Sede. Con Chenis, le varie edizioni iniziano a<br />
diventare anche tematiche. Con lui nasce anche la festa dell’artista.<br />
Il valore e il peso della Biennale di San Gabriele sono variamente<br />
quantificabili.<br />
Cominciando dalla constatazione che era proprio necessaria la<br />
sua creazione. Se non lo fosse stata non sarebbe durata tanto a<br />
lungo: un quarto di secolo! E non avrebbe prodotto così tanti frutti<br />
e suscitato tanti interessi ed attenzione.<br />
Prima della Biennale di San Gabriele altre ne erano sorte in Italia<br />
nel secolo scorso, ma tutte di vita breve. Nate da coraggioso volontarismo<br />
ma non prese in debita considerazione dalle gerarchie,<br />
salvezza<br />
e<br />
culture<br />
Il valore<br />
di una profezia<br />
155-161<br />
culture<br />
157
salvezza e<br />
culture<br />
TITO AMODEI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
culture<br />
158<br />
anche se indicative di potenziali risultati, se si guarda all’interesse<br />
suscitato tra gli artisti e la cultura laica.<br />
Anche nel resto dell’orbe cattolico manifestazioni simili non<br />
hanno avuto molta fortuna e lunga vita. E la spiegazione del fenomeno<br />
ci porterebbe lontano; tuttavia sarebbe utile approfondire questa<br />
complessa materia che direbbe molto sulla cultura nella Chiesa e<br />
il prezzo che essa ha pagato per avere sottovalutato l’apporto che<br />
l’arte avrebbe potuto dare alla promozione della fede.<br />
L’arte per sua natura cerca visibilità. Viene prodotta nella solitudine<br />
dall’artista che è provocato dai fermenti di cui spesso egli stesso<br />
ignora l’origine ma che sono ineludibili; esprimendoli in forme<br />
sue proprie produce linguaggio e questo deve comunicare.<br />
Fino a tutto il ‘700, nelle grandi città gli artisti esponevano le loro<br />
opere sul sagrato delle chiese perché tutti potessero vederle e giudicarle.<br />
Anche se l’approvazione definitiva era riservata al committente.<br />
E dal sagrato, se l’immagine lo consentiva, passava facilmente ad<br />
occupare gli spazi sacri.<br />
Molto dopo nasce l’istituzione delle gallerie d’arte, luoghi selettivi<br />
per amatori ed intenditori. Oppure si creano eventi per un pubblico<br />
più vasto con le Biennali e le Quadriennali, nelle quali si tentavano<br />
dei consuntivi sullo stato di salute dell’arte e sulle ricerche<br />
linguistiche che via via venivano portate avanti. Non si richiedevano<br />
supporti ideologici, salvo che nelle opere sollecitate o promosse<br />
da regimi dittatoriali.<br />
In quelle rassegne sempre più vaste e sempre più attente al contemporaneo<br />
la Chiesa e il sacro erano sistematicamente bandite.<br />
Anche perché, il prodotto che guardasse alla religione non avrebbe<br />
retto il confronto con quanto la ricerca più avanzata offriva. Anzi,<br />
dal versante del sacro non c’erano quasi mai proposte. Avendo la<br />
Chiesa ripiegato da tempo, per coprire il fabbisogno di iconografia,<br />
sul prodotto commerciale, deprimente e impersonale della offensiva<br />
chincaglieria.<br />
Se l’arte ufficiale ignorava il tema sacro, per la diffusa laicizzazione<br />
della società e della cultura, la cultura ecclesiastica le voltava<br />
le spalle. Il danno, per lungo tempo, è stato irreparabile.<br />
E anche alla Biennale di San Gabriele, così colta, così libera, da<br />
facilmente accogliere anche i linguaggi più avanzati o sperimentali,<br />
malgrado l’impegno e il coraggio, oltre che la fatica del fondatore,<br />
e il fermo proposito di non farla morire nella Chiesa italiana, per<br />
molto tempo non fu accordata particolare attenzione dai rappresen-
tanti ufficiali dalla Gerarchia. Anche se più tardi la Cei le accorda<br />
credito e sostegno.<br />
Finalmente il 25 novembre 2008 la Fondazione Stauròs, di cui la<br />
Biennale è una emanazione, tramite l’interesse dell’Accademia<br />
Pontificia dei Virtuosi al Pantheon, riceve una medaglia e un messaggio<br />
pontificio, in segno di riconoscimento per il lavoro fatto negli<br />
ultimi 25 anni a favore del dialogo tra la Chiesa e gli artisti contemporanei.<br />
Tra l’altro nel suo messaggio il Papa ha detto: “Sono, inoltre,<br />
contento che, quale segno di apprezzamento e incoraggiamento si<br />
offra una medaglia del pontificato alla Fondazione Stauròs Italiana<br />
Onlus per la realizzazione del museo di Arte Sacra Contemporanea<br />
e per l’organizzazione della Biennale dell’Arte Sacra, appuntamento<br />
ormai tradizionale per gli artisti che si impegnano nel settore dell’arte<br />
sacra” 2 .<br />
Ora qualcuno dovrebbe calcolare quanta fede sia stata diffusa e<br />
conservata con la dottrina, anche con la sola catechesi spicciola, e<br />
quanta ne sia stata diffusa e incrementata attraverso la contemplazione<br />
e la devozione dell’immagine o dell’iconografia sacra.<br />
Sarebbe indubbiamente una sorpresa insospettabile.<br />
Perciò non ci si capacita come in una società, che ha fatto dell’immagine<br />
il mezzo di comunicazione privilegiato, la Chiesa, che<br />
ha avuto il categorico mandato di comunicare la rivelazione stenti<br />
ancora, in genere, a riconoscere il contributo persuasivo dell’arte di<br />
oggi all’assolvimento di un così alto mandato.<br />
Il padre Adriano, testimone convinto, coraggioso ed evangelicamente<br />
libero, a ragione deve essere considerato profeta 3 . Con l’augurio<br />
che il suo non sia un grido nel deserto.<br />
Gli artisti, il clero sensibile e la Congregazione alla quale egli ha<br />
appartenuto e che ha onorato, mi pare, siano impegnati a testimoniare<br />
ancora quanto il linguaggio di oggi sia indispensabile alla conoscenza<br />
di Cristo e del suo Vangelo.<br />
2 Piergiorgio Bartoli, superiore provinciale Piet “In memoriam” in Percorsi<br />
formativi 2008, edizione Stauròs.<br />
3 “Mai ha rinunciato all’urgenza di dissodare il campo dell’arte, confidando<br />
di trovare in esso nuovi germogli per rievangelizzare la cultura contemporanea<br />
e per esprimere il culto divino” (Carlo Chenis).<br />
salvezza<br />
e<br />
culture<br />
Il valore<br />
di una profezia<br />
155-161<br />
culture<br />
159
salvezza e<br />
culture<br />
TITO AMODEI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
culture<br />
160<br />
THE VALUE OF A PROPHESY<br />
By Tito Amodei, C.P.<br />
In memory of Father Adriano di Bonaventura.<br />
For all of 25 years Fr. Adriano di Bonaventura, <strong>Passio</strong>nist priest<br />
(1934-2008) had directed with great constancy, personal sacrifice<br />
and enthusiasm the Biennial of Sacred Art at San Gabriele (TE).<br />
This Biennial which he started in 1984, was first held at Pescara,<br />
but was later transferred to the <strong>Passio</strong>nist Gran Sasso basilica.<br />
LA VALEUR D’UNE PROPHÉTIE<br />
Par Tito Amodei<br />
En mémoire du père Adrianoo di Bonaventura.<br />
Pendant vingt-cinq ans le père Adriano di Bonaventura, passioniste<br />
(1934-2008), a dirigé avec fidélité, sacrifices et enthousiasme la<br />
Biennale d’Art Sacré de Saint Gabriel (TE). La Biennale qu’il avait<br />
imaginée et fondée en 1984 à Pescara, fut transférée par la suite<br />
dans le complexe conventuel du Gran Sasso.<br />
EL VALOR DE UNA PROFECÍA<br />
Por Tito Amodei<br />
“In memoriam” del P. Adriano Di Bonaventura<br />
ENG<br />
FRA<br />
ESP<br />
Durante veinticinco años el P. Adriano Di Bonaventura (1934-<br />
2008) dirigió con constancia, mucho sacrificio y entusiasmo, la<br />
Bienal de Arte Sacro de San Gabriel (TE), Bienal que había concebido<br />
y fundado en 1984 en Pescara, más tarde trasladada al complejo<br />
conventual del Gran Sasso.
GER<br />
DER WERT EINER PROPHETIE<br />
Von Tito Amodei<br />
In memoriam P. Adriano di Bonaventura.<br />
Fünfundzwanzig Jahre lang hat Pater Adriano di Bonaventura,<br />
<strong>Passio</strong>nist (1934-2008) mit Ausdauer, unter Opfern und mit<br />
Enthusiasmus die Zeitschrift Arte Sacra di San Gabriele (TE)<br />
geleitet. Die halbjährlich erscheinende Zeitschrift ist von ihm im<br />
Jahre 1984 in Pescara entworfen und gegründet worden. Später hat<br />
er sie in den Konvent am Gran Sasso verlegt.<br />
POL<br />
WARTOŚĆ PEWNEGO PROROCTWA<br />
Tito Amodei CP<br />
Artykuł poświęcony pamięci o. Adriano di Bonaventura CP.<br />
Przez dwadzieścia pięç lat o. Adriano di Bonawentura, pasjonista<br />
(1934-2008) kierował wytrwale, z poświęceniem i entuzjazmem<br />
Biennale Sztuki Sakralnej w Św. Gabrielu (TE). Biennale, który<br />
wymarzył i założył w 1984 w Pescara, a potem przeniósł do centrum<br />
kongresowego w Gran Sasso.<br />
salvezza<br />
e<br />
culture<br />
Il valore<br />
di una profezia<br />
155-161<br />
culture<br />
161
di ELISABETTA VALGIUSTI<br />
Il grande film del 1953, La carrozza d’oro, di Jean Renoir, propone<br />
una straordinaria Anna Magnani nel ruolo di Camilla,<br />
una teatrante che approda con un gruppo della commedia dell’arte<br />
nel lontano Perù. Il film, ispirato al testo “Le carrosse du<br />
Saint-Sacrament” di Prosper Mérimée, si incentra su una carrozza<br />
d’oro, simbolo di potere e<br />
prestigio, che viene donata a<br />
Camilla dal Vicerè spagnolo, innamoratosi<br />
di lei.<br />
E’ un incanto vedere La<br />
carrozza d’oro . E’ l’incanto<br />
della grande arte<br />
del cinema di un tempo,<br />
quello dei grandi autori<br />
con immagini e volti e<br />
scene indimenticabili. Il<br />
film è dedicato al rapporto fra amore e arte contrapposti al potere.<br />
Anna Magnani, cioè Camilla, la capocomica di un gruppo di attori<br />
italiani della commedia dell’arte, ne è interprete straordinaria con la<br />
sua carica di passionalità e tenerezza, con la<br />
sua varietà di stati d’animo e di espressioni.<br />
Il film viene prodotto all’inizio degli anni ’50<br />
quando il grande regista Jean Renoir, figlio<br />
del pittore Auguste, è rientrato in Europa<br />
dopo l’esilio negli Stati Uniti . Renoir è già<br />
famosissimo dagli anni ’30 per i suoi film e<br />
per il suo impegno politico. I suoi capolavori<br />
La grande illusione del 1937 e La regola<br />
del gioco del 1939 affrontano a livello storico<br />
e sociale questioni cruciali della realtà<br />
salvezza<br />
e<br />
culture<br />
LA CARROZZA<br />
D’ORO<br />
DI<br />
ANNA<br />
MAGNANI<br />
La Carrozza d’oro<br />
di Anna Magnani<br />
163-168<br />
culture<br />
163
salvezza e<br />
culture<br />
ELISABETTA VALGIUSTI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
culture<br />
164<br />
francese ed europea che si affacciano sul baratro della seconda guerra<br />
mondiale. Durante l’esilio americano Renoir realizza Il diario di<br />
una cameriera dal famoso romanzo di Octave Mirbeau, ma il regista<br />
non si adatta al clima cinematografico di Hollywood mentre un<br />
suo soggiorno in India frutta nel 1951 il film Il fiume che rimane<br />
nella storia del cinema indiano. Quindi, nel dopoguerra La carrozza<br />
d’oro rappresenta una ripresa del cinema europeo di grande ispirazione<br />
e qualità che doveva essere girato da Luchino Visconti ma<br />
venne poi affidato a Renoir. Viene realizzato negli studi di Cinecittà<br />
da una co-produzione italo-francese con un cast tecnico-artistico di<br />
altissimo livello.<br />
La storia si svolge in una miserabile colonia spagnola in Perù,<br />
dove si trova un bel Vicerè annoiatissimo. Nello stesso giorno vi<br />
giungono la compagnia italiana del teatro dell’arte e la carrozza<br />
d’oro. I poveri teatranti vengono ricevuti malissimo e devono adattarsi<br />
a trasformare un pollaio in un teatro. In breve i loro spettacoli<br />
riscuotono un grande successo fra i campesinos. Il successo e l’innamoramento<br />
del Vicerè per Camilla trasforma la vita dei poveri<br />
teatranti, ma scatena la gelosia degli aristocratici spagnoli specialmente<br />
quando la carrozza d’oro viene donata a Camilla. La carrozza<br />
diventa il pretesto di un ricatto politico degli aristocratici nei confronti<br />
del Vicerè e della sua gestione. Il Vicerè deve scegliere: o dare<br />
le dimissioni e mantenere gli impegni amorosi oppure lasciare<br />
Camilla e riprendersi la carrozza e il potere. E da buon politico sceglie<br />
il tradimento. L’addolorata e furiosa Camilla vuole tenersi a tutti<br />
i costi la carrozza proprio in quanto simbolo della priorità assoluta<br />
dell’amore e della bellezza sul potere. Ma lei e i suoi amici sono in<br />
pericolo in quella terra straniera e gli eventi precipitano a causa di<br />
un duello fra altri due pretendenti di Camilla. Camilla è annientata<br />
dal fallimento, dalla perdita dell’amore e dell’onore. Con un colpo<br />
di teatro e di cinema straordinario, la storia si ribalta. Camilla si presenta<br />
trionfante con la sua carrozza al palazzo del Vicerè. Sullo scalone<br />
del palazzo è preceduta dal Vescovo al quale ha donato la carrozza<br />
per poter compiere le sue visite ai campesinos. Il Vescovo ha<br />
accettato il dono e ringrazia pubblicamente la donna che vede così<br />
riconosciuta la sua dignità e viene liberata da qualsiasi accusa.<br />
Ma la storia, per quanto intrigante e graziosa, non può descrivere la<br />
finezza e l’eleganza delle scenografie e dei costumi, la bellezza delle<br />
coreografie specialmente nelle scene sul palcoscenico del teatro<br />
dell’arte, la sapienza della fotografia che rappresenta uno dei primi
e straordinari utilizzi della pellicola in Technicolor, la meticolosità<br />
del montaggio. Il tutto esaltato da una splendida esecuzione delle<br />
musiche tratte dal repertorio di Antonio Vivaldi. Alla composizione<br />
del soggetto e della sceneggiatura aveva partecipato il regista<br />
coadiuvato da Renzo Avanzo, Giulio Macchi, Jack Kirchland; la<br />
fotografia era affidata al figlio Claude Renoir; il montaggio curato<br />
da Mario Serandrei. Oltre alla Magnani e a Duncan Lamont nel<br />
ruolo del Vicerè, nel cast troviamo attori noti di quel tempo come<br />
Odoardo Spadaro, Nadia Fiorelli, Paul Campbell, Georges<br />
Higghins.<br />
Così il grande regista francese Truffaut descrive l’opera: «La carrozza<br />
d’oro è uno dei film chiave di Jean Renoir perché riprende i<br />
temi di molti altri, principalmente quello della sincerità in amore e<br />
quello della vocazione artistica; è un film costruito secondo il gioco<br />
delle scatole cinesi che si incastrano le une nelle altre, un film sul<br />
teatro nel teatro. C’è molta ingiustizia nell’accoglienza riservata dal<br />
pubblico e dalla critica a La carrozza d’oro, che è forse il capolavoro<br />
di Renoir. Si tratta, comunque, del film più nobile e raffinato che<br />
sia mai stato girato. Vi si trova tutta la spontaneità e l’inventiva del<br />
Renoir d’anteguerra unite al rigore del Renoir americano. Qui tutto<br />
è distinzione e gentilezza, grazia e freschezza. È un film tutto di<br />
gesti e di comportamenti. Il teatro e la vita si mescolano in un’azione<br />
sospesa tra il piano terra e il primo piano di un palazzo come la<br />
commedia dell’arte oscilla tra il rispetto della tradizione e l’improvvisazione.<br />
Anna Magnani è l’ammirevole vedette di questo film elegante<br />
in cui il colore, il ritmo, il montaggio sono all’altezza di un<br />
accompagnamento musicale in cui Vivaldi fa la parte del leone. La<br />
carrozza d’oro è di una bellezza assoluta, ma la sua bellezza sta tutta<br />
nel suo profondo soggetto. Ho descritto l’altro capolavoro di Jean<br />
Renoir, La règle du jeu, come una conversazione aperta, un film al<br />
quale si è invitati a partecipare; le cose vanno diversamente per La<br />
carrozza d’oro che è un lavoro chiuso, finito, che bisogna guardare<br />
senza toccare, un film che ha trovato la sua forma definitiva, un<br />
oggetto perfetto».<br />
Va ricordato che nel 2008 sono stati organizzati eventi e mostre<br />
in occasione del centenario della nascita di Anna Magnani avvenuta<br />
a Roma il 7 marzo 1908. La vita e la carriera della Magnani presentano<br />
elementi personali e professionali spesso difficili e dolorosi.<br />
Il suo carattere e il suo tipo fisico la rendono un prototipo della<br />
donna italiana forte e appassionata. Anna rappresenta un modello<br />
salvezza<br />
e<br />
culture<br />
La Carrozza d’oro<br />
di Anna Magnani<br />
163-168<br />
culture<br />
165
salvezza e<br />
culture<br />
ELISABETTA VALGIUSTI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
culture<br />
166<br />
femminile di innovazione nella società e nella cultura italiana.<br />
Intraprende giovanissima la carriera teatrale, approda alla rivista di<br />
avanspettacolo, per il cinema è protagonista la prima volta in La<br />
Cieca di Sorrento . Nei ruoli che interpreta nella sua lunga carriera<br />
in film di produzione italiana come L’onorevole Angelina, Roma<br />
città aperta, L’Amore, Bellissima, Siamo donne, Nella città l’inferno,<br />
Mamma Roma, la Magnani crea figure eccezionalmente vive e<br />
credibili che ben esprimono i problemi e le sfide delle donne italiane<br />
a lei contemporanee sia nel periodo dei Telefoni bianchi sia nel<br />
momento di passaggio del paese, nel dopoguerra, fra mondo tradizionale<br />
e modernità. La Magnani non teme di esporsi, costruisce la<br />
sua carriera con scelte spesso complesse e audaci, applica la sua<br />
grande arte a personaggi diversissimi fra loro collaborando con i<br />
migliori attori, registi, scrittori del suo tempo. E’ un personaggio<br />
pubblico amatissimo specie dalle donne. Qualche critico ha affermato<br />
che il cinema italiano non le ha offerto le possibilità che meritava.<br />
Questo viene dimostrato nel 1955 quando la Magnani va ad<br />
Hollywood per interpretare insieme a Burt Lancaster La Rosa<br />
tatuata, scritto appositamente per lei dal grande commediografo e<br />
scrittore Tennesse Williams, suo grande estimatore ed amico. Il film<br />
fu un successo straordinario e la Magnani ricevette il premio Oscar<br />
come miglior attrice protagonista. Nel 1959 la troviamo in Pelle<br />
di serpente, diretta da Sydney Lumet, al suo fianco c’è Marlon<br />
Brando. Un’altra straordinaria interpretazione, un “cult”. Poi per<br />
Selvaggio è il vento, di George Cukor, la Magnani riceve l’Orso<br />
d’argento al Festival di Berlino.<br />
L’arte, la forza, il temperamento di questa grande artista hanno<br />
significato moltissimo per il nostro paese. Nel mondo il suo volto<br />
ha rappresentato un’Italia libera, vitale, coraggiosa. La Magnani ci<br />
manca molto. Olivia, figlia di Luca Magnani, ha intrapreso il lavoro<br />
della nonna. Ha uno splendido volto e un gran carattere. Magari,<br />
come nel film La Carrozza d’Oro, la Magnani è riuscita a farci un<br />
altro bel dono. Qualcosa di nuovo. Grazie, Anna.
ENG<br />
THE GOLDEN CHARIOT<br />
By Elisabetta Valgiusti<br />
That famous 1953 film, “The Golden Coach” * by Jean Renoir, gave<br />
the role of Camilla to the extraordinary Anna Magnani, a theater<br />
actress who starred together with a group from the Art Comedy<br />
Institute of far-away Peru. The film, the text of which was inspired<br />
by Prosper Mériméer’s “The Chariot of Blessed Sacrament Coach”<br />
* is centered on a golden coach, a symbol of power and prestige,<br />
donated to Camilla by the Spanish Viceroy, madly in love with her.<br />
FRA<br />
LE CARROSSE D’OR D’ANNE MAGNANI<br />
Par Elisabetta Valgiusti<br />
Le grand film de 1953, le carrosse d’or, de Jean Renoir, met en scène<br />
une extraordinaire Anne Magnani dans le rôle de Camilla, une<br />
comédienne ambulante qui arrive avec un groupe de la comedia<br />
dell’arte du lointain Pérou. Le film, inspiré du texte « Le Carrosse<br />
du Saint-Sacrement » de Prosper Mérimée, se concentre sur un carrosse<br />
d’or, symbole du pouvoir et du prestige, qui est donné à<br />
Camilla par le vice-roi espagnol amoureux d’elle.<br />
ESP<br />
LA CARROZZA D’ORO DE ANA MAGNANI<br />
Por Isabel Valgiusti<br />
La gran pe´licula del año 1953, “La carrozza d’oro” (La carroza de<br />
Oro), de Jean Renoir, presentaba a la extraordinaria Ana Magnani<br />
en el papel de Camila, artista de teatro llegada al lejano Perú con<br />
un grupo de compañeros del mundo del arte. La película, inspirada<br />
en “El carro del Santísimo Sacramento”, de Próspero Merimèe, se<br />
centra en la carroza de oro, símbolo del poder y del prestigio, que<br />
regaló a Camila el virrey español, enamorado de ella.<br />
salvezza<br />
e<br />
culture<br />
La Carrozza d’oro<br />
di Anna Magnani<br />
163-168<br />
culture<br />
167
salvezza e<br />
culture<br />
ELISABETTA VALGIUSTI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
culture<br />
168<br />
DIE GOLDENE KAROSSE VON ANNA MAGNANI<br />
Von Elisabetta Valgiusti<br />
Der großartige Film aus dem Jahr 1953, Die goldende Karosse, von<br />
Jean Renoir, zeigt eine außerordentliche Anna Magnani in der Rolle<br />
der Camilla, einer Komödiantin, die mit ihrer Komödiengruppe im<br />
fernen Peru landet. Der Film ist vom Buch „Le carrosse du Saint-<br />
Sacrament“ von Prosper Mérimée inspiriert und kreist um eine goldene<br />
Karosse als Symbol für Macht und Prestige, die der spanische<br />
Vizekönig Camilla schenkt, in die er sich verliebt hat.<br />
ZŁOTA KAROCA ANNY MAGNANI<br />
Elisabetta Valgiusti<br />
GER<br />
POL<br />
Wielki film Złota karoca (Carrosse d’or) Jeana Renoira przedstawia<br />
wspaniałą Annę Magnani w roli Camilli, aktorki teatralnej, która z<br />
trupą teatralną przypływa do odległego Peru. Film jest ekranizacją<br />
tekstu Le carrosse du Saint-Sacrament” Prospera Mérimée.<br />
Koncentruje się on na złotej karecie jako symbolu władzy i prestiżu,<br />
którą Camilli podarował Wicekról hiszpański, który się w niej<br />
zakochał.
Tova<br />
di ADOLFO LIPPI C.P.<br />
REICH TOVA, Il mio Olocausto, Romanzo.<br />
Traduzione di C. Prinetti, Einaudi, Torino, 2008,<br />
pp. VIII-288, € 16,50.<br />
TOAFF ARIEL, Ebraismo virtuale, Rizzoli, Milano,<br />
2008, pp. 142, € 12.<br />
My Holocaust è un romanzo uscito nel<br />
2007 in America, dopo altri romanzi e racconti<br />
pubblicati dall’autrice, un’ebrea proveniente<br />
da una famiglia di stretta osservanza<br />
religiosa. Suo marito è stato direttore<br />
dello United States Holocaust<br />
Memorial Museum. Curiosamente,<br />
Maurice Messer, il protagonista di questo<br />
romanzo, è precisamente il direttore di<br />
questo stesso museo ed egli viene presentato, insieme al figlio,<br />
come un sagace sfruttatore della memoria delle vittime a scopo di<br />
profitto. La scrittura vivace, piena di fantasia e ricca di sfumature<br />
manifesta una naturale vena narrativa. E’ una satira cinica, allegra<br />
e scandalosa che comincia con la fuga da casa della figlia del protagonista,<br />
la quale sceglie di diventare monaca carmelitana proprio<br />
nel monastero di Auschwitz aspramente contestato dagli ebrei in<br />
nome della memoria delle vittime, e si rifiuta persino di incontrare<br />
i suoi familiari. Prosegue con una lunga serie di smacchi e di<br />
compromessi e termina con la sottrazione del museo alla sola<br />
memoria delle vittime ebraiche per essere destinato alla memoria di<br />
tutti gli olocausti della terra. Vuole essere uno scioccante atto di<br />
accusa contro la banalizzazione della memoria e la cultura del vittimismo<br />
autoconsolatorio. Se fosse stato scritto da un non ebreo,<br />
rivista<br />
della<br />
stampa<br />
UNA<br />
DEMITIZZAZIONE<br />
EBRAICA<br />
DELLA<br />
MEMORIA<br />
DELL’OLOCAUSTO<br />
Una demitizzazione<br />
ebraica della<br />
memoria dell’olocausto<br />
169-175<br />
stampa<br />
169
ivista<br />
della<br />
stampa<br />
ADOLFO LIPPI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
stampa<br />
170<br />
certamente avrebbe scatenato le più feroci proteste e sarebbe stato<br />
qualificato come uno scritto antisemita.<br />
Verso il termine del romanzo, all’interno del museo che si esige<br />
dedicato a tutti gli olocausti della terra, due bambini gemelli che straziano<br />
gli astanti con i loro pianti, smettono finalmente di piangere.<br />
“Lui (Maurice Messer, il protagonista) pensa che abbiano smesso di<br />
piangere, ma io li sento ancora, quelli che sono presenti in questo<br />
posto e quelli che sono lontani, i vivi e i morti, quelli amati e quelli<br />
scartati, i bambini neri con la pancia gonfia e gli occhi sporgenti, i<br />
neonati intirizziti stesi tutti soli su uno straccio nella piazza del mercato<br />
con una ciotolina di latta da mendicante ai piedi, i neonati grigi<br />
come la cenere strappati alle madri e lanciati nelle fosse in fiamme.<br />
E’ la mia vocazione tenere vive le loro urla nelle mie orecchie, non<br />
così forti da intorpidirmi, e neanche da farmi abituare alla confusione,<br />
e non così deboli da illudermi che siano distanti nel tempo, nel<br />
luogo, nel fato, ma sempre penetranti, frastagliate, presenti, stimmate<br />
che si rinnovano in continuazione fra i miei occhi, un dolore perpetuo,<br />
senza possibilità di fuga nell’oblio, e senza alcun sollievo.<br />
Oltre che una vocazione, è anche la mia passione, mantenere per<br />
sempre viva nella mia mente tutta la sofferenza che c’è stata e che<br />
ci sarà, come un sigillo sul cuore, vicina e fedele alla memoria, tenere<br />
conto dell’eterna angoscia ogni minuto che passa, essere perennemente<br />
nello stato di shock di chi non crede ai suoi occhi, di chi non<br />
riesce a respirare, di chi non riesce a capire. Ancora, ancora, un<br />
minuto dopo l’altro, devo portarmi una mano alla bocca per l’orrore.<br />
Fa’ che non mi abitui, Signore, è tutto quello che Ti chiedo. Fa’<br />
che sia sempre un dolore, sono il mio corpo e il mio sangue a desiderarlo.<br />
Lasciami sospesa per sempre nell’aria sottile, in perfetta<br />
coscienza e puro terrore, nello spazio tra il salto dalla torre in fiamme<br />
e lo schianto finale sulla fredda terra. Vago per questo museo in<br />
rovina per illuminare le immagini e le icone alla luce di una candela<br />
della memoria. La ragazza che lotta per coprirsi il seno sarà<br />
inchiodata per sempre nel momento dopo lo stupro. Il vecchio con<br />
la barba mezza strappata rimarrà per sempre nelle grinfie dei suoi<br />
torturatori. Il ragazzino con gli occhi scuri, il berretto in testa e le<br />
braccia alzate rimarrà per sempre congelato sotto il tiro della pistola.<br />
Le rispettabili madri di famiglia, grottescamente nude all’aperto<br />
in un campo sotto il cielo tremolante saranno per sempre umiliate<br />
dal nostro morboso sguardo mentre aspettano in fila di venire uccise.<br />
E aspetteranno per sempre, perfettamente consapevoli.
Rimarrai per sempre inchiodato alla Tua croce.<br />
Io sono inchiodata a Te” (pp. 276-277).<br />
Vengono in mente le immagini della Crocifissione bianca di<br />
Chagall.<br />
Nonostante tutto questo (e altro), il vecchio impresario<br />
dell’Olocausto (Chi è un ebreo? Domanda fasulla. La vera domanda<br />
è: Chi è un buon ebreo? E la risposta dipende dalla consistenza<br />
della donazione, p. 154) non molla. Il suo museo si chiamerà ora<br />
United States Holocausts Memorial Museum (Memoriale di tutti gli<br />
Olocausti). Ma la sostanza non cambia. E così si conclude il romanzo:<br />
“Una piccola S in più, dice il vecchio. Niente di importante,<br />
signore e signori. Ma due S? Ss? Mai! E’ quello il limite” (p. 281).<br />
Una concezione della realtà può essere espressa in categorie filosofiche,<br />
ma, forse meglio, in una narrazione, (come nel midrash,<br />
nella Haggadah) o in una pittura. La coscienza ebraica, mettendo in<br />
crisi se stessa, torna a sconvolgere la “buona coscienza” occidentale,<br />
costruita a furia di autogiustificazioni: noi non siamo come quei<br />
cattivacci dell’inquisizione, delle crociate o, peggio ancora, come<br />
gli schiavisti romani o greci. Noi siamo democratici. Rispettiamo<br />
l’altro. Aborriamo le oppressioni. Non è vero.<br />
Sopravvivere, questa è la cosa importante per uomini come<br />
Maurice. “Prima sopravvivi, dopo puoi occuparti di sottigliezze<br />
come la moralità e i sentimenti. Quando qualcuno ti dice che ti ucciderà,<br />
devi fare attenzione, prenderlo sul serio, credergli. Il mattino<br />
seguente ti svegli prima e lo ammazzi. Se sopravvivi, vinci. Se non<br />
sopravvivi, perdi. Se perdi, sei niente… Una volta Blanche (la<br />
moglie del protagonista) aveva letto su una rivista che le cellule del<br />
cancro erano la forma di vita più adatta perché mangiavano tutto<br />
quello che avevano intorno, si espandevano, si riproducevano, avevano<br />
successo, vincevano. Forse non era granché come esempio;<br />
forse non dava un’idea carina di Maurice e degli altri – essere paragonati<br />
a delle cellule cancerose. Il cancro era un male, ma in questo<br />
mondo, se sopravvivi vinci, e se vinci sei bravo” (pp. 17-18).<br />
Quest’ultimo paragone è tanto amaro anche perché ci si ferma<br />
alle conseguenze immediate del cancro e non si procede oltre. La<br />
conseguenza ultima è che alla fine, anche le cellule del cancro muoiono<br />
insieme all’organismo che distruggono. Qui si vede quanto è<br />
vero che gli equilibri del mondo non poggiano sulla moralità e sulla<br />
giustizia, ma sulla competizione e la sopraffazione. Finalmente,<br />
però, tutto questo porta alla distruzione e alla morte. Ogni volta che<br />
rivista<br />
della<br />
stampa<br />
Una demitizzazione<br />
ebraica della<br />
memoria dell’olocausto<br />
169-175<br />
stampa<br />
171
ivista<br />
della<br />
stampa<br />
ADOLFO LIPPI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
stampa<br />
172<br />
uccido un altro, uccido due volte me stesso, chiamo la morte in casa<br />
mia. A lungo andare la violenza non paga. Tremano i fondamenti<br />
(falsi) della Morale del mondo. Si comprende quanto è vero il pensiero<br />
di Lévinas che diceva che l’etica si può fondare (e promuovere)<br />
solo sulla risposta responsabile e totalmente gratuita di colui che<br />
è eletto e chiamato.<br />
Toaff<br />
A questo emblematico romanzo ho creduto bene affiancare il saggio<br />
di Ariel Toaff che, per certi aspetti conferma la stessa critica<br />
verso la banalizzazione dell’Olocausto e il vittimismo e, per altri,<br />
amplia il discorso estendendolo alla storia ebraica del passato e alla<br />
concezione dominante del popolo ebraico come un popolo sempre<br />
giusto e sempre vittima, immune sia da peccati che dalla violenza,<br />
diverso perciò da tutti gli altri. Concezione dominante nella cultura<br />
generale, ma soprattutto nella cultura ebraica, dove c’è chi presume<br />
di sostenerla fino ad accusare di antisemitismo chiunque la mette in<br />
dubbio. Si potrebbe partire, per comprendere questo libro, da quanto<br />
avvenne dopo la pubblicazione del libro-scandalo Pasque di sangue,<br />
dello stesso autore. Nel febbraio del 2007, la commissione per<br />
l’educazione della Kenesset, dello Stato di Israele, si riunì per condannare<br />
senza appello quel libro e per esaminare l’eventualità di<br />
processare il suo autore come antisemita e “falsario manipolatore”<br />
della storia ebraica (p. 39).<br />
Toaff per certi aspetti sembra chiamare il suo popolo, il popolo<br />
ebraico, ad essere adulto, a lasciare indietro l’infanzia dei ghetti e a<br />
saper stare nel mondo aperto, per altri aspetti sembra proclamare<br />
questa uscita come già di fatto avvenuta, almeno in Israele e forse<br />
fuori d’Italia più che in Italia. C’è un ebraismo virtuale, cioè non<br />
reale, paradossalmente tenuto in piedi da antisemiti e da ebrei insieme.<br />
“In realtà – dice Toaff – sono stati proprio gli antisemiti ad avere<br />
sempre proposto un’idea statica e omogenea del mondo ebraico,<br />
costante e uniforme nel tempo, senza frammentazioni e lacerazioni<br />
interne, senza differenze etniche e culturali, senza conflitti interni<br />
religiosi e sociali” (p. 34). Si tratta, come detto sopra, dell’immagine<br />
dell’ebreo eternamente vittima e perennemente impeccabile. “E’<br />
nato così il mito della storia virtuale di un popolo virtuale, sempre
positivo e silenzioso, perennemente angosciato dal pericolo costante<br />
che qualcuno lo spinga nel baratro e in perenne attesa di una mano<br />
amica, quando non quella stessa di Dio, che venga a salvarlo. Chi<br />
pretenda presentare la storia del popolo ebraico come storia reale di<br />
un popolo reale, con i suoi pregi e i suoi difetti, con le sue sofferenze,<br />
la sua voglia di vivere e reagire, con le sue diatribe interne e i<br />
compromessi spesso adottati per sopravvivere, con il divario fra<br />
norma e prassi che l’ha caratterizzato, con i suoi atti eroici e le sue<br />
ipocrisie, con la sua cultura e le sue superstizioni, se non viene subito<br />
zittito, è tacciato di antisemitismo e, se ebreo, di odio verso se<br />
stesso” (pp. 43-44).<br />
Non ci vuol molto a capire che malevole invenzioni come I protocolli<br />
dei saggi anziani di Sion presuppongono la persuasione dell’esistenza<br />
di un ebraismo monolitico e compatto, teso ad assumere<br />
il controllo del mondo intero a proprio vantaggio. Quanto meno le<br />
persone sono istruite sull’ebraismo reale, tanto più tendono a considerarlo<br />
monolitico e compatto. Quanto più si studia l’ebraismo,<br />
tanto più si comprende questo popolo e la sua cultura come diversificati<br />
ed eterogenei. Quando mi capita di dover spiegare l’ebraismo<br />
ai miei correligionari, faccio non poca fatica a presentare adeguatamente,<br />
non dico le singole personalità ebree, ma anche semplicemente<br />
le principali categorie della cultura e della storia ebraica postbiblica:<br />
formazione del Talmud, filosofia medioevale ebraica, misticismo<br />
e kabbalà, il messianismo, le crociate e gli ebrei, le espulsioni,<br />
i ghetti, askenaziti e sefarditi, i chassidim, l’emancipazione e le<br />
sue conseguenze, ebraismo liberale, riformato e ortodosso, l’assimilazione,<br />
l’antisemitismo antico e moderno, i pogrom, il sionismo, le<br />
aliah, la Shoah, i kibbutzim, il nuovo stato di Israele, le successive<br />
guerre, il dialogo ebraico-cristiano, ecc. Poi la narrativa ebraica e<br />
specificamente israeliana, i principali pensatori ebrei, le innumerevoli<br />
e diversissime personalità ebraiche della cultura mondiale.<br />
Quello che più interessa al sottoscritto e che, peraltro, ritengo<br />
estremamente importante per tutti, è la possibilità di un dialogo più<br />
sereno fra ebrei e cristiani, un dialogo in cui non si debba sempre<br />
stare all’erta per il timore di essere tacciati di antisemitismo e magari<br />
sopportare in silenzio affermazioni di cui non si è convinti. Nuoce<br />
certamente a questo dialogo il chiasso giornalistico che su di esso si<br />
fa. Molto giornalismo è di fatto condizionato dalla spinta a scrivere<br />
cose che si vendano bene, come la validità di un programma televisivo<br />
è misurato dall’audience. Non c’è niente che si venda meglio di<br />
rivista<br />
della<br />
stampa<br />
Una demitizzazione<br />
ebraica della<br />
memoria dell’olocausto<br />
169-175<br />
stampa<br />
173
ivista<br />
della<br />
stampa<br />
ADOLFO LIPPI<br />
SapCr XXIV<br />
GENNAIO-GIUGNO 2009<br />
stampa<br />
174<br />
ciò che è scandalistico. Se scrivi qualcosa di scientificamente dimostrabile<br />
e falsificabile, vendi poco. Hochhuth ha venduto bene fin<br />
dall’inizio con un discorso dirompente su Pio XII. Male è che molti<br />
ebrei vadano dietro a questi discorsi non scientificamente storici né<br />
etici. Quale è il risultato? Cosa si aspetta, che i non ebrei diffidino<br />
di persone di grande valore culturale ed etico come Andrea Riccardi<br />
per abbeverarsi a quelli che vendono bene la loro merce? Ma allora<br />
siete antisemiti… Perché? Perché non ce la sentiamo di andar dietro<br />
a una cultura superficiale, a una storiografia da giornalismo. Chi è<br />
che favorisce il male endemico dell’antisemitismo, a cui Israele,<br />
secondo l’ateo Yehoshua o il credente Lévinas, è stato sarà sempre<br />
esposto, già prima del cristianesimo e lo sarà finché Israele vuole<br />
essere fedele alla sua missione o alla sua tradizione religiosa? Chi è<br />
che ci gioca con leggerezza?<br />
Perché non utilizzare le chiavi di lettura della storia che si possono<br />
trovare nella psicologia e nella sociologia, nelle scienze umane in<br />
genere? Toaff parla giustamente di compromessi adottati dagli ebrei<br />
per sopravvivere. Ma quale persona e quale popolo non li adottano?<br />
Perché esporre immediatamente tutto sotto i riflettori di un moralismo<br />
spietato e abbastanza banale, invece di riconoscere i meccanismi<br />
di difesa che operano automaticamente negli individui e nei<br />
popoli? Come il discorso della Tova, così anche il discorso di Toaff,<br />
chiamando in causa gli intellettuali ebrei, chiama in causa, di fatto,<br />
tutta la cultura occidentale. I cristiani hanno agito senza rispetto<br />
verso l’altro: ma chi sono i cristiani? Come si pensa che uno diventi<br />
cristiano? Si pensa che poiché il re si è convertito e un intero<br />
popolo si è convertito in massa, per ciò stesso, come per un colpo<br />
di bacchetta magica, questo popolo abbia cominciato ad agire evangelicamente?<br />
Questa è una concezione magica della realtà, non storica.<br />
Non corrisponde né alla storia dell’ebraismo biblico o postbiblico<br />
né alla storia del Cristianesimo.<br />
Dopo il Concilio Vaticano II si è imparato che un’apologetica ad<br />
ogni costo non è il modo migliore di fare la storia e neanche di<br />
difendere il proprio gruppo. Le manipolazioni della storia non pagano.<br />
La verità è sempre migliore. Come Papa Ratzinger ripete sempre<br />
non ascoltato, relativismo e menzogna sono scelte di morte. Il<br />
virtuale illude, ma poi delude. Pensiamo ai miti contemporanei.<br />
Mentre si è portati a fare grandi risate sulle mitologie antiche o<br />
medioevali e così costruirsi una buona coscienza a buon mercato,<br />
non si è affatto coscienti delle deformazioni della storia provenienti
dalle mitologie contemporanee, ad esempio da quella del<br />
Risorgimento italiano o da quelle costruite artificiosamente dalle<br />
ideologie del secolo XX.<br />
A Camaldoli mi sono trovato d’accordo con un rabbino (ma in<br />
disaccordo con un altro e certamente con molti preti) sulla definizione<br />
di Dio come sempre più grande di ogni immagine che se ne può<br />
avere all’interno di un qualsiasi gruppo religioso. Sembra che uno<br />
scambio di opinioni che generi una ricerca seria non trovi convergenze<br />
all’interno di un singolo gruppo, ma trovi piuttosto, sempre di<br />
più, convergenze trasversali. In fondo, i fondamentalisti islamici,<br />
ebrei, protestanti o cattolici hanno delle strutture di pensiero comuni.<br />
Così le persone aperte. Chouraqui, uomo dello stato di Israele e<br />
uomo di dialogo, uomo di preghiera e uomo di ricerca intellettuale,<br />
poteva scrivere questa frase che io condivido pienamente (ma forse<br />
non tutti i cattolici condividono): “Il pensiero di Israele, che ha<br />
avuto tutte le audacie, dovrà avere il coraggio definitivo di afferrare<br />
le dimensioni nuove del mondo che deve comprendere e di vedere<br />
nelle religioni che sono uscite dal suo seno, non più delle rivali, che<br />
si accaniscono per perderlo, ma delle compagne, delle sorelle che<br />
devono unire le loro forze per il servizio di uno stesso Maestro e la<br />
salvezza di una stessa creazione” (Il Pensiero ebraico, Queriniana,<br />
1999, 102). Potrà un ebreo convincersi che ci sono cristiani (e preti)<br />
ai quali sta a cuore la sorte della fede di Israele, della sua risposta<br />
all’appello di Dio, come la loro stessa vita?<br />
Il dialogo ebraico-cristiano non è soltanto un’attitudine positiva<br />
come ogni dialogo, ma è un’urgenza del nostro tempo. Dispiace<br />
quando esso viene messo in crisi. Dispiace ancora di più quando<br />
viene messo in crisi, come è accaduto ultimamente, per motivi<br />
inconsistenti. Toaff, come Chouraqui, lascia forti dubbi sulla validità<br />
dell’azione di certi rabbini (v. ultima pagina, 138). Si potrà dialogare<br />
da gruppo a gruppo, senza timore di essere tacciati per nemici,<br />
sulla validità dell’azione delle singole persone e non del gruppo<br />
considerato falsamente come omogeneo?<br />
rivista<br />
della<br />
stampa<br />
Una demitizzazione<br />
ebraica della<br />
memoria dell’olocausto<br />
169-175<br />
stampa<br />
175
MAX JOSEF METZGER,<br />
La mia vita per la pace.<br />
Lettere dalle prigioni naziste<br />
scritte con le mani legate,<br />
Traduzione e cura di Lubomir Zak,<br />
Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo<br />
(MI) 2008, pp. 269<br />
€ 18,00<br />
Stupore è la parola<br />
che traduce un<br />
insieme di<br />
impressioni, sentimenti<br />
e riflessioni suscitati<br />
dalla lettura di queste<br />
270 pagine di “profezia”<br />
nel solco della<br />
Storia. Immagini efficaci<br />
del Vangelo di<br />
Cristo divengono icona<br />
e prendono corpo dinanzi alla figura davvero gigante, umanamente<br />
e cristianamente, del Servo di Dio don Max Josef Metzger (1887-<br />
1944). La potenzialità delle sue idee di pace tra i popoli d’Europa e<br />
di unità della Chiesa nel dialogo ecumenico tra le diverse confessioni<br />
cristiane, sul fondamento della verità e della carità, e di “cattolicità”<br />
incarnata innanzitutto in una comunità religiosa mista di uomini<br />
e donne chiamati con la propria vita pura e santa ad essere testimoni<br />
dell’ “Ordine del Regno di Cristo” quale “ecclesiola in ecclesia”<br />
del tutto simile alla primitiva comunità cristiana, rendono perfettamente<br />
l’ideale evangelico del Regno dei Cieli paragonato al<br />
minuscolo granello di senape che in sé racchiude tutta la vitalità<br />
futura del grande albero.<br />
Quanto a lui, Metzger, sacerdote cattolico, la fedele corrispondenza<br />
alla grazia divina l’ha condotto in perfetta e obbediente<br />
“sequela <strong>Christi</strong>” nell’analoga passione di accettazione della volontà<br />
di Dio in una condanna a morte da innocente, con ingiusto procedimento<br />
di mesi di attesa istruttoria e, quindi, di esecuzione della<br />
pena capitale tramite ghigliottina nel carcere di Brandenburg il lunedì<br />
17 aprile 1944. Riferendoci a lui, non possiamo pensare ad altro<br />
che al chicco di grano destinato a morire solo per produrre il suo<br />
molto frutto, come appropriatamente ricorda nella Prefazione al<br />
libro il Card. Walter Kasper.<br />
Le circa ottanta pagine del saggio introduttivo, la traduzione dell’epistolario<br />
e le numerose quanto preziose note di accompagnamento<br />
alla lettura di queste “lettere dalle prigioni naziste scritte con<br />
recensioni<br />
recensioni<br />
177
ecensioni le mani legate”, sono curati da Lubomir Zak, docente di teologia<br />
presso la Pontificia Università Lateranense. Con stile incalzante e<br />
pensiero attento all’analisi essenziale di un dato estremamente eloquente<br />
in sé, il prof. Zak presenta ampiamente il profilo geniale di<br />
colui che definisce “scomodo profeta di un mondo migliore”, carico<br />
d’una nuova visione della Cristianità, della Chiesa e dell’Europa che<br />
appena oggi, seppure dopo oltre quarant’anni dalla celebrazione del<br />
Concilio Ecumenico Vaticano II e quasi trenta di vulcanico pontificato<br />
di Giovanni Paolo II, stenta ancora a farsi strada e concretizzarsi,<br />
nonostante siano stati molti gli elementi, i fattori e le sollecitazioni<br />
messi in atto dinamicamente in tali direzioni accennate.<br />
Ecco perché stupiscono le tante citazioni, precise e rigorosamente<br />
selezionate dalla vasta produzione letteraria e documentaria di<br />
Metzger, ordinato sacerdote il 9 luglio 1911 e già pienamente attivo<br />
a Graz per una fecondissima “educazione alla pace”. Nel 1918, per<br />
esempio, sulla rivista da lui fondata, Il tempo nuovo, scriveva con<br />
lapidaria lucidità: “La pace sta in piedi o cade con il rinnovamento<br />
intellettuale e morale della società umana. Se deve cambiare la fisionomia<br />
della società umana, deve prima modificarsi la psiche dei<br />
popoli e dei singoli. Sta qui il punto chiave di tutta la questione della<br />
pace. La pace è un problema educativo” (p. 20).<br />
Sono concetti talmente veri da far tremare i nostri giorni inquieti<br />
e tormentati di uomini “non di buona volontà”! Giustamente, chi ha<br />
curato qui i tratti biografici interiori ed intellettuali di Metzger afferma<br />
che egli nel cuore fu un idealista, benché “nella sua intelligenza<br />
ed esperienza fu certo un sobrio realista che conosceva il vero stato<br />
delle cose” (p. 25). Il Servo di Dio si rendeva conto, forse, di essere<br />
un novello “Battista” che grida inascoltato nel deserto? La sua<br />
“colpa”, comunque, fu proprio questa chiarezza ermeneutica della<br />
realtà, del mondo, dello stato delle cose nel mondo e di parola nell’analisi<br />
dell’evidenza esposta con limpido buon senso sapienziale<br />
dell’esistenza, istintivo e acuto discernimento tra verità e menzogna<br />
senza compromessi anche quando il loro orizzonte sembrava tendere<br />
a sfumarsi e confondersi. Non per lui, capace di netto giudizio<br />
come quello espresso sulla politica di potere, della quale altro non si<br />
servono che falsità, egoismi e ingiustizia (cf. p. 26), o riguardo al<br />
Cristianesimo, sulla cui autenticità e freschezza evangelica, giovane<br />
sacerdote nel 1916, si chiedeva: “I popoli cristiani sono oggi davvero<br />
tali? Gli uomini d’oggi sono cristiani in modo da poter rivendicare<br />
il diritto di portare con onore il nome di Cristo?”. Quarant’anni<br />
recensioni<br />
178
ecensioni<br />
dopo, nel 1956, un altro prete, don Primo Mazzolari, faceva<br />
sentire la sua voce con le stesse domande rivolte a molte coscienze<br />
intorpidite.<br />
Don Metzger auspicava nei Cristiani un sincero ritorno allo spirito<br />
delle Beatitudini e vedeva la necessità del ritorno al<br />
“Cristianesimo pratico” – leggere “vissuto”! – delle origini, quale<br />
risposta al bolscevismo avanzante ed al capitalismo disumano.<br />
Quanto alla divisione dei Cristiani, in una delle sue ultime lettere la<br />
definisce sine glossa: “l’eresia interna della Chiesa” (p. 189).<br />
Fu tra i primi cattolici impegnato, a titolo personale, nel dialogo<br />
ecumenico e fondò la Fraternità interconfessionale “Una Sancta”, i<br />
cui punti basilari per i membri erano: “l’essere maggiormente consapevoli<br />
della già data (anche dogmaticamente) unità di tutti in<br />
Cristo per mezzo dell’unico battesimo; pregare per una più ampia<br />
attuazione di quest’unità anche nel ‘corpo della Chiesa’; impegnarsi<br />
come costruttori di ponti per un reciproco avvicinamento dei fratelli<br />
separati a causa di molteplici malintesi e dell’umana incapacità<br />
di comprendere” (p. 52).<br />
Un capolavoro è la sua lettera a Pio XII datata Avvento 1939 (pp.<br />
105-115), dove, tra l’altro, suggerisce un incontro ecumenico di preghiera<br />
ad Assisi ed auspica un successivo Concilio. In questi suoi<br />
scritti dalle carceri naziste, indirizzati per lo più a membri della<br />
comunità da lui fondata sotto il nome di “Societas <strong>Christi</strong> Regis”,<br />
nella quale egli era “fratello Paolo”, costante è il riferimento di conforto<br />
nella lettura del Nuovo Testamento in greco e tedesco, specialmente<br />
dell’epistolario paolino, dove con l’Apostolo si identifica in<br />
espressioni che preludono il martirio.<br />
Impedito di celebrare la S. Messa, visse con crescente e reale<br />
intensità l’esperienza della Comunione dei santi: spesso le sue lettere<br />
parlano di consolazione al pensiero che “noi siamo tutti ‘circumstantes’<br />
(quelli che stanno attorno)” (p. 98). Allora la solitudine si<br />
colma di ecclesialità pura del Corpo di Cristo intero. Toccante è la<br />
sua difesa in un testo del 28 settembre 1943 indirizzato al giudice<br />
istruttore. Di sé scrive dalla prigione di Berlino: “Sono un sacerdote<br />
cattolico, e lo sono con anima e corpo. Tuttavia, la mia forma<br />
mentis non corrisponde all’idea che di solito uno si crea quando si<br />
immagina un prete… Sono un uomo di giudizio indipendente, che<br />
ha un attivo interesse per ciò che avviene nel mondo. Il mio atteggiamento<br />
religioso è dominato del tutto dall’idea del Regno di Dio,<br />
dall’ethos del Vangelo” (p. 166).<br />
recensioni<br />
179
ecensioni<br />
recensioni<br />
180<br />
Fu proprio tale suo essere assolutamente ed evangelicamente<br />
libero che lo rese un nemico del Terzo Reich da eliminare, benché<br />
non si trovino in lui attacchi diretti al nazismo o interessi d’interventi<br />
politici palesi. Col verdetto di morte sul capo pronto ad essere eseguito,<br />
dopo mesi di prigione, ancora il 18 gennaio 1944 il suo interesse<br />
principale è l’inizio della Settimana di Preghiera per l’Unità<br />
dei Cristiani. Il suo animo poetico stila allora in bellissimi versi un<br />
testamento ecumenico intitolato: “Una Sancta”, seguito da una altissima<br />
meditazione sul Padre nostro e l’Eucaristia (cf. pp. 224-226).<br />
La sua pace interiore, la grazia, la sua vita in Dio gli consente di<br />
apprezzare dalla nuda cella del carcere della morte la bellezza della<br />
natura che pulsa cantico di vita. In una lettera del 27 gennaio 1944<br />
parla della “cincia”, “volata alla finestra una sola volta, mentre<br />
viene regolarmente un corvo”, di cui con umorismo aggiunge:<br />
“certo, non porta pane come a Paolo eremita” (p. 227), riferendosi<br />
al celebre S. Paolo di Tebe visitato da S. Antonio abate nel deserto e<br />
ivi nutrito dal pane del volatile ogni giorno.<br />
Senza data è la sublime riflessione sulla morte (pp. 235-246),<br />
degna di un S. Francesco d’Assisi che per altro cita (cf. p. 238).<br />
“Sorella Morte”, colei che detiene sull’uomo il massimo potere (cf.<br />
p. 235), arrivò a visitarlo il 17 aprile 1944, come recita laconico il<br />
protocollo nazista di avvenuta esecuzione: “Alle ore 15,26 il condannato,<br />
con le mani legate dietro la schiena, è stato introdotto da<br />
due ufficiali carcerari… Dall’introduzione del condannato all’annuncio<br />
dell’eseguita sentenza sono trascorsi 7 secondi” (pp. 266-<br />
267). Sette secondi per “l’inizio ‘della vera vita eterna’ “ e dire:<br />
“Salve, sorella morte!” (p. 238); sette secondi per diventare seme<br />
fecondo della Storia della Chiesa dei decenni successivi.<br />
Una curata bibliografia rende questo libro un documento interessantissimo,<br />
degno di essere inserito in lezioni di pace, di ecumenismo<br />
e di autentica spiritualità per i giorni nostri, eredi di tanta nobile<br />
figura.<br />
(Luciana Maria Mirri)
MC GINN BERNARD,<br />
Storia della mistica cristiana<br />
in occidente.<br />
I. Le origini (I-V secolo),<br />
II. Lo sviluppo (VI-XII secolo),<br />
III. La fioritura della mistica<br />
(1200-1350), Marietti 1820,<br />
Genova-Milano 1997, 2003, 2008,<br />
pp XX+529, XIV+688, XIII+544,<br />
rilegato con sopracoperta,<br />
€ 60, 80, 80.<br />
Un imponente<br />
work in progress,<br />
la cui<br />
crescita, lenta e sicura,<br />
non permette previsioni<br />
di tempi e di estensione<br />
ma, allo stesso tempo,<br />
consente un sia pure<br />
provvisorio bilancio.<br />
Nel titolo americano, a<br />
quello che poi è reso in<br />
italiano, è premesso<br />
The Presence of God,<br />
che riprende un’idea di<br />
mistica che, fra le molte possibili, recepisce l’idea di Teresa d’Avila,<br />
mistica e dottore, che con sublime semplicità anzi nonchalance scrive:<br />
“Mi accadeva improvvisamente d’essere presa dalla sensazione<br />
della presenza di Dio… credo che la chiamino teologia mistica”.<br />
Erede della contemplatio degli autori monastici, la teologia mistica<br />
dei successivi autori medioevali costituisce il presupposto di una<br />
concezione moderna che l’Autore ritiene “vada più opportunamente<br />
considerata non un’entità autonoma o indipendente o una forma di<br />
religione a sé stante, ma un elemento delle concrete comunità e tradizioni<br />
religiose”. L’elemento mistico, naturalmente presente nel<br />
cristianesimo fin dalle origini, diventa esplicito, in tempi e circostanze<br />
concrete, in forme e modi diversi “in cui ha interagito con le<br />
forme istituzionali, intellettuali, sociali di vita religiosa”. Dunque,<br />
“un processo, un modo di vita, piuttosto che definito esclusivamente<br />
nei termini di una qualche esperienza di unione con Dio”. Una<br />
presenza, una consapevolezza che “non deve essere considerata isolatamente<br />
dalle pratiche ascetiche e intellettuali… Questo è il motivo<br />
per cui ho parlato dell’elemento mistico del Cristianesimo come<br />
la parte del suo credo e delle sue pratiche che riguardano la preparazione,<br />
la consapevolezza e la reazione alla presenza diretta o<br />
immediata di Dio”. Il contesto ellenistico (da Platone a Plotino, a<br />
Porfirio, ai misteri…) e la tradizione ebraica, la speculazione filoso-<br />
recensioni<br />
recensioni<br />
181
ecensioni<br />
recensioni<br />
182<br />
fica e la pratica teurgica, con il cristianesimo subiscono una rivoluzione,<br />
mediante una vita strutturalmente intessuta nella ecclesìa, con<br />
la “ fede nella nuova e definitiva presenza di Dio realizzatasi in<br />
Gesù”. Dalla realtà mistica di Cristo nella chiesa, che i primi cristiani<br />
vivono naturalmente, nasce e si sviluppa il proprium della mistica<br />
cristiana con Origene, Evagrio, Dionigi, Gregorio di Nissa. Con<br />
Tertulliano e Cipriano, la Vetus latina, l’opera di papa Damaso,<br />
l’edizione latina della Vita di Antonio e quella di Martino, le<br />
Conlationes di Cassiano, gli Acta martyrum, si forma il cristianesimo<br />
latino, fino alla fioritura di Girolamo, Ambrogio, Agostino. Dai<br />
sapienti gnostici e dai filosofi platonici i mistici cristiani riprendono<br />
il tema dell’ascesi dell’anima, da uno stato di decadenza a Dio, su<br />
una solida base esegetica, con la lectio biblica, enfatizzando l’indispensabile<br />
opera dell’intervento divino, della grazia e ponendo al<br />
centro della riflessione, accanto alla conoscenza, l’amore, concepito<br />
come agàpe-éros.<br />
La mistica altomedioevale, dopo il passaggio dalla Roma imperiale<br />
alla cristianità e la traslatio imperii, “trova la sua incarnazione<br />
istituzionale nello stile di vita monastico”, tra il 500 e 1100, la società<br />
che dal tempo di Carlo Magno si autocomprende come “cristianità”:<br />
Benedetto da Norcia, il padre del monachesimo occidentale, con<br />
la sua Regula (non mancano i doverosi cenni alla Regula Magistri)<br />
e Gregorio Magno, monaco prima che papa, con i Dialogi, ma anche<br />
la Regula pastoralis, e le opere di esegesi: un contemplativo in azione.<br />
La mistica dialettica fa la sua comparsa con Giovanni Scoto<br />
Eriugena, con il suo debito verso le fonti greche e latine e il fondamento<br />
biblico. L’Eriugena traduce Dionigi, si traducono i Verba<br />
seniorum (vite e detti dei primi monaci greci), si leggono i classici<br />
della letteratura monastica spirituale, particolarmente Cassiano e,<br />
soprattutto ci si consacra allo studio della Bibbia, senza trascurare<br />
le arti liberali. Con il XII secolo, il grande risveglio, il passaggio<br />
dalla contemplatio alla teologia mistica per opera dei cistercensi. A<br />
partire dall’Exordium parvum, un forte impulso di sostegno all’opera<br />
riformatrice del monaco Ildebrando, poi papa Gregorio VII. La<br />
teologia monastica si incentra sulla ordinatio caritatis: la caritas,<br />
l’antropologia biblica e teologica, la cristologia, con Bernardo di<br />
Chiaravalle e Guglielmo di St Thierry che vi apporta la dimensione<br />
mistica trinitaria. E poi: Guerric d’Igny, Isacco della Stella,<br />
Baldovino e Giovanni di Ford, Aelredo di Rievaulx. Costante, sulla<br />
scorta di Bernardo, la lectio del Cantico, con tutte le possibili
interpretazioni e applicazioni. Solitudo, lectio/meditatio, oratio/contemplatio<br />
caratterizzano questo stato di vita “di perfezione” in cui<br />
nasce e si sviluppa la “teologia monastica”. Gli ultimi capitoli del II<br />
volume sono dedicati ai visionari e contemplativi: Ruperto di Deutz,<br />
Gioacchino da Fiore, i “monaci neri”, i benedettini, come Pietro il<br />
Venerabile, i certosini, fondati da Bruno e i canonici regolari<br />
dell’Abbazia di San Vittore, con la apostolica vivendi forma: Ugo,<br />
Riccardo e altri.<br />
Affacciatesi sulla scena alla fine del II volume, con Ildegarda di<br />
Bingen e Elisabetta di Schoenau (e non sono comparse!), le donne e<br />
la “questione femminile” sono protagoniste del III volume il cui sottotitolo<br />
(non riportato né nel prospetto generale né nel frontespizio<br />
del volume, ma ripetutamente dichiarato nella Prefazione e nella<br />
amplissima Introduzione) è, appunto: “”Uomini e donne nella nuova<br />
mistica”. Si dà il dovuto rilievo ai grandi fondatori degli ordini mendicanti,<br />
Francesco e Domenico (e come poteva essere diversamente!),<br />
si parla di Innocenzo III e del Concilio Lateranense IV del<br />
1215, della teologia in volgare dei mistici, dell’impulso alla cura<br />
animarum come conseguenza di una ben intesa spiritualità non<br />
astratta dal mondo da parte degli ordini mendicanti e dei canonici<br />
regolari e, per logica conseguenza di pastoralia e predicabili. Si<br />
parla di “nuova mistica” in un clima di democratizzazione: non è<br />
appannaggio di una élite di monaci ma, come leggiamo nel delizioso<br />
Sacrum Commercium: “Questo, Madonna, è il nostro chiostro”,<br />
risposero i frati a Madonna Povertà che chiedeva che le venisse<br />
mostrato il chiostro. E si parla molto di donne, a partire dalle beghine<br />
della Lotaringia e, insieme a Francesco, della sua pianticella<br />
Chiara. Con la prima mistica francescana e la sintesi di<br />
Bonaventura, ecco le mistiche francescane: con le pauperes dominae<br />
di Chiara, Elisabetta d’Ungheria, Isabella di Francia, Dolcelina<br />
di Digne, Margherita da Cortona, Angela da Foligno… Tra le mulieres<br />
religiosae, notevoli esperimenti di mistica femminile: Beatrice<br />
di Nazareth, la prima scrittrice, Cristina di Stommeln, Agnese<br />
Blannbekin, le reclusae come Juette d’Huy e la nostra Umiliana de’<br />
Cerchi, Margherita di Magdeburgo. Tre grandi mistiche beghine:<br />
Hadewijch di Anversa, Mectilde di Magdeburgo, Margherita Porete<br />
con Lo specchio delle anime semplici giudicato eretico con conseguente<br />
bruciamento di Margherita. Seguono le cistercensi di Helfta,<br />
con la grande Gertrude, la premonstratense Cristina di Hane, la<br />
vallombrosana Umiltà di Faenza, la certosina Margherita d’Oingt,<br />
recensioni<br />
recensioni<br />
183
ecensioni<br />
recensioni<br />
184<br />
le domenicane Diana d’Andalò (di cui abbiamo un bel carteggio con<br />
Giordano di Sassonia “il secondo fondatore dell’ordine”),<br />
Benvenuta da Cividale, Vanna da Orvieto, Margherita di Città di<br />
Castello.<br />
Di Caterina da Siena, annuncia l’Autore, si parlerà nel prossimo<br />
volume, che non si può prevedere quando uscirà, né da quanti altri<br />
sarà seguito. Vogliamo, in conclusione, sottolineare, tra i molti pregi<br />
ai quali abbiamo dovuto solo indirettamente accennare, la estrema<br />
pertinenza delle osservazioni che Mc Ginn, parlando di donne spirituali,<br />
visionarie, mistiche fa a proposito di certe tendenze femministe<br />
nello studio della mistica, come più in generale della storia della<br />
chiesa, della spiritualità, dell’esegesi. “Manca la prova di un contributo<br />
decisivo portato dalle donne nella mistica prima del tredicesimo<br />
secolo”, e poi: “Non mi sembra fruttuoso, né possibile, individuare<br />
una specifica ‘mistica femminile’ nel tardo Medioevo”, sia per<br />
la “stupefacente varietà che caratterizza le donne stesse”, che per la<br />
“malleabilità dei ruoli sessuali” nel modificare, trasformare e trascendere<br />
il loro ruolo nella esperienza mistica. Se nella mistica, per<br />
sua natura esperienzale, dimensione sempre più esplicitamente teorizzata<br />
(Erlebnismystik), la corporeità tende a essere enfatizzata<br />
dalle donne, certe “stravaganti manifestazioni corporee”, non vanno<br />
interpretate come manifestazione di rottura con concezioni più controllate<br />
e “intellettualizzate” presenti nella tradizione mistica precedente,<br />
ma “come indizi di squilibrio personale o addirittura di isteria”.<br />
Non si dimentichi che, nella maggior parte dei casi, l’esperienza<br />
mistica femminile subiva la mediazione letteraria dei direttori di<br />
spirito: i testi ci dicono quello che gli uomini pensavano delle sante<br />
donne. “Le nostre problematiche sono spesso profondamente differenti<br />
da quelle della mistica medioevale”.<br />
(Salvatore Spera)
BRACCIOLINI POGGIO,<br />
Contra Hypocritas,<br />
a cura di Davide Canfora,<br />
Storia e Letteratura<br />
(“Edizione Nazionale<br />
dei Testi Umanistici” 9),<br />
Roma 2008, pp LXXX+66,<br />
cm 14x21, Euro 18,00.<br />
L’irridente, colto,<br />
brillante autore<br />
delle Facetiae,<br />
ancora una volta coglie<br />
da par suo la novità e la<br />
vitalità di una lunga tradizione<br />
antifratesca e<br />
anticlericale, dai grandi<br />
padri della letteratura<br />
italiana a Sacchetti,<br />
Coluccio Salutati,<br />
Leonardo Bruni… Aveva anticipato alcuni temi, di un sostanziale<br />
anticlericalismo che attraversa i suoi scritti, in una lettera a Niccolò<br />
Niccoli del 16 dicembre 1429 sui frati “circulatores” che si aggirano<br />
“capite demisso” e simulano “doctrina et vite bonitas”, mentre in<br />
realtà sono persone spregevoli che infestano la curia romana, al<br />
punto che “totiens deceptus sum… ut iam nesciam quid credam aut<br />
cui credam”: Tema sfiorato anche nel coevo De avaritia: “Num<br />
aliud spectant - parlando dei sacerdoti - quaerunt, ambiunt sub fidei<br />
velamento, nisi ut parvo labore ditiores fiant?”. Ma ormai, scrive<br />
nella dedicatoria a Francesco Accolti di Arezzo, è convinto che<br />
rispetto all’avarizia, l’ipocrisia è “multo scelestius vitium” e che<br />
urge parlarne “ob publicam utilitatem”, adesso che è morto (23 febbraio<br />
1447) papa Eugenio IV (“veluti ad uberrima pascua advolantes<br />
pontificem circuibant tanto persepe studio, ut nil posset esse<br />
fastidiosius”), e si può sperare che con Niccolò V la curia romana<br />
inauguri un nuovo corso nei confronti dei frati osservanti, perché<br />
“hoc tempus, ut ait Terentius, aliam vitam, alios mores postulat”. Le<br />
ripetute espressioni: “Sexcenta eiusmodi hypocritarum occurrunt<br />
exempla mihi nota, quae possem referre, nisi vererer ne dedita viderer<br />
opera eorum acta insectari. Hec recensui ut videant omnes quam<br />
nefaria sint, quam abhominanda persepe istorum opera, quos hypocritas<br />
vocant… Occurrunt plura eiusmodi virorum exempla, quos<br />
prolixitatis causa praetermitto…” non si lasciano smontare dalla<br />
difesa (d’ufficio) che, in casa di Carlo Marsuppini e con lo stesso<br />
Bracciolini, tenta il prelato Girolamo Aliotti che, sia pure personal-<br />
recensioni<br />
recensioni<br />
185
ecensioni<br />
recensioni<br />
186<br />
mente integro, è ottimo conoscitore degli ipocriti, insinua Poggio. Ci<br />
sono iactatores e ostentatores, da non confondere con gli hypocriti<br />
veri e propri. Si può simulare per conseguire un bene pubblico,<br />
come fece Numa Pompilio, l’ ipocrisia non riguarda solo gli uomini<br />
di chiesa e, poi, ci sono tanti bravi e santi religiosi. Ma, è la replica,<br />
è dei religiosi ipocriti che si parla, proprio perché si aggirano<br />
poveri e trasandati e “Iesum Christum semper in ore habent”. E dire<br />
che “magis in hypocritas Salvator noster invectus est quam in reliquos<br />
facinorosos… Alibi falsos prophetas eos appellavit, a quibus<br />
monuit cavendum esse; multis quoque in locis hoc scelus admonet<br />
fugiendum, detestans hoc solum vitium divina sapientia tamquam<br />
illud quo nullum nequius neque magis nefarium reperitur, quod plurium<br />
malorum causam et originem secum ferat”. Di qui i toni profetici<br />
e apocalittici di un incontenibile furor: “Verum omnem religiosorum<br />
fecem ex infima abiectaque hominum conditione collectam,<br />
qui privata causa ambiunt et prensant curiam, homines ignavos,<br />
rudes, sordidos, sola ostentatione et vultus pallore conspicuos,<br />
hominibus inutiles neque acceptos Deo, versari continuo in frequentia<br />
omnium gentium, postes palatii observare, beneficia, immunitates,<br />
gratis, privilegia… Res quippe non culpanda solum, sed vendicanda<br />
est eiusmodi homines, veluti solutos legibus, quo velint evagari<br />
sub humilitatis et mundi contemptus simulatione, quo facilius<br />
suis cupiditatibus obsequantur…”. Grande letteratura, indubbiamente.<br />
Appunto: letteratura!<br />
(Salvatore Spera)
ERASMI MAURIZIO,<br />
Chiara d’Assisi.<br />
La fecondità storica di un carisma,<br />
Messaggero<br />
(“Studi francescani”16),<br />
Padova 2008,<br />
prefazione di Felice Accrocca,<br />
pp 299, cm 14x21, Euro 30.00.<br />
“Avendo frequentato<br />
per qualche<br />
tempo la Curia, mi<br />
sono imbattuto in molte<br />
realtà contrarie al mio<br />
spirito. Erano tutti così<br />
occupati nelle cose<br />
temporali e mondane,<br />
in questioni di re e di<br />
regni, in liti e processi,<br />
che appena permetteva-<br />
no che si parlasse di cose spirituali. Ho trovato però in quelle regioni<br />
una sola consolazione: persone, d’ambo i sessi, ricchi e laici,<br />
lasciata ogni cosa per Cristo, fuggivano il mondo. Si chiamavano<br />
frati minori e sorelle minori e sono tenuti in grande considerazione<br />
dal signor papa e dai cardinali… Costoro vivono secondo la forma<br />
della Chiesa primitiva…”. La lettera del 1216 di Jacques de Vitry<br />
descrive con vivacità ed esattezza il fenomeno della apostolica<br />
vivendi forma ben inquadrandola nelle sue componenti e nel contesto<br />
ecclesiale. Si intravvedono gli intrecci biografici e spirituali di<br />
Francesco e Chiara e il loro ruolo vitale di forma Minorum e forma<br />
Sororum. Un ruolo, documenta il volume, che, senza nulla togliere<br />
al carisma eccezionale di Francesco, non è meno rilevante in Chiara.<br />
Se Francesco si pone non solo come forma Minorum ma anche<br />
forma Sororum attraverso la cura, l’affetto, le premure e gli insegnamenti<br />
(documentati nelle testimonianze e negli scritti), Chiara non è<br />
da meno. Lei “indigna ancilla <strong>Christi</strong> et plantula beatissimi patris<br />
Francisci (RegCh I,3) tale rimane nella memoria collettiva:<br />
“Domina Clara, Ordinis sororum prima plantula, abbatissa sororum<br />
pauperum monasterii Sancti Damiani de Assisio, emulatrix sancti<br />
Francisci in conservando semper paupertatem Filii Dei”( CompAss<br />
13,1). Soprattutto dopo la morte di Francesco, Chiara è sicuro punto<br />
di riferimento anche per i frati, tra i quali, molto importante, frate<br />
Elia.<br />
La Bolla di canonizzazione è precisa nel definire chiaramente<br />
l’ispirazione di Francesco e il ruolo di Chiara nella fondazione delle<br />
recensioni<br />
recensioni<br />
187
ecensioni<br />
recensioni<br />
188<br />
pauperes sorores: “Qui Chiara, per esortazione dello stesso<br />
Francesco, diede principio a questa nuova e santa osservanza; ella fu<br />
il primo e stabile fondamento di questo grande Ordine; fu la pietra<br />
angolare di questo sublime edificio”. Il volume ricostruisce le complesse<br />
vicende, tanto note quanto ingarbugliate, attraverso le quali<br />
dall’Ordo sancti Damiani fortemente voluto dal cardinale Ugolino,<br />
poi papa Gregorio IX (1227-41), si giunse all’Ordo sanctae Clarae.<br />
Tanto determinato Ugolino nell’opera istituzionalizzatrice che doveva<br />
contemperare la clausura e la povertà , quanto “ostinata” Chiara<br />
nel difendere e nell’ottenere il privilegium paupertatis: “Il signor<br />
papa Gregorio… ancor più intensamente amava con affetto paterno<br />
questa santa. E si studiava di persuaderla che acconsentisse a possedere<br />
qualche proprietà, per far fronte ad ogni eventuale circostanza<br />
e ai pericoli del mondo… Ma ella si oppose con decisione incrollabile<br />
e in nessun modo si lasciò convincere”. Dunque, accettazione<br />
della forma vitae, ma con la deroga del privilegium paupertatis. A<br />
ragione la detta Bolla di canonizzazione recita: “Fu soprattutto<br />
un’innamorata e indefessa coltivatrice della povertà; e tanto fissò al<br />
suo cuore questa virtù, tanto fu avvinta dal desiderio di possederla<br />
che, amandola sempre fermamente e sempre più ardendo nell’abbracciarla,<br />
mai si scostò per nessuna ragione dalla sua stretta e piacevole<br />
unione” (17). Perciò, scrive Erasmi: “’Sorelle povere’ è il<br />
punto di arrivo della comprensione che Chiara ha del carisma della<br />
propria comunità” (p. 152), anche se, correttamente, deve scrivere:<br />
“Paradossalmente, a distanza di pochi anni, anche le sorelle di<br />
Chiara, quindi la comunità di San Damiano, persero la loro originale<br />
prerogativa e si assimilarono al resto delle clarisse adottando,<br />
appunto, la regola di Urbano”. La Beata Clara di Urbano IV (1261-<br />
64) è del 1263. In conclusione, una eterogenesi dei fini.<br />
Il quarto e ultimo capitolo “Chiara d’Assisi: l’attualizzazione di<br />
un carisma”, riprende, come si può facilmente intuire, alcuni capisaldi<br />
della spiritualità clariana (soprattutto dal Testamento), nella<br />
vita comunitaria nella chiesa e nella società di oggi.<br />
(Salvatore Spera)
1. Introduzione<br />
TEOLOGICO (53)<br />
Musulmani e cristiani di fronte al<br />
Crocifisso: tra scandalo e adesion di<br />
fede. Note di teologia delle religioni,<br />
di M. Di Tora,<br />
in Coda P. – Crociata M. edd.,<br />
Il Crocifisso e le religioni,<br />
Città Nuova, Roma 2002, pp. 281-298.<br />
Il tema della crocifissione di Gesù nella tradizione islamica,<br />
viene qui trattato solo alla luce della prospettiva teologicofondamentale,<br />
ossia secondo l’ottica della teologia delle religioni;<br />
affrontando quindi il problema della verità religiosa, e quello<br />
riguardante la credibilità della fede. Lo scopo è quello di riflettere,<br />
a partire dall’analisi dei capisaldi della fede islamica sulla negazione<br />
della crocifissione di Gesù, su alcune tendenze teologiche attuali<br />
nell’ambito della teologia delle religioni e di rilanciare all’attenzione<br />
della teologia fondamentale il tema della fondazione della fede.<br />
2. Rivelazione divina e messaggio islamico<br />
Uno degli attuali temi della teologia delle religioni riguarda<br />
il rapporto tra rivelazione cristiana e le altre manifestazioni<br />
del sacro. La posizione teologica attualmente più<br />
accreditata, sostenuta anche da proposizioni conciliari è quella di J.<br />
Dupuis che riconosce nelle altre tradizioni, e in particolare<br />
nell’Islam, una reale mediazione della salvezza e della rivelazione;<br />
sostenendo anche che i libri sacri di tali religioni sono ispirati e<br />
schede<br />
bibliografiche<br />
schede<br />
189
schede<br />
bibliografiche<br />
schede<br />
190<br />
costituiscono parola di Dio, divenendo così vie di salvezza per i credenti.<br />
Qui ci si propone di verificare la validità e la coerenza di tale<br />
affermazione teologica, consapevoli che la crocifissione di Gesù sia<br />
un formidabile banco di prova.<br />
Per quanto riguarda la crocifissione di Gesù, l’islam, si muove<br />
all’interno di alcune coordinate teologiche ben definite e, va detto<br />
con franchezza, che l’insegnamento coranico sulla vita di Gesù<br />
risulta molto preciso e fortemente polemico. I passi coranici 4, 157-<br />
158; 3,55 e 5,117;19,15.33, sono rivelati nel periodo medinese, in<br />
cui si cristallizza l’opposizione al cristianesimo. Non risulta chiaro<br />
su chi sia stata proiettata l’immagine di Gesù, se Giuda o Sergio,<br />
certo è che l’Islam nega che Gesù sia stato crocifisso ed ucciso. A<br />
ciò si aggiunge che per i musulmani i cardini del cristianesimo come<br />
la crocifissione, la redenzione portata da Cristo, la divinità di Gesù,<br />
la Trinità ed il culto alla Vergine Maria, sono da rigettare perché dottrine<br />
di origine pagana introdotte dall’apostolo Paolo.<br />
Ma le ragioni di fondo è che l’Islam non ammette che qualcuno<br />
muoia per gli altri, così come è indegno di Dio lasciar morire i suoi<br />
inviati nella sconfitta. Va segnalato anche che il Dio coranico è persona<br />
assolutamente libera e le sue azioni sono totalmente arbitrarie,<br />
nulla gli si può chiedere perché non è tenuto a dar ragione agli uomini…<br />
ciò gli permette anche di cambiare continuamente idea abrogando<br />
quanto aveva appena detto; non a caso ogni prescrizione<br />
coranica termina con: a meno che Dio non voglia altrimenti. Ne<br />
risulta una assoluta libertà di Dio e una totale dipendenza dell’uomo<br />
all’unico e vero motore dell’universo, tutto dipende dalla sua volontà:<br />
Allah cancella quello che vuole e conferma quello che vuole<br />
(Corano 13,39); ed ancora: Egli castiga chi vuole e perdona chi<br />
vuole (Corano,5,40).<br />
Nella rivelazione coranica per garantire l’assoluta libertà di Dio,<br />
ad esclusione del patto primordiale, non c’è alcuna alleanza con<br />
l’uomo, Dio piuttosto ordina agli uomini senza però né allearsi ad<br />
essi e senza neppure svelarsi, tanto che nel Corano Dio non rivela<br />
alcun tratto della sua identità come invece fa nella Bibbia. Già da<br />
qui si capisce come l’Islam non possa accogliere alcun patto di<br />
fedeltà di Dio verso l’uomo peccatore e bisognoso di salvezza, tanto<br />
più non può accettare un Dio che si lascia crocifiggere pur di rimanere<br />
fedele al suo progetto di amore e salvezza verso l’uomo. Oltre<br />
a ciò l’Islam, ha in sé una concezione più simile al monismo matematico<br />
che al monoteismo e perciò non è in grado di intravedere la
possibilità della Trinità. Per l’islam i cristiani credono in una trinità<br />
composta da Allha, da Maria sua compagna e da Gesù, loro figlio<br />
carnale. L’evento della crocifissione è negato anche perché l’Islam<br />
non concepisce l’essenza della natura di Dio come ricchezza di<br />
amore che si dona in vista di una comunione con Sé. Queste fondamentali<br />
note teologiche precludono all’Islam ogni possibile accettazione<br />
del mistero della croce e nello stesso tempo determinano la<br />
distanza teologica tra le due religioni. Da quanto detto fin d’ora scaturisce<br />
la prima doverosa precisazione e cioè che l’accezione religioni<br />
del libro sia da rigettare, in quanto, pur avendo esse un “libro”<br />
va rilevato come il contenuto teologico ed il ruolo del libro sia nelle<br />
tre religioni, Ebraismo, Cristianesimo ed Islam, ma molto diverso<br />
come diversissimo appare il volto del Dio rivelato nelle tre religioni<br />
ed in modo particolare nell’Islam. I due monoteismi infatti, ebraico-cristiano<br />
e islamico risultano profondamente distanti su molti<br />
punti essenziali che creano distanze abissali, che devono essere<br />
tenute presenti quando parliamo di religioni monoteiste, facendo<br />
riferimento alle tre citate, poiché conglobarle nel termine può dare il<br />
senso di tre amici o simili mentre non è affatto così.<br />
Sulla posizione teologica di J. Dupuis che riconosce nell’Islam<br />
una vera rivelazione e in Maometto un genuino profeta, va chiarito<br />
che al massimo qui si deve applicare il concetto di rivelazione<br />
naturale, ripresa con autorevolezza anche nelle Fides et ratio,<br />
che permette di riconoscere un bene nelle altre religioni e nello<br />
stesso tempo protegge dai rischi, quelle riflessioni che tendono<br />
a concedere ad ogni religione una valenza divina rivelativa e<br />
salvifica. Infatti le religioni naturali testimoniano il movimento<br />
dell’uomo verso Dio, mentre il cristianesimo è dato dal movimento<br />
di Dio verso l’uomo.<br />
3. La credibilità della rivelazione<br />
tra posizione islamica e cristiana<br />
Le lunghe puntualizzazioni sopra riportate erano necessarie al<br />
fine di introdurre il passaggio successivo, si tratta qui di un<br />
argomento che, per la gravità del suo contenuto, raramente è<br />
espresso chiaramente dalla teologia delle religioni, ma che nasce spontaneo<br />
quando si confrontano due posizioni contraddittorie, su un medesimo<br />
evento storico, e cioè la validità della verità religiosa.<br />
schede<br />
bibliografiche<br />
schede<br />
191
schede<br />
bibliografiche<br />
schede<br />
192<br />
O Gesù è morto crocifisso, oppure no; non può esistere un tertium<br />
ad hoc, che tenda a salvaguardare parte di una verità e parte di<br />
un’altra. Il tema della verità dell’islam non può essere eluso, anche<br />
perché esso si presenta come la rivelazione che, dopo l’ebraismo e<br />
il cristianesimo, le autentica, le purifica e da loro compimento<br />
(Corano 5,48). Di fronte a ciò la teologia delle religioni non può non<br />
considerare seriamente la problematica relativa alla vera religione<br />
ed alla sua intrinseca credibilità. Anche lo studio relativo alla crocifissione<br />
di Gesù ed al suo senso rilancia tale tema e a sua volta ne<br />
solleva un altro altrettanto fondamentale: quello dei criteri di credibilità<br />
per la sua verifica razionale e ciò è inevitabile di fronte a due<br />
religioni che si presentano con la pretesa universalistica. Oltre al tertium<br />
ad hoc sopra citato, che certamente non regge dinnanzi alla<br />
verifica razionale, va fatto notare anche che la prova essenziale della<br />
missione profetica di Muhammad, il quale non compie miracoli, ma<br />
gli vengono poi attribuiti dalla tradizione posteriore 1 , è garantita dall’inimitabilità<br />
contenutistica e stilistica del testo sacro che attesterebbe<br />
l’incapacità umana a produrre qualcosa di simile. Dunque<br />
l’unico miracolo di Muhammad, che la tradizione dichiara analfabeta<br />
sarebbe quello di aver stilato il Corano quale parola divina assolutamente<br />
ineguagliabile.<br />
Se poi ci si chiedesse, come e a partire da quali premesse, quali<br />
motivazioni l’islam porti a sostegno del rifiuto della morte di Gesù<br />
in croce, dovremo concludere che essi si fondano esclusivamente su<br />
una posizione non tanto di fede ma fideista. Ma per una religione<br />
che avanza la pretesa salvifica universalistica, è sufficiente appoggiarsi<br />
in posizione fideista sulla parola del Corano?<br />
L’analisi della verifica della credibilità in seno al cristianesimo,<br />
che corrisponde alla storia della teologia cristiana, ha portato a<br />
distinguere tra criteri oggettivi (miracoli, profezie ecc.) e criteri soggettivi<br />
(con riferimento al soggetto credente). Se dunque l’inimitabilità<br />
del Corano è segno della sua fondatezza rivelativa, cosa<br />
dovremmo dire della croce di Gesù che la consapevolezza cristiana<br />
riconosce come scandalo per i giudei e ed anche per i musulmani e<br />
stoltezza per i pagani? Ma agli occhi di un teologo fondamentale<br />
non sfugge la considerazione che lo scandalo della croce evoca<br />
necessariamente la dimensione della credibilità della fede, in cui si<br />
1 Cfr. Corano, Sure 28,47-48; 29,51-52; 17,59.
gioca uno dei più convincenti motivi di credibilità, oggettivo ed<br />
intrinseco, dell’origine soprannaturale del cristianesimo. Se l’uomo<br />
e le religioni non riescono a comprendere come la morte possa essere<br />
fonte di vita e di amore, Dio ha scelto per rivelare il suo mistero<br />
di salvezza, proprio ciò che l’uomo non avrebbe mai potuto pensare.<br />
Egli sceglie non la sapienza delle parole ma la Parola della<br />
Sapienza, la croce, quale atto estremo del divino amore e che san<br />
Paolo pone come criterio di verità ed insieme di salvezza. E mentre<br />
l’islam nega la croce perché niente è più blasfemo di un Dio che ha<br />
un Figlio che muore sul patibolo, più la nega e più la rende credibile…<br />
la croce infatti è un evento assolutamente inatteso per la prospettiva<br />
ebraica e fuori da ogni concezione di fede pagana che si<br />
rende credibile solo attraverso una rivelazione in cui Dio stesso ne<br />
ha scritto il copione.<br />
Concludendo appare chiaro come l’islam all’analisi della credibilità<br />
della fede si presenti con degli evidenti buchi che lo rende difficilmente<br />
credibile. Alla fine possiamo dire con G.M. Salvati che<br />
solo la croce di Cristo apparendo credibile salva tutti e paradossalmente<br />
è proprio quella croce da molti negata che smonta e sconfigge<br />
tutti i tentativi non cristiani di giungere a Dio.<br />
Fr. Maximus a S.R.P. Cp.<br />
schede<br />
bibliografiche<br />
schede<br />
193
schede<br />
bibliografiche<br />
schede<br />
194<br />
1. Premessa<br />
TEOLOGICO (54)<br />
Per un dialogo etico tra le religioni<br />
all’ombra della croce,<br />
di Salvatore Privitera,<br />
in Coda P. – Crociata M. edd.,<br />
Il Crocifisso e le religioni,<br />
Città Nuova, Roma 2002,<br />
pp. 299-309.<br />
L’etica, che dovrebbe essere un oggetto privilegiato nel dialogo<br />
tra religioni, in realtà, a dire dell’A., è la grande<br />
assente, pur essendo un terreno ineliminabile nel dialogo<br />
interreligioso. Infatti, di fronte ad una qualsiasi divergenza etica, le<br />
diverse parti hanno sempre l’obbligo di confrontarsi per appurare la<br />
verità. Ma, ancora più assente, nel dialogo ecumenico fra le diverse<br />
culture, appare la croce, perché la tendenza attuale sembra essere<br />
quella di appianare le difficoltà, cercando di adattare la prospettiva<br />
etica alla situazione culturale piuttosto di conformare quest’ultima<br />
alle esigenze etiche. Va precisato, però, che con “croce” qui intendiamo<br />
non solo l’assunzione dell’evento finale della vita di Gesù,<br />
ma anche e soprattutto la dimensione del sacrificio, del rinnegamento<br />
di sé come veicoli indispensabili per la realizzazione della propria<br />
moralità. Così intesa, la dimensione staurica rende molto problematico<br />
il dialogo del cristianesimo, non solo con le altre culture e religioni,<br />
ma anche con la stessa cultura contemporanea. C’è da chiedersi,<br />
però, se nelle altre religioni, pur mancando l’evento storico<br />
della Croce di Gesù, manchi davvero anche la “croce” o non si tratti<br />
piuttosto di un modo diverso di impostare il discorso sulla “croce<br />
personale”.
2. La “croce” nell’etica cristiana<br />
L’immagine della via stretta accompagna la riflessione eticobiblica<br />
e tutta la vita della Chiesa, dal suo nascere fino ad<br />
oggi. Infatti, la “croce”, come evento che accompagna la vita<br />
terrena del credente è esperienza classica della spiritualità sia<br />
dell’Antico che del Nuovo Testamento, accomunando in qualche<br />
modo Giobbe e Paolo, il profeta ed il santo… perché, chi si pone alla<br />
sequela del Maestro non ha altra via, se non quella dell’imitazione<br />
di Cristo, ed il vivere moralmente significherà sempre il caricarsi<br />
sulle spalle la propria “croce”; al di là del modo di pensare della cultura<br />
contemporanea o delle altre religioni.<br />
3. La “croce” nell’etica qua talis<br />
La dimensione staurica è ineliminabile dall’etica, almeno<br />
finché con etica intendiamo l’assunzione del punto di vista<br />
dell’imparzialità 2 , poiché non si potrà mai avere tale<br />
assunzione e la tensione verso questo principio senza dover affrontare<br />
i sacrifici consequenziali.<br />
Appare chiaro che in ogni vita umana arriva il momento della<br />
scelta tra fare il male o subirlo, piccolo o grande che sia e quando si<br />
presenta tale condizione, chiunque voglia vivere secondo il principio<br />
morale dell’imparzialità, sarà chiamato più a subire che a compiere<br />
ingiustizia.<br />
Perciò, le religioni non cristiane non possano non conoscere la<br />
croce, come simbolo del sacrificio personale, a cui l’uomo morale deve<br />
sottoporsi nella sua tensione esistenziale verso l’imparzialità del bene.<br />
4. La “croce” nel dialogo tra le religioni<br />
Innanzitutto bisogna chiedersi se: ammessa la mancanza della<br />
Croce come evento storico, nella riflessione teologica di certe<br />
religioni, possiamo anche accettare automaticamente l’assenza<br />
della “croce”, intesa come condizione del soggetto morale che<br />
2 Per dirla con Socrate: “... se fossi costretto a scegliere, preferirei piuttosto<br />
patire che commettere ingiustizia”. Platone. Giorgia, 469c.<br />
schede<br />
bibliografiche<br />
schede<br />
195
schede<br />
bibliografiche<br />
schede<br />
196<br />
tende verso la perfezione, nella sua riflessione etica? E che cosa è<br />
infatti, l’itinerario mistico delle religioni orientali se non un incamminarsi<br />
sulla via del dominio delle proprie reazioni emotivo-istintuali<br />
per giungere alla vera e piena serenità interiore?<br />
Diremo che è un cammino ascetico, eticamente orientato che si<br />
propone il superamento delle passioni, anche se non attraverso la<br />
lotta diretta, come nella cultura giudeo-cristiana, quanto piuttosto<br />
mediante la prevenzione e l’aggiramento. Ma non possiamo certamente<br />
dire che non sia eticamente orientato né che non conosca l’assunzione<br />
della dimensione della “croce” intesa come sacrificio e rinnegamento<br />
di sé. L’A. si rende conto delle difficoltà e dell’accurata<br />
analisi che si dovrà fare, prima di poter avviare un qualsiasi confronto<br />
fra la visione etica occidentale e quella orientale, ma si dice altrettanto<br />
convito della necessità di un tale confronto etico sulla dimensione<br />
della “croce” all’interno del dialogo tra le religioni. Un confronto<br />
ecumenico sulla dimensione staurica dell’etica è quanto mai<br />
necessario in quanto non possiamo pensare ad una religione senza<br />
etica, né tanto meno ad un etica senza “croce”.<br />
5. Progetto di un etica mondiale senza croce?<br />
Assistiamo già a diversi tentativi di dialogo tra religioni al<br />
fine di rielaborare un’etica a livello mondiale, ma la<br />
caratteristica di questi tentativi sembra essere il subdolo<br />
riduzionismo della prospettiva etica a ciò che di fatto costituisce una<br />
base da tutti condivisa. Ma se la prospettiva etica è quella che di<br />
fatto viene condivisa da tutti, significa che cambiando l’oggetto<br />
della condivisione, cambierà anche la prospettiva dell’etica. Così,<br />
nel progetto di un etica mondiale di Hans Küng o anche nella<br />
dichiarazione del parlamento delle religioni mondiali, la visione<br />
etica viene livellata a quelli che sono gli elementi fondamentali di<br />
qualsiasi prospettiva etica. Non è infatti, sul bonum faciendum et<br />
malum vitandum, né sul largo consenso che vanta questo principio<br />
che si potrà fare dei passi avanti per la ricerca etica nel dialogo ecumenico<br />
e fra le diverse religioni; ma piuttosto nell’affrontare le tante<br />
divergenze e nel risolvere i tanti problemi che si potrà trovare la via<br />
per l’elaborazione di un etica mondiale. Certamente, nel progetto di<br />
un etica mondiale non è direttamente presente la dimensione della<br />
croce, anche se il problema nasce nel momento stesso in cui la persona<br />
sceglie il principio di imparzialità.
6. Il riduzionismo staurico nell’etica contemporanea<br />
L’uomo di oggi non pensa tanto ad elevarsi fino a Dio,<br />
come ai tempi della Torre di Babele, ma pensa semplicemente<br />
di poterlo ridimensionare per condurlo maggiormente<br />
alla propria realtà. Così le religioni non sono più percepite<br />
come testimonianze della difficoltà dell’uomo di rappresentarsi Dio<br />
o della stessa difficoltà divina – per così dire – di rivelarsi all’uomo,<br />
ma piuttosto come modalità umane di riportare Dio entro la propria<br />
realtà. Anche la stessa teologia cattolica delle religioni, sotto tale<br />
influsso, a volte subisce la tentazione di ridimensionare l’unicità<br />
della stessa rivelazione. Così, anche la concezione dell’etica, filosofica<br />
e teologica, sotto un tale influsso rischia di non proporsi più<br />
come la ricerca di quella verità morale che sta sopra all’uomo, ma<br />
piuttosto come la costruzione umana di un quid che dipende solo<br />
dalle condizioni storico-culturali e geografico-ambientali in cui è<br />
stato creato o che condizionavano il suo creatore.<br />
Tutto questo rischia di ridurre la vita morale ad un puro atteggiamento<br />
interiore, staccato da un reale comportamento morale e quindi<br />
dalla fatica e dalla croce quotidiana, ma l’etica non è un semplice<br />
sentire, quanto piuttosto una spinta al bene operare. A tale<br />
proposito emblematica è la realtà della New Age, con il suo<br />
tentativo di appiattire le diversità, ammorbidendo le posizioni e<br />
livellando le asperità. Ma alla fine crea un unico calderone dove<br />
tutto si risolve sul piano del sentire personale più che su quello di un<br />
concreto agire morale corrispondente al sentire valoriale.<br />
7. Per un dialogo tra le religioni all’ombra della croce<br />
Per un vero dialogo tra le religioni s’impone la necessità di<br />
superare in etica il facile irenismo di cercare ciò che ci<br />
accomuna e ciò che già possiamo condividere, al fine di<br />
accettare la sfida del dialogo proprio su ciò che ci differenzia, e<br />
mossi dall’amore-ricerca della verità. Dovremmo sforzarci di cercare<br />
il perchè genetico ed argomentativo di certe diversità, per verificare<br />
se le proprie posizioni sono validamente fondate oppure no.<br />
Questo, però, presuppone una grandissima disponibilità a mettere in<br />
discussione il proprio modo di vedere le cose e di pensare, al fine di<br />
cercare sempre più la verità per poter aderire ad essa. Le divergen-<br />
schede<br />
bibliografiche<br />
schede<br />
197
schede<br />
bibliografiche<br />
schede<br />
198<br />
ze etiche, come quelle di tipo religioso, vanno profondamente analizzate,<br />
confrontate ed approfondite, poiché non può mai risultare<br />
vero in campo morale che due modi di pensare o di agire tra loro<br />
contraddittori, possano risultare contemporaneamente veri.<br />
Nel dialogo fra le diverse religioni è necessario un atteggiamento<br />
di totale imparzialità come piena disponibilità a rinunciare a ciò<br />
che si pensa nel caso in cui dovesse risultare falso, ed accettare ciò<br />
che dopo accurata riflessione dovesse risultare vero. Nel momento<br />
in cui, per la fede cristiana, ed anche per al rivelazione biblica, la<br />
croce assume una dimensione di fondamentale importanza, il cristiano<br />
si trova di fronte all’obbligo morale di sapere quello che è nelle<br />
sue facoltà intellettive di conoscere questo mistero, mentre il non<br />
cristiano avrà la necessita di confrontarsi con chi in questo mistero<br />
crede e vive, al fine di verificare le proprie posizioni. Se infatti, il<br />
fatto storico della croce non è un’invenzione dei vangeli, come noi<br />
crediamo, non possiamo fare a meno di cercare di capirne il significato,<br />
di spiegarlo e di dimostrarlo, almeno fin dove è possibile farlo.<br />
Le diverse religioni hanno quindi il dovere morale di dialogare,<br />
confrontandosi proprio sui contenuti teologici che le diversifica,<br />
come non potranno eludere dal loro dialogo quei contenuti etici tra<br />
loro più divergenti, confluiti in esse nel tempo attraverso la dimensione<br />
socio culturale.<br />
Se dunque l’evento “croce” risulta un evento specifico, realmente<br />
verificatosi nella fede cristiana, è nostro dovere il verificarne ed<br />
approfondirne la conoscenza attraverso il confronto dialogico con le<br />
altre religioni e con le varie culture e con la stessa cultura contemporanea,<br />
al fine di poterne presentare le caratteristiche specifiche, e<br />
ciò non per ridimensionare l’evento e la fede, ma piuttosto per permettere<br />
a chiunque, da qualunque punto di vista si collochi, un sereno<br />
incontro con l’evento “croce” e con il suo messaggio teologico<br />
ed etico.<br />
Fr. maximus a S.R.P. Cp.
PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE<br />
CATTEDRA GLORIA CRUCIS<br />
PRODUZIONE SCIENTIFICA<br />
DELLA CATTEDRA GLORIA CRUCIS<br />
AA.VV. Memoria <strong>Passio</strong>nis in Stanislas Breton, Edizioni<br />
Staurós, S. Gabriele Teramo, 2004.<br />
PIERO CODA Le sette Parole di Cristo in Croce, Edizioni<br />
Staurós, S. Gabriele Teramo, ottobre 2004.<br />
LUIS DIEZ MERINO, CP Il Figlio dell’Uomo nel Vangelo della <strong>Passio</strong>ne,<br />
Edizioni Staurós, S. Gabriele Teramo, ottobre<br />
2004.<br />
MARIO COLLU, CP Il Logos della Croce centro e fonte del Vangelo,<br />
Edizioni Staurós, S. Gabriele Teramo, novembre<br />
2004.<br />
TITO DI STEFANO, CP Croce e libertà, Edizioni Staurós, S. Gabriele<br />
Teramo, dicembre 2004.<br />
CARLO CHENIS, SDB Croce e arte, Edizioni Staurós, S. Gabriele<br />
Teramo, gennaio 2004.<br />
ANGELA MARIA LUPO, CP La Croce di Cristo segno definitivo<br />
FERNANDO TACCONE, CP (ed.)<br />
dell’Alleanza tra Dio e l’Uomo, Edizioni<br />
Staurós, S. Gabriele Teramo, febbraio 2004.<br />
Quale volto di Dio rivela il Crocifisso?, Edizioni<br />
OCD, Roma Morena, 2006.<br />
FERNANDO TACCONE, CP (ed.) La visione del Dio invisibile nel volto del<br />
Crocifisso, Edizioni OCD, Roma Morena, 2008.<br />
FERNANDO TACCONE, CP (ed.) Stima di sé e kenosi, Edizioni OCD, Roma<br />
Morena, 2008.<br />
FERNANDO TACCONE, CP (ed.) Croce e identità cristiana di Dio nei primi secoli,<br />
Edizioni OCD, Roma Morena, 2009.<br />
L’attività scientifica della Cattedra Gloria Crucis è fruibile nel sito www.passiochristi.org<br />
alla voce Cattedra Gloria Crucis.<br />
La rivista La Sapienza della Croce è anch’essa fruibile nello stesso sito alla voce<br />
Sapienza della Croce.