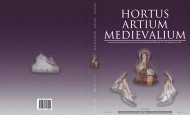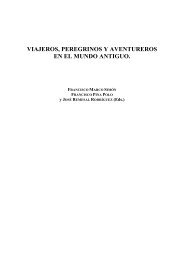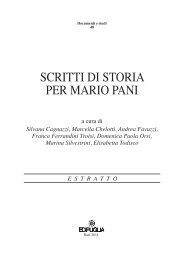AM XXXVII.indb - archeologia.unifg.it
AM XXXVII.indb - archeologia.unifg.it
AM XXXVII.indb - archeologia.unifg.it
- TAGS
- archeologia.unifg.it
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
età altomedievale 5 e poi nel X e nei primi decenni<br />
dell’XI sec., quando tali dinamiche si indirizzarono<br />
più decisamente verso soluzioni di accentramento di<br />
5 Sulle alture dei Monti Dauni e il Gargano costiero, in contesti<br />
terr<strong>it</strong>oriali e amministrativi di amb<strong>it</strong>o gastaldale longobardo furono<br />
innalzati alcuni castra (per riscontri archeologici, si veda il caso di<br />
Monterotaro: Dalena 2006; si veda anche Russi 2005; Favia c.s.a;<br />
sull’insediamento longobardo si veda anche Martin 1984, p. 98;<br />
Martin, Noyé 1988a, p. 305); il promontorio richiamò anche l’interesse<br />
precoce di grandi monasteri quali Montecassino e S. Vincenzo<br />
al Volturno (Favia c.s.a; si veda anche Del Treppo 1956, pp. 79-80;<br />
Corsi 1980, pp. 47-48, 56-60; Licinio 1994, p. 23). Segnali di una<br />
certa v<strong>it</strong>al<strong>it</strong>à echeggiano nella media e bassa valle del Fortore (Russi<br />
1985, p. 218; Gravina 1993, 1996, pp. 19-20, 30-31; Russi c.s.).<br />
Altre tracce insediative affiorano dalle carte, ove già fra VIII e IX sec.,<br />
si menzionano curtes, loci e vici, ubicati in una fascia intermedia tra<br />
la pianura del Tavoliere e le alture preappenniniche, privi però di una<br />
<strong>it</strong>erazione di c<strong>it</strong>azioni nei secoli successivi (Martin 1993, p. 204).<br />
Una forma specifica di presenza sul terr<strong>it</strong>orio era rappresentata dalla<br />
condoma, termine c<strong>it</strong>ato nelle carte lucerine e sipontine di VIII sec.,<br />
che pare indicare case rurali, spesso dipendenti da autor<strong>it</strong>à gastaldali<br />
o monastiche, ab<strong>it</strong>ate talora da servi. Variamente valutata nella sua<br />
consistenza (ipotesi di valenza collettive di queste strutture in Guillou<br />
1974, p. 173; letture più contenute in Fuiano 1978, pp. 50-51; Martin<br />
1993, pp. 206-208), questa un<strong>it</strong>à rurale sembra in certa misura rispondere<br />
ai caratteri di un insediamento sparso, seppure sotto un controllo<br />
padronale. Compaiono inoltre riferimenti a chiese o piccoli monasteri<br />
(le cui aree di insistenza in taluni casi sono state rinvenute attraverso<br />
analisi aerofotografiche: Romano, Volpe 2005, pp. 253-254, fig. 1 a<br />
p. 243 e fig. 9; Goffredo 2006, pp. 219-220, figg. 5-7; si veda anche<br />
Corsi 1980, p. 101), testimonianza di un certo ruolo delle strutture<br />
religiose nei processi di popolamento altomedievale e alle soglie<br />
dell’anno Mille, senza peraltro che tale ruolo paia avere assunto un<br />
rilievo particolarmente consistente nella formazione dell’insediamento<br />
e di nuovi nuclei demici. Nella geografia insediativa del Gargano (ma<br />
anche in qualche settore subappenninico e del Tavoliere) acquisì una<br />
sua valenza anche l’hab<strong>it</strong>at rupestre sebbene senza il respiro proprio<br />
di altri distretti apuli (Favia 2008a, 2008b, pp. 346-349, figg. 3-4). Va<br />
infine ricordato che la rete urbana altomedievale nella Puglia settentrionale<br />
ricalcò sostanzialmente l’assetto tardoantico, scontando peraltro<br />
alcune scomparse e acquisendo rarissimi esempi (Lesina e Vieste) di<br />
avanzamento di status verso una condizione c<strong>it</strong>tadina.<br />
PASQUALE FAVIA<br />
198<br />
fig. 1 – Carta della Puglia<br />
settentrionale con ubicazione<br />
dei principali s<strong>it</strong>i<br />
menzionati nel testo.<br />
villaggio, di fortificazione dei s<strong>it</strong>i e di piena riappropriazione<br />
allo sfruttamento umano del Tavoliere. In<br />
questi decenni a cavallo del Mille, certamente una<br />
spinta all’elaborazione di nuovi progetti di intervento<br />
sul terr<strong>it</strong>orio fu motivata dalla necess<strong>it</strong>à di risposta alle<br />
esigenze difensive in aree attraversate da un confine<br />
instabile, confl<strong>it</strong>tuale, e poi, una volta dissolta tale<br />
frontiera, alle esigenze di rapido stanziamento e consolidamento<br />
dei nuovi ceti dominanti a componente<br />
normanna. La cornice pol<strong>it</strong>ica e ist<strong>it</strong>uzionale e il livello<br />
“evenemenziale” delle vicende belliche dunque non<br />
furono certo ininfluenti sulle nov<strong>it</strong>à insediative in via<br />
di introduzione; tuttavia le indagini archeologiche<br />
documentano anche flussi di occupazione più articolati,<br />
mirati a recuperare più intensamente all’utilizzo<br />
antropico la pianura, a riutilizzare i bacini insediativi<br />
frequentati in epoca romana e tardo antica, a diversificare<br />
le tipologie insediative, a contemperare gli<br />
spazi boschivi e pastorali, di ered<strong>it</strong>à altomedievale,<br />
con rinnovate attiv<strong>it</strong>à agricole rivolte verso le colture<br />
arboricole specializzate e quelle cerealicole. I segnali di<br />
incremento degli stanziamenti nel Tavoliere si sposano<br />
in effetti in più casi al recupero del sostrato topografico<br />
e della rete di s<strong>it</strong>i di età romana. Così gli scavi di<br />
Herdonia, se, allo stato attuale della ricerca, come si<br />
è detto, non riannodano i fili di una chiara continu<strong>it</strong>à<br />
di occupazione 6 , tuttavia colgono, fra fine X e inizi<br />
XI sec., le spie di una fisionomia insediativa in via<br />
di definizione, seppure ancora non urbanisticamente<br />
precisata, che si riconfigura fra i resti della c<strong>it</strong>tà romana,<br />
talora riutilizzati (fig. 2), anche dal punto di vista<br />
6 Si veda supra nota n. 3.