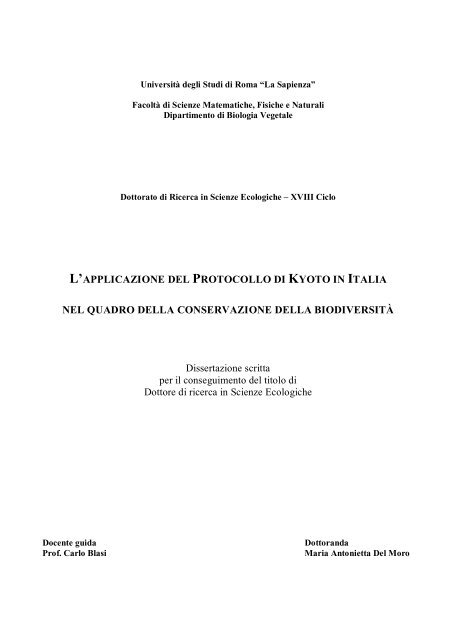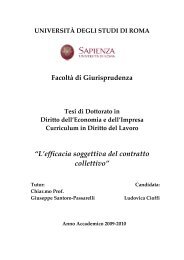TESI MA Del Moro - Padis - Sapienza
TESI MA Del Moro - Padis - Sapienza
TESI MA Del Moro - Padis - Sapienza
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Università degli Studi di Roma “La <strong>Sapienza</strong>”<br />
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali<br />
Dipartimento di Biologia Vegetale<br />
Dottorato di Ricerca in Scienze Ecologiche – XVIII Ciclo<br />
L’APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI KYOTO IN ITALIA<br />
NEL QUADRO DELLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ<br />
Dissertazione scritta<br />
per il conseguimento del titolo di<br />
Dottore di ricerca in Scienze Ecologiche<br />
Docente guida Dottoranda<br />
Prof. Carlo Blasi Maria Antonietta <strong>Del</strong> <strong>Moro</strong>
Indice<br />
1. INTRODUZIONE E OBIETTIVI DELLA RICERCA …………….…... pag. 5<br />
1.1 Il riscaldamento globale, i gas ad effetto serra e la Convenzione quadro<br />
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) ………………... pag. 5<br />
1.1.1 Il Protocollo di Kyoto ...………….………………………………………….… pag. 6<br />
1.1.2 Gli accordi di Marrakesh …………………………………………………........ pag. 8<br />
1.1.3 L’applicazione del Protocollo in Italia ……………………...………………... pag. 11<br />
1.1.4 Il ruolo delle foreste nell’assorbimento del carbonio ………………..……...... pag. 15<br />
1.2 La biodiversità …………………………………………………………………....... pag. 20<br />
1.2.1 La Convenzione sulla Biodiversità ……………..……………………………. pag. 23<br />
1.3 Obiettivi della ricerca …………………………………….………………………. pag. 25<br />
2. DATI E METODI …………………………………………………………….…. pag. 27<br />
2.1 Analisi della eterogeneità territoriale a scala locale ………..…….................. pag. 27<br />
2.1.1 Uso e copertura del suolo ……………….......................................................... pag. 27<br />
2.1.1.1 I dati territoriali di base e la scelta del sistema di riferimento ……... pag. 27<br />
2.1.1.2 Ortorettificazione e georefenziazione delle immagini digitali<br />
del 1990 .…………………………………………………………… pag. 32<br />
2.1.1.3 Analisi multitemporale 1990-2000 e classificazione secondo<br />
Corine Land Cover (tabella corrispondenza classi CLC ed<br />
attività contabilizzabili quali crediti di carbonio)…………...……… pag. 34<br />
2.1.2 Bioclimi e serie di vegetazione ………………………………………………. pag. 42<br />
2.2 Analisi della eterogeneità territoriale a scala nazionale …………..………... pag. 42<br />
2.2.1 Criterio di selezione delle aree campione ……………………………………. pag. 43<br />
2.2.2 L’eterogeneità bioclimatica italiana e la sua relazione con la copertura<br />
2.2.3 vegetazionale (classi forestali e serie di vegetazione) ….…………………….. pag. 46<br />
2.2.2.1 Bioclimi e classi CLC …………………………………………….. pag. 47<br />
2.2.2.2 Bioclimi e serie di vegetazione …………………………………… pag. 47<br />
2
3. RISULTATI ……………………………………………………………………… pag. 48<br />
3.1 Analisi della eterogeneità territoriale a scala locale ……...……………........ pag. 48<br />
3.1.1 Uso e copertura del suolo ………………......................................................... pag. 48<br />
3.1.1.1 Ortorettificazione e georefenziazione delle immagini digitali<br />
del 1990 ………................................................................................. pag. 48<br />
3.1.1.2 Analisi multitemporale 1990-2000 e classificazione secondo<br />
Corine Land Cover …………………………..……………………... pag. 50<br />
3.1.2 Bioclimi e serie di vegetazione ………………………………………………. pag. 54<br />
3.2 Analisi della eterogeneità territoriale a scala nazionale ……………………. pag. 57<br />
3.2.1 La copertura del suolo ………………………………………………………... pag. 57<br />
3.2.2 L’eterogeneità bioclimatica e la sua relazione con la copertura vegetazionale<br />
(classi forestali e serie di vegetazione) …………………………………….…. pag. 63<br />
3.2.2.1 Bioclimi e classi CLC2000 al I livello gerarchico …………………. pag. 63<br />
3.2.2.2 Bioclimi e classi forestali CLC2000 al III e IV-V livello gerarchico pag. 66<br />
3.2.2.3 Le classi di uso del suolo nelle celle campione …………………….. pag. 86<br />
3.2.2.4 Bioclimi e serie di vegetazione nelle celle campione …………..…. pag.134<br />
3.3 Modelli di intervento …………………………………………….…………….... pag. 235<br />
4. CONCLUSIONI ………………………………………..……………….……… pag. 239<br />
5. BIBLIOGRAFIA …………………………………………………………....….. pag. 246<br />
6. ACRONIMI E GLOSSARIO DEI TERMINI ………………..………..... pag. 255<br />
3
ALLEGATI<br />
All. 1 Legenda dettagliata CORINE Land Cover III livello (fonte APAT)<br />
All. 2 Legenda sintetica CORINE Land Cover IV Livello - con dettaglio al 4° livello per la<br />
classe 3 e al 5° livello per la classe 3.1.3 (fonte APAT)<br />
All. 3 La Convenzione “Completamento delle Conoscenze Naturalistiche di Base” (CCNB)<br />
per il territorio italiano - Il progetto europeo I&CLC2000<br />
All. 4 L’Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi di Carbonio (INFC)<br />
All. 5 La metodologia IPPC per il Carbon accounting<br />
All. 6 Workshop e pubblicazioni<br />
RINGRAZIAMENTI<br />
4
1. INTRODUZIONE E OBIETTIVI DELLA RICERCA<br />
1.1 Il riscaldamento globale, i gas ad effetto serra e la Convenzione quadro<br />
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC)<br />
L’aumento della temperatura globale, fenomeno planetario noto come Global Warming, e<br />
quantificato nel corso del XX secolo in 0,75° C, è attribuito alla crescita eccessiva della<br />
concentrazione in atmosfera dei cosiddetti gas ad effetto serra 1 (Prentice et al., 2001). La sola<br />
anidride carbonica (CO2), dalla Rivoluzione Industriale ad oggi, è aumentata da 280 a 368 parti per<br />
milione in volume (Marland et al., 2005). Il tasso decennale di incremento nell’ultimo secolo è stato<br />
persistente e più rapido di qualsiasi altro periodo dell’ultimo millennio (Keeling et Whorf, 1999).<br />
L’effetto serra è in realtà un fenomeno naturale per effetto del quale la radiazione solare penetra<br />
nell’atmosfera e riscalda la superficie terrestre, mantenendola così a temperature compatibili con la<br />
vita. La radiazione terrestre di ritorno è assorbita dai gas serra che intrappolano il calore<br />
impedendone la dispersione al di fuori all’atmosfera e inducendo una generale tendenza al<br />
riscaldamento. La concentrazione troppo elevata di questi gas crea però scompensi al sistema terraatmosfera<br />
e contribuisce ai cambiamenti climatici, riconosciuti come una delle minacce più gravi<br />
alla vita del nostro pianeta (ECCM, 2002). Alcune fluttuazioni nella composizione atmosferica<br />
possono essere ricondotte a variazioni dell’eccentricità dell’orbita terrestre, che influiscono sulla<br />
quantità di energia solare intercettata dalla Terra, o anche dal rilascio di sostanze gassose da parte di<br />
fonti naturali quali i vulcani, ma la causa preponderante è individuabile nelle attività umane: l’uso<br />
dei combustibili fossili, le industrie e i cambiamenti di uso del suolo tra cui la deforestazione hanno<br />
provocato nel corso del tempo un incremento della concentrazione in atmosfera, in particolare, di<br />
anidride carbonica (CEALP, 2003).<br />
Le attività di natura antropogenica hanno accresciuto dunque significativamente l’effetto serra<br />
naturale, come riconosce l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate change), che afferma “the<br />
balance of evidence suggests a discernible human influence on the climate system”. Secondo questo<br />
gruppo di esperti che ha il compito preparare rapporti, studi, valutazioni e linee guide sul<br />
cambiamento climatico e sui suoi effetti potenziali, la temperatura terrestre potrebbe aumentare tra<br />
1° e 6° C già entro l’anno 2100.<br />
Nel 1992, i delegati di 150 paesi, presa coscienza del problema, hanno approvato la United Nations<br />
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC): essa è stata adottata a New York il 9<br />
maggio e presentata ai governi per la firma nel corso del vertice delle Nazioni Unite sull’Ambiente e<br />
lo Sviluppo svoltosi a Rio de Janeiro nel successivo mese di giugno. La conferenza UNCED (United<br />
Nations Conference on Environment and Development) ha originato cinque documenti formali:<br />
cambiamenti climatici, biodiversità, foreste, “Rio Declaration on Environment and Development” e<br />
“Agenda 21”. Nella Dichiarazione, che consiste di un preambolo e di 27 principi, vengono date<br />
indicazioni volte a promuovere un più sano ed efficiente rapporto tra uomo e ambiente. In<br />
particolare, è richiamata l’attenzione su un numero di argomenti rilevanti, tra i quali l’equità tra le<br />
generazioni, i bisogni del mondo povero, la cooperazione tra stati, la responsabilità civile e la<br />
compensazione dei danni ambientali, il Principio “chi inquina-paga” (come sarà discusso<br />
1 Tra i gas-serra, di seguito menzionati anche come GHG (Green House Gases), vi sono il biossido di carbonio, il metano,<br />
l’ossido di azoto, gli idro- e perfluorocarburi, ecc..<br />
5
dettagliatamente in seguito), la valutazione d’impatto ambientale. Il concetto di fondo di sviluppo<br />
sostenibile cui si ispira viene elaborato nel rapporto “Our Common Future” (1987), redatto dal<br />
WCED (World Commission on Environment and Development), organismo internazionale istituito<br />
dalle Nazioni Unite nel 1983.<br />
La UNFCCC, sottoscritta da 154 Paesi più l'Unione europea ed entrata in vigore il 21 marzo 1994,<br />
si ispira ai principi guida delle “responsabilità comuni ma differenziate” (“the Parties should protect<br />
the climate system for the benefit of present and future generations of humankind, on the basis of<br />
equity and in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective<br />
capabilities”) e della “precauzionalità”.<br />
Questa convenzione costituisce la base del successivo Protocollo di Kyoto. Essa definisce in<br />
particolare un obiettivo di stabilizzazione delle concentrazioni di gas-serra per la protezione del<br />
sistema climatico e promuove interventi a livello nazionale e internazionale per il suo<br />
raggiungimento. Non prevede però impegni vincolanti per la riduzione delle emissioni, ma solo una<br />
assunzione di responsabilità dei Paesi industrializzati a produrre comunicazioni nazionali al<br />
Segretariato della stessa Convenzione, riportando, inter alia, le proprie emissioni di gas-serra ai<br />
livelli del 1990 entro l’anno 2000.<br />
1.1.1 Il Protocollo di Kyoto<br />
Una svolta riguardo alla politica sui cambiamenti climatici si è avuta nel corso della COP3 2 della<br />
Convenzione con l'adozione a Kyoto, nel dicembre 1997, dell’omonimo Protocollo.<br />
Il Protocollo di Kyoto della UNFCCC mette in evidenza il nuovo atteggiamento della comunità<br />
internazionale rispetto al problema dei cambiamenti climatici 3 . Si tratta infatti di un atto esecutivo<br />
che obbliga i Paesi Annex I 4 , ossia Paesi industrializzati e Paesi con economia in transizione, alla<br />
riduzione delle emissioni di sei tipi di gas-serra, non controllati dal Protocollo di Montreal 5 per la<br />
protezione della fascia di ozono, e individuati in: anidride carbonica (CO2), metano (CH4), ossido di<br />
azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) ed esafluoruro di zolfo (SF6).<br />
L’anidride carbonica è prodotta per lo più dall'impiego dei combustibili fossili in tutte le attività<br />
energetiche e industriali, oltre che nei trasporti; il metano deriva principalmente dalle discariche dei<br />
rifiuti, dagli allevamenti zootecnici e dalle coltivazioni di riso; il protossido di azoto dal settore<br />
agricolo e dalle industrie chimiche; gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi e l'esafluoruro di zolfo<br />
sono impiegati nelle industrie chimiche e manifatturiere.<br />
Il target di riduzione delle emissioni rispetto ai livelli del 1990, in particolare di CO2, CH4 e N2O e<br />
di altri tre gas di origine industriale, per il periodo 2008-2012, è fissato a livello mondiale ad almeno<br />
il 5,2% e per i paesi membri dell'Unione europea all'8% 6 . In seguito a una decisione del Consiglio<br />
dei Ministri dell'Ambiente dell'UE, per l’Italia l’impegno è stato fissato al 6,5% .<br />
2 Le Conference of Parties (COP) costituiscono i momenti decisionali delle convenzioni internazionali.<br />
3 http://europa.eu.int/scadplus/glossary/kyoto_protocol_it.htm<br />
4 www.minambiente.it/Sito/settori_azione/pia/docs/protocollo_kyoto_it.pdf<br />
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf<br />
5 Per “Protocollo di Montreal” si intende il Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono,<br />
adottato a Montreal il 16 settembre 1987, nella sua forma successivamente modificata ed emendata.<br />
6 L’art. 4 del Protocollo di Kyoto consente di adempiere al vincolo sulle emissioni di gas-serra per macroregioni (bubble):<br />
l’Unione Europea ha infatti un obiettivo globale dell’8% che, in un secondo tempo, è stato ripartito tra i diversi stati (Italia: -<br />
6,5%; Francia: 0%; Germania: -21%; UK: -12,5%; ecc.).<br />
6
Gli impegni assunti con il Protocollo, a differenza di quelli della Convenzione, sono vincolanti per i<br />
Paesi firmatari. Ciò implica che i Paesi inadempienti sono economicamente sanzionabili 7 .<br />
Sono cioè inseriti in modo fattivo in questo accordo i due concetti ribaditi a Rio de Janeiro in<br />
occasione della Conferenza sullo Sviluppo e l’Ambiente del 1992:<br />
1) il Principio dell’inquinatore-pagatore, confluito nel principio 16 della Dichiarazione di Rio<br />
sullo Sviluppo e l’Ambiente, afferma che chi inquina dovrebbe pagare l’intero costo dei danni<br />
ambientali causati dalla sua attività: ciò creerebbe un incentivo alla riduzione del danno ambientale.<br />
Concretamente si estrinseca nell’uso di strumenti di politica ambientale quali le tasse ambientali, i<br />
permessi di inquinamento negoziabili, la responsabilità civile, ecc.<br />
2) il Principio precauzionale, incorporato nel principio 15 della Dichiarazione di Rio, secondo cui,<br />
qualora vi siano minacce di danni seri e irreversibili all’ambiente, l’assenza di certezza scientifica<br />
circa un fenomeno (come nel caso dell’effetto serra) non giustifica la posposizione di misure di<br />
prevenzione del danno ambientale. Pertanto, esso afferma che, in caso di incompleta conoscenza<br />
scientifica e di possibilità di danni non rimediabili, è bene evitare il rischio attraverso un’azione<br />
preventiva immediata, ancorché basata su un’informazione imperfetta, piuttosto che rimandare<br />
l’azione per acquisire informazioni certe.<br />
Il Protocollo di Kyoto rappresenta, in effetti, una prima fase della lotta ai cambiamenti climatici. Per<br />
preparare il periodo successivo al 2012, la Commissione Europea ha avviato nel 2004 una vasta<br />
consultazione delle parti interessate e lanciato sia uno specifico programma europeo sul<br />
cambiamento climatico sia una proposta di direttiva concernente un sistema di scambio di diritti di<br />
emissione del biossido di carbonio.<br />
Le azioni primarie di intervento devono concentrarsi nei settori: industriale, civile, agricolo, dei<br />
trasporti e delle energie rinnovabili. Ogni Paese è tenuto ad elaborare politiche e misure, quali:<br />
- il miglioramento dell'efficienza energetica in tutti i settori rilevanti dell'economia nazionale;<br />
- la protezione e il miglioramento dei meccanismi di rimozione e di raccolta dei GHG;<br />
- la promozione di metodi sostenibili di gestione forestale, di imboschimento e di rimboschimento<br />
e di forme sostenibili di agricoltura;<br />
- la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di energia rinnovabile, di tecnologie<br />
per la cattura e l'isolamento dell’anidride carbonica e di tecnologie avanzate ed innovative<br />
compatibili con l'ambiente;<br />
- la riduzione progressiva delle imperfezioni del mercato, degli incentivi fiscali, delle esenzioni<br />
tributarie e dei sussidi in tutti i settori responsabili di emissioni di GHG;<br />
- l'adozione di misure volte a limitare e/o ridurre le emissioni di gas ad effetto serra nel settore dei<br />
trasporti;<br />
- la limitazione e/o riduzione delle emissioni di metano attraverso il recupero e l’utilizzazione del<br />
gas nel settore della gestione dei rifiuti, nonché nella produzione, il trasporto e la distribuzione<br />
di energia.<br />
Accanto all'obbligo imprendiscibile della riduzione sono previsti tutta una serie di adempimenti<br />
secondari: dalla creazione di studi e progetti volti all’aumento dell'efficienza energetica alla<br />
7 La direttiva 2003/87/CE stabilisce una sanzione per le emissioni di ogni tonnellata eccedente il limite stabilito pari a<br />
Euro 40/anno nel periodo 2005-2007, e pari a Euro 100/anno nel periodo 2008-2012.<br />
7
ideazione di progetti in grado di potenziare le capacità di assorbimento di gas-serra (le opere volte<br />
ad aumentare l’estensione dela copertura vegetale, se iniziate dopo il 1990, possono infatti essere<br />
tenute in debito conto ai fini del bilancio tra quanto rilasciato e quanto assorbito).<br />
Tra gli adempimenti sono da citare anche la realizzazione di progetti di cooperazione tra gli Stati in<br />
via di sviluppo e gli Stati sviluppati. Possono cioè essere utilizzati anche i meccanismi flessibili<br />
previsti dal Protocollo di Kyoto:<br />
Il Clean Development Mechanism (CDM) consente ai Paesi industrializzati e con economia in<br />
transizione di realizzare progetti nei Paesi in via di sviluppo che producano benefici ambientali in<br />
termini di riduzione delle emissioni di gas-serra e di sviluppo economico e sociale dei Paesi ospiti e<br />
nello stesso tempo generino crediti di emissione per i Paesi che promuovono gli interventi;<br />
La Joint Implementation (JI) consente ai Paesi industrializzati e con economia di transizione di<br />
realizzare progetti per la riduzione delle emissioni di gas-serra in un altro Paese dello stesso gruppo<br />
e di utilizzare i crediti derivanti, congiuntamente con il Paese ospite;<br />
L’Emissions Trading (ET) consente lo scambio di crediti di emissione tra Paesi industrializzati e<br />
con economia in transizione: un Paese che abbia conseguito una diminuzione delle proprie<br />
emissioni di gas serra superiore al proprio obiettivo può così cedere (ricorrendo all’ET) tali “crediti”<br />
a un Paese che, al contrario, non sia stato in grado di rispettare i propri impegni di riduzione delle<br />
emissioni di gas-serra.<br />
Il Protocollo di Kyoto è entrato in vigore i1 16 febbraio 2005, quando è stato raggiunto il quorum<br />
sufficiente di paesi industrializzati, responsabili del 55% delle emissioni globali.<br />
Gli effetti di questo evento non riguardano tanto le prospettive di riduzione delle emissioni mondiali<br />
di gas-serra sul breve periodo; infatti se l’obiettivo dichiarato del Protocollo di Kyoto era quello di<br />
una riduzione delle emissioni di gas-serra nei Paesi industrializzati del 5,2% nel 2008-2012 rispetto<br />
ai livelli del 1990, la mancata adesione degli USA e le concessioni richieste dalla Russia hanno<br />
finito col ridurre questa percentuale allo 0,4% rispetto ai valori del 1990. L’effetto più importante<br />
dell'entrata in vigore - che rappresenta un grosso successo politico per l’Unione Europea, che si è<br />
impegnata strenuamente per il rafforzamento di questo processo - è invece quello di rilanciare la<br />
cooperazione internazionale per la tutela del clima globale del pianeta, di cui il Protocollo<br />
rappresenta solo il primo passo. Dal 2005, infatti, la Conferenza delle Parti del Protocollo ha avviato<br />
un processo negoziale per definire gli obiettivi di riduzione per i per i periodi d'impegno successivi<br />
a quelli fissati nel 1997 (in gergo post-Kyoto).<br />
1.1.2 Gli accordi di Marrakesh<br />
Nel corso della Settima Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro sui Cambiamenti<br />
Climatici (COP7), tenutasi a Marrakesh 8 dal 29 ottobre al 9 novembre 2001, sono stati discussi i<br />
dettagli relativi all’uso degli strumenti operativi e sono state stabilite le definizioni (Tabella 1) delle<br />
attività del settore forestale e dei cambiamenti di uso del suolo – noto come LULUCF 9 sector –<br />
ammissibili alla contabilizzazione dei crediti di carbonio, ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 3<br />
8 http://unfccc.int/cop7/index-13.html<br />
9 Land Use, Land Use Change and Forestry.<br />
8
del Protocollo. Per conseguire i risultati proposti, il Protocollo di Kyoto consente infatti di fare<br />
anche uso degli assorbimenti di CO2 da foreste e terreni agricoli (i cosiddetti carbon sink).<br />
A Marrakesh è stata però ribadita l’esigenza di limitare al minimo l’uso dei carbon sink al fine di<br />
non eludere gli impegni reali di riduzione ed evitare che si contrappongano agli obiettivi di<br />
conservazione della biodiversità e di gestione sostenibile delle foreste.<br />
Tabella 1 - Definizioni ufficiali relative al settore LULUCF secondo gli accordi di Marrakesh<br />
(COP7 UNFCCC, Marrakesh, 2001) con traduzione a fronte.<br />
ANNEX<br />
Definitions, modalities, rules and guidelines<br />
relating to land use, land-use change and<br />
forestry activities under the Kyoto Protocol<br />
ALLEGATO<br />
Definizioni, modalità, regole e linee guida<br />
relative alle attività di uso del suolo,<br />
cambiamento di uso del suolo e attività forestali<br />
secondo il Protocollo di Kyoto<br />
A. Definitions A. Definizioni<br />
1. For land use, land-use change and<br />
forestry activities under Article 3, paragraphs<br />
3 and 4, the following definitions shall apply:<br />
Forest is a minimum area of land of 0.05-1.0<br />
hectares with tree crown cover (or equivalent<br />
stocking level) of more than 10-30 per cent<br />
with trees with the potential to reach a<br />
minimum height of 2-5 metres at maturity in<br />
situ. A forest may consist either of closed<br />
forest formations where trees of various<br />
storeys and undergrowth cover a high<br />
proportion of the groundor open forest. Young<br />
natural stands and all plantations which have<br />
yet to reach a crown density of 10-30 per cent<br />
or tree height of 2-5 metres are included<br />
under forest, as are areas normally forming<br />
part of the forest area which are temporarily<br />
unstocked as a result of human intervention<br />
such as harvesting or natural causes but<br />
which are expected to revert to forest.<br />
Afforestation is the direct human-induced<br />
conversion of land that has not been forested<br />
for a period of at least 50 years to forested<br />
1. Per le attività legate all’uso del suolo, alle<br />
variazioni di uso del suolo e alla forestazione 10<br />
secondo i paragrafi 3 e 4 dell’Articolo 3, si<br />
applicheranno le definizioni seguenti:<br />
Foresta è un’area con dimensioni minime di 0,05-<br />
1,0 ettari, con un tasso di copertura arborea di<br />
almeno 10-30%, con piante in grado di<br />
raggiungere, a maturità e in situ, un’altezza<br />
minima di 2,5 m.<br />
* Un Paese può scegliere, sia per le dimensioni<br />
minime che per il tasso di copertura, il limite<br />
minimo all’interno del range.<br />
Afforestazione è la conversione in foresta, per<br />
azione antropica, di un’area che non sia stata<br />
foresta per almeno 50 anni; l’afforestazione può<br />
10 Forestazione è un termine di ampia diffusione negli ultimi anni. Inizialmente utilizzato per opere d’imboschimento o<br />
rimboschimento, è stato poi utilizzato ad indicare vari interventi di natura forestale, attribuendogli un significato non lontano<br />
da quello dell’inglese Forestry. Alcuni autori (Hofmann, 1994) ritengono gli siano preferibili gli specifici riferimenti alla<br />
coltura boschiva, al rimboschimento, all’arboricoltura da legno, all’assestamento forestale, ai piani forestali, ecc. Esso è però<br />
entrato nel linguaggio corrente e per questo motivo sarà utilizzato anche in questo lavoro.<br />
9
land through planting, seeding and/or the<br />
human-induced promotion of natural seed<br />
sources.<br />
Reforestation is the direct human-induced<br />
conversion of non-forested land to forested<br />
land through planting, seeding and/or the<br />
human-induced promotion of natural seed<br />
sources, on land that was forested but that has<br />
been converted to non-forested land. For the<br />
first commitment period, reforestation<br />
activities will be limited to reforestation<br />
occurring on those lands that did not contain<br />
forest on 31 December 1989.<br />
Deforestation is the direct human-induced<br />
conversion of forested land to non forested<br />
land.<br />
Revegetation is a direct human-induced<br />
activity to increase carbon stocks on sites<br />
through the establishment of vegetation that<br />
covers a minimum area of 0.05 hectares and<br />
does not meet the definitions of afforestation<br />
and reforestation contained here.<br />
Forest management is a system of practices<br />
for stewardship and use of forest land aimed<br />
at fulfilling relevant ecological (including<br />
biological diversity), economic and social<br />
functions of the forest in a sustainable<br />
manner.<br />
Cropland management is the system of<br />
practices on land on which agricultural crops<br />
are grown and on land that is set aside or<br />
temporarily not being used for crop<br />
production.<br />
Grazing land management is the system of<br />
practices on land used for livestock<br />
production aimed at manipulating the amount<br />
and type of vegetation and livestock produced.<br />
essere realizzata per mezzo di piantagione, semina<br />
e/o un intervento antropico di sostegno alla<br />
affermazione delle modalità naturali di<br />
propagazione.<br />
Riforestazione è la conversione, per azione<br />
antropica, in foresta di un terreno già in<br />
precedenza forestale, ma che nel passato<br />
cinquantennio è stato convertito ad altri usi,<br />
realizzata per mezzo di piantagione, semina e/o<br />
azione antropica di sostegno all’affermazione di<br />
modalità naturali di propagazione.<br />
Deforestazione è la conversione per azione<br />
antropica di un’area forestale in non forestale.<br />
Rivegetazione è una azione antropica volta ad<br />
aumentare gli stock di carbonio in un sito,<br />
mediante la realizzazione di una copertura<br />
vegetale su un’area minima di 0,5 ettari, che non<br />
rientri nelle definizioni di afforestazione e<br />
riforestazione.<br />
Gestione forestale è un complesso di pratiche per<br />
la conduzione e l’uso sostenibile di una foresta,<br />
finalizzate al conseguimento di rilevanti funzioni<br />
ecologiche (quali la tutela della diversità<br />
biologica), economiche e sociali.<br />
Gestione delle colture agrarie è un complesso di<br />
pratiche su territori su cui sono effettuate<br />
coltivazioni agrarie e su terreni messi a riposo o<br />
temporaneamente non adoperati per produzioni<br />
agricole.<br />
Gestione dei prati e dei pascoli è un complesso di<br />
pratiche su terreni utilizzati per l’allevamento del<br />
bestiame, volti a modificare la quantità e il tipo di<br />
vegetazione e il bestiame allevato.<br />
10
1.1.3 L’applicazione del Protocollo in Italia<br />
Fin dall'inizio degli anni Novanta, l'Italia è stata fra le nazioni più attive nel promuovere una politica<br />
di protezione dell'atmosfera, assumendo importanti impegni internazionali. I passi principali della<br />
politica italiana sul clima sono stati i seguenti:<br />
- il 29 ottobre 1990, su proposta e sotto la presidenza italiana, l'Unione Europea ha assunto<br />
l'impegno di stabilizzazione delle emissioni di anidride carbonica ai livelli del 1990 entro il<br />
2000 e di controllo delle emissioni degli altri gas-serra;<br />
- l'Italia ha ratificato la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici con la legge n. 65 del 15<br />
gennaio 1994, entrata poi ufficialmente in vigore il 21 marzo 1994;<br />
- con il "Programma nazionale per il contenimento delle emissioni di anidride carbonica",<br />
approvato dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 11 , l'Italia ha<br />
emanato il 25 febbraio 1994 il primo provvedimento nazionale in attuazione degli impegni della<br />
Convenzione;<br />
- il 16 gennaio 1995 l'Italia ha trasmesso alle Nazioni Unite e all'Unione europea la Prima<br />
Comunicazione Nazionale alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici;<br />
- alla "Conferenza nazionale sui cambiamenti climatici, energia e trasporti", tenutasi a Roma dal<br />
13 al 15 novembre 1997 (due settimane prima di Kyoto), è stata presentata la Seconda<br />
Comunicazione Nazionale alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, che fa il punto<br />
sulla situazione nel raggiungimento dell'obiettivo della stabilizzazione al 2000 e individua un<br />
elenco di misure coerenti con il raggiungimento dell'obiettivo del -7% al 2010;<br />
- la delibera CIPE del 3 dicembre 1997 ha formalmente approvato le linee generali della Seconda<br />
Comunicazione, rimandando però l'approvazione dei programmi attuativi degli impegni<br />
scaturenti dalle decisioni internazionali a una delibera successiva dello stesso CIPE;<br />
- la delibera CIPE del 19 novembre 1998 ha approvato le "Linee guida per le politiche e le misure<br />
nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra", definendo i criteri, i tempi e le azioni per il<br />
conseguimento dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas-serra fissato dal Protocollo di<br />
Kyoto e dalle decisioni dell’Unione Europea;<br />
- l’Italia ha ratificato il Protocollo di Kyoto con la legge n. 120 del 1° giugno 2002: impegnava il<br />
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (<strong>MA</strong>TT) a presentare al CIPE la proposta di<br />
revisione della citata delibera CIPE del 19 novembre 1998;<br />
- il 19 dicembre 2002 il CIPE ha approvato la revisione delle “Linee-guida per le politiche e le<br />
misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra” del 19 novembre 1998 e il relativo<br />
Piano di Azione Nazionale per la riduzione delle emissioni dei gas serra (PAN), redatti dal<br />
<strong>MA</strong>TT.<br />
11 http://www.cipecomitato.it/ML_Cipe.asp<br />
11
La nuova delibera e il relativo Piano di Azione tengono conto degli elementi delle decisioni<br />
negoziali assunte dalla Marrakesh. Tali elementi riguardano la possibilità di contabilizzare, come<br />
riduzione delle emissioni, il carbonio assorbito dalle nuove piantagioni forestali e dalle attività<br />
agroforestali e di utilizzare in maniera sostanziale i meccanismi flessibili (Clean Development<br />
Mechanism, Joint Implementation, Emissions Trading).<br />
Da un punto di vista finanziario, nel triennio 2002-2004, la legge di ratifica ha destinato 25 milioni<br />
di Euro/anno alla realizzazione di progetti pilota, a livello nazionale e internazionale, finalizzati alla<br />
riduzione delle emissioni e all’aumento degli assorbimenti di carbonio; a partire dal 2003, 68<br />
milioni di Euro/anno sono stati destinati al finanziamento di progetti nei Paesi in via di sviluppo<br />
(PVS) finalizzati alla riduzione delle emissioni ed alla protezione dagli effetti dei cambiamenti<br />
climatici.<br />
Il PAN individua i programmi e le misure da attuare per rispettare l’obiettivo di riduzione delle<br />
emissioni dei gas serra attribuito all’Italia secondo il quale nel periodo 2008-2012 le emissioni<br />
dovranno essere ridotte del 6,5%, rispetto al 1990, ossia non potranno superare i 487 Mt CO2<br />
equivalente. In particolare il PAN individua tre diversi gruppi di misure:<br />
- le misure incluse nello scenario di riferimento;<br />
- le misure da attuare nel settore agricolo e forestale per aumentare la capacità di assorbimento del<br />
carbonio;<br />
- le ulteriori misure di riduzione, sia a livello interno, sia mediante i meccanismi di cooperazione<br />
internazionale CDM e JI.<br />
Poiché le emissioni tendenziali al 2010 corrispondono a 580 Mt di CO2 equivalenti, il gap da<br />
colmare a quella data sarà pari a 93 Mt di CO2 equivalenti. Partendo da queste premesse, il PAN è<br />
stato elaborato individuando prioritariamente le misure già adottate – anche se non ancora attuate –<br />
finalizzate alla promozione dello sviluppo economico dell’Italia, che hanno come effetto collaterale<br />
la riduzione delle emissioni. Tali misure concorrono a definire lo scenario di riferimento e<br />
consentono una riduzione delle emissioni di circa 52 Mt di CO2 equivalenti rispetto allo scenario<br />
tendenziale, riducendo il gap a 41 Mt di CO2 equivalenti.<br />
L’elenco delle misure incluse nello scenario di riferimento è riportato nella Tabella 2. Sulla base<br />
dello scenario di riferimento la delibera definisce i livelli massimi di emissione per i diversi settori,<br />
ovvero gli obblighi di riduzione che i settori dovranno rispettare nel periodo 2008-2012.<br />
12
Tabella 2 - Misure incluse nello scenario di riferimento per la riduzione delle emissioni<br />
Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 2003<br />
Tipologia delle misure Riduzione(MtCO2/anno)<br />
Industria elettrica 26,0<br />
Espansione cicli combinati per 3200 MW 8,9<br />
Espansione capacità import per 2300 MW 10,6<br />
Ulteriore crescita fonti rinnovabili per 2800 MW 6,5<br />
Civile - Decreti efficienza usi finali 6,3<br />
Trasporti 7,5<br />
Autobus e veicoli privati con carburanti a minor densità di<br />
carbonio (Gpl, metano)<br />
Sistemi di ottimizzazione e collettivizzazione del trasporto<br />
privato<br />
Rimodulazione dell’imposizione<br />
Attivazione sistemi informatico-telematici<br />
Sviluppo infrastrutture nazionali e incentivazione del trasporto<br />
combinato su rotaia e del cabotaggio<br />
Totale misure nazionali 39,8<br />
Crediti di carbonio da CDM e JI 12,0<br />
TOTALE MISURE 51,8<br />
Il secondo gruppo di misure previsto dal PAN prevede un’ulteriore riduzione delle emissioni<br />
mediante interventi di afforestazione e riforestazione, attività di gestione forestale, di gestione dei<br />
suoli agricoli e dei pascoli, di rivegetazione. A tali misure, basate sulla capacità delle piante di<br />
assorbire CO2 dall’atmosfera e di fissarla per periodi più o meno lunghi nei diversi pool degli<br />
ecosistemi agricoli e forestali, è riconosciuto un potenziale di fissazione di 10,2 Mt di CO2<br />
equivalenti (in grado, quindi di compensare emissioni di gas-serra per una stessa quantità).<br />
Per la realizzazione di tali attività il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto<br />
con il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali e d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni,<br />
presenterà al CIPE il Piano dettagliato per il primo triennio 2004-2006.<br />
É prevista inoltre la realizzazione del secondo inventario delle foreste (ISAFA, 1985)<br />
dell’Inventario Nazionale delle Foreste e di serbatoi di Carbonio (INFC; Allegato 4), allo scopo di<br />
poter stimare il potenziale nazionale di fissazione di carbonio derivante dalla gestione forestale, e<br />
del Registro Nazionale dei serbatoi di Carbonio, al fine di certificare i flussi di carbonio nel periodo<br />
2008-2012 derivanti da attività di afforestazione, riforestazione, deforestazione, gestione forestale,<br />
gestione di suoli agricoli, pascoli e rivegetazione.<br />
Per colmare il gap residuale di circa 30 Mt di CO2 equivalenti sono state individuate ulteriori misure<br />
di riduzione (Tabella 3), sia a livello nazionale che mediante i meccanismi di cooperazione<br />
internazionale. Le opzioni indicate consentono una riduzione delle emissioni compresa tra 55 e 99<br />
Mt CO2 equivalente.<br />
1,5<br />
2,1<br />
3,9<br />
13
Tabella 3 - Opzioni per ulteriori misure di riduzione delle emissioni<br />
Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 2003<br />
Tipologia delle opzioni per settori<br />
A) OPZIONI PER ULTERIORI MISURE NAZIONALI DI<br />
RIDUZIONE<br />
Fonti di energia<br />
Riduzione potenziale<br />
(MtCO2 eq/anno)<br />
Settore industriale 6,9 – 13,0<br />
Settore civile<br />
3,8 - 6,5<br />
Settore agricoltura 0,28 - 0,34<br />
Settore trasporti 13,3 – 19,1<br />
Altre fonti<br />
Settore industriale 6,20<br />
Settore agricoltura 0,61 – 1,29<br />
Settore rifiuti 0,64<br />
Altro (solventi, fluorurati) 0,76<br />
B) OPZIONI PER L’IMPIEGO DEI MECCANISMI JI E CDM<br />
Assorbimento di carbonio 5 - 10<br />
Progetti nel settore dell’energia 15,5 - 38<br />
Tra queste opzioni saranno individuate quelle misure che, al minor costo, consentono di colmare il<br />
gap di 30 Mt di CO2 equivalenti.<br />
Per l’individuazione delle ulteriori misure di riduzione delle emissioni, è stato definito un insieme di<br />
possibili programmi e iniziative nei settori dell’energia, dei trasporti, dell’industria,<br />
dell’agricoltura, della cooperazione economica e tecnologica internazionale. Le possibili opzioni<br />
verranno scelte, fermo restando il raggiungimento dell’obiettivo ambientale, con il criterio<br />
dell’aumento dell’efficienza dell’economia italiana.<br />
I soggetti istituzionali più direttamente coinvolti sono dunque: il Ministero dell’Ambiente e della<br />
Tutela del Territorio, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e l’Agenzia per la protezione<br />
dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT 12 ).<br />
In Tabella 4 sono indicati gli interventi nel settore dell’uso del suolo e della forestazione utili alla<br />
generazione dei crediti di carbonio. E’ specificato che le attività possono essere realizzate anche<br />
all’estero, in aderenza ai meccanismi di flessibilità previsti dal Protocollo di Kyoto.<br />
12 Ex ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente)<br />
14
Tabella 4 - Attività ammissibili per la certificazione dei crediti di carbonio<br />
Fonte: Piano Nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell’effetto serra: 2003-2010 (2002)<br />
Entro dicembre 2006 il nostro Paese dovrà fornire una serie di informazioni generali e la propria<br />
definizione di bosco e indicare quali attività fra quelle non obbligatorie, ricadenti nell’art. 3.4,<br />
intende contabilizzare come crediti e con quale priorità.<br />
1.1.4 Il ruolo delle foreste nell’assorbimento del carbonio<br />
Le foreste svolgono un ruolo fondamentale nel ciclo del carbonio sia per l’attività fotosintetica e<br />
respiratoria sia perché immagazzinano nel suolo e nella biomassa epigea grandi quantità di carbonio<br />
in forme stabili (Tans et al, 1990; Enting e Mansbridge 1991; Sundquist, 1993; Schimel, 1995). Lo<br />
stato delle foreste è d’altra parte sensibile agli estremi climatici, agli inquinanti atmosferici, alle<br />
variazioni delle condizioni del suolo, come pure agli attacchi di diversi agenti patogeni. Le<br />
concentrazioni di CO2 nell’atmosfera, la biodiversità e la funzione di assorbimento del carbonio nel<br />
settore forestale sono pertanto temi centrali nella ricerca attuale sui cambiamenti e le alterazioni in<br />
atto per cause antropiche (Global Change).<br />
Grandi quantità di dati emergono da indagini scientifiche interdisciplinari di numerosi programmi<br />
internazionali come IGBP (International Geosphere-Biosphere Program), WCRP (World Climate<br />
Research Program), IHDP (International Human Dimensions Programme on Global Environmental<br />
15
Change) ed europei CARBOEUROFLUX e CARBOAGE 13 e sono oggetto di approfondimento da<br />
parte della comunità scientifica mondiale.<br />
Alcune fra queste ricerche sono specifiche sulle foreste europee (Kauppi et al., 1992; Martin et al.,<br />
1998; Nabuurs, et al., 1998; Nadelhoffer et al., 1999; Schulze et al., 2000; UN-ECE/CE, 2000).<br />
Molti studi quantitativi svolti a scala di ecosistema hanno utilizzato tecniche distruttive (Lieth et<br />
Whittaker, 1975), altri tecniche di telerilevamento (Fung et al., 1987), altri ancora tecniche<br />
micrometerologiche fra cui quella della correlazione turbolenta o eddy covariance (Manca et al.,<br />
2001; Tirone et al., 2001).<br />
Nell’ambito del programma comunitario ICP Forests 14 di valutazione e sorveglianza degli effetti<br />
dell’inquinamento atmosferico sulle foreste, uno studio sul sequestro netto di carbonio negli<br />
ecosistemi forestali della rete di monitoraggio (UN-ECE/CE, 2000) indica che l’assorbimento netto<br />
di carbonio da parte delle foreste europee potrebbe rappresentare il 40% del deposito totale del<br />
carbonio (C sink) dell’intero continente. La capacità di fissazione del carbonio da parte delle foreste<br />
sembrerebbe dovuta ad un aumento netto dell’accrescimento forestale, mentre il suo sequestro nel<br />
suolo sarebbe limitato. Il forte incremento netto stimato può essere dovuto a più fattori: alla<br />
deposizione di azoto, all’aumento delle concentrazioni di CO2 (effetto fertilizzante del biossido di<br />
carbonio), e al cambiamento delle pratiche di gestione e di silvicoltura (compreso l’assorbimento<br />
risultante dalla struttura per classi di età delle foreste europee).<br />
E’ opportuno comunque evidenziare che i tempi di ricambio del carbonio fissato nel sottosuolo sono<br />
molto più lunghi rispetto a quelli del soprassuolo per cui è probabile che la sua fissazione possa<br />
avere una maggiore durata rispetto al sequestro di carbonio legato all’accrescimento forestale di più<br />
breve permanenza.<br />
Il processo di immagazzinamento del carbonio avviene però anche con la forestazione di nuove<br />
superfici. Laddove la deforestazione, il degrado e l’impoverimento riducono gli stock di carbonio, la<br />
gestione sostenibile delle foreste, attraverso imboschimenti e rimboschimenti può incrementare la<br />
quantità di carbonio fissato. Secondo il Global Forest Resources Assessment update 2005 (FAO,<br />
2005) è stimato che le foreste dell’intero pianeta arrivano ad accumulare 283 Gigatonnellate (Gt) di<br />
carbonio soltanto nella loro biomassa e che il carbonio fissato nella biomassa, nella lettiera e nel<br />
legno degli ecosistemi forestali corrisponde circa al 50% in più dell’ammontare totale del carbonio<br />
presente in atmosfera. In questi studi, il carbonio nella biomassa forestale risulta diminuito nel<br />
periodo 1990-2005 in Africa, Asia e America del Sud, ma aumentato in tutte le altre regioni del<br />
mondo. E’ stato richiesto ai paesi che hanno contribuito alla redazione del rapporto per il FRA2005,<br />
di indicare le aree forestali nelle quali ritengono che la conservazione della diversità biologica sia<br />
l’azione prioritaria. Questa superficie, secondo i dati raccolti, è aumentata significativamente dal<br />
1990 e le foreste indicate non sono necessariamente interne ad aree protette.<br />
E’ qui che le azioni di governo del territorio (in particolare di forestazione, ma anche di<br />
rivegetazione) devono avere luogo secondo modelli di intervento coerenti con le caratteristiche del<br />
territorio in cui si inseriscono. D’altra parte l’attenzione che è necessario riservare alla gestione di<br />
un bosco può consentire il salto di qualità alla politica forestale di un Paese (Hofmann, 1994),<br />
conducendola dalla semplice forestazione, che si esprime soprattutto nei rimboschimenti, alla<br />
selvicoltura vera e propria e alla conservazione della diversità biologica.<br />
13 http://www.carboeurope.org<br />
14 http://www.icp-forests.org/<br />
16
Nelle attività di afforestazione e riforestazione (Tabella 4) è possibile certificare tutto il carbonio<br />
accumulato nella biomassa epigea ed ipogea, nonché nella necromassa della superficie di impianto,<br />
perché realizzato dal 1° gennaio 1990. Gli impianti devono massimizzare la fissazione di anidride<br />
carbonica ed immagazzinare a lungo quella fissata (dal momento del taglio, infatti, il carbonio<br />
contenuto nella biomassa asportata è considerato emesso e genera quindi un debito). Queste due<br />
condizioni di base sono soddisfatte impiegando, in ogni impianto, due serie di specie: una a rapido<br />
accrescimento, con alti tassi di assorbimento e bassa capacità di immagazzinamento, ed una con<br />
lenti tassi di accrescimento iniziale, ma in grado di avere un’elevata capacità di stoccaggio del<br />
carbonio nel tempo e nello spazio (Colonna et Zanatta, 2005).<br />
La voce “nuovi impianti” di Tabella 4 si riferisce alle attività di afforestazione e riforestazione<br />
previste dalla misura III.3 DEL Reg. CEE 1257/99, relativo al Piano di Sviluppo Rurale (Colletti,<br />
2001) succeduto al Reg. CEE 2080/92.<br />
La voce “vecchi impianti”, invece, comprende le piantagioni realizzate per effetto del Reg. CEE<br />
2080/92 15 . L’obiettivo di questo regolamento, nato nel 1992 in un contesto estraneo a Kyoto anche<br />
se all’art. 1 prevede “la lotta all’effetto serra, mediante l’assorbimento di CO2, era essenzialmente la<br />
conversione di seminativi con produzioni in eccedenza in colture arboree, sia per evitare le<br />
sovrapproduzioni agricole (problema questo già affrontato dalla PAC 16 con altri due regolamenti, il<br />
Reg.1094/88 17 e il Reg. 1096/88 18 ) sia per ovviare alle carenze silvicole del nostro Paese. Questa<br />
forma di utilizzo dei terreni può essere inclusa nelle misure human induced.<br />
I dati relativi all’applicazione del Reg. 2080/92 in Europa, anche se non omogenei, sono disponibili<br />
grazie ad un rapporto prepratao per il Parlamento ed il Consiglio Europeo (AA.VV., 1997) e ad una<br />
attività di valutazione dei risultati voluta dalla stessa Comunità Europea (Picard, 2001).<br />
In Italia questo schema di aiuto comunitario è stato gestito dalle amministrazioni regionali e<br />
provinciali: ogni Regione ha presentato un programma di attuazione in due fasi, la prima relativa al<br />
periodo 1994-1996 (e poi estesa al 1997) e la seconda relativa al periodo 1998-1999 (Anderle et al.,<br />
2002; Magnani et al., 2005). Per l’intero territorio nazionale erano previste oltre 141.000 ettari di<br />
piantagioni di cui alla fine del 2000 risultava realizzato circa il 74%, sia per una adesione ridotta<br />
delle Regioni Obiettivo 1 19 sia per una difficoltà oggettiva di reperimento del materiale vivaistico<br />
nonché per le procedure di attuazione che prevedevano il rimborso dopo il collaudo degli impianti<br />
(Colletti, 2001).<br />
Comunque, i gruppi di essenze utilizzate prioritariamente per le azioni di imboschimento sono<br />
costituite al 75% da latifoglie e specie miste, al 22% dalle specie a rapido accrescimento e al 3%<br />
dalle resinose. Il maggior impiego delle prime si spiega con i premi di manutenzione e i rimborsi più<br />
elevati. Probabilmente questo spiega anche che le regioni fuori dell’obiettivo 1 hanno utilizzato per<br />
le attività di afforestazione una percentuale inferiore (67,6%) di latifoglie e specie miste rispetto alle<br />
regioni obiettivo 1 (91,5%). In particolare, tra le latifoglie sono state utilizzate il noce, il ciliego e il<br />
frassino, considerati nell’arboricoltura da legno come specie di pregio, mentre tra le specie a rapido<br />
15<br />
Il Regolamento CEE 2080/92 finanzia l’imboschimento delle superfici agricole.<br />
16<br />
La Politica Agricola Comunitaria, nota come Riforma McSharry dal nome del commissario europeo proponente, venne<br />
varata nel 1990, a seguito della discussione accesa all’indomani del Conferenza di Rio de Janeiro sui temi ambientali e il<br />
loro rapporto con l’agricoltura.<br />
17<br />
Il Regolamento CEE 1094/88 riguarda il set-aside, ovvero la messa a riposo dei seminativi per far fronte alle eccedenze<br />
agricole.<br />
18<br />
Il Regolamento CEE 1096/88 (seguito dal 2079/92, relativo al prepensionamento e all’ingresso dei giovani in agricoltura),<br />
ha istituito un regime comunitario di incoraggiamento alla cessazione dell’attività agricola.<br />
19<br />
Ai sensi del Regolamento CEE 2052/88, sono comprese le regioni economicamente svantaggiate, ossia Abruzzo,<br />
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna.<br />
17
accrescimento pioppo, robinia ed eucalipto (ISMEA, 2001; Anderle et al., 2002; Magnani et al.,<br />
2005).<br />
Sono state condotte alcune analisi a livello regionale (Colletti, 2001; Colonna et Zanatta, 2005), più<br />
approfondite per una maggiore disponibilità di dati per la Toscana ed il Lazio nel centro Italia ed<br />
alcune regioni per l’Italia settentrionale.<br />
Un esempio di progetto di pianificazione territoriale finanziato almeno parzialmente con alcuni dei<br />
regolamenti citati, e che prevede dei piani di forestazione, è costituito dal Piano Triennale 2004-<br />
2006 20 della Regione Emilia Romagna che prevede azioni finalizzate all’incremento<br />
dell’assorbimento di carbonio. L’ente, già dagli inizi degli anni ottanta, ha intrapreso una serie di<br />
iniziative volte ad incentivare il potenziamento e l’accrescimento dei boschi di pianura sia attraverso<br />
finanziamenti regionali (L.R. n. 30/81) sia per mezzo di programmi cofinanziati dall’Unione<br />
Europea (Programma Obiettivo 5b, Reg. CEE 2078/92 21 , Reg. CEE 2080/92).<br />
Gli interventi di forestazione proposti dalla Regione emiliana, oltre a rispondere agli adempimenti<br />
previsti dal Protocollo di Kyoto, si propongono gli obiettivi della riqualificazione territoriale, della<br />
salvaguardia delle specie e degli habitat secondo quanto previsto dalla Direttiva Habitat e<br />
dell’incremento della biodiversità, in particolare nel territorio planiziale ancora dotato di un<br />
patrimonio naturalistico notevole, ma caratterizzato dal punto di vista forestale dalla presenza<br />
ridottissima di boschi relitti e dalla diffusione discontinua, soprattutto lungo le aste fluviali, di<br />
formazioni ripariali solo a tratti strutturate a bosco. Nella fascia collinare e di pianura, le comunità<br />
forestali coprono in effetti appena il 4% del territorio regionale, che si estende per 2.212.500 ettari,<br />
mentre nella fascia montana appenninica raggiungono il 54%.<br />
Le piantumazioni previste dal Piano riguardano le pertinenze fluviali e gli ex-coltivi privi di<br />
vegetazione arborea, i terreni agricoli, gli ex-pioppeti specializzati abbandonati, i terreni<br />
abbandonati da altro uso del suolo, ma comunque idonei all’impianto di specie legnose. Per la<br />
costituzione di crediti di carbonio sono previsti impianti di arboricoltura da legno a rapido<br />
accrescimento, preferibilmente a cicli medi (25-50 anni) in ambito agricolo.<br />
Sono indicate in apposito elenco le specie autoctone arboree e arbustive da utilizzare negli interventi<br />
e per ciascuna sono specificati tipo di terreno, condizioni edafiche, grado di adattabilità e zona<br />
fitoclimatica. Questo elenco ha in realtà solo funzioni di orientamento e non è esaustivo, anche<br />
perché alcune tra le specie citate sono ritenute rare e difficili da reintrodurre (Myricaria germanica,<br />
Salix aurita e Salix myrsinifolia), altre sono specie naturalizzate e “tradizionali” (Pinus pinea,<br />
Morus nigra e Ficus carica), ma anche invadenti (Robinia pseudacacia, Ailanthus altissima, Acer<br />
negundo, Celtis australis) o di incerto avvenire per diffusi problemi sanitari (Platanus sp.).<br />
Nella Regione Emilia Romagna è stato peraltro effettuato un censimento (Minotta, 2003) per<br />
valutare gli aspetti relativi alle finalità produttive, attraverso un monitoraggio degli impianti<br />
effettuati con finanziamenti pubblici, tra cui il Reg. CEE 2080/92 e anche altri a carattere<br />
preminentemente forestale. E’ risultato che il 50% circa degli impianti si estendono tra 1 e 3 ettari,<br />
mentre il 30% è al di sotto di 1 ettaro; gli impianti puri sono pari al 46% del totale di cui l’80%<br />
effettuati con noce comune; negli impianti misti, invece, vi sono più specie pregiate, ma mancano<br />
consociazioni tra specie principali ed accessorie. Le specie accessorie garantiscono una funzione<br />
ecologica di miglioramento del terreno e uno sviluppo adeguato della chioma della specie<br />
principale, mentre quest’ultima costituisce il prodotto principale per l’imprenditore. Infine, la<br />
20 http://www.regione.emilia-romagna.it/foreste/risforestali/foreste2.htm<br />
21 Il Regolamento CEE 2078/92 supporta finanziariamente i metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di<br />
protezione dell’ambiente e con la cura dello spazio rurale.<br />
18
provenienza geografica del materiale vivaistico risulta sconosciuta, anche se sembra che i vivaisti<br />
tendano ad utilizzare semi di provenienza regionale.<br />
Nella pianura emiliana, in particolare nella provincia di Modena, è stato monitorato per 5 anni il<br />
bilancio del carbonio di un rimboschimento realizzato con questa tipologia di fondi. Le misure<br />
sperimentali hanno riguardato sia la componente aerea, che le diverse componenti ipogee e sono<br />
state integrate da misure ricavate a livello di intero popolamento. Un modello matematico a base<br />
funzionale ha consentito l’estrapolazione dei dati al fine di stimare più efficacemente quale possa<br />
essere il contributo dell’arboricoltura da legno nel suo complesso al raggiungimento degli obiettivi<br />
del Protocollo di Kyoto (Magnani et al., 2005).<br />
Lo studio sembra dimostrare che la capacità degli ecosistemi forestali di assorbimento del carbonio<br />
all’atmosfera non dipende semplicemente dagli incrementi legnosi, ma anche dal suo accumulo nel<br />
suolo e nelle radici, dato confortato da studi analoghi condotti nel Nord europeo (Poulton et al.,<br />
2003). Sembra inoltre che gran parte dell’accumulo ipogeo sia attribuibile all’incremento di radici<br />
fini e grossolane, mentre l’accumulo di sostanza organica nel suolo ammonterebbe a non più di 2.02<br />
tonnellate di CO2 ha -1 anno -1 e questo valore non si discosta da quelli generalmente rilevati in terreni<br />
agricoli in via di ricolonizzazione da parte della vegetazione naturale (Post et Kwon, 2000).<br />
19
1.2 La biodiversità<br />
Vi sono diverse possibili definizioni di biodiversità. A partire da quella formulata dall’Office of<br />
Technology Assessment del governo degli U.S.A (OTA, 1987) per cui il termine biodiversità sta ad<br />
indicare “la varietà e la variabilità degli organismi viventi e dei sistemi ecologici in cui essi vivono.<br />
La diversità può essere definita come il numero degli elementi diversi e la loro frequenza relativa.<br />
Nella diversità biologica tali elementi sono organizzati in più livelli, dall’ecosistema in toto alle<br />
strutture chimiche che costituiscono le basi molecolari dell’ereditarietà”. Più recentemente<br />
l’International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, tra le organizzazione<br />
internazionali più attive nella conservazione della diversità delle specie (IUCN, 2004, 2003, 2001,<br />
1994), ha sintetizzato il concetto in “variabilità di ogni tipo esistente tra gli organismi viventi”.<br />
Sono dunque la varietà e variabilità offerte dal sistema vivente e dal complesso degli ecosistemi, in<br />
cui vivono tutti gli organismi, a costituire la materia prima della biodiversità nel nostro pianeta. Non<br />
è però possibile affidarsi a delle semplici valutazioni quantitative. Domandarsi quante specie vivono<br />
in un determinato habitat non è sufficiente. Bisogna valutare anche la componente qualitativa, che si<br />
esprimerà, dopo la misurazione delle frequenze relative con cui le specie di quel particolare habitat<br />
si manifestano, nella analisi delle ragioni per cui quella situazione si verifica.<br />
Secondo Whittaker (1965, 1972), sono possibili tre diversi livelli di studio della biodiversità:<br />
1. α-diversità, nell’ambito di un singolo popolamento;<br />
2. β-diversità nell’ambito dei popolamenti di due o più siti o stazioni secondo un gradiente;<br />
3. γ-diversità nell’ambito di numerosi popolamenti che formano un sistema.<br />
Questa suddivisione è stata riveduta, anche dallo stesso autore nel 1976, e ampliata, ma comprende<br />
sempre 3 livelli:<br />
a) un primo livello che analizza la diversità attraverso il rapporto tra il numero dei viventi e la<br />
superficie da essi occupata,<br />
b) un secondo livello che analizza la diversità nella comunità,<br />
c) un terzo livello che analizza la diversità nei paesaggi complessi.<br />
a) Nel primo la misura della diversità è data semplicemente dal rapporto tra il numero degli elementi<br />
considerati e la superficie che essi occupano, sintetizzabili nei concetti di densità specifica e di<br />
diversità ambientale. Le diverse specie che vivono in una determinata area vivono infatti adattate a<br />
nicchie ecologiche diverse che esprimono la eterogeneità dell’ambiente che consente la loro<br />
coesistenza. La superficie ha dunque un ruolo di variabile indipendente.<br />
Va precisato che la relazione tra numero di elementi di un certo tipo e la superficie non è sempre<br />
lineare, ossia non è detto che aumentando l’estensione areale aumenti anche il numero di specie ivi<br />
presenti. Viene infatti raggiunto un livello di saturazione oltre il quale la ricchezza specifica non<br />
aumenta e per questa ragione la rappresentazione grafica più corretta è una curva di tipo logistico.<br />
b) La valutazione della diversità al livello successivo, ossia all’interno di un insieme eterospecifico<br />
di organismi che vivono in una medesima area geografica (comunità) stabilendo un complesso di<br />
relazioni fra loro e l’ambiente nel quale vivono, è facilitata dall’uso degli indici di Simpson e di<br />
Shannon (1949) che considerano insieme i due fattori fondamentali nello studio della biodiversità,<br />
ovvero il numero complessivo di specie e la loro abbondanza relativa. A questo livello di indagine<br />
non è più sufficiente conoscere semplicemente il numero dei componenti per unità di superficie e la<br />
20
icchezza di specie di una comunità e la frequenza con cui queste si presentano divengono<br />
indipendenti dall’area occupata. Ciò consente d’altra parte di confrontare comunità che occupano<br />
superfici diverse e per cui risulta assai utile la suddivisione dei viventi in classi di frequenza, come<br />
richiesto dal calcolo di questi indici. Un sistema è ricco di biodiversità quando vi sono molte classi<br />
di elementi e tutte hanno una quantità di elementi simile. Invece la biodiversità è bassa quando le<br />
classi sono poche e fra queste una o alcune presentano un maggior numero di elementi.<br />
c) L’ultimo livello, appunto perché si riferisce a sistemi complessi, è anche il meno indagato.<br />
Corrisponde di fatto alla γ-diversità di Whittaker. Un esempio è fornito da un confronto effettuato<br />
tra diversi tipi di sistemi paesistici italiani e di altri paesi mediterranei, per i quali sono stati messi in<br />
relazione la diversità degli ecosistemi (espressa come rapporto tra numero medio di specie e numero<br />
di associazioni) con la loro produttività primaria annua (t/ha). Si è osservato che a sistemi ecologici<br />
con un valore elevato di diversità (cioè con un numero medio di specie elevato rispetto al numero di<br />
associazioni) corrisponde una bassa produttività. E’ il caso degli ecosistemi oligotrofici di alta<br />
montagna, ad esempio nelle Dolomiti centrali. Gli ecosistemi agricoli della Pianura Padana risultano<br />
invece eutrofici, ossia con produttività elevata e bassa diversità. Ancora più disturbati e artificiali<br />
dei precedenti sono gli ecosistemi distrofici mediterranei con entrambi i fattori a valore molto<br />
contenuto.<br />
La biodiversità si esprime dunque in molteplici forme, tanto in senso biogeografico e climatico,<br />
quanto genetico e paesaggistico (Blasi et al., 2005).<br />
L’elevata diversità faunistica e floristica dell’Italia, ad esempio, è dovuta alla molteplicità di<br />
ambienti che il territorio offre in virtù delle tipologie litologiche, topografiche e climatiche presenti<br />
in un ambito poco esteso, ma anche alla storia paleogeografica e paleoclimatica assai complessa. La<br />
presenza di barriere e collegamenti geografici, infatti, condiziona la dispersione delle specie e<br />
quindi influisce sulla delimitazione dei loro areali. In Italia la ricchezza di specie è particolarmente<br />
significativa: 6.711 piante vascolari (Abbate et al., 2001; Pignatti, 1982), 1.130 briofite (Cortini<br />
Pedrotti, 2001, 1992; Aleffi et Schumacker, 1995), 55.600 specie animali (Minelli, 1996) e di<br />
queste l’86% appartengono agli ambienti continentali (secondo Stoch, 2000).<br />
La distribuzione della vegetazione è correlata principalmente ai caratteri climatici e in particolare<br />
temperatura e precipitazioni sono fattori strettamenti collegati alla numerosità delle specie. Si<br />
osserva, ad esempio in Europa, un aumento del numero di specie vegetali nelle aree geografiche in<br />
cui vi è una maggiore disponibilità idrica (che varia secondo un gradiente latitudinale in alcuni casi,<br />
altitudinale in altri) e valori di temperatura più elevati: è il caso della fascia tropicale in cui si ha il<br />
massimo di diversità floristica e della fascia mediterranea, attorno ai 40-45° N, in cui si osserva un<br />
secondo massimo. Nel corso di questo secolo, proprio per approfondire questa tematica, ha avuto<br />
grande sviluppo la scienza della fitoclimatologia che studia le relazioni tra l’andamento delle<br />
temperature e dei regimi di piovosità e la distribuzione delle comunità vegetali (Blasi, 2004).<br />
La diversità biologica presenta anche, strettamente connessa con quella ambientale, una componente<br />
genetica. Ogni organismo sviluppa sia strutture e funzioni proprie della specie cui appartiene, sia<br />
caratteristiche individuali. Questa variabilità è presente a tutti i livelli di organizzazione della stessa<br />
informazione ereditaria, dai codoni ai geni e ai cromosomi ed è determinata dalle mutazioni, ovvero<br />
da variazioni geniche, cromosomiche o genomiche del patrimonio ereditario degli individui poi<br />
trasmesse alla discendenza.<br />
Infine, il paesaggio, inteso come risultato della interazione complessa e sistemica di fattori naturali,<br />
storico-culturali e sociali, riflette il succedersi delle vicende umane che sono comunque collocate<br />
entro i confini dei processi fisici e biologici che si svolgono con modalità e tempi propri. Esso<br />
21
costituisce il livello di organizzazione gerarchicamente più elevato e il riferimento più immediato e<br />
spontaneo per la conservazione della diversità biologica.<br />
L’uomo da sempre esercita una profonda influenza sull’ambiente e tra le cause riconosciute di<br />
perdita di biodiversità vi sono i cambiamenti di uso del suolo e i cambiamenti climatici, le<br />
variazioni delle concentrazioni di CO2 e delle deposizioni azotate nel suolo per effetto delle<br />
fertilizzazioni in agricoltura e la massiccia diffusione di specie esotiche di flora e fauna (Blasi et al.,<br />
2005), tutti processi nei quali il fattore antropico è determinante.<br />
La causa principale del cambiamento di uso del suolo è costituito dall’aumento e dall’espansione<br />
della popolazione umana il cui effetto più evidente e cospicuo è rappresentato dalla frammentazione<br />
a scala di habitat e di paesaggio, processo iniziato secondo Malcom et Hunter (1996) con gli<br />
interventi legati allo sviluppo agricolo. Parte degli effetti dell’azione antropica sulla biodiversità si<br />
esprime, come detto, nelle modificazioni degli habitat e conseguentemente degli ecosistemi ad essi<br />
legati. L’uomo sottrae estese aree alle foreste, le disbosca con il taglio per la produzione di legname<br />
oppure le incendia, comunque ne destina gran parte alla coltivazione intensiva; inquina con le<br />
emissioni di gas e liquidi tossici l’atmosfera e il patrimonio idrico dei continenti, dei mari e degli<br />
oceani. E attua questi processi con una intensità e una velocità che le capacità di resistenza e di<br />
resilienza degli ecosistemi non riescono a contrastare. Un terreno destinato alle coltivazione agricola<br />
intensiva, cui non venga concesso riposo, ad esempio con la rotazione delle colture, dopo alcuni<br />
anni di elevata produttività diviene gradualmente più sterile fino a guadagnare una nuova area alla<br />
desertificazione. Nel periodo compreso tra il 1850 e il 1998, le emissioni nette cumulative e globali<br />
di anidride carbonica derivanti da cambiamenti di uso del usolo sono state stimate in circa 136+<br />
55Gt di carbonio. Secondo Houghton (1999) e Houghton et al. (2000; 1999), l’87% di queste<br />
emissioni è dovuto a trasformazioni che hanno interessato territori boscati e il 13% ha riguardato<br />
aree coltivate e praterie delle medie latitudini (Moutinho et Schwartzman, 2005).<br />
I rapporti IPCC chiariscono efficacemente questa problematica (Prentice et al., 2001; Watson et al,<br />
2001) e si rimanda ad essi per un ulteriore approfondimento.<br />
E’ oggetto anche di un vivo dibattito scientifico l’effetto della fertilizzazione dei suoli a mezzo<br />
azoto. Essa risulta infatti particolarmente efficiente nell’aumentare la produzione agricola e la<br />
produttività delle piantagioni di foreste nelle regioni climatiche mediterranee, temperate e boreali<br />
(Linder et al., 1996). In alcuni ambiti territoriali, però, le deposizioni di N risultano eccedere le<br />
capacità di assimilazione di alcuni ecosistemi forestali, in cui si verifica un fenomeno noto come<br />
“saturazione da azoto” dovuto allo sbilanciamento dei nutrienti (Aber et al., 1989, 1998). Inoltre da<br />
alcuni studi è emerso che vi è una relazione tra i cambiamenti nella ricchezza di specie e il gradiente<br />
di disponibilità dei nutrienti rappresentabile con una curva a campana: la ricchezza di specie è bassa<br />
a bassi livelli di specie, aumenta fino a un picco per i livelli intermedi e declina più gradualmente ad<br />
alti livelli di nutrienti (Pausas et Austin, 2001).<br />
Infine l’azione antropica si è esercitata sin dai tempi della scoperta delle Americhe, e si esercita<br />
ancor oggi, attraverso la diffusione di specie esotiche nei diversi continenti. Il serbatoio di<br />
biodiversità che ciascun continente costituiva è stato privato dell’isolamento geografico che l’ha<br />
generato in tempi lunghissimi. L’introduzione di specie estranee ha prodotto, laddove le condizioni<br />
ambientali ne hanno consentito la naturalizzazione, una diminuzione del numero e della frequenza<br />
delle specie autoctone e numerosi fenomeni di ibridazione. E’ stato calcolato per l’Italia che, tra il<br />
Medioevo e gli inizi del 1900, il numero di specie di piante vascolari introdotte accidentalmente è<br />
superiore a 600 mentre quelle introdotte volontariamente, soprattutto specie arboree, poco più di 50.<br />
Tra queste, in Italia ad esempio, sono ormai divenute dominanti Ailanthus altissima e Robinia<br />
pseudoacacia, provenienti rispettivamente dalla Cina e dal Nord-America e introdotte l’una per la<br />
22
produzione, fallita, di uno sfingide alternativo al baco da seta, l’altra per il consolidamento delle<br />
scarpate e poi diffusasi ovunque.<br />
1.2.1 La Convenzione sulla biodiversità<br />
La Convention on Biological Diversity (CBD) si propone la conservazione della diversità biologica,<br />
l’uso sostenibile e durevole delle sue componenti e una giusta ed equa condivisione dei benefici<br />
derivanti dall’uso delle risorse genetiche. Le azioni di conservazione della biodiversità sono infatti<br />
fondamentali a tutti i livelli di organizzazione biologica (geni, specie, comunità, ecosistemi,<br />
paesaggio e clima) e devono essere attuate mediante finanziamenti, un accesso adeguato alle risorse<br />
genetiche e il trasferimento opportuno delle tecnologie necessarie, tenendo peraltro in debito conto i<br />
diritti di tutti su tali risorse e tecnologie (Blasi, 2004).<br />
In questo senso la CBD è una Convenzione di straordinaria importanza in quanto prevede di<br />
conservare la biodiversità e individua al contempo nello sviluppo sostenibile e nella equa<br />
ripartizione delle risorse gli strumenti di base per centrare il proprio obiettivo primario (Blasi et al.,<br />
2005). Ogni Paese ratificante è tenuto, secondo l’art. 6, ad identificare gli elementi fondamentali ai<br />
fini conservativi della diversità biologica del proprio territorio, a monitorarne lo stato, a fronteggiare<br />
le minacce attraverso l’elaborazione di strategie, piani e programmi nazionali e la loro integrazione<br />
nelle politiche settoriali o plurisettoriali pertinenti.<br />
Il quadro di riferimento di qualunque azione venga intrapresa nell’ambito della CBD deve essere<br />
caratterizzato da un approccio ecosistemico (ecosystem approach) che si basa sull’applicazione di<br />
metodologie scientifiche focalizzate sui diversi livelli di organizzazione biologica e comprendente i<br />
processi, le funzioni e le interazioni tra gli organismi e il loro ambiente. Questa modalità considera<br />
la specie umana, con la sua diversità culturale, come parte integrante di molti ecosistemi e pone in<br />
evidenza la necessità di adattare le scelte gestionali alla loro natura complessa e in costante<br />
trasformazione. Spesso essi funzionano con meccanismi non lineari e per questo la gestione deve<br />
essere aperta ad una metodologia learning-by-doing, che richiede un approccio di studio e di analisi<br />
contemporaneamente teorico e applicativo.<br />
Alla salvaguardia della biodiversità contribuiscono in modo fattivo anche le direttive europee n.<br />
79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e n. 92/43/CEE finalizzata alla<br />
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.<br />
Quest’ultima è di fondamentale importanza in quanto ha posto l’accento sulla necessità di collegare<br />
la conservazione dell’habitat alla conservazione della specie.<br />
Il Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice (SBSTA), organo tecnicoscientifico<br />
e tecnologico dell’UNFCCC, ha ribadito recentemente l’esigenza di integrazione tra la<br />
CBD, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Desertificazione (UNCCD) e la stessa<br />
UNFCCC nell’Inf. 19 del 2 novembre 2004, Options for enhanced cooperation among the three Rio<br />
Conventions.<br />
Nella prima parte della Decisione 11/CP.7 22 , adottata alla COP7 del Protocollo di Kyoto che ha<br />
visto complessi negoziati fra i paesi che intendevano limitare al massimo l’uso dei sink e quelli che<br />
intendevano utilizzarli per raggiungere gran parte degli obiettivi di riduzione, è confermato il fine di<br />
difendere l’integrità e la complessità dell’accordo proprio per evitare che il ricorso massiccio ai<br />
22 FCCC/CP/2001/13/Add.1 (http://unfccc.int)<br />
23
sink si contrapponga agli obiettivi di conservazione della biodiversità e di gestione sostenibile delle<br />
foreste (Pettenella et al., 2003).<br />
Nella COP6 della stessa CBD (L’Aja, 2002) è stata anche adottata la Decisione VI/22 23 finalizzata<br />
in particolare alla conservazione della diversità biologica forestale in quanto considerata elemento<br />
insostituibile per la complessiva conservazione della biodiversità soprattutto in relazione al rapporto<br />
foreste-clima.<br />
L'Italia ha ratificato la Convenzione sulla Biodiversità con la Legge 124 del 14 febbraio 1994 e ha<br />
predisposto poco dopo le “Linee strategiche per l’attuazione della Convenzione di Rio de Janeiro e<br />
per la redazione del piano nazionale sulla biodiversità”, approvato con delibera CIPE il 16 marzo<br />
1994. Più recentemente, il 27 aprile 2004 è stato istituito il Comitato di Coordinamento Nazionale<br />
per la Biodiversità al fine di coordinare e definire la posizione italiana sulle tematiche inerenti alla<br />
sua gestione e conservazione.<br />
23 “Forest biological diversity” - UNEP/CBD/COP/6/20 (www.biodiv.org)<br />
24
1.3 Obiettivi della ricerca<br />
Il Protocollo di Kyoto, in vigore dal 16 febbraio 2005, richiede ai Paesi ratificanti di contribuire<br />
efficacemente al processo di riduzione della concentrazione di anidride carbonica in atmosfera<br />
attraverso azioni tangibili volte a diminuirne l’emissione o ad aumentarne l’assorbimento.<br />
In questa ricerca sono state affrontate le problematiche ad esse collegate, cercando di dare risposta a<br />
diversi quesiti, di seguito elencati nell’ambito di due questioni-chiave.<br />
1. Il Protocollo consente di fare uso degli assorbimenti di CO2 derivanti dai territori forestali ed<br />
agricoli (i cosiddetti carbon sink) esistenti nel nostro Paese (oltre che di meccanismi di<br />
cooperazione internazionale quali il Joint implementation e il Clean Development Mechanism) e<br />
la COP7 di Marrakesh 24 del 2001 ha stabilito le definizioni delle attività del settore forestale e, in<br />
generale, dei cambiamenti di uso del suolo ritenute ammissibili alla contabilizzazione dei crediti<br />
di carbonio, secondo i paragrafi 3 e 4 dell’articolo 3 del Protocollo.<br />
In questo contesto, quali sono le classi di copertura e/o uso del suolo presenti sul territorio<br />
italiano, come lo caratterizzano e che superficie occupano?<br />
Quali, fra queste, sono più soggette a variazioni della destinazione d’uso nel corso del tempo?<br />
Come possono essere messe in relazione queste classi con quelle derivanti dalle definizioni<br />
ammesse alla contabilizzazione dei crediti di carbonio?<br />
E’ dunque possibile una stima della quantità di carbonio fissato in queste classi e della sua<br />
variazione in relazione ad eventuali cambiamenti di copertura e/o uso del suolo osservati?<br />
2. Le azioni volte ad aumentare l’estensione della copertura vegetale, se iniziate dopo il 1990,<br />
possono essere tenute in debito conto ai fini del bilancio tra quanto rilasciato in atmosfera e<br />
quanto assorbito.<br />
Rispetto a tale ambito, è possibile, e come, ricorrere all’uso dei carbon sink in modo compatibile<br />
con l’eterogeneità biogeografica, bioclimatica e vegetazionale del nostro Paese? E’ possibile<br />
cioè individuare categorie vegetazionali complesse in relazione a bioclima, struttura e<br />
composizione floristica del territorio anche in funzione della loro capacità di assorbimento di C?<br />
Quando gli interventi gestionali possono contrapporsi agli obiettivi di conservazione della<br />
biodiversità e di gestione sostenibile delle foreste? E’ possibile quindi predisporre modelli<br />
gestionali diversificati in funzione della variabilità fitocenotica e floristica?<br />
Quali specie vegetali possono essere considerate funzionali all’assorbimento di CO2 e quindi<br />
essere utilizzate allo scopo senza però compromettere piani e programmi connessi con<br />
l’applicazione della CBD e della Direttiva Habitat?<br />
L’interrogativo di fondo, cui avremo dato risposta se i quesiti posti saranno stati risolti, è: il nostro<br />
Paese è in grado di adempiere a quanto richiesto dal Protocollo di Kyoto in armonia con gli impegni<br />
assunti con le altre convenzioni internazionali?<br />
24 http://unfccc.int/cop7/index-13.html<br />
25
Per rispondere ai quesiti precedentemente esposti sono state condotte essenzialmente due tipologie<br />
di attività:<br />
1. Una analisi della eterogeneità condotta a scala locale, sia attraverso la classificazione dell’uso<br />
del territorio di un’area campione alle date del 1990 e del 2000, avente lo scopo di identificare,<br />
quantificare e localizzare geograficamente le classi di copertura del suolo associate alle<br />
definizioni del LULUCF Sector contabilizzabili come crediti di carbonio, sia attraverso una<br />
caratterizzazione della stessa area in senso bioclimatico e vegetazionale.<br />
2. Una analisi su scala nazionale della eterogeneità territoriale, in termini di diversità bioclimatica<br />
e vegetazionale, di un sistema di 56 unità campione selezionate secondo metodologia statistica,<br />
al fine di valutare concretamente la ricaduta in termini di biodiversità di eventuali cambiamenti<br />
di uso del suolo (afforestazione, riforestazione, abbandoni colturali volontari, ecc.) previsti per<br />
adempiere agli obblighi del Protocollo di Kyoto.<br />
26
2. DATI E METODI<br />
I molteplici dati territoriali utilizzati sono di natura composita. In parte sono costituiti dai risultati<br />
emersi dalla fotointerpretazione e dalla classificazione a scala locale dell’uso del suolo di immagini<br />
digitali ortorettificate (analisi dell’eterogeneità reale); in parte derivano da operazioni di<br />
intersezione cartografica di piani tematici vettoriali già esistenti e provenienti da fonti diverse, volte<br />
ad analizzare a scala nazionale la complessa relazione esistente tra l’uso del suolo e la diversità<br />
biologica potenziale della penisola italiana (diversità bioclimatica e vegetazionale).<br />
2.1 Analisi della eterogeneità territoriale a scala locale<br />
2.1.1 Uso e copertura del suolo<br />
La classificazione dell’uso del suolo costituisce lo stadio conclusivo di un complesso di attività che<br />
vanno dalla individuazione e dal reperimento dei dati territoriali sino all’adeguato trattamento cui<br />
devono essere sottoposti perché siano effettivamente ed efficacemente utilizzabili e alle opportune<br />
elaborazioni.<br />
2.1.1.1 - I dati territoriali di base e la scelta del sistema di riferimento<br />
I dati di base utilizzati sono costituiti da immagini digitali risalenti al 1990 e al 2000. Le due date<br />
sono necessarie per condurre una analisi multitemporale e produrre un inventario cartografico delle<br />
categorie di uso del suolo eventualmente contabilizzabili come crediti di carbonio. In ottemperanza<br />
agli adempimenti previsti dal Protocollo di Kyoto, infatti, ogni nazione è tenuta a fornire dati<br />
inventariali relativi al proprio territorio sia per il 1990, scelto dalle Parti quale anno di riferimento<br />
(baseline), che per il 2000.<br />
Figura 1 - Area di studio scelta per l'analisi di dettaglio<br />
27
L’area indagata è situata in una zona di confine tra le regioni Molise e Abruzzo. La sua superficie,<br />
pari a circa 116.000 ettari, interessa per la maggior parte le province di Campobasso e Isernia e in<br />
misura minore L’Aquila e Chieti.<br />
La scelta del sito è legata ad una conoscenza approfondita di questo ambito geografico dal punto di<br />
vista floristico e vegetazionale, aspetto fondamentale per il completamento del quadro conoscitivo<br />
territoriale e per la formulazione delle relative valutazioni in termini di conservazione della diversità<br />
delle specie.<br />
Le foto digitali del 1990 provengono dal Volo Italia 1988-1989 che copre il territorio italiano per<br />
tutta la sua estensione con oltre 5.500 fotogrammi. Nel periodo fra marzo 1988 e settembre 1989 per<br />
conto della Compagnia Generale delle Riprese Aeree di Parma, proprietaria del volo, sono stati<br />
eseguiti oltre 31.000 km di riprese, in direzione Est/Ovest e ad una quota relativa di volo costante di<br />
circa 11.500 metri dal suolo, realizzando fotogrammi alla scala media 1:75.000 nel rispetto dei<br />
parametri di sovrapposizione del 60% longitudinalmente e del 20% lateralmente (IGM et AGEA,<br />
2005).<br />
Figura 2 - Volo Italia 1988-1989<br />
E’ stata impiegata una camera<br />
fotogrammetrica Leica – Wild RC-<br />
20 con un obiettivo grandangolo<br />
con lunghezza focale di 150<br />
millimetri. Per ogni porzione<br />
dell’immagine il potere di<br />
risoluzione 25 è superiore alle 80<br />
coppie di linee per millimetro<br />
mentre la risoluzione nominale della<br />
pellicola ad alta risoluzione<br />
Panatomic X Aerographic II 2412<br />
HR della Kodak utilizzata per lo<br />
sviluppo è superiore alle 125 coppie<br />
di linee per millimetro. Ciò<br />
consente di sfruttare a pieno le<br />
caratteristiche dell’obiettivo e, in<br />
ultima analisi, di poter ottenere per<br />
fotogrammi in scala 1:75.000 una<br />
risoluzione sul terreno inferiore al<br />
metro, pari a quella delle ortofoto<br />
digitali del 2000.<br />
Le strisciate coprenti il territorio di<br />
interesse (53B, 55B del luglio 1989<br />
e 54BC dell’ottobre dello stesso<br />
anno) sono state identificate<br />
consultando la Tavola 7 del piano di<br />
25 Risoluzione = si intende, in questo caso, la dimensione dell’oggetto più piccolo che può essere distinto dal sensore.<br />
28
volo in formato cartaceo. I fotogrammi utili (Tabella 5) sono stati poi individuati a video dal sito<br />
web www.terraitaly.com della C.G.R., la quale ha reso disponibili, per i fini di questa ricerca, le<br />
relative immagini in formato digitale. Queste, però, ancorché in formato numerico, non erano<br />
utilizzabili all’atto della fornitura in quanto non corrette geometricamente e prive di riferimento in<br />
un sistema geografico.<br />
Tabella 5 - Fotogrammi comprendenti l'area di studio<br />
Volo Italia C.G.R. – scala 1:75.000 – 1988-1989<br />
Strisciata Fotogramma Data<br />
53B 5079, 5076, 5073, 5070 24.07.89<br />
54BC 3055, 3053, 3050 25.10.89<br />
55B 5109, 5111, 5113 24.07.89<br />
Figura 3 - Tavola 7 del Volo Italia 1988-1989<br />
29
Figura 4 - Fotogrammi (indicati in Tabella 5) comprendenti l'area di studio. Le frecce<br />
indicano la direzione di volo e la sequenza di scatto delle immagini.<br />
Per l’anno 2000 erano invece disponibili presso il laboratorio immagini digitali della stessa area<br />
ortorettificate e georeferenziate in Gauss-Boaga fuso est, su datum Roma40.<br />
Il dataset del 2000 aveva dunque un sistema di coordinate riferito al mondo reale, mentre quello del<br />
1990 era costituito semplicemente da un insieme di immagini raster 26 . Poiché le relazioni spaziali<br />
tra gli oggetti territoriali sono definibili, e quindi misurabili, attraverso un sistema di coordinate e<br />
dal momento che ciascun dataset territoriale ha una sua collocazione geografica, si è ritenuto<br />
opportuno scegliere il sistema Gauss-Boaga fuso est, su datum Roma40, quale riferimento<br />
geografico sia per le immagini digitali del 1990 sia per tutti gli altri dati prodotti.<br />
26 Raster = struttura dei dati in forma di matrice numerica in cui ogni cella contiene un valore corrispondente ad un attributo.<br />
La posizione spaziale di un elemento è quindi implicitamente rappresentata dalla posizione della cella.<br />
30
Figura 5 - Quadro di unione delle sezioni di ortofoto dell'anno 2000. Il codice alfanumerico<br />
(ad esempio 380110e) identifica univocamente la sezione con 6 cifre (corrispondenti alla<br />
codifica utilizzata per le Carte Tecniche Regionali) e indica il fuso di appartenenza con<br />
l’ultima lettera ( in questo caso fuso Est).<br />
Infine tutti i dati disponibili relativi al territorio in analisi sono stati organizzati sistematicamente in<br />
un sistema informativo geografico (GIS) così da renderli agevolmente accessibili e consultabili.<br />
31
2.1.1.2 - Ortorettificazione e georefenziazione delle immagini digitali del 1990<br />
Le foto aeree digitali del 1990, non corrette geometricamente né georeferenziate all’atto della<br />
fornitura, sono state opportunamente trattate al fine di ottenere:<br />
- la precisione geometrica utile al confronto multitemporale, quindi necessariamente equivalente a<br />
quella delle ortofoto digitali del 2000, e confrontabile con le tolleranze planimetriche della<br />
cartografia tradizionale alla stessa scala;<br />
- la visione in continuum e ad una scala costante del territorio anche per questa data;<br />
- infine, l’integrabilità con altri dati territoriali all’interno di un GIS.<br />
Il fotogramma aereo (Figura 6) consiste nella<br />
proiezione centrale di una porzione del territorio;<br />
perché esso acquisisca una valenza comparabile a<br />
quella cartografica e come questa consenta delle<br />
misurazioni, deve essere trasformato in una<br />
proiezione ortografica (Gomarasca, 2004).<br />
Figura 6 - Esempio di fotogramma aereo<br />
L’ortoproiezione di una immagine digitale si<br />
ottiene correggendo la posizione di ogni singola<br />
unità elementare da cui è composta, il pixel.<br />
Questa operazione richiede l’utilizzo di un<br />
Modello Digitale del Terreno (DTM)<br />
opportunamente georiferito: ciascuna cella viene<br />
infatti spostata per effetto delle deformazioni<br />
prospettiche dovute alle variazioni altimetriche del territorio descritte dal DTM (Figura 8).<br />
Il software utilizzato richiede di selezionare il file<br />
contenente le informazioni relative alla camera<br />
fotogrammetrica di ripresa, in questo caso una<br />
Leica – Wild RC-20 con un obiettivo<br />
grandangolo con lunghezza focale di 150<br />
millimetri, e di indicare la posizione delle marche<br />
fiduciali (Figura 7) presenti sull’immagine di<br />
partenza ai quattro angoli (cerchio di Figura 6 in<br />
alto a destra), per utilizzarle quali punti di<br />
aggancio.<br />
Figura 7 - Marca fiduciale<br />
32
L’estrazione dei punti di<br />
controllo dell’altezza del suolo<br />
(Ground Control Height) dal<br />
DTM (Figura 8) e il loro utilizzo<br />
per la rettifica polinomiale quali<br />
punti di controllo al suolo<br />
(Ground Control Points o gcp)<br />
completano il processo di<br />
ortorettificazione.<br />
Figura 8 – Modello Digitale del<br />
Terreno (DTM) dell’area<br />
campione dell’Alto Molise.<br />
Le porzioni più chiare<br />
corrispondono, in questa<br />
modalità di visualizzazione<br />
dell’immagine, alle quote più<br />
elevate.<br />
I dati del 1990 sono stati anche<br />
georiferiti, come detto, nel sistema cartografico Roma40 Gauss-Boaga, fuso est. Il processo di<br />
georeferenziazione associa ad un punto su un’immagine un suo punto omologo (ground control<br />
point) sul riferimento cartografico prescelto, costituito in questo caso dalle ortofoto digitali del<br />
2000, così da permettere la loro perfetta sovrapposizione. I punti di controllo sono luoghi che<br />
possono essere facilmente localizzati sia sulla immagine che sulla mappa; sono più frequentemente<br />
utilizzati particolari topografici di individuazione certa quali gli angoli degli edifici, le intersezioni<br />
tra strade, i ponti o, in assenza di questi, anche gli elementi naturali invariati nell’arco di tempo<br />
considerato.<br />
Per ogni gcp preso sul dataset da georeferenziare, deve dunque essere selezionato graficamente (o<br />
anche digitando la relativa coppia di coordinate) il corrispondente punto sul dataset di riferimento.<br />
I punti di controllo sono utilizzati per stabilire una relazione tra i due set di dati ed una<br />
trasformazione polinomiale deforma nel modo opportuno l’immagine priva del riferimento<br />
geografico, raddrizzandola e georeferenziandola.<br />
La scelta dei ground control point e del loro<br />
numero, oltre che della trasformazione, influisce<br />
sull’entità dell’errore di georeferenziazione<br />
dell’immagine perché ad ogni manipolazione essa<br />
viene deformata (stretching, resampling, ecc.) per<br />
adattarla al riferimento indicato (confronta Figura<br />
9 con Figura 10).<br />
Figura 9 – Ortofoto del 2000 con poligono di<br />
uso del suolo (bosco) digitalizzato<br />
33
Figura 10 – Errore di georeferenziazione<br />
dell’immagine del 1990 in cui lo stesso<br />
poligono di uso del suolo di Figura 9 non<br />
coincide con la porzione di territorio<br />
identificata come bosco.<br />
Allo scopo di ottenere la necessaria accuratezza,<br />
intesa come grado di perfezione ottenuto per la<br />
misurazione, cui è legata la qualità dei risultati<br />
(Gomarasca, 2004), il procedimento di<br />
georeferenziazione è stato rigoroso. Nella<br />
fattispecie, per la morfologia disomogenea del territorio in cui le quote variano da 0 a 2778 metri,<br />
sono sempre stati scelti in media 8 punti, sempre in luoghi facilmente riconoscibili e rimasti<br />
immutati nel tempo. La polinomiale usata è una trasformazione affine di 1° ordine.<br />
Le immagini del 1990 sono state infine ritagliate e mosaicate dove necessario per assicurare una<br />
visione continua e coerente con il quadro di unione delle sezioni di ortofoto digitali dell’anno 2000.<br />
2.1.1.3 - Analisi multitemporale 1990-2000 e classificazione secondo Corine Land Cover (tabella<br />
corrispondenza classi CLC ed attività contabilizzabili quali crediti di carbonio)<br />
Negli studi a carattere territoriale è fondamentale comprendere la natura dei cambiamenti della<br />
struttura e della composizione del paesaggio nel tempo e localizzarli geograficamente. Il territorio è<br />
costituito da un mosaico di differenti tipi di copertura del suolo la cui disposizione nello spazio<br />
geografico risponde a motivi di natura ecologica e antropica e può dunque essere studiato nella<br />
struttura, costituita dalla distribuzione spaziale degli ecosistemi e delle forme; nelle funzioni, che<br />
hanno a che fare con tutto ciò che si sposta all’interno del mosaico ambientale, sia in termini biotici<br />
che abiotici; nella dinamica, che riguarda le trasformazioni nel tempo (Forman e Godron, 1986).<br />
In questo senso l’indagine multitemporale consente di analizzare l’organizzazione del territorio,<br />
individuare le principali trasformazioni e comprendere l’evoluzione del rapporto tra la componente<br />
antropica e quella naturale o semi-naturale (Livani et al., 2004). Queste informazioni sono<br />
evidentemente importanti per la pianificazione territoriale e la gestione ambientale (Forman e<br />
Godron, 1986).<br />
Le azioni concrete di gestione del territorio, finalizzate ad aumentare la fissazione di carbonio nel<br />
suolo, sono quelle di afforestazione e riforestazione (art. 3.3), di gestione delle foreste, dei terreni<br />
agricoli, dei prati e dei pascoli e anche di rivegetazione (art. 3.4). Poiché inducono assorbimenti<br />
netti di gas-serra, esse possono essere iscritte nel Registro Nazionale dei serbatoi di carbonio e<br />
generare una quantità equivalente di crediti o Removal Units (RMU) che il Paese attuante può<br />
quindi emettere (Ciccarese, 2005) se human induced, ovvero legate all’attività antropica, e se<br />
realizzate dal 1990 in poi (Ciccarese et al., 2001).<br />
L’IPCC ha redatto uno Special Report on Land Use, land-use change and forestry activities, al fine<br />
di esaminare attentamente come la concentrazione di carbonio nell’atmosfera e nella biosfera si<br />
modifichi in relazione alle azioni previste negli art. 3.3 e 3.4, 6 e 12 del Protocollo di Kyoto<br />
(Watson et al., 2000) e di orientare queste azioni nel modo più appropriato.<br />
34
Esso prevede che il Paese debba scegliere la propria definizione di bosco, individuare tra le attività<br />
non obbligatorie (art. 3.4) quelle che intende portare in contabilizzazione dei crediti, indicando quali<br />
ritiene prioritarie, e provvedere alla realizzazione di un inventario delle categorie di utilizzo del<br />
territorio secondo i metodi che ritiene più opportuni tra quelli proposti o formulandone di nuovi<br />
(Allegato 5).<br />
L’IPCC ha anche elaborato nel 2003, per stimare, misurare, monitorare e rendicontare le variazioni<br />
degli stock di carbonio in relazione a queste attività, il rapporto Good Practice Guidance (GPG) of<br />
Land Use, Land-use Change and Forestry che traccia le linee guida alle buone pratiche per<br />
l’utilizzo del territorio, i cambiamenti nell’uso del suolo e la selvicoltura. Il rapporto definisce le<br />
principali categorie di uso del suolo (territori boscati, territori agricoli, prati e pascoli, zone umide,<br />
insediamenti antropici) e indica anche le metodologie da seguire per la stima degli stock di carbonio<br />
e le loro variazioni sia nelle categorie principali citate, presenti in tutto il territorio nazionale, sia<br />
nelle aree che ricadono nelle attività di afforestazione e riforestazione, di gestione forestale, di<br />
gestione dei suoli agricoli, dei pascoli e in rivegetazione e in quelle previste nei progetti JI (art. 6) e<br />
CDM (art. 12). In questa ricerca è stato scelto, ai fini di un eventuale futuro conteggio dei crediti<br />
(Carbon accounting) nell’area indagata, il Land-Based approach che prevede, tra gli step, la<br />
definizione delle attività applicabili e l’identificazione delle unità territoriali su cui queste attività<br />
insistono (Figura 11, Allegato 5).<br />
Figura 11 - Step necessari per i due approcci di Carbon accounting previsti<br />
Fonte: Special Report on Land Use, land-use change and forestry activities (2000)<br />
35
Allo scopo quindi di produrre un inventario delle categorie di uso del suolo contabilizzabili come<br />
crediti di carbonio, le ortofoto digitali 1990 e 2000 sono state fotointerpretate e classificate in<br />
funzione dell’uso del suolo secondo la legenda del CORINE Land Cover (Allegati 1 e 2), sistema di<br />
classificazione riconosciuto a livello europeo (AA.VV., 1995; Maricchiolo et al., 2004).<br />
Per entrambe le date è stata effettuata la restituzione cartografica delle tipologie di uso del suolo<br />
osservate (Forman, 1995; Pigato, 1995) ed è stata prodotta una carta della copertura del suolo in<br />
scala nominale 1:10.000.<br />
In Tabella 6 le definizioni delle attività degli artt. 3.3 e 3.4 del Protocollo sono associate alle<br />
categorie di CORINE Land Cover (CLC) .<br />
Tabella 6 - Corrispondenza categorie CLC alle attività contabilizzabili come crediti di C<br />
Categorie CLC Attività contabilizzabili<br />
3.1 Zone boscate Gestione forestale<br />
Afforestazione e riforestazione<br />
2.3.1 Prati stabili +<br />
Gestione dei prati e dei pascoli<br />
3.2.1 Aree a pascolo naturale e praterie<br />
3.2.2 Brughiere e cespuglieti +<br />
Rivegetazione<br />
3.2.3 Aree a vegetazione sclerofilla +<br />
3.2.4 Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione<br />
3.3.3 Aree con vegetazione rada Afforestazione e riforestazione<br />
Rivegetazione<br />
2.1 Seminativi +<br />
Gestione delle colture agrarie<br />
2.2 Colture permanenti +<br />
2.4 Zone agricole eterogenee<br />
Le classi di copertura del suolo sono state attribuite ad unità spaziali risultate omogenee alla<br />
fotointerpretazione, o composte da zone elementari appartenenti ad una stessa classe, e comunque<br />
nettamente distinte dalle unità che le circondano. La superficie minima rappresentabile<br />
cartograficamente è variabile in funzione della scala che degli scopi applicativi (Tabella 7).<br />
L’area minima non può infatti occupare sulla carta uno spazio inferiore a circa 4 x 4 mm perché<br />
altrimenti apparirebbe puntiforme e oggetti territoriali aventi questa superficie risulterebbero poco<br />
leggibili. Ne deriva che alla scala 1:5.000 si possono cartografare aree di almeno 400 mq e alla scala<br />
1:50.000 di almeno 40.000 mq (Tabella 7).<br />
Tabella 7 – Aree minime cartografabili alle diverse scale<br />
Scala di<br />
Area minima<br />
fotointerpretazione cartografabile in m 2<br />
1:5.000 400<br />
1:10.000 1600<br />
1:25.000 10.000 (1 ha)<br />
1: 50.000 40.000 (40 ha)<br />
36
L’area minima cartografabile è stata fissata, per questo lavoro, a 5000 metri quadrati poiché questa<br />
superficie è significativa alla scala nominale 1:10.000 e corrisponde all’area minima richiesta dalla<br />
definizione di bosco FAO FRA2000 (UN-ECE/FAO, 1997, 2000) adottata.<br />
Definizioni FAO FRA2000 di Bosco e di Altre terre boscate<br />
Bosco: territorio con copertura arborea maggiore del 10% su un’estensione maggiore di 0,5 ha. Gli<br />
alberi devono poter raggiungere un’altezza minima di 5 m a maturità in situ. Può trattarsi di<br />
formazioni chiuse o aperte. Soprassuoli forestali giovani, anche se derivati da piantagione, o aree<br />
temporaneamente scoperte per cause naturali o per l’intervento dell’uomo, ma suscettibili di<br />
ricopertura a breve termine secondo i requisiti sopra indicati, sono inclusi nella definizione di bosco.<br />
Sono inoltre inclusi: vivai forestali e arborei da seme (che costituiscono parte integrante del bosco);<br />
strade forestali, fratte tagliate, fasce tagliafuoco e altre piccole aperture del bosco; boschi inclusi in<br />
parchi nazionali, riserve naturali e altre aree protette; barriere frangivento e fasce boscate di<br />
larghezza superiore a 20 m, purchè maggiori di 0,5 ha. Sono incluse anche le piantagioni finalizzate<br />
a scopi forestali comprese quelle di alberi da gomma e le sugherete.<br />
Altre Terre Boscate: territorio con copertura arborea del 5-10% di alberi in grado di raggiungere<br />
un’altezza minima di 5 m a maturità in situ oppure territorio con una copertura maggiore del 10%<br />
costituita da alberi che non raggiungono un’altezza di 5 m a maturità in situ o da arbusti e cespugli.<br />
Tabella 8 - Requisiti richiesti dalla definizione di bosco FAO FRA2000<br />
Requisiti minimi Usi del suolo<br />
Area minima 0,5 ha (5000 mq)<br />
Larghezza minima 20 m<br />
Altezza a maturità (solo per la classe boschi) 5 m<br />
I requisiti rappresentati in tabella che rientrano nella definizione di bosco, sono stati utilizzati anche<br />
per le altre categorie di uso del suolo non rientranti nella classe 3. Territori boscati e ambienti<br />
seminaturali. Il terzo, comunque riportato per completezza di informazione, non può essere del tutto<br />
soddisfatto – come già detto – tramite fotointerpretazione di immagini digitali, a meno di integrare<br />
quanto percepibile in fotointerpretazione con informazioni di altra natura (cartografia di uso del<br />
suolo preesistente o della vegetazione, rilievi di campagna, ecc.).<br />
L’utilizzo di ortofoto (De Natale et al., 2003) presenta diversi vantaggi: l’ortorettificazione, la<br />
precisione geometrica, la visione in continuum del territorio e ad una scala costante, la possibilità di<br />
gestione dell’immagine agendo su contrasto e luminosità, l’integrabilità con altri dati all’interno di<br />
un GIS.<br />
L’impossibilità della visione stereoscopica costituisce d’altronde lo svantaggio più significativo in<br />
quanto determinate caratteristiche (altezza degli alberi, chioma, ecc.), come già evidenziato, non<br />
sono determinabili.<br />
L’attività di fotointerpretazione si è articolata in diverse fasi, descritte in Tabella 9, ed ha richiesto la<br />
compilazione di chiavi interpretative (Tabelle da 10 a 14) utili a ridurre la probabilità commettere<br />
errori fotointerpretativi.<br />
37
Tabella 9 - Fasi della fotointerpretazione<br />
1. Osservazione del territorio da fotointerpretare nel suo insieme, per riconoscere la<br />
morfologia del territorio. L’analisi del complesso degli elementi sopra citati consente di<br />
individuare le valli osservando la distribuzione dei centri abitati, di accertare l’andamento dei<br />
versanti e la loro esposizione attraverso il riconoscimento degli impluvi e il disegno della rete<br />
idrografica e stradale, di ricavare dalle ombre le informazioni sull’altezza degli elementi a<br />
sviluppo verticale (come nel caso delle chiome degli alberi).<br />
2. Realizzazione di alcuni campioni fotografici e di sintesi descrittive dei diversi usi del suolo<br />
presenti nell’area indagata, anche utilizzando informazioni accessorie utili all’identificazione<br />
(cartografie precedenti, rilievi di campagna, ecc.). Per tutte le classi non presenti nelle tabelle<br />
9, 10, 11, 12 e 13 si è fatto riferimento alle descrizioni delle voci di legenda del CORINE Land<br />
Cover (Allegati 1 e 2).<br />
3. Analisi dei parametri delle foto alla luce dello studio del territorio e del campione fotografico<br />
e unitamente ad altri elementi complementari di valutazione quali l’ubicazione, l’associazione<br />
e il tempo. Questi infatti descrivono gli oggetti non per come appaiono, ma per le relazioni che<br />
stabiliscono con l’ambiente circostante.<br />
4. Identificazione e classificazione degli oggetti di interesse sul territorio, in questo caso dei<br />
poligoni corrispondenti alle classi della legenda.<br />
5. Riesamina dei poligoni dubbi con il ricorso, ove possibile, a dati ausiliari per completare la<br />
classificazione e/o controllo di verità a terra.<br />
Gli elementi di base, o parametri, per l’interpretazione di fotogrammi e immagini digitali<br />
(Gomarasca, 2004; ISAFA, 2003) sono costituiti da:<br />
- tono e colore, legati alla risposta o firma spettrale degli oggetti e a come questa è resa<br />
nell’immagine;<br />
- grandezza e forma, elementi interpretativi geometrici;<br />
- altezza e ombra, anch’essi elementi interpretativi geometrici;<br />
- struttura e tessitura, elementi interpretativi che definiscono spazialmente tono e colore.<br />
38
Tabella 10 - Chiave di fotointerpretazione della classe<br />
3.1 Zone boscate<br />
(attività di gestione forestale, afforestazione e riforestazione)<br />
Formazioni naturali lasciate evolvere naturalmente 27 di alberi in grado di produrre legno o altri<br />
prodotti definiti come forestali: boschi di latifoglie, conifere e misti. I boschi ripari sono di solito<br />
associati ai corsi d’acqua.<br />
Toni di grigio più scuri rispetto coltivi e aree urbane.<br />
Strutture irregolari con forme geometriche e confini lineari nei boschi naturali.<br />
Tessitura scabrosa dovuta principalmente agli effetti dell’ombra delle chiome.<br />
Altezza a volte intuibile sulla base delle ombre.<br />
Sono compresi i rimboschimenti, ossia formazioni boscate non naturali, comunque in grado di<br />
produrre legno o altri prodotti definiti come forestali: boschi di latifoglie, conifere e misti.<br />
Struttura: nei rimboschimenti, soprattutto se giovani, è facile individuare geometrie regolari<br />
dovute alla disposizione ordinata degli alberi.<br />
Tessitura generalmente medio grossolana nelle fustaie adulte e mature, da media a fine nei<br />
popolamenti più giovani e nei soprassuoli cedui, soprattutto se monoplani; media e regolare, con<br />
elementi ovoidali e puntiformi nel caso di fustaie di conifere; tessitura irregolare nel caso di fustaie<br />
irregolari e multiplane.<br />
Altezza a volte intuibile sulla base delle ombre.<br />
Tabella 11 - Chiave di fotointerpretazione delle classi<br />
2.3.1 Prati stabili + 3.2.1 Aree a pascolo naturale e praterie<br />
(gestione dei prati e dei pascoli)<br />
Comprendono i prati stabili destinati alla produzione di foraggio nonché le aree a pascolo<br />
naturale, le praterie di alta quota e le aree incolte che derivano dall’abbandono delle pratiche<br />
agricole.<br />
E’ più probabile trovare la classe 3.2.1 in alta quota o su forti pendenze, quindi in ambiente<br />
montano, piuttosto che in aree vallive o pianeggianti; negli ambienti alpini, ampie radure nel bosco<br />
associate a fabbricati di forma allungata identificano spesse aree a pascolo.<br />
Forme solitamente regolari per la prima, piuttosto irregolari per la seconda.<br />
Tessitura meno uniforme e margini con forma frastagliata nei pascoli attivi (contrariamente ai<br />
pascoli abbandonati).<br />
Toni e tessitura più uniformi nelle praterie d’alta quota.<br />
27 * Il senso di “lasciate evolvere naturalmente” sta nel fatto che le formazioni non sono soggette a pratiche agronomiche,<br />
ma soltanto a interventi selvicolturali (diradamenti, tagli di rinnovazione, ecc.)..<br />
39
Tabella 12 - Chiave di fotointerpretazione delle classi<br />
3.2.2 Brughiere e cespuglieti + 3.2.3 Aree a vegetazione sclerofilla<br />
+ 3.2.4 Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione<br />
(rivegetazione)<br />
Formazioni naturali lasciate evolvere naturalmente di arbusteti e vegetazione mediterranea,<br />
generalmente definita come macchia.<br />
La vegetazione dispersa su campi agricoli può essere interpretata come indice di abbandono<br />
colturale.<br />
I pascoli abbandonati hanno tessitura meno uniforme e margini con forma meno frastagliata.<br />
Tabella 13 - Chiave di fotointerpretazione della classe<br />
3.3.3 Aree con vegetazione rada<br />
(attività di afforestazione, riforestazione e rivegetazione)<br />
Vedi descrizione legenda Corine Land Cover (Allegati 1 e 2)<br />
Tabella 14 - Chiave di fotointerpretazione delle classi<br />
2.1 Seminativi + 2.2 Colture permanenti + 2.4 Zone agricole eterogenee<br />
(gestione delle colture agrarie)<br />
Aree coltivate. Possono essere confusi con le praterie naturali o i pascoli, per cui bisogna<br />
osservare la morfologia del territorio, pendenza, quota, tipo di confine, stato della viabilità e delle<br />
infrastrutture.<br />
Forme geometriche molto regolari (negli usi del suolo antropici infatti prevalgono le linee dritte o<br />
spezzate, con curvature ed andamenti regolari).<br />
Tessitura da fine a striata (a causa delle lavorazioni del terreno): fine per le colture erbacee, striata<br />
se la lavorazione è recente (con una trama caratteristica per i coltivi).<br />
Toni di grigio variabili a seconda del suolo, delle condizioni di lavorazione e di irrigazione, dello<br />
stadio fenologico, del vigore e del tipo di coltura. Macchie più scure possono indicare colture<br />
mature, depressioni, densità variabile delle colture o irregolare distribuzione di sostanza organica o<br />
di umidità (ristagni d’acqua)<br />
La distribuzione spaziale (struttura) delle aziende agricole, delle colture all’interno dei campi è<br />
caratteristica del tipo di agricoltura che viene praticato: quindi è necessaria una conoscenza del<br />
contesto territoriale per poter essere ben interpretata.<br />
Vigneti: disposti in filari regolari talvolta intercalati da alberi.<br />
Frutteti: generalmente disposti in sesti regolari (quadrati o rettangolari), talvolta in filari<br />
generalmente di spessore maggiore rispetto ai vigneti; quelli di vecchio impianto hanno di solito<br />
una disposizione meno regolari e sono consociati con altre colture.<br />
Oliveti: ad eccezione di quelli di nuovo impianto, non presentano una disposizione regolare, gli<br />
alberi sono più distanziati rispetto ai frutteti, soprattutto se consociati con colture erbacee; possono<br />
confondersi con querce o altri alberi forestali, ma si distinguono per la tonalità cinere della chioma<br />
40
e spesso per la potatura a vaso caratteristica (con il nucleo della chioma più chiaro rispetto alla<br />
parte più periferica).<br />
Gli impianti di arboricoltura da legno sono impianti forestali specializzati per la produzione<br />
legnosa, coltivati secondo turni brevi (10, 30 anni) e sottoposti a pratiche agronomiche: i sesti<br />
sono generalmente ampi e definitivi, anche se quelli più recenti sono relativamente stretti; possono<br />
essere di latifoglie (pioppi o latifoglie di pregio) o di conifere: pioppeti, eucalitteti, pinete di pino<br />
insigne, impianti CEE 2080 (di legno, noce e ciliegio che sono realizzati con soggetti “selvatici”<br />
non innestati con varietà o cultivar di interesse alimentare); distinguibili dai frutteti per i sesti più<br />
ampi e una maggiore dimensione delle chiome degli alberi oltre ad una tessitura più grossolana<br />
perché sono sottoposti ad una minore intensità colturale; oppure si distinguono, come nel caso dei<br />
pioppeti, perché spesso ubicati in situazioni morfologiche specifiche (golene o greti fluviali).<br />
2.1.2 Bioclimi e serie di vegetazione<br />
L’elevata estensione in senso latitudinale della penisola italiana, la presenza di complessi orografici<br />
orientati nelle direzioni Nord/Sud ed Ovest/Est e anche la vicinanza delle masse continentali<br />
africana ed eurasiatica, determinano una elevata diversità di bioclimi e tipi climatici a seconda che<br />
prevalgano la componente tropicale o medio-europea (Blasi, 2004; Blasi et al., 2005) che non<br />
possono non influire significativamente sul territorio. L’area campione dell’Alto Molise è stata<br />
quindi studiata in funzione della propria eterogeneità bioclimatica perché anche ad essa è<br />
strettamente legata la sua diversità biologica. Allo scopo è stata utilizzata la cartografia del<br />
Fitoclima d’Italia in scala 1:250.000 prodotta nell’ambito della Convenzione Completamento delle<br />
Conoscenze Naturalistiche di Base tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e<br />
l’Università degli Studi “La <strong>Sapienza</strong>” di Roma (Allegato 3).<br />
Studio analogo è stato condotto utilizzando la cartografia digitale in scala 1:250.000 delle serie di<br />
vegetazione, realizzata nell’ambito della citata Convenzione (Allegato 3). La vegetazione naturale<br />
potenziale (VNP) è la vegetazione che tende a formarsi naturalmente in un certo luogo quando non è<br />
presente il disturbo antropico (Tuxen, 1956). Le serie o sigmeti (Rivas Martinez, 1976; Géhu,<br />
1986), costituiti dall’insieme delle comunità vegetali appartenenti a successioni che hanno la stessa<br />
tappa matura come stadio finale, descrivono dunque il territorio sia in funzione della sua<br />
potenzialità vegetazionale in assenza di disturbo sia in relazione al pattern di copertura e di uso<br />
attuale (stadi seriali). In questo senso, se la comunità presente coincide con la tappa matura, esse<br />
divengono anche rappresentative della biodiversità vegetale reale; diversamente, l’ambito di<br />
pertinenza della serie indica la superficie potenzialmente interessata da una determinata tappa<br />
matura.<br />
Alla scala di rappresentazione cartografica, alcuni sigmeti possono risultare non cartografabili. Lo<br />
sono invece i geosigmeti in quanto insiemi di serie contigue presenti all’interno di una stessa unità<br />
geomorfologia e di un’unica unità biogeografia.<br />
Nell’Alto Molise, l’analisi di dettaglio è stata integrata con sopralluoghi e rilievi di campagna volti a<br />
verificare a terra le tipologie di copertura del suolo e in particolare le fisionomie vegetazionali<br />
(forestali e non forestali) cartografate, la presenza degli stadi seriali o delle eventuali tappe mature e<br />
dei caratteri bioclimatici individuati con lo studio delle serie di vegetazione e dei bioclimi.<br />
41
2.2 Analisi della eterogeneità territoriale a scala nazionale<br />
La distribuzione della vegetazione di qualsiasi regione geografica sulla superficie terrestre è<br />
strettamente collegata, almeno in prima approssimazione, alle sue caratteristiche climatiche e la loro<br />
correlazione è stata ampiamente dimostrata in letteratura, sebbene siano pochi gli studi sistematici<br />
condotti sull’intero territorio italiano (Pavari, 1916; De Philippis, 1937; Tomaselli, 1973; Blasi,<br />
2004). L’eterogeneità bioclimatica della penisola è dunque in rapporto con la propria copertura<br />
biofisica, la cui rappresentazione cartografica può riguardare più strettamente le categorie di<br />
copertura del suolo (land cover) oppure fare riferimento alle funzioni socio-economiche che queste<br />
possono assumere nel territorio (land use).<br />
Per tali ragioni si è ritenuto necessario indagare la relazione esistente tra la copertura del suolo<br />
territorio italiano cartografata nell’ambito del progetto CORINE Land Cover (AA.VV., 1995; Blasi,<br />
2004; Maricchiolo et al., 2004) e l’eterogeneità bioclimatica e vegetazionale in termini di serie di<br />
vegetazione (Blasi, 2004) .<br />
2.2.1 Criterio di selezione delle aree campione<br />
Il ricorso agli schemi di campionamento statistico, che consentono l’osservazione di una parte di<br />
una popolazione (campione) e di trarre conclusioni sull’intera popolazione, rappresenta una<br />
necessità per tutta una serie di indagini che riguardano ambiti diversi, dal settore forestale a quello<br />
della biologia ambientale (Corona et al., 2001), a diverse scale applicative e per esigenze di<br />
conoscenza relative ai cambiamenti sia della consistenza sia dello stato delle risorse ambientali<br />
(Edwards, 1998). Il censimento,<br />
infatti, è più facilmente applicabile,<br />
anche e soprattutto in termini di<br />
tempi e costi di realizzazione, per<br />
indagini di portata limitata o per aree<br />
poco estese. Inoltre un rilevamento<br />
campionario basato su una<br />
definizione formale di<br />
rappresentatività permette di valutare<br />
in maniera più oggettiva l’incertezza<br />
delle stime e assicura affidabilità<br />
all’inventario e all’eventuale<br />
monitoraggio.<br />
Figura 12 - Reticolo di 1200 celle<br />
Due schemi di campionamento sono<br />
più frequentemente utilizzati in<br />
particolare per gli inventari forestali:<br />
il cosiddetto model based, che<br />
prevede una conoscenza a priori di<br />
specifiche relazioni tra gli attributi di<br />
interesse e altri attributi facilmente<br />
rilevabili e non consente di<br />
42
conoscere l’entità dell’errore di stima, nemmeno in termini probabilistici, e il design-based, qui<br />
utilizzato, di natura essenzialmente probabilistica (Corona, 2001; Fattorini, 2001) e nel quale la<br />
dimensione delle aree può essere usata come variabile ausiliaria per il miglioramento della<br />
precisione delle stime.<br />
L’unità inventariale è in questo caso costituita dal territorio nazionale, in quanto ad esso corrisponde<br />
alla popolazione interessata dall’indagine. Il disegno di campionamento, che specifica la modalità di<br />
selezione delle unità che costituiscono il campione (Tosi, 2001), è stato concepito in modo tale da<br />
analizzare un campione ritenuto rappresentativo.<br />
Con una procedura informatica è stato generato un reticolo in formato vettoriale che ricopre<br />
idealmente il territorio nazionale a partire da una cella di base (cella 559 in Figura 12). La<br />
replicazione di questa unità territoriale, che è costituita dall’area dell’Alto Molise oggetto<br />
dell’analisi di dettaglio ed ha dimensioni di 25’ in longitudine e 18’ in latitudine (pari a circa<br />
116.000 ettari), ha prodotto una griglia di 1200 celle, ciascuna con un suo identificativo.<br />
Di queste, 389 (Figura 13) intersecano la penisola italiana, la Sardegna, la Sicilia e le isole minori.<br />
Figura 14 - Regioni macroclimatiche italiane<br />
Fonte: Completamento delle conoscenze naturalistiche di base<br />
(Blasi, 2004; Blasi et al., 2005)<br />
Allegato 3<br />
E’ stato poi introdotto un fattore di stratificazione al fine<br />
di estrarre in modo casuale nei due macroclimi un<br />
Figura 13 - Reticolo in intersezione<br />
con il territorio italiano (389 celle)<br />
Per analizzare il rapporto tra la<br />
copertura del suolo e la vegetazione alla<br />
luce della eterogeneità bioclimatica<br />
della penisola, è stata effettuata<br />
l’intersezione cartografica del layer del<br />
reticolo con il piano tematico delle<br />
regioni macroclimatiche e sono state<br />
create due griglie, una per la Regione<br />
Mediterranea e una per la Regione<br />
Temperata (Figura 13).<br />
43
numero di celle costituente il campione da analizzare. Tale fattore è la classe CLC 3. Territori<br />
boscati e ambienti seminaturali che rappresenta tra le categorie CLC di primo livello quella con<br />
elementi di maggiore naturalità e la copertura più estesa delle voci di natura forestale.<br />
Nella prima area campione dell’Alto Molise è stata calcolata<br />
l’incidenza di questa classe in termini di superficie, risultata pari a<br />
94.686 ettari su 116.000 ettari (Figura 14).<br />
Figura 15 - Cella 559 Alto Molise<br />
Sono state quindi selezionate in entrambe le griglie, le celle aventi<br />
una percentuale di copertura della categoria 3. Territori boscati e<br />
ambienti seminaturali comparabile a quella della prima area<br />
campione (94.686 ettari ).<br />
Il valore soglia entro il quale sono state selezionate le celle è stato fissato a circa 92.000 ettari per la<br />
Regione Temperata e a circa 40.000 ettari per la Regione Mediterranea. In questo caso il valore è<br />
stato anche scelto in misura proporzionale alla minore estensione della Regione Mediterranea, che<br />
copre circa il 30% del territorio nazionale, e alla minore copertura della classe 3. Territori boscati e<br />
ambienti seminaturali in questo macroclima.<br />
In base al criterio di<br />
selezione descritto, sono<br />
state estratte in totale 56<br />
unità di campionamento: 39<br />
celle nella Regione<br />
Temperata e 17 nella<br />
Regione Mediterranea<br />
(Figura 16).<br />
A ciascuna cella, per<br />
facilitarne l’identificazione<br />
sul territorio, è stato poi<br />
assegnato il nome di un<br />
comune fra quelle ricadenti,<br />
in parte o del tutto, al suo<br />
interno. La cella 1062 è,<br />
per esempio, denominata<br />
Campo di Trens (BZ); la<br />
171 invece Castiglione di<br />
Sicilia (CT).<br />
Figura 16 - Celle estratte<br />
nella Regione (in verde)<br />
Temperata e nella<br />
Regione Mediterranea (in<br />
rosso)<br />
44
Tabella 15 - Celle campione della Regione Temperata<br />
PROGR GRIGLIA_ID HECTARES PROGR GRIGLIA_ID HECTARES<br />
1 1063 106031,05 21 847 109923,88<br />
2 1062 105997,15 22 818 110492,38<br />
3 1034 106655,07 23 817 110483,76<br />
4 1033 106615,73 24 791 111112,58<br />
5 1031 106552,64 25 790 111085,87<br />
6 1030 106529,12 26 789 111064,98<br />
7 1005 107284,71 27 763 111741,44<br />
8 1004 107238,78 28 676 113556,84<br />
9 1003 107198,79 29 646 114103,85<br />
10 1002 107163,76 30 617 114716,54<br />
11 1001 107134,65 31 616 114647,70<br />
12 1000 107110,74 32 588 115335,34<br />
13 972 107740,51 33 587 115258,20<br />
14 970 107686,62 34 586 115188,36<br />
15 969 107667,59 35 559 115960,96<br />
16 968 107654,58 36 558 115876,37<br />
17 964 107656,55 37 413 119054,34<br />
18 933 108245,10 38 412 118933,78<br />
19 932 108265,19 39 383 119580,02<br />
20 902 108836,42<br />
Tabella 16 - Celle campione della Regione Mediterranea<br />
PROGR GRIGLIA_ID HECTARES PROGR GRIGLIA_ID HECTARES<br />
1 487 116449,73 11 325 120898,52<br />
2 457 116972,83 12 307 119539,06<br />
3 456 116970,25 13 305 119540,85<br />
4 427 117492,66 14 276 120039,56<br />
5 414 119182,09 15 171 122918,83<br />
6 397 118010,71 16 170 122802,01<br />
7 396 118008,06 17 169 122692,85<br />
8 367 118522,47<br />
9 366 118519,78<br />
10 337 119032,42<br />
2.2.2 L’eterogeneità bioclimatica italiana e la sua relazione con la copertura<br />
vegetazionale (classi forestali e serie di vegetazione)<br />
La realtà composita del territorio italiano in termini bioclimatici e vegetazionali richiede una analisi<br />
attenta delle ricadute delle azioni di afforestazione e riforestazione (art. 3.3 compulsory activities),<br />
nonché delle eventuali attività di rivegetazione e di gestione delle foreste, delle terre agricole, dei<br />
45
prati e dei pascoli (art. 3.4 not compulsory activities) previste dal Protocollo di Kyoto e dalle<br />
decisioni assunte successivamente. Sono state dunque esaminate le classi di copertura del suolo, in<br />
particolare quelle forestali, e le serie di vegetazione prevalenti nei nove bioclimi individuati come<br />
porzioni di territorio omogenee per la penisola italiana. Sette appartenengono alla Regione<br />
Macroclimatica Temperata (Temperato oceanico, Temperato semicontinentale, Temperato<br />
oceanico-semicontinentale, Temperato subcontinentale, Temperato semicontinentalesubcontinentale,<br />
Temperato oceanico di transizione Temperato oceanico-semicontinentale di<br />
transizione) e due alla Mediterranea (Mediterraneo oceanico e Mediterraneo oceanico di<br />
transizione).<br />
L’analisi della eterogeneità del territorio italiano in termini bioclimatici e vegetazionali è stata<br />
eseguita mettendo a sistema, mediante operazioni di intersezione cartografica, le 56 unità territoriali<br />
campione con i piani tematici relativi all’uso del suolo, ai bioclimi e alle serie di vegetazione. Allo<br />
scopo sono state utilizzate le cartografie del CORINE Land Cover al 2000, del Fitoclima e delle<br />
Serie di vegetazione d’Italia (già utilizzate nello studio di dettaglio dell’area campione dell’Alto<br />
Molise).<br />
2.2.2.1 - Bioclimi e classi CLC<br />
E’ stata analizzata la relazione esistente tra la copertura territoriale dei nove bioclimi e le classi<br />
CLC. Sono stati elaborati i valori di copertura delle classi CLC2000 sia al I livello gerarchico che al<br />
III e al IV-V per le sole categorie forestali. Le voci di legenda sono coerenti con le attività<br />
antropiche contabilizzabili quali crediti di carbonio, secondo le decisioni assunte nella COP7 del<br />
Protocollo di Kyoto.<br />
Sono stati stimati in tutte le celle campione del reticolo il numero e la percentuale di copertura delle<br />
classi CLC. Vengono discusse in particolare le voci di legenda importanti ai fini del Protocollo di<br />
Kyoto.<br />
2.2.2.2 - Bioclimi e serie di vegetazione<br />
Bioclimi e serie di vegetazione sono stati analizzati all’interno delle 56 celle campione.<br />
Per quanto riguarda la componente bioclimatica, sono descritti i nove raggruppamenti per il<br />
territorio italiano e riportate le tabelle indicanti la copertura di ciascuno all’interno delle celle.<br />
Per quanto concerne invece le serie di vegetazione, ciascuna unità cartografata e identificata nelle<br />
celle di campionamento è descritta in termini fitosociologici, ossia nelle caratteristiche floristiche,<br />
fisionomiche e sindinamiche (Westhoff et van der Maarel, 1973), sia dello stadio maturo sia dalle<br />
cenosi che lo sostituiscono quando invece il disturbo è presente.<br />
Sono stati quindi stimati in tutte le celle campione del reticolo il numero e la percentuale di<br />
copertura dei bioclimi e delle serie di vegetazione.<br />
46
3. RISULTATI<br />
3.1 Analisi della eterogeneità territoriale a scala locale<br />
3.1.1 Uso e copertura del suolo<br />
3.1.1.1 - Ortorettificazione e georefenziazione delle immagini digitali del 1990<br />
I procedimenti di ortorettificazione e di georeferenziazione delle foto digitali del 1990 sono stati<br />
rigorosi e hanno richiesto ampi margini di tempo, inevitabili per ottenere la necessaria accuratezza,<br />
poiché ad essa è legata la qualità dei risultati (Gomarasca, 2004).<br />
Tale attività ha consentito di ottenere la migliore sovrapposizione possibile tra le immagini del 1990<br />
e quelle del 2000 (Figura 17) e quindi di procedere alla fotointerpretazione e alla classificazione<br />
dell’uso del territorio dei due dataset relativi all’area campione dell’Alto Molise con un margine di<br />
errore accettabile.<br />
Figura 17 - Quadro di unione delle sezioni di ortofoto dell'anno 1990<br />
I procedimenti effettuati sulle foto del 1990 hanno consentito di ottenere la migliore<br />
sovrapposizione possibile con le immagini del 2000 e di procedere alla classificazione dell’uso del<br />
territorio dei due dataset relativi all’area dell’Alto Molise con un margine di errore contenuto entro i<br />
5-8 metri, considerato accettabile alla scala 1:10.000.<br />
47
E’ stato anche effettuato un controllo a campione di alcune porzioni di territorio sulle ortofoto<br />
digitali del 1990 e del 2000. E’ possibile rilevare come l’area dei poligoni di uso del suolo utilizzati<br />
quali unità di verifica resti costante nelle due date così come combacino le intersezioni fra strade e<br />
altri elementi lineari.<br />
Figura 18 - Sovrapposizione di poligoni di uso del suolo a una porzione di ortofoto del 1990 (a<br />
sinistra) ed ad una porzione di ortofoto del 2000 (a destra)<br />
Figura 19 - Errori di posizionamento relativi all’immagine digitale 3050. Sono indicati nel<br />
campo RMS, mentre nel campo Height è indicato il corrispondente valore di quota del DTM .<br />
48
In Figura 19 è stata riportata una delle tabelle relative ai ground control point utilizzati per il<br />
georiferimento e la stima dell’errore di posizionamento in cui è evidenziato che l’errore massimo di<br />
posizionamento è pari a 7,43 metri.<br />
Gli errori insiti nei processi di georeferenziazione delle immagini digitali e di fotointerpretazione, e<br />
nella quantificazione del cambiamento di uso del suolo che ne consegue, inducono ragionevolmente<br />
a ritenere che comunque, a meno di una ortorettificazione delle immagini (che richiede anche<br />
l’utilizzo di un modello digitale del terreno), sia meno oneroso procedere ad una fotointerpretazione<br />
per punti.<br />
I procedimenti di manipolazione effettuno richiedono infatti necessariamente tempi piuttosto lunghi,<br />
e costi elevati 28 se si intende ottenere un livello di precisione utile allo scopo.<br />
3.1.1.2 - Analisi multitemporale 1990-2000 e classificazione secondo Corine Land Cover<br />
Premessa<br />
La classificazione dell’uso e copertura del territorio è stato in parte condizionato dalla difficoltà di<br />
derivare le categorie CLC dalle definizioni delle attività ammesse alla contabilizzazione dei crediti<br />
di carbonio.<br />
La definizione di bosco scelta per questo lavoro, mutuata dal FRA2000 e la stessa dell’IFNC<br />
considera forestate le porzioni di territorio con tasso di copertura arborea maggiore o uguale al 10%.<br />
Una soglia troppo bassa che consente di definire foresta anche ambiti territoriali che non lo sono e<br />
che può condurre ad una sovrastima del territorio boscato e, contemporaneamente, ad una<br />
sottovalutazione di quelle tipologie che in quella di bosco risulterebbero incluse.<br />
Secondo il Protocollo di Kyoto questo valore può in realtà variare dal 10 al 30%. Comunque l’Italia<br />
dovrà pronunciarsi nel merito di questa definizione entro la fine del 2006.<br />
Vi è una oggettiva necessità di accorpamento delle due voci di afforestation e reforestation. Nel<br />
caso del nostro Paese, relativamente a queste attività che possono essere realizzate per mezzo di<br />
piantagione, semina e/o un intervento antropico di sostegno alla affermazione delle modalità<br />
naturali di propagazione, possiamo infatti parlare sinteticamente di “rimboschimenti” in quanto, con<br />
rare eccezioni, non esistono ambiti che non siano mai stati coperti dal bosco. D’altra parte, a meno<br />
della consultazione di altre fonti informative (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Catasto,<br />
ecc.), disponibili peraltro in formati e scale applicative diversi, è possibile soltanto identificare le<br />
aree boscate, senza potergli associare l’elemento temporale richiesto ai fini contabili.<br />
La categoria deforestazione è per il nostro Paese di relativo interesse: a parte una effettiva<br />
carenza di dati e informazioni su questo fenomeno in Italia, i boschi negli ultimi anni hanno<br />
aumentato la loro estensione di circa il 26 % (il dato si riferisce in particolare ai boschi di latifoglie,<br />
di conifere e misti di conifere e latifoglie). Peraltro non è possibile includervi le aree soggette ad<br />
incendi boschivi poiché per legge questi eventi non determinano un cambiamento di uso del suolo.<br />
28 Oltre al costo di acquisto delle immagini del 1990, l’ortorettificazione delle immagini richiede l’utilizzo di un modello<br />
digitale del terreno, peraltro non sempre facile a procurarsi.<br />
49
La voce di rivegetazione è definita come una azione antropica tesa ad aumentare lo stock di<br />
carbonio in un sito, mediante la realizzazione di una copertura vegetale su un’area minima di 0,5<br />
ettari che non rientri nelle definizioni di afforestazione e riforestazione. Essa prevede cioè, perché<br />
possa essere conteggiata, che sia verificata la condizione di volontarietà (il fattore human induced)<br />
oltre all’elemento temporale del 1990 quale data di inizio della attività. Sarebbe invece opportuno<br />
dare una interpretazione estensiva di questa definizione per introdurvi anche i casi di recupero<br />
dovuti dell’abbandono. In Italia essi rappresentano i casi più frequenti di rivegetazione. Questa<br />
tipologia di copertura del suolo ha infatti una notevole rilevanza territoriale in quanto comprende<br />
aree abbandonate con processi di ricolonizzazione in atto da parte:<br />
- della vegetazione erbacea e arbustiva (Figure<br />
20 e 21) di cui costituiscono esempio i pascoli<br />
alpini di alta quota invasi da salici e ontano<br />
verde<br />
Figura 20 - Pascoli abbandonati in fase di<br />
ricolonizzazione<br />
gli abbandoni delle categorie colturali, che<br />
sono peraltro soggette a processi di<br />
degradazione del suolo legati alla perdita di<br />
sostanza organica e quindi ad emissioni di gas<br />
ad effetto serra (fenomeno che riguarda,<br />
soprattutto nelle aree mediterranee, le<br />
coltivazioni arboree abbandonate percorse dal<br />
fuoco);<br />
Figura 21 - Coltivazioni agrarie in fase di<br />
ricolonizzazione<br />
- della vegetazione arborea (Figura 22), come nel caso della diffusione del larice su prati e pascoli<br />
ai margini dei boschi alpini, o della robinia e dell’ailanto nelle zone di pianura (condizione che<br />
però potrebbe rientrare delle voci di<br />
afforestazione e riforestazione), ma che<br />
comunque entrerebbe in contrasto con la<br />
necessità di limitare, al fine di conservare la<br />
biodiversità, la presenza di queste specie in<br />
quanto “esotiche invasive”.<br />
Figura 22 - Margini dei boschi in<br />
ricolonizzazione<br />
50
Le attività di gestione forestale, ossia un complesso di pratiche per la conduzione e l’uso<br />
sostenibile di una foresta, finalizzate al conseguimento di rilevanti funzioni ecologiche (quali la<br />
tutela della diversità biologica), economiche e sociali, sono di difficile identificazione oltre che<br />
probabilmente poco redditizie in termini di crediti. Possono comprendere infatti programmi di<br />
protezione della flora e della fauna, come pure interventi di gestione forestale sostenibile. Inoltre, i<br />
crediti che ne derivano, a differenza della altre attività human induced, non sono conteggiati in toto:<br />
prima vengono utilizzati per pareggiare eventuali debiti derivanti dal bilancio (afforestazione +<br />
riforestazione - deforestazione) e poi ridotti al 15%.<br />
Per gestione delle colture agrarie si intende un complesso di pratiche su territori su cui sono<br />
effettuate coltivazioni agrarie e su terreni messi a riposo o temporaneamente non adoperati per<br />
produzioni agricole. Rispetto a questa tipologia, c’è una perplessità di fondo legata alla nuova<br />
Politica Agricola Comunitaria. La PAC prevede attualmente (da gennaio 2005) l’erogazione di aiuti<br />
alle aziende agricole, e agli agricoltori, in generale sulla base del reddito dichiarato negli ultimi tre<br />
anni e non sulla produttività. Vale a dire, in termini pratici, che i soggetti interessati potrebbero<br />
decidere di non gestire la propria terra perché comunque destinatari dell’aiuto se il reddito<br />
dichiarato è elevato oppure perché comunque non beneficiari se invece è esiguo (come nel caso<br />
delle realtà agricole più piccole). In entrambi i casi potrebbe verificarsi la tendenza ad un aumento<br />
esponenziale degli abbandoni delle colture agricole.<br />
Le attività di gestione dei prati e dei pascoli consistono in un complesso di pratiche su terreni<br />
utilizzati per l’allevamento del bestiame, volti a modificare la quantità e il tipo di vegetazione e il<br />
bestiame allevato. In questo caso la gestione, sempre per effetto della citata PAC, potrebbe essere<br />
rivolta più marcatamente verso il prato-pascolo, anche per l’oggettiva necessità dei proprietari dei<br />
fondi di mantenerli puliti. Il bestiame in questo caso potrebbe essere utilizzato a questo scopo, di<br />
conseguenza favorendo queste pratiche.<br />
La classificazione al 2000 dell’area di studio (Figura 23) indica le superfici boscate e gli ambienti<br />
seminaturali estesi per oltre l’81% (quasi 95.000 ettari) e le superfici agricole per circa il 18%.<br />
18%<br />
Copertura del suolo area campione<br />
1%<br />
81%<br />
1 - Superfici artificiali<br />
2 - Superfici agricole<br />
3 - Territori boscati e<br />
ambienti seminaturali<br />
Figura 23 - Estensione della classi I livello nella cella 559 di Castelverrino<br />
51
Si tratta quindi di un territorio in cui la componente seminaturale è dominante e con una incidenza<br />
agricola non trascurabile. La classificazione integrata con le informazioni di ulteriore dettaglio<br />
provenienti dal CLC2000 (Tabella 17) evidenzia come le classi di III, IV e V livello più estese nella<br />
categoria 3 dei Territori boscati e ambienti seminaturali siano quelle relative ai boschi di latifoglie<br />
(311), che coprono il 65,09% dell’area di studio. Nell’ambito delle zone caratterizzate da<br />
vegetazione arbustiva e/o erbacea (32), che complessivamente si estendono per oltre il 16% della<br />
superficie, sono significativamente rappresentate la classe 321 delle aree a pascolo naturale e delle<br />
praterie (7,7%) e le classi 322 delle brughiere e dei cespuglietti (3,5%) e 324 delle aree a<br />
vegetazione boschiva ed arbustiva evoluzione (5,3%). Dato interessante, soprattutto relativamente<br />
alle attività di gestione dei prati e dei pascoli e di rivegetazione previste dall’art. 3.4 del Protocollo<br />
di Kyoto.<br />
Tabella 17 - Classi III, IV e V livello più estese nella categoria 3 del CLC<br />
CLC2000 COUNT SUM_HA % CLC2000 COUNT SUM_HA %<br />
3211 25 5.334,16 4,60 3112 78 51.961,68 44,81<br />
3212 19 3.548,38 3,06 3113 10 4.197,75 3,62<br />
area totale 8.882,54 7,66 3115 27 18.132,48 15,64<br />
3116 2 32,26 0,03<br />
3117 2 27,95 0,02<br />
CLC2000 COUNT SUM_HA % 3121 2 49,05 0,04<br />
322 26 4.116,58 3,55 3122 7 113,96 0,10<br />
324 31 6.145,88 5,30 3123 3 243,05 0,21<br />
area totale 10.262,46 8,85 31312 6 256,11 0,22<br />
31315 1 47,40 0,04<br />
31321 1 124,65 0,11<br />
31322 2 46,95 0,04<br />
31323 6 247,48 0,21<br />
area totale 75.480,78 65,09<br />
Lo studio multitemporale 1990-2000 (Tabella 18) ha evidenziato un cambiamento di entità poco<br />
significativa. Le categorie di copertura del suolo trasformate sono: la classe 243 relativa alle aree<br />
prevalentemente occupate da colture agrarie e con presenza di spazi naturali importati, che si è<br />
trasformata a vantaggio delle superfici artificiali, soprattutto delle zone residenziali a tessuto<br />
discontinuo (112); la 311, da bosco di latifoglie verso aree comunque a vegetazione arborea e<br />
arbustiva in evoluzione (324); infine dei seminativi (211) trasformati anch’essi nella classe 112.<br />
Tabella 18 - Cambiamento uso del suolo 1990-2000<br />
CLC90 CLC2000 SUPERFICIE (ha)<br />
311 324 25,87<br />
243 112 26,19<br />
243 121 5,73<br />
211 121 5,04<br />
243 112 14,29<br />
52
3.1.2 Bioclimi e serie di vegetazione<br />
I bioclimi più rappresentati nell’area campione dell’Alto Molise sono il Temperato oceanico<br />
semicontinentale e il Temperato oceanico semicontinentale di transizione che complessivamente<br />
occupano circa l’85% della superficie della cella, seguiti dal Temperato. oceanico che ne ricopre<br />
circa il 17% (Figura 24, Tabella 19).<br />
Il primo, localizzato nelle prealpi centrali ed orientali, in zone collinari del medio adriatico e valli<br />
interne di tutto l’appennino fino alla Basilicata ad esposizione tirrenica, presenta tipi climatici<br />
variabili da supratemperato/orotemperato iperumido-ultraiperumido a mesotemperato umido<br />
subumido. Nel secondo, ubicato nelle pianure e nei contrafforti collinari del medio-basso adriatico e<br />
ionico, i tipi climatici variano da supratemperato umido-subumido a mesomediterraneo umidosubumido.<br />
Copertura %<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
Bioclimi nella cella 559 dell'Alto Molise<br />
7,81<br />
0,24<br />
bioclima 33<br />
48,17<br />
bioclima 42<br />
26,55<br />
bioclima 31<br />
16,96<br />
0,27<br />
Figura 24 - Estensione dei bioclimi nella cella 559 dell’Alto Molise<br />
33 - Temperato oceanicosemicontinentale<br />
42 - Temperato oceanicosemicontinentale<br />
di<br />
transizione<br />
31 - Temperato oceanico<br />
41 - Temperato oceanico di<br />
transizione<br />
11 - Mediterraneo oceanico<br />
21 - Mediterraneo oceanico<br />
di transizione<br />
Il Temperato oceanico invece è tipico di tutto l’arco alpino, appenninico ad alta e media quota e<br />
della Sicilia ad alte quote; qui i tipi climatici variano da criorotemperato ultraiperumido-iperumido a<br />
mesotemperato iperumido-umido.<br />
53
Tabella 19 - Estensione dei bioclimi nella cella 559 dell’Alto Molise<br />
BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA<br />
33 - Temperato oceanico-semicontinentale 55.857,43<br />
42 - Temperato oceanico-semicontinentale di transizione 30.783,16<br />
31 - Temperato oceanico 19.669,01<br />
41 - Temperato oceanico di transizione 9.058,06<br />
11 - Mediterraneo oceanico 309,36<br />
21 - Mediterraneo oceanico di transizione 283,21<br />
area cella 115.960,23<br />
Nella successiva Tabella 20 sono invece riportati per ciascuna serie di vegetazione presente<br />
nell’area campione il numero dei poligoni (COUNT) che la costituiscono, l’estensione totale in ettari<br />
(SUM_HA) e percentuale (%) calcolata rispetto alla superficie della cella stessa.<br />
Daphno laureolae-Quercetum cerris è la serie di vegetazione più diffusa, occupa infatti il 34,1%<br />
della sua superficie. Si tratta di una serie mesofila del cerro che ricopre un’ampia area nel settore<br />
centrale del Molise e la cui tappa matura è costituita da boschi con Quercus cerris dominante<br />
consociato con Q. pubescens, Ostrya carpinifolia e Fraxinus ornus.<br />
Seguono la serie Anemono apenninae-Fagetum sylvaticae e la Geranio versicoloris-Fagion<br />
sylvaticae che occupano l’una circa 26.000 ettari, l’altra circa 21.000 ettari. La serie sud-appenninica<br />
delle faggete termofile, distribuita sul Matese e altri ambiti montuosi, è caratterizzata da Fagus<br />
sylvatica e Ilex aquifolium e risulta sicuramente ridotta in estensione rispetto alla sua potenzialità,; la<br />
riduzione della pressione esercitata princiapalmente dallo sfruttamento silvo-pastorale può favorire<br />
un suo ampliamento. La serie centro-sud appenninica delle cerrete mesofile meso-supratemperate è<br />
essenzialmente localizzata proprio nell’Alto Molise. Si tratta di cerrete miste mesofile, legate alla<br />
fascia submontana in prossimità delle faggete.<br />
54
Tabella 20 - Copertura delle serie nell’area campione dell’Alto Molise, cella 559 di Castelverrino (IS)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 27 - Serie centro-sudappenninica dei boschi submontani neutro-basifili di cerro e roverella<br />
(Daphno laureolae-Quercetum cerris) 29<br />
6 39544,18 34,10<br />
2 18 - a: Serie sud-appenninica delle faggete termofile (Anemono apenninae-Fagetum sylvaticae) 6 26141,02 22,54<br />
3 19 - Serie centro-sud appenninica delle cerrete mesofile meso-supratemperate (Geranio<br />
versicoloris-Fagion sylvaticae)<br />
4 21091,07 18,19<br />
4 25 - b: Serie dei boschi misti submontani a dominanza di carpino nero e cerro (Laburno-<br />
Ostryenion)<br />
3 10737,74 9,26<br />
5 48 - a: Serie centro-sud-appenninica dei boschi di cerro e farnetto (Echinopo siculi-Quercetum<br />
frainetto)<br />
2 8799,63 7,59<br />
6 58 - a: Serie appenninica centro-meridionale submediterranea e mesomediterranea neutrobasifila<br />
della roverella (Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis)<br />
3 3591,90 3,10<br />
7 8 - Serie centro-appenninica delle faggete neutrobasifile microterme (Cardamino kitaibeli-<br />
Fagetum sylvaticae)<br />
4 2005,22 1,73<br />
8 42 - a: Serie delle cerrete mesofile dei depositi piroclastici (Coronillo emeri-Quercetum cerris)<br />
dell'Italia centrale<br />
2 1670,14 1,44<br />
9 25 - a: Serie centro-appenninica neutrobasifila dei boschi misti submontani (Melittto-Ostryetum<br />
capinifoliae)<br />
1 1122,59 0,97<br />
10 87 - a: Geosigmeto centro-appenninico delle conche intermontane (Carpinion betuli, Cytiso-<br />
Quercenion, Laburno-Ostryenion)<br />
1 616,29 0,53<br />
11 90 - a: Geosigmeto di vegetazione dulcacquicola idrofitica ed elofitica (Charetea fragilis,<br />
Lemnetea minoris, Nymphaeion, Potamion pectinati, Magnocaricion elatae, Phragmition<br />
australis, Populion albae)<br />
1 394,41 0,34<br />
12 89 - Geosigmeto ripariale e dei fondovalle alluvionali (Salicion albae, Populion albae, Alno-<br />
Ulmion, Carpinion betuli, Teucrio siculi-Quercion cerris)<br />
1 246,78 0,21<br />
area totale cella 559 115960,96<br />
29 Per semplificare il riconoscimento della tappa matura si è scelto di utilizzare il riferimento sintassonomico relativo all’associazione e non il riferimento previsto dal<br />
Codice di Nomenclatura fitosociologica per il quale si dovrebbe riportare Daphno laureolae – Querceto cerris sigmetum.<br />
55
3.2 Analisi della eterogeneità territoriale a scala nazionale<br />
3.2.1 Copertura del suolo in Italia<br />
La cartografia CORINE Land Cover all’anno 2000 indica che il territorio italiano, che si estende per<br />
oltre 30 milioni di ettari, è costituito per 15,7 milioni di ettari da ambiti agricoli, per 12,8 milioni da<br />
ambiti boscati e semi-naturali e 1,4 milioni da superfici artificiali (Tabella 21).<br />
Tabella 21 - Estensione in ettari e % delle categorie CLC2000 I livello<br />
Codice CLC - I livello<br />
NUM<br />
CLC2000<br />
SUP (ha) COP (%)<br />
1. Superfici artificiali 16.022 1.434.441 4,63<br />
2. Superfici agricole utilizzate 51.687 15.692.901 50,65<br />
3. Territori boscati e ambienti seminaturali 46.884 12.812.095 41,35<br />
4. Zone umide 348 69.196 0,22<br />
5. Corpi idrici 711 974.746 3,15<br />
Se lo strato tematico CLC2000 è letto in modo funzionale ad una rappresentazione del paesaggio in<br />
piccola scala, si evidenziano in effetti due configurazioni strutturali dominanti: una matrice agricola<br />
(55% della superficie totale) e una matrice a boschi e ambienti seminaturali (40% della superficie).<br />
La prima, più presente nelle morfologie piane, costituisce oltre la metà di quelle collinari; la<br />
seconda rappresenta il tessuto connettivo dell’ossatura montuosa della penisola italiana (Barbati et<br />
al., 2004).<br />
La transizione tra i due sistemi è rappresentata da una matrice paesistica a carattere misto,<br />
localizzata prevalentemente nelle zone di rottura morfologica o in prossimità di limiti altitudinali,<br />
dove le tessere appartenenti a diversi usi del suolo (Forman et Godron, 1986) sono distribuite in<br />
modo composito, senza cioè che alcuna abbia assunto un ruolo prevalente nelle dinamiche<br />
territoriali.<br />
Osserviamo il cambiamento del territorio in termini di uso del suolo tra il 1990 e il 2000 in Tabella<br />
22. Per ogni codice CLC sono riportati per gli anni 1990 e 2000 il numero dei poligoni (COUNT),<br />
la superficie complessiva della classe in ettari (SUM_HA) e l’entità del cambiamento osservato fra<br />
il 1990 e il 2000 (Change 1990-2000), espressa come differenza della superficie, in ettari e<br />
percentuale.<br />
Al I livello gerarchico di classificazione emerge un incremento areale delle categorie 1. Superfici<br />
artificiali e 3. Territori boscati e ambienti seminaturali: le aree urbane aumentano di oltre 82.000<br />
ettari come pure i boschi e gli altri ambienti seminaturali per circa 60.000 ettari.<br />
Si osserva inoltre un decremento significativo e complementare della categoria 2. Superfici agricole<br />
utilizzate, con oltre 143.000 ettari perduti. L’abbandono colturale delle aree agricole e pastorali<br />
continua infatti a essere una delle principali driving force delle dinamiche paesaggistiche in Italia<br />
(Maricchiolo et al., 2004).<br />
56
Tabella 22 - Sintesi del cambiamento osservato al I livello gerarchico degli strati CLC90 e<br />
CLC2000.<br />
Codice CLC<br />
I livello<br />
CLC90 CLC2000<br />
COUNT SUM_HA COUNT SUM_HA<br />
Change<br />
1990-2000<br />
(ha)<br />
Change<br />
1990-2000<br />
(%)<br />
1. Superfici artificiali 15.200 1.351.638 16.022 1.434.441 82.803 0,27<br />
2. Superfici agricole 51.375 15.836.395 51.687 15.692.901 -143.494 -0,46<br />
3. Territori boscati e<br />
amb. seminaturali<br />
46.964 12.752.332 46.884 12.812.095 59.763 0,19<br />
4. Zone umide 342 69.185 348 69.196 11 0,00<br />
5. Corpi idrici 691 977.250 711 974.746 -2.504 -0,01<br />
Osserviamo il cambiamento analizzando le classi di uso del suolo al III livello gerarchico del<br />
CLC90 e CLC2000 nelle Tabelle 23, 24, 25 e 26 (Maricchiolo et al., 2004)).<br />
Per ogni codice di uso/copertura del suolo sono riportati per gli anni 1990 e 2000 il numero dei<br />
poligoni (NUM), la superficie complessiva della classe in ettari (SUP), la copertura percentuale<br />
(COP) rispetto alla superficie nazionale e l’entità del cambiamento osservato fra il 1990 e il 2000,<br />
espressa come differenza delle coperture percentuali.<br />
Il decremento delle superfici agricole si esprime nei valori negativi di copertura dei seminativi in<br />
aree non irrigue (211), dei frutteti (222), degli oliveti (223), dei prati stabili (231), delle colture<br />
temporanee associate a colture permanenti (241), dei sistemi colturali e particellari complessi (242),<br />
delle colture agrarie (243) e delle aree agroforestali (244): ossia in tutte le voci di III livello<br />
appartenenti alla classe principale, fatta eccezione per i seminativi in aree irrigue (212), le risaie<br />
(213) e i vigneti (221). Ciò sta ad indicare un fenomeno di abbandono generalizzato della pratica<br />
agricola, piuttosto che una preferenza produttiva accordata ad alcune colture agrarie piuttosto che<br />
ad altre (Tabella 24).<br />
L’altra principale voce di cambiamento, rappresentata dai territori boscati ed altri ambienti<br />
seminaturali (Tabella 25)., si esprime meno omogeneamente nel III livello e vede da un lato la<br />
diminuzione dello 0,10% per le aree a pascolo e praterie naturali (321) e dello 0,15% per le aree a<br />
vegetazione arboreo-arbustiva in evoluzione (324), dall’altro un aumento significativo dei boschi<br />
(311+312+313), pari complessivamente allo 0,27% e delle aree a vegetazione sclerofilla, per lo<br />
0,16%<br />
Si osserva che l’incremento di superficie delle aree a vegetazione sclerofilla compete con quello<br />
relativo ai soli boschi di latifoglie (311), cresciuti dello 0,19% e che vi è un decremento delle<br />
categorie prative e pascolive, comune alle classi principali delle superfici agricole (231 Prati stabili)<br />
e di quelle boscate e seminaturali (321 Aree a pascolo naturale e praterie).<br />
Meno soggetti al cambiamento nell’arco di tempo considerato sono le voci di legenda afferenti alle<br />
categorie 1. Superfici artificiali (Tabella 23), 4. Zone umide e 5. Corpi idrici (Tabella 26).<br />
57
Tabella 23 - Risultati del progetto I&CLC2000 in Italia per la categoria 1. Superfici artificiali<br />
Codice CLC - III liv.<br />
1. Superfici artificiali<br />
NUM<br />
CLC90<br />
SUP (ha) COP<br />
(%)<br />
CLC2000<br />
NUM SUP (ha) COP<br />
(%)<br />
Change<br />
1990<br />
2000<br />
111. Zone residenziali a<br />
tessuto continuo<br />
1.224 146.944 0.5 1.224 147.381 0.5 0.00<br />
112. Zone residenziali a<br />
tessuto discontinuo<br />
9.239 886.700 2.9 9.621 936.723 3.0 0.16<br />
121. Aree industriali,<br />
commerciali e<br />
servizi<br />
2.831 193.943 0.6 3.110 218.113 0.7 0.08<br />
122. Reti stradali, ferr. e<br />
infrastrutture<br />
196 12.498 ~0.0 217 13.456 ~0.0 0.00<br />
123. Aree portuali 126 11.189 ~0.0 130 11.379 ~0.0 0.00<br />
124. Aeroporti 90 20.635 0.1 91 20.761 0.1 0.00<br />
131. Aree estrattive 882 43.117 0.1 971 47.222 0.2 0.01<br />
132. Discariche 32 1.815 ~0.0 36 2.001 ~0.0 0.00<br />
133. Cantieri 121 6.658 ~0.0 138 7.420 ~0.0 0.00<br />
141. Aree verdi urbane 186 10.348 ~0.0 188 10.381 ~0.0 0.00<br />
142. Aree ricr. e sportive 273 17.791 0.1 296 19.604 0.1 0.01<br />
Tabella 24 - Risultati del progetto I&CLC2000 in Italia per la categoria 2. Superfici agricole<br />
Codice CLC - III liv.<br />
2. Superfici agricole<br />
NUM<br />
CLC90<br />
SUP (ha) COP<br />
(%)<br />
CLC2000<br />
NUM SUP (ha) COP<br />
(%)<br />
Change<br />
1990<br />
2000<br />
211. Seminativi aree non<br />
irrigue<br />
10.297 8.078.702 26.1 10.428 8.011.023 25.9 -0.22<br />
212. Seminativi aree<br />
irrigue<br />
13 40.819 0.1 12 40.786 0.1 0.00<br />
213. Risaie 186 276.049 0.9 196 279.838 0.9 0.01<br />
221. Vigneti 2.504 535.540 1.7 2.546 537.658 1.7 0.01<br />
222. Frutteti 1.638 399.655 1.3 1.638 397.931 1.3 -0.01<br />
223. Oliveti 4.109 1.263.888 4.1 4.123 1.254.322 4.0 -0.03<br />
231. Prati stabili 4.119 456.547 1.5 4.076 448.860 1.4 -0.02<br />
241. Colture temporanee<br />
associate a colture<br />
permanenti<br />
2.668 394.985 1.3 2.660 391.350 1.3 -0.01<br />
242. Sistemi colturali e<br />
particellari compl.<br />
10.362 2.209.517 7.1 10.481 2.196.918 7.1 -0.04<br />
243. Colture agrarie e<br />
spazi nat. imporanti<br />
14.933 1.993.097 6.4 15.016 1.954.433 6.3 -0.12<br />
244. Aree agroforestali 546 187.596 0.6 511 179.782 0.6 -0.03<br />
58
Tabella 25 - Risultati del progetto I&CLC2000 in Italia per la categoria 3. Territori boscati e<br />
ambienti seminaturali<br />
Codice CLC - III liv.<br />
3. Territori boscati e<br />
ambienti seminaturali<br />
CLC90 CLC2000<br />
NUM SUP (ha) COP<br />
(%)<br />
NUM SUP (ha) COP<br />
(%)<br />
Change<br />
1990<br />
2000<br />
311. Boschi di latifoglie 10.610 5.489.855 17.7 10.648 5.549.663 17.9 0.19<br />
312. Boschi di conifere 3.965 1.331.035 4.3 3.973 1.345.760 4.3 0.05<br />
313. Boschi misti 4.974 1.038.552 3.4 5.024 1.047.479 3.4 0.03<br />
321. Aree pascolo<br />
naturale e praterie<br />
7.137 1.464.708 4.7 7.040 1.434.692 4.6 -0.10<br />
322. Brughiere e<br />
cespuglieti<br />
2.055 276.664 0.9 2.039 276.411 0.9 0.00<br />
323. Aree a vegetazione<br />
sclerofilla<br />
3.054 962.583 3.1 3.060 1.009.769 3.3 0.15<br />
324. Veg. in evoluzione 10.358 1.014.758 3.3 10.233 969.475 3.1 -0.15<br />
331. Spiagge, dune,<br />
sabbie<br />
560 83.113 0.3 564 82.804 0.3 0.00<br />
332. Rocce nude, falesie,<br />
rupi e affioramenti<br />
1.061 520.903 1.7 1.056 520.649 1.7 0.00<br />
333. Aree con<br />
vegetazione rada<br />
2.966 497.928 1.6 2.979 498.594 1.6 0.00<br />
334. Aree incendiate 26 3.689 ~0.0 70 8.420 ~0.0 0.02<br />
335. Ghiacciai e nevi<br />
perenni<br />
198 68.544 0.2 198 68.379 0.2 0.00<br />
Tabella 26 - Risultati del progetto I&CLC2000 in Italia per le categorie 4. Zone umide e 5.<br />
Corpi idrici<br />
Codice CLC<br />
III livello<br />
NUM<br />
CLC90<br />
SUP (ha) COP<br />
(%)<br />
CLC2000<br />
NUM SUP (ha) COP<br />
(%)<br />
Change<br />
1990<br />
2000<br />
411. Paludi interne 146 15.820 0.1 150 15.875 0.1 0.00<br />
412. Torbiere 1 38 ~0.0 1 38 ~0.0 0.00<br />
421. Paludi salmastre 165 43.256 0.1 167 43.212 0.1 0.00<br />
422. Saline 30 10.071 ~0.0 30 10.071 ~0.0 0.00<br />
423. Zone intertidali 0 0 0.0 0 0 0.0 0.00<br />
511. Corsi d’acqua,<br />
canali e idrovie<br />
113 49.542 0.2 114 49.406 0.2 0.00<br />
512. Bacini d’acqua 478 168.190 0.5 498 169.386 0.5 0.00<br />
521. Lagune 60 94.697 0.3 59 94.453 0.3 0.00<br />
522. Estuari 4 251 ~0.0 4 251 ~0.0 0.00<br />
523. Mari e oceani 36 664.570 2.1 36 661.250 2.1 -0.01<br />
59
I dati CLC2000 sui boschi sono stati analizzati anche in riferimento ai territori amministrativi<br />
regionali. Nell’ultima colonna di Tabella 27 sono indicate in ordine decrescente le percentuali di<br />
copertura dei boschi rispetto al territorio nazionale.<br />
L’Italia è coperta al 26,24 % da boschi (classe 31, comprensiva delle sottoclassi 311 dei boschi di<br />
latifoglie, 312 dei boschi di conifere e 313 dei boschi misti di conifere e latifoglie). Su circa 8<br />
milioni di ettari di ambiti boscati, oltre 2,4 milioni (circa il 31%)sono concentrati in Toscana,<br />
Piemonte e Trentino. Puglia, Molise e Valle d’Aosta hanno invece i valori di copertura più bassi.<br />
Tabella 27 - Copertura dei boschi (classi 311+312+313) rispetto al territorio nazionale<br />
Regione<br />
Superficie regione 30<br />
(ha)<br />
Boschi<br />
(ha)<br />
Copertura sul territorio nazionale<br />
(%)<br />
Toscana 2.298.689,46 1.002.526,43 3,32<br />
Piemonte 2.538.863,95 787.118,44 2,61<br />
Trentino 1.360.067,43 649.102,75 2,15<br />
Lombardia 2.386.360,13 594.205,55 1,97<br />
Calabria 1.522.313,82 567.794,04 1,88<br />
Emilia Romagna 2.212.497,39 490.110,11 1,62<br />
Lazio 1.722.785,31 434.460,41 1,44<br />
Veneto 1.838.557,05 398.111,66 1,32<br />
Sardegna 2.408.692,23 388.132,59 1,29<br />
Campania 1.366.948,69 383.091,97 1,27<br />
Liguria 540.736,23 336.912,34 1,12<br />
Abruzzo 1.083.001,89 307.969,52 1,02<br />
Friuli 789.789,99 299.867,33 0,99<br />
Umbria 846.467,02 297.722,60 0,99<br />
Basilicata 1.007.326,28 295.490,78 0,98<br />
Marche 972.927,59 203.620,10 0,67<br />
Sicilia 2.583.235,56 192.421,20 0,64<br />
Puglia 1.953.796,51 110.491,44 0,37<br />
Molise 446.095,75 107.475,16 0,36<br />
Valle d'Aosta 326.088,12 77.927,760 0,26<br />
totale 30.205.240,37 7.924.552,19 26,24<br />
La regione più boscata invece rispetto alla propria superficie (Tabella 28) è la Liguria con 336.912<br />
ha su circa 540.736, seguita dal Trentino e dalla Toscana (rispettivamente 47,78 e 43,63%) che<br />
quindi risultano tra le prime tre regioni con la maggior superficie a bosco anche in questo caso.<br />
30 Fonte Istat.<br />
60
Tabella 27 - Copertura dei boschi (classi 311+312+313) rispetto al territorio regionale<br />
Regione<br />
Superficie regione<br />
(ha)<br />
Boschi<br />
(ha)<br />
Copertura sulla regione<br />
(%)<br />
Liguria 540.736,23 336.912,34 62,39<br />
Trentino 1.360.067,43 649.102,75 47,78<br />
Toscana 2.298.689,46 1.002.526,43 43,63<br />
Friuli 789.789,99 299.867,33 37,98<br />
Calabria 1.522.313,82 567.794,04 37,34<br />
Umbria 846.467,02 297.722,60 35,18<br />
Piemonte 2.538.863,95 787.118,44 31,01<br />
Basilicata 1.007.326,28 295.490,78 29,34<br />
Abruzzo 1.083.001,89 307.969,52 28,44<br />
Campania 1.366.948,69 383.091,97 28,04<br />
Lazio 1.722.785,31 434.460,41 25,23<br />
Lombardia 2.386.360,13 594.205,55 24,90<br />
Molise 446.095,75 107.475,16 24,10<br />
Valle d'Aosta 326.088,12 77.927,760 23,92<br />
Emilia Romagna 2.212.497,39 490.110,11 22,10<br />
Veneto 1.838.557,05 398.111,66 21,68<br />
Marche 972.927,59 203.620,10 20,92<br />
Sardegna 2.408.692,23 388.132,59 16,11<br />
Sicilia 2.583.235,56 192.421,20 7,45<br />
Puglia 1.953.796,51 110.491,44 5,65<br />
totale 30.205.240,37 7.924.552,19 -<br />
61
3.2.2 Bioclimi e classi CLC<br />
3.2.2.1 - Bioclimi e classi CLC2000 al I livello gerarchico<br />
Nelle tabelle 27 e 28 sono riportati i risultati dell’intersezione cartografica tra il tematismo dei nove bioclimi (Blasi, 2004; Blasi et al.,<br />
2005), in ordine decrescente di estensione nel grafico e nella legenda di Figura 25, e quello del CORINE Land Cover 2000.<br />
superficie in ha<br />
7.000.000<br />
6.000.000<br />
5.000.000<br />
4.000.000<br />
3.000.000<br />
2.000.000<br />
1.000.000<br />
0<br />
Figura 25 - Estensione nel territorio italiano dei nove bioclimi<br />
6.113.640<br />
4.870.417<br />
4.109.217<br />
3.447.420<br />
3.004.752<br />
2.781.637<br />
bioclimi<br />
2.718.872<br />
1.611.239 1.551.615<br />
11 Mediterraneo<br />
oceanico<br />
33 Temperato oceanicosemicontinentale<br />
31 Temperato oceanico<br />
34 Temperato<br />
subcontinentale<br />
35 Temperato<br />
semicontinentalesubcontinentale<br />
42 Temperato oceanicosemicontinentale<br />
di<br />
transizione<br />
21 Mediterraneo<br />
oceanico di transizione<br />
32 Temperato<br />
semicontinentale<br />
41 Temperato oceanico<br />
di transizione<br />
62
Tabella 27 – Copertura delle classi CLC di I livello nei bioclimi italiani<br />
Le superfici agricole sono gli usi del suolo decisamente dominanti nel bioclima Mediterraneo oceanico (74,4%) e nel Temperato<br />
subcontinentale (81,7%) e molto ben rappresentate anche nel Temperato semicontinentale-sbucontinentale (60,5%) e nel Temperato<br />
oceanico semicontinentale di transizione (64,7%).<br />
La categoria 3 comprendente le superfici boscate e gli ambienti seminaturali è invece dominante nel bioclima Temperato oceanico<br />
(91,3%) ed è significativamente estesa nel bioclima Temperato semicontinentale (65,1%) e nel Temperato oceanico di transizione<br />
(64,9%).<br />
63
Tabella 28 – Copertura delle classi CLC di I livello nei bioclimi italiani<br />
64
3.2.2.2 - Bioclimi e classi forestali CLC2000 al III e IV-V livello gerarchico<br />
Nelle tabelle e nei grafici a seguire sono analizzate in ciascun bioclima le classi di uso del suolo appartenenti alla categoria 3 del CLC.<br />
In particolare sono approfondite le classi di maggior interesse in relazione agli obiettivi di Kyoto: in particolare quelle forestali (voci<br />
di legenda 31 corrispondenti ai boschi, fino al IV-V livello) e quelle legati ad ambiti di prato-pascolo o in rivegetazione (321, 322,<br />
323, ecc; in colore azzurro).<br />
In Figura 26 il grafico tridimensionale sintetizza la presenza di queste classi (asse x), con il valore della superficie coperta in valore<br />
percentuale (asse z) all’interno dei bioclimi (asse y). Le superfici boscate e gli ambienti seminaturali che dominano, come detto, nel<br />
bioclima Temperato oceanico (Tabella 27) si si esprimono maggiormente nelle classi 311 dei boschi di latifoglie, 321 delle aree a<br />
pascolo naturale e praterie e 312 dei boschi di conifere. Nel bioclima Temperato semicontinentale (Tabella 28) sono estesi i boschi di<br />
conifere, ma prevalgono nettamente le formazioni boscate di latifoglie. Queste sono altrettanto sviluppate nel bioclima Temperato<br />
oceanico di transizione (Tabella 28) in cui sono più rappresentate anche le classi relative al prato-pascolo e alle zone a vegetazione<br />
sclerofilla. I boschi di latifoglie coprono aree di dimensioni anche maggiori negli altri bioclimi legati alla Regione Temperata. Nei due<br />
bioclimi della Regione Mediterranea le classi di uso del suolo più estese sono quelle relative alle aree a sclerofille.<br />
Nelle tabelle da 28 a 36 sono riportati in dettaglio i valori percentuali di copertura delle classi, mentre negli istogrammi (in cui le<br />
colonne 31 corrispondenti ai boschi sono colorate in verde e quelle relative alle voci di rivegetazione sono in azzurro) delle figure da<br />
27 a 35 è indicato in centinaia di ettari. E’ bene precisare che - per esigenze legate al tipo di visualizzazione grafica - negli<br />
istogrammi alcuni voci di legenda possono non comparire come descrizione sull’asse delle x pur essendo presenti in tabella.<br />
65
Figura 26 - Copertura cat. 3. Territori boscati e ambienti seminaturali nei bioclimi<br />
66
Tabella 28 - Fisionomie forestali nel Bioclima 11 – Mediterraneo Oceanico<br />
CLC III liv. Descrizione %<br />
311 Boschi di latifoglie<br />
18,56<br />
312 Boschi di conifere<br />
6,95<br />
313 Boschi misti di conifere e latifoglie<br />
3,90<br />
321 Aree a pascolo naturale e praterie<br />
19,03<br />
322 Brughiere e cespuglieti<br />
7,03<br />
323 Aree a vegetazione sclerofilla<br />
39,65<br />
331 Spiagge, dune e sabbie 0,72<br />
332 Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti<br />
4,17<br />
CLC IV-V Descrizione %<br />
3111 Boschi a prevalenza di leccio e/o sughera<br />
10,45<br />
3112 Boschi a prevalenza di querce caducifoglie (cerro e/o roverella<br />
e/o farnetto e/o rovere e/o farnia)<br />
5,06<br />
3113 Boschi misti a prevalenza di latifoglie mesofile e<br />
0,45<br />
3114<br />
mesotermofile (acero-frassino, carpino nero-orniello)<br />
Boschi a prevalenza di castagno<br />
0,37<br />
3115 Boschi a prevalenza di faggio<br />
0,15<br />
3116 Boschi a prevalenza di specie igrofile (boschi a prevalenza di<br />
salici e/o pioppi e/o ontani, ecc.)<br />
0,45<br />
3117 Boschi e piantagioni a prevalenza di latifoglie non native 1,63<br />
3121 Boschi a prevalenza di pini mediterranei e cipressete<br />
6,58<br />
3122 Boschi a prevalenza di pini montani e oromediterranei (pino<br />
nero e laricio, pino silvestre, pino loricato)<br />
0,17<br />
3125 Boschi e piantagioni a prevalenza di conifere non native 0,19<br />
3211 Praterie continue<br />
14,43<br />
3212 Praterie discontinue<br />
4,60<br />
3231 Macchia alta 6,60<br />
3232 Macchia bassa e garighe<br />
33,05<br />
31311 Boschi misti a prevalenza di leccio 1,28<br />
31312 Boschi misti a prevalenza di querce caducifoglie 0,44<br />
31314 Boschi misti a prevalenza di castagno 0,04<br />
31315 Boschi misti a prevalenza di faggio 0,03<br />
31321 Boschi misti a prevalenza di pini mediterranei 1,96<br />
31322 Boschi misti a prevalenza di pini montani e/ooromediterranei 0,14<br />
67
Figura 26 - Fisionomie forestali nel Bioclima 11 – Mediterraneo Oceanico<br />
Superficie in centinaia di ettari<br />
3500<br />
3000<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
655<br />
Brughiere e<br />
cespuglieti<br />
67<br />
389<br />
Rocce nude,<br />
falesie, rupi,<br />
affioramenti<br />
974<br />
471<br />
Boschi a<br />
prevalenza di<br />
querce<br />
42 34 14 42<br />
Boschi a<br />
prevalenza di<br />
castagno<br />
Boschi a<br />
prevalenza di<br />
specie igrofile<br />
152<br />
614<br />
Boschi a<br />
prevalenza di pini<br />
mediterranei e<br />
16 18<br />
Boschi e<br />
piantagioni a<br />
prevalenza di<br />
Fisionomie forestali<br />
1345<br />
428<br />
Praterie<br />
discontinue<br />
615<br />
3080<br />
Macchia bassa e<br />
garighe<br />
120<br />
41 4 3<br />
Boschi misti a<br />
prevalenza di<br />
querce<br />
Boschi misti a<br />
prevalenza di<br />
faggio<br />
182<br />
13<br />
Boschi misti a<br />
prevalenza di pini<br />
montani e/o<br />
68
Tabella 29 - Fisionomie forestali nel Bioclima 21 – Mediterraneo Oceanico di Transizione<br />
CLC III liv. Descrizione %<br />
311 Boschi di latifoglie<br />
312 Boschi di conifere<br />
313 Boschi misti di conifere e latifoglie<br />
321 Aree a pascolo naturale e praterie<br />
322 Brughiere e cespuglieti<br />
323 Aree a vegetazione sclerofilla<br />
331 Spiagge, dune e sabbie<br />
332 Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti<br />
37,03<br />
3,97<br />
5,49<br />
12,38<br />
2,03<br />
38,44<br />
0,20<br />
0,45<br />
CLC IV-V Descrizione %<br />
3111 Boschi a prevalenza di leccio e/o sughera<br />
21,62<br />
3112 Boschi a prevalenza di querce caducifoglie (cerro e/o roverella<br />
e/o farnetto e/o rovere e/o farnia)<br />
12,30<br />
3113 Boschi misti a prevalenza di latifoglie mesofile e mesotermofile<br />
(acero-frassino, carpino nero-orniello)<br />
1,13<br />
3114 Boschi a prevalenza di castagno 0,88<br />
3115 Boschi a prevalenza di faggio<br />
0,08<br />
3116 Boschi a prevalenza di specie igrofile (boschi a prevalenza di<br />
salici e/o pioppi e/o ontani, ecc.)<br />
0,80<br />
3117 Boschi e piantagioni a prevalenza di latifoglie non native 0,20<br />
3121 Boschi a prevalenza di pini mediterranei e cipressete<br />
3,78<br />
3122 Boschi a prevalenza di pini montani e oromediterranei (pino nero<br />
e laricio, pino silvestre, pino loricato)<br />
0,16<br />
3125 Boschi e piantagioni a prevalenza di conifere non native<br />
0,04<br />
3211 Praterie continue<br />
7,96<br />
3212 Praterie discontinue<br />
4,42<br />
3231 Macchia alta 6,94<br />
3232 Macchia bassa e garighe<br />
31,50<br />
31311 Boschi misti a prevalenza di leccio 2,22<br />
31312 Boschi misti a prevalenza di querce caducifoglie 0,45<br />
31313 Boschi misti a prevalenza di latifoglie mesofile 0,04<br />
31314 Boschi misti a prevalenza di castagno 0,03<br />
31316 Boschi misti a prevalenza di specie igrofile 0,01<br />
31317 Boschi misti a prevalenza di latifoglie non native 0,01<br />
31321 Boschi misti a prevalenza di pini mediterranei 2,58<br />
31322 Boschi misti a prevalenza di pini montani e/o oromediterranei 0,15<br />
69
Figura 27 - Fisionomie forestali nel Bioclima 21 – Mediterraneo Oceanico di Transizione<br />
Superficie in centinaia di ettari<br />
3500<br />
3000<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
207<br />
Brughiere e<br />
cespuglieti<br />
20 46<br />
Rocce nude,<br />
falesie, rupi,<br />
affioramenti<br />
2206<br />
1255<br />
Boschi a<br />
prevalenza di<br />
querce<br />
116 90<br />
Boschi a<br />
prevalenza di<br />
castagno<br />
8<br />
82<br />
Boschi a<br />
prevalenza di<br />
specie igrofile<br />
21<br />
385<br />
Boschi a<br />
prevalenza di pini<br />
mediterranei e<br />
16 4<br />
Boschi e<br />
piantagioni a<br />
prevalenza di<br />
812<br />
451<br />
Praterie<br />
discontinue<br />
Fisionomie forestali<br />
708<br />
3214<br />
Macchia bassa e<br />
garighe<br />
227<br />
46<br />
Boschi misti a<br />
prevalenza di<br />
querce<br />
4 3 0 1 1<br />
Boschi misti a<br />
prevalenza di<br />
castagno<br />
Boschi misti a<br />
prevalenza di<br />
specie igrofile<br />
263<br />
Boschi misti a<br />
prevalenza di pini<br />
mediterranei<br />
70<br />
16
Tabella 30 - Fisionomie forestali nel Bioclima 31 – Temperato Oceanico<br />
CLC III liv. Descrizione %<br />
311 Boschi di latifoglie<br />
28,59<br />
312 Boschi di conifere<br />
18,95<br />
313 Boschi misti di conifere e latifoglie<br />
6,64<br />
321 Aree a pascolo naturale e praterie<br />
23,18<br />
322 Brughiere e cespuglieti<br />
7,55<br />
323 Aree a vegetazione sclerofilla<br />
0,85<br />
331 Spiagge, dune e sabbie<br />
0,05<br />
332 Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti<br />
12,87<br />
335 Ghiacci e nevi perenni 1,32<br />
CLC IV-V Descrizione %<br />
3111 Boschi a prevalenza di leccio e/o sughera<br />
1,11<br />
3112 Boschi a prevalenza di querce caducifoglie (cerro e/o roverella<br />
e/o farnetto e/o rovere e/o farnia)<br />
7,12<br />
3113 Boschi misti a prevalenza di latifoglie mesofile e mesotermofile<br />
(acero-frassino, carpino nero-orniello)<br />
3,50<br />
3114 Boschi a prevalenza di castagno<br />
4,82<br />
3115 Boschi a prevalenza di faggio<br />
11,97<br />
3116 Boschi a prevalenza di specie igrofile (boschi a prevalenza di<br />
salici e/o pioppi e/o ontani, ecc.) )<br />
0,03<br />
3117 Boschi e piantagioni a prevalenza di latifoglie non native 0,03<br />
3121 Boschi a prevalenza di pini mediterranei e cipressete<br />
0,15<br />
3122 Boschi a prevalenza di pini montani e oromediterranei (pino nero<br />
e laricio, pino silvestre, pino loricato)<br />
2,91<br />
3123 Boschi di abete bianco e/o abete rosso 9,36<br />
3124 Boschi di larice e/o pino cembro 6,45<br />
3125 Boschi e piantagioni a prevalenza di conifere non native 0,07<br />
3211 Praterie continue<br />
5,92<br />
3212 Praterie discontinue<br />
17,26<br />
3231 Macchia alta 0,20<br />
3232 Macchia bassa e garighe<br />
0,65<br />
31311 Boschi misti a prevalenza di leccio 0,04<br />
31312 Boschi misti a prevalenza di querce caducifoglie 0,36<br />
31313 Boschi misti a prevalenza di latifoglie mesofile 0,40<br />
31314 Boschi misti a prevalenza di castagno 0,49<br />
31315 Boschi misti a prevalenza di faggio 1,63<br />
31316 Boschi misti a prevalenza di specie igrofile 0,01<br />
31317 Boschi misti a prevalenza di latifoglie non native 0,02<br />
31321 Boschi misti a prevalenza di pini mediterranei 0,06<br />
31322 Boschi misti a prevalenza di pini montani e/o oromediterranei 1,49<br />
31323 Boschi misti a prevalenza di abete bianco e/o abete rosso 1,26<br />
31324 Boschi misti a prevalenza di larice e/o pino cembro 0,88<br />
71
Figura 28 - Fisionomie forestali nel Bioclima 31 – Temperato Oceanico<br />
Superficie in centinaia di ettari<br />
7000<br />
6000<br />
5000<br />
4000<br />
3000<br />
2000<br />
1000<br />
0<br />
Aree a pascolo<br />
naturale e praterie<br />
2831<br />
18<br />
4828<br />
Rocce nude,<br />
falesie, rupi,<br />
affioramenti<br />
496 418<br />
2672<br />
Boschi a<br />
prevalenza di<br />
querce<br />
1313<br />
1807<br />
4488<br />
Boschi a<br />
prevalenza di<br />
faggio<br />
58<br />
Boschi a<br />
prevalenza di pini<br />
mediterranei e<br />
1092<br />
3511<br />
2417<br />
Boschi di larice<br />
e/o pino cembro<br />
2220<br />
6472<br />
27 75 244 149 183<br />
Praterie<br />
discontinue<br />
Fisionomie forestali<br />
Boschi misti a<br />
prevalenza di<br />
leccio<br />
Boschi misti a<br />
prevalenza di<br />
castagno<br />
611<br />
2<br />
Boschi misti a<br />
prevalenza di<br />
latifoglie non<br />
558 472 330<br />
Boschi misti a<br />
prevalenza di<br />
abete bianco e/o<br />
72<br />
9
Tabella 31 - Fisionomie forestali nel Bioclima 32 – Temperato semicontinentale<br />
CLC - III liv. Descrizione %<br />
311 Boschi di latifoglie<br />
50,23<br />
312 Boschi di conifere<br />
20,82<br />
313 Boschi misti di conifere e latifoglie<br />
9,08<br />
321 Aree a pascolo naturale e praterie<br />
12,25<br />
322 Brughiere e cespuglieti<br />
4,70<br />
323 Aree a vegetazione sclerofilla<br />
0,37<br />
331 Spiagge, dune e sabbie<br />
0,34<br />
332 Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti<br />
2,20<br />
CLC -IV-V Descrizione %<br />
3111 Boschi a prevalenza di leccio e/o sughera<br />
0,42<br />
3112 Boschi a prevalenza di querce caducifoglie (cerro e/o roverella<br />
e/o farnetto e/o rovere e/o farnia)<br />
14,61<br />
3113 Boschi misti a prevalenza di latifoglie mesofile e mesotermofile<br />
(acero-frassino, carpino nero-orniello)<br />
9,78<br />
3114 Boschi a prevalenza di castagno<br />
15,21<br />
3115 Boschi a prevalenza di faggio 8,53<br />
3116 Boschi a prevalenza di specie igrofile (boschi a prevalenza di<br />
salici e/o pioppi e/o ontani, ecc.)<br />
0,26<br />
3117 Boschi e piantagioni a prevalenza di latifoglie non native 1,44<br />
3121 Boschi a prevalenza di pini mediterranei e cipressete<br />
0,38<br />
3122 Boschi a prevalenza di pini montani e oromediterranei (pino nero<br />
e laricio, pino silvestre, pino loricato)<br />
4,95<br />
3123 Boschi di abete bianco e/o abete rosso 9,41<br />
3124 Boschi di larice e/o pino cembro 6,07<br />
3125 Boschi e piantagioni a prevalenza di conifere non native 0,01<br />
3211 Praterie continue<br />
2,26<br />
3212 Praterie discontinue<br />
9,99<br />
3231 Macchia alta 0,16<br />
3232 Macchia bassa e garighe<br />
0,21<br />
31311 Boschi misti a prevalenza di leccio 0,01<br />
31312 Boschi misti a prevalenza di querce caducifoglie 1,22<br />
31313 Boschi misti a prevalenza di latifoglie mesofile 1,75<br />
31314 Boschi misti a prevalenza di castagno 2,06<br />
31315 Boschi misti a prevalenza di faggio 0,92<br />
31316 Boschi misti a prevalenza di specie igrofile 0,00<br />
31317 Boschi misti a prevalenza di latifoglie non native 0,15<br />
31321 Boschi misti a prevalenza di pini mediterranei 0,11<br />
31322 Boschi misti a prevalenza di pini montani e/o oromediterranei 1,92<br />
31323 Boschi misti a prevalenza di abete bianco e/o abete rosso 0,54<br />
31324 Boschi misti a prevalenza di larice e/o pino cembro 0,38<br />
31325 Boschi misti a prevalenza di conifere non native 0,02<br />
73
Figura 29 - Fisionomie forestali nel Bioclima 32 – Temperato semicontinentale<br />
Superficie in centinaia di ettari<br />
1800<br />
1600<br />
1400<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
483<br />
Brughiere e<br />
cespuglieti<br />
35<br />
226<br />
43<br />
Boschi a<br />
prevalenza di<br />
leccio e/o sughera<br />
1500<br />
1004<br />
1562<br />
Boschi a<br />
prevalenza di<br />
castagno<br />
876<br />
26<br />
148<br />
Boschi e<br />
piantagioni a<br />
prevalenza di<br />
39<br />
509<br />
966<br />
Boschi di abete<br />
bianco e/o abete<br />
rosso<br />
623<br />
232<br />
1026<br />
Praterie<br />
discontinue<br />
16 21 1<br />
Fisionomie forestali<br />
Boschi misti a<br />
prevalenza di<br />
leccio<br />
125<br />
179 212<br />
Boschi misti a<br />
prevalenza di<br />
castagno<br />
94<br />
0 15 11<br />
Boschi misti a<br />
prevalenza di<br />
latifoglie non<br />
197<br />
55 39<br />
Boschi misti a<br />
prevalenza di<br />
abete bianco e/o<br />
2<br />
74
Tabella 32 - Fisionomie forestali nel Bioclima 33 – Temperato oceanico-semicontinentale<br />
CLC - III liv. Descrizione %<br />
311 Boschi di latifoglie<br />
62,61<br />
312 Boschi di conifere<br />
7,31<br />
313 Boschi misti di conifere e latifoglie<br />
12,80<br />
321 Aree a pascolo naturale e praterie<br />
10,11<br />
322 Brughiere e cespuglieti<br />
5,16<br />
323 Aree a vegetazione sclerofilla<br />
1,23<br />
331 Spiagge, dune e sabbie<br />
0,18<br />
332 Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti<br />
0,60<br />
CLC IV-V Descrizione %<br />
3111 Boschi a prevalenza di leccio e/o sughera<br />
3,87<br />
3112 Boschi a prevalenza di querce caducifoglie (cerro e/o roverella<br />
e/o farnetto e/o rovere e/o farnia)<br />
28,32<br />
3113 Boschi misti a prevalenza di latifoglie mesofile e<br />
8,73<br />
3114<br />
mesotermofile (acero-frassino, carpino nero-orniello)<br />
Boschi a prevalenza di castagno<br />
7,39<br />
3115 Boschi a prevalenza di faggio<br />
13,46<br />
3116 Boschi a prevalenza di specie igrofile (boschi a prevalenza di<br />
salici e/o pioppi e/o ontani, ecc.) (ove risolvibili<br />
cartograficamente<br />
0,72<br />
3117 Boschi e piantagioni a prevalenza di latifoglie non native 0,13<br />
3121 Boschi a prevalenza di pini mediterranei e cipressete<br />
0,87<br />
3122 Boschi a prevalenza di pini montani e oromediterranei (pino<br />
nero e laricio, pino silvestre, pino loricato)<br />
1,29<br />
3123 Boschi di abete bianco e/o abete rosso 4,72<br />
3124 Boschi di larice e/o pino cembro 0,36<br />
3125 Boschi e piantagioni a prevalenza di conifere non native 0,07<br />
3211 Praterie continue<br />
5,59<br />
3212 Praterie discontinue<br />
4,52<br />
3231 Macchia alta 0,60<br />
3232 Macchia bassa e garighe<br />
0,63<br />
31311 Boschi misti a prevalenza di leccio 0,20<br />
31312 Boschi misti a prevalenza di querce caducifoglie 1,27<br />
31313 Boschi misti a prevalenza di latifoglie mesofile 1,10<br />
31314 Boschi misti a prevalenza di castagno 0,48<br />
31315 Boschi misti a prevalenza di faggio 2,97<br />
31316 Boschi misti a prevalenza di specie igrofile 0,01<br />
31317 Boschi misti a prevalenza di latifoglie non native 0,05<br />
31321 Boschi misti a prevalenza di pini mediterranei 1,02<br />
31322 Boschi misti a prevalenza di pini montani e/o oromediterranei 2,22<br />
31323 Boschi misti a prevalenza di abete bianco e/o abete rosso 3,18<br />
31324 Boschi misti a prevalenza di larice e/o pino cembro 0,24<br />
31325 Boschi misti a prevalenza di conifere non native 0,06<br />
75
Figura 30 - Fisionomie forestali nel Bioclima 33 – Temperato oceanico-semicontinentale<br />
Superficie in centina di ettari<br />
9000<br />
8000<br />
7000<br />
6000<br />
5000<br />
4000<br />
3000<br />
2000<br />
1000<br />
0<br />
1432<br />
Brughiere e<br />
cespuglieti<br />
1074<br />
7856<br />
2421<br />
2051<br />
3734<br />
49 166 198 36<br />
Rocce nude,<br />
falesie, rupi,<br />
affioramenti<br />
Boschi a<br />
prevalenza di<br />
querce<br />
Boschi a<br />
prevalenza di<br />
castagno<br />
Boschi a<br />
prevalenza di<br />
specie igrofile<br />
240 357<br />
Boschi a<br />
prevalenza di pini<br />
mediterranei e<br />
1309<br />
Boschi di abete<br />
bianco e/o abete<br />
rosso<br />
101 20<br />
Boschi e<br />
piantagioni a<br />
prevalenza di<br />
1551<br />
1255<br />
Praterie<br />
discontinue<br />
Fisionomie forestali<br />
168 174 54<br />
Macchia bassa e<br />
garighe<br />
354 304 133<br />
Boschi misti a<br />
prevalenza di<br />
querce<br />
Boschi misti a<br />
prevalenza di<br />
castagno<br />
824<br />
Boschi misti a<br />
prevalenza di<br />
specie igrofile<br />
2 15 284<br />
Boschi misti a<br />
prevalenza di pini<br />
mediterranei<br />
617<br />
883<br />
Boschi misti a<br />
prevalenza di<br />
abete bianco e/o<br />
66 15<br />
76<br />
Boschi misti a<br />
prevalenza di<br />
conifere non
Tabella 33 - Fisionomie forestali nel Bioclima 34 – Temperato subcontinentale<br />
CLC III liv. Descrizione %<br />
311 Boschi di latifoglie<br />
84,29<br />
312 Boschi di conifere<br />
1,91<br />
313 Boschi misti di conifere e latifoglie<br />
3,25<br />
321 Aree a pascolo naturale e praterie<br />
1,51<br />
322 Brughiere e cespuglieti<br />
4,71<br />
331 Spiagge, dune e sabbie<br />
4,23<br />
332 Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti<br />
0,09<br />
CLC IV-V Descrizione %<br />
3111 Boschi a prevalenza di leccio e/o sughera<br />
0,53<br />
3112 Boschi a prevalenza di querce caducifoglie (cerro e/o roverella<br />
e/o farnetto e/o rovere e/o farnia)<br />
18,93<br />
3113 Boschi misti a prevalenza di latifoglie mesofile e mesotermofile<br />
(acero-frassino, carpino nero-orniello)<br />
4,68<br />
3114 Boschi a prevalenza di castagno<br />
7,30<br />
3115 Boschi a prevalenza di faggio<br />
0,16<br />
3116 Boschi a prevalenza di specie igrofile (boschi a prevalenza di<br />
salici e/o pioppi e/o ontani, ecc.)<br />
21,76<br />
3117 Boschi e piantagioni a prevalenza di latifoglie non native 30,92<br />
3121 Boschi a prevalenza di pini mediterranei e cipressete<br />
0,37<br />
3122 Boschi a prevalenza di pini montani e oromediterranei (pino nero<br />
e laricio, pino silvestre, pino loricato)<br />
0,54<br />
3123 Boschi di abete bianco e/o abete rosso 0,72<br />
3124 Boschi di larice e/o pino cembro 0,16<br />
3125 Boschi e piantagioni a prevalenza di conifere non native 0,11<br />
3211 Praterie continue<br />
1,29<br />
3212 Praterie discontinue<br />
0,23<br />
31312 Boschi misti a prevalenza di querce caducifoglie 1,05<br />
31313 Boschi misti a prevalenza di latifoglie mesofile 0,48<br />
31314 Boschi misti a prevalenza di castagno 0,40<br />
31316 Boschi misti a prevalenza di specie igrofile 0,01<br />
31317 Boschi misti a prevalenza di latifoglie non native 0,73<br />
31321 Boschi misti a prevalenza di pini mediterranei 0,12<br />
31322 Boschi misti a prevalenza di pini montani e/o oromediterranei 0,46<br />
77
Figura 31 - Fisionomie forestali nel Bioclima 34 – Temperato subcontinentale<br />
Superficie in centinaia di ettari<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
101<br />
Brughiere e<br />
cespuglieti<br />
91<br />
2<br />
Rocce nude,<br />
falesie, rupi,<br />
affioramenti<br />
11<br />
406<br />
Boschi a<br />
prevalenza di<br />
querce<br />
100<br />
157<br />
Boschi a<br />
prevalenza di<br />
castagno<br />
467<br />
664<br />
4 8 12 15<br />
Boschi a<br />
prevalenza di<br />
specie igrofile<br />
Boschi a<br />
prevalenza di pini<br />
mediterranei e<br />
Boschi di abete<br />
bianco e/o abete<br />
rosso<br />
Fisionomie forestali<br />
3 2<br />
Boschi e<br />
piantagioni a<br />
prevalenza di<br />
28<br />
5<br />
Praterie<br />
discontinue<br />
23<br />
10 9 16<br />
Boschi misti a<br />
prevalenza di<br />
latifoglie mesofile<br />
Boschi misti a<br />
prevalenza di<br />
latifoglie non<br />
3<br />
10<br />
Boschi misti a<br />
prevalenza di pini<br />
montani e/o<br />
78
Tabella 34 - Fisionomie forestali nel Bioclima 35 – Temperato semicontinentale-subcontinentale<br />
CLC I liv. Descrizione %<br />
311 Boschi di latifoglie<br />
62,09<br />
312 Boschi di conifere<br />
9,07<br />
313 Boschi misti di conifere e latifoglie<br />
17,05<br />
321 Aree a pascolo naturale e praterie<br />
3,73<br />
322 Brughiere e cespuglieti<br />
4,39<br />
323 Aree a vegetazione sclerofilla 0,03<br />
331 Spiagge, dune e sabbie<br />
3,39<br />
332 Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti<br />
0,25<br />
CLC IV-V Descrizione %<br />
3111 Boschi a prevalenza di leccio e/o sughera<br />
0,29<br />
3112 Boschi a prevalenza di querce caducifoglie (cerro e/o roverella<br />
e/o farnetto e/o rovere e/o farnia)<br />
5,61<br />
3113 Boschi misti a prevalenza di latifoglie mesofile e<br />
35,99<br />
3114<br />
mesotermofile (acero-frassino, carpino nero-orniello)<br />
Boschi a prevalenza di castagno<br />
9,64<br />
3115 Boschi a prevalenza di faggio<br />
4,47<br />
3116 Boschi a prevalenza di specie igrofile (boschi a prevalenza di<br />
salici e/o pioppi e/o ontani, ecc.)<br />
2,68<br />
3117 Boschi e piantagioni a prevalenza di latifoglie non native 3,40<br />
3121 Boschi a prevalenza di pini mediterranei e cipressete<br />
0,62<br />
3122 Boschi a prevalenza di pini montani e oromediterranei (pino<br />
nero e laricio, pino silvestre, pino loricato)<br />
2,64<br />
3123 Boschi di abete bianco e/o abete rosso 5,25<br />
3124 Boschi di larice e/o pino cembro 0,53<br />
3125 Boschi e piantagioni a prevalenza di conifere non native 0,04<br />
3211 Praterie continue<br />
2,81<br />
3212 Praterie discontinue<br />
0,92<br />
3232 Macchia bassa e garighe<br />
0,02<br />
31311 Boschi misti a prevalenza di leccio 0,03<br />
31312 Boschi misti a prevalenza di querce caducifoglie 0,49<br />
31313 Boschi misti a prevalenza di latifoglie mesofile 8,16<br />
31314 Boschi misti a prevalenza di castagno 1,12<br />
31315 Boschi misti a prevalenza di faggio 2,17<br />
31316 Boschi misti a prevalenza di specie igrofile 0,04<br />
31317 Boschi misti a prevalenza di latifoglie non native 0,07<br />
31321 Boschi misti a prevalenza di pini mediterranei 0,12<br />
31322 Boschi misti a prevalenza di pini montani e/o oromediterranei 2,67<br />
31323 Boschi misti a prevalenza di abete bianco e/o abete rosso 1,87<br />
31324 Boschi misti a prevalenza di larice e/o pino cembro 0,30<br />
79
Figura 32 - Fisionomie forestali nel Bioclima 35 – Temperato semicontinentale-subcontinentale<br />
Superficie in centinaia di ettari<br />
3000<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
Brughiere e<br />
cespuglieti<br />
325 251<br />
18 22<br />
Boschi a<br />
prevalenza di<br />
leccio e/o sughera<br />
415<br />
2665<br />
714<br />
Boschi a<br />
prevalenza di<br />
castagno<br />
331<br />
199 252<br />
Boschi e<br />
piantagioni a<br />
prevalenza di<br />
46<br />
195<br />
389<br />
Boschi di abete<br />
bianco e/o abete<br />
rosso<br />
39 3<br />
Praterie continue<br />
208<br />
68<br />
Fisionomie forestali<br />
2 2 37<br />
Boschi misti a<br />
prevalenza di<br />
leccio<br />
605<br />
83<br />
Boschi misti a<br />
prevalenza di<br />
castagno<br />
161<br />
3 5 9<br />
Boschi misti a<br />
prevalenza di<br />
latifoglie non<br />
198 139 22<br />
Boschi misti a<br />
prevalenza di<br />
abete bianco e/o<br />
80
Tabella 35 - Fisionomie forestali nel Bioclima 41 – Temperato oceanico di transizione<br />
CLC I liv. Descrizione %<br />
311 Boschi di latifoglie<br />
55,11<br />
312 Boschi di conifere<br />
4,10<br />
313 Boschi misti di conifere e latifoglie<br />
8,55<br />
321 Aree a pascolo naturale e praterie<br />
10,87<br />
322 Brughiere e cespuglieti<br />
4,80<br />
323 Aree a vegetazione sclerofilla 15,70<br />
331 Spiagge, dune e sabbie<br />
0,04<br />
332 Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti<br />
0,83<br />
CLC IV-V Descrizione %<br />
3111 Boschi a prevalenza di leccio e/o sughera<br />
12,07<br />
3112 Boschi a prevalenza di querce caducifoglie (cerro e/o roverella<br />
e/o farnetto e/o rovere e/o farnia)<br />
25,95<br />
3113 Boschi misti a prevalenza di latifoglie mesofile e<br />
4,22<br />
3114<br />
mesotermofile (acero-frassino, carpino nero-orniello)<br />
Boschi a prevalenza di castagno<br />
10,36<br />
3115 Boschi a prevalenza di faggio<br />
1,26<br />
3116 Boschi a prevalenza di specie igrofile (boschi a prevalenza di<br />
salici e/o pioppi e/o ontani, ecc.)<br />
0,38<br />
3117 Boschi e piantagioni a prevalenza di latifoglie non native 0,90<br />
3121 Boschi a prevalenza di pini mediterranei e cipressete<br />
3,22<br />
3122 Boschi a prevalenza di pini montani e oromediterranei (pino<br />
nero e laricio, pino silvestre, pino loricato)<br />
0,84<br />
3125 Boschi e piantagioni a prevalenza di conifere non native 0,04<br />
3211 Praterie continue<br />
4,51<br />
3212 Praterie discontinue<br />
6,35<br />
3231 Macchia alta 3,33<br />
3232 Macchia bassa e garighe<br />
12,35<br />
31311 Boschi misti a prevalenza di leccio 1,51<br />
31312 Boschi misti a prevalenza di querce caducifoglie 1,23<br />
31313 Boschi misti a prevalenza di latifoglie mesofile 0,15<br />
31314 Boschi misti a prevalenza di castagno 1,41<br />
31317 Boschi misti a prevalenza di latifoglie non native 0,43<br />
31321 Boschi misti a prevalenza di pini mediterranei 2,76<br />
31322 Boschi misti a prevalenza di pini montani e/o oromediterranei 0,99<br />
31323 Boschi misti a prevalenza di abete bianco e/o abete rosso 0,01<br />
31325 Boschi misti a prevalenza di conifere non native 0,03<br />
81
Figura 33 - Fisionomie forestali nel Bioclima 41 – Temperato oceanico di transizione<br />
Superficie in centinaia di ettari<br />
3000<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
463<br />
Brughiere e<br />
cespuglieti<br />
4<br />
80<br />
Rocce nude,<br />
falesie, rupi,<br />
affioramenti<br />
1165<br />
2505<br />
Boschi a<br />
prevalenza di<br />
querce<br />
408<br />
1000<br />
Boschi a<br />
prevalenza di<br />
castagno<br />
122<br />
37<br />
Boschi a<br />
prevalenza di<br />
specie igrofile<br />
87<br />
311<br />
Boschi a<br />
prevalenza di pini<br />
mediterranei e<br />
81<br />
3<br />
Boschi e<br />
piantagioni a<br />
prevalenza di<br />
435<br />
613<br />
Praterie<br />
discontinue<br />
Fisionomie forestali<br />
321<br />
1192<br />
Macchia bassa e<br />
garighe<br />
146 119<br />
Boschi misti a<br />
prevalenza di<br />
querce<br />
14<br />
136<br />
Boschi misti a<br />
prevalenza di<br />
castagno<br />
41<br />
266<br />
Boschi misti a<br />
prevalenza di pini<br />
mediterranei<br />
96<br />
3<br />
Boschi misti a<br />
prevalenza di<br />
conifere non<br />
82
Tabella 36 - Fisionomie forestali nel Bioclima 42 – Temperato oceanico semicontinentale di<br />
transizione<br />
CLC I liv. Descrizione %<br />
311 Boschi di latifoglie<br />
59,82<br />
312 Boschi di conifere<br />
3,94<br />
313 Boschi misti di conifere e latifoglie<br />
4,54<br />
321 Aree a pascolo naturale e praterie<br />
17,41<br />
322 Brughiere e cespuglieti<br />
6,91<br />
323 Aree a vegetazione sclerofilla 6,61<br />
331 Spiagge, dune e sabbie<br />
0,32<br />
332 Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti<br />
0,45<br />
CLC IV-V Descrizione %<br />
3111 Boschi a prevalenza di leccio e/o sughera<br />
9,42<br />
3112 Boschi a prevalenza di querce caducifoglie (cerro e/o roverella<br />
e/o farnetto e/o rovere e/o farnia)<br />
36,52<br />
3113 Boschi misti a prevalenza di latifoglie mesofile e mesotermofile<br />
(acero-frassino, carpino nero-orniello)<br />
5,17<br />
3114 Boschi a prevalenza di castagno<br />
2,70<br />
3115 Boschi a prevalenza di faggio<br />
3,67<br />
3116 Boschi a prevalenza di specie igrofile (boschi a prevalenza di<br />
salici e/o pioppi e/o ontani, ecc.) )<br />
1,95<br />
3117 Boschi e piantagioni a prevalenza di latifoglie non native 0,40<br />
3121 Boschi a prevalenza di pini mediterranei e cipressete<br />
2,54<br />
3122 Boschi a prevalenza di pini montani e oromediterranei (pino nero<br />
e laricio, pino silvestre, pino loricato)<br />
0,98<br />
3123 Boschi di abete bianco e/o abete rosso 0,01<br />
3125 Boschi e piantagioni a prevalenza di conifere non native 0,41<br />
3211 Praterie continue<br />
11,03<br />
3212 Praterie discontinue<br />
6,38<br />
3231 Macchia alta 1,39<br />
3232 Macchia bassa e garighe<br />
5,22<br />
31311 Boschi misti a prevalenza di leccio 0,56<br />
31312 Boschi misti a prevalenza di querce caducifoglie 1,61<br />
31313 Boschi misti a prevalenza di latifoglie mesofile 0,27<br />
31314 Boschi misti a prevalenza di castagno 0,33<br />
31315 Boschi misti a prevalenza di faggio 0,03<br />
31321 Boschi misti a prevalenza di pini mediterranei 1,02<br />
31322 Boschi misti a prevalenza di pini montani e/o oromediterranei 0,67<br />
31323 Boschi misti a prevalenza di abete bianco e/o abete rosso 0,03<br />
83
Figura 34 - Fisionomie forestali nel Bioclima 42 – Temperato oceanico semicontinentale di transizione<br />
Superficie in centinaia di ettari<br />
3500<br />
3000<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
618<br />
Brughiere e<br />
cespuglieti<br />
29 40<br />
Rocce nude,<br />
falesie, rupi,<br />
affioramenti<br />
843<br />
3269<br />
Boschi a<br />
prevalenza di<br />
querce<br />
463<br />
Boschi a<br />
prevalenza di<br />
castagno<br />
242 328<br />
174<br />
Boschi a<br />
prevalenza di<br />
specie igrofile<br />
36<br />
228<br />
Boschi a<br />
prevalenza di pini<br />
mediterranei e<br />
87<br />
37<br />
Boschi e<br />
piantagioni a<br />
prevalenza di<br />
987<br />
571<br />
Praterie<br />
discontinue<br />
Fisionomie forestali<br />
125<br />
467<br />
Macchia bassa e<br />
garighe<br />
50<br />
144<br />
Boschi misti a<br />
prevalenza di<br />
querce<br />
24 29 3<br />
Boschi misti a<br />
prevalenza di<br />
castagno<br />
92 60<br />
Boschi misti a<br />
prevalenza di pini<br />
mediterranei<br />
2<br />
Boschi misti a<br />
prevalenza di<br />
abete bianco e/o<br />
84
3.2.2.3 - Le classi di uso del suolo nelle celle campione<br />
E’ stata analizzata in tutte le celle campione la relazione tra l’eterogeneità bioclimatica italiana, a<br />
livello macrolimatico e le classi CLC della categoria 3. Territori boscati e ambienti seminaturali.<br />
Sono esaminate più approfonditamente quelle di maggior interesse in relazione agli obiettivi di<br />
Kyoto (agricole, forestali e/o legate ad ambiti in rivegetazione).<br />
Nella Regione Mediterranea la copertura della categoria 3. Territori boscati e ambienti<br />
seminaturali va da un minimo di 40.913,64 ettari (33,3% della superficie della cella di Escalaplano,<br />
NU) ad un massimo di 99.258,18 ettari (83,4% della cella di Castiglione di Sicilia, CT).<br />
Tabella 37 - Celle campione della Regione Mediterranea<br />
Progr. Cella Nome Dimensioni Copertura (ha) cat.<br />
3. Terr. boscati e amb. seminat.<br />
1 337 Escalaplano (NU) 119.032,42 99.258<br />
2 307 Sinnai (CA) 119.539,06 86.882<br />
3 397 Oliena (NU) 118.010,71 77.547<br />
4 427 Bitti (NU) 117.492,66 77.247<br />
5 305 Iglesias (CA) 119.540,85 72.105<br />
6 367 Desulo (NU) 118.522,47 70.130<br />
7 457 Telti (SS) 116.972,83 69.667<br />
8 366 Samugheo (NU) 118.519,78 62.985<br />
9 169 Mistretta (ME) 122.692,85 62.470<br />
10 456 Bordigiadas (SS) 116.970,25 59.408<br />
11 276 Pula (CA) 120.039,56 58.765<br />
12 414 Tusi (MT) 119.182,09 46.871<br />
13 396 Bortigali (NU) 118.008,06 45.853<br />
14 325 Campana (CS) 120.898,52 42.457<br />
15 487 Arzachena (SS) 116.449,73 42.282<br />
16 170 Bronte (CT) 122.802,01 42.032<br />
17 171 Castiglione di Sicilia (CT) 122.918,83 40.914<br />
Nella Regione Temperata, invece, questa classe copre dall’83% (92041,12 ettari nella cella di<br />
Bobbio, PC) fino al 100% (115.257,98 ettari nella cella di Celano, AQ) della superficie dell’unità<br />
considerata.<br />
Tabella 38 – Celle campione della Regione Temperata<br />
Progr. Cella Nome Dimensioni Copertura (ha) cat.<br />
3. Terr. boscati e amb. seminat.<br />
1 587 Celano (AQ) 115.258,20 115.257,98<br />
2 588 Sulmona (AQ) 115.335,34 114.678,35<br />
3 617 Barisciano (AQ) 114.716,54 114.468,86<br />
85
4 646 Cascia (PG) 114.103,85 114.102,37<br />
5 413 San Martino d'Agri (PZ) 119.054,34 111.188,92<br />
6 818 Val di Taro (PR) 110.492,38 110.492,35<br />
7 616 Petrella Salto (RI) 114.647,70 110.398,28<br />
8 586 Pereto (AQ) 115.188,36 108.694,04<br />
9 932 Cogne (AO) 108.265,19 108.265,16<br />
10 1004 Longarone (BL) 107.238,78 107.238,77<br />
11 1003 Siror (TN) 107.198,79 107.198,79<br />
12 1000 Vermiglio (TN) 107.110,74 107.110,74<br />
13 970 Pieve di Bono (TN) 107.686,62 106.356,83<br />
14 558 Barrea (AQ) 115.876,37 106.117,33<br />
15 968 Ardesio (BG) 107.654,58 106.080,04<br />
16 1034 Auronzo di Cadore (BL) 106.655,07 105.825,49<br />
17 1033 Badia (BZ) 106.615,73 105.486,26<br />
18 412 Sanza (SA) 118.933,78 105.049,91<br />
19 790 Pievepelago (MO) 111.085,87 103.522,95<br />
20 933 Issogne (AO) 108.245,10 103.093,03<br />
21 791 Castel di Casio (BO) 111.112,58 103.081,35<br />
22 383 Rotonda (PZ) 119.580,02 102.024,67<br />
23 1063 Selva dei Molini (BZ) 106.031,05 101.649,24<br />
24 1002 Castello-Molina di Fiemme (TN) 107.163,76 101.448,60<br />
25 817 Borzonasca (GE) 110.483,76 100.190,47<br />
26 789 Fivizzano (MS) 111.064,98 100.006,15<br />
27 972 Asiago (VI) 107.740,51 98.551,69<br />
28 969 Borno (BS) 107.667,59 98.213,93<br />
29 1005 Tramonti di Sopra (PN) 107.284,71 95.879,35<br />
30 676 Visso (MC) 113.556,84 95.817,57<br />
31 964 Vannio Anzino (VB) 107.656,55 95.496,16<br />
32 1062 Campo di Trens (BZ) 105.997,15 95.154,99<br />
33 559 Castelverrino (IS) 115.960,96 94.686,26<br />
34 1001 Campodenno (TN) 107.134,65 94.431,95<br />
35 902 Groscavallo (TO) 108.836,42 94.311,88<br />
36 1030 Stelvio (BZ) 106.529,12 93.648,90<br />
37 1031 San Pancrazio (BZ) 106.552,64 93.357,60<br />
38 763 Bagno di Romagna (FO) 111.741,44 93.203,14<br />
39 847 Bobbio (PC) 109.923,88 92.041,12<br />
Come già fatto per l’analisi condotta all’interno dei nove bioclimi, la copertura delle classi<br />
appartenenti alla categoria 3.3 Zone aperte con vegetazione rada o assente, anche se non di diretto<br />
86
interesse ai fini del Protocollo di Kyoto 31 , è stata comunque calcolata. Si tratta di classi<br />
comprendenti zone prive di vegetazione come spiagge e dune (331), rocce nude e affioramenti<br />
rocciosi in genere (332), aree incendiate (334), ghiacciai e nevi perenni (335).<br />
La copertura delle classi 3.3 nelle celle di campionamento (fatta esclusione per la 3.3.3 che riguarda<br />
la vegetazione rada delle steppe, delle tundre e dei calanchi) è risultata sempre inferiore al 5% nella<br />
Regione Mediterranea (max 4,38% nella cella 171 di Castiglione di Sicilia, CT).<br />
Questa percentuale viene superata in 16 celle della Regione Temperata localizzate per lo più nella<br />
zona alpina (Tabella 39).<br />
Tabella 39 – Celle campione della Regione Temperata<br />
Progr. % Cella campione<br />
1 10,03 1063 di Selva dei Molini (BZ)<br />
2 17,59 1034 di Auronzo di Cadore (BL)<br />
3 17,41 1033 di Badia (BZ)<br />
4 5,15 1031 di San Pancrazio (BZ)<br />
5 30,38 1030 di Stelvio (BZ)<br />
6 9,54 1003 di Siror (TN)<br />
7 6,14 1002 di Castello-Molina di Fiemme (TN)<br />
8 5,98 1001 di Campodenno (TN)<br />
9 11,81 1000 di Vermiglio (TN)<br />
10 6,67 970 di Pieve di Bono (TN)<br />
11 5,33 969 di Borno (BS)<br />
12 10,33 968 di Ardesio (BG)<br />
13 7 964 di Vannio Anzino (VB)<br />
14 8,74 933 di Issogne (AO)<br />
15 26,23 932 di Cogne (AO)<br />
16 21,15 902 di Groscavallo (TO)<br />
L’esclusione di queste classi nel criterio di selezione delle unità di campionamento avrebbe<br />
comportato, con un valore soglia fissato nella Regione Temperata a circa 90.000 ettari, in generale<br />
una riduzione del numero di unità rispetto all’estensione di questo macroclima e l’esclusione dalle<br />
analisi di queste celle significative per l’arco alpino.<br />
I risultati, presentati prima per la Regione Mediterranea e poi la Temperata, sono sintetizzati in<br />
tabelle composte dalle colonne:<br />
CODE_00 in cui è indicato il codice corrispondente alla classe di copertura del suolo al 3° livello<br />
proveniente dal Corine Land Cover 2000. Ciascuna voce è descritta nella relativa<br />
legenda (Allegato 1).<br />
COUNT che indica il numero di poligoni che costituiscono ciascuna classe.<br />
31 Fatta eccezione eventualmente per la classe 333. Aree con vegetazione rada (comprendente steppe, tundre e aree<br />
calanchive).<br />
87
SUM_HA che rappresenta il valore totale di copertura in ettari (approssimato alla seconda cifra<br />
decimale) di ciascuna classe rispetto all’estensione totale della cella.<br />
% che rappresenta la percentuale di copertura (approssimata alla seconda cifra decimale) di<br />
ciascuna classe rispetto all’estensione totale della cella.<br />
REGIONE MEDITERRANEA<br />
Tabella 40 - Copertura CLC nella cella 487 di Arzachena (SS)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
111 3 343,33 0,29<br />
112 51 3568,24 3,06<br />
121 2 118,05 0,10<br />
123 1 25,12 0,02<br />
131 9 372,47 0,32<br />
142 3 190,51 0,16<br />
211 59 11719,31 10,06<br />
242 5 369,06 0,32<br />
243 93 10411,76 8,94<br />
244 30 2606,60 2,24<br />
311 17 3733,74 3,21<br />
312 2 410,31 0,35<br />
321 7 267,89 0,23<br />
323 76 33525,28 28,79<br />
324 8 302,74 0,26<br />
331 1 33,04 0,03<br />
332 10 729,85 0,63<br />
333 33 2209,41 1,90<br />
421 3 262,27 0,23<br />
512 1 125,16 0,11<br />
523 2 18219,74 15,65<br />
area totale cella 487 116449,730<br />
88
Tabella 41 - Copertura CLC nella cella 457 di Telti (SS)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
111 3 515,03 0,44<br />
112 23 1503,28 1,29<br />
121 5 511,01 0,44<br />
123 2 106,81 0,09<br />
124 1 152,86 0,13<br />
131 3 96,67 0,08<br />
141 1 29,71 0,03<br />
211 40 15533,12 13,28<br />
221 10 530,35 0,45<br />
242 19 2140,27 1,83<br />
243 77 7213,52 6,17<br />
244 45 17329,61 14,82<br />
311 44 12478,16 10,67<br />
312 24 5262,04 4,50<br />
313 5 627,38 0,54<br />
321 39 2416,87 2,07<br />
323 80 45580,52 38,97<br />
324 5 820,03 0,70<br />
332 10 626,57 0,54<br />
333 20 1720,80 1,47<br />
334 2 91,60 0,08<br />
421 2 244,64 0,21<br />
512 1 124,72 0,11<br />
523 1 1317,28 1,13<br />
area totale cella 457 116972,83<br />
89
Tabella 42 - Copertura CLC nella cella 456 di Bortigiadas (SS)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
111 3 157,83 0,13<br />
112 22 1341,74 1,15<br />
121 1 169,12 0,14<br />
131 2 138,95 0,12<br />
133 1 52,53 0,04<br />
211 57 26635,35 22,77<br />
242 36 3261,51 2,79<br />
243 114 13460,54 11,51<br />
244 45 11829,72 10,11<br />
311 40 20290,87 17,35<br />
312 11 1652,57 1,41<br />
313 5 307,06 0,26<br />
321 27 2024,15 1,73<br />
323 78 25867,75 22,11<br />
331 1 32,32 0,03<br />
332 3 292,08 0,25<br />
333 9 1304,09 1,11<br />
421 1 83,95 0,07<br />
511 1 52,62 0,04<br />
512 3 1351,86 1,16<br />
523 1 1425,78 1,22<br />
area totale cella 456 116970,252<br />
Tabella 43 - Copertura CLC nella cella 427 di Bitti (NU)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
111 1 32,76 0,03<br />
112 8 465,65 0,40<br />
121 2 72,98 0,06<br />
131 6 244,74 0,21<br />
211 39 7346,22 6,25<br />
221 2 91,04 0,08<br />
223 1 59,11 0,05<br />
242 9 1059,51 0,90<br />
243 64 6532,97 5,56<br />
244 46 25969,73 22,10<br />
311 44 20429,92 17,39<br />
312 26 9835,49 8,37<br />
321 77 10307,69 8,77<br />
323 70 32178,93 27,39<br />
324 12 1368,27 1,16<br />
332 3 446,72 0,38<br />
333 9 907,14 0,77<br />
512 3 143,79 0,12<br />
area totale cella 427 117492,66<br />
90
Tabella 44 - Copertura CLC nella cella 414 di Tusi (MT)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
112 15 825,50 0,69<br />
121 5 191,59 0,16<br />
131 2 59,59 0,05<br />
142 1 23,64 0,02<br />
211 109 46364,16 38,90<br />
221 4 129,76 0,11<br />
222 35 6142,57 5,15<br />
223 21 3375,00 2,83<br />
231 23 1906,59 1,60<br />
241 99 15100,14 12,67<br />
242 16 2930,63 2,46<br />
243 124 11498,99 9,65<br />
311 93 13914,18 11,67<br />
312 3 123,88 0,10<br />
313 5 423,64 0,36<br />
321 14 1823,60 1,53<br />
323 21 1122,57 0,94<br />
324 81 6231,06 5,23<br />
331 14 2494,75 2,09<br />
333 29 2665,00 2,24<br />
334 1 176,54 0,15<br />
512 2 944,32 0,79<br />
523 1 387,56 0,33<br />
area totale cella 414 119182,09<br />
91
Tabella 45 - Copertura CLC nella cella 397 di Oliena (NU)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
111 3 542,54 0,46<br />
112 14 1144,40 0,97<br />
121 1 63,59 0,05<br />
122 1 63,05 0,05<br />
131 1 45,68 0,04<br />
211 47 6814,27 5,77<br />
221 3 251,08 0,21<br />
223 11 1366,72 1,16<br />
242 14 1977,15 1,68<br />
243 102 13840,10 11,73<br />
244 55 21688,64 18,38<br />
311 54 25323,03 21,46<br />
312 12 1832,41 1,55<br />
313 5 873,40 0,74<br />
321 52 6511,86 5,52<br />
323 83 28177,77 23,88<br />
324 24 2420,64 2,05<br />
332 13 1863,92 1,58<br />
333 19 2798,92 2,37<br />
334 1 87,56 0,07<br />
512 2 323,98 0,27<br />
area totale cella 397 118010,71<br />
92
Tabella 46 - Copertura CLC nella cella 396 di Bortigali (NU)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
111 1 36,38 0,03<br />
112 23 1724,08 1,46<br />
121 5 443,14 0,38<br />
131 2 187,71 0,16<br />
142 1 31,70 0,03<br />
211 54 23917,51 20,27<br />
221 1 34,77 0,03<br />
222 1 87,47 0,07<br />
223 8 910,37 0,77<br />
231 1 250,95 0,21<br />
241 4 329,75 0,28<br />
242 14 2354,59 2,00<br />
243 87 9835,57 8,33<br />
244 61 25996,41 22,03<br />
311 40 15670,70 13,28<br />
312 5 557,44 0,47<br />
313 1 118,56 0,10<br />
321 47 17964,21 15,22<br />
323 60 15697,78 13,30<br />
324 6 536,43 0,45<br />
333 1 76,02 0,06<br />
334 1 92,19 0,08<br />
512 3 1154,35 0,98<br />
area totale cella 396 118008,06<br />
93
Tabella 47 - Copertura CLC nella cella 367 di Desulo (NU)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
112 20 986,91 0,83<br />
121 2 69,24 0,06<br />
211 14 766,29 0,65<br />
223 2 206,41 0,17<br />
241 1 34,76 0,03<br />
242 10 1913,13 1,61<br />
243 55 7219,28 6,09<br />
244 17 2400,71 2,03<br />
311 47 33978,03 28,67<br />
312 44 8263,80 6,97<br />
313 17 2336,65 1,97<br />
321 48 15929,34 13,44<br />
322 19 3566,04 3,01<br />
323 63 35463,56 29,92<br />
324 20 2629,90 2,22<br />
332 2 5,53 0,00<br />
333 23 2517,69 2,12<br />
512 1 235,20 0,20<br />
area totale cella 367 118522,47<br />
Tabella 48 - Copertura CLC nella cella 366 di Samugheo (OR)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
112 26 1326,95 1,12<br />
121 1 25,13 0,02<br />
131 5 178,59 0,15<br />
133 1 55,06 0,05<br />
211 62 21259,49 17,94<br />
223 6 346,07 0,29<br />
241 2 209,19 0,18<br />
242 20 2696,19 2,27<br />
243 135 15421,94 13,01<br />
244 43 11061,07 9,33<br />
311 54 20958,22 17,68<br />
312 37 6015,58 5,08<br />
313 5 891,98 0,75<br />
321 46 4175,19 3,52<br />
323 86 31132,47 26,27<br />
324 28 2528,41 2,13<br />
333 1 105,33 0,09<br />
511 1 0,97 0,00<br />
512 1 132,00 0,11<br />
area totale cella 366 118519,78<br />
94
Tabella 49 - Copertura CLC nella cella 337 di Escalaplano (NU)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
112 15 913,846 0,77<br />
121 2 120,256 0,10<br />
131 3 122,430 0,10<br />
211 30 8827,706 7,42<br />
221 1 6,341 0,01<br />
223 8 244,741 0,21<br />
242 12 1185,157 1,00<br />
243 98 10508,294 8,83<br />
244 14 2279,020 1,91<br />
311 60 11454,044 9,62<br />
312 32 4164,785 3,50<br />
313 13 2398,067 2,01<br />
321 74 9063,592 7,61<br />
323 33 64861,302 54,49<br />
324 7 685,400 0,58<br />
333 5 474,186 0,40<br />
334 3 229,717 0,19<br />
512 2 1493,540 1,25<br />
area totale cella 337 119032,42<br />
95
Tabella 50 - Copertura CLC nella cella 325 di Campana (CS)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
111 2 155,238 0,13<br />
112 24 1373,968 1,14<br />
121 1 55,483 0,05<br />
131 1 61,028 0,05<br />
133 2 91,567 0,08<br />
211 83 21123,738 17,47<br />
221 5 363,534 0,30<br />
222 1 24,833 0,02<br />
223 72 12113,533 10,02<br />
231 4 376,165 0,31<br />
241 54 8256,738 6,83<br />
242 15 820,447 0,68<br />
243 122 9247,785 7,65<br />
311 53 26189,827 21,66<br />
312 28 10868,040 8,99<br />
313 43 10144,571 8,39<br />
321 53 6301,198 5,21<br />
322 9 871,993 0,72<br />
323 36 2215,168 1,83<br />
324 64 4005,495 3,31<br />
331 5 1035,319 0,86<br />
333 19 1107,266 0,92<br />
334 1 39,551 0,03<br />
512 1 52,141 0,04<br />
523 1 1472,033 1,22<br />
area totale cella 325 120898,52<br />
96
Tabella 51 - Copertura CLC nella cella 307 di Sinnai (CA)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
111 6 900,26 0,75<br />
112 27 3380,56 2,83<br />
121 3 145,71 0,12<br />
131 5 270,62 0,23<br />
211 37 9497,68 7,95<br />
221 2 94,26 0,08<br />
222 10 1158,36 0,97<br />
223 8 1249,54 1,05<br />
241 1 91,60 0,08<br />
242 36 6942,21 5,81<br />
243 70 7710,39 6,45<br />
244 2 88,47 0,07<br />
311 25 18563,48 15,53<br />
312 26 4918,58 4,11<br />
313 5 850,33 0,71<br />
321 30 3367,17 2,82<br />
323 23 54622,62 45,69<br />
324 5 244,11 0,20<br />
331 3 259,57 0,22<br />
333 14 1166,62 0,98<br />
411 1 159,00 0,13<br />
421 2 110,64 0,09<br />
422 1 292,63 0,24<br />
512 2 260,81 0,22<br />
521 2 15,37 0,01<br />
523 1 2062,10 1,73<br />
area totale cella 307 119539,06<br />
97
Tabella 52 - Copertura CLC nella cella 305 di Iglesias (CA)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
111 4 193,21 0,16<br />
112 19 1686,63 1,41<br />
121 2 317,68 0,27<br />
123 2 57,44 0,05<br />
131 17 1079,28 0,90<br />
132 1 61,86 0,05<br />
211 15 14243,24 11,91<br />
221 3 128,41 0,11<br />
222 4 320,44 0,27<br />
223 2 592,90 0,50<br />
241 4 366,75 0,31<br />
242 27 4822,66 4,03<br />
243 55 5224,73 4,37<br />
244 5 488,64 0,41<br />
311 52 19361,88 16,20<br />
312 15 1254,26 1,05<br />
313 6 1208,31 1,01<br />
321 54 4552,63 3,81<br />
323 55 39906,85 33,38<br />
324 12 562,67 0,47<br />
331 1 31,48 0,03<br />
332 1 34,95 0,03<br />
333 28 3432,79 2,87<br />
334 1 37,73 0,03<br />
421 1 123,42 0,10<br />
512 2 134,35 0,11<br />
523 1 4528,60 3,79<br />
area totale cella 305 119540,85<br />
98
Tabella 53 - Copertura CLC nella cella 276 di Pula (CA)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
111 2 68,89 0,06<br />
112 18 1840,89 1,53<br />
121 5 587,61 0,49<br />
142 4 212,70 0,18<br />
211 15 3306,66 2,75<br />
222 5 204,78 0,17<br />
223 2 97,73 0,08<br />
241 1 101,17 0,08<br />
242 16 2961,72 2,47<br />
243 41 3944,66 3,29<br />
244 3 308,39 0,26<br />
311 7 25417,39 21,17<br />
312 22 2818,03 2,35<br />
313 6 795,19 0,66<br />
321 10 401,05 0,33<br />
323 37 27891,75 23,24<br />
324 4 331,61 0,28<br />
332 3 186,98 0,16<br />
333 11 686,45 0,57<br />
334 1 39,55 0,03<br />
421 2 1386,83 1,16<br />
422 1 22,33 0,02<br />
512 1 51,98 0,04<br />
523 1 5504,80 4,59<br />
area totale cella 276 120039,56<br />
99
Tabella 54 - Copertura CLC nella cella 171 di Castiglione di Sicilia (CT)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
111 19 1633,667 1,33<br />
112 39 2843,165 2,31<br />
121 2 63,394 0,05<br />
122 1 27,413 0,02<br />
123 1 29,292 0,02<br />
131 1 28,253 0,02<br />
211 14 917,104 0,75<br />
221 3 163,407 0,13<br />
222 31 15462,039 12,58<br />
223 15 3595,551 2,93<br />
241 2 114,550 0,09<br />
242 22 2556,468 2,08<br />
243 20 7352,861 5,98<br />
311 42 12300,664 10,01<br />
312 7 1694,763 1,38<br />
313 9 2136,364 1,74<br />
321 68 13398,950 10,90<br />
322 28 5079,067 4,13<br />
323 18 1589,222 1,29<br />
324 45 9688,492 7,88<br />
331 1 68,029 0,06<br />
332 2 4233,093 3,44<br />
333 11 1085,797 0,88<br />
511 7 923,025 0,75<br />
523 1 4167,448 3,39<br />
area totale cella 171 122918,83<br />
100
Tabella 55 - Copertura CLC nella cella 170 di Bronte (CT)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
111 6 630,59 0,51<br />
112 10 727,84 0,59<br />
121 1 28,56 0,02<br />
131 2 56,46 0,05<br />
211 50 15194,33 12,37<br />
221 3 580,51 0,47<br />
222 10 4299,31 3,50<br />
223 11 1544,20 1,26<br />
241 6 795,06 0,65<br />
242 11 1860,99 1,52<br />
243 25 3609,57 2,94<br />
311 36 19248,32 15,67<br />
312 9 895,63 0,73<br />
313 18 2535,93 2,07<br />
321 59 29364,56 23,91<br />
322 36 13157,72 10,71<br />
323 33 6203,05 5,05<br />
324 55 17059,29 13,89<br />
331 1 6,72 0,01<br />
332 6 4162,83 3,39<br />
333 4 540,76 0,44<br />
511 3 273,55 0,22<br />
512 1 26,25 0,02<br />
area totale cella 170 122802,01<br />
101
Tabella 56 - Copertura CLC nella cella 169 di Mistretta (ME)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
111 13 563,67 0,46<br />
112 5 456,56 0,37<br />
121 1 28,39 0,02<br />
131 6 217,86 0,18<br />
211 31 23300,07 18,99<br />
222 2 8,20 0,01<br />
223 37 8108,40 6,61<br />
241 10 2120,56 1,73<br />
242 4 294,80 0,24<br />
243 23 6510,62 5,31<br />
311 40 19979,50 16,28<br />
312 7 478,67 0,39<br />
313 7 3583,63 2,92<br />
321 61 22920,09 18,68<br />
322 17 7371,74 6,01<br />
323 79 24058,66 19,61<br />
324 16 2113,83 1,72<br />
333 3 212,16 0,17<br />
511 3 257,07 0,21<br />
512 1 108,39 0,09<br />
area totale cella 169 122692,85<br />
102
Tabella 57 - Copertura in ettari della cat. 3 . Territori boscati e ambienti seminaturali nelle celle della Regione Mediterranea<br />
CODE_00 169 170 171 276 305 307 325 337 366<br />
311 - Boschi di latifoglie 19979,50 19248,32 12300,66 25417,39 19361,88 18563,48 26189,83 11454,04 20958,22<br />
312 - Boschi di conifere 478,67 895,63 1694,76 2818,03 1254,26 4918,58 10868,04 4164,79 6015,58<br />
313 - Boschi misti di conifere e lat. 3583,63 2535,93 2136,36 795,19 1208,31 850,33 10144,57 2398,07 891,98<br />
321 - Aree a pascolo naturale e prat. 22920,09 29364,56 13398,95 401,05 4552,63 3367,17 6301,20 9063,59 4175,19<br />
322 - Brughiere e cespuglieti 7371,74 13157,72 5079,07 0,00 0,00 0,00 871,99 0,00 0,00<br />
323 - Aree a vegetazione sclerofilla 24058,66 6203,05 1589,22 27891,75 39906,85 54622,62 2215,17 64861,30 31132,47<br />
324 - Aree a vegetazione boschiva ed 2113,83 17059,29 9688,49 331,61 562,67 244,11 4005,50 685,40 2528,41<br />
arbustiva in evoluzione<br />
331 - Spiagge, dune e sabbie 0,00 6,72 68,03 0,00 31,48 259,57 1035,32 0,00 0,00<br />
332 - Rocce nude, falesie, rupi, affior. 0,00 4162,83 4233,09 186,98 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
333 - Aree con vegetazione rada 212,16 540,76 1085,80 686,45 3432,79 1166,62 1107,27 474,19 105,33<br />
334 - Aree percorse da incendi 0,00 0,00 0,00 39,55 37,73 0,00 39,55 229,72 0,00<br />
area totale cella (ha) 122692,85 122802,01 122918,83 120039,56 119540,85 119539,06 120898,52 119032,42 118519,78<br />
CODE_00 367 396 397 414 427 456 457 487<br />
311 - Boschi di latifoglie 33978,03 15670,70 25323,03 13914,18 20429,92 20290,87 12478,16 3733,74<br />
312 - Boschi di conifere 8263,80 557,44 1832,41 123,88 9835,49 1652,57 5262,04 410,31<br />
313 - Boschi misti di conifere e latif. 2336,65 118,56 873,40 423,64 307,06 627,38 0,00<br />
321 - Aree a pascolo naturale e prat. 15929,34 17964,21 6511,86 1823,60 10307,69 2024,15 2416,87 267,89<br />
322 - Brughiere e cespuglieti 3566,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
323 - Aree a vegetazione sclerofilla 35463,56 15697,78 28177,77 1122,57 32178,93 25867,75 45580,52 33525,28<br />
324 - Aree a vegetazione boschiva ed 2629,90 536,43 2420,64 6231,06 1368,27 0,00 820,03 302,74<br />
arbustiva in evoluzione<br />
331 - Spiagge, dune e sabbie 0,00 0,00 0,00 2494,75 0,00 32,32 0,00 33,04<br />
332 - Rocce nude, falesie, rupi, affior. 5,53 0,00 1863,92 0,00 446,72 292,08 626,57 729,85<br />
333 - Aree con vegetazione rada 2517,69 76,02 2798,92 2665,00 907,14 1304,09 1720,80 2209,41<br />
334 - Aree percorse da incendi 0,00 92,19 87,56 176,54 0,00 0,00 91,60 0,00<br />
area totale cella (ha) 118522,47 118008,06 118010,71 119182,09 117492,66 116970,25 116972,83 116449,73<br />
103
Identificativo delle celle<br />
487<br />
457<br />
456<br />
427<br />
414<br />
397<br />
396<br />
367<br />
366<br />
337<br />
325<br />
307<br />
305<br />
276<br />
171<br />
170<br />
169<br />
Figura 36 - Copertura della cat. 3. Territori boscati e ambienti seminaturali<br />
nelle celle della Regione Mediterranea<br />
0% 20% 40% 60% 80% 100%<br />
Copertura % delle voci di III livello<br />
311 - Boschi di latifoglie<br />
312 - Boschi di conifere<br />
313 - Boschi misti di conifere e<br />
latifoglie<br />
321 - Aree a pascolo naturale e<br />
praterie<br />
322 - Brughiere e cespuglieti<br />
323 - Aree a vegetazione sclerofilla<br />
324 - Aree a vegetazione boschiva ed<br />
arbustiva in evoluzione<br />
331 - Spiagge, dune e sabbie<br />
332 - Rocce nude, falesie, rupi,<br />
affioramenti<br />
333 - Aree con vegetazione rada<br />
334 - Aree percorse da incendi<br />
104
REGIONE TEMPERATA<br />
Tabella 58 - Copertura CLC nella cella 1063 di Selva dei Molini (BZ)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
112 30 1358,21 1,28<br />
121 6 241,22 0,23<br />
211 6 1600,90 1,51<br />
222 1 16,54 0,02<br />
231 87 9205,77 8,68<br />
242 12 3302,24 3,11<br />
243 33 1368,01 1,29<br />
311 2 79,62 0,08<br />
312 19 50830,13 47,94<br />
313 5 678,75 0,64<br />
321 62 11919,22 11,24<br />
322 31 2071,26 1,95<br />
324 60 4384,07 4,13<br />
331 1 26,61 0,03<br />
332 16 8208,00 7,74<br />
333 47 7559,20 7,13<br />
335 6 2400,59 2,26<br />
512 3 123,20 0,12<br />
area totale cella 1063 106031,05<br />
Tabella 59 - Copertura CLC nella cella 1062 di Campo di Trens (BZ)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
112 11 777,07 0,73<br />
121 4 139,04 0,13<br />
122 2 610,46 0,58<br />
222 1 258,05 0,24<br />
231 53 8123,46 7,66<br />
242 8 593,89 0,56<br />
243 16 742,57 0,70<br />
312 27 42534,51 40,13<br />
313 1 58,81 0,06<br />
321 96 19168,55 18,08<br />
322 52 3968,57 3,74<br />
324 80 7491,08 7,07<br />
331 1 33,14 0,03<br />
332 24 10755,36 10,15<br />
333 67 8791,52 8,29<br />
335 3 218,27 0,21<br />
512 1 25,35 0,02<br />
area totale cella 1062 105997,15<br />
105
Tabella 60 - Copertura CLC nella cella 1034 di Auronzo di Cadore (BL)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
112 14 1153,252 1,08<br />
121 2 60,176 0,06<br />
131 1 27,963 0,03<br />
142 1 51,736 0,05<br />
211 1 64,808 0,06<br />
231 26 2764,531 2,59<br />
243 12 812,293 0,76<br />
311 1 38,727 0,04<br />
312 11 58454,540 54,81<br />
313 21 2559,593 2,40<br />
321 41 6529,868 6,12<br />
322 30 3207,903 3,01<br />
324 21 2330,257 2,18<br />
331 4 294,608 0,28<br />
332 25 18160,995 17,03<br />
333 82 9220,366 8,65<br />
335 3 298,911 0,28<br />
512 4 302,356 0,28<br />
area totale cella 1034 106655,07<br />
Tabella 61 - Copertura CLC nella cella 1033 di Badia (BZ)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
111 1 43,036 0,04<br />
112 18 1003,002 0,94<br />
231 64 7108,977 6,67<br />
242 4 152,360 0,14<br />
243 21 1378,551 1,29<br />
311 1 81,282 0,08<br />
312 35 42318,549 39,69<br />
313 6 369,497 0,35<br />
321 75 17290,035 16,22<br />
322 36 2540,001 2,38<br />
324 69 5964,479 5,59<br />
331 1 43,955 0,04<br />
332 34 18286,310 17,15<br />
333 75 9692,234 9,09<br />
335 1 234,244 0,22<br />
512 3 109,223 0,10<br />
area totale cella 1033 106615,73<br />
106
Tabella 62 - Copertura CLC nella cella 1031 di San Pancrazio (BZ)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
111 1 103,14 0,10<br />
112 30 2162,54 2,03<br />
121 3 316,63 0,30<br />
142 1 31,23 0,03<br />
211 1 206,44 0,19<br />
221 6 594,35 0,56<br />
222 8 9185,44 8,62<br />
231 68 5973,08 5,61<br />
242 16 2465,38 2,31<br />
243 48 2962,84 2,78<br />
311 23 3267,07 3,07<br />
312 16 44322,08 41,60<br />
313 24 6453,51 6,06<br />
321 31 5521,91 5,18<br />
322 18 1530,09 1,44<br />
324 61 8055,18 7,56<br />
332 14 5348,33 5,02<br />
333 21 7736,58 7,26<br />
335 3 137,98 0,13<br />
411 1 27,49 0,03<br />
512 2 151,36 0,14<br />
area totale cella 1031 106552,64<br />
107
Tabella 63 - Copertura CLC nella cella 1030 di Stelvio (BZ)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
112 12 656,56 0,62<br />
121 4 94,37 0,09<br />
131 1 35,84 0,03<br />
211 7 574,69 0,54<br />
222 1 1395,42 1,31<br />
231 39 4946,42 4,64<br />
242 8 2288,50 2,15<br />
243 16 1290,21 1,21<br />
311 5 342,59 0,32<br />
312 26 25503,86 23,94<br />
313 2 147,84 0,14<br />
321 40 11037,80 10,36<br />
322 25 1889,66 1,77<br />
324 41 6104,66 5,73<br />
331 2 57,09 0,05<br />
332 5 23854,59 22,39<br />
333 36 14057,80 13,20<br />
335 15 8458,26 7,94<br />
411 1 56,90 0,05<br />
512 3 147,74 0,14<br />
area totale cella 1030 106529,12<br />
Tabella 64 - Copertura CLC nella cella 1005 di Tramonti di Sopra (PN)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
112 24 1986,64 1,85<br />
121 6 291,37 0,27<br />
131 1 35,95 0,03<br />
211 9 12960,40 12,08<br />
221 8 930,18 0,87<br />
231 15 1083,48 1,01<br />
242 5 361,26 0,34<br />
243 30 2567,22 2,39<br />
311 65 29304,41 27,31<br />
312 42 4679,27 4,36<br />
313 37 32503,07 30,30<br />
321 42 6826,76 6,36<br />
322 29 3497,05 3,26<br />
324 47 3151,78 2,94<br />
331 14 2943,60 2,74<br />
332 11 1165,80 1,09<br />
333 30 2624,53 2,45<br />
512 4 371,96 0,35<br />
area totale cella 1005 107284,71<br />
108
Tabella 65 - Copertura CLC nella cella 1004 di Longarone (BL)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
111 1 42,46 0,04<br />
112 25 1591,44 1,48<br />
121 9 589,77 0,55<br />
131 2 74,90 0,07<br />
133 3 148,49 0,14<br />
211 8 1410,54 1,32<br />
231 19 3001,74 2,80<br />
242 23 5540,97 5,17<br />
243 40 3872,98 3,61<br />
311 57 20468,56 19,09<br />
312 37 22677,73 21,15<br />
313 52 18916,66 17,64<br />
321 43 5639,09 5,26<br />
322 34 7008,65 6,54<br />
324 29 3204,32 2,99<br />
331 18 1918,65 1,79<br />
332 16 2903,76 2,71<br />
333 34 7584,65 7,07<br />
334 1 45,11 0,04<br />
512 2 598,32 0,56<br />
area totale cella 1004 107238,78<br />
Tabella 66 - Copertura CLC nella cella 1003 di Siror (TN)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
112 22 1198,18 1,12<br />
121 1 26,65 0,02<br />
211 3 314,49 0,29<br />
231 39 2444,74 2,28<br />
242 3 401,36 0,37<br />
243 32 3120,98 2,91<br />
311 21 8157,11 7,61<br />
312 35 42305,05 39,46<br />
313 55 12480,90 11,64<br />
321 62 8837,55 8,24<br />
322 37 3387,83 3,16<br />
324 59 4771,15 4,45<br />
331 3 117,81 0,11<br />
332 19 10067,37 9,39<br />
333 41 9265,20 8,64<br />
335 1 39,58 0,04<br />
512 5 262,86 0,25<br />
area totale cella 1003 107198,79<br />
109
Tabella 67 - Copertura CLC nella cella 1002 di Castello-Molina di Fiemme (TN)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
112 25 1404,05 1,31<br />
121 4 128,74 0,12<br />
221 9 757,00 0,71<br />
222 2 2641,59 2,47<br />
231 49 4290,37 4,00<br />
241 3 774,67 0,72<br />
242 8 417,90 0,39<br />
243 52 3655,81 3,41<br />
311 15 2814,33 2,63<br />
312 45 51168,58 47,75<br />
313 42 12895,96 12,03<br />
321 56 4892,43 4,57<br />
322 44 3174,07 2,96<br />
324 87 6645,79 6,20<br />
332 18 6577,51 6,14<br />
333 39 4549,84 4,25<br />
411 1 96,67 0,09<br />
512 4 278,47 0,26<br />
area totale cella 1002 107163,76<br />
Tabella 68 - Copertura CLC nella cella 1001 di Campodenno (TN)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
111 1 27,19 0,03<br />
112 54 3200,94 2,99<br />
121 6 548,54 0,51<br />
122 1 66,03 0,06<br />
131 8 701,34 0,65<br />
221 21 2877,69 2,69<br />
222 24 9475,86 8,84<br />
231 29 2833,89 2,65<br />
242 23 2631,66 2,46<br />
243 44 3583,08 3,34<br />
311 47 5652,64 5,28<br />
312 38 33743,86 31,50<br />
313 59 17186,05 16,04<br />
321 25 3554,89 3,32<br />
322 24 2631,33 2,46<br />
324 73 6080,89 5,68<br />
332 9 6306,17 5,89<br />
333 31 5309,29 4,96<br />
512 5 723,30 0,68<br />
area totale cella 1001 107134,65<br />
110
Tabella 69 - Copertura CLC nella cella 1000 di Vermiglio (TN)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
112 12 876,96 0,82<br />
131 1 27,56 0,03<br />
231 24 2662,36 2,49<br />
241 1 100,68 0,09<br />
243 19 1505,81 1,41<br />
311 6 644,29 0,60<br />
312 23 27134,96 25,33<br />
313 16 3205,60 2,99<br />
321 57 8738,16 8,16<br />
322 38 3745,61 3,50<br />
324 66 6655,11 6,21<br />
331 2 42,88 0,04<br />
332 11 26331,27 24,58<br />
333 51 17538,15 16,37<br />
335 13 7696,33 7,19<br />
512 5 205,01 0,19<br />
area totale cella 1000 107110,74<br />
Tabella 70 - Copertura CLC nella cella 972 di Asiago (VI)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
111 2 63,05 0,06<br />
112 39 2861,30 2,66<br />
121 6 244,87 0,23<br />
124 1 47,37 0,04<br />
131 4 125,87 0,12<br />
211 4 307,90 0,29<br />
221 2 174,08 0,16<br />
222 4 536,94 0,50<br />
231 40 7273,80 6,75<br />
241 2 120,06 0,11<br />
242 20 3340,34 3,10<br />
243 63 4965,72 4,61<br />
311 49 17805,16 16,53<br />
312 47 37737,69 35,03<br />
313 90 20645,63 19,16<br />
321 61 6289,50 5,84<br />
322 11 985,83 0,92<br />
324 34 1988,59 1,85<br />
331 2 60,38 0,06<br />
332 1 52,56 0,05<br />
333 6 1861,80 1,73<br />
512 2 252,07 0,23<br />
area totale cella 972 107740,51<br />
111
Tabella 71 - Copertura CLC nella cella 970 Pieve di Bono (TN)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
112 20 1005,45 0,93<br />
121 2 55,70 0,05<br />
211 3 310,94 0,29<br />
231 16 1442,18 1,34<br />
241 7 501,05 0,47<br />
242 7 1527,72 1,42<br />
243 42 4723,25 4,39<br />
311 57 10075,75 9,36<br />
312 68 20042,27 18,61<br />
313 61 28012,20 26,01<br />
321 47 11782,46 10,94<br />
322 40 3294,37 3,06<br />
324 83 7681,97 7,13<br />
332 6 7173,03 6,66<br />
333 40 8386,42 7,79<br />
335 1 11,73 0,01<br />
512 8 1660,14 1,54<br />
area totale cella 970 107686,62<br />
Tabella 72 - Copertura CLC nella cella 969 di Borno (BS)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
112 52 3157,270 2,93<br />
121 12 586,486 0,54<br />
131 3 55,894 0,05<br />
211 22 2946,558 2,74<br />
231 25 2310,740 2,15<br />
243 40 2872,252 2,67<br />
311 37 13718,778 12,74<br />
312 45 21542,819 20,01<br />
313 52 22035,031 20,47<br />
321 96 15899,970 14,77<br />
322 32 2793,382 2,59<br />
324 78 5746,166 5,34<br />
332 13 5479,596 5,09<br />
333 37 7753,642 7,20<br />
335 3 225,036 0,21<br />
512 3 543,973 0,51<br />
area totale cella 969 107667,59<br />
112
Tabella 73 - Copertura CLC nella cella 968 di Ardesio (BG)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA<br />
111 1 28,73 0,03<br />
112 41 2213,06 2,06<br />
121 10 384,97 0,36<br />
142 1 159,73 0,15<br />
211 2 924,80 0,86<br />
231 29 1824,37 1,69<br />
243 31 2713,86 2,52<br />
311 22 18849,43 17,51<br />
312 33 15692,25 14,58<br />
313 31 22767,11 21,15<br />
321 125 19754,47 18,35<br />
322 22 1644,80 1,53<br />
324 58 5065,50 4,71<br />
332 21 10964,54 10,18<br />
333 30 4341,71 4,03<br />
335 4 158,61 0,15<br />
512 5 166,64 0,15<br />
area totale cella 968 107654,58<br />
Tabella 74 - Copertura CLC nella cella 964 di Vannio Anzino (VB)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
112 8 586,61 0,54<br />
121 5 381,45 0,35<br />
122 1 118,46 0,11<br />
211 2 272,47 0,25<br />
231 10 865,93 0,80<br />
242 2 153,21 0,14<br />
243 33 2574,61 2,39<br />
311 43 25311,02 23,51<br />
312 66 12083,95 11,22<br />
313 83 12534,96 11,64<br />
321 56 16956,11 15,75<br />
322 45 5461,96 5,07<br />
324 107 9022,04 8,38<br />
331 3 548,19 0,51<br />
332 9 6795,64 6,31<br />
333 47 4359,19 4,05<br />
335 4 194,06 0,18<br />
512 4 143,58 0,13<br />
area totale cella 964 107656,55<br />
113
Tabella 75 - Copertura CLC nella cella 933 di Issogne (AO)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
112 20 1255,45 1,16<br />
121 5 254,02 0,23<br />
131 1 0,24 0,00<br />
211 2 124,44 0,11<br />
221 5 323,57 0,30<br />
231 53 4395,62 4,06<br />
242 8 974,34 0,90<br />
243 57 5748,90 5,31<br />
311 41 11817,20 10,92<br />
312 60 21134,20 19,52<br />
313 43 6459,28 5,97<br />
321 85 14066,99 13,00<br />
322 59 6354,75 5,87<br />
324 125 15151,84 14,00<br />
332 38 9455,92 8,74<br />
333 88 10574,84 9,77<br />
511 1 153,52 0,14<br />
area totale cella 933 108245,10<br />
Tabella 76 - Copertura CLC nella cella 932 di Cogne (AO)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
111 1 162,12 0,15<br />
112 17 1526,65 1,41<br />
121 5 462,33 0,43<br />
124 1 42,48 0,04<br />
131 1 25,86 0,02<br />
133 2 133,44 0,12<br />
142 2 65,24 0,06<br />
221 4 168,22 0,16<br />
222 4 247,70 0,23<br />
231 41 3496,98 3,23<br />
242 11 1519,94 1,40<br />
243 59 5006,42 4,62<br />
311 15 1239,63 1,14<br />
312 45 22482,50 20,77<br />
313 26 2769,17 2,56<br />
321 72 10629,80 9,82<br />
322 36 3262,05 3,01<br />
324 115 11279,13 10,42<br />
332 16 25178,89 23,26<br />
333 95 15348,66 14,18<br />
335 19 3217,98 2,97<br />
area totale cella 932 108265,19<br />
114
Tabella 77 - Copertura CLC nella cella 902 di Groscavallo (TO)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
112 10 453,63 0,42<br />
131 1 0,01 0,00<br />
231 16 1099,50 1,01<br />
242 3 61,02 0,06<br />
243 22 2611,30 2,40<br />
311 21 20414,04 18,76<br />
312 26 4246,40 3,90<br />
313 17 4393,59 4,04<br />
321 56 16189,69 14,88<br />
322 49 6817,13 6,26<br />
324 60 6612,22 6,08<br />
331 1 58,85 0,05<br />
332 16 18719,04 17,20<br />
333 58 15714,95 14,44<br />
334 1 23,40 0,02<br />
335 9 4129,50 3,79<br />
512 5 351,15 0,32<br />
area totale cella 902 108836,42<br />
Tabella 78 - Copertura CLC nella cella 847 di Bobbio (PC)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
112 8 416,21 0,38<br />
211 55 5984,79 5,44<br />
231 7 735,76 0,67<br />
242 6 324,24 0,29<br />
243 121 28527,60 25,95<br />
311 46 45270,94 41,18<br />
312 29 2189,50 1,99<br />
313 46 13152,86 11,97<br />
321 39 4294,84 3,91<br />
324 98 7413,43 6,74<br />
331 8 924,24 0,84<br />
333 14 660,03 0,60<br />
512 1 29,45 0,03<br />
area totale cella 847 109923,88<br />
115
Tabella 79 - Copertura CLC nella cella 818 di Borgo Val di Taro (PR)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
111 1 63,20 0,06<br />
112 16 876,12 0,79<br />
121 4 142,78 0,13<br />
133 2 60,57 0,05<br />
142 1 45,61 0,04<br />
211 16 1224,32 1,11<br />
223 1 36,07 0,03<br />
231 2 121,74 0,11<br />
242 21 1742,94 1,58<br />
243 126 19924,84 18,03<br />
244 1 33,60 0,03<br />
311 25 75198,04 68,06<br />
312 17 984,61 0,89<br />
313 30 1977,00 1,79<br />
321 18 2470,91 2,24<br />
324 75 4988,73 4,51<br />
331 5 360,55 0,33<br />
333 2 240,75 0,22<br />
area totale cella 818 110492,38<br />
Tabella 80 - Copertura CLC nella cella 817 di Borzonasca (GE)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
111 2 187,35 0,17<br />
112 13 1488,82 1,35<br />
122 1 64,97 0,06<br />
123 1 64,14 0,06<br />
142 1 42,80 0,04<br />
211 7 664,12 0,60<br />
223 5 218,71 0,20<br />
231 3 97,85 0,09<br />
242 27 2202,37 1,99<br />
243 79 8539,29 7,73<br />
311 11 68863,44 62,33<br />
312 24 1857,66 1,68<br />
313 40 7107,81 6,43<br />
321 29 4991,74 4,52<br />
323 5 618,69 0,56<br />
324 93 8185,29 7,41<br />
333 10 746,73 0,68<br />
334 4 980,54 0,89<br />
512 2 118,67 0,11<br />
523 1 1820,33 1,65<br />
area totale cella 817 110483,76<br />
116
Tabella 81 - Copertura CLC nella cella 791 di Castel di Casio (BO)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
112 24 1738,393 1,56<br />
121 4 124,527 0,11<br />
131 1 25,506 0,02<br />
211 42 4098,017 3,69<br />
223 2 43,408 0,04<br />
231 18 884,515 0,80<br />
242 12 628,769 0,57<br />
243 109 23267,121 20,94<br />
311 40 68066,042 61,26<br />
312 28 2346,786 2,11<br />
313 83 6087,990 5,48<br />
321 3 268,732 0,24<br />
324 43 3138,676 2,82<br />
331 1 54,899 0,05<br />
333 1 38,270 0,03<br />
511 1 64,697 0,06<br />
512 2 236,231 0,21<br />
area totale cella 791 111112,58<br />
Tabella 82 - Copertura CLC nella cella 790 di Pievepelago (MO)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
112 25 1306,036 1,18<br />
121 3 112,855 0,10<br />
131 1 30,190 0,03<br />
142 1 53,865 0,05<br />
211 23 1478,455 1,33<br />
231 8 644,600 0,58<br />
242 10 1222,084 1,10<br />
243 95 16040,243 14,44<br />
311 26 72309,478 65,09<br />
312 27 2412,154 2,17<br />
313 81 7457,654 6,71<br />
321 24 5368,871 4,83<br />
322 4 260,347 0,23<br />
324 35 2024,856 1,82<br />
331 1 173,028 0,16<br />
332 2 54,808 0,05<br />
333 3 136,347 0,12<br />
area totale cella 790 111085,87<br />
117
Tabella 83 -.Copertura CLC nella cella 789 di Fivizzano (MS)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
111 4 212,41 0,19<br />
112 34 4501,85 4,05<br />
121 6 1172,19 1,06<br />
122 1 26,54 0,02<br />
123 1 39,80 0,04<br />
131 18 1455,05 1,31<br />
132 1 69,09 0,06<br />
141 2 60,64 0,05<br />
142 2 87,90 0,08<br />
211 13 1110,30 1,00<br />
221 2 376,18 0,34<br />
223 21 1539,16 1,39<br />
231 15 749,89 0,68<br />
241 2 96,98 0,09<br />
242 58 4102,62 3,69<br />
243 115 7910,40 7,12<br />
311 21 61935,23 55,76<br />
312 14 872,45 0,79<br />
313 64 6303,02 5,68<br />
321 31 3702,34 3,33<br />
323 3 322,75 0,29<br />
324 78 8303,47 7,48<br />
331 4 123,32 0,11<br />
332 12 972,20 0,88<br />
333 20 2171,57 1,96<br />
512 3 159,09 0,14<br />
523 1 1079,08 0,97<br />
area totale cella 789 111064,98<br />
118
Tabella 84 - Copertura CLC nella cella 763 di Bagno di Romagna (FO)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
112 15 957,932 0,86<br />
121 3 114,903 0,10<br />
122 1 30,662 0,03<br />
211 49 7231,607 6,47<br />
231 40 2794,084 2,50<br />
241 1 4,614 0,00<br />
242 24 3021,174 2,70<br />
243 95 14221,755 12,73<br />
244 1 10,536 0,01<br />
311 46 57322,929 51,30<br />
312 55 4681,843 4,19<br />
313 114 13503,895 12,08<br />
321 32 1428,268 1,28<br />
324 73 6072,200 5,43<br />
332 5 165,897 0,15<br />
333 2 91,046 0,08<br />
512 1 88,096 0,08<br />
area totale cella 763 111741,44<br />
Tabella 85 - Copertura CLC nella cella 676 di Visso (MC)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
112 13 401,32 0,35<br />
211 69 7495,01 6,60<br />
231 65 9549,38 8,41<br />
241 10 321,96 0,28<br />
242 104 6534,41 5,75<br />
243 123 10354,40 9,12<br />
311 85 42064,63 37,04<br />
312 20 1497,32 1,32<br />
313 26 1902,07 1,67<br />
321 57 15553,44 13,70<br />
322 26 1169,96 1,03<br />
323 3 351,10 0,31<br />
324 215 12161,43 10,71<br />
332 17 1348,83 1,19<br />
333 32 2685,79 2,37<br />
512 2 165,78 0,15<br />
area totale cella 676 113556,84<br />
119
Tabella 86 - Copertura CLC nella cella 646 di Cascia (PG)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
111 1 27,748 0,02<br />
112 14 643,049 0,56<br />
121 1 39,160 0,03<br />
133 1 25,273 0,02<br />
211 34 11897,602 10,43<br />
231 49 4426,246 3,88<br />
242 13 1028,514 0,90<br />
243 113 13261,093 11,62<br />
311 41 57280,778 50,20<br />
312 26 1520,107 1,33<br />
313 12 899,040 0,79<br />
321 91 12931,207 11,33<br />
322 17 786,644 0,69<br />
323 1 45,032 0,04<br />
324 152 7918,327 6,94<br />
331 1 98,579 0,09<br />
332 5 150,371 0,13<br />
333 26 1048,379 0,92<br />
512 2 76,704 0,07<br />
area totale cella 646 114103,85<br />
Tabella 87 - Copertura CLC nella cella 617 di Barisciano (AQ)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
111 2 264,476 0,23<br />
112 20 1440,066 1,26<br />
121 7 366,292 0,32<br />
142 2 74,078 0,06<br />
211 31 12253,897 10,68<br />
223 5 542,489 0,47<br />
231 11 2732,516 2,38<br />
241 1 206,782 0,18<br />
242 26 3044,966 2,65<br />
243 39 5553,558 4,84<br />
311 74 21224,890 18,50<br />
312 45 4028,868 3,51<br />
313 34 2226,229 1,94<br />
321 49 39370,594 34,32<br />
322 1 443,232 0,39<br />
324 76 10922,043 9,52<br />
332 12 4472,882 3,90<br />
333 37 5548,684 4,84<br />
area totale cella 617 114716,54<br />
120
Tabella 88 - Copertura CLC nella cella 616 di Petrella Salto (RI)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
112 20 741,16 0,65<br />
121 3 197,68 0,17<br />
124 1 30,45 0,03<br />
131 1 26,58 0,02<br />
211 30 9864,09 8,60<br />
223 5 244,57 0,21<br />
231 9 567,12 0,49<br />
241 1 136,74 0,12<br />
242 11 522,94 0,46<br />
243 83 11419,53 9,96<br />
311 54 58344,90 50,89<br />
312 19 1129,81 0,99<br />
313 33 3486,80 3,04<br />
321 76 16097,34 14,04<br />
322 9 397,01 0,35<br />
324 117 7619,20 6,65<br />
332 14 1298,54 1,13<br />
333 22 1394,39 1,22<br />
512 3 1128,84 0,98<br />
area totale cella 616 114647,70<br />
Tabella 89 - Copertura CLC nella cella 588 di Sulmona (AQ)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
111 5 270,46 0,23<br />
112 15 703,05 0,61<br />
121 5 353,67 0,31<br />
131 1 18,30 0,02<br />
211 19 5732,46 4,97<br />
223 12 1629,29 1,41<br />
231 14 3941,11 3,42<br />
242 24 6384,54 5,54<br />
243 33 3562,19 3,09<br />
311 64 34102,03 29,57<br />
312 53 5957,62 5,17<br />
313 45 4110,33 3,56<br />
321 46 25021,95 21,69<br />
322 6 1431,58 1,24<br />
324 80 14658,70 12,71<br />
332 7 534,87 0,46<br />
333 18 6832,19 5,92<br />
512 1 90,99 0,08<br />
area totale cella 588 115335,34<br />
121
Tabella 90 - Copertura CLC nella cella 587 di Celano (AQ)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
111 16 1148,818 1,00<br />
112 23 1239,719 1,08<br />
121 7 448,196 0,39<br />
131 3 196,469 0,17<br />
141 2 52,978 0,05<br />
211 15 18048,679 15,66<br />
212 1 14152,433 12,28<br />
223 1 171,248 0,15<br />
231 7 1662,743 1,44<br />
241 2 374,435 0,32<br />
242 27 4187,617 3,63<br />
243 21 5211,001 4,52<br />
311 42 24708,669 21,44<br />
312 21 1435,265 1,25<br />
313 16 1258,675 1,09<br />
321 57 22054,584 19,13<br />
322 8 3632,037 3,15<br />
324 70 10711,057 9,29<br />
332 14 2575,924 2,23<br />
333 16 1987,647 1,72<br />
area totale cella 587 115258,20<br />
Tabella 91 - Copertura CLC nella cella 586 di Pereto (AQ)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
111 3 180,58 0,16<br />
112 26 852,63 0,74<br />
121 3 171,41 0,15<br />
122 1 818,73 0,71<br />
211 20 7968,29 6,92<br />
223 5 270,36 0,23<br />
231 12 1399,27 1,21<br />
242 6 799,84 0,69<br />
243 71 12201,81 10,59<br />
311 50 61816,45 53,67<br />
312 12 706,92 0,61<br />
313 9 1117,41 0,97<br />
321 71 10084,32 8,75<br />
322 19 2358,41 2,05<br />
324 121 12879,96 11,18<br />
332 6 277,47 0,24<br />
333 14 1237,40 1,07<br />
512 1 47,10 0,04<br />
area totale cella 586 115188,36<br />
122
Tabella 92 - Copertura CLC nella cella 558 di Barrea (AQ)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
111 2 98,26 0,08<br />
112 17 705,43 0,61<br />
121 1 27,57 0,02<br />
131 2 81,59 0,07<br />
211 15 8162,31 7,04<br />
223 2 1041,54 0,90<br />
231 14 4769,53 4,12<br />
242 15 1429,19 1,23<br />
243 34 7800,12 6,73<br />
311 35 50871,09 43,90<br />
312 16 1198,49 1,03<br />
313 22 3293,81 2,84<br />
321 61 16448,25 14,19<br />
322 16 3265,76 2,82<br />
324 55 8506,70 7,34<br />
331 3 125,50 0,11<br />
332 20 2847,81 2,46<br />
333 23 4938,24 4,26<br />
512 3 265,19 0,23<br />
area totale cella 558 115876,37<br />
123
Tabella 93 - Copertura CLC nella cella 413 di San Martino d’Agri (PZ)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
112 13 532,25 0,45<br />
121 4 258,86 0,22<br />
124 1 49,47 0,04<br />
131 6 218,78 0,18<br />
133 1 28,22 0,02<br />
211 104 16456,06 13,82<br />
221 1 28,69 0,02<br />
222 5 516,53 0,43<br />
223 20 3589,55 3,02<br />
231 10 731,69 0,61<br />
241 58 6403,68 5,38<br />
242 19 1884,21 1,58<br />
243 117 12534,42 10,53<br />
311 81 50793,93 42,66<br />
312 10 633,40 0,53<br />
313 11 1514,90 1,27<br />
321 46 9426,54 7,92<br />
322 47 4396,60 3,69<br />
323 6 775,32 0,65<br />
324 82 5775,85 4,85<br />
331 9 1447,77 1,22<br />
332 2 311,93 0,26<br />
333 7 328,17 0,28<br />
411 1 33,16 0,03<br />
512 1 384,36 0,32<br />
area totale cella 413 119054,34<br />
124
Tabella 94 - Copertura CLC nella cella 412 di Sanza (SA)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
111 8 343,289 0,29<br />
112 24 1346,291 1,13<br />
121 1 35,537 0,03<br />
122 3 123,208 0,10<br />
131 7 183,034 0,15<br />
211 32 13057,475 10,98<br />
221 1 129,761 0,11<br />
223 4 557,058 0,47<br />
231 15 1020,720 0,86<br />
241 32 3793,966 3,19<br />
242 31 4648,595 3,91<br />
243 95 7913,042 6,65<br />
311 47 55415,450 46,59<br />
312 17 1516,585 1,28<br />
313 20 2267,298 1,91<br />
321 113 14208,234 11,95<br />
322 10 613,829 0,52<br />
323 9 1513,314 1,27<br />
324 104 6905,276 5,81<br />
331 2 74,833 0,06<br />
332 1 121,905 0,10<br />
333 21 3145,079 2,64<br />
area totale cella 412 118933,78<br />
125
Tabella 95 - Copertura CLC nella cella 383 di Rotonda (PZ)<br />
CODE_00 COUNT SUM_HA %<br />
111 1 59,59 0,05<br />
112 21 1011,41 0,85<br />
121 4 183,74 0,15<br />
131 12 484,96 0,41<br />
132 1 31,92 0,03<br />
211 37 5809,35 4,86<br />
221 2 60,80 0,05<br />
222 1 10,95 0,01<br />
223 10 409,87 0,34<br />
231 3 88,73 0,07<br />
241 59 7325,47 6,13<br />
242 32 2831,57 2,37<br />
243 135 10060,33 8,41<br />
311 51 55671,77 46,56<br />
312 17 2473,24 2,07<br />
313 29 6988,57 5,84<br />
321 81 12099,88 10,12<br />
322 26 3182,31 2,66<br />
323 7 535,36 0,45<br />
324 82 5857,45 4,90<br />
331 4 579,81 0,48<br />
332 19 1656,00 1,38<br />
333 13 1948,62 1,63<br />
334 1 91,37 0,08<br />
411 1 26,89 0,02<br />
512 2 100,07 0,08<br />
area totale cella 383 119580,02<br />
126
Tabella 96 - Copertura in ettari della cat. 3. Territori boscati e ambienti seminaturali nelle celle della Regione Temperata<br />
CODE_00 383 412 413 558 559 586 587 588<br />
311 - Boschi di latifoglie 55671,77 55415,45 50793,93 50871,09 38231,45 61816,45 24708,67 34102,03<br />
312 - Boschi di conifere 2473,24 1516,59 633,40 1198,49 986,05 706,92 1435,27 5957,62<br />
313 - Boschi misti di conifere e latif. 6988,57 2267,30 1514,90 3293,81 1735,32 1117,41 1258,68 4110,33<br />
321 - Aree a pascolo naturale e prat. 12099,88 14208,23 9426,54 16448,25 10089,04 10084,32 22054,58 25021,95<br />
322 - Brughiere e cespuglieti 3182,31 613,83 4396,60 3265,76 6820,48 2358,41 3632,04 1431,58<br />
323 - Aree a vegetazione sclerofilla 535,36 1513,31 775,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
324 - Aree a vegetazione boschiva ed 5857,45 6905,28 5775,85 8506,70 9478,02 12879,96 10711,06 14658,70<br />
arbustiva in evoluzione<br />
331 - Spiagge, dune e sabbie 579,81 74,83 1447,77 125,50 410,97 0,00 0,00 0,00<br />
332 - Rocce nude, falesie, rupi, affior. 1656,00 121,91 311,93 2847,81 0,00 277,47 2575,92 534,87<br />
333 - Aree con vegetazione rada 1948,62 3145,08 328,17 4938,24 3461,28 1237,40 1987,65 6832,19<br />
334 - Aree percorse da incendi 91,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
335 - Ghiacciai e nevi perenni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
area totale cella (ha) 119580,02 118933,78 119054,34 115876,37 115960,96 115188,36 115258,20 115335,34<br />
CODE_00 616 617 646 676 763 789 790 791<br />
311 - Boschi di latifoglie 58344,90 21224,89 57280,78 42064,63 57322,93 61935,23 72309,48 68066,04<br />
312 - Boschi di conifere 1129,81 4028,87 1520,11 1497,32 4681,84 872,45 2412,15 2346,79<br />
313 - Boschi misti di conifere e latif. 3486,80 2226,23 899,04 1902,07 13503,90 6303,02 7457,65 6087,99<br />
321 - Aree a pascolo naturale e prat. 16097,34 39370,59 12931,21 15553,44 1428,27 3702,34 5368,87 268,73<br />
322 - Brughiere e cespuglieti 397,01 443,23 786,64 1169,96 0,00 0,00 260,35 0,00<br />
323 - Aree a vegetazione sclerofilla 0,00 0,00 45,03 351,10 0,00 322,75 0,00 0,00<br />
324 - Aree a vegetazione boschiva ed 7619,20 10922,04 7918,33 12161,43 6072,20 8303,47 2024,86 3138,68<br />
arbustiva in evoluzione<br />
331 - Spiagge, dune e sabbie 0,00 0,00 98,58 0,00 0,00 123,32 173,03 54,90<br />
332 - Rocce nude, falesie, rupi, affior. 1298,54 4472,88 150,37 1348,83 165,90 972,20 54,81 38,27<br />
333 - Aree con vegetazione rada 1394,39 5548,68 1048,38 2685,79 91,05 2171,57 136,35 0,00<br />
334 - Aree percorse da incendi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
335 - Ghiacciai e nevi perenni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
area totale cella (ha) 114647,70 114716,54 114103,85 113556,84 111741,44 111064,98 111085,87 111112,58<br />
127
CODE_00 817 818 847 902 932 933 964 968<br />
311 - Boschi di latifoglie 68863,44 75198,04 45270,94 20414,04 1239,63 11817,20 25311,02 18849,43<br />
312 - Boschi di conifere 1857,66 984,61 2189,50 4246,40 22482,50 21134,20 12083,95 15692,25<br />
313 - Boschi misti di conifere e latif. 7107,81 1977,00 13152,86 4393,59 2769,17 6459,28 12534,96 22767,11<br />
321 - Aree a pascolo naturale e prat. 4991,74 2470,91 4294,84 16189,69 10629,80 14066,99 16956,11 19754,47<br />
322 - Brughiere e cespuglieti 0,00 0,00 0,00 6817,13 3262,05 6354,75 5461,96 1644,80<br />
323 - Aree a vegetazione sclerofilla 618,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
324 - Aree a vegetazione boschiva ed 8185,29 4988,73 7413,43 6612,22 11279,13 15151,84 9022,04 5065,50<br />
arbustiva in evoluzione<br />
331 - Spiagge, dune e sabbie 0,00 360,55 924,24 58,85 0,00 0,00 548,19 0,00<br />
332 - Rocce nude, falesie, rupi, affior. 0,00 0,00 0,00 18719,04 25178,89 9455,92 6795,64 10964,54<br />
333 - Aree con vegetazione rada 746,73 240,75 660,03 15714,95 15348,66 10574,84 4359,19 4341,71<br />
334 - Aree percorse da incendi 980,54 0,00 0,00 23,40 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
335 - Ghiacciai e nevi perenni 0,00 0,00 0,00 4129,50 3217,98 0,00 194,06 158,61<br />
area totale cella (ha) 110483,76 110492,38 109923,88 108836,42 108265,19 108245,10 107656,55 107654,58<br />
CODE_00 969 970 972 1000 1001 1002 1003 1004<br />
311 - Boschi di latifoglie 13718,78 10075,75 17805,16 644,29 5652,64 2814,33 8157,11 20468,56<br />
312 - Boschi di conifere 21542,82 20042,27 37737,69 27134,96 33743,86 51168,58 42305,05 22677,73<br />
313 - Boschi misti di conifere e latif. 22035,03 28012,20 20645,63 3205,60 17186,05 12895,96 12480,90 18916,66<br />
321 - Aree a pascolo naturale e prat. 15899,97 11782,46 6289,50 8738,16 3554,89 4892,43 8837,55 5639,09<br />
322 - Brughiere e cespuglieti 2793,38 3294,37 985,83 3745,61 2631,33 3174,07 3387,83 7008,65<br />
323 - Aree a vegetazione sclerofilla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
324 - Aree a vegetazione boschiva ed 5746,17 7681,97 1988,59 6655,11 6080,89 6645,79 4771,15 3204,32<br />
arbustiva in evoluzione<br />
331 - Spiagge, dune e sabbie 0,00 0,00 60,38 42,88 0,00 0,00 117,81 1918,65<br />
332 - Rocce nude, falesie, rupi, affior. 5479,60 7173,03 52,56 26331,27 6306,17 6577,51 10067,37 2903,76<br />
333 - Aree con vegetazione rada 7753,64 8386,42 1861,80 17538,15 5309,29 4549,84 9265,20 7584,65<br />
334 - Aree percorse da incendi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,11<br />
335 - Ghiacciai e nevi perenni 225,04 11,73 0,00 7696,33 0,00 0,00 39,58 0,00<br />
area totale cella (ha) 107667,59 107686,62107740,51 107110,74 107134,65 107163,76 107198,79 107238,78<br />
128
CODE_00 1005 1030 1031 1033 1034 1062 1063<br />
311 - Boschi di latifoglie 29304,41 342,59 3267,07 81,28 38,73 0,00 79,62<br />
312 - Boschi di conifere 4679,27 25503,86 44322,08 42318,55 58454,54 42534,51 50830,13<br />
313 - Boschi misti di conifere e latif. 32503,07 147,84 6453,51 369,50 2559,59 58,81 678,75<br />
321 - Aree a pascolo naturale e prat. 6826,76 11037,80 5521,91 17290,04 6529,87 19168,55 11919,22<br />
322 - Brughiere e cespuglieti 0,00 0,00 1530,09 2540,00 3207,90 3968,57 2071,26<br />
323 - Aree a vegetazione sclerofilla 3497,05 1889,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
324 - Aree a vegetazione boschiva ed 3151,78 6104,66 8055,18 5964,48 2330,26 7491,08 4384,07<br />
arbustiva in evoluzione<br />
331 - Spiagge, dune e sabbie 2943,60 57,09 0,00 43,96 294,61 33,14 26,61<br />
332 - Rocce nude, falesie, rupi, affior. 1165,80 23854,59 5348,33 18286,31 18161,00 10755,36 8208,00<br />
333 - Aree con vegetazione rada 2624,53 14057,80 7736,58 9692,23 9220,37 8791,52 7559,20<br />
334 - Aree percorse da incendi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
335 - Ghiacciai e nevi perenni 0,00 8458,26 137,98 234,24 298,91 218,27 2400,59<br />
area totale cella (ha) 107284,71 106529,12 106552,64 106615,73 106655,07 105997,15 106031,05<br />
129
Identificativo delle celle<br />
383<br />
412<br />
413<br />
558<br />
559<br />
586<br />
587<br />
588<br />
616<br />
617<br />
646<br />
676<br />
763<br />
789<br />
790<br />
791<br />
Figura 37 - Copertura della cat. 3. Territori boscati e ambienti seminaturali<br />
nelle celle (383-791) della Regione Temperata<br />
0% 20% 40% 60% 80% 100%<br />
Copertura % delle voci di III livello<br />
311 - Boschi di latifoglie<br />
312 - Boschi di conifere<br />
313 - Boschi misti di conifere e<br />
latifoglie<br />
321 - Aree a pascolo naturale e<br />
praterie<br />
322 - Brughiere e cespuglieti<br />
323 - Aree a vegetazione sclerofilla<br />
324 - Aree a vegetazione boschiva<br />
ed arbustiva in evoluzione<br />
331 - Spiagge, dune e sabbie<br />
332 - Rocce nude, falesie, rupi,<br />
affioramenti<br />
333 - Aree con vegetazione rada<br />
334 - Aree percorse da incendi<br />
335 - Ghiacciai e nevi perenni<br />
130
Celle della Regione Temperata<br />
817<br />
818<br />
847<br />
902<br />
932<br />
933<br />
964<br />
968<br />
969<br />
970<br />
972<br />
1000<br />
1001<br />
1002<br />
1003<br />
1004<br />
Figura 38 - Copertura della cat. 3. Territori boscati e ambienti seminaturali<br />
nelle celle (817-1004) della Regione Temperata<br />
0% 20% 40% 60% 80% 100%<br />
Copertura % delle voci di III livello<br />
311 - Boschi di latifoglie<br />
312 - Boschi di conifere<br />
313 - Boschi misti di conifere e<br />
latifoglie<br />
321 - Aree a pascolo naturale e<br />
praterie<br />
322 - Brughiere e cespuglieti<br />
323 - Aree a vegetazione<br />
sclerofilla<br />
324 - Aree a vegetazione<br />
boschiva ed arbustiva in<br />
evoluzione<br />
331 - Spiagge, dune e sabbie<br />
332 - Rocce nude, falesie, rupi,<br />
affioramenti<br />
333 - Aree con vegetazione rada<br />
334 - Aree percorse da incendi<br />
335 - Ghiacciai e nevi perenni<br />
131
Celle della Regione Temperata<br />
1063<br />
1062<br />
1034<br />
1033<br />
1031<br />
1030<br />
1005<br />
Figura 39 - Copertura della cat. 3. Territori boscati e ambienti seminaturali<br />
nelle celle (1005-1063) della Regione Temperata<br />
0% 20% 40% 60% 80% 100%<br />
Copertura % delle voci di III livello<br />
311 - Boschi di latifoglie<br />
312 - Boschi di conifere<br />
313 - Boschi misti di conifere e<br />
latifoglie<br />
321 - Aree a pascolo naturale e<br />
praterie<br />
322 - Brughiere e cespuglieti<br />
323 - Aree a vegetazione<br />
sclerofilla<br />
324 - Aree a vegetazione<br />
boschiva ed arbustiva in<br />
evoluzione<br />
331 - Spiagge, dune e sabbie<br />
132
3.2.2.4 – Bioclimi e serie di vegetazione nelle celle<br />
Tutte le celle di campionamento sono analizzate in funzione della propria eterogeneità bioclimatica<br />
e di vegetazione naturale potenziale. Un primo risultato di sintesi è riportato nelle tabelle 97, 98 e<br />
99 dove sono indicati – ripartiti per regione macroclimatica ed appartenenza geografica alla zona<br />
alpina, alla penisola e alle isole maggiori - il numero di bioclimi e di serie di vegetazione per<br />
ciascuna unità campione.<br />
I grafici nelle figure 40, 41 e 42 mettono in evidenza la numerosità di bioclimi e di serie<br />
vegetazione presenti all’interno delle unità di campionamento e ben rappresentano la grande<br />
eterogeneità del nostro territorio.<br />
Nella Regione Mediterranea il maggior numero di serie (Tabella 97, Figura 40) si osserva:<br />
- nella cella 414 di Tusi, in provincia di Matera (12 serie di cui 5 geosigmeti);<br />
- in tre celle siciliane, la 169 di Mistretta in provincia di Messina, la 170 di Bronte e la 171 di<br />
Castiglione di Sicilia (rispettivamente 13 e ben 21 serie), ambedue nella provincia catanese;<br />
- in tre celle sarde, ossia la 456 di Bordigiadas (11 serie e 1 geosigmeto), la 457 di Telti (12 serie)<br />
e la 487 di Arzachena (11 serie), queste ultime in provincia di Sassari.<br />
Nelle unità campione 169 e 457 si verifica anche il maggior numero di bioclimi (4).<br />
Tabella 97 - Numero dei bioclimi e delle serie di vegetazione (e/o geosigmeti) nelle celle della<br />
Regione Mediterranea<br />
Regione Mediterranea PROGR GRIGLIA_ID Bioclimi Serie (e/o geosigmeti)<br />
Penisola<br />
Sicilia<br />
Sardegna<br />
1 325 3 8<br />
2 414 2 12<br />
3 169 4 15<br />
4 170 3 13<br />
5 171 3 21<br />
6 276 3 7<br />
7 305 3 9<br />
8 307 3 9<br />
9 337 3 8<br />
10 366 3 9<br />
11 367 3 8<br />
12 396 3 9<br />
13 397 3 9<br />
14 427 3 7<br />
15 456 3 12<br />
16 457 4 12<br />
17 487 2 11<br />
133
Tabella 98 - Numero dei bioclimi e delle serie di vegetazione (e/o geosigmeti) nelle celle<br />
peninsulari della Regione Temperata<br />
Regione Temperata PROGR GRIGLIA_ID Bioclimi Serie (e/o geosigmeti)<br />
Penisola<br />
1 383 3 16<br />
2 412 3 13<br />
3 413 3 8<br />
4 558 3 13<br />
5 559 6 12<br />
6 586 3 15<br />
7 587 3 9<br />
8 588 4 12<br />
9 616 4 15<br />
10 617 4 10<br />
11 646 4 17<br />
12 676 4 16<br />
13 763 4 10<br />
14 789 6 17<br />
15 790 5 12<br />
16 791 5 11<br />
17 818 8 13<br />
Nell’Italia peninsulare temperata (Tabella 98, Figura 41) vi sono celle con un numero di bioclimi<br />
mediamente più elevato:<br />
- 8 bioclimi nell’unità di campionamento 818 di Borgo Val di Taro nella provincia parmense;<br />
- 6 bioclimi nella cella 559 (l’area campione dell’Alto Molise) e nella 789 di Fivizzano (MS).<br />
In quest’ultima sono stati identificati ben 17 tra serie di vegetazione (12) e geosigmeti (5), il valore<br />
più elevato. Questo valore, il più elevato in tutta quest’area, è proprio della cella perugina 646 di<br />
Cascia (14 serie di vegetazione e 3 geosigmeti). Una numerosità elevata in termini di vegetazione<br />
naturale potenziale (16 serie) è riscontrabile anche nelle unità campione 383 di Rotonda in<br />
provincia di Potenza e 676 di Visso in provincia di Macerata (in entrambe 3 su 16 sono geosigmeti)<br />
Nelle celle alpine della Regione Temperata la maggiore variabilità in termini di vegetazione<br />
naturale potenziale (16 serie) si osserva nelle celle 1033 di Badia (BZ) e 933 di Issogne (AO), nella<br />
quale vi è la numerosità più elevata anche dal punto di vista bioclimatico (5 bioclimi).<br />
In generale nelle celle alpine si riscontra un numero superiore di geosigmeti rispetto al numero di<br />
serie di vegetazione, fatto che risulta evidente nell’analisi condotta sulle singole celle.<br />
134
Tabella 99 - Numero dei bioclimi e delle serie di vegetazione (e/o geosigmeti) nelle celle alpine<br />
della Regione Temperata<br />
Regione Temperata PROGR GRIGLIA_ID Bioclimi Serie (e/o geosigmeti)<br />
Alpi<br />
18 817 5 13<br />
19 847 4 12<br />
20 902 3 10<br />
21 932 2 11<br />
22 933 5 16<br />
23 964 4 9<br />
24 968 3 14<br />
25 969 4 12<br />
26 970 3 14<br />
27 972 3 15<br />
28 1000 4 15<br />
29 1001 4 15<br />
30 1002 4 14<br />
31 1003 4 15<br />
32 1004 3 15<br />
33 1005 3 13<br />
34 1030 3 14<br />
35 1031 4 13<br />
36 1033 3 16<br />
37 1034 4 17<br />
38 1062 2 11<br />
39 1063 2 11<br />
Questi risultati evidenziano che l’applicabilità del Protocollo di Kyoto ai sensi dell’articolo 3.3 che<br />
prevede attività obbligatorie di afforestazione e riforestazione e dell’articolo 3.4 che richiede<br />
attività di gestione delle foreste, delle terre agricole, dei prati e dei pascoli, e di rivegetazione, è<br />
possibile in Italia solo se attuata in ambiti omogenei definiti dalle caratteristiche bioclimatiche e<br />
vegetazionali del territorio.<br />
135
Numero (bioclimi/serie)<br />
25<br />
24<br />
23<br />
22<br />
21<br />
20<br />
19<br />
18<br />
17<br />
16<br />
15<br />
14<br />
13<br />
12<br />
11<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
325<br />
414<br />
169<br />
170<br />
Figura 40 - Numero di bioclimi e serie di vegetazione<br />
nelle celle della Regione Mediterranea<br />
171<br />
276<br />
305<br />
307<br />
337<br />
366<br />
Identificativo celle<br />
367<br />
396<br />
397<br />
427<br />
456<br />
Serie<br />
Bioclimi<br />
457<br />
487<br />
136
Numero (bioclimi/serie)<br />
25<br />
24<br />
23<br />
22<br />
21<br />
20<br />
19<br />
18<br />
17<br />
16<br />
15<br />
14<br />
13<br />
12<br />
11<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
383<br />
412<br />
413<br />
558<br />
Figura 41 - Numero di bioclimi e serie di vegetazione<br />
nelle celle peninsulari della Regione Temperata<br />
559<br />
586<br />
587<br />
588<br />
616<br />
617<br />
Identificativo celle<br />
646<br />
676<br />
763<br />
789<br />
Serie<br />
Bioclimi<br />
790<br />
791<br />
818<br />
137
Numero (bioclimi/serie)<br />
23<br />
22<br />
21<br />
20<br />
19<br />
18<br />
17<br />
16<br />
15<br />
14<br />
13<br />
12<br />
11<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
817<br />
847<br />
902<br />
932<br />
933<br />
964<br />
Figura 42 - Numero di bioclimi e serie di vegetazione<br />
nelle celle alpine della Regione Temperata<br />
968<br />
969<br />
970<br />
972<br />
1000<br />
1001<br />
1002<br />
Identificativo celle<br />
1003<br />
1004<br />
1005<br />
1030<br />
1031<br />
Serie<br />
Bioclimi<br />
1033<br />
1034<br />
1062<br />
1063<br />
138
3.2.2.4 a – Bioclimi nelle celle<br />
Il Macroclima Temperato è localizzato nell’Italia<br />
settentrionale, in tutto l’arco appenninico,<br />
l’antiappenninico e nelle isole maggiori a medie e alte<br />
quote e copre una superficie pari a 20.464.604 ha<br />
(±68%) del territorio italiano.<br />
La Regione Mediterranea si estende per 9.744.205 ha<br />
(±32% della penisola) su tutto il versante tirrenico, a<br />
esclusione di un tratto della Riviera di levante in<br />
Liguria, continua nelle grandi e piccole isole, nella<br />
parte ionica ed in adriatico fino ad arrivare in<br />
Abruzzo all’altezza di Pescara (Figura 43).<br />
Figura 43 - Regione Temperata e Regione<br />
Mediterranea, dalla Carta del Fitoclima d’Italia<br />
(Blasi et al. 2005; Blasi, 2004)<br />
Le regioni di Transizione sono geograficamente<br />
contigue ai macroclimi corrispondenti. La Regione<br />
Mediterranea di Transizione è costituita da classi nel<br />
cui interno si nota la contemporanea presenza di<br />
stazioni termopluviometriche mediterranee e temperate con prevalenza delle prime, così come nella<br />
Regione Temperata di Transizione le stazioni temperate prevalgono sulle mediterranee.<br />
Un Macroclima può caratterizzare più classi e per questa ragione le classi sono state raggruppate in<br />
funzione dei Bioclimi, complessi climatici definiti in funzione del valore dell’indice di<br />
continentalità Ic. Ciascuno dei 9 bioclimi individuati evidenzia vaste aree omogenee per caratteri<br />
fisici e andamento dei parametri climatici, quali altitudine, esposizione (tirrenica o adriatica),<br />
precipitazione, morfologie particolari (vallate alpine, vallate interne appenniniche e delle isole<br />
maggiori), pianure costiere. Di seguito una breve descrizione dei parametri che li caratterizzano:<br />
11 - Bioclima mediterraneo oceanico: comprende le classi 14-15-18 e contorna tutta l’Italia dalla<br />
liguria all’Abruzzo. E’ presente dal basso Lazio a Pescara e nelle grandi isole. I tipi climatici<br />
variano da un inframediterraneo secco-subumido ad un termomediterraneo subumido.<br />
21 - Bioclima mediterraneo oceanico di transizione: comprende le classi 17-20 ha una presenza<br />
continua sulle coste del medio e alto tirreno. Risulta più frammentato nel basso tirreno e Sicilia: si<br />
segnala una importante presenza nelle pianure interne e nei primi contrafforti della Sardegna. I tipi<br />
climatici variano da un termotemperato umido-subumido ad un mesomediterraneo umidosubumido.<br />
31 - Bioclima temperato oceanico: comprende le classi 1-3-6-7-10 ed è tipico di tutto l’arco<br />
alpino, appenninico ad alta e media quota e nella Sicilia. I tipi climatici variano da criorotemperato<br />
ultraiperumido-iperumido a mesotemperato iperumido-umido.<br />
139
32 - Bioclima temperato semicontinentale: comprende le classi 2-12-28 ed è localizzato nelle<br />
vallate alpine e nelle vallate interne dell’Appennino centro-settentrionale a esposizione<br />
prevalentemente adriatica. I tipi climatici variano da orotemperato umido-subumido/iperumido a<br />
supratemperato umido-subumido.<br />
Figura 44 – Bioclimi italiani, dalla Carta del<br />
Fitoclima d’Italia (Blasi, 2004; Blasi et al., 2005)<br />
33 - Bioclima temp. oceanico semicontinentale:<br />
comprende le classi 4-5-9-16-21 ed è ubicato nelle<br />
prealpi centrali ed orientali, in zone collinari del<br />
medio adriatico e nelle valli interne di tutto<br />
l’Appennino fino alla Basilicata con esposizione<br />
tirrenica. Locali presenze in Sardegna. I tipi climatici<br />
variano da supratemperato/orotemperato iperumidoultraiperumido<br />
a mesotemperato umido subumido.<br />
34 - Bioclima temp. subcontinentale: comprendente<br />
le classi 24-26 ed ètipico della Pianura Padana dal<br />
Piemonte alla foce del Po. I tipi climatici variano da<br />
supratemperato umido-subumido a mesotemperato<br />
umido-subumido.<br />
35 - Bioclima temp. semicont. - subcontinentale:<br />
comprendente le classi 13-23-25 ed è localizzato a sud del Po , nelle valli moreniche prealpine<br />
centrali e nelle pianure alluvionali della parte orientale dell’Italia settentrionale. I tipi climatici<br />
variano da supratemperato iperumido/umido a mesotemperato umido-subumido.<br />
41 - Bioclima temperato oceanico di transizione: comprendente la classe 8 ed è ubicato<br />
prevalentemente in tutte le valli dell’antiappennino tirrenico e ionico, con significative presenze<br />
nelle grandi isole. I tipi climatici variano da mesotemperato a mesomediterraneo umido/iperumido.<br />
42 - Bioclima temperato oceanico-semicontinentale di transizione: comprendente le classi 11-<br />
19-22-27 edè localizzato prevalentemente nelle pianure e nei primi contrafforti collinari del medio<br />
e basso adriatico e ionico; presenze significative nelle zone interne delle Madonie in alcune aree<br />
della Sardegna. I tipi climatici variano da supratemperato umido-subumido a mesomediterraneo<br />
umido-subumido.<br />
140
3.2.2.4 a – Bioclimi nelle celle<br />
Sono presentati (nelle tabelle da 100 a 154) i risultati derivanti dall’intersezione cartografica tra il<br />
piano tematico dei nove bioclimi e quello delle celle campione, fatta eccezione per la cella 559<br />
dell’Alto Molise già analizzata in dettaglio.<br />
Ciascuna tabella è composta dalle colonne:<br />
PROGR che riporta un valore numerico progressivo, indicante anche il numero dei bioclimi<br />
presenti nella cella.<br />
BIOCLI<strong>MA</strong> in cui è indicato il nome del bioclima.<br />
SUM_HA che rappresenta il valore di copertura in ettari (approssimato alla seconda cifra<br />
decimale) di ciascun complesso bioclimatico rispetto all’estensione totale della cella.<br />
% che rappresenta la percentuale di copertura (approssimata alla seconda cifra<br />
decimale) di ciascun bioclima rispetto all’estensione totale della cella.<br />
E’ opportuno precisare che:<br />
a) Nelle unità campione<br />
(Figure 45 e 46) ricadenti<br />
oltre i confini nazionali<br />
(902, 964, 1030, 1034,<br />
1062 e 1063) oppure in<br />
mare (276, 305, 307, 325,<br />
414, 456, 487, 789 e 817)<br />
l’estensione dei bioclimi<br />
è stata comunque<br />
calcolata rispetto all’area<br />
totale della cella.<br />
Figura 45 - Celle campione<br />
della Regione Temperata<br />
site ai confini del territorio<br />
nazionale o ricadenti in<br />
mare<br />
141
Figura 46 - Celle campione della Regione Mediterranea ricadenti in mare<br />
b) I valori di copertura dei bioclimi sono disposti in ordine decrescente.<br />
c) Vengono presentate prima le 17 tabelle della Regione Mediterranea, poi le 38 della Regione<br />
Temperata (quella relativa alla cella 559 dell’Alto Molise è già stata esaminata).<br />
142
REGIONE MEDITERRANEA<br />
Tabella 100 – Estensione dei bioclimi nella cella 487 di Arzachena (SS)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 11 - Mediterraneo oceanico 51.083,06 43,87<br />
2 21 - Mediterraneo oceanico di transizione 21.045,11 18,07<br />
area totale cella 487 116.449,73<br />
Tabella 101 - Estensione dei bioclimi nella cella 457 di Telti (SS)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 21 - Mediterraneo oceanico di transizione 66.073,53 56,49<br />
2 11 - Mediterraneo oceanico 37.008,87 31,64<br />
3 41 - Temperato oceanico di transizione 10.718,89 9,16<br />
4 42 - Temperato oceanico-semicontinentale di transizione 1.327,83 1,14<br />
5 33 - Temperato oceanico semicontinentale 585,41 0,50<br />
area totale cella 457 116972,83<br />
Tabella 102 - Estensione dei bioclimi nella cella 456 di Bortigiadas (SS)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 21 - Mediterraneo oceanico di transizione 66.683,13 57,01<br />
2 11 - Mediterraneo oceanico 40.827,78 34,90<br />
3 42 - Temperato oceanico-semicontinentale di transizione 2.803,01 2,40<br />
4 33 - Temperato oceanico semicontinentale 122,79 0,10<br />
area totale cella 456 116970,25<br />
Tabella 103 - Estensione dei bioclimi nella cella 427 di Bitti (NU)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 41 - Temperato oceanico di transizione 64.958,65 55,29<br />
2 21 - Mediterraneo oceanico di transizione 38.974,42 33,17<br />
3 11 - Mediterraneo oceanico 5.543,67 4,72<br />
4 33 - Temperato oceanico semicontinentale 3.835,43 3,26<br />
5 42 - Temperato oceanico-semicontinentale di transizione 3.796,16 3,23<br />
6 31 - Temperato oceanico 384,33 0,33<br />
area totale cella 427 117492,66<br />
143
Tabella 104 - Estensione dei bioclimi nella cella 414 di Tusi (MT)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 42 - Temperato oceanico-semicontinentale di transizione 107.247,46 91,28<br />
2 11 - Mediterraneo oceanico 7.799,52 6,64<br />
3 33 - Temperato oceanico semicontinentale 3.337,32 2,84<br />
area totale cella 427 117492,66<br />
Tabella 105 - Estensione dei bioclimi nella cella 397 di Oliena (NU)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 11 - Mediterraneo oceanico 16.036,14 13,59<br />
2 21 - Mediterraneo oceanico di transizione 46.689,78 39,56<br />
3 31 - Temperato oceanico 1.674,03 1,42<br />
4 41 - Temperato oceanico di transizione 53.610,76 45,43<br />
area totale cella 397 118010,71<br />
Tabella 106 - Estensione dei bioclimi nella cella 396 di Bortigali (NU)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 21 - Mediterraneo oceanico di transizione 83.199,75 70,50<br />
2 41 - Temperato oceanico di transizione 17.362,82 14,71<br />
3 11 - Mediterraneo oceanico 16.517,39 14,00<br />
4 33 - Temperato oceanico semicontinentale 928,10 0,79<br />
area totale cella 396 118.008,06<br />
Tabella 107 - Estensione dei bioclimi nella cella 367 di Desulo (NU)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 41 - Temperato oceanico di transizione 72.216,42 60,93<br />
2 21 - Mediterraneo oceanico di transizione 22.916,17 19,33<br />
3 31 - Temperato oceanico 19.166,04 16,17<br />
4 11 - Mediterraneo oceanico 3.798,92 3,21<br />
5 33 - Temperato oceanico semicontinentale 424,92 0,36<br />
area totale cella 367 118.522,47<br />
144
Tabella 108 - Estensione dei bioclimi nella cella 366 di Samugheo (OR)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 21 - Mediterraneo oceanico di transizione 91.331,24 77,06<br />
2 41 - Temperato oceanico di transizione 16.300,70 13,75<br />
3 11 - Mediterraneo oceanico 10.887,84 9,19<br />
area totale cella 366 118.519,78<br />
Tabella 109 - Estensione dei bioclimi nella cella 337 di Escalaplano (NU)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 21 - Mediterraneo oceanico di transizione 101.901,61 85,61<br />
2 41 - Temperato oceanico di transizione 9.740,31 8,18<br />
3 11 - Mediterraneo oceanico 6.766,57 5,68<br />
4 42 - Temperato oceanico-semicontinentale di transizione 623,93 0,52<br />
area totale cella 337 119.032,42<br />
Tabella 110 - Estensione dei bioclimi nella cella 325 di Campana (CS)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 11 - Mediterraneo oceanico 56.943,64 47,10<br />
2 41 - Temperato oceanico di transizione 26.138,59 21,62<br />
3 31 - Temperato oceanico 19.963,60 16,51<br />
4 21 - Mediterraneo oceanico di transizione 14.208,06 11,75<br />
area totale cella 325 120.898,52<br />
Tabella 111 - Estensione dei bioclimi nella cella 307 di Sinnai (CA)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 21 - Mediterraneo oceanico di transizione 60.784,95 50,85<br />
2 11 - Mediterraneo oceanico 46.372,92 38,79<br />
3 41 - Temperato oceanico di transizione 8.982,12 7,51<br />
area totale cella 307 119.539,06<br />
Tabella 112 - Estensione dei bioclimi nella cella 305 di Iglesias (CA)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 21 - Mediterraneo oceanico di transizione 61864,20 51,75<br />
2 11 - Mediterraneo oceanico 35469,62 29,67<br />
3 42 - Temperato oceanico-semicontinentale di transizione 2717,73 2,27<br />
area totale cella 305 119540,85<br />
145
Tabella 113 - Estensione dei bioclimi nella cella 276 di Pula (CA)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 21 - Mediterraneo oceanico di transizione 37232,46 31,02<br />
2 11 - Mediterraneo oceanico 34793,51 28,99<br />
3 41 - Temperato oceanico di transizione 1545,49 1,29<br />
area cella 276 120039,56<br />
Tabella 114 - Estensione dei bioclimi nella cella 171 di Castiglione di Sicilia (CT)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 11 - Mediterraneo oceanico 31.848,52 25,91<br />
2 41 - Temperato oceanico di transizione 23.746,60 19,32<br />
3 21 - Mediterraneo oceanico di transizione 16.090,52 13,09<br />
4 31 - Temperato oceanico 15.224,68 12,39<br />
area totale cella 171 122.918,83<br />
Tabella 115 - Estensione dei bioclimi nella cella 170 di Bronte (CT)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 41 - Temperato oceanico di transizione 45.846,41 37,33<br />
2 31 - Temperato oceanico 44.751,71 36,44<br />
3 21 - Mediterraneo oceanico di transizione 25.888,81 21,08<br />
4 11 - Mediterraneo oceanico 6.315,08 5,14<br />
area totale cella 170 122.802,01<br />
Tabella 116 - Estensione dei bioclimi nella cella 169 di Mistretta (ME)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 21 - Mediterraneo oceanico di transizione 47.771,41 38,94<br />
2 11 - Mediterraneo oceanico 34.808,06 28,37<br />
3 42 - Temperato oceanico-semicontinentale di transizione 23.752,67 19,36<br />
4 31 - Temperato oceanico 9.777,59 7,97<br />
5 41 - Temperato oceanico di transizione 6.583,12 5,37<br />
area totale cella 169 122.692,84<br />
146
REGIONE TEMPERATA<br />
Tabella 117 - Estensione dei bioclimi nella cella 1063 di Selva dei Molini (BZ)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 31 - Temperato oceanico 57.856,26 54,57<br />
2 32 - Temperato semicontinentale 46.251,46 43,62<br />
area totale cella 1063 106.031,05<br />
Tabella 118 - Estensione dei bioclimi nella cella 1062 di Campo di Trens (BZ)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 31 - Temperato oceanico 59.092,41 55,75<br />
2 32 - Temperato semicontinentale 43.041,15 40,61<br />
area totale cella 1062 105.997,15<br />
Tabella 119 - Estensione dei bioclimi nella cella 1034 di Auronzo di Cadore (BL)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 31 - Temperato oceanico 95.164,25 89,23<br />
2 35 - Temperato semicontinentale - subcontinentale 5.658,45 5,31<br />
3 32 - Temperato semicontinentale 4.821,25 4,52<br />
4 33 - Temperato oceanico semicontinentale 381,99 0,36<br />
area totale cella 1034 106.655,07<br />
Tabella 120 - Estensione dei bioclimi nella cella 1033 di Badia (BZ)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 31 - Temperato oceanico 101.274,66 94,99<br />
2 32 - Temperato semicontinentale 5.342,78 5,01<br />
3 33 - Temperato oceanico semicontinentale 0,31 0,00<br />
area totale cella 1033 106.615,73<br />
Tabella 121 - Estensione dei bioclimi nella cella 1031 di San Pancrazio (BZ)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 31 - Temperato oceanico 65.679,74 61,64<br />
2 32 - Temperato semicontinentale 30.317,05 28,45<br />
3 34 - Temperato subcontinentale 10.539,08 9,89<br />
4 35 - Temperato semicontinentale - subcontinentale 16,78 0,02<br />
area totale cella 1031 106.552,64<br />
147
Tabella 122 - Estensione dei bioclimi nella cella 1030 di Stelvio (BZ)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 31 - Temperato oceanico 90.728,97 85,17<br />
2 32 - Temperato semicontinentale 9.114,98 8,56<br />
3 34 - Temperato subcontinentale 1.390,61 1,31<br />
area totale cella 1030 106.529,12<br />
Tabella 123 - Estensione dei bioclimi nella cella 1005 di Tramonti di Sopra (PN)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 33 - Temperato oceanico semicontinentale 57.036,81 53,16<br />
2 35 - Temperato semicontinentale - subcontinentale 36.098,87 33,65<br />
3 31 - Temperato oceanico 14.185,77 13,22<br />
area totale cella 1005 107.284,71<br />
Tabella 124 - Estensione dei bioclimi nella cella 1004 di Longarone (BL)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 31 - Temperato oceanico 54.981,18 51,27<br />
2 35 - Temperato semicontinentale - subcontinentale 30.763,76 28,69<br />
3 33 - Temperato oceanico semicontinentale 21.507,03 20,06<br />
area totale cella 1004 107.238,78<br />
Tabella 125 - Estensione dei bioclimi nella cella 1003 di Siror (TN)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 31 - Temperato oceanico 83.849,89 78,22<br />
2 35 - Temperato semicontinentale - subcontinentale 13.085,67 12,21<br />
3 33 - Temperato oceanico semicontinentale 9.757,68 9,10<br />
4 32 - Temperato semicontinentale 507,78 0,47<br />
area totale cella 1003 107.198,79<br />
Tabella 126 - Estensione dei bioclimi nella cella 1002 di Castello-Molina di Fiemme (TN)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 31 - Temperato oceanico 82.881,23 77,34<br />
2 33 - Temperato oceanico semicontinentale 12.656,83 11,81<br />
3 35 - Temperato semicontinentale - subcontinentale 9.810,34 9,15<br />
4 32 - Temperato semicontinentale 1.815,36 1,69<br />
area totale cella 1002 107163,76<br />
148
Tabella 127 - Estensione dei bioclimi nella cella 1001 di Campodenno (TN)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 31 - Temperato oceanico 47.236,35 44,09<br />
2 35 - Temperato semicontinentale - subcontinentale 28.189,84 26,31<br />
3 33 - Temperato oceanico semicontinentale 18.636,64 17,40<br />
4 32 - Temperato semicontinentale 13.071,81 12,20<br />
area totale cella 1001 107.134,65<br />
Tabella 128 - Estensione dei bioclimi nella cella 1000 di Vermiglio (TN)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 31 - Temperato oceanico 95.590,41 89,24<br />
2 33 - Temperato oceanico semicontinentale 9.114,43 8,51<br />
3 35 - Temperato semicontinentale - subcontinentale 1.988,57 1,86<br />
4 32 - Temperato semicontinentale 417,33 0,39<br />
area totale cella 1000 107.110,74<br />
Tabella 129 - Estensione dei bioclimi nella cella 972 di Asiago (VI)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 33 - Temperato oceanico semicontinentale 47.323,79 43,92<br />
2 35 - Temperato semicontinentale - subcontinentale 37.513,13 34,82<br />
3 31 - Temperato oceanico 22.903,59 21,26<br />
area totale cella 972 107.740,51<br />
Tabella 130 - Estensione dei bioclimi nella cella 970 Pieve di Bono (TN)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 31 - Temperato oceanico 41.186,11 38,25<br />
2 33 - Temperato oceanico semicontinentale 34.672,41 32,20<br />
3 35 - Temperato semicontinentale - subcontinentale 31.261,25 29,03<br />
4 32 - Temperato semicontinentale 547,82 0,51<br />
area totale cella 970 107.686,62<br />
149
Tabella 131 - Estensione dei bioclimi nella cella 969 di Borno (BS)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 31 - Temperato oceanico 41.186,11 38,25<br />
2 33 - Temperato oceanico semicontinentale 34.672,41 32,20<br />
3 35 - Temperato semicontinentale - subcontinentale 31.261,25 29,03<br />
4 32 - Temperato semicontinentale 547,82 0,51<br />
area totale cella 969 107.667,59<br />
Tabella 132 - Estensione dei bioclimi nella cella 968 di Ardesio (BG)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 35 - Temperato semicontinentale - subcontinentale 45.124,32 41,92<br />
2 33 - Temperato oceanico semicontinentale 37.266,01 34,62<br />
3 31 - Temperato oceanico 25.264,25 23,47<br />
area totale cella 968 107.654,58<br />
Tabella 133 - Estensione dei bioclimi nella cella 964 di Vannio Anzino (VB)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 31 - Temperato oceanico 73.751,23 68,51<br />
2 32 - Temperato semicontinentale 12.619,98 11,72<br />
3 33 - Temperato oceanico semicontinentale 7.823,33 7,27<br />
4 35 - Temperato semicontinentale - subcontinentale 4.304,68 4,00<br />
area totale cella 964 107.656,55<br />
Tabella 134 - Estensione dei bioclimi nella cella 933 di Issogne (AO)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 31 - Temperato oceanico 78.421,01 72,45<br />
2 32 - Temperato semicontinentale 18.530,13 17,12<br />
3 35 - Temperato semicontinentale - subcontinentale 6.979,27 6,45<br />
4 33 - Temperato oceanico semicontinentale 3.170,94 2,93<br />
5 34 - Temperato subcontinentale 1.143,76 1,06<br />
area totale cella 933 108.245,10<br />
Tabella 135 - Estensione dei bioclimi nella cella 932 di Cogne (AO)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 31 - Temperato oceanico 87.019,45 80,38<br />
2 32 - Temperato semicontinentale 21.245,73 19,62<br />
area totale cella 932 108.265,19<br />
150
Tabella 136 - Estensione dei bioclimi nella cella 902 di Groscavallo (TO)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 31 - Temperato oceanico 66.837,26 61,41<br />
2 32 - Temperato semicontinentale 30.280,46 27,82<br />
3 34 - Temperato subcontinentale 793,29 0,73<br />
area totale cella 902 108.836,42<br />
Tabella 137 - Estensione dei bioclimi nella cella 847 di Bobbio (PC)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 31 - Temperato oceanico 41.725,38 37,96<br />
2 33 - Temperato oceanico semicontinentale 29.179,46 26,55<br />
3 32 - Temperato semicontinentale 21.681,83 19,72<br />
4 42 - Temperato oceanico-semicontinentale di transizione 14.909,83 13,56<br />
5 34 - Temperato subcontinentale 2.427,40 2,21<br />
area totale cella 847 109.923,88<br />
Tabella 138 - Estensione dei bioclimi nella cella 818 di Borgo Val di Taro (PR)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 33 - Temperato oceanico semicontinentale 54.867,01 49,66<br />
2 31 - Temperato oceanico 44.899,96 40,64<br />
3 32 - Temperato semicontinentale 7.349,52 6,65<br />
4 41 - Temperato oceanico di transizione 2.496,15 2,26<br />
5 42 - Temperato oceanico-semicontinentale di transizione 879,74 0,80<br />
area totale cella 818 110.492,38<br />
Tabella 139 - Estensione dei bioclimi nella cella 817 di Borzonasca (GE)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 31 - Temperato oceanico 41.697,78 37,74<br />
2 33 - Temperato oceanico semicontinentale 40.623,01 36,77<br />
3 41 - Temperato oceanico di transizione 20.504,65 18,56<br />
4 21 - Mediterraneo oceanico di transizione 2.761,79 2,50<br />
5 42 - Temperato oceanico-semicontinentale di transizione 1.133,03 1,03<br />
area totale cella 817 110.483,76<br />
151
Tabella 140 - Estensione dei bioclimi nella cella 791 di Castel di Casio (BO)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 33 - Temperato oceanico semicontinentale 58.270,64 52,44<br />
2 31 - Temperato oceanico 42.072,68 37,86<br />
3 32 - Temperato semicontinentale 8.099,41 7,29<br />
4 41 - Temperato oceanico di transizione 2.183,08 1,96<br />
5 34 - Temperato subcontinentale 416,24 0,37<br />
6 42 - Temperato oceanico-semicontinentale di transizione 70,53 0,06<br />
area totale cella 791 111.112,58<br />
Tabella 141 - Estensione dei bioclimi nella cella 790 di Pievepelago (MO)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 31 - Temperato oceanico 64.488,71 58,05<br />
2 33 - Temperato oceanico semicontinentale 34.882,72 31,40<br />
3 41 - Temperato oceanico di transizione 11.714,44 10,55<br />
area totale cella 790 111.085,87<br />
Tabella 142 - Estensione dei bioclimi nella cella 789 di Fivizzano (MS)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 33 - Temperato oceanico semicontinentale 43.186,79 38,88<br />
2 31 - Temperato oceanico 38.371,44 34,55<br />
3 41 - Temperato oceanico di transizione 21.236,24 19,12<br />
4 21 - Mediterraneo oceanico di transizione 5.354,90 4,82<br />
area totale cella 789 111.064,98<br />
Tabella 143 - Estensione dei bioclimi nella cella 763 di Bagno di Romagna (FO)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 33 - Temperato oceanico semicontinentale 59.478,20 53,23<br />
2 31 - Temperato oceanico 40.947,59 36,64<br />
3 32 - Temperato semicontinentale 7.654,17 6,85<br />
4 42 - Temperato oceanico-semicontinentale di transizione 3.661,48 3,28<br />
area totale cella 763 111.741,44<br />
152
Tabella 144 - Estensione dei bioclimi nella cella 676 di Visso (MC)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 31 - Temperato oceanico 57.758,43 50,86<br />
2 33 - Temperato oceanico semicontinentale 52.649,42 46,36<br />
3 42 - Temperato oceanico-semicontinentale di transizione 3.694,53 3,25<br />
area totale cella 676 113.556,84<br />
Tabella 145 - Estensione dei bioclimi nella cella 646 di Cascia (PG)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 31 - Temperato oceanico 57.758,43 50,62<br />
2 33 - Temperato oceanico semicontinentale 52.649,42 46,14<br />
3 42 - Temperato oceanico-semicontinentale di transizione 3.694,53 3,24<br />
area totale cella 646 114.103,85<br />
Tabella 146 - Estensione dei bioclimi nella cella 617 di Barisciano (AQ)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 31 - Temperato oceanico 54.074,53 47,14<br />
2 42 - Temperato oceanico-semicontinentale di transizione 32.010,07 27,90<br />
3 33 - Temperato oceanico semicontinentale 28.632,08 24,96<br />
area totale cella 617 114.716,54<br />
Tabella 147 - Estensione dei bioclimi nella cella 616 di Petrella Salto (RI)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 33 - Temperato oceanico semicontinentale 48.298,65 42,13<br />
2 31 - Temperato oceanico 42.445,15 37,02<br />
3 42 - Temperato oceanico-semicontinentale di transizione 19.207,82 16,75<br />
4 41 - Temperato oceanico di transizione 4.694,06 4,09<br />
area totale cella 616 114.647,70<br />
Tabella 148 - Estensione dei bioclimi nella cella 588 di Sulmona (AQ)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 31 - Temperato oceanico 50.971,16 44,19<br />
2 33 - Temperato oceanico semicontinentale 37.615,18 32,61<br />
3 42 - Temperato oceanico-semicontinentale di transizione 26.749,00 23,19<br />
area totale cella 588 115335,34<br />
153
Tabella 149 - Estensione dei bioclimi nella cella 587 di Celano (AQ)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 31 - Temperato oceanico 46.105,27 40,00<br />
2 42 - Temperato oceanico-semicontinentale di transizione 39.385,95 34,17<br />
3 33 - Temperato oceanico semicontinentale 28.351,32 24,60<br />
4 41 - Temperato oceanico di transizione 1.415,66 1,23<br />
area totale cella 587 115.258,20<br />
Tabella 150 - Estensione dei bioclimi nella cella 586 di Pereto (AQ)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 33 - Temperato oceanico semicontinentale 52.474,55 45,56<br />
2 31 - Temperato oceanico 37.381,38 32,45<br />
3 41 - Temperato oceanico di transizione 19.603,87 17,02<br />
4 42 - Temperato oceanico-semicontinentale di transizione 5.727,69 4,97<br />
area totale cella 586 115.188,36<br />
Tabella 151 - Estensione dei bioclimi nella cella 558 di Barrea (AQ)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 31 - Temperato oceanico 50.614,87 43,68<br />
2 33 - Temperato oceanico semicontinentale 44.265,33 38,20<br />
3 41 - Temperato oceanico di transizione 19.423,02 16,76<br />
4 21 - Mediterraneo oceanico di transizione 1.169,82 1,01<br />
5 42 - Temperato oceanico-semicontinentale di transizione 403,33 0,35<br />
area totale cella 558 115.876,37<br />
Tabella 152 - Estensione dei bioclimi nella cella 413 di San Martino d’Agri (PZ)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 33 - Temperato oceanico semicontinentale 57.566,42 48,35<br />
2 41 - Temperato oceanico di transizione 33.482,01 28,12<br />
3 31 - Temperato oceanico 17.815,30 14,96<br />
4 42 - Temperato oceanico-semicontinentale di transizione 10.190,60 8,56<br />
area totale cella 413 119.054,34<br />
154
Tabella 153 - Estensione dei bioclimi nella cella 412 di Sanza (SA)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 41 - Temperato oceanico di transizione 34.904,35 29,35<br />
2 33 - Temperato oceanico semicontinentale 30.676,66 25,79<br />
3 21 - Mediterraneo oceanico di transizione 26.893,41 22,61<br />
4 31 - Temperato oceanico 10.883,56 9,15<br />
5 42 - Temperato oceanico-semicontinentale di transizione 9.086,19 7,64<br />
6 11 - Mediterraneo oceanico 6.489,61 5,46<br />
area totale cella 412 118.933,78<br />
Tabella 154 - Estensione dei bioclimi nella cella 383 di Rotonda (PZ)<br />
PROGR BIOCLI<strong>MA</strong> SUM_HA %<br />
1 41 - Temperato oceanico di transizione 59.271,06 49,57<br />
2 31 - Temperato oceanico 43.261,45 36,18<br />
3 21 - Mediterraneo oceanico di transizione 10.712,15 8,96<br />
4 33 - Temperato oceanico semicontinentale 2.790,09 2,33<br />
5 11 - Mediterraneo oceanico 2.131,67 1,78<br />
6 42 - Temperato oceanico-semicontinentale di transizione 1.413,60 1,18<br />
area totale cella 383 119.580,02<br />
155
3.2.2.4 b – Serie di vegetazione nelle celle<br />
Dall’analisi delle serie di vegetazione all’interno delle celle, i cui esiti sono riportati nelle tabelle da<br />
155 a 209 , emergono le serie prevalenti in ciascuna unità di campionamento.<br />
Questo risultato può essere letto come indicazione gestionale poiché può orientare le azioni di<br />
conservazione della biodiversità vegetale, se intesa quale diversità di vegetazione naturale<br />
potenziale (Tuxen, 1956).<br />
Ciascuna tabella di copertura delle serie di vegetazione è composta dalle colonne:<br />
PROGR che riporta un valore numerico progressivo, indicante anche il numero delle serie (e dei<br />
geosigmeti) presenti nella cella.<br />
DESCR in cui è descritta brevemente la serie di vegetazione. Per semplificare il riconoscimento<br />
della tappa matura è stato utilizzato il riferimento sintassonomico relativo<br />
all’associazione e non quello previsto dal Codice di Nomenclatura fitosociologica<br />
(Weber et al., 2000). Ad esempio, per la serie centro-sudappenninica dei boschi<br />
submontani neutro-basifili di cerro e roverella è indicata con il riferimento Daphno<br />
laureolae-Quercetum cerris invece che con Daphno laureolae–Querceto cerris<br />
sigmetum..<br />
COUNT che indica il numero di poligoni che costituiscono ciascuna serie di vegetazione.<br />
SUM_HA che rappresenta il valore di copertura in ettari (approssimato alla seconda cifra decimale)<br />
di ciascuna serie di vegetazione rispetto all’estensione totale della cella.<br />
% che rappresenta la percentuale di copertura (approssimata alla seconda cifra decimale) di<br />
ciascuna serie di vegetazione rispetto all’estensione totale della cella.<br />
E’ opportuno fare alcune precisazioni utili ad una più efficace lettura dei dati.<br />
a) Sono presenti in tabella i valori di copertura dei geosigmeti laddove le serie non siano state<br />
cartografate, fondamentalmente per ragioni di scala. I geosigmeti sono infatti costituiti da un<br />
insieme di serie coesistenti in una stessa unità geomorfologica e un’unica unità biogeografica e<br />
quindi, per definizione, di estensione maggiore.<br />
b) Una serie di vegetazione può presentare delle varianti. E’ stato scelto di non effettuare<br />
accorpamenti allo scopo di conservare il contenuto informativo in termini di biodiversità 32 .<br />
32 Ad esempio, nella cella 325 la serie 51a sud-appenninica dei boschi acidofili supramediterranei di farnetto (Cytiso villosi-<br />
Quercetum frainetto) è distinta dalla medesima serie 51b che si presenta (in queso caso nella stessa unità di<br />
campionamento) anche nella variante a mosaico con la serie dell'Erico-Quercetum vigilianae.<br />
156
c) Sono state eliminate dalle tabelle, in quanto ritenuti non significativi, le righe relative:<br />
- alle serie di vegetazione aventi una superficie non nulla, ma risultante pari a 0,00 (ha e/o %)<br />
per effetto dell’approssimazione,<br />
- ai tipi di copertura del suolo non assimilabili ad alcuna serie di vegetazione (ad esempio, i<br />
corpi idrici o le zone di deserto vulcanico nelle celle siciliane), ma presenti nella cartografia<br />
utilizzata.<br />
d) Per ciascuna tabella sono descritte soltanto alcune delle serie (o dei geosigmeti) più<br />
significative per l’estensione o per l’ambito territoriale in cui sono collocate.<br />
e) Le serie sono disposte in ordine decrescente di estensione secondo la colonna SUM_HA (%) .<br />
f) Come per i bioclimi, vengono presentate prima le 17 tabelle della Regione Mediterranea, poi le<br />
38 della Regione Temperata.<br />
157
REGIONE MEDITERRANEA<br />
Tabella 155 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 487 di Arzachena (SS)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 13 - Serie sarda, termo-mesomediterranea, del leccio (Prasio majoris-Quercetum ilicis typicum e<br />
phyllireetosum angustifoliae)<br />
2 48122,12 41,32<br />
2 16 - Serie sardo-corsa calcifuga, meso-supramediterranea, del leccio (Galio scabri-Quercetum<br />
ilicis)<br />
1 10067,22 8,65<br />
3 5 - Serie sarda, calcifuga, del ginepro turbinato (Erico arboreae-Juniperetum turbinatae) 15 3856,89 3,31<br />
4 12 - Serie sarda calcifuga, termomediterranea, del leccio (Pyro amygdaliformis-Quercetum<br />
ilicis)<br />
6 3416,44 2,93<br />
5 4 - Serie sarda occidentale, calcicola, del ginepro turbinato (Chamaeropo humilis-Juniperetum<br />
turbinatae)<br />
1 2483,02 2,13<br />
6 6 - Serie sarda nord-occidentale, calcifuga, del ginepro turbinato (Euphorbio characiae-<br />
Juniperetum turbinatae)<br />
2 1894,11 1,63<br />
7 21 - Serie sarda della quercia di Virgilio (Lonicero implexae-Quercetum virgilianae) 2 1548,61 1,33<br />
8 22 - Serie sarda centrale della quercia di Sardegna (Ornithogalo pyrenaici-Quercetum ichnusae) 1 290,25 0,25<br />
9 1 - Serie psammofila del ginepro coccolone (Asparago acutifolii-Juniperetum macrocarpae) 2 215,87 0,19<br />
10 15 - Serie sarda calcicola, mesomediterranea, del leccio (Prasio majoris-Quercetum ilicis<br />
quercetosum virgilianae)<br />
2 171,64 0,15<br />
11 23 - Serie sarda centro-orientale della quercia congesta (Glechomo sardoae-Quercetum<br />
congestae)<br />
1 117,60 0,10<br />
area totale cella 487 116449,73<br />
Lo stadio maturo della serie termo-mesomediterranea del leccio, che copre quasi la metà della superficie della cella (41,3%), è rappresentato<br />
da boschi climatofili a Quercus ilex con Juniperus oxycedrus, J. Turbinata e Prasium majus con Phillyrea latifolia, P. angustifolia negli<br />
aspetti più termofili, Erica arborea, Rhamnus alaternus e Pistacia lentiscus. Galio scabri-Quercetum ilicis è come la precedente una serie<br />
indifferente edifica con una vegetazione potenziale a leccio. Per entrambe le cenosi di sostituzione sono costituite da: macchia alta<br />
dell’associazione Erico arboreae-Arbutetum unedonis su substrati acidi; macchia a Pistacia lentiscus e Rhamnus alaternus su substrati<br />
alcalini; garighe a Cistus monspeliensis o a Osyris alba, specie colonizzatrici delle aree incenditate; praterie ad emicriptofite della classe<br />
Artemisietea e dalle comunità terofitiche della classe Tuberarietea guttatae.<br />
158
Tabella 156 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 457 di Telti (SS)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 13 - Serie sarda, termo-mesomediterranea, del leccio (Prasio majoris-Quercetum ilicis typicum e<br />
phyllireetosum angustifoliae)<br />
3 17758,11 15,18<br />
2 20 - Serie sarda centro-occidentale edafo-mesofila, mesomediterranea, della sughera (Violo<br />
dehnhardtii-Quercetum suberis)<br />
3 16722,82 14,30<br />
3 17 - Serie sarda centro-meridionale calcicola, meso-supramediterranea, del leccio (Aceri<br />
monspessulani-Quercetum ilicis)<br />
3 15676,53 13,40<br />
4 16 - Serie sardo-corsa calcifuga, meso-supramediterranea, del leccio (Galio scabri-Quercetum<br />
ilicis)<br />
5 14690,47 12,56<br />
5 12 - Serie sarda calcifuga, termomediterranea, del leccio (Pyro amygdaliformis-Quercetum ilicis) 3 13085,38 11,19<br />
6 14 - Serie sarda occidentale calcicola, termomediterranea, del leccio (Prasio majoris-Quercetum<br />
ilicis chamaeropetosum humilis)<br />
2 12749,67 10,90<br />
7 21 - Serie sarda della quercia di Virgilio (Lonicero implexae-Quercetum virgilianae) 3 12049,41 10,30<br />
8 15 - Serie sarda calcicola, mesomediterranea, del leccio (Prasio majoris-Quercetum ilicis<br />
quercetosum virgilianae)<br />
2 6977,27 5,96<br />
9 19 - Serie sarda, termo-mesomediterranea, della sughera (Galio scabri-Quercetum suberis) 2 2639,47 2,26<br />
10 23 - Serie sarda centro-orientale della quercia congesta (Glechomo sardoae-Quercetum<br />
congestae)<br />
1 1511,63 1,29<br />
11 1 - Serie psammofila del ginepro coccolone (Asparago acutifolii-Juniperetum macrocarpae) 1 1038,94 0,89<br />
12 5 - Serie sarda, calcifuga, del ginepro turbinato (Erico arboreae-Juniperetum turbinatae) 1 768,74 0,66<br />
area totale cella 457 116972,83<br />
La serie del leccio Prasio majoris-Quercetum ilicis typicum e phyllireetosum angustifoliae è rappresentata per il 15,2%, seguita dalla serie<br />
edafo-mesofila mesomediterranea della sughera (14,3%) e dalla serie calcicola supramediterranea del leccio (13,4%). La vegetazione naturale<br />
potenziale della serie Violo dehnhardtii-Quercetum suberis, che trova il suo sviluppo ottimale su substrati vulcanici oligo-miocenici e pliopleistocenici<br />
della Sardegna NW, è un mesobosco dominato da Quercus suber con altre querce a foglie caduche ed Hedera helix. Aceri<br />
monspessulani-Quercetum ilicis è invece una serie esclusiva dei substrati calcarei carbonatici e calcareo-dolomitici in cui le cenosi di<br />
sostituzione sono costituite da arbusteti del Pruno rubion e orli erbacei riferibili per lo più al Geranio purpurei-Cardaminetalia hirsutae<br />
mentre la vegetazione potenziale è di micro-mesoboschi climatofili in cui dominano il leccio e sclerofille come Phillyrea latifolia.<br />
159
Tabella 157 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 456 di Bortigiadas (SS)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 20 - Serie sarda centro-occidentale edafo-mesofila, mesomediterranea, della sughera (Violo<br />
dehnhardtii-Quercetum suberis)<br />
2 44523,83 38,06<br />
2 21 - Serie sarda della quercia di Virgilio (Lonicero implexae-Quercetum virgilianae) 1 14666,26 12,54<br />
3 15 - Serie sarda calcicola, mesomediterranea, del leccio (Prasio majoris-Quercetum ilicis<br />
quercetosum virgilianae)<br />
8 13400,13 11,46<br />
4 17 - Serie sarda centro-meridionale calcicola, meso-supramediterranea, del leccio (Aceri<br />
monspessulani-Quercetum ilicis)<br />
1 13334,49 11,40<br />
5 19 - Serie sarda, termo-mesomediterranea, della sughera (Galio scabri-Quercetum suberis) 8 8658,01 7,40<br />
6 12 - Serie sarda calcifuga, termomediterranea, del leccio (Pyro amygdaliformis-Quercetum ilicis) 4 4514,86 3,86<br />
7 13 - Serie sarda, termo-mesomediterranea, del leccio (Prasio majoris-Quercetum ilicis typicum e<br />
phyllireetosum angustifoliae)<br />
1 3723,83 3,18<br />
8 16 - Serie sardo-corsa calcifuga, meso-supramediterranea, del leccio (Galio scabri-Quercetum<br />
ilicis)<br />
4 2896,11 2,48<br />
9 14 - Serie sarda occidentale calcicola, termomediterranea, del leccio (Prasio majoris-Quercetum<br />
ilicis chamaeropetosum humilis)<br />
2 2554,06 2,18<br />
10 29 - Geosigmeto alofilo sardo delle aree salmastre degli stagni e delle lagune costiere<br />
(Ruppietea, Thero-Suaedetea, Saginetea maritimae, Salicornietea fruticosae, Juncetea maritimi,<br />
Phragmito-Magnocaricetea)<br />
2 1494,47 1,28<br />
11 1 - Serie psammofila del ginepro coccolone (Asparago acutifolii-Juniperetum macrocarpae) 1 637,69 0,55<br />
12 2 - Serie sarda calcifuga, termomediterranea, del leccio (Pyro amygdaliformis-Quercetum ilicis) 1 31,22 0,03<br />
area totale cella 456 116970,25<br />
Le serie della sughera Violo dehnhardtii-Quercetum suberis e del leccio Aceri monspessulani-Quercetum ilicis sono state già descritte per la<br />
cella 457 di Telti (SS). Tra le formazioni forestali a querce caducifoglie più termofile e calcicole della Sardegna rientra l’associazione Lonicero<br />
implexae-Quercetum virgilianae (12,5%), ascrivibile secondo Bacchetta et al. (2004) alla suballeanza endemica sardo-corsa Clematido cirrhosae-<br />
Quercenion ilicis dell’alleanza Fraxino orni-Quercion ilicis. La vegetazione potenziale della serie Prasio majoris-Quercetum ilicis quercetosum<br />
virgilianae è costituita da boschi climatofili a Quercus ilex e Quercus virgiliana, talvolta con Fraxinus ornus. Nello strato arbustivo sono presenti<br />
Rhamnus alaternus, Viburnum tinus, Clematis vitalba, Crataegus monogyna e Osyris alba. Le cenosi arbustive di sostituzione sono difatti riferibili<br />
alle associazioni Rhamno alaterni-Spartietum juncei e Clematido cirrhosae-Crataegetum monogynae.<br />
Il geosigmeto alofilo sardo delle aree salmastre degli stagni e delle lagune costiere (Ruppietea, Thero-Suaedetea, Saginetea maritimae,<br />
Salicornietea fruticosae, Juncetea maritimi, Phragmito-Magnocaricetea) si estende per 1494,5 ettari. Sono microgeosigmeti uniformemente<br />
diffusi lungo le coste dell’isola, ma solo in particolari condizioni geomorfologiche raggiungono estensioni tali da renderli cartografabili. Si tratta di<br />
160
comunità vegetali specializzate per crescere su suoli generalmente limoso-argillosi, scarsamente drenanti, allagati per periodi più o meno lunghi da<br />
acque salate. I contatti catenali tra le comunità si articolano in funzione dei gradienti ecologici determinati da periodi di periodi di inondazione<br />
e/o sommersione, dalla granulometria del substrato e dalla salinità delle acque.<br />
Tabella 158 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 427 di Bitti (NU)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 20 - Serie sarda centro-occidentale edafo-mesofila, mesomediterranea, della sughera (Violo<br />
dehnhardtii-Quercetum suberis)<br />
4 68339,45 58,16<br />
2 13 - Serie sarda, termo-mesomediterranea, del leccio (Prasio majoris-Quercetum ilicis typicum e<br />
phyllireetosum angustifoliae)<br />
5 12105,29 10,30<br />
3 15 - Serie sarda calcicola, mesomediterranea, del leccio (Prasio majoris-Quercetum ilicis<br />
quercetosum virgilianae)<br />
3 9687,87 8,25<br />
4 19 - Serie sarda, termo-mesomediterranea, della sughera (Galio scabri-Quercetum suberis) 2 9338,63 7,95<br />
5 16 - Serie sardo-corsa calcifuga, meso-supramediterranea, del leccio (Galio scabri-Quercetum<br />
ilicis)<br />
3 8339,72 7,10<br />
6 14 - Serie sarda occidentale calcicola, termomedi erranea, del leccio (Prasio majoris-Quercetum<br />
ilicis chamaeropetosum humilis)<br />
5 7611,15 6,48<br />
7 17 - Serie sarda centro-meridionale alcicola, meso-supramediterranea, del leccio (Aceri<br />
monspessulani-Quercetum ilicis)<br />
2 2070,55 1,76<br />
area totale cella 427 117492,66<br />
Un mesobosco dominato da Quercus suber con altre querce caducifoglie ed Hedera helix rappresenta lo stadio maturo della serie Violo<br />
dehnhardtii-Quercetum suberis che si estende per oltre il 58% della superficie della cella. Essa ha il suo optimum su substrati vulcanici oligomiocenici<br />
e plio-pleistocenici della Sardegna NW.<br />
Lo stadio maturo della serie termo-mesomediterranea del leccio, invece, che copre il 10,3%, è rappresentato da boschi climatofili a Quercus<br />
ilex con Juniperus oxycedrus, J. Turbinata e Prasium majus con Phillyrea latifolia, P. angustifolia negli aspetti più termofili, Erica arborea,<br />
Rhamnus alaternus e Pistacia lentiscus.<br />
161
Tabella 159 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 414 di Tusi (MT)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 62 - Serie ionica costiera mesomediterranea secca della roverella su depositi argillosi (Lauro-<br />
Quercenion)<br />
11 54295,80 45,56<br />
2 93 - Geosigmeto ionico mesomediterraneo secco-subumido delle aree soggette ad erosione<br />
calanchiva (Camphorosmo monspeliaceae-Lygetum sparti, Camphorosmo monspeliacae -<br />
Atriplicetum halimi, Cardopato corymbosi- Lygetum sparti, Arundinetum plinianae, Helictotricho<br />
convoluti-Pistacetum lentisci, ecc.)<br />
9 35733,45 29,98<br />
3 88 – b: Geosigmeto meridionale ripariale edafoigrofilo e planiziale dei boschi a ontano, farnia<br />
(Alno-Quercion roboris) e pioppo bianco (Populion albae ): formazioni planiziari dell’alleanza<br />
Alno-Quercion roboris.<br />
3 10636,05 8,92<br />
4 89 - Geosigmeto ripariale e dei fondovalle alluvionali (Salicion albae, Populion albae, Alno-<br />
Ulmion, Carpinion betuli, Teucrio siculi-Quercion cerris)<br />
4 4377,37 3,67<br />
5 85 - Serie ionica dei populeti a pioppo gatterino e frassino meridionale dei fondovalle argillosi<br />
(Populetalia albae)<br />
2 3412,63 2,86<br />
6 65 - a: Serie sud-appenninica termomediterranea della quercia virgiliana e dell'olivastro (Oleo-<br />
Quercetum virgilianae)<br />
2 3358,54 2,82<br />
7 81 - Serie ionica costiera della macchia a lentisco e ginepro coccolone (Helictotricho convoluti-<br />
Pistacietum lentisci)<br />
1 1942,84 1,63<br />
8 65 - b: Serie sud-appenninica termomediterranea della quercia virgiliana e dell'olivastro (Oleo-<br />
Quercetum virgilianae) a mosaico con la serie del Pistacio-Pinetum halepensis<br />
1 1274,42 1,07<br />
9 50 - Serie sud-appenninica delle cerrete termofile neutro-subacidofile (Lathyro digitati-Quercetum<br />
cerris)<br />
3 578,19 0,49<br />
10 82 - Serie costiera termomediterranea della macchia a mirto e lentisco (Myrto-Pistacietetum<br />
lentisci)<br />
2 580,85 0,49<br />
11 94 - Geosigmeto costiero della vegetazione psammofila, retrodunale e alofila delle spiagge e dei<br />
sistemi dunari recenti (Cakiletea, Ammophiletea, Elichryso-Crucianelletea, Quercetea ilicis)<br />
2 460,59 0,39<br />
12 92 - a: Geosigmeto termo-mesomediterraneo della vegetazione delle fiumare. Articolazione<br />
catenale in relazione alla profondità della falda freatica ed al disturbo arrecato dalle piene<br />
(Artemisio-Helicrysetum italici, Nerion oleandri, Tamarici africanae-Viticetum agni-casti).<br />
1 376,80 0,32<br />
area totale cella 414 119182,09<br />
La serie ionica costiera della roverella del Lauro-Quercenion si estende per quasi la metà della superficie della cella 414. Ubicata nelle aree<br />
calanchive del materano su depositi argillosi, le comunità forestali della sua tappa matura sono caratterizzate dalla dominanza di Quercus<br />
162
pubescens s.l. e presentano diverse specie della macchia mediterranea oltre ad alcune tipiche dei querceti caducifogli termofili dello Ptilostemo-<br />
Quercenion. Essendo discontinuo, lo strato dominante consente l’ingresso nel sottobosco di numerose specie arbustive termofile quali Pistacia<br />
lentiscus, Spartium junceum, Rhamnus alaternus, Rosa sempervirens, e, in alcuni casi, anche di elementi della gariga quali Cistus creticus subsp.<br />
eriocephalus, Cistus monspeliensis e Dorycnium hirsutum. Mantelli e cespuglieti a Pistacia lentiscus, Rosa sempervirens e Rhamnus alaternus<br />
appartengono alla variante edafo-xerofila e aspetti di Roso-Rubetum alla variante edafomesofila mentre mantelli a Spartium junceum sono<br />
localizzati nei versanti esposti a nord. Infine si segnalano garighe a Cistus eriocephalus e Cistus monspeliensis, praterie aride a Stipa capensis e<br />
Stipa austroitalica e Stipa bromoides, pratelli dell’Helianthemetea annuae.<br />
Seguono questa serie, in termini di copertura, due geosigmeti. Il primo, più esteso (35733,5 ettari), si rinviene nelle aree soggette ad erosione<br />
calanchiva sulle quali si instauraurano fitocenosi in grado di tollerare peculiari condizioni ambientali quanto a substrato (argille azzurrre di origine<br />
marina), chimismo (presenza di cloruri), eclima (prolungato periodo di aridità estiva e piogge brevi ed intense nella stagione autunnale). Le varie<br />
comunità si articolano nei loro contatti catenali in funzione dei diversi ambiti microgeomorfologici.<br />
Il geosigmeto edafoigrofilo e planiziale delle formazioni planiziari dei boschi a ontano, farnia (Alno-Quercion roboris ) e pioppo bianco (Populion<br />
albae) copre 10636 ettari. Il bosco di farnia si presenta piuttosto impoverito a causa della devastazione antropica del suo habitat. Quercus robur<br />
rappresenta la specie dominante lo strato arboreo, mentre lo strato arbustivo è ricco di sempreverdi mediterranee come Laurus nobilis, Smilax asper<br />
e Rhamnus alaternus. Le serie dominanti sono del Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae e Fraxino-Quercetum roboris. Nelle aree rilevate la<br />
sostituzione avviene tramite comunità di macchia mediterranea mentre in quelle depresse si osserva una situazione mista di specie sempreverdi ad<br />
attitudini meso-igrofile ed elementi del Pruno-Rubion ulmifolii. Le comunità erbacee fanno principalmente riferimento al Bromo-Oryzopsion e al<br />
Thero-Brachypodion.<br />
163
Tabella 160 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 397 di Oliena (NU)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 19 - Serie sarda, termo-mesomediterranea, della sughera (Galio scabri-Quercetum suberis) 4 53940,32 45,71<br />
2 13 - Serie sarda, termo-mesomediterranea, del leccio (Prasio majoris-Quercetum ilicis typicum e<br />
phyllireetosum angustifoliae)<br />
3 20942,50 17,75<br />
3 14 - Serie sarda occidentale calcicola, termomediterranea, del leccio (Prasio majoris-Quercetum<br />
ilicis chamaeropetosum humilis)<br />
3 16976,01 14,39<br />
4 20 - Serie sarda centro-occidentale edafo-mesofila, mesomediterranea, della sughera (Violo<br />
dehnhardtii-Quercetum suberis)<br />
2 9794,53 8,30<br />
5 17 - Serie sarda centro-meridionale calcicola, meso-supramediterranea, del leccio (Aceri<br />
monspessulani-Quercetum ilicis)<br />
1 8529,00 7,23<br />
6 Corpi d’acqua 2 6056,62 5,13<br />
7 15 - Serie sarda calcicola, mesomediterranea, del leccio (Prasio majoris-Quercetum ilicis<br />
quercetosum virgilianae)<br />
2 1195,28 1,01<br />
8 12 - Serie sarda calcifuga, termomediterranea, del leccio (Pyro amygdaliformis-Quercetum ilicis) 1 501,92 0,43<br />
9 16 - Serie sardo-corsa calcifuga, meso-supramediterranea, del leccio (Galio scabri-Quercetum<br />
ilicis)<br />
2 74,54 0,06<br />
area totale cella 397 118010,71<br />
La serie termo-mesomediterranea della sughera Galio scabri-Quercetum suberis è la più estesa. Si sviluppa su substrati granitici della Sardegna<br />
orientale e meridionale (subass. quercetosum suberis), talvolta su metamorfiti (subass. rhamnetosum alaterni). Lo stadio maturo è costituito da<br />
mesoboschi a Quercus suber con Q. ilex, Viburnum tinus, Arbutus unedo, Erica arborea, Phyllirea latifolia , Myrtus communis, Juniperus<br />
oxycedrus subsp. oxycedrus. Lo strato erbaceo è caratterizzatoda Galium scabrum, Cyclamen repandum, Ruscus aculeatus. La vegetazione<br />
forestale è sostituita da formazioni arbustive riferibili all’associazione Erico arboreae-Arbutetum unedoni e da garighe a Cistus monspeliensis e C.<br />
salvifolius.<br />
La serie termo-mesomediterranea del leccio Prasio majoris-Quercetum ilicis typicum e phyllireetosum angustifoliae, che si estende per il<br />
17,7%, è già stata descritta per la cella 457 di Telti (SS).<br />
La serie termomediterranea del leccio Prasio majoris-Quercetum ilicis chamaeropetosum humilis copre il 14,4%. Ubicata su calcari<br />
mesozoici costieri, è costituita da formazioni termofile a Juniperus turbinata e Quercus ilex nello strato arboreo mentre nello strato arbustivo sono<br />
presenti Phyllirea angustifolia, Chamaerops humilis, Pistacia lentiscus e Prasium majus. Le cenosi vegetali di sostituzione sono rappresentate dalla<br />
macchia a Pistacia lentiscus e Chamaerops humilis (Pistacio-Chamaeropetum humilis), dalle garighe a Cistus creticus ssp. eriocephalus (Dorycnio<br />
penthaphylli-Cistetum eriocephali), dalle praterie emicriptofitiche delle associazioni Scilloobtusifoliae-Bellidetum sylvestris e Asphodelo<br />
microcarpi-Brachypodietum ramosi; dalle comunità terofitiche effimere della classe Tuberarietea guttatae.<br />
164
Tabella 161 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 396 di Bortigali (NU)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 19 - Serie sarda, termo-mesomediterranea, della sughera (Galio scabri-Quercetum suberis) 7 41167,65 34,89<br />
2 16 - Serie sardo-corsa calcifuga, meso-supramediterranea, del leccio (Galio scabri-Quercetum<br />
ilicis)<br />
6 31510,37 26,70<br />
3 20 - Serie sarda centro-occidentale edafo-mesofila, mesomediterranea, della sughera (Violo<br />
dehnhardtii-Quercetum suberis)<br />
6 23800,98 20,17<br />
4 15 - Serie sarda calcicola, mesomediterranea, del leccio (Prasio majoris-Quercetum ilicis<br />
quercetosum virgilianae)<br />
3 8997,40 7,62<br />
5 12 - Serie sarda calcifuga, termomediterranea, del leccio (Pyro amygdaliformis-Quercetum ilicis) 2 7062,68 5,98<br />
6 10 - Serie sarda basifila, termomediterranea, dell'olivastro (Asparago albi-Oleetum sylvestris) 1 2328,34 1,97<br />
7 29 - Geosigmeto alofilo sardo delle aree salmastre, degli stagni e delle lagune costiere<br />
(Ruppietea, Thero-Suaedetea, Saginetea maritimae, Salicornietea fruticosae, Juncetea maritimi,<br />
Phragmito-Magnocaricetea)<br />
1 1707,34 1,45<br />
8 13 - Serie sarda, termo-mesomediterranea, del leccio (Prasio majoris-Quercetum ilicis typicum e<br />
phyllireetosum angustifoliae)<br />
1 1160,55 0,98<br />
9 22 - Serie sarda centrale della quercia di Sardegna (Ornitogalo pyrenaici-Quercetum ichnusae) 1 272,75 0,23<br />
area totale cella 396 118008,06<br />
Galio scabri-Quercetum suberis si estende per il 34,9%. La serie è stata descritta per la cella 397 di Oliena (NU).<br />
Galio scabri-Quercetum ilicis copre il 26,7% dell’area della cella. E’ una serie indifferente edifica con una vegetazione potenziale a Quercus<br />
ilex in cui le fitocenosi sostitutive sono costituite da: macchia alta dell’associazione Erico arboreae-Arbutetum unedonis su substrati acidi;<br />
macchia a Pistacia lentiscus e Rhamnus alaternus su substrati alcalini; garighe a Cistus monspeliensis o a Osyris alba, specie colonizzatrici<br />
delle aree incenditate; praterie ad emicriptofite della classe Artemisietea e dalle comunità terofitiche della classe Tuberarietea guttatae.<br />
Prasio majoris-Quercetum ilicis typicum e phyllireetosum angustifoliae è stata descritta per la cella 457 di Telti (SS).<br />
La serie edafo-mesofila, mesomediterranea, Violo dehnhardtii-Quercetum suberis, che si estende per oltre il 20,2% della superficie della<br />
cella, ha il suo optimum su substrati vulcanici oligo-miocenici e plio-pleistocenici e la tappa matura è un bosco a Quercus suber e altre querce<br />
caducifoglie.<br />
Le serie più estese nelle due celle seguenti, 367 di Desulo (NU), 366 di Samugheo (OR) e 337 di Escalaplano (NU), sono già state descritte. I<br />
valori di copertura sono indicati nelle rispettive tabelle.<br />
165
Tabella 162 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 367 di Desulo (NU)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 13 - Serie sarda, termo-mesomediterranea, del leccio (Prasio majoris-Quercetum ilicis typicum e<br />
phyllireetosum angustifoliae)<br />
3 49154,36 41,47<br />
2 19 - Serie sarda, termo-mesomediterranea, della sughera (Galio scabri-Quercetum suberis) 7 44744,39 37,75<br />
3 14 - Serie sarda occidentale calcicola, termomediterranea, del leccio (Prasio majoris-Quercetum<br />
ilicis chamaeropetosum humilis)<br />
5 9624,28 8,12<br />
4 22 - Serie sarda centrale della quercia di Sardegna (Ornithogalo pyrenaici-Quercetum ichnusae) 5 8375,76 7,07<br />
5 16 - Serie sardo-corsa calcifuga, meso-supramediterranea, del leccio (Galio scabri-Querc. ilicis) 3 5108,36 4,31<br />
6 15 - Serie sarda calcicola, mesomediterranea, del leccio (Prasio majoris-Quercetum ilicis<br />
quercetosum virgilianae)<br />
2 903,25 0,76<br />
7 10 - Serie sarda basifila, termomediterranea, dell'olivastro (Asparago albi-Oleetum sylvestris) 1 336,59 0,28<br />
8 1 - Serie psammofila del ginepro coccolone (Asparago acutifolii-Juniperetum macrocarpae) 1 275,50 0,23<br />
area totale cella 367 118522,47<br />
Tabella 163 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 366 di Samugheo (OR)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 16 - Serie sardo-corsa calcifuga, meso-supramediterranea, del leccio (Galio scabri-Querc. ilicis) 6 41155,60 34,72<br />
2 19 - Serie sarda, termo-mesomediterranea, della sughera (Galio scabri-Quercetum suberis) 2 24661,72 20,81<br />
3 13 - Serie sarda, termo-mesomediterranea, del leccio (Prasio majoris-Quercetum ilicis typicum e<br />
phyllireeto um angustifoliae)<br />
6 19354,64 16,33<br />
4 18 - Serie sarda centro-occidentale calcifuga, meso-supratemperata, del leccio (Saniculo<br />
europeae-Quercetum ilicis)<br />
4 14260,80 12,03<br />
5 22 - Serie sarda centrale della quercia di Sardegna (Ornithogalo pyrenaici-Quercetum ichnusae) 1 7581,32 6,40<br />
6 20 - Serie sarda centro-occidenta e edafo-mesofila, mesomediterranea, della sughera (Violo<br />
dehnhardtii-Quercetum suberis)<br />
2 5156,65 4,35<br />
7 10 - Serie sarda basifila, termomediterranea, dell'olivastro (Asparago albi-Oleetum sylvestris) 1 2876,05 2,43<br />
8 15 - Serie sarda calcicola, mesomediterranea, del leccio (Prasio majoris-Q uercetum ilicis 1 1874,08 1,58<br />
quercetosum virgilianae)<br />
9 29 - Geosigmeto alofilo sardo delle aree salmastre, degli stagni e delle lagune costiere<br />
(Ruppietea, Thero-Suaedetea, Saginetea maritimae, Salicornietea fruticosae, Juncetea maritimi,<br />
Phragmito-Magnocaricetea)<br />
4 1598,93 1,35<br />
area totale cella 366 118519,78<br />
166
Tabella 164 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 337 di Escalaplano (NU)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 13 - Serie sarda, termo-mesomediterranea, del leccio (Prasio majoris-Quercetum ilicis typicum e<br />
phyllireetosum angustifoliae)<br />
2 51084,65 42,92<br />
2 16 - Serie sardo-corsa calcifuga, meso-supramediterranea, del leccio (Galio scabri-Quercetum<br />
ilicis)<br />
4 27001,95 22,68<br />
3 17 - Serie sarda centro-meridionale calcicola, meso-supramediterranea, del leccio (Aceri<br />
monspessulani-Quercetum ilicis)<br />
2 20270,29 17,03<br />
4 18 - Serie sarda centro-occidentale calcifuga, meso-supratemperata, del leccio (Saniculo<br />
europaeae-Quercetum ilicis)<br />
3 7394,05 6,21<br />
5 22 - Serie sarda centrale della quercia di Sardegna (Ornithogalo pyrenaici-Quercetum ichnusae) 7 7286,01 6,12<br />
6 21 - Serie sarda della quercia di Virgilio (Lonicero implexae-Quercetum virgilianae) 3 3842,87 3,23<br />
7 20 - Serie sarda centro-occidentale edafo-mesofila, mesomediterranea, della sughera (Violo<br />
dehnhardtii-Quercetum suberis)<br />
1 1449,26 1,22<br />
8 15 - Serie sarda calcicola, mesomediterranea, del leccio (Prasio majoris-Quercetum ilicis<br />
quercetosum virgilianae)<br />
1 703,34 0,59<br />
area totale cella 337 119032,42<br />
Nella cella 325 ubicata nelle province calabresi di Cosenza e Crotone, la serie di vegetazione più estesa (45,9%) risulta la termomediterranea<br />
Oleo-Quercetum virgilianae che si mosaica con la serie dell'Oleo-Ceratonion (Oleo-Juniperetum turbinatae,Oleo-Pistacietum lentisci),<br />
interessando la fascia collinare del versante ionico dal livello del mare fino a 500-600 m.<br />
La serie dell’Oleo-Quercetum virgiliana , che predilige i substrati argillosi, marnosi e marnoso-argillosi della fascia termomediterranea, prevale sui<br />
versanti con esposizioni più fresche, quali quelli settentrionali.Nelle esposizioni più calde si localizza la macchia dell’Oleo-Ceratonion con la serie<br />
dell’Oleo-Juniperetum turbinatae sulle superfici più acclivi e dell’Oleo-Pistacietum lentisci, nelle zone meno acclivi. Incendi e processi erosivi che<br />
portano alla formazione di morfotipi calanchivi consentono l’affermarsi delle praterie steppiche a Lygeum spartum del Moricandio-Lygeion, che<br />
attualmente caratterizzano gran parte del territorio interessato da questo mosaico.<br />
La serie sud-appenninica delle cerrete mesofile neutro-subacidofile (Physospermo verticillati-Quercetum cerris) è localizzata in gran parte dei<br />
rilievi collinari e montani della porzione occidentale e meridionale della regione, generalmente fra gli 800 e i 1200 m circa, prevalentemente su<br />
substrati flyschoidi argilloso-arenacei. Nello stadio maturo la comunità è caratterizzata dalla dominanza di specie forestali dei Quercetalia<br />
pubescentipetraeae accompagnate da un ricco contingente erbaceo dei Fagetalia. Gli stadi della serie sono costituiti da arbusteti del Berberidion a<br />
Rosa obtusifolia, Rosa nitidula e Prunus spinosa, praterie a Bromus erectus e Brachypodium rupestre del Bromion erecti.<br />
167
Tabella 165 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 325 di Campana (CS)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 65 - c: Serie sud-appenninica termomediterranea della quercia virgiliana e dell'olivastro (Oleo-<br />
Quercetum virgilianae) a mosaico con la serie delle macchie a ginepro fenicio e lentisco dell'Oleo-<br />
Ceratonion (Oleo-Juniperetum turbinatae ,Oleo-Pistacietum lentisci)<br />
2 55533,85 45,93<br />
2 49 - Serie sud-appenninica delle cerrete mesofile neutro-subacidofile (Physospermo verticillati-<br />
Quercetum cerris)<br />
1 25761,29 21,31<br />
3 51- a: Serie sud-appenninica dei boschi acidofili supramediterranei di farnetto (Cytiso villosi-<br />
Quercetum frainetto)<br />
1 13052,96 10,80<br />
4 51- b: Serie sud-appenninica dei boschi acidofili supramediterranei di farnetto (Cytiso villosi-<br />
Quercetum frainetto) a mosaico con la serie dell'Erico-Quercetum vigilianae<br />
1 10284,66 8,51<br />
5 18 - a: Serie sud-appenninica delle faggete termofile (Anemono apenninae-Fagetum sylvaticae) 2 5751,40 4,76<br />
6 64 - Serie sud-appenninica mesomediterranea acidofila della quercia virgiliana e dell'erica arborea<br />
(Erico-Quercetum virgilianae)<br />
2 2848,83 2,36<br />
7 65 - a: Serie sud-appenninica termomediterranea della quercia virgiliana e dell'olivastro (Oleo-<br />
Quercetum virgilianae)<br />
1 2348,99 1,94<br />
8 92 - a: Geosigmeto termo-mesomediterraneo della vegetazione delle fiumare. Articolazione<br />
catenale in relazione alla profonditÓ della falda freatica ed al disturbo arrecato dalle piene<br />
((Artemisio-Helicrysetum italici, Nerion oleandri, Tamarici africanae-Viticetum agni-casti)<br />
3 1335,35 1,10<br />
area totale cella 325 120898,52<br />
In questa stessa cella, la serie dei boschi acidofili supramediterranei di farnetto Cytiso villosi-Quercetum frainetto occupa una superficie di<br />
13053 ettari circa. Presente nelle fasce submontana e montana (da 700 a 1200 m) dei versanti ionici, poco o mediamente acclivi, dell’Appennino<br />
calabrese, questa serie talvolta si alterna con quella dell’Erico-Querceto virgilianae formando dei mosaici o inserendosi come serie accessoria.<br />
La tappa matura, che si localizza su suoli bruni acidi profondi e ben evoluti, è rappresentata dal bosco mesotermofilo a dominanza di farnetto<br />
(Quercus frainetto), talora con presenza di acero napoletano (Acer neapolitanum), carpino nero (Ostrya carpinifolia ) e orniello (Fraxinus ornus)<br />
governato a ceduo, con strato arbustivo di citiso trifloro (Cytisus villosus) ed erica (Erica arborea). Lo strato erbaceo è costituito da un ricco<br />
contingente di specie nemorali quali Euphorbia amygdaloides ssp. arbuscula, Poa sylvicola, Clinopodium vulgare ssp. arundanum, Festuca<br />
heterophylla , ecc. Gli stadi della serie sono cespuglieti a citiso trifloro e ginestra dei carbonai (Cytisetum villoso-scoparii), pascoli mesofili<br />
(Molinio-Arrhenateretea), garighe a Calicotome infesta e cisti (Cisto-Ericion).<br />
Se la serie descritta è a mosaico con Erico-Quercetum virgilianae, querceti caducifogli a farnetto (Cytiso-Querceto frainetto sigmetum), localizzati<br />
negli impluvi e comunque in condizioni edafiche di maggior freschezza ed umidità, si alternano con quelli a quercia castagnara (Erico-Querceto<br />
virgilianae sigmetum), sitati nei displuvi.<br />
168
Le serie di vegetazione più estese nelle celle 307 di Sinnai (CA), 305 di Iglesias (OR) e 276 di Pula (CA) sono già state descritte. I valori di<br />
copertura sono riportati nelle tabelle seguenti.<br />
Tabella 166 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 307 di Sinnai (CA)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 13 - Serie sarda, termo-mesomediterranea, del leccio (Prasio majoris-Quercetum ilicis typicum e<br />
phyllireetosum angustifoliae)<br />
1 39132,97 32,74<br />
2 17 - Serie sarda centro-meridionale calcicola, meso-supramediterranea, del leccio (Aceri<br />
monspessulani-Quercetum ilicis)<br />
1 33912,70 28,37<br />
3 16 - Serie sardo-corsa calcifuga, meso-supramediterranea, del leccio (Galio scabri-Quercetum.<br />
ilicis)<br />
1 18502,39 15,48<br />
4 10 - Serie sarda basifila, termomediterranea, dell'olivastro (Asparago albi-Oleetum sylvestris) 2 15191,91 12,71<br />
5 4 - Serie sarda occidentale, calcicola, del ginepro turbinato (Chamaeropo humilis-Juniperetum<br />
turbinatae)<br />
2 4366,45 3,65<br />
6 18 - Serie sarda centro-occidentale calcifuga, meso-supratemperata, del leccio (Saniculo<br />
europaeae-Quercetum ilicis)<br />
4 3106,13 2,60<br />
7 26 - Geosigmeto edafoigrofilo e planiziale (Populenion albae, Fraxino angustifoliae-Ulmenion<br />
minoris, Salicion albae)<br />
1 950,13 0,79<br />
8 3 - Serie sarda del ginepro turbinato (Oleo sylvestris-Juniperetum turbinatae) 2 607,04 0,51<br />
9 1 - Serie psammofila del ginepro coccolone (Asparago acutifolii-Juniperetum macrocarpae) 2 359,87 0,30<br />
area totale cella 307 119539,06<br />
169
Tabella 167 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 305 di Iglesias (CA)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 16 - Serie sardo-corsa calcifuga, meso-supramediterranea, del leccio (Galio scabri-Querc. ilicis) 4 40662,44 34,02<br />
2 13 - Serie sarda, termo-mesomediterranea, del leccio (Prasio majoris-Quercetum ilicis typicum e<br />
phyllireetosum angustifoliae)<br />
3 35967,70 30,09<br />
3 29 - Geosigmeto alofilo sardo delle aree salmastre, degli stagni e delle lagune costiere<br />
(Ruppietea, Thero-Suaedetea, Saginetea maritimae, Salicornietea fruticosae, Juncetea maritimi,<br />
Phragmito-Magnocaricetea)<br />
5 10420,53 8,72<br />
4 3 - Serie sarda del ginepro turbinato (Oleo sylvestris-Juniperetum turbinatae) 4 8298,90 6,94<br />
5 12 - Serie sarda calcifuga, termomedi erranea, del leccio (Pyro amygdaliformis-Quercetum ilicis) 1 2885,28 2,41<br />
6 11 - Serie sarda calcifuga, mesomediterranea, dell'olivastro (Cyclamino repandi-Oleetum<br />
sylvestris)<br />
1 711,34 0,60<br />
7 1 - Serie psammofila del ginepro coccolone (Asparago acutifolii-Juniperetum macrocarpae) 1 470,09 0,39<br />
8 2 - Serie psammofila sarda sud-occidentale della quercia di Palestina (Rusco aculeati-Quercetum<br />
calliprini)<br />
1 467,13 0,39<br />
9 10 - Serie sarda basifila, termomediterranea, dell'olivastro (Asparago albi-Oleetum sylvestris) 1 150,85 0,13<br />
area totale cella 305 119540,85<br />
Tabella 168 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 276 di Pula (CA)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 13 - Serie sarda, termo-mesomediterranea, del leccio (Prasio majoris-Quercetum ilicis typicum e<br />
phyllireetosum angustifoliae)<br />
1 44225,32 36,84<br />
2 16 - Serie sardo-corsa calcifuga, meso-supramediterranea, del leccio (Galio scabri-Querc. ilicis) 4 17910,28 14,92<br />
3 11 - Serie sarda calcifuga, mesomediterranea, dell'olivastro (Cyclamino repandi-Oleetum<br />
sylvestris)<br />
2 6781,35 5,65<br />
4 3 - Serie sarda del ginepro turbinato (Oleo sylvestris-Juniperetum turbinatae) 3 1524,56 1,27<br />
5 26 - Geosigmeto edafoigrofilo e planiziale (Populenion albae, Fraxino angustifoliae-Ulmenion<br />
minoris, Salicion albae)<br />
2 1278,27 1,06<br />
6 10 - Serie sarda basifila, termomediterranea, dell'olivastro (Asparago albi-Oleetum sylvestris) 1 1115,85 0,93<br />
7 29 - Geosigmeto alofilo sardo delle aree salmastre, degli stagni e delle lagune costiere<br />
(Ruppietea, Thero-Suaedetea, Saginetea maritimae, Salicornietea fruticosae, Juncetea maritimi,<br />
Phragmito-Magnocaricetea)<br />
1 686,11 0,57<br />
area totale cella 376 120039,56<br />
170
Tabella 169 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 171 di Castiglione di Sicilia (CT)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 23 - Serie dei querceti caducifogli termofili acidofili (Erico-Quercetum virgilianae) 2 26419,30 21,49<br />
2 22 - Serie dei querceti caducifogli termofili basifili (Oleo-Quercetum virgilianae) 18 15862,93 12,91<br />
3 33 - Serie dei querceti caducifogli mesofili e acidofili (Festuco heterophyllae-Quercetum<br />
1 7402,17 6,02<br />
congestae)<br />
4 20 - Serie dei sughereti termo-mesofili (Genisto aristate-Quercetum suberis) 8 6578,77 5,35<br />
5 29 - Serie dei querceti caducifogli mesofili acidofili (Vicio cassubicae-Quercetum cerridis) 4 4468,79 3,64<br />
6 27 - Serie dei querceti caducifogli mesofili e acidofili (Arabido-Quercetum congestae) 1 3753,35 3,05<br />
7 35 - Serie dei faggeti acidofili (Epipactido meridionalis-Fagetum) 1 3102,93 2,52<br />
8 26 - Serie dei querceti caducifogli mesofili acidofili (Agropyro panormitani-Quercetum<br />
1 2997,63 2,44<br />
congestae)<br />
9 9 - Serie della macchia-foresta di sclerofille mediterranee (Myrto-Lentiscetum) 2 2975,67 2,42<br />
10 36 - Serie dei faggeti acidofili (Rubo aetnici-Fagetum) 2 2859,08 2,33<br />
11 39 - Serie dei fruticeti montani su substrati vulcanici (Rumici-Astragalion siculi) 1 2640,74 2,15<br />
12 28 - Serie dei cerreti (Arrhenathero nebrodensis-Quercetum cerridis) 2 2266,47 1,84<br />
13 18 - Serie dei lecceti mesofili basifili (Aceri campestris-Quercetum ilicis) 19 1920,48 1,56<br />
14 30 - Serie dei querceti caducifogli mesofili e acidofili (Quercetum gussonei) 2 1863,93 1,52<br />
15 16 - Serie dei lecceti mesofili acidifili (Teucrio siculi-Quercetum ilicis) 3 677,32 0,55<br />
16 1 - Serie psammofila delle dune (Ammophilion australis) 3 378,91 0,31<br />
17 3 - Serie della macchia a ginepro coccolone (Ephedro-Juniperetum macrocarpae) 1 318,60 0,26<br />
18 14 - Serie dei lecceti termofili basifili (Pistacio lentisci-Quercetum ilicis) 3 221,06 0,18<br />
19 8 - Serie della macchia semirupestre ad olivastro ed euforbia arborescente (Oleo-Euphorbietum 4 190,22 0,15<br />
dendroidis)<br />
20 19 - Serie dei lecceti mesofili acidifili (Geranio versicoloris-Qeurcetum ilicis) 4 80,63 0,07<br />
21 2 - Serie delle fitocenosi aeroaline delle falesie (Crithmo-Limonion) 2 42,98 0,03<br />
area totale cella 171 122918,83<br />
La serie più estesa dell’Erico-Quercetum virgilianae (21,5% della superficie della cella) è legata agli ambienti costieri o collinari posti a<br />
quote in genere non superiori a 500-600 m e predilige suoli profondi di natura silicea a reazione acida. La testa di serie è una formazione<br />
boschiva a dominanza di Quercus virgiliana; un fitto strato arbustivo è rappresentato da specie calcifughe come Erica arborea, Cytisus<br />
villosus, Arbutus unedo, Calicotome infesta, Teline monspessulana, ecc. La sua forma degradata si indirizza verso una vegetazione arbustiva<br />
dell’Ericion arboreae, delle garighe acidofile del Cisto-Ericion o del Cistion ladaniferi che a loro volta, con l’accentuarsi dei processi erosivi<br />
171
del suolo, vengono sostituiti da praticelli del Tuberarion guttatae. Nell’ambito del territorio riferito all’Erico-Quercetum virgilianae sono<br />
presenti rimboschimenti a Pinus halepensis e castagneti.<br />
La serie dei querceti caducifogli termofili basifili, che occupa una superficie di 15.862 ha, è distribuita in tutta la Regione Sicilia e interessa<br />
una fascia altimetrica piuttosto ampia che va dalla costa fino a 1000-1100 m di quota e substrati di varia natura (calcari, dolomie, marne,<br />
argille, basalti, calcareniti, ecc.). L’associazione testa di serie è una formazione forestale prettamente termofila, caratterizzata da Quercus<br />
virgiliana e Quercus amplifolia dominantii: si tratta di un bosco a prevalenza di querce caducifoglie ricco sia di specie xerofile come Olea<br />
europaea var. sylvestris, Pistacia lentiscus,Teucrium fruticans, Prasium majus, Euphorbia dendroides, Chamaerops humilis, Ceratonia<br />
siliqua, Asparagus albus, che di specie termofile come Quercus ilex, Rubia peregrina, Carex distachya, Osyris alba, Asparagus acutifolius,<br />
Smilax aspera, Calicotome infesta, Arisarum vulgare, Lonicera implexa, Phillyrea latifolia, Ruscus aculeatus, ecc. Gli stadi della serie<br />
dell’Oleo-Quercetum virgilianae sono costituiti da garighe del Cisto-Ericion. La distruzione di queste formazioni arbustive soprattutto<br />
causata dagli incendi porta all’insediamento di praterie perenni dell’Helichryso-Ampelodesmetum mauritanici. L’ulteriore degradazione del<br />
suolo per erosione induce l’insediamento di praticelli effimeri del Trachynion distachyae, come il Vulpio-Trisetarietum aureae e, nei tratti<br />
rocciosi, il Thero-Sedetum cerulei. Anche in questo ambito territoriale sono presenti rimboschimenti realizzati soprattutto con specie dei<br />
generi Pinus (P. halepensis, P. pinaster, P. pinea. P. nigra), Cupressus (C. sempervirens, C. arizonica, C. macrocarpa) ed Eucaliptus.<br />
Tabella 170 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 170 di Bronte (CT)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 33 - Serie dei querceti caducifogli mesofili e acidofili (Festuco heterophyllae-Quercetum<br />
congestae)<br />
2 54346,38 44,26<br />
2 34 - Serie dei faggeti acidofili (Anemono apenninae-Fagetum) 5 18902,02 15,39<br />
3 28 - Serie dei cerreti (Arrhenathero nebrodensis-Quercetum cerridis) 9 15529,51 12,65<br />
4 35 - Serie dei faggeti acidofili (Epipactido meridionalis-Fagetum) 1 12292,40 10,01<br />
5 30 - Serie dei querceti caducifogli mesofili e acidofili (Quercetum gussonei) 4 9589,87 7,81<br />
6 22 - Serie dei querceti caducifogli termofili basifili (Oleo-Quercetum virgilianae) 7 5174,71 4,21<br />
7 39 - Serie dei fruticeti montani su substrati vulcanici (Rumici-Astragalion siculi) 1 2134,72 1,74<br />
8 27 - Serie dei querceti caducifogli mesofili e acidofili (Arabido-Quercetum congestae) 1 1939,32 1,58<br />
9 26 - Serie dei querceti caducifogli mesofili acidofili (Agropyro panormitani-Quercetum<br />
congestae)<br />
1 1116,73 0,91<br />
10 15 - Serie dei querceti caducifogli termofili (Celtido aetnensis-Quercetum virgilianae) 3 667,16 0,54<br />
11 18 - Serie dei lecceti mesofili basifili (Aceri campestris-Quercetum ilicis) 7 539,45 0,44<br />
12 19 - Serie dei lecceti mesofili acidifili (Geranio versicoloris-Qeurcetum ilicis) 1 151,81 0,12<br />
13 14 - Serie dei lecceti termofili basifili (Pistacio lentisci-Quercetum ilicis) 3 102,43 0,08<br />
area totale cella 170 122802,01<br />
172
La serie Festuco heterophyllae-Quercetum congestae copre quasi la metà della superficie dell’unità campione 170 e oltre il 31% della 169.<br />
Localizzata in Sicilia nelle stazioni montane, in particolare sul versante meridionale dei Nebrodi e su quello occidentale e meridionale etneo,<br />
è la serie dei querceti caducifogli mesofili e acidofili a dominanza di Quercus congesta.<br />
Nella cella 170 è rappresentata per il 15,4% la serie dei faggeti acidofili Anemono apenninae-Fagetum (15,4%), che è presente nelle<br />
Madonie, nei Nebrodi e nei Peloritani. La tappa matura è un bosco mesofilo a netta dominanza di Fagus sylvatica.<br />
La serie dell’Arrhenathero nebrodensis-Quercetum cerridis, interposta tra i querceti termofili, in basso, e il faggeto, si estende per 15.529,5<br />
ettari. Lo stadio maturo è costituito da un cerreto montano ben differenziato dalle analoghe formazioni appenniniche centro-meridionali per<br />
la presenza di alcune specie endemiche siciliane (Arrhenatherum nebrodense, Aristolochia sicula, A. clusii).<br />
Tabella 171 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 169 di Mistretta (ME)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 33 - Serie dei querceti caducifogli mesofili e acidofili (Festuco heterophyllae-Quercetum<br />
congestae)<br />
4 38212,93 31,15<br />
2 30 - Serie dei querceti caducifogli mesofili e acidofili (Quercetum gussonei) 2 27588,47 22,49<br />
3 24 - Serie dei querceti caducifogli mesofili basifili (Sorbo torminalis-Quercetum virgilianae) 4 15797,85 12,88<br />
4 28 - Serie dei cerreti (Arrhenathero nebrodensis-Quercetum cerridis) 5 14462,30 11,79<br />
5 20 - Serie dei sughereti termo-mesofili (Genisto aristate-Quercetum suberis) 14 10868,83 8,86<br />
6 22 - Serie dei querceti caducifogli termofili basifili (Oleo-Quercetum virgilianae) 16 5452,42 4,44<br />
7 34 - Serie dei faggeti acidofili (Anemono apenninae-Fagetum) 2 5027,34 4,10<br />
8 31 - Serie dei querceti caducifogli mesofili acidofili (Quercetum leptobalanae) 13 2780,65 2,27<br />
9 18 - Serie dei lecceti mesofili basifili (Aceri campestris-Quercetum ilicis) 10 721,84 0,59<br />
10 32 - Serie dei querceti (Ilici-Quercetum petraeae) 4 676,23 0,55<br />
11 9 - Serie della macchia-foresta di sclerofille mediterranee (Myrto-Lentiscetum) 1 416,32 0,34<br />
12 23 - Serie dei querceti caducifogli termofili acidofili (Erico-Quercetum virgilianae) 3 246,16 0,20<br />
13 8 - Serie della macchia semirupestre ad olivastro ed euforbia arborescente (Oleo-Euphorbietum<br />
dendroidis)<br />
4 214,97 0,18<br />
14 16 - Serie dei lecceti mesofili acidifili (Teucrio siculi-Quercetum ilicis) 4 142,98 0,12<br />
15 14 - Serie dei lecceti termofili basifili (Pistacio lentisci-Quercetum ilicis 4 83,56 0,07<br />
area totale cella 169 122692,85<br />
La cella 169 è anche coperta per il 22,5% dal Quercetum gussonei, anch’essa serie dei querceti caducifogli mesofili e acidofili in cui però la<br />
tappa matura è una formazione a bosco dominata da Quercus gussonei, specie affine a Quercus. cerris, ma dai caratteri più termofili.<br />
173
La serie dei querceti caducifogli mesofili basifili (Sorbo torminalis-Quercetum virgilianae) si estende per 15.795,8 ettari su suoli profondi di<br />
natura calcarea. Localizzata nella Sicilia centrale ed in particolare nel complesso dei Monti Sicani, a quote comprese tra 900 e 1400 m., ha<br />
come associazione testa di serie un querceto caratterizzato da Quercus virgiliana insieme a Sorbus torminalis, Physospermum verticillatum e<br />
Huetia cynapioides, queste ultime specie rare in Sicilia (in particolare le ultime due, esclusive di questa formazione forestale). A questi taxa<br />
si accompagnano altre essenze legnose quali Quercus ilex, Q. amplifolia, Fraxinus ornus, Acer campestre. La presenza di un certo<br />
contingente dei Querco-Fagetea (Brachypodium sylvaticum, Acer campestre, Daphne laureola, Clematis vitalba, Hedera elix, Euphorbia<br />
amygdaloides subsp. arbuscula, Sorbus aucuparia, ecc.) evidenziano il carattere mesofilo dell’associazione. Le comunità arbustive della<br />
serie vengono riferite al Cerastio-Astragalion nebrodensis o al Pruno-Rubion ulmifolii.<br />
La serie dei cerreti (Arrhenathero nebrodensis-Quercetum cerridis), già descritta in precedenza, è diffusa ampiamente sui Monti Nebrodi<br />
(Sicilia settentrionale) nella fascia altimetrica interposta tra i querceti termofili, in basso, e il faggeto. Gli aspetti di degradazione di un cerreto<br />
montano che ne costituisce invece la tappa matura portano all’insediamento di praterie mesofile riferibili al Plantaginion cupanii.<br />
174
REGIONE TEMPERATA<br />
Tabella 172 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 1063 di Selva dei Molini (BZ)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 3 - Geosigmeto della vegetazione di prateria alpina e pioniera ipsofila su substrati a reazione acida<br />
(Caricion curvulae)<br />
10 19487,04 18,38<br />
2 11 - a: Geosigmeto delle peccete e degli arbusteti subalpini dei substrati silicatici: boschi di conifere<br />
altimontani e subalpini, delle mughete e del rododendreto a Rhododendron ferrugineum<br />
(Calamagrostio villosae-Abietetum, Homogyno-Piceetum, Rhododendro ferruginei-Pinetum<br />
prostatae, Rhododendretum ferruginei)<br />
9 18428,60 17,38<br />
3 11 - b: Geosigmeto delle peccete e degli arbusteti subalpini dei substrati silicatici: rodoreti e<br />
junipereti (serie del Vaccinio-Rhododendretum ferruginei e serie edafo-xerofila del Festucetum<br />
scabriculmis)<br />
16 17244,03 16,26<br />
4 74 - Serie acidofila dei boschi di rovere del piano supratemperato (Luzulo niveae-Quercetum<br />
petraeae)<br />
1 15514,72 14,63<br />
5 14 - Serie dei boschi ad abete bianco e rosso del Vaccinio-Abietenion (Calamagrostio villosae-<br />
Abietetum albae, Vaccinio-Abietetum albae)<br />
3 12049,39 11,36<br />
6 21 - Serie acidofila altomontana delle abetine ad abete bianco dei piani supratemperato e<br />
orotemperato (Pyrolo rotundifoliae-Abietetum albae, Luzulo niveae-Abietetum albae)<br />
3 8784,41 8,28<br />
7 42 - Serie acidofila del pino silvestre di Dicrano-Pinion sylvestris (Vaccinio vitis-idaea-Pinetum<br />
sylvestris)<br />
4 6930,96 6,54<br />
8 20 - Serie delle peccete montane e altimontane (Abieti-Piceion) 5 3013,49 2,84<br />
9 13 - Serie delle mughete basifile dei piani orotemperato e criorotemperato dell’alleanza Erico-<br />
Pinion mugo (Erico carneae-Pinetum mugo, Mugo-Rhododendretum)<br />
1 1325,41 1,25<br />
10 1 - Geosigmeto meso-endalpico dei substrati intrusivi e metamorfici dell'orizzonte altoalpinosubnivale:<br />
vegetazione dei ghiaioni e delle rocce (Sieversio-Oxyrietum, Androsacetum alpinae,<br />
Androsacion vandelli, Saxifrago-Poetum alpinae, Luzuletum alpino-pilosae)<br />
2 722,66 0,68<br />
11 7 - Geosigmeto della vegetazione delle praterie alpine e vegetazione pioniera ipsofila su substrati a<br />
reazione alcalina (Seslerion albicantis s.l.)<br />
2 346,84 0,33<br />
area totale cella 1063 106031,05<br />
Le serie di vegetazione più estese sono Luzulo niveae-Quercetum petraeae, serie acidofila dei boschi di rovere del piano supratemperato, che<br />
si estende per il 14,6% della cella e Calamagrostio villosae-Abietetum albae, Vaccinio-Abietetum albae, serie dei boschi ad abete bianco e<br />
rosso del Vaccinio-Abietenion, che ne copre l’11,5%.<br />
175
Un tempo molto più estesi, i boschi del Luzulo niveae-Quercetum petraeae che hanno fortemente subito l’azione antropica (trasformazioni dovute<br />
all’agricoltura, alle ceduazioni, alla sostituzione con rimboschimenti a conifere) sono ora limitati alle zone rupestri molto acclivi non sfruttabili<br />
dall’uomo. Quercus petraea è dominante, accompagnata da Fraxinus ornus, Tilia cordata, Prunus avium. Lo strato arbustivo presenta, oltre agli<br />
individui giovani delle dominanti, Prunus avium, Laburnum alpinum, Genista tinctoria e G. germanica. Tra le erbacee sono presenti Luzula nivea,<br />
Festuca heterophylla, Poa nemoralis e Hieracium sp.pl. Queste fitocenosi presentano delle affinità floristiche con il Potentillo albae-Quercetum<br />
petraeae dell’Europa centrale, dal quale si differenziano per la presenza di un contingente di specie termofile (Fraxinus ornus, Asplenium<br />
adiantum-nigrum, Prunus mahaleb), acidofile (Hieracium racemosum, Polypodium vulgare, Luzula nivea, Vaccinium myrtillus, Phyteuma<br />
betonicifolium), prealpiche (Laburnum alpinum) ed endemiche (Melampyrum italicum) e di esclusive (Galium sylvaticum, Dactylis<br />
polygama, Stellaria holostea, Carex umbrosa e Holcus mollis). Le formazioni trentine rappresenterebbero infatti la vicariante prealpica, termofila e<br />
acidofila di quelle centro-europee.<br />
La serie dei boschi ad abete bianco e rosso del Vaccinio-Abietenion è localizzata in corrispondenza di pendii umidi su substrati di natura<br />
silicatica (Calamagrostio villosae-Abietetum) o con chimismo basico e neutro-subacido, su suoli primitivi ranker, a quote comprese tra i 1300 e i<br />
1450 m (fino ai 1650 per la serie del Calamagrostio villosae-Abietetum) nel piano orotemperato. Lo stadio maturo del Calamagrostio villosae-<br />
Abietetum albae è rappresentato da abetine ad Abies alba con Picea abies, Larix decidua o Pinus cembra, ricche di elementi della peccata come<br />
Vaccinium myrtillus, Melampyrum sylvaticum, M. pratense, Homogyne alpina. La riconduzione alla suballeanza Vaccinio -Abietenion è supportata<br />
dalla presenza Abies alba, Prenanthes purpurea e Fagus sylvatica. Queste formazioni presentano alcune specie orofile che fungono da differenziali<br />
di associazione: Calamagrostis villosa, Larix decidua, Pinus cembra, Clematis alpina. L’elevata umidità favorisce uno strato muscinale<br />
significativo. La tappa matura del Vaccinio -Abietetum albae è invece costituita da abetine ad Abies alba con Picea abies e Fagus sylvatica, con<br />
numerosi element della classe Vaccinio-Piceetea: Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Homogyne alpina, Melampyrum pratense subsp.vulgatum, M.<br />
sylvaticum.<br />
Caricion curvulae, geosigmeto della vegetazione di prateria alpina e pioniera ipsofila su substrati a reazione acida, copre il 18,4%. Lo stadio<br />
maturo è costituito da praterie riferibili a diverse associazioni quali cariceti a Carex curvula, festuceti a Festuca varia, festuceti a F. paniculata.<br />
particolarmente diffuso è il Festucetum variae, che rappresenta un’asociazione xerofila tipica dei pendii aridi e sassosi presente sia nel piano<br />
subalpino (spesso di origine secondaria) sia nel piano alpino. La specie dominante è sempre F. varia accompagnata da un contingente caratteristico<br />
composto da Laserpitium halleri, Bupleurum stellatum, Hieracium hoppeanum, Veronica fruticans, Pulmonaria angustifolia, Koeleria hirsuta.<br />
Laddove le condizioni edafiche risultano improntate ad una maggiore umidità subentrano specie meso-igrofile quali Nardus stricta, Festuca rubra,<br />
Potentilla erecta, Hieracium auricola, Crocus vernalis.<br />
Nelle zone subpianeggianti o pianeggianti il Festucetum variae è sostituito dal nardeto e Festuca varia si limita solo ai dossi del terreno o agli<br />
affioramenti rocciosi. Il nardeto è caratterizzato da un discreto numero di specie tra cui le più significative, oltre a Nardus stricta, risultano: Festuca<br />
rubra, Hieracium auricola, Nigritella nigra, Gentiana kochiana, Campanula barbata, Anthoxanthum odoratum, Luzula campestris, Hieracium<br />
pilosella, Arnica montana, Euphrasia minima, Antennaria dioica. Nelle piccole sorgenti che possono bordare i festuceti o i nardeti si sviluppano<br />
tipiche comunità di torbiera (la cui estensione varia da 2-3 ad oltre 200 mq.) a dominanza di carici quali in particolare Carex fusca: l’associazione<br />
Caricetum fuscae si sviluppa su substrati acidi del piano subalpino ed alpino in situazione di acqua stagnante o debolmente fluente. Le specie<br />
caratteristiche ed a più alta frequenza che popolano questa comunità sono: Carex fusca, Carex echinata, Carex canescens, Carex frigida, Carex<br />
magellanica, Carex dioica, Carex panicea, Equisetum palustre, Tofieldia palustris, Viola palustris, Juncus filiformis, Juncus alpinus, Tricophorum<br />
176
caespitosum, Pinguicula alpina. La serie è localizzata su substrati metamorfici nel piano criorotemperato al di sopra dei 2200 m. In questi ambienti<br />
di alta quota la dinamica è molto lenta o addirittura inesistente: si tratta dunque di un tipico microgeosigmeto del piano alpino con tipologie di<br />
vegetazione permanente in rapporti catenali.<br />
I boschi di conifere altimontani e subalpini, delle mughete e del rododendreto a Rhododendron ferrugineum (Calamagrostio villosae-<br />
Abietetum, Homogyno-Piceetum, Rhododendro ferruginei-Pinetum prostatae,Rhododendretum ferruginei) riferiti al geosigmeto delle<br />
peccete e degli arbusteti subalpini dei substrati silicatici si estendono per 18428,6 ettari, sono localizzati su substrati metamorfici nel piano<br />
orotemperato a quote tra i 1500 e i 2000 m. Questa pecceta è caratterizzata nello strato arboreo dominante da abete rosso (Picea excelsa) e in quello<br />
dominato da Sorbus aucuparia, oltre che dall’abbondante presenza nello strato arbustivo di Vaccinium myrtillus e Vaccinium vitis-idaea. Tra le<br />
specie erbacee si segnalano Lunula sieberi, Luzula luzulina, Orthilia secunda, Melampyrum sylvaticum, Listera cordata, Oxalis acetosella,<br />
Homogyne alpina, Avenella flexuosa. La pecceta subalpina è in contatto al limite inferiore con il Veronico urticifoliae-Piceetum (che rappresenta la<br />
pecceta del piano montano) e al limite superiore con la fascia ad arbusti contorti a Rhododendron hirsutum.Cespuglieti a Vaccinium myrtillus e<br />
Vaccinium vitis-idaea, praterie a Festuca rubra e Festuca nigrescens sui versanti, praterie a Nardus stricta negli avvallamenti sono le fitocenosi di<br />
sostituzione.<br />
Sempre riferibili al geosigmeto delle peccete e degli arbusteti subalpini dei substrati silicatici vi sono i rodoreti e junipereti (serie del<br />
Vaccinio-Rhododendretum ferruginei e serie edafo-xerofila del Festucetum scabriculmis) che coprono una quota di superficie pari 17244 a<br />
ettari. In questo caso lo stadio maturo è rappresentato da comunità ad arbusti contorti riferibili prevalentemente al Rhododendro-Vaccinietum. Si<br />
tratta di una comunità che si sviluppa in corrispondenza del limite superiore del bosco prevalentemente su versanti esposti a nord oppure su<br />
altipiani o pendii poco inclinati. La composizione floristica di questa comunità è caratterizzata dalla dominanza di Rhododendron ferrugineum,<br />
Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis-idaea, Pinus mugo, Juniperus nana. Lo strato erbaceo è tipicamente impoverito e<br />
composto prevalentemente da Lunula sieberi, Solidago virgaurea subsp. pumila, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, Dryopteris<br />
carthusiana, Melampyrum sylvaticum. Gli stadi di degradazione danno luogo a comunità di sostituzione ascrivibili al Nardion strictae e<br />
all’Androsacion alpinae.<br />
Gli ultimi due geosigmeti descritti sono ancora più estesi nella cella adiacente 1062 di Campo di Trens (BZ) in cui coprono complessivamente il<br />
43,5% della superficie dell’unità campione, seguiti dal geosigmeto del Caricion curvulae.<br />
La presenza di 5 geosigmeti e 6 serie di vegetazione sia nella cella 1063 che nella 1062, indica che solo una parte delle serie di vegetazione esistenti<br />
nelle due areee di campionamento sono risultate cartografabili alla scala.<br />
177
Tabella 173 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 1062 di Campo di Trens (BZ)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 11 - b: Geosigmeto delle peccete e degli arbusteti subalpini dei substrati silicatici: rodoreti e<br />
junipereti (serie del Vaccinio-Rhododendretum ferruginei e serie edafo-xerofila del Festucetum<br />
scabriculmis)<br />
13 24181,45 22,81<br />
2 11 - a: Geosigmeto delle peccete e degli arbusteti subalpini dei substrati silicatici: boschi di<br />
conifere altimontani e subalpini, delle mughete e del rododendreto a Rhododendron ferrugineum<br />
(Calamagrostio villosae-Abietetum, Homogyno-Piceetum, Rhododendro ferruginei-Pinetum<br />
prostatae, Rhododendretum ferruginei)<br />
17 23018,24 21,72<br />
3 3 - Geosigmeto della vegetazione di prateria alpina e pioniera ipsofila su substrati a reazione acida<br />
(Caricion curvulae)<br />
16 20584,54 19,42<br />
4 21 - Serie acidofila altomontana delle abetine ad abete bianco dei piani supratemperato e<br />
orotemperato (Pyrolo rotundifoliae-Abietetum albae, Luzulo niveae-Abietetum albae)<br />
3 15699,22 14,81<br />
5 14 - Serie dei boschi ad abete bianco e rosso del Vaccinio-Abietenion (Calamagrostio villosae-<br />
Abietetum albae, Vaccinio-Abietetum albae)<br />
4 10522,41 9,93<br />
6 74 - Serie acidofila dei boschi di rovere del piano supratemperato (Luzulo niveae-Quercetum<br />
petraeae)<br />
2 4296,18 4,05<br />
7 42 - Serie acidofila del pino silvestre di Dicrano-Pinion sylvestris (Vaccinio vitis-idaea-Pinetum<br />
sylvestris)<br />
2 2114,01 1,99<br />
8 41 - a: Serie endalpica delle pinete a pino silvestre: Erico-Pinion sylvestris 1 519,22 0,49<br />
9 13 - Serie delle mughete basifile dei piani orotemperato e criorotemperato dell’alleanza Erico-<br />
Pinion mugo (Erico carneae-Pinetum mugo, Mugo-Rhododendretum)<br />
1 373,17 0,35<br />
10 7 - Geosigmeto della vegetazione delle praterie alpine e vegetazione pioniera ipsofila su substrati a<br />
reazione alcalina (Seslerion albicantis s.l.)<br />
2 369,55 0,35<br />
11 1 - Geosigmeto meso-endalpico dei substrati intrusivi e metamorfici dell'orizzonte altoalpinosubnivale:<br />
vegetazione dei ghiaioni e delle rocce (Sieversio-Oxyrietum, Androsacetum alpinae,<br />
Androsacion vandelli, Saxifrago-Poetum alpinae, Luzuletum alpino-pilosae)<br />
2 23,34 0,02<br />
area totale cella 1062 105997,15<br />
178
Tabella 174 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 1034 di Auronzo di Cadore (BL)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 16 - Geosigmeto della pecceta subalpina (altimontana) e della mugheta microterma su substrati a<br />
reazione alcalina (Adenostylo glabrae-Piceetum, Rhododendro hirsuti-Pinetum prostratae)<br />
21 18683,77 17,52<br />
2 24 - Serie degli abieteti montani (Abieti-faggeti e Piceo-abieteti) su substrati a reazione alcalina<br />
(Adenostylo glabrae-Abietetum)<br />
19 15844,71 14,86<br />
3 23 - Geosigmeto delle peccete e delle faggete montane su substrati a reazione acida (serie di Luzulo<br />
nemorosae-Piceetum e Luzulo nemorosae-Fagetum)<br />
27 13745,41 12,89<br />
4 5 - Geosigmeto delle praterie alpine e della vegetazione pioniera ipsofila su substrati a reazione alcalina<br />
(serie dominante di Ranunculo hybridi-Caricetum sempervirentis)<br />
14 11952,42 11,21<br />
5 15 - Geosigmeto della pecceta subalpina e del rododendreto a Rhododendron ferrugineum su substrati<br />
a reazione acida<br />
22 9113,82 8,55<br />
6 9 - Geosigmeto del larici-cembreto e della mugheta microterma su substrati a reazione alcalina (Serie<br />
di Calamagrostio villosae-Picetum cembrae e di Rhododendro hirsuti-Pinetum prostratae)<br />
11 7519,82 7,05<br />
7 13 - Serie delle mughete basifile dei piani orotemperato e criorotemperato dell’alleanza Erico-Pinion<br />
mugo (Erico carneae-Pinetum mugo, Mugo-Rhododendretum)<br />
6 6288,94 5,90<br />
8 7 - Geosigmeto della vegetazione delle praterie alpine e vegetazione pioniera ipsofila su substrati a<br />
reazione alcalina (Seslerion albicantis s.l.)<br />
5 5344,41 5,01<br />
9 20 - Serie delle peccete montane e altimontane dell’Abieti-Piceion 7 5190,77 4,87<br />
10 43 - Serie delle pinete oromediterranee a Pinus sylvestris e Pinus nigra (Fraxino orni-Pinetum nigrae) 3 5005,21 4,69<br />
11 83 - a: Geosigmeto perialveale montano endalpico 1 1719,83 1,61<br />
12 21 - Serie acidofila altomontana delle abetine ad abete bianco dei piani supratemperato e orotemperato<br />
(Pyrolo rotundifoliae-Abietetum albae, Luzulo niveae-Abietetum albae)<br />
2 1536,01 1,44<br />
13 41 - a: Serie endalpica delle pinete a pino silvestre: Erico-Pinion sylvestris 1 1000,90 0,94<br />
14 11 - a: Geosigmeto delle peccete e degli arbusteti subalpini dei substrati silicatici: boschi di conifere<br />
altimontani e subalpini, delle mughete e del rododendreto a Rhododendron ferrugineum<br />
(Calamagrostio villosae-Abietetum, Homogyno-Piceetum, Rhododendro ferruginei-Pinetum prostatae,<br />
Rhododendretum ferruginei)<br />
1 930,03 0,87<br />
15 4 b: Geosigmeto delle praterie alpine e della vegetazione pioniera ipsofila su substrati a reazione acida:<br />
serie dominanti di Sieversio-Nardetum strictae e Gentianello anisodontae-Festucetum variae<br />
4 702,81 0,66<br />
16 11 - b: Geosigmeto delle peccete e degli arbusteti subalpini dei substrati silicatici: rodoreti e junipereti<br />
(serie del Vaccinio-Rhododendretum ferruginei e serie edafo-xerofila del Festucetum scabriculmis)<br />
1 538,22 0,50<br />
17 3 - Geosigmeto della vegetazione di prateria alpina e pioniera ipsofila su substrati a reazione acida<br />
(Caricion curvulae)<br />
1 516,62 0,48<br />
area totale cella 1034 106655,07<br />
179
Più estesi invece nella cella 1034 di Auronzo di Cadore sono invece i due geosigmeti della pecceta subalpina e della mugheta microterma su<br />
substrati a reazione alcalina (17,5%) e delle peccete e faggete montane su substrati a reazione acida (12,9%) e la serie degli abieteti montani<br />
(14,9%).<br />
Quest’ultima, diffusa in tutta la montagna veneta, è presente in tutte le aree a grande vocazione forestale. Gli abieteti sono l’espressione forestale<br />
più interessante e naturalisticamente apprezzabile delle Dolomiti; tratta di boschi disetaneiformi, governati a fustaia che si rinnovano senza<br />
particolare difficoltà. La composizione arborea è variabile localmente, secondo cicli secolari, con predominanza di facies con percentuali maggiori<br />
di abete rosso o di faggio. In ogni caso la dominanza e il ruolo dell’abete bianco restano preponderanti. Lo strato arbustivo è articolato e oltre alla<br />
specie che formano lo strato arboreo compaiono soprattutto Lonicera nigra, L. alpigena, Sorbus aucuparia, Ribes, Corylus avellana, Acer<br />
pseudoplatanus. Lo strato erbaceo è di regola molto ricco, soprattutto nelle aree con maggiore influenza fagetale. Frequenti su larghi tratti<br />
numerose specie di felci, Festuca altissima e Petasites albus. In settori con elevata umidità atmosferica sono presenti aspetti a Carex alba di<br />
Adenostylo glabrae-Abietetum, su ripidi versanti, con accentuato drenaggio e fenomeni di aridità estiva.<br />
L’abieteto può essere preceduto, nella serie evolutiva, da comunità di Dentario-Fagetum e Adenostylo glabrae-Piceetum. Nelle aree in cui<br />
l’abieteto è ottimale, si afferma la rinnovazione di abete bianco anche in condizioni edafiche non ideali, ad esempio su ripidi pendii e, nelle zone<br />
più aperte, Abies alba tollera meglio la concorrenza della Picea. Aree prative sono occasionali e legate alla gestione; esse includono triseteti e<br />
arrenatereti (Centaureo transalpinae-Trisetetum, Centaureo carniolicae-Arrhenatherum elatioris); frequenti anche gli stadi di degradazione a<br />
Deschampsia caespitosa. Diffuse le aree con vegetazione nitrofila (Rumicion alpini) derivante dal pascolo e dalle attività antropiche estranee alla<br />
dinamica forestale.<br />
Il geosigmeto della pecceta e della mugheta microterma ingloba due strutture, una arborea ed una arbustiva con i relativi stadi transizione. Nella<br />
pecceta, Picea excelsa è sempre dominante, talvolta accompagnato da Larix decidua. La copertura arbustiva è variabile, con netta prevalenza di<br />
ericacee ed anche Sorbus chamaemespilus, Lonicera caerulea, Clematis alpina. Raramente manca il pino mugo. Lo strato erbaceo, laddove non c’è<br />
pascolo, è rappresentato da specie capaci di tollerare variazioni di umidità del suolo come Adenostyles glabra, Sesleria caerulea, Rubus saxatilis,<br />
Valeriana tripteris, Petasites paradoxus, Calamagrostis varia, Carex ferruginea. Spesso queste formazioni caratterizzano versanti acclivi in cui<br />
l’evoluzione del suolo è rallentata dal dilavamento e dall’erosione superficiale favoriti da nuovi apporti di ghiaie. Le mughete ospitano qualche<br />
pianta arborea (abete rosso o larice), salici (soprattutto Salix glabra, S. waldsteiniana, S.appendiculata), con Erica carnea, Rhodothamnus<br />
chamaecistus e Rhododendron hirsutum sempre molto ben rappresentati, al pari di Juniperus sibirica.<br />
Il geosigmeto Luzulo nemorosae-Piceetum e Luzulo nemorosae-Fagetum è diffuso in modo esclusivo nella fascia montana delle aree con substrati<br />
silicatici e i suoli sono, in generale, abbastanza evoluti, profondi, con drenaggio buono. Entrambe le serie dominanti (quella del faggio, meno<br />
estesa, certamente anche per motivi antropici) sono caratterizzate da una struttura arborea abbastanza densa. Le peccete sono governate a fustaia<br />
mente le faggete, di norma, a ceduo. Raramente le faggete sono pure e presentano invece una copertura significativa di abete rosso ed anche di<br />
abete bianco. Lo strato arbustivo è in genere scarso, frutto della rinnovazione delle stesse specie guida arboree o da Corylus avellana, più frequente<br />
in aree soggette a interventi ripetuti. Raramente mancano Sorbus aucuparia e specie del genere Lonicera, soprattutto Lonicera nigra. Lo strato<br />
erbaceo è in generale povero di specie.<br />
180
Tabella 175 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 1033 di Badia (BZ)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 20 - Serie delle peccete montane e altimontane dell’Abieti-Piceion 5 16124,80 15,12<br />
2 13 - Serie delle mughete basifile dei piani orotemperato e criorotemperato dell’alleanza Erico-Pinion<br />
mugo (Erico carneae-Pinetum mugo, Mugo-Rhododendretum)<br />
12 15881,15 14,90<br />
3 15 - Geosigmeto della pecceta subalpina e del rododendreto a Rhododendron ferrugineum su substrati a<br />
reazione acida<br />
9 15874,91 14,89<br />
4 7 - Geosigmeto della vegetazione delle praterie alpine e vegetazione pioniera ipsofila su substrati a<br />
reazione alcalina (Seslerion albicantis s.l.)<br />
13 15863,74 14,88<br />
5 11 - a: Geosigmeto delle peccete e degli arbusteti subalpini dei substrati silicatici: boschi di conifere<br />
altimontani e subalpini, delle mughete e del rododendreto a Rhododendron ferrugineum (Calamagrostio<br />
villosae-Abietetum, Homogyno-Piceetum, Rhododendro ferruginei-Pinetum prostatae, Rhododendretum<br />
ferruginei)<br />
4 9259,97 8,69<br />
6 11 - b: Geosigmeto delle peccete e degli arbusteti subalpini dei substrati silicatici: rodoreti e junipereti<br />
(serie del Vaccinio-Rhododendretum ferruginei e serie edafo-xerofila del Festucetum scabriculmis)<br />
10 7489,29 7,02<br />
7 5 - Geosigmeto delle praterie alpine e della vegetazione pioniera ipsofila su substrati a reazione alcalina<br />
(serie dominante di Ranunculo hybridi-Caricetum sempervirentis)<br />
12 7285,53 6,83<br />
8 9 - Geosigmeto del larici-cembreto e della mugheta microterma su substrati a reazione alcalina (Serie di<br />
Calamagrostio villosae-Picetum cembrae e di Rhododendro hirsuti-Pinetum prostratae)<br />
14 4113,98 3,86<br />
9 3 - Geosigmeto della vegetazione di prateria alpina e pioniera ipsofila su substrati a reazione acida<br />
(Caricion curvulae)<br />
10 3120,56 2,93<br />
10 14 - Serie dei boschi ad abete bianco e rosso del Vaccinio-Abietenion (Calamagrostio villosae-<br />
Abietetum albae, Vaccinio-Abietetum albae)<br />
3 3100,42 2,91<br />
11 21 - Serie acidofila altomontana delle abetine ad abete bianco dei piani supratemperato e orotemperato<br />
(Pyrolo rotundifoliae-Abietetum albae, Luzulo niveae-Abietetum albae)<br />
6 2996,66 2,81<br />
12 16 - Geosigmeto della pecceta subalpina (altimontana) e della mugheta microterma su substrati a<br />
reazione alcalina (Adenostylo glabrae-Piceetum, Rhododendro hirsuti-Pinetum prostratae)<br />
11 2146,41 2,01<br />
13 4 b: Geosigmeto delle praterie alpine e della vegetazione pioniera ipsofila su substrati a reazione acida:<br />
serie dominanti di Sieversio-Nardetum strictae e Gentianello anisodontae-Festucetum variae<br />
12 1397,82 1,31<br />
14 41 a: Serie endalpica delle pinete a pino silvestre: Erico-Pinion sylvestris 1 1323,11 1,24<br />
15 25 Geosigmeto della faggeta e dei piceo-faggeti montani su substrati a reazione alcalina (serie<br />
dominante di Anemono trifoliae-Fagetum e di Dentario-pentaphylli-Fagetum)<br />
1 359,72 0,34<br />
16 1 - Geosigmeto meso-endalpico dei substrati intrusivi e metamorfici dell'orizzonte altoalpino- subnivale:<br />
vegetazione dei ghiaioni e delle rocce (Sieversio-Oxyrietum, Androsacetum alpinae, Androsacion<br />
vandelli, Saxifrago-Poetum alpinae, Luzuletum alpino-pilosae)<br />
2 149,36 0,14<br />
181
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
17 24 - Serie degli abieteti montani (Abieti-faggeti e Piceo-abieteti) su substrati a reazione alcalina<br />
(Adenostylo glabrae-Abietetum)<br />
2 52,85 0,05<br />
18 42 Serie acidofila del pino silvestre di Dicrano-Pinion sylvestris (Vaccinio vitis-idaea-Pinetum<br />
sylvestris)<br />
1 21,15 0,02<br />
19 23 Geosigmeto delle peccete e delle faggete montane su substrati a reazione acida (serie di Luzulo<br />
nemorosae-Piceetum e Luzulo nemorosae-Fagetum)<br />
1 8,44 0,01<br />
area totale cella 1033 106615,73<br />
La serie delle peccete montane e altimontane dell’Abieti-Piceion, localizzata nel piano orotemperato a quote comprese tra i 1500 m circa ai<br />
1800 m su substrati calcarei e dolomitici, copre una superficie di 16124,8 ettari. Si tratta di peccete basifile su substrati basici caratterizzate<br />
dalla presenza nello strato arboreo dominante di Picea abies e Larix decidua, nello strato arboreo dominato di Sorbus aucuparia, nello strato<br />
arbustivo di Vaccinium myrtillus, Daphne mezereum, Lonicera alpigena, Rosa pendulina, Polygala chamaebuxus e nello strato erbaceo<br />
Adenostyles glabra, melampyrum sylvaticum, Solidago virgaurea, Valeriana tripteris, Viola biflora, carex digitata, Clematis alpina. Gli stadi<br />
di degradazione portano allo sviluppo di mughete o rododendreti e alla successiva degradazione in seslerio-cariceti.<br />
La serie delle mughete dell’alleanza Erico-Pinion mugo (Erico carneae-Pinetum mugo, Mugo-Rhododendretum) si sviluppa su substrati<br />
carbonatici ad esposizione prevalentemente meridionale. Si tratta di un’associazione di microbosco-arbusteto a dominanza di Pinus mugo la<br />
cui struttura è caratterizzata da un fitto intrico di individui di Pinus mugo che creano un ambiente quasi impenetrabile all’interno del quale si<br />
trovano Salix caprea, S. glabra, Sorbus chamaemespylus. Il sottobosco erbaceo è tipicamente povero. Dove la mugheta si dirada entrano<br />
specie calcicole moderatamente eliofile quali Calamagrostis varia, Sesleria albicans, Erica carnea, Polygala chamaebuxus, Chamaecytisus<br />
hirsutus, C. purpureus, Genista radiata ecc. Le pinete calcicole a pino mugo sono in contatto catenale con le faggete del Cardamino-<br />
Fagetum e con le praterie subalpine del Carici-Seslerietum. Il Mugo-Rhododendretum si sviluppa invece in stazioni più tipicamente igrofile<br />
caratterizzate da un denso strato muscinale costituito soprattutto da Rhytidiadelphus triquetrus, Hylocomium splendens, Pleurozium<br />
schreberi. Nello strato arbustivo si evidenziano Rhododendron hirsutum, R. intermedium, Arctostaphylos alpina e Sorbus chamaemespilus.<br />
Nella cella 1031 di San Pancrazio (BZ) la serie altomontana delle abetine ad abete bianco copre il 16,5% della cella. Pyrolo rotundifoliae-<br />
Abietetum albae., abetine ad Abies alba con Picea abies, ricca di specie della classe Erico-Pinetea, si trovano tra i 1050 e i 1400 m su pendenze<br />
modeste e rocciosità ridotta, mentre Luzulo niveae-Abietetum albae., abetine ad Abies alba con Picea abies .in cui tra le erbacee dominano Luzula<br />
nivea, Calamagrostis arundinacea, Oxalis acetosella, Hieracium sylvaticum. si stabilisce tra i 1200 e i 1450 m, su pendenze e rocciosità più<br />
accentuate. E’ presente un cospicuo strato di muschi a Hylocomium splendens, Dicranum scoparium, Eurhhynchium striatum, Rhitidiadelphus<br />
triquetrus, Plagiochila asplenioides.<br />
La serie del carpino nero e del frassino maggiore (Fraxino orni-Ostryetum carpinifoliae), che si estende per il 15,2%, è localizzata a ridosso<br />
dei fondovalle al di sotto dei 1000 m su substrati del piano supratemperato. La tappa matura è rappresentata da orno-ostrieti in cui la struttura del<br />
bosco è tipicamente costituita da alte percentuali di specie arbustive ed erbacee in quanto solo raramente i consorzi del Fraxino-Ostryetum riescono<br />
a raggiungere gradi di sviluppo soddisfacenti. Le specie arbustive più frequenti sono Erica carnea, Cotinus coggygria, Amelanchier ovalis,<br />
182
Juniperus communis, tra le specie erbacee Carex alba, Brachypodium pinnatum, Cyclamen purpurascens e nelle situazioni più pioniere Carex<br />
humilis e Sesleria albicans.<br />
Tabella 176 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 1031 di San Pancrazio (BZ)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 21 - Serie acidofila altomontana delle abetine ad abete bianco dei piani supratemperato e<br />
orotemperato (Pyrolo rotundifoliae-Abietetum albae, Luzulo niveae-Abietetum albae)<br />
8 17541,46 16,46<br />
2 44 - b: Serie del carpino nero e del frassino maggiore del piano supratemperato (Fraxino orni-<br />
Ostryetum carpinifoliae)<br />
5 16148,85 15,16<br />
3 3 - Geosigmeto della vegetazione di prateria alpina e pioniera ipsofila su substrati a reazione acida<br />
(Caricion curvulae)<br />
6 14791,42 13,88<br />
4 25 - Geosigmeto della faggeta e dei piceo-faggeti montani su substrati a reazione alcalina (serie<br />
dominante di Anemono trifoliae-Fagetum e di Dentario-pentaphylli-Fagetum)<br />
1 13352,01 12,53<br />
5 11 - a: Geosigmeto delle peccete e degli arbusteti subalpini dei substrati silicatici: boschi di conifere<br />
altimontani e subalpini, delle mughete e del rododendreto a Rhododendron ferrugineum (Calamagrostio<br />
villosae-Abietetum, Homogyno-Piceetum, Rhododendro ferruginei-Pinetum prostatae, Rhododendretum<br />
ferruginei)<br />
15 12340,25 11,58<br />
6 11 - b: Geosigmeto delle peccete e degli arbusteti subalpini dei substrati silicatici: rodoreti e<br />
junipereti (serie del Vaccinio-Rhododendretum ferruginei e serie edafo-xerofila del Festucetum<br />
scabriculmis)<br />
11 12178,26 11,43<br />
7 14 - Serie dei boschi ad abete bianco e rosso del Vaccinio-Abietenion (Calamagrostio villosae-<br />
Abietetum albae, Vaccinio-Abietetum albae)<br />
9 5948,68 5,58<br />
8 83 - a: Geosigmeto perialveale montano endalpico 1 4105,46 3,85<br />
9 34 - Mosaico delle faggete submontane da subacidofile a mesiche (Luzulo-Fagion, Aremonio-<br />
Fagion) su substrati silicatici prevalenti più o meno ricchi in carbonati<br />
3 3572,51 3,35<br />
10 74 - Serie acidofila dei boschi di rovere del piano supratemperato (Luzulo niveae-Quercetum<br />
petraeae)<br />
1 2251,55 2,11<br />
11 42 - Serie acidofila del pino silvestre di Dicrano-Pinion sylvestris (Vaccinio vitis-idaea-Pinetum<br />
sylvestris)<br />
1 2018,39 1,89<br />
12 41 - a: Serie endalpica delle pinete a pino silvestre: Erico-Pinion sylvestris 2 1546,55 1,45<br />
13 78 - Serie dei boschi a carpino bianco e serie del frassino maggiore del piano supratemperato (Galio<br />
laevigati-Carpinetum betuli, Salvio glutinosae-Fraxinetum excelsioris)<br />
2 757,26 0,71<br />
area totale cella 1031 106552,64<br />
183
Gli stadi sostitutivi della serie sono rappresentati da: mantello del Cotino-Amelanchieretum ovalis, mantello del Prunetum mahaleb, praterie<br />
dell’Euphrasio-Seslerietum, vegetazione pioniera xerofila dello Stipetum calamagrostis, vegetazione pioniera delle pareti rocciose dell’Asplenietum<br />
trichomano-rutae murariae.<br />
Tabella 177 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 1030 di Stelvio (BZ)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 3 - Geosigmeto della vegetazione di prateria alpina e pioniera ipsofila su substrati a reazione acida<br />
(Caricion curvulae)<br />
11 37003,58 34,74<br />
2 11 - b: Geosigmeto delle peccete e degli arbusteti subalpini dei substrati silicatici: rodoreti e<br />
junipereti (serie del Vaccinio-Rhododendretum ferruginei e serie edafo-xerofila del Festucetum<br />
scabriculmis)<br />
20 14677,77 13,78<br />
3 1 - Geosigmeto meso-endalpico dei substrati intrusivi e metamorfici dell'orizzonte altoalpinosubnivale:<br />
vegetazione dei ghiaioni e delle rocce (Sieversio-Oxyrietum, Androsacetum alpinae,<br />
Androsacion vandelli, Saxifrago-Poetum alpinae, Luzuletum alpino-pilosae)<br />
9 11770,22 11,05<br />
4 34 - Mosaico delle faggete submontane da subacidofile a mesiche (Luzulo-Fagion, Aremonio-<br />
Fagion) su substrati silicatici prevalenti più o meno ricchi in carbonati<br />
1 11532,04 10,83<br />
5 11 - a: Geosigmeto delle peccete e degli arbusteti subalpini dei substrati silicatici: boschi di conifere<br />
altimontani e subalpini, delle mughete e del rododendreto a Rhododendron ferrugineum<br />
(Calamagrostio villosae-Abietetum, Homogyno-Piceetum, Rhododendro ferruginei-Pinetum<br />
prostatae, Rhododendretum ferruginei)<br />
13 8253,48 7,75<br />
6 44 - b: Serie del carpino nero e del frassino maggiore del piano supratemperato (Fraxino orni-<br />
Ostryetum carpinifoliae)<br />
2 3087,33 2,90<br />
7 7 - Geosigmeto della vegetazione delle praterie alpine e vegetazione pioniera ipsofila su substrati a<br />
reazione alcalina (Seslerion albicantis s.l.)<br />
1 3054,63 2,87<br />
8 21- Serie acidofila altomontana delle abetine ad abete bianco dei piani supratemperato e<br />
orotemperato (Pyrolo rotundifoliae-Abietetum albae, Luzulo niveae-Abietetum albae)<br />
4 3012,88 2,83<br />
9 14 - Serie dei boschi ad abete bianco e rosso del Vaccinio-Abietenion (Calamagrostio villosae-<br />
Abietetum albae, Vaccinio-Abietetum albae)<br />
4 3006,36 2,82<br />
10 6 - Geosigmeto delle praterie alpine e della vegetazione pioniera ipsofila su substrati a reazione<br />
alcalina (serie dominante di Seslerio-Caricetum sempervirentis)<br />
3 2513,44 2,36<br />
11 15 - a: Geosigmeto della pecceta subalpina e del rododendreto a Rhododendron ferrugineum su<br />
substrati a reazione acida: serie dominanti di Homogyno-Piceetum e di Rhododendretum ferruginei<br />
1 2057,12 1,93<br />
12 13 - Serie delle mughete basifile dei piani orotemperato e criorotemperato dell’alleanza Erico-<br />
Pinion mugo (Erico carneae-Pinetum mugo, Mugo-Rhododendretum)<br />
2 700,68 0,66<br />
184
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
13 41 - b: Serie endalpica delle pinete a pino silvestre: Erico-Pinetum sylvestris 1 418,59 0,39<br />
14 83 - a: Geosigmeto perialveale montano endalpico 1 228,19 0,21<br />
area totale cella 1030 106529,12<br />
Le serie e i geosigmeti più estesi nella cella 1030 di Stelvio (BZ) sono già stati descritti nelle celle precedenti.<br />
Tabella 178 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 1005 di Tramonti di Sopra (PN)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 33 - b: Geosigmeto delle faggete (Aremonio-Fagion), degli ostrieti primitivi e delle pinete (Erico-<br />
Fraxinion orni) su substrati dolomitici prevalenti<br />
3 41772,69 38,94<br />
2 55 - b: Mosaico potenziale di ostrio-querceti (Carpinion orientalis) e querco-carpineti (Erythronio-<br />
Carpinion) dei substrati fluvio-glaciali dell'alta pianura<br />
2 16969,50 15,82<br />
3 33 - a: Geosigmeto delle faggete submontane-altimontane su substrati a reazione alcalina<br />
(Aremonio-Fagion)<br />
3 13728,42 12,80<br />
4 17 - Serie della faggeta subalpina su substrati a reazione alcalina (Saxifrago rotundifoliae-Fagetum<br />
sylvaticae)<br />
12 7698,27 7,18<br />
5 57 - a: Geosigmeto degli ostrio-querceti su substrati a reazione alcalina (serie dominante di<br />
Buglossoido-Ostryetum)<br />
4 6660,49 6,21<br />
6 16 - Geosigmeto della pecceta subalpina (altimontana) e della mugheta microterma su substrati a<br />
reazione alcalina (Adenostylo glabrae-Piceetum, Rhododendro hirsuti-Pinetum prostratae)<br />
4 6562,86 6,12<br />
7 52 - Geosigmeto dei boschi a prevalenza di rovere e/o di rovere e carpino bianco su substrati<br />
silicatici prevalenti (Erythronio-Carpinion)<br />
3 4934,96 4,60<br />
8 5 - Geosigmeto delle praterie alpine e della vegetazione pioniera ipsofila su substrati a reazione<br />
alcalina (serie dominante di Ranunculo hybridi-Caricetum sempervirentis)<br />
11 3315,06 3,09<br />
9 84 - a: Geosigmeto perialveale planiziale: geosigmeto dell'alta pianura 3 2151,15 2,01<br />
10 26 - Geosigmeto delle peccete montane (Abieti-Piceion) su substrati carbonatici 11 1398,59 1,30<br />
11 34 - Mosaico delle faggete submontane da subacidofile a mesiche (Luzulo-Fagion, Aremonio-<br />
Fagion) su substrati silicatici prevalenti più o meno ricchi in carbonati<br />
1 1327,37 1,24<br />
12 83 - b: Geosigmeto perialveale montano meso-esalpico 7 761,75 0,71<br />
13 83 - a: Geosigmeto perialveale montano endalpico 1 3,62 0,00<br />
area totale cella 1005 107284,71<br />
185
L’unica serie cartografata all’interno della cella 1005 di Tramonti di Sopra (PN) è quella della faggeta subalpina (Saxifrago rotundifoliae-<br />
Fagetum sylvaticae), localizzata nella fascia prealpina a quote comprese tra i 1400 ed i 1800 m. Molto più rara in Veneto che in Friuli, è<br />
caratterizzata da uno stato arboreo faggio-dominante, con presenza di Rhododendron ferrugineum, Rhododendron hirsutum, Sorbus aucuparia,<br />
Lonicera alpigena, Rosa pendulina, Daphne mezereum, Rubus idaeus e Rubus saxatilis nello strato arbustivo. In quello erbaceo si trovano<br />
Saxifraga rotundifolia, Polystichum lonchitis, Luzula sylvatica subsp. sylvatica, Homogyne alpina, Valeriana tripteris, Vaccinium myrtillus, Oxalis<br />
acetosella e il raro Streptopus amplexifolius. La faggeta subalpina presenta contatti seriali con Crepido aureae-Poetum alpinae, in stazioni<br />
pianeggianti su terreni freschi o con lieve inclinazione su morfotipi modellati dal glacialismo, o con Carici ornithopodae-Seslerietum albicantis in<br />
stazioni più acclivi.<br />
186
Tabella 179 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 1004 di Longarone (BL)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 16 - Geosigmeto della pecceta subalpina (altimontana) e della mugheta microterma su substrati a<br />
reazione alcalina (Adenostylo glabrae-Piceetum, Rhododendro hirsuti-Pinetum prostratae)<br />
17 17167,84 16,01<br />
2 50 - Geosigmeto dei carpineti e querco-carpineti delle vallate prealpine interne (Erytronio-<br />
Carpinion)<br />
6 15744,24 14,68<br />
3 25 - Geosigmeto della faggeta e dei piceo-faggeti montani su substrati a reazione alcalina (serie<br />
dominante di Anemono trifoliae-Fagetum e di Dentario-pentaphylli-Fagetum)<br />
8 14265,50 13,30<br />
4 33 - b: Geosigmeto delle faggete (Aremonio-Fagion), degli ostrieti primitivi e delle pinete (Erico-<br />
Fraxinion orni) su substrati dolomitici prevalenti<br />
4 10232,98 9,54<br />
5 33 - a: Geosigmeto delle faggete submontane-altimontane su substrati a reazione alcalina<br />
(Aremonio-Fagion)<br />
9 9506,64 8,86<br />
6 83 - a: Geosigmeto perialveale montano endalpico 1 7036,17 6,56<br />
7 43 - Serie delle pinete oromediterranee a Pinus sylvestris e Pinus nigra (Fraxino orni-Pinetum<br />
nigrae)<br />
10 5668,93 5,29<br />
8 17 - Serie della faggeta subalpina su substrati a reazione alcalina (Saxifrago rotundifoliae-Fagetum<br />
sylvaticae)<br />
8 5513,93 5,14<br />
9 23 - Geosigmeto delle peccete e delle faggete montane su substrati a reazione acida (serie di Luzulo<br />
nemorosae-Piceetum e Luzulo nemorosae-Fagetum)<br />
9 5077,02 4,73<br />
10 24 - Serie degli abieteti montani (Abieti-faggeti e Piceo-abieteti) su substrati a reazione alcalina<br />
(Adenostylo glabrae-Abietetum)<br />
16 5016,61 4,68<br />
11 57 - a: Geosigmeto degli ostrio-querceti su substrati a reazione alcalina (serie dominante di<br />
Buglossoido-Ostryetum)<br />
5 3443,01 3,21<br />
12 5 - Geosigmeto delle praterie alpine e della vegetazione pioniera ipsofila su substrati a reazione<br />
alcalina (serie dominante di Ranunculo hybridi-Caricetum sempervirentis)<br />
19 2919,26 2,72<br />
13 15 - Geosigmeto della pecceta subalpina e del rododendreto a Rhododendron ferrugineum su<br />
substrati a reazione acida<br />
8 2448,15 2,28<br />
14 26 - Geosigmeto delle peccete montane (Abieti-Piceion) su substrati carbonatici 5 2176,11 2,03<br />
15 83 - b: Geosigmeto perialveale montano meso-esalpico 5 432,87 0,40<br />
area totale cella 1004 107238,78<br />
Il geosigmeto della pecceta subalpina e della mugheta microterma (Adenostylo glabrae-Piceetum, Rhododendro hirsuti-Pinetum prostratae), già<br />
stato descritto per la cella 1034 di Auronzo di Cadore (BL), si estende per 17.167,8 ettari della cella 1004.<br />
187
Per quanto concerne il geosigmeto dei carpineti e querco-carpineti delle vallate prealpine interne (Erytronio-Carpinion), Quercus robur e<br />
Carpinus betulus caratterizzano i lembi di bosco di fondovalle, fatta eccezione per le aree più disturbate e invase dalla robinia. C. betulus è<br />
particolarmente vitale e colonizza anche prati permanenti abbandonati, sia pingue (Arrhenatherion) che magro a dominanza di Bromus erectus<br />
(Hypochoeridenionmaculatae). L’associazione prevalente è Ornithogalo pyrenaici-Carpinetum betuli, nelle sue diverse subassociazioni; rispetto al<br />
tipo centrale (caricetosum pilosae), sono presenti varianti umide, diffuse negli impluvi delle valli affluenti, con farnia e Fraxinus excelsior,<br />
prossime a Hacquetio-Fraxinetum, e la subassociazione ostryetosum, più xerica, che occupa estesi versanti a sud. Sono cedui che talvolta<br />
invecchiano dimostrando un’elevata potenzialità e grandi quantità di plantule di latifoglie in rinnovazione. In questa serie, in realtà molto articolata<br />
e difficilmente cartografabile, sono incluse situazioni in cui il castagno è prevalente, soprattutto in corrispondenza di affioramenti marnosoarenacei.<br />
I carpineti e i querco-carpineti sono comunità forestali ricche di specie arboree ed arbustive come Prunus avium, Rosa arvensis, Tamus<br />
communis. Nello strato erbaceo, pure ricco, sono numerose le geofite a fioritura primaverile quali Erythronium dens-canis, Galanthus nivalis,<br />
Leucojum vernum, Gagea lutea, Ranunculus ficaria, Anemone nemorosa.<br />
<strong>Del</strong>le serie dominanti riferibili al geosigmeto della faggeta e dei Piceo-faggeti montani, che copre il 13,3% della cella e interessa una fascia<br />
montana e altimontana da 1000 a 1600 metri, Anemono trifoliae-Fagetum risulta legato soprattutto ai substrati dolomitici e prevale su versanti<br />
acclivi e suoli poco evoluti, mentre in stazioni topograficamente favorevoli con suoli più profondi comunque ricchi di scheletro è più competitivo<br />
Dentario-Fagetum. I Piceo-faggeti, unitamente agli abieteti e rispetto ad essi meno esigenti a livello edifico, sono l’espressione forestale<br />
caratteristica del paesaggio dolomitico. La struttura è spesso bistratificata con l’abete rosso e il larice che superano il faggio. Localmente anche il<br />
faggio raggiunge le stesse altezze e le conifere hanno una minore incidenza nello strato arboreo. Di qui l’opportunità di raggruppare nello stesso<br />
geosigmeto anche lembi di faggeta (Dentario-Fagetum) in quanto l’articolazione orografica delle valli determina condizioni microclimatiche che<br />
non consentono la separazione. Tra le altre entità arboree si segnalano soprattutto nello strato dominato Sorbus aria, S. aucuparia, Laburnum<br />
alpinum e Acer pseudoplatanus. Tra gli arbusti sono prevalenti Corylus avellana, Daphne mezereum, Lonicera alpigena, L. xylosteum, Rubus<br />
saxatilis. A livello erbaceo, le stazioni di Anemono-Fagetum sono caratterizzate dal normale e ricco corredo delle faggete, ma anche da specie<br />
indicatrici di suolo più acidificato in superficie (Maianthemum bifolium, Huperzia selago, Vaccinium myrtillus, Prenanthes purpurea, Orthilia<br />
secunda) e di ruscellamento superficiale (Calamagrostis varia, Valeriana tripteris, Adenostyles glabra). Nei tratti in cui prevale Dentario<br />
pentaphylli-Fagetum sono più numerose le felci (Dryopteris filixmas, Athyrium filix -foemina, Dryopteris dilatata, Polystichum aculeatum,<br />
Gymnocarpium dryopteris,Thelypteris phegopteris, ecc.). In questo geosigmeto sono incluse anche buona parte delle faggete azonali in cui sono<br />
frequenti Pinus mugo, Salix glabra e, soprattutto, Rhododendron hirsutum.<br />
188
Tabella 180 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 1003 di Siror (TN)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 25 - Geosigmeto della faggeta e dei piceo-faggeti montani su substrati a reazione alcalina (serie<br />
dominante di Anemono trifoliae-Fagetum e di Dentario-pentaphylli-Fagetum)<br />
11 19684,92 18,36<br />
2 16 - Geosigmeto della pecceta subalpina (altimontana) e della mugheta microterma su substrati a<br />
reazione alcalina (Adenostylo glabrae-Piceetum, Rhododendro hirsuti-Pinetum prostratae)<br />
13 13790,34 12,86<br />
3 11 - b: Geosigmeto delle peccete e degli arbusteti subalpini dei substrati silicatici: rodoreti e<br />
junipereti (serie del Vaccinio-Rhododendretum ferruginei e serie edafo-xerofila del Festucetum<br />
scabriculmis)<br />
6 8556,48 7,98<br />
4 11 - a: Geosigmeto delle peccete e degli arbusteti subalpini dei substrati silicatici: boschi di conifere<br />
altimontani e subalpini, delle mughete e del rododendreto a Rhododendron ferrugineum<br />
(Calamagrostio villosae-Abietetum, Homogyno-Piceetum, Rhododendro ferruginei-Pinetum prostatae,<br />
Rhododendretum ferruginei)<br />
6 7766,69 7,25<br />
5 15 - Geosigmeto della pecceta subalpina e del rododendreto a Rhododendron ferrugineum su<br />
substrati a reazione acida<br />
23 5726,81 5,34<br />
6 23 - Geosigmeto delle peccete e delle faggete montane su substrati a reazione acida (serie di<br />
Luzulo nemorosae-Piceetum e Luzulo nemorosae-Fagetum)<br />
12 5672,92 5,29<br />
7 14 - Serie dei boschi ad abete bianco e rosso del Vaccinio-Abietenion (Calamagrostio villosae-<br />
Abietetum albae, Vaccinio-Abietetum albae)<br />
3 4805,95 4,48<br />
8 24 - Serie degli abieteti montani (Abieti-faggeti e Piceo-abieteti) su substrati a reazione alcalina<br />
(Adenostylo glabrae-Abietetum)<br />
8 4741,02 4,42<br />
9 5 - Geosigmeto delle praterie alpine e della vegetazione pioniera ipsofila su substrati a reazione<br />
alcalina (serie dominante di Ranunculo hybridi-Caricetum sempervirentis)<br />
12 4594,52 4,29<br />
10 3 - Geosigmeto della vegetazione di prateria alpina e pioniera ipsofila su substrati a reazione acida<br />
(Caricion curvulae)<br />
8 4554,35 4,25<br />
11 13 - Serie delle mughete basifile dei piani orotemperato e criorotemperato dell’alleanza Erico-<br />
Pinion mugo (Erico carneae-Pinetum mugo, Mugo-Rhododendretum)<br />
7 4189,22 3,91<br />
12 33 - a: Geosigmeto delle faggete submontane-altimontane su substrati a reazione alcalina<br />
(Aremonio-Fagion)<br />
1 4082,66 3,81<br />
13 23 - c: Geosigmeto delle peccete e delle faggete montane su substrati a reazione acida (serie di<br />
Luzulo nemorosae-Piceetum e Luzulo nemorosae-Fagetum): serie dominante di Luzulo-Fagion<br />
1 3798,59 3,54<br />
14 57 - a: Geosigmeto degli ostrio-querceti su substrati a reazione alcalina (serie dominante di<br />
Buglossoido-Ostryetum)<br />
3 3405,43 3,18<br />
189
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
15 50 - Geosigmeto dei carpineti e querco-carpineti delle vallate prealpine interne (Erytronio-<br />
Carpinion)<br />
3 2667,25 2,49<br />
16 7 - Geosigmeto della vegetazione delle praterie alpine e vegetazione pioniera ipsofila su substrati a<br />
reazione alcalina (Seslerion albicantis s.l.)<br />
8 2655,96 2,48<br />
17 78 - Serie dei boschi a carpino bianco e serie del frassino maggiore del piano supratemperato<br />
(Galio laevigati-Carpinetum betuli, Salvio glutinosae-Fraxinetum excelsioris)<br />
1 2230,31 2,08<br />
18 4 - b: Geosigmeto delle praterie alpine e della vegetazione pioniera ipsofila su substrati a reazione<br />
acida: serie dominanti di Sieversio-Nardetum strictae e Gentianello anisodontae-Festucetum<br />
variae<br />
8 1100,56 1,03<br />
19 20 - Serie delle peccete montane e altimontane dell’Abieti-Piceion 4 1076,73 1,00<br />
20 74 - Serie acidofila dei boschi di rovere del piano supratemperato (Luzulo niveae-Quercetum<br />
petraeae)<br />
1 845,08 0,79<br />
21 9 - Geosigmeto del larici-cembreto e della mugheta microterma su substrati a reazione alcalina<br />
(Serie di Calamagrostio villosae-Picetum cembrae e di Rhododendro hirsuti-Pinetum prostratae)<br />
3 654,93 0,61<br />
22 43 - Serie delle pinete oromediterranee a Pinus sylvestris e Pinus nigra (Fraxino orni-Pinetum<br />
nigrae)<br />
6 486,47 0,45<br />
23 21 - Serie acidofila altomontana delle abetine ad abete bianco dei piani supratemperato e<br />
orotemperato (Pyrolo rotundifoliae-Abietetum albae, Luzulo niveae-Abietetum albae)<br />
2 50,64 0,05<br />
area totale cella 1003 107198,79<br />
190
Tabella 181 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 1002 di Castello-Molina di Fiemme (TN)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 14 - Serie dei boschi ad abete bianco e rosso del Vaccinio-Abietenion (Calamagrostio villosae-<br />
Abietetum albae, Vaccinio-Abietetum albae)<br />
11 21672,56 20,22<br />
2 11 - a: Geosigmeto delle peccete e degli arbusteti subalpini dei substrati silicatici: boschi di conifere<br />
altimontani e subalpini, delle mughete e del rododendreto a Rhododendron ferrugineum<br />
(Calamagrostio villosae-Abietetum, Homogyno-Piceetum, Rhododendro ferruginei-Pinetum prostatae,<br />
Rhododendretum ferruginei)<br />
14 21232,06 19,81<br />
3 11 - b: Geosigmeto delle peccete e degli arbusteti subalpini dei substrati silicatici: rodoreti e<br />
junipereti (serie del Vaccinio-Rhododendretum ferruginei e serie edafo-xerofila del Festucetum<br />
scabriculmis)<br />
6 18083,51 16,87<br />
4 21 - Serie acidofila altomontana delle abetine ad abete bianco dei piani supratemperato e<br />
orotemperato (Pyrolo rotundifoliae-Abietetum albae, Luzulo niveae-Abietetum albae)<br />
5 13180,50 12,30<br />
5 23 - c: Geosigmeto delle peccete e delle faggete montane su substrati a reazione acida (serie di<br />
Luzulo nemorosae-Piceetum e Luzulo nemorosae-Fagetum): serie dominante di Luzulo-Fagion<br />
7 9223,20 8,61<br />
6 74 - Serie acidofila dei boschi di rovere del piano supratemperato (Luzulo niveae-Quercetum<br />
petraeae)<br />
4 5533,39 5,16<br />
7 3 - Geosigmeto della vegetazione di prateria alpina e pioniera ipsofila su substrati a reazione acida<br />
(Caricion curvulae)<br />
13 4782,38 4,46<br />
8 44 - b: Serie del carpino nero e del frassino maggiore del piano supratemperato (Fraxino orni-<br />
Ostryetum carpinifoliae)<br />
2 3912,17 3,65<br />
9 13 - Serie delle mughete basifile dei piani orotemperato e criorotemperato dell’alleanza Erico-<br />
Pinion mugo (Erico carneae-Pinetum mugo, Mugo-Rhododendretum)<br />
3 3050,36 2,85<br />
10 20 - Serie delle peccete montane e altimontane dell’Abieti-Piceion 2 1536,15 1,43<br />
11 83 - a: Geosigmeto perialveale montano endalpico 1 1503,69 1,40<br />
12 7 - Geosigmeto della vegetazione delle praterie alpine e vegetazione pioniera ipsofila su substrati a<br />
reazione alcalina (Seslerion albicantis s.l.)<br />
3 1378,34 1,29<br />
13 25 - Geosigmeto della faggeta e dei piceo-faggeti montani su substrati a reazione alcalina (serie<br />
dominante di Anemono trifoliae-Fagetum e di Dentario-pentaphylli-Fagetum)<br />
4 1249,42 1,17<br />
14 41 - a: Serie endalpica delle pinete a pino silvestre: Erico-Pinion sylvestris 1 826,03 0,77<br />
area totale cella 1002 107163,76<br />
Le serie e/o geosigmeti più estesi delle celle 1002, 1001 e 1000sono stati descritti per unità di campionamento precedenti e per questo non<br />
vengono nuovamente analizzati.<br />
191
Tabella 182 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 1001 di Campodenno (TN)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 25 - Geosigmeto della faggeta e dei piceo-faggeti montani su substrati a reazione alcalina (serie<br />
dominante di Anemono trifoliae-Fagetum e di Dentario-pentaphylli-Fagetum)<br />
8 33923,78 31,66<br />
2 44 - b: Serie del carpino nero e del frassino maggiore del piano supratemperato (Fraxino orni-<br />
Ostryetum carpinifoliae)<br />
5 19216,14 17,94<br />
3 13 - Serie delle mughete basifile dei piani orotemperato e criorotemperato dell’alleanza Erico-<br />
Pinion mugo (Erico carneae-Pinetum mugo, Mugo-Rhododendretum)<br />
4 9326,60 8,71<br />
4 78 - Serie dei boschi a carpino bianco e serie del frassino maggiore del piano supratemperato<br />
(Galio laevigati-Carpinetum betuli, Salvio glutinosae-Fraxinetum excelsioris)<br />
5 9149,68 8,54<br />
5 7 - Geosigmeto della vegetazione delle praterie alpine e vegetazione pioniera ipsofila su substrati<br />
a reazione alcalina (Seslerion albicantis s.l.)<br />
2 6929,56 6,47<br />
6 74 - Serie acidofila dei boschi di rovere del piano supratemperato (Luzulo niveae-Quercetum<br />
petraeae)<br />
3 6571,04 6,13<br />
7 83 - a: Geosigmeto perialveale montano endalpico 1 6138,39 5,73<br />
8 21 - Serie acidofila altomontana delle abetine ad abete bianco dei piani supratemperato e<br />
orotemperato (Pyrolo rotundifoliae-Abietetum albae, Luzulo niveae-Abietetum albae)<br />
4 4413,42 4,12<br />
9 20 - Serie delle peccete montane e altimontane dell’Abieti-Piceion 4 3563,04 3,33<br />
10 23 - c: Geosigmeto delle peccete e delle faggete montane su substrati a reazione acida (serie di<br />
Luzulo nemorosae-Piceetum e Luzulo nemorosae-Fagetum): serie dominante di Luzulo-Fagion<br />
2 2951,03 2,75<br />
11 11 - a: Geosigmeto delle peccete e degli arbusteti subalpini dei substrati silicatici: boschi di conifere<br />
altimontani e subalpini, delle mughete e del rododendreto a Rhododendron ferrugineum<br />
(Calamagrostio villosae-Abietetum, Homogyno-Piceetum, Rhododendro ferruginei-Pinetum<br />
prostatae, Rhododendretum ferruginei)<br />
4 2311,31 2,16<br />
12 11 - b: Geosigmeto delle peccete e degli arbusteti subalpini dei substrati silicatici: rodoreti e<br />
junipereti (serie del Vaccinio-Rhododendretum ferruginei e serie edafo-xerofila del Festucetum<br />
scabriculmis)<br />
5 1098,50 1,03<br />
13 14 - Serie dei boschi ad abete bianco e rosso del Vaccinio-Abietenion (Calamagrostio villosae-<br />
Abietetum albae, Vaccinio-Abietetum albae)<br />
5 669,84 0,63<br />
14 41 - a: Serie endalpica delle pinete a pino silvestre: Erico-Pinion sylvestris 1 460,82 0,43<br />
15 3 - Geosigmeto della vegetazione di prateria alpina e pioniera ipsofila su substrati a reazione acida<br />
(Caricion curvulae)<br />
3 411,51 0,38<br />
area totale cella 1001 107134,65<br />
192
Tabella 183 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 1000 di Vermiglio (TN)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 3 - Geosigmeto della vegetazione di prateria alpina e pioniera ipsofila su substrati a reazione acida<br />
(Caricion curvulae)<br />
9 40904,32 38,19<br />
2 11 - b: Geosigmeto delle peccete e degli arbusteti subalpini dei substrati silicatici: rodoreti e<br />
junipereti (serie del Vaccinio-Rhododendretum ferruginei e serie edafo-xerofila del Festucetum<br />
scabriculmis)<br />
20 20422,26 19,07<br />
3 1 - Geosigmeto meso-endalpico dei substrati intrusivi e metamorfici dell'orizzonte altoalpinosubnivale:<br />
vegetazione dei ghiaioni e delle rocce (Sieversio-Oxyrietum, Androsacetum alpinae,<br />
Androsacion vandelli, Saxifrago-Poetum alpinae, Luzuletum alpino-pilosae)<br />
8 10341,87 9,66<br />
4 11 - a: Geosigmeto delle peccete e degli arbusteti subalpini dei substrati silicatici: boschi di<br />
conifere altimontani e subalpini, delle mughete e del rododendreto a Rhododendron ferrugineum<br />
(Calamagrostio villosae-Abietetum, Homogyno-Piceetum, Rhododendro ferruginei-Pinetum<br />
prostatae, Rhododendretum ferruginei)<br />
9 8539,82 7,97<br />
5 14 - Serie dei boschi ad abete bianco e rosso del Vaccinio-Abietenion (Calamagrostio villosae-<br />
Abietetum albae, Vaccinio-Abietetum albae)<br />
8 7622,12 7,12<br />
6 15 - a: Geosigmeto della pecceta subalpina e del rododendreto a Rhododendron ferrugineum su<br />
substrati a reazione acida: serie dominanti di Homogyno-Piceetum e di Rhododendretum<br />
ferruginei<br />
6 4102,19 3,83<br />
7 25 - Geosigmeto della faggeta e dei piceo-faggeti montani su substrati a reazione alcalina (serie<br />
dominante di Anemono trifoliae-Fagetum e di Dentario-pentaphylli-Fagetum)<br />
2 3625,35 3,38<br />
8 20 - Serie delle peccete montane e altimontane dell’Abieti-Piceion 3 3341,82 3,12<br />
9 21 - Serie acidofila altomontana delle abetine ad abete bianco dei piani supratemperato e<br />
orotemperato (Pyrolo rotundifoliae-Abietetum albae, Luzulo niveae-Abietetum albae)<br />
3 2288,45 2,14<br />
10 23 - c: Geosigmeto delle peccete e delle faggete montane su substrati a reazione acida (serie di<br />
Luzulo nemorosae-Piceetum e Luzulo nemorosae-Fagetum): serie dominante di Luzulo-Fagion<br />
2 1387,22 1,30<br />
11 78 - Serie dei boschi a carpino bianco e serie del frassino maggiore del piano supratemperato<br />
(Galio laevigati-Carpinetum betuli, Salvio glutinosae-Fraxinetum excelsioris)<br />
1 1340,97 1,25<br />
12 36 - Serie dei boschi misti mesofili del Tilio-Acerion 2 958,03 0,89<br />
13 74 - Serie acidofila dei boschi di rovere del piano supratemperato (Luzulo niveae-Quercetum<br />
petraeae)<br />
2 924,23 0,86<br />
14 6 - Geosigmeto delle praterie alpine e della vegetazione pioniera ipsofila su substrati a reazione<br />
alcalina (serie dominante di Seslerio-Caricetum sempervirentis)<br />
3 649,66 0,61<br />
193
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
15 10 - Geosigmeto endalpico tra serie delle larici-cembrete e la serie edafo-xerofila degli junipereti<br />
(Larici-Pinetum cembrae, Empetro-Vaccinietum, Junipero-Arctostaphyletum)<br />
1 396,31 0,37<br />
16 13 - Serie delle mughete basifile dei piani orotemperato e criorotemperato dell’alleanza Erico-<br />
Pinion mugo (Erico carneae-Pinetum mugo, Mugo-Rhododendretum)<br />
2 260,53 0,24<br />
17 7 - Geosigmeto della vegetazione delle praterie alpine e vegetazione pioniera ipsofila su substrati a<br />
reazione alcalina (Seslerion albicantis s.l.)<br />
1 5,60 0,01<br />
area totale cella 1000 107110,74<br />
194
Tabella 184 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 972 di Asiago (VI)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 33 - a: Geosigmeto delle faggete submontane-altimontane su substrati a reazione alcalina<br />
(Aremonio-Fagion)<br />
10 36619,79 33,99<br />
2 25 - Geosigmeto della faggeta e dei piceo-faggeti montani su substrati a reazione alcalina (serie<br />
dominante di Anemono trifoliae-Fagetum e di Dentario-pentaphylli-Fagetum)<br />
15 18515,35 17,19<br />
3 16 - Geosigmeto della pecceta subalpina (altimontana) e della mugheta microterma su substrati a<br />
reazione alcalina (Adenostylo glabrae-Piceetum, Rhododendro hirsuti-Pinetum prostratae)<br />
6 9140,60 8,48<br />
4 57 - a: Geosigmeto degli ostrio-querceti su substrati a reazione alcalina (serie dominante di<br />
Buglossoido-Ostryetum)<br />
4 6948,40 6,45<br />
5 44 - b: Serie del carpino nero e del frassino maggiore del piano supratemperato (Fraxino orni-<br />
Ostryetum carpinifoliae)<br />
2 5623,21 5,22<br />
6 78 - Serie dei boschi a carpino bianco e serie del frassino maggiore del piano supratemperato<br />
(Galio laevigati-Carpinetum betuli, Salvio glutinosae-Fraxinetum excelsioris)<br />
4 5607,95 5,21<br />
7 23 - c: Geosigmeto delle peccete e delle faggete montane su substrati a reazione acida (serie di<br />
Luzulo nemorosae-Piceetum e Luzulo nemorosae-Fagetum): serie dominante di Luzulo-Fagion<br />
3 4738,15 4,40<br />
8 24 - Serie degli abieteti montani (Abieti-faggeti e Piceo-abieteti) su substrati a reazione alcalina<br />
(Adenostylo glabrae-Abietetum)<br />
22 4298,60 3,99<br />
9 83 - a: Geosigmeto perialveale montano endalpico 2 3737,35 3,47<br />
10 74 - Serie acidofila dei boschi di rovere del piano supratemperato (Luzulo niveae-Quercetum<br />
petraeae)<br />
2 3512,37 3,26<br />
11 14 - Serie dei boschi ad abete bianco e rosso del Vaccinio-Abietenion (Calamagrostio villosae-<br />
Abietetum albae, Vaccinio-Abietetum albae)<br />
3 2665,39 2,47<br />
12 11 - a: Geosigmeto delle peccete e degli arbusteti subalpini dei substrati silicatici: boschi di<br />
conifere altimontani e subalpini, delle mughete e del rododendreto a Rhododendron ferrugineum<br />
(Calamagrostio villosae-Abietetum, Homogyno-Piceetum, Rhododendro ferruginei-Pinetum<br />
prostatae, Rhododendretum ferruginei)<br />
4 2320,30 2,15<br />
13 7 - Geosigmeto della vegetazione delle praterie alpine e vegetazione pioniera ipsofila su substrati a<br />
reazione alcalina (Seslerion albicantis s.l.)<br />
6 1316,57 1,22<br />
14 50 - Geosigmeto dei carpineti e querco-carpineti delle vallate prealpine interne (Erytronio-<br />
Carpinion)<br />
2 1166,61 1,08<br />
15 11 - b: Geosigmeto delle peccete e degli arbusteti subalpini dei substrati silicatici: rodoreti e<br />
junipereti (serie del Vaccinio-Rhododendretum ferruginei e serie edafo-xerofila del Festucetum<br />
scabriculmis)<br />
1 777,37 0,72<br />
195
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
16 13 - Serie delle mughete basifile dei piani orotemperato e criorotemperato dell’alleanza Erico-<br />
Pinion mugo (Erico carneae-Pinetum mugo, Mugo-Rhododendretum)<br />
2 407,63 0,38<br />
17 5 - Geosigmeto delle praterie alpine e della vegetazione pioniera ipsofila su substrati a reazione<br />
alcalina (serie dominante di Ranunculo hybridi-Caricetum sempervirentis)<br />
3 242,56 0,23<br />
18 3 - Geosigmeto della vegetazione di prateria alpina e pioniera ipsofila su substrati a reazione acida<br />
(Caricion curvulae)<br />
3 102,31 0,09<br />
area totale cella 972 107740,51<br />
Il geosigmeto delle faggete submontane-altimontane (Aremonio-Fagion) è una serie molto diffusa in Veneto (Prealpi e Dolomiti meridionali,<br />
dal Baldo fino in Alpago), da circa 600-800 fino a 1400-1500 m, secondo i versanti, su substrati di natura carbonatica. Caratterizza estesi territori<br />
prealpini, in cui il faggio è sempre specie guida ma, al contrario delle altre formazioni da esso dominate, è spesso accompagnato da varie specie<br />
arboree. A livello submontano si segnalano Carpinus betulus, Fraxinus ornus, Acer campestre. Ostrya carpinifolia e Sorbus aria anche a quote<br />
superiori. Nelle forre e in stazioni pingui e fresche, si riscontrano Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Ulmus glabra, Tilia platyphyllos, Taxus<br />
baccata . Anche lo strato arbustivo è ricco e strutturato con specie quali Crataegus monogyna, Crataegus oxyacantha, Corylus avellana, Viburnum<br />
opulus, Sambucus nigra, Hedera helix e la rara Daphne laureola. Piuttosto frequenti sono gli ostrio-faggeti (Ostryo-Fagetum) sui versanti più<br />
difficili e con suoli primitivi, ove raggiungono quote notevoli. La loro separazione da stadi più degradati e ricchi di carpino nero dell’Anemono-<br />
Fagetum non è sempre agevole. Si tratta quasi ovunque di cedui, largamente utilizzati per la produzione di legna da ardere. La serie dominante di<br />
Aremonio-Fagion include anche, e spesso senza soluzione di continuità, le faggete montane e quelle altimontane (Dentario pentaphylli-Fagetum).<br />
Questa serie si osserva oggi quasi esclusivamente in corrispondenza di valli e versanti incisi, perché le stazioni meno acclivi e più favorevoli,<br />
soprattutto nella fascia submontana, hanno subito numerosi interventi antropici, ma la sua potenzialità è assai più estesa.<br />
Alcune faggete derivano da stadi a Corylus avellana a loro volta impostatisi su prati falciati, pingui e concimati (Centaureo-Arrhentheretum o<br />
Centaureo-Trisetetum) oppure magri, a Bromus erectus (Mesobromion s.l.), alle quote inferiori o di Caricion austroalpinae più in alto.<br />
L’interruzione della ceduazione ha consentito anche la formazione di stadi a Brachypodium caespitosum, spesso rimboschitisi in modo naturale. I<br />
tagli hanno favorito sui versanti ripidi, soprattutto in passato, le comunità di Orno-Ostryon; queste con l’invecchiamento hanno lasciato il posto alla<br />
ripresa dell’Ostryo- Fagetum. In tutta la fascia occupata da questa serie sono ben rappresentate le comunità di mantello e di orlo (Galantho-<br />
Coryletum, comunità a Melampyrum velebiticum di Trifolion medii), neoformazioni a Populus tremula , stadi a Betula pendula di ricostituzione del<br />
bosco, successivi a incendi su terreni acidificati. Si trovano anche frequentemente comunità a Salix appendiculata di ricostituzione del bosco su<br />
pendii acclivi soggetti a slavine. Anche comunità di Atropetalia, conseguenti a interventi selvicolturali o a schianti naturali, sono collegate<br />
dinamicamente alla serie.<br />
Le serie e/o geosigmeti più estesi delle celle 970 e 969 sono stati descritti per unità di campionamento precedenti e per questo non vengono<br />
nuovamente analizzati.<br />
196
Tabella 185 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 970 Pieve di Bono (TN)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 25 - Geosigmeto della faggeta e dei piceo-faggeti montani su substrati a reazione alcalina (serie<br />
dominante di Anemono trifoliae-Fagetum e di Dentario-pentaphylli-Fagetum)<br />
5 29768,32 27,64<br />
2 11 - b: Geosigmeto delle peccete e degli arbusteti subalpini dei substrati silicatici: rodoreti e<br />
junipereti (serie del Vaccinio-Rhododendretum ferruginei e serie edafo-xerofila del Festucetum<br />
scabriculmis)<br />
11 12574,58 11,68<br />
3 44 - b: Serie del carpino nero e del frassino maggiore del piano supratemperato (Fraxino orni-<br />
Ostryetum carpinifoliae)<br />
3 12061,88 11,20<br />
4 3 - Geosigmeto della vegetazione di prateria alpina e pioniera ipsofila su substrati a reazione acida<br />
(Caricion curvulae)<br />
3 8567,39 7,96<br />
5 14 - Serie dei boschi ad abete bianco e rosso del Vaccinio-Abietenion (Calamagrostio villosae-<br />
Abietetum albae, Vaccinio-Abietetum albae)<br />
5 6462,83 6,00<br />
6 8 - Geosigmeto esalpico della vegetazione delle praterie alpine e vegetazione pioniera ipsofila su<br />
substrati a reazione alcalina (serie di Caricion austroalpinae e di Rhododendro hirsuti-Pinetum<br />
prostratae)<br />
5 4648,99 4,32<br />
7 11 - a: Geosigmeto delle peccete e degli arbusteti subalpini dei substrati silicatici: boschi di<br />
conifere altimontani e subalpini, delle mughete e del rododendreto a Rhododendron ferrugineum<br />
(Calamagrostio villosae-Abietetum, Homogyno-Piceetum, Rhododendro ferruginei-Pinetum<br />
prostatae, Rhododendretum ferruginei)<br />
6 4365,67 4,05<br />
8 15 - a: Geosigmeto della pecceta subalpina e del rododendreto a Rhododendron ferrugineum su<br />
substrati a reazione acida: serie dominanti di Homogyno-Piceetum e di Rhododendretum<br />
ferruginei<br />
6 3655,14 3,39<br />
9 20 - Serie delle peccete montane e altimontane dell’Abieti-Piceion 4 2957,60 2,75<br />
10 44 - a: Serie edafoxerofila esalpica submontana a pino silvestre, carpino nero e orniello<br />
(Chamaecytiso purpurei-Pinetum sylvestris e Erico-Fraxinion orni)<br />
3 2899,71 2,69<br />
11 13 - Serie delle mughete basifile dei piani orotemperato e criorotemperato dell’alleanza Erico-<br />
Pinion mugo (Erico carneae-Pinetum mugo, Mugo-Rhododendretum)<br />
7 2719,46 2,53<br />
12 23 - c: Geosigmeto delle peccete e delle faggete montane su substrati a reazione acida (serie di<br />
Luzulo nemorosae-Piceetum e Luzulo nemorosae-Fagetum): serie dominante di Luzulo-Fagion<br />
2 2704,53 2,51<br />
13 22 - Serie esalpica delle faggete mesofile e dei piceo-faggeti dell'orizzonte montano dei substrati<br />
carbonatici: Vicio oroboidis-Fagetum, piceo-faggete orobiche (Aremonio-Fagion s.l.)<br />
2 2654,10 2,46<br />
14 78 - Serie dei boschi a carpino bianco e serie del frassino maggiore del piano supratemperato<br />
(Galio laevigati-Carpinetum betuli, Salvio glutinosae-Fraxinetum excelsioris)<br />
3 2132,36 1,98<br />
197
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
15 83 - a: Geosigmeto perialveale montano endalpico 1 1773,20 1,65<br />
16 73 - Serie submontana dei querceti a rovere termofili oligotrofici (Genisto-Quercion) 1 1684,09 1,56<br />
17 36 - Serie dei boschi misti mesofili del Tilio-Acerion 4 1480,10 1,37<br />
18 74 - Serie acidofila dei boschi di rovere del piano supratemperato (Luzulo niveae-Quercetum<br />
petraeae)<br />
1 1265,29 1,17<br />
19 41 - a: Serie endalpica delle pinete a pino silvestre: Erico-Pinion sylvestris 1 649,79 0,60<br />
20 83 b: Geosigmeto perialveale montano meso-esalpico 1 501,41 0,47<br />
21 23 - d: Geosigmeto delle peccete e delle faggete montane su substrati a reazione acida (serie di<br />
Luzulo nemorosae-Piceetum e Luzulo nemorosae-Fagetum) a mosaico con la serie delle pinete<br />
xerofile (Dicrano-Pinion)<br />
1 253,39 0,24<br />
22 7 - Geosigmeto della vegetazione delle praterie alpine e vegetazione pioniera ipsofila su substrati a<br />
reazione alcalina (Seslerion albicantis s.l.)<br />
1 243,16 0,23<br />
23 87 - Serie dei boschi di leccio del Celtido-Quercetum ilicis 2 192,71 0,18<br />
24 47 - Serie climacica submontana dei substrati silicatici: aceri-frassineti e boschi misti di latifoglie<br />
(Arunco-Fraxinetum castanetosum)<br />
1 17,69 0,02<br />
area totale cella 970 107686,62<br />
198
Tabella 186 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 969 di Borno (BS)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 11 - b: Geosigmeto delle peccete e degli arbusteti subalpini dei substrati silicatici: rodoreti e<br />
junipereti (serie del Vaccinio-Rhododendretum ferruginei e serie edafo-xerofila del Festucetum<br />
scabriculmis)<br />
11 16928,58 15,72<br />
2 8 - Geosigmeto esalpico della vegetazione delle praterie alpine e vegetazione pioniera ipsofila su<br />
substrati a reazione alcalina (serie di Caricion austroalpinae e di Rhododendro hirsuti-Pinetum<br />
prostratae)<br />
11 14691,59 13,65<br />
3 20 - Serie delle peccete montane e altimontane dell’Abieti-Piceion 11 14588,72 13,55<br />
4 22 - Serie esalpica delle faggete mesofile e dei piceo-faggeti dell'orizzonte montano dei substrati<br />
carbonatici: Vicio oroboidis-Fagetum, piceo-faggete orobiche (Aremonio-Fagion s.l.)<br />
10 14317,61 13,30<br />
5 51 - Serie avanalpica dei querceti e ostrieti mesofili dei substrati carbonatici (Erythronio<br />
Carpinion)<br />
6 12975,51 12,05<br />
6 15 - a: Geosigmeto della pecceta subalpina e del rododendreto a Rhododendron ferrugineum su<br />
substrati a reazione acida: serie dominanti di Homogyno-Piceetum e di Rhododendretum<br />
ferruginei<br />
11 9294,52 8,63<br />
7 82 - a: Geosigmeto della serie edafo-igrofila dei boschi perialveali 1 7837,58 7,28<br />
8 73 - Serie submontana dei querceti a rovere termofili oligotrofici (Genisto-Quercion) 3 7773,48 7,22<br />
9 47 - Serie climacica submontana dei substrati silicatici: aceri-frassineti e boschi misti di latifoglie<br />
(Arunco-Fraxinetum castanetosum)<br />
6 3585,72 3,33<br />
10 1 - Geosigmeto meso-endalpico dei substrati intrusivi e metamorfici dell'orizzonte altoalpinosubnivale:<br />
vegetazione dei ghiaioni e delle rocce (Sieversio-Oxyrietum, Androsacetum alpinae,<br />
Androsacion vandelli, Saxifrago-Poetum alpinae, Luzuletum alpino-pilosae)<br />
1 2856,37 2,65<br />
11 37 - Geosigmeto submontano dei substrati carbonatici: querceti e ostrieti mesofili (Erythronio-<br />
Carpinion), aceri-tiglieti (Arunco-Aceretum)<br />
1 1979,81 1,84<br />
12 23 - d: Geosigmeto delle peccete e delle faggete montane su substrati a reazione acida (serie di<br />
Luzulo nemorosae-Piceetum e Luzulo nemorosae-Fagetum) a mosaico con la serie delle pinete<br />
xerofile (Dicrano-Pinion)<br />
1 609,39 0,57<br />
area totale cella 969 107667,59<br />
199
Tabella 187 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 968 di Ardesio (BG)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 22 - Serie esalpica delle faggete mesofile e dei piceo-faggeti dell'orizzonte montano dei substrati<br />
carbonatici: Vicio oroboidis-Fagetum, piceo-faggete orobiche (Aremonio-Fagion s.l.)<br />
15 34823,44 32,35<br />
2 37 - Geosigmeto submontano dei substrati carbonatici: querceti e ostrieti mesofili (Erythronio-<br />
Carpinion), aceri-tiglieti (Arunco-Aceretum)<br />
3 23104,47 21,46<br />
3 11 - b: Geosigmeto delle peccete e degli arbusteti subalpini dei substrati silicatici: rodoreti e<br />
junipereti (serie del Vaccinio-Rhododendretum ferruginei e serie edafo-xerofila del Festucetum<br />
scabriculmis)<br />
2 16843,07 15,65<br />
4 8 - Geosigmeto esalpico della vegetazione delle praterie alpine e vegetazione pioniera ipsofila su<br />
substrati a reazione alcalina (serie di Caricion austroalpinae e di Rhododendro hirsuti-Pinetum<br />
prostratae)<br />
11 10750,68 9,99<br />
5 15 - a: Geosigmeto della pecceta subalpina e del rododendreto a Rhododendron ferrugineum su<br />
substrati a reazione acida: serie dominanti di Homogyno-Piceetum e di Rhododendretum<br />
ferruginei<br />
8 6908,44 6,42<br />
6 47 - Serie climacica submontana dei substrati silicatici: aceri-frassineti e boschi misti di latifoglie<br />
(Arunco-Fraxinetum castanetosum)<br />
8 6079,70 5,65<br />
7 51 - Serie avanalpica dei querceti e ostrieti mesofili dei substrati carbonatici (Erythronio<br />
Carpinion)<br />
4 2888,75 2,68<br />
8 20 - Serie delle peccete montane e altimontane dell’Abieti-Piceion 2 2371,86 2,20<br />
9 10 - Geosigmeto endalpico tra la serie delle larici-cembrete e la serie edafo-xerofila degli<br />
junipereti (Larici-Pinetum cembrae, Empetro-Vaccinietum, Junipero-Arctostaphyletum)<br />
2 1322,28 1,23<br />
10 1 - Geosigmeto meso-endalpico dei substrati intrusivi e metamorfici dell'orizzonte altoalpinosubnivale:<br />
vegetazione dei ghiaioni e delle rocce (Sieversio-Oxyrietum, Androsacetum alpinae,<br />
Androsacion vandelli, Saxifrago-Poetum alpinae, Luzuletum alpino-pilosae)<br />
1 1168,82 1,09<br />
11 82 - a: Geosigmeto della serie edafo-igrofila dei boschi perialveali 2 869,19 0,81<br />
12 3 - Geosigmeto della vegetazione di prateria alpina e pioniera ipsofila su substrati a reazione acida<br />
(Caricion curvulae)<br />
2 395,62 0,37<br />
13 23 - c: Geosigmeto delle peccete e delle faggete montane su substrati a reazione acida (serie di<br />
Luzulo nemorosae-Piceetum e Luzulo nemorosae-Fagetum): serie dominante di Luzulo-Fagion<br />
1 79,00 0,07<br />
14 23 - d: Geosigmeto delle peccete e delle faggete montane su substrati a reazione acida (serie di<br />
Luzulo nemorosae-Piceetum e Luzulo nemorosae-Fagetum) a mosaico con la serie delle pinete<br />
xerofile (Dicrano-Pinion)<br />
1 49,27 0,05<br />
area totale cella 968 107654,58<br />
200
Nella unità campione 968 di Ardesio (BG) la più estesa (32,5%) è la serie climatica esalpica dell’orizzonte montano dei substrati cartonatici:<br />
comprende la serie delle faggete mesofile riferibili all’Eu-Fagion e all’Aremonio-Fagion s.s. e delle piceo-faggete orobiche (Aremonio-<br />
Fagion s.l.). Le tipologie forestali che costituiscono lo stadio maturo di questa unità ambientale presentano problematiche di tipo<br />
biogeografico a scala regionale. Per la Lombardia occidentale lo stadio maturo è rappresentato da faggete mesofile a Galium odoratum,<br />
mentre per la Lombardia orientale da una fitocenosi assimilabile al Vicio oroboidis-Fagetum. L’inquadramento fitosociologico per le faggete<br />
mesofile della Lombardia centrale (zona orobica) è ancora incerto. Lo strato arboreo è dominato esclusivamente dal faggio, sporadicamente<br />
compaiono Abies alba, Laburnum alpinum, Ostrya carpinifolia e Picea excelsa. Anche a livello arbustivo domina il faggio, ma Fraxinus<br />
excelsior, Sorbus aria, Abies alba, Populus tremula e Crataegus monogyna, accrescono la biodiversità della comunità, per quanto questo<br />
strato sia scarsamente rappresentato. Nelle piceofaggete orobiche la presenza di conifere (Picea excelsa e Larix decidua) è talvolta quasi<br />
preponderante, vi si rinvengono anche Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Salix caprea e Sorbus aucuparia. Lo strato erbaceo<br />
comprende specie calciofile come Cyclamen purpurascens, Hepatica nobilis ed Helleborus niger, comuni a tutte le faggete. Nella Lombardia<br />
occidentale le faggete mesofile sono rapprentate da Galium odoratum, Cardamine heptaphylla, Geranium nodosum, Senecio fuchsii,<br />
Lamiastrum galeobdolon, Aconitum vulparia.<br />
Tra gli stadi della serie si evidenziano: sui versanti più solivi, seslerieti esalpici, sui versanti più freschi, praterie meso-igrofile a Sesleria<br />
varia e Molinia arundinacea, prati da sfalcio dell’Hormino-Avenetum parlatorei; il mantello è rappresentato nella zona orobica da<br />
formazioni arbustive a Cytisus emeriflorus, nella Lombardia occidentale da formazioni arbustive a Amelanchier ovalis; prebosco: Ostryo-<br />
Fagetum. La serie edafoxerofila delle faggete è rappresentata da mughete (Erico-Pinion mugo).<br />
Nelle celle 964, 933, 932 e 902 sono più numerosi i geosigmeti rispetto alle serie di vegetazione cartografabili. Ne vengono descritti alcuni<br />
tra quelli aventi maggiore estensione in queste unità di campionamento.<br />
Nell’ambito della serie 30-a delle faggete e delle fago-abetine di Luzulo-Fagion rientrano sia le faggete oligotrofiche (serie acidofila del<br />
faggio) sia le fago-abetine (Abeti-Fagion).<br />
Tra le faggete, quella oligotrofica è la più diffusa in Piemonte e caratterizza il paesaggio di gran parte delle vallate alpine. Molto sfruttato per<br />
la ceduazione, che in passato veniva effettuata quasi ovunque, questo tipo di bosco anche oggi si presenta impoverito e con valori di<br />
biodiversità molto bassa, probabilmente veniva infatti praticata una eliminazione totale delle specie di accompagnamento per favorire il<br />
faggio. Solo in poche zone, ove c’erano problemi di protezione di centri abitati, si sono conservate rarissime fustaie che presentano una<br />
maggiore ricchezza floristica rispetto ai boschi cedui e in alcune si nota una certa tendenza al bosco misto con rovere alle quote più basse,<br />
con abete rosso o bianco alle quote medie o alte. L’antropizzazione nel passato aveva anche in parte sostituito tali boschi con castagneti (solo<br />
a quote basse), pascoli o anche coltivi. Queste pratiche nel tempo sono state abbandonate e ciò ha determinato una colonizzazione molto<br />
estesa da parte di arbusteti in diversi stadi dinamici. Le faggete abbandonate da più tempo si trovano in gran parte nel Piemonte<br />
settentrionale, per ragioni sia storiche che geomorfologiche.<br />
La faggeta oligotrofica copre, potenzialmente e realmente, una fascia molto ampia, sia in altitudine, da 600-700 a 1500 m, raggiungendo<br />
anche i 1800 m in condizioni particolari, sia in latitudine, essendo presente in tutto l’arco alpino occidentale. Per le sue esigenze climatiche<br />
ed edafiche la maggior estensione si osserva nel distretti alpini a più elevate precipitazioni e soprattutto su substrati silicei. I suoli che ne<br />
derivano sono evoluti, in genere profondi, acidi o anche molto acidi, con molto scheletro, non grossolano. Una caratteristica tipica di questi<br />
201
suoli è la presenza di una lettiera particolarmente abbondante formata dalle foglie cadute e indecomposte, che spesso ostacola la<br />
germinazione delle specie erbacee.<br />
Questo tipo di faggeta si trova a mosaico con il querceto di rovere a Teucrium scorodonia nel Piemonte settentrionale, con il querceto di<br />
rovere a Physospermum cornubiense dei substrati serpentinosi appenninici e dei paleosuoli dell’alta Pianura alessandrina, con le fago-abetine<br />
dell’Abieti-Fagion e con la pineta endalpica basifila di pino silvestre. Il bosco maturo è riferibile all’alleanza Luzulo-Fagion, presentando<br />
Fagus sylvatica, Sorbus aucuparia, Betula pendula, Quercus petraea, Laburnum anagyroides e Laburnum alpinum (più raro), Rhododendron<br />
ferrugineum, Vaccinium myrtillus, Luzula nivea, Avenella flexuosa, Prenanthes purpurea, Maianthemum bifolium, Veronica urticifolia e<br />
Hieracium gr. murorum.<br />
Le fago-abetine, che prediligono substrati molto acidi, di profondità variabile, sempre ricchi in scheletro e in prevalenza a esposizione Nord<br />
tra 800 e 1500-1600 m, sono invece riferibili all’alleanza Abieti-Fagion e presentano Abies alba e Fagus selvatica dominanti con presenza<br />
localizzata di Larix decidua e Picea abies. Sono presenti,nello strato arbustivo, Sorbus aucuparia, Rhododendron ferrugineum, Laburnum<br />
anagyroides e, nello strato erbaceo, Avenella flexuosa, Vaccinium myrtillus, Oxalis acetosella, Maianthemum bifolium, Prenanthes purpurea<br />
e alcune felci tra cui Gymnocarpium dryopteris.<br />
Anche in questo caso si osserva una forte influenza dei tagli selettivi sulla composizione floristica che quindi a volte risulta alterata<br />
rispettoalla composizione naturale e presenta una maggiore semplificazione e minore biodiversità.<br />
Per la serie 20 delle peccete montane e altimontane dell’Abieti-Piceion emerge una difficoltà di individuazione dell’effettiva estensione del bosco<br />
potenziale a causa della notevole antropizzazione pregressa che ha favorito la selezione delle altre specie arboree presenti e la sostituzione per<br />
ampliare le aree pascolive. Attualmente si hanno delle prime indicazioni di ritorno verso il bosco originario, anche attraverso una selvicoltura<br />
naturalistica estensiva che permetta un arricchimento di queste formazioni.<br />
Si tratta di boschi riferibili all’ordine Abieti-Piceion con prevalenza di Abies alba e abbondanze variabili di Picea abies, Larix decidua, Fagus<br />
sylvatica, Sorbus aucuparia, Rhododendron ferrugineum, Laburnum anagyroides, Avenella flexuosa, Vaccinium myrtillus, Festuca flavescens (non<br />
nelle vallate Sesia e Ossola), Rubus idaeus. Prediligono suoli molto acidi, di solito ricchi in scheletro, con buona capacità di drenaggio, ricchi in<br />
sostanza organica e con lettiera notevolmente indecomposta.<br />
202
Tabella 188 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 964 di Vannio Anzino (VB)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 30 - a: Serie delle faggete e delle fago-abetine di Luzulo-Fagion 7 34414,78 31,97<br />
2 20 - Serie delle peccete montane e altimontane dell’Abieti-Piceion 10 22406,76 20,81<br />
3 3 - Geosigmeto della vegetazione di prateria alpina e pioniera ipsofila su substrati a reazione acida<br />
(Caricion curvulae)<br />
7 18423,40 17,11<br />
4 70 - a: Serie dei querceti acidofili di rovere a Teucrium scorodonia (Quercion robori-petraeae) 5 10162,04 9,44<br />
5 10 - Geosigmeto endalpico tra serie delle larici-cembrete e la serie edafo-xerofila degli junipereti<br />
(Larici-Pinetum cembrae, Empetro-Vaccinietum, Junipero-Arctostaphyletum)<br />
5 5437,67 5,05<br />
6 82 - a: Geosigmeto della serie edafo-igrofila dei boschi perialveali 1 3738,51 3,47<br />
7 2 - Geosigmeto dei pascoli alpini e della vegetazione pioniera ipsofila su rocce ultrabasiche (Serie<br />
dominanti di Caricion curvulae e di Festucion variae)<br />
5 1669,89 1,55<br />
8 30 - b: Serie delle faggete e delle fago-abetine di Luzulo-Fagion a mosaico con la serie dei<br />
1 1364,23 1,27<br />
querceti di rovere a Teucrium scorodonia<br />
9 67 - Serie degli orno-querceti di roverella (Quercetalia pubescenti-petraeae) 2 782,22 0,73<br />
area totale cella 964 107656,55<br />
La serie del geosigmeto dei pascoli alpini su silice (Caricion curvulae), che rappresenta nella cella 964 di Vannio Anzino (VB) il 31,9% della<br />
superficie, è individuata, in modo frammentato, su tutto il territorio valdostano. Bisogna precisare che in questo caso il grado di precisione<br />
ottenuto nella definizione dei confini e dell’estensione dei poligoni del geosigmeto è direttamente influenzata dalla scala della base<br />
cartografica utilizzata, una carta geologica di scarso dettaglio (1:100.000). Dal punto di vista altitudinale il geosigmeto è compreso tra il<br />
limite superiore di diffusione del bosco e il geosigmeto degli affioramenti rocciosi e dei detriti silicei. I suoli sono poco evoluti, sottili, a<br />
tessitura grossolana, con pH basso e ricchi in sostanza organica debolmente umificata. La copertura erbacea cresce lenta, soprattutto a quote<br />
elevate, e la necromassa di origine vegetale è presente in quantità significative nella lettiera.<br />
I pascoli alpini tipici di suoli acidi o acidificati, che coprono grandi superfici al di sopra del limite del bosco, si riferiscono generalmente a tre<br />
diverse alleanze: Caricion curvulae, Nardion strictae e Festucion variae. Le praterie riferibili a quest’ultima alleanza raramente superano i<br />
2200 metri e sono tipiche di pendii soleggiati, a ridotta copertura nevosa; comprendono i popolamenti del limite inferiore dell’orizzonte<br />
alpino e coprono una fascia di transizione verso i pascoli e i pratopascoli dell’orizzonte suba lpino. Sono frequenti gli arbusteti dominati da<br />
Rhododendron ferrugineum, Juniperus communis ssp. nana e Vaccinium myrtillus, riferibili al Rhododendro-Vaccinion e al Juniperion<br />
nanae. La riduzione del pascolo, che si osserva in parte del territorio regionale, ne permette una progressiva estensione. In Valle d’Aosta, le<br />
cotiche a Plantago alpina e Festuca ovina, quelle a Festuca violacea e quelle a Helictotrichon parlatorei sono le più diffuse praterie riferibili<br />
al Festucion variae. Le specie più comuni sono, oltre a Festuca ovina, Festuca violacea ed Helictotrichon parlatorei, Potentilla grandiflora,<br />
Pulsatilla vernalis, Antennaria dioica, Plantago alpina, Bellardiochloa violacea e Geum montanum. Nel Nardion strictae sono comprese<br />
praterie influenzate in diversa misura dal pascolamento, in cui Nardus stricta risulta spesso dominante, sviluppate su pendii debolmente<br />
203
acclivi, a considerevole copertura nevosa e caratterizzati da un pH generalmente compreso tra 5 e 6. Tipiche di quest’alleanza sono le cotiche<br />
a Nardus stricta e Festuca rubra, le cotiche a Trifolium alpinum, comuni nella regione, e quelle ad Alopecurus gerardii. Le specie più<br />
comuni, oltre a quelle già citate, sono Geum montanum, Arnica montana, Campanula barbata, Gentiana acaulis, Botrychium lunaria,<br />
Avenella flexuosa, Festuca violacea, Alchemilla pentaphyllea, Minuartia verna ed Anthoxanthum odoratum. Il Caricion curvulae comprende<br />
popolamenti di suoli acidi degli orizzonti alto alpino e nivale. Tipiche di quest’alleanza sono le cotiche a Festuca halleri e quelle a Carex<br />
curvula. Le specie più diffuse sono, oltre a quelle già citate, Avenula versicolor, Potentilla aurea, Hieracium glaciale, Agrostis rupestre,<br />
Luzula lutea, Silene acaulis, Minuartia sedoides e Trifolium alpinum. Le vallette nivali sono caratterizzate dalle seguenti associazioni, in<br />
ordine decrescente di persistenza del manto nevoso: Polytrichetum sexangolaris, Salicetum herbaceae e Caricetum foetidae. Gli arbusteti a<br />
Loiseleuria procumbens e Vaccinium uliginosum, riferibili all’alleanza Loiseleurio - Vaccinion sono localizzati in prevalenza sulle creste<br />
ventose dove si ha copertura nevosa poco persistente, distribuita in modo eterogeneo e discontinuo, e suolo molto superficiale.<br />
204
Tabella 189 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 933 di Issogne (AO)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 10 - Geosigmeto endalpico tra la serie delle larici-cembrete e la serie edafo-xerofila degli<br />
junipereti (Larici-Pinetum cembrae, Empetro-Vaccinietum, Junipero-Arctostaphyletum)<br />
10 24921,39 23,02<br />
2 3 - Geosigmeto della vegetazione di prateria alpina e pioniera ipsofila su substrati a reazione<br />
acida (Caricion curvulae)<br />
13 18347,64 16,95<br />
3 30 - a: Serie delle faggete e delle fago-abetine di Luzulo-Fagion 10 12941,97 11,96<br />
4 11 - Geosigmeto delle peccete e degli arbusteti subalpini dei substrati silicatici 9 9806,97 9,06<br />
5 38 - Serie mesalpico-endalpica acidofila a pino silvestre (Deschampsio-Pinion) 3 7276,44 6,72<br />
6 66 - Serie dei querceti di roverella (Quercetalia pubescenti-petraeae) 3 6666,40 6,16<br />
7 6 - Geosigmeto delle praterie alpine e della vegetazione pioniera ipsofila su substrati a reazione<br />
alcalina (serie dominante di Seslerio-Caricetum sempervirentis)<br />
10 4990,27 4,61<br />
8 70 - a: Serie dei querceti acidofili di rovere a Teucrium scorodonia (Quercion robori-petraeae) 4 4748,27 4,39<br />
9 7 - Geosigmeto della vegetazione delle praterie alpine e vegetazione pioniera ipsofila su substrati a<br />
reazione alcalina (Seslerion albicantis s.l.)<br />
8 4148,61 3,83<br />
10 82 - a: Geosigmeto della serie edafo-igrofila dei boschi perialveali 1 4142,06 3,83<br />
11 39 - a: Serie endalpica basifila di pino silvestre (Ononido-Pinion) 4 2757,87 2,55<br />
12 2 - Geosigmeto dei pascoli alpini e della vegetazione pioniera ipsofila su rocce ultrabasiche (Serie<br />
dominanti di Caricion curvulae e di Festucion variae)<br />
15 2621,45 2,42<br />
13 12 - Serie delle pinete endalpiche di pino uncinato (Rhododendro-Pinetum uncinatae) 1 2162,25 2,00<br />
14 20 - Serie delle peccete montane e altimontane dell’Abieti-Piceion 4 1449,48 1,34<br />
15 36 - Serie dei boschi misti mesofili del Tilio-Acerion 2 1120,62 1,04<br />
16 77 - b: Serie padana occidentale dei querco-carpineti (Carpinion betuli) della bassa pianura 1 143,43 0,13<br />
area totale cella 933 108245,10<br />
Il geosigmeto endalpico tra la serie delle larici-cembrete e la serie edafo-xerofila degli junipereti (Larici-Pinetum cembrae, Empetro-<br />
Vaccinietum, Junipero-Arctostaphyletum) copre nelle celle 933 di Issogne e 932 di Cogne, entrambe nella provincia di Aosta, rispettivamente<br />
24921,4 e 17343 ettari.<br />
Distribuita in modo continuo su tutto il territorio regionale, con confini altitudinali sono costanti e tra 1600-1700 metri e i 2000-2200 metri tipici<br />
del limite superiore di diffusione del bosco, la serie è indifferente ai substrati. Si tratta di formazione forestali molto diffuse in tutto la regione<br />
riferibili fitosociologicamente all’ordine Piceetalia excelsae, alleanza Piceion excelsae. Le specie più abbondanti dello strato arboreo sono, oltre a<br />
Larix decidua, Picea abies, Pinus cembra e Pinus uncinata. Lo strato arbustivo è dominato da Rhododendron ferrugineum, Vaccinium myrtillus,<br />
Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium gaultherioides, Alnus viridis, Juniperus nana e, limitatamente alla Valle di Cogne e a ridottissime porzioni della<br />
Valpelline, della Valle di Rhêmes e della Valsavarenche, Juniperus sabina. Le specie più comuni dello strato erbaceo sono Calamagrostis villosa,<br />
205
Festuca flavescens, Avenella flexuosa, Empetrum hermaphroditum, Festuca acuminata, Hieracium sylvaticum, Homogyne alpina e, nelle stazioni<br />
più xerofile, Arctostaphylos uva-ursi, Festuca laevigata e Agrostis tenuis. Dal punto di vista fisionomico spesso si tratta di boschi aperti,<br />
caratterizzati da una notevole copertura arbustiva e erbacea. La rinnovazione, in ragione delle spiccate caratteristiche di eliofilia, appare quindi<br />
difficile, soprattutto nelle stazioni dove il tappeto erboso è significativo.<br />
L’influenza antropica, significativa in passato, è stata diretta e consistita fondamentalmente in tagli rasi finalizzati all’ampliamento delle aree<br />
destinate a pascolo. L’effetto macroscopico è risultato l’abbassamento del limite altitudinale del bosco che in alcune zone si attesta attualmente<br />
attorno ai 1500-2000 metri di quota. Parallelamente è avvenuta anche una significativa alterazione della composizione floristica sia a seguito del<br />
taglio selettivo di alcune specie arboree sia a causa della diffusa pratica del pascolamento in bosco. L’attuale riduzione della pressione<br />
agropastorale, consente una graduale ricolonizzazione delle aree un tempo intensamente pascolate.<br />
Tabella 190 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 932 di Cogne (AO)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 3 - Geosigmeto della vegetazione di prateria alpina e pioniera ipsofila su substrati a reazione acida<br />
(Caricion curvulae)<br />
13 33990,78 31,40<br />
2 10 - Geosigmeto endalpico tra serie delle larici-cembrete e la serie edafo-xerofila degli junipereti<br />
(Larici-Pinetum cembrae, Empetro-Vaccinietum, Junipero-Arctostaphyletum)<br />
9 17343,04 16,02<br />
3 11 - Geosigmeto delle peccete e degli arbusteti subalpini dei substrati silicatici 5 16482,95 15,22<br />
4 6 - Geosigmeto delle praterie alpine e della vegetazione pioniera ipsofila su substrati a reazione<br />
alcalina (serie dominante di Seslerio-Caricetum sempervirentis)<br />
18 12369,90 11,43<br />
5 66 Serie dei querceti di roverella (Quercetalia pubescenti-petraeae) 1 6332,54 5,85<br />
6 38 - Serie mesalpico-endalpica acidofila a pino silvestre (Deschampsio-Pinion) 5 5661,51 5,23<br />
7 2 - Geosigmeto dei pascoli alpini e della vegetazione pioniera ipsofila su rocce ultrabasiche (Serie<br />
dominanti di Caricion curvulae e di Festucion variae)<br />
20 4213,57 3,89<br />
8 39 a: Serie endalpica basifila di pino silvestre (Ononido-Pinion) 4 3902,02 3,60<br />
9 7 - Geosigmeto della vegetazione delle praterie alpine e vegetazione pioniera ipsofila su substrati a<br />
reazione alcalina (Seslerion albicantis s.l.)<br />
15 3757,27 3,47<br />
10 82 - a: Geosigmeto della serie edafo-igrofila dei boschi perialveali 1 2673,56 2,47<br />
11 36 - Serie dei boschi misti mesofili del Tilio-Acerion 1 1537,45 1,42<br />
area totale cella 932 108265,19<br />
206
Tabella 191 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 902 di Groscavallo (TO)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA<br />
1 3 - Geosigmeto della vegetazione di prateria alpina e pioniera ipsofila su substrati a reazione<br />
acida (Caricion curvulae)<br />
4 28293,68 26,00<br />
2 30 - a: Serie delle faggete e delle fago-abetine di Luzulo-Fagion 3 27264,18 25,05<br />
3 2 - Geosigmeto dei pascoli alpini e della vegetazione pioniera ipsofila su rocce ultrabasiche<br />
(Serie dominanti di Caricion curvulae e di Festucion variae)<br />
7 18822,40 17,29<br />
4 10 - Geosigmeto endalpico tra serie delle larici-cembrete e la serie edafo-xerofila degli junipereti<br />
(Larici-Pinetum cembrae, Empetro-Vaccinietum, Junipero-Arctostaphyletum)<br />
5 13395,15 12,31<br />
5 70 - a: Serie dei querceti acidofili di rovere a Teucrium scorodonia (Quercion robori-petraeae) 2 6739,59 6,19<br />
6 6 - Geosigmeto delle praterie alpine e della vegetazione pioniera ipsofila su substrati a reazione<br />
alcalina (serie dominante di Seslerio-Caricetum sempervirentis)<br />
6 2516,87 2,31<br />
7 77 - b: Serie padana occidentale dei querco-carpineti (Carpinion betuli) della bassa pianura 1 569,09 0,52<br />
8 11 - Geosigmeto delle peccete e degli arbusteti subalpini dei substrati silicatici 2 272,83 0,25<br />
9 70 - b: Serie dei querceti acidofili di rovere a Teucrium scorodonia (Quercion robori-petraeae) a<br />
mosaico con la serie dei querco-carpineti dell'alta pianura<br />
1 155,55 0,14<br />
10 82 - a: Geosigmeto della serie edafo-igrofila dei boschi perialveali 1 95,50 0,09<br />
area totale cella 902 108836,42<br />
Il mosaico dei querceti e ostrieti delle aree collinari emiliane occidentali (Boschi misti dell’Ostryo-Aceretum opulifolii platantheretosum e<br />
del Campanulo-Ostryenion e) copre nella cella 847 di Bobbio (PC) il 29,9% della superficie.<br />
La serie dell’Ostryo-Aceretum opulifolii predilige versanti e siti freschi. I boschi collinari del Laburno-Ostryion, rappresentati<br />
dall’associazione Ostryo-Aceretum opulifolii. La presenza di suoli moderatamente argillosi e un substrato abbastanza omogeneo (flysch della<br />
formazione marnosoarenacea) favoriscono le facies forestali miste di carpino nero e cerro. Gli stadi sostitutivi della serie sono costitutiti da<br />
mantelli e arbusteti dei Prunetalia spinosae, specialmente a Spartium junceum sui versanti caldi, e prati e pascoli post-colturali<br />
(Agropyretalia repentis/Brometalia erecti).<br />
I querceti caducifogli misti del Campanulo-Ostryenion, che si distribuiscono nelle aree collinari del piacentino, sono caratterizzati sui<br />
versanti freschi da carpino nero (Ostrya carpinifolia), orniello (Fraxinus ornus), acero campestre (Acer campestre), cerro (Quercus cerris), e<br />
roverella (Quercus pubescens) mentre sui versanti soleggiati soprattutto di roverella (Quercus pubescens), con Cotinus coggygrya<br />
Dal punto di sintassonomico, è bene precisare che i querceti collinari del piacentino sono una vegetazione mal nota (non ci sono riferimenti<br />
bibliografici), probabilmente riferibile al Campanulo-Ostryenion (in conformità a qualche osservazione). Gli stadi della serie sono mantelli e<br />
arbusteti dei Prunetalia spinosae, e prati e pascoli post-colturali (Agropyretalia repentis/Brometalia erecti).<br />
207
Tabella 192 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 847 di Bobbio (PC)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 53 - cd: Mosaico dei querceti e ostrieti delle aree collinari emiliane occidentali (Boschi misti<br />
dell’Ostryo-Aceretum opulifolii platantheretosum e del Campanulo-Ostryenion)<br />
3 32855,96 29,89<br />
2 21 - b: Serie dei boschi misti submontani dell'Emilia occidentale (Campanulo-Ostryenion) 5 28851,59 26,25<br />
3 85 Geosigmeto dell'Appennino pavese fra serie a Quercus pubescens, serie a Quercus cerris e<br />
serie a Fagus sylvatica<br />
1 18963,10 17,25<br />
4 9 - c: Mosaico di serie delle faggete termofile dell’Appennino emiliano occidentale (Seslerio<br />
cylindricae-Fagetum , Leucojo-Fagetum, Daphno laureolae-Fagetum coryletosum)<br />
7 11104,31 10,10<br />
5 7 - b: Serie nord-appenninica delle faggete microterme dell'Appennino emiliano occidentale<br />
(Trochiscantho-Fagetum)<br />
4 3848,14 3,50<br />
6 32 - a: Serie della faggeta appenninica ad Adenostyles australis su calcare (Trochiscantho-<br />
Fagetum)<br />
1 3805,32 3,46<br />
7 32 - b: Serie della faggeta appenninica ad Adenostyles australis su calcare (Seslerietosum<br />
autumnalis)<br />
5 3461,49 3,15<br />
8 64 - a: Serie dei boschi del Physospermo-Quercetum petraeae 2 2214,52 2,01<br />
9 32 - c: Serie della faggeta appenninica ad Adenostyles australis su calcare (Sorbetosum<br />
aucupariae)<br />
3 1776,84 1,62<br />
10 58 - Serie degli ostrio-querceti dell’Appennino calcareo marnoso (Knautio drymejae-Ostryetum)<br />
a mosaico con i querceti di roverella<br />
3 1680,95 1,53<br />
11 28 - e: Serie dei boschi di faggio del Fagion sylvaticae a mosaico con la serie del Physospermo-<br />
Quercetum petraeae<br />
1 703,76 0,64<br />
12 89 - Geosigmeto ripariale e dei fondovalle alluvionali (Salicion albae, Populion albae, Alno-<br />
Ulmion, Carpinion betuli, Teucrio siculi-Quercion cerris)<br />
1 657,98 0,60<br />
area totale cella 847 109923,88<br />
La serie dei boschi misti submontani dell'Emilia occidentale (Campanulo-Ostryenion) si estende nella cella 818 di Borgo Val di Taro (PR)<br />
sul 24,3% della superficie. Si tratta di un boschi diffusi negli ambiti alto-collinari e submontani (tra i 700 e i 100 m di quota) dell’Appennino<br />
parmense e piacentino, su substrati litologici molto vari: arenarie, argille, marne, serpentini. Gli stadi maturi delle serie sono differenziati<br />
dalla presenza di Anemone trifolia subsp. brevidentata, Sesleria cylindrica e Buphthalmum salicifolium, facenti capo a più serie semplici.,<br />
con boschi misti generalmente a dominanza d’Ostrya carpinifolia o di Quercus cerris (a seconda del maggiore o minore drenaggio edafico)<br />
con o senza Carpinus betulus. Le fitocenosi di sostituzione sono mantelli e arbusteti dei Prunetalia spinosae insieme a prati e pascoli postcolturali<br />
(Agropyretaliaepentis/Brometalia erecti).<br />
208
Tabella 193 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 818 di Borgo Val di Taro (PR)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 21 - b: Serie dei boschi misti submontani dell'Emilia occidentale (Campanulo-Ostryenion) 2 26885,4600 24,33<br />
2 53 - cd: Mosaico dei querceti e ostrieti delle aree collinari emiliane occidentali (Boschi misti<br />
dell’Ostryo-Aceretum opulifolii platantheretosum e del Campanulo-Ostryenion)<br />
4 21843,4900 19,77<br />
3 29 - b: Serie nord-appennica delle cerrete acidofile con rovere e castagno (Teucrio scorodoniae-<br />
Castanetum sativae quercetosum cerris) Asphodelo-Castaneetum<br />
1 20262,1100 18,34<br />
4 9 - c: Mosaico di serie delle faggete termofile dell’Appennino emiliano occidentale (Seslerio<br />
cylindricae-Fagetum , Leucojo-Fagetum, Daphno laureolae-Fagetum coryletosum)<br />
6 10942,3600 9,90<br />
5 9 - a: Serie nord-appenninica delle faggete eutrofiche (Cardamino heptaphyllae-Fagetum<br />
sylvaticae)<br />
3 7069,6600 6,40<br />
6 64 - f: Serie dei boschi del Physospermo-Quercetum petraeae a mosaico con la serie del Lathyro-<br />
Quercetum cerridis<br />
1 4724,23 4,28<br />
7 28 - a: Serie dei boschi di faggio del Fagion sylvaticae 1 4207,07 3,81<br />
8 37 - Serie delle cerrete mesoigrofile (Melico uniflorae-Quercetum cerris) dell'Italia centrale 2 3927,5900 3,55<br />
9 64 - a: Serie dei boschi del Physospermo-Quercetum petraeae 1 3883,32 3,51<br />
10 31 - a: Serie centro-appenninca meso-supratemperata dei boschi acidofili di rovere e cerro delle<br />
pianure fluvio lacustri e conche intermontane (Hieracio racemosi-Quercetum petraeae)<br />
1 3418,3900 3,09<br />
11 7 - b: Serie nord-appenninica delle faggete microterme dell'Appennino emiliano occidentale<br />
(Trochiscantho-Fagetum)<br />
5 2409,5900 2,18<br />
12 9 - b: Serie nord-appenninica delle faggete eutrofiche (Cardamino heptaphyllae-Fagetum<br />
sylvaticae) a mosaico con la serie nord-appenninica delle faggete acidofile microterme (Roso<br />
pendulinae-Fagetum sylvaticae)<br />
1 777,8900 0,70<br />
13 2 - Serie nord-appenninica delle brughiere dÆaltitudine a mirtilli (Empetro-Vaccinietum) 1 141,2200 0,13<br />
area totale cella 818 110492,38<br />
La serie dei boschi di faggio del Fagion sylvaticae si estende nella cella 817 di Borzonasca (GE) per 30258,3 ettari. Sono formazioni boscate<br />
con una struttura piuttosto chiusa, con uno strato arboreo costituito quasi soltanto da Fagus sylvatica; una scarsa componente arbustiva<br />
(Vaccinium myrtillus) e una ricca presenza di specie erbacee (sia emicriptofite che geofite) fra le quali Luzula nivea, Lunula pedemontana,<br />
Prenanthes purpurea, Geranium nodosum, Trochiscanthes nodiflora, Cardamine heptaphylla, Festuca heterophylla, Veronica urticifolia,<br />
Paris quadrifolia, Neottia nidus avis. Gli stadi della serie sono sconosciuti: si ipotizzano preboschi a varia dominanza (Corylus avellana o<br />
Alnus incana), mantelli dell’ordine Prunetalia e praterie dell’alleanza Bromion, spesso a mosaico con lande basse a mirtillo e calluna<br />
(Vaccinio -Callunetum).<br />
209
La serie dei boschi del Physospermo-Quercetum petraeae (25,5%) è caratterizzata nello stadio maturo da boschi mesofili con lo strato<br />
arboreo dominato da Quercus petraea, cui si associano altre essenze quali castagno (la cui presenza in taluni casi diventa preponderante),<br />
carpino bianco, orniello, acero campestre, ciliegio e cerro; scarsa copertura dello strato arbustivo, limitato alla sporadica presenza di<br />
Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Rhamnus catartica, Prunus spinosa, Cornus mas, Pyrus pyraster etc. Lo strato erbaceo,<br />
caratterizzato da Anemone trifolia e Physospermum cornubiense, comprende altre specie nemorali, molte delle quali acidofile, quali Festuca<br />
heterophylla, Ornithogalum pyrenaicum, Luzula albida, L. pedemontana, L. forsteri, L. sylvatica e L. nivea (nelle stazioni a quote altitudinali<br />
maggiormente elevate), Carex digitata, Avenella flexuosa, Lathyrus niger, Lathyrus montanus, Pteridium aquilinum, Hieracium gr.<br />
sylvaticum, Teucrium scorodonia.<br />
Tabella 194 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 817 di Borzonasca (GE)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 28 - a: Serie dei boschi di faggio del Fagion sylvaticae 2 30258,28 27,39<br />
2 64 - a: Serie dei boschi del Physospermo-Quercetum petraeae 2 28198,76 25,52<br />
3 65 - a: Serie dei boschi di roverella del Rubio-Quercetum pubescentis 2 9959,30 9,01<br />
4 9 - c: Mosaico di serie delle faggete termofile dell'Appennino emiliano occidentale (Seslerio<br />
cylindricae-Fagetum , Leucojo-Fagetum, Daphno laureolae-Fagetum coryletosum)<br />
4 7410,40 6,71<br />
5 21 - b: Serie dei boschi misti submontani dell'Emilia occidentale (Campanulo-Ostryenion) 5 6759,13 6,12<br />
6 64 - f: Serie dei boschi del Physospermo-Quercetum petraeae a mosaico con la serie del Lathyro-<br />
Quercetum cerridis<br />
4 6633,79 6,00<br />
7 7 - b: Serie nord-appenninica delle faggete microterme dell'Appennino emiliano occidentale<br />
(Trochiscantho-Fagetum)<br />
2 4888,37 4,42<br />
8 28 - e: Serie dei boschi di faggio del Fagion sylvaticae a mosaico con la serie del Physospermo-<br />
Quercetum petraeae<br />
2 4538,54 4,11<br />
9 65 - d: Serie dei boschi di roverella del Rubio-Quercetum pubescentis a mosaico con la serie del<br />
Physospermo-Quercetum petraeae<br />
2 3517,93 3,18<br />
10 28 - g: Serie dei boschi di faggio del Fagion sylvaticae a mosaico con la serie del Lathyro-<br />
Quercetum cerridis<br />
1 2826,85 2,56<br />
11 81 - Geosigmeti della vegetazione riparia e alluvionale (Salicetum incano-purpureae, Salicetum<br />
triandrae, Salicetum albae, Salici-Populetum nigrae, Aro-Alnetum)<br />
1 881,04 0,80<br />
12 86 - b: Serie dei boschi di leccio del Viburno tini-Quercetum ilicis:aspetti mesofili 1 741,35 0,67<br />
13 32 - a: Serie della faggeta appenninica ad Adenostyles australis su calcare (Trochiscantho-<br />
Fagetum)<br />
1 353,72 0,32<br />
area totale cella 817 110483,76<br />
210
Gli stadi della serie sono rappresentati da mantelli folti a ginestra dei carbonai, riferiti all’associazione Calluno-Sarothamnetum scoparii, che<br />
si arricchisce di specie termofile come Erica arborea e Cistus salvifolius (subassociazione ericetosum arboreae) nelle stazioni più xerofile e<br />
a quote altitudinali minori. Praterie a Bromus erectus, Trifolium incarnatum e Brachypodium rupestre (Trifolio-Brometum erecti), che spesso<br />
formano mosaici con lande basse a Genista pilosa, Erica carnea e Calluna vulgaris (Erico-Genistetum pilosae); tali brughiere colonizzano<br />
anche le radure dei boschi e i margini dei sentieri su terreni asciutti e moderatamente freschi.<br />
Tabella 195 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 791 di Castel di Casio (BO)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 53 - c: Mosaico dei querceti e ostrieti delle aree collinari emiliane orientali (Ostryo-Aceretum<br />
opulifolii plathantheretosum Ostryo-Aceretum opulifolii anemonetosum, Knautio purpureae-<br />
Quercetum pubescentis)<br />
3 47392,22 42,65<br />
2 29 - Serie nord-appennica delle cerrete acidofile con rovere e castagno (Teucrio scorodoniae-<br />
Castanetum sativae quercetosum cerris)<br />
6 22604,40 20,34<br />
3 23 - b: mosaico tra le serie dei boschi misti submontani dell'Emilia orientale (Dryopterido-<br />
Ostryetum e Ostryo-Aceretum opulifolii)<br />
9 17136,75 15,42<br />
4 9 - a: Serie nord-appenninica delle faggete eutrofiche (Cardamino heptaphyllae-Fagetum<br />
sylvaticae)<br />
5 12728,70 11,46<br />
5 9 - c: Mosaico di serie delle faggete termofile dell'Appennino emiliano orientale (Leucojo-<br />
Fagetum, Daphno laureolae-Fagetum)<br />
7 5547,71 4,99<br />
6 9 - b: Serie nord-appenninica delle faggete eutrofiche (Cardamino heptaphyllae-Fagetum<br />
sylvaticae) a mosaico con la serie nord-appenninica delle faggete acidofile microterme (Roso<br />
pendulinae-Fagetum sylvaticae)<br />
1 2089,19 1,88<br />
7 7 - a: Serie nord-appenninica delle faggete acidofile microterme (Roso pendulinae-Fagetum<br />
sylvaticae)<br />
2 1723,26 1,55<br />
8 89 - a: Geosigmeto ripariale e dei fondovalle alluvionali della regione temperata 1 803,29 0,72<br />
9 22 - a: Serie centronord-appenninica delle cerrete neutro-subacidofile submontane (Acero<br />
obtusati-Quercetum cerris)<br />
1 465,10 0,42<br />
10 2 - Serie nord-appenninica delle brughiere d’altitudine a mirtilli (Empetro-Vaccinietum) 1 262,41 0,24<br />
11 55 - Serie nordappenninica degli ostrieti mesoxerici (Daphno laureolae-Ostryetum carpinifoliae) 1 70,82 0,06<br />
area totale cella 791 111112,58<br />
211
Tabella 196 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 790 di Pievepelago (MO)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 29 - Serie nord-appennica delle cerrete acidofile con rovere e castagno (Teucrio scorodoniae-<br />
Castanetum sativae quercetosum cerris)<br />
5 27250,76 24,53<br />
2 9 - b: Serie nord-appenninica delle faggete eutrofiche (Cardamino heptaphyllae-Fagetum<br />
sylvaticae) a mosaico con la serie nord-appenninica delle faggete acidofile microterme (Roso<br />
pendulinae-Fagetum sylvaticae)<br />
1 16996,03 15,30<br />
3 7 - a: Serie nord-appenninica delle faggete acidofile microterme (Roso pendulinae-Fagetum<br />
sylvaticae)<br />
10 16612,58 14,95<br />
4 9 - c: Mosaico di serie delle faggete termofile dell'Appennino emiliano orientale (Leucojo-<br />
Fagetum, Daphno laureolae-Fagetum)<br />
1 15060,38 13,56<br />
5 23 - b: mosaico tra le serie dei boschi misti submontani dell'Emilia orientale (Dryopterido-<br />
Ostryetum e Ostryo-Aceretum opulifolii)<br />
4 13492,73 12,15<br />
6 53 - c: Mosaico dei querceti e ostrieti delle aree collinari emiliane orientali (Ostryo-Aceretum<br />
opulifolii plathantheretosum Ostryo-Aceretum opulifolii anemonetosum, Knautio purpureae-<br />
Quercetum pubescentis)<br />
4 4794,60 4,32<br />
7 21 - a: Serie apuana degli ostrieti mesofili (Roso caninae-Ostryetum carpinifoliae) 2 4368,48 3,93<br />
8 9 - a: Serie nord-appenninica delle faggete eutrofiche (Cardamino heptaphyllae-Fagetum<br />
sylvaticae)<br />
4 4122,74 3,71<br />
9 2 - Serie nord-appenninica delle brughiere d’altitudine a mirtilli (Empetro-Vaccinietum) 5 3753,86 3,55<br />
10 31 - a: Serie centro-appenninca meso-supratemperata dei boschi acidofili di rovere e cerro delle<br />
pianure fluvio lacustri e conche intermontane (Hieracio racemosi-Quercetum petraeae)<br />
2 3087,17 2,78<br />
11 37 - Serie delle cerrete mesoigrofile (Melico uniflorae-Quercetum cerris) dell'Italia centrale 1 1128,45 1,02<br />
12 89 - Geosigmeto ripariale e dei fondovalle alluvionali (Salicion albae, Populion albae, Alno-<br />
Ulmion, Carpinion betuli, Teucrio siculi-Quercion cerris)<br />
1 230,55 0,21<br />
area totale cella 790 111085,87<br />
La serie nord-appennica delle cerrete acidofile con rovere e castagno (Teucrio scorodoniae-Castanetum sativae quercetosum cerris) copre<br />
27.250,76 ettari, pari al 24,5% della superficie della cella. Si tratta di boschi a prevalenza di cerro con castagno e, più raramente rovere che<br />
costituiscono la tappa matura in vaste aree della Toscana settentrionale. Si sviluppano su litotipi arenacei o su anageniti, sempre su suolo<br />
acido. I boschi originari restano, fortemente antropizzati, solo in aree particolarmente ripide e marginali; altrove infatti sono stati trasformati<br />
prevalentemente in boschi di castagno o, più raramente, in colture agrarie. La marginalità economica di questi territori fa sì che, le aree<br />
agricole e pastorali siano prevalentemente in condizioni di abbandono e in fase di ricolonizzazione naturale.<br />
212
La cerreta acidofila Teucrio scorodoniae–Castanetum sativae quercetosum cerris si adatta a suoli superficiale e poveri di elementi nutritivi e<br />
si insedia dal limite inferiore della faggeta. Nel piano arboreo domina Quercus cerris, con Castanea sativa, Fagus sylvatica e, più raramente<br />
Quercus petraea; negli altrii piani Vaccinium myrtillus, Luzula pedemontana, Luzula nivea, Deshampsia flexuosa e Teucrium scorodonia. Gli<br />
stadi sostitutivi sono costituiti da Teucrio scorodoniae–Castanetum sativae, castagneto acidofilo; Erico arboreae–Quercetum cerridis,<br />
cerreta su suolo debolmente acido soggetto a forte inaridimento estivo; Sambuco nigrae–Robinietum pseudoacaciae, robinieto d’invasione in<br />
stazioni fresche e fertili.<br />
La serie delle cerrete mesoigrofile (Melico uniflorae-Quercetum cerris) è rappresentata da un bosco mesofilo di cerro su suoli profondi<br />
derivanti da litotipi diversi diffusi in zona temperata con precipitazioni elevate e legati prevalentemente alla fascia alto collinare e basso<br />
montana dove è presente in forma zonale in aree geografiche anche molto lontane tra loro (Lunigiana, Casentino, Val Tiberina, Colline<br />
Pisane, gruppo delle Cornate di Gerfalco – Colline Metallifere, parte meridionale del comprensorio amiatino). Il corteggio floristico<br />
dominato da specie mesofile e nemorali, mentre nelle aree montane su arenaria assumono un peso maggiore le entità subacidofile. I boschi di<br />
questa tipologia, pur edificati da una specie eliofila, sono chiusi e spesso stratificati per la presenza di un piano intermedio di entità sciafile<br />
(Carpinus betu lus) e/o tolleranti l’ombra come Sorbus torminalis, Malus sylvestris, Acer campestre, Ulmus minor e Crataegus oxyacantha.<br />
Melico uniflorae–Quercetum cerridis è una cerreta che predilige un suolo profondo, fertile, a reazione debolmente acida, legata,<br />
generalmente, a morfologia poco inclinata. Nel piano arboreo domina Quercus cerris con Carpinus betulus, Acer campestre; nei piani<br />
sottoposti Cornus mas, Corylus avellana, Crataegus sp.pl., Melica uniflora, Festuca heterophylla, Brachypodium sylvaticum, Anemone<br />
nemorosa,Euphorbia dulcis, E. amygdaloides.Gli stadi seriali sono un castagneto mesofilo moderatamente acidofilo su suolo profondo e<br />
ricco di elementi nutritivi in stazioni a morfologia poco inclinata (Symphyto tuberosi–Castanetum sativae); arbusteti a dominanza di ginestra<br />
dei carbonai, di colonizzazione dei pascoli su suoli a lieve acidità (Sarothamnion); Sambuco nigrae–Robinietum pseudoacaciae, robinieto<br />
d’invasione; Bromion erecti, prateria semimesofila compatta su suolo più evoluto del precedente in ambiente caldo e asciutto.<br />
Molinio -Arrhenatheretalia, prateria mesofila compatta su suolo evoluto in aree a morfologia dolce e soggetta a pascolamento e a sfalcio<br />
annuale.<br />
213
Tabella 197 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 789 di Fivizzano (MS)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA<br />
1 29 - Serie nord-appennica delle cerrete acidofile con rovere e castagno (Teucrio scorodoniae-<br />
Castanetum sativae quercetosum cerris)<br />
8 34239,41 30,83<br />
2 37 - Serie delle cerrete mesoigrofile (Melico uniflorae-Quercetum cerris) dell'Italia centrale 4 25219,99 22,71<br />
3 21 - a: Serie apuana degli ostrieti mesofili (Roso caninae-Ostryetum carpinifoliae) 8 11856,15 10,67<br />
4 9 - a: Serie nord-appenninica delle faggete eutrofiche (Cardamino heptaphyllae-Fagetum<br />
sylvaticae)<br />
4 11599,87 10,44<br />
5 9 - b: Serie nord-appenninica delle faggete eutrofiche (Cardamino heptaphyllae-Fagetum<br />
sylvaticae) a mosaico con la serie nord-appenninica delle faggete acidofile microterme (Roso<br />
pendulinae-Fagetum sylvaticae)<br />
6 7525,98 6,78<br />
6 31 - a: Serie centro-appenninca meso-supratemperata dei boschi acidofili di rovere e cerro delle<br />
pianure fluvio lacustri e conche intermontane (Hieracio racemosi-Quercetum petraeae)<br />
2 4962,75 4,47<br />
7 7 - a: Serie nord-appenninica delle faggete acidofile microterme (Roso pendulinae-Fagetum<br />
sylvaticae)<br />
2 2807,38 2,53<br />
8 89 - Geosigmeto ripariale e dei fondovalle alluvionali (Salicion albae, Populion albae, Alno-<br />
Ulmion, Carpinion betuli, Teucrio siculi-Quercion cerris)<br />
1 2543,29 2,29<br />
9 2 - Serie nord-appenninica delle brughiere d’altitudine a mirtilli (Empetro-Vaccinietum) 7 2252,94 2,03<br />
10 86 - d: Serie dei boschi di leccio del Viburno tini-Quercetum ilicis a mosaico con la serie del<br />
Lathyro-Quercetum cerridis<br />
1 1593,25 1,43<br />
11 81 - Geosigmeti della vegetazione riparia e alluvionale (Salicetum incano-purpureae, Salicetum<br />
triandrae, Salicetum albae, Salici-Populetum nigrae, Aro-Alnetum)<br />
1 1398,31 1,26<br />
12 95 - Geosigmeto delle dune consolidate e dei depositi interdunali (Fraxino-Quercetum roboris,<br />
Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae, Hydrocotylo-Alnetum glutinosae, Populion albae,<br />
Juncion maritimi, Magnocaricion elatae, Viburno tini-Quercetum ilicis)<br />
1 1042,45 0,94<br />
13 4 - Serie (apuana) delle praterie ipsofile discontinue (Seslerio tenuifoliae-Caricetum sempervirentis) 2 604,61 0,54<br />
14 9 - c: Mosaico di serie delle faggete termofile dell'Appennino emiliano orientale (Leucojo-<br />
Fagetum, Daphno laureolae-Fagetum)<br />
2 222,71 0,20<br />
15 1 - Geosigmeto appenninico della vegetazione d'altitudine del piano crio-orotemperato<br />
(Leontopodio-Elynenion, Arabidion Coeruleae, Thlaspienion stylosi, Salicion herbaceae)<br />
1 217,30 0,20<br />
16 94 - Geosigmeto costiero della vegetazione psammofila, retrodunale e alofila delle spiagge e dei<br />
sistemi dunari recenti (Cakiletea, Ammophiletea, Elichryso-Crucianelletea, Quercetea ilicis)<br />
1 217,04 0,20<br />
17 86 - b: Serie dei boschi di leccio del Viburno tini-Quercetum ilicis: aspetti mesofili 1 46,35 0,04<br />
area totale cella 789 111064,98<br />
214
Tabella 198 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 763 di Bagno di Romagna (FO)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 53 - b: Serie centro-nordappenninca mesotemperata neutro-basifila della roverella (Peucedano<br />
cervariae-Quercetum pubescentis) a mosaico con la serie dell'Ostryo-Aceretum opulifolii<br />
6 31745,90 28,41<br />
2 23 - c: Mosaico di serie dei boschi misti delle aree submontane interne della Romagna (Ostryo-<br />
Aceretum opulifolii, Euonymo latifolii-Fagion)<br />
6 24349,64 21,79<br />
3 37 - Serie delle cerrete mesoigrofile (Melico uniflorae-Quercetum cerris) dell'Italia centrale 3 19515,38 17,46<br />
4 9 - a: Serie nord-appenninica delle faggete eutrofiche (Cardamino heptaphyllae-Fagetum<br />
sylvaticae)<br />
3 12868,76 11,52<br />
5 9 - c: Mosaico di serie delle faggete termofile dell'Appennino emiliano orientale (Leucojo-<br />
Fagetum, Daphno laureolae-Fagetum)<br />
5 11014,29 9,86<br />
6 31 - a: Serie centro-appenninca meso-supratemperata dei boschi acidofili di rovere e cerro delle<br />
pianure fluvio lacustri e conche intermontane (Hieracio racemosi-Quercetum petraeae)<br />
1 4788,18 4,29<br />
7 22 - a: Serie centronord-appenninica delle cerrete neutro-subacidofile submontane (Acero<br />
obtusati-Quercetum cerris)<br />
3 4159,37 3,72<br />
8 9 - b: Serie nord-appenninica delle faggete eutrofiche (Cardamino heptaphyllae-Fagetum<br />
sylvaticae) a mosaico con la serie nord-appenninica delle faggete acidofile microterme (Roso<br />
pendulinae-Fagetum sylvaticae)<br />
1 2061,37 1,84<br />
9 7 - a: Serie nord-appenninica delle faggete acidofile microterme (Galeopsi-Fagetum) 3 856,21 0,77<br />
10 29 - Serie nord-appennica delle cerrete acidofile con rovere e castagno (Teucrio scorodoniae-<br />
Castanetum sativae quercetosum cerris)<br />
1 382,35 0,34<br />
area totale cella 763 111741,44<br />
La serie centro-nordappenninca mesotemperata neutro-basifila della roverella (Peucedano cervariae-Quercetum pubescentis) a mosaico con<br />
la serie dell'Ostryo-Aceretum opulifolii si estende nella cella 763 il 28,4% della superficie. Il substrato tipo è per lo più il flysch della classica<br />
formazione marnoso-arenacea romagnola, ma sono diffuse argille e marne.<br />
La serie dell’Ostryo-Aceretum opulifolii è già stata descritta per la cella 847 di Bobbio (PC). I boschi collinari del Laburno-Ostryion,<br />
rappresentati dall’associazione Ostryo-Aceretum opulifolii. La presenza di suoli moderatamente argillosi e un substrato abbastanza omogeneo<br />
(flysch della formazione marnosoarenacea) favoriscono le facies forestali miste di carpino nero e cerro. Gli stadi sostitutivi della serie sono<br />
costitutiti da mantelli e arbusteti dei Prunetalia spinosae, specialmente a Spartium junceum sui versanti caldi, e prati e pascoli post-colturali<br />
(Agropyretalia repentis/Brometalia erecti).<br />
Il mosaico di serie dei boschi misti delle aree submontane interne della Romagna (Ostryo-Aceretum opulifolii, Euonymo latifolii-Fagion)<br />
copre il 21,8% della cella 763. E’ diffuso sui rilievi della Romagna tra i 700 e i 1000 metri di quota e si trova in contatto con le faggete poste<br />
215
più in alto su suoli per lo più a debole grado di acidificazione. Sui versanti sono localizzati i boschi submontani mesofili di latifoglie miste<br />
dell’associazione Ostryo- Aceretum opulifolii (Laburno-Ostryion) di ricche di specie arboree come Ostrya carpinifolia, Quercus cerris,<br />
Fraxinus ornus, Acer opulifolium, Acer campestre, ecc.<br />
Negli avvallamenti si trovano ostrieti mesofili con faggio dell’Euonymo latifolii-Fagion mesofili e su suoli spiccatamente umidi, in impluvi e<br />
falde di detrito umide, caratterizzati dalla presenza d’Euonymus latifolius e varie specie nettamente mesofile, come Fagus sylvatica. Stadi<br />
della serie sono gli ostrieti pionieri meso-xerofili con Sesleria nitida var., tipici dei versanti scoscesi su detrito marnoso-acenaceo; mantelli e<br />
arbusteti dei Prunetalia spinosae; colonizzazione di prati e pascoli post-colturali (Agropyretalia repentis/Brometalia erecti).<br />
Sono poi descritte le 3 serie più estese nella successiva unità di campionamento 676 di Visso (MC).<br />
Nelle Marche la serie Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae, che qui copre il 32,9% della superficie, è presente prevalentemente sui<br />
versanti carbonatici boschi a dominanza di Ostrya carpinifolia , con presenza di specie caducifoglie nello strato arboreo tra cui: Fraxinus ornus,<br />
Acer obtusatum, Quercus pubescens s.l., Laburnum anagyroides, Sorbus aria, e Corylus avellana. Nello strato arbustivo: Coronilla emerus,<br />
Daphne laureola, Cornus mas, C.sanguinea, Prunus spinosa, Cytisus sessilifolius, Lonicera caprifolium, L. xylosteum, Malus sylvestris, Acer<br />
campestre, Juniperus communis, , ecc. Lo strato erbaceo è ricco di specie nemorali quali Scutellaria columnae, Helleborus bocconei, Melittis<br />
melissophyllum, Primula vulgaris, Lilium bulbiferum ssp. croceum, Lathyrus venetus, Viola reichenbachiana, Cyclamen repandum, C.<br />
hederifolium, Campanula trachelium, Digitalis micrantha, Euphorbia amygdaloides, Sanicula europea, ecc. I boschi riferiti a questa associazione<br />
hanno una valenza ecologica molto ampia per cui colonizzano ambienti notevolmente diversi nei quali si presentano in particolari aspetti che sono<br />
stati riferiti a particolari subassociazioni. Nei settori caratterizzati dalla presenza di clasti alloctoni su suolo umido ricco di humus si rinviene la<br />
subass. saxifragetosum rotundifoliae differenziata da Saxifraga rotundifolia, Doronicum columnae, Polypodium vulgare e Polystichum setiferum.<br />
In forma frammentaria e in posizioni rupestri, con suolo ricco di humus è invece presente la subass. buxetosum sempervirentis mentre gli ornoostrieti,<br />
anch’essi rupestri però su suoli notevolmente erosi o poco evoluti, sono differenziabili per la presenza, talvolta tapezzante di specie del<br />
genere Sesleria : seslerietosum nitidae e seslerietosum autumnalis. La subass. cytisetosum sessilifolii caratterizza invece gli orno-ostrieti termofili<br />
con abbondanza di Quercus pubescens nello strato arboreo.<br />
Gli stadi della serie sono costituiti da un prebosco a Laburnum anagyroides (Scutellario-Ostryetum carpinifoliae variante a Laburnum<br />
anagyroides), mantelli di vegetazione a dominanza di Spartium junceum, Cytisus sessilifolius,Coronilla emerus (Spartio juncei-Cytisetum<br />
sessilifolii, Lonicero etruscae-Prunetum mahaleb e Juniperus oxycedri-Cotinetum coggygriae), orli di vegetazione (Digitalidi micranthae-<br />
Peucedanetum verticillaris, Ptilostemo strictae-Melampyretum italici e Digitali micranthae-Helleboretum bocconei), praterie aridofile (Asperulo<br />
purpureae-Brometum erecti e Seslerio nitidae-Brometum erecti) e semimesofile (Brizo mediae Brometum erecti), vegetazione infestante (Knautio<br />
integrifoliae-Anthemidetum altissimae).<br />
La serie climatica centro-appenninica delle faggete neutrobasifile termofile (Lathyro veneti-Fagetum sylvaticae) si trova su tutti i rilievi<br />
calcarei delle dorsali marchigiana e umbro-marchigiana e del massiccio dei Monti Sibillini, a quote comprese tra 800-1000 e 1200 m.<br />
Lo stadio maturo è caratterizzato da boschi polifitici dominati da Fagus sylvatica con presenza nello strato arboreo di caducifoglie quali Acer<br />
obtusatum, Ostrya carpinifolia e Sorbus aria, nello strato erbaceo sono diffusi Lathyrus venetus, Cyclamen hederifolium, C. repandum, Viola<br />
reichenbachiana, Helleborus bocconei, Cardamine kitaibelii, C. enneaphyllos, Galanthus nivalis e Scilla bifolia. Tali faggete rappresentano<br />
l’aspetto di transizione tra gli orno-ostrieti dell’associazione Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae e le faggete più mesofile presenti alle<br />
216
quote superiori dell’associazione Cardamino kitaibelii-Fagetum sylvaticae; coesistono quindi elementi floristici del piano bioclimatico<br />
mesotemperato che si mescolano, in parte, con quelli propri del supratemperato. Sono stadi seriali il mantello mesofilo a Cornus mas e con<br />
Crataegus monogyna e C. levigata (aggr. a Crataegus levigata e Cornus mas) e gli orli di vegetazione a Digitalis micrantha e Helleborus bocconei<br />
(ass. Digitalidi micranthae-Helleboretum bocconei). La vegetazione erbacea è data da praterie governate a pratopascolo, emicriptofitiche, semimesofile,<br />
a dominanza di Bromus erectus e Briza media (ass. Brizo mediae-Brometum erecti) con Centaurea triumfetti, C. ambigua, Knautia<br />
purpurea, Trifolium ochroleucum, T. pratense ssp. pratense, Leontodon cichoraceus, Luzula campestris, Armeria canescens, ecc.<br />
La serie centro-appenninica delle faggete neutrobasifile microterme (Cardamino kitaibeli-Fagetum sylvaticae) occupa le maggiori superfici<br />
sui Monti Sibillini localizzandosi al di sopra dei 1200 m di quota. Costituisce la serie climacica diffusa sui rilievi calcarei, in rapporto<br />
all’esposizione dei versanti, e fino al limite superiore del bosco.Lo stadio maturo è rappresentato da una faggeta microterma, generalmente<br />
monospecifica che talvolta si arricchisce di alcune essenze arboree quali: Acer pseudoplatanus, Acer platanoides e Taxus baccata . Nello strato<br />
erbaceo sono diffuse Polystichum aculeatum, Cardamine enneaphyllos, Actaea spicata, Polygonatum multiflorum, Geranium nodosum.<br />
Gli stadi seriali sono costituiti da mantelli di vegetazione a Rhamnus alpina subsp. fallax (aggr. a Rhamnus alpina subsp. fallax) e orli a dominanza<br />
di Trifolium medium e T. ochroleucon (ass. Trifolietum medii-ochroleuci); praterie di contatto a dominanza di Sesleria apennina (ass. Carici<br />
humilis-Seslerietum apenninae) sovente invasa da un arbusteto eliofilo a Genista radiata mentre quelle in dinamica successionale appartengono<br />
all’associazione Brizo mediae-Brometum erecti.<br />
217
Tabella 199 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 676 di Visso (MC)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 24 - a: Serie appenninica submediterranea-mesotemperata degli ostrieti neutrobasifili (Scutellario<br />
columnae-Ostryetum carpinifoliae)<br />
11 37382,01 32,92<br />
2 15 - a: Serie centro-appenninica delle faggete neutrobasifile termofile (Lathyro veneti-Fagetum<br />
sylvaticae)<br />
8 25784,22 22,71<br />
3 8 - Serie centro-appenninica delle faggete neutrobasifile microterme (Cardamino kitaibeli-<br />
Fagetum sylvaticae)<br />
4 24706,96 21,76<br />
4 24 - d: Serie pre-Appenninica centrale submediterranea mesotemperata degli ostrieti a carpino<br />
orientale su substrati arenacei (Scutellario -Ostryetum carpinetosum)<br />
3 5923,10 5,22<br />
5 5 - a: Serie appenninica degli arbusteti altomontani a ginepro nano (Daphno-Juniperion nanae) 2 5424,39 4,78<br />
6 32 - b: Serie umbro-marchigiana delle cerrete silicicole e acidofile montane (Carici sylvaticae-<br />
Quercetum cerris) a mosaico con la serie dello Scutellario-Ostryetum<br />
2 5241,78 4,62<br />
7 53 - Serie centro-nordappenninca mesotemperata neutro-basifila della roverella (Peucedano<br />
cervariae-Quercetum pubescentis)<br />
2 2705,26 2,38<br />
8 32 - a: Serie umbro-marchigiana delle cerrete silicicole e acidofile montane (Carici sylvaticae-<br />
Quercetum cerris)<br />
3 1584,75 1,40<br />
9 86 - Geosigmeto centro-appenninico edafo-igrofilo azonale dei piani carsici montani<br />
(Potamion, Nymphaeion albae, Phragmition, Magnocaricion, Glycerio-Sparganion, Caricion<br />
davallianae, Salicion cinereae, Nardo-Agrostion tenuis, Cynosurion cristati, Ranunculion velutini)<br />
1 1057,16 0,93<br />
10 24 - c: Serie appenninica edafoxerofila dei boschi di roverella e carpino nero neutrobasifili<br />
(Scutellario -Ostryetum cytisetosum sessilifolii)<br />
2 943,70 0,83<br />
11 72 - b: Serie adriatico-occidentale calcicola mesomediterranea subumida e secca del leccio<br />
(Cyclamino hederifolii-Quercetum ilicis cyclaminetosum hederifolii) a mosaico con la serie del<br />
Cephalanthero longifoliae-Quercetum ilicis<br />
2 744,86 0,66<br />
12 89 - Geosigmeto ripariale e dei fondovalle alluvionali (Salicion albae, Populion albae, Alno-<br />
Ulmion, Carpinion betuli, Teucrio siculi-Quercion cerris)<br />
1 677,61 0,60<br />
13 22 - a: Serie centronord-appenninica delle cerrete neutro-subacidofile submontane (Acero<br />
obtusati-Quercetum cerris)<br />
1 435,06 0,38<br />
14 69 - Serie centro-nordappenninica delle leccete neutro-basifile miste a caducifoglie (Fraxino<br />
orni-Quercetum ilicis)<br />
3 372,77 0,33<br />
15 1 - Geosigmeto appenninico della vegetazione d'altitudine del piano crio-orotemperato<br />
(Leontopodio-Elynenion, Arabidion Coeruleae, Thlaspienion stylosi, Salicion herbaceae)<br />
1 364,57 0,32<br />
218
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
16 24 - b: Serie pre-appenninica settentrionale submediterranea-mesotemperata degli ostrieti su<br />
substrati argillosi (Scutellari)<br />
1 135,08 0,12<br />
17 90 - a: Geosigmeto di vegetazione dulcacquicola idrofitica ed elofitica (Charetea fragilis,<br />
Lemnetea minoris, Nymphaeion, Potamion pectinati, Magnocaricion elatae, Phragmition<br />
australis, Populion albae)<br />
1 73,59 0,06<br />
area totale cella 676 113556,84<br />
La serie centro-appenninica delle cerrete mesofile dei substrati torbiditici (Listero ovatae-Quercetum cerris) nella cella 646 di Cascia (PG)<br />
copre una superficie all’incirca equivalente (15,6%) della serie appenninica degli ostrieti neutrobasifili Scutellario columnae-Ostryetum<br />
carpinifoliae (15,1%). Si trova su Substrati torbiditici ad elevata componente pelitica, tra gli 800 e i 1300 metri. Nello stadio maturo la specie<br />
dominante nello strato più alto è Quercus cerris, accompagnato sporadicamente da elementi forestali pertinenti ai Fagetalia (Fagus sylvatica, Acer<br />
pseudoplatanus) e ai Quercetalia pubescentis (Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia). Lo strato arboreo inferiore è molto ricco e costituito<br />
prevalentemente da Prunus avium, Corylus avellana ed Acer campestre. A livello arbustivo domina Lonicera xylosteum, insieme con Lonicera<br />
caprifolium, Crataegus laevigata, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rosa arvensis e Rubus hirtus. Lo strato erbaceo è tipicamente mesofilo e<br />
caratterizzato floristicamente dalla abbondante presenza di orchidee, in particolare Listera ovata, Epipactis gr. helleborine, Cephalanthera rubra,<br />
Cephalanthera damasonium, e da altre entità nemorali tipiche dei querceti meso-eutrofici quali Salvia glutinosa, Aegopodium podagaria,<br />
Geranium nodosum.<br />
Nel dinamismo della serie sono presenti stadi arbustivi afferenti al Berberidion vulgaris, che in condizioni edafo-mesofile sono caratterizzati da<br />
Salix caprea, Rubus caesius e Viburnum lantana; in condizioni climatofile da Crataegus laevigata, Rosa canina, Rosa corymbifera e Prunus<br />
spinosa; in siti edafo-xerofili da Juniperus communis. Gli stadi erbacei sono costituiti da cenosi dell’Arrhenaterion e del Cynosurion per quanto<br />
concerne gli aspetti più mesici (frequenti Arrhenatherum elatior, Briza media, Cynosurus cristatus, Trisetum flavescens ecc.) e del Phleo-Bromion<br />
negli aspetti serici (Sesleria nitida, Bromus erectus, Onobrychis viciaefolia, Ononis spinosa, Brachypodium rupestre).<br />
219
Tabella 200 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 646 di Cascia (PG)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 8 - Serie centro-appenninica delle faggete neutrobasifile microterme (Cardamino kitaibeli-<br />
Fagetum sylvaticae)<br />
10 33336,44 29,22<br />
2 35 - Serie centro-appenninica delle cerrete mesofile dei substrati torbiditici (Listero ovatae-<br />
Quercetum cerris)<br />
1 17855,37 15,65<br />
3 24 - a: Serie appenninica submediterranea-mesotemperata degli ostrieti neutrobasifili<br />
(Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae)<br />
13 17270,88 15,14<br />
4 32 - b: Serie umbro-marchigiana delle cerrete silicicole e acidofile montane (Carici sylvaticae-<br />
Quercetum cerris) a mosaico con la serie dello Scutellario-Ostryetum<br />
2 11495,18 10,07<br />
5 12 - Serie centro-appenninica delle faggete acidofile (Solidagini-Fagetum sylvaticae) 3 8550,33 7,49<br />
6 87 - a: Geosigmeto centro-appenninico delle conche intermontane (Carpinion betuli, Cytiso-<br />
Quercenion, Laburno-Ostryenion)<br />
3 7318,18 6,41<br />
7 15 - a: Serie centro-appenninica delle faggete neutrobasifile termofile (Lathyro veneti-Fagetum<br />
sylvaticae)<br />
9 6712,61 5,88<br />
8 19 - Serie centro-sud appenninica delle cerrete mesofile meso-supratemperate (Geranio<br />
versicoloris-Fagion sylvaticae)<br />
1 3193,00 2,80<br />
9 54 - a: Serie dei boschi di roverella appenninici semicontinentali a: Cytiso sessilifolii-Quercetum<br />
pubescentis<br />
1 2310,59 2,02<br />
10 32 - a: Serie umbro-marchigiana delle cerrete silicicole e acidofile montane (Carici sylvaticae-<br />
Quercetum cerris)<br />
1 2288,20 2,01<br />
11 86 - Geosigmeto centro-appenninico edafo-igrofilo azonale dei piani carsici montani (Potamion,<br />
Nymphaeion albae, Phragmition, Magnocaricion, Glycerio-Sparganion, Caricion davallianae,<br />
Salicion cinereae, Nardo-Agrostion tenuis, Cynosurion cristati, Ranun<br />
1 1250,66 1,10<br />
12 25 - b: Serie dei boschi misti submontani a dominanza di carpino nero e cerro (Laburno-<br />
Ostryenion)<br />
1 526,49 0,46<br />
13 89 - Geosigmeto ripariale e dei fondovalle alluvionali (Salicion albae, Populion albae, Alno-<br />
Ulmion, Carpinion betuli, Teucrio siculi-Quercion cerris)<br />
1 423,33 0,37<br />
14 5 - a: Serie appenninica degli arbusteti altomontani a ginepro nano (Daphno-Juniperion nanae) 1 354,19 0,31<br />
15 24 - c: Serie appenninica edafoxerofila dei boschi di roverella e carpino nero neutrobasifili<br />
(Scutellario-Ostryetum cytisetosum sessilifolii)<br />
1 272,90 0,24<br />
16 89 - c: Serie azonale edafo-igrofila dei terrazzi fluviali antichi dell'Italia centrale 1 259,35 0,23<br />
17 69 - Serie centro-nordappenninica delle leccete neutro-basifile miste a caducifoglie (Fraxino<br />
orni-Quercetum ilicis)<br />
3 219,35 0,19<br />
220
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
18 24 - d: Serie pre-Appenninica centrale submediterranea mesotemperata degli ostrieti a carpino<br />
orientale su substrati arenacei (Scutellario -Ostryetum carpinetosum)<br />
1 217,04 0,19<br />
19 18 - a: Serie sud-appenninica delle faggete termofile (Anemono apenninae-Fagetum sylvaticae) 3 171,73 0,15<br />
20 3 - Serie centro-appenninica delle brughiere d’altitudine a mirtillo nero (Vaccinio-Hypericetum<br />
richeri)<br />
1 78,05 0,07<br />
area totale cella 646 114103,85<br />
221
Tabella 201 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 617 di Barisciano (AQ)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 54 - a: Serie dei boschi di roverella appenninici semicontinentali a: Cytiso sessilifolii-Quercetum<br />
pubescentis<br />
1 37660,00 32,83<br />
2 8 - Serie centro-appenninica delle faggete neutrobasifile microterme (Cardamino kitaibeli-<br />
Fagetum sylvaticae)<br />
5 23412,64 20,41<br />
3 18 - a: Serie sud-appenninica delle faggete termofile (Anemono apenninae-Fagetum sylvaticae) 6 21346,36 18,61<br />
4 5 - a: Serie appenninica degli arbusteti altomontani a ginepro nano (Daphno-Juniperion nanae) 3 16031,77 13,98<br />
5 25 - b: Serie dei boschi misti submontani a dominanza di carpino nero e cerro (Laburno-<br />
Ostryenion)<br />
4 6906,56 6,02<br />
6 87 - a: Geosigmeto centro-appenninico delle conche intermontane (Carpinion betuli, Cytiso-<br />
Quercenion, Laburno-Ostryenion)<br />
1 4340,85 3,78<br />
7 12 - Serie centro-appenninica delle faggete acidofile (Solidagini-Fagetum sylvaticae) 2 2543,22 2,22<br />
8 1 - Geosigmeto appenninico della vegetazione d'altitudine del piano crio-orotemperato<br />
(Leontopodio-Elynenion, Arabidion Coeruleae, Thlaspienion stylosi, Salicion herbaceae)<br />
6 1884,81 1,64<br />
9 19 - Serie centro-sud appenninica delle cerrete mesofile meso-supratemperate (Geranio<br />
versicoloris-Fagion sylvaticae)<br />
1 315,64 0,28<br />
10 58 - a: Serie appenninica centro-meridionale submediterranea e mesomediterranea neutrobasifila<br />
della roverella (Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis)<br />
2 274,70 0,24<br />
area totale cella 617 114716,54<br />
La serie dei boschi di roverella appenninici semicontinentali (Cytiso sessilifolii-Quercetum pubescentis) si estende in questa cella per 37660<br />
ettari. E’ diffusa nell’Abruzzo interno, soprattutto in corrispondenza delle conche intermontane, e predilige una discreta continentalità e i<br />
substrati calcarei della piattaforma mesozoica laziale -abruzzese, con suoli poco evoluti, nelle porzioni più elevate delle pianure alluvionali<br />
fluviali e fluvio-lacustri. Si tratta di boschi e le boscaglie del Cytiso sessilifolii-Quercetum pubescentis che si presentano generalmente come<br />
cenosi molto degradate. Prevale Quercus pubescens, cui si accompagnano poche altre specie arboree quali Fraxinus ornus, Acer campestre,<br />
ecc. Lo strato arbustivo è caratterizzato prevalentemente da Cytisus sessilifolius, Rosa canina, Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus, Cornus<br />
mas, mentre lo strato erbaceo è rappresentato prevalentemente da Brachypodium rupestre, Teucrium chamaedrys e Chamaecytisus<br />
spinescens, tutte specie eliofile indici del degrado strutturale in cui versano questi lembi residui di queste formazioni boschive, da sempre<br />
intensamente ceduate. L'associazione è inquadrata nell'alleanza Quercion pubescenti-petraeae, che riunisce i querceti ed i querceti misti a<br />
prevalenza di roverella su suoli neutri o basici, a carattere continentale o sub-continentale, con scarsa rappresentanza di elementi orientali.<br />
Elementi caratteristici sono Cytisus sessilifolius, Coronilla emerus subsp. emerus ed Helleborus foetidus. E’ presente, talvolta, Buxus<br />
sempervirens, che differenzia una subassociazione leggermente più mesofila.<br />
222
Le fitocenosi arboree di sostituzione sono arbusteti e mantelli collinari riferibili alle associazioni Spartio juncei-Cytisetum sessilifolii e<br />
Chamaecytiso spinescentis-Juniperetum oxycedri (alleanza Cytision sessilifolii), talora in aspetti differenziati da Buxus sempervirens.<br />
Tabella 202 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 616 di Petrella Salto (RI)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 8 - Serie centro-appenninica delle faggete neutrobasifile microterme (Cardamino kitaibeli-<br />
Fagetum sylvaticae)<br />
8 20081,51 17,52<br />
2 15 - a: Serie centro-appenninica delle faggete neutrobasifile termofile (Lathyro veneti-Fagetum<br />
sylvaticae)<br />
5 19951,18 17,40<br />
3 18 - a: Serie sud-appenninica delle faggete termofile (Anemono apenninae-Fagetum sylvaticae) 5 13585,23 11,85<br />
4 27 - Serie centro-sudappenninica dei boschi submontani neutro-basifili di cerro e roverella<br />
(Daphno laureolae-Quercetum cerris)<br />
2 11582,52 10,10<br />
5 24 - a: Serie appenninica submediterranea-mesotemperata degli ostrieti neutrobasifili (Scutellario<br />
columnae-Ostryetum carpinifoliae)<br />
8 10528,02 9,18<br />
6 25 - a: Serie centro-appenninica neutrobasifila dei boschi misti submontani (Melittto-Ostryetum<br />
capinifoliae)<br />
3 9084,51 7,92<br />
7 54 - a: Serie dei boschi di roverella appenninici semicontinentali a: Cytiso sessilifolii-Quercetum<br />
pubescentis<br />
8 7632,40 6,66<br />
8 87 - a: Geosigmeto centro-appenninico delle conche intermontane (Carpinion betuli, Cytiso-<br />
Quercenion, Laburno-Ostryenion)<br />
2 6621,93 5,78<br />
9 25 - b: Serie dei boschi misti submontani a dominanza di carpino nero e cerro (Laburno-<br />
Ostryenion)<br />
3 5682,30 4,96<br />
10 35 - Serie centro-appenninica delle cerrete mesofile dei substrati torbiditici (Listero ovatae-<br />
Quercetum cerris)<br />
4 4571,08 3,99<br />
11 19 - Serie centro-sud appenninica delle cerrete mesofile meso-supratemperate (Geranio<br />
versicoloris-Fagion sylvaticae)<br />
3 2658,44 2,32<br />
12 5 - a: Serie appenninica degli arbusteti altomontani a ginepro nano (Daphno-Juniperion nanae) 3 1025,51 0,89<br />
13 58 - a: Serie appenninica centro-meridionale submediterranea e mesomediterranea neutrobasifila<br />
della roverella (Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis)<br />
1 185,47 0,16<br />
14 12 - Serie centro-appenninica delle faggete acidofile (Solidagini-Fagetum sylvaticae) 1 96,75 0,08<br />
15 89 - Geosigmeto ripariale e dei fondovalle alluvionali (Salicion albae, Populion albae, Alno-<br />
Ulmion, Carpinion betuli, Teucrio siculi-Quercion cerris)<br />
1 35,56 0,03<br />
area totale cella 616 114647,70<br />
223
Ancora in riferimento alla serie Cytiso sessilifolii-Quercetum pubescentis, n contatto seriale con queste sono i pascoli emicriptofitici<br />
dell'alleanza appenninica Phleo ambigui- Bromion erecti, riferibili, a seconda dell'ambito geografico e delle caratteristiche climatiche e<br />
pedologiche, a differenti associazioni: Asperulo purpureae-Brometum erecti; Seselio -Viarum-Brometum erecti linarietosum purpureae,<br />
Globulario meridionalis-Stipetum capillatae; Linotommasini-Stipetum apenninicolae. Vi sono anche garighe collinari e basso-montane<br />
riferibili a diverse associazioni: Saturejo montanae-Brometum erecti, senza dubbio la più rappresentata sui versanti caldi e soleggiati esposti<br />
ai quadranti meridionali; Saturejo montanae-Salvietum angustifoliae e Sideritido italicae-Phlomidetum fruticosae, entrambe presenti<br />
esclusivamente nell'area del Fucino e sul M. Salviano. In serie con le garighe sono i pascoli terofitici dell'alleanza Trachinion distachiae,<br />
soprattutto nelle porzioni poste a quote più basse. Le fitocenosi terofitiche sono rappresentate da comunità erbacee infestanti le colture della<br />
classe Stellarietea mediae, che per abbandono dei campi evolvono verso comunità nitrofilo-ruderali perenni del Dauco- Melilotion.<br />
Tabella 203 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 588 di Sulmona (AQ)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 18 - a: Serie sud-appenninica delle faggete termofile (Anemono apenninae-Fagetum sylvaticae) 4 36303,21 31,48<br />
2 8 - Serie centro-appenninica delle faggete neutrobasifile microterme (Cardamino kitaibeli-Fagetum<br />
sylvaticae)<br />
7 24072,69 20,87<br />
3 58 - a: Serie appenninica centro-meridionale submediterranea e mesomediterranea neutrobasifila<br />
della roverella (Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis)<br />
1 13236,17 11,48<br />
4 54 - a: Serie dei boschi di roverella appenninici semicontinentali a: Cytiso sessilifolii-Quercetum<br />
pubescentis<br />
8 10980,59 9,52<br />
5 26 - Serie centroappenninica dei boschi misti collinari di caducifoglie a locale dominanza di<br />
roverella, cerro o carpino nero (Ostryo-Carpinion)<br />
6 8811,40 7,64<br />
6 25 - b: Serie dei boschi misti submontani a dominanza di carpino nero e cerro (Laburno-<br />
Ostryenion)<br />
5 6428,38 5,57<br />
7 6 - Serie appennica degli arbusteti altomontani a pino mugo (Epipactido atropurpureae-Pinion mugo) 1 4866,87 4,22<br />
8 87 - a: Geosigmeto centro-appenninico delle conche intermontane (Carpinion betuli, Cytiso-<br />
Quercenion, Laburno-Ostryenion)<br />
1 4411,79 3,83<br />
9 1 - Geosigmeto appenninico della vegetazione d'altitudine del piano crio-orotemperato<br />
(Leontopodio-Elynenion, Arabidion Coeruleae, Thlaspienion stylosi, Salicion herbaceae)<br />
1 3448,69 2,99<br />
10 5 - a: Serie appenninica degli arbusteti altomontani a ginepro nano (Daphno-Juniperion nanae) 3 1834,65 1,59<br />
11 19 - Serie centro-sud appenninica delle cerrete mesofile meso-supratemperate (Geranio<br />
versicoloris-Fagion sylvaticae)<br />
1 915,91 0,79<br />
12 42 - a: Serie delle cerrete mesofile dei depositi piroclastici (Coronillo emeri-Quercetum cerris)<br />
dell'Italia centrale<br />
1 25,01 0,02<br />
area totale cella 588 115335,34<br />
224
Tabella 204 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 587 di Celano (AQ)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 54 - a: Serie dei boschi di roverella appenninici semicontinentali a: Cytiso sessilifolii-Quercetum<br />
pubescentis<br />
4 44221,92 38,37<br />
2 18 - a: Serie sud-appenninica delle faggete termofile (Anemono apenninae-Fagetum sylvaticae) 7 19518,53 16,93<br />
3 87 - a: Geosigmeto centro-appenninico delle conche intermontane (Carpinion betuli, Cytiso-<br />
Quercenion, Laburno-Ostryenion)<br />
1 15037,35 13,05<br />
4 25 - b: Serie dei boschi misti submontani a dominanza di carpino nero e cerro (Laburno-Ostryenion) 4 14779,46 12,82<br />
5 8 - Serie centro-appenninica delle faggete neutrobasifile microterme (Cardamino kitaibeli-Fagetum<br />
sylvaticae)<br />
11 12205,82 10,59<br />
6 5 - a: Serie appenninica degli arbusteti altomontani a ginepro nano (Daphno-Juniperion nanae) 5 9379,03 8,14<br />
7 24 - a: Serie appenninica submediterranea-mesotemperata degli ostrieti neutrobasifili (Scutellario<br />
columnae-Ostryetum carpinifoliae)<br />
1 66,64 0,06<br />
8 26 - Serie centroappenninica dei boschi misti collinari di caducifoglie a locale dominanza di<br />
roverella, cerro o carpino nero (Ostryo-Carpinion)<br />
1 27,55 0,02<br />
9 15 - a: Serie centro-appenninica delle faggete neutrobasifile termofile (Lathyro veneti-Fagetum<br />
sylvaticae)<br />
1 21,91 0,02<br />
area totale cella 587 115258,20<br />
Le serie più estese (Anemono apenninae-Fagetum sylvaticae, Cardamino kitaibeli-Fagetum sylvaticae) presenti nelle celle 588 di Sulmona,<br />
587 di Celano, 558 di Barrea tutte nella provincia aquilana sono già state descritte (in particolare la sud-appenninica delle faggete termofile è<br />
stata esaminata nell’analisi di dettaglio condotta nell’area campione 559 Castelverrino (IS) dell’Alto Molise.<br />
Viene qui descritta la serie centro-appenninica neutrobasifila dei boschi misti submontani (Melittto-Ostryetum capinifoliae) che nell’unità<br />
campione 586 di Pereto copre il 18,1% della superficie.<br />
In questa unità sono state cartografate comunità di querceto misto probabilmente suddivisibili in due aspetti, uno a carattere submontano,<br />
maggiormente mesofilo, ed uno termofilo delle aree collinari. Allo stato delle attuali conoscenze vegetazionali non sono stati ancora precisati i<br />
rispettivi ambiti potenziali ed un più preciso riferimento sintassonomico. In generale, anche in un singolo popolamento la fisionomia a è costituita<br />
da numerose essenze arboree: Quercus pubescens, Quercus cerris, Ostrya carpinifolia, Acer obtusatum. Lo strato arboreo inferiore prevede fra gli<br />
altri Fraxinus ornus, Acer campestre, Pyrus piraster, Sorbus torminalis. Negli aspetti più mesofili sono presenti Tilia platyphyllos, Laburnum<br />
anagyroides, Carpinus betulus, Sorbus aria. Negli aspetti più termofili divengono più frequenti Quercus pubescens e Carpinus orientalis, e<br />
sporadicamente Cercis siliquastrum e Acer monspessulanum.<br />
Il Melittio-Ostryetum può degradare per effetto del taglio verso comunità riferibili allo Scutellario-Ostryetum. I mantelli sono generalmente<br />
afferenti al Berberidion (nelle stazioni più alte in quota o su suoli più profondi), o al Cytision sessilifolii (su suoli più poveri). Le praterie fanno<br />
riferimento al Cynosurion ed al Phleo-Bromion.<br />
225
Tabella 205 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 586 di Pereto (AQ)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 25 - a: Serie centro-appenninica neutrobasifila dei boschi misti submontani (Melittto-Ostryetum<br />
capinifoliae)<br />
5 20894,41 18,14<br />
2 8 - Serie centro-appenninica delle faggete neutrobasifile microterme (Cardamino kitaibeli-Fagetum<br />
sylvaticae)<br />
4 18540,23 16,10<br />
3 18 - a: Serie sud-appenninica delle faggete termofile (Anemono apenninae-Fagetum sylvaticae) 2 17019,98 14,78<br />
4 25 - b: Serie dei boschi misti submontani a dominanza di carpino nero e cerro (Laburno-<br />
Ostryenion)<br />
4 12041,95 10,45<br />
5 27 - Serie centro-sudappenninica dei boschi submontani neutro-basifili di cerro e roverella<br />
(Daphno laureolae-Quercetum cerris)<br />
9 9509,80 8,26<br />
6 24 - a: Serie appenninica submediterranea-mesotemperata degli ostrieti neutrobasifili (Scutellario<br />
columnae-Ostryetum carpinifoliae)<br />
15 9185,87 7,97<br />
7 54 - a: Serie dei boschi di roverella appenninici semicontinentali a: Cytiso sessilifolii-Quercetum<br />
pubescentis<br />
4 7693,75 6,68<br />
8 35 - Serie centro-appenninica delle cerrete mesofile dei substrati torbiditici (Listero ovatae-<br />
Quercetum cerris)<br />
2 5301,83 4,60<br />
9 15 - a: Serie centro-appenninica delle faggete neutrobasifile termofile (Lathyro veneti-Fagetum<br />
sylvaticae)<br />
9 5279,20 4,58<br />
10 87 - a: Geosigmeto centro-appenninico delle conche intermontane (Carpinion betuli, Cytiso-<br />
Quercenion, Laburno-Ostryenion)<br />
1 4303,74 3,74<br />
11 89 - Geosigmeto ripariale e dei fondovalle alluvionali (Salicion albae, Populion albae, Alno-<br />
Ulmion, Carpinion betuli, Teucrio siculi-Quercion cerris)<br />
4 2843,77 2,47<br />
12 69 - Serie centro-nordappenninica delle leccete neutro-basifile miste a caducifoglie (Fraxino orni-<br />
Quercetum ilicis)<br />
4 1226,72 1,06<br />
13 5 - a: Serie appenninica degli arbusteti altomontani a ginepro nano (Daphno-Juniperion nanae) 4 537,45 0,47<br />
14 87 - b: Serie centro-appenninica dei querco-carpineti delle conche intermontane (Carpinion betuli) 1 445,05 0,39<br />
15 58 - a: Serie appenninica centro-meridionale submediterranea e mesomediterranea neutrobasifila<br />
della roverella (Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis)<br />
1 302,62 0,26<br />
area totale cella 586 115188,36<br />
226
Tabella 206 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 558 di Barrea (AQ)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 8 - Serie centro-appenninica delle faggete neutrobasifile microterme (Cardamino kitaibeli-Fagetum<br />
sylvaticae)<br />
4 41463,98 35,78<br />
2 18 - a: Serie sud-appenninica delle faggete termofile (Anemono apenninae-Fagetum sylvaticae) 7 20844,96 17,99<br />
3 27 - Serie centro-sudappenninica dei boschi submontani neutro-basifili di cerro e roverella (Daphno<br />
laureolae-Quercetum cerris)<br />
4 17148,07 14,80<br />
4 5 - a: Serie appenninica degli arbusteti altomontani a ginepro nano (Daphno-Juniperion nanae) 4 9200,33 7,94<br />
5 19 - Serie centro-sud appenninica delle cerrete mesofile meso-supratemperate (Geranio versicoloris-<br />
Fagion sylvaticae)<br />
1 7109,08 6,14<br />
6 15 - a: Serie centro-appenninica delle faggete neutrobasifile termofile (Lathyro veneti-Fagetum<br />
sylvaticae)<br />
3 3925,30 3,39<br />
7 25 - b: Serie dei boschi misti submontani a dominanza di carpino nero e cerro (Laburno-Ostryenion) 1 3899,93 3,37<br />
8 24 - a: Serie appenninica submediterranea-mesotemperata degli ostrieti neutrobasifili (Scutellario<br />
columnae-Ostryetum carpinifoliae)<br />
2 3747,49 3,23<br />
9 25 - a: Serie centro-appenninica neutrobasifila dei boschi misti submontani (Melittto-Ostryetum<br />
capinifoliae)<br />
5 3340,35 2,88<br />
10 87 - a: Geosigmeto centro-appenninico delle conche intermontane (Carpinion betuli, Cytiso-<br />
Quercenion, Laburno-Ostryenion)<br />
1 2397,52 2,07<br />
11 89 - Geosigmeto ripariale e dei fondovalle alluvionali (Salicion albae, Populion albae, Alno-Ulmion,<br />
Carpinion betuli, Teucrio siculi-Quercion cerris)<br />
4 2074,26 1,79<br />
12 90 - a: Geosigmeto di vegetazione dulcacquicola idrofitica ed elofitica (Charetea fragilis, Lemnetea<br />
minoris, Nymphaeion, Potamion pectinati, Magnocaricion elatae, Phragmition australis, Populion<br />
albae)<br />
1 488,48 0,42<br />
13 48 - a: Serie centro-sud-appenninica dei boschi di cerro e farnetto (Echinopo siculi-Quercetum<br />
frainetto)<br />
1 73,95 0,06<br />
area totale cella 558 115876,37<br />
227
Tabella 207 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 413 di San Martino d’Agri (PZ)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA<br />
1 49 - Serie sud-appenninica delle cerrete mesofile neutro-subacidofile (Physospermo verticillati-<br />
Quercetum cerris)<br />
4 48443,72 40,69<br />
2 50 - Serie sud-appenninica delle cerrete termofile neutro-subacidofile (Lathyro digitati-Quercetum<br />
cerris)<br />
5 42237,12 35,48<br />
3 93 - Geosigmeto ionico mesomediterraneo secco-subumido delle aree soggette ad erosionecalanchiva<br />
(Camphorosmo monspeliaceae-Lygetum sparti, Camphorosmo monspeliacae - Atriplicetum halimi,<br />
Cardopato corymbosi- Lygetum sparti, Arundinetum plinianae, Helictotricho convoluti-Pistacetum<br />
lentisci ecc.)<br />
5 11340,77 9,53<br />
4 18 - a: Serie sud-appenninica delle faggete termofile (Anemono apenninae-Fagetum sylvaticae) 6 7727,20 6,49<br />
5 89 - Geosigmeto ripariale e dei fondovalle alluvionali (Salicion albae, Populion albae, Alno-Ulmion,<br />
Carpinion betuli, Teucrio siculi-Quercion cerris)<br />
7 3758,81 3,16<br />
6 28 - Serie sud-appenninica degli ostrieti neutro-basifili submontani con Melittis albida (Melitto<br />
albidae-Ostryetum carpinifoliae)<br />
1 3266,84 2,74<br />
7 17 - Serie sud-appenninica delle faggete microterme (Campanulo trichocalycinae-Fagetum<br />
sylvaticae)<br />
6 1585,59 1,33<br />
8 5 - a: Serie appenninica degli arbusteti altomontani a ginepro nano (Daphno-Juniperion nanae) 1 73,75 0,06<br />
area totale cella 413 119054,34<br />
La serie sud-appenninica delle cerrete mesofile neutro-subacidofile (Physospermo verticillati-Quercetum cerris) è la più estesa nelle celle 413<br />
di San Martino d’Agri e 383 di Rotonda (PZ).<br />
Generalmente fra gli 800 e i 1200 m circa (talora fino a 1400 m), predilige rilievi dei substrati flyschoidi argilloso-arenacei; anche rilievi marnosi e<br />
sull’edificio vulcanico del Vulture. E’ una comunità caratterizzata dalla dominanza di specie forestali dei Quercetalia pubescentipetraeae<br />
accompagnate da un ricco contingente erbaceo dei Fagetalia . Discreto è il contingente di specie a distribuzione italica limitata al settore meridionale<br />
(Melittis albida, Lathyrus grandiflorum, Huetia cynapioides, Doronicum orientale, Euphorbia corallioides, Heptaptera angustifolia, Euonymus<br />
verrucosus). Di particolare interesse è la tipica subassociazione ad Abies alba presente nei pressi di Laurenzana e Ruoti; all’abete si accompagna<br />
sporadicamente anche Fagus sylvatica. Le fitocenosi seriali sono costituitte da arbusteti del Berberidion a Rosa obtusifolia, Rosa nitidula e Prunus<br />
spinosa, praterie a Bromus erectus e Brachypodium rupestre del Bromion erecti.<br />
Lathyro digitati-Quercetum cerris e Melitto albidae-Ostryetum carpinifoliae sono le serie di vegetazione più estese nella unità di<br />
campionamento 412 di Sanza (SA), con valori di copertura rispettivamente del 20,1 e 18,2%.<br />
Lathyro digitati-Quercetum cerris occupa i rilievi collinari dei settori orientale e meridionale della Regione, generalmente tra i 500 e gli 800 m. Lo<br />
stadio maturo è rappresentato da boschi misti di querce caducifoglie (Quercus cerris, Q. frainetto, Q. virgiliana, Q. pubescens) relativamente termofili<br />
228
con sottobosco caratterizzato da Lathyrus jordanii, Anthoxanthum odoratum, Teucrium siculum, Cytisus villosus, Sedum tenuifolium, Malus<br />
florentina, Pulicaria odora. In alcuni casi Quercus frainetto può assumere un ruolo codominante al cerro. Rappresentano stadi seriali la vegetazione<br />
arbustiva a Prunus spinosa, Rubus ulmifolius e Spartium junceum (Pruno-Rubion ulmifolii); i pascoli e prati-pascoli antropogeni a Trifolium<br />
nigrescens, Medicago hispida, Dactylis glomerata subsp.glomerata , Scorpiurus muricatus (Cynosurion cristati).<br />
Tabella 208 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 412 di Sanza (SA)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 50 - Serie sud-appenninica delle cerrete termofile neutro-subacidofile (Lathyro digitati-Quercetum<br />
cerris)<br />
4 23883,57 20,08<br />
2 28 - Serie sud-appenninica degli ostrieti neutro-basifili submontani con Melittis albida (Melitto<br />
albidae-Ostryetum carpinifoliae)<br />
10 21708,02 18,25<br />
3 18 - a: Serie sud-appenninica delle faggete termofile (Anemono apenninae-Fagetum sylvaticae) 7 21474,69 18,06<br />
4 49 - Serie sud-appenninica delle cerrete mesofile neutro-subacidofile (Physospermo verticillati-<br />
Quercetum cerris)<br />
9 16227,19 13,64<br />
5 64 - a: Serie sud-appenninica mesomediterranea acidofila della quercia virgiliana e dell'erica arborea<br />
(Erico-Quercetum virgilianae)<br />
2 9793,59 8,23<br />
6 54 - b: Serie dei boschi di roverella appenninici semicontinentali Cytiso-Quercenion 1 8863,04 7,45<br />
7 69 - Serie centro-nordappenninica delle leccete neutro-basifile miste a caducifoglie (Fraxino orni-<br />
Quercetum ilicis)<br />
2 5108,21 4,30<br />
8 87 - a: Geosigmeto centro-appenninico delle conche intermontane (Carpinion betuli, Cytiso-<br />
Quercenion, Laburno-Ostryenion)<br />
1 3208,94 2,70<br />
9 89 - Geosigmeto ripariale e dei fondovalle alluvionali (Salicion albae, Populion albae, Alno-Ulmion,<br />
Carpinion betuli, Teucrio siculi-Quercion cerris)<br />
3 3159,80 2,66<br />
10 17 - Serie sud-appenninica delle faggete microterme (Campanulo trichocalycinae-Fagetum<br />
sylvaticae)<br />
4 3099,20 2,61<br />
11 58 - a: Serie appenninica centro-meridionale submediterranea e mesomediterranea neutrobasifila<br />
della roverella (Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis)<br />
2 2068,35 1,74<br />
12 5 - a: Serie appenninica degli arbusteti altomontani a ginepro nano (Daphno-Juniperion nanae) 2 173,20 0,15<br />
13 92 – a: Geosigmeto termo-mesomediterraneo della vegetazione delle fiumare. Articolazione catenale<br />
in relazione alla profonditÓ della falda freatica ed al disturbo arrecato dalle piene (Artemisio-<br />
Helicrysetum italici, Nerion oleandri, Tamarici africanae-Viticetum agni-casti)<br />
1 165,99 0,14<br />
area totale cella 412 118933,78<br />
229
Melitto albidae-Ostryetum carpinifoliae si trova su versanti calcarei. Si tratta, allo stadio maturo, di fitocenosi forestali legate a versanti piuttosto<br />
ripidi caratterizzati dalla costante presenza di CaCO3 nel substrato. Lo strato arboreo è normalmente dominato da Ostrya carpinifolia e<br />
subordinatamente da Fraxinus ornus mentre Acer obtusatum diviene abbondante soprattutto in corrispondenza di valli profondamente incassate. Nello<br />
strato erbaceo risulta caratterizzante Festuca exaltata che rappresenta un chiaro termine di discontinuità cenologica e biogeografica verso gli ornoostrieti<br />
dell’Appennino centrale. In corrispondenza di localizzate emergenze rupestri assume un importante ruolo costruttivo Quercus ilex. Stadi<br />
seriali sono i mantelli del Berberidion principalmente caratterizzati da Cornus mas, Pyrus piraster e Crataegus laevigata, praterie del Phleo-Bromion<br />
con locale abbondanza di Artemisia alba.<br />
230
Tabella 209 - Copertura delle serie (e/o dei geosigmeti) nella cella 383 di Rotonda (PZ)<br />
PROGR DESCR COUNT SUM_HA %<br />
1 49 - Serie sud-appenninica delle cerrete mesofile neutro-subacidofile (Physospermo verticillati-<br />
Quercetum cerris)<br />
1 30511,92 25,52<br />
2 18 - a: Serie sud-appenninica delle faggete termofile (Anemono apenninae-Fagetum sylvaticae) 7 23652,89 19,78<br />
3 70 - b: Serie mesomediterranea umida basifila del leccio (Festuco exaltatae-Quercetum ilicis) a<br />
mosaico con la serie del Roso-Quercetum pubescentis<br />
5 22997,65 19,23<br />
4 70 - a: Serie mesomediterranea umida basifila del leccio (Festuco exaltatae-Quercetum ilicis) 2 13285,01 11,11<br />
5 28 - Serie sud-appenninica degli ostrieti neutro-basifili submontani con Melittis albida (Melitto<br />
albidae-Ostryetum carpinifoliae)<br />
1 6855,56 5,73<br />
6 65 - a: Serie sud-appenninica termomediterranea della quercia virgiliana e dell'olivastro (Oleo-<br />
Quercetum virgilianae)<br />
1 6796,62 5,68<br />
7 17 - Serie sud-appenninica delle faggete microterme (Campanulo trichocalycinae-Fagetum sylvaticae) 2 6236,13 5,22<br />
8 51 - b: Serie sud-appenninica dei boschi acidofili supramediterranei di farnetto (Cytiso villosi-<br />
Quercetum frainetto) a mosaico con la serie dell'Erico-Quercetum vigilianae<br />
1 2455,05 2,05<br />
9 50 - Serie sud-appenninica delle cerrete termofile neutro-subacidofile (Lathyro digitati-Quercetum<br />
cerris)<br />
2 1791,19 1,50<br />
10 62 - Serie ionica costiera mesomediterranea secca della roverella su depositi argillosi (Lauro-<br />
Quercenion)<br />
1 1687,56 1,41<br />
11 64 - b: Serie sud-appenninica mesomediterranea acidofila della quercia virgiliana e dell'erica arborea<br />
(Erico-Quercetum virgilianae) a mosaico con la Serie sud-appenninica delle sugherete acidofile<br />
termo-mesomediterraneee (Helleboro-Quercetum suberis)<br />
1 1218,71 1,02<br />
12 89 - Geosigmeto ripariale e dei fondovalle alluvionali (Salicion albae, Populion albae, Alno-Ulmion,<br />
Carpinion betuli, Teucrio siculi-Quercion cerris)<br />
1 886,71 0,74<br />
13 5 - b: Serie appenninica degli arbusteti altomontani a ginepro nano (Daphno-Juniperion nanae) a<br />
mosaico con la Serie del pino loricato (Junipero-Pinetum leucodermis)<br />
3 613,73 0,51<br />
14 93 - Geosigmeto ionico mesomediterraneo secco-subumido delle aree soggette ad erosione<br />
calanchiva (Camphorosmo monspeliaceae-Lygetum sparti, Camphorosmo monspeliacae - Atriplicetum<br />
halimi, Cardopato corymbosi- Lygetum sparti, Arundinetum plinianae, Helictotricho convoluti-<br />
Pistacetum lentisci ecc.)<br />
2 305,93 0,26<br />
15 5 - a: Serie appenninica degli arbusteti altomontani a ginepro nano (Daphno-Juniperion nanae) 1 155,97 0,13<br />
16 88 - Geosigmeto meridionale ripariale edafoigrofilo e planiziale dei boschi a ontano, farnia (Alno-<br />
Quercion roboris) e pioppo bianco (Populion albae)<br />
1 129,42 0,11<br />
area totale cella 383 119580,02<br />
231
Considerando l’estensione media delle unità di campionamento, si osserva di norma una elevata diversità fitocenotica su superfici inferiori a<br />
quelle provinciali.<br />
E’ possibile utilizzare l’estensione della serie di vegetazione come criterio selettivo laddove questa risulti relazionabile a specifiche azioni di<br />
conservazione. Vengono presentati due esempi in cui il numero delle serie di vegetazione si riduce significativamente in funzione dell’area<br />
prescelta. Si tratta di due celle siciliane, in cui il numero delle serie da 15 (stesso valore di partenza per entrambe) scende:<br />
- a 8 nella cella 169 di Mistretta (ME) e a 6 nella cella 170 di Bronte (CT) con un filtro a 500 ettari (Tabella 210);<br />
- a 6 e 3 con un filtro a 1000 ettari (Tabella 211).<br />
Tabella 210 - Variabilità delle serie nelle due celle ubicate in Sicilia (filtro 500 ha)<br />
GRIGLIA_ID Serie di vegetazione Area (ha) N° serie<br />
Ilici-Quercetum petraeae 568,34<br />
Quercetum leptobalanae 950,03<br />
Oleo-Quercetum virgilianae 3.046,25<br />
169<br />
Genisto aristate-Quercetum suberis<br />
Sorbo torminalis-Quercetum virgilianae<br />
4.227,12<br />
5.601,94<br />
8<br />
Arrhenathero nebrodensis-Quercetum cerridis 9.332,51<br />
Festuco heterophyllae-Quercetum congestae 15.439,62<br />
170<br />
Quercetum gussonei 20.110,17<br />
Oleo-Quercetum virgilianae 655,98<br />
Arabido-Quercetum congestae 859,21<br />
Agropyro panormitani-Quercetum congestae 924,15<br />
Arrhenathero nebrodensis-Quercetum cerridis 4.198,22<br />
Quercetum gussonei 8.273,99<br />
Festuco heterophyllae-Quercetum congestae 25.173,74<br />
6<br />
232
Tabella 211 - Variabilità delle serie nelle due celle ubicate in Sicilia (filtro 1000 ha)<br />
GRIGLIA_ID Serie di vegetazione Area (ha) N° serie<br />
Oleo-Quercetum virgilianae 3.046,25<br />
Genisto aristate-Quercetum suberis 4.227,12<br />
169<br />
Sorbo torminalis-Quercetum virgilianae<br />
Arrhenathero nebrodensis-Quercetum cerridis<br />
5.601,94<br />
9.332,51<br />
6<br />
Festuco heterophyllae-Quercetum congestae 15.439,62<br />
Quercetum gussonei 20.110,17<br />
Arrhenathero nebrodensis-Quercetum cerridis 4.198,22<br />
170 Quercetum gussonei 8.273,99 3<br />
Festuco heterophyllae-Quercetum congestae 25.173,74<br />
233
3.3 Modelli di intervento<br />
Vengono proposti per alcuni ambiti territoriali significativi in termini bioclimatici e biogeografici<br />
dei modelli in cui sono precisate, tenendo anche conto delle informazioni derivanti dalle conoscenze<br />
sindinamiche disponibili, le specie arboree da utilizzare nel caso di interventi di forestazione. Sono<br />
altresì indicate, le specie autoctone legnose a rapido accrescimento solitamente presenti nei mantelli<br />
e nella fascia marginale relativa ai boschi utilizzati come riferimento in questi modelli.<br />
In particolare per la Regione Temperata sono state prese in considerazione la cella 969, ritenuta<br />
sufficientemente rappresentativa anche delle altre celle del settore alpino, la cella 763 a confine tra<br />
Emilia Romagna e Toscana, in quanto utile ad un confronto con un piano di forestazione redatto<br />
dall’ente preposto, cioè la Regione emiliana, e finalizzato dell’incremento nella fissazione di<br />
carbonio e la cella 559 tra Abruzzo e Molise che è anche l’area campione dell’Alto Molise indagata<br />
a scala di dettaglio.<br />
Infine, per la Regione Mediterranea sono state scelte due unità di campionamento in Sicilia (169 e<br />
170), simili fra loro, e la cella 397 localizzata in Sardegna.<br />
REGIONE TEMPERATA<br />
Modello di intervento per la cella 969 di Borno (BS)<br />
La serie delle peccete montane e altimontane dell’Abieti-Piceion si estende per il 13,5% della cella<br />
mentre la serie esalpica delle faggete mesofile e dei piceo-faggeti dell'orizzonte montano dei<br />
substrati carbonatici: Vicio oroboidis-Fagetum, piceo-faggete orobiche (Aremonio-Fagion s.l.)<br />
copre il 13,3% della superficie indagata.<br />
Quali specie arboree idonee ad interventi di forestazione si segnalano Picea abies, Abies alba, Acer<br />
pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Laburnum alpinum e Alnus viridis. In particolare Alnus viridis e<br />
Laburnum alpinumm sono le specie coerenti con il dinamismo delle vegetazioni naturali potenziali e<br />
con elevata rapidità di accrescimento.<br />
Modello di intervento per la cella 763 di Bagno di Romagna (FO)<br />
Per la serie centro-nordappenninca mesotemperata neutro-basifila della roverella (Peucedano<br />
cervariae-Quercetum pubescentis) che si estende, a mosaico con la serie dell'Ostryo-Aceretum<br />
opulifolii, per il 28,4% della superficie della cella, si potrebbero utilizzare quali specie arboree<br />
prefenziali Quercus pubescens, Fraxinus ornus e Acer campestre mentre per effettuare delle<br />
piantumazioni arbustive potrebbero essere impiegate Cytisus sessilifolius, Juniperus communis e<br />
Cornus sanguinea.<br />
Per la seconda serie (Ostryo-Aceretum opulifolii) più estesa nell’unità di campionamento (21,79%),<br />
tra le specie arboree Ostrya carpinifolia, Quercus cerris, Acer opalus ssp. opalus e Fraxinus ornus e<br />
tra gli arbusti Prunus spinosa, Crataegus monogyna e Euonymous europaeus.<br />
234
Figura 47 - Principali complessi forestali in Emilia Romagna 33<br />
Il Piano Triennale della Regione Emilia Romagna (cui è stato accennato nel paragrafo 2.3), per la<br />
realizzazione in ambiti di pianura di nuovi boschi naturali, costituiti cioè da specie autoctone<br />
certificate ed idonee agli ambienti specifici, identifica quali modelli di riferimento “quelli del bosco<br />
asciutto a Farnia, Frassino ossifillo, Tiglio, Carpino bianco, Acero campestre e quelli del bosco<br />
umido a Pioppi bianco e nero, Salice bianco, Ontano nero” e sono consigliati per gli impianti di<br />
arboricoltura, specificatamente finalizzati alla fissazione di carbonio, Fraxinus oxycarpa, Juglans<br />
regia e Prunus avium. Sono considerate adatte per ogni tipo di intervento le specie Alnus glutinosa,<br />
Carpinus betulus, Corylus avellana, Populus alba e Populus nigra, Populus tremula, Quercus<br />
robur, Salix alba, Salix caprea. Salvo che per quest’ultima, per cui è indicata l’alta pianura, per tutte<br />
le altre non è però indicata una preferenza fitoclimatica.<br />
33 http://www.regione.emilia-romagna.it/foreste/risforestali/foreste2.htm<br />
235
Modello di intervento per la cella 559 di Castelverrino (IS)<br />
Nell’area campione dell’Alto Molise Daphno laureolae-Quercetum cerris è la serie di vegetazione<br />
più diffusa e occupa il 34,1% della superficie. Tra le specie arboree ottimali per interventi di<br />
forestazione si potrebbero impiegare Quercus cerris, Quercus pubescens, Ostrya carpinifolia, Acer<br />
obtusatum e Carpinus orientalis mentre tra quelle arbustive sono indicate Ligustrum vulgare,<br />
Cornus sanguinea, Spartium junceum e Pyracantha coccinea.<br />
In termini di copertura, seguono la serie Anemono apenninae-Fagetum sylvaticae e la Geranio<br />
versicoloris-Fagion sylvaticae rispettivamente con il 22,54 e il 18,19%. Per entrambe le serie<br />
sarebbe opportuna una azione di forestazione con specie arboree quali Fagus sylvatica, Acer<br />
obtusatum e Acer pseudoplatanus, Quercus cerris, Populus tremula e Salix caprea. La serie sudappenninica<br />
delle faggete termofile, che è distribuita sul Matese e altri ambiti montuosi, è in effetti<br />
ridotta in estensione rispetto alla sua potenzialità e questi interventi, congiuntamente alla riduzione<br />
della pressione esercitata dallo sfruttamento silvo-pastorale, potrebbero favorire un suo<br />
ampliamento.<br />
REGIONE MEDITERRANEA<br />
Modello di intervento per la cella 397 di Oliena (NU)<br />
La serie termo-mesomediterranea della sughera Galio scabri-Quercetum suberis è la più estesa<br />
(45,71%) e si sviluppa su substrati granitici nella Sardegna orientale e meridionale e talvolta su<br />
metamorfiti. Per la vegetazione arborea sarebbe opportuno utilizzare specie quali Quercus suber con<br />
Quercus ilex, che sono elementi costitutivi dello stadio maturo mentre per la vegetazione di mantello<br />
Viburnum tinus, Arbutus unedo, Erica arborea, Phyllirea latifolia, Myrtus communis e Juniperus<br />
oxycedrus subsp. oxycedrus.<br />
La serie termo-mesomediterranea del leccio Prasio majoris-Quercetum ilicis typicum e<br />
phyllireetosum angustifoliae, che copre il 17,7% della cella indica quali specie arboree ottimali per<br />
la forestazione Quercus ilex oltre a Pistacia lentiscus, Phyllirea latifolia, Rhamnus alaternus, Phyllirea<br />
angustfolia, Erica arborea, Myrtus communis e Juniperus oxycedrus, che in queste stazioni possono<br />
assumere portamento arboreo.<br />
Modello di intervento per la cella 169 di Mistretta (ME) e la cella 170 di Bronte (CT)<br />
La serie Festuco heterophyllae-Quercetum congestae si estende per oltre il 44% dell’unità campione<br />
170 e oltre il 31% della 169. E’ la serie dei querceti caducifogli mesofili e acidofili a dominanza di<br />
Quercus congesta, localizzata in Sicilia nelle stazioni montane, in particolare sul versante<br />
meridionale dei Nebrodi e su quello occidentale e meridionale etneo. Tra le specie arboree idonee ad<br />
interventi di piantumazione, si segnalano Quercus congestae, Quercus dalechampii, Quercus ilex e<br />
Quercus amplifolia, mentre tra le arbustive Cytisus villosus, Prunus spinosa, e Crataegus<br />
monogyna.<br />
236
Nella cella 170 è rappresentata per il 15,4% la serie dei faggeti acidofili Anemono apenninae-<br />
Fagetum, che è presente nelle Madonie, nei Nebrodi e nei Peloritani. Poiché la tappa matura è un<br />
bosco mesofilo a netta dominanza di Fagus sylvatica, si indicano, oltre a questa specie Ilex<br />
aquifolium, Acer obtusatum, Acer campestre e Fraxinus excelsior.<br />
237
4. CONCLUSIONI<br />
Le osservazioni che seguono fanno riferimento alle due questioni-chiave sintetizzate negli obiettivi.<br />
1. Il Protocollo consente di fare uso dei carbon sink presenti nei territori forestali ed agricoli del<br />
nostro Paese (oltre che di meccanismi di cooperazione internazionale) e di inserirli nel Registro<br />
Nazionale quali crediti di carbonio, ai sensi degli artt. 3.3 e 3.4 del Protocollo.<br />
Quali sono le classi di copertura e/o uso del suolo presenti sul territorio italiano, come lo<br />
caratterizzano e che superficie occupano?<br />
Quali, fra queste, sono più soggette a variazioni della destinazione d’uso nel corso del tempo?<br />
Come possono essere messe in relazione queste classi con quelle derivanti dalle definizioni<br />
ammesse alla contabilizzazione dei crediti di carbonio?<br />
E’ possibile una stima della quantità di carbonio fissato in queste classi e della sua variazione in<br />
relazione ad eventuali cambiamenti di copertura e/o uso del suolo osservati?<br />
Ad una visione d’insieme, il territorio italiano, che si estende per oltre 30 milioni di ettari, appare<br />
costituito per 15,7 milioni di ettari da una matrice agricola (~55% della superficie totale), per 12,8<br />
milioni da una matrice a boschi e ambienti seminaturali (~40% della superficie) e per 1,4 milioni da<br />
superfici artificiali (~5%). Il passaggio tra i due sistemi principali è rappresentato da una matrice<br />
paesistica a carattere misto in cui i diversi usi del suolo sono distribuiti in modo composito, senza<br />
che alcuno abbia assunto un ruolo prevalente nelle dinamiche territoriali.<br />
Il cambiamento del territorio in termini di uso del suolo tra il 1990 e il 2000 si esprime, a livello di<br />
macrocategorie, in un incremento areale delle categorie 1. Superfici artificiali e 3. Territori boscati<br />
e ambienti seminaturali: le aree urbane aumentano di oltre 82.000 ettari come pure i boschi e gli<br />
altri ambienti seminaturali per circa 60.000 ettari.<br />
Le foreste italiane, in particolare, sono in crescita. L’ultimo rilevamento FAO (1995, 2005)<br />
presentata nel corso dell’ultima United Nations Climate Change Conference (COP 11 and<br />
COP/MOP 1) tenutasi a Montreal tra il 28 novembre e il 9 dicembre 2005 34 , indica una superficie di<br />
9,98 milioni di ettari, pari ad un terzo del territorio nazionale e al 5% della superficie boschiva<br />
europea. L’incremento emerge sia dai risultati di I fase dell’Inventario Nazionale delle Foreste e dei<br />
serbatoi di Carbonio (INFC) che stimano la superficie in 10,7 ettari (Allegato 4), anche<br />
considerando le incertezze insite nella metodologia di valutazione (Mollicone et Federici S., 2005b;<br />
Tabacchi et al., 2005), sia dal confronto multitemporale CLC90-2000.<br />
E’ bene sottolineare però la diminuzione di alcuni classi di uso del suolo, sempre appartenenti alla<br />
macrocategoria 3 del CLC, e di interesse ai fini del Protocollo di Kyoto, ovvero le aree a pascolo<br />
naturale e le praterie e le aree a vegetazione arboreo-arbustiva in evoluzione (Tabella 25), per le<br />
quali si osserva rispettivamente un decremento dello 0,10% (-30.000 ha circa) e dello 0,15% (-<br />
45.200 ha circa).<br />
34 http://unfccc.int/meetings/cop_11/items/3394.php
Si osserva una riduzione, complementare all’aumento della categoria 3, della voce 2. Superfici<br />
agricole utilizzate, con oltre 143.000 ettari di ambiti agrari perduti. Questa contrazione delle<br />
superfici agricole si esprime prevalentemente nelle classi dei seminativi in aree non irrigue, dei<br />
frutteti, degli oliveti, dei prati stabili, delle colture temporanee associate a colture permanenti, dei<br />
sistemi colturali e particellari complessi, delle colture agrarie e delle aree agroforestali. Questo<br />
abbandono delle pratiche agricole e pastorali si conferma come uno dei fenomeni più incisivi nelle<br />
dinamiche paesaggistiche in Italia.<br />
Tra le classi appartenenti alla categoria 1. Superfici artificiali, si sono ulteriormente estese le zone<br />
residenziali a tessuto discontinuo (passate da 886.700 a 936.723 ha, pari allo 0,16%) e le aree<br />
industriali, commerciali e servizi (passate da 193.943 a 218.113 ha, pari allo 0,8%)<br />
Sono risultate invece meno interessate dal cambiamento le voci di legenda afferenti alle categorie 4.<br />
Zone umide e 5. Corpi idrici.<br />
La produzione di inventari finalizzata alla stima della quantità di carbonio che i diversi tipi di uso<br />
del suolo possono fissare deve essere, per rispondere a pieno a quanto richiesto dal Protocollo di<br />
Kyoto, quanto più precisa ed affidabile.<br />
Per l’analisi di dettaglio, che è stata condotta nell’Alto Molise anche per gli aspetti vegetazionali, è<br />
stato scelto di effettuare una fotointerpretazione di tipo areale, piuttosto che per punti (Preto, 1983a;<br />
Preto, 1983b; Napolitano, 1999; Miozzo et Napolitano, 2001).<br />
Per questa stessa ragione, però, le cartografie prodotte per l’area campione per le date 1990 e 2000<br />
hanno richiesto tempi di realizzazione molto elevati per ottenere il livello di precisione necessario.<br />
Gli errori conseguenti ai procedimenti di manipolazione dei dati territoriali scelti, e dunque<br />
inevitabili anche nella quantificazione del cambiamento di uso del suolo, inducono ad affermare<br />
che nel caso di ricerche su area vasta è certamente meno oneroso procedere ad una<br />
fotointerpretazione per punti piuttosto che areale, sia perché più speditiva sia perché consente<br />
eventualmente l’utilizzo di foto aeree non necessariamente in formato digitale.<br />
La metodologia utilizzata è infatti più adatta ad indagini che interessino zone poco estese. Il<br />
risultato emerso dall’analisi multitemporale è legato anche ad un arco temporale (1990-2000) che è<br />
troppo breve per individuare, anche a scala di dettaglio, cambiamenti significativi nell’utilizzo del<br />
territorio e di conseguenza per rilevare le relative variazioni degli stock di carbonio. In particolare<br />
la vocazione naturalistica dell’area in esame non ha favorito tale confronto che risulta per intervalli<br />
brevi più evidente nel caso di ambiti antropizzati (“superfici artificiali”).<br />
Alla luce dei risultati emersi, anche dalla valutazione delle voci di legenda assimilabili alle attività<br />
direct human induced, sarebbe opportuno venissero riviste le definizioni di bosco e di rivegetazione<br />
da adottare, argomento sul quale vi è dibattito aperto sia a livello nazionale che internazionale<br />
(Mollicone et Federici, 2005b; Anderle et al., 2002).<br />
La copertura arborea minima attualmente prevista per identificare come bosco una porzione del<br />
territorio (pari al 10%), dovrebbe essere aumentata in quanto, di norma, questo limite non<br />
garantisce la presenza di dinamiche forestali, ma in genere mantiene ancora evidente, in termini<br />
strutturali e funzionali, le caratteristiche delle comunità vegetali che precedono la formazione del<br />
bosco. La voce di rivegetazione dovrebbe poi essere interpretata in senso più ampio e comprendere<br />
anche i casi di ricolonizzazione dovuti all’abbandono poiché questi rappresentano nel territorio<br />
italiano i casi più numerosi.<br />
Le metodologie suggerite dall’IPPC consentono la stima del carbonio fissato nelle tipologie di uso<br />
del suolo cartografate, ma la necessaria quantificazione della componente di biomassa legnosa<br />
239
(Allegato 5) ha suggerito, piuttosto che utilizzare dati provenienti dal precedente inventario del<br />
1985, di rinviare tale computo alla conclusione dell’Inventario Nazionale delle Foreste e dei<br />
serbatoi di Carbonio. La terza fase dell’INFC prevede infatti (Allegato 4) la raccolta di elementi<br />
quantitativi, principalmente la massa legnosa presente, di un sottoinsieme delle unità campionarie<br />
classificate in seconda fase.<br />
Tabella 212 - Prospetto delle diverse definizioni della classe foresta<br />
Fonte: Mollicone et Federici, 2005b.<br />
Uso delle terre FAO-FRA2000<br />
Forest includes natural forests<br />
and forest plantations. It is used<br />
to refer to land with a tree canopy<br />
cover of more than 10 percent<br />
and area of more than 0.5 ha.<br />
Forests are determined both by<br />
the presence of trees and the<br />
absence of other predominant<br />
land uses . The trees should be<br />
able to reach a minimum height of<br />
5 m. Young stands that have not<br />
yet but are expected to reach a<br />
crown density of 10 percent and<br />
tree height of 5 m are included<br />
under forest, as are temporarily<br />
unstocked areas. The term<br />
includes forests used for purposes<br />
of production, protection,<br />
multiple-use or conservation (i.e.<br />
forest in national parks, nature<br />
reserves and other protected<br />
areas), as well as forest stands on<br />
Definizioni di foresta<br />
Copertura delle terre FAO-<br />
FRA2000<br />
Forest Land with tree crown<br />
cover (or equivalent stocking<br />
level) of more than 10 percent and<br />
area of more than 0.5 ha. The<br />
trees should be able to reach a<br />
minimum height of 5 m at<br />
maturity in situ. May consist<br />
either of closed forest formations<br />
where trees of various storeys and<br />
undergrowth cover a high<br />
proportion of the ground; or open<br />
forest formations with a<br />
continuous vegetation cover in<br />
which tree crown cover exceeds<br />
10 percent. Young natural stands<br />
and all plantations established for<br />
forestry purposes which have yet<br />
to reach a crown density of 10<br />
percent or tree height of 5 m are<br />
included under forest, as are<br />
areas normally forming part of<br />
the forest area which are<br />
Uso delle terre INFC<br />
Bosco: territorio con copertura<br />
arborea maggiore del 10% su<br />
un’estensione maggiore di 0.5 ha.<br />
Gli alberi devono poter<br />
raggiungere un’altezza minima di<br />
5 m a maturità in situ. Può trattarsi<br />
di formazioni chiuse od aperte.<br />
Soprassuoli forestali giovani,<br />
anche se derivati da piantagione,<br />
od aree temporaneamente scoperte<br />
per cause naturali o per<br />
l’intervento dell’uomo, ma<br />
suscettibili di ricopertura a breve<br />
termine secondo i requisiti sopra<br />
indicati, sono inclusi nella<br />
definizione di bosco. Sono inoltre<br />
inclusi: vivai forestali ed arborei<br />
da seme (che costituiscono parte<br />
integrante del bosco); strade<br />
forestali, fratte tagliate, fasce<br />
tagliafuoco ed altre piccole<br />
aperture del bosco; boschi inclusi<br />
240
agricultural lands (e.g.<br />
windbreaks and shelterbelts of<br />
trees with a width of more than 20<br />
m) , and rubberwood plantations<br />
and cork oak stands. The term<br />
specifically excludes stands of<br />
trees established primarily for<br />
agricultural production, for<br />
example fruit tree plantations. It<br />
also excludes trees planted in<br />
agroforestry systems.<br />
temporarily unstocked as a result<br />
of human intervention or natural<br />
causes but which are expected to<br />
revert to forest. Includes: forest<br />
nurseries and seed orchards that<br />
constitute an integral part of the<br />
forest; forest roads, cleared<br />
tracts, firebreaks and other small<br />
open areas; forest in national<br />
parks, nature reserves and other<br />
protected areas such as those of<br />
specific scientific, historical,<br />
cultural or spiritual interest;<br />
windbreaks and shelterbelts of<br />
trees with an area of more than<br />
0.5 ha and width of more than 20<br />
m; plantations primarily used for<br />
forestry purposes, including<br />
rubberwood plantations and cork<br />
oak stands. Excludes: Land<br />
predominantly used for<br />
agricultural practices<br />
in parchi nazionali, riserve naturali<br />
ed altre aree protette; barriere<br />
frangivento e fasce boscate di<br />
larghezza superiore a 20 metri,<br />
purché maggiori di 0,5 ha. Sono<br />
incluse anche le piantagioni<br />
finalizzate a scopi forestali<br />
comprese quelle di alberi da<br />
gomma e le sugherete.<br />
241
2. La seconda questione riguarda l’individuazione delle modalità di utilizzo dei carbon sink in<br />
maniera compatibile con l’eterogeneità biogeografica, bioclimatica e vegetazionale del nostro<br />
Paese.<br />
E’ possibile cioè individuare dei complessi vegetazionali legati ai caratteri bioclimatici, alla<br />
struttura e alla composizione floristica del territorio, anche in funzione della loro capacità di<br />
assorbimento di carbonio, predisponendo dei modelli gestionali diversificati in funzione di<br />
questa variabilità e quindi senza compromettere piani e programmi connessi con l’applicazione<br />
della Convenzione sulla Biodiversità e della Direttiva Habitat?<br />
A scala nazionale 35 e internazionale si stanno pianificando attività di forestazione che in molti casi<br />
poco tengono conto delle problematiche connesse con il sistema complesso delle convenzioni e<br />
degli obiettivi internazionali in merito alla conservazione della biodiversità (Figura 48). Si tratta di<br />
un problema che interessa gran parte delle regioni del Mediterraneo (Figura 49; Myers et al, 1999;<br />
Myers et al, 2000; Médail et Quézel, 1999; Sala et al, 2000) ed in particolare paesi come l’Italia ad<br />
elevata biodiversità floristica, faunistica e vegetazionale nei quali l’impatto di cambiamenti nell’uso<br />
del suolo (Naveh et Kutiel, 1990) può produrre effetti negativi difficili, se non impossibili, da<br />
recuperare.<br />
Le azioni di forestazione, nella fattispecie ai fini della fissazione di carbonio, possono invece<br />
concorrere, se concertate nell’ambito di programmi effettivamente sostenibili, non solo ad un buon<br />
governo del territorio, ma a conservare ed eventualmente incrementare la diversità di specie, di<br />
comunità, di ecosistemi e di paesaggio.<br />
Il ruolo che gli interventi di afforestazione e riforestazione, come pure quelli rivegetazione,<br />
potrebbero svolgere nella riduzione delle emissioni totali non è d’altronde trascurabile. A livello<br />
europeo si stima che fra il 1990 ed il 2000 l’estensione delle aree rimboschite sia stata pari a circa<br />
170.000 ha/anno; se mantenuta, questa tendenza potrebbe portare in combinazione con l’espansione<br />
naturale del bosco ad una fissazione di 14 Mt CO2 anno -1 nel periodo di riferimento 2008-2012<br />
(ECCP - Working Group on Forest Sinks, 2003). Una stima ancora più elevata può individuarsi<br />
nelle intenzioni espresse dagli Stati membri dell’Unione Europea, secondo cui gli interventi di<br />
riforestazione fra il 1990 ed il 2008-2012 dovrebbero contribuire con la rimozione di 23 milioni di<br />
tonnellate di CO2 all’anno (EEA, 2004), equivalenti ad oltre l’8% della riduzione dovuta<br />
complessivamente dall’Europa dei 15 (Magnani et al., 2005).<br />
Come già osservato da Anderle et al. (2002), però, le valutazioni relative alla capacità di fissazione<br />
del carbonio da parte di impianti di questo genere non prendono in considerazione il carattere<br />
temporaneo di gran parte delle Kyoto forest 36 s finora realizzate in Italia e quindi su quelle da<br />
realizzare. L’aspetto relativo alla permanenza dei sink di carbonio è considerato un elemento<br />
fondamentale in quanto attiene alla capacità del sistema di contenimento delle emissioni attuato dal<br />
Paese di conservare illo tempore gli obiettivi raggiunti e richiede per questo una attenta riflessione<br />
sul destino degli impianti alla conclusione del turno. Il problema non riguarda soltanto le<br />
piantagioni a pioppo ed eucalitto, previsti per il primo periodo di adempimento del Protocollo di<br />
Kyoto (2008-2012), bensì anche gli altri impianti di arboricoltura da legno di qualità per i quali il<br />
35 www.regione.emilia-romagna.it/foreste<br />
36 Il nome di Kyoto forests è attribuito ai boschi di neoformazione realizzati dopo la data di riferimento del 1990, con<br />
interventi di afforestazione e riforestazione. Essi comprendono anche gli impianti di arboricoltura specializzata da legno.<br />
242
turno prescritto per accedere ai finanziamenti non supera comunque i 20 anni (Magnani et al.,<br />
2005).<br />
L’analisi condotta a livello nazionale sulla eterogeneità del nostro territorio fa inoltre emergere in<br />
modo chiaro che l’applicabilità del Protocollo di Kyoto ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 3 (attività<br />
obbligatorie di afforestazione e riforestazione) e 4 (attività non obbligatorie di rivegetazione 37 e di<br />
gestione delle foreste, delle terre agricole, dei prati e dei pascoli), non può prescindere in Italia da<br />
una sua attuazione in ambiti omogenei in senso bioclimatico e di vegetazione naturale potenziale.<br />
Il ricorso ai carbon sink, e quindi alle concrete azioni di gestione del territorio funzionali<br />
all’assorbimento di anidride carbonica, può solo in questo modo essere compatibile con gli obiettivi<br />
di conservazione della biodiversità e di gestione sostenibile delle foreste.<br />
Figura 48 – Hotspot di biodiversità 38<br />
L’analisi dei caratteri bioclimatici e delle vegetazioni potenziali nel sistema delle 56 celle di<br />
campionamento ha consentito di desumere indicazioni puntuali per definire e qualificare in termini<br />
floristici e sintassonomici questo modello di applicabilità del Protocollo di Kyoto che, non entrando<br />
in conflitto con gli obiettivi della Direttiva Habitat e della Convenzione sulla Diversità Biologica,<br />
indirettamente contribuisce a sostenerli.<br />
37 Sarebbe opportuno che questa voce comprendesse anche i casi di ricolonizzazione dovuti all’abbandono che nel territorio<br />
italiano rappresentano i casi più numerosi di rivegetazione.<br />
38 www.biodiversityhotspots.org/xp/hotspots/mediterranean<br />
243
I “nuovi” boschi, naturali o d’impianto, devono pertanto essere costituiti da complessi di specie<br />
arboree ed arbustive autoctone, legate per definizione alle specificità del territorio in cui devono<br />
essere inseriti. Questo senza dubbio può favorire il raggiungimento di una stabilità e e di una<br />
permanenza maggiore degli impianti che, essendo collegati in termini di flora e di composizione<br />
alla vegetazioen autoctona, daranno luogo nel tempo a boschi coerenti con la vegetazione naturale<br />
potenziale.<br />
Si auspica pertanto che ciascun ente coinvolto operativamente negli interventi di forestazione abbia<br />
particolare riguardo nel fare riferimento ad un elenco di specie redatto con i criteri indicati, salvo<br />
che vi sia una motivata necessità di impiegare delle specie diverse (ad esempio nel caso di entità<br />
particolarmente rare e difficili da reintrodurre).<br />
A queste esigenze cercano essenzialmente di rispondere gli esempi di modelli di intervento proposti<br />
nel paragrafo 3.3 che tengono conto della eterogeneità climatica e floristica.<br />
Figura 49 – Hotspot di biodiversità nel Mediterraneo<br />
Questo approccio per l’applicazione del Protocollo di Kyoto fa riferimento all’ecosystem approach<br />
della CBD e offre anche elementi utili per l’applicazione delle diverse Direttive e Convenzioni a scala<br />
di specie, di comunità e di paesaggio. In forma indiretta dall’analisi della variabilità bioclimatica e<br />
vegetazionale (in termini di VNP) si possono avere infatti interessanti informazioni multifunzionali ad<br />
obiettivi quali presenza di boschi vetusti, stato di conservazione e qualità ambientale, obiettivi legati<br />
alla scadenza del 2010 considerata da tutte le convenzioni (Berna, CBD, Direttiva Habitat,..) come un<br />
primo e prossimo riferimento temporale per l’insieme delle politiche da adottare per la conservazione<br />
della biodiversità e la riduzione del complesso degli inquinanti.<br />
244
5. BIBLIOGRAFIA<br />
Abbate G., Alessandrini A., Conti F., La Posta A., Ronchieri I., Tartaglini N., Blasi C., 2001. La<br />
Banca Dati della Flora vascolare italiana. Inf. Bot. Ital. 33 (2): 417-420.<br />
Aber J.D., McDowell W., Nadelhoffer K., Magill A., Bernston G., Kamakea M., McNulty S.,<br />
Currie W., Rustad L., Fernandez I., 1998. Nitrogen saturation in temperate forest ecosystems.<br />
BioScience, 48: 921-934.<br />
Aber J.D., Nadelhoffer K., Steudler P., Melillo J.M., 1989. Nitrogen saturation in northern forest<br />
ecosystems. BioScience, 48: 378-386.<br />
Aleffi M., Schumacker R., 1995. Checklist and red-list of liverworts (Marcantiophyta) and<br />
liverworts (Anthocerotophyta) of Italy. Fl. Medit., 5: 73-161.<br />
Anderle A., Ciccarese, L., Dal Bon D., Pettenella D., Zanolini E.. Assorbimento e fissazione di<br />
carbonio nelle foreste e nei prodotti legnosi in Italia. Rapporto APAT 21/2002. 68 pp.<br />
http://www.apat.gov.it//site/_contentfiles/00023400/23465_Rapporti_02_21.pdf<br />
AA.VV., 1995. CORINE land cover - Part 1: Methodology - Part 2: Nomenclature. Published by:<br />
Commission of the European Communities OPOCE (Office for official publications of the<br />
european communities).<br />
http://reports.eea.eu.int/COR0-landcover/en<br />
AA.VV., 1997. Report to the Parliament and to the Council on the application of regulation (EEC)<br />
No. 2080/92 instituting a Community aid scheme for forestry measure in agriculture (COM 630 del<br />
28.11.1997).<br />
Bacchetta G., Biondi E., Filigheddu R., Farris E. & Mossa L., 2004. A phytosociological study of<br />
the deciduous oak woods of Sardinia (Italy). Fitosociologia, 41(1): in stampa.<br />
Barbati A., Blasi C., Corona P.M., Travaglino D., Chirici G., 2004. Applicazione della cartografia<br />
Corine Land Cover per la macrocaratterizzazione dei paesaggi italiani. Atti 8 a Conferenza<br />
Nazionale ASITA (Roma, 14-17 dicembre 2004), Volume I: 265-270.<br />
Blasi C. (Ed.), Boitani L., La Posta S., Manes F., Marchetti M., 2005. Stato della biodiversità in<br />
Italia. Contributo alla strategia nazionale per la biodiversità. Palombi & Partner, Roma. 466 pp.<br />
Blasi C. (Ed.), 2004. Conoscenze naturalistiche in Italia. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del<br />
Territorio, Direzione della Conservazione della Natura. Società Botanica Italiana, Commissione per<br />
la promozione della ricerca botanica. 100 pp.<br />
Blasi C., 1994. Fitoclimatologia del Lazio. Fitosociologia, 27: 151-175.<br />
245
Blasi C., Mazzoleni S., Paura B., 1988. Proposte per una regionalizzazione fitoclimatica della<br />
Campania, Italia meridionale. Atti II Colloquio “Probl. Def. Amb. Fis. Biol. Medit.”, Castro Marina<br />
(Lecce).<br />
Bossard M., Feranec J. and Otahel J., 2000. CORINE land cover technical guide - Addendum 2000.<br />
Technical report No 40. EEA (European Environment Agency).<br />
http://reports.eea.eu.int/tech40add/en<br />
CEALP (Centro di Ecologia Alpina), 2003. Il ruolo delle foreste nel bilancio del carbonio. Aspetti<br />
ecologici ed economici. Report No. 28.<br />
http://www.cealp.it<br />
Chirici G., Corona P., Marchetti M. 2002. Realizzazione della “Carta dell’uso del suolo e delle<br />
coperture vegetazionali” a copertura nazionale. Atti 6 a Conferenza Nazionale ASITA (Perugia, 5-8<br />
novembre 2002), Volume I: 787-792.<br />
Ciccarese L., Pettenella D., Schlamadinger B., 2001. Foreste come serbatoi di carbonio: il punto<br />
dopo il fallimento della conferenza dell’Aia. Sherwood - Foreste ed alberi oggi, 64 (02/01): 43-46.<br />
Ciccarese L., 2005. Selvicoltura e cambiamenti climatici : adempiere agli impegni di Kyoto. Alberi<br />
e Territorio, 3: 44-49.<br />
Colletti L., 2001. Risultati dell’applicazione del Regolamento CEE 2080/92 in Italia. Sherwood –<br />
Foreste ed alberi oggi, 70 (9/01): 23-30.<br />
Colonna N., Zanatta A., 2005. Il Regolamento 2080/92 sull’afforestazione dei suoli agricoli. Un<br />
contributo al contenimento della CO2 atmosferica. Laboratorio ENEA-CR, Frascati.<br />
http://biotec.casaccia.enea.it/despub.asp<br />
Corona P., 2001. Introduzione al rilevamento campionario delle risorse forestali. Edizioni CUSL,<br />
Firenze. 284 pp.<br />
Corona P., Ferretti M., Tabacchi G., 2001. Riflessioni sugli aspetti campionari nella valutazione e<br />
nel monitoraggio delle risorse ambientali. Seminario “Il campionamento nella valutazione e<br />
monitoraggio delle risorse ambientali” (Firenze, 5 dicembre 2000). Comunicazioni di ricerca<br />
ISAFA 2001/2: 7-12.<br />
Cortini Pedrotti C., 2001. New Checklist of the Mosses of Italy. Fl. Medit., 11: 23-107<br />
Cortini Pedrotti C., 1992. Checklist of the Mosses of Italy. Fl. Medit., 2: 119-221.<br />
Büttner G., Feranec J., Jaffrain G., 2002. CORINE land cover update 2000: Technical guidelines.<br />
Technical report No 89. Publisched by: EEA (European Environmente Agency).<br />
http://reports.eea.eu.int/technical_report_2002_89/en<br />
De Natale F., Gasparini P., Puzzolo V., Tosi V., 2003. Stima del grado di copertura forestale da<br />
ortofoto e applicazione della definizione di bosco negli inventari forestali. L’Italia Forestale e<br />
Montana 58(4): 289-300.<br />
246
De Philippis A., 1937. Classificazione ed indici del clima in rapporto alla vegetazione forestale<br />
italiana. Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 54: 1-169.<br />
ECCM (The Edinburgh Centre for Carbon Management), 2002. Climate Change, Carbon and<br />
Forests: Some General Guidelines for Credible Carbon Offset Projects. Technical Document no. 6.<br />
http://www.eccm.uk.com/publications.html<br />
EEA (European Environment Agency), 2004. Greenhouse gas emission trends and projections in<br />
Europe 2004. European Environment Agency, Luxembourg, pp. 35.<br />
ECCP (European Climate Change Programme) - Working Group on Forest Sinks, 2003.<br />
Conclusions and recommendations regarding forest related sinks and climate change mitigation.<br />
http://europa.eu.int/comm/environment/climat/pdf/forest_sinks_final_report.pdf<br />
Enting I.G., Mansbridge J.V., 1991. Latitudinal distribution of sources and sinks of CO2: results of<br />
an inversion study. Tellus 43B: 156-170.<br />
Edwards D., 1998. Issues and themes for natural resources trend and change detection. Ecological<br />
Applications, 8: 323-325.<br />
FAO, 2005. Global Forest Resources Assessment update 2005.<br />
http://www.fao.org/forestry/fra2005<br />
FAO, 1995. Forest Resources Assessment 1990. Global Synthesis. FAO Forestry Paper 124, Rome.<br />
http://www.fao.org/forestry/fra2000report<br />
Fattorini L., 2001. Inferenza basata su disegni e su modelli negli inventari forestali. Seminario “Il<br />
campionamento nella valutazione e monitoraggio delle risorse ambientali” (Firenze, 5 dicembre<br />
2000). Comunicazioni di ricerca ISAFA 2001/2: 13-23.<br />
Forman R., 1995. Land mosaics. The ecology of landscapes and regions. Cambridge University<br />
Press, Cambridge. 632 pp.<br />
Forman R.T.T., Godron M., 1986. Landscape Ecology. John Wiley & Sons. New York.<br />
Fung I.Y., Tucker C.J., Prentice K.C., 1987. Application of advanced very high resolution<br />
radiometer vegetation index to study atmosphere-biosphere exchange of CO2. Geophysical<br />
Research, 92: 2999-3015.<br />
Géhu J.M., 1986. Des complexes de groupement vegetaux à la phytosociologie paysagere<br />
contemporaine. Inf. Bot. Ital. 18: 53-83.<br />
Gomarasca M.A., 2004. Elementi di geomatica. Ed. AIT (Associazione Italiana di<br />
Telerilevamento). Artestampa, Galliate Lombardo (VA). 618 pp.<br />
Hofmann A.A., 1994. Foreste e forestazione in Europa. Rivista del Coordinamento Nazionale dei<br />
Parchi e delle Riserve Naturali, 13.<br />
http://www.parks.it/federparchi/rivista/P13/41.html<br />
247
Houghton R.A.,1999. The annual net flux of carbon to the atmosphere from changes in land use<br />
1850-1990. Tellus, 50b: 298-313.<br />
Houghton R.A., Skole D.L., Nobre C.A., Harkler J.L., Lawrence K.T., Chomentowski W.H., 2000.<br />
Annual fluxes of carbon from deforestation and regrowth in the Brazilian Amazon. Nature, 403:<br />
301-304.<br />
Houghton R.A., Harckler J.L., Lawrence K.T., 1999. The U.S. Carbon budget: contributions from<br />
land-use change. Science, 285: 574-578.<br />
IGM, AGEA, 2005. Ortofoto Digitali alla scala nominale 1:10.000. Linee Guida. 13 pp.<br />
http://www.cnipa.gov.it/site/_files/linee%20guida%20orto10000%20vers01.pdf<br />
ISAFA (Istituto Superiore per l’Assestamento Forestale e l’Alpicoltura), 2003. Inventario<br />
Nazionale delle Foreste e dei serbatoi di Carbonio (INFC) - Manuale di di fotointerpretazione per la<br />
classificazione delle unità di campionamento di I fase. 51 pp.<br />
http://www.ifni.it/documenti/manualefaseI.pdf<br />
ISAFA, 1985. Inventario Forestale Nazionale. Sintesi metodologica e risultati. Ministero Politiche<br />
Agricole e Forestali - Direzione generale per l’Economia Montana e per le Foreste, Corpo Forestale<br />
dello Stato.<br />
IUCN (Union for the Conservation of Nature and Natural Resources), 2004. IUCN Red List of<br />
Threatened Species. IUCN Species Survival Commission. IUCN, Gland, Switzerland and<br />
Cambridge, UK.<br />
http://www.iucn.org<br />
IUCN (Union for the Conservation of Nature and Natural Resources), 2003. Guidelines for<br />
Application of IUCN Red List Criteria at Regional Levels: Version 3.0. IUCN Species Survival<br />
Commission. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.<br />
IUCN (Union for the Conservation of Nature and Natural Resources), 2001. IUCN Red List<br />
Categories and Criteria: Version 3.1. IUCN Species Survival Commission. IUCN, Gland,<br />
Switzerland and Cambridge, UK.<br />
IUCN (Union for the Conservation of Nature and Natural Resources), 1994. IUCN Red List<br />
Categories. Prepared by the IUCN Species Survival Commission. IUCN, Gland, Switzerland.<br />
Kauppi P.E., Mielikäinen K., Kuusela K. 1992. Biomass and carbon budget of European forests,<br />
1971 to 1990. Science, 256: 70-74.<br />
Keeling C.D., Whorf T.P., 1999. Atmospheric and CO2 records from sites in the SIO air sampling<br />
network. In: Trends: A compendium of Data on Global Change. Carbon Dioxide Information<br />
Analyses Center, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, TN, USA.<br />
248
Lieth H., Whittaker R.H., 1975. Primary production of the major vegetation units of the world. In:<br />
Primary Productivity of the Biosphere (Lieth H., Whittaker R.H., Eds), Springer-Verlag, New<br />
York: 237-263.<br />
Linder S., McMurtrie R.E., Landsberg J.J., 1996. Global change impacts on managed forests. In:<br />
Walker B., Steffen W. (Eds.) Global Change and Terrestrial Ecosystems. International Geosphere-<br />
Biosphere Program (IGBP) Book Series 2: 275-290. Cambridge University Press, Cambridge,<br />
United Kingdom and New York, N.Y., USA.<br />
Livani P., Marignani M., Ricotta C., Campatola F., Avena, 2004. Analisi multitemporale della<br />
qualità ambientale del territorio. Il caso del Comune di Ariccia (Roma) nel periodo 1954-1996.<br />
Genio Rurale, 1: 16-19.<br />
Magnani F., Grassi G., Tonon G., Cantoni L., Ponti F., Vicinelli E., Boldreghini P., Nardino M.,<br />
Georgiadis T., Facini O., Rossi F., 2005. Quale ruolo per l’arboricoltura da legno italiana nel<br />
protocollo di Kyoto? Indicazioni da una "Kyoto forest" della pianura emiliana. Forest@ 2 (4): 333-<br />
344.<br />
http://www.sisef.it/<br />
Malcom L., Hunter J.r., 1996. Fundamentals of Conservation Biology. Blackwell Science, Inc.,<br />
USA.<br />
Manca G., Tedeschi V., Tirone G., Borghetti M., Valentini R., 2001. Bilancio del carbonio in una<br />
cronosequenza (Quercus cerris L.) dell’Italia centrale. Atti Congresso Nazionale SISEF (Società<br />
Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale) “Alberi e Foreste per il Nuovo Millennio” 3: 73-78.<br />
http://www.sisef.it/sisef/<br />
Maricchiolo C., Sambucini V., Pugliese A., Blasi C., Marchetti M., Chirici G., Corona P., 2004. La<br />
realizzazione in Italia del progetto europeo I&CLC2000: metodologie operative e risultati. Atti 8 a<br />
Conferenza Nazionale ASITA (Roma, 14-17 dicembre 2004), Volume I: CXIII-CXXVIII.<br />
Marland, G., Boden T.A., e Andres R. J., 2005. Global, Regional, and National CO2 Emissions. In<br />
Trends: A Compendium of Data on Global Change. Carbon Dioxide Information Analysis Center,<br />
Oak Ridge National Laboratory, U.S. Department of Energy, Oak Ridge, Tenn., U.S.A.<br />
http://cdiac.esd.ornl.gov/trends/emis/tre_glob.htm<br />
Martin, P. H.; Valentini, R.; Jaques, M.; Fabbri, K.; Galati, D. & Quarantino, R. et al. 1998. New<br />
estimate of the carbon sink strength of EU forests integrating flux measurements, field surveys and<br />
space observations: 0.17-0.35 Gt(C). Ambio, 27 (7): 582-584.<br />
<strong>MA</strong>TT (Ministero Ambiente e Tutela del Territorio), 2002. Terza comunicazione nazionale<br />
dell’Italia alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici.<br />
http://www.minambiente.it/st/Ministero.aspx?doc=pubblico/clima/doc.xml<br />
Médail F., Quézel P., 1999. Biodiversity hotspots in the Mediterranean Basin: Setting global<br />
conservation priorities. Conservation Biology 13: 1510-1513.<br />
249
Minelli S., 1996. La Checklist delle specie della fauna italiana. Un bilancio del progetto. Bollettino<br />
del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 20 (1993): 249-261.<br />
Minotta G., 2003. L’arboricoltura da legno: un’attività produttiva al servizio dell’ambiente,”libro<br />
bianco” sulle produzioni legnose fuori foresta in Italia. Avenue Media, Bologna.<br />
Miozzo M., Napoletano, 2001. Confronto fra i risultati di stima di superfici forestali ottenuti da una<br />
cartografia di copertura del suolo e quelli derivati da campionamento sistematico. Seminario “Il<br />
campionamento nella valutazione e monitoraggio delle risorse ambientali” (Firenze, 5 dicembre<br />
2000). Comunicazioni di ricerca ISAFA 2001/2: 113-128.<br />
Mollicone D., Federici S., 2005a. L’uso delle terre: il Protocollo di Kyoto, la definizione FAO di<br />
foresta e l’Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio. Forest@ 2 (4):<br />
321-330.<br />
http://www.sisef.it<br />
Mollicone D., Federici S., 2005b. La stima delle superfici forestali per l’Italia: le incertezze del<br />
Nuovo Inventario delle Foreste e del Carbonio. Forest@ 2 (2): 143-150.<br />
http://www.sisef.it<br />
Moutinho P., Schwartzman S. (Eds.), 2005. Tropical Deforestation and Climate Change. Amazon<br />
Institute for Environmental Research.: IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia),<br />
Belém - Pará - Brazil; Environmental Defense, Washington DC - USA.132 pp.<br />
http://www.environmentaldefense.org/documents/4930_TropicalDeforestation_and_ClimateChang<br />
e.pdf<br />
Myers N., Mittermeier R.A., Mittermeier C.G., da Fonseca G.A.B., Kent J., 2000. Biodiversity<br />
hotspots for conservation priorities. Nature, 403: 853–858.<br />
Myers N., Cowling R. 1999. Mediterranean Basin. In R.A. Mittermeier, N. Myers & C. Goettsch<br />
Mittermeier (Eds.), Hotspots - Earth’s Biologically Richest and Most Endangered Terrestrial<br />
Ecoregions: 254-267. Mexico City: CEMEX & Conservation International.<br />
Nabuurs G. J., Päivinen R., Sikkema R., Mohren G. M. J., 1998. The role of European forests in the<br />
global carbon cycle - A review. Biomass and bioenergy, 13 (6) : 345-358.<br />
Nadelhoffer K. J., Emmett B. A., Gundersen P., Kjønaas O. J., Koopmans C. J., Schleppi P. A.,<br />
Tietema A., Wright R.F., 1999. Nitrogen deposition makes a minor contribution to carbon<br />
sequestration in temperate forests. Nature, 398: 145 -148.<br />
Napolitano P., Carbonetti G., Zini E., Bocci M., Miozzo M., Petri P., 1999. Progetto pilota di un<br />
database dell’uso e copertura del suolo nella provincia di Arezzo. Atti 3 a Conferenza Nazionale<br />
ASITA (Napoli, 9-12 dicembre 1999).<br />
Naveh Z., Kutiel P. 1990. Changes in the Mediterranean vegetation of Israel in response to human<br />
habitation and land use. In G.M. Woodwell. (Ed.), The Earth in Transition: Patterns and Processes<br />
of Biotic Impoverishment: 259-299. New York: Cambridge University Press.<br />
250
OTA (Office of Technology Assessment of the U.S. Congress) 1987. Technologies to maintain<br />
biological diversity. OTA –F-330. U.S. Government Printin Office, Washington D.C., U.S.A.<br />
Pausas J.G., Austin M.P., 2001. Pattern of species plant richness in relation to different<br />
environments. An appraisal. Journal of Vegetation Science 12: 153-166.<br />
Pavari A., 1916. Studio preliminare sulla coltura di specie forestali esotiche in Italia I. parte<br />
generale. Annali R. Istit. Sup. For. Naz. 1. 1914-1915.<br />
Pettenella D., Zanolini E., Pauli F., 2003. Valutazione delle attività forestali nelle strategie di<br />
mitigazione dei cambiamenti climatici previste dal Protocollo di Kyoto. In “La risposta al<br />
cambiamento climatico in Italia. Vulnerabilità climatica. Valutazioni socio-economiche delle<br />
strategie di adattamento. Misure di mitigazione forestale”: 71-96.<br />
http://www.environmentdaily.com/docs/30131c.pdf<br />
Picard O., 2001. Evalutation of the Community aid scheme for forestry measures in agriculture of<br />
regulation No. 2080/92. Institute for Forestry Development, France.<br />
Pigato C., 1995. Topografia e fotogrammetria. Poseidonia, Bologna. 408 pp.<br />
Pignatti S., 1982. Flora d’Italia. 3 Voll. Ed agricole, Bologna.<br />
Post W.M., Kwon K.C., 2000. Soil carbon sequestration and land-use change: processes and<br />
potential. Global Change Biology 6: 317-328.<br />
Poulton P.R., Pye E., Hargreaves P.R., Jenkinson D.S., 2003. Accumulation of carbon and nitrogen<br />
by old arable land reverting to woodland. Global Change Biology 9: 942-955.<br />
Prentice I.C., Farquhar G.D., Fasham M.J.R., Goulden M.L., Heimann M., JaramilloV.J., Kheshgi<br />
H.S., Le Quéré C., Scholes R.J., Wallace D.W.R., 2001. The Carbon Cycle and Atmospheric CO2.<br />
In Climate Change 2001: The Scientific Bases. Contribution of Working Group I to the IPCC Third<br />
Assessment Report, Cambridge University Press.<br />
Preto G., 1983a. La fotointerpretazione per punti. Modalità di esecuzione. Monti e Boschi 34 (4):<br />
55-60.<br />
Preto G., 1983b. La fotointerpretazione per punti. Correzione degli errori. Monti e Boschi 34 (6):<br />
53-60.<br />
Rivas Martinez S., 1976. Sinfitosociologia, una nueva metodologia para el studio del paisaje<br />
vegetal. Anal. Inst. Bot. Cavanilles 33: 79-188.<br />
Rivas Martinez S., 1996. Clasificacion Bioclimatica de la Tierra. Folia Bot. Madrit., 16: 1-32.<br />
Sala O.E., Chapin F.S. III, Armesto J.J., Berlow E., Bloomfield J., Dirzo R., Huber-Sanwald E.,<br />
Huenneke L.F., Jackson R., Kinzig A., Leemans R., Lodge D., Mooney H.A., Oesterheld M., Poff<br />
L., Sykes M .T., Walker B.H., Walker M., Wall D. , 2000. Global biodiversity scenarios for the<br />
year 2100. Science’s Compass 287: 1770-1774.<br />
251
Schulze E.D., Högberg L., van Oene H., Persson T., Harrison A.F., Read D., Kjoller A., Matteuci,<br />
G., 2000. Interactions between the carbon and nitrogen cycle and the role of biodiversity: A<br />
synopsis of a study along a north-south transect through Europe. In: Schulze, E.D. (Ed.): Carbon<br />
and nitrogen cycling in European forest ecosystems. Ecological Studies 142, Springer Verlag,<br />
Heidelberg.<br />
Schimel D.S., 1995. Terrestrial ecosystem and the carbon cycle. Global change Biology 1: 77-91.<br />
Shannon C.E., Weaver W., 1949. The mathematical theory of communication. Univ. Illinois Press,<br />
Urbana. 117 pp.<br />
Simpson E.H., 1949. Measurement of diversity. Nature: 163, 688.<br />
Stoch F., 2000. How many endemic species? Specie richness assessment and conservation priorities<br />
in Italy. Belgian Journal of Entomology, 2: 125-133.<br />
Sundquist E.T., 1993. The global carbon dioxide budget. Science, 259: 934-941.<br />
Tabacchi G., De Natale F., Fattorini L., Gasparini P., 2005. Risposta a “La stima delle superfici<br />
forestali per l’Italia: le incertezze del Nuovo Inventario delle Foreste e del Carbonio” di Mollicone<br />
e Federici. Forest@ 2(3): 258-267.<br />
http://www.sisef.it<br />
Tirone G., Manca G., Valentini R., Seufert G., 2001. Assorbimento di carbonio negli ecosistemi<br />
forestali mediterranei: confronto tra una lecceta e una pineta. Atti Congresso Nazionale SISEF<br />
(Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale) “Alberi e Foreste per il Nuovo Millennio”<br />
3: 99-104.<br />
http://www.sisef.it/sisef/<br />
Tomaselli R., Balduzzi A., Filippello S., 1973. Carta bioclimatica d’Italia. La vegetazione forestale<br />
d’Italia. Ministero dell’Agricoltura Collana Verde, 33 Roma.<br />
Tosi V., 2001. Il monitoraggio delle risorse forestali attraverso gli inventari su vaste superfici.<br />
Seminario “Il campionamento nella valutazione e monitoraggio delle risorse ambientali” (Firenze, 5<br />
dicembre 2000). Comunicazioni di ricerca ISAFA 2001/2.<br />
Tuxen R., 1956. Die heutige potentielle natürliche Vegetation als Gegenstand der<br />
Vegetationskartierung. Angew. Pflanzensoziol. 13: 5-42.<br />
UN-ECE/EC, 2002. Stato delle foreste. Convenzione sull’inquinamento atmosferico a lunga<br />
distanza: Programma concertato internazionale di valutazione e sorveglianza degli effetti<br />
dell’inquinamento atmosferico sulle foreste. Azione comunitaria per la protezione delle foreste<br />
contro l’inquinamento atmosferico. Bilancio esecutivo 2002. Federal Research Centre for Forestry<br />
and Forest Products PCC of ICP Forests, Hamburg. European Commission DG AGRI, Bruxels. 35<br />
pp.<br />
http://www.icp-forests.org<br />
http://europa.eu.int/comm/agriculture<br />
252
UN-ECE/EC, 2000. Stato delle foreste. Convenzione sull’inquinamento atmosferico a lunga<br />
distanza: Programma concertato internazionale di valutazione e sorveglianza degli effetti<br />
dell’inquinamento atmosferico sulle foreste. Azione comunitaria per la protezione delle foreste<br />
contro l’inquinamento atmosferico. Bilancio esecutivo 2000. Federal Research Centre for Forestry<br />
and Forest Products PCC of ICP Forests, Hamburg. European Commission DG AGRI, Bruxels. 44<br />
pp.<br />
UN-ECE/FAO, 2000. Forest resources of Europe, CIS, North America, Australia, Japan and New<br />
Zealand. UN-ECE/FAO Contribution to the Global Forest Resources Assessment 2000. Main<br />
Report. Timber and Forest Study Papers, n. 17. United Nations, Geneva.<br />
UN-ECE/FAO, 1997. UN-ECE/FAO Temperate and Boreal Forest Resources Assessment 2000.<br />
Terms and definitions. United Nations, Geneva.<br />
UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), 2001. COP7 di Marrakesh,<br />
Decision 11/CP7. Land use, land-use change and forestry. FCCC/CP/2001/13/Add. : 54-63.<br />
http://unfccc.int/resource/docs/cop7/13a01.pdf<br />
Watson R.T., Noble I.R., Bolin B., Ravindranath N.H., Verardo D.J., Dokken D.J., 2003. Good<br />
Practice Guidance of Land Use, Land-use Change and Forestry. Cambridge University Press. 377<br />
pp.<br />
Watson R.T., Noble I.R., Bolin B., Ravindranath N.H., Verardo D.J., Dokken D.J., 2000. Land Use,<br />
Land-Use Change, and Forestry. Special Report. Cambridge University Press. 377 pp.<br />
http://grida.no/climate/ipcc/land-use/index.htm<br />
WCED (World Commission on Environment and Development), 1987. Our Common Future.<br />
Oxford University Press. 400 pp.<br />
Weber H.E., Moravec J., Therillat J.P., 2000. International Code of Phytosociological<br />
Nomenclature. 3 rd edition. Journal of Vegetation Science 11: 739-768.<br />
Westhoff V. et van der Maarel E., 1973. The Braun-Blanquet approach. In Whittaker R.H. (ed.),<br />
Ordination and Classification of Communities. Handbook of Vegetation Science 5: 617-726. Junk,<br />
Den Haag.<br />
Whittaker R.H., 1965. Dominance and diversity in land plant communities. Science, 147: 250-260.<br />
Whittaker R.H., 1972. Evolution and measurement of species diversity. Taxon, 21: 213-260.<br />
253
6. ACRONIMI E GLOSSARIO DEI TERMINI<br />
Activities Implemented Jointly (AIJ): progetti per il contenimento delle emissioni di gas serra che i<br />
paesi (o due imprese) realizzano congiuntamente. Sostanzialmente, l'AIJ ha rapresentato una fase<br />
pilota della Joint Implementation (vedi) e del Clean Development Mechanism (vedi) attraverso la<br />
quale i paesi acquisiscono esperienza per questo genere di progetti. Le riduzioni delle emissioni di<br />
gas serra realizzate in questa fase, ora conclusa, non danno luogo a crediti di emissione da utilizzare<br />
per adempiere i vincoli previsti dal Protocollo di Kyoto (vedi CER ed ERU).<br />
Additionality: termine originato dagli articoli sulla JI (Joint Implementation, vedi) e sul CDM<br />
(Clean Development Mechanism, vedi) del Protocollo di Kyoto secondo cui i paesi soggetti a<br />
vincolo di emissione (vedi Annex I Countries) possono intraprendere - in altri paesi Annex I, oppure<br />
in paesi in via di sviluppo - progetti che generano “reductions in emissions that are additional to<br />
any that would occur in the absence of the certified project activity”. Tali riduzioni addizionali<br />
possono essere portate, dai Paesi Annex I, in detrazione delle proprie emissioni interne di gas-serra.<br />
Le Conferenze delle Parti (vedi Conference of Parties) non hanno ancora chiarito se l’addizionalità<br />
debba essere intesa solo in termini fisico-ambientali (riduzione di emissioni) oppure anche in<br />
termini finanziari, ovvero se si debbano prendere in considerazione solo quei progetti che<br />
effettivamente liberano nuove risorse finanziarie e che, quindi, non sarebbero stati realizzati in<br />
assenza di un programma di JI o CDM.<br />
Afforestation: piantare alberi su aree, potenzialmente idonee, che non hanno ospitato boschi e<br />
foreste nel passato.<br />
AGEA (Agenzia Generale per le Erogazioni in Agricoltura)<br />
Agenda 21: documento nel quale viene esposto il programma di attuazione della Dichiarazione di<br />
Rio de Janeiro (vedi UNCED). Esso affronta temi che vanno dalla demografia al commercio, dal<br />
trasferimento delle tecnologie alle istituzioni internazionali, dallo sviluppo rurale agli oceani, ecc.,<br />
indicando per ciascuno linee d’azione che, sebbene non vincolanti sul piano legale, riflettono il<br />
consenso sostanziale dei partecipanti alla Conferenza di Rio.<br />
Anidride carbonica: gas inerte, incolore, inodore, non tossico e non infiammabile, presente<br />
naturalmente nell’atmosfera. Viene originato anche dalla combustione dei combustibili fossili, della<br />
biomassa e dall’uso del territorio, a seguito del rilascio di carbonio (vedi). Rappresenta il principale<br />
gas serra (vedi) e costituisce circa l’81% delle emissioni di gas serra dei paesi soggetti ai vincoli del<br />
Protocollo di Kyoto. L’aumento della sua concentrazione nell’atmosfera è la causa principale del<br />
global warming. Il rapporto di massa tra carbonio ed anidride carbonica è pari a 12/44.<br />
Annex A: annesso al Protocollo di Kyoto in cui vengono esplicitati i sei gas serra (vedi Greenhouse<br />
Gas) oggetto dell’accordo.<br />
Annex B Countries: elenco di paesi, inclusi nell’annesso B del Protocollo di Kyoto, che hanno<br />
accettato di rispettare un vincolo per le proprie emissioni di gas serra. L’Annex B coincide in larga<br />
parte, ma non del tutto, con l’Annex I: ad esempio, l’Annex B include la Croazia, la Slovenia, il<br />
Liechtenstein ed il Principato di Monaco, che non sono inclusi nell’Annex I.<br />
254
Annex I Countries: elenco di paesi inclusi nell’annesso I alla UNFCCC (vedi) che include i paesi<br />
OCSE e quelli con economie in transizione (Europa centrale e dell’Est, esclusa la ex-Jugoslavia e<br />
l’Albania). Nell’articolo 4.2 a e 4.2 b della UNFCCC tali paesi si impegnavano alla stabilizzazione<br />
delle emissioni di gas serra ai livelli dell’anno 1990. Tutti gli altri paesi non inclusi nell’elenco<br />
vengono solitamente definiti Non-Annex I. Il Protocollo di Kyoto fa riferimento a riduzioni<br />
quantitative delle emissioni di gas serra dei paesi Annex I, tuttavia ne definisce i valori quantitativi<br />
nell’anesso B (vedi Annex B Countries).<br />
Annex II Countries: elenco di paesi, inclusi nell’annesso II della UNFCCC (vedi) che include i<br />
paesi OCSE, ovvero quei paesi che, secondo gli articoli 4.3, 4.4 e 4.5 della UNFCCC, dovrebbero<br />
promuovere il trasferimento di tecnologia pulita ai paesi in via di sviluppo.<br />
AOSIS (Alliance of Small Island States): gruppo di piccole isole e di paesi costieri<br />
particolarmente sensibili agli effetti del cambiamento climatico. Costituitosi nel 1990, include più<br />
di 40 paesi posizionati negli oceani, nell’area caraibica, nel Mediterraneo.<br />
Approccio ecosistemico: si basa sull’applicazione di metodologie scientifiche focalizzate sui<br />
diversi livelli di organizzazione biologica e comprendente i processi, le funzioni e le interazioni tra<br />
gli organismi e il loro ambiente.<br />
Assigned Amount: ammontare di gas serra che ogni paese soggetto a vincolo di emissione si è<br />
impegnato a non superare nel periodo 2008-2012 (vedi Commitment Period). Per ciascun paese,<br />
esso si calcola moltiplicando le sue emissioni di gas serra al 1990 per 5 (i 5 anni del commitment<br />
period) e, poi, per la percentuale prevista nell’Annex B (vedi anche Annex B Countries e Part of<br />
Assigned Amount).<br />
Banking: possibilità prevista dall’art. 3.13 del Protocollo di Kyoto che consente ad un paese<br />
soggetto a vincolo di emissione di utilizzare riduzioni delle proprie emissioni di gas-serra in<br />
eccesso rispetto al proprio target per periodi successivi al primo Commitment Period (vedi). Mentre<br />
il banking è ammesso dal Protocollo, il borrowing, ovvero l’utilizzo nel primo periodo di impegno<br />
di crediti emergenti in momenti ad esso successivi, è escluso.<br />
BAPA (Buenos Aires Plan of Action): Piano d’Azione approvato a Buenos Aires nel 1998, al<br />
termine della COP 4 (vedi Conference of Parties), il cui obiettivo era di chiarire, entro l’anno 2000,<br />
alcune delle questioni irrisolte del Protocollo di Kyoto: in particolare, i meccanismi di Kyoto (vedi<br />
Kyoto Flexible Mechanisms) e questioni quali il finanziamento, il trasferimento di tecnologia e<br />
l’assistenza ai paesi in via di sviluppo al fine di minimizzare gli effetti negativi del cambiamento<br />
climatico.<br />
Baseline: linea di riferimento dalla quale si parte nel conteggio delle riduzioni delle emissioni dei<br />
gas serra nei progetti di Joint Implementation (vedi) o di Clean Development Mechanism (vedi). E’<br />
possibile ipotizzare diversi tipi di baseline: specifiche per progetto, ossia calcolate per un certo<br />
progetto e valide solo per quello; specifiche per settore; specifiche per tecnologia; regionali, per<br />
paesi, per macroaree, ecc. Rispetto all’orizzonte temporale, invece, le baseline possono essere<br />
costanti, cioè lasciate inalterate per tutto il periodo di vita del progetto, oppure dinamiche, cioè<br />
soggette a variazione in ragione dei cambiamenti tecnologici che emergono nel corso del tempo. La<br />
rilevanza del dibattito sull’argomento scaturisce dal fatto che baseline stringenti limitano il<br />
potenziale di ERU (vedi) e di CER (vedi) mentre baseline ampie hanno l’effetto opposto.<br />
255
Berlin Mandate: accordo, raggiunto alla COP 1 di Berlino (1995), che ha costituito la base del<br />
Protocollo di Kyoto (vedi Conference of the Parties e AGBM).<br />
Bubble: possibilità, prevista dall’art. 4 del Protocollo di Kyoto, di adempiere al vincolo sulle<br />
emissioni di gas-serra per macroregioni (bubble). L’Unione Europea rappresenta una bolla, ovvero<br />
ha un target globale del - 8% che, in un secondo tempo, è stato ripartito tra i diversi stati (Italia: -<br />
6,5%; Francia: 0%; Germania: -21%; UK: -12,5%; ecc.).<br />
Buco dell’ozono: deterioramento dello strato d’ozono in prossimità delle calotte polari originato<br />
dall’immissione in atmosfera dei clorofluorocarburi (vedi), gas inerti usati nei circuiti di<br />
raffreddamento e nelle bombolette spray. L’ozono è il gas atmosferico capace di evitare che le<br />
radiazioni solari ultraviolette più dannose raggiungano la terra: per questol’impoverimento<br />
dell’ozono in entrambi gli emisferi causa malattie alla pelle (melanomi) e morte della fauna e della<br />
flora. Al fine di contenere tali effetti nocivi, i paesi hanno adottato il Protocollo di Montreal (vedi<br />
Protocollo di Montreal; vedi idrofluorocarburi).<br />
Capacity building: azioni che hanno l’obiettivo di rafforzare la capacità dei paesi in via di sviluppo<br />
di fronteggiare il cambiamento climatico e di crescere economicamente nel rispetto dell’ambiente.<br />
Costituisce uno dei blocchi di discussione delle COP (vedi Conference of Parties).<br />
Carbonio: elemento chimico (C) diffuso in natura, costituente fondamentale di flora e fauna.<br />
Presente in atmosfera in forma di anidride carbonica (1 t C = 3,67 t CO2 ; 1 t CO2 = 0,273 t C),<br />
riveste un ruolo fondamentale nel trasferimento di energia e massa lungo le reti trofiche.<br />
CDM (Clean Development Mechanism): meccanismo flessibile previsto dall’art. 12 del Protocollo<br />
di Kyoto attraverso il quale i paesi soggetti a vincolo di emissione (vedi Annex I Countries)<br />
possono realizzare progetti in paesi in via di sviluppo ed in tal modo sia favorire lo sviluppo di quei<br />
paesi sia generare riduzioni di emissioni certificate (vedi CER) addizionali rispetto a quelle che<br />
sarebbero state originate da progetti alternativi standard. Le CERs possono essere utilizzate dai<br />
paesi Annex I che hanno realizzato il progetto per adempiere i loro obblighi di emissione nel<br />
Commitment Period (vedi). Le parti possono generare CERs a partire dal 2000 (vedi anche<br />
Additionality e Baseline).<br />
CER (Certified Emission Reduction): certificati di riduzione delle emissioni, che consistono in un<br />
definito ammontare di riduzione delle emissioni di gas-serra realizzato attraverso un progetto di<br />
CDM (Clean Development Mechanism, vedi).<br />
CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica)<br />
Clorofluorocarburi (CFC): derivati del metano, dell'etano, o del propano. Si tratta di prodotti<br />
gassosi, inerti, impiegati per lungo tempo come propellenti di aerosol, spray, come fluidi nei circuiti<br />
frigoriferi, ecc. Sono composti biologicamente inerti, che vengono attaccati dall'ozono che si trova<br />
nelle fasce alte dell'atmosfera, contribuendo a ridurne lo spessore fino ad eliminarlo (vedi Buco<br />
dell'ozono; vedi Protocollo di Montreal). Al posto dei CFC sono stati proposti gli<br />
idroclorofluorocarburi (vedi) che sono più facilmente biodegradabili.<br />
Commitment Period: periodo di tempo entro il quale le parti soggette ai vincoli di emissione<br />
previsti dal Protocollo di Kyoto devono rispettare tali vincoli. Il primo periodo di adempimento va<br />
dal 2008 al 2012. Il secondo periodo dovrà essere definito entro il 2005.<br />
256
Compliance: adempimento degli obblighi previsti dal Protocollo di Kyoto (art. 18). Le COP (vedi<br />
Conference of Parties) non hanno ancora definito i provvedimenti per i casi di non rispetto<br />
dell’accordo (non-compliance).<br />
COP (Conference of the Parties): organo della UNFCCC (vedi) che ha come finalità principale<br />
l’implementazione della Convenzione. A tal fine può dar vita ad iniziative che hanno valenza legale<br />
(legal instruments). Si riunisce una volta l’anno. La prima Conferenza delle Parti si è tenuta a<br />
Berlino nel 1995. La terza, tenutasi a Kyoto nel 1997, ha originato il Protocollo di Kyoto. La COP è<br />
assistita da due organi: il Subsidiary Body for Implementation (vedi) ed il Subsidiary Body for<br />
Scientific and Technical Advice (vedi). La COP opera anche come Meeting of the Parties (MOP,<br />
vedi).<br />
Cropland Management: gestione delle terre agricole.<br />
Deforestation: distruzione di aree coperte da vegetazione (boschi, foreste, ecc.), derivante da<br />
incendi, disboscamenti, siccità, cambiamenti climatici, ecc.<br />
DEM (Digital Elevation Model): modello di dati raster che rappresenta l’elevazione del terreno.<br />
Può essere generato a partire da piani quotati o da curve di livello.<br />
DIGITALE: informazione esprimibile mediante numeri interi che è possibile memorizzare su<br />
supporto magnetico.<br />
Domestic Actions: azioni di politica energetico-ambientale realizzate all’interno di un paese al fine<br />
di rispettare il vincolo definito nel Protocollo di Kyoto. Alternativamente, i paesi hanno la<br />
possibilità di rispettare il vincolo ricorrendo ai meccanismi di Kyoto (vedi Kyoto Flexible<br />
Mechanisms).<br />
DTM (Digital Terrain Model): Modello Digitale del Terreno. Comprende DEM e TIN.<br />
Early Credit: crediti anticipati previsti dall’art. 12 del Protocollo di Kyoto per i progetti di CDM<br />
(Clean Devolpment Mechanism, vedi). Le riduzioni di emissioni (vedi CER) derivanti da progetti di<br />
CDM a partire dal 2000 possono essere utilizzate per adempiere gli obblighi nel primo Commitment<br />
Period (vedi).<br />
EC (European Commission)<br />
ECCM (The Edinburgh Centre for Carbon Management)<br />
ECCP (European Climate Change Programme): gruppo di lavoro sul sequestro di carbonio delle<br />
foreste europee.<br />
EEA (European Environmental Agency)<br />
Effetto serra: aumento della temperatura terrestre originato dai gas-serra (vedi), naturalmente<br />
presenti nell’atmosfera. L’aumento della loro concentrazione, a seguito della crescita delle attività<br />
industriali, di trasporto e di consumo di natura antropogenica, è all’origine del Global Warming<br />
(vedi).<br />
257
EIT (Economies in Transition): economie in transizione, paesi dell’ex blocco sovietico ora in<br />
trasformazione verso l’economia di mercato.<br />
Eligibility: termine usato nel dibattito post-Kyoto con riferimento ai progetti di CDM (Clean<br />
Development Mechanism, vedi) e JI (Joint Implementation, vedi) ed ai criteri che dovrebbero essere<br />
utilizzati per la loro approvazione. Deve essere ancora chiarito se, ed in che misura, i progetti che<br />
prevedono l’assorbimento di carbonio (vedi Sinks e Land Use, Land Use Change and Forestry)<br />
siano eleggibili, ovvero ammissibili, in particolare nell’ambito di programmi di CDM.<br />
ERU (Emission Reduction Unit): unità di rimozione per i JI project; una ERU rappresenta un<br />
definito ammontare di riduzione delle emissioni di gas serra realizzato attraverso un progetto di JI<br />
(Joint Implementation, vedi), oppure scambiato nell’ambito dell’Emissions Trading (vedi).<br />
Esafluoruro di zolfo (SF6): gas serra compreso nel basket oggetto del Protocollo di Kyoto.<br />
ET (Emissions Trading): meccanismo flessibile, previsto dall’art. 17 del Protocollo di Kyoto, che<br />
prevede lo scambio di emissioni di gas serra realizzato tra Paesi soggetti a vincolo di emissione. In<br />
particolare, i paesi Annex I (vedi Annex I Countries) che riducono le emissioni in misura maggiore<br />
rispetto al target che hanno sottoscritto, possono vendere tale surplus ad altri Paesi soggetti a<br />
vincolo di emissione. Secondo il Protocollo, le commodity che possono essere oggetto di scambio<br />
sono due: “any part of an assigned amount” (vedi Part of Assigned Amount), cioè le emissioni dei<br />
paesi dell’Annex I sottoposti al rispetto di un vincolo, ed “any Emission Reduction Unit” (vedi),<br />
cioè le ERUs ottenute attraverso progetti di JI (Joint Implementation, vedi). Non è chiaro, invece,<br />
dal Protocollo, se sia scambiabile anche il terzo tipo di commodity, le CERs (Certified Emission<br />
Reduction, vedi), derivanti dalla realizzazione di progetti di CDM (Clean Development Mechanism,<br />
vedi) (vedi anche Fungibility).<br />
FAO (Food and Agriculture Organization)<br />
Flexibility Mechanisms: vedi Kyoto FlexibleMechanisms.<br />
Forest Management: gestione delle foreste.<br />
FRA2000 (Forest Resources Assessment 2000)<br />
Full Carbon accounting: approccio sostenuto dall’Umbrella Group tendente ad includere qualsiasi<br />
tipo di attività che ricada nella gestione del territorio agricolo e forestale nel senso più ampio del<br />
termine: fertilizzazione, diradamento, verde urbano, colonizzazione naturale da parte del bosco di<br />
coltivi abbandonati.<br />
Fungibility: termine usato nel dibattito post-Kyoto con riferimento agli scambi da realizzare<br />
nell’ambito dell’Emissions Trading (vedi). In particolare, il problema che tali scambi pongono è se<br />
le CER (vedi) acquisite nell’ambito di progetti di CDM (vedi), possano essere assimilate del tutto<br />
alle ERU (Emission Reduction Unit, vedi) e alle PAA (Part of Assigned Amount, vedi), ovvero se le<br />
CER possano diventare oggetto di scambio nell’ambito dell’Emissions Trading (vedi).<br />
Gas-serra o Greenhouse Gas (GHG): gas che concorrono all’effetto serra naturale, accrescendone<br />
l’intensità. Il Protocollo di Kyoto (vedi) ne prende in considerazione sei: anidride carbonica (CO2)<br />
258
(vedi), metano (CH4), ossido di azoto (N2O) (vedi), idrofluorocarburi (HFCs), perfluorocarburi<br />
(PFCs), esafluoruro di zolfo (SF6). Vedi anche Global Warming Potential (GWP).<br />
GCH (Ground Control Height): punti di controllo di altezza dal suolo.<br />
GCP (Ground Control Point): punti di controllo al suolo.<br />
GHG (Green House Gas): gas ad effetto serra.<br />
Global Environmental Facility (GEF): fondo gestito dalla World Bank, dall’UNEP (United<br />
Nations Environment Programme, vedi) e dall’UNDP (United Nations Development Programme,<br />
vedi), destinato ai progetti ambientali nell’ambito dei diversi trattati internazionali. Il GEF<br />
rappresenta anche il meccanismo finanziario di cui si serve la UNFCCC (vedi).<br />
Global Warming: aumento della temperatura terrestre originato dalla crescita della concentrazione<br />
dei gas serra (vedi Greenhouse Gas) nell’atmosfera. Causa di tale crescita sono le attività<br />
industriali, di trasporto e di consumo dell’uomo legate, principalmente, alla combustione dei<br />
combustibili fossili.<br />
GPG (Good Practice Guidance of Land Use, Land-use Change and Forestry)<br />
Grazing land management: gestione dei prati e dei pascoli.<br />
Gross-Net approach: approccio di contabilizzazione dei crediti in cui non è prevista la<br />
comparazione con un anno di riferimento (vedi Net-Net approach), come nel caso delle attività di<br />
forest management.<br />
GWP (Global Warming Potential): misura dell’effetto relativo di una sostanza nel riscaldare<br />
l’atmosfera in un dato periodo di tempo (100 anni nel caso del Protocollo di Kyoto) rapporto tra lo<br />
schermo radiante risultante dall’emissione in atmosfera di 1 Kg di un gas serra e quello risultante<br />
dall’emissione di 1 Kg di anidride carbonica, in un certo periodo di tempo. In altri termini, il GWP<br />
misura il contributo al riscaldamento dell’atmosfera, in un certo arco di tempo, di un gas-serra in<br />
rapporto alla CO2 presa come gas di riferimento. Dato un orizzonte temporale di 100 anni, alla CO2<br />
è assegnato un GWP di 1. Per gli altri gas-serra del Protocollo: il metano (CH4) ha un GWP di 23;<br />
l’ossido di azoto (N2O) di 310; i perfluorocarburi (PFC) hanno un GWP compreso tra 6.500 e<br />
9.200 e gli idrofluorocarburi (HFC) compreso tra 140 e 11.700 ; infine l’esafluoruro di zolfo (SF6)<br />
ha un GWP di 23.900.<br />
Hot Air: il surplus nell’abbattimento delle emissioni di gas serra rispetto al target previsto dal<br />
Protocollo di Kyoto, da parte di alcuni paesi, in particolare Russia e Ucraina. Effetto della<br />
depressione economica, tale surplus di abbattimento potrebbe alimentare gli scambi di emissioni tra<br />
paesi (vedi Emissions Trading).<br />
Idrofluorocarburi (HFC): gas industriali (costituiti da idrogeno, fluoro, cloro e carbonio)<br />
utilizzati come sostituti dei clorofluorocarburi (vedi), rispetto ai quali hanno un impatto distruttivo<br />
dell’ozono inferiore del 95% (vedi anche Buco dell’ozono e Protocollo di Montreal).<br />
IFN85 (Inventario Forestale Nazionale 1985)<br />
259
IGBP (International Geosphere-Biosphere Programme)<br />
IGM (Istituto Geografico Militare)<br />
IHDP (International Human Dimensions Programme on Global Environmental Change)<br />
INFC (Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi di Carbonio)<br />
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate change): gruppo di esperti nominato congiuntamente<br />
nel 1988 da WMO (World Metereological Organization) e dell’UNEP (United Nations<br />
Environment Programme, vedi). Esso ha come fine quello di preparare rapporti, studi, valutazioni e<br />
linee guide sul cambiamento climatico e sui suoi effetti potenziali. Organizzato in 4 Gruppi di<br />
Lavoro [(I, Scienza; II) Impatto, Adattamento e Vulnerabilità); III) Mitigazione); IV)<br />
Contabilizzazione dei gas serra], l’IPCC assiste la COP (Conference of Parties, vedi) cui fornisce<br />
pareri tecnici, scientifici e socioeconomici.<br />
ISAFA (Istituto Sperimentale per l’Assestamento Forestale e l’Alpicoltura)<br />
IUCN (Union for the Conservation of Nature and Natural Resources)<br />
JI (Joint Implementation): meccanismo flessibile previsto dall’art. 6 del Protocollo di Kyoto<br />
attraverso il quale i paesi soggetti a vincolo di emissione (vedi Annex I Countries) possono<br />
realizzare progetti in altri paesi Annex I ed in tal modo generare ERU (vedi) addizionali rispetto a<br />
quelle che sarebbero state originate da progetti alternativi standard. Esso differisce dal Clean<br />
Development Mechanism (vedi) perché non prevede né la realizzazione di progetti in paesi in via di<br />
Kyoto Flexible Mechanisms: meccanismi previsti dal Protocollo di Kyoto per consentire ai paesi<br />
soggetti a vincolo di contenimento delle emissioni di adempiere i loro obblighi non solo attraverso<br />
gli interventi domestici (vedi Domestic Actions); anche definiti Kyoto Flexible Mechanisms,<br />
comprendono l’Emissions Trading (vedi), la Joint Implementation (vedi) e il Clean Development<br />
Mechanism (vedi).<br />
Land Cover (LC): la copertura fisica e biologica della Terra, ad esempio la vegetazione e gli<br />
insediamenti umani.<br />
Land Use (LU): l’insieme delle attività sociali ed economiche riferibili alla copertura del suolo e a<br />
cui la gestione del territorio è finalizzata.<br />
Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF): insieme di attività legate all’uso del<br />
territorio per le quali l’UNFCCC e il Protocollo di Kyoto chiedono ai Paesi firmatari di riportare i<br />
bilanci dei gas-serra, secondo modalità e linee guida definite in ambito IPCC.<br />
<strong>MA</strong>TT (Ministero Ambiente e Tutela del Territorio)<br />
Meeting of the Parties (MOP): organo del Protocollo di Kyoto che ha potere di riunirsi solo<br />
quando il Protocollo entrerà in azione. Il MOP è l’unico organo che può emendare il Protocollo. Per<br />
evitare duplicazioni la COP (Conference of Parties, vedi) agisce anche come MOP.<br />
260
Metano (CH4): gas-serra compreso tra i sei elencatI in un apposito allegato del Protocollo di<br />
Kyoto, per il quale si richiede un contenimento dei livelli di emissione.del Protocollo di Kyoto.<br />
National Communication: comunicazione periodica dei Paesi aderenti al Protocollo prevista dalla<br />
UNFCCC (vedi) e dal Protocollo di Kyoto attraverso la quale i paesi danno informazioni circa<br />
l’adempimento degli obblighi da essi assunti. Le comunicazioni nazionali contengono, pertanto,<br />
informazioni sia sulle emissioni sia sulle politiche e sulle azioni domestiche (vedi Domestic<br />
Actions).<br />
NEP (Net Ecosystem Productivity)<br />
Net-net approach: approccio di contabilizzazione dei crediti in cui è prevista la comparazione con<br />
un anno di riferimento (1990). Nell'ambito degli Accordi di Marrakesh, è l'approccio da usare per<br />
le attività di grazing land e cropland management e revegetation.<br />
NPP (Net Primary Production)<br />
OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)<br />
OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio)<br />
http://www.mincomes.it/OMC/confmin.htm<br />
Ossido di azoto (N2O): gas-serra compreso nel basket oggetto del Protocollo di Kyoto.<br />
OTA (Office of Technology Assessment)<br />
PAC (Politica Agricola Comunitaria): politica promossa dagli Stati membri dell’UE a sostegno<br />
dell’agricoltura e nota anche come Riforma McSharry dal nome del commissario europeo<br />
proponente. Il 26 giugno 2003 i ministri europei dell'agricoltura ne hanno approvato una radicale<br />
riforma e la nuova PAC è orientata verso gli interessi dei consumatori e dei contribuenti e, nello<br />
stesso tempo, lascia gli agricoltori liberi di produrre ciò che esige il mercato.<br />
Per evitare l'abbandono della produzione, gli Stati membri possono scegliere di mantenere ancora<br />
una certa correlazione tra sovvenzioni e produzione, a precise condizioni ed entro limiti<br />
chiaramente definiti. La concessione di questo nuovo "pagamento unico per azienda" è subordinata<br />
al rispetto delle norme in materia di salvaguardia ambientale, sicurezza alimentare e protezione<br />
degli animali. I fondi che si renderanno reperibili grazie alla riduzione dei pagamenti diretti a<br />
favore delle grandi aziende saranno messi a disposizione degli agricoltori per realizzare programmi<br />
in materia di ambiente, qualità o benessere degli animali. Il Consiglio ha inoltre deciso di rivedere i<br />
settori del latte, del riso, dei cereali, del frumento duro, dei foraggi essiccati e della frutta a guscio.<br />
Al fine di rispettare gli stretti vincoli di bilancio fissati per l'UE a 25 da qui al 2013, i ministri<br />
hanno convenuto di introdurre un meccanismo di disciplina finanziaria. La riforma rafforzerà anche<br />
la posizione negoziale dell'UE nelle trattative commerciali in corso nell'ambito dell'OMC<br />
(Organizzazione Mondiale per il Commercio).<br />
http://europa.eu.int/comm/agriculture/capreform/index_it.htm<br />
Part of Assigned Amount (PAA): parte dell’ammontare assegnato (vedi Assigned Amount) che<br />
costituisce oggetto di transazione nell’ambito dell’Emissions Trading (vedi) (vedi anche<br />
Fungibility).<br />
261
Perfluorocarburi (PFC): gas industriali compresi nel basket oggetto del Protocollo di Kyoto.<br />
PFA: scenario delle Politiche Forestali Attive in cui si ipotizzano politiche di incentivazione attive<br />
e un trend positivo di messa a coltura degli impianti.<br />
Pixel: ogni singola unità elementare da cui è composta una immagine digitale.<br />
Policies and Measures (PAM): azioni, interventi, politiche, tecnologie e processi intrapresi da un<br />
paese, isolatamente o in modo coordinato con altri paesi, per mitigare le emissioni di gas serra (vedi<br />
Greenhouse Gas).<br />
Protocollo di Kyoto: accordo internazionale per la riduzione delle emissioni di gas-serra. Siglato a<br />
Kyoto nel dicembre 1997, il Protocollo è entrato in vigore il 16 febbraio 2005, a 90 giorni dalla<br />
ratifica del Protocollo effettuata da almeno 55 Parti aderenti alla UNFCCC (United Nations<br />
Framework Convention on Climate Change, vedi), le cui emissioni rappresentino almeno il 55%<br />
del totale delle emissioni di anidride carbonica, al 1990, dei paesi OCSE e delle Economie in<br />
Transizione (paesi dell’Europa Centrale e dell’Est). I gas oggetto dell’accordo sono sei: anidride<br />
carbonica (CO2), metano (CH4), ossido di azoto (N2O), esafluoruro di zolfo (SF6),<br />
idrofluorocarburi (HFCs) e perfluorocarburi (PFCs). Il valore medio di riduzione delle emissioni<br />
(misurate in CO2 equivalenti) è pari al 5,2%. Alcuni significativi tassi di riduzione sono: Europa, -<br />
8%; USA, -7%; Canada, Ungheria, Polonia e Giappone, -6%; Russia, Ucraina e Nuova Zelanda,<br />
0%; Norvegia, +1%; Australia, +8%; Islanda, +10%. L'obiettivo di riduzione è da realizzare<br />
nell’intervallo 2008-2012, utilizzando come anno base il 1990 per i primi tre gas o, per i restanti tre<br />
e a discrezione delle Parti, il 1995.<br />
Protocollo di Montreal: adottato nel 1987 da un gruppo di venticinque Paesi e divenuto effettivo<br />
l’1/1/89, il Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer ha come obiettivo, per i<br />
Paesi sviluppati, la riduzione dell’uso dei clorofluorcarburi (vedi) del 50% entro il 1992, rispetto ai<br />
livelli del 1986, al fine di limitare il danno che possono arrecare allo scudo d’ozono (vedi Buco<br />
dell’ozono). Ai Paesi in via di sviluppo, invece, il protocollo di Montreal concede un periodo di<br />
adattamento di dieci anni. I vincoli stabiliti dal Protocollo sono stati in seguito irrigiditi dagli<br />
accordi di Helsinki (1989), Londra (1990) e Copenaghen (1992), ai quali hanno aderito oltre 100<br />
paesi, che prevedono l’eliminazione dei clorofluorcarburi entro il 2000. Gli idrofluorocarburi<br />
(vedi), generalmente usati come sostituti dei clorofluorocarburi, vengono proibiti con gradualità in<br />
un periodo di 35 anni che ha termine nel 2030.<br />
PSR: scenario relativo ai Piani di Sviluppo Rurale, da Reg. CEE 1257/99 (ex 2080/92), in cui si<br />
ipotizza che, in funzione di tale Reg. e del mercato dei prodotti dei rimboschimenti così com’è<br />
attualmente, si riducano notevolmente gli impianti a bosco di notevoli superfici.<br />
Raster: struttura dei dati in forma di matrice numerica in cui ogni cella contiene un valore<br />
corrispondente ad un attributo. La posizione spaziale di un elemento è quindi implicitamente<br />
rappresentata dalla posizione della cella.<br />
Reforestation: costituzione di piantagioni con specie forestali su terre già forestate in passato, ma<br />
distrutte o depauperate nel tempo a causa dell’attività umana, di incendi, ecc.<br />
RMU (Removal Units): unità di riduzione per i carbon sink.<br />
262
Sink: ecosistemi, foreste ed in generale qualunque attività, processo o meccanismo in grado di<br />
rimuovere un gas-serra, un aerosol o un precursore di gas-serra dall’atmosfera, assorbendolo<br />
dall’atmosfera. Il Protocollo di Kyoto prevede che i paesi soggetti a vincolo di emissione possano<br />
fare uso, per assorbire il carbonio, delle attività di LULUCF (Land Use, Land Use Change and<br />
Forestry, vedi). Un determinato pool o riserva può divenire un sink di carbonio atmosferico se,<br />
durante un dato periodo di tempo, la quantità di C assorbita è superiore alla quantità rilasciata.<br />
SISEF (Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale)<br />
Source: opposto di removal, indica qualsiasi fonte di emissione di gas-serra in atmosfera.<br />
Stock: la quantità assoluta di C contenuta in un pool in un dato momento temporale.<br />
Subsidiary Body for Implementation (SBI): organo che assiste la COP (Conference of Parties,<br />
vedi) nella verifica dell’implementazione della Convenzione e nella preparazione ed<br />
implementazione delle sue decisioni. Si riunisce una o due volte l’anno.<br />
Subsidiary Body for Scientific and Technical Advice (SBSTA): organo con finalità di carattere<br />
tecnico che assiste la COP (Conference of Parties, vedi) nella verifica dello stato della conoscenza<br />
scientifica sul cambiamento climatico, degli effetti delle misure prese nell’implementazione della<br />
Convenzione, ed in generale fornisce assistenza su ricerca, tecnologia e programmi scientifici<br />
rilevanti per il cambiamento climatico. Si riunisce una o due volte l’anno.<br />
Supplementarity: termine originato dagli articoli sulla Joint Implementation (vedi) e sull’Emissions<br />
Trading (vedi) del Protocollo di Kyoto, nei quali si afferma che tali meccanismi flessibili (vedi<br />
Kyoto Flexible Mechanisms) debbano essere supplementari alle azioni domestiche, ovvero agli<br />
interventi sul territorio nazionale (es. tassazione ambientale, risparmio energetico) che mitigano le<br />
emissioni di gas serra. In altri termini, i paesi soggetti a vincolo di emissione possono rispettare il<br />
proprio target facendo uso della Joint implementation e delI’Emissions Trading solo limitatamente.<br />
Sviluppo sostenibile: “Sviluppo che soddisfa le esigenze del presente senza compromettere la<br />
possibilità per le future generazioni di soddisfare le loro esigenze” (definizione della WCED<br />
riportata nel rapporto “Our Common Future” del 1987). Sostenibilità, pertanto, implica equità<br />
intergenerazionale, ovvero il non trasferimento dei costi ambientali della crescita (alti livelli di<br />
inquinamento, depauperamento delle risorse, degradamento dell’ambiente, danni irreparabili<br />
all’ecosistema, ecc.) dalle generazioni correnti a quelle future. L’equità tra paesi ricchi e paesi<br />
poveri, d’altra parte, rappresenta il secondo cardine dello sviluppo sostenibile. Numerose altre<br />
definizioni, non sempre coerenti tra di loro, sono state proposte. Pertanto, molto dibattuto sia sul<br />
piano scientifico che su quello politico, lo sviluppo sostenibile costituisce oggi un concetto dai<br />
contorni non rigidamente definit. Le diverse gradazioni in cui si si articola (very weak, weak,<br />
strong, very strong sustainability) testimoniano l’esistenza di gradi di libertà nella sua<br />
interpretazione.<br />
TIN (Triangular Irregular Network): modello tridimensionale vettoriale del terreno generato da<br />
un insieme sparso di punti quotati (piano quotato) costituito da una rete di triangoli.<br />
Umbrella Group: gruppo di paesi che, in alcune negoziazioni sul cambiamento climatico, ha<br />
operato come un unico blocco. Ne fanno parte USA, Canada, Nuova Zelanda, Australia e<br />
Giappone.<br />
263
UNCCD (United Nations Convention to combat Desertification): convenzione internazionale per<br />
la lotta contro il fenomeno della desertificazione.<br />
UNCED (United Nations Conference on Environment and Development): conferenza tenuta a<br />
Rio De Janeiro nel giugno 1992. Essa ha originato cinque documenti formali: cambiamenti<br />
climatici, biodiversità, foreste, “Rio Declaration on Environment and Development” e “Agenda<br />
21”. Nella Dichiarazione, che consiste di un preambolo e di 27 principi, vengono date indicazioni<br />
volte a promuovere un più sano ed efficiente rapporto tra uomo e ambiente. In particolare, si<br />
richiama l’attenzione su un numero di argomenti rilevanti per l’ambiente, tra i quali l’equità<br />
intergenerazionale, i bisogni del mondo povero, la cooperazione tra stati, la responsabilità civile e<br />
la compensazione dei danni ambientali, il principio inquinatore-pagatore, la valutazione d’impatto<br />
ambientale.<br />
UNDP (United Nations Development Programme): organismo delle Nazioni Unite la cui finalità è<br />
l’assistenza allo sviluppo dei paesi poveri, favorendo in essi percorsi sostenibili di sviluppo.<br />
UN-ECE (United Nations - Economic Comission for Europe)<br />
UNEP (United Nations Environment Programme): organismo delle Nazioni Unite la cui finalità è<br />
il coordinamento delle azioni a favore dell’ambiente intraprese dai paesi da istituzioni governative e<br />
non.<br />
UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change): convenzione delle<br />
Nazioni Unite che ha come obiettivo ultimo la stabilizzazione della concentrazione dei gas serra<br />
nell’atmosfera a livelli non pericolosi ed in tempi utili. Siglata alla Conferenza di Rio de Janeiro del<br />
1992, la UNFCCC prevede per i paesi industrializzati, come primo obiettivo senza valore legale, la<br />
stabilizzazione delle emissioni di gas serra (vedi) ai livelli del 1990 entro l’anno 2000. Firmata e<br />
ratificata da più di 150 paesi, la UNFCCC costituisce la base del Protocollo di Kyoto (vedi).<br />
Unfinished Business: temi del Protocollo di Kyoto che devono essere ancora chiariti, ovvero<br />
rispetto ai quali le COP (Conference of Parties, vedi) non hanno ancora dato un’interpretazione<br />
univoca. Molti di essi concernono i meccanismi di Kyoto (vedi Kyoto Flexible Mechanisms) e<br />
questioni quali l’addizionalità (vedi Additionality), la supplementarità (vedi Supplementarity),<br />
l’eleggibilità (vedi Eligibility), la fungibilità (vedi Fungibility).<br />
Vegetazione naturale potenziale (VNP): è la vegetazione che tende a formarsi naturalmente in un<br />
certo luogo quando non è presente il disturbo antropico (Tuxen, 1956).<br />
WCED (World Commission on Environment and Development): organismo internazionale<br />
comunemente denominato “Commissione Brundtland” dal nome del primo ministro norvegese, Gro<br />
Harlem Brundtland, che lo ha presieduto. Istituito dalle Nazioni Unite nel 1983, questa<br />
commissione ha dato origine al rapporto “Our Common Future” (1987) in cui viene elaborato e<br />
definito il concetto di sviluppo sostenibile (vedi).<br />
WCRP (World Climate Research Programme)<br />
WPO (World Meteorological Organization)<br />
264
RINGRAZIAMENTI<br />
A mamma e papà, che hanno condiviso con me questi anni di studio e compreso i miei sforzi, e a<br />
mio fratello Stefano, che ho sentito vicino sempre.<br />
A Federico, che mi ha aiutato a perseverare nel raggiungimento di questo obiettivo, soprattutto<br />
quando mi sembrava più lontano.<br />
A Carolina, che un giorno è apparsa al mio orizzonte e da allora lo ha reso più gaio.<br />
*****************************<br />
Al Prof. Carlo Blasi che mi ha sostenuto ed incoraggiato, nutrendo fiducia nelle mie capacità e nella<br />
mia volontà di portare a conclusione in modo degno questo triennio di ricerca.<br />
Ai colleghi ricercatori che mi hanno consigliata, in particolar modo a Lorenzo Ciccarese.<br />
Ai colleghi di lavoro, che mi hanno sopportato in questi anni, prima per il conseguimento della<br />
laurea, poi per questo dottorato.<br />
265
Allegato 1<br />
Legenda dettagliata CORINE Land Cover III livello (fonte APAT)<br />
1. SUPERFICI ARTIFICIALI<br />
1.1. Zone urbanizzate di tipo residenziale<br />
1.1.1. Zone residenziali a tessuto continuo<br />
Spazi strutturati dagli edifici e dalla viabilità. Gli edifici, la viabilità e le superfici ricoperte<br />
artificialmente occupano più dell'80% della superficie totale.<br />
La vegetazione non lineare e il suolo nudo rappresentano l'eccezione. Sono qui compresi<br />
cimiteri senza vegetazione. Problema particolare degli abitati a sviluppo lineare (villes-rue):<br />
anche se la larghezza delle costruzioni che fiancheggiano la strada, compresa la strada stessa,<br />
raggiunge solo 75 m, e a condizione che la superficie totale superi i 25 ha, queste aree saranno<br />
classificate come tessuto urbano continuo (o discontinuo se le aree non sono congiunte).<br />
1.1.2. Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado<br />
Spazi caratterizzati dalla presenza di edifici. Gli edifici, la viabilità e le superfici a copertura<br />
artificiale coesistono con superfici coperte da vegetazione e con suolo nudo, che occupano in<br />
maniera discontinua aree non trascurabili. Gli edifici, la viabilità e le superfici ricoperte<br />
artificialmente coprono dal 50 all'80% della superficie totale. Si dovrà tenere conto di questa<br />
densità per le costruzioni localizzate all'interno di spazi naturali (foreste o spazi erbosi).<br />
Questa voce non comprende:<br />
- le abitazioni agricole sparse delle periferie delle città o nelle zone di coltura estensiva<br />
comprendenti edifici adibiti a impianti di trasformazione e ricovero; le residenze secondarie<br />
disperse negli spazi naturali o agricoli. Comprende invece cimiteri senza vegetazione.<br />
1.2. Zone industriali, commerciali ed infrastrutturali<br />
1.2.1. Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati<br />
Aree a copertura artificiale (in cemento, asfaltate o stabilizzate: per esempio terra battuta), senza<br />
vegetazione, che occupano la maggior parte del terreno. (Più del 50% della superficie).<br />
La zona comprende anche edifici e/o aree con vegetazione. Le zone industriali e commerciali<br />
ubicate nei tessuti urbani continui e discontinui sono da considerare solo se si distinguono<br />
nettamente dall'abitato. (Insieme industriale di aree superiore a 25 ha con gli spazi associati:<br />
muri di cinta, parcheggi, depositi, ecc.). Le stazioni centrali delle città fanno parte di questa<br />
categoria, ma non i grandi magazzini integrati in edifici di abitazione, i sanatori, gli stabilimenti<br />
termali, gli ospedali, le case di riposo, le prigioni, ecc.<br />
1.2.2. Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche<br />
Larghezza minima da considerare: 100 m.<br />
Autostrade, ferrovie, comprese le superfici annesse (stazioni, binari, terrapieni, ecc.) e le reti<br />
ferroviarie più larghe di 100 m che penetrano nella città. Sono qui compresi i grandi svincoli<br />
stradali e le stazioni di smistamento, ma non le linee elettriche ad alta tensione con vegetazione<br />
bassa che attraversano aree forestali.<br />
1.2.3. Aree portuali<br />
Infrastrutture delle zone portuali compresi i binari, i cantieri navali e i porti da diporto. Quando i<br />
moli hanno meno di 100 m., di larghezza, la superficie dei bacini (d'acqua dolce o salata)<br />
delimitati dagli stessi è da comprendere nel calcolo dei 25 ha.<br />
1
1.2.4. Aeroporti<br />
Infrastrutture degli aeroporti: piste, edifici e superfici associate. Sono da considerare solo le<br />
superfici che sono interessate dall'attività aeroportuale (anche se alcune parti di queste sono<br />
utilizzate occasionalmente per agricoltura-foraggio). Di norma queste aree sono delimitate da<br />
recinzioni o strade. In molti casi, l'area aeroportuale figura sulle carte topografiche a grande<br />
scala (1:25.000 e 1:50.000). Non sono compresi i piccoli aeroporti da turismo (con piste<br />
consolidate) ed edifici di dimensioni molto piccole.<br />
1.3. Zone estrattive, cantieri, discariche e terreni artefatti e abbandonati<br />
1.3.1. Aree estrattive<br />
Estrazione di materiali inerti a cielo aperto (cave di sabbia e di pietre) o di altri materiali<br />
(miniere a cielo aperto). Ne fanno parte cave di ghiaia, eccezion fatta, in ogni caso, per le<br />
estrazioni nei letti dei fiumi. Sono qui compresi gli edifici e le installazioni industriali associate.<br />
Rimangono escluse le cave sommerse, mentre sono comprese le superfici abbandonate e<br />
sommerse, ma non recuperate, comprese in aree estrattive. Le rovine, archeologiche e non, sono<br />
da includere nelle aree ricreative.<br />
1.3.2. Discariche<br />
Discariche e depositi di miniere, industrie e collettività pubbliche.<br />
1.3.3. Cantieri<br />
Spazi in costruzione, scavi e suoli rimaneggiati.<br />
1.4. Zone verdi artificiali non agricole<br />
1.4.1. Aree verdi urbane<br />
Spazi ricoperti di vegetazione compresi nel tessuto urbano. Ne fanno parte cimiteri con<br />
abbondante vegetazione e parchi urbani.<br />
1.4.2. Aree ricreative e sportive<br />
Aree utilizzate per camping, attività sportive, parchi di divertimento, campi da golf, ippodromi,<br />
rovine archeologiche e non, ecc. Ne fanno parte i parchi attrezzati (aree dotate intensamente di<br />
attrezzature ricreative, da picnic, ecc.) compresi nel tessuto urbano.<br />
N.B.: sono escluse le piste da sci, da classificare, di norma, come 2.3.1 e 3.2.1<br />
2. SUPERFICI AGRICOLE UTILIZZATE<br />
2.1. Seminativi<br />
Superfici coltivate regolarmente arate e generalmente sottoposte ad un sistema di rotazione.<br />
2.1.1. Seminativi in aree non irrigue<br />
Sono da considerare perimetri irrigui solo quelli individuabili per fotointerpretazione, satellitare<br />
o aerea, per la presenza di canali e impianti di pompaggio. Cereali, leguminose in pieno campo,<br />
colture foraggere, coltivazioni industriali, radici commestibili e maggesi. Vi sono compresi i<br />
vivai e le colture orticole, in pieno campo, in serra e sotto plastica, come anche gli impianti per<br />
la produzione di piante medicinali, aromatiche e culinarie. Vi sono comprese le colture<br />
foraggere (prati artificiali), ma non i prati stabili.<br />
2
2.1.2. Seminativi in aree irrigue<br />
Colture irrigate stabilmente e periodicamente grazie ad un'infrastruttura permanente (canale di<br />
irrigazione, rete di drenaggio). La maggior parte di queste colture non potrebbe realizzarsi senza<br />
l'apporto artificiale d'acqua. Non vi sono comprese le superfici irrigate sporadicamente.<br />
2.1.3. Risaie<br />
Superfici utilizzate per la coltura del riso.<br />
Terreni terrazzati e dotati di canali di irrigazione. Superfici periodicamente inondate.<br />
2.2. Colture permanenti<br />
Colture non soggette a rotazione che forniscono più raccolti e che occupano il terreno per un<br />
lungo periodo prima dello scasso e della ripiantatura: si tratta per lo più di colture legnose. Sono<br />
esclusi i prati, i pascoli e le foreste.<br />
2.2.1. Vigneti<br />
Superfici piantate a vigna<br />
2.2.2. Frutteti e frutti minori<br />
Impianti di alberi o arbusti fruttiferi: colture pure o miste di specie produttrici di frutta o alberi<br />
da frutto in associazione con superfici stabilmente erbate. Ne fanno parte i castagneti da frutto e<br />
i noccioleti. I frutteti di meno di 25 ha compresi nei terreni agricoli (prati stabili o seminativi)<br />
ritenuti importanti sono da comprendere nella classe 2.4.2.. I frutteti con presenza di diverse<br />
associazioni di alberi sono da includere in questa classe.<br />
2.2.3. Oliveti<br />
Superfici piantate ad olivo, comprese particelle a coltura mista di olivo e vite.<br />
2.3. Prati stabili (foraggere permanenti)<br />
2.3.1. Prati stabili (foraggere permanenti)<br />
Superfici a copertura erbacea densa a composizione floristica rappresentata principalmente da<br />
graminacee, non soggette a rotazione. Sono per lo più pascolate ma il foraggio può essere<br />
raccolto meccanicamente. Ne fanno parte i prati permanenti e temporanei e le marcite. Sono<br />
comprese inoltre aree con siepi. Le colture foraggere (prati artificiali inclusi in brevi rotazioni)<br />
sono da classificare come seminativi (2.1.1).<br />
2.4. Zone agricole eterogenee<br />
2.4.1. Colture temporanee associate a colture permanenti<br />
Colture temporanee (seminativi o prati) in associazione con colture permanenti sulla stessa<br />
superficie, quando le particelle a frutteto comprese nelle colture annuali non associate<br />
rappresentano meno del 25% della superficie totale.<br />
2.4.2. Sistemi colturali e particellari complessi<br />
Mosaico di piccoli appezzamenti con varie colture annuali, prati stabili e colture permanenti,<br />
occupanti ciascuno meno del 75% della superficie totale dell'unità.<br />
Vi sono compresi gli "orti per pensionati" e simili.. Eventuali "lotti" superanti i 25 ha sono da<br />
includere nelle zone agricole.<br />
3
2.4.3. Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali<br />
importanti<br />
Le colture agrarie occupano più del 25 e meno del 75% della superficie totale dell'unità.<br />
2.4.4. Aree agroforestali<br />
Colture annuali o pascolo sotto copertura arborea composta da specie forestali.<br />
3. TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMI-NATURALI<br />
3.1. Zone boscate<br />
3.1.1. Boschi di latifoglie<br />
Formazioni vegetali, costituite principalmente da alberi ma anche da cespugli e arbusti, nelle<br />
quali dominano le specie forestali a latifoglie. La superficie a latifoglie deve coprire almeno il<br />
75% dell'unità, altrimenti è da classificare bosco misto.<br />
N.B.: vi sono compresi i pioppeti e gli eucalitteti.<br />
3.1.2. Boschi di conifere<br />
Formazioni vegetali costituite principalmente da alberi ma anche da cespugli e arbusti, nelle<br />
quali dominano le specie forestali conifere. La superficie a conifere deve coprire almeno il 75%<br />
dell'unità, altrimenti è da classificare bosco misto. N.B.: vi sono comprese le conifere a rapido<br />
accrescimento.<br />
3.1.3. Boschi misti di conifere e latifoglie<br />
Formazioni vegetali, costituite principalmente da alberi ma anche da cespugli ed arbusti, dove<br />
non dominano né le latifoglie, né le conifere.<br />
3.2. Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea<br />
3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie<br />
Aree foraggere a bassa produttività. Sono spesso situate in zone accidentate. Interessano spesso<br />
superfici rocciose, roveti e arbusteti. Sulle aree interessate dalla classe non sono di norma<br />
presenti limiti di particelle (siepi, muri, recinti).<br />
3.2.2. Brughiere e cespuglietti<br />
Formazioni vegetali basse e chiuse, composte principalmente di cespugli, arbusti e piante<br />
erbacee (eriche, rovi, ginestre dei vari tipi ecc.). Vi sono comprese le formazioni a pino mugo.<br />
3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla<br />
Ne fanno parte macchie e garighe. Macchie: associazioni vegetali dense composte da numerose<br />
specie arbustive miste su terreni silicei acidi in ambiente mediterraneo. Garighe: associazioni<br />
cespugliose discontinue delle piattaforme calcaree mediterranee. Sono spesso composte da<br />
quercia coccifera, corbezzolo, lavanda, timo, cisto bianco, ecc. Possono essere presenti rari<br />
alberi isolati.<br />
3.2.4. Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione<br />
Vegetazione arbustiva o erbacea con alberi sparsi. Formazioni che possono derivare dalla<br />
degradazione della foresta o da una rinnovazione della stessa per ricolonizzazione di aree non<br />
forestali.<br />
4
3.3. Zone aperte con vegetazione rada o assente<br />
3.3.1. Spiagge, dune e sabbie<br />
Le spiagge, le dune e le distese di sabbia e di ciottoli di ambienti litorali e continentali, compresi<br />
i letti sassosi dei corsi d'acqua a regime torrentizio. Le dune ricoperte di vegetazione (erbacea o<br />
legnosa) devono essere classificate nelle voci corrispondenti: boschi (3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3), prati<br />
(2.3. 1) o aree a pascolo naturale (3.2.1)<br />
3.3.2. Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti<br />
3.3.3. Aree con vegetazione rada<br />
Comprende le steppe xerofile, le steppe alofile, le tundre e le aree calanchive in senso lato.<br />
3.3.4. Aree percorse da incendi<br />
Superfici interessate da incendi recenti. I materiali carbonizzati sono ancora presenti.<br />
3.3.5. Ghiacciai e nevi perenni<br />
Superfici coperte da ghiacciai o da nevi perenni.<br />
4. ZONE UMIDE<br />
4.1. Zone umide interne<br />
Zone non boscate, parzialmente, temporaneamente o permanentemente saturate da acqua<br />
stagnante o corrente.<br />
4.1.1. Paludi interne<br />
Terre basse generalmente inondate in inverno e più o meno saturate d'acqua durante tutte le<br />
stagioni.<br />
4.1.2. Torbiere<br />
Terreni spugnosi umidi nei quali il suolo è costituito principalmente da muschi e materiali<br />
vegetali decomposti. Torbiere utilizzate o meno.<br />
4.2. Zone umide marittime<br />
Zone non boscate, saturate parzialmente, temporaneamente o in permanenza da acqua salmastra<br />
o salata.<br />
4.2.1. Paludi salmastre<br />
Terre basse con vegetazione, situate al di sotto del livello di alta marea, suscettibili pertanto di<br />
inondazione da parte delle acque del mare. Spesso in via di riempimento, colonizzate a poco a<br />
poco da piante alofile.<br />
4.2.2. Saline<br />
Saline attive o in via di abbandono.<br />
Parti di paludi salmastre utilizzate per la produzione di sale per evaporazione. Sono nettamente<br />
distinguibili dal resto delle paludi per la forma regolare delle particelle e il loro sistema di<br />
argini.<br />
4.2.3. Zone intertidali<br />
5
Superfici limose, sabbiose o rocciose generalmente prive di vegetazione comprese fra il livello<br />
delle alte e basse maree.<br />
5. CORPI IDRICI<br />
5.1. Acque continentali<br />
5.1.1. Corsi d'acqua, canali e idrovie<br />
Corsi di acqua naturali o artificiali che servono per il deflusso delle acque. Larghezza minima da<br />
considerare: 100 m.<br />
5.1.2. Bacini d'acqua<br />
Superfici naturali o artificiali coperte da acque.<br />
5.2. Acque marittime<br />
5.2.1. Lagune<br />
Aree coperte da acque salate o salmastre, separate dal mare da barre di terra o altri elementi<br />
topografici simili. Queste superfici idriche possono essere messe in comunicazione con il mare<br />
in certi punti particolari, permanentemente o periodicamente.<br />
5.2.2. Estuari<br />
Parte terminale dei fiumi, alla foce, che subisce l'influenza delle acque.<br />
5.2.3. Mari e oceani<br />
Aree al di là del limite delle maree più basse.<br />
6
Allegato 2<br />
Legenda sintetica CORINE Land Cover IV Livello - con dettaglio al 4°livello per la classe<br />
3 e al 5° livello per la classe 3.1.3 (fonte APAT)<br />
1. SUPERFICI ARTIFICIALI<br />
1.1. Zone urbanizzate di tipo residenziale<br />
1.1.1. Zone residenziali a tessuto continuo<br />
1.1.2. Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado<br />
1.2. Zone industriali, commerciali ed infrastrutturali<br />
1.2.1. Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati<br />
1.2.2. Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche<br />
1.2.3. Aree portuali<br />
1.2.4. Aeroporti<br />
1.3. Zone estrattive, cantieri, discariche e terreni artefatti e abbandonati<br />
1.3.1. Aree estrattive<br />
1.3.2. Discariche<br />
1.3.3. Cantieri<br />
1.4. Zone verdi artificiali non agricole<br />
1.4.1. Aree verdi urbane<br />
1.4.2. Aree ricreative e sportive<br />
2. SUPERFICI AGRICOLE UTILIZZATE<br />
2.1. Seminativi<br />
2.1.1. Seminativi in aree non irrigue<br />
2.1.1.1. Colture intensive<br />
2.1.1.2. Colture estensive<br />
2.1.2. Seminativi in aree irrigue<br />
2.1.3. Risaie<br />
2.2. Colture permanenti<br />
2.2.1. Vigneti<br />
2.2.2. Frutteti e frutti minori<br />
2.2.3. Oliveti<br />
2.3. Prati stabili (foraggere permanenti)<br />
2.3.1. Prati stabili (foraggere permanenti)<br />
2.4. Zone agricole eterogenee<br />
2.4.1. Colture temporanee associate a colture permanenti<br />
2.4.2. Sistemi colturali e particellari complessi<br />
2.4.3. Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali<br />
importanti<br />
2.4.4. Aree agroforestali<br />
1
3. TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMI-NATURALI<br />
3.1. Zone boscate<br />
3.1.1. Boschi di latifoglie<br />
3.1.1.1 Boschi a prevalenza di leccio e/o sughera<br />
3.1.1.2 Boschi a prevalenza di querce caducifoglie (cerro e/o roverella e/o farnetto e/o rovere<br />
e/o farnia)<br />
3.1.1.3. Boschi misti a prevalenza di latifoglie mesofile e mesotermofile (acero-frassino, carpino<br />
nero-orniello)<br />
3.1.1.4 Boschi a prevalenza di castagno<br />
3.1.1.5 Boschi a prevalenza di faggio<br />
3.1.1.6. Boschi a prevalenza di specie igrofile (boschi a prevalenza di salici e/o pioppi e/o<br />
ontani, ecc.)<br />
3.1.1.7. Boschi e piantagioni a prevalenza di latifoglie non native (robinia, eucalipti, ailanto, ...)<br />
3.1.2. Boschi di conifere<br />
3.1.2.1. Boschi a prevalenza di pini mediterranei (pino domestico, pino marittimo) e cipressete<br />
3.1.2.2. Boschi a prevalenza di pini montani e oromediterranei (pino nero e laricio, pino<br />
silvestre, pino loricato)<br />
3.1.2.3. Boschi a prevalenza di abete bianco e/o abete rosso<br />
3.1.2.4. Boschi a prevalenza di larice e/o pino cembro<br />
3.1.2.5. Boschi e piantagioni a prevalenza di conifere non native (douglasia, pino insigne, pino<br />
strobo, …)<br />
3.1.3. Boschi misti di conifere e latifoglie<br />
3.1.3.1. Boschi misti a prevalenza di latifoglie<br />
3.1.3.1.1. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di leccio e/o sughera<br />
3.1.3.1.2. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di querce caducifoglie<br />
3.1.3.1.3. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di latifoglie mesofile e<br />
mesotermofile<br />
3.1.3.1.4. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di castagno<br />
3.1.3.1.5. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di faggio<br />
3.1.3.1.6. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di specie igrofile<br />
3.1.3.2. Boschi misti a prevalenza di conifere<br />
3.1.3.2.1. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di pini mediterranei<br />
3.1.3.2.2. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di pini montani e oromediterranei<br />
3.1.3.2.3. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di abete bianco e/o abete rosso<br />
3.1.3.2.4. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di larice e/o pino cembro<br />
3.1.3.2.5. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di conifere non native<br />
3.2. Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea<br />
3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie<br />
3.2.1.1. Praterie continue<br />
3.2.1.2. Praterie discontinue<br />
3.2.2. Brughiere e cespuglieti<br />
3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla<br />
3.2.3.1. Macchia alta<br />
3.2.3.2. Macchia bassa e garighe<br />
3.2.4. Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione<br />
3.3. Zone aperte con vegetazione rada o assente<br />
3.3.1. Spiagge, dune e sabbie<br />
3.3.2. Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti<br />
2
3.3.3. Aree con vegetazione rada<br />
3.3.4. Aree percorse da incendi<br />
3.3.5. Ghiacciai e nevi perenni<br />
4. ZONE UMIDE<br />
4.1. Zone umide interne<br />
4.1.1. Paludi interne<br />
4.1.2. Torbiere<br />
4.2. Zone umide marittime<br />
4.2.1. Paludi salmastre<br />
4.2.2. Saline<br />
4.2.3. Zone intertidali<br />
5. CORPI IDRICI<br />
5.1. Acque continentali<br />
5.1.1. Corsi d'acqua, canali e idrovie<br />
5.1.2. Bacini d'acqua<br />
5.2. Acque marittime<br />
5.2.1. Lagune<br />
5.2.2. Estuari<br />
5.2.3. Mari e oceani<br />
3
Allegato 3<br />
La Convenzione “Completamento delle Conoscenze Naturalistiche di Base” (CCNB) per il<br />
territorio italiano<br />
La Convenzione, avviata dal Ministero per l’Ambiente e la Tutela del Territorio in<br />
collaborazione con diversi Dipartimenti Universitari e con il Consiglio Nazionale delle<br />
Ricerche, rende disponibile un patrimonio di informazioni naturalistiche omogenee per l’intero<br />
territorio nazionale e utili alla pianificazione e alla gestione degli habitat naturali (Blasi, 2004).<br />
Sono stati previsti dei moduli conoscitivi specifici per le diverse aree tematiche indagate:<br />
A: La Carta delle serie di vegetazione e l’analisi floristica a scala nazionale<br />
B: La Carta dell’uso del suolo (CORINE Land Cover IV livello per gli aspetti naturali e<br />
seminaturali)<br />
C: Ampliamento delle conoscenze zoologiche sul territorio nazionale<br />
D: L’analisi bioclimatica con produzione della Carta del fitoclima d’Italia<br />
E: Descrizione di base delle biocenosi marine costiere<br />
F: Conoscenze naturalistiche ed ecologiche di base per la predisposizione di un piano nazionale<br />
per le zone umide e la creazione di un sistema nazionale di zone umide<br />
La cartografia relativa ai moduli A, B e D, realizzata in scala 1:250.000, è stata prodotta anche<br />
in formato digitale e utilizzata, in questa lavoro di ricerca, per le necessarie operazioni di<br />
elaborazione ed analisi condotte sul territorio nazionale.<br />
Modulo A - La carta delle serie di vegetazione<br />
La Carta delle serie di vegetazione d’Italia in scala 1:250.000, realizzata nell’ambito del Modulo<br />
A floristico-vegetazionale della CCNB, costituisce un prodotto di sintesi di fondamentale<br />
importanza ai fini della comprensione delle caratteristiche ambientali del nostro territorio, oltre<br />
che un patrimonio di dati ed informazioni disponibili per numerose discipline e per svariati usi<br />
applicativi (Blasi, 2004).<br />
Le cartografie prodotte, per ciascuna regione amministrativa italiana, rappresentano porzioni del<br />
territorio italiano aventi la stessa tipologia di serie di vegetazione, in quanto vocate alla stessa<br />
potenzialità in termini di vegetazione naturale (Tuexen, 1956). Ciascuna unità cartografata è<br />
descritta in termini fitosociologici, ossia nelle sue caratteristiche floristiche, fisionomiche e<br />
sindinamiche (Westhoff et van der Maarel, 1973), sia dalla comunità vegetale rappresentante la<br />
sua potenzialità in assenza di disturbo (tappa matura) sia dalle cenosi che la sostituiscono<br />
quando invece il disturbo è presente. La serie di vegetazione (Rivas Martinez, 1976; Géhu,<br />
1986) è infatti costituita dall’insieme delle comunità vegetali appartenenti a successioni che<br />
hanno la stessa tappa matura come stadio finale.<br />
Modulo B - La Carta dell’uso del suolo (CORINE Land Cover IV livello per gli aspetti<br />
naturali e seminaturali)<br />
Nell’ambito del programma CORINE 1 , avviato dal Consiglio delle Comunità Europee nel 1985<br />
per rispondere all’esigenza di verificare lo stato dell'ambiente nell'area comunitaria e orientare<br />
in modo organico le politiche territoriali comuni, il progetto CORINE Land Cover (AA.VV.,<br />
1995) venne specificamente destinato al rilevamento e al monitoraggio delle caratteristiche del<br />
territorio (comprese anche parti significative dell’Est europeo e del bacino mediterraneo non<br />
1 COoRdination de l'INformation sur l'Environnement<br />
1
necessariamente appartenenti all’Unione Europea) con particolare attenzione alle esigenze di<br />
difesa e tutela ambientali. La diffusione di standard e metodologie comuni volte a facilitare la<br />
realizzazione di iniziative intercomunitarie fu obiettivo non secondario di questo progetto. La<br />
copertura CORINE Land Cover 90 (CLC90) e i suoi aggiornamenti sono infatti ad oggi<br />
riconosciuti da organi direttivi della Commissione Europea quali DG-Regional policy, DG-<br />
Environment e DG-Agriculture, oltre che dalla AEA (Agenzia Europea per l’Ambiente) e dalla<br />
rete European Topic Centres (ETCs), quale strumenti di base per definire le politiche territoriali,<br />
monitorarne gli effetti e formulare eventuali azioni correttive.<br />
La metodologia, descritta nella guida tecnica 2 redatta da esperti della Commissione Europea e di<br />
precisione sufficiente a rilevare cambiamenti significativi nell’ambiente, si concretizzò nella<br />
produzione di un cartografia della copertura del suolo in scala 1:100.000, con una legenda<br />
(Allegato 1) di 44 classi distribuite su 3 livelli gerarchici. Il primo comprende 5 voci generali<br />
che abbracciano le maggiori categorie di copertura sul pianeta (territori modellati<br />
artificialmente, territori agricoli, territori boscati e ambienti semi-naturali, zone umide, corpi<br />
idrici), il secondo 15, adatte ad una rappresentazione a scale di 1:500.000/1.000.000 e il terzo<br />
44, con voci più di dettaglio, adatte ad una scala di 1:100.000.<br />
La legenda è integrabile da successivi livelli di approfondimento purché resti immutata per i<br />
primi 3 livelli; ciò allo scopo di mantenere omogeneità nell’ambito geografico europeo.<br />
Le classi di copertura del suolo, attribuite ad unità spaziali omogenee o composte da zone<br />
elementari appartenenti ad una stessa classe, sono nettamente distinte dalle unità che le<br />
circondano. La superficie minima cartografabile, considerata significativa alla scala 1:100.000,<br />
è pari a 25 ettari, e corrisponde, a questa scala, ad un quadrato di 5 mm di lato o ad un cerchio di<br />
2,8 mm di raggio.<br />
La Carta dell’uso del suolo e delle coperture vegetazionali in scala 1:250.000 (Chirici et al.,<br />
2002), prodotta nell’ambito del Modulo B della CCNB, ha aumentato il dettaglio tematico di<br />
questa cartografia, riclassificando al IV livello le voci 2. Superfici agricole utilizzate e 3.<br />
Territori boscati e ambienti semi-naturali. Il IV livello risponde anche alla necessità di<br />
integrazione della categoria di CORINE biotopi per le tipologie terrestri e agli habitat di cui alla<br />
Direttiva 92/43 dell’Unione Europea.<br />
L’unità cartografica minima, considerata significativa alla scala utilizzata, è di 50 ettari (40<br />
ettari per i poligoni lineari). Tutti i poligoni che nel III livello CLC avevano un’estensione<br />
minore sono stati però mantenuti al fine di evitare una perdita di informazioni. La conoscenza<br />
dell’uso e della copertura del suolo è stata inoltre ampliata da studi vegetazionali, volti ad<br />
approfondire in particolare l’aspetto fisionomico delle tipologie forestali regionali.<br />
2 http://reports.eea.eu.int/COR0-landcover/en<br />
2
Il progetto europeo I&CLC2000<br />
I&CLC2000 (Maricchiolo et al., 2004) prevede per 25 Paesi europei l’aggiornamento della<br />
copertura CORINE Land Cover all’anno 2000 (CLC2000) e la produzione del database<br />
geografico dei cambiamenti di uso del suolo tra il 1990 e il 2000 (CLCchange) attraverso<br />
l’acquisizione di una copertura di immagini satellitari Landsat 7 ETM+ (Image2000).<br />
Coordinato a livello europeo dall’Agenzia Europea per l’Ambiente (AEA) e in Italia<br />
dall’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici (APAT), è stato realizzato<br />
con il contributo tecnico-scientifico della Università di Roma “La <strong>Sapienza</strong>”, della Università di<br />
Firenze e della Università della Tuscia di Viterbo.<br />
La realizzazione dei due strati informativi (CLC2000 e CLCchange) ha reso indispensabile una<br />
revisione della copertura del CLC90, al fine di ottenere la consistenza geometrica e tematica<br />
necessaria al confronto 1990-2000. Allo scopo è stato utilizzato l’approfondimento tematico<br />
della classe 3. Territori boscati e ambienti semi-naturali del CLC90 eseguito per la Carta<br />
dell’uso del suolo e delle coperture vegetazionali in scala 1:250.000 nell’ambito del Modulo B<br />
della Convenzione CCNB.<br />
Le coperture CLC90 e CLC2000 sono state prodotte alla scala 1:100.000, con unità<br />
cartografabile pari a 25 ha e larghezza minima dei poligoni pari a 100 m (1 mm alla scala<br />
considerata). Per lo strato CLCchange l’area minima è pari a 5 ha.<br />
I dati CORINE Land Cover utilizzati per le successive elaborazioni provengono dunque dalla<br />
revisione e dall’aggiornamento della copertura CORINE Land Cover rispettivamente all’anno<br />
1990 e 2000 effettuati nell’ambito di questo progetto.<br />
3
Modulo D - La carta del Fitoclima<br />
La cartografia del Fitoclima d’Italia in scala 1:250.000 (Blasi, 2004) è stata prodotta dal<br />
Dipartimento di Biologia Vegetale dell’Università “La <strong>Sapienza</strong>” di Roma con la collaborazione<br />
dell’Isituto di Ecologia ed Idrologia forestale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di<br />
Cosenza.<br />
La proposta metodologica alla base di questo progetto, che ha preso spunti da diversi studi<br />
bioclimatici (Pavari, 1916; De Philippis, 1937; Blasi et al. 1992; Blasi, 1994) prevede l’utilizzo<br />
dei dati grezzi delle stazioni termopluviometriche e delle relative variabili mensili delle<br />
temperature minime e massime e delle precipitazioni in integrazione con gli indici bioclimatici,<br />
ottimizzando quindi il valore informativo di entrambi. Gli indici, essendo infatti empirici e<br />
fortemente dipendenti dall’area sulla quale sono calibrati, possono avere un grado di<br />
informazione incompleto. L’analisi multivariata (variabili vs stazioni) applicata dunque a valori<br />
di tmin, Tmax e P mensili, provenienti da 400 stazioni termpluviometriche distribuite sul<br />
territorio italiano e calcolati per 30 anni a partire dal 1955, ha individuato 28 classi. La<br />
rappresentazione spaziale di questi gruppi secondo la loro appartenenza geografica ha<br />
consentito la produzione della carta del Fitoclima d’Italia che comprende: 18 classi Temperate,<br />
5 Temperate di Transizione, 3 Mediterranee e 2 Mediterranee di Transizione.<br />
Ogni classe fitoclimatica (primo livello gerarchico) è descritta da Regione climatica e Bioclima<br />
(rispettivamente secondo e terzo livello gerarchico). La Regione Climatica di appartenenza è<br />
definita in funzione del valore dell’indice ombrotermico estivo normale e compensato Ios2,<br />
Ios3, Ios4 di Rivas Martinez (1996), riportato in Tabella 1, ovvero:<br />
- se l’indice è > 2 la classe appartiene alla Regione Temperata,<br />
- se l’indice è < 2 la classe appartiene alla Regione Mediterranea.<br />
Indice ombrotermico estivo normale e compensato<br />
Ios2=(Pluglio+Pagosto)/(Tmedluglio+Tmedagosto)<br />
Ios3=(Pgiu.+Plu.+Pago.)/(Tmedgiu.+Tmedlu.+Tmedago.)<br />
Ios4=(Pmag.+Pgiu.+Plu.+Pago.)/(Tmedmag.+Tmedgiu.+Tmedlu.+Tmedago.)<br />
Indice di termicità<br />
It=(Tmedann.+tmin.mese+freddo+Tmaxmese+freddo)*10<br />
Indice pluviometrico o ombrico<br />
Io=Σ(mesi dell’anno con Tmed>0°C) P/Tmed<br />
Indice di continentalità semplice<br />
Ic= (Tmed mese+caldo) – (Tmed mese+freddo)<br />
Tabella 1 - Indici<br />
Le Regioni di Transizione costituiscono le varianti termiche o pluviometriche delle Regioni ed<br />
hanno valori intermedi.<br />
4
Il terzo livello, ossia il Bioclima, è definito come escursione termica delle stazioni appartenenti<br />
alla classe (Tabella 2).<br />
Escursione termica Bioclima<br />
fino a 18°C oceanico<br />
da 18° a 21°C semicontinentale<br />
da 21° a 28°C subcontinentale<br />
Oltre i 28°C continentale<br />
Tabella 2 – Escursione termica nei bioclimi principali<br />
Il Piano Termico e Pluviometrico, che costituisce il quarto livello gerarchico, è individuato<br />
attraverso i 2 indici di Rivas Martinez: It (indice termico) e Io (indice ombrico o pluviometrico).<br />
Una prima analisi per la caratterizzazione in senso fitoclimatico della penisola italiana è stata<br />
fatta a livello di Macroclima e Bioclima.<br />
Il Macroclima Temperato è localizzato nell’Italia settentrionale, in tutto l’arco appenninico,<br />
l’antiappenninico e nelle isole maggiori a medie e alte quote e copre circa il 70% del territorio<br />
italiano La Regione Mediterranea si estende su tutto il versante tirrenico, a esclusione di un<br />
tratto della Riviera di levante in Liguria, continua nelle grandi e piccole isole, nella parte ionica<br />
ed in adriatico fino ad arrivare in Abruzzo all’altezza di Pescara (Figura 1).<br />
Figura 1 - Regioni macroclimatiche<br />
5
Le regioni di Transizione sono geograficamente contigue ai macroclimi corrispondenti. La<br />
Regione Mediterranea di Transizione è costituita da classi nel cui interno si nota la<br />
contemporanea presenza di stazioni termopluviometriche mediterranee e temperate con<br />
prevalenza delle prime, così come nella Regione Temperata di Transizione le stazioni temperate<br />
prevalgono sulle mediterranee.<br />
Un macroclima può caratterizzare più classi e per questa ragione le classi sono state raggruppate<br />
in funzione del Bioclima, complesso climatico definito in funzione del valore dell’indice di<br />
continentalità Ic. Ciascuno dei 9 bioclimi individuati (Figura 2) evidenzia vaste aree omogenee<br />
per caratteri fisici e andamento dei parametri climatici, quali altitudine, esposizione (tirrenica o<br />
adriatica), precipitazione, morfologie particolari (vallate alpine, vallate interne appenniniche e<br />
delle isole maggiori), pianure costiere.<br />
Figura 2 – Nove bioclimi<br />
6
Cartografia Sistema di riferimento Fotointerpretazione<br />
Copertura del suolo 1990 -2000 dell’area<br />
campione Alto Molise (cella 559 di<br />
Castelverrino, provincia di Isernia)<br />
INFC<br />
Carta delle Serie di vegetazione d’Italia<br />
(CCNB, Modulo A)<br />
Carta dell’uso del suolo<br />
CORINE Land Cover IV livello per gli<br />
aspetti naturali e seminaturali<br />
(CCNB, Modulo B)<br />
Carta del Fitoclima d’Italia<br />
(CCNB, Modulo D)<br />
Gauss-Boaga fuso est, datum<br />
Roma40<br />
Gauss-Boaga fuso est, datum<br />
Roma40<br />
Scala<br />
nominale<br />
Area minima<br />
cartografabile<br />
areale 1:10.000 0,5 ha<br />
per punti<br />
1:10.000 0,5 ha<br />
UTM 32, datum ED50 areale 1:250.000 ~300 ha 3<br />
UTM 32, datum ED50 areale 1:250.000 50 ha<br />
UTM 32, datum ED50 areale 1:250.000 200 ha<br />
CLC90, CLC2000 (I&CLC2000) UTM 32, datum WGS84 areale 1:100.000<br />
3 La cartografia delle serie di vegetazione è stata prodotta a livello regionale. Questo ha comportato una variabilità della superficie minima cartografabile anche funzionale alle<br />
specificità del territorio.<br />
25 ha<br />
7
Allegato 4<br />
L’Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi di Carbonio (INFC)<br />
Le informazioni sulla consistenza territoriale e sullo stato delle foreste italiane erano limitate,<br />
alla fine degli anni Novanta, al solo Inventario Forestale Nazionale del 1985. Il Ministero delle<br />
Politiche Agricole e Forestali, che già allora aveva curato il progetto, avvalendosi del supporto<br />
tecnico-operativo del Corpo Forestale dello Stato e della consulenza scientifica di ISAFA<br />
(Istituto Sperimentale per l’Assestamento Forestale e l’Alpicoltura), ha avviato nel 2003 una<br />
nuova rilevazione delle risorse forestali in Italia che dovrà anche fornire le informazioni<br />
richieste al nostro Paese in adempimento agli obblighi derivanti dalla ratifica del Protocollo di<br />
Kyoto, in vigore dal 16 febbraio 2005.<br />
Il disegno inventariale dell’Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi di Carbonio<br />
prevede un campionamento triplo per la stratificazione. La stratificazione è un processo<br />
impiegato in quasi tutti gli inventari per dividere l’unità in aree relativamente omogenee,<br />
solitamente su base cartografica o sulla base di interpretazione di immagini. Può essere<br />
effettuata prima (pre-stratificazione) o dopo (post-stratificazione) la selezione dei campioni, allo<br />
scopo di ridurre il numero di unità di campionamento al suolo necessarie o di ridurre l’errore di<br />
campionamento.<br />
La prima fase, ultimata, ha previsto la classificazione di 301.000 punti, uno ogni chilometro<br />
quadrato, attraverso interpretazione 1 di ortofoto digitali con categorie coerenti con il I livello<br />
gerarchico del CORINE Land Cover (con alcune differenze 2 ) e con l’adozione delle definizioni<br />
di bosco FAO FRA2000 (FRA2000).<br />
L’intensità di campionamento è nove volte superiore a quella di IFN85, che realizzato in<br />
un’unica sessione inventariale e con una diversa definizione di bosco. L’identificazione dei<br />
punti di osservazione è in coordinate cartografiche Gauss-Boaga secondo il fuso di<br />
appartenenza, su datum Roma40.<br />
Il livello di classificazione adottato (Tabella 1), che prevede di fatto la distinzione tra superfici<br />
boscate e non boscate, è raggiungibile con standard di accuratezza elevati anche da<br />
fotointerpreti non necessariamente esperti e in tempi brevi.<br />
L’identificazione di una tipologia di maggior dettaglio (possibile con le ortofoto) in questa fase<br />
dell’INFC avrebbe reso necessari sia un periodo di formazione dei fotointerpreti incompatibile<br />
con i tempi previsti sia una procedura per la correzione degli errori di classificazione che<br />
comunque si sarebbero verificati in misura non trascurabile.<br />
I risultati preliminari e i relativi commenti sono disponibili sul sito dell’INFC 3 e sintetizzati<br />
nella Tabella 2.<br />
1<br />
Per questa attività sono stati impiegati oltre 50 team di fotointerpreti del CFS organizzati su base locale per la<br />
conoscenza diretta del territorio.<br />
2<br />
La classe 2. Superfici agricole non comprende nell’INFC i castagneti da frutto e le altre formazioni forestali a<br />
prevalente produzione di frutti, inclusi invece nella classe 3. Superfici boscate ed ambienti seminaturali; e prevede la<br />
sottoclasse 2.1 Piantagioni di arboricoltura da legno che non compare in CORINE. Questo consente l’aggregazione dei<br />
risultati della seconda fase dell’INFC secondo le classi FAO.<br />
3<br />
http://www.ifni.it/<br />
1
Tabella 1 - Classi e sottoclassi di uso del suolo e relativi codici secondo la tipologia adottata<br />
per la classificazione dei punti di I fase (ISAFA, 2003)<br />
La seconda fase, in via di completamento, ha previsto l’estrazione di un sottoinsieme di punti,<br />
selezionato in modo casuale e con criteri di proporzionalità, delle unità campionarie di prima<br />
fase risultate forestali. La classificazione dei circa 30.000 punti (il 30% di quelle forestali di<br />
prima fase) avviene attraverso rilievi al suolo, necessari per ottenere un dettaglio non consentito<br />
dalla fotointerpretazione a video relativamente alle diverse categorie inventariali (bosco alto,<br />
basso, arbusteto, ecc.). L’ausilio di tecnologia GPS consente alla squadra 4 di giungere, con una<br />
approssimazione di alcuni metri, fino al cosiddetto punto C che viene “materializzato” al suolo<br />
introducendovi una placca di metallo. Ciò consente di tornare più agevolmente al punto in tempi<br />
successivi, sia in terza fase che per un eventuale monitoraggio della medesima prozione<br />
forestale campionata.<br />
Sono oggetto di rilievo attributi generali relativi alla stazione e al soprassuolo (proprietà,<br />
gestione, viabilità, vincoli, dissesti, ecc.), la categoria inventariale, il tipo di vegetazione<br />
forestale (secondo una tipologia omogenea per il territorio nazionale basata sul criterio della<br />
specie prevalente: bosco di faggio, bosco di pino silvestre, ecc.) e altri caratteri qualitativi (tipo<br />
colturale, stadio di sviluppo, patologie, ecc.). Dal 2° livello la classificazione dell’INFC si<br />
discosta dallo standard CORINE per focalizzare l’attenzione sulle sole classi di interesse<br />
inventariale.<br />
4 Questa fase prevede l’impiego di 100 squadre di rilevatori, ciascuna costituita da 3 componenti (scelte fra risorse del<br />
CFS con la partecipazione di personale delle Regioni e delle Province Autonome).<br />
2
La terza fase prevede la raccolta di elementi quantitativi, principalmente la massa legnosa<br />
presente, di un sottoinsieme delle unità campionarie classificate in seconda fase, pari a 10.000<br />
punti (tasso di campionamento pari a circa il 30% della fase precedente). Le unità campionarie<br />
saranno oggetto di una rigorosa materializzazione sul terreno, con materializzazione anche di<br />
aree di saggio, e valutazioni sia qualitative che quantitative degli attributi di interesse<br />
inventariale.<br />
3
Tabella 2 – Risultati preliminari di prima fase INFC<br />
4
Allegato 5<br />
La metodologia IPPC per il Carbon accounting<br />
Lo scambio di carbonio tra atmosfera e biosfera è un fattore di controllo fondamentale per<br />
comprendere il fenomeno del riscaldamento del pianeta e dei cambiamenti climatici che gli sono<br />
legati. Su questo processo naturale avvenuto per centinaia di milioni di anni, l’uomo ha influito<br />
e continua a influire in modo determinante attraverso l’uso del suolo, i cambiamenti nell’uso del<br />
suolo e le attività forestali.<br />
Per questo motivo l’IPCC ha redatto uno Special Report on Land Use, land-use change and<br />
forestry activities (Watson et al., 2000), nel quale ha indicato i passi metodologici da seguire per<br />
la produzione degli inventari di uso del suolo e per la contabilizzazione dei crediti di carbonio:<br />
STEP 1<br />
Stabilire la definizione di “bosco” applicandola al contesto nazionale, stabilendo le condizioni<br />
di precedenza e/o una gerarchia tra le attività previste all’art. 3.4 del Protocollo di Kyoto. Più<br />
dettagliatamente si tratta di:<br />
1.1 scegliere i valori numerici nella definizione (entro la fine del 2006 le Parti devono decidere i<br />
propri parametri) relativamente a: area minima, copertura arborea minima, altezza minima e<br />
larghezza minima degli alberi a maturità. Questi parametri non potranno essere cambiati per<br />
tutto il periodo di adempimento previsto;<br />
1.2 applicare la definizione alla situazione nazionale: decidere quali (if any) attività dell’art. 3.4<br />
(Forest Management, Cropland Management, Grazing land Management e Revegetation),<br />
sono eleggibili per il nostro Paese e quindi contabilizzabili;<br />
1.3 stabilire una gerarchia tra le attività di cui al punto precedente.<br />
STEP 2<br />
Determinare le porzioni di territorio su cui le attività hanno avuto luogo dal 1990 e per le quali,<br />
dunque, gli scambi possono essere calcolati. E’ necessario pertanto:<br />
2.1 utilizzando la definizione di foresta prescelta, sviluppare metodi per individuare le superfici<br />
forestate e non al 1990, obiettivo che può essere portato a termine realizzando una<br />
cartografia che identifichi tutte le foreste al 1° gennaio 1990 per cui tutti i cambiamenti di<br />
uso del suolo relativi alle aree boscate e attuati dal ‘90 possono essere ricavati facendo<br />
riferimento a questa cartografia di base;<br />
2.2 in alternativa si può utilizzare il Reporting Method che si basa sulla identificazione<br />
geografica completa ed esplicita di tutte le units of land soggette alle attività dell’art. 3.3 e a<br />
tutte le lands soggette alle attività dell’art. 3.4; per implementare questa metodologia, le<br />
Parti devono identificare e indicare la localizzazione spaziale di tutte le lands (art. 3.4) e di<br />
tutte le units of land (art. 3.3) su una cartografia completa di tutte le aree entro i confini<br />
nazionali (ciò richiede il rilevamento periodico di un certo numero di aree campione<br />
spazialmente e statisticamente valide 1 ).<br />
1 Scelte in accordo con i principi riportati nella sezione 5.3 del Capitolo 5 (Note from Charter 2 of the GPG on<br />
LULUCF Sector).
In questa ricerca per il Carbon accounting è stato scelto il Land-Based approach che prevede<br />
appunto, tra gli step, la definizione delle attività applicabili e l’identificazione delle unità<br />
territoriali su cui queste attività insistono.<br />
Il rapporto IPPC del 2003 Good Practice Guidance (GPG) of Land Use, Land-use Change and<br />
Forestry, che definisce le principali categorie di uso del suolo (territori boscati, territori agricoli,<br />
prati e pascoli, zone umide, insediamenti antropici), indica le metodologie da seguire per la<br />
stima degli stock di carbonio e le loro variazioni sia nelle categorie principali sia nelle aree che<br />
ricadono nelle attività di afforestazione e riforestazione (art. 3.3), gestione forestale, dei suoli<br />
agricoli, dei pascoli e rivegetazione (art. 3.4) e in quelle previste nei progetti JI (art. 6) e CDM<br />
(art. 12).<br />
Vi sono descritte tre metodologie corrispondenti a diversi gradi di precisione e in rapporto<br />
gerarchico fra loro (Ciccarese, 2005), oltre che funzionali alle diverse disponibilità nazionali<br />
delle informazioni. I Paesi possono utilizzare:<br />
1. semplici equazioni basate su dati già posseduti o o anche dati specifici nazionali;<br />
2. modelli e altri strumenti di valutazione delle variazioni degli stock;<br />
3. dati derivanti da indagini stazionali specifiche o ricerche ed esperimenti, in grado di<br />
integrare i due o più dei metodi citati.<br />
In particolare nel LULUCF sector, la stima deve riguardare tutti gli elementi costituenti gli<br />
ecosistemi forestali, ovvero la biomassa epigea, la necromassa legnosa, la lettiera e la sostanza<br />
organica del suolo, che costituiscono altrettanti pool di carbonio. Ciascuno di essi infatti è un<br />
sistema capace di accumulare o rilasciare carbonio. La GPG prevede due metodi possibili:<br />
1. Default method, che in un anno di riferimento sottrae le perdite dovute a fattori naturali<br />
(come incendi, uragani, ecc.) oppure di natura antropica (come prelievi di legname, ecc.)<br />
all’incremento di biomassa;<br />
2. Stock change method, che prevede la stima della biomassa totale di un’area in due tempi<br />
diversi e poi che questo valore venga diviso per il numero di anni compresi nell’intervallo<br />
temporale considerato.<br />
Questo naturalmente implica che gli inventari forestali siano solitamente progettati in modo da<br />
poter calcolare la produzione legnosa.<br />
Il computo delle variazioni degli stock si effettua in ogni caso moltiplicando la differenza tra il<br />
peso secco degli incrementi e quello delle perdite di biomassa per alcuni fattori di conversione.<br />
Si trasforma poi il valore ottenuto in carbonio, che corrisponde a circa il 50% del peso secco<br />
della biomassa; quindi in anidride carbonica moltiplicando per 3,67 (Tabella 1) il risultato<br />
ottenuto.<br />
Tabella 1 - Fattori di conversione carbonio-anidride carbonica (e viceversa)<br />
1 tonnellata C = 3,67 tonnellate CO2<br />
1 tonnellata CO2 = 0,273 tonnellate C
Allegato 6<br />
10th European PhD Workshop on International Climate Policy (2005)<br />
Il workshop, in inglese, viene di consuetudine organizzato con scadenza semestrale da uno dei<br />
partecipanti che si offre di ospitare nella sua università il successivo incontro.<br />
Si svolge in due giornate durante le quali studenti di dottorato di diverse facoltà e università<br />
europee, attivi nel campo del climate change seppure interessati a diversi aspetti, presentano e<br />
condividono a un tavolo comune le proprie idee di ricerca.<br />
Ogni partecipante dispone di venti minuti per presentare il proprio lavoro e gli eventuali risultati<br />
preliminari. A ciascuno è assegnato un contro-relatore, selezionato tra gli altri partecipanti, che<br />
ha il compito di stimolare la discussione sulla ricerca presentata. I contro-relatori sono<br />
selezionati dall’organizzatore del workshop in base ad affinità di tema di ricerca e ricevono la<br />
presentazione su cui dovranno stimolare il dibattito due settimane prima del workshop.<br />
La decima edizione dello European PhD Workshop on International Climate Policy, in cui ho<br />
ricoperto il ruolo di organizzatrice e coordinatrice, si è svolto presso il Dipartimento di Biologia<br />
Vegetale il 3 e 4 giugno 2005.<br />
Nelle immagini due momenti del workshop.<br />
1
Segue il programma dell’evento, disponibile insieme alle relazioni presentate sul sito<br />
dell’Università “La <strong>Sapienza</strong>” all’indirizzo:<br />
http://sweb01.dbv.uniroma1.it/workshop1/indice1.htm<br />
e sul sito appositamente creato e gestito dai partecipanti alle diverse edizioni del Workshp ICP<br />
all’indirizzo:<br />
http://www.ku-eichstaett.de/Fakultaeten/WWF/Lehrstuehle/VWF/icp/past_events.de<br />
2
10th European Ph.D Workshop on International Climate Policy<br />
Plant Biology Department<br />
University “La <strong>Sapienza</strong>”, Rome, Italy<br />
June 3-4 2005<br />
Friday, 3 rd June 2005<br />
11:00 - 11:30 Registration and Welcome University La <strong>Sapienza</strong>, Rome<br />
11:30 – 12:00 Prof. Carlo Blasi – Coordinator of the Ecological Sciences PhD<br />
Welcome<br />
Maria Antonietta <strong>Del</strong> <strong>Moro</strong> - University La <strong>Sapienza</strong>, Rome, Italy<br />
Frauke Eckermann – Dortmund University, Germany<br />
Welcome and Organisational Details<br />
Session 1 Sustainability and the CDM Discussant<br />
12:00 – 13:00 The implications of the Clean Development<br />
Mechanism for Sustainable Development: prospects<br />
for Developing Countries<br />
Francesca Farioli - Interuniversity Research Centre on<br />
Sustainable Development, University La <strong>Sapienza</strong>,<br />
Rome Italy<br />
13:00– 14:00 The contribution of the CDM to sustainable<br />
development in the energy sector in West Africa: Case<br />
Studies for Benin, Burkina Faso, Niger, and Togo<br />
Honorat Satoguina – Hamburg Institute of<br />
International Economics (HWWA), Germany<br />
14:00– 15:30 Lunch/Coffee Break<br />
15:30 – 16:30 Sustainable Energy Development in Developing<br />
Countries: Latin American energy intensity<br />
developments<br />
Eeva Kuntsi-Reunanen - Turku School of Economics,<br />
Finland<br />
16:30 – 17:30 The Success of the Clean Development Mechansism<br />
Felicia Mueller-Pelzer - Humboldt-University Berlin,<br />
Germany<br />
19:30 Dinner<br />
Felicia Mueller-Pelzer –<br />
Humboldt-University<br />
Berlin, Germany<br />
Francesca Farioli –<br />
University La <strong>Sapienza</strong>,<br />
Rome, Italy<br />
Honorat Satoguina –<br />
HWWA, Germany<br />
Eeva Kuntsi-Reunanen<br />
Turku School of<br />
Economics, Finland<br />
3
10th European Ph.D Workshop on International Climate Policy<br />
Plant Biology Department<br />
University “La <strong>Sapienza</strong>”, Rome, Italy<br />
June 3-4 2005<br />
Saturday, 4 th June 2005<br />
Session 2 Climate Policy Discussant<br />
9:30 – 10:30 Verification of Firm Data under the EU Emissions<br />
Trading Scheme<br />
Frauke Eckermann –Dortmund University, Germany<br />
10:30– 11:30 Political economy and economic impacts of climate<br />
policy<br />
Niels Anger – Centre for European Economic<br />
Research (ZEW) Mannheim, Germany<br />
11:30 – 12:30 A Study of rainfall in the Roman area in the years<br />
1951-2000<br />
Olivia Testa - Institute of Atmospheric Sciences and<br />
Climate (ISAC) of the Italian National Research<br />
Council (CNR).<br />
12:30 – 14:00 Lunch Break<br />
Session 3 Land Use Changes and the consequences on C sinks/sources<br />
14:00 – 15:00 Eligibility and significance of natural revegetation in<br />
abandoned agricultural areas under the Kyoto<br />
Protocol<br />
Giuliana Zanchi - University of Padova, Italy<br />
15:00– 15:30 Kyoto Protocol and its relationship with CBD<br />
Maria Antonietta <strong>Del</strong> <strong>Moro</strong> - University La <strong>Sapienza</strong>,<br />
Rome, Italy<br />
15:30– 16:00 Closing remarks, evaluation and outlook<br />
on the next PhD workshop<br />
Niels Anger –<br />
ZEW Mannheim,<br />
Germany<br />
Giuliana Zanchi –<br />
University of Padova,<br />
Italy<br />
Maria Antonietta <strong>Del</strong><br />
<strong>Moro</strong> – University La<br />
<strong>Sapienza</strong>, Rome, Italy<br />
Elisabetta Salvatori –<br />
University La <strong>Sapienza</strong>,<br />
Rome, Italy<br />
Katia Poneti –<br />
Università di Firenze,<br />
Rome, Italy<br />
4
Pubblicazioni<br />
Ciccarese L., <strong>Del</strong> <strong>Moro</strong> M.A., Pettenella D., Zanchi G. (in pubbl.). Revegetation in<br />
Mediterranean areas. Progetto Carboinvent. Multi-source inventory methods for quantifying<br />
carbon stocks and stock changes in European forests. Coordinating Institution Joanneum<br />
Research Forschungsgesellschaft mbH. Graz, Austria.<br />
www.joanneum.at/Carboinvent<br />
<strong>Del</strong> <strong>Moro</strong> M.A, Blasi C. (in pubbl.). Analisi multitemporale e cartografia della evoluzione del<br />
paesaggio vegetale di un’area umida nella città di Roma.<br />
<strong>Del</strong> <strong>Moro</strong> M.A, Blasi C. (2005). Analisi multitemporale e qualità ambientale di un’area umida<br />
nella città di Roma. Atti 9 a Conferenza Asita , 15-18 novembre 2005, Catania.<br />
Baiocchi V., Bortolotti C., Crespi M.G., <strong>Del</strong> <strong>Moro</strong> M.A., Pieri, S., (2004). Accuratezza delle<br />
trasformazioni tra datum e sistemi cartografici nazionali implementate nei software di maggior<br />
utilizzo nelle applicazioni GIS. Atti 8 a Conferenza Asita “Geomatica - Standardizzazione,<br />
interoperabilità e nuove tecnologie”, 14-17 dicembre 2004, Roma.<br />
<strong>Del</strong> <strong>Moro</strong> M.A., Carranza M.L., Celesti L., Blasi C. (2004). Analisi floristica e della evoluzione<br />
del paesaggio in un’area umida della città di Roma. Poster in Atti del Congresso della Società<br />
Italiana di Fitosociologia "Le comunità vegetali negli ecosistemi urbani e nelle aree<br />
archeologiche: problematiche ed applicazioni”, 19-21 feb. 2004, Roma.<br />
5