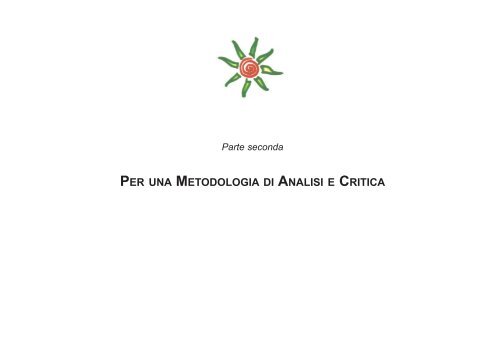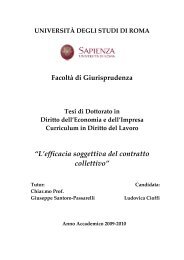Analisi tipologica dell'edilizia tradizionale: la tipizzazione ... - Padis
Analisi tipologica dell'edilizia tradizionale: la tipizzazione ... - Padis
Analisi tipologica dell'edilizia tradizionale: la tipizzazione ... - Padis
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Parte seconda<br />
PER UNA METODOLOGIA DI ANALISI E CRITICA
CAPITOLO II-1<br />
<strong>Analisi</strong> <strong>tipologica</strong><br />
dell’edilizia <strong>tradizionale</strong>: <strong>la</strong><br />
<strong>tipizzazione</strong> ambientale<br />
I. Il senso del tipo<br />
Tra le molte definizioni che, a partire da Quatremère de Quincy,<br />
sono state date del concetto di "tipo", una delle più convincenti è<br />
quel<strong>la</strong> che vede in esso l'espressione antropologica di un uso<br />
consolidato, perfezionato dal<strong>la</strong> sua lunghissima applicazione, non<br />
però in riferimento ad un singolo oggetto esistente, quanto più ad<br />
una forma astratta, quasi "idealistica", che può incorrere, nel<strong>la</strong> sua<br />
realizzazione materiale, in variazioni anche significative senza<br />
perdere il suo significato.<br />
Il tipo costituisce dunque, come fondamento antropologico<br />
dell'architettura, una promessa di permanenza. La sua validità è in<br />
genere legata al vastissimo grado di applicazione, al<strong>la</strong> sua<br />
ripetizione in diverse condizioni, dimensioni, ricchezza di<br />
esecuzione ecc.: è proprio questa infinità di manifestazioni che<br />
conduce, per via deduttiva, a considerare il tipo come una<br />
soluzione "sempre efficace", perlomeno entro determinati limiti<br />
62<br />
contestuali.<br />
La metafora biologica che è spesso stata applicata allo<br />
studio tipologico dell'architettura considera le singole unità edilizie<br />
di base come delle "cellule", entità che fanno parte del più ampio<br />
organismo urbano. La crescita di questo organismo segue<br />
determinate regole dettate da condizioni economiche,<br />
morfologiche, culturali ecc., utilizzando le "cellule" come elementi<br />
di crescita. Il tutto avviene, come nel caso degli esseri viventi,<br />
seguendo un più ampio e in buona parte imperscrutabile disegno.<br />
A partire dagli anni '50 del Novecento, soprattutto grazie agli studi<br />
iniziati da Saverio Muratori a Roma e Venezia ed Ernesto N.<br />
Rogers a Mi<strong>la</strong>no e poi continuati dai loro allievi, l'analisi <strong>tipologica</strong><br />
dei fenomeni urbani ha conosciuto un forte sviluppo ed una<br />
diffusione molto ampia. Nel tentativo di recuperare un senso di<br />
"continuità" (per usare un termine rogersiano) con l'architettura<br />
<strong>tradizionale</strong>, l'analisi <strong>tipologica</strong> si è occupata di individuare delle<br />
"invarianti di picco<strong>la</strong> sca<strong>la</strong>", quale ad esempio il tipo come<br />
espressione di una funzione sedimentata, che potessero da un <strong>la</strong>to<br />
spiegare <strong>la</strong> nascita e l'evoluzione delle città storiche, nonché<br />
orientare le modalità di intervento dei progettisti contemporanei.<br />
Proprio per il suo intimo legame con <strong>la</strong> "picco<strong>la</strong> sca<strong>la</strong>", lo<br />
studio del tipo ha costituito un valido antidoto contro l'utopismo<br />
tardomodernista, proponendo un'alternativa che si distinguesse dal
Capitolo II-1<br />
gigantismo degli interventi urbani a sca<strong>la</strong> metropolitana. Per <strong>la</strong> sua<br />
discendenza "culturale", e come alternativa al<strong>la</strong> "tabu<strong>la</strong> rasa" delle<br />
avanguardie moderniste, il tipo è servito anche a soddisfare <strong>la</strong><br />
necessità di contestualizzare il "carattere" e <strong>la</strong> funzione delle nuove<br />
costruzioni, un'esigenza divenuta centrale nel decennio del<strong>la</strong><br />
ricostruzione postbellica.<br />
I risultati di questi studi e delle realizzazioni che li hanno<br />
seguiti sono stati vari e di diversa qualità. La costanza dei tipi e le<br />
affinità non indifferenti nei sistemi urbani da essi generati hanno<br />
fatto sì che questa metodologia di analisi venisse da alcuni<br />
considerata infallibile, in grado dunque di spiegare anche i più<br />
complessi fenomeni di aggregazione: esiste al giorno d'oggi anche<br />
un "movimento" per lo studio tipologico delle città, fortemente<br />
legato agli insegnamenti di Saverio Muratori.<br />
Ma vi sono stati anche numerosi critici di questa<br />
metodologia: da un <strong>la</strong>to c'è chi ha attaccato <strong>la</strong> validità del sistema<br />
di analisi in quanto tale, obiettando all'alto grado di determinismo<br />
meccanicistico che esso implica; dall'altro, chi ha criticato non tanto<br />
il metodo quanto i risultati, osservando che il culturalismo implicito<br />
nel<strong>la</strong> ricerca di radici "forti" per l'architettura scade, in molti casi, nel<br />
passatismo nostalgico.<br />
Se il tipo ha rivestito un ruolo non secondario nel<strong>la</strong><br />
63<br />
<strong>Analisi</strong> <strong>tipologica</strong> dell’edilizia <strong>tradizionale</strong>: <strong>la</strong> <strong>tipizzazione</strong> ambientale<br />
rie<strong>la</strong>borazione del<strong>la</strong> pratica compositiva dell'architettura in<br />
riferimento agli aspetti più strettamente funzionali, storici e<br />
urbanistici, non si può dire lo stesso per quanto riguarda l'ambito<br />
tecnologico e ambientale. L'architettura <strong>tradizionale</strong>, tipizzata per<br />
definizione, si è evoluta sì rispondendo a precisi modelli di uso, ma<br />
anche per fungere da mediazione tra i fruitori e gli elementi naturali<br />
che intervengono sul contesto - sole, luce, aria, venti, precipitazioni<br />
ecc. L'architettura moderna del ventesimo secolo ha in buona parte<br />
rie<strong>la</strong>borato queste modalità di interazione, cambiando<br />
radicalmente l'equilibrio <strong>tradizionale</strong>: grandi superfici aumentano il<br />
grado di trasparenza a fronte del<strong>la</strong> maggiore opacità <strong>dell'edilizia</strong><br />
<strong>tradizionale</strong>; gli spazi protetti dagli agenti atmosferici sono ora più<br />
liberamente esposti al mondo esterno. Anche le caratteristiche<br />
costruttive determinate dalle nuove tecnologie incidono su questo<br />
equilibrio: il te<strong>la</strong>io in cemento armato viene tamponato da elementi<br />
leggeri, rinunciando al<strong>la</strong> massa termica fornita dal<strong>la</strong> muratura<br />
portante; il vetro e l'acciaio rendono possibili le grandi superfici<br />
vetrate.<br />
Il problema del<strong>la</strong> qualità ambientale dell'architettura<br />
moderna è ampio e non ancora del tutto risolto. Le nuove tecniche<br />
rendevano sì possibili soluzioni architettoniche rivoluzionarie, ma<br />
obbligavano ad un ulteriore aumento del grado tecnologico per<br />
consentirne successivamente <strong>la</strong> fruizione in "condizioni di comfort".<br />
Ma <strong>la</strong> nuova architettura, figlia dell'ideologia modernista del<strong>la</strong>
Capitolo II-1<br />
rivoluzione industriale, non concepiva questo come un problema,<br />
ignara delle gravissime conseguenze che queste scelte avrebbero<br />
causato sul<strong>la</strong> lunga durata.<br />
L'architettura del secondo dopoguerra, che ha trovato il suo<br />
fondamento teorico in una rivisitazione critica dell'ideologia<br />
modernista, ha negato <strong>la</strong> validità dei modelli compositivi, figurativi<br />
ed in parte funzionali di quel movimento, accettandone però le<br />
innovazioni tecnologiche. Chi invece nello stesso periodo storico<br />
ha portato avanti le idee forti del moderno secondo una linea di<br />
continuità, quali ad esempio gli architetti del<strong>la</strong> corrente high-tech,<br />
ha accentuato <strong>la</strong> valenza del mito macchinista, nato con le grandi<br />
esposizioni universali del XIX secolo.<br />
Ciò che si vuole dunque sottolineare è l'esistenza, oltre ai<br />
tipi "c<strong>la</strong>ssici" legati a significati estetici, funzionali, economici ecc.,<br />
anche di "tipi ambientali", ossia schemi compositivi evolutisi a<br />
causa del<strong>la</strong> loro positiva influenza sul<strong>la</strong> qualità ambientale dello<br />
spazio interno. Metodi per proteggere gli ambienti domestici dalle<br />
intemperie, per conservare una temperatura più alta o più bassa<br />
rispetto all'esterno, per favorire <strong>la</strong> venti<strong>la</strong>zione: diversi di questi<br />
accorgimenti sono stati tipizzati dal<strong>la</strong> sedimentazione storica, ed è<br />
possibile rintracciarli in un grandissimo numero di esempi.<br />
I tipi ambientali, simili per molti versi a quelli morfologici, si<br />
64<br />
<strong>Analisi</strong> <strong>tipologica</strong> dell’edilizia <strong>tradizionale</strong>: <strong>la</strong> <strong>tipizzazione</strong> ambientale<br />
ripetono, a differenza di questi, non secondo zone culturali<br />
omogenee, quanto per regioni climatiche. La casa a corte, esempio<br />
c<strong>la</strong>ssico di tipo morfologico, può considerarsi allo stesso tempo un<br />
tipo ambientale, essendo possibile trovarne esempi in molte<br />
regioni dal clima simile a quello del bacino mediterraneo.<br />
Una questione che potrebbe rive<strong>la</strong>rsi un interessante<br />
legame tra tecnica e metafisica rimane però aperta. Così come al<br />
concetto di tipo è stato attribuito, soprattutto da parte di alcuni<br />
autori, un significato che va ben oltre quello strettamente<br />
funzionale, così il tipo ambientale potrebbe rappresentare più del<strong>la</strong><br />
semplice necessità di proteggersi da un clima ostile. In un<br />
interessante volume intito<strong>la</strong>to Formal Structure in Indian<br />
Architecture1, K<strong>la</strong>us Herdeg ha individuato alcuni elementi<br />
ricorrenti nel<strong>la</strong> morfologia delle architetture del subcontinente<br />
indiano. Si dà il caso che alcuni di questi morfemi rispondono<br />
ottimalmente anche al clima locale: è possibile dunque che il piano<br />
estetico e quello ambientale - tecnico possiedano dei punti di<br />
intersezione?<br />
Appare chiaro che taluni aspetti del<strong>la</strong> strutturazione<br />
dell'architettura interagiscono su diversi piani di significato, non<br />
so<strong>la</strong>mente legati ad un funzionamento di base, ma anche a livello<br />
simbolico. Quello che Herdeg definisce "struttura formale" è<br />
palesemente determinato anche dal<strong>la</strong> necessità di conservare un
Capitolo II-1<br />
microclima interno favorevole allo sviluppo del<strong>la</strong> vita umana. Si<br />
tratta, dunque, del<strong>la</strong> riproposizione attraverso il tipo di una<br />
condizione di vita ancestrale, nel<strong>la</strong> quale le esigenze spirituali del<strong>la</strong><br />
figurazione e quelle materiali del<strong>la</strong> creazione di un rifugio<br />
coincidevano. Questo può essere dunque il vero senso del "tipo":<br />
l'incarnazione di valori e significati antichi, <strong>la</strong> "promessa di<br />
permanenza".<br />
II. Il tipo come strumento di analisi e progettazione<br />
La possibilità di individuare una <strong>tipizzazione</strong> non so<strong>la</strong>mente<br />
nell'ambito del<strong>la</strong> morfologia funzionale, ma anche per quanto<br />
riguarda delle costanti ambientali, può essere sicuramente sfruttata<br />
nell'ambito di uno studio come il presente, volto a individuare delle<br />
soluzioni fortemente radicate nel<strong>la</strong> realtà culturale per <strong>la</strong><br />
progettazione di sistemi insediativi a basso contenuto tecnologico.<br />
Una volta ipotizzata <strong>la</strong> validità del metodo, ossia rilevata <strong>la</strong><br />
rispondenza dell'astrazione del tipo al<strong>la</strong> realtà costruita, è dunque<br />
possibile prenderlo in considerazione come strumento progettuale,<br />
realizzandone un'applicazione in chiave contemporanea. Così<br />
come questo è stato fatto per i tipi morfologici, è senz'altro<br />
possibile procedere nel<strong>la</strong> stessa maniera per i tipi ambientali.<br />
L'analisi di queste invarianti va però condotta con alcuni partico<strong>la</strong>ri<br />
accorgimenti. Gli studi tipologici c<strong>la</strong>ssici hanno messo a fuoco <strong>la</strong><br />
65<br />
<strong>Analisi</strong> <strong>tipologica</strong> dell’edilizia <strong>tradizionale</strong>: <strong>la</strong> <strong>tipizzazione</strong> ambientale<br />
dimensione urbana, individuando i tipi come elementi di base e i<br />
processi di crescita come loro successiva aggregazione. Allo<br />
stesso modo, i tipi ambientali non vengono necessariamente<br />
conclusi nel<strong>la</strong> sca<strong>la</strong> del singolo edificio, o vengono incorporati in<br />
architetture di tale dimensioni da poter essere considerate a tutti gli<br />
effetti oggetti a sca<strong>la</strong> urbana. Tale è il caso ad esempio delle case<br />
urbane di alcune città indiane, costituite prevalentemente da<br />
piccole unità addensate intorno a spazi aperti, secondo il modello<br />
is<strong>la</strong>mico del "pa<strong>la</strong>zzo a padiglioni".<br />
I tipi ambientali riscontrabili in esempi di questo genere sono<br />
difficilmente realizzabili sul<strong>la</strong> sca<strong>la</strong> del singolo edificio di dimensioni<br />
normali; ciononostante, anche nell'architettura <strong>tradizionale</strong> non è<br />
difficile individuare tipi ambientali che incorporano diversi corpi di<br />
fabbrica, spazi aperti, strade ecc., come nel caso delle vie porticate<br />
di molte città nordafricane. Il valore urbano di questi tipi non va<br />
pertanto sottovalutato, né nelle fasi di analisi, né in quel<strong>la</strong> di<br />
applicazione.<br />
Un ulteriore problema è quello dell'applicazione di questi tipi<br />
dal punto di vista dell'ottenimento di condizioni di venti<strong>la</strong>zione e<br />
igieniche sufficienti. Non va trascurato il fatto che buona parte delle<br />
innovazioni morfologiche apportate dall'architettura moderna sono<br />
state, almeno inizialmente, introdotte al fine di migliorare le<br />
condizioni di vita dei residenti delle pestilenziali Mietkasernen; una
Capitolo II-1<br />
più efficiente venti<strong>la</strong>zione, nonché l'azione battericida dei raggi<br />
so<strong>la</strong>ri, hanno contribuito al raggiungimento di condizioni igieniche<br />
più accettabili. Chiaramente rinunciare a queste conquiste non è<br />
pensabile né moralmente possibile; è dunque necessario<br />
individuare un equilibrio, che pur nello sfruttare le potenzialità<br />
ambientali di questi tipi, non rinunci ad ottenere standard igienici<br />
consoni.<br />
Nei paesi in via di sviluppo <strong>la</strong> problematica è<br />
sostanzialmente inversa, poiché è necessario, in tutti gli interventi<br />
di edilizia abitativa, e soprattutto in quelli destinati alle fasce meno<br />
abbienti del<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione, raggiungere livelli igienici sufficienti, al<br />
fine di garantire <strong>la</strong> salubrità delle costruzioni. In questo caso i tipi<br />
ambientali possono fornire validi spunti progettuali, poiché anche<br />
da quel punto di vista si tratta di forme sperimentate ed efficaci. Se<br />
Bungalow a Lahore: in rosso, <strong>la</strong> zona “calda” dell’anello termico, che protegge il nucleo “freddo” interno<br />
66<br />
<strong>Analisi</strong> <strong>tipologica</strong> dell’edilizia <strong>tradizionale</strong>: <strong>la</strong> <strong>tipizzazione</strong> ambientale<br />
ovviamente non sono in grado di attestarsi su standard qualitativi<br />
come quelli imposti dal<strong>la</strong> normativa edilizia moderna, allo stesso<br />
tempo possono comunque migliorare le condizioni igieniche del<strong>la</strong><br />
comune edilizia a basso costo nei paesi in via di sviluppo.<br />
III. Quattro "tipi ambientali" del contesto di riferimento<br />
Il concetto di "anello termico"<br />
L'anello termico è una partico<strong>la</strong>re conformazione p<strong>la</strong>nimetrica che<br />
si può riscontrare in numerosissime opere di edilizia domestica del<br />
periodo c<strong>la</strong>ssico e coloniale. Si tratta di un corridoio continuo, di<br />
<strong>la</strong>rghezza variabile, che separa le zone abitative interne dal<strong>la</strong><br />
facciata dell'edificio. Nei periodi di maggiore inso<strong>la</strong>zione, questo<br />
semplice dispositivo permette di iso<strong>la</strong>re <strong>la</strong> zona abitata<br />
dall'irraggiamento so<strong>la</strong>re e dall'aria calda proveniente dall'esterno.<br />
Gli spazi interni rimangono, di fatto, ciechi: è però possibile una<br />
loro venti<strong>la</strong>zione (cross-venti<strong>la</strong>tion), agendo sulle aperture sui <strong>la</strong>ti.<br />
L'anello termico infatti il più delle volte non è descritto da pareti<br />
chiuse, ma piuttosto da elementi leggeri o mobili, come possono<br />
essere tende, schermi, separè e altri divisori che si attestano lungo<br />
il perimetro delle colonne che inscrivono lo spazio abitativo.<br />
L'anello termico assolve altri due importanti compiti: da un
Capitolo II-1<br />
<strong>la</strong>to, essendo un corridoio continuo, di permettere una venti<strong>la</strong>zione<br />
dello spazio intorno al nucleo centrale, con un conseguente<br />
abbassamento di temperatura; dall'altro, come nel<strong>la</strong> migliore<br />
tradizione dell'architettura is<strong>la</strong>mica, quello di definire chiaramente<br />
<strong>la</strong> gerarchia degli spazi costruiti, tra serventi e serviti.<br />
Questa partico<strong>la</strong>re tipologia è stata utilizzata in diverse<br />
conformazioni. Raro è il caso di un anello completo che giri tutto<br />
intorno all'edificio, anche perché tale accorgimento risulta<br />
necessario solo nei casi in cui si tratti di una costruzione iso<strong>la</strong>ta<br />
(condizione non molto frequente nell'architettura cittadina). Più<br />
spesso si riscontrano invece dei corridoi ubicati su due <strong>la</strong>ti lunghi<br />
dell'edificio, mentre i <strong>la</strong>ti corti rimangono ciechi.<br />
L'anello termico presenta, secondo i canoni di abitabilità<br />
nostrani, una serie di limitazioni, come l'impossibilità di condurre<br />
luce naturale all'interno dello spazio centrale, almeno in grandi<br />
quantità; <strong>la</strong> scarsità del<strong>la</strong> venti<strong>la</strong>zione nelle giornate<br />
partico<strong>la</strong>rmente calde, nonché <strong>la</strong> difficoltà di raggiungere un<br />
adeguato livello di ricambio d'aria. Nelle costruzioni ottocentesche<br />
in Pakistan questi inconvenienti sono stati solo parzialmente<br />
superati dall'uso di sistemi meccanici di venti<strong>la</strong>zione (venti<strong>la</strong>tori,<br />
impianti di condizionamento ecc.) e di illuminazione artificiale. Non<br />
bisogna però dimenticare che <strong>la</strong> tradizione del costruito spontaneo<br />
implica spesse volte una chiusura notevole degli spazi, a vantaggio<br />
67<br />
<strong>Analisi</strong> <strong>tipologica</strong> dell’edilizia <strong>tradizionale</strong>: <strong>la</strong> <strong>tipizzazione</strong> ambientale<br />
del comfort termico ma a discapito del<strong>la</strong> qualità ambientale<br />
generale.<br />
Disposizione altimetrica dei volumi<br />
La complessa artico<strong>la</strong>zione dei volumi nell'edilizia domestica delle<br />
città indiane segue uno schema che, nel suo rispondere alle<br />
esigenze di costruzione dello spazio urbano, risulta favorevole<br />
anche per una fruizione climaticamente ottimizzata. Il principio<br />
compositivo consiste nel compiere una progressiva sottrazione di<br />
volumi dall'ingombro prismatico del<strong>la</strong> costruzione man mano che si<br />
Javeli a Jaisalmer, India: evidenziato in arancione il progressivo svasamento dei volumi verso l’alto
Capitolo II-1<br />
procede dal basso verso l'alto. Risulta così che gli spazi al<br />
pianoterra sono chiusi e compatti, mentre gli ultimi piani sono<br />
arieggiati, generalmente tramite <strong>la</strong> costruzione di un invaso vuoto<br />
ruotante intorno al<strong>la</strong> corte centrale.<br />
Le strade delle città sono dunque prive di grandi aperture. Al<br />
pianoterra delle case sono alloggiate botteghe di piccole<br />
dimensioni - se il proprietario del<strong>la</strong> casa in questione è un<br />
commerciante, saranno le sue stesse botteghe. L'ingresso<br />
all'abitazione avviene generalmente da una strada secondaria,<br />
essendo i fronti principali dedicati precipuamente al commercio. Gli<br />
ingressi sono piccoli e poco appariscenti, pertanto facilmente<br />
control<strong>la</strong>bili e sicuri.<br />
I piani superiori sono invece più aperti, permettendo anche<br />
una maggiore venti<strong>la</strong>zione dell'edificio. La vita del<strong>la</strong> famiglia<br />
procede in sintonia con <strong>la</strong> conformazione degli spazi: <strong>la</strong> giornata<br />
comincia ai piani alti, e i membri del<strong>la</strong> famiglia scendono poi nei<br />
piani più bassi, freschi e bui, durante il corso del<strong>la</strong> giornata: gli<br />
ambienti ai piani bassi sono dunque quelli serali. Il ciclo si completa<br />
di nuovo in alto, sui tetti a terrazza, i quali, essendo stati scaldati<br />
per tutto il giorno dal sole, offrono una superficie ideale per dormire<br />
all'aperto. La famiglia si trasferisce dunque nuovamente verso<br />
l'alto, dove passa <strong>la</strong> notte2. 68<br />
<strong>Analisi</strong> <strong>tipologica</strong> dell’edilizia <strong>tradizionale</strong>: <strong>la</strong> <strong>tipizzazione</strong> ambientale<br />
Una costruzione artico<strong>la</strong>ta in questa maniera presenta<br />
dunque i seguenti vantaggi:<br />
Corti centrali<br />
- ampio sfruttamento degli spazi al pianoterra, più "redditizi"<br />
rispetto a quelli alti;<br />
- possibilità di venti<strong>la</strong>zione ottimale degli ambienti alti;<br />
- possibilità di espansione degli spazi alti in caso di<br />
"al<strong>la</strong>rgamento" del<strong>la</strong> famiglia.<br />
Elemento fondamentale dell'abitazione - cittadina e rurale - del<strong>la</strong><br />
regione indiana è <strong>la</strong> corte centrale. Premesso che si tratta forse<br />
dell'espediente più diffuso nelle aree calde del pianeta per<br />
migliorare le condizioni termiche delle abitazioni, risulta però utile<br />
sottolineare l'uso partico<strong>la</strong>rmente raffinato che se ne è fatto nelle<br />
costruzioni is<strong>la</strong>miche, mediate e tradotte poi nel Subcontinente<br />
indiano.<br />
La corte centrale, anche negli edifici di modesta entità,<br />
mostra una serie di vantaggi ed un'amplissima flessibilità nell'uso.<br />
Come elemento distributivo e spaziale è presente in una<br />
combinazione pressoché infinita di varianti; come dispositivo<br />
bioclimatico <strong>la</strong> sua funzione varia dal vano di venti<strong>la</strong>zione, al<strong>la</strong><br />
semplice presenza come "elemento freddo" a contatto con le pareti
Capitolo II-1<br />
del<strong>la</strong> casa. Sovente si<br />
riscontrano poi nelle corti<br />
altre funzioni, come <strong>la</strong><br />
raccolta dell'acqua piovana<br />
o <strong>la</strong> presenza di<br />
attrezzature speciali per<br />
<strong>la</strong>vorazioni artigianali o<br />
agricole.<br />
Nel<strong>la</strong> tradizione indiana,<br />
<strong>la</strong> "casa a corte" esiste,<br />
come tipologia, da tempi<br />
immemorabili. Dal<br />
Casa a corte a Meknes (Marocco)<br />
semplice recinto delle case<br />
in fango del deserto del<br />
Rajahstan all'invaso monumentalmente decorato delle ricche<br />
magioni cittadine, essa trascende il semplice significato ancestrale<br />
di "spazio delimitato e protetto" per diventare un ambiente aperto<br />
polifunzionale.<br />
Meritano un primo spazio di attenzione gli accorgimenti che<br />
vengono adottati per mantenere le corti ad una temperatura<br />
costantemente bassa:<br />
- rapporto altezza - <strong>la</strong>rghezza studiato in maniera da<br />
69<br />
<strong>Analisi</strong> <strong>tipologica</strong> dell’edilizia <strong>tradizionale</strong>: <strong>la</strong> <strong>tipizzazione</strong> ambientale<br />
impedire l'eccessivo soleggiamento;<br />
- uso di gronde molto sporgenti;<br />
- presenza, al<strong>la</strong> quota pavimento, di specchi d'acqua o<br />
pozzi, che raffreddano l'ambiente tramite un processo di<br />
trasformazione isentalpica dell'aria.<br />
Le corti interne sono pertanto spazi che si trovano<br />
costantemente ad una temperatura più bassa rispetto al resto del<strong>la</strong><br />
costruzione. Le zone abitative, soprattutto se separate dall'esterno<br />
(come nel caso re<strong>la</strong>tivo all'anello termico) affacciano sulle corti<br />
centrali, permettendo così l'immissione, all'interno del<strong>la</strong> casa,<br />
dell'aria più fredda. La differenza di temperatura che si viene a<br />
creare tra le superfici esposte e quelle ombreggiate provoca<br />
immediatamente una venti<strong>la</strong>zione naturale che coadiuva nel<strong>la</strong><br />
creazione di un effetto camino - l'aria calda viene risucchiata<br />
dall'interno degli ambienti e risale verso l'alto. L'effetto camino<br />
viene accentuato<br />
ulteriormente<br />
restringendo <strong>la</strong><br />
sezione del<strong>la</strong> corte<br />
centrale a favore<br />
dell'altezza,<br />
aumentando così <strong>la</strong><br />
velocità dell'aria in<br />
movimento.<br />
Corte interna porticata a Sri Lanka (G. Bawa)
Porticati e colonnati<br />
Elemento presente prevalentemente nell'architettura sacra, il<br />
colonnato presenta, nel<strong>la</strong> semplicità del<strong>la</strong> sua esecuzione<br />
architettonica, un espediente di grande efficacia per <strong>la</strong><br />
realizzazione di un effettivo ombreggiamento del corpo costruito. Il<br />
colonnato, o porticato, se inteso nel<strong>la</strong> sua accezione più urbana, è<br />
un tipo certo non originale del<strong>la</strong> regione indiana, ma deriva più<br />
probabilmente dalle costruzioni occidentali di matrice attica,<br />
ellenistica e poi araba.<br />
Zanzibar: casa cittadina con porticato al pianoterra<br />
Capitolo II-1<br />
70<br />
<strong>Analisi</strong> <strong>tipologica</strong> dell’edilizia <strong>tradizionale</strong>: <strong>la</strong> <strong>tipizzazione</strong> ambientale<br />
Passaggi porticati a Sri Lanka (G. Bawa)<br />
Nel mondo is<strong>la</strong>mico, e soprattutto nel<strong>la</strong> costruzione di<br />
moschee con annessi porticati per lo svolgimento delle funzioni<br />
commerciali tipiche dei luoghi di pellegrinaggio, <strong>la</strong> "piazza coperta"<br />
è un elemento che ha trovato, nel corso dei secoli, un <strong>la</strong>rgo campo<br />
di applicazione. Le moschee stesse, soprattutto quelle di matrice<br />
nordafricana, sono spesso costituite da piazze coperte, con<br />
semplici suddivisioni spaziali scandite dall'ordine del colonnato.<br />
L'intersezione tra lo spazio interno ed esterno è una semplice<br />
interruzione dell'ordine colonnato nel<strong>la</strong> sua zona centrale, per<br />
proseguire solo sui <strong>la</strong>ti, formando spesso uno schema a<br />
quadriportico analogo a quello delle basiliche di pellegrinaggio<br />
dell'era romanica.
Nelle diverse correnti architettoniche che si sono intersecate<br />
nel<strong>la</strong> regione indiana, molteplici esempi di architettura temp<strong>la</strong>re<br />
hanno utilizzato elementi porticati per <strong>la</strong> definizione degli spazi<br />
pubblici. La netta contrapposizione tra spazi ombreggiati e<br />
soleggiati provoca fenomeni di venti<strong>la</strong>zione utili per<br />
l'abbassamento del<strong>la</strong> temperatura all'interno del<strong>la</strong> zona del<br />
porticato.<br />
Note<br />
Capitolo II-1<br />
1 K. Herdeg, Formal Structure in Indian Architecture. New York: Rizzoli, 1990.<br />
2 Per una interessante descrizione del<strong>la</strong> vita di una famiglia parsi a Lahore, si<br />
veda il romanzo di Bapsi Sidhwa, Il talento dei Parsi. Vicenza: Neri Pozza, 2000.<br />
71<br />
<strong>Analisi</strong> <strong>tipologica</strong> dell’edilizia <strong>tradizionale</strong>: <strong>la</strong> <strong>tipizzazione</strong> ambientale
CAPITOLO II-2<br />
L’architettura<br />
contemporanea e lo<br />
sviluppo: identità e alterità<br />
I. L'identità moderna e l'alterità del contesto<br />
Nel mondo in via di sviluppo, nelle cosiddette "economie di<br />
transizione", il fare architettura costituisce un'attività riccamente<br />
problematica, continuamente in sospensione tra i vincoli imposti<br />
dal<strong>la</strong> limitatezza delle risorse e le potenzialità che proprio il<br />
superamento di questi vincoli è in grado di esprimere. Chiaramente<br />
sussiste <strong>la</strong> possibilità di apportare un significativo grado di<br />
innovazione tecnologica, intesa non necessariamente come<br />
"aumento del<strong>la</strong> complessità"; ma ciò che più ci interessa in questa<br />
specifica parte dello studio è <strong>la</strong> questione linguistica, l'ampliamento<br />
dello spettro delle possibilità espressive.<br />
È possibile infatti rintracciare, nel <strong>la</strong>voro di molti architetti<br />
"occidentali" che hanno operato nei paesi in via di sviluppo,<br />
interessanti contaminazioni culturali, derivanti proprio dal<strong>la</strong> volontà<br />
di interpretare positivamente una condizione attuale, ossia quel<strong>la</strong><br />
del<strong>la</strong> limitatezza delle risorse. A partire da Le Corbusier, che in<br />
72<br />
Verso un'architettura scrive "Non c'è l'uomo primitivo; ci sono<br />
mezzi primitivi. L'idea è costante, in potenza dall'inizio" 1, gli<br />
architetti del<strong>la</strong> modernità si sono confrontati con il superamento di<br />
questa scarsezza di mezzi, inventando nuove soluzioni tecniche,<br />
immediatamente riverberatesi nell'ambito figurativo<br />
dell'architettura.<br />
Spesso questo ha portato al<strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione di veri e propri<br />
palinsesti tecnici: applicazioni del tutto sconsiderate di tecnologie<br />
complesse in contesti non adatti al<strong>la</strong> loro riproduzione. In alcuni<br />
casi <strong>la</strong> mitopoietica universalista del<strong>la</strong> modernità si è scontrata<br />
fragorosamente con le realtà del regionalismo, del<strong>la</strong> differenza dei<br />
modelli locali, delle condizioni esterne. In molti altri casi però, i<br />
risultati sono stati bril<strong>la</strong>nti, sia per gli aspetti ambientali affrontati in<br />
maniera innovativa, sia per l'efficacia figurativa dell'architettura che<br />
ne è derivata.<br />
Ciò che ha sempre reso problematico il rapporto tra gli<br />
architetti provenienti dal mondo industrializzato e le realtà di<br />
sviluppo è stata <strong>la</strong> volontà di applicare in maniera pedissequa<br />
modelli provenienti da contesti culturali diversi. Ma questa<br />
tendenza non ha rappresentato una costante nel complesso<br />
rapporto tra l'architettura e l'alterità, se così si vuole riassumere <strong>la</strong><br />
problematica di cui ci stiamo occupando. In alcune epoche e<br />
regioni, ad esempio durante il colonialismo britannico in India,
Capitolo II-2<br />
l'adattamento delle tipologie edilizie tradizionali alle necessità dei<br />
coloni ha dato luogo al<strong>la</strong> nascita di nuove forme costruttive,<br />
sinteticamente ideate per rispondere a esigenze figurative<br />
d'importazione nell'ambito di una realtà locale estrema e<br />
condizionante. Lo sviluppo del bungalow2, ad esempio,<br />
rappresenta un processo di questo genere, dall'esito quanto mai<br />
interessante.<br />
Se da un <strong>la</strong>to l'edilizia "minore" ha sempre mostrato una<br />
maggiore propensione all'adattamento, quel<strong>la</strong> "monumentale" ha<br />
invece più pervicacemente conservato <strong>la</strong> sua identità specifica,<br />
cadendo spesso nel<strong>la</strong> creazione di palinsesti non so<strong>la</strong>mente<br />
tecnologici ma anche figurativi. Eppure, anche in questo campo - si<br />
pensi al<strong>la</strong> Dacca di Kahn, o forse anche al<strong>la</strong> Chandigardh di Le<br />
Corbusier - alcune architetture eccezionali hanno dimostrato come<br />
<strong>la</strong> comprensione delle "culture altre" è effettivamente possibile,<br />
tanto da poter reinterpretare questo sapere e restituirlo come<br />
risposta forte ad un problema che va ben al di là del<strong>la</strong> creazione di<br />
condizioni ambientali confortevoli.<br />
In questi celebri esempi, l'architettura moderna conserva<br />
dunque <strong>la</strong> sua identità, entrando in dialogo con l'alterità del<br />
contesto. È vero che si tratta di opere ideate dai due più grandi<br />
maestri dell'architettura del ventesimo secolo; Is<strong>la</strong>mabad, <strong>la</strong> nuova<br />
capitale per il Pakistan, non è nemmeno lontanamente<br />
73<br />
L’architettura contemporanea e lo sviluppo: identità e alterità<br />
paragonabile a quanto costruito nel Punjab indiano e nel<br />
Bang<strong>la</strong>desh. Ma abbandonando <strong>la</strong> dimensione urbana di questi<br />
interventi alquanto singo<strong>la</strong>ri, possiamo rintracciare molti altri<br />
esempi felici, accanto, ovviamente a fallimenti di vario genere.<br />
Quello che si tenterà di compiere, nelle prossime pagine,<br />
sarà dunque un regesto di alcuni interventi puntuali nei contesti di<br />
sviluppo; interventi che si ritengono significativi per il loro modo di<br />
interagire con l'ambiente dato, con l'universo culturale e materiale<br />
nel quale sono stati realizzati; nonché, e questo è quanto più ci<br />
importa, i diversi modi in cui l'identità dell'architettura moderna si è<br />
misurata con l'alterità dei contesti differenti.<br />
Il periodo storico che è oggetto del<strong>la</strong> presente analisi<br />
sull'architettura "occidentale" nel mondo in sviluppo è <strong>la</strong> seconda<br />
metà del ventesimo secolo; tale periodo pone, soprattutto se<br />
considerato sotto quest'ottica, un problema non indifferente legato<br />
al<strong>la</strong> preponderanza eidetica nel<strong>la</strong> pratica architettonica, questione<br />
del<strong>la</strong> quale si è già par<strong>la</strong>to in precedenza. Nelle opere che stanno<br />
per essere analizzate <strong>la</strong> componente ideologica è fortemente<br />
presente, e funge anzi da fattore determinante centrale, sempre<br />
chiaramente visibile.<br />
Forse proprio per <strong>la</strong> strutturazione più fragile - almeno da un<br />
punto di vista di risorse - dei contesti di sviluppo, in questi esempi
Capitolo II-2<br />
<strong>la</strong> preponderanza dell'idea sembra prendere piede in maniera più<br />
forte rispetto alle opere che gli stessi architetti hanno realizzato in<br />
altri contesti. Purtuttavia è anche riconoscibile una linea di<br />
continuità, che consente una "trasfusione" delle medesime basi<br />
concettuali da un contesto all'altro senza sostanziale variazione. In<br />
altre parole, cambia il grado di "visibilità" del<strong>la</strong> componente<br />
ideologica, ma rimane invariata <strong>la</strong> sua "intenzionalità".<br />
II. Gradi e modi del costruire nello sviluppo<br />
Centro culturale Jean-Marie Tjibaou, Noumea, Nuova Caledonia.<br />
Renzo Piano Building Workshop, con Ove Arup & Partners, 1991-<br />
1998.<br />
Il centro culturale progettato da Renzo Piano nel<strong>la</strong> Nuova<br />
Caledonia costituisce un esempio di "inserimento poetico" molto<br />
caratterizzato. Seguendo una linea di ricerca che gli è propria,<br />
Piano si ispira a morfologie naturali, trasformandone <strong>la</strong> sca<strong>la</strong> e<br />
riadattando gli oggetti così ottenuti in un processo di composizione<br />
a livello paesaggistico.<br />
Il centro culturale a Noumea nasce proprio da una dinamica<br />
di questo genere. Le strutture in legno <strong>la</strong>mel<strong>la</strong>re e acciaio che<br />
Piano utilizza come "guscio" per proteggere e definire i singoli<br />
74<br />
L’architettura contemporanea e lo sviluppo: identità e alterità<br />
Renzo Piano: centro culturale a Noumea. Vista complessiva, porticato e dettaglio costruttivo<br />
padiglioni del complesso sono chiaramente ispirate al<strong>la</strong> struttura<br />
delle nervature delle foglie. Nelle intenzioni dell'architetto, lo scopo<br />
di questi gusci è quello di schermare il sole e modu<strong>la</strong>re l'azione del<br />
vento, alternativamente catturandolo per raffreddare i padiglioni, o<br />
proteggendo da esso gli spazi interni. Anche il sistema (per <strong>la</strong> verità<br />
non del tutto convincente) di venti<strong>la</strong>zione passiva ideato all'interno<br />
dei padiglioni, dovrebbe in qualche modo dipendere da o<br />
col<strong>la</strong>borare con le grandi foglie.<br />
L'intento figurativo di Renzo Piano è chiaro, e costruisce un
Capitolo II-2<br />
insieme che <strong>la</strong>vora efficacemente sulle diverse scale di percezione:<br />
dal<strong>la</strong> dimensione paesaggistica sino a quel<strong>la</strong> del<strong>la</strong> definizione del<br />
dettaglio, il centro culturale riesce effettivamente a dominare il<br />
contesto, determinandolo in maniera univoca. È proprio a questa<br />
univocità che vogliamo rivolgere <strong>la</strong> nostra attenzione: essa esprime<br />
<strong>la</strong> predominanza di un'idea ineluttabile, di un meccanismo che<br />
intende porsi come "tramite" invalicabile gli tra elementi naturali e<br />
l'essere umano.<br />
Il carattere di tecnologia industriale delle opere di Piano - ed<br />
il Centro culturale Tjibaou non fa eccezione - è tale da tendere ad<br />
una trasposizione figurativa dall'ambito architettonico a quello<br />
industriale, tanto da alludere, più che al concetto di "edificio", a<br />
quello di "macchina". Il vasto uso di semi<strong>la</strong>vorati industriali, di<br />
componentistica in acciaio, nonché dello stesso legno <strong>la</strong>mel<strong>la</strong>re,<br />
versione altamente "ingegnerizzata" di un materiale naturale,<br />
esprimono chiaramente questa affinità non so<strong>la</strong>mente visiva.<br />
Si tratta in questo caso di un palinsesto? Piano decide, in<br />
Nuova Caledonia, di utilizzare tecnologie importate in blocco, il che<br />
include ovviamente anche materiali, componenti, nonché il knowhow<br />
necessario per <strong>la</strong> realizzazione dell'opera. L'identità moderna<br />
del<strong>la</strong> sua architettura viene affermata in maniera forte, e gli "scudi"<br />
da lui concepiti sono, in questo senso, più strumento di protezione<br />
da un ambiente "ostile" che non reali elementi di derivazione<br />
75<br />
L’architettura contemporanea e lo sviluppo: identità e alterità<br />
naturale. Il dialogo con il paesaggio è abilmente risolto, grazie<br />
anche all'informalità del<strong>la</strong> disposizione p<strong>la</strong>nimetrica ed al<strong>la</strong> sca<strong>la</strong><br />
abbastanza ridotta dei singoli oggetti; purtuttavia, si tratta di<br />
"macchine", di complessi "respiratori" collocati in un paesaggio, in<br />
un rapporto innegabilmente di "dominazione".<br />
Centro di formazione per l'avicoltura Kahere Ei<strong>la</strong>, Koliagbe,<br />
Guinea. Heikkinen - Komonen Architetti, 1997-2000.<br />
Ad un estremo opposto rispetto al<strong>la</strong> "esuberanza tecnologica" di<br />
Renzo Piano possiamo collocare <strong>la</strong> scuo<strong>la</strong> per avicoltura realizzata<br />
dagli architetti fin<strong>la</strong>ndesi Mikko Heikkinen e Marku Komonen.<br />
Forse limitati da un budget bassissimo (appena superiore ai<br />
100.000 dol<strong>la</strong>ri), gli architetti hanno utilizzato tecnologie costruttive<br />
di base, realizzate con materiali facilmente disponibili e messi in<br />
opera da maestranze locali.<br />
Posti di fronte al<strong>la</strong> problematica centrale del costruire nello<br />
sviluppo - <strong>la</strong> limitatezza delle risorse - i progettisti non hanno<br />
rinunciato a mettere in atto un dialogo fra tradizione locale e<br />
figuratività moderna. Così l'impianto p<strong>la</strong>nimetrico, artico<strong>la</strong>to da<br />
padiglioni intorno ad un'ampia corte centrale dominata da un<br />
albero, è basato sul<strong>la</strong> tipica disposizione dei vil<strong>la</strong>ggi del<strong>la</strong> Guinea,<br />
che è stata qui reinterpretata per riprodurre, all'interno di un centro<br />
di formazione professionale, il senso di "comunità"
Capitolo II-2<br />
Heikkinen - Komonen: centro di formazione per avicoltura a Koliagbe, Guinea<br />
Pianta, veduta d’insieme e interno di un’au<strong>la</strong> didattica<br />
76<br />
L’architettura contemporanea e lo sviluppo: identità e alterità<br />
dell'insediamento tipico.<br />
I tre padiglioni che<br />
circondano <strong>la</strong> corte centrale<br />
manifestano invece con<br />
decisione <strong>la</strong> loro provenienza<br />
europea, se non addirittura<br />
scandinava. Le forme, il<br />
proporzionamento, il rigore<br />
geometrico che li caratterizza<br />
è inequivocabilmente<br />
riconducibile ad una<br />
contemporaneità<br />
dell'architettura neomoderna; ciononostante, l'immagine definitiva<br />
creata da questa architettura non induce necessariamente a<br />
considerar<strong>la</strong> un palinsesto. In parte, ciò è riconducibile al<strong>la</strong> qualità<br />
dei materiali e delle tecniche costruttive adoperate.<br />
I padiglioni sono infatti realizzati principalmente con una<br />
muratura portante in blocchi di terra pressata, innovazione<br />
introdotta per evitare il consumo di combustibili per <strong>la</strong> cottura dei<br />
<strong>la</strong>terizi. Questi blocchi stabilizzati sono completati da singoli<br />
elementi in calcestruzzo, al fine di rendere possibili aperture più<br />
ampie rispetto a quelle che sarebbero ottenibili tramite <strong>la</strong><br />
tecnologia <strong>tradizionale</strong>.
Capitolo II-2<br />
Il legno, risorsa partico<strong>la</strong>rmente scarsa, è stato utilizzato per<br />
realizzare i pi<strong>la</strong>stri che sostengono <strong>la</strong> copertura dell'au<strong>la</strong> didattica:<br />
in mancanza di singoli tronchi di dimensioni sufficienti, questi<br />
pi<strong>la</strong>stri sono stati composti tramite l'aggregazione di quattro parti di<br />
dimensioni ridotte, unite da un'anima in ferro. Anche per <strong>la</strong><br />
travatura del<strong>la</strong> copertura è stato adottato un principio analogo: le<br />
travi in legno, troppo sottili per poter da sole sostenere il carico,<br />
sono state "armate" grazie a semplici tiranti in acciaio. Le altre<br />
tecniche adoperate nel<strong>la</strong> realizzazione del<strong>la</strong> scuo<strong>la</strong> seguono<br />
logiche simili: utilizzo di risorse locali, "trasformate" però attraverso<br />
una "meccanizzazione" elementare, che ne consente l'estensione<br />
delle prestazioni.<br />
Tutti questi accorgimenti necessari per supplire al<strong>la</strong><br />
indisponibilità di materiali da costruzione adeguati sono stati resi<br />
possibili dal<strong>la</strong> conoscenza delle proprietà dei materiali, dunque una<br />
forma di sapere che coniuga l'empirismo del costruire con <strong>la</strong><br />
"cultura razionale" di stampo occidentale. L'applicazione di questa<br />
struttura conoscitiva forte, però, ha portato ad un risultato che<br />
intende dialogare con <strong>la</strong> realtà circostante, sussumendo<strong>la</strong> come<br />
parte fondante del processo che dà forma all'architettura.<br />
77<br />
L’architettura contemporanea e lo sviluppo: identità e alterità<br />
Dacca, nuova capitale del Bang<strong>la</strong>desh. Louis I. Kahn, 1962-1973<br />
Ciò che Louis Kahn ha compiuto con i suoi edifici in Bang<strong>la</strong>desh<br />
(ma anche con i suoi interventi ad Ahmedabad, in India) trascende<br />
per molti versi il senso del presente studio. Kahn,<br />
contemporaneamente a Le Corbusier, rimette in discussione <strong>la</strong><br />
questione del<strong>la</strong> monumentalità, una delle "vittime eccellenti" del<br />
nichilismo modernista. Per fare questo, riparte dalle radici<br />
dell'occidente, ad esempio del<strong>la</strong> cultura architettonica del<strong>la</strong> Roma<br />
imperiale, ma trova proprio in una congiunzione ideale con<br />
l'identità specifica del subcontinente indiano <strong>la</strong> sua ragione<br />
d'essere.<br />
Attento interprete delle tecniche costruttive già nelle sue<br />
opere statunitensi, Kahn affronta <strong>la</strong> scarsità di risorse delle<br />
economie di sviluppo comprendendone i processi di mutamento, e<br />
applicando poi queste potenzialità nei suoi edifici. Nascono così le<br />
acrobazie costruttive del campidoglio di Dacca, <strong>la</strong> magnifica volta<br />
rigata del<strong>la</strong> sa<strong>la</strong> delle assemblee, le coraggiose strutture in<br />
calcestruzzo armate con bambù e altre fibre vegetali3. Il prometeismo dell'architetto è in questo partico<strong>la</strong>re caso<br />
rivolto però, in un certo senso, "all'indietro": Kahn non sta<br />
"inventando" nuove forme, quanto tentando di ricuperare spazialità<br />
antiche - i grandi mausolei moghul - tramite un processo che non
Capitolo II-2<br />
Louis Kahn: assemblea nazionale del Bang<strong>la</strong>desh Vista dal centro cittadino e pianta<br />
78<br />
si limita esclusivamente ad un'imitazione formale. Se l'architettura<br />
è determinata fortemente dalle tecniche che ne consentono <strong>la</strong><br />
messa in opera, è necessario riprodurre anche questa condizione<br />
di autenticità per porre in atto una continuità con <strong>la</strong> storia4. È questo un palinsesto? Quanto forte è <strong>la</strong> componente<br />
ideologica di questa architettura? La profondità metafisica<br />
dell'opera è tale che risulta difficile sondare <strong>la</strong> domanda,<br />
comprenderne le ragioni ultime. È di fatto innegabile che <strong>la</strong> nuova<br />
capitale del Bang<strong>la</strong>desh, a circa trenta anni dal suo<br />
completamento, ha assunto un ruolo fondamentale nel<strong>la</strong><br />
costruzione dell'identità di una nazione . La capacità mostrata da<br />
Kahn di comprendere le istanze immateriali, interpretandole nel<strong>la</strong><br />
materialità del costruito, il tutto all'interno di un dialogo profondo tra<br />
identità moderna e alterità specifica, costituisce comunque un<br />
esempio di grandissimo valore.<br />
Hassan Fathy<br />
L’architettura contemporanea e lo sviluppo: identità e alterità<br />
Accanto a questi tre esempi, testimone ciascuno di una diversa<br />
manifestazione dell'ideologia modernista, si può affiancare l'opera<br />
di Hassan Fathy, l'architetto egiziano che negli anni '50 e '60 diede<br />
un grande impulso allo studio dell'architettura nei contesti di<br />
sviluppo tramite i suoi scritti e <strong>la</strong> sua attività di docente in<br />
Inghilterra.
Diversamente dagli autori<br />
di cui si è fin qui par<strong>la</strong>to,<br />
Fathy proveniva da un<br />
contesto di sviluppo, e delle<br />
sue problematiche era<br />
pertanto intriso in maniera<br />
p<strong>la</strong>usibilmente più profonda<br />
rispetto ad essi. Inoltre, a<br />
dimostrazione di quanto<br />
sovrastrutturale sia il<br />
linguaggio moderno, Fathy<br />
utilizza disinvoltamente il<br />
repertorio vernaco<strong>la</strong>re,<br />
tramutandolo in uno<br />
strumento di attuazione <strong>tipologica</strong> e semantica di rara efficacia. La<br />
capacità di leggere <strong>la</strong> contemporaneità nelle opere di Fathy è<br />
acquisita: lo stemperamento dell'innovazione formale è tanto<br />
accentuato da riportare <strong>la</strong> figurazione ad uno stato<br />
apparentemente "primitivo". Ma nel caso di Fathy non si può<br />
par<strong>la</strong>re certamente di mimesi dell'architettura spontanea: il rigore e<br />
l'ordine formale con cui avviene <strong>la</strong> composizione e lo studio dello<br />
spazio architettonico, testimoniano un'intenzionalità che distingue<br />
nettamente lo "spontaneo" dal "progettato".<br />
Hassan Fathy, Casa Hamed Said a El Marg, 1945<br />
Capitolo II-2<br />
Ciò che dunque distingue nettamente Fathy dagli altri autori<br />
79<br />
L’architettura contemporanea e lo sviluppo: identità e alterità<br />
considerati è <strong>la</strong> volontà di non "formalizzare" <strong>la</strong> ricerca compositiva<br />
con un linguaggio estraneo: nelle case da lui realizzate, l'intero<br />
processo di figurazione avviene tramite un col<strong>la</strong>ge di elementi<br />
costruttivi tradizionali, riutilizzati però secondo modalità che non si<br />
ritiene del tutto errato definire di "spoglio". Dal repertorio formale<br />
tipico dell'architettura domestica nordafricana, Fathy deduce<br />
pertanto le componenti che sono necessarie ai suoi scopi e le<br />
congiunge tra di loro, utilizzando dunque linguaggio e tecniche<br />
costruttive tradizionali e al limite del pittoresco, dando luogo a<br />
nuovi risultati espressivi.<br />
III. Conclusione<br />
I quattro autori che abbiamo considerato rappresentano altrettanti<br />
modi di operare ideologicamente nei contesti "informali" dello<br />
sviluppo. Come si è potuto constatare, <strong>la</strong> gamma di questi sistemi<br />
teorici, anche considerata <strong>la</strong> distanza cronologica che li separa, è<br />
a dir poco vasta. Se ciascuna delle modalità di intervento<br />
presentate possiede una intrinseca coerenza, creando esempi più<br />
che validi di architettura contemporanea, purtuttavia queste opere<br />
rispondono in maniera diversa a quelle che sono state poste come<br />
premesse concettuali al presente <strong>la</strong>voro.<br />
Il procedimento che abbiamo, nell'ambito di queste pagine,
Capitolo II-2<br />
definito come "palinsesto", presenta una serie di problematiche<br />
proprie, che ne rendono più complessa l'applicazione nei contesti<br />
di sviluppo. La mancanza di un collegamento con <strong>la</strong> realtà<br />
materiale del costruire costituisce per l'architettura uno dei più<br />
grandi rischi; e tale pericolo assume connotati ancora più<br />
drammatici quando entra in gioco anche <strong>la</strong> limitatezza delle risorse.<br />
Benché gli esempi presentati siano egregiamente risolti, non<br />
necessariamente possono essere tutti egualmente riprodotti come<br />
"modelli procedurali". La fortissima componente tecnologica di un<br />
intervento come quello di Piano, ad esempio, presuppone <strong>la</strong> totale<br />
sostituzione delle pratiche costruttive specifiche con altre di<br />
"importazione". Lo stesso si può dire del<strong>la</strong> componente figurativa.<br />
Per le architetture di Kahn e di Heikkinen - Komonen, l'equilibrio è<br />
già ristabilito, almeno sotto l'aspetto dell'uso delle risorse. Benché<br />
il patrimonio figurativo non rinunci comunque ad un linguaggio di<br />
tipo "storicamente" moderno, l'uso di tecniche costruttive<br />
appropriate, anzi l'innovazione apportata ad esse, ne rende più<br />
bi<strong>la</strong>nciato l'equilibrio materiale e concettuale. Fathy, al termine<br />
opposto degli altri, sia per <strong>la</strong> componente costruttiva che quel<strong>la</strong><br />
figurativa, sceglie di "citare" l'architettura <strong>tradizionale</strong>, evitando così<br />
di incorrere in problemi di "inserimento culturale".<br />
La condizione ideale, probabilmente, è da ricercarsi proprio<br />
nel termine medio, quello che è lontano sia dall'imposizione di una<br />
tecnicità impropria, ma anche dall'attitudine almeno<br />
80<br />
apparentemente rinunciataria di Fathy. Questo poiché si ritiene che<br />
è proprio attraverso <strong>la</strong> dialettica tra innovazione e conservazione -<br />
tra modernità e tradizione - che può venire al<strong>la</strong> luce un nuovo modo<br />
di fare architettura, un modo, appunto, che trovi <strong>la</strong> sua ragion<br />
d'essere nell'equilibrio tra queste due po<strong>la</strong>rità.<br />
Note<br />
L’architettura contemporanea e lo sviluppo: identità e alterità<br />
1 Le Corbusier, Verso un'architettura, trad. P. Cerri. Mi<strong>la</strong>no, Longanesi, 1984, p.<br />
53.<br />
2 Vedi M. Desai, "The Adaptation and Growth of the Bungalow in India", in<br />
Environmental Design, n. 15-16, 1995.<br />
3 Vedi F. Langford, "Concrete in Dacca", in Mimar, n. 6, ott. - dic. 1982.<br />
4 Vedi, a questo proposito, gli scritti di Kahn, ed in partico<strong>la</strong>re "Legge e rego<strong>la</strong><br />
in Architettura", in Casabel<strong>la</strong>, n. 693, ottobre 2001, p. 4-5.<br />
5 Al riguardo, è fondamentale <strong>la</strong> testimonianza riportata nelle interviste<br />
contenute nel documentario "My Architect: A Son's Journey", di N. Kahn.
CAPITOLO II-3:<br />
Le tecniche costruttive<br />
tradizionali e <strong>la</strong> loro<br />
applicazione attuale<br />
I. Premessa<br />
Nel<strong>la</strong> pratica architettonica contemporanea, dominata da<br />
un'inarrestabile corsa verso il perfezionamento degli standard<br />
tecnologici, l'uso di tecniche costruttive tradizionali può essere<br />
considerato uno "strappo al<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>". Benché quest'affermazione<br />
contenga un certo grado di approssimazione, é anche vero che,<br />
per diverse ragioni, sia nei paesi industrializzati sia in quelli in via<br />
di sviluppo vengono privilegiati metodi costruttivi moderni,<br />
espressione del<strong>la</strong> cosiddetta "industria edilizia".<br />
Quali siano le ragioni di questa tendenza costituisce una<br />
domanda complessa, che necessita di una molteplicità di risposte.<br />
Da un <strong>la</strong>to sono di grande rilevanza i fattori economici, poiché le<br />
tecniche costruttive standardizzate vengono offerte (e spesso<br />
dipinte) come le più facilmente utilizzabili ed economicamente<br />
vantaggiose. Ciò può considerarsi valido a livello "globale", ed il<br />
modo in cui stanno crescendo le grandi città di tutto il mondo ne é<br />
81<br />
senz'altro una prova.<br />
Una seconda ragione risiede nel fatto che le capacità<br />
artigianali richieste per utilizzare molte delle tecniche costruttive<br />
tradizionali sono in buona misura scomparse, perlomeno nelle<br />
nazioni più ricche, nelle quali il processo di specializzazione del<br />
<strong>la</strong>voro ha favorito i modi di produzione industriale. La perdita di<br />
questo patrimonio di conoscenze ed abilità non potrà essere<br />
invertita se non tramite complesse strategie di formazione<br />
professionale. Nei paesi in via di sviluppo questo problema é meno<br />
evidente, ma il numero già normalmente basso di artigiani<br />
qualificati non può tenere il<br />
Herbert Ablinger: edificio industriale con<br />
struttura portante in terra. Pie<strong>la</strong>ch, Austria<br />
passo con l'enorme tasso di<br />
crescita del<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione ed il<br />
conseguente fabbisogno<br />
abitativo.<br />
Una terza ragione, che<br />
deriva dal<strong>la</strong> nostra storia<br />
culturale, ci riporta all'inizio del<br />
ventesimo secolo: <strong>la</strong> nascita<br />
del<strong>la</strong> "estetica macchinista",<br />
rappresentata dall'architettura<br />
Futurista prima e Moderna poi,<br />
ha attribuito alle tecniche
Capitolo II-3<br />
tradizionali un significato di "moralità regressiva". La predominanza<br />
di quest'ideologia rispetto ad altre, ad esempio il "razionalismo<br />
costruttivo" di Auguste Choisy1, ha <strong>la</strong>nciato l'architettura su di una<br />
strada di instancabile innovazione, in buona misura percorsa<br />
ancora oggi.<br />
Le radici di questo fenomeno vanno però ricercate ancora<br />
più indietro nel tempo, durante <strong>la</strong> seconda metà del XIX secolo,<br />
epoca nel<strong>la</strong> quale il "moderno" prodotto industriale cominciò a farsi<br />
strada rispetto all' "antiquato" oggetto artigianale. L'apprezzamento<br />
per i prodotti del<strong>la</strong> catena di montaggio, contro il quale si<br />
scagliarono numerosi intellettuali da John Ruskin in poi, costituisce<br />
a tutt'oggi una delle più radicate matrici culturali del nostro tempo.<br />
Dal Crystal Pa<strong>la</strong>ce del 1851 al<strong>la</strong> Halle des Machines del 1889,<br />
l'assimi<strong>la</strong>zione dell'estetica industriale nell'architettura seguirà un<br />
percorso destinato a cambiare radicalmente il volto delle<br />
costruzioni.<br />
La dipendenza dell'architettura dal<strong>la</strong> tecnica é un fenomeno<br />
che si é già manifestato in precedenti epoche storiche: il concetto<br />
di arte del costruire risale ai tempi medievali, e alcune formu<strong>la</strong>zioni<br />
teoriche, quali <strong>la</strong> Art de Bâtir di Labrouste o <strong>la</strong> Baukunst di Mies<br />
fanno riferimento alle abilità dei capomastri del gotico. Ciò che però<br />
é radicalmente cambiato é <strong>la</strong> qualità di mediazione operata dal<strong>la</strong><br />
tecnica: se in origine si trattava di un insieme di abilità volte a<br />
82<br />
Tecniche costruttive tradizionali e loro applicazione attuale<br />
trasformare risorse esistenti e disponibili in materia costruita, <strong>la</strong><br />
rivoluzione industriale apporterà un nuovo grado di separazione,<br />
consistente nel<strong>la</strong> capacità di creare risorse non direttamente<br />
disponibili in natura.<br />
É chiaro che questo processo può so<strong>la</strong>mente avere luogo<br />
<strong>la</strong>ddove sia presente un sistema industriale altamente<br />
specializzato. Fino all'avvento dell'industrializzazione coloniale,<br />
quelle regioni geografiche nelle quali tale evoluzione ancora non<br />
aveva avuto luogo dovevano necessariamente fare affidamento su<br />
tecniche costruttive tradizionali.<br />
La produzione industriale in sé non é moralmente<br />
discutibile, poiché può essere considerata semplicemente uno<br />
strumento di mediazione tra l'universo materiale ed il mondo<br />
immateriale delle esigenze umane. Ciò che sicuramente però<br />
costituisce un problema obiettivo é il costo del sistema industriale:<br />
dal punto di vista di sfruttamento delle risorse, impatto ambientale,<br />
nonché di vera capacità di soddisfare i bisogni dell'uomo,<br />
rimangono sicuramente aperte molte questioni.<br />
Date queste premesse, lo scopo di questo capitolo sarà<br />
quello di illustrare alcune considerazioni sull'uso delle tecniche<br />
costruttive tradizionali nel contesto edilizio contemporaneo, sia nei<br />
paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo. Verrà prestata
Capitolo II-3<br />
attenzione sia a tecniche consolidate che ad altre di carattere più<br />
innovativo, e verranno presentati alcuni esempi.<br />
II. Le tecniche costruttive tradizionali e <strong>la</strong> loro applicazione<br />
nell'architettura contemporanea<br />
Svantaggi derivanti dall'uso di tecniche costruttive tradizionali<br />
Per avvicinarci alle radici del problema dell'uso nel contesto<br />
contemporaneo delle tecniche costruttive tradizionali é necessario<br />
analizzare attentamente quali sono i motivi che potrebbero<br />
frenarne l'applicazione, sia nei paesi industrializzati che in quelli in<br />
via di sviluppo.<br />
Un primo motivo, secondo Amos Rapoport2, é da<br />
identificarsi nelle tendenze socioculturali prevalenti, le quali<br />
possono essere considerate una conseguenza del<strong>la</strong><br />
"occidentalizzazione" del mondo. Nel costruire una casa per il<br />
proprio uso, <strong>la</strong> maggior parte delle persone preferisce aderire ad<br />
una "immagine" che faccia riferimento ad un partico<strong>la</strong>re stile di vita,<br />
spesso a scapito di altri fattori, quali i costi, il comfort, <strong>la</strong><br />
durevolezza delle strutture ecc. In ogni area suburbana delle<br />
grandi città occidentali, ad esempio, é raro incontrare edifici<br />
residenziali realizzati con tecniche radicalmente diverse rispetto a<br />
83<br />
Tecniche costruttive tradizionali e loro applicazione attuale<br />
quelle delle case adiacenti. Oltre ad essere un riparo, <strong>la</strong> casa é il<br />
simbolo di uno stile di vita, di una mentalità, dell'appartenenza ad<br />
una comunità e dello status economico e sociale del<strong>la</strong> persona che<br />
<strong>la</strong> abita.<br />
Il fatto che una casa esprima tutti questi valori rende difficile<br />
una rie<strong>la</strong>borazione dell'immagine complessiva dell'edificio:<br />
Rapoport considera questo fatto una costante pressoché<br />
universale, applicabile al<strong>la</strong> maggior parte delle società del mondo.<br />
Come esempio, cita il caso di un programma di sviluppo abitativo<br />
nell'Altip<strong>la</strong>no peruviano3, che dovette confrontarsi (e infine cedere)<br />
Djenne (Mali): <strong>la</strong> grande mosche in terra, costruita nel 1907
Capitolo II-3<br />
al desiderio dei fruitori finali di avere tetti in <strong>la</strong>miera metallica<br />
piuttosto che costruiti con tecniche tradizionali, nonostante il<br />
pessimo grado di comfort consentito da questo specifico materiale.<br />
Ma l'immagine era più importante, e dovette essere imposta come<br />
priorità.<br />
La necessità di avere un riparo, secondo Rapoport, é fisica<br />
ma anche psicologica, e piuttosto che vivere in una casa che non<br />
corrisponda al<strong>la</strong> propria idea di "casa", molte persone sono<br />
disposte a rinunciare a potenziali vantaggi.<br />
Oltre a questi fattori culturali ve ne sono altri, molto più<br />
concreti, che impediscono <strong>la</strong> diffusione più ampia delle tecniche<br />
costruttive tradizionali: <strong>la</strong> mancanza di abilità artigianali negli<br />
operatori del settore é un motivo; un altro é legato al<strong>la</strong> disponibilità<br />
di risorse primarie.<br />
Benché in genere le tecniche costruttive tradizionali<br />
vengono realizzate con materiali disponibili localmente, é anche<br />
vero che il cambiamento delle condizioni ambientali può aver<br />
causato <strong>la</strong> riduzione nel<strong>la</strong> accessibilità di tali risorse. Il caso del<br />
legno é evidente: in molte regioni l'uso eccessivo del patrimonio<br />
boschivo per fini edilizi ed energetici ha reso sempre più rara<br />
questa risorsa, soprattutto quando non sono stati messi in atto<br />
programmi di rimboschimento.<br />
84<br />
Tecniche costruttive tradizionali e loro applicazione attuale<br />
Oltre all'evidente danno ecologico causato dal<br />
disboscamento, che provoca erosione del suolo, scomparsa degli<br />
habitat naturali ecc., é chiaro che <strong>la</strong> diminuzione del materiale edile<br />
comporta l'innalzamento dei prezzi, riducendo quindi il numero di<br />
utenti finali che hanno accesso a questo bene. Se nei paesi<br />
industrializzati il sistema del mercato offre prodotti alternativi che<br />
possono sostituire completamente il legno, nelle aree più povere<br />
del mondo non sempre sono disponibili altre tecniche che possano<br />
supplire al<strong>la</strong> mancanza di questo materiale. A causa del<strong>la</strong> durata<br />
limitata del legno come materiale da costruzione, il suo riuso per<br />
fini edilizi può essere compiuto solo entro determinati limiti, anche<br />
se in alcune regioni nelle quali <strong>la</strong> sua disponibilità é estremamente<br />
limitata, le travi di grandi dimensioni vengono tradizionalmente<br />
riutilizzate più volte in edifici successivi.<br />
Il legno rappresenta il caso più evidente di questa<br />
problematica, ma molti altri materiali da costruzione sono<br />
comunque divenuti meno facilmente accessibili a causa del<strong>la</strong><br />
scomparsa delle loro pratiche produttive. In molti casi, i prodotti<br />
industriali sono diventati l'unica vera alternativa, in termini sia di<br />
accessibilità che di costi.<br />
In anni recenti, nelle economie emergenti sono stati condotti<br />
molti programmi per ripristinare le tecniche tradizionali di<br />
produzione dei materiali; benché alcune esperienze si siano
Capitolo II-3<br />
rive<strong>la</strong>te positive, non é stata possibile <strong>la</strong> loro diffusione su <strong>la</strong>rga<br />
sca<strong>la</strong>.<br />
Un altro tipo di problema, di grande importanza nei contesti<br />
industrializzati, é quello dell'adeguamento delle tecniche<br />
tradizionali alle normative edilizie. Gli standard prestazionali attuali<br />
sono in genere basati sulle caratteristiche dei sistemi costruttivi<br />
industrializzati, che vengono standardizzati e certificati per quanto<br />
riguarda <strong>la</strong> resistenza meccanica, <strong>la</strong> normativa antincendio, i<br />
parametri igienici, <strong>la</strong> qualità del<strong>la</strong> finitura ecc. La maggior parte<br />
delle tecniche costruttive tradizionali non è stata sottoposta a<br />
questo processo di standardizzazione normativa, e viene pertanto<br />
esclusa da un uso rego<strong>la</strong>re, ponendo un serio ostacolo al<strong>la</strong> sua<br />
diffusione.<br />
Per "aggiornare" le tecniche costruttive tradizionali é<br />
richiesto uno sforzo di ricerca molto ampio, poiché é necessario<br />
giungere ad un livello di standardizzazione che ne assicuri <strong>la</strong><br />
costanza di esecuzione al di là delle condizioni locali. Nonostante<br />
<strong>la</strong> comprovata fattibilità di questo processo, dimostrata dallo<br />
sviluppo di tecniche semi-industrializzate di costruzione in terra<br />
negli Stati Uniti, si tratta certamente di un traguardo a lungo<br />
termine, che investe sia il settore pubblico sia quello privato.<br />
Rimane comunque aperta una questione di carattere ideologico:<br />
quanto più "sostenibili" possono considerarsi delle tecniche<br />
85<br />
Tecniche costruttive tradizionali e loro applicazione attuale<br />
dall'esecuzione artigianale, che utilizzino però materie prime non<br />
locali al fine di assicurare <strong>la</strong> buona riuscita dell'opera?<br />
Nei paesi in via di sviluppo, nei quali <strong>la</strong> normativa edilizia<br />
non é ancora consolidata e consente quindi una maggiore<br />
flessibilità, questo problema non é così evidente, ma richiede<br />
comunque delle serie riflessioni. È importante stabilire delle<br />
prestazioni minime dei materiali e delle tecniche costruttive, per<br />
assicurare che <strong>la</strong> loro applicazione non sia di fatto nociva per <strong>la</strong><br />
salute o metta a repentaglio l'incolumità dei fruitori. Se queste<br />
tecniche venissero rese appetibili da un punto di vista economico<br />
ma anche culturale, é p<strong>la</strong>usibile che diventerebbero un'alternativa<br />
valida non so<strong>la</strong>mente nelle economie di sviluppo, ma anche<br />
nell'occidente industrializzato.<br />
Vantaggi derivanti dall'uso di tecniche costruttive tradizionali<br />
Dopo aver brevemente analizzato i problemi principali derivanti<br />
dall'uso di tecnologie tradizionali, si può passare ad un'analisi di<br />
quelli che invece sono i vantaggi che si possono ottenere tramite <strong>la</strong><br />
loro applicazione. L'elenco dei benefit è alquanto ampio, anche<br />
<strong>la</strong>sciando da parte motivazioni strettamente ideologiche o<br />
estetiche: le loro potenzialità sono assolutamente fuori<br />
discussione. Alcuni di questi vantaggi possono essere considerati<br />
in un contesto generale; altri sono invece specifici delle situazioni
di sviluppo.<br />
Capitolo II-3<br />
Thatta (Sindh, Pakistan): case con “gabbie” per catturare i venti<br />
Il primo punto rilevante é nuovamente quello delle<br />
prestazioni. La ridotta aderenza alle normative edilizie non significa<br />
necessariamente prestazioni insufficienti, poiché spesso<br />
l'impostazione del sistema normativo é tale da escludere i materiali<br />
tradizionali non su base prestazionale. La corretta applicazione<br />
delle tecniche costruttive premoderne può fornire ottimi risultati<br />
che, d'altro canto, sarebbero difficilmente ottenibili tramite i sistemi<br />
costruttivi standardizzati.<br />
Ciascuna regione geografica ha prodotto, nel corso del<strong>la</strong><br />
86<br />
Tecniche costruttive tradizionali e loro applicazione attuale<br />
sua storia, un patrimonio di tecniche caratteristiche, che<br />
possiedono <strong>la</strong> virtù di essere perfettamente adattate all'ambiente<br />
fisico nel quale sono nate. Il collegamento tra condizioni materiali<br />
e costruzione é diretto, derivante da un lungo processo di<br />
evoluzione tecnica: <strong>la</strong> conoscenza pre-scientifica dei fenomeni<br />
naturali ha consentito persino lo sviluppo di sistemi tecnici ad alta<br />
complessità, come le torri del vento o sistemi di raffreddamento ad<br />
acqua. I tipi edilizi regionali sono spesso perfettamente adattati<br />
anche agli ambienti più estremi: Rapoport cita il caso dell'igloo<br />
eschimese come l'esempio più <strong>la</strong>mpante. Ovviamente é anche<br />
possibile trovare delle eccezioni a questa norma: in alcuni casi<br />
partico<strong>la</strong>ri le istanze simboliche sono state privilegiate rispetto a<br />
quelle del comfort o del<strong>la</strong> economicità; in generale però<br />
l'adattamento alle condizioni locali é ottimale.<br />
Durante <strong>la</strong> seconda metà del XX secolo, il recupero di<br />
queste logiche "regionali" é stato al centro del dibattito<br />
architettonico; in parte, l'architettura so<strong>la</strong>re passiva è stata il<br />
risultato di questo dibattito e del<strong>la</strong> "riscoperta" di strumenti tecnici<br />
di antica origine.<br />
Nel contesto delle economie emergenti, le tecniche<br />
costruttive tradizionali, se applicate correttamente, possono<br />
consentire <strong>la</strong> realizzazione di soluzioni economiche e molto<br />
efficienti, in campo residenziale e non.
Capitolo II-3<br />
Questa considerazione ci porta al prossimo punto del<strong>la</strong><br />
questione, quello economico. Da questo punto di vista, le<br />
condizioni variano ampiamente a seconda del carattere specifico<br />
del sistema economico locale. Nei paesi occidentali, <strong>la</strong> scelta di<br />
adottare tecniche costruttive tradizionali può condurre ad un<br />
aumento dei costi; ciò può essere dovuto a diversi fattori: da un <strong>la</strong>to<br />
<strong>la</strong> necessità di avvalersi di manodopera con abilità specifiche e di<br />
limitata presenza sul mercato, con il conseguente aumento del<br />
costo; dall'altro, i materiali da costruzione industriali sono<br />
disponibili a costi bassi, e nessuna tecnica <strong>tradizionale</strong> può<br />
competere con essi sotto questo aspetto. Se é vero che si può<br />
ottenere un ammortamento grazie al<strong>la</strong> maggiore efficienza<br />
energetica, si tratta di tempi molto estesi che non agevo<strong>la</strong>no <strong>la</strong><br />
diffusione di queste pratiche. In assenza dunque del desiderio di<br />
un'immagine architettonica di tipo diverso o di una migliore qualità<br />
ambientale, é difficile che le tecniche costruttive alternative si<br />
impongano su una vasta sca<strong>la</strong>.<br />
Nelle economie di sviluppo le cose sono alquanto diverse.<br />
La mancanza di risorse monetarie causa una sostanziale<br />
impossibilità di acquisire materiali prodotti industrialmente. Dato<br />
che molte delle tecniche tradizionali possono essere eseguite<br />
senza un gran numero di <strong>la</strong>voratori specializzati, ed i materiali<br />
necessari sono spesso direttamente disponibili dall'ambiente<br />
circostante, i singoli individui o intere comunità possono utilizzarle<br />
87<br />
Tecniche costruttive tradizionali e loro applicazione attuale<br />
con un enorme vantaggio economico. Un gran numero di comunità<br />
rurali nei paesi in via di sviluppo mettono in atto questo processo<br />
ancora oggi, sfruttando abilità e conoscenze che vengono<br />
trasmesse di generazione in generazione.<br />
Una volta che queste comunità rurali vengono disciolte a<br />
causa del<strong>la</strong> migrazione urbana, le condizioni sociali che<br />
consentono <strong>la</strong> messa in atto di queste pratiche costruttive vengono<br />
meno. La perdita di identità culturale e di spirito comunitario<br />
comporta anche l'abbandono delle tecniche costruttive tradizionali:<br />
le conseguenze di questo processo sono devastanti, poiché "l'atto<br />
del costruire" in quanto tale rappresenta uno dei più importanti<br />
fattori di coesione sociale, all'interno del quale ogni categoria di<br />
individui - uomini, donne, anziani e bambini - trovano il proprio<br />
ruolo. Il costruire costituisce l'atto di fondazione per antonomasia.<br />
In molti programmi di recupero di insediamenti informali in<br />
tutto il mondo il riutilizzo di pratiche costruttive estinte é stato al<br />
centro degli interventi. Il riportare in vita il processo che consentiva<br />
di costruire il vil<strong>la</strong>ggio può dar luogo al<strong>la</strong> ricostituzione dell'unità<br />
sociale autocosciente, incarnata nell'atto col<strong>la</strong>borativo del<br />
costruire. Dato che l'intero processo, dal<strong>la</strong> produzione dei materiali<br />
sino al<strong>la</strong> costruzione ed al<strong>la</strong> finitura, può essere compiuto<br />
all'interno del<strong>la</strong> comunità stessa, sono richieste poche risorse<br />
monetarie. Inoltre viene ridotto l'impatto ambientale, con ovvi
Capitolo II-3<br />
vantaggi da un punto di vista ecologico.<br />
I risultati più importanti vengono però ottenuti sotto l'aspetto<br />
del<strong>la</strong> qualità sociale, poiché il livello di vita del<strong>la</strong> comunità può<br />
migliorare notevolmente, soprattutto nel<strong>la</strong> messa in atto di strategie<br />
di self-help. La rivitalizzazione delle tecniche costruttive<br />
tradizionali, pertanto, può consentire anche un miglioramento da<br />
un punto di vista "umanitario".<br />
Come estensione di questa considerazione, possiamo far<br />
riferimento a quello che Fritz Schumacher definì "tecnologia dal<br />
volto umano". Nell'osservare che in genere <strong>la</strong> tecnologia tende a<br />
ridurre il <strong>la</strong>voro manuale, Schumacher scrive:<br />
Il tipo di <strong>la</strong>voro che <strong>la</strong> tecnologia moderna riduce in maniera più efficace<br />
é l'abile e produttivo <strong>la</strong>voro del<strong>la</strong> mani dell'uomo, che maneggiano veri<br />
materiali di un tipo o un altro. In una società industriale avanzata questo<br />
<strong>la</strong>voro é divenuto molto raro, e guadagnare decorosamente tramite<br />
queste attività é praticamente impossibile. Una gran parte delle<br />
moderne nevrosi potrebbero essere derivate proprio da questo fatto;<br />
perché gli esseri umani, che vennero definiti da Tommaso d'Aquino<br />
esseri con cervello e mani, apprezzano più di qualsiasi altra cosa essere<br />
impegnati utilmente e creativamente con le mani e con il cervello. 4<br />
Questa affermazione comporta un gran numero di<br />
considerazioni successive. Benché intrisa di considerazioni<br />
ideologiche di matrice marxista, va a criticare buona parte delle<br />
88<br />
Tecniche costruttive tradizionali e loro applicazione attuale<br />
esperienze culturali del XX secolo e, in partico<strong>la</strong>r modo, l'ideologia<br />
dominante del modernismo in architettura e nelle arti industriali.<br />
La questione é però più sottile; quanto Schumacher afferma<br />
contiene un senso profondo di verità, poiché il sentimento di<br />
piacere implicito nell'atto del fare é innegabile. È forse l'intera<br />
cultura moderna ad essere a rischio a causa del<strong>la</strong> perdita<br />
dell'attitudine al "fare"? È meglio <strong>la</strong>sciare questa domanda senza<br />
risposta, ma i risultati positivi ottenuti tramite le attività di self-help<br />
nei paesi in via di sviluppo non possono che dare ragione alle<br />
affermazioni di Schumacher.<br />
Un ulteriore e fondamentale aspetto dell'uso delle<br />
tecnologie tradizionali é quello del loro impatto ambientale. Per<br />
definizione, queste tecnologie sono prevalentemente <strong>la</strong>bourintensive,<br />
e si avvalgono di risorse disponibili localmente. Queste<br />
due peculiarità assicurano un certo grado di sostenibilità: <strong>la</strong> grande<br />
quantità di manodopera richiesta implica in genere l'assenza di<br />
macchinari dispendiosi e ad alto consumo energetico, e le risorse<br />
locali non richiedono trasporti su lunghe distanze, riducendo<br />
ulteriormente l'aggravio sul bi<strong>la</strong>ncio energetico.<br />
Nelle nazioni industrializzate, <strong>la</strong> quantità di <strong>la</strong>voro manuale<br />
può in genere essere ridotta tramite l'uso di macchinari di picco<strong>la</strong><br />
dimensione, in genere meno dannosi da un punto di vista ecologico
dei grandi impianti di produzione.<br />
Chiaramente bisogna considerare l'impatto che queste<br />
tecniche hanno sul paesaggio fisico. Se condotto senza controllo o<br />
una conoscenza minima delle proprietà del tessuto naturale, l'uso<br />
di materiali ottenuti direttamente dall'ambiente può causare danni<br />
ecologici di non lieve entità. Ad esempio, abbattere una foresta per<br />
costruire baite in legno non é esattamente un'attività ecologica, ma<br />
tali estremi possono essere control<strong>la</strong>ti attraverso un uso equilibrato<br />
delle risorse rinnovabili. Si può comunque ipotizzare che coloro<br />
che utilizzano le tecniche costruttive tradizionali per il loro carattere<br />
ecologico dovrebbero, almeno in certa misura, possedere una<br />
sufficiente consapevolezza ambientale per evitare certe<br />
contraddizioni.<br />
Possibili ambiti di miglioramento<br />
Capitolo II-3<br />
Come si è visto, le tecniche costruttive tradizionali possiedono un<br />
enorme potenziale, che spazia dagli aspetti economici a quelli<br />
sociali ed ambientali. Nonostante questo, il loro campo di<br />
applicazione é assai limitato, per diverse ragioni, sia nei paesi in<br />
via di sviluppo che in quelli industrializzati. Per ciascuna di queste<br />
due realtà, anche se con un alto grado di generalizzazione, é<br />
possibile ipotizzare alcune strategie per aumentare l'uso di queste<br />
tecnologie. Tali strategie possono essere riassunte sotto tre punti:<br />
89<br />
Tecniche costruttive tradizionali e loro applicazione attuale<br />
formazione professionale, riduzione dei costi, e miglioramento<br />
attraverso <strong>la</strong> ricerca tecnologica. Ciascuno di questi tre aspetti<br />
trova applicazione sia nei paesi ricchi che in quelli poveri.<br />
La formazione professionale comporta <strong>la</strong> creazione o<br />
l'al<strong>la</strong>rgamento di una c<strong>la</strong>sse di operai specializzati che siano in<br />
grado di utilizzare le tecniche costruttive tradizionali su base non<br />
elitaria. Le modalità con le quali questi operai possono essere<br />
formati variano da regione a regione5, e dovrebbero in genere<br />
rispettare i modi consolidati di trasmissione culturale. Una volta che<br />
questa c<strong>la</strong>sse professionale sia stata formata e sia operativa sul<br />
mercato, <strong>la</strong> riduzione dei costi sarà una delle prime conseguenze.<br />
Un'ulteriore questione legata al<strong>la</strong> formazione professionale,<br />
e di fondamentale importanza, é re<strong>la</strong>tiva all'espansione del<strong>la</strong><br />
coscienza ambientale che queste tecniche possono causare, da un<br />
punto di vista generale ma anche più specificamente ecologico.<br />
Nel contesto delle economie industriali, ciò può essere associato<br />
ad una promozione di queste tecniche da un punto di vista di<br />
"moda".<br />
La riduzione dei costi é da un <strong>la</strong>to legata al<strong>la</strong> formazione<br />
professionale; dall'altro, é determinata dal<strong>la</strong> disponibilità dei<br />
materiali. L'accessibilità dipende da molti fattori, dal<strong>la</strong> disponibilità<br />
delle materie prima nelle vicinanze, al<strong>la</strong> qualità delle infrastrutture
Capitolo II-3<br />
a livello nazionale, fino al<strong>la</strong> normativa che rego<strong>la</strong> l'uso delle risorse<br />
naturali.<br />
La ricerca tecnologica nel campo delle costruzioni<br />
tradizionali può favorire <strong>la</strong> loro applicazione sia nei paesi in via di<br />
sviluppo sia in quelli industrializzati. Da un <strong>la</strong>to può accelerare il<br />
processo di standardizzazione che, come è stato precedentemente<br />
osservato, costituisce un ostacolo per <strong>la</strong> diffusione a <strong>la</strong>rgo raggio.<br />
Dall'altro, può migliorare le prestazioni dei materiali, fornendo delle<br />
alternative per quelli non facilmente accessibili, e adattando le<br />
tecniche tradizionali ai bisogni contemporanei.<br />
Nei contesti di sviluppo numerosi progetti hanno contribuito<br />
al<strong>la</strong> promozione dell'uso delle tecniche costruttive tradizionali<br />
tramite le suddette strategie. Benché molte di queste iniziative<br />
abbiano dato risultati eccellenti, <strong>la</strong> loro influenza é rimasta limitata<br />
ad ambienti ristretti, poiché le pressioni economiche e culturali<br />
imposte dalle tecniche "moderne" non <strong>la</strong>sciano molto spazio alle<br />
alternative.<br />
90<br />
III. Conclusione<br />
Tecniche costruttive tradizionali e loro applicazione attuale<br />
Come si è visto, le tecniche costruttive tradizionali vengono al<br />
giorno d'oggi alquanto dibattute; sorge dunque <strong>la</strong> domanda sul<br />
perché di tanto interesse. Sembra in fatti che non tutti gli sforzi<br />
convergano in una so<strong>la</strong> direzione, ma siano piuttosto frammentati<br />
su diverse posizioni ideologiche.<br />
Da un <strong>la</strong>to, le nazioni industrializzate sembrano aver trovato<br />
in queste tecniche una nuova frontiera di sviluppo economico. Da<br />
questo punto di vista, il fattore estetico svolge un ruolo importante,<br />
non del tutto bi<strong>la</strong>nciato tra nostalgia vernaco<strong>la</strong>re e vera<br />
progettazione architettonica.<br />
Un altro fattore importante è quello rappresentato dal<br />
"misticismo ecologico" così in voga nel<strong>la</strong> società occidentale<br />
odierna: gli esponenti radicali di questo movimento vedono nelle<br />
pratiche costruttive tradizionali uno strumento di emancipazione<br />
dal<strong>la</strong> catene del<strong>la</strong> produzione industriale.<br />
Infine, nei paesi in via di sviluppo le tecniche costruttive<br />
tradizionali vengono considerate per <strong>la</strong> loro "appropriatezza", una<br />
sorta di "ultimo baluardo" prima del col<strong>la</strong>sso finale delle megalopoli<br />
del terzo mondo. Al<strong>la</strong> ricerca di un nuovo (e politicamente corretto)<br />
Existenzminimum, sia gli operatori dello sviluppo sia i costruttori
locali cercano di realizzare una "architettura per i poveri".<br />
I primi due fattori considerati non sembrano di fatto<br />
possedere molto potenziale per divenire un vero nuovo stimolo per<br />
l'architettura, mancando di quel<strong>la</strong> demiurgica forza di risolvere i<br />
problemi che è tipica del<strong>la</strong> disciplina: si tratterebbe, almeno<br />
apparentemente, di edifici convenzionali con un "look" pittoresco.<br />
Può darsi dunque che le cose debbano funzionare al<br />
contrario. Invece di imparare dai paesi ricchi, dovrebbero essere i<br />
paesi in via di sviluppo ad insegnare, non tanto <strong>la</strong> pratica<br />
costruttiva in sé, quanto il punto di vista ideologico del costruire con<br />
ciò che già esiste. Se mai questo processo dovesse venire al<strong>la</strong><br />
luce, lo si potrebbe battezzare reverse technology transfer.<br />
Note<br />
1 Vedi R. Banham, Theory and Design in the First Machine Age. New York:<br />
Praeger, 1967, p. 23-34.<br />
2 Vedi A. Rapoport, House Form and Culture. Englewood Cliffs: Prentice-Hall,<br />
1969, specialmente il capitolo 3.<br />
3 A. Rapoport, ibidem, p. 22-24.<br />
Capitolo II-3<br />
91<br />
Tecniche costruttive tradizionali e loro applicazione attuale<br />
4 E. F. Schumacher. Small is Beautiful. Point Roberts: Hartley and Marks, 1999,<br />
p. 122.<br />
5 Vedi P. Oliver, "Transmitting Technologies", in Mimar n.38, March 1991.
CAPITOLO II-4:<br />
Un caso di studio: le<br />
costruzioni in terra oggi<br />
I. Premessa. Perché le costruzioni in terra?<br />
Tra tutte le tecniche costruttive che appartengono al passato<br />
"vernaco<strong>la</strong>re" dell'architettura, le costruzioni in terra sono senz'altro<br />
quelle che hanno più profondamente affascinato i progettisti, a<br />
partire dal<strong>la</strong> seconda metà del XX secolo. Di conseguenza, questa<br />
tecnica è stata continuamente riutilizzata, rie<strong>la</strong>borata e innovata.<br />
Le ragioni per questo interesse diffuso sono molte, e si tenterà qui<br />
di esporne alcune.<br />
Le ragioni culturali innanzi tutto, considerato che le<br />
costruzioni in terra rappresentano un modo antico, addirittura<br />
arcaico di fare architettura: si può quasi affermare che<br />
appartengono al "DNA architettonico" del genere umano. Grazie<br />
al<strong>la</strong> sua vastissima diffusione, <strong>la</strong> costruzione in terra è parte del<br />
patrimonio architettonico di quasi ogni cultura.<br />
Nel<strong>la</strong> sua costante ricerca di radici, l'architettura si é<br />
occupata molte volte l'idea dell'edificio primitivo: ne è prova il<br />
92<br />
dibattito, avvenuto a partire dal XVIII secolo, sul<strong>la</strong> capanna<br />
primitiva. Durante il XX secolo, nell'ambito delle ampie ricerche<br />
antropologiche sulle culture primitive quali quelle di Frobenius<br />
sull'Africa antica, l'interesse si é spostato all'architettura<br />
spontanea, dissolvendo il velo quasi "mitico" che avvolgeva le<br />
teorizzazioni precedenti. Il celebre volume di Bernard Rudofsky<br />
Architecture without Architects, pubblicato al principio degli anni<br />
'70, risvegliò un enorme interesse per le costruzioni in terra.<br />
Se durante i periodi precedenti gli studi sull'architettura<br />
primitiva erano stati alimentati dall'interesse antropologico<br />
Zone di diffusione delle costruzioni in terra in tutto il pianeta (da Houben)
Capitolo II-4<br />
nell'ambito sociale, ad esempio nel famoso caso italiano dei Sassi<br />
di Matera, l'architettura spontanea venne successivamente<br />
investigata per le sue potenzialità estetiche da un <strong>la</strong>to, e, a partire<br />
dai primi anni '70, momento di def<strong>la</strong>grazione del<strong>la</strong> grande crisi<br />
energetica ed ecologica, per i suoi aspetti di sostenibilità,<br />
prevalentemente legati ai fattori tecnici ed ai metodi so<strong>la</strong>ri passivi.<br />
Accanto a questa tendenza chiaramente occidentale, i<br />
progetti di sviluppo in tutto il mondo hanno cominciato ad<br />
interessarsi alle tecniche costruttive tradizionali, piuttosto che<br />
all'applicazione in contesti di sviluppo di pratiche industrializzate.<br />
Ciò fu reso possibile anche grazie ad un primo momento di sintesi,<br />
avvenuto a seguito del<strong>la</strong> realizzazione di interventi di cooperazione<br />
internazionale che avevano messo in evidenza i limiti del transfer<br />
di tecnologie operato su base "dogmatica". Le “tavole” di Mahoney,<br />
sviluppate per conto delle Nazioni Unite, furono un risultato di<br />
queste riflessioni, una critica nei confronti di quanto era stato<br />
realizzato sino a quel momento.<br />
Le costruzioni in terra, chiaramente, hanno svolto un ruolo<br />
fondamentale in questo processo di sviluppo, con un rinnovato<br />
interesse che legava i paesi industrializzati a quelli in via di<br />
sviluppo. Al<strong>la</strong> fine degli anni '70 una serie di associazioni, quali <strong>la</strong><br />
francese CRATerre, hanno iniziato il loro programma di ricerca e<br />
cooperazione. A tutt'oggi, l'interesse in questo campo non é ancora<br />
93<br />
diminuito.<br />
Un caso di studio: le costruzioni in terra oggi<br />
II. L'adattamento ai contesti industrializzati contemporanei<br />
A differenza di molte altre tecniche costruttive tradizionali, le<br />
costruzioni in terra vivono una grande popo<strong>la</strong>rità, che le ha portate<br />
ad essere adattate al contesto architettonico contemporaneo.<br />
Queste innovazioni, purtuttavia, non hanno alterato<br />
significativamente il carattere delle tecniche originali, contribuendo<br />
al<strong>la</strong> sostanziale conservazione delle tecniche tradizionali nel<strong>la</strong><br />
Sistema di casseforme commerciale per <strong>la</strong> realizzazione di pareti portanti in terra
pratica contemporanea.<br />
Capitolo II-4<br />
Il primo risultato del<strong>la</strong> ricerca tecnologica è stato quello di<br />
stabilire una serie di prove che possono fornire le informazioni<br />
necessarie sulle caratteristiche delle materie prime, a partire dal<br />
terriccio utilizzato per l'impasto. Queste informazioni determinano<br />
<strong>la</strong> procedura ottimale da seguirsi per ottenere <strong>la</strong> massima qualità<br />
del prodotto finito1. È stato sviluppato un gran numero di test, e i<br />
dati risultanti possono essere utilizzati sin dal<strong>la</strong> fase di<br />
progettazione. In generale, questi metodi di analisi stabiliscono i<br />
valori di parametri quali composizione chimica, resistenza agli<br />
agenti acidi, e<strong>la</strong>sticità, p<strong>la</strong>sticità, forza legante, ritiro del materiale,<br />
nonché <strong>la</strong> resistenza meccanica finale del<strong>la</strong> struttura risultante.<br />
Un secondo traguardo raggiunto dal<strong>la</strong> ricerca tecnologica<br />
ha consentito da ottimizzare i sistemi costruttivi esistenti, al fine di<br />
assicurare <strong>la</strong> qualità dei risultati. A questo fine sono state introdotte<br />
alcune innovazioni, in genere derivanti da processi di<br />
razionalizzazione delle tecniche tradizionali. In molti casi ciò è stato<br />
compiuto semplicemente utilizzando gli strumenti che vengono<br />
normalmente usati nei cantieri edilizi, per compiere<br />
meccanicamente delle operazione altrimenti eseguibili a mano con<br />
maggiore dispendio di forza <strong>la</strong>voro e minore precisione.<br />
Tra i procedimenti meccanici <strong>la</strong> compattazione, che consiste<br />
94<br />
Un caso di studio: le costruzioni in terra oggi<br />
sostanzialmente nell'applicazione di una pressione sull'impasto, é<br />
uno dei più efficaci. La compattazione sortisce effetti positivi sia per<br />
quanto riguarda <strong>la</strong> resistenza meccanica, grazie all'aumento del<strong>la</strong><br />
densità, e per <strong>la</strong> permeabilità all'acqua, che viene ridotta<br />
diminuendo le fessure nel materiale. L'aumento del<strong>la</strong> resistenza<br />
meccanica che viene ottenuto tramite <strong>la</strong> compattazione é re<strong>la</strong>tivo<br />
al<strong>la</strong> quantità di liquidi presenti nel terriccio utilizzato: se <strong>la</strong><br />
composizione é troppo secca o troppo umida, <strong>la</strong> compattazione<br />
potrebbe non avvenire correttamente.<br />
Le costruzioni in "terra compattata" (rammed earth) vengono<br />
Arizona: fasi del<strong>la</strong> realizzazione di un casa in “rammed earth construction”
Capitolo II-4<br />
realizzate tramite un processo di compattazione, che è stato<br />
ottimizzato grazie all'adozione di presse meccaniche. Il termine<br />
<strong>tradizionale</strong> francese - pisè - indica una tecnica costruttiva che<br />
richiedeva una notevole quantità di manodopera; i mezzi meccanici<br />
possono superare questa limitazione ed ottenere risultati<br />
control<strong>la</strong>bili.<br />
Inoltre, poiché le costruzioni in terra compattata sono basate<br />
sull'uso di casseforme, alcune imprese hanno sviluppato delle<br />
forme altamente sofisticate e riutilizzabili, che vengono studiate per<br />
tenere in forma le pareti sino a quando non sia giunto a termine il<br />
periodo di essiccamento.<br />
Oltre al<strong>la</strong> compattazione, <strong>la</strong> materia prima può essere<br />
<strong>la</strong>vorata in blocchi, tramite l'uso di presse manuali o meccaniche.<br />
Questi blocchi vengono poi utilizzati per formare le pareti, con una<br />
malta per legante. L'incremento di resistenza meccanica viene<br />
ottenuto durante il processo di compattazione che ha luogo prima<br />
del<strong>la</strong> posa in opera. Le pareti non portanti possono essere<br />
realizzate senza compattazione, ad esempio con i wickels, forme<br />
cilindriche di argil<strong>la</strong> stabilizzate con paglia, oppure co<strong>la</strong>ndo un<br />
composto liquido in una cassaforma sottile.<br />
Le possibili composizioni chimiche dei terreni sono state<br />
studiate ampiamente, consentendo così di identificare soluzioni<br />
95<br />
Un caso di studio: le costruzioni in terra oggi<br />
per <strong>la</strong> stabilizzazione ed il miglioramento delle prestazioni. Se<br />
tradizionalmente <strong>la</strong> stabilizzazione veniva eseguita utilizzando<br />
paglia o altre fibre vegetali, oggi possono essere utilizzati diversi<br />
tipi di additivi chimici, quali ad esempio il comune cemento<br />
port<strong>la</strong>nd, il bitume, <strong>la</strong> calce ecc., tutte sostanze mirate a migliorare<br />
<strong>la</strong> resistenza meccanica finale delle strutture portanti2. Altri additivi,<br />
che vengono mesco<strong>la</strong>ti all'intonaco di finitura, sono utilizzati per<br />
migliorare <strong>la</strong> resistenza alle infiltrazioni dell'acqua e dell'umidità.<br />
Il problema fondamentale delle costruzioni in terra è,<br />
naturalmente, legato alle infiltrazioni liquide, poiché le pareti non<br />
sono generalmente impermeabili. Come si è visto, tale<br />
inconveniente può essere in parte mitigato; tramite gli additivi è<br />
risultato però anche necessario sviluppare una serie di dettagli<br />
costruttivi specifici, volti a impedire il più possibile l'ingresso<br />
dell'acqua nelle fughe, come sempre i punti più sensibili del<strong>la</strong><br />
struttura.<br />
Gernot Minke ha presentato, nel suo Earth Construction<br />
Handbook3, una serie di dettagli costruttivi sviluppati<br />
appositamente per questo tipo di costruzioni. La realizzazione del<br />
plinto, ad esempio, è di fondamentale importanza, poiché è proprio<br />
in quel punto che viene separata <strong>la</strong> massa di terra dal terreno<br />
umido. Il giunto tra <strong>la</strong> base in calcestruzzo o in pietra e <strong>la</strong> struttura<br />
in terra deve essere protetto da ogni infiltrazione, poiché ogni
Capitolo II-4<br />
Dettali costruttivi e giunti per <strong>la</strong> costruzione in terra, da Houben<br />
96<br />
Un caso di studio: le costruzioni in terra oggi
Capitolo II-4<br />
aggiustamento in quel<strong>la</strong> zona potrebbe comportare serie<br />
conseguenze al<strong>la</strong> stabilità dell'intera costruzione.<br />
La lista delle innovazioni che sono state sviluppate potrebbe<br />
continuare; ma ciò che è stato sinora illustrato dovrebbe bastare a<br />
dimostrare che le tecniche costruttive tradizionali possiedono<br />
realmente il potenziale per essere adattate all'edilizia<br />
contemporanea.<br />
III. Un "costruttore in terra" di oggi: Rick Joy<br />
Come si è visto, l'adattabilità delle costruzioni in terra non è<br />
so<strong>la</strong>mente una questione teorica, ma è stata anche ampiamente<br />
sperimentata. È purtuttavia chiaro che l'uso di questa tecnica<br />
fornisce i migliori risultati so<strong>la</strong>mente nelle condizioni climatiche più<br />
adatte, ovvero nelle regioni calde ed aride. È per questa ragione<br />
che vi sono pochi esempi europei di costruzioni in terra<br />
contemporanee, mentre ve ne sono moltissimi nel<strong>la</strong> zona sudoccidentale<br />
degli Stati Uniti ed in Australia.<br />
Ciò che risalta maggiormente delle costruzioni in terra<br />
contemporanee è il fatto che, nonostante queste facciano<br />
fortemente riferimento alle potenzialità figurative del<strong>la</strong> tecnica<br />
specifica, hanno e<strong>la</strong>borato una nuova estetica di matrice<br />
chiaramente moderna, senza cedere alle nostalgie vernaco<strong>la</strong>ri. La<br />
97<br />
Un caso di studio: le costruzioni in terra oggi<br />
Rick Joy, Catalina House, Arizona, 1997<br />
composizione mostra grande originalità, così come l'esecuzione<br />
tecnica e lo studio del dettaglio architettonico, il tutto perfettamente<br />
adattato al carattere dell'ambiente.<br />
Le case progettate da Rick Joy sono tra gli esempi più<br />
interessanti. Avendo studiato in Arizona, Joy è chiaramente<br />
influenzato dall' "estetica del deserto", <strong>la</strong> stessa che diede forma<br />
al<strong>la</strong> Taliesin West di Wright. La terra compattata assume forme<br />
moderne, perde qualsiasi ornamento, ed il disegno è ridotto a linee<br />
pure. La tessitura delle pareti in terra reagisce all'azione del<strong>la</strong> luce<br />
del deserto in maniera sorprendente, creando dei giochi vibratili di
Capitolo II-4<br />
luce ed ombra; si tratta dello stesso fenomeno osservato da Sverre<br />
Fehn nel<strong>la</strong> case primitive del deserto marocchino.<br />
Il riduzionismo formale adottato da Joy ha motivazioni<br />
anche di carattere tecnologico, poiché <strong>la</strong> trasformazione di ogni<br />
artico<strong>la</strong>zione in giunti sottili rende più ardua l'infiltrazione<br />
dell'acqua. Le rare precipitazioni dell'Arizona non costituiscono un<br />
serio rischio per <strong>la</strong> stabilità delle pareti, che vengono "cotte" al sole<br />
sino a raggiungere un altissimo grado di resistenza.<br />
Le re<strong>la</strong>zioni dimensionali tra le pareti opache e le finestre<br />
testimonia l'autenticità del metodo costruttivo utilizzato, poiché è<br />
possibile ottenere luci ampie so<strong>la</strong>mente tramite espedienti tecnici<br />
Rick Joy, Catalina House, Arizona, 1997. Sezione trasversale e vista dell’interno<br />
98<br />
Un caso di studio: le costruzioni in terra oggi<br />
di una certa complessità. Tale carattere ricorda inoltre <strong>la</strong> penombra<br />
tipica del<strong>la</strong> case del deserto in altre regioni: in climi come questo,<br />
è di fondamentale importanza il tenere lontana dall'interno del<strong>la</strong><br />
casa <strong>la</strong> fortissima luce del giorno.<br />
Questi edifici sono una prova materiale del<strong>la</strong> fattibilità<br />
dell'uso delle tecniche costruttive tradizionali nel contesto<br />
contemporaneo: non solo una fattibilità tecnologica, ma anche <strong>la</strong><br />
possibilità di reinterpretare queste tecniche in chiave moderna,<br />
evitando un regressivo "ritorno al<strong>la</strong> natura".
Una pressa manuale per <strong>la</strong> produzione di blocchi in<br />
terra cruda (da Ahmed)<br />
Capitolo II-4<br />
IV. Costruzioni in terra<br />
contemporanee nei paesi in<br />
via di sviluppo<br />
Nelle economie emergenti, le<br />
costruzioni in terra possono<br />
risultare enormemente efficaci,<br />
soprattutto grazie al<strong>la</strong> loro<br />
flessibilità ed al basso consumo<br />
di risorse. Si tratta delle uniche<br />
tecniche costruttive che<br />
consentono l'accesso a<br />
processi di autocostruzione a<br />
comunità con scarse o nessuna<br />
risorsa finanziaria.<br />
Uno dei maggiori punti di interesse riguarda <strong>la</strong> disponibilità<br />
di materiali per produrre gli orizzontamenti degli edifici. Poiché il<br />
legno, che viene spesso usato a questo scopo, è eccessivamente<br />
costoso o non disponibile, sono stati compiuti molti sforzi per<br />
sviluppare sistemi voltati efficienti e di semplice realizzazione.<br />
Ogni regione geografica nel<strong>la</strong> quale <strong>la</strong> scarsità di legno è da<br />
sempre stata un fattore limitante ha sviluppato un proprio tipo di<br />
volta: tra le più comuni le volte egiziane, afgane o persiane. La<br />
99<br />
Un caso di studio: le costruzioni in terra oggi<br />
ricerca tecnologica ha consentito di ottimizzare queste tipologie<br />
tradizionali, in modo facilitarne <strong>la</strong> posa in opera tramite semplici<br />
guide mobili. Le volte possono essere realizzate su grandi luci<br />
senza utilizzare complesse impalcature ed in brevi periodi di<br />
tempo.<br />
È pertanto possibile, applicando <strong>la</strong> ricerca tecnologica di<br />
base alle tecniche costruttive tradizionali, realizzare edifici che<br />
svolgano funzioni non esclusivamente residenziali. In alcuni<br />
vil<strong>la</strong>ggi del Pakistan settentrionale, ad esempio, gli insediamenti<br />
dei rifugiati afgani, composti principalmente di case in terra, sono<br />
Costruzioni in terra in Pakistan: casseforme in legno e “compasso” per <strong>la</strong> realizzazione di una volta
Plinti di fondazione e tipologie di volte, da Houben<br />
Capitolo II-4<br />
100<br />
stati integrati da uno spazio<br />
voltato più ampio, che serve<br />
per tutte le funzioni del<br />
vil<strong>la</strong>ggio, dal <strong>la</strong>voro comunitario<br />
alle assemblee o per le<br />
celebrazioni.<br />
Per il futuro di molte<br />
regioni del mondo che stanno<br />
tentando di liberarsi<br />
dall'oppressione del<strong>la</strong> povertà,<br />
le costruzioni in terra possono<br />
pertanto essere un modo di<br />
migliorare le condizioni di vita<br />
Intonacatura stagionale di una casa in terra, Mali<br />
senza sacrificare le poche risorse economiche, proteggendo allo<br />
stesso tempo l'ambiente naturale, una delle ricchezze più preziose.<br />
Note<br />
Un caso di studio: le costruzioni in terra oggi<br />
1 Vedi G. Minke, Earth Construction Handbook. Southampton: WIT Press, 2000,<br />
p. 21 e seguenti.<br />
2 Vedi Ahmed, K.I. Up to the Waist in Mud. Dhaka: University Press, 1994.<br />
3 Vedi G. Minke, Earth Construction Handbook, p. 120 e seguenti.