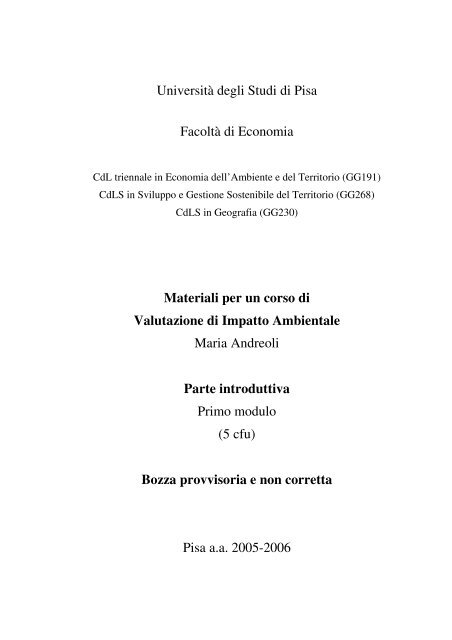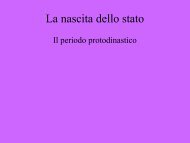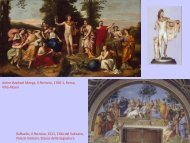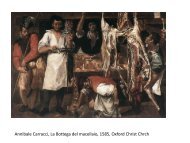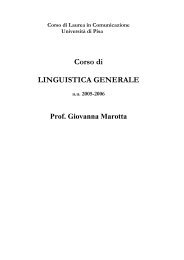Materiali per un corso di Valutazione di Impatto Ambientale - Omero ...
Materiali per un corso di Valutazione di Impatto Ambientale - Omero ...
Materiali per un corso di Valutazione di Impatto Ambientale - Omero ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Pisa<br />
Facoltà <strong>di</strong> Economia<br />
CdL triennale in Economia dell’Ambiente e del Territorio (GG191)<br />
CdLS in Sviluppo e Gestione Sostenibile del Territorio (GG268)<br />
CdLS in Geografia (GG230)<br />
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong><br />
Maria Andreoli<br />
Parte introduttiva<br />
Primo modulo<br />
(5 cfu)<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
Pisa a.a. 2005-2006
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
Premessa<br />
Questa <strong>di</strong>spensa, che raccoglie il materiale <strong>per</strong> lo stu<strong>di</strong>o del primo modulo<br />
dell’insegnamento <strong>di</strong> VIA, è nato dall’esigenza <strong>di</strong> ri<strong>un</strong>ire in <strong>un</strong> solo supporto <strong>di</strong>dattico<br />
materiale proveniente da fonti <strong>di</strong>verse, spesso costituite (come il testo del Malcevschi o<br />
<strong>di</strong> alc<strong>un</strong>i dei testi e<strong>di</strong>ti dal Sole 24 ore) che sono esauriti presso l’e<strong>di</strong>tore.<br />
In altre parole, non avendo trovato <strong>un</strong> testo in grado <strong>di</strong> fornire <strong>un</strong> supporto <strong>per</strong> tutti<br />
gli argomenti trattati all’interno del modulo, seguendo l’impostazione voluta, ritenendo<br />
<strong>di</strong>s<strong>per</strong>sivo stu<strong>di</strong>are su <strong>un</strong>a molteplicità <strong>di</strong> fonti <strong>di</strong>verse, spesso <strong>di</strong>fficili da integrare,<br />
abbiamo cercato, con <strong>un</strong>’ o<strong>per</strong>a che è prevalentemente <strong>di</strong> “taglia e cuci” ricostruisse in<br />
<strong>un</strong> insieme relativamente coor<strong>di</strong>nato i <strong>di</strong>versi argomenti.<br />
Da questo p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista, quin<strong>di</strong>, questo supporto non ha la pretesa <strong>di</strong> costituire<br />
qualcosa <strong>di</strong> nuovo o <strong>di</strong> migliore del materiale già presente “sul mercato” in campo <strong>di</strong><br />
valutazione <strong>di</strong> impatto ambientale, ma soltanto <strong>di</strong> riassemblare materiale già esistente in<br />
<strong>un</strong>a forma ed organizzazione che fosse adeguata al tipo <strong>di</strong> studente che si trova ad<br />
affrontare tale problematica.<br />
Della bontà <strong>di</strong> tale o<strong>per</strong>azione, sono gli utenti a dover giu<strong>di</strong>care … anche se<br />
probabilmente il materiale si avvantaggerebbe <strong>di</strong> <strong>un</strong>a rielaborazione che – staccandosi<br />
<strong>un</strong> po’ <strong>di</strong> più dalle fonti originarie – aumentasse la coerenza del filo conduttore che<br />
viene sviluppato attraverso queste pagine.<br />
Scopo <strong>di</strong> questo primo modulo è soprattutto fornire <strong>un</strong>a consapevolezza delle<br />
problematiche in campo economico ambientale – anche attraverso <strong>un</strong>a ricostruzione<br />
storica <strong>di</strong> come sono state affrontate, ricostruzione che in parte verrà ripresa anche nel<br />
secondo modulo – ed <strong>un</strong> approccio metodologico che consenta <strong>di</strong> avvicinarsi in maniera<br />
anche critica ai <strong>di</strong>versi strumenti normativi, tra cui anche la legislazione in campo <strong>di</strong><br />
VIA, che hanno cercato <strong>di</strong> affrontarle.<br />
Nel secondo modulo, viceversa, si cercherà <strong>di</strong> dare <strong>un</strong> maggiore spazio e strumenti e<br />
procedure <strong>per</strong> la <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong>, anche in relazione a quelli che<br />
sono gli in<strong>di</strong>rizzi ed i vincoli determinati dai <strong>di</strong>versi strumenti normativi in materia.<br />
Resta, alla base, la convinzione che non esistano regole assolute che p<strong>un</strong>tualmente<br />
seguite possano portare ad <strong>un</strong>a soluzione, ma che ogni problema vada affrontato con<br />
rigore e onestà, alla ricerca <strong>di</strong> <strong>un</strong>a soluzione che possa essere considerata, in <strong>un</strong><br />
processo democratico e partecipato, la più sod<strong>di</strong>sfacente <strong>per</strong> la collettività in complesso.<br />
Pag. 2 <strong>di</strong> 148<br />
2
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
1. Nascita della <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> ed altri strumenti utilizzati <strong>per</strong><br />
l’analisi delle decisioni pubbliche con risvolti in campo economico e ambientale<br />
Le caratteristiche e finalità della <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> possono essere<br />
meglio comprese se si va ad analizzare la Storia, motivazioni e finalità della<br />
<strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> 1 , partendo dal concetto che essa è strettamente<br />
legata al problema delle scelte in ambito pubblico.<br />
Gli studenti <strong>di</strong> <strong>un</strong>a facoltà <strong>di</strong> economia sono in genere a conoscenza dei meccanismi<br />
che portano l’impren<strong>di</strong>tore privato a prendere delle decisioni. Nella teoria micro-<br />
economica, senza scendere in modelli teorici più o meno complessi, il “criterio guida”<br />
utilizzato dall’impren<strong>di</strong>tore nel fare le sue scelte può essere in<strong>di</strong>viduato nella<br />
massimizzazione del profitto, cioè della <strong>di</strong>fferenza tra Ricavi totali e Costi totali.<br />
Se il mercato non avesse im<strong>per</strong>fezioni e fallimenti questo tipo <strong>di</strong> comportamento<br />
porterebbe anche al risultato migliore <strong>per</strong> la società nel suo complesso (cfr. la teoria<br />
della mano invisibile <strong>di</strong> Adam Smith, 1776) in quanto l’impren<strong>di</strong>tore, nel <strong>per</strong>seguire la<br />
sua convenienza <strong>per</strong>sonale, assicurerebbe anche alla società nel suo complesso la<br />
massima efficienza nell’utilizzo delle risorse.<br />
Si potrebbe pensare che il decisore pubblico potrebbe utilizzare <strong>un</strong> approccio<br />
assolutamente analogo, andando a massimizzare non la <strong>di</strong>fferenza tra ricavi e costi<br />
privati, ma la <strong>di</strong>fferenza tra benefici e costi <strong>di</strong> tutta la collettività. Infatti «... l’organismo<br />
pubblico dovrebbe eseguire, ogni qual volta si appresta ad effettuare <strong>un</strong> investimento <strong>di</strong><br />
particolare rilevanza economica e territoriale, quegli stu<strong>di</strong> e quelle rilevazioni che<br />
consentono <strong>di</strong> stabilire se quel determinato investimento è valido da <strong>un</strong> p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista<br />
economico e sociale, ossia se i benefici che si ottengono dalla sua esecuzione sono<br />
su<strong>per</strong>iori ai costi (<strong>di</strong> esecuzione, <strong>di</strong> esercizio, <strong>di</strong> smantellamento e <strong>di</strong> tutela ambientale)<br />
che occorre sostenere.» 2<br />
Di conseguenza, «in <strong>un</strong>a visione “ottimistica” della realtà, che potesse cioè<br />
prescindere da interessi particolari <strong>di</strong> politici e burocrati, il criterio <strong>per</strong> decidere se<br />
intraprendere <strong>un</strong>’azione pubblica starebbe nel valutare se i benefici sociali derivanti da<br />
tale azione siano almeno pari ai costi sociali determinati dall’azione stessa.» 3 In questo<br />
1 E. Gerelli, E. Laniado (1987), Storia, motivazioni e finalità della valutazione <strong>di</strong> impatto ambientale,<br />
Terra, n. 2, pp. 4-7<br />
2 Bazzani G.M., Malagoli C., Ragazzoni A. (1993) <strong>Valutazione</strong> delle risorse ambientali: inquadramento e<br />
metodologie <strong>di</strong> VIA, Ed agricole, Bologna, p. 58<br />
3 Gerelli e Laniado (1987), op. cit.<br />
Pag. 3 <strong>di</strong> 148<br />
3
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
caso, la precisazione che stiamo lavorando in <strong>un</strong>a visione “ottimistica” della realtà<br />
deriva dal fatto che i comportamenti del politico possono non essere “ottimali” dal<br />
p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista della collettività nel suo complesso in quanto influenzati, ad esempio, da<br />
tangenti più o meno sostanziose o, molto più semplicemente, da pressioni esercitate da<br />
gruppi più o meno influenti. Di conseguenza, si possono avere decisioni in cui esiste<br />
<strong>un</strong>a componente “soggettiva” <strong>di</strong> interesse da parte del politico, componente che può<br />
andare ad integrare o, al limite, sostituire la componente oggettiva <strong>di</strong> ricerca del bene<br />
pubblico, che dovrebbe essere in qualche misura “in<strong>di</strong>pendente” dal contesto economico<br />
e sociale in cui si o<strong>per</strong>a. Ad esempio, in alc<strong>un</strong>i casi, <strong>un</strong>’area può avere problemi<br />
occupazionali così gran<strong>di</strong> da premere <strong>per</strong> il mantenimento <strong>di</strong> produzioni relativamente<br />
inquinanti, anche se a livello <strong>di</strong> collettività nel suo complesso, tale decisione può essere<br />
connotata da costi sociali maggiori dei benefici sociali: <strong>per</strong> il politico locale, com<strong>un</strong>que,<br />
sarà molto <strong>di</strong>fficile <strong>di</strong>sconoscere le esigenze specifiche del suo elettorato (e, ad<br />
esempio, far chiudere <strong>un</strong> impianto che si rivela dannoso <strong>per</strong> l’ambiente quando esso<br />
impiega manodo<strong>per</strong>a in <strong>un</strong>’area ad elevato livello <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione).<br />
Com<strong>un</strong>que, anche se si ipotizza <strong>di</strong> lavorare in <strong>un</strong> contesto “ideale” rispetto al<br />
comportamento del politico, «il problema sarebbe semplice se questi costi e benefici<br />
fossero misurabili, ma sappiamo che, anche nella migliore delle ipotesi, così non è.<br />
La necessità dell’intervento pubblico è infatti determinata, anche in <strong>un</strong>a situazione<br />
ideale caratterizzata da previsioni certe e da concorrenza <strong>per</strong>fetta, da quello che gli<br />
economisti denominano “fallimento del mercato” (propriamente, parziale fallimento<br />
del mercato), in quanto il mercato stesso non è in grado <strong>di</strong> attribuire prezzi, e quin<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
razionare, tal<strong>un</strong>e risorse, come l’aria e l’acqua, e certi beni, quali le bellezze naturali<br />
ed artistiche.» 4 Tale fenomeno ha cause <strong>di</strong>verse, che derivano dalla mancanza <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti<br />
<strong>di</strong> proprietà su certi beni (si conosce il proprietario <strong>di</strong> <strong>un</strong>a casa o <strong>di</strong> <strong>un</strong> terreno, ma chi è<br />
il proprietario dell'aria o dell'acqua?), dal fatto che in alc<strong>un</strong>i casi l’utilizzo da parte <strong>di</strong> <strong>un</strong><br />
soggetto non pregiu<strong>di</strong>ca l’utilizzo da parte <strong>di</strong> altri (beni “non rivali”, come il paesaggio,<br />
che non viene “consumato” da chi lo guarda), ecc. Quin<strong>di</strong>, anche ammettendo che chi<br />
inquina o rovina delle risorse debba pagarle (principio del “chi inquina paga”, e<br />
tentativo <strong>di</strong> “riportare all’interno” i costi esterni), non sempre si riesce ad in<strong>di</strong>viduare <strong>di</strong><br />
preciso a chi i “danni” relativi agli effetti esterni dovrebbero essere pagati e, in assenza<br />
4 Gerelli e Laniado (1987), op. cit.<br />
Pag. 4 <strong>di</strong> 148<br />
4
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
<strong>di</strong> <strong>un</strong> mercato, a quale “prezzo”. Il problema sembrò, allora, quello <strong>di</strong> trovare <strong>un</strong><br />
meccanismo <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> questi prezzi in grado <strong>di</strong> sostituire il mercato.<br />
«Per rendere l’intervento pubblico razionale e compatibile con la logica del<br />
mercato, a partire dagli anni trenta il Congresso degli Stati Uniti richiese che le<br />
decisioni pubbliche in tal<strong>un</strong>i settori (specialmente investimenti idrici) venissero prese<br />
sulla base dei costi e dei benefici sociali (“to whomsoever they may accrue”). Nasceva<br />
in pratica l’analisi costi benefici che, <strong>per</strong> rime<strong>di</strong>are al fallimento del mercato, ne<br />
simulava il f<strong>un</strong>zionamento stimando a tavolino, col medesimo metro monetario dei<br />
prezzi, le grandezze che il mercato stesso non misura automaticamente. Ad esempio, il<br />
beneficio <strong>di</strong> <strong>un</strong>a <strong>di</strong>ga che si progetta <strong>di</strong> costruire <strong>per</strong> irrigazione può essere stimato<br />
in<strong>di</strong>rettamente sulla base dell’aumento <strong>di</strong> produzione agricola dovuto alla maggior<br />
<strong>di</strong>sponibilità idrica.» 5 In questo caso il beneficio legato all’utilizzo della <strong>di</strong>ga rimaneva<br />
essenzialmente <strong>di</strong> natura economica (il maggior red<strong>di</strong>to conseguibile dagli agricoltori<br />
avendo a <strong>di</strong>sposizione l’acqua rispetto alla situazione <strong>di</strong> colture non irrigue) <strong>per</strong> cui<br />
sembrava relativamente facile utilizzare <strong>un</strong> metodo monetario <strong>per</strong> valutare la<br />
convenienza a fare questo investimento non dal p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista del singolo, ma<br />
dall’intera collettività, semplicemente in<strong>di</strong>viduando i costi e benefici complessivi.<br />
«Senonché, dopo il fallimento del mercato cui si poneva riparo con l’analisi costi<br />
benefici, si prospettò ben presto <strong>un</strong> secondo (parziale) fallimento, riguardante proprio<br />
questa analisi. Ci si avvide infatti che non tutti gli effetti d’<strong>un</strong>a decisione pubblica (e ci<br />
riferiamo qui <strong>per</strong> semplicità alla decisione d’investimento) potevano essere valutati,<br />
anche se in modo in<strong>di</strong>retto, col metro monetario. E ciò <strong>per</strong> il riconoscimento che certe<br />
grandezze sono “incommensurabili”, e che quin<strong>di</strong>, accanto alle valutazioni monetarie<br />
(che sfociano in <strong>un</strong> in<strong>di</strong>catore <strong>un</strong>ico quale il rapporto o la <strong>di</strong>fferenza tra costi e<br />
benefici) occorreva fornire al decisore <strong>un</strong>o o più separati documenti descrittivi <strong>di</strong> effetti<br />
specifici: la riduzione o la scomparsa <strong>di</strong> specie animali, l’aumento del rumore e dei<br />
connessi <strong>di</strong>sturbi, le mo<strong>di</strong>fiche del paesaggio, e così via.» 6 Questo tipo <strong>di</strong> effetti si può<br />
ben avere anche con <strong>un</strong> intervento quale la realizzazione <strong>di</strong> <strong>un</strong>a <strong>di</strong>ga, se si pensa al<br />
rumore soprattutto in fase <strong>di</strong> cantiere, alla mo<strong>di</strong>fica <strong>di</strong> habitat limitrofi alla <strong>di</strong>ga ed alla<br />
“scomparsa” <strong>di</strong> specie ed ecosistemi nelle zone che vengono sommerse, al rischio <strong>per</strong> la<br />
vita umana che può derivare da eventuali incidenti (si pensi alla catastrofe del Vajont).<br />
Anche rimanendo nel campo esclusivamente economico, come vedremo in seguito, si<br />
5 Gerelli e Laniado (1987), op. cit.<br />
6 Gerelli e Laniado (1987), op. cit.<br />
Pag. 5 <strong>di</strong> 148<br />
5
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
possono avere dei fenomeni <strong>di</strong>fficilmente valutabili in quanto la <strong>di</strong>ga, <strong>un</strong>itamente ad <strong>un</strong><br />
innalzamento del red<strong>di</strong>to producibile dall’agricoltura in conseguenza della sua<br />
realizzazione, può anche determinare <strong>un</strong>a <strong>di</strong>versa <strong>di</strong>stribuzione del red<strong>di</strong>to tra <strong>di</strong>verse<br />
aree o gruppi sociali: ad esempio in genere l’effetto maggiore in termini <strong>di</strong> incremento<br />
<strong>di</strong> red<strong>di</strong>to si ha introducendo l’irrigazione in aree <strong>di</strong> pianura fertili, ma questo avrebbe<br />
come conseguenza <strong>un</strong>a <strong>per</strong><strong>di</strong>ta <strong>di</strong> competitività relativa da parte degli agricoltori delle<br />
aree collinari e montane, che verrebbero quin<strong>di</strong> ad essere danneggiati da tale scelta. In<br />
altre parole, ci troveremmo ad aumentare la ricchezza della società in <strong>un</strong>a sorta <strong>di</strong><br />
approccio “anti-Robin Hood”, in cui si toglie al povero <strong>per</strong> dare al ricco. E’ chiaro come<br />
<strong>un</strong> tale tipo <strong>di</strong> comportamento può dare luogo a tensioni sociali <strong>di</strong> notevole entità.<br />
«Veniva così esplicitata l’impossibilità anche tecnica – a tacere <strong>di</strong> altre<br />
considerazioni – <strong>di</strong> <strong>un</strong>a soluzione “tecnocratica” <strong>per</strong> la decisione d’investimento, ossia<br />
<strong>di</strong> <strong>un</strong>a decisione fondata su <strong>di</strong> <strong>un</strong> <strong>un</strong>ivoco risultato dell’analisi costi benefici. Infatti,<br />
oltre a tale risultato, occorre tener conto degli altri elementi accennati (incom-<br />
mensurabili) presentati in modo non omogeneo, in quanto non valutatati in moneta,<br />
sicché spetta in definitiva al politico esprimere <strong>un</strong>a decisione sintetico-intuitiva, che<br />
tenga conto dei <strong>di</strong>versi elementi presentatigli: red<strong>di</strong>tività economico-sociale misurata<br />
dall’analisi costi benefici, effetti non monetizzabili sull’ambiente, sulla salute umana,<br />
sui valori estetici, ecc.» 7<br />
In altre parole, nell’ipotesi <strong>di</strong> poter risolvere tutto in sede strettamente economica,<br />
monetizzando con sicurezza tutti i costi e benefici sociali, il ruolo preponderante<br />
sarebbe stato giocato dai tecnici, incaricati delle monetizzazioni dei vari effetti, ed al<br />
politico non sarebbe rimasto molto da fare in quanto, in assenza <strong>di</strong> altre considerazioni,<br />
l’<strong>un</strong>ica soluzione razionale sarebbe stata quella <strong>di</strong> scegliere l’alternativa con la<br />
maggiore <strong>di</strong>fferenza (od il più elevato rapporto) tra benefici e costi sociali. In presenza<br />
<strong>di</strong> valori non monetizzabili, non volendo lasciare al politico il <strong>di</strong>fficile compito <strong>di</strong><br />
effettuare <strong>un</strong>a decisione senza avere <strong>un</strong>a chiara consapevolezza delle conseguenze delle<br />
<strong>di</strong>verse alternative, sorge il problema <strong>di</strong> fornirgli <strong>un</strong> aiuto ad effettuare la scelta<br />
migliore, che rappresenti <strong>un</strong> supporto alla sua decisione senza, com<strong>un</strong>que, pretendere <strong>di</strong><br />
in<strong>di</strong>care la soluzione ottima tra quelle possibili. Vedremo in seguito come, a parte che<br />
<strong>per</strong> la VIA, in molte decisioni <strong>di</strong> natura “pubblica” ci sia <strong>un</strong>a componente <strong>di</strong> natura<br />
“tecnica” o “scientifica”, sulla quale, deve innestarsi <strong>un</strong>a decisione <strong>di</strong> natura “politica”.<br />
7 Gerelli e Laniado (1987), op. cit.<br />
Pag. 6 <strong>di</strong> 148<br />
6
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
«Tornando com<strong>un</strong>que alla cronaca della gestazione della VIA, possiamo <strong>di</strong>re che<br />
(…) lo Army Corps of Engineers americano (…) aveva inventato, in sostanza, la VIA,<br />
con l’apprestare anche voluminose relazioni descriventi, in termini fisici, gli effetti<br />
ambientali dell’investimento, a completamento dell’analisi costi benefici in termini<br />
monetari. Alla fine degli anni sessanta, con l’estendersi delle preoccupazioni<br />
ambientali, la situazione si è, almeno entro certi limiti, rovesciata. Anziché impostare<br />
l’analisi dei progetti <strong>di</strong> investimento partendo dagli elementi valutabili in<strong>di</strong>rettamente a<br />
prezzi <strong>di</strong> mercato, <strong>per</strong> poi aggi<strong>un</strong>gere analisi sugli “incommensurabili”» 8 «il grande<br />
interesse <strong>per</strong> le componenti ambientali – <strong>di</strong>fficilmente monetizzabili – consigliò <strong>di</strong><br />
intraprendere, in tal<strong>un</strong>i casi, la strada opposta. Si pensò cioè <strong>di</strong> analizzare anzitutto gli<br />
effetti ambientali, integrando ad essi, con <strong>un</strong>a documentazione in qualche misura<br />
subor<strong>di</strong>nata, le valutazioni propriamente economiche. Con il National Environmental<br />
Policy Act del 1969 era così nata – ancora <strong>un</strong>a volta negli Stati Uniti, sempre tesi a<br />
razionalizzare le decisioni – la valutazione <strong>di</strong> impatto ambientale (VIA)» 9<br />
Se si può <strong>di</strong>re che la VIA sia nata negli Stati Uniti alla fine degli anni sessanta con il<br />
NEPA (National Environmental Policy Act), <strong>per</strong> quanto riguarda la situazione della<br />
Com<strong>un</strong>ità Europea, la prima <strong>di</strong>rettiva a livello com<strong>un</strong>itario 10 in materia <strong>di</strong> impatto<br />
ambientale è nata molto più tar<strong>di</strong> (nel 1985, cioè <strong>di</strong> circa 15 anni dopo il NEPA) da <strong>un</strong>a<br />
duplice esigenza:<br />
• da <strong>un</strong>a parte quella della salvaguar<strong>di</strong>a ambientale, avendo ormai chiara<br />
consapevolezza che il migliore approccio a tale problematica è quello <strong>di</strong> tipo<br />
preventivo (prevenire l’inquinamento) piuttosto che curativo (cercare <strong>di</strong><br />
8 In particolare ci si riferisce ai costi o benefici intangibili o incommensurabili, <strong>per</strong> i quali esistono<br />
particolari <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> monetizzazione. “In particolare, con il termine <strong>di</strong> intangibili sono intesi quei<br />
costi o quei benefici <strong>per</strong> i quali è impossibile stabilire <strong>un</strong>a reale influenza del progetto sull’ambiente<br />
esterno o sul sistema economico esterno (l’aria, l’acqua, l’inquinamento del mare, ecc.) Con il termine<br />
<strong>di</strong> incommensurabili vengono, invece, intesi quei costi e quei benefici <strong>per</strong> i quali è impossibile, al<br />
momento attuale, definire <strong>un</strong> accettabile valore che consenta <strong>di</strong> paragonarli e <strong>di</strong> confrontarli con gli altri<br />
(la salute umana, la vita umana, ecc.).” Bazzani, Malagoli e Ragazzoni, op. cit. p. 59<br />
9 Gerelli e Laniado, op. cit.<br />
10 In realtà, come afferma Schmidt <strong>di</strong> Friedberg, «in Europa la valutazione <strong>di</strong> impatto gi<strong>un</strong>se assai<br />
rapidamente: alla fine degli anni 70 era presente in forma propria in Danimarca, Francia, Germania<br />
Federale, Svezia e, in forma più o meno semplificata, nel Regno Unito, in Olanda, Spagna, Belgio,<br />
Austria ecc. ». Solo che, <strong>per</strong> i gran<strong>di</strong> interessi coinvolti, anche a livello economico, soltanto alc<strong>un</strong>i anni<br />
dopo e «con molta fatica e molti compromessi» è nata la <strong>di</strong>rettiva 377/85, tra l’altro vista da molti come<br />
<strong>un</strong>a “soluzione <strong>di</strong> minimo” rispetto alle proposte iniziali che erano state fatte. Cfr. P. Schmidt <strong>di</strong><br />
Friedberg, S. Malcevschi, Guida pratica agli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> impatto ambientale, Il Sole24ore, 1998, p. 5<br />
Pag. 7 <strong>di</strong> 148<br />
7
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
rime<strong>di</strong>are a problemi ambientali già manifestatisi) 11 . Inoltre, <strong>per</strong> l’esistenza <strong>di</strong><br />
possibili impatti transfrontalieri (impatti derivanti da attività o decisioni<br />
realizzate non nello Stato in cui creano danni, ma in Stati più o meno limitrofi),<br />
era chiaro che tale problema andasse affrontato a scala più ampia 12 ;<br />
• dall’altro quello <strong>di</strong> non <strong>di</strong>storcere la concorrenza a livello economico: infatti,<br />
avendo il “rispetto dell’ambiente” dei costi più o meno sostenuti, le attività<br />
produttive tendevano a localizzarsi negli Stati con legislazioni più <strong>per</strong>missive,<br />
creando dei problemi a livello economico agli Stati più rigi<strong>di</strong> in materia<br />
ambientale (trasferimento delle attività produttive, con <strong>per</strong><strong>di</strong>ta <strong>di</strong> posti <strong>di</strong> lavoro,<br />
ecc.).<br />
L’applicazione della VIA, infatti, oltre ad avere risvolti ambientali, ha notevoli<br />
risvolti economici e proprio gli interessi ed i conflitti legati ad essi, oltre alla <strong>di</strong>versa<br />
situazione dei <strong>di</strong>versi Stati membri, ha fatto sì che inizialmente ci si limitasse ad <strong>un</strong>a<br />
soluzione <strong>di</strong> minimo, cioè l’imposizione della VIA solo <strong>per</strong> <strong>un</strong> ristretto elenco <strong>di</strong><br />
categorie <strong>di</strong> o<strong>per</strong>e (circa venti) e senza prevedere che il proponente (cioè chi vuole<br />
realizzare <strong>un</strong>’o<strong>per</strong>a, il quale può essere <strong>un</strong> soggetto pubblico o privato) presenti <strong>per</strong> la<br />
valutazione più alternative tra le quali scegliere. Cosa significa tutto ciò?<br />
Prendere in considerazione solo le o<strong>per</strong>e (ad esempio <strong>un</strong>a centrale) significa che<br />
esiste l’obbligo <strong>di</strong> valutazione <strong>di</strong> impatto ambientale <strong>per</strong> <strong>un</strong>a Centrale termoelettrica, ma<br />
non <strong>per</strong> il Piano energetico nazionale (cioè <strong>per</strong> lo strumento <strong>di</strong> programmazione<br />
economica con il quale si decidono le linee <strong>di</strong> sviluppo del settore energetico, compresi<br />
gli in<strong>di</strong>rizzi sulle tecnologie <strong>di</strong> produzione da preferire o promuovere), oppure <strong>per</strong> la<br />
realizzazione <strong>di</strong> <strong>un</strong>’autostrada, ma non <strong>per</strong> il piano nazionale dei trasporti.<br />
Prendere in considerazione solo le o<strong>per</strong>e significa anche prevedere l’obbligo <strong>di</strong> VIA<br />
<strong>per</strong> <strong>un</strong> impianto industriale, ma non <strong>per</strong> gli strumenti <strong>di</strong> pianificazione con i quali si<br />
11 Infatti, in molti casi, quando si manifestano effetti visibili sull’ambiente in conseguenza <strong>di</strong> fenomeni,<br />
quali quelli dell’inquinamento, si è già arrivati ad <strong>un</strong>a situazione così deteriorata che risulta<br />
estremamente <strong>di</strong>fficile intervenire “ex post”.<br />
12 E’ chiaro, soprattutto dopo l’incidente <strong>di</strong> Chernobyl, i cui effetti sono arrivati anche in Italia, come<br />
molti tipi <strong>di</strong> impatti negativi possano manifestarsi anche in Stati che sono relativamente <strong>di</strong>stanti da<br />
quelli dove si è originata la causa che li ha determinati. A livello internazionale, il problema degli<br />
impatti transfrontalieri è stato regolato con la Convenzione <strong>di</strong> Espoo, dal nome della città finlandese<br />
dove tale convenzione si è tenuta nel febbraio 1991, ratificata dall’Unione Europea nel 1996 ed entrata<br />
in vigore dal settembre del 1997. La convenzione è stata ratificata anche da Stati al <strong>di</strong> fuori dell’Unione<br />
Europea, quali la Svizzera e l’Armenia. Per maggiori informazioni, cfr. ad esempio, F. La Camera,<br />
1998, <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong>. Guida all’applicazione della normativa, Il Sole 24 ore –<br />
Pirola, pp. 55-60.<br />
Pag. 8 <strong>di</strong> 148<br />
8
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
definiscono le norme <strong>di</strong> governo <strong>di</strong> <strong>un</strong> territorio e le destinazione d’uso (inse<strong>di</strong>amenti<br />
industriali, inse<strong>di</strong>amenti civili, agricoltura, ecc.) da dare alle <strong>di</strong>verse parti dello stesso.<br />
In altre parole, si è cominciato con l’approccio forse più facile, ma sicuramente non<br />
il più razionale, in quanto “tagliava fuori” le problematiche legate alle decisioni<br />
strategiche, cioè quelle in materia <strong>di</strong> programmazione economica settoriale e<br />
pianificazione territoriale. Questo aspetto è stato in seguito recu<strong>per</strong>ato, in primo luogo<br />
all’interno <strong>di</strong> alc<strong>un</strong>e legislazioni regionali (cfr. la legge 5 del 1995 della Regione<br />
Toscana e successiva legge n.1 del 2005, entrambe relative alle Norme sul Governo del<br />
Terriotorio), in secondo luogo con la <strong>di</strong>rettiva 42/2001/CE relativa alla <strong>Valutazione</strong><br />
<strong>Ambientale</strong> Strategica (o valutazione ambientale delle decisioni strategiche) 13 .<br />
Negli Stati Uniti il campo <strong>di</strong> applicazione della VIA (cfr. NEPA), a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong><br />
quanto è avvenuto in Europa, è estremamente ampio: non <strong>per</strong> niente il NEPA prevede <strong>di</strong><br />
«adottare <strong>un</strong> approccio sistematico ed inter<strong>di</strong>sciplinare <strong>per</strong> assicurare l’uso integrato<br />
delle scienze sociali e naturali e della progettazione ambientale nella pianificazione e<br />
nei processi decisionali che possono avere <strong>un</strong> impatto sull’ambiente umano» 14 . In altre<br />
parole, l’obbligo <strong>di</strong> valutazione <strong>di</strong> impatto è esteso a qualsiasi tipo <strong>di</strong> attività che possa<br />
avere degli effetti in termini <strong>di</strong> benefici e costi sociali. Questa è stata <strong>un</strong>a <strong>di</strong>fferenza<br />
fondamentale, soprattutto fino a quando l’obbligo <strong>di</strong> valutazione ambientale non è stata<br />
estesa anche a livello com<strong>un</strong>itario alle “decisioni strategiche”, rispetto alla situazione<br />
dell’Unione Europea. Infatti, come nota Schmidt <strong>di</strong> Friedberg 15 «… l’archetipo<br />
stat<strong>un</strong>itense non considera liste <strong>di</strong> inclusione 16 come quelle europee: l’obbligo <strong>di</strong><br />
valutazione è valido <strong>per</strong> tutte le o<strong>per</strong>e, salvo specifiche esclusioni. Fatto che dà allo<br />
strumento USA <strong>un</strong>’incisività, in termini <strong>di</strong> gestione <strong>di</strong> sistema, irraggi<strong>un</strong>gibile dal suo<br />
omologo com<strong>un</strong>itario».<br />
13 In realtà, nel tempo, anche a livello nazionale le valutazioni ambientali erano state estese alla<br />
programmazione <strong>di</strong> alc<strong>un</strong>i settori, ad esempio quello energetico.<br />
14 F. La Camera (1998), <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong>. Guida all’applicazione della normativa. Il<br />
Sole24ore Pirola, p. 10<br />
15 Schmidt <strong>di</strong> Friedberg, 1998, op. cit., p. 5<br />
16 La normativa com<strong>un</strong>itaria lavora principalmente con “liste <strong>di</strong> inclusione”, cioè liste che elencano tutte<br />
le categorie <strong>di</strong> progetto che devono essere sottoposte obbligatoriamente a valutazione <strong>di</strong> impatto<br />
ambientale o <strong>per</strong> le quali tale necessità debba essere verificata; viceversa la normativa stat<strong>un</strong>itense<br />
lavora con “liste <strong>di</strong> esclusione”, cioè liste <strong>di</strong> categorie <strong>per</strong> le quali non è prevista né l’obbligatorietà <strong>di</strong><br />
sottoporle a VIA, né la necessità <strong>di</strong> verificare se tale proce<strong>di</strong>mento si renda necessario. Le liste <strong>di</strong><br />
esclusione vengono concordate dalle varie amministrazioni con il CEQ (Co<strong>un</strong>cil of Environmental<br />
Quality).<br />
Pag. 9 <strong>di</strong> 148<br />
9
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
Come già accennato in precedenza, i problemi decisionali relativi a problematiche<br />
economiche ed ambientali sono stati affrontati nel tempo con <strong>di</strong>verse tecniche <strong>di</strong><br />
supporto alle decisioni, anche a causa del mutamento <strong>di</strong> <strong>per</strong>cezione delle problematiche<br />
stesse, determinato dall’emergenza nel tempo <strong>di</strong> effetti negativi prodotti da alc<strong>un</strong>i tipi <strong>di</strong><br />
interventi, ed evidenziato nei seguenti schemi, dai quali appare come «le cose siamo<br />
evolute, passando dalla convergenza alla <strong>di</strong>vergenza degli interessi.<br />
Anni sessanta Anni novanta<br />
• Esiste <strong>un</strong>a convergenza <strong>di</strong> interessi<br />
sulla necessità dello sviluppo<br />
• La nozione <strong>di</strong> interesse pubblico è<br />
chiara e riconosciuta<br />
• Le analisi e valutazioni <strong>di</strong> progetti si<br />
fanno solo sulla base <strong>di</strong> criteri conto<br />
economici (costo/benefici)<br />
• L’opport<strong>un</strong>ità circa la realizzazione<br />
<strong>di</strong> <strong>un</strong> progetto non viene <strong>di</strong>scussa<br />
• Si sviluppano mega progetti con<br />
strutture decisionali piramidali<br />
• Le risorse <strong>di</strong>sponibili sono<br />
considerate infinite<br />
• Non esiste il processo partecipativo<br />
• I progetti pubblici vengono realizzati<br />
in generale senza opposizione e<br />
laddove esiste essa viene messa<br />
spesso a tacere<br />
• I gruppi <strong>di</strong> opinione non hanno<br />
possibilità <strong>di</strong> farsi sentire<br />
• Il professionista gode <strong>di</strong> molta fiducia<br />
• Siamo <strong>di</strong> fronte alle prime avvisaglie<br />
ambientaliste<br />
• Si è <strong>di</strong> fronte ad <strong>un</strong> pluralismo <strong>di</strong> idee, <strong>di</strong><br />
valori, <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> riferimento e <strong>di</strong> interessi<br />
• L’interesse pubblico non può essere definito in<br />
anticipo e in assenza <strong>di</strong> <strong>un</strong> processo<br />
partecipativo<br />
• I criteri <strong>di</strong> analisi e valutazione devono tener<br />
conto <strong>di</strong> fattori <strong>di</strong>versi e non quantificabili<br />
sotto il profilo finanziario<br />
• La giustificazione <strong>di</strong> <strong>un</strong> progetto è <strong>un</strong> elemento<br />
<strong>di</strong> base e deve tener conto dell’integrazione <strong>di</strong><br />
criteri <strong>di</strong> valutazione <strong>di</strong>versi<br />
• Si sviluppano progetti moduli con strutture<br />
decisionali orizzontali<br />
• La crisi delle risorse materiali e finanziarie è<br />
chiara, esiste la necessità del massimo<br />
ren<strong>di</strong>mento<br />
• Il processo partecipativo è <strong>un</strong> elemento<br />
essenziale dell’iter decisionale<br />
• I progetti pubblici sono costantemente oggetto<br />
<strong>di</strong> forti opposizioni, anche da parte <strong>di</strong> gruppi<br />
minoritari.<br />
• I gruppi minoritari hanno strumenti molto<br />
potenti (Internet) <strong>per</strong> l’organizzazione <strong>di</strong><br />
<strong>un</strong>’opposizione strutturata e sono <strong>di</strong> regola<br />
coinvolti nella procedura<br />
• Il lavoro del professionista è spesso molto<br />
criticato<br />
• I gruppi <strong>di</strong> protezione dell’ambiente sono<br />
organizzati e aumenta la presa <strong>di</strong> coscienza del<br />
problema ambientale<br />
Pag. 10 <strong>di</strong> 148<br />
10
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
A fronte <strong>di</strong> questi elementi l’accento deve essere messo sul processo piuttosto che<br />
sul prodotto, favorendo le procedure partecipative, i processi progettuali interattivi in<br />
cui la valutazione <strong>di</strong>venta motore <strong>per</strong> soluzioni più adatte.<br />
Si passa da <strong>un</strong> concetto <strong>di</strong> risanamento ambientale postumo a <strong>un</strong> intervento <strong>di</strong><br />
pre<strong>di</strong>zione e prevenzione ambientale.<br />
Anni sessanta Anni novanta<br />
• I progetti sono considerati non nocivi<br />
a meno che si <strong>di</strong>mostri il contrario<br />
(es. catastrofi ambientali)<br />
• Non esiste la nozione <strong>di</strong> impatto<br />
ambientale<br />
• Non esiste la nozione <strong>di</strong> impatto<br />
irreversibile, vista la fiducia illimitata<br />
nella scienza<br />
• Non esiste il concetto <strong>di</strong> mitigazione<br />
e compensazione<br />
• Ogni progetto è potenzialmente dannoso, deve<br />
essere <strong>di</strong>mostrata la sua compatibilità<br />
ambientale prima della sua realizzazione<br />
• La nozione <strong>di</strong> impatto è chiara e riconosciuta<br />
• La scienza ha <strong>di</strong>mostrato i suoi limiti, la<br />
nozione <strong>di</strong> impatto irreversibile è riconosciuta<br />
anche se poco applicata<br />
• Il concetto <strong>di</strong> mitigazione è chiaro e<br />
riconosciuto, quello <strong>di</strong> compensazione è chiaro<br />
ma non applicato<br />
Si fa strada la nozione <strong>di</strong> sviluppo sostenibile o<br />
sostenibilità, troppo spesso interpretata quale<br />
strumento <strong>per</strong> giustificare qualsiasi progetto<br />
In questo clima <strong>di</strong> cambiamenti anche le relazioni temporali si sono mo<strong>di</strong>ficate,<br />
lasciando più spazio all’incertezza e alla flessibilità.<br />
Anni sessanta Anni novanta<br />
• Il passato remoto ed il presente si<br />
conoscono bene: si può immaginare il<br />
futuro<br />
• Il futuro viene previsto come<br />
estrapolazione del trend evolutivo in<br />
<strong>corso</strong><br />
• Le ipotesi <strong>di</strong> sviluppo sono definite in<br />
modo certo<br />
• L’immagine a l<strong>un</strong>go termine è<br />
definita, il breve termine rappresenta<br />
<strong>un</strong>a prima tappa realizzativa<br />
• Come si può immaginare il futuro se si hanno<br />
<strong>di</strong>fficoltà a capire il presente?<br />
• Il presente è oggetto <strong>di</strong> continui e repentini<br />
mutamenti: l’incertezza <strong>di</strong>venta <strong>un</strong> parametro<br />
importante nell’immaginare il futuro<br />
• Si fa strada la nozione <strong>di</strong> flessibilità e la<br />
necessità <strong>di</strong> sa<strong>per</strong>si adattare velocemente a<br />
nuove situazioni<br />
• Vengono definite soluzioni a breve termine<br />
con <strong>un</strong>a valutazione delle conseguenze a me<strong>di</strong>o<br />
(l<strong>un</strong>go) termine<br />
Pag. 11 <strong>di</strong> 148<br />
11
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
In <strong>un</strong> clima <strong>di</strong> incertezza si tratta <strong>di</strong> capire come prendere decisioni significative,<br />
valide nel tempo e capaci <strong>di</strong> non aumentare il debito ambientale con scelte irreversibili<br />
che potrebbero penalizzare nuove opzioni <strong>di</strong> sviluppo, considerato che ness<strong>un</strong> fattore è<br />
acquisito come stabile.» 17<br />
Gli schemi <strong>di</strong> cui sopra possono essere forse più facilmente interpretati se si torna<br />
in<strong>di</strong>etro nel tempo agli anni sessanta.<br />
Erano quelli gli anni del boom economico, della volontà <strong>di</strong> rivalsa dopo i duri anni<br />
del secondo conflitto mon<strong>di</strong>ale, <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> progressi scientifici con la conseguente<br />
modernizzazione <strong>di</strong> agricoltura ed industria, della creazione delle gran<strong>di</strong> infrastrutture,<br />
dell’intenso processo <strong>di</strong> industrializzazione sostenuto dal crescere dei consumi e<br />
dall’espulsione <strong>di</strong> manodo<strong>per</strong>a eccedente dal settore agricolo. Delle nuove tecnologie si<br />
conoscevano quasi esclusivamente gli aspetti positivi e <strong>per</strong> questo c’era <strong>un</strong>a quasi<br />
illimitata fiducia sia nei poteri della scienza (attraverso il progresso tecnico) che nei<br />
professionisti e ricercatori. Il modello <strong>di</strong> sviluppo era considerato “<strong>un</strong>ico” ed<br />
<strong>un</strong>iversalmente accettato, basato soprattutto sulla <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> <strong>un</strong>a industrializzazione<br />
spinta (spesso legata alla grande industria, <strong>per</strong> poter sfruttare al meglio le economie <strong>di</strong><br />
scala) e sul processo <strong>di</strong> concentrazione delle attività produttive e degli inse<strong>di</strong>amenti<br />
nelle aree più ricche. Si parlava soprattutto <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> progetti e gli in<strong>di</strong>rizzi (anche a<br />
livello <strong>di</strong> politiche <strong>di</strong> sviluppo) venivano essenzialmente dall’alto, senza coinvolgere la<br />
popolazione ma senza che questa esprimesse forti istanze partecipative. Essendo la<br />
pressione antropica ancora relativamente limitata, non ci si poneva problemi rispetto ad<br />
<strong>un</strong> uso efficiente delle risorse, che venivano impiegate senza risparmio. La fiducia nel<br />
progresso, anche in assenza <strong>di</strong> risvolti negativi che si sono manifestati con l’andar del<br />
tempo, ha fatto sì che si partisse da <strong>un</strong>a “pres<strong>un</strong>zione <strong>di</strong> innocenza” dei progetti, <strong>per</strong> cui,<br />
in assenza <strong>di</strong> prova contraria, essi venivano considerati sicuri. Inoltre, vista la fiducia<br />
nella scienza, anche nel caso <strong>di</strong> consapevolezza <strong>di</strong> probabili ricadute negative, si<br />
ipotizza che la scienza sarà com<strong>un</strong>que in grado – <strong>un</strong>a volta che si porrà il problema – <strong>di</strong><br />
in<strong>di</strong>viduare <strong>un</strong>a soluzione. D’altra parte, ci si sente <strong>per</strong>fettamente in grado <strong>di</strong> prevedere<br />
gli sviluppi futuri, in quanto il ritmo <strong>di</strong> crescita si è <strong>di</strong>mostrato nel tempo crescente con<br />
trend relativamente regolari: si ipotizza, quin<strong>di</strong>, che tali trend possano <strong>per</strong>manere nel<br />
tempo, senza avere accelerazioni esponenziali o fratture in quello che è il processo <strong>di</strong><br />
17 V. Bettini, L.W. Canter, L. Ortolano (a cura <strong>di</strong>) Ecologia dell’impatto ambientale, UTET, Torino,<br />
2000, pp. XVII-XIX<br />
Pag. 12 <strong>di</strong> 148<br />
12
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
sviluppo. Di conseguenza, anche le progettazioni vengono fatte tenendo presente il<br />
p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> arrivo, in <strong>un</strong> futuro anche abbastanza lontano, con <strong>un</strong>a sud<strong>di</strong>visione temporale<br />
che è da considerarsi semplicemente come <strong>un</strong>a sud<strong>di</strong>visione in tappe interme<strong>di</strong>e.<br />
Stante il contesto precedentemente descritto non ci si preoccupa <strong>di</strong> mitigare (cioè <strong>di</strong><br />
ridurre) l’impatto ambientale (ad esempio, prevedendo i depuratori <strong>per</strong> gli scarichi o<br />
delle siepi che costituiscano barriere visive <strong>per</strong> e<strong>di</strong>fici impattanti sul paesaggio) né,<br />
tanto meno, <strong>di</strong> compensare 18 (monetariamente o con benefici <strong>di</strong> natura <strong>di</strong>versa) gruppi o<br />
in<strong>di</strong>vidui che abbiano subito <strong>un</strong> impatto 19.<br />
Se si confronta tale situazione con quella degli anni novanta e successivi, si nota<br />
come il contesto sia completamente cambiato. Non esiste più <strong>un</strong>a nozione<br />
<strong>un</strong>iversalmente accettata <strong>di</strong> quale aspetto debba assumere lo sviluppo o il progresso, ma<br />
si riven<strong>di</strong>ca <strong>un</strong> approccio allo sviluppo che tenga conto delle peculiarità e delle esigenze<br />
locali, questo anche in conseguenza del fatto che il modello legato alla concentrazione<br />
delle attività produttive e degli inse<strong>di</strong>amenti ha portato a notevoli squilibri territoriali ed<br />
a conseguenze ambientali non in<strong>di</strong>fferenti, legate da <strong>un</strong>a parte al sovrasfruttamento<br />
delle risorse e dall’altra all’abbandono dei territori ritenuti marginali. Nel processo <strong>di</strong><br />
sviluppo <strong>di</strong>ventano sempre più frequenti e forti le istanze partecipative, che chiedono il<br />
passaggio da <strong>un</strong>’ottica <strong>di</strong> tipo Top-Down (dall’alto verso il basso, con decisioni che i<br />
vertici politici “impongono” alla popolazione dall’alto) ad <strong>un</strong>’ottica <strong>di</strong> tipo Bottom-Up<br />
(in cui le istanze <strong>di</strong> sviluppo devono partire “dal basso” tenendo presenti caratteristiche<br />
ed esigenze delle <strong>di</strong>verse regioni). In altre parole, non è più il politico a poter decidere<br />
qual è il bene pubblico, ma deve essere la collettività ad esprimere i propri obiettivi e<br />
criteri, non necessariamente riconducibili a valori monetari.<br />
L’uscita <strong>di</strong> libri quale lo stu<strong>di</strong>o sui “Limiti dello sviluppo” commissionato dal Club<br />
<strong>di</strong> Roma ad alc<strong>un</strong>i ricercatori del Massachussets Institute of Technology (MIT) pone<br />
l’accento sul problema dell’esaurimento <strong>di</strong> risorse non rinnovabili e strategiche <strong>per</strong> la<br />
nostra economia, quali il petrolio, mentre altri, quali “Primavera silenziosa” <strong>di</strong> R.<br />
Carson, sottolineano le problematiche ambientali legate all’immissione <strong>di</strong> inquinanti o<br />
18 In realtà, a parte le compensazioni monetarie, si possono avere anche compensazioni <strong>di</strong> tipo<br />
ambientale, ad esempio prevedendo la ricostituzione <strong>di</strong> <strong>un</strong> elemento dell’ambiente ritenuto <strong>di</strong> pregio a<br />
valle <strong>per</strong> compensare il danno previsto a carico <strong>di</strong> <strong>un</strong> altro. Nella parte relativa ai criteri <strong>per</strong> i giu<strong>di</strong>zi <strong>di</strong><br />
compatibilità ambientale, avremo modo <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>re <strong>di</strong> più la natura più o meno omogenea dei<br />
<strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> compensazione.<br />
19 Come vedremo meglio in seguito, in molti testi <strong>di</strong> legge si inserisce negli obiettivi quello <strong>di</strong> prevenire,<br />
ridurre (mitigare) e compensare gli impatti ambientali.<br />
Pag. 13 <strong>di</strong> 148<br />
13
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
all’uso <strong>di</strong> sostanze dannose <strong>per</strong> l’ambiente (fitofarmaci usati in maniera irrazionale).<br />
Inoltre incidenti e catastrofi ambientali (Minamata, Chernobyl, Seveso, Bhopal, ecc.) 20<br />
mettono in crudo risalto l’elevato rischio che si corre non considerando “a priori” la<br />
potenziale <strong>per</strong>icolosità dei progetti. A seguito delle problematiche ambientali sempre<br />
più forti e <strong>di</strong>ffuse i movimenti ambientalisti assumono <strong>un</strong>a forza ed <strong>un</strong> seguito via via<br />
maggiore ed i movimenti <strong>di</strong> opinione si mobilitano <strong>per</strong> cercare <strong>di</strong> contrastare o<strong>per</strong>e non<br />
ritenute accettabili. La <strong>di</strong>ffusione dei mass me<strong>di</strong>a e <strong>di</strong> strumenti <strong>di</strong> com<strong>un</strong>icazione molto<br />
potenti fanno sì che sia più facile <strong>di</strong>ffondere le informazioni e mobilitare il <strong>di</strong>ssenso,<br />
anche se a volte questo può essere “manovrato” da gruppi interessati. Sempre più, come<br />
vedremo meglio in seguito, le valutazioni del tecnico tendono a <strong>di</strong>vergere da quelle del<br />
privato citta<strong>di</strong>no. La popolazione ha forti istanze partecipative al processo decisionale.<br />
La nozione <strong>di</strong> mitigazione viene riconosciuta ed accettata, anche <strong>per</strong> problemi <strong>di</strong><br />
consenso del pubblico.<br />
Stante l’accelerazione dei fenomeni non si vede più lo sviluppo come <strong>un</strong> processo<br />
regolare e lineare <strong>per</strong> cui <strong>di</strong>venta <strong>di</strong>fficile fare previsioni rispetto al futuro, anche <strong>per</strong>ché<br />
ci si è resi conto che la realtà, sia a livello economico che a livello ambientale, è molto<br />
più complessa e “pilotabile” <strong>di</strong> quanto si ritenesse in passato. Di conseguenza, non<br />
riuscendo a prevedere con certezza gli scenari futuri (in cui determinati progetti<br />
andranno ad o<strong>per</strong>are) si cerca <strong>di</strong> privilegiare interventi dotati <strong>di</strong> elevata flessibilità, e<br />
quin<strong>di</strong> in grado <strong>di</strong> adattarsi il più possibile ad eventuali mutamenti <strong>di</strong> contesto. Di<br />
conseguenza si tiene soprattutto conto delle problematiche a breve termine,<br />
accompagnandole con valutazioni a me<strong>di</strong>o e l<strong>un</strong>go termine, magari riferite a possibili<br />
itinerari <strong>di</strong> sviluppo <strong>di</strong>versi.<br />
Come si può forse apprezzare da quanto sopra esposto, l’Analisi Costi Benefici ed il<br />
suo approccio monetario si inquadrano abbastanza bene nel contesto storico fino agli<br />
anni sessanta, mentre mostrano molti dei loro limiti <strong>per</strong> quel che riguarda la situazione<br />
attuale. Nel tempo – come abbiamo accennato – altri meto<strong>di</strong> sono stati proposti,<br />
riscuotendo <strong>un</strong> successo più o meno grande. Anche se molti <strong>di</strong> loro hanno messo in<br />
piena luce i propri <strong>di</strong>fetti (sinteticamente illustrati in tabella 1) ciò non significa che essi<br />
non siano suscettibili <strong>di</strong> impiego. Vedremo, infatti, nel proseguo del <strong>corso</strong> come<br />
l’Analisi Costi Benefici (ACB) rivesta a tutt’oggi <strong>un</strong>a sua importanza come criterio <strong>di</strong><br />
20 Cfr. l’elenco riportato in G. Santoprete, Ambiente e risorse naturali. Attività antropiche e<br />
inquinamento, E<strong>di</strong>zioni ETS, 2003, pp. 250-252<br />
Pag. 14 <strong>di</strong> 148<br />
14
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
valutazione dell’efficiente uso <strong>di</strong> denaro pubblico (e <strong>di</strong> conseguenza possa essere <strong>un</strong>o<br />
dei criteri considerati in <strong>un</strong> giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> valutazione <strong>di</strong> impatto ambientale) e come le<br />
tecniche <strong>di</strong> analisi multicriteriale possano essere usate <strong>per</strong> la fase più tecnica del<br />
proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> VIA, cioè quella che mette le <strong>di</strong>verse alternative a confronto, anche se<br />
tale fase è inserita in <strong>un</strong> contesto più ampio e partecipativo.<br />
In tabella 1 sono descritte le tecniche utilizzate nel tempo <strong>per</strong> il supporto alle<br />
decisioni, come elencate dall’OCDE (1989) e riportate nel La Camera. 21<br />
Tabella 1 - Tecniche <strong>di</strong> supporto alle decisioni<br />
Metodo Descrizione Vantaggi Svantaggi<br />
1.<br />
Analisi Costi-<br />
Benefici<br />
2.<br />
Analisi Costi-<br />
Efficacia<br />
3.<br />
Analisi Multicriteria<br />
4.<br />
Analisi dei<br />
rischi<br />
5.<br />
Analisi delle<br />
decisioni<br />
6.<br />
<strong>Valutazione</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Impatto</strong><br />
ambientale<br />
Valuta i progetti sulla<br />
base della stima<br />
monetaria <strong>di</strong> costi e<br />
benefici netti<br />
Seleziona i progetti che<br />
minimizzano i costi a<br />
parità <strong>di</strong> efficacia<br />
(risultati)<br />
Seleziona i progetti in<br />
base ad <strong>un</strong>a f<strong>un</strong>zione<br />
“obiettivo” che include<br />
l’importanza attribuita<br />
dalla decisione ai vari<br />
obiettivi<br />
Confronta i benefici <strong>di</strong> <strong>un</strong><br />
progetto con i rischi dello<br />
stesso<br />
Analisi passo dopo passo<br />
delle conseguenze delle<br />
scelte in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />
incertezza<br />
Dettagliata stima degli<br />
effetti in termini <strong>di</strong><br />
impatto ambientale<br />
positivo o negativo delle<br />
azioni progettuali<br />
I valori sono espressi in<br />
termini quantitativi e<br />
confrontabili<br />
Non bisogna stimare i<br />
benefici. Valore implicito<br />
nell’obiettivo<br />
Permette <strong>un</strong>a<br />
quantificazione implicita<br />
<strong>di</strong> costi e benefici, offre<br />
<strong>un</strong>a fase trasparente <strong>per</strong><br />
le decisioni, <strong>per</strong>mette <strong>di</strong><br />
“or<strong>di</strong>nare” i vari progetti<br />
confrontando costi e<br />
benefici <strong>di</strong>versi<br />
Intende <strong>per</strong>mettere <strong>un</strong>a<br />
considerazione<br />
complessiva dei costi,<br />
benefici e rischi<br />
Permette l’uso <strong>di</strong> vari<br />
obiettivi. Esplicita le<br />
scelte e le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />
incertezza<br />
Esplicita la<br />
considerazione degli<br />
effetti ambientali, anche<br />
quelli non monetizzabili<br />
Pag. 15 <strong>di</strong> 148<br />
Non dà <strong>di</strong>retta<br />
considerazione della<br />
<strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> costi e<br />
benefici. Difficoltà <strong>di</strong><br />
stima monetaria <strong>di</strong> tal<strong>un</strong>i<br />
effetti ambientali<br />
Non dà importanza ai<br />
benefici. Non considera i<br />
costi “esterni”<br />
Esige <strong>un</strong>’assegnazione <strong>di</strong><br />
pesi che può essere non<br />
esaustiva o arbitraria.<br />
Occorrono molte<br />
informazioni <strong>per</strong> la<br />
quantificazione. La bontà<br />
dei risultati <strong>di</strong>pende dagli<br />
input del modello<br />
Molto vago. I fattori<br />
considerati sono spesso<br />
non misurabili<br />
Obiettivi non sempre<br />
chiari, meccanismo non<br />
chiaro <strong>di</strong> assegnazione<br />
dei pesi<br />
Difficoltà <strong>di</strong> integrare le<br />
analisi descrittive degli<br />
effetti ambientali<br />
(“intangibili”) con la<br />
stima monetaria. Criteri<br />
non chiari sull’uso delle<br />
informazioni rivolte a<br />
sostegno delle decisioni<br />
Fonte: OCDE (1989) citato in F. La Camera, <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> Guida<br />
all’applicazione della normativa, Il Sole 24 ore Pirola, 1998.<br />
21 F. La Camera, op. cit., pp. 1-2<br />
15
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
In questa sede non ci soffermeremo più a l<strong>un</strong>go sulle caratteristiche dei <strong>di</strong>versi<br />
meto<strong>di</strong>, riservandoci <strong>di</strong> riprenderne almeno alc<strong>un</strong>i nella seconda parte del <strong>corso</strong>,<br />
soprattutto <strong>per</strong>ché essi possono essere visti come “integrati” nella valutazione <strong>di</strong> impatto<br />
ambientale, piuttosto che in contrapposizione ad essa.<br />
Infatti, ad esempio, il risultato dell'analisi costi benefici, può costituire <strong>un</strong>o dei<br />
criteri su cui valutare <strong>un</strong> progetto, rappresentando <strong>un</strong> in<strong>di</strong>ce del “ren<strong>di</strong>mento” <strong>di</strong> <strong>un</strong><br />
investimento pubblico in termini <strong>di</strong> costi e benefici sociali, come mette in evidenza la<br />
seguente citazione tratta da Bazzani, Malagoli e Ragazzoni 22 .<br />
«Occorre com<strong>un</strong>que rilevare che l’analisi costi-benefici costituisce <strong>un</strong> valido<br />
strumento <strong>di</strong> supporto alle decisioni anche nelle metodologie <strong>di</strong> valutazione <strong>di</strong> impatto<br />
ambientale “non monetarie”, soprattutto nel caso in cui l’aspetto economico abbia<br />
<strong>un</strong>’elevata rilevanza nello stabilire se realizzare o meno il progetto. In particolare,<br />
l’inserimento dell’analisi costi-benefici in <strong>un</strong>a procedura <strong>di</strong> or<strong>di</strong>namento dei progetti<br />
non monetaria può essere effettuata principalmente <strong>per</strong> i seguenti motivi:<br />
1) attraverso l’analisi costi-benefici si valutano tal<strong>un</strong>i dati <strong>di</strong> base che vengono<br />
inseriti nelle analisi non monetarie, al fine <strong>di</strong> valutare gli effetti economici dei<br />
vari progetti. Tali valori, opport<strong>un</strong>amente ponderati, costituiscono, insieme, agli<br />
altri, <strong>un</strong>o dei tanti aspetti sui quali fondare l’or<strong>di</strong>namento dei progetti;<br />
2) l’analisi costi-benefici fornisce le in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> carattere economico relative al<br />
progetto scelto. In questo caso essa costituisce <strong>un</strong>a ulteriore valutazione <strong>di</strong><br />
supporto al processo decisionale che porta all’accettazione o al rifiuto <strong>di</strong> <strong>un</strong><br />
determinato progetto.»<br />
Affiancare il risultato dell’ACB con altri criteri può servire a correggere il fatto che<br />
esso non riesce a tenere conto <strong>di</strong> grandezze non monetizzabili.<br />
Introducendo criteri <strong>di</strong>versi da quello monetario, la consapevolezza che alc<strong>un</strong>e<br />
valutazioni sono caratterizzate da livelli <strong>di</strong> incertezza/soggettività spesso ineliminabili e<br />
prevedendo esplicitamente la partecipazione dei soggetti interessati, il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong><br />
VIA può correggere la critica <strong>di</strong> “tecnocraticità” della ACB messa in evidenza da<br />
Gerelli e Laniado (op. cit., 1987), prevedendo <strong>un</strong>o specifico ruolo sia del politico che<br />
del pubblico. A sua volta l'analisi multicriteriale può essere utilizzata <strong>per</strong> la fase più<br />
tecnica della “valutazione ambientale” cioè quella che prevede <strong>di</strong> effettuare <strong>un</strong>a<br />
valutazione <strong>di</strong> merito sui risultati emersi dallo stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> impatto ambientale (che<br />
22 Bazzani G.M., Malagoli C., Ragazzoni A. (1993), op. cit., p. 58<br />
Pag. 16 <strong>di</strong> 148<br />
16
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
prevede l’in<strong>di</strong>viduazione, descrizione e valutazione degli effetti della realizzazione<br />
dell’o<strong>per</strong>a) soprattutto nel caso in cui vi siano <strong>di</strong>versi aspetti – <strong>di</strong>fficilmente<br />
sintetizzabili – <strong>di</strong> cui tenere conto ai fini della decisione finale e non esista <strong>un</strong> <strong>un</strong>ico<br />
progetto ma più alternative da mettere a confronto. In questo caso, me<strong>di</strong>ante l'analisi<br />
multiattributi, potrebbe essere possibile or<strong>di</strong>nare gerarchicamente (cioè dal meglio al<br />
peggio) le <strong>di</strong>verse alternative <strong>di</strong> progetto. Inoltre, come già accennato, la <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> dovrebbe prevedere <strong>un</strong>a partecipazione attiva del pubblico, che,<br />
soprattutto se attuata in fase iniziale, rende possibile:<br />
– mettere in evidenza nei momenti iniziali (quando gli oneri sostenuti sono minimi)<br />
eventuali problemi <strong>di</strong> conflitto esistenti;<br />
– avere <strong>un</strong>a valutazione dell'importanza dei <strong>di</strong>versi criteri che rispecchi effettivamente<br />
il set delle preferenze della popolazione.<br />
Infine, come vedremo nel secondo modulo, scopo della valutazione <strong>di</strong> impatto<br />
ambientale non è tanto quello <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare qual è – tra tante – la soluzione ottima, ma<br />
quello <strong>di</strong> essere sicuri <strong>di</strong> scartare le soluzioni che non sono adeguate, lasciando al<br />
politico la possibilità <strong>di</strong> effettuare <strong>un</strong>a scelta tra le rimanenti. Si rovescia, quin<strong>di</strong>, l’ottica<br />
dei meto<strong>di</strong> “ottimizzanti”, passando dall’in<strong>di</strong>viduazione della soluzione ottimale<br />
all’eliminazione delle soluzioni “sicuramente peggiori” delle altre e, quin<strong>di</strong>, da scartare.<br />
Per quanto riguarda il significato del termine “<strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong>”,<br />
ci preme sottolineare come questo sia utilizzato con due accezioni <strong>di</strong>verse, cioè come:<br />
“approccio metodologico” o come “filosofia secondo la quale affrontare alc<strong>un</strong>i<br />
problemi <strong>di</strong> natura decisionale”, intendendo in questo caso in<strong>di</strong>care tutte le<br />
problematiche affrontate in sede <strong>di</strong> ricerca (anche applicata) <strong>per</strong> stabilire come<br />
debba essere definita e realizzata <strong>un</strong>a VIA “ideale”<br />
come procedura prevista dalla legge, legata a specifiche imposizioni/ adempimenti<br />
previsti dalla normativa stessa. Chiaramente, in questo caso, la maniera <strong>di</strong> come<br />
vada effettuata <strong>un</strong>a procedura <strong>di</strong> VIA <strong>di</strong>pende dal singolo dettato <strong>di</strong> legge (quin<strong>di</strong><br />
potremo avere <strong>di</strong>fferenze nelle procedure <strong>di</strong> applicazione tra Stati <strong>di</strong>versi od in<br />
Regioni <strong>di</strong>verse <strong>di</strong> <strong>un</strong>o stesso Stato, ad esempio l’Italia, in <strong>di</strong>pendenza <strong>di</strong> quanto<br />
dettato dalle specifiche leggi in vigore).<br />
Pag. 17 <strong>di</strong> 148<br />
17
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
Se pren<strong>di</strong>amo il manuale della Regione Lombar<strong>di</strong>a 23 questo definisce la VIA come<br />
«<strong>un</strong>o strumento-processo <strong>per</strong> l'attuazione <strong>di</strong> <strong>un</strong>a politica preventiva» che «rappresenta<br />
<strong>un</strong>a applicazione del principio “la migliore politica ecologica consiste nell'evitare fin<br />
dall'inizio inquinamenti ed altri inconvenienti, anziché combattere successivamente gli<br />
effetti”»<br />
Infine ci preme ricordare come, con la <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> (VIA), si<br />
cerchi <strong>di</strong> tenere conto anche <strong>di</strong> tutti gli effetti non monetizzabili, valutandoli ed<br />
inserendoli nell’analisi a livello preventivo 24 .<br />
La VIA, quin<strong>di</strong>, è preventiva ed ha <strong>un</strong> significato farla quando:<br />
esistono progetti alternativi: in realtà le alternative sono sempre almeno due, nel<br />
senso che esiste sempre la possibilità <strong>di</strong> realizzare <strong>un</strong> progetto e quella <strong>di</strong> non fare<br />
niente 25 . In questo caso, <strong>per</strong>ò, la VIA non ha molto senso <strong>per</strong>ché le alternative sono<br />
troppo limitate. Inoltre, in alc<strong>un</strong>i casi, la decisione <strong>di</strong> “non intervenire” non è<br />
politicamente accettabile;<br />
esiste conflittualità tra gli obiettivi, altrimenti non esistono problemi <strong>di</strong> scelta tra<br />
obiettivi e, quin<strong>di</strong>, fra progetti 26 ;<br />
non esiste possibilità <strong>di</strong> <strong>un</strong>a monetizzazione o valutazione oggettiva. Anche in<br />
questo caso, se si possono valutare oggettivamente sia i costi che i benefici <strong>di</strong> tutte<br />
le alternative, la VIA <strong>di</strong>venta su<strong>per</strong>flua.<br />
Se si verificano le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui sopra non si può risolvere il problema a livello<br />
tecnico, ma devono intervenire sia il tecnico che il politico, interagendo tra loro.<br />
23 Regione Lombar<strong>di</strong>a, Manuale <strong>per</strong> la <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong>. I – In<strong>di</strong>rizzi <strong>per</strong> la<br />
realizzazione dello Stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong>, 1994, scaricabile dal sito della Regione Lombar<strong>di</strong>a,<br />
www.regione.lombar<strong>di</strong>a.it, scegliendo dal menù sucessivamente: Ambiente e territorio, S.I.L.V.I.A.,<br />
guide.<br />
24 Le valutazioni ex post costituiscono <strong>un</strong>a grossa tentazione in quanto sono caratterizzate da <strong>un</strong> maggior<br />
grado <strong>di</strong> certezza nell’in<strong>di</strong>viduazione e misurazione degli effetti che si sono verificati, ma proprio <strong>per</strong> la<br />
loro caratteristica <strong>di</strong> valutazioni “ex post” possono servire solo <strong>per</strong> mitigare impatti già esistenti.<br />
25 La cosidetta Alternativa (o Progetto) 0, che riguarda la situazione che si prevede si verifichi in assenza<br />
<strong>di</strong> intervento. Risulta, quin<strong>di</strong>, costituita non dalla situazione attuale, ma da quella che si prevede <strong>di</strong><br />
verifichi – nello stesso orizzonte temporale preso in esame <strong>per</strong> verificare gli effetti <strong>di</strong> <strong>un</strong> progetto – nel<br />
caso che questo non venga realizzato.<br />
26 Quando gli obiettivi non sono conflittuali, quando cioè è possibile avere contemporaneamente <strong>un</strong><br />
ambiente più pulito ed <strong>un</strong> livello <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to più elevato, non esiste <strong>un</strong> problema <strong>di</strong> scelta. Ness<strong>un</strong><br />
in<strong>di</strong>viduo razionale avrebbe, infatti, problemi a scegliere se è migliore l’alternativa <strong>di</strong> essere ricco e<br />
sano o quella <strong>di</strong> essere povero e malato.<br />
Pag. 18 <strong>di</strong> 148<br />
18
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
In questo primo modulo ci occu<strong>per</strong>emo in <strong>un</strong> primo momento della <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> come “approccio metodologico”, andando solo in <strong>un</strong> secondo<br />
momento ad evidenziare come la legislazione com<strong>un</strong>itaria ed italiana hanno affrontato<br />
questo problema nel tempo. Una lettura in senso <strong>di</strong>namico della legislazione sulla VIA<br />
metterà in evidenza anche come alc<strong>un</strong>e delle istanze partite dalla com<strong>un</strong>ità scientifica<br />
già prima della emanazione della prima <strong>di</strong>rettiva com<strong>un</strong>itaria o, com<strong>un</strong>que, durante i<br />
primi passi dell’adozione <strong>di</strong> questa procedura a livello com<strong>un</strong>itario, siano state recepite<br />
(anche se spesso solo parzialmente) – o <strong>di</strong>sconosciute - dalla legislazione più recente.<br />
Gli aspetti più “tecnici”, sia in termini metodologici (strumenti a <strong>di</strong>sposizione, ecc.)<br />
che procedurali verranno trattati nel secondo modulo.<br />
2. La <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong>: definizione <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong>, <strong>di</strong> Ambiente e <strong>di</strong><br />
Qualità <strong>Ambientale</strong><br />
Iniziamo a parlare più specificatamente <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong><br />
andando ad esaminare il significato dell’espressione, e cominciando a definire che cos’è<br />
<strong>un</strong> impatto.<br />
2.1. La definizione <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong><br />
Per poter parlare <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong>, bisogna definire con<br />
chiarezza cosa si intende <strong>per</strong> impatto. A tal proposito il Malcevschi 27 propone la<br />
seguente definizione: «L’ <strong>Impatto</strong> ambientale è l’effetto <strong>di</strong> <strong>un</strong> intervento antropico che<br />
ha provocato l’alterazione <strong>di</strong> singole componenti dell’ambiente o <strong>di</strong> <strong>un</strong> sistema<br />
ambientale nel suo complesso. Più precisamente: è la conseguenza <strong>di</strong> interferenze<br />
prodotte da <strong>un</strong>a sorgente iniziale, che attraverso catene <strong>di</strong> interventi più o meno<br />
complesse generano pressioni su bersagli ambientali significativi potenzialmente in<br />
grado <strong>di</strong> alterarli»<br />
Nella definizione <strong>di</strong> impatto ambientale sopra presentata vi è <strong>un</strong> accenno al<br />
problema della significatività: infatti bisogna tenere presente come tutte le azioni/<br />
attività, anche quella <strong>di</strong> vivere hanno <strong>un</strong> loro impatto, se non altro (nel caso dell’uomo)<br />
come consumo <strong>di</strong> ossigeno e produzione <strong>di</strong> anidride carbonica durante il processo <strong>di</strong><br />
respirazione. Di conseguenza risulta chiaro come sia impossibile (e, com<strong>un</strong>que, sarebbe<br />
27 Le citazione dal Malcelvschi riprese nel presente materiale, qualora non specificato <strong>di</strong>versamente,<br />
fanno riferimento al testo: S. Malcevschi (1991), Qualità ed impatto ambientale. Teoria e strumenti<br />
della <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong>, ETASLIBRI.<br />
Pag. 19 <strong>di</strong> 148<br />
19
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
inefficiente in termini <strong>di</strong> rapporto costi-benefici) considerate tutte le possibili alterazioni<br />
derivanti da <strong>un</strong>a interferenza. Bisognerà, quin<strong>di</strong>, considerare solo le alterazioni<br />
significative, anche se nella scelta <strong>di</strong> quali alterazioni siano significative e quali no<br />
<strong>per</strong>mangono margini <strong>di</strong> soggettività. Tra l’altro la significatività, o meno, <strong>di</strong> <strong>un</strong>a<br />
alterazione non può essere in<strong>di</strong>viduata a prescindere dal contesto in cui si o<strong>per</strong>a, ma<br />
andrà valutata caso <strong>per</strong> caso. Infatti, se l’impatto derivante dal processo <strong>di</strong> respirazione<br />
umana (assorbimento <strong>di</strong> ossigeno ed emissione <strong>di</strong> anidride carbonica) può essere<br />
irrilevante in molti casi, nel caso in cui si valuti il suo effetto sulla salute umana <strong>di</strong> <strong>un</strong><br />
gruppo che vive in <strong>un</strong> ambiente privo <strong>di</strong> ricambio <strong>di</strong> aria dall’esterno (ve<strong>di</strong> il caso <strong>di</strong><br />
<strong>un</strong>a navicella spaziale), l’impatto può <strong>di</strong>ventare non solo significativo, ma <strong>di</strong><br />
fondamentale importanza.<br />
Sempre secondo Malcevschi, «la significatività viene nella pratica interpretata in<br />
rapporto alla possibilità che aumentino in modo apprezzabile i rischi sulla salute e la<br />
sicurezza delle popolazioni, o che vengano mo<strong>di</strong>ficati gli usi plurimi delle risorse<br />
coinvolte, o che vengano almeno in parte pregiu<strong>di</strong>cati gli obiettivi <strong>di</strong> tutela<br />
dell’ambiente espressi in sede amministrativa, scientifica, culturale.»<br />
An<strong>di</strong>amo adesso ad approfon<strong>di</strong>re le definizioni degli elementi attraverso i quali è<br />
possibile descrivere <strong>un</strong> impatto, utilizzando come riferimento le definizioni del Manuale<br />
della Regione Lombar<strong>di</strong>a (op. cit. pp. 51-52):<br />
a) «sorgente (<strong>di</strong> impatto): è l’intervento in progetto (o<strong>per</strong>e fisicamente definibili, attività<br />
antropiche, pianificazioni che prevedono sistemi <strong>di</strong> interventi) suscettibile <strong>di</strong><br />
produrre effetti significativi sull’ambiente in cui si inserisce;<br />
b) azioni elementari: sono gli elementi dell’intervento (es. scarichi, macchinari, traffico<br />
indotto, ecc.) che generano interferenze sull’ambiente circostante; esse devono<br />
essere definite relativamente alle <strong>di</strong>verse fasi della vita <strong>di</strong> <strong>un</strong> intervento (costruzione,<br />
esercizio, eventi anomali e possibili malf<strong>un</strong>zionamenti, smantellamento)». Il ri<strong>corso</strong><br />
alle azioni elementari ci <strong>per</strong>mette <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare con maggiore precisione il tipo <strong>di</strong><br />
impatto che avrà luogo, nel senso che l’impatto relativo ad <strong>un</strong>’azione <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>sboscamento sarà <strong>di</strong>verso da quello provocato da <strong>un</strong>a mo<strong>di</strong>fica dell’assetto del<br />
terreno, da quello <strong>di</strong> emissione <strong>di</strong> fumi nell’aria, ecc.<br />
c) «interferenze <strong>di</strong>rette: sono le alterazioni <strong>di</strong>rette, descrivigili in termini <strong>di</strong> fattori<br />
ambientali, che l’intervento produce sull’ambiente in cui si inserisce, considerate<br />
nella fase iniziale in cui vengono generate dalle azioni <strong>di</strong> progetto (ad es. rumori,<br />
Pag. 20 <strong>di</strong> 148<br />
20
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
emissioni in atmosfera o in corpi idrici, ingombro <strong>di</strong> aree, ecc.)». Queste<br />
interferenze <strong>di</strong>rette possono essere considerate i fattori che sono in grado <strong>di</strong> causare<br />
le alterazioni alle quali gli impatti sono legati.<br />
d) «bersagli ambientali: sono gli elementi quali ad esempio <strong>un</strong> pozzo <strong>per</strong><br />
l’approvvigionamento idropotabile, <strong>un</strong> e<strong>di</strong>ficio in cui abitano <strong>per</strong>sone, <strong>un</strong> sito in cui<br />
ni<strong>di</strong>ficano determinate specie <strong>di</strong> uccelli, descrivibili in termini <strong>di</strong> componenti<br />
ambientali, che possono essere raggi<strong>un</strong>ti e alterati da <strong>per</strong>turbazioni causate<br />
dall’intervento in oggetto; si possono <strong>di</strong>stinguere i “bersagli primari”, fisicamente<br />
raggi<strong>un</strong>ti dalle interferenze prodotte dall’intervento, dai “bersagli secondari” che<br />
vengono raggi<strong>un</strong>ti attraverso “vie critiche” più o meno complesse; bersagli<br />
secondari possono essere costituiti da elementi fisicamente in<strong>di</strong>viduabili (ad esempio<br />
ecosistemi lontani, pozzi in zone idrogeologicamente a valle), ma anche da sistemi<br />
relazionali astratti quali attività antropiche (ad esempio l’agricoltura <strong>di</strong> <strong>un</strong>a zona) o<br />
altri elementi del sistema socio-economico (ad esempio il sistema dei trasporti)». Un<br />
esempio <strong>di</strong> bersaglio primario colpito, ad esempio, da <strong>un</strong>’interferenza, quale quella<br />
legata all’utilizzo <strong>di</strong> <strong>un</strong> prodotto tossico (ad esempio il DDT), è l’aria, la cui qualità<br />
viene ad essere alterata dalla presenza <strong>di</strong> questa sostanza estranea. A sua volta,<br />
entrando nella catena trofica, attraverso <strong>per</strong>corsi più o meno l<strong>un</strong>ghi e complicati (vie<br />
critiche), il DDT sarà in grado <strong>di</strong> raggi<strong>un</strong>gere altri bersagli, anche molto lontani nello<br />
spazio e nel tempo dal luogo <strong>di</strong> emissione originaria (ad esempio il DDT è stato<br />
trovato anche nel grasso dei pinguini).<br />
e) «pressione ambientale: esprime il livello <strong>di</strong> interferenza che <strong>un</strong> dato bersaglio<br />
ambientale 28 subisce nel momento in cui viene raggi<strong>un</strong>to dalle conseguenze<br />
dell’intervento; <strong>un</strong> termine collegato usato soprattutto <strong>per</strong> l’inquinamento<br />
atmosferico è quello <strong>di</strong> “immissione”; in seguito all’ “emissione” 29 <strong>di</strong> sostanze<br />
inquinanti (i fumi che lasciano il camino, ovvero l’interferenza <strong>di</strong>retta sul<br />
28 Il Glossario del Manuale della Regione Lombar<strong>di</strong>a (op. cit.) p. 222 dà la seguente definizione:<br />
«Pressione sull’ambiente: insieme dei livelli <strong>di</strong> interferenza che <strong>un</strong>a data azione <strong>di</strong> progetto esercita<br />
sull’ambiente e che possono costituire premessa <strong>per</strong> alterazioni significative dell’ambiente stesso. Si<br />
parla generalmente <strong>di</strong> pressione antropica <strong>per</strong> l’insieme delle pressioni esercitate dagli interventi e<br />
dalle attività <strong>di</strong> origine umana sull’ambiente»<br />
29 Glossario del Manuale della Regione Lombar<strong>di</strong>a (op. cit.), p. 220 dà le seguenti definizioni:<br />
« Immissioni: Introduzione nell’ambiente <strong>di</strong> materia ed energia in <strong>di</strong>verse forme o fasi (sostanze<br />
volatili, onde sonore, ecc.), originate dall’intervento in progetto, in quantità e modalità tali da risultare<br />
potenzialmente significative; Emissioni: Fuoriuscite nell’ambiente, causate da elementi dell’intervento<br />
(camini, su<strong>per</strong>fici esposte, ecc.), <strong>di</strong> materia ed energia in <strong>di</strong>verse forme o fasi (sostanze volatili, onde<br />
sonore, ecc.)». In altre parole, semplificando, potremmo <strong>di</strong>re che ci riferiamo sempre al fenomeno <strong>di</strong><br />
introduzione anomala <strong>di</strong> fonti <strong>di</strong> interferenza, <strong>un</strong>a volta visto da parte della sorgente (emissione) e<br />
l’altra vista da parte del bersaglio che la riceve (immissione).<br />
Pag. 21 <strong>di</strong> 148<br />
21
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
compartimento atmosferico) ed agli specifici processi <strong>di</strong> <strong>di</strong>s<strong>per</strong>sione (trasporto da<br />
parte del vento, ecc.), l’“immissione” rappresenta l’inquinamento che effettivamente<br />
raggi<strong>un</strong>ge <strong>un</strong> dato p<strong>un</strong>to del territorio; nel caso delle sostanze contaminanti la<br />
pressione può essere espressa attraverso l’esposizione a cui il soggetto considerato è<br />
sottoposto (ad esempio l’esposizione a determinati ra<strong>di</strong>onucli<strong>di</strong>.<br />
Distinto è invece il concetto <strong>di</strong> “dose”; esso esprime la quantità <strong>di</strong> pressione esterna<br />
che effettivamente viene ass<strong>un</strong>ta dal bersaglio ambientale (che su<strong>per</strong>a cioè le sue<br />
barriere naturali o artificiali). Ad esempio, <strong>un</strong> organismo può essere esposto ad <strong>un</strong><br />
determinato livello <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>oattività presente nell’ambiente esterno, ma <strong>di</strong> essa solo<br />
<strong>un</strong>a parte raggi<strong>un</strong>ge effettivamente l’organismo stesso».<br />
SORGENTE<br />
Azione<br />
elementare<br />
BERSAGLIO<br />
AMBIENTALE<br />
PRIMARIO<br />
Figura 1 – Modello grafico <strong>di</strong> <strong>un</strong> impatto ambientale<br />
(fig. 1.1 Malcevschi, fig. 5 del Manuale Regione Lombar<strong>di</strong>a)<br />
Legenda: «Una sorgente, ad esempio <strong>un</strong> impianto industriale) comporta azioni elementari (ad<br />
esempio <strong>un</strong> canale <strong>di</strong> scarico) che producono interferenze sull’ambiente esterno (lo scarico<br />
rilascia determinate quantità <strong>di</strong> acque inquinate); l’interferenza tocca <strong>di</strong>rettamente alc<strong>un</strong>i<br />
bersagli (in questo caso le acque scaricate si immettono nel corpo idrico ricettore);<br />
successivamente, attraverso processi più o meno articolati (<strong>di</strong>luizione delle acque inquinate,<br />
scorrimento a valle dei contaminanti, consumo dell’ossigeno presente nelle acque, ecc.) si<br />
mo<strong>di</strong>ficano altri elementi del sistema ambientale complessivo ed altri bersagli possono essere<br />
compromessi (ad esempio le acque inquinate del <strong>corso</strong> d’acqua possono irrigare e contaminare<br />
colture destinate all’alimentazione umana)» (Malcevschi)<br />
La figura 1 (Modello grafico <strong>di</strong> <strong>un</strong> impatto ambientale, riportata sia sul Manuale<br />
della Regione Lombar<strong>di</strong>a che sul Malcevschi) fornisce <strong>un</strong>a illustrazione grafica <strong>di</strong><br />
quanto sopra descritto.<br />
Interferenza<br />
<strong>di</strong>retta<br />
Da notare che, come fa notare il Malcevschi, <strong>per</strong> parlare <strong>di</strong> impatto, non sia<br />
necessario che la pressione si traduca in <strong>un</strong>’alterazione del bersaglio (ad esempio che<br />
l’immissione <strong>di</strong> <strong>un</strong> inquinante nell’ambiente o l’esposizione <strong>di</strong> <strong>un</strong> in<strong>di</strong>viduo ad <strong>un</strong>a<br />
Pag. 22 <strong>di</strong> 148<br />
Processo critico<br />
SISTEMA AMBIENTALE<br />
22
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
sostanza inquinante si traduca in <strong>un</strong>a dose <strong>di</strong> contaminante effettivamente ass<strong>un</strong>ta), in<br />
quanto ciò che conta è che la pressione sia avvenuta.<br />
Un’altra problematica che vale la pena <strong>di</strong> sottolineare è quella legata alla definizione<br />
<strong>di</strong> “ambiente”. Infatti, mentre alc<strong>un</strong>i interpretano questo concetto in senso stretto,<br />
intendendo esclusivamente le componenti “naturali” (aria, acqua, suolo, flora, fa<strong>un</strong>a,<br />
ecc.) <strong>per</strong> altri il concetto deve essere inteso in senso lato, includendo anche il “sistema<br />
uomo-ambiente”, fino a comprendervi fenomeni <strong>di</strong> natura economica (in quanto legati<br />
all’interazione tra attività umane e risorse naturali, ecc.), sociale, ecc. La motivazione <strong>di</strong><br />
tale tipo <strong>di</strong> approccio è essenzialmente legata al fatto che qualsiasi tipo <strong>di</strong> decisione che<br />
sia legata esclusivamente a parametri <strong>di</strong> natura ambientale in senso stretto (ad esempio,<br />
la mancata realizzazione <strong>di</strong> <strong>un</strong> impianto, in quanto ritenuto inquinante) senza<br />
considerare i parametri socio-economici legati alla stessa (creazione <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to, <strong>di</strong><br />
occupazione, <strong>di</strong> beni ritenuti strategici <strong>per</strong> la società, ecc.) rischia <strong>di</strong> portare a<br />
<strong>di</strong>storsioni, analogamente a quanto avveniva in passato, quando le decisioni venivano<br />
prese esclusivamente in base a parametri <strong>di</strong> natura economica, trascurando gli effetti<br />
sull’ambiente. In altre parole, <strong>per</strong> in<strong>di</strong>viduare linee <strong>di</strong> condotta sod<strong>di</strong>sfacenti sia dal<br />
p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista socio-economico che ambientale in senso stretto bisogna che le decisioni<br />
vengano prese tenendo conto contemporaneamente <strong>di</strong> tutti i fattori rilevanti <strong>per</strong><br />
entrambi i “macro-comparti” (economico e ambientale).<br />
Infatti, l’accettazione <strong>di</strong> <strong>un</strong>a determinata scelta in base a soli parametri ambientali,<br />
ad esempio la decisione <strong>di</strong> realizzare <strong>un</strong> impianto in quanto impattante a livelli ritenuti<br />
“accettabili”, in assenza <strong>di</strong> valutazione delle <strong>per</strong>formance economiche, può portare a<br />
scelte sub-ottime in quanto sarebbe stato possibile, a parità <strong>di</strong> impatto causato, ottenere<br />
migliori <strong>per</strong>formance dal p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista socio-economico (maggiore produzione <strong>di</strong><br />
red<strong>di</strong>to, <strong>di</strong> occupazione, <strong>di</strong> beni rilevanti ai fini del benessere complessivo della<br />
società), mentre <strong>un</strong>’o<strong>per</strong>a socio-economica strategica <strong>per</strong> la società potrebbe essere non<br />
autorizzata in quanto ritenuta troppo impattante, anche se il livello <strong>di</strong> impatto non<br />
presenta caratteristiche tali da non poter essere mitigato o com<strong>un</strong>que “sostenuto”<br />
dall’ambiente stesso senza arrivare a soglie che siano considerate inaccettabili 30 .<br />
30 Volendo banalizzare la situazione possiamo fare il seguente esempio: ness<strong>un</strong>a <strong>per</strong>sona razionale, in <strong>un</strong>a<br />
situazione <strong>di</strong> abbondanza, sarà <strong>di</strong>sposto a mangiare <strong>un</strong> alimento potenzialmente dannoso <strong>per</strong> la sua<br />
salute, quale <strong>un</strong> cibo avariato o potenzialmente contaminato da sostanze nocive. Viceversa, questa<br />
potrebbe essere <strong>un</strong>a scelta <strong>per</strong>fettamente razionale <strong>per</strong> qualc<strong>un</strong>o talmente tanto povero da essere a<br />
rischio <strong>di</strong> morire <strong>di</strong> fame. In quel caso, il rischio <strong>di</strong> morte o malattia futura derivante dall’ass<strong>un</strong>zione <strong>di</strong><br />
alimenti “non sicuri” risulta sicuramente più accettabile rispetto ad <strong>un</strong>a morte certa e a breve termine<br />
<strong>per</strong> ine<strong>di</strong>a.<br />
Pag. 23 <strong>di</strong> 148<br />
23
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
Ritornando al modello grafico <strong>di</strong> <strong>un</strong> impatto ambientale (cfr. figura 1), può valere la<br />
pena mettere in evidenza come, in <strong>un</strong>’ottica <strong>di</strong> procedura <strong>di</strong> VIA, la sorgente iniziale è<br />
<strong>di</strong> origine antropica, in quanto tale procedura è volta ad in<strong>di</strong>viduare gli effetti delle<br />
attività umane in vista <strong>di</strong> <strong>un</strong>a loro autorizzazione, o meno.<br />
Lo schema <strong>di</strong> definizione <strong>di</strong> <strong>un</strong> impatto ambientale può essere correlato anche ai<br />
passi logici (non sempre tutti possibili) che devono essere fatti <strong>per</strong> inserire nell’ACB <strong>un</strong><br />
valore monetario relativo a qualcosa che non ha <strong>un</strong> prezzo <strong>di</strong> mercato. Pren<strong>di</strong>amo come<br />
esempio <strong>un</strong> caso <strong>di</strong> inquinamento atmosferico. Nostro obiettivo è trovare il costo sociale<br />
derivante da tutti i possibili livelli delle emissioni. Come messo in evidenza da Bazzani,<br />
Malagoli e Ragazzoni 31 «<strong>per</strong> poter effettuare questa o<strong>per</strong>azione è necessario stabilire<br />
dapprima il grado <strong>di</strong> emissione, ovvero l’entità dell’impatto in termini fisici, chimici,<br />
qualitativi, ecc. e successivamente occorrerà verificare lo stato dell’ambiente in seguito<br />
alle emissioni provocate dal progetto. Verificata l’entità della mo<strong>di</strong>ficazione<br />
dell’ambiente, occorrerà stabilire il probabile danno fisico e convertirlo in danno<br />
monetario». I passi da compiere, quin<strong>di</strong>, risultano legati alla stima <strong>di</strong>:<br />
Emissioni. E' il parametro da cui partire nel processo <strong>di</strong> monetizzazione dei danni<br />
causati dai fumi. Per semplicità si potrebbe limitare l’analisi al caso <strong>di</strong> <strong>un</strong> solo<br />
inquinante, <strong>per</strong> esempio la SO2. In questo caso conoscendo le caratteristiche<br />
tecnologiche dell’impianto ed avendo a <strong>di</strong>sposizione i dati rilevati in impianti<br />
analoghi è abbastanza facile avere <strong>un</strong>a previsione molto atten<strong>di</strong>bile <strong>di</strong> quella che<br />
sarà l’immissione <strong>di</strong> fumi nell’atmosfera. Trattandosi <strong>di</strong> <strong>un</strong> singolo impianto (ad<br />
esempio <strong>un</strong>a fabbrica con la sua ciminiera che scarica i fumi nell’ambiente)<br />
parleremo <strong>di</strong> <strong>un</strong>a sorgente p<strong>un</strong>tiforme <strong>di</strong> inquinamento, mentre se si fosse trattato <strong>di</strong><br />
<strong>un</strong>a strada o <strong>di</strong> <strong>un</strong>a ferrovia, avremmo parlato <strong>di</strong> fonte <strong>di</strong> inquinamento lineare. Nei<br />
casi <strong>di</strong> inquinamento quali, ad esempio, quello relativo ad eccessivo uso <strong>di</strong><br />
fertilizzanti e fitofarmaci da parte delle attività agricole si parla <strong>di</strong> fonte <strong>di</strong><br />
inquinamento <strong>di</strong>ffusa, in quanto la sorgente praticamente coincide con tutto il<br />
territorio investito ad attività agricole intensive.<br />
Dal livello <strong>di</strong> emissione bisogna passare allo<br />
Stato dell’ambiente che da esso consegue, cioè – nello specifico caso – alla<br />
concentrazione a terra della SO2. Ma questa <strong>di</strong>pende fortemente da parametri quali<br />
31 Bazzani, Malagoli e Ragazzoni (1993), op. cit., p 59<br />
Pag. 24 <strong>di</strong> 148<br />
24
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
l’altimetria, i venti, ecc. <strong>per</strong> cui la stessa emissione può portare a localizzazioni e<br />
concentrazioni <strong>di</strong>verse in <strong>di</strong>pendenza dalle con<strong>di</strong>zioni metereologiche e da altri<br />
fattori. Abbiamo, quin<strong>di</strong>, già introdotto delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> incertezza, a causa delle<br />
quali – anche in assenza <strong>di</strong> altri problemi – non potremo <strong>per</strong>venire ad <strong>un</strong> risultato<br />
certo. Per stimare quale sarà la <strong>di</strong>ffusione dell’inquinante nell’ambiente (e la<br />
concentrazione che da tale <strong>di</strong>ffusione risulterà) in genere si fa riferimento a modelli<br />
matematici che, in base alle caratteristiche pedoclimatiche (dove è localizzata la<br />
sorgente, quanto è alta la ciminiera, quali sono i venti prevalenti, qual è la<br />
conformazione del suolo intorno al p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> emissione, ecc.) del sito <strong>di</strong><br />
localizzazione dell’impianto sono in grado <strong>di</strong> stimare il livello <strong>di</strong> <strong>di</strong>s<strong>per</strong>sione 32 .<br />
Supposto, com<strong>un</strong>que, <strong>di</strong> aver stimato la concentrazione della SO2 nelle <strong>di</strong>verse<br />
localizzazioni (zone omogenee <strong>per</strong> concentrazione) dobbiamo in<strong>di</strong>viduare qual è il<br />
Danno in <strong>un</strong>ità fisiche prodotto dalla stessa. Questo passaggio è ancora più <strong>di</strong>fficile<br />
del precedente. I danni possono essere <strong>di</strong> vario genere: danni alle colture, alle<br />
abitazioni ed ai monumenti, alla salute umana, ecc. Ma come quantificare questi<br />
danni fisici? In genere si cerca <strong>di</strong> utilizzare gran<strong>di</strong> regressioni statistiche, ma<br />
bisognerebbe utilizzare come parametri <strong>di</strong> controllo i dati <strong>di</strong> ambienti (<strong>per</strong> esempio<br />
città) molto simili, ma non inquinate. Questo <strong>per</strong> isolare – a parità <strong>di</strong> tutte le altre<br />
con<strong>di</strong>zioni – gli effetti dell’inquinamento. Chiaramente, l’entità del danno <strong>di</strong>penderà<br />
anche dalle caratteristiche del territorio in cui si è <strong>di</strong>ffuso l’inquinante: in altre<br />
parole, il tipo <strong>di</strong> danno causato da elevate concentrazioni <strong>di</strong> SO2 sarà completamente<br />
<strong>di</strong>verso a seconda che queste vadano a localizzarsi in zone ad elevata densità<br />
abitativa, in zone <strong>di</strong> elevato pregio naturalistico oppure in aree desertiche.<br />
Supponendo <strong>di</strong> riuscire a stimare il danno in <strong>un</strong>ità fisiche, rimane sempre il<br />
problema più grosso, che è quello <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare il<br />
Danno monetario. Una volta in<strong>di</strong>viduato il danno fisico (quanti e<strong>di</strong>fici danneggiati e<br />
come, quanti danni alla salute umana in termini <strong>di</strong> minori aspettative <strong>di</strong> vita o <strong>di</strong><br />
maggiori incidenze <strong>di</strong> malattie come le bronchiti croniche, <strong>di</strong> problemi <strong>di</strong><br />
fitotossicità a carico <strong>di</strong> specie vegetali più o meno rare, ecc.) bisogna convertirlo in<br />
termini monetari. Su questo aspetto l’ACB è andata in crisi, soprattutto <strong>per</strong> i danni<br />
alla salute umana. Infatti non si è riusciti a trovare <strong>un</strong> metodo socialmente<br />
accettabile <strong>per</strong> valutare la salute e la vita umana, cioè <strong>per</strong> <strong>di</strong>re quanto “vale” <strong>un</strong>a<br />
32 Per <strong>un</strong> esempio a livello cartografico, cfr. figura 4.11 – Mappa delle linee <strong>di</strong> isoconcentrazione, sul<br />
testo del Malcevschi<br />
Pag. 25 <strong>di</strong> 148<br />
25
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
bronchite cronica od <strong>un</strong> tumore al polmone o, peggio ancora, <strong>un</strong> determinato<br />
aumento <strong>per</strong>centuale della probabilità che tali eventi avversi si verifichino.<br />
Lo schema riportato in figura 2 riprende l’esposizione sopra fatta: dalla sorgente (o<br />
fonte) dell’inquinamento provengono le emissioni che vengono immesse nell’ambiente<br />
(non necessariamente omogeneo, ma anzi spesso caratterizzato da variabilità interna più<br />
o meno spinta). Tali emissioni, a seconda delle caratteristiche del territorio in cui<br />
vengono immesse (altimetria, acclività, ventosità, ecc.) verranno a <strong>di</strong>s<strong>per</strong>dersi in<br />
maniera <strong>di</strong>versa, risultando in <strong>un</strong>a concentrazione a terra che può variare da area ad area<br />
ma che, tendenzialmente, è più elevata in prossimità della sorgente (in sito 33) piuttosto<br />
che a <strong>di</strong>stanze maggiori (area vasta 34).<br />
Emissioni<br />
AMBIENTE<br />
Figura 2 - Schema Emissione – Danno<br />
Fonte Cappellin e Laniado, 1987<br />
Se si considera il solo impatto rispetto alla salute umana, si dovrà andare a vedere<br />
quali e quanti in<strong>di</strong>vidui risultano esposti alle sostanze immesse nell’ambiente ed a quali<br />
concentrazioni e <strong>per</strong> quali esposizioni 35 . In base a tali informazioni si potrà cercare <strong>di</strong><br />
risalire ad danno in <strong>un</strong>ità fisiche, cioè al tipo <strong>di</strong> effetti negativi sulla salute umana (in<br />
questo caso in<strong>di</strong>cati come “malattie”) che possono essere attribuiti all’alterazione<br />
causata dalla fonte in oggetto.<br />
Concentra-<br />
zione a terra<br />
Rispetto al problema del costo associato all’impatto ambientale è interessante notare<br />
come tale problematica sia stata oggetto <strong>di</strong> analisi da parte <strong>di</strong> numerosi stu<strong>di</strong>osi che<br />
33 “Area <strong>di</strong>rettamente interessata dall’intervento in progetto.” Da Glossario Manuale Regione Lombar<strong>di</strong>a,<br />
op. cit., p. 217<br />
34 “Area vasta: area interessata dai potenziali effetti del progetto, <strong>di</strong>retti ed in<strong>di</strong>retti. Tale area può<br />
assumere confini <strong>di</strong>fferenti a seconda della categoria <strong>di</strong> effetti considerati; ad esempio, <strong>per</strong> gli effetti<br />
relativi all’inquinamento atmosferico, si considerano le aree potenzialmente coinvolte dalle ricadute,<br />
<strong>per</strong> quelli relativi agli scarichi idrici si considera la successione dei corpi idrici a valle, <strong>per</strong> gli effetti<br />
socio-economici può essere necessario considerare l’intero territorio a livello interregionale.” Da<br />
Glossario Manuale Regione Lombar<strong>di</strong>a, op. cit., p. 217<br />
35 Ad esempio, se l’esposizione alla sostanza nociva risultasse limitata all’attività lavorativa (chiaramente<br />
questo non è il caso <strong>di</strong> <strong>un</strong>a emissione proveniente da <strong>un</strong>a ciminiera che si <strong>di</strong>s<strong>per</strong>de nell’ambiente<br />
circostante, ma potrebbe essere il caso <strong>di</strong> attività lavorative che prevedono l’esposizione ad amianto o a<br />
determinati tipi <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>azioni, o a polveri che non si <strong>di</strong>ffondono, come nel caso dell’attività estrattiva in<br />
miniera) il tempo <strong>di</strong> esposizione giornaliero sarebbe <strong>di</strong>verso rispetto ad <strong>un</strong>a sostanza che si <strong>di</strong>ffonde<br />
nell’ambiente e può essere respirata durante tutto il giorno.<br />
Pag. 26 <strong>di</strong> 148<br />
INDIVIDUI<br />
Malattie<br />
26
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
hanno suggerito più criteri <strong>di</strong> risoluzione, riconducibili essenzialmente a quelli <strong>di</strong><br />
seguito elencati:<br />
costo opport<strong>un</strong>ità, cioè valutazione del red<strong>di</strong>to <strong>per</strong>duto in seguito alla rin<strong>un</strong>cia<br />
all’uso dei fattori/processi produttivi/prodotti inquinanti (in questo caso si previene<br />
l’inquinamento, ad esempio prevedendo tipi <strong>di</strong> tecnologie che non provocano la<br />
produzione <strong>di</strong> sostanze nocive come residui);<br />
costo necessario <strong>per</strong> <strong>di</strong>sinquinare (in questo caso si mitigano gli effetti<br />
dell’inquinamento. Un caso particolare potrebbe essere quello dell’utilizzo <strong>di</strong><br />
depuratori, che non prevengono il formarsi <strong>di</strong> sostanze nocive, ma che impe<strong>di</strong>scono<br />
<strong>un</strong>a loro <strong>di</strong>ffusione incontrollata nell’ambiente);<br />
costo relativo all’indennizzo delle <strong>per</strong>sone o cose danneggiate dall’inquinamento (in<br />
questo caso non si fa nulla <strong>per</strong> prevenire il danno, ma si compensa chi ha subito o<br />
subirà il danno <strong>per</strong> l’inquinamento. Chiaramente, l’indennizzo <strong>di</strong> <strong>per</strong>sone o cose<br />
danneggiate potrebbe essere previsto – anche in caso <strong>di</strong> azioni volte a prevenire e<br />
ridurre gli effetti dell’inquinamento – <strong>per</strong> i danni causati dalla quota residua dello<br />
stesso, considerata come non eliminabile 36 ).<br />
Questo tipo <strong>di</strong> <strong>di</strong>s<strong>corso</strong> sarà ripreso in seguito quando si parlerà <strong>di</strong> alternative<br />
<strong>per</strong>corribili in ambito <strong>di</strong> impatto ambientale, in cui – fra le alternative da considerare –<br />
c’è anche quella <strong>di</strong> cercare <strong>di</strong> eliminare la causa <strong>di</strong> impatto ambientale 37 , e quin<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
prevenire lo stesso.<br />
Se si esamina lo schema <strong>di</strong> Figura 2, tratto da Cappelin e Laniado (1987) 38 , relativo<br />
ai danni da inquinamento atmosferico (ma che mantiene la stessa vali<strong>di</strong>tà anche <strong>per</strong><br />
qualsiasi altro comparto ambientale) ed alle procedure <strong>per</strong> stimarli sopra descritte, si<br />
può notare come i tre criteri sopra elencati si collochino temporalmente in tre momenti<br />
<strong>di</strong>versi: il primo (costo opport<strong>un</strong>ità del mancato inquinamento) a monte delle emissioni;<br />
il secondo (costo del <strong>di</strong>sinquinamento) a livello della concentrazione nell’ambiente; il<br />
36 A tal proposito il Glossario del Manuale della Regione Lombar<strong>di</strong>a, op. cit., definisce come Impatti<br />
residui quegli «Impatti che l’intervento produce sull’ambiente, <strong>un</strong>a volta che il progetto ha recepito le<br />
mitigazioni tecniche in<strong>di</strong>viduate nel <strong>corso</strong> della procedura» p. 221<br />
37 cfr., ad esempio, la Tabella 3 – Alternative nel campo dei trasporti, tratto da “La <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong><br />
<strong>Ambientale</strong> – Istruzioni <strong>per</strong> l’uso” <strong>di</strong> M. Alberti, M. Berrini, A. Melone, M. Zambrini, riportato nel<br />
Manuale della Regione Lombar<strong>di</strong>a scaricabile da sito web, all’in<strong>di</strong>rizzo precedentemente citato.<br />
38 R. Cappellin, E. Laniado, La valutazione <strong>di</strong> impatto ambientale come scelta tra progetti alternativi,<br />
Terra, n. 2, pp. 20-24<br />
Pag. 27 <strong>di</strong> 148<br />
27
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
terzo (costo dell’indennizzo del danno da inquinamento) a valle delle malattie (ed altri<br />
danni) provocate dall’inquinamento 39 .<br />
Secondo <strong>un</strong>a visione esclusivamente economica – a parte, cioè, ogni considerazione<br />
<strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne etico – converrebbe scegliere il criterio che minimizza il costo: <strong>di</strong>sinquinare<br />
quando questo è più conveniente del non inquinare ed indennizzare (o compensare) i<br />
danneggiati quando questo crea meno problemi del <strong>di</strong>sinquinare (da notare che, se il<br />
possibile utilizzo <strong>di</strong> fattori/processi inquinanti fa lievitare molto il red<strong>di</strong>to prodotto, può<br />
essere sufficiente destinare <strong>un</strong>a frazione dell’incremento <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to ottenuto a finanziare<br />
il <strong>di</strong>sinquinamento o l’indennizzo). Viste le <strong>di</strong>fficoltà che hanno i danneggiati ad<br />
in<strong>di</strong>viduare in maniera oggettiva chi ha determinato il danno e ad avere <strong>un</strong>a<br />
compensazione <strong>per</strong> lo stesso, è possibile che vengano attuate scelte che determinano<br />
situazioni <strong>di</strong> più elevato costo sociale <strong>per</strong> la collettività, ma a fronte <strong>di</strong> <strong>un</strong> minore costo<br />
economico <strong>per</strong> chi è responsabile dell’attività antropica impattante.<br />
Le possibilità <strong>di</strong> scelta variano non solo in <strong>di</strong>pendenza del tipo <strong>di</strong> inquinamento (non<br />
sempre è possibile <strong>di</strong>sinquinare, specie su gran<strong>di</strong> masse come aria ecc.), ma anche a<br />
seconda del livello <strong>di</strong> inquinamento e dell’oggetto del danno.<br />
Infine, non bisogna trascurare il fatto che le valutazioni relative ai tre tipi <strong>di</strong> costo<br />
avranno, con molta probabilità, <strong>di</strong>verso grado <strong>di</strong> approssimazione.<br />
A questo proposito, riteniamo importante sottolineare il significato della parola<br />
<strong>Valutazione</strong>. Abbiamo messo in evidenza nelle parti precedenti (anche in relazione alla<br />
previsione del danno monetario legato ad <strong>un</strong>a nuova sorgente <strong>di</strong> inquinamento) come,<br />
lavorando la VIA in <strong>un</strong>’ottica <strong>di</strong> ex ante (cioè preventiva), non è possibile avere <strong>un</strong>a<br />
misura precisa dell’impatto ambientale <strong>di</strong> <strong>un</strong>a scelta. Questo anche <strong>per</strong>ché, come<br />
vedremo nel prossimo paragrafo, gli impatti possono avere caratteristiche molto <strong>di</strong>verse<br />
tra loro. Chiaramente, inoltre, la bontà delle valutazioni che potranno essere effettuate<br />
<strong>di</strong>penderà da <strong>un</strong>a serie <strong>di</strong> fattori quali la <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> risorse finanziarie, umane ed in<br />
termini <strong>di</strong> tempo che si hanno a <strong>di</strong>sposizione <strong>per</strong> condurre lo stu<strong>di</strong>o, la <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong><br />
informazioni precise sulle con<strong>di</strong>zioni iniziali dell’ambiente in cui si prevede che si<br />
realizzi l’impatto, i modelli <strong>di</strong> simulazione/previsione o le informazioni su casi analoghi<br />
39 Da A. Scardera, <strong>Valutazione</strong> economica <strong>di</strong> tecniche colturali a <strong>di</strong>verso impatto ambientale, tesi <strong>di</strong><br />
laurea, Agraria, a.a. 1991-1992<br />
Pag. 28 <strong>di</strong> 148<br />
28
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
che si hanno a <strong>di</strong>sposizione. In ogni caso, come sarà maggiormente chiaro in seguito, il<br />
risultato della VIA (ed anche dello Stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> ad essa associato) 40<br />
sarà caratterizzato da <strong>un</strong> grado più o meno elevato <strong>di</strong> precisione/atten<strong>di</strong>bilità, oltre che<br />
<strong>di</strong>pendere dall' attribuzione <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> valore <strong>di</strong> natura soggettiva e <strong>di</strong>pendenti anche<br />
dalla <strong>per</strong>cezione e dal set <strong>di</strong> preferenza dei singoli in<strong>di</strong>vidui, che rende in<strong>di</strong>spensabile<br />
parlare <strong>di</strong> valutazione dell’impatto piuttosto che <strong>di</strong> misura dello stesso. A proposito<br />
della complessità dei problemi interessati da <strong>un</strong>a valutazione <strong>di</strong> impatto ambientale,<br />
«Schmidt <strong>di</strong> Friedberg (1991) evidenzia come le decisioni in campo ambientale tendano<br />
a essere impegnative, complesse (coinvolgono molte variabili ambientali interagenti<br />
che producono inarrestabili catene <strong>di</strong> retroazioni), “a geometria variabile” (possono<br />
variare enormemente le scale spaziali e temporali), articolate (molti soggetti sono<br />
coinvolti), ambigue (gli scenari futuri hanno sempre elevati margini <strong>di</strong> incertezza),<br />
<strong>di</strong>somogenee (vantaggi e svantaggi non si ripartiscono equamente sulla popolazione e<br />
sul territorio)» 41.<br />
Appare, quin<strong>di</strong>, evidente, che con la VIA si cercherà <strong>di</strong> prendere <strong>un</strong>a decisione che,<br />
con ragionevole sicurezza, rappresenti <strong>un</strong>a scelta sod<strong>di</strong>sfacente, anche se – <strong>per</strong> i<br />
problemi <strong>di</strong> valutazione precedentemente accennati – nel proce<strong>di</strong>mento stesso <strong>di</strong> VIA<br />
sono presenti elementi <strong>di</strong> soggettività e <strong>di</strong> incertezza che sono “controllabili”, ma non<br />
interamente eliminabili. Di conseguenza, sarà <strong>di</strong> importanza fondamentale che il<br />
processo <strong>di</strong> VIA sia trasparente e che sia ri<strong>per</strong>corribile, cioè che siano note le ipotesi e<br />
e le scelte effettuate – soprattutto nel caso in cui ci siano problemi <strong>di</strong> soggettivitià delle<br />
valutazioni/scelte – e che sia possibile ri<strong>per</strong>correre lo stesso proce<strong>di</strong>mento utilizzando<br />
ipotesi <strong>di</strong>verse, ad esempio riguardo al set <strong>di</strong> preferenze relative dei <strong>di</strong>versi obiettivi o<br />
ad ipotesi <strong>di</strong> impatti e/o scenari.<br />
Nel proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> VIA hanno <strong>un</strong> ruolo importante sia tecnici che politici ed<br />
amministratori, ma anche le regole che stabiliscono come tale proceduta deve essere<br />
attuata, in quanto sono tali regole che possono garantire/favorire il raggi<strong>un</strong>gimento <strong>di</strong> <strong>un</strong><br />
grado <strong>di</strong> oggettività e trasparenza sod<strong>di</strong>sfacente.<br />
40 Anche se a volte i due termini vengono confusi, in genere si usa la <strong>di</strong>zione “valutazione <strong>di</strong> impatto<br />
ambientale” <strong>per</strong> in<strong>di</strong>care l’intero proce<strong>di</strong>mento attraverso il quale si arriva ad <strong>un</strong> giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong><br />
compatibilità ambientale, ecc., mentre il termine “stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> impatto ambientale” viene attribuito alla<br />
fase <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o – eminentemente tecnico – che consente <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare, prevedere e valutare i possibili<br />
impatti sull’ambiente derivanti dalla realizzazione <strong>di</strong> <strong>un</strong>’o<strong>per</strong>a.<br />
41 citato in Malcevschi, da cui sono stralciate altre parti del seguente testo<br />
Pag. 29 <strong>di</strong> 148<br />
29
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
2.2. Le <strong>di</strong>verse tipologie <strong>di</strong> impatti e <strong>di</strong> risorse impattate<br />
Le <strong>di</strong>verse azioni elementari danno origine ad impatti che possono essere classificati<br />
a seconda delle loro caratteristiche in:<br />
Positivi o negativi. «Impatti negativi sono quelli a cui il soggetto valutante (in sede<br />
progettuale o in sede <strong>di</strong> decisione amministrativa) ha riconosciuto elementi <strong>di</strong><br />
indesiderabilità rispetto alle scale <strong>di</strong> qualità adottate; impatti positivi sono quelli<br />
che rispetto a tali scale presentano elementi <strong>di</strong> desiderabilità». 42 Esempi <strong>di</strong> impatti<br />
positivi sono: aumento del red<strong>di</strong>to, dell’occupazione, risanamento <strong>di</strong> <strong>un</strong>’area<br />
degradata; impatti negativi sono quelli legati, ad esempio, ad <strong>un</strong> aumento dei livelli<br />
<strong>di</strong> inquinamento, ad <strong>un</strong> degrado del paesaggio, ecc.<br />
Diretti(o primari) o in<strong>di</strong>retti (o secondari). «Impatti <strong>di</strong>retti sono le alterazioni che<br />
l’o<strong>per</strong>a induce sull’ambiente attraverso l’eliminazione <strong>di</strong> elementi preesistenti (ad<br />
esempio la vegetazione) o la produzione <strong>di</strong> interferenze <strong>di</strong>rette da parte <strong>di</strong> elementi<br />
dell’o<strong>per</strong>a (ad esempio il rumore). Impatti in<strong>di</strong>retti sono i cambiamenti provocati<br />
dall’o<strong>per</strong>a come risultante <strong>di</strong> <strong>un</strong> processo comprendente varie fasi. Ad esempio, la<br />
rimozione <strong>di</strong> vegetazione l<strong>un</strong>go le sponde (impatto primario) causa l’erosione<br />
accelerata delle sponde stesse, <strong>un</strong> eccesso <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti nel corpo idrico recettore,<br />
<strong>un</strong> aumento della torbi<strong>di</strong>tà dell’acqua, danni <strong>per</strong> l’ittiofa<strong>un</strong>a, riduzione della<br />
qualità del corpo idrico (impatti secondari). Impatti secondari sono da considerarsi<br />
anche le nuove attività sociali ed economiche stimolate o indotte dal progetto». 43 ;<br />
a breve o l<strong>un</strong>go termine. «Impatti a breve termine sono le alterazioni imme<strong>di</strong>ate e <strong>di</strong><br />
breve durata, relative <strong>di</strong> solito alla fase <strong>di</strong> costruzione dell’o<strong>per</strong>a e alla prima fase<br />
<strong>di</strong> esercizio. In genere hanno termine o vengono presto corretti nella fase <strong>di</strong><br />
esercizio dell’o<strong>per</strong>a stessa. Impatti a l<strong>un</strong>go termine sono le alterazioni che<br />
<strong>per</strong>durano oltre la fase <strong>di</strong> costruzione e <strong>di</strong> iniziale esercizio dell’o<strong>per</strong>a, o che<br />
derivano da croniche alterazioni dell’ambiente causate dall’o<strong>per</strong>a in fase <strong>di</strong><br />
esercizio (ad esempio la costruzione <strong>di</strong> <strong>un</strong>a <strong>di</strong>ga può causare impatti a l<strong>un</strong>go<br />
termine come l’arretramento delle coste marine in seguito al deposito dei se<strong>di</strong>menti<br />
fluviali del bacino artificiale)» 44<br />
42 Da Manuale della Regione Lombar<strong>di</strong>a (op. cit). Appen<strong>di</strong>ce I, Definizione dei termini adottati, (spesso<br />
in<strong>di</strong>cato sinteticamente come “Glossario”) p. 221<br />
43 Cfr. nota precedente<br />
44 Cfr note precedenti<br />
Pag. 30 <strong>di</strong> 148<br />
30
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
irreversibili o reversibili. «Impatti reversibili sono le alterazioni indotte dall’o<strong>per</strong>a<br />
che possono essere eliminate me<strong>di</strong>ante mitigazioni tecniche o processi naturali, in<br />
modo che lo stato originario possa essere ripristinato. Impatti irreversibili sono<br />
invece le mo<strong>di</strong>ficazioni definitive indotte dall’o<strong>per</strong>a, tali <strong>per</strong> cui lo stato originario<br />
non può essere ripristinato. Occorre ricordare che la reversibilità, dal p<strong>un</strong>to <strong>di</strong><br />
vista scientifico, si ha solo nel caso <strong>di</strong> sistemi isolati, e quin<strong>di</strong> non nei sistemi<br />
ambientali reali; è <strong>per</strong>tanto più opport<strong>un</strong>o far riferimento alla rinnovabilità delle<br />
componenti ambientali <strong>per</strong>turbate» 45 Nel caso che le alterazioni indotte vengano<br />
eliminate me<strong>di</strong>ante processi naturali si <strong>di</strong>ce che gli impatti sono reversibili<br />
spontaneamente, <strong>per</strong> <strong>di</strong>stinguerli dalle situazioni in cui la reversibilità è possibile<br />
solo con intervento dell’uomo. Ad esempio, la scomparsa <strong>di</strong> <strong>un</strong>a specie è <strong>un</strong> impatto<br />
irreversibile, nel senso che non sarà possibile “risuscitarla”, come pure è<br />
irreversibile la <strong>di</strong>struzione <strong>di</strong> <strong>un</strong> bene archeologico/culturale. Viceversa, <strong>un</strong> esempio<br />
<strong>di</strong> impatto reversibile spontaneamente potrebbe essere quello legato all’<br />
allontanamento <strong>di</strong> <strong>un</strong>a specie da <strong>un</strong>’area nella quale era presente in con<strong>di</strong>zioni non<br />
alterate, dovuto al <strong>di</strong>sturbo indotto dai rumori <strong>di</strong> <strong>un</strong> cantiere, nel caso in cui tale<br />
specie torni a <strong>di</strong>ffondersi <strong>di</strong> nuovo nell’area <strong>un</strong>a volta che la causa del <strong>di</strong>sturbo<br />
viene a cessare. Un esempio <strong>di</strong> impatto reversibile con intervento dell’uomo<br />
potrebbe essere legato a situazioni in cui, avendo dovuto provvedere <strong>per</strong> la<br />
realizzazione <strong>di</strong> <strong>un</strong>’o<strong>per</strong>a (ad esempio la costruzione <strong>di</strong> <strong>un</strong> metanodotto) alla<br />
rimozione della co<strong>per</strong>tura vegetale pre-esistente, si provvede a ripristinarla me<strong>di</strong>ante<br />
opport<strong>un</strong>e attività <strong>di</strong> semina o trapianto. I processi naturali che determinano la<br />
reversibilità <strong>di</strong> <strong>un</strong> impatto possono essere legati alle capacità omeostatiche<br />
dell’ambiente (cioè alla capacità <strong>di</strong> mantenere <strong>un</strong> equilibrio stabile nel tempo<br />
nonostante il variare delle con<strong>di</strong>zioni esterne) ed anche al grado <strong>di</strong> resilienza (cfr.<br />
parte successiva).<br />
locali o regionali o nazionali o globali nel senso che anche la scala alla quale si<br />
manifestano gli impatti può essere estremamente variabile: ad esempio l’impatto<br />
derivante da fonti <strong>di</strong> inquinamento acustico tenderà ad essere localizzato in<br />
prossimità delle fonti <strong>di</strong> emissione, mentre impatti derivanti dai fumi degli<br />
inse<strong>di</strong>amenti civili e industriali (ad esempio quelli che hanno dato luogo al<br />
fenomeno delle piogge acide) oppure l’immissione nell’ambiente <strong>di</strong> sostanze<br />
45 Cfr note precedenti<br />
Pag. 31 <strong>di</strong> 148<br />
31
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
inquinanti quali il D.D.T. (che è stato trovato anche nel grasso dei pinguini del polo,<br />
dove è arrivato attraverso fenomeni <strong>di</strong> bioaccumulo nella catena trofica 46 ) possono<br />
manifestarsi anche in aree relativamente lontane dalla sorgente <strong>di</strong> emissione o<br />
<strong>di</strong>ffondersi più o meno <strong>un</strong>iformemente a livello globale.<br />
Inizialmente la legislazione italiana sulla VIA si è focalizzata maggiormente sui tipi<br />
<strong>di</strong> impatti, considerando come criterio <strong>per</strong> decidere se sottoporre, o meno, <strong>un</strong> progetto a<br />
VIA soltanto il tipo <strong>di</strong> progetto. In altre parole, era la tipologia <strong>di</strong> “sorgente” a<br />
determinare, o meno, la necessità <strong>di</strong> sottoporre a VIA <strong>un</strong>’o<strong>per</strong>a, mentre veniva<br />
completamente trascurata la tipologia <strong>di</strong> ambiente in cui l’o<strong>per</strong>a andava ad inserirsi.<br />
Alc<strong>un</strong>e delle legislazioni a livello regionale hanno previsto, viceversa, fin dall’inizio,<br />
anche questo tipo <strong>di</strong> approccio 47 ed al momento attuale, come sarà più chiaro in seguito,<br />
alc<strong>un</strong>e fonti legislative a livello com<strong>un</strong>itario (ad esempio la cosidetta “<strong>di</strong>rettiva habitat”<br />
92/43/CEE del 21 maggio 1992) e nazionale (ad esempio l’Atto <strong>di</strong> In<strong>di</strong>rizzo e<br />
Coor<strong>di</strong>namento) prevedono che l’assoggettamento, o meno, <strong>di</strong> <strong>un</strong>’o<strong>per</strong>a a VIA <strong>di</strong>penda<br />
non solo dalla sua tipologia e <strong>di</strong>mensioni, ma anche dall’ambiente in cui viene ad essere<br />
localizzata.<br />
46 La catena trofica è quella che vede la successione <strong>di</strong> specie in termini <strong>di</strong> fonti/utilizzazioni <strong>di</strong> cibo. Un<br />
esempio semplificato potrebbe vedere in successione vegetali, animali erbivori (che si nutrono dei<br />
vegetali che costitiscono l’anello precedente della catena) che costituiscono a loro volta fonte <strong>di</strong><br />
nutrimento <strong>per</strong> animali carnivori, che a loro volta sono predati da altre specie carnivore (<strong>di</strong> secondo<br />
livello). In tale esempio l’animale carnivoro <strong>di</strong> primo livello costituisce <strong>un</strong> anello interme<strong>di</strong>o della<br />
catena trofica essendo <strong>un</strong> utilizzatore dell’anello precedente (animale erbivoro <strong>di</strong> cui si ciba), ma <strong>un</strong>a<br />
fonte <strong>di</strong> cibo <strong>per</strong> l’anello successivo (il predatore da cui, a sua volta, è mangiato). Nel caso del D.D.T.,<br />
questa sostanza si accumula nei grassi e si degrada solo molto lentamente: quin<strong>di</strong> man mano che si sale<br />
verso la parte più alta della catena trofica, il D.D.T. tenderà ad accumularsi (tesaurizzarsi) in quanto<br />
viene a concentrarsi in <strong>un</strong> in<strong>di</strong>viduo (carnivoro) tutto il D.D.T. che è stato ingerito dagli animali che lo<br />
precedono nella catena alimentare. Un esempio <strong>di</strong> tale processo sarà affrontato parlando degli standard<br />
<strong>di</strong> legge.<br />
47 Ad esempio la L.R. 7 settembre 1990, n. 43 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia<br />
“Or<strong>di</strong>namento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong>” all’art. 5<br />
(ambiti <strong>di</strong> applicazione) p<strong>un</strong>to b) recita: «sono sottoposti alla <strong>di</strong>sciplina della presente legge (…) i<br />
progetti delle o<strong>per</strong>e, e delle loro mo<strong>di</strong>fiche sostanziali, in<strong>di</strong>viduate secondo le categorie e le soglie <strong>di</strong><br />
cui all’art. 6, ovvero localizzate nelle aree sensibili come definite dall’art 7 (…)» stabilendo come<br />
criterio <strong>per</strong> sottoporre, o meno, <strong>un</strong>’o<strong>per</strong>a a <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> impatto ambientale non solo la tipologia <strong>di</strong><br />
progetto (categoria) e le sue caratteristiche in termini <strong>di</strong>mensionali (soglie), ma anche l’inclusione o<br />
meno in aree sensibili (in<strong>di</strong>pendentemente dalla categoria e dalle soglie). La stessa legge considera aree<br />
sensibili «quelle porzioni <strong>di</strong> territorio dove sia riscontrata la presenza <strong>di</strong> valori ambientali, <strong>un</strong>a<br />
particolare fragilità dell’equilibrio ecologico, ovvero <strong>un</strong>a rilevante concentrazione <strong>di</strong> attività ed<br />
inse<strong>di</strong>amenti che comportino già notevoli effetti sull’ambiente». Confronta queste in<strong>di</strong>cazioni alla luce<br />
delle definizioni <strong>di</strong> qualità ambientale dati nelle parti successive <strong>di</strong> questa <strong>di</strong>spensa e tratte dal<br />
Malcevschi.<br />
Pag. 32 <strong>di</strong> 148<br />
32
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
Le caratteristiche dell’ambiente impattato, infatti, influenzano l’importanza dell’<br />
impatto in relazione al fatto che esso vada a colpire risorse ambientali che sono:<br />
com<strong>un</strong>i o rare, nel senso che <strong>un</strong> impatto a carico <strong>di</strong> <strong>un</strong>a specie com<strong>un</strong>e o coltivata<br />
(al limite, la <strong>di</strong>struzione <strong>di</strong> <strong>un</strong> campo <strong>di</strong> grano) sarà molto meno importante <strong>di</strong> quello<br />
a carico <strong>di</strong> <strong>un</strong>a specie rara (al limite, la scomparsa <strong>di</strong> <strong>un</strong>a specie a rischio <strong>di</strong><br />
estinzione);<br />
riproducibili o rinnovabili, ad esempio, nel campo energetico, la produzione<br />
me<strong>di</strong>ante risorse rinnovabili (energia solare, eolica, geotermica, del moto ondoso,<br />
maremotrice, idraulica, biomassa, gas <strong>di</strong> <strong>di</strong>scarica, gas residuati dai processi <strong>di</strong><br />
depurazione e biogas) 48 ha <strong>un</strong> significato <strong>di</strong>verso rispetto alla produzione me<strong>di</strong>ante<br />
fonti non rinnovabili, quali il petrolio (o altri combustibili fossili), il quale – <strong>un</strong>a<br />
volta arrivato ad esaurimento – non è suscettibile <strong>di</strong> formarsi <strong>di</strong> nuovo in <strong>un</strong> arco <strong>di</strong><br />
tempo che sia significativo <strong>per</strong> l’uomo. Un esempio <strong>di</strong> riproducibilità potrebbe<br />
essere quello <strong>di</strong> <strong>un</strong>a costruzione (magari <strong>un</strong>a normale casa <strong>di</strong> abitazione, che può<br />
essere comodamente ricostruita) rispetto ad <strong>un</strong>’o<strong>per</strong>a d’arte quale la Gioconda o<br />
quale <strong>un</strong>a ceramica <strong>di</strong> Mastro Giorgio da Gubbio, il cui segreto rispetto ai colori che<br />
impiegava <strong>per</strong> ottenere particolari riflessi, non è ancora stato sco<strong>per</strong>to. Chiaramente,<br />
<strong>un</strong> impatto a carico <strong>di</strong> <strong>un</strong>a risorsa riproducibile o rinnovabile è – a parità <strong>di</strong> altre<br />
con<strong>di</strong>zioni – da considerarsi molto meno importante rispetto a quello <strong>di</strong> <strong>un</strong>a risorsa<br />
non rinnovabile o non riproducibile;<br />
strategiche o non strategiche <strong>per</strong> lo sviluppo della società, ad esempio risorse quali<br />
il petrolio, l’acqua, ecc. hanno <strong>un</strong>’importanza molto maggiore, al momento attuale,<br />
rispetto ad altre risorse <strong>per</strong> le quali non vi è necessità <strong>di</strong> impiego <strong>per</strong> processi<br />
fondamentali <strong>per</strong> lo sviluppo della società.<br />
Inoltre gli impatti, possono essere anche <strong>di</strong>stinti tra:<br />
probabili e certi, nel senso che a seguito della realizzazione <strong>di</strong> <strong>un</strong> impianto<br />
industriale (<strong>un</strong>a fabbrica) si avrà sicuramente sottrazione <strong>di</strong> suolo ad usi alternativi,<br />
sia agricoli che e<strong>di</strong>lizi, sia avrà <strong>un</strong> impatto visivo, ma non necessariamente si<br />
dovranno verificare impatti quali quelli dovuti ad <strong>un</strong>a fuga incontrollata <strong>di</strong> sostanze<br />
tossiche o ad <strong>un</strong>o scoppio dell’impianto stesso, fenomeni che si possono verificare<br />
con <strong>un</strong> determinato livello <strong>di</strong> probabilità (auspicabilmente molto ridotto), ma che<br />
48 Cfr. Dir. 2001/77/CE del 27 settembre 2001, art. 2a<br />
Pag. 33 <strong>di</strong> 148<br />
33
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
non necessariamente si verificano sempre. Questo comporta il problema della<br />
gestione del rischio, anche <strong>per</strong>ché la probabilità o il grado <strong>di</strong> incertezza legato ad <strong>un</strong><br />
determinato evento possono variare sensibilmente da caso a caso. Chiaramente, <strong>di</strong><br />
nuovo, a parità <strong>di</strong> altre caratteristiche, <strong>un</strong> impatto probabile avrà <strong>un</strong> significato (ed<br />
<strong>un</strong>’importanza) <strong>di</strong>versi da <strong>un</strong> impatto certo. Tra i problemi <strong>di</strong> scelta tra impatti<br />
probabili ed impatti certi potremmo citare ad esempio la scelta tra <strong>un</strong>a centrale<br />
nucleare (ambientalmente “più pulita” se non si verificano incidenti) ed <strong>un</strong>a centrale<br />
a carbone, meno soggetta ad effetti devastanti in caso <strong>di</strong> incidenti, ma che<br />
(soprattutto in passato) scarica nell’aria polveri suscettibili <strong>di</strong> dare problemi<br />
respiratori alle popolazioni che vivono nelle aree circostanti.<br />
«Secondo Lowrance (1980) il rischio è <strong>un</strong>a misura ponderata della probabilità e<br />
della <strong>di</strong>mensione (magnitudo) <strong>di</strong> eventi avversi.<br />
I termini che intervengono nella definizione del rischio sono molteplici: si può <strong>di</strong>re, in<br />
generale, che la <strong>di</strong>mensione <strong>di</strong> <strong>un</strong> rischio <strong>di</strong>pende:<br />
• dalla probabilità dell’evento in questione (quanto maggiore sarà la probabilità <strong>di</strong><br />
<strong>un</strong>a piena fluviale, tanto maggiore il rischio esistente),<br />
• dalle sue <strong>di</strong>mensioni (quanto maggiore la portata <strong>di</strong> piena, tanto maggiore il<br />
rischio),<br />
• dalla vulnerabilità dei bersagli (il rischio è maggiore se l’esondazione interessa <strong>un</strong><br />
centro abitato, minore se interessa <strong>un</strong> bosco <strong>di</strong> salici, che sono specie igrofile),<br />
• dalla <strong>per</strong>icolosità intrinseca della causa <strong>di</strong> pressione (il rischio è maggiore se<br />
l’acqua <strong>di</strong> piena ha sco<strong>per</strong>chiato <strong>un</strong>a <strong>di</strong>scarica incontrollata <strong>di</strong> rifiuti tossici),<br />
• dall’importanza del bersaglio (il rischio è maggiore se le case sono abitate in<br />
<strong>per</strong>manenza, minore se solo occasionalmente e in <strong>per</strong>io<strong>di</strong> in cui le piene non<br />
arrivano),<br />
• dalle <strong>di</strong>mensioni del bersaglio (il rischio è maggiore se l’allagamento riguarda 100<br />
<strong>per</strong>sone da sgomberare, minore se lo sgombero deve essere pre<strong>di</strong>sposto <strong>per</strong> 10<br />
<strong>per</strong>sone). » (cfr. Malcevschi pp. 13 e 14)<br />
Il problema del rischio deve essere legato a quello degli scenari, ad esempio nel caso<br />
precedente della piena, si deve tenere conto <strong>di</strong> tutti i fattori (variazioni climatiche, <strong>di</strong><br />
utilizzo del territorio, quali cementificazione degli argini, possibile <strong>di</strong>ffusione futura<br />
degli inse<strong>di</strong>amenti, ecc.) che influenzeranno l’evoluzione futura del rischio. Infatti non<br />
Pag. 34 <strong>di</strong> 148<br />
34
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
ha senso valutare il rischio solo nel momento presente, ma bisogna tener conto <strong>di</strong><br />
possibili evoluzioni o <strong>di</strong> eventi che si verificano soltanto spora<strong>di</strong>camente, ma che non<br />
sono esclu<strong>di</strong>bili. Ad esempio il <strong>di</strong>sastro del Vajont non fu causato dal fatto che non<br />
erano state adeguatamente previste le possibili ondate <strong>di</strong> piena che la <strong>di</strong>ga avrebbe<br />
dovuto sopportare, ma <strong>per</strong>ché tra gli scenari analizzati non era stato incluso (o preso in<br />
considerazione) quello <strong>di</strong> <strong>un</strong> <strong>di</strong>ssesto che portasse alla caduta nell’invaso <strong>di</strong> <strong>un</strong>a<br />
porzione della pen<strong>di</strong>ce sovrastante lo stesso.<br />
In base a quanto sopra esposto potremmo <strong>di</strong>re che la VIA dovrà recu<strong>per</strong>are anche<br />
elementi della Risk Analisys (cfr. Tabella 1). Tra l'altro, l'analisi dei rischi riveste <strong>un</strong>a<br />
notevole importanza in quanto soltanto avendo consapevolezza delle possibili<br />
conseguenze <strong>di</strong> catastrofi o malf<strong>un</strong>zionamenti si possono mettere a p<strong>un</strong>to adeguate<br />
misure <strong>per</strong> ridurre al massimo l'impatto causato dall'eventuale verificarsi dell'evento<br />
avverso. In altre parole, semplificando al massimo, se ho coscienza della possibilità che<br />
si sviluppi <strong>un</strong> incen<strong>di</strong>o, posso dotarmi <strong>di</strong> estintori e <strong>di</strong> scale antincen<strong>di</strong>o. Se non tengo<br />
presente questa probabilità <strong>per</strong> quanto remota e non mi preparo ad affrontarla, nel caso<br />
che questa si verifichi i danni saranno molto più elevati (ad esempio, se l'incen<strong>di</strong>o<br />
scoppia ed io non ho previsto né estintori né piano <strong>di</strong> evacuazione, rischio <strong>di</strong> avere non<br />
solo elevati danni, ma anche <strong>per</strong><strong>di</strong>te <strong>di</strong> vite umane che avrebbero potuto essere evitate).<br />
Come è intuitivo, non sempre è possibile arrivare ad <strong>un</strong>a determinazione<br />
quantitativa della probabilità <strong>di</strong> <strong>un</strong> impatto e della “grandezza” dello stesso, ma possono<br />
sussistere anche notevoli margini <strong>di</strong> incertezza. Inoltre, anche <strong>per</strong> quanto riguarda le<br />
<strong>di</strong>mensioni <strong>di</strong> impatti certi, a volte si è costretti a lavorare con informazioni <strong>di</strong> natura<br />
qualitativa, sia pure or<strong>di</strong>nabili. Una informazione <strong>di</strong> natura or<strong>di</strong>nabile è <strong>un</strong>a<br />
informazione che consente <strong>di</strong> or<strong>di</strong>nare dei “valori” dal meglio al peggio, senza <strong>per</strong>ò<br />
<strong>per</strong>mettere l’in<strong>di</strong>viduazione dei rapporti <strong>di</strong> grandezza degli stessi. Ad esempio, è<br />
possibile definire l’intensità <strong>di</strong> <strong>un</strong> impatto come lieve, me<strong>di</strong>a e forte: questo consente <strong>di</strong><br />
mettere in or<strong>di</strong>ne i casi dal meglio al peggio anche se non consente <strong>di</strong> <strong>di</strong>re quanto <strong>un</strong><br />
impatto forte sia più grande <strong>di</strong> <strong>un</strong> impatto me<strong>di</strong>o o quanto <strong>un</strong> impatto me<strong>di</strong>o sia più<br />
grande <strong>di</strong> <strong>un</strong> impatto lieve. Un altro esempio <strong>per</strong> far capire la potenzialità ed i limiti <strong>di</strong><br />
informazioni <strong>di</strong> natura or<strong>di</strong>nale, potrebbe essere quello <strong>di</strong> avere <strong>un</strong> gruppo <strong>di</strong> <strong>per</strong>sone da<br />
dover mettere in or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> altezza decrescente: non avendo <strong>un</strong>o strumento adeguato non<br />
sarà possibile misurare “a vista” la loro altezza esatta, ma confrontandoli sarà<br />
probabilmente possibile metterli in or<strong>di</strong>ne dal più alto al più basso senza sbagliare.<br />
Pag. 35 <strong>di</strong> 148<br />
35
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
Vedremo nella seconda parte del modulo come sia possibile, anche in presenza <strong>di</strong> dati <strong>di</strong><br />
natura or<strong>di</strong>nale, arrivare ad <strong>un</strong> giu<strong>di</strong>zio comparativo <strong>di</strong> merito tra più progetti alternativi<br />
rispetto ad <strong>un</strong>a pluralità <strong>di</strong> criteri.<br />
2.3. L’intensità o misura degli impatti<br />
Parlando <strong>di</strong> intensità dell’impatto è importante dare <strong>un</strong>a definizione <strong>di</strong> come possa<br />
essere misurato <strong>un</strong> impatto ambientale. Infatti abbiamo dato <strong>un</strong>a definizione dello stesso<br />
(cfr. figura 1), ma non abbiamo fornito in<strong>di</strong>cazioni su come esso vada misurato. Questo<br />
può essere fatto a partire dall’esame della Figura 3 (tratta dal Malcevschi e riportata nel<br />
Manuale della Regione Lombar<strong>di</strong>a) relativa al modello grafico della compatibilità<br />
ambientale.<br />
In tale grafico abbiamo sulle or<strong>di</strong>nate <strong>un</strong>a misura della qualità ambientale<br />
complessiva, mentre sulle ascisse abbiamo il tempo. Il p<strong>un</strong>to in alto a sinistra del<br />
grafico, corrispondente al vertice più alto del poligono ed al momento temporale A,<br />
in<strong>di</strong>vidua il momento iniziale, in assenza <strong>di</strong> <strong>un</strong> determinato intervento, in cui si<br />
presuppone <strong>di</strong> dover fare (e dar seguito al) la scelta se effettuare o non effettuare l’o<strong>per</strong>a<br />
in oggetto. Secondo il grafico <strong>di</strong> figura 3, se tale intervento verrà realizzato, il livello <strong>di</strong><br />
qualità ambientale verrà ad abbassarsi, prima in maniera relativamente rapida (primo<br />
tratto della spezzata <strong>di</strong>scendente), poi in maniera più lenta (secondo tratto della<br />
spezzata). In questo caso, potrebbe venire la tentazione <strong>di</strong> definire l’impatto ambientale<br />
come la <strong>di</strong>fferenza tra i valori <strong>di</strong> qualità ambientale che si verificano a seguito della<br />
realizzazione dell’intervento e quello che era il livello <strong>di</strong> qualità ambientale iniziale.<br />
Questo, in realtà, non è corretto in quanto, anche in assenza <strong>di</strong> realizzazione dell’<br />
intervento, non necessariamente la qualità ambientale rimarrà costante, ma potrà essere<br />
soggetta (come effettivamente accade sul grafico) ad <strong>un</strong> deterioramento più o meno<br />
contenuto (oppure ad <strong>un</strong> miglioramento). Quin<strong>di</strong> <strong>un</strong>a corretta stima dell’impatto<br />
ambientale può aversi solo paragonando la situazione in presenza <strong>di</strong> intervento alla<br />
situazione in assenza <strong>di</strong> intervento, ma utilizzando in entrambi i casi gli stessi<br />
riferimenti temporali.<br />
L’entità dell’impatto ambientale complessivo è data dall’area all’interno del<br />
poligono evidenziato sul grafico, che tiene conto non solo della <strong>di</strong>fferenza in termini <strong>di</strong><br />
qualità ambientale che si verifica alla fine dell’orizzonte temporale in<strong>di</strong>viduato, ma<br />
anche delle <strong>di</strong>fferenze nei <strong>per</strong>io<strong>di</strong> precedenti. Questo, in altre parole, significa che,<br />
andando a considerare – ad esempio – l’impatto della realizzazione <strong>di</strong> <strong>un</strong>a<br />
Pag. 36 <strong>di</strong> 148<br />
36
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
metropolitana, l’impatto non sarà dato soltanto dal cambiamento del livello <strong>di</strong> qualità<br />
ambientale tra presenza ed assenza della metropolitana, ma anche <strong>di</strong> tutti quegli impatti<br />
(rumori, polveri, problemi <strong>di</strong> circolazione, ecc.) che si verificheranno durante la fase <strong>di</strong><br />
realizzazione.<br />
Alta<br />
QUALITA’<br />
Q(x)<br />
Bassa<br />
Evoluzione senza intervento<br />
CONDIZIONI DI INACCETTABILITA’<br />
t(A) t(P)<br />
Figura 3 –Modello grafico della compatibilità ambientale<br />
(fig. 1.2 Malcevschi, fig. 6 del Manuale Regione Lombar<strong>di</strong>a)<br />
Legenda: «In or<strong>di</strong>nata vi è la scala che <strong>di</strong>stingue le situazioni <strong>di</strong> alta da quelle <strong>di</strong> bassa qualità<br />
ambientale. In ascissa si descrive l’arco <strong>di</strong> tempo entro cui <strong>un</strong> dato intervento (A) viene<br />
realizzato ed ha modo <strong>di</strong> mostrare i suoi effetti, <strong>di</strong>ciamo fino al momento t(P). L’intervento<br />
viene realizzato nel momento t(A); a partire da quel momento il livello <strong>di</strong> qualità ambientale<br />
iniziale si mo<strong>di</strong>fica ed evolve con <strong>un</strong> certo andamento. Per valutare gli effetti indotti<br />
dall’intervento occorre confrontare questo andamento con quello che si sarebbe avuto qualora<br />
l’intervento non fosse stato realizzato (la linea su<strong>per</strong>iore nella figura). La <strong>di</strong>fferenza tra le due<br />
linee (“evoluzione senza l’intervento” ed “evoluzione con l’intervento” esprime quantitativamente<br />
la stima dell’impatto sulla qualità ambientale provocato dall’intervento nell’<br />
intervallo <strong>di</strong> tempo compreso tr ail momento t(A) ed il momento t(P). Q(x) esprime <strong>un</strong>a soglia al<br />
<strong>di</strong> sotto della quale la qualità ambientale non è giu<strong>di</strong>cata accettabile. Qualora gli effetti<br />
preve<strong>di</strong>bili, espressi nel grafico della linea “evoluzione con intervento”, portino a livelli <strong>di</strong><br />
qualità inferiori alla soglia ideale Q(x), l’intervento in oggetto viene giu<strong>di</strong>cato ambientalmente<br />
incompatibile». (Malcevschi)<br />
Pag. 37 <strong>di</strong> 148<br />
tempo<br />
37
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
Facciamo notare come in Figura 3 sia in<strong>di</strong>cata anche <strong>un</strong>a linea - Q(x) - al <strong>di</strong> sotto<br />
della quale si hanno con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> inaccettabilità: questa potrebbe aiutare a definire la<br />
compatibilità ambientale, nel senso che si potrebbe utilizzare come criterio <strong>per</strong><br />
giu<strong>di</strong>care compatibile <strong>un</strong> intervento il fatto che determini <strong>un</strong>a qualità ambientale<br />
su<strong>per</strong>iore (intervento compatibile) od inferiore (intervento non compatibile) a quella<br />
in<strong>di</strong>viduata dalla soglia.<br />
E' importante notare come tale soglia <strong>di</strong> inaccettabilità non vada su<strong>per</strong>ata in ness<strong>un</strong><br />
momento temporale; in altre parole non è sufficiente che la qualità ambientale finale in<br />
presenza <strong>di</strong> intervento sia su<strong>per</strong>iore al livello minimo <strong>di</strong> accettabilità previsto: bisogna<br />
che questa con<strong>di</strong>zione sia stata rispettata durante tutto l'arco temporale preso in<br />
considerazione. Per fare <strong>un</strong> esempio potremmo <strong>di</strong>re che, anche se costruendo <strong>un</strong>a serie<br />
<strong>di</strong> metropolitane a Roma si potesse completamente risolvere il problema del traffico,<br />
tale intervento sarebbe <strong>di</strong>fficilmente accettato se <strong>per</strong> realizzarlo fosse necessario<br />
bloccare l'intero traffico veicolare (pubblico e privato) <strong>per</strong> venti anni. In altre parole,<br />
anche se la qualità ambientale a valle dell'intervento sarebbe più elevata sia della soglia<br />
minima <strong>di</strong> accettabilità prevista che della qualità ambientale attuale, durante il <strong>per</strong>iodo<br />
<strong>di</strong> cantiere si scenderebbe a livelli <strong>di</strong> qualità ambientale (dal p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista sociale)<br />
ritenuti non accettabili.<br />
Facciamo ora notare, ma lo riprenderemo in seguito in maggior dettaglio, come la<br />
determinazione dell’impatto possa essere fatta <strong>di</strong>rettamente (imputando all’alternativa<br />
che prevede la realizzazione dell’intervento dei valori che tengano conto delle<br />
<strong>di</strong>fferenze in termini <strong>di</strong> qualità ambientale rispetto alla situazione in assenza <strong>di</strong><br />
intervento) oppure in<strong>di</strong>rettamente, confrontando l’alternativa in presenza <strong>di</strong> intervento,<br />
caratterizzata dai suoi specifici valori in termini <strong>di</strong> qualità ambientale, con l’alternativa<br />
che prevede la non realizzazione dell’intervento, anch’essa caratterizzata da specifici<br />
valori in termini <strong>di</strong> livello <strong>di</strong> qualità ambientale.<br />
Per fare <strong>un</strong> esempio ipotetico, basato sul presupposto che l’impatto sia dovuto<br />
soltanto alla <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> qualità ambientale al momento finale, supponendo che la<br />
qualità iniziale dell’aria misurata in termini <strong>di</strong> concentrazione <strong>di</strong> SO2 sia pari a 10, che<br />
la situazione in presenza <strong>di</strong> intervento sia pari a 15 e quella in assenza (allo stesso<br />
riferimento temporale) sia pari a 8 (<strong>per</strong>ché si presuppone che si verifichi <strong>un</strong>a minor<br />
immissione <strong>di</strong> SO2 nell’aria dovuta alla sostituzione <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> riscaldamento<br />
obsoleti), la valutazione dell’entità dell’impatto ambientale può essere fatta <strong>di</strong>rettamente<br />
considerando la sola situazione <strong>di</strong> realizzazione dell’intervento (che avrà <strong>un</strong> valore <strong>di</strong><br />
Pag. 38 <strong>di</strong> 148<br />
38
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
impatto pari a 15 – 8 = 7) oppure in<strong>di</strong>rettamente, confrontando l’alternativa <strong>di</strong><br />
realizzazione <strong>di</strong> intervento (caratterizzata da <strong>un</strong> livello <strong>di</strong> concentrazione pari a 15) e<br />
quella <strong>di</strong> mancata realizzazione dell’intervento (caratterizzata da <strong>un</strong> livello <strong>di</strong><br />
concentrazione pari a 8). In ogni caso, com<strong>un</strong>que, essendo l’impatto la conseguenza <strong>di</strong><br />
<strong>un</strong>a interferenza sull’ambiente, la sua misura sarà data dalla <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> situazione in<br />
presenza ed assenza <strong>di</strong> interferenza, a parità <strong>di</strong> ogni altra con<strong>di</strong>zione, comprese le<br />
evoluzioni in atto.<br />
Il grafico <strong>di</strong> Figura 3, come abbiamo in precedenza accennato può servire anche ad<br />
introdurre il concetto <strong>di</strong> Compatibilità ambientale. Infatti, scopo <strong>di</strong> <strong>un</strong>a <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> a livello preventivo è <strong>di</strong> consentire soltanto azioni che siano<br />
“compatibili dal p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista ambientale”, in quanto prevenire effetti indesiderati è più<br />
facile che rimuoverli <strong>un</strong>a volta che si siano determinati. Come vedremo meglio in<br />
seguito l’introduzione della “compatibilità ambientale”, o meglio ancora del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong><br />
compatibilità ambientale, nell’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co italiano è avvenuta con<br />
l’istituzione del Ministero dell’Ambiente, nel 1986. Ma cosa si intende <strong>di</strong> preciso <strong>per</strong><br />
compatibilità ambientale?<br />
Secondo il Malcevschi (cfr. pag. 15) «Gli impatti che ci interessano sono il frutto <strong>di</strong><br />
azioni umane, quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> decisioni, <strong>di</strong> scelte, <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zi. Un intervento in progetto può<br />
produrre impatti che possono essere giu<strong>di</strong>cati accettabili oppure no. Una componente<br />
del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> accettabilità è il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> compatibilità ambientale: l’intervento in<br />
esame può essere giu<strong>di</strong>cato ambientalmente compatibile o incompatibile (e quin<strong>di</strong><br />
inaccettabile dal p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista ambientale) in f<strong>un</strong>zione dei livelli <strong>di</strong> criticità ambientale<br />
conseguenti ai suoi effetti».<br />
«In sintesi l’analisi della compatibilità degli interventi comporta:<br />
a) definizione dello stato attuale dell’ambiente rispetto ad <strong>un</strong>a scala <strong>di</strong> qualità;<br />
b) previsione dell’evoluzione che l’ambiente avrebbe in assenza dell’intervento;<br />
c) previsione dell’evoluzione che si avrebbe qualora l’intervento venisse<br />
effettivamente realizzato;<br />
d) stima degli impatti attribuibili all’intervento in progetto;<br />
e) valutazione degli impatti stimati, sulla base <strong>di</strong> opport<strong>un</strong>i criteri che definiscano le<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> accettabilità da parte <strong>di</strong> chi valuta»(cfr. Malcevschi, pag. 16)<br />
Pag. 39 <strong>di</strong> 148<br />
39
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
Un esame dettagliato <strong>di</strong> tali criteri sarà proposto dopo aver esaminato alc<strong>un</strong>i concetti<br />
fondamentali relativamente all’ambiente ed alla qualità ambientale. In questa sede ci<br />
preme com<strong>un</strong>que sottolineare come già il Malcevschi non delinei <strong>un</strong> criterio <strong>di</strong><br />
compatibilità ambientale <strong>un</strong>ivoco, nel senso che da <strong>un</strong>a parte parla <strong>di</strong> utilizzo come<br />
criterio decisionale dei «livelli <strong>di</strong> criticità ambientale conseguenti ai suoi effetti» (in<br />
altre parole, <strong>un</strong> progetto è considerato compatibile con l’ambiente se i livelli <strong>di</strong> criticità<br />
ambientale conseguenti ai suoi effetti sono tali da consentire <strong>di</strong> restare al <strong>di</strong> sopra <strong>di</strong> <strong>un</strong>a<br />
soglia <strong>di</strong> “accettabilità” o <strong>di</strong> “qualità ambientale <strong>di</strong> riferimento” prefissata,<br />
in<strong>di</strong>pendentemente dall’entità degli impatti determinati), mentre dall’altra parla <strong>di</strong><br />
«valutazione degli impatti stimati, sulla base <strong>di</strong> opport<strong>un</strong>i criteri che definiscano le<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> accettabilità da parte <strong>di</strong> chi valuta». In quest’ultimo caso sembra che il<br />
criterio guida debba essere quello <strong>di</strong> valutare l’entità degli impatti stimati, a carico delle<br />
<strong>di</strong>verse componenti ambientali (ed includendo, al limite, anche valutazioni relative agli<br />
impatti su componenti che fanno riferimento ad <strong>un</strong> concetto <strong>di</strong> ambiente in senso<br />
“allargato”, cioè comprendendo anche variabili maggiormente legate alla qualità della<br />
vita della popolazione in senso lato), tenendo conto <strong>di</strong> quelle che sono le opinioni<br />
soggettive <strong>di</strong> chi valuta relativamente ai giu<strong>di</strong>zi da esprimere rispetto ai criteri<br />
in<strong>di</strong>viduati. Vedremo in seguito come questi due approcci trovino effettivamente<br />
riscontro in due <strong>di</strong>versi criteri <strong>per</strong> il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> compatibilità ambientale (la ricettività<br />
ambientale ed il miglioramento compensativo), proposti sempre dal Malcevschi,<br />
insieme con altri, nel capitolo V del suo libro.<br />
In figura 3, come in precedenza accennato, il livello <strong>di</strong> compatibilità ambientale<br />
potrebbe essere definito dalla linea orizzontale al <strong>di</strong> sotto della quale le con<strong>di</strong>zioni<br />
vengono considerate inaccettabili. Ulteriori considerazioni possono essere fatte a partire<br />
da <strong>un</strong>a citazione del Manuale della Regione Lombar<strong>di</strong>a, che fornisce alc<strong>un</strong>e brevi<br />
in<strong>di</strong>cazioni su come la soglia Q(x) può essere definita. «Tale livello può essere definito<br />
in mo<strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenti: può rappresentare <strong>un</strong> livello al <strong>di</strong> sotto del quale si ritiene in sede<br />
tecnica che l’ambiente rischi il collasso; oppure può rappresentare <strong>un</strong> limite<br />
convenzionale <strong>di</strong> ricettività ambientale che si adotta ai fini delle valutazioni; oppure la<br />
soglia non è fissa, ma varia in f<strong>un</strong>zione dello stato iniziale (ad esempio si possono<br />
giu<strong>di</strong>care inaccettabili peggioramenti significativi dello stato iniziale)» 49 . Vedremo<br />
come tale definizione apra la porta alla necessità <strong>di</strong> definizione <strong>di</strong> ulteriori concetti<br />
49 Manuale della Regione Lombar<strong>di</strong>a, op. cit., p. 54<br />
Pag. 40 <strong>di</strong> 148<br />
40
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
(ricettività ambientale, criticità, che saranno descritti parlando della qualità ambientale)<br />
ed anche ad ulteriori criteri <strong>per</strong> il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> compatibilità ambientale (ad esempio,<br />
introducendo il criterio del peggioramento significativo, che sarà esaminato in <strong>un</strong>o<br />
specifico capitolo). Resta, quin<strong>di</strong>, il problema <strong>di</strong> come in<strong>di</strong>viduare <strong>un</strong>a soglia, magari<br />
mantenuta prudenzialmente bassa rispetto ai limiti <strong>di</strong> accettabilità in senso stretto <strong>per</strong><br />
tenere conto del principio <strong>di</strong> precauzione, che <strong>di</strong>scrimini tra situazioni ambientalmente<br />
compatibili, e non.<br />
2.4. Concetto <strong>di</strong> Ambiente<br />
Nella generalità dei casi, quando si parla <strong>di</strong> ambiente, <strong>per</strong> semplificazione, si tende a<br />
considerarlo come <strong>un</strong> insieme <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> compartimenti fisicamente <strong>di</strong>stinguibili, quali<br />
litosfera (ovvero la crosta terrestre comprensiva del suolo e, in parte, del sottosuolo)<br />
atmosfera (il manto gassoso che sovrasta la litosfera), idrosfera (le masse ed i flussi<br />
idrici che si aggi<strong>un</strong>gono ai compartimenti precedenti), biosfera (il complesso degli<br />
esseri viventi, dai gran<strong>di</strong> mammiferi ai micro-organismi costituenti <strong>un</strong>a pellicola<br />
invisibile formata anche dal suolo, che avvolge il globo terrestre), antroposfera<br />
(comprensiva dell’insieme degli esseri umani e delle o<strong>per</strong>e che essi hanno realizzato),<br />
sia pure in parte legati tra loro da <strong>un</strong> insieme <strong>di</strong> relazioni.<br />
Chi <strong>di</strong> voi ha già affrontato il <strong>corso</strong> <strong>di</strong> Risorse Naturali e dell’Ambiente ha avuto già<br />
modo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>are alc<strong>un</strong>e delle principali caratteristiche dei comparti ambientali, che<br />
sono stati definiti come sopra con la sola eccezione della sfera legata all’attività umana,<br />
che <strong>per</strong> il tipo <strong>di</strong> approccio del <strong>corso</strong>, era in quella sede stata “ristretta” alla tecnosfera.<br />
In questa sede non ci sarà la possibilità <strong>di</strong> affrontare <strong>di</strong> nuovo <strong>un</strong> esame – sia pure<br />
abbastanza su<strong>per</strong>ficiale – delle caratteristiche dei <strong>di</strong>versi comparti, ma riteniamo<br />
com<strong>un</strong>que in<strong>di</strong>spensabile che vengano acquisiti almeno <strong>un</strong>a serie <strong>di</strong> concetti base<br />
rispetto all’ambiente, soprattutto <strong>per</strong> chi non avesse sostenuto l’esame <strong>di</strong> Risorse<br />
Naturali e dell’Ambiente.<br />
Figura 4 - Schema generale dei gran<strong>di</strong> compartimenti ambientali, fornisce <strong>un</strong>a<br />
rappresentazione grafica semplificata dei <strong>di</strong>versi comparti ambientali e delle loro<br />
“relazioni”. Ogn<strong>un</strong>o dei compartimenti sopra in<strong>di</strong>viduati – rappresentato nel grafico da<br />
<strong>un</strong> cerchio - è in genere oggetto <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o da parte <strong>di</strong> <strong>di</strong>scipline specialistiche, con<br />
approcci, linguaggi e metodologie specifiche, che – come accennavamo sopra – non<br />
saremo in grado <strong>di</strong> affrontare in questa sede. Questo comporta il problema che spesso si<br />
Pag. 41 <strong>di</strong> 148<br />
41
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
tende a considerare l’ambiente come <strong>un</strong>a giustapposizione <strong>di</strong> settori, ogn<strong>un</strong>o affrontato<br />
singolarmente, nell’ambito <strong>di</strong> <strong>un</strong>a specifica <strong>di</strong>sciplina o gruppo <strong>di</strong> <strong>di</strong>scipline.<br />
Com<strong>un</strong>que, come mette in evidenza il Manuale della Regione Lombar<strong>di</strong>a (op. cit. p.<br />
50) «Un modello <strong>di</strong> questo tipo (rispetto al quale è facile rapportare le componenti<br />
precedentemente in<strong>di</strong>viduate) ha il vantaggio della semplicità concettuale, ma implica<br />
delimitazioni fisiche che nella realtà non ci sono: i vari compartimenti sono infatti<br />
fortemente compenetrati tra loro.<br />
La litosfera, l’idrosfera, l’atmosfera, la biosfera, l’antroposfera non possono essere<br />
completamente separate sul piano fisico: esseri viventi sono presenti nel suolo, nei<br />
sitemi acquatici, nell’aria; acqua e aria sono presenti negli interstizi del terreno nonché<br />
all’interno degli spazi abitati dall’uomo; scambi <strong>di</strong> materia avvengono continuamente<br />
tra i vari comparti (…).<br />
In <strong>un</strong> torrente alpino reale sono presenti contemporaneamente sia l’acqua che<br />
scorre, ai ai pesci che vi nuotano, sia i massi affioranti, sia le bolle <strong>di</strong> aria che rendono<br />
l’acqua bianca, sia le <strong>per</strong>sone che <strong>di</strong>scendono in kajak l<strong>un</strong>go le scie <strong>di</strong> acqua bianca».<br />
Figura 4 – Schema generale dei gran<strong>di</strong> compartimenti ambientali<br />
(fig. X.X Malcevschi, fig. 2 del Manuale Regione Lombar<strong>di</strong>a)<br />
Di conseguenza, se l’approccio rappresentato in figura 4 può costituire <strong>un</strong>a prima<br />
tappa, in quanto l’analisi <strong>di</strong> <strong>un</strong> particolare fenomeno può richiedere competenze<br />
specialistiche, è anche vero che non si può considerare l’ambiente come somma <strong>di</strong><br />
singole componenti, ciasc<strong>un</strong>a da analizzare singolarmente, ma che esso deve essere<br />
Pag. 42 <strong>di</strong> 148<br />
42
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
considerato come <strong>un</strong> sistema organico <strong>di</strong> relazioni da affrontare nella loro globalità 50 .<br />
Come afferma il Malcevschi (op. cit.) «il termine “ambiente” esprime il sistema <strong>di</strong><br />
relazioni che lega gli esseri viventi e il loro sviluppo (compreso l’uomo e la sua storia)<br />
alle matrici chimiche e fisiche in cui sono immersi. Ogni essere vivente, e più in<br />
generale ogni livello <strong>di</strong> organizzazione (cellula, organismo, com<strong>un</strong>ità, ecosistema,<br />
bioma, biosfera) ha <strong>un</strong> suo ambiente interno ed <strong>un</strong> suo ambiente esterno. Per quanto<br />
riguarda la V.I.A. i livelli <strong>di</strong> maggior interesse sono quelli che riguardano l’uomo e<br />
l’ecosistema». In altre parole, è importante collocare ciasc<strong>un</strong> pezzo <strong>di</strong> informazione<br />
specialistica in <strong>un</strong> quadro <strong>di</strong> riferimento com<strong>un</strong>e, sia pure semplificato.<br />
Come l’ambiente nel complesso è stato <strong>di</strong>viso in <strong>di</strong>versi comparti ambientali<br />
(idrosfera, atmosfera, ecc.), ciasc<strong>un</strong> comparto può essere a sua volta scomposto in <strong>un</strong>a<br />
serie <strong>di</strong> componenti <strong>di</strong> maggior dettaglio, quali acque sotterranee, acque su<strong>per</strong>ficiali<br />
(entrambe rientranti nell’idrosfera), suolo, sottosuolo (entrambe ricadenti nella<br />
litosfera), flora e vegetazione e fa<strong>un</strong>a (entrambi ricompresi nella biosfera, ecc.) a loro<br />
volta articolabili in sud<strong>di</strong>visioni più ristrette. Vedremo, in seguito, come questa<br />
“scomposizione dell’ambiente” in componenti via via più ristrette abbia <strong>un</strong> senso ai fini<br />
<strong>di</strong> organizzare l’analisi della qualità attuale dell’ambiente e <strong>di</strong> prevederne le eventuali<br />
variazioni. Infatti, come vedremo meglio in seguito, non è in genere possibile trovare <strong>un</strong><br />
parametro <strong>di</strong> qualità ambientale complessivo, ad esempio dell’aria, che sia <strong>di</strong>rettamente<br />
misurabile, ma la qualità dell’aria stessa va valutata dopo aver analizzato <strong>un</strong> pluralità <strong>di</strong><br />
parametri <strong>di</strong>versi, quali la presenza <strong>di</strong> sostanze nocive, la presenza <strong>di</strong> polveri sottili, le<br />
vibrazioni, ecc. Tornando sempre al Malcevschi (op.cit.) «Proce<strong>di</strong>mento metodologico<br />
corretto è d<strong>un</strong>que, affrontando <strong>un</strong>a questione ambientale, la successione <strong>di</strong> <strong>un</strong>a prima<br />
fase analitica (la scomposizione nelle <strong>di</strong>verse componenti) con <strong>un</strong>a successiva fase<br />
sintetica (il riconoscimento delle relazioni tra le componenti e delle proprietà specifiche<br />
del sistema). In ogni caso lo stu<strong>di</strong>o del complesso degli esseri viventi deve essere<br />
affrontato in <strong>un</strong> ambito in grado <strong>di</strong> integrarli».<br />
In genere, <strong>per</strong> quanto riguarda l’in<strong>di</strong>viduazione delle componenti ambientali, settori<br />
ed in<strong>di</strong>catori in cui articolare l’analisi degli impatti <strong>di</strong> <strong>un</strong>a determinata o<strong>per</strong>a, esistono<br />
delle norme <strong>di</strong> legge o delle linee guida che facilitano il compito <strong>di</strong> chi realizza lo stu<strong>di</strong>o<br />
<strong>di</strong> impatto ambientale. Di questo parleremo più <strong>di</strong>ffusamente in seguito.<br />
50 Con <strong>un</strong> esempio forse improprio, ma s<strong>per</strong>o chiarificatore, sarebbe come considerare <strong>un</strong> fabbricato<br />
come insieme <strong>di</strong> <strong>un</strong> certo numero <strong>di</strong> mattoni e <strong>di</strong> altri materiali, senza andare a considerare le modalità<br />
con cui questi concorrono a comporre <strong>un</strong> tutto e che fanno sì che – anche a parità <strong>di</strong> materiali utilizzati<br />
– si possano realizzare e<strong>di</strong>fici molto <strong>di</strong>versi.<br />
Pag. 43 <strong>di</strong> 148<br />
43
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
In questa sede ci preme, invece, far notare come – relativamente al grado <strong>di</strong><br />
dettaglio con il quale esaminare le <strong>di</strong>verse componenti ambientali – il Manuale della<br />
Regione Lombar<strong>di</strong>a (op. cit., p. 48) metta in guar<strong>di</strong>a dal rischio <strong>di</strong> de<strong>di</strong>care troppo<br />
tempo alla fase <strong>di</strong> analisi, se non si può de<strong>di</strong>care <strong>un</strong>o sforzo adeguato anche a quella <strong>di</strong><br />
sintesi. «L’analisi delle singole componenti non deve far <strong>di</strong>menticare <strong>un</strong> aspetto<br />
fondamentale: la scissione dell’ambiente in singole componenti deve costituire solo <strong>un</strong><br />
passaggio <strong>per</strong> <strong>un</strong>a ricomposizione sintetica del sistema complessivo. Un’analisi<br />
eccessivamente dettagliata delle singole componenti può far <strong>per</strong>dere <strong>di</strong> vista l’ambiente<br />
nel suo complesso, reale bersaglio degli impatti provocati da <strong>un</strong> intervento in progetto.<br />
E’ quin<strong>di</strong> necessario comprendere le varie componenti in quadri sintetici, capaci <strong>di</strong><br />
mostrarne in modo semplice le relazioni e <strong>di</strong> rendere conto del sistema ambientale<br />
complessivo». Questo è <strong>un</strong> in<strong>di</strong>rizzo che viene richiesto anche a livello o<strong>per</strong>ativo nella<br />
redazione degli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> impatto ambientale (SIA). Infatti le linee guida dell’ANPA e del<br />
Ministero dell’Ambiente 51 , a tale proposito mettono in evidenza come «E’<br />
assolutamente inutile fornire SIA <strong>di</strong> centinaia o migliaia <strong>di</strong> pagine laddove la maggior<br />
parte dello spazio è de<strong>di</strong>cata alla descrizione dei fenomeni <strong>di</strong> base o a riportare<br />
pe<strong>di</strong>ssequamente la normativa vigente, tutto materiale i cui contenuti si danno <strong>per</strong><br />
scontati e che appesantiscono inutilmente il SIA, rendendo più <strong>di</strong>fficoltoso il<br />
re<strong>per</strong>imento dell’informazione e dei dati veramente utili. Se si ritiene com<strong>un</strong>que<br />
f<strong>un</strong>zionale riportare <strong>un</strong>a descrizione dei fenomeni <strong>di</strong> base o dei modelli utilizzati (<strong>per</strong><br />
esempio relativamente alla <strong>di</strong>s<strong>per</strong>sione dei contaminanti e alle reazioni chimiche in<br />
atmosfera o in falda), questo può essere fatto in appen<strong>di</strong>ce raccogliendo <strong>di</strong>rettamente le<br />
referenze qualificate, senza <strong>per</strong>dere tempo ed energie a parafrasare cose già<br />
ampiamente riportate e consolidate nella letteratura specialistica. Analogamente, se si<br />
ritiene importante raccogliere tutta la normativa rilevante, questa può formare <strong>un</strong>’altra<br />
appen<strong>di</strong>ce. E’ opport<strong>un</strong>o che il rapporto principale sia snello 52 e fornito <strong>di</strong> tabelle e<br />
grafici che riportano l’informazione essenziale in relazione a situazione esistente,<br />
pressioni indotte dall’o<strong>per</strong>a, impatti e mitigazioni previste.»<br />
Un’ulteriore considerazione da fare relativamente al processo <strong>di</strong> sintesi delle<br />
informazioni relative agli effetti sull’ambiente è che le <strong>di</strong>verse componenti ambientali<br />
51<br />
A.N.P.A., Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (2001), Linee guida V.I.A., scaricabile<br />
da rete<br />
52<br />
«Per progetti non particolarmente complessi, <strong>un</strong> rapporto principale intorno alle 50 pagine sembra<br />
essere adeguato, mentre <strong>per</strong> progetti più complessi si può arrivare a 100 pagine. Su<strong>per</strong>are le 150 pagine<br />
significa rendere complicata la lettura e l’assimilazione dei contenuti del SIA» p. 58<br />
Pag. 44 <strong>di</strong> 148<br />
44
Componenti ambientali<br />
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
possono essere lette – a seconda delle specifiche relazioni analizzate – in sistemi<br />
ambientali <strong>di</strong>versi che possono essere considerate sulla base <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse chiavi<br />
interpretative, quali l’ecosistema, il paesaggio, il territorio, attraverso le quali si possono<br />
stu<strong>di</strong>are gli impatti su <strong>un</strong> sistema ambientale complessivo.<br />
MODIFICHE<br />
FATTORI FISICI<br />
(rumori, ra<strong>di</strong>azioni, ecc.)<br />
Azioni <strong>di</strong> progetto<br />
INGOMBRI<br />
CONSUMI<br />
Aria<br />
RICHIAMI<br />
EMISSIONI<br />
Acque su<strong>per</strong>ficiali<br />
Acque sotterranee<br />
Suolo<br />
Sottosuolo<br />
Flora e<br />
vegetazione<br />
Fa<strong>un</strong>a<br />
Popolazione<br />
Figura 5 – Rapporti tra componenti ambientali, fattori <strong>di</strong> interferenza, sistemi ambientali<br />
(fig. X.X Malcevschi, fig. 4 del Manuale Regione Lombar<strong>di</strong>a)<br />
Ad esempio suolo, acque su<strong>per</strong>ficiali, flora e o<strong>per</strong>e dell’uomo possono essere rilette<br />
in termini <strong>di</strong> sistema paesaggistico, oppure le interazioni tra flora, fa<strong>un</strong>a e componente<br />
abiotica possono essere rilette in chiave ecosistemica, ecc., come in<strong>di</strong>cato in figura 5.<br />
Chiaramente, a seconda della chiave interpretativa utilizzata <strong>per</strong> analizzare il sistema<br />
ambientale, i parametri <strong>di</strong> qualità richiesti <strong>per</strong> <strong>un</strong>a determinata componente ambientale<br />
Pag. 45 <strong>di</strong> 148<br />
ECOSISTEMA<br />
PAESAGGIO<br />
TERRITORIO<br />
SISTEMA SANITARIO E SOCIALE<br />
SISTEMA ECONOMICO<br />
45
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
potranno variare sensibilmente, ad esempio il giu<strong>di</strong>zio sulla qualità <strong>di</strong> determinate acque<br />
su<strong>per</strong>ficiali vista in relazione alla qualità degli ecosistemi, ai problemi <strong>di</strong> natura<br />
sanitaria della popolazione o all’uso irriguo nelle attività agricole potrà essere anche<br />
sensibilmente <strong>di</strong>verso.<br />
A tal proposito è interessante notare che «<strong>un</strong>a sottile <strong>di</strong>stinzione concettuale è quella<br />
tra le “componenti”, ovvero gli elementi costitutivi, ed i “fattori”, ovvero quegli<br />
elementi che costituiscono causa <strong>di</strong> interferenza e <strong>di</strong> possibile <strong>per</strong>turbazione nei<br />
confronti delle altre componenti ambientali. In realtà tutte le componenti ambientali<br />
costituiscono anche <strong>un</strong> fattore <strong>di</strong> interferenza più o meno significativo nei confronti<br />
delle altre componenti. Ad esempio, l’acqua è <strong>un</strong>a componente dell’ambiente, ma è<br />
anche <strong>un</strong> fattore che modella la su<strong>per</strong>ficie terrestre; il rumore è <strong>un</strong> fattore <strong>di</strong><br />
interferenza in grado <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare il comportamento <strong>di</strong> <strong>per</strong>sone presenti, ma<br />
costituisce anche <strong>un</strong> “ambiente sonoro” che può essere considerato <strong>un</strong>a componente<br />
dell’ambiente complessivo: le singole sostanze chimiche sono al contempo elementi<br />
costitutivi e fattori <strong>di</strong> <strong>per</strong>turbazione nei confronti delle <strong>un</strong>ità ambientali esistenti.» (da<br />
Manuale della Regione Lombar<strong>di</strong>a, pp. 47-48).<br />
La parte seguente, ampliamente stralciata dal capitolo 2 del testo del Malcevschi<br />
(op. cit.), è volta a dare alc<strong>un</strong>e fondamentali definizioni relativamente a termini, quali<br />
“ecosistema”, “territorio”, “paesaggio”, “natura”, “habitat”, che rappresentano sia<br />
concetti molto vicini a quello <strong>di</strong> ambiente, e che possono anche costituire esempi <strong>di</strong><br />
sistemi ambientali, come in<strong>di</strong>cato in figura 5 <strong>per</strong> ecosistema, paesaggio e territorio.<br />
Inoltre, è importante avere chiaro il significato <strong>di</strong> vari concetti (ad esempio quello <strong>di</strong><br />
habitat) in quanto esso si ritrova anche in molte normative che riguardano la tutela<br />
dell’ambiente in generale e la valutazione dell’impatto ambientale in particolare.<br />
Habitat<br />
Esistono numerosi termini utilizzati spesso come sinonimo <strong>di</strong> “ambiente”, ciasc<strong>un</strong>o<br />
dei quali riflette <strong>per</strong>altro <strong>un</strong> concetto particolare. Il concetto <strong>di</strong> “habitat” esprime la<br />
posizione <strong>di</strong> <strong>un</strong>a certa specie (quin<strong>di</strong> anche dell’uomo) all’interno del contesto<br />
ambientale in cui vive e si riproduce.<br />
Nell’accezione precedente il termine “habitat” viene usato specificamente <strong>per</strong><br />
rappresentare lo spazio fisico occupato dalla specie considerata; in tal senso l’habitat<br />
corrisponde ad <strong>un</strong>a “nicchia spaziale” all’interno dell’ambiente. In tale accezione, è<br />
possibile delimitare fisicamente <strong>un</strong>a porzione <strong>di</strong> spazio in cui la specie trova le<br />
Pag. 46 <strong>di</strong> 148<br />
46
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>per</strong> vivere e <strong>per</strong> riprodursi. Tale accezione può in realtà essere estesa in<br />
modo da rappresentare il complesso delle esigenze ambientali (in aggi<strong>un</strong>ta a quelle<br />
spaziali, quin<strong>di</strong> anche microclimatiche, relative all’ambiente chimico, ecc.)<br />
dell’organismo considerato; in tal caso il concetto <strong>di</strong> nicchia spaziale si amplia a<br />
quello <strong>di</strong> “nicchia ecologica”. Se si accetta la definizione <strong>di</strong> nicchia ecologica come<br />
“stile <strong>di</strong> vita” della specie, si può capire come, in questa accezione, <strong>un</strong>o stesso spazio<br />
fisico può dare “ospitalità” a più specie <strong>di</strong>verse, purché gli stili <strong>di</strong> vita siano tali da<br />
<strong>per</strong>mettere <strong>un</strong>a loro convivenza (<strong>di</strong>verse abitu<strong>di</strong>ni alimentari, ecc.).<br />
Ogni ambiente può essere analizzato in termini <strong>di</strong> habitat. Una corretta analisi <strong>di</strong><br />
<strong>un</strong> dato ambiente deve d<strong>un</strong>que analizzare gli habitat delle specie presenti (almeno <strong>di</strong><br />
quelle più significative). Infatti, impatti che portino a delle mo<strong>di</strong>ficazioni significative <strong>di</strong><br />
tali habitat possono portare anche alla scomparsa (<strong>per</strong> “migrazione” o <strong>per</strong> “estinzione”)<br />
delle specie che erano solite abitarvi prima che si verificassero le alterazioni. Da questo<br />
p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista, bisogna sempre controllare che nello spazio fisico che è suscettibile <strong>di</strong><br />
essere alterato da <strong>un</strong> intervento non esistano habitat o specie che sono inclusi in liste che<br />
ne prevedano la conservazione <strong>per</strong> le loro peculiari caratteristiche <strong>di</strong> pregio.<br />
A tal proposito citiamo, tra le altre, la <strong>di</strong>rettiva Habitat 92/43/CEE che si occupa<br />
della conservazione degli “habitat naturali”, definiti all’art.2b come «zone terrestri o<br />
acquatiche che si <strong>di</strong>stinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e<br />
biotiche, interamente naturali o seminaturali» ed il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357,<br />
relativo alla conservazione degli habitat naturali <strong>di</strong> interesse com<strong>un</strong>itario, cioè «gli<br />
habitat naturali, in<strong>di</strong>cati nell'allegato A, che, nel territorio dell'Unione europea,<br />
alternativamente: 1) rischiano <strong>di</strong> scomparire nella loro area <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione naturale;<br />
2) hanno <strong>un</strong>'area <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o <strong>per</strong><br />
il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta; 3) costituiscono esempi notevoli <strong>di</strong><br />
caratteristiche tipiche <strong>di</strong> <strong>un</strong>a o più delle cinque regioni biogeografiche seguenti: alpina,<br />
atlantica, continentale, macaronesica e me<strong>di</strong>terranea» (art. 2.c)<br />
Da notare come ad <strong>un</strong>a specie non debba essere associato <strong>un</strong> solo habitat, in quanto<br />
la stessa potrebbe avere abitu<strong>di</strong>ni migratorie, <strong>per</strong> cui svolge fasi <strong>di</strong>verse del proprio<br />
ciclo vitale in habitat <strong>di</strong>versi (<strong>un</strong> esempio è quello delle specie che cambiano habitat al<br />
momento della riproduzione). Nel caso <strong>di</strong> <strong>un</strong>a specie protetta o a rischio <strong>di</strong> estinzione,<br />
quin<strong>di</strong>, non tutti gli habitat in cui si trova a vivere avranno <strong>un</strong>a stessa importanza, ma<br />
questa <strong>di</strong>penderà dalla <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> tali habitat e dall’importanza delle f<strong>un</strong>zioni che vi<br />
Pag. 47 <strong>di</strong> 148<br />
47
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
vengono svolte, oltre che dalla vulnerabilità della specie nel particolare momento del<br />
ciclo in cui si trova a vivere nell’habitat in questione.<br />
Ai fini della trattazione generale dei problemi dell’ambiente, è evidentemente <strong>di</strong><br />
interesse primario l’habitat dell’uomo; esso è lo specifico oggetto <strong>di</strong> numerose<br />
<strong>di</strong>scipline; anche buona parte degli stu<strong>di</strong> sull’inquinamento ambientale finora condotti<br />
si collocano in questo contesto. Non bisogna <strong>di</strong>menticarsi, infatti, che la valutazione<br />
dell’impatto ambientale, pur tendendo a conservare l’ambiente e a <strong>di</strong>fenderlo dalle<br />
alterazioni determinate da attività antropiche, è com<strong>un</strong>que derivata da <strong>un</strong> interesse<br />
dell’uomo <strong>per</strong> l’ambiente in cui vive, interesse che non è assolutamente neutrale.<br />
Ecosistema<br />
Mentre l’habitat rappresenta l’ambiente riferito ad <strong>un</strong> dato organismo (ad esempio<br />
<strong>un</strong>a singola specie), l’ecosistema rappresenta l’insieme degli organismi e dei fattori<br />
abiotici che sono presenti in <strong>un</strong> certo spazio fisico, nonché l’insieme delle relazioni che<br />
li legano a dei processi <strong>di</strong>namici a cui sono soggetti.<br />
Il D.P.C.M. 27.12.1988 che definisce le norme attuative <strong>per</strong> la realizzazione delle<br />
valutazioni <strong>di</strong> impatto ambientale a livello nazionale definisce l’ecosistema come <strong>un</strong><br />
«complesso <strong>di</strong> componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed<br />
inter<strong>di</strong>pendenti, che formano <strong>un</strong> sistema <strong>un</strong>itario e identificabile (quali <strong>un</strong> lago, <strong>un</strong><br />
bosco, <strong>un</strong> fiume, il mare) <strong>per</strong> propria struttura, f<strong>un</strong>zionamento ed evoluzione<br />
temporale» (All.I, lettera e). In <strong>un</strong>’ecosistema sono presenti produttori primari,<br />
consumatori <strong>di</strong> vario livello e decompositori, in grado <strong>di</strong> assicurare il ciclo dei <strong>di</strong>versi<br />
elementi (azoto, fosforo, ecc.). Essi possono essere caratterizzati da <strong>un</strong> grado <strong>di</strong><br />
complessità più o meno elevato. In genere sono i cosidetti “agro-ecosistemi”, cioè gli<br />
ecosistemi creati dall’uomo con l’attività agricola e forestale, a mostrare il maggior<br />
grado <strong>di</strong> semplificazione in quanto l’uomo non è interessato a tutte le specie che si<br />
troverebbero ad interagire in <strong>un</strong> ecosistema più simile ad <strong>un</strong>o naturale, ma tende a<br />
spingere soltanto le specie che sono in grado <strong>di</strong> assicurargli <strong>un</strong>a produzione. Quin<strong>di</strong>, ad<br />
esempio, invece <strong>di</strong> avere <strong>un</strong>a pluralità <strong>di</strong> specie vegetali quali quelle che si hanno con in<br />
situazioni naturali, tenderà a far crescere solo le proprie colture e ad eliminare con<br />
<strong>di</strong>versi mezzi (chimici, meccanici, agronomici) tutte le altre specie, che ritiene infestanti<br />
e dannose. In genere gli ecosistemi così semplificati sono relativamente più instabili <strong>di</strong><br />
quelli complessi in quanto alla complessa rete alimentare e <strong>di</strong> interazione che<br />
caratterizza <strong>un</strong> ecosistema naturale si sostituisce <strong>un</strong>a situazione in cui alc<strong>un</strong>i anelli<br />
Pag. 48 <strong>di</strong> 148<br />
48
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
possono <strong>di</strong>ventare <strong>di</strong> fondamentale importanza od altri venire a mancare, con<br />
conseguenti squilibri. Ad esempio, <strong>un</strong> uso in<strong>di</strong>scriminato degli insettici<strong>di</strong> porterà non<br />
soltanto alla scomparsa degli insetti dannosi <strong>per</strong> le colture, ma anche degli insetti<br />
predatori che in genere ne controllano la popolazione, impedendo che <strong>di</strong>venti troppo<br />
numerosa. Se sopravvivono alc<strong>un</strong>i insetti dannosi (o arrivano da altre zone) in <strong>un</strong>a<br />
situazione <strong>di</strong> assenza <strong>di</strong> predatori, si possono avere anche delle “esplosioni” delle loro<br />
popolazioni, che non trovano più <strong>un</strong> freno se non nella mancanza <strong>di</strong> cibo (e se questo è<br />
costituito dalle piante coltivate, in genere risulta abbondante e concentrato in spazi<br />
ridotti, <strong>per</strong> cui è facile da re<strong>per</strong>ire) 53 .<br />
In genere, date le con<strong>di</strong>zioni abiotiche in cui l’ecosistema si sviluppa, esso tenderà<br />
verso <strong>un</strong>a con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> stabilità suscettibile <strong>di</strong> rimanere relativamente costante nel<br />
tempo, in assenza <strong>di</strong> alterazioni <strong>di</strong> rilievo <strong>per</strong> effetti esterni. Così <strong>un</strong> campo lasciato a se<br />
stesso, potrebbe evolversi ospitando in <strong>un</strong> primo momento <strong>un</strong>a co<strong>per</strong>tura vegetale<br />
sempre più variata, poi potrebbero cominciare a comparire cespugli ed infine essenze<br />
arboree, fino alla formazione <strong>di</strong> <strong>un</strong> bosco, che potrebbe <strong>per</strong>durare anche a l<strong>un</strong>go nel<br />
tempo in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> relativa stabilità, se non si verificano eventi esterni che ne<br />
alterino l’equilibrio, eventi non necessariamente <strong>di</strong> natura antropica (ad esempio <strong>un</strong><br />
fulmine durante il temporale potrebbe incen<strong>di</strong>are il bosco e <strong>di</strong>struggerlo, <strong>per</strong> cui il ciclo<br />
potrebbe ricominciare <strong>di</strong> nuovo dall’inizio) 54 .<br />
Analizzare gli ecosistemi significa riconoscere e stu<strong>di</strong>are le proprietà emergenti del<br />
sistema rispetto a quelle delle sue singole componenti. Una caratteristica particolar-<br />
53 Una giustificazione dell’esistenza dei predatori, che nutrendosi <strong>di</strong> animali invece che <strong>di</strong> vegetali<br />
risultano componenti degli ecosistemi relativamente costosi, potrebbe essere proprio quella legata alla<br />
loro f<strong>un</strong>zione in termini <strong>di</strong> controllo a “feedback” (o retroazione) della popolazione degli erbivori. In<br />
altre parole, se la popolazione <strong>di</strong> erbivori aumentasse oltre la densità ottimale, l’abbondanza <strong>di</strong> cibo<br />
porterebbe ad <strong>un</strong> aumento del numero dei predatori, che a sua volta avrebbe l’effetto <strong>di</strong> riportare la<br />
popolazione <strong>di</strong> erbivori a livelli ottimali. Come conseguenza della <strong>di</strong>minuzione degli erbivori, anche la<br />
popolazione dei predatori tornerebbe nel tempo su livelli più bassi, <strong>per</strong> <strong>un</strong> rientro della <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong><br />
“cibo” su livelli “normali”. Cfr, a tal proposito E. Odum (1994), Ecologia <strong>per</strong> il nostro ambiente<br />
minacciato, Piccin, p. 75<br />
54 «Le com<strong>un</strong>ità biotiche subiscono <strong>un</strong> processo <strong>di</strong> sviluppo che va dalla giovinezza alla maturità,<br />
analogo alla crescita e allo sviluppo <strong>di</strong> <strong>un</strong> organismo (…) Lo sviluppo delle com<strong>un</strong>ità a breve termine<br />
(1000 anni o meno) è conosciuto come successione ecologica, ma è forse meglio rappresentata dal<br />
termine sviluppo dell’ecosistema <strong>per</strong>ché è <strong>un</strong> processo attivo che comprende cambiamenti sia negli<br />
organismi che nell’ambiente fisico. (…) esistono modelli definiti in questi cambiamenti che, in assenza<br />
<strong>di</strong> gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbi, sono preve<strong>di</strong>bili. Quando <strong>un</strong>’area <strong>di</strong>venta <strong>di</strong>sponibile <strong>per</strong> lo sviluppo <strong>di</strong> <strong>un</strong>a<br />
com<strong>un</strong>ità (come, <strong>per</strong> esempio, quando <strong>un</strong> campo coltivato viene abbandonato e lasciato risviluppare in<br />
modo naturale), le piante e gli animali opport<strong>un</strong>isti la colonizzano in <strong>un</strong>a serie <strong>di</strong> com<strong>un</strong>ità<br />
temporanee, o pionieristiche, chiamate sta<strong>di</strong> serali. Gradualmente, si sviluppano delle com<strong>un</strong>ità<br />
sempre più stabili finché si instaura <strong>un</strong>o sta<strong>di</strong>o climax o maturo che è in equilibrio con (cioè<br />
determinato da) il clima della regione e il substrato locale, la topografia, e le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà» da<br />
E. Odum (1994), Ecologia <strong>per</strong> il nostro ambiente minacciato, Piccin, p. 185<br />
Pag. 49 <strong>di</strong> 148<br />
49
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
mente importante a livello <strong>di</strong> sistema è data dalla natura dei flussi <strong>di</strong> energia e <strong>di</strong><br />
materia che attraversano l’ambiente. A tale proposito, può essere interessante<br />
esaminare la seguente citazione, presa dall’Odum 55 : «L’energia fluisce dal sole o da<br />
altre fonti esterne, attraversa la com<strong>un</strong>ità biotica e la relativa rete alimentare, ed esce<br />
dall’ecosistema sotto forma <strong>di</strong> calore, materia organica, ed organismi prodotti nel<br />
sistema. Anche se l’energia può essere immagazzinata ed utilizzata in <strong>un</strong> secondo<br />
tempo, il flusso <strong>di</strong> energia è a senso <strong>un</strong>ico, nel senso che <strong>un</strong>a volta che l’energia è stata<br />
utilizzata, cioè convertita da <strong>un</strong> tipo in <strong>un</strong> altro (dalla luce solare al cibo, <strong>per</strong> esempio),<br />
non può più essere riutilizzata; se la produzione <strong>di</strong> cibo deve continuare, allora la luce<br />
solare deve continuamente fluire in entrata. (…) Al contrario, i materiali chimici –<br />
elementi e composti – possono essere usati e riutilizzati senza <strong>per</strong><strong>di</strong>ta <strong>di</strong> profitto. In <strong>un</strong><br />
ecosistema ben or<strong>di</strong>nato molti <strong>di</strong> questi materiali camminano aventi e in<strong>di</strong>etro fra le<br />
componenti biotica ed abiotica in <strong>un</strong> <strong>per</strong><strong>corso</strong> ciclico.» Chiaramente, se questa è la<br />
situazione che caratterizza gli ecosistemi naturali, gli ecosistemi artificiali legati alla<br />
presenza dell’uomo presentano caratteristiche abbastanza <strong>di</strong>verse, che si sono<br />
evidenziate man mano che nel tempo, con l’ausilio delle tecnologie, l’uomo si è<br />
allontanato da <strong>un</strong>o stile <strong>di</strong> vita relativamente “naturale”. Al momento attuale potremmo<br />
<strong>di</strong>re che l’attività umana – a <strong>di</strong>fferenza da quanto si verifica negli ecosistemi naturali – è<br />
legata ad <strong>un</strong> consumo molto elevato <strong>di</strong> risorse che non sempre riescono a rientrare nei<br />
cicli e ad essere riutilizzate, oltre alla produzione <strong>di</strong> sostanze artificiali tossiche,<br />
anch’esse <strong>di</strong>fficilmente gestibili. Per quanto riguarda l’energia, la società moderna ne<br />
prevede <strong>un</strong> utilizzo sempre crescente, <strong>per</strong> cui – assieme all’energia che proviene dal<br />
sole – l’uomo è costretto ad utilizzare altre tecnologie, non sempre “pulite”, come quelle<br />
che prevedono il consumo <strong>di</strong> carburanti fossili o l’utilizzo dell’energia nucleare. A tal<br />
proposito, può essere interessante riportare <strong>un</strong>o stralcio da Vismara 56 , che descrive tre<br />
scenari estremi della storia dell’uomo. «Il primo scenario è relativo all’uomo<br />
preistorico, <strong>un</strong> cacciatore le cui esigenze energetiche erano <strong>un</strong>icamente quelle<br />
nutrizionali, almeno finché non scoprì il fuoco <strong>per</strong> cucinare e scaldarsi. Questo<br />
cacciatore aveva bisogno <strong>di</strong> <strong>un</strong> livello <strong>di</strong> nutrimento equivalente a 100 W/giorno, che<br />
otteneva da cacciagione, ra<strong>di</strong>ci e frutti non coltivati, o<strong>per</strong>ando su <strong>un</strong> territorio minimo<br />
<strong>di</strong> 60.000 m 2 . Il secondo scenari, corrispondente all’uomo agricoltore primitivo, <strong>un</strong><br />
55 E. Odum (1994), Ecologia <strong>per</strong> il nostro ambiente minacciato, Piccin, p. 46<br />
56 Vismara, R. (2001), Protezione ambientale. Criteri e tecniche <strong>per</strong> la pianificazione territoriale, Gruppo<br />
E<strong>di</strong>toriale Esselibri – Simone, pp. 17-18<br />
Pag. 50 <strong>di</strong> 148<br />
50
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
ruolo largamente riscontrabile anche oggi in molte zone povere del pianeta, vede<br />
sempre <strong>un</strong> fabbisogno nutrizionale <strong>di</strong> 100W/giorno, che ottiene soprattutto dai vegetali<br />
che coltiva (riso, soia, mais etc.). Gli animali non si allevano <strong>per</strong> mangiarli, ma <strong>per</strong><br />
utilizzarli come energia meccanica agricola (muovere aratri, trainare carri) e <strong>per</strong><br />
ottenere latte e formaggio. Gli escrementi degli animali e degli uomini vencono riciclati<br />
come fertilizzanti. Il terzo e ultimo scenario è relativo all’uomo “civilizzato” della parte<br />
ricca del mondo o<strong>di</strong>erno. Le sue necessità nutrizionali sono sempre <strong>di</strong> 100 W/giorno e<br />
<strong>per</strong> ottenerle gli basta coltivare 4000 m 2 <strong>di</strong> terreno (come l’uomo agricoltore<br />
primitivo). Per coltivare questo terreno necessita <strong>di</strong> <strong>un</strong> surplus energetico e chimico<br />
(fertilizzanti) esterno molto maggiore della produttività agricola che ottiene: egli non<br />
usa gli animali come fonte <strong>di</strong> energia meccanica ma come cibo. Ricicla solo gli<br />
escrementi animali (e solo in parte) e getta via gli escrementi umani. In più consuma,<br />
<strong>per</strong> supportare il suo stile <strong>di</strong> vita (automobili, aerei, riscaldamento, elettrodomestici,<br />
telefoni, computers, consumismo esas<strong>per</strong>ato, beni usa e getta etc.) <strong>un</strong>’enorme quantità<br />
<strong>di</strong> energia (3.000 W/giorno) non nutrizionale. Il confronto con l’uomo primitivo, ma<br />
anche con la parte povera del mondo d’oggi, è 1:40 se non <strong>di</strong> più».<br />
Anche dal p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista dell’utilizzo <strong>di</strong> altre sostanze, a parte i consumi energetici,<br />
esistono fonti <strong>di</strong> preoccupazioni, come messo in evidenza da Barry Commoner 57 quando<br />
afferma «Abbiamo spezzato il cerchio della vita trasfromando i suoi cicli senza fine in<br />
eventi umani <strong>di</strong> tipo lineare (…)».<br />
Un ecosistema riflette <strong>un</strong>ità spazialmente definite, con caratteristiche strutturali e<br />
f<strong>un</strong>zionali specifiche, tessere a <strong>di</strong>versi or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> grandezza <strong>di</strong> <strong>un</strong> mosaico reale<br />
fisicamente ricostruibile (ecomosaico).<br />
Gli ecomosaici costituiscono inoltre sistemi <strong>di</strong>namici, determinati da processi<br />
evolutivi riconoscibili a <strong>di</strong>fferenti scale temporali.<br />
Territorio<br />
Ogni in<strong>di</strong>viduo, ogni popolazione governa <strong>un</strong> dato spazio, lo occupa fisicamente in<br />
modo continuativo o saltuario, ne sfrutta gli elementi presenti (o si riserva <strong>di</strong> utilizzarli<br />
all’occorrenza). Tale spazio governato corrisponde al “territorio” <strong>di</strong> quel soggetto o <strong>di</strong><br />
quella popolazione.<br />
57 Commoner, B. (1986) Il cerchio da chiudere, Garzanti, p. 101 Riprenderemo questa problematica<br />
parlando del criterio dell’impatto nullo.<br />
Pag. 51 <strong>di</strong> 148<br />
51
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
Il concetto si applica sia all’uomo che ad altre specie animali. Potremmo in qualche<br />
maniera definire il territorio come quella porzione <strong>di</strong> habitat in cui l’in<strong>di</strong>viduo tende a<br />
concentrare la propria presenza.<br />
Ai fini <strong>di</strong> <strong>un</strong> linguaggio trans<strong>di</strong>sciplinare che si occupa <strong>di</strong> qualità e <strong>di</strong> impatto<br />
ambientali, si può assumere che quando si parla <strong>di</strong> “territorio” si intenda, salvo<br />
<strong>di</strong>verse specificazioni, lo spazio governato da <strong>un</strong>a data com<strong>un</strong>ità umana.<br />
Analizzare <strong>un</strong> territorio significa verificare la consistenza, la <strong>di</strong>stribuzione spaziale,<br />
le <strong>di</strong>namiche <strong>di</strong> <strong>un</strong> certo numero <strong>di</strong> elementi: la popolazione in questione, le sue<br />
attività, i flussi degli in<strong>di</strong>vidui e dei materiali, le infrastrutture al loro servizio, in<br />
generale gli interventi realizzati e in progetto, i confini amministrativi entro cui la<br />
popolazione agisce e si trasforma. Come l’ecosistema, anche il territorio è <strong>un</strong> sistema<br />
<strong>di</strong> relazioni.<br />
Attraverso i processi <strong>di</strong> pianificazione l’uomo tende a razionalizzare l’uso del<br />
territorio, in maniera che questa risorsa ormai scarsa non venga “sprecata” <strong>per</strong> <strong>un</strong> suo<br />
uso selvaggio da parte dei singoli. Non <strong>per</strong> niente le leggi toscane relative al processo <strong>di</strong><br />
pianificazione (e che prevedono anche elementi <strong>di</strong> valutazione ambientale) hanno come<br />
titolo “norme <strong>per</strong> il governo del territorio” (cfr. L.R.T n. 5/1995 e n. 1/2005).<br />
Anche il territorio, come l’ecosistema, non è <strong>un</strong>a realtà statica. La comprensione<br />
del sistema territoriale richiede anche la comprensione dei processi in atto. Non si può,<br />
quin<strong>di</strong>, comprendere la realtà territoriale se non conoscendo le <strong>di</strong>namiche relative alla<br />
popolazione (numerosità, composizione), alle attività produttive, ai centri dove si<br />
localizzano i servizi <strong>di</strong> tipo primario o su<strong>per</strong>iore, ecc.<br />
Un concetto centrale, nelle tematiche territoriali, è quello <strong>di</strong> “risorsa”. Con tale<br />
termine si descrivono gli elementi del territorio che possono essere in qualche modo<br />
oggetto <strong>di</strong> fruizione da parte della popolazione considerata.<br />
A tal proposito la già citata L.R.T. n.1/2005 si preoccupa <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare le risorse<br />
essenziali del territorio, come definite all’articolo 3 58 , <strong>di</strong> cui «ness<strong>un</strong>a (…) può essere<br />
ridotta in modo significativo e irreversibile in riferimento agli equilibri degli ecosistemi<br />
<strong>di</strong> cui è componente». Da notare come le risorse essenziali del territorio non sia limitate<br />
58 «1. La Regione, con la presente legge, promuove e garantisce la tutela delle risorse essenziali del<br />
territorio in quanto beni com<strong>un</strong>i che costituiscono patrimonio della collettività.<br />
2. L’insieme delle risorse essenziali <strong>di</strong> cui al comma 1 è costituito da:<br />
a) aria, acqua, suolo e ecosistemi della fa<strong>un</strong>a e della flora;<br />
b) città e sistemi degli inse<strong>di</strong>amenti;<br />
c) paesaggio e documenti della cultura;<br />
d) sistemi infrastrutturali e tecnologici»<br />
Pag. 52 <strong>di</strong> 148<br />
52
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
a risorse naturali in senso stretto (aria, acqua, ecc.) ma includano anche risorse<br />
fortemente legate all’attività antropica (città e sistemi degli inse<strong>di</strong>amenti, ecc.).<br />
Il territorio può essere inteso come il substrato su cui si appoggia il sistema <strong>di</strong><br />
relazioni che regolano la società in oggetto e la sua economia (il sistema socio-<br />
economico). In questo senso l’analisi dell’ambiente naturale e delle caratteristiche del<br />
territorio costituisce <strong>un</strong>a parte <strong>di</strong> <strong>un</strong> ben più complesso stu<strong>di</strong>o della realtà socio-<br />
economica.<br />
Ambiente vissuto<br />
Habitat, ecosistema, territorio sono ambienti “oggettivi”, insiemi <strong>di</strong> parametri<br />
scientificamente definiti e <strong>di</strong> loro relazioni matematiche. In realtà ogni essere vivente<br />
(in particolare ogni <strong>per</strong>sona) ha <strong>un</strong> proprio ambiente soggettivo, il risultato delle<br />
proprie <strong>per</strong>cezioni e delle proprie es<strong>per</strong>ienze.<br />
Nel trattare il tema della qualità ambientale non si può rimuovere l’esistenza dei<br />
mon<strong>di</strong> soggettivi anche <strong>per</strong> <strong>un</strong>a ragione pratica: le mo<strong>di</strong>fiche della qualità<br />
dell’ambiente indotte dall’uomo (quelle che producono gli effetti indesiderati o che<br />
risanano le situazioni degradate) sono il frutto <strong>di</strong> azioni <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui, che agiscono sulla<br />
base dei propri mon<strong>di</strong> soggettivi.<br />
Un obiettivo concreto <strong>di</strong> soluzione <strong>di</strong> problemi ambientali implica quin<strong>di</strong>, oltre ad<br />
<strong>un</strong>’analisi “oggettiva” del problema trattato, anche il fare i conti con i mon<strong>di</strong><br />
“soggettivi” <strong>di</strong> coloro che prendono le decisioni.<br />
Si possono ricercare elementi costanti nella qualità degli ambienti soggettivi. In<br />
altre parole ci si può porre l’obiettivo <strong>di</strong> oggettivare l’ambiente vissuto e <strong>di</strong><br />
comprenderlo in termini più generali <strong>di</strong> “qualità della vita”.<br />
Si può praticamente prendere atto che gruppi <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> com<strong>un</strong>e provenienza<br />
possono mostrare atteggiamenti analoghi nei confronti dei problemi della qualità<br />
ambientale; tali atteggiamenti possono variare sensibilmente tra gruppi <strong>di</strong>versi.<br />
Non solo singoli in<strong>di</strong>vidui, non solo <strong>di</strong>versi gruppi sociali, ma anche culture<br />
<strong>di</strong>fferenti hanno atteggiamenti, metri <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio tra loro <strong>di</strong>versi nei confronti<br />
dell’ambiente.<br />
Una domanda resta <strong>di</strong> importanza fondamentale ai fini delle valutazioni <strong>di</strong> qualità<br />
dell’ambiente e delle possibili trasformazioni: quanto pesa il metro delle valutazioni<br />
“oggettive” espresse in sede scientifica, rispetto ai metri espressi dalle <strong>di</strong>verse culture,<br />
dai vari gruppi sociali, dai singoli in<strong>di</strong>vidui? Chiaramente, mentre le valutazioni<br />
Pag. 53 <strong>di</strong> 148<br />
53
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
oggettive espresse in sede scientifica fanno capo principalmente alle attività del gruppo<br />
che si occupa <strong>di</strong> realizzare lo stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> impatto ambientale, le valutazioni soggettive dei<br />
<strong>di</strong>versi gruppi sociali, ecc., potranno emergere soltanto attraverso l’o<strong>per</strong>a <strong>di</strong><br />
coinvolgimento e partecipazione del “pubblico” nelle valutazioni. Resta il problema, nel<br />
caso <strong>di</strong> valutazioni soggettive <strong>di</strong>verse da parte <strong>di</strong> gruppi <strong>di</strong>versi, su come arrivare ad <strong>un</strong>a<br />
situazione <strong>di</strong> compromesso o sul grado <strong>di</strong> importanza da attribuire alle <strong>di</strong>verse<br />
valutazioni soggettive.<br />
Paesaggio<br />
Tra i termini che descrivono l’ambiente, quello <strong>di</strong> “paesaggio” è <strong>un</strong>o dei più<br />
controversi e ambigui. Molte <strong>di</strong>scipline lo hanno utilizzato, spesso con significati<br />
<strong>di</strong>fferenti. Il paesaggio è stato <strong>di</strong> volta in volta considerato come ambiente visibile,<br />
come sistema dei segni e dei significati <strong>di</strong> <strong>un</strong> territorio, come sistema generale <strong>di</strong><br />
relazioni tra gli elementi dell’ambiente.<br />
Secondo la definizione stabilita durante la Convenzione Europea del Paesaggio<br />
(CEP), tenutasi a Firenze il 20 ottobre 2000, il termine paesaggio «Designa <strong>un</strong>a<br />
determinata parte <strong>di</strong> territorio, così come è <strong>per</strong>cepita dalle popolazioni, il cui carattere<br />
deriva dall'azione <strong>di</strong> fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni». Da notare,<br />
inoltre, come <strong>un</strong>o dei due principi basilari su cui la CEP fonda il proprio dettaglio<br />
normativo sia la seguente: «il paesaggio costituisce <strong>un</strong> bene in sé, in<strong>di</strong>pendentemente<br />
dal valore concretamente attribuitogli, da riconoscere e giu<strong>di</strong>care come tale. La tesi<br />
secondo la quale il paesaggio è tutelabile sotto il profilo legale soltanto quando assume<br />
<strong>un</strong> valore eccezionale (che esclude la tutela quando questo valore non è riscontrato) è<br />
su<strong>per</strong>ato dalla CEP. Nel momento in cui <strong>un</strong>o Stato recepisce i principi della CEP sarà<br />
chiamato a riconoscere <strong>un</strong>a rilevanza paesaggistica all’intero territorio posto sotto la<br />
sua sovranità» 59 . In realtà, nonostante la Convenzione sia stata tenuta a Firenze, l’Italia<br />
non l’ha ancora ratificata, anche se alc<strong>un</strong>i dei suoi contenuti sono stati recepiti dal<br />
D.Lgs n. 42 del 22/01/2004, Co<strong>di</strong>ce dei beni culturali e del paesaggio.<br />
Nel presente contesto si privilegia <strong>per</strong> il termine “paesaggio” il significato <strong>di</strong><br />
“aspetto dell’ecosistema e del territorio”, così come <strong>per</strong>cepito dai soggetti culturali che<br />
lo fruiscono.<br />
59 da: sintesi dell’intervento <strong>di</strong> Riccardo Priore su “L’applicazione della Convenzione europea del<br />
paesaggio come occasione <strong>di</strong> valorizzazione economica delle risorse rurali del territorio” tenuto al<br />
Workshop su “Evoluzione del paesaggio e politiche <strong>di</strong> sviluppo rurale”, Perugia, 30 settembre 2005<br />
Pag. 54 <strong>di</strong> 148<br />
54
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
La <strong>per</strong>cezione <strong>di</strong> <strong>un</strong> dato ambiente da parte <strong>di</strong> soggetti umani comprende<br />
inevitabilmente aspetti semantici e culturali. Culture <strong>di</strong>fferenti possono avere chiavi<br />
<strong>di</strong>fferenti <strong>per</strong> leggere <strong>un</strong> medesimo ambiente. Così <strong>un</strong> gruppo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>osi olandesi,<br />
durante <strong>un</strong> incontro tenutosi a Montes<strong>per</strong>toli (FI) nel maggio 1997 nell’ambito <strong>di</strong><br />
<strong>un</strong>’azione concertata sulla produzione <strong>di</strong> paesaggio da parte dell’agricoltura biologica e<br />
sostenibile 60 commentò che la qualità del paesaggio toscana (che pure noi, e non solo<br />
noi, amiamo molto) risultava in qualche modo influenzata negativamente dalla<br />
“mancanza <strong>di</strong> acqua”, nel senso che effettivamente nelle nostre campagne non sono<br />
molto frequenti laghetti, corsi d’acqua, canali, ecc. Confesso che durante <strong>un</strong> successivo<br />
incontro tenutosi in Olanda, pur avendo apprezzato la suggestività del paesaggio<br />
olandese, a me mancavano i boschi e le colline e <strong>di</strong> canali mi sembrava ce ne fossero<br />
anche troppi. Analogamente, <strong>un</strong> friulano trapiantato in Finlan<strong>di</strong>a mi ha <strong>un</strong>a volta<br />
confessato che a lui mancavano le montagne, tant’è vero che ogni tanto faceva <strong>un</strong>a<br />
capatina in Norvegia <strong>per</strong> vederne qualc<strong>un</strong>a, affrontando <strong>un</strong> viaggio sicuramente non<br />
breve. Ogn<strong>un</strong>o <strong>di</strong> noi ha, quin<strong>di</strong>, probabilmente <strong>un</strong>a sensibilità <strong>di</strong>versa <strong>per</strong> i <strong>di</strong>versi tipi<br />
<strong>di</strong> paesaggio, in relazione alle caratteristiche dei paesaggi delle zone in cui è vissuto e<br />
dei propri gusti <strong>per</strong>sonali, anche se questo non significa necessariamente che non sia in<br />
grado <strong>di</strong> apprezzare paesaggi <strong>di</strong>versi: anzi, a volte i paesaggi esotici risultano<br />
particolarmente apprezzati.<br />
Si è fatta ricerca <strong>di</strong> strumenti oggettivi <strong>per</strong> le analisi del paesaggio. Si è cercato <strong>di</strong><br />
scomporlo in componenti ricorrenti (ad esempio <strong>di</strong>stinguendo il paesaggio “naturale”<br />
da quello “umano”). Si sono analizzati gli elementi <strong>un</strong>ificanti e riscontrabili in tutte le<br />
realtà paesaggistiche (ad esempio i margini, le emergenze ecc.). Ad esempio, me<strong>di</strong>ante<br />
interviste ad <strong>un</strong> campione rappresentativo <strong>di</strong> <strong>per</strong>sone, si è cercato <strong>di</strong> risalire a quello che<br />
è il valore (in termini paesaggistici) attribuito ad <strong>un</strong> albero isolato, <strong>un</strong> bosco, <strong>un</strong>a<br />
montagna, ecc.<br />
Da <strong>un</strong>’analisi svolta da Marangon e Tempesta è emerso come – almeno nelle aree<br />
del Nord-Est – «i fattori che contribuiscono ad aumentare la gradevolezza del<br />
paesaggio sono dati dalla presenza <strong>di</strong> formazioni arboree (siepi e filari <strong>di</strong> alberi) o da<br />
alberi sparsi, nonché <strong>di</strong> prati stabili e corsi <strong>di</strong> acqua. Al contrario contribuiscono a<br />
ridurre la qualità del paesaggio le su<strong>per</strong>fici a seminativo, a set-aside e le serre.<br />
60 EU concerted action AIR3-CT93-1210: The landscape and nature production capacity of organic/<br />
sustainable types of agriculture.<br />
Pag. 55 <strong>di</strong> 148<br />
55
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
Incidono inoltre in modo negativo tutti gli elementi estranei alla coltivazione quali le<br />
strade asfaltate e i pali della luce» 61 .<br />
Un paesaggio ha in genere specificità locali, caratteristiche morfologiche <strong>un</strong>iche<br />
che riflettono il particolare sistema <strong>di</strong> relazioni tra gli elementi presenti, la storia<br />
in<strong>di</strong>viduale del sito, che traduce i segni delle attività umane.<br />
Da questo p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista, il paesaggio – in quanto bene ritenuto <strong>di</strong>fficilmente<br />
riproducibile – potrebbe costituire <strong>un</strong> elemento <strong>di</strong> sviluppo. «In quanto risorsa<br />
<strong>di</strong>fficilmente trasferible ed imitabile, il paesaggio, soprattutto nelle aree rurali, può<br />
favorire degli straor<strong>di</strong>nari vantaggi competitivi <strong>per</strong> gli impren<strong>di</strong>tori e le com<strong>un</strong>ità locali<br />
che sapranno meglio salvaguardarlo e valorizzarlo. Investire <strong>per</strong> la qualità del<br />
paesaggio rurale può contribuire, soprattutto in Italia, ad <strong>un</strong>o sviluppo durevole,<br />
fondato sulla <strong>per</strong>cezione della ricchezza, della specificità e della <strong>di</strong>versità <strong>di</strong> <strong>un</strong><br />
patrimonio naturale e culturale, ben sintetizzato dal paesaggio, <strong>un</strong>ico al mondo» 62 .<br />
Il paesaggio è frutto <strong>di</strong> <strong>un</strong>a lettura culturale, ma dal momento che esistono <strong>di</strong>versi<br />
soggetti culturali <strong>un</strong>o stesso paesaggio può essere letto in mo<strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenti.<br />
Dal p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista delle previsioni degli impatti sul paesaggio, molto è stato fatto<br />
con lo sviluppo <strong>di</strong> tecniche legate ai GIS, che <strong>per</strong>mettono <strong>di</strong> verificare come verrebbe<br />
alterato <strong>un</strong> paesaggio esistente (che può essere fotografato e riprodotto al computer)<br />
introducendo nuovi elementi quali <strong>un</strong> fabbricato, <strong>un</strong>a siepe, ecc., simulandone anche l’<br />
apprezzamento dai <strong>di</strong>versi p<strong>un</strong>ti <strong>di</strong> osservazione. Ad esempio la procedura PLANLAND<br />
«è costituita da <strong>un</strong>a coppia integrata <strong>di</strong> “motori” valutativi e decisionali inerenti<br />
considerazioni <strong>di</strong> tipo ecologico-paesistiche ed estetico-<strong>per</strong>cettive. Entrambi i “motori”<br />
sono connessi coerentemente in <strong>un</strong>’<strong>un</strong>ica procedura attraverso la simulazione GIS-<br />
supportata <strong>di</strong> scenari: la valutazione ed il confronto reiterato <strong>di</strong> questi scenari messi<br />
progressivamente a p<strong>un</strong>to porta alla definizione <strong>di</strong> <strong>un</strong> quadro progettuale definitivo che<br />
ottimizza i <strong>di</strong>versi obiettivi prefissati» … «Durante la fase analitica le rappresentazioni<br />
fotografiche panascopiche ottenute da vari p<strong>un</strong>ti <strong>di</strong> vista dell’area vengono sottoposte<br />
ad analisi visuale, <strong>per</strong> valutare le caratteristiche ecologico-<strong>per</strong>cettive dell’area<br />
considerata (…) Le stesse immagini sono utilizzate, assieme agli altri dati ottenuti dalle<br />
61 Da F. Marangon, T. Tempesta (1998), Paesaggio rurale e risultati economici dell’azienda agricola. Un’<br />
indagine attraverso l’analisi a molti obiettivi, in (a cura <strong>di</strong> D. Regazzi), Atti del XXXIII Convegno<br />
SIDEA tenutosi a Napoli nel settembre 1996, Grafitalia srl, Cercola (Na), p. 308<br />
62 da: sintesi dell’intervento <strong>di</strong> Riccardo Priore su “L’applicazione della Convenzione europea del<br />
paesaggio come occasione <strong>di</strong> valorizzazione economica delle risorse rurali del territorio”, op. cit.<br />
Pag. 56 <strong>di</strong> 148<br />
56
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
analisi e dai sopralluoghi effettuati, <strong>per</strong> riprodurre me<strong>di</strong>ante simulazioni l’area nel suo<br />
complesso» 63 .<br />
Come vedremo meglio in seguito, l’analisi della qualità del paesaggio, rispetto ad<br />
analisi ambientali in chiavi <strong>di</strong>versa, presenta ancora maggiori elementi <strong>di</strong> soggettività,<br />
<strong>per</strong> cui risultanto <strong>di</strong> particolare importanza le procedure che possono portare ad <strong>un</strong>a<br />
oggettivazione delle valutazioni.<br />
Natura<br />
Il concetto <strong>di</strong> ecosistema, <strong>di</strong> habitat, <strong>per</strong>fino quello <strong>di</strong> paesaggio si sono sviluppati<br />
in tempi relativamente recenti. Il concetto <strong>di</strong> natura, intesa come “ambiente non<br />
umano”, ha invece accompagnato tutta la storia dell’uomo.<br />
La natura ha ass<strong>un</strong>to <strong>di</strong>fferenti significati e livelli <strong>di</strong> importanza nel <strong>corso</strong> della<br />
storia dell’uomo. Nella sua considerazione si sono sempre bilanciate componenti<br />
emotive con componenti utilitaristiche.<br />
Nel <strong>per</strong>iodo attuale vi è <strong>un</strong>a forte ripresa della natura intesa come “emozione”,<br />
filtrata da sempre migliori standard scientifici e <strong>di</strong>dattici.<br />
Ambiente (in complesso)<br />
Si può tentare <strong>un</strong> riepilogo dei <strong>di</strong>versi significati attraverso cui i vari termini (habitat,<br />
ecosistema, territorio, ambiente vissuto, paesaggio, natura) concorrono a formare il<br />
concetto <strong>di</strong> ambiente.<br />
Un primo modello concettuale <strong>un</strong>ificante è quello che riassume i rapporti tra le<br />
singole componenti e i fattori ambientali, i sistemi <strong>di</strong> componenti, le azioni dell’uomo<br />
che mo<strong>di</strong>ficano l’ambiente; l’ambiente può essere letto come sistema <strong>di</strong> componenti e<br />
fattori raggi<strong>un</strong>ti da flussi <strong>di</strong> fattori <strong>di</strong> interferenza.<br />
Un altro schema generale può <strong>di</strong>fferenziare i vari concetti sulla base degli elementi<br />
costitutivi del sistema ambientale, dell’esistenza o meno <strong>di</strong> <strong>un</strong> centro del sistema <strong>di</strong><br />
relazioni, dell’esistenza o meno <strong>di</strong> filtri <strong>per</strong>cettivi.<br />
Nella pratica si può suggerire, trattando problemi concreti in ambienti reali, <strong>di</strong><br />
finalizzare le analisi dell’ambiente alle possibilità successive <strong>di</strong> intervento sui problemi<br />
stessi.<br />
In tale prospettiva si può suggerire <strong>di</strong> analizzare <strong>un</strong>a data realtà attraverso <strong>un</strong>a<br />
serie <strong>di</strong> modelli tra loro collegati: <strong>un</strong> modello dell’assetto fisico, <strong>un</strong> modello<br />
63 tratto da: La procedura PLANLAND®: <strong>un</strong> nuovo strumento <strong>per</strong> l’analisi e la progettazione paesistica.<br />
Scaricato da internet all’in<strong>di</strong>rizzo http://www.danielfranco.org/plan_it.html, scaricato il 18/10/2005<br />
Pag. 57 <strong>di</strong> 148<br />
57
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
ecosistemico, <strong>un</strong> modello territoriale, <strong>un</strong> modello socio-economico, <strong>un</strong> modello<br />
culturale, <strong>un</strong> modello <strong>di</strong> valutazione, <strong>un</strong> modello istituzionale.<br />
Gli schemi proposti costituiscono, come tutti i modelli, semplificazioni <strong>di</strong> realtà più<br />
complesse. Il loro scopo principale è quello <strong>di</strong> costituire <strong>un</strong> riferimento <strong>per</strong> la<br />
costruzione <strong>di</strong> linguaggi com<strong>un</strong>i o in generale <strong>per</strong> la <strong>di</strong>scussione sui temi trattati.<br />
Da notare come molti dei concetti relativi all'ambiente facciano riferimento al<br />
concetto <strong>di</strong> spazio: ad esempio l'habitat viene definito come “lo spazio fisico occupato<br />
da <strong>un</strong>a specie”. Ancora più evidente la connotazione spaziale <strong>di</strong> <strong>un</strong> territorio e quanto le<br />
<strong>di</strong>stanze possano influenzare le relazioni umane e – ad esempio – le <strong>per</strong>cezioni <strong>di</strong> <strong>un</strong><br />
rischio. Inoltre, se l'ambiente, lo spazio, il territorio non sono omogenei al loro interno,<br />
saranno anche <strong>di</strong>versi gli impatti su <strong>di</strong> essi prodotti da <strong>un</strong>a stessa sorgente <strong>di</strong> impatto. In<br />
altre parole, se l'inquinante che esce da <strong>un</strong>a sorgente p<strong>un</strong>tiforme, a causa delle <strong>di</strong>versità<br />
<strong>di</strong> orografia, ecc., si <strong>di</strong>ffonde in maniera <strong>di</strong>fforme nelle aree circostanti, in primo luogo<br />
si avranno concentrazioni <strong>di</strong>verse nelle <strong>di</strong>verse zone omogenee (cfr fig. 4.11 del<br />
Malcevschi) e quin<strong>di</strong>, ad esempio, la qualità dell'aria – valutata attraverso la<br />
concentrazione <strong>di</strong> inquinante nell’aria - sarà <strong>di</strong>versa nelle <strong>di</strong>verse localizzazioni, in<br />
secondo luogo, a seconda delle caratteristiche dell'ambiente impattato, gli impatti<br />
potranno assumere intensità <strong>di</strong>verse nelle <strong>di</strong>verse localizzazioni, in quanto potrà essere<br />
<strong>di</strong>verso sia il livello <strong>di</strong> pregio che <strong>di</strong> vulnerabilità dell’ambiente “bersaglio”. Questo<br />
significa che non si potrà avere (almeno imme<strong>di</strong>atamente) <strong>un</strong>a misura <strong>un</strong>ica <strong>di</strong> qualità<br />
dell'aria, ma si dovranno avere tante misure <strong>per</strong> quante sono le aree che risultano<br />
omogenee <strong>per</strong> grado <strong>di</strong> concentrazione dell'inquinante.<br />
L’importanza della <strong>di</strong>mensione spaziale è desumibile anche dal Manuale della<br />
Regione Lombar<strong>di</strong>a, quando mette in evidenza come «la conoscenza dell’area<br />
investigata avviene prevedendo la definizione dei <strong>di</strong>versi campi <strong>di</strong> indagine, geo-<br />
referenziandone gli elementi significativi, analizzandone congi<strong>un</strong>tamente le varie carte<br />
tematiche e le banche dati che descrivono l’evoluzione nel tempo dei parametri più<br />
significativi» 64 Di conseguenza, tutte le volte che la variabile spaziale <strong>di</strong>venta<br />
fondamentale nell’analisi degli impatti (cioè praticamente quasi sempre) l’utilizzo <strong>di</strong><br />
cartografie e <strong>di</strong> sistemi informatici <strong>per</strong> gestirle <strong>di</strong>venta <strong>di</strong> fondamentale importanza.<br />
64 Manuale della Regione Lombar<strong>di</strong>a, op.cit., p. 47 (il sottolineato è nostro)<br />
Pag. 58 <strong>di</strong> 148<br />
58
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
Questa necessità <strong>di</strong> dettagliare le stime (o i rilievi) nello spazio si può applicare<br />
anche alla variabile tempo. Infatti, anche all'interno <strong>di</strong> <strong>un</strong>a stessa zona, la<br />
concentrazione <strong>di</strong> <strong>un</strong> inquinante non sarà sempre costante, ma <strong>di</strong>penderà, ad esempio,<br />
dalle con<strong>di</strong>zioni climatiche (pioggia, vento). Così, ad esempio, a parità <strong>di</strong> fonte <strong>di</strong><br />
immissione <strong>di</strong> <strong>un</strong> inquinante in <strong>un</strong> fiume, il grado <strong>di</strong> concentrazione nell'acqua nello<br />
stesso <strong>di</strong>penderà dal fatto se si è, o meno, in <strong>un</strong> <strong>per</strong>iodo <strong>di</strong> piena, cioè dalla quantità <strong>di</strong><br />
acqua in cui l'inquinante verrà ad essere <strong>di</strong>luito. Come vedremo meglio in seguito,<br />
questo comporta la necessità <strong>di</strong> ripetere rilievi e previsioni <strong>per</strong> tenere conto delle<br />
variazioni <strong>di</strong> impatti che si possono avere a seconda della localizzazione spaziale o del<br />
momento temporale, ma implica anche <strong>un</strong> problema <strong>di</strong> sintesi dei dati, nel senso che<br />
non si può pensare <strong>di</strong> descrivere l’impatto legato ad <strong>un</strong>a immissione <strong>di</strong> inquinante<br />
me<strong>di</strong>ante <strong>un</strong>a mole <strong>di</strong> dati enorme legata alla variabilità spazio-temporale.<br />
Al termine <strong>di</strong> questo paragrafo, introduciamo <strong>un</strong>a serie <strong>di</strong> figure relative: la figura 6<br />
all’importanza della variabile spaziale nella <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> <strong>un</strong> inquinante sul territorio, la<br />
figura 7 ad <strong>un</strong> possibile modello <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> <strong>un</strong> inquinante da <strong>un</strong>a fonte p<strong>un</strong>tiforme,<br />
la figura 8, ad <strong>un</strong>a rappresentazione delle <strong>di</strong>verse categorie tipologiche <strong>di</strong> spazi<br />
in<strong>di</strong>viduabili in <strong>un</strong> territorio.<br />
Figura 6 – Deposizioni <strong>di</strong> Cesio-137 in Europa a seguito dell’incidente a Chernobyl<br />
(Fonte: Commissione Europea, 1998)<br />
Pag. 59 <strong>di</strong> 148<br />
59
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
Figura 7 – Mappa delle linee <strong>di</strong> isoconcentrazione<br />
(Fonte: Figura 4.11 Malcevschi, 1991)<br />
Figura 8 – Azzonamento del Piano Territoriale <strong>di</strong> Coor<strong>di</strong>namento del Consorzio<br />
Lombardo della Valle del Ticino<br />
(Fonte: Figura 2.10, Malcevschi, 1991)<br />
Pag. 60 <strong>di</strong> 148<br />
60
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
2.5. Le componenti della qualità ambientale<br />
In <strong>un</strong>o dei precedenti paragrafi abbiamo introdotto il problema della misurazione<br />
dell’entità <strong>di</strong> <strong>un</strong> impatto facendo uso <strong>di</strong> <strong>un</strong> grafico che riportava in or<strong>di</strong>nata la misura<br />
della qualità ambientale. E’ chiaro come tale concetto è relativo ad <strong>un</strong>a <strong>di</strong>mensione<br />
complessa, che non può essere sintetizzata <strong>per</strong> mezzo <strong>di</strong> <strong>un</strong> in<strong>di</strong>catore singolo<br />
<strong>di</strong>rettamente misurabile. In altre parole, in qualche modo la qualità è <strong>un</strong> concetto<br />
pluri<strong>di</strong>mensionale, legato in maniera più o meno stretta ad <strong>un</strong>a serie <strong>di</strong> grandezze che<br />
possono essere considerate in<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> elevata (o scarsa) qualità ambientale.<br />
Di conseguenza, <strong>per</strong> poter apprezzare la qualità complessiva <strong>di</strong> <strong>un</strong> sistema<br />
ambientale, bisogna avere consapevolezza <strong>di</strong> quali sono le caratteristiche costitutive<br />
della stessa, <strong>per</strong> le quali poi dovranno essere in<strong>di</strong>viduati degli in<strong>di</strong>catori che ci<br />
<strong>per</strong>mettano <strong>di</strong> valutare il livello qualitativo presente o futuro <strong>di</strong> <strong>un</strong> sistema ambientale.<br />
Come <strong>di</strong>ce il Malcevschi 65 , <strong>di</strong> nuovo utilizzato come “guida” <strong>per</strong> la successiva<br />
trattazione: Analizzare <strong>un</strong>a caratteristica della qualità significa definirne i rapporti con<br />
le altre caratteristiche e con il concetto <strong>di</strong> qualità complessiva, valutarne la<br />
misurabilità in termini oggettivi, riconoscerne il campo <strong>di</strong> applicazione.<br />
Rarità<br />
La rarità è <strong>un</strong>a caratteristica che può essere applicata a categorie omogenee <strong>di</strong><br />
elementi ambientali <strong>di</strong> qual<strong>un</strong>que tipo, e può essere definita come <strong>un</strong>a con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong><br />
scarsa <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> quel tipo <strong>di</strong> elemento.<br />
Si possono riconoscere <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> rarità, con <strong>di</strong>fferenti implicazioni teoriche ed<br />
applicative. Così, come dal p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista delle risorse naturali con possibile utilizzo<br />
economico, la rarità assume chiaramente rilevanza, in quanto il problema principale<br />
dell’economia è proprio quello <strong>di</strong> allocare risorse (relativamente) scarse (rispetto alla<br />
domanda <strong>di</strong> impiego) tra impieghi alternativi, <strong>per</strong> quanto riguarda risorse naturali in<br />
senso stretto, la rarità può assumere fondamentale importanza, ad esempio ai fini della<br />
conservazione della bio<strong>di</strong>versità.<br />
65 Il presente paragrafo è ampliamente stralciato dal capitolo III del Malcevschi, op. cit., <strong>di</strong> cui riprende le<br />
espressioni evidenziate in grassetto, integrandole con ulteriori considerazioni e citazioni <strong>di</strong> altri autori.<br />
Un esame più approfon<strong>di</strong>to delle chiavi <strong>di</strong> lettura del sistema ambientale (trattate nel paragrafo<br />
precedente) e delle caratteristiche cui è legata la qualità ambientale (trattate nel presente paragrafo) può<br />
essere costituito dai capitoli II e III del Malcevschi che, <strong>per</strong> problemi <strong>di</strong> tempo a <strong>di</strong>sposizione, non<br />
abbiamo potuto trattare in maggior dettaglio.<br />
Pag. 61 <strong>di</strong> 148<br />
61
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
Di grande importanza sono gli aspetti <strong>di</strong>namici. Un concetto particolarmente<br />
importante al riguardo è quello <strong>di</strong> rarefazione. Se si innescano o si intensificano trend<br />
al decremento rispetto a specie che sono già rare, si può arrivare fino alla loro estinzione<br />
che, purtroppo, ai giorni nostri è sempre più frequente <strong>per</strong> motivi <strong>di</strong>versi, che vanno<br />
dalla <strong>di</strong>struzione degli habitat, alla caccia, all’inquinamento 66 . «Il valore ecologico <strong>di</strong><br />
<strong>un</strong>a specie risiede nelle sue interazioni, meravigliosamente complesse, con il proprio<br />
ambiente e le altre specie. La battaglia ecologica contro l’estinzione ha d<strong>un</strong>que<br />
fondamenti più profon<strong>di</strong>, <strong>per</strong> esempio, della ragione <strong>di</strong> tipo economico secondo cui non<br />
si dovrebbe provocare l’estinzione delle piante della foresta fluviale <strong>per</strong>ché, con le loro<br />
virtù meca<strong>di</strong>mentose, potrebbero rivelarsi <strong>di</strong> incalcolabile valore <strong>per</strong> l’umanità» 67<br />
La rarità è <strong>un</strong> criterio fondamentale nella valutazione della qualità <strong>di</strong> <strong>un</strong> elemento.<br />
Per questo esiste <strong>un</strong>a legislazione a tutela delle specie rare o a rischio <strong>di</strong> estinzione,<br />
che va tenuta presente in sede <strong>di</strong> analisi dei potenziali impatti sull’ambiente. Ad<br />
esempio, il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. all’Art.2 comma g, definisce le specie <strong>di</strong><br />
interesse com<strong>un</strong>itario ai fini <strong>di</strong> <strong>un</strong>a loro conservazione, come «le specie, in<strong>di</strong>cate negli<br />
allegati B, D ed E, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente: 1) sono in<br />
<strong>per</strong>icolo con l'esclusione <strong>di</strong> quelle la cui area <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione naturale si estende in<br />
modo marginale sul territorio dell'Unione europea e che non sono in <strong>per</strong>icolo né<br />
vulnerabili nell'area del paleartico occidentale; 2) sono vulnerabili, quando il loro<br />
passaggio nella categoria delle specie in <strong>per</strong>icolo è ritenuto probabile in <strong>un</strong> prossimo<br />
futuro, qualora <strong>per</strong>sistano i fattori alla base <strong>di</strong> tale rischio; 3) sono rare, quando le<br />
popolazioni sono <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni e, pur non essendo attualmente né in <strong>per</strong>icolo né<br />
vulnerabili, rischiano <strong>di</strong> <strong>di</strong>ventarlo a prescindere dalla loro <strong>di</strong>stribuzione territoriale;<br />
4) sono endemiche e richiedono particolare attenzione, a causa della specificità del<br />
loro habitat o delle incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato <strong>di</strong><br />
conservazione»<br />
Diversità e complessità<br />
La “<strong>di</strong>versità” <strong>di</strong> <strong>un</strong> sistema combina il numero <strong>di</strong> elementi <strong>di</strong>fferenti presenti<br />
(ricchezza, varietà) e i relativi rapporti quantitativi. Tale caratteristica è stata stu<strong>di</strong>ata<br />
in molteplici realtà ambientali.<br />
66 Cfr., ad esempio, E. Callenbach, (2003), Ecologia. Una guida tascabile, Blu e<strong>di</strong>zioni srl, pp. 54-56<br />
67 E. Callenbach, (2003), Ecologia. Una guida tascabile, Blu e<strong>di</strong>zioni srl, p. 55<br />
Pag. 62 <strong>di</strong> 148<br />
62
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
Una caratteristica concettualmente vicina alla <strong>di</strong>versità è la "complessità", che<br />
esprime anche aspetti <strong>di</strong> tipo relazionale: complesso è <strong>un</strong> sistema che combina <strong>un</strong>a<br />
elevata <strong>di</strong>versificazione dei suoi elementi costitutivi con <strong>un</strong>a rete <strong>di</strong> molteplici relazioni<br />
tra <strong>di</strong> essi.<br />
Come si è precedentemente messo in evidenza rispetto agli ecosistemi, quelli<br />
caratterizzati da <strong>un</strong> più elevato livello <strong>di</strong> <strong>di</strong>versità e complessità tendono in genere ad<br />
essere maggiormente stabili, anche se, come mette in evidenza il Malcevschi, c’è stata<br />
<strong>un</strong> cambiamento nel tempo del ruolo attribuito alla <strong>di</strong>versità: infatti «mentre nei decenni<br />
scorsi si attribuiva importanza alla <strong>di</strong>versità in quanto si ipotizzava <strong>un</strong>a sua relazione<br />
necessaria con le caratteristiche <strong>di</strong> stabilità ecologica, ora si tende soprattutto a<br />
sottolineare l’importanza della conservazione nella biosfera <strong>di</strong> <strong>un</strong> patrimonio genetico<br />
il più <strong>di</strong>versificato possibile» 68 . Quando applicata agli ecosistemi, la <strong>di</strong>versità spesso<br />
viene associata alla bio<strong>di</strong>versità, cioè al numero <strong>di</strong> specie esistenti nell’ecosistema (ed<br />
alle loro relazioni). A tal proposito, la L. 14 febbraio 1994, n. 124, all’ Art.2 definisce la<br />
<strong>di</strong>versità biologica (o bio<strong>di</strong>versità) come «Variabilità degli organismi viventi <strong>di</strong> ogni<br />
origine, compresi inter alia gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici,<br />
ed i complessi ecologici <strong>di</strong> cui fanno parte; ciò include la <strong>di</strong>versità nell'ambito delle<br />
specie, e tra le specie degli ecosistemi». Il concetto <strong>di</strong> <strong>di</strong>versità, <strong>per</strong>ò, potrebbe essere<br />
anche riferito ad <strong>un</strong> paesaggio (che può essere più o meno “variegato”) o ad <strong>un</strong><br />
territorio, in base alle tipologie <strong>di</strong> strutture presenti al suo interno ed al tipo <strong>di</strong> relazioni<br />
che tra esse intercorrono (che potrebbero assumere il carattere <strong>di</strong> complessità). Come<br />
mette in evidenza Callenbach, «l’IMPATTO umano sulla bio<strong>di</strong>versità ha spesso<br />
conseguenze impreviste. Magari tagliamo <strong>un</strong>a vecchia siepe <strong>per</strong> procurarci qualche<br />
metro in più da coltivare, ma questo farà sì che gli uccelli non possano più ni<strong>di</strong>ficare<br />
presso il nostro campo, e gli insetti nocivi (mangiati dagli uccelli) potrebbero<br />
improvvisamente moltiplicarsi. Capire i complessi e <strong>di</strong>fferenti equilibri della bio-<br />
<strong>di</strong>versità, ci <strong>per</strong>metterà <strong>di</strong> mantenerli» 69 .<br />
La <strong>di</strong>versità varia con le <strong>di</strong>mensioni dell’ambiente considerato, a seconda del<br />
contesto geografico, in relazione allo stato <strong>di</strong>namico del sistema complessivo.<br />
La <strong>di</strong>versità ambientale può essere stimata in modo relativamente oggettivo,<br />
attraverso in<strong>di</strong>ci sintetici convenzionali.<br />
68 Schmidt <strong>di</strong> Friedberg, Malcevschi (1998), Guida pratica agli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> impatto ambientale, op. cit. p. 82<br />
69 E. Callenbach, (2003), Ecologia. Una guida tascabile, Blu e<strong>di</strong>zioni srl, p. 21<br />
Pag. 63 <strong>di</strong> 148<br />
63
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
La <strong>di</strong>versità ambientale costituisce <strong>un</strong> criterio importante nella valutazione della<br />
qualità ambientale complessiva.<br />
Essa è tutelata o incentivata da varie norme, ad esempio il D.P.R. 8 settembre 1997,<br />
n. 357. all’Art. 2 m si occupa dei Siti <strong>di</strong> Interesse Com<strong>un</strong>itario (S.I.C.) anche il<br />
relazione del loro ruolo in termini <strong>di</strong> conservazione della bio<strong>di</strong>versità. Infatti <strong>un</strong> S.I.C.<br />
viene definito come «<strong>un</strong> sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene,<br />
contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare <strong>un</strong> tipo <strong>di</strong> habitat<br />
naturale <strong>di</strong> cui all'allegato A o <strong>di</strong> <strong>un</strong>a specie <strong>di</strong> cui all'allegato B in <strong>un</strong>o stato <strong>di</strong><br />
conservazione sod<strong>di</strong>sfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla<br />
coerenza della rete ecologica "Natura 2000” <strong>di</strong> cui all'articolo 3, al fine <strong>di</strong> mantenere<br />
la <strong>di</strong>versità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in<br />
questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti <strong>di</strong> importanza<br />
com<strong>un</strong>itaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione<br />
naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e<br />
riproduzione». Tra gli strumenti che mirano ad incentivare, <strong>di</strong>rettamente o<br />
in<strong>di</strong>rettamente, la bio<strong>di</strong>versità potremmo viceversa citare le misure agroambientali,<br />
all’interno dei piani <strong>di</strong> sviluppo rurale.<br />
Struttura e f<strong>un</strong>zioni<br />
La struttura <strong>di</strong> <strong>un</strong>a certa realtà ambientale ed il suo ruolo f<strong>un</strong>zionale all’interno del<br />
sistema globale possono costituire parametri concorrenti ad <strong>un</strong> giu<strong>di</strong>zio complessivo <strong>di</strong><br />
qualità<br />
Un tema <strong>di</strong> particolare rilievo relativamente alla struttura delle <strong>un</strong>ità ambientali, è<br />
quello relativo alle loro <strong>di</strong>mensioni.<br />
Le <strong>di</strong>mensioni <strong>di</strong> <strong>un</strong>a <strong>un</strong>ità ambientale sono <strong>un</strong>a caratteristica oggettivabile; anche<br />
la forma è <strong>un</strong>a caratteristica relativamente oggettivabile sulla base <strong>di</strong> modelli <strong>di</strong><br />
riferimento. Disporre <strong>di</strong> modelli morfologici <strong>di</strong> riferimento può essere particolarmente<br />
utile in sede <strong>di</strong> valutazione e <strong>di</strong> progettazione del territorio.<br />
Forma e <strong>di</strong>mensioni <strong>di</strong> <strong>un</strong>a <strong>un</strong>ità ambientale sono, ad esempio, molto importanti ai<br />
fini della possibilità <strong>di</strong> <strong>un</strong> determinato spazio fisico <strong>di</strong> rappresentare <strong>un</strong> habitat<br />
sod<strong>di</strong>sfacente <strong>per</strong> <strong>un</strong>a determinata specie. Ad esempio, come mette in evidenza il<br />
Callenbach, «Quando rimangono soltanto habitat piccoli ed isolati li definiamo<br />
frammentati. Più piccole sono le aree risparmiate, più <strong>di</strong>struttivi sono gli effetti della<br />
frammentazione. Per esempio, in <strong>un</strong>a foresta spezzettata in zone <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amento,<br />
Pag. 64 <strong>di</strong> 148<br />
64
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
scompaiono gli uccelli che ne abitano la parte interna e necessitano <strong>di</strong> <strong>un</strong>a fitta<br />
vegetazione, come il tordo sassello e la capinera; soltanto le specie che vivono ai<br />
margini del bosco, come la ghiandaia azzurra, il corvo e lo scricciolo, possono<br />
sopravvivere». Se la <strong>di</strong>mensione <strong>di</strong> <strong>un</strong> habitat è importante, è chiaro che la sua forma ne<br />
definirà l’area <strong>di</strong> contatto rispetto all’ambiente esterno, <strong>per</strong> cui – se tale su<strong>per</strong>ficie <strong>di</strong><br />
contatto risulta troppo elevata – l’ambiente interno potrà non essere in grado <strong>di</strong> resistere<br />
alle interferenze che provengono dall’esterno.<br />
Oltre alla geometria, altro aspetto fondamentale nella valutazione <strong>di</strong> <strong>un</strong>a struttura è<br />
l’assetto f<strong>un</strong>zionale, che definisce il ruolo ambientale <strong>di</strong> ogni elemento all’interno del<br />
sistema <strong>di</strong> relazioni. Ad esempio, <strong>un</strong> ruolo fondamentale potranno assumere le aree che<br />
esplicano <strong>un</strong>a f<strong>un</strong>zione in termini <strong>di</strong> fornire <strong>un</strong> rifugio durante la stagione riproduttiva, o<br />
viceversa, le aree nelle quali si determinano le o<strong>per</strong>azioni <strong>di</strong> “ricarica” <strong>di</strong> <strong>un</strong>a falda che<br />
alimenta pozzi <strong>di</strong> acque potabili. Anche in questo caso, come <strong>per</strong> i precedenti, struttura<br />
e f<strong>un</strong>zioni non sono caratteristiche <strong>di</strong> qualità ambientale necessariamente legate a<br />
sistemi ambientali interpretati in chiave ecosistemica o naturalistica in senso stretto, ma<br />
possono benissimo essere applicate a chiavi <strong>di</strong> lettura <strong>di</strong>verse, quali quella territoriale.<br />
Tornando ad <strong>un</strong> approccio in chiave <strong>di</strong> ecosistema, il Malcevschi mette in evidenza<br />
anche l’importanza del “ruolo ecosistemico”, definito come la capacità da parte <strong>di</strong> <strong>un</strong>a<br />
entità «<strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare la struttura e le f<strong>un</strong>zioni <strong>di</strong> altri elementi del medesimo ecosistema<br />
o <strong>di</strong> altre <strong>un</strong>ità ecosistemiche confinanti o lontane. Di particolare rilievo, a questo<br />
riguardo, è la posizione dell’elemento ambientale considerato all’interno dei cicli bio-<br />
geo-chimici; <strong>un</strong> ruolo importante a questo riguardo hanno ad esempio quelle <strong>un</strong>ità<br />
ecosistemiche che possono costituire via critica <strong>per</strong> il convogliamento <strong>di</strong> contaminanti,<br />
come i corsi d’acqua. Un altro esempio, riferito alle singole specie, è quello relativo al<br />
ruolo rispetto alla catena trofica, dove le specie poste ai vertici sono maggiormente<br />
esposte ai rischi <strong>di</strong> bioaccumulo <strong>di</strong> sostanze inquinanti» 70 . Il problema <strong>di</strong> bioaccumulo<br />
nella catena trofica sarà ripreso nell’ambito <strong>di</strong> alc<strong>un</strong>e considerazioni su come stabilire i<br />
livelli soglia <strong>per</strong> gli standard <strong>di</strong> legge (<strong>di</strong> emissione, <strong>di</strong> concentrazione, <strong>di</strong> consumo).<br />
Stabilità<br />
Un’altra caratteristica spesso usata <strong>per</strong> descrivere la qualità <strong>di</strong> realtà ambientali è<br />
la stabilità del sistema considerato, che può essere definita come il mantenimento nel<br />
tempo <strong>di</strong> <strong>un</strong>a data con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> equilibrio. In questo senso «l’ “equilibrio ecologico”<br />
70 Schmidt <strong>di</strong> Friedberg, Malcevschi (1998), Guida pratica agli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> impatto ambientale, op. cit. p. 83<br />
Pag. 65 <strong>di</strong> 148<br />
65
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
può essere espresso (…) come <strong>un</strong>a con<strong>di</strong>zione teorica dell’ecosistema <strong>di</strong> stabilità<br />
risultante dalla combinazione <strong>di</strong> forze e pressioni tra loro antagoniste ed equivalenti<br />
(es. produzione/consumo <strong>di</strong> biomasse) 71 ». Abbiamo visto come tale stabilità – sia pure il<br />
risultato <strong>di</strong> equilibri <strong>di</strong>namici - caratterizzi in genere gli ecosistemi che sono arrivati al<br />
loro sta<strong>di</strong>o evolutivo finale (climax), in assenza <strong>di</strong> <strong>per</strong>turbazioni esterne, soprattutto <strong>di</strong><br />
tipo antropico, ma anche <strong>di</strong> tipo naturale, quali gli incen<strong>di</strong> spontanei.<br />
Ai nostri fini il campo <strong>di</strong> applicazione del concetto <strong>di</strong> stabilità riguarda soprattutto i<br />
sistemi ambientali (ecosistemi, sistemi territoriali, sistemi socio-economici) più che non<br />
i singoli elementi dell’ambiente. Sorge il problema <strong>di</strong> definire in modo corretto cosa<br />
intendere <strong>per</strong> equilibri ecologici e ambientali. Di particolare interesse e importanza ai<br />
fini dei processi valutativi sono le analisi della stabilità a livello <strong>di</strong> biosfera.<br />
I rapporti tra stabilità e qualità ambientali sono evidentemente cruciali. In <strong>un</strong><br />
recente passato il ruolo della stabilità ambientale è stato valutato in modo ambiguo<br />
sulla base <strong>di</strong> relazioni non confermate tra stabilità e <strong>di</strong>versità biologica. Infatti, come<br />
abbiamo accennato in precedenza, in genere gli ecosistemi complessi vengono<br />
considerati maggiormente stabili rispetto a quelli “semplificati”, dove <strong>un</strong>’alterazione<br />
nella catena delle relazioni tra le <strong>di</strong>verse specie può essere più <strong>di</strong>fficilmente “ammor-<br />
tizzabile” in quanto possono non esistere specie in grado <strong>di</strong> svolgere lo stesso ruolo <strong>di</strong><br />
quella eventualmente scomparsa.<br />
Vi sono specifici campi applicativi (ad esempio quello della stabilità dei versanti) in<br />
cui i rapporti tra stabilità e qualità sono stati affrontati in modo tecnicamente preciso.<br />
Quin<strong>di</strong>, non necessariamente, com<strong>un</strong>que, il concetto <strong>di</strong>stabilità deve essere applicato<br />
agli ecosistemi. Ad esempio, esso viene generalmente impiegato anche parlando <strong>di</strong><br />
problemi legati alla stabilità dei versanti. In questo caso la stabilità è legata a parametri<br />
tecnici specifici, come il grado <strong>di</strong> pendenza <strong>di</strong> <strong>un</strong> terreno, la sua composizione nei<br />
<strong>di</strong>versi strati, la co<strong>per</strong>tura vegetale che su <strong>di</strong> esso insiste, la rete idrologica, il clima<br />
soprattutto in relazione ad eventi climatici quali piogge, la ero<strong>di</strong>bilità degli strati<br />
su<strong>per</strong>ficiali del terreno, ecc.<br />
Mentre il concetto <strong>di</strong> equilibrio ecologico e ambientale mantiene <strong>un</strong>a sua<br />
importanza decisiva a livello <strong>di</strong> biosfera, a livello territoriale <strong>di</strong>venta fondamentale il<br />
rapporto tra stabilità e assetto culturale. E' lecito avere dubbi su <strong>un</strong>a coincidenza<br />
bi<strong>un</strong>ivoca tra elevati livelli <strong>di</strong> stabilità (quali quelli che possono essere mantenuti da <strong>un</strong><br />
71 Schmidt <strong>di</strong> Friedberg, Malcevschi (1998), Guida pratica agli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> impatto ambientale, op. cit. p. 83<br />
Pag. 66 <strong>di</strong> 148<br />
66
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
ecosistema che ha raggi<strong>un</strong>to il livello <strong>di</strong> climax) e elevati livelli <strong>di</strong> qualità ambientale.<br />
L’evoluzione è <strong>un</strong>a caratteristica intrinseca dell’ambiente.<br />
Inquinamento e degrado<br />
Nelle valutazione <strong>di</strong> qualità <strong>un</strong> aspetto <strong>di</strong> grande importanza è quello relativo allo<br />
stato <strong>di</strong> salute del sistema complessivo, alla sua integrità.<br />
Tali aspetti, che <strong>per</strong> quanto riguarda gli esseri viventi vengono considerati stati<br />
patologici, <strong>per</strong> quanto riguarda l’ambiente sono essenzialmente rappresentati dai<br />
concetti <strong>di</strong> “degrado” e <strong>di</strong> “inquinamento”.<br />
Con il termine “degrado” si intende in generale <strong>un</strong>a con<strong>di</strong>zione dell’entità<br />
esaminata che si allontana dal suo stato ottimale.<br />
Il termine inquinamento può essere definito come la presenza, all’interno <strong>di</strong> <strong>un</strong>a<br />
data realtà ambientale, <strong>di</strong> sostanze estranee (in quei termini qualitativi e/o quantitativi)<br />
alle con<strong>di</strong>zioni normali <strong>di</strong> f<strong>un</strong>zionamento e sviluppo.<br />
La stima dell’inquinamento può essere fatta rispetto a scale <strong>di</strong>fferenti sia sul piano<br />
spaziale e temporale, sia rispetto alle convenzioni adottate <strong>per</strong> definire i livelli <strong>di</strong><br />
gravità.<br />
Pericolosità, pressione antropica<br />
Considerando i singoli fattori <strong>di</strong> interferenza <strong>di</strong>venta molto importante definirne i<br />
livelli <strong>di</strong> “<strong>per</strong>icolosità”, ovvero la capacità intrinseca <strong>di</strong> produrre inquinamento o<br />
degrado.<br />
Nel campo delle sostanze che possono avere effetti negativi sugli organismi viventi<br />
<strong>un</strong>a forma particolarmente importante <strong>di</strong> <strong>per</strong>icolosità è quella definita dai concetti <strong>di</strong><br />
“nocività” e <strong>di</strong> “tossicità”. A livello <strong>di</strong> tali concetti, come vedremo meglio in seguito,<br />
si usa in genere <strong>di</strong>stinguere tra fenomeni <strong>di</strong> natura “acuta” e fenomeni <strong>di</strong> natura<br />
“cronica”. Si parla <strong>di</strong> tossicità acuta quando gli effetti si manifestano nel breve <strong>per</strong>iodo<br />
e sono in genere <strong>di</strong> <strong>un</strong>a certa rilevanza, mentre si parla <strong>di</strong> tossicità cronica quando gli<br />
effetti si manifestano nel l<strong>un</strong>go <strong>per</strong>iodo, a seguito <strong>di</strong> <strong>un</strong>’ass<strong>un</strong>zione della sostanza<br />
tossica prol<strong>un</strong>gata nel tempo 72 . In genere, mentre gli effetti in termini <strong>di</strong> tossicità acuta<br />
sono facilmente in<strong>di</strong>viduabili, molto più subdoli sono i problemi legati alla tossicità<br />
72 Chiaramente, <strong>di</strong>verse sono le situazioni in cui si possono avere problemi <strong>di</strong> tossicità cronica od acuta;<br />
se, ad esempio, <strong>per</strong> <strong>un</strong> inquinante al quale si è esposti nel tempo <strong>per</strong>ché presente nell’aria che si respira<br />
o <strong>per</strong>ché siamo ad esso esposti <strong>per</strong> problemi lavorativi è in genere rilevante la tossicità cronica, nel caso<br />
che si valutino gli effetti <strong>di</strong> eventuali malf<strong>un</strong>zionamenti o incidenti (che ad esempio possono causare la<br />
fuoriuscita <strong>di</strong> sostanze tossiche) dovremo preoccuparci della tossicità acuta.<br />
Pag. 67 <strong>di</strong> 148<br />
67
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
cronica, dove a volte – visto il tempo e lo spazio che possono intercorrere tra<br />
l’ass<strong>un</strong>zione ed il manifestarsi dell’effetto – è <strong>di</strong>fficile risalire alle relazioni <strong>di</strong> “causa-<br />
effetto”. Il manifestarsi <strong>di</strong> fenomeni <strong>di</strong> natura acuta o cronica può anche <strong>di</strong>pendere dalla<br />
dose che si assume nell’<strong>un</strong>ità <strong>di</strong> tempo, nel senso che – come accade <strong>per</strong> <strong>un</strong> veleno –<br />
l’avvelenamento può avere <strong>un</strong> esito mortale sia in caso <strong>di</strong> ass<strong>un</strong>zione istantanea <strong>di</strong> <strong>un</strong>a<br />
dose consistente, ma anche <strong>per</strong> <strong>un</strong> lento avvelenamento dovuto a piccolissime dosi<br />
ass<strong>un</strong>te nel tempo. Riprenderemo il problema della tossicità parlando degli standard <strong>di</strong><br />
emissione e <strong>di</strong> concentrazione.<br />
Si parla <strong>di</strong> “pressione antropica” <strong>per</strong> descrivere il complesso delle <strong>per</strong>turbazioni<br />
dell’ambiente (o <strong>di</strong> sue specifiche componenti) causate <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente<br />
dall’azione umana. Un in<strong>di</strong>catore complessivo della pressione antropica potrebbe<br />
essere, ad esempio, l’impronta ecologica.<br />
Sensibilità, fragilità<br />
Differenti elementi dell’ambiente rispondono in modo <strong>di</strong>verso a <strong>un</strong>a medesima<br />
forma <strong>di</strong> pressione; hanno cioè <strong>di</strong>fferenti sensibilità o, utilizzando <strong>un</strong> termine<br />
complementare, <strong>di</strong>versi livelli <strong>di</strong> resistenza. Tali concetti si applicano a qualsiasi tipo <strong>di</strong><br />
realtà ambientale. Quin<strong>di</strong>, se la “sensibilità” <strong>di</strong> <strong>un</strong> sistema ad <strong>un</strong> dato <strong>di</strong>sturbo è la<br />
caratteristica che ne descrive le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica al variare del <strong>di</strong>sturbo stesso, la<br />
“resistenza” è la sua capacità <strong>di</strong> evitare mo<strong>di</strong>fiche rispetto allo stato originario durante<br />
<strong>un</strong> episo<strong>di</strong>o <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo 73 .<br />
La sensibilità <strong>di</strong> <strong>un</strong>a realtà ambientale non è <strong>un</strong>a caratteristica assoluta, bensì<br />
relativa: essa può variare a seconda della natura delle pressioni in giuoco. In altre<br />
parole, la sensibilità può essere legata ad <strong>un</strong>o specifico tipo <strong>di</strong> interferenza, ad esempio,<br />
come mette in evidenza il Malcevschi, le specie ittiche sono sensibili alla presenza<br />
dell’ammoniaca nell’acqua. In qualche caso è com<strong>un</strong>que utile ragionare in termini <strong>di</strong><br />
sensibilità globale, definita talvolta come “sensitività (...). Tra gli esempi <strong>di</strong> sistemi ad<br />
elevata sensitività, il Malcevschi ricorda le grotte, in quanto sono sufficienti piccole<br />
interferenze <strong>per</strong> mo<strong>di</strong>ficarne drasticamente le caratteristiche ecologiche.<br />
Un particolare tipo <strong>di</strong> sensitività è la “fragilità” del sistema, caratteristica che<br />
esprime più specificamente la facilità con cui il sistema in oggetto può collassare<br />
(ovvero arrivare a mo<strong>di</strong>fiche irreversibili <strong>di</strong> stato) quando oggetto <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbi. Tra gli<br />
esemi <strong>di</strong> ecosistemi fragili, il Malcevschi ricorda le praterie <strong>di</strong> alta quota, in quanto la<br />
73 Schmidt <strong>di</strong> Friedberg, Malcevschi (1998), Guida pratica agli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> impatto ambientale, op. cit. p. 83<br />
Pag. 68 <strong>di</strong> 148<br />
68
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
realizzazione <strong>di</strong> <strong>un</strong>a nuova strada può innescare processi <strong>di</strong> erosione tali da pregiu<strong>di</strong>care<br />
l’intero sistema.<br />
La sensibilità, oltre che ad <strong>un</strong> sistema nel suo complesso (<strong>un</strong>a prateria <strong>di</strong> alta quota),<br />
può essere riferita anche ad <strong>un</strong>a singola specie (<strong>un</strong>a specie ittica), <strong>per</strong> esempio <strong>per</strong><br />
in<strong>di</strong>care l’intensità degli impatti che riceve al cambiamento <strong>di</strong> alc<strong>un</strong>e caratteristiche,<br />
quali la presenza <strong>di</strong> <strong>un</strong> determinato inquinante nel proprio habitat, od <strong>un</strong>a mo<strong>di</strong>fica nelle<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> tem<strong>per</strong>atura, ecc.<br />
Resilienza, Vulnerabilità<br />
La “sensibilità” è <strong>un</strong>a caratteristica che esprime le <strong>di</strong>mensioni della risposta ad<br />
impatti <strong>di</strong> origine esterna. Tale risposta comprende <strong>un</strong> allontanamento dalla stato<br />
iniziale, ma può anche comprendere <strong>un</strong>a fase successiva <strong>di</strong> ritorno alle con<strong>di</strong>zioni<br />
iniziali. La resilienza <strong>di</strong> <strong>un</strong> sistema ambientale è più precisamente la caratteristica che<br />
rende conto della sua capacità <strong>di</strong> ritornare allo stato iniziale dopo aver subito <strong>un</strong>a<br />
pressione <strong>di</strong> origine esterna. Un modello grafico della resilienza è riportato in figura 9.<br />
Da tale grafico è possibile apprezzare anche alc<strong>un</strong>e delle caratteristiche principali<br />
della resilienza. L’elasticità in<strong>di</strong>ca la velocità con cui il sistema è in grado <strong>di</strong> ripristinare<br />
lo stato iniziale dopo la <strong>per</strong>turbazione (<strong>un</strong> <strong>corso</strong> d’acqua ha <strong>un</strong>a elasticità maggiore <strong>di</strong><br />
<strong>un</strong> lago, a causa del più veloce ricambio dell’acqua); l’ampiezza <strong>di</strong> risposta in<strong>di</strong>ca il<br />
livello <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica rispetto alla con<strong>di</strong>zione iniziale che il sistema può sopportare<br />
essendo poi in grado <strong>di</strong> ritornare allo stato iniziale (determinate forme <strong>di</strong> prato sono in<br />
grado <strong>di</strong> soppor-tare elevati livelli <strong>di</strong> calpestio tornando alle con<strong>di</strong>zioni iniziali, altre<br />
forme no); l’isteresi è la proprietà che descrive la simmetria delle modalità <strong>di</strong> ripristino<br />
dopo <strong>un</strong>o stress rispetto alle modalità <strong>di</strong> degrado (in particolare, rispetto al tempo, i<br />
tempi richiesti <strong>per</strong> il ripristino possono essere anche molto più l<strong>un</strong>ghi rispetto a quelli in<br />
cui lo stress ha determinato la <strong>per</strong><strong>di</strong>ta <strong>di</strong> qualità, ad esempio nel caso del taglio <strong>di</strong> <strong>un</strong><br />
bosco. In altri casi, viceversa, come nell’ipotesi <strong>di</strong> autorecu<strong>per</strong>o dopo l’immissione <strong>di</strong><br />
<strong>un</strong> inquinante in <strong>un</strong> corpo acquifero, i tempi possono essere più vicini); la malleabilità è<br />
l’ampiezza con cui il sistema può assumere, dopo <strong>un</strong> <strong>di</strong>sturbo, stati <strong>di</strong>fferenti da quello<br />
iniziale (sistemi boschivi possono riprendere la struttura originaria dopo <strong>un</strong> taglio,<br />
mo<strong>di</strong>ficando <strong>per</strong>altro in modo più o meno accentuato la composizione iniziale <strong>di</strong><br />
specie) 74 .<br />
74 Schmidt <strong>di</strong> Friedberg, Malcevschi (1998), Guida pratica agli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> impatto ambientale, op. cit., p. 84<br />
Pag. 69 <strong>di</strong> 148<br />
69
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
STATO dell’AMBIENTE<br />
STATO<br />
INIZIALE<br />
RESILIENZA<br />
Ampiezza<br />
Isteresi<br />
Elasticità<br />
Malleabilità<br />
STATO<br />
FINALE<br />
Figura 9 – Modello grafico del concetto <strong>di</strong> resilienza, applicato ad <strong>un</strong>a generica <strong>un</strong>ità<br />
ambientale<br />
(cfr. fig. 3.11 Malcevschi, 1991)<br />
Legenda: «In or<strong>di</strong>nata si» utilizza «<strong>un</strong> generico parametro in grado <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care la qualità dello<br />
stato dell’<strong>un</strong>ità considerata. In ascissa è espresso il tempo; si immagina che in <strong>un</strong>a con<strong>di</strong>zione<br />
iniziale naturale si produca <strong>un</strong>a pressione esterna. La curva illustra le modalità <strong>di</strong> risposta del<br />
sistema rispetto a tale impatto <strong>di</strong> origine esterna definite con il termine “resilienza”.<br />
Particolari caratteristiche della resilienza sono l’“elasticità”, l’“ampiezza”, la “malleabilità”»<br />
(Malcevschi)<br />
La resilienza è espressione <strong>di</strong> fenomeni <strong>di</strong> tipo naturale e non artificiali, <strong>per</strong> cui può<br />
essere legata a fenomeni <strong>di</strong> rinnovabilità naturale. Più generalmente, occorre<br />
considerare la rinnovabilità della realtà ambientale considerata; essa <strong>di</strong>pende da<br />
processi naturali e dalla possibilità <strong>di</strong> <strong>un</strong>a ricostruzione artificiale, sulla base <strong>di</strong><br />
specifici interventi antropici. Nel caso che gli interventi me<strong>di</strong>ante i quali si ritorna ad<br />
<strong>un</strong>a situazione assimilabile a quella precedente siano <strong>di</strong> natura antropica si parla <strong>di</strong><br />
rinnovabilità artificiale, legata a processi <strong>di</strong> recu<strong>per</strong>o (che sottintende <strong>un</strong>’azione in<br />
grado <strong>di</strong> riportare <strong>un</strong>a situazione <strong>di</strong> degrado ad <strong>un</strong> livello qualitativamente migliore, ad<br />
esempio recu<strong>per</strong>o <strong>di</strong> cave <strong>di</strong>smesse), ripristino (che pone l’accento soprattutto sulla<br />
eguaglianza tra la nuova situazione e quella precedente, ad esempio nel caso <strong>di</strong><br />
ripristino della vegetazione naturale preesistente ad <strong>un</strong> intervento, ad esempio la posa <strong>di</strong><br />
<strong>un</strong> metanodotto) e restauro (che sottintende soprattutto la riparazione <strong>di</strong> parti<br />
Pag. 70 <strong>di</strong> 148<br />
Tempo<br />
70
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
danneggiate, ad esempio il restauro <strong>di</strong> <strong>un</strong> monumento naturale) 75 . Nello stesso ambito<br />
concettuale, si parla <strong>di</strong> reversibilità degli impatti ambientali, sia spontanea che tramite<br />
interventi antropici più o meno importanti.<br />
Un’ulteriore estensione dei concetti precedenti è il concetto <strong>di</strong> vulnerabilità. La<br />
vulnerabilità <strong>di</strong> <strong>un</strong>a data realtà può essere definita come la capacità complessiva <strong>di</strong><br />
subire degra<strong>di</strong> o collassi in conseguenza <strong>di</strong> pressioni esterne.<br />
Il concetto <strong>di</strong> vulnerabilità si applica all’insieme delle <strong>di</strong>fferenti realtà ambientali;<br />
la stima della caratteristica può avvenire attraverso la combinazione <strong>di</strong> caratteristiche<br />
parziali che rendono conto <strong>di</strong> particolari aspetti della vulnerabilità stessa. Ad esempio,<br />
la vulnerabilità <strong>di</strong> <strong>un</strong> acquifero può essere legata alla <strong>per</strong>meabilità dei suoli, alla<br />
profon<strong>di</strong>tà delle falde, ecc.<br />
Un concetto importante, legato a quelli <strong>di</strong> sensibilità e <strong>di</strong> vulnerabilità<br />
dell’ambiente, è quello <strong>di</strong> capacità portante, ovvero il livello oltre il quale il sistema in<br />
oggetto non è capace <strong>di</strong> sostenere lo sfruttamento delle risorse interne.<br />
La capacità <strong>di</strong> carico (o <strong>di</strong> portata o carrying capacity) <strong>di</strong> <strong>un</strong> territorio rappresenta il<br />
numero degli organismi che è in grado <strong>di</strong> sostentare ed è determinata dalle risorse<br />
<strong>di</strong>sponibili. In genere esistono in natura meccanismi in grado <strong>di</strong> regolare la densità <strong>di</strong><br />
<strong>un</strong>a popolazione, in maniera che essa non cresca al <strong>di</strong> sopra della capacità <strong>di</strong> carico; in<br />
altre parole, <strong>un</strong> aumento <strong>di</strong> predatori che si nutrono <strong>di</strong> quella popolazione (e la cui<br />
popolazione può crescere in <strong>di</strong>pendenza dell’abbondanza <strong>di</strong> cibo), l’insorgere <strong>di</strong><br />
malattie dovuto ad <strong>un</strong>a carenza <strong>di</strong> cibo o ad <strong>un</strong>a densità eccessiva che ne favorisce la<br />
trasmissione, ecc. tenderanno a mantenere la popolazione entro determinati limiti. Come<br />
<strong>di</strong>ce il Callenbach, «la capacità <strong>di</strong> carico è <strong>un</strong> limite posto dalla natura e non può<br />
essere aggirato. Un termine correlato è popolazione ottimale, situazione che si verifica<br />
quando in <strong>un</strong> ecosistema il numero <strong>di</strong> organismi cresce o <strong>di</strong>minuisce in misura modesta,<br />
anno dopo anno, senza toccare il massimo <strong>per</strong> poi venire bruscamente ridotto da<br />
malattie e morte. Attenti stu<strong>di</strong> ecologici <strong>di</strong>mostrano che alc<strong>un</strong>i ecosistemi naturali si<br />
avvicinanto alla popolazione ottimale, piuttosto che a quella massima» 76 .<br />
Secondo Odum, nel caso <strong>di</strong> popolazioni umane il concetto <strong>di</strong> capacità portante va<br />
adattato. Infatti «basare la capacità portante sul numero o sulla biomassa è fattibile<br />
finché ogni <strong>un</strong>ità (ogni in<strong>di</strong>viduo o <strong>un</strong>ità <strong>di</strong> peso) ha più o meno lo stesso impatto<br />
sull’ambiente come ogni altra <strong>un</strong>ità. Tuttavia gli organismi possono <strong>di</strong>fferire<br />
75 Schmidt <strong>di</strong> Friedberg, Malcevschi (1998), Guida pratica agli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> impatto ambientale, op. cit. p. 84<br />
76 E. Callenbach, (2003), Ecologia. Una guida tascabile, Blu e<strong>di</strong>zioni srl, p. 25<br />
Pag. 71 <strong>di</strong> 148<br />
71
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
ampiamente <strong>per</strong> quanto riguarda l’impatto. Ciò è specialmente vero <strong>per</strong> l’uomo in<br />
quanto (…) il consumo pro capite <strong>di</strong> energia e risorse in <strong>un</strong> paese industrializzato può<br />
essere 50 volte più grande <strong>di</strong> quello che si ha in <strong>un</strong>a nazione povera. Concordemente, la<br />
capacità portante, in termini <strong>di</strong> numero <strong>di</strong> <strong>per</strong>sone che possono essere mantenute al<br />
loro stile <strong>di</strong> vita abituale da <strong>un</strong>a data base <strong>di</strong> energia e risorse, sarebbe molto più bassa<br />
in <strong>un</strong> paese industrializzato.<br />
Numero in<strong>di</strong>vidui<br />
K2<br />
S<br />
K1<br />
SX<br />
Figura 10 – Diagramma <strong>per</strong> la capacità portante<br />
(cfr. fig. 3.13 Malcevschi, 1991)<br />
A<br />
Capacità portante<br />
D<br />
«Una data realtà ambientale (ad esempio <strong>un</strong>a popolazione <strong>di</strong> <strong>un</strong>a specie) ha <strong>un</strong>a sua capacità<br />
<strong>di</strong> crescita, che <strong>di</strong>pende fondamentalmente dalla velocità intrinseca <strong>di</strong> accrescimento<br />
(espressione della sua capacità riproduttiva e <strong>di</strong> sviluppo) e dalle risorse vitali <strong>di</strong>sponibili. Ad<br />
<strong>un</strong> certo p<strong>un</strong>to la popolazione esaurirà le risorse vitali <strong>di</strong>sponibili; a seconda della loro natura<br />
(rinnovabilità e <strong>di</strong>sponibilità nel tempo), la popolazione può stabilizzarsi su <strong>un</strong> determinato<br />
valore stazionario, può fluttuare in modo regolare, oppure può declinare. Il valore raggi<strong>un</strong>to<br />
dalla popolazione, la sua densità <strong>di</strong> equilibrio relativamente alle risorse <strong>di</strong>sponibili (in assenza<br />
<strong>di</strong> predatori) viene definita “capacità portante” (carrying capacity)» (Malcevschi)<br />
Poiché l’uomo varia in modo così ampio <strong>per</strong> quel che riguarda il suo impatto sulle<br />
risorse vitali <strong>per</strong> il sostentamento, i sociologi aggi<strong>un</strong>gono <strong>un</strong>a seconda <strong>di</strong>mensione,<br />
l’intensità dell’uso, al loro concetto <strong>di</strong> capacità portante. Per esempio, William R.<br />
Catton (1987) definisce la capacità portante come “il volume e l’intensità dell’uso che<br />
Pag. 72 <strong>di</strong> 148<br />
B<br />
C<br />
Tempo t<br />
72
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
possono essere sostenuti senza degradare l’adattabilità futura dell’ambiente <strong>per</strong><br />
quell’uso» 77<br />
Il concetto <strong>di</strong> capacità portante sfocia in quello <strong>di</strong> ricettività dell’ambiente, <strong>di</strong><br />
eccezionale importanza ai fini del governo del territorio. Infatti, con questo termine, si<br />
intende l’ammontare complessivo <strong>di</strong> interferenze che <strong>un</strong> dato sistema ambientale è in<br />
grado <strong>di</strong> tollerare senza andare incontro a fenomeni <strong>di</strong> degrado più o meno gravi ed<br />
irreversibili. In questo caso, la pressione <strong>di</strong> <strong>un</strong>a popolazione (quale quella umana)<br />
sull’ambiente non è solo e soltanto legata allo sfruttamento delle risorse, ma anche alle<br />
interferenze <strong>di</strong> natura antropica generate, le quali non devono su<strong>per</strong>are <strong>un</strong>a determinata<br />
soglia. Ad esempio, nel caso dei problemi <strong>di</strong> conservazione della qualità delle acque «la<br />
definizione della ricettività ambientale, intesa come soglia <strong>di</strong> tollerabilità nei confronti<br />
<strong>di</strong> scarichi inquinanti al <strong>di</strong> sotto della quale non vengono pregiu<strong>di</strong>cate le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />
qualità dell’ambiente acquatico, è estremamente complessa, ed è correlata alla<br />
capacità <strong>di</strong> autodepurazione del fiume che, a sua volta, è f<strong>un</strong>zione dellaa interazione <strong>di</strong><br />
processi biochimici e idro<strong>di</strong>namici. Essa, inoltre, va riferita alla tipologia d’uso cui la<br />
risorsa è destinata piuttosto che ad <strong>un</strong> improbabile stato “naturale” <strong>di</strong> assoluta<br />
incontaminazione» 78 . Il concetto <strong>di</strong> ricettività ambientale sarà ripreso nell’ambito della<br />
trattazione dei criteri <strong>per</strong> il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> compatibilità ambientale.<br />
Criticità ambientale<br />
La criticità <strong>di</strong> <strong>un</strong>a data realtà ambientale esprime il complesso delle caratteristiche<br />
che ne rendono la situazione precaria, suscettibile <strong>di</strong> degra<strong>di</strong> irreversibili. Una<br />
situazione <strong>di</strong> criticità può essere determinata, ad esempio, da <strong>un</strong> <strong>per</strong>dura <strong>di</strong> interferenze<br />
nel tempo, <strong>per</strong> cui l’ambiente non è in grado <strong>di</strong> tamponare o <strong>di</strong> riparare il danno, in<br />
quanto i suoi meccanismi sono troppo “deboli” o “lenti” <strong>per</strong> contrastare gli impatti<br />
provenienti dall’esterno. Figura 11 introduce il concetto <strong>di</strong> criticità ambientale come<br />
legata ad impatti cumulativi rispetto al tempo.<br />
Da esso è facile vedere come, dal p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista dell’effetto sulla qualità ambientale,<br />
<strong>un</strong>’interferenza che si verifica solo <strong>per</strong> <strong>un</strong> lasso <strong>di</strong> tempo relativamente limitato (ad<br />
esempio in sede <strong>di</strong> realizzazione <strong>di</strong> <strong>un</strong>’o<strong>per</strong>a) possa avere <strong>un</strong> significato molto <strong>di</strong>verso<br />
<strong>di</strong> quello <strong>di</strong> <strong>un</strong>’interferenza che, viceversa, si estende sul tutto il <strong>per</strong>iodo <strong>di</strong> vita utile<br />
dell’o<strong>per</strong>a stessa (fase <strong>di</strong> gestione).<br />
77 E. Odum (1994), Ecologia <strong>per</strong> il nostro ambiente minacciato, Piccin, p. 157<br />
78 scaricato l’8/10/2004 dall’in<strong>di</strong>rizzo http://www.latibi.<strong>un</strong>ibas.it/prodotti/rapporti/13rapp01/P<strong>un</strong>o.html<br />
Pag. 73 <strong>di</strong> 148<br />
73
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
Stato della componente ambientale<br />
Impatti cumulativi<br />
PERSISTENZA RESILIENZA INERZIA COLLASSO<br />
Figura 11 – La criticità <strong>di</strong> <strong>un</strong>a realtà ambientale esprime il complesso delle caratteristiche<br />
che ne rendono la situazione precaria, suscettibile <strong>di</strong> degra<strong>di</strong> irreversibili.<br />
(cfr. fig. 3.14 Malcevschi, 1991)<br />
Legenda: «Un medesimo sistema, sufficientemente resistente ad <strong>un</strong> singolo impatto ambientale,<br />
se oggetto <strong>di</strong> impatti successivi può progressivamente indebolirsi <strong>di</strong>minuendo la propria<br />
resilienza fino a scivolare <strong>per</strong> inerzia in situazioni strutturalmente <strong>di</strong>fferenti, in qualche caso<br />
attraverso modalità catastrofiche che ne provocano il collasso. La “<strong>per</strong>sistenza” descrive <strong>un</strong>o<br />
stato rispetto al quale <strong>un</strong> sistema ambientale non mo<strong>di</strong>fica significativamente la propria<br />
struttura interna entro <strong>un</strong> intervallo <strong>di</strong> tempo prefissato, ancorché siano intervenute<br />
interferenze più o meno consistenti. L’ “inerzia” è la capacità del sistema <strong>di</strong> <strong>per</strong>sistere nella<br />
propria <strong>di</strong>namica (anche se è <strong>di</strong>vergente rispetto allo stato iniziale) se non intervengono<br />
pressioni esterne. Si ha “collasso” quando avviene <strong>un</strong>a rapida mo<strong>di</strong>fica del sistema dello stato<br />
originario che assume la forma <strong>di</strong> <strong>un</strong>o snaturamento definitivo (ve<strong>di</strong> anche il concetto <strong>di</strong><br />
fragilità)» (Malcevschi, op. cit. p. 188)<br />
Nel nostro esame delle <strong>di</strong>verse categorie <strong>di</strong> impatto, svolto nella prima parte <strong>di</strong><br />
questo materiale, non abbiamo introdotto il concetto <strong>di</strong> impatto cumulativo, che non<br />
dovrebbe necessitare <strong>di</strong> definizione in quanto <strong>di</strong> significato chiaramente intuibile. Gli<br />
impatti possono derivare da “cumulo” rispetto allo spazio (più sorgenti <strong>di</strong> interferenza<br />
localizzate nello stesso territorio possono dar luogo a degli impatti “cumulativi” che<br />
sono molto <strong>di</strong>versi dalla somma dei singoli impatti) o al tempo (il <strong>per</strong>durare <strong>di</strong><br />
<strong>un</strong>’interferenza ambientale può portare ad impatti i cui esiti possono variare in maniera<br />
molto sensibile in <strong>di</strong>pendenza della tipologia dell’impatto e della sua <strong>per</strong>manenza nel<br />
tempo). In questo caso, come messo in evidenza, gli impatti cumulativi hanno degli<br />
Pag. 74 <strong>di</strong> 148<br />
Tempo<br />
74
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
esiti, in termini <strong>di</strong> <strong>per</strong><strong>di</strong>ta <strong>di</strong> qualità ambientale, che possono essere molto <strong>di</strong>versi dalla<br />
somma dei singoli impatti. Chiaramente, proprio <strong>per</strong> questi problemi <strong>di</strong> natura sinergica,<br />
gli impatti cumulativi sono in genere più <strong>di</strong>fficili da stimare, anche <strong>per</strong>ché a volte è<br />
<strong>di</strong>fficile effettuare <strong>un</strong>a stima <strong>di</strong> quelli che saranno gli impatti che si verranno a<br />
cumulare. Per questa <strong>di</strong>fficoltà oggettiva la Com<strong>un</strong>ità Europea ha messo a p<strong>un</strong>to delle<br />
specifiche linee guida (come nel caso degli impatti secondari o in<strong>di</strong>retti, anche loro <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>fficile in<strong>di</strong>viduazione e quantificazione) <strong>per</strong> la valutazione degli impatti cumulativi<br />
nelle procedura <strong>di</strong> VIA.<br />
Il campo <strong>di</strong> applicazione del concetto <strong>di</strong> criticità riguarda l’intero sistema delle<br />
realtà ambientali. Molto importante in campo ambientale è il concetto <strong>di</strong> via critica,<br />
cioè «delle catene <strong>di</strong> eventi spazio temporali, <strong>per</strong>corsi preferenziali <strong>di</strong> contaminanti, in<br />
grado <strong>di</strong> generare impatti gravi» 79 .<br />
L’analisi della criticità può avvenire, come <strong>per</strong> altre caratteristiche, sulla base <strong>di</strong><br />
specifici parametri in<strong>di</strong>viduati come significativi, o sulla base <strong>di</strong> in<strong>di</strong>ci sintetici.<br />
Valore culturale ed estetico<br />
La qualità <strong>di</strong> <strong>un</strong>’<strong>un</strong>ità dell’ambiente è anche data dalla sua importanza sul piano<br />
culturale. «ad esempio <strong>un</strong> fontanile, pur essendo <strong>un</strong> sistema <strong>di</strong> origine antropica, può<br />
avere non solo <strong>un</strong> elevato valore naturalistico e scientifico (può ad<strong>di</strong>rittura in qualche<br />
caso ospitare specie endemiche), ma anche <strong>un</strong> elevato valore culturale (in quanto<br />
testimonianza <strong>di</strong> mo<strong>di</strong> storici <strong>di</strong> coltivazione)» 80 .<br />
Si possono riconoscere varie componenti del valore culturale.<br />
Una caratteristica significativa a tal fine è la “rappresentatività” nei confronti <strong>di</strong><br />
modelli ideali a cui viene attribuito il massimo della qualità intrinseca.<br />
Il riconoscimento <strong>di</strong> <strong>un</strong>a “identità” specifica può costituire motivo <strong>di</strong> apprez-<br />
zamento culturale <strong>di</strong> <strong>un</strong>a data realtà ambientale.<br />
Una caratteristica che può <strong>di</strong>pendere sia dal contesto culturale che dal gusto<br />
in<strong>di</strong>viduale è il “valore estetico” della realtà considerata, la sua bellezza.<br />
Un altro aspetto importante che non deve essere <strong>di</strong>menticato nella valutazione <strong>di</strong><br />
<strong>un</strong>’<strong>un</strong>ità ambientale, è quanto essa costituisca <strong>un</strong> valore <strong>per</strong> i singoli in<strong>di</strong>vidui, quali<br />
siano i termini del suo “valore soggettivo”. Un importante modo <strong>per</strong> affrontare tale<br />
79 Schmidt <strong>di</strong> Friedberg, Malcevschi (1998), Guida pratica agli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> impatto ambientale, op. cit. p. 86<br />
80 Schmidt <strong>di</strong> Friedberg, Malcevschi (1998), Guida pratica agli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> impatto ambientale, op. cit. p. 85<br />
Pag. 75 <strong>di</strong> 148<br />
75
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
aspetto è quello <strong>di</strong> prendere atto dell’interesse effettivamente suscitato dalle <strong>un</strong>ità<br />
considerate.<br />
Da questo p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista, mentre possono essere ricercate delle metodologie <strong>per</strong><br />
ridurre il più possibile la soggettività nelle attribuzioni dei giu<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> valore (anche se<br />
bisogna essere consapevoli che essa non è mai completamente eliminabile, in particolari<br />
situazioni risulta <strong>di</strong>fficile oggettivare tali giu<strong>di</strong>zi, proprio <strong>per</strong>ché legati a singoli<br />
in<strong>di</strong>vidui o piccole com<strong>un</strong>ità locali. Quin<strong>di</strong>, come afferma il Malcevschi, «accanto alle<br />
caratteristiche più o meno oggettivabili a livello <strong>di</strong> com<strong>un</strong>ità scientifica e culturale, va<br />
sempre verificato anche quello che è l’effettivo “interesse” suscitato, ovvero la<br />
capacità dell’elemento ambientale considerato<strong>di</strong> suscitare attenzione negli in<strong>di</strong>vidui<br />
coinvolti (a livello locale, regionale, nazionale). Ai fini della VIA quest’ultima<br />
caratteristica è particolarmente importante, <strong>per</strong>ché si verifica spesso il caso che <strong>un</strong><br />
dato elemento ambientale, a cui non si possono attribuire caratteristiche <strong>di</strong> elevata<br />
qualità secondo criteri consolidati, acquista invece <strong>un</strong> elevato valore (si potrebbe <strong>di</strong>re<br />
“affettivo”) <strong>per</strong> le com<strong>un</strong>ità locali. Uno spazio a<strong>per</strong>to senza particolari caratteristiche<br />
oggettive <strong>di</strong> interesse può in qualche caso suscitare grande attenzione e può<br />
con<strong>di</strong>zionare l’accettabilità o meno <strong>di</strong> <strong>un</strong>a sua trasformazione da parte del pubblico<br />
coinvolto» 81 .<br />
Una chiave <strong>di</strong> lettura che spesso implica valutazioni <strong>di</strong> qualità ambientale in termini<br />
<strong>di</strong> valore estetico e culturale è quella paesaggistica. La soggettività legata a tali<br />
valutazioni può avere delle ricadute anche a livello normativo; ad esempio Priore mette<br />
in evidenza come: «considerata l’importanza della componente soggettiva del<br />
paesaggio, le popolazioni devono essere attivamente e costantemente coinvolte nei<br />
processi decisionali pubblici relativi al paesaggio. In f<strong>un</strong>zione <strong>di</strong> esigenze<br />
democratiche, economiche e <strong>di</strong> efficacia amministrativa, il paesaggio, salvo nei casi in<br />
cui viene rilevato <strong>un</strong> interesse su<strong>per</strong>iore, deve essere salvaguardato, gestito e/o<br />
progettato attraverso decisioni pubbliche prese vicino ai citta<strong>di</strong>ni. Nel fare<br />
esplicitamente riferimento ai principi <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà e <strong>di</strong> autonomia, la CEP in<strong>di</strong>ca<br />
chiaramente che le responsabilità pubbliche in materia <strong>di</strong> paesaggio devono quin<strong>di</strong>, <strong>di</strong><br />
preferenza, essere decentrate a livello territoriale» 82 .<br />
81 Schmidt <strong>di</strong> Friedberg, Malcevschi (1998), Guida pratica agli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> impatto ambientale, op. cit. p. 85<br />
82 da: sintesi dell’intervento <strong>di</strong> Riccardo Priore su “L’applicazione della Convenzione europea del<br />
paesaggio come occasione <strong>di</strong> valorizzazione economica delle risorse rurali del territorio”, op. cit.<br />
Pag. 76 <strong>di</strong> 148<br />
76
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
Valore ecologico, naturalità<br />
Una caratteristica a cavallo tra gli aspetti “oggettivi” e quelli “soggettivi” della<br />
qualità ambientale è il cosiddetto “valore ecologico”.<br />
Un aspetto del valore ecologico che si propone <strong>di</strong> sintetizzare <strong>un</strong> elevato numero <strong>di</strong><br />
informazioni, è la “naturalità” della realtà considerata. Tale naturalità può essere in<br />
qualche maniera vista in contrapposizione all’artificialità <strong>di</strong> molti sistemi ambientali ad<br />
elevato livello <strong>di</strong> antropizzazione.<br />
Il valore ecologico può anche essere considerato come la combinazione <strong>di</strong> <strong>un</strong>a serie<br />
<strong>di</strong> valori parziali, relativi alle singole componenti del sistema ambientale, o ad altre<br />
caratteristiche che compongono la qualità complessiva (rarità, ecc.).<br />
Si sono elaborati anche in<strong>di</strong>ci quantitativi <strong>per</strong> esprimere l’importanza ecologica.<br />
(…). Spesso si tratta <strong>di</strong> in<strong>di</strong>ci sintetici che tengono conto <strong>di</strong> <strong>un</strong>a pluralità <strong>di</strong> parametri.<br />
Valore come risorsa<br />
Dal p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista del governo del territorio, più ancora che il valore culturale o<br />
ecologico <strong>di</strong> <strong>un</strong>a data componente dell’ambiente interessa spesso il suo valore come<br />
risorsa, il suo valore economico.<br />
Una caratteristica con sensibili implicazioni ambientali nella valutazione <strong>di</strong> <strong>un</strong>a<br />
risorsa è la sua accessibilità, attuale o potenziale. Questo potrebbe essere collegato alla<br />
caratteristica <strong>di</strong> scarsità/abbondanza (cfr. risorse com<strong>un</strong>i o rare) che può determinare<br />
<strong>un</strong>a <strong>di</strong>versa valutazione dell’importanza della risorsa.<br />
Un’altra caratteristica del valore <strong>di</strong> <strong>un</strong>a risorsa ambientale, è la sua idoneità <strong>per</strong><br />
particolari utilizzi. Ad esempio, parlando delle risorse e delle loro caratteristiche,<br />
abbiamo messo in evidenza come ce ne siano alc<strong>un</strong>e che vengono considerate<br />
strategiche (ad esempio combustibili fossili) ai fini del tipo <strong>di</strong> sviluppo che caratterizza<br />
la nostra attuale società. Ci si può porre, a questo riguardo l’interrogativo se <strong>per</strong><br />
<strong>un</strong>’<strong>un</strong>ità ambientale possano essere in<strong>di</strong>viduate vocazioni specifiche <strong>di</strong> utilizzo.<br />
Qualità ambientale complessiva<br />
Il concetto <strong>di</strong> qualità ambientale rischia <strong>di</strong> apparire, sulla base delle analisi<br />
condotte nei p<strong>un</strong>ti precedenti, troppo frammentato e complesso. E' importante, invece,<br />
<strong>per</strong> poterlo affrontare efficacemente, trovare adeguate chiavi sintetiche riass<strong>un</strong>tive.<br />
Pag. 77 <strong>di</strong> 148<br />
77
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
Si propone <strong>un</strong> semplice modello riass<strong>un</strong>tivo, che considera la qualità <strong>di</strong> <strong>un</strong>a realtà<br />
ambientale come combinazione <strong>di</strong> due caratteristiche fondamentali: la sua importanza<br />
intrinseca, e il suo livello attuale <strong>di</strong> degrado.<br />
A seconda delle <strong>di</strong>mensioni della realtà esaminata cambia poi il suo valore<br />
complessivo, mentre l’aspetto <strong>di</strong>namico è definito dal livello <strong>di</strong> criticità.<br />
3. La compatibilità ambientale degli interventi ed i criteri <strong>per</strong> valutarla<br />
Abbiamo accennato in precedenza come, a livello com<strong>un</strong>itario, la <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> sia “nata” con la <strong>di</strong>rettiva 337 del 1985. In Italia, la nascita della<br />
VIA a livello nazionale può essere fatta risalire alla legge relativa all'Istituzione del<br />
Ministero dell'ambiente, che all'art. 6 introduceva il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> compatibilità<br />
ambientale. Il suddetto Art. 6 legge n. 349 del 1986 recita quanto segue:<br />
«Comma 3. I progetti delle o<strong>per</strong>e <strong>di</strong> cui al precendente comma 2 sono com<strong>un</strong>icati,<br />
prima della loro approvazione, al Ministro dell'Ambiente, al Ministro <strong>per</strong> i beni<br />
culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della<br />
valutazione dell'impatto sull'Ambiente. (...)<br />
Comma 4. Il Ministero dell'Ambiente, sentita la Regione interessata, <strong>di</strong> concerto<br />
con il Ministro <strong>per</strong> i beni culturali e ambientali, si pron<strong>un</strong>cia sulla compatibilità<br />
ambientale nei successivi novanta giorni, (...)».<br />
Il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> compatibilità ambientale, come vedremo meglio in seguito,<br />
rappresenta <strong>un</strong>a componente <strong>di</strong> <strong>un</strong> processo che prevede momenti <strong>di</strong> analisi <strong>di</strong> natura<br />
prettamente tecnica, momenti <strong>di</strong> confronto con il pubblico e partecipazione e momenti<br />
<strong>di</strong> natura istituzionale, tra cui quello della “decisione”, che rimane com<strong>un</strong>que in ambito<br />
politico. Esso può avere quattro possibili esiti <strong>di</strong>versi. Infatti l’o<strong>per</strong>a proposta può avere<br />
<strong>un</strong> giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> compatibilità ambientale:<br />
positivo, nel senso che la realizzazione dell’o<strong>per</strong>a viene considerata<br />
compatibile con l’ambiente, quin<strong>di</strong> la procedura autorizzativa potrà<br />
continuare il suo iter;<br />
positivo con prescrizioni, nel senso che la realizzazione dell’o<strong>per</strong>a viene<br />
considerata compatibile con l’ambiente solo nel caso in cui il proponente si<br />
impegni a rispettare <strong>un</strong>a serie <strong>di</strong> prescrizioni (ad esempio relative a misure <strong>di</strong><br />
mitigazione da attuare) alle quali il parere positivo è stato vincolato;<br />
Pag. 78 <strong>di</strong> 148<br />
78
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
interlocutoria negativo; in questo caso non viene emesso <strong>un</strong> parere positivo<br />
non tanto <strong>per</strong>ché il progetto non viene ritenuto compatibile, ma <strong>per</strong>ché si<br />
ritiene che la documentazione prodotta non sia sufficiente <strong>per</strong> poter<br />
esprimere <strong>un</strong> parere definitivo. Proprio <strong>per</strong> questo il giu<strong>di</strong>zio è <strong>di</strong> natura<br />
interlocutoria ma, in assenza <strong>di</strong> <strong>un</strong> completamento della documentazione e <strong>di</strong><br />
<strong>un</strong> successivo parere positivo, ha gli effetti <strong>di</strong> <strong>un</strong> parere negativo;<br />
negativo, nel senso che, esaminata la documentazione presentata (che è<br />
ritenuta adeguata ad esprimere <strong>un</strong> giu<strong>di</strong>zio) e valutati i potenziali effetti dell’<br />
o<strong>per</strong>a sull’ambiente, questa viene ritenuta non compatibile, in quanto<br />
nemmeno con delle prescrizioni si riuscirebbe a ridurne l’impatto entro i<br />
limiti <strong>di</strong> accettabilità. Chiaramente, <strong>un</strong> giu<strong>di</strong>zio negativo può essere espresso<br />
anche in caso <strong>di</strong> inaccettabilità dovuta ad impatti indebiti, ecc., anche se in<br />
questo caso non si tratta <strong>di</strong> <strong>un</strong>a valutazione strettamente ambientale 83 .<br />
Introducendo il concetto <strong>di</strong> compatibilità ambientale abbiamo in precedenza<br />
evidenziato la necessità <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare criteri che <strong>per</strong>mettano <strong>di</strong> verificare con la<br />
maggiore obiettività possibile se <strong>un</strong> intervento <strong>di</strong>a luogo ad <strong>un</strong>a situazione<br />
ambientalmente compatibile, o meno.<br />
Per quanto riguarda il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> compatibilità ambientale nel panorama legislativo<br />
italiano, secondo il Malcevschi, «è necessario <strong>di</strong>stinguere il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> compatibilità<br />
ambientale esprimibile in sede tecnica della procedura complessiva <strong>di</strong> valutazione <strong>di</strong><br />
impatto ambientale, nonché dalla decisione finale sulla realizzabilità dell’intervento in<br />
progetto. Tali momenti possono essere amministrativamente ri<strong>un</strong>iti in <strong>un</strong> <strong>un</strong>ico<br />
proce<strong>di</strong>mento, o tenuti <strong>di</strong>stinti in proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong>versi»<br />
Infatti il giu<strong>di</strong>zio complessivo sulla valutazione <strong>di</strong> impatto ambientale può essere<br />
legato non solo a giu<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> natura tecnica, ma anche <strong>di</strong> natura politica. Ad esempio in<br />
alc<strong>un</strong>i casi la situazione a livello <strong>di</strong> pressione sul politico <strong>per</strong>ché intervenga può essere<br />
83 In realtà il problema dei criteri <strong>di</strong> verifica preventivi era particolarmente sentito soprattutto in passato,<br />
in assenza <strong>di</strong> <strong>un</strong>a normativa che si preoccupasse della valutazione ambientale delle scelte strategiche<br />
(ad esempio quelle legate alla pianificazione territoriale ed alla programmazione economica <strong>di</strong> settore)<br />
e in presenza <strong>di</strong> <strong>un</strong>a normativa sulla valutazione <strong>di</strong> impatto ambientale delle o<strong>per</strong>e che legava lo stu<strong>di</strong>o<br />
<strong>di</strong> impatto ambientale al momento del progetto <strong>di</strong> massima (cioè <strong>di</strong> <strong>un</strong> progetto praticamente<br />
definitivo), mentre invece si prevede anche <strong>un</strong> progetto preliminare con stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> pre-fattibilità<br />
ambientale, almeno <strong>per</strong> alc<strong>un</strong>i tipi <strong>di</strong> o<strong>per</strong>e. In passato i problemi legati alla giustificazione dell’o<strong>per</strong>a<br />
in termini della sua necessità ed adeguatezza a rispondere a determinati obiettivi erano legati alla<br />
redazione <strong>di</strong> <strong>un</strong> quadro programmatico <strong>di</strong> “ampio respiro”, quadro programmatico che adesso assume<br />
<strong>un</strong>a minore importanza. Queste problematiche verrano riprese ed approfon<strong>di</strong>te in seguito.<br />
Pag. 79 <strong>di</strong> 148<br />
79
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
tale <strong>per</strong> cui egli può decidere anche <strong>di</strong> accettare <strong>un</strong> intervento non considerato<br />
“compatibile”. Si pensi, ad esempio, ai molti casi in cui, essendo stata richiesta o decre-<br />
tata la chiusura <strong>di</strong> <strong>un</strong> impianto in quanto ritenuto inquinante in maniera inaccettabile, si<br />
è dovuti tornare in<strong>di</strong>etro a causa dell’opposizione della popolazione locale, che magari<br />
in quella fabbrica vedeva l’<strong>un</strong>ica possibilità <strong>di</strong> occupazione della zona.<br />
In altre parole, <strong>per</strong>ché <strong>un</strong> iter autorizzativo possa arrivare a buon fine devono essere<br />
espresse e sod<strong>di</strong>sfatte:<br />
• valutazioni <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne giuri<strong>di</strong>co;<br />
• valutazioni sull’efficacia delle soluzioni tecniche adottate;<br />
• valutazioni <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne economico (costi/benefici)<br />
• valutazioni <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne ambientale<br />
<strong>per</strong> cui il solo giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> compatibilità ambientale in senso stretto, anche se<br />
dovrebbe essere tenuto in debito conto in sede <strong>di</strong> autorizzazione, non è da solo<br />
sufficiente a consentire la realizzazione <strong>di</strong> <strong>un</strong>’o<strong>per</strong>a, in quanto la decisione finale sarà<br />
presa in altra sede. Vedremo in seguito come, pur essendo vero che la <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> si inserisce nel quadro <strong>di</strong> <strong>un</strong> proce<strong>di</strong>mento autorizzativo più ampio,<br />
valutazioni <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne giuri<strong>di</strong>co (ad esempio, verica del rispetto dei limiti <strong>di</strong> legge in<br />
campo <strong>di</strong> emissioni), <strong>di</strong> natura tecnica sull’efficacia delle soluzioni adottate (verifica<br />
che <strong>per</strong> come è stato tecnicamente progettato, l’intervento è in grado <strong>di</strong> raggi<strong>un</strong>gere gli<br />
obiettivi che si poneva) e <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne economico (ad esempio sulla razionalità della spesa<br />
anche in or<strong>di</strong>ne ai risultati conseguiti, soprattutto quando si parla <strong>di</strong> impiego <strong>di</strong> fon<strong>di</strong><br />
pubblici) siano state com<strong>un</strong>que inserite nelle linee guida dell’ANPA-Ministero dell’<br />
Ambiente <strong>per</strong> la <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong>. In questo caso non si tratta <strong>di</strong><br />
entrare in valutazioni <strong>di</strong> merito, che esulano dal campo della <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong><br />
<strong>Ambientale</strong>. Infatti, come mettono in evidenza le linee guida ANPA-Ministero<br />
dell’Ambiente, «Per quanto riguarda il primo gruppo (i criteri <strong>di</strong> verifica preventiva),<br />
essi attengono in realtà ad altri contesti valutativi (costi/benefici sul piano economico,<br />
fattibilità tecnologica). In sede <strong>di</strong> V.I.A. si tratterà quin<strong>di</strong> semplicemente <strong>di</strong> prendere<br />
atto del fatto che tali valutazioni siano effettivamente intervenute, <strong>per</strong> evitare che o<strong>per</strong>e<br />
inutili o tecnicamente sbagliate producano impatti indebiti (inutili, non necessari) sull’<br />
ambiente» 84<br />
84 ANPA-Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (2001) Linee guide V.I.A., parte generale,<br />
p. 17, scaricabile da internet<br />
Pag. 80 <strong>di</strong> 148<br />
80
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
Di seguito riportiamo <strong>un</strong>a breve carrellata <strong>di</strong> quelli che sono i criteri sui quali ci si<br />
può basare in sede <strong>di</strong> decisione (giu<strong>di</strong>zio) se <strong>un</strong> intervento è da ritenersi compatibile dal<br />
p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista ambientale. Infatti, come <strong>di</strong>ce il Malcevschi «occorre evitare che tale<br />
giu<strong>di</strong>zio sia troppo soggettivo, affidato alla sensibilità e all’es<strong>per</strong>ienza <strong>di</strong> chi deve<br />
valutare; sensibilità ed es<strong>per</strong>ienza possono variare enormemente tra <strong>per</strong>sona e <strong>per</strong>sona<br />
(…) Si rende opport<strong>un</strong>a <strong>un</strong>’esplicitazione dei possibili criteri, e <strong>un</strong> confronto che ne<br />
mostri i reciproci vantaggi e svantaggi». Le fonti utilizzate a tal proposito sono tre, il<br />
Malcevschi (<strong>di</strong>verse pubblicazioni) 85 , il La Camera e le linee guida <strong>per</strong> la VIA<br />
dell’ANPA-Ministero dell’Ambiente e <strong>per</strong> la Tutela del Territorio (MATT), occasio-<br />
nalmente integrate con altre fonti. Vedremo come, in realtà, alc<strong>un</strong>i criteri siano<br />
relativamente simili, o strettamente correlati tra <strong>di</strong> loro.<br />
Ricor<strong>di</strong>amo come <strong>un</strong> impatto tenda ad essere caratterizzato da varie “componenti”,<br />
quali: la fonte <strong>di</strong> interferenza (il progetto che la causa), il bersaglio colpito dall’<br />
interferenza (l’ambiente impattato), gli attori coinvolti nell’impatto (soggetti che, a<br />
titolo attivo – cioè con possibilità <strong>di</strong> intervenire – o a titolo passivo sono interessati<br />
dall’impatto). Così alc<strong>un</strong>i criteri si focalizzeranno sulle caratteristiche della sorgente<br />
(standard <strong>di</strong> emissione, BAT), altri sull’ambiente impattato (peggioramento<br />
significativo, ricettività ambientale), altri ancora sugli attori (accettazione sociale).<br />
L’applicazione dei <strong>di</strong>versi criteri avverrà in base alla natura dei casi specifici, oppure<br />
integrandone più <strong>di</strong> <strong>un</strong>o in maniera da eliminare i possibili rischi legati ai <strong>di</strong>fetti che<br />
ciasc<strong>un</strong>o <strong>di</strong> loro presenta. Infatti non esiste <strong>un</strong> criterio <strong>un</strong>ico, suscettibile <strong>di</strong> utilizzo<br />
ottimale in tutte le situazioni.<br />
Come messo precedentemente in evidenza, le linee guida ANPA-MATT iniziano<br />
l’esame dei <strong>di</strong>versi criteri cominciando dai cosiddetti CRITERI DI VERIFICA<br />
PREVENTIVA, <strong>di</strong> seguito descritti, criteri che non sono legati a problematiche<br />
strettamente ambientali ed hanno in parte <strong>per</strong>so <strong>di</strong> importanza (cfr. nota 83).<br />
«Inaccettabilità <strong>di</strong> impatti indebiti in caso <strong>di</strong> realizzazione <strong>di</strong> o<strong>per</strong>e non necessarie<br />
Qualora l’intervento in progetto non abbia <strong>un</strong>a effettiva giustificazione sotto il<br />
profilo socio-economico, gli impatti prodotti, <strong>di</strong> qual<strong>un</strong>que natura e livello siano, sono<br />
85 In assenza <strong>di</strong> specifiche citazioni, il materiale è generalmente tratto dalle o<strong>per</strong>e <strong>di</strong> Malcevschi (1991) e<br />
Schmidt <strong>di</strong> Friedberg e Malcevschi (1998), più volte ricordati e da Malcevschi, <strong>Impatto</strong> ambientale e<br />
compatibilità degli interventi, Genio Rurale, n. 6, 1993, pp. 61-68<br />
Pag. 81 <strong>di</strong> 148<br />
81
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
da considerare ingiustificati; essi infatti produrranno consumi ambientali e<br />
trasformazioni evitabili; ad esempio potrà essere inutile realizzare <strong>un</strong>a nuova<br />
infrastruttura stradale in <strong>un</strong> territorio già sufficientemente co<strong>per</strong>to dal p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista<br />
viabilistico, o che può essere convenientemente sostituito rafforzando il sistema<br />
ferroviario esistente. Impatti <strong>di</strong> questo tipo sono potenzialmente riscontrabili in tutte le<br />
categorie <strong>di</strong> progetti, e saranno tanto maggiori quanto maggiori si prevedono le<br />
<strong>di</strong>mensioni e le pressioni prodotte dal progetto.<br />
Inaccettabilità <strong>di</strong> impatti indebiti in caso <strong>di</strong> incapacità del progetto <strong>di</strong> rispondere ai<br />
suoi obiettivi tecnici<br />
Se il progetto non sarà in grado <strong>di</strong> rispondere ai suoi obiettivi tecnici si saranno<br />
prodotti impatti ingiustificati. Impatti <strong>di</strong> questo tipo sono potenzialmente riscontrabili in<br />
tutte le categorie <strong>di</strong> progetti. Ad esempio <strong>un</strong>a <strong>di</strong>ga il cui invaso non potrà essere<br />
riempito <strong>per</strong> l’esiguità degli apporti idrici preve<strong>di</strong>bili, o <strong>un</strong>’infrastruttura stradale <strong>di</strong><br />
gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni <strong>per</strong> cui si prevedono bassi livelli <strong>di</strong> traffico, comporteranno impatti<br />
ambientali inutili, quin<strong>di</strong> da evitare.<br />
Inaccettabilità <strong>di</strong> impatti indebiti legati alla scelta <strong>di</strong> soluzioni progettuali non ottimali<br />
o sovra<strong>di</strong>mensionate<br />
La scelta <strong>di</strong> <strong>un</strong>’opzione tecnica <strong>di</strong> base <strong>per</strong> cui esistano alternative più vantaggiose<br />
sotto il profilo ambientale, o <strong>un</strong> sovra<strong>di</strong>mensionamento del progetto rispetto agli<br />
obiettivi comporteranno la produzione <strong>di</strong> impatti indebiti (es. consumi non necessari <strong>di</strong><br />
suolo o altre risorse ambientali). Impatti <strong>di</strong> questo tipo sono potenzialmente<br />
riscontrabili in tutte le categorie <strong>di</strong> progetti, ma acquistano maggiore peso <strong>per</strong> quelle<br />
o<strong>per</strong>e che producono consistenti ingombri sul territorio. Ad esempio la sezione <strong>di</strong> <strong>un</strong>a<br />
nuova infrastruttura stradale potrà essere sovra<strong>di</strong>mensionata rispetto alle reali<br />
esigenze (quattro corsie invece <strong>di</strong> due), producendo impatti aggi<strong>un</strong>tivi che potrebbero<br />
essere evitati con <strong>un</strong> <strong>di</strong>mensionamento meno intrusivo nell’ambiente; o il progetto potrà<br />
prevedere elementi (es. svincoli) non necessari alla f<strong>un</strong>zionalità dell’o<strong>per</strong>a, quin<strong>di</strong><br />
suscettibili <strong>di</strong> produrre consumi indebiti <strong>di</strong> ambiente» 86 .<br />
Prima <strong>di</strong> entrare nel merito dei criteri legati specificatamente a progetto o ambiente,<br />
il documento ANPA-MATT mette in evidenza anche i criteri che possono portare ad <strong>un</strong><br />
86 ANPA-MATT (2001), Linee Guide V.I.A., parte generale, pp. 17-18<br />
Pag. 82 <strong>di</strong> 148<br />
82
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> compatibilità ambientale non positivo, in relazione ai contenuti del progetto<br />
e/o dello stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> impatto ambientale. Tali criteri vengono, quin<strong>di</strong>, legati «ALL’<br />
INADEGUATEZZA O INCOMPLETEZZA DEL LIVELLO PROGETTUALE AI FINI<br />
DELLA VALUTAZIONE<br />
Inaccettabilità <strong>di</strong> impatti evitabili conseguenti ad <strong>un</strong> livello progettuale troppo<br />
avanzato non più in grado <strong>di</strong> essere mo<strong>di</strong>ficato in elementi rilevanti ai fini degli<br />
effetti ambientali<br />
Qualora la VIA sia effettuata su <strong>un</strong> progetto troppo avanzato <strong>di</strong> <strong>un</strong>’o<strong>per</strong>a complessa<br />
sarà <strong>di</strong>fficile, in presenza <strong>di</strong> alternative migliori sotto il profilo localizzativo o<br />
tecnologico, mo<strong>di</strong>ficare il progetto stesso: occorrerà prevedere <strong>un</strong> nuovo progetto. Si<br />
tolgono così gra<strong>di</strong> <strong>di</strong> libertà alle possibilità <strong>di</strong> miglioramento progettuale ottenibili<br />
all’interno della procedura <strong>di</strong> VIA, sia in sede <strong>di</strong> produzione del progetto, sia me<strong>di</strong>ante<br />
sistemi prescrittivi. Aumenta così la probabilità <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> compatibilità ambientali<br />
negativi che avrebbero potuto essere evitati. Un esempio frequente è quello degli<br />
impatti indebiti prodotti dalla scelta <strong>di</strong> alternative localizzative (<strong>di</strong> sito o <strong>di</strong> tracciato)<br />
non ottimali. Qualora venga realizzato <strong>un</strong> progetto definitivo su localizzazioni che<br />
avevano alternative a minor impatto ambientale, si avranno impatti indebiti, che<br />
potevano essere evitati attraverso <strong>un</strong>a corretta trattazione in sede <strong>di</strong> progetto<br />
preliminare e <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> prefattibilità ambientale» 87 . Riprenderemo questo argomento<br />
al momento <strong>di</strong> trattare le problematiche generali relative alla valutazione ambientale, al<br />
p<strong>un</strong>to che riguarda il momento in cui collocare la VIA.<br />
«Inaccettabilità <strong>di</strong> rischi <strong>di</strong> impatto ambientale legato ad o<strong>per</strong>e connesse non ancora<br />
definite progettualmente che potranno comportare significativi effetti negativi.<br />
Il progetto presentato ai fini della VIA può essere solo <strong>un</strong>a sezione <strong>di</strong> <strong>un</strong> più<br />
complessivo sistema <strong>di</strong> interventi da realizzare. E’ possibile che elementi <strong>di</strong> tale<br />
sistema, ancora non precisati progettualmente ma necessari affinché il progetto in<br />
esame sia davvero f<strong>un</strong>zionale, provochino impatti ambientali significativi. Ad esempio<br />
<strong>un</strong> progetto stradale può costituire tratta parziale <strong>di</strong> <strong>un</strong> tracciato più generale <strong>di</strong> cui<br />
non è <strong>di</strong>sponibile il progetto completo; la sua approvazione potrà rendere in futuro<br />
obbligate, <strong>per</strong> il completamento dell’o<strong>per</strong>a, scelte tecniche (ad esempio legate alla<br />
connessione tra le <strong>di</strong>verse tratte) con implicazioni ambientali negative; <strong>un</strong>a <strong>di</strong>ga a fini<br />
irrigui dovrà essere affiancata da <strong>un</strong> sistema <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione dell’acqua non ancora<br />
87 ANPA-MATT (2001), Linee Guide V.I.A., parte generale, pp. 18<br />
Pag. 83 <strong>di</strong> 148<br />
83
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
definito; <strong>un</strong> pozzo <strong>di</strong> estrazione <strong>di</strong> idrocarburi potrà costituire solo <strong>un</strong> elemento <strong>di</strong> <strong>un</strong><br />
complesso sistema <strong>di</strong> o<strong>per</strong>e <strong>di</strong> connessione e trattamento delle sostanze estratte; la<br />
realizzazione <strong>di</strong> <strong>un</strong> cantiere potrà richiedere la realizzazione <strong>di</strong> strade <strong>di</strong> accesso non<br />
specificate progettualmente, ma potenzialmente in grado <strong>di</strong> produrre impatti negativi<br />
evitabili. Occorre <strong>per</strong>tanto, tendenzialmente, che la procedura <strong>di</strong> VIA esamini l’intero<br />
sistema <strong>di</strong> o<strong>per</strong>e interconnesse. Qualora non sia possibile, è com<strong>un</strong>que necessario<br />
<strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> analisi e valutazioni che consentano <strong>di</strong> escludere incompatibilità ambientali<br />
irrime<strong>di</strong>abili da parte delle o<strong>per</strong>e connesse.<br />
Inaccettabilità <strong>di</strong> impatti indebiti a causa del mantenimento <strong>di</strong> o<strong>per</strong>e esistenti non più<br />
necessarie a progetto realizzato<br />
Un progetto può prevedere la sostituzione o la <strong>di</strong>smissione <strong>di</strong> o<strong>per</strong>e esistenti senza<br />
definirne modalità <strong>di</strong> smantellamento o <strong>di</strong> riutilizzo. Ad esempio la realizzazione <strong>di</strong> <strong>un</strong><br />
nuovo elettrodotto può comportare l’abbandono <strong>di</strong> linee elettriche esistenti che, se non<br />
smantellate, <strong>per</strong>petueranno impatti (es. paesaggistici) a questo p<strong>un</strong>to evitabili; <strong>un</strong><br />
adeguamento stradale può comportare la sostituzione <strong>di</strong> tratti stradali esistenti che non<br />
verranno più utilizzati, <strong>per</strong> i quali si pone <strong>un</strong> problema <strong>di</strong> decommissioning <strong>per</strong> evitare<br />
impegni <strong>di</strong> ambiente non più giustificati» 88 .<br />
Il criterio dell’impatto nullo<br />
Passando ai criteri veri e propri, secondo il Malcevschi «Il criterio apparentemente<br />
più semplice e risolutivo è quello del “rischio e impatto zero”, ovvero accettare <strong>un</strong><br />
nuovo intervento solo qualora non produca alc<strong>un</strong> impatto indesiderato, o non comporti<br />
rischi negativi <strong>di</strong> alc<strong>un</strong> genere (…). Il criterio è <strong>di</strong> imme<strong>di</strong>ata comprensione e<br />
desiderabilità: sono considerati ambientalmente incompatibili e <strong>di</strong> conseguenza<br />
inaccettabili tutti gli interventi che comportano impatti <strong>di</strong>rettamente misurabili o<br />
riconoscibili in termini qualitativi o probabilistici».<br />
Abbiamo messo precedentemente in evidenza come qualsiasi azione, dal<br />
camminare, al voltare la pagina <strong>di</strong> <strong>un</strong> libro, crea <strong>un</strong>a serie <strong>di</strong> impatti, anche se non<br />
necessariamente significativi. In realtà si potrebbe pensare che gli impatti, anche se<br />
inevitabili, potrebbero essere successivamente mitigati in maniera che impatti e rischi<br />
residui risultino nulli. In realtà neanche questo è possibile, <strong>per</strong> cui tale criterio non è in<br />
realtà <strong>un</strong> vero criterio tecnico, ma <strong>un</strong> criterio politico, che esprime <strong>un</strong> principio ideale.<br />
88 ANPA-MATT (2001), Linee Guide V.I.A., parte generale, pp. 18-19<br />
Pag. 84 <strong>di</strong> 148<br />
84
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
Inoltre, evitare <strong>un</strong> qualsiasi tipo <strong>di</strong> impatto, in<strong>di</strong>pendentemente dal suo significato e<br />
<strong>di</strong>mensione, comporterebbe <strong>un</strong> “congelare” il mondo nel suo stato attuale, mondo che,<br />
anche prima della comparsa dell’uomo, è andato incontro a processi evolutivi a volte<br />
anche estremamente drastici nei loro effetti. Questo a volte può portare a delle posizioni<br />
provocatorie, ad esempio nella battuta che se l’uomo primitivo avesse utilizzato la<br />
valutazione <strong>di</strong> impatto ambientale, probabilmente pensando ad incen<strong>di</strong>, roghi delle<br />
streghe, ecc., non si sarebbe mai sognato <strong>di</strong> inventare il fuoco, ritenendolo <strong>un</strong>o<br />
strumento troppo impattante. Al <strong>di</strong> là del <strong>di</strong>battito sul fatto se sia meglio preservare o<br />
conservare l’ambiente, <strong>un</strong>a formulazione più razionale del criterio potrebbe specificare<br />
che la linea guida <strong>per</strong> accettare, o meno, <strong>un</strong> intervento <strong>di</strong> origine antropica sia quella <strong>di</strong><br />
verificare che non abbia impatti significativi e <strong>di</strong> tipo negativo. Infatti, <strong>di</strong> nuovo, non<br />
avrebbe alc<strong>un</strong> senso andare a limitare le azioni che provocano <strong>un</strong> innalzamento della<br />
qualità ambientale complessiva. In questo caso, come vedremo meglio in seguito, il<br />
criterio si “trasforma” in quello del peggioramento significativo.<br />
Data la manifesta insostenibilità dell’attuale comportamento umano, s’impone,<br />
com<strong>un</strong>que, l’esigenza <strong>di</strong> <strong>un</strong> cambiamento che porti a «“chiudere il cerchio”: questo<br />
significa ridurre gli impatti dell’uomo sulla terra. Le variabili su cui occorre agire, <strong>per</strong><br />
ridurle, sono tre: la popolazione, <strong>di</strong> modo che si fermi il ritmo <strong>di</strong> crescita e si stabilizzi;<br />
le abitu<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> consumo (in special modo nei Paesi industrializzati), <strong>di</strong> modo che al<br />
consumismo e allo spreco subentrino parsimonia e filosofia del riutilizzo; le tecnologie,<br />
che <strong>per</strong>mettano <strong>di</strong> riciclare, e <strong>di</strong> ridurre la quantità <strong>di</strong> energia e <strong>di</strong> materie <strong>per</strong> <strong>un</strong>ità <strong>di</strong><br />
prodotto» 89 . Se, quin<strong>di</strong>, il criterio <strong>di</strong> rischio ed impatto zero è da considerarsi<br />
semplicemente <strong>un</strong> principio ideale, praticamente <strong>di</strong> impossibile applicazione nella<br />
realtà, si può com<strong>un</strong>que concordare con il p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista <strong>di</strong> Nebbia «Per quanto sia<br />
impossibile, <strong>per</strong> elementari ragioni termo<strong>di</strong>namiche e chimico-fisiche, produrre e usare<br />
merci con “zero-rifiuti”, si tratta com<strong>un</strong>que <strong>di</strong> <strong>un</strong>a possibile provocazione e stimolo<br />
verso innovazioni che ci facciano uscire almeno da alc<strong>un</strong>e delle molte trappole in cui la<br />
miopia tecnologica del passato ci ha fatto cadere» 90 .<br />
I criteri, più realistici, che seguono appartengono a due gran<strong>di</strong> famiglie, quelli basati<br />
sul progetto e quin<strong>di</strong> sulla sorgente e quelli basati sull’ambiente, cioè sul bersaglio.<br />
89 F. Betti (2005), Dall’in<strong>di</strong>viduazione degli effetti esterni alla V.I.A.: strumenti e politiche <strong>per</strong> la <strong>di</strong>fesa<br />
dell’ambiente, tesi <strong>di</strong> laurea, Facoltà <strong>di</strong> Economia, Università <strong>di</strong> Pisa, p. 23<br />
90 Giorgio Nebbia, citato in Betti, op.cit., p. 24<br />
Pag. 85 <strong>di</strong> 148<br />
85
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
Continuando con la <strong>di</strong>sanima dei criteri incontriamo <strong>un</strong>a famiglia <strong>di</strong> criteri, che le<br />
linee guida ANPA-MATT definiscono “criteri tecnologici” e che fanno soprattutto<br />
riferimento alle caratteristiche del progetto. Tra questi, il primo criterio preso in esame è<br />
quello degli standard <strong>di</strong> emissione. In questa sede, anche <strong>per</strong> chiarire in parte come<br />
valutazioni <strong>di</strong> tipo tecnico interagiscono con valutazioni <strong>di</strong> tipo economico e politico<br />
(problema che si incontra molto spesso nella valutazione ambientale) abbiamo deciso <strong>di</strong><br />
de<strong>di</strong>care <strong>un</strong> po’ più <strong>di</strong> spazio agli standard, integrando la trattazione sintetica che <strong>di</strong><br />
questo problema fanno sia le linee guida dell’ANPA-MATT, sia i testi del Malcevschi.<br />
Per questo ampliamento della trattazione ci baseremo soprattutto sul Vismara 91 .<br />
Innanzitutto è bene mettere in evidenza come esistano standard <strong>di</strong>versi, il cui<br />
significato può essere maggiormente chiaro se si ricordano figura 1 e 2 ed il loro<br />
significato, in particolare il Vismara in<strong>di</strong>vidua:<br />
Standard <strong>di</strong> emissione, legati alla fonte <strong>di</strong> inquinamento, e relativi – ad<br />
esempio, ad emissioni gassose, emissioni idriche, emissioni solide, ecc. Tali<br />
standard sono, quin<strong>di</strong>, volti a regolare ad esempio la concentrazione <strong>di</strong> <strong>un</strong>a<br />
determinata sostanza inquinante (ad esempio l’anidride solforosa) nelle<br />
emissioni determinate da <strong>un</strong>’o<strong>per</strong>a;<br />
Standard ambientali, relativi in questo caso non alla concentrazione delle<br />
emissioni ma in alc<strong>un</strong>i bersagli primari, ad esempio componenti ambientali<br />
quali acqua, suolo, alimenti, ecc. Si potrebbe quin<strong>di</strong> <strong>di</strong>re che mentre gli<br />
standard <strong>di</strong> emissione sono legati al livello <strong>di</strong> interferenze provocate<br />
sull’ambiente, gli standard ambientali sono legati allo stato dell’ambiente<br />
stesso, in quanto ricettore le cui caratteristiche vengono mo<strong>di</strong>ficate dalle<br />
emissioni;<br />
Standard biologici e sanitari, relativi ad <strong>un</strong> bersaglio secondario, in questo<br />
caso rappresentato da <strong>un</strong> organismo od organo, il quale subirà gli effetti<br />
finali legati all’introduzione dell’inquinante nell’ambiente.<br />
In altre parole, come <strong>di</strong>ce il Vismara, «il controllo <strong>di</strong> <strong>un</strong> effetto dannoso<br />
sull’ambiente o sulla salute può essere ottenuto stabilendo delle barriere <strong>di</strong> sicurezza in<br />
termini standard, sia a livello dell’ origine dell’agente dannoso (la fonte) sia a livello<br />
della presenza nell’ambiente sia nell’organismo od organo bersaglio» 92 .<br />
91<br />
R. Vismara (2001), Protezione ambientale. Criteri e tecniche <strong>per</strong> la pianificazione territoriale, op. cit.<br />
92<br />
R. Vismara (2001), op. cit., p. 50<br />
Pag. 86 <strong>di</strong> 148<br />
86
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
In altri corsi avrete stu<strong>di</strong>ato l’approccio economico legato agli standard <strong>di</strong> emissione<br />
e come questo presupponga <strong>un</strong>a stima del costo marginale sociale (o danno marginale).<br />
In realtà non sempre è facile risalire all’in<strong>di</strong>viduazione del costo sociale legato a<br />
quantità crescenti <strong>di</strong> inquinamento (o produzione), su cui basarsi nello scegliere il<br />
livello che deve assumere lo standard <strong>per</strong> garantire la massima utilità sociale.<br />
Interessante, a tale proposito, può essere riprendere il prospetto relativo all’iter <strong>per</strong><br />
la definizione <strong>di</strong> <strong>un</strong>o standard ambientale o umano proposto dal Vismara 93 . In esso<br />
possiamo in<strong>di</strong>viduare tre fasi principali:<br />
<strong>Valutazione</strong> scientifica<br />
<strong>Valutazione</strong> del livello me<strong>di</strong>o ambientale naturale,<br />
Statistiche epidemiologiche<br />
Test tossicologici su animali, vegetali, uomo,<br />
Test <strong>di</strong> trasporto e trasformazione biotica ed abiotica,<br />
Stima della massima dose e concentrazione giornaliera,<br />
Stima <strong>di</strong> <strong>un</strong> fattore <strong>di</strong> sicurezza,<br />
Stima <strong>di</strong> <strong>un</strong> criterio <strong>di</strong> qualità biologico umano in f<strong>un</strong>zione<br />
dell’uso della risorsa,<br />
Proposta <strong>di</strong> standard <strong>di</strong> legge;<br />
<strong>Valutazione</strong> politica<br />
<strong>Valutazione</strong> delle priorità,<br />
<strong>Valutazione</strong> del costo economico,<br />
<strong>Valutazione</strong> dell’accettazione sociale delle conseguenze,<br />
<strong>Valutazione</strong> delle conseguenze impren<strong>di</strong>toriali,<br />
Attribuzione delle competenze sul problema alle <strong>di</strong>verse<br />
strutture pubbliche centrali e locali,<br />
Decisioni sulla sud<strong>di</strong>visione dei costi tra i vari soggetti,<br />
Scadenze temporali <strong>per</strong> il raggi<strong>un</strong>gimento dell’obiettivo,<br />
Verifica della coerenza con altri standard settoriali,<br />
Verifica <strong>di</strong> coerenza con le <strong>di</strong>rettive dell’UE,<br />
Decisione sull’adozione graduale <strong>di</strong> standard provvisori;<br />
Decisione politica<br />
Standard <strong>di</strong> legge<br />
Se ci concentriamo sulla parte relativa alla valutazione scientifica, ci ren<strong>di</strong>amo conto<br />
come il <strong>per</strong><strong>corso</strong> <strong>per</strong> determinare il potenziale danno legato ad <strong>un</strong>a sostanza inquinante<br />
alle <strong>di</strong>verse concentrazioni sia l<strong>un</strong>go e costellato da <strong>di</strong>fficoltà ed incertezza. D’altra<br />
parte, come sottolineato in precedenza, è impossibile in<strong>di</strong>viduare <strong>un</strong>o standard<br />
“ottimale” se non si in<strong>di</strong>viduano le conseguenze negative che la sostanza oggetto <strong>di</strong><br />
regolazione può provocare alle <strong>di</strong>verse concentrazioni. Infatti, se si stabiliscono<br />
93 R. Vismara, op. cit., p. 51<br />
Pag. 87 <strong>di</strong> 148<br />
87
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
standard irragionevolmente troppo “stretti” (cioè si limita la emissione o la<br />
concentrazione della sostanza nell’ambiente in maniera eccessiva rispetto alla sua<br />
potenziale <strong>per</strong>icolosità) si rischia <strong>di</strong> penalizzare l’attività che la produce (con<br />
conseguenti effetti negativi a livello economico-sociale <strong>per</strong> imprese e consumatori<br />
interessati) senza che da questo derivi <strong>un</strong> miglioramento della qualità ambientale<br />
sufficiente a compensare gli effetti negativi <strong>di</strong> tale penalizzazione. Viceversa, nel caso<br />
<strong>di</strong> standard troppo “larghi” si rischia <strong>di</strong> non tutelare adeguatamente l’ambiente.<br />
La valutazione scientifica dovrebbe partire da <strong>un</strong>o stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> quello che è il livello<br />
me<strong>di</strong>o ambientale naturale, proprio <strong>per</strong>ché le emissioni vanno ad alterare quella che è la<br />
situazione naturale in maniera più o meno significativa (vedremo meglio in seguito<br />
come variazioni non significative possano essere considerate trascurabili) e con effetti<br />
che <strong>di</strong>penderanno anche dal livello iniziale (se la situazione iniziale è già relativamente<br />
critica, gli effetti <strong>di</strong> ulteriori immissioni <strong>di</strong> inquinanti nell’ambiente possono essere<br />
molto più gravi che nel caso in cui la situazione iniziale presenti livelli <strong>di</strong> criticità<br />
trascurabili).<br />
Per valutare gli effetti <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi livelli <strong>di</strong> concentrazione <strong>di</strong> <strong>un</strong> inquinante nell’<br />
ambiente si può ricorrere a stu<strong>di</strong> epidemiologici, cioè ad analisi statistiche che cerchino<br />
<strong>di</strong> mettere in relazioni causa-effetto (cioè determinare quelli che sono gli effetti legati<br />
all’ass<strong>un</strong>zione/esposizione ad <strong>un</strong> determinato inquinante; relazione che può essere<br />
anche <strong>di</strong> tipo SI/NO) o, meglio ancora, le relazioni dose-risposta (cioè qual è il tipo <strong>di</strong><br />
effetto che si determina in <strong>di</strong>pendenza della dose <strong>di</strong> <strong>un</strong> determinato inquinante ass<strong>un</strong>ta,<br />
relazioni che dovrebbero essere <strong>di</strong> tipo quantitativo). Gli stu<strong>di</strong> epidemiologici, <strong>per</strong> ovvi<br />
motivi, in genere indagano le tossicità <strong>di</strong> tipo cronico. Essi «prendono in considerazione<br />
<strong>un</strong> elevato numero <strong>di</strong> <strong>per</strong>sone prese a campione tra la popolazione generale e<br />
analizzano le forme <strong>di</strong> esposizione a bassi livelli <strong>di</strong> inquinante attraverso il cibo,<br />
l’acqua, l’aria e gli alimenti. Gli stu<strong>di</strong> epidemiologici si basano <strong>per</strong>ciò sui livelli <strong>di</strong><br />
inquinamento in atto e non implicano dosaggi s<strong>per</strong>imentali. (…) Gli stu<strong>di</strong><br />
epidemiologici sono molto costosi in quanto il numero <strong>di</strong> esposti a basse dosi o<br />
concentrazioni <strong>di</strong> sostanze è molto più elevato degli esposti ad alta concentrazione. Il<br />
rilevamento <strong>di</strong> effetti sugli esposti a basse dosi o concentrazioni coinvolge l’analisi su<br />
<strong>un</strong> campione <strong>di</strong> <strong>un</strong> numero molto elevato <strong>di</strong> <strong>per</strong>sone, poiché la <strong>per</strong>centuale <strong>di</strong> effetti<br />
rilevabili è molto bassa. Spesso poi la esposizione a bassi livelli <strong>di</strong> sostanze chimiche è<br />
solo <strong>un</strong>a concausa o causa favorente <strong>un</strong> effetto sanitario dannoso. Tipico è il caso <strong>di</strong><br />
elevata incidenza <strong>di</strong> cancro polmonare in minatori <strong>di</strong> uranio o asbesto che è molto<br />
Pag. 88 <strong>di</strong> 148<br />
88
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
<strong>di</strong>fferente se confrontato tra fumatori e non fumatori. E’ bene quin<strong>di</strong> <strong>di</strong>re che (…) i<br />
risultati degli stu<strong>di</strong> epidemiologici si prestano ad <strong>un</strong> elevato livello <strong>di</strong> incertezza. La<br />
<strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> ottenere significative correlazioni dose/effetto è dovuta alla concomitante<br />
presenza <strong>di</strong> <strong>un</strong>a serie <strong>di</strong> fattori <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo:<br />
la eterogeneità della popolazione in termini <strong>di</strong> sensibilità all’agente, <strong>di</strong>fferente età e<br />
sesso degli esposti,<br />
le abitu<strong>di</strong>ni <strong>di</strong>fferenti <strong>di</strong> vita, in particolare de<strong>di</strong>zione al fumo e consumo <strong>di</strong> alcool,<br />
la possibilità <strong>di</strong> conoscere la precedente storia sanitaria dell’in<strong>di</strong>viduo (malattie<br />
riscontrate);<br />
la conoscenza delle attitu<strong>di</strong>ni alimentari passate e presenti;<br />
la <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare <strong>un</strong>a popolazione <strong>di</strong> confronto non esposta ma<br />
sostanzialmente simile alla prima<br />
(…) Dati più significativi <strong>di</strong> quelli ottenuti su <strong>un</strong>’intera popolazione possono essere<br />
ottenuti dagli stu<strong>di</strong> su esposti negli ambienti <strong>di</strong> lavoro» 94 .<br />
I limiti presentati dalle statistiche epidemiologiche fanno sì che spesso esse vengano<br />
affiancate o sostituite dai test tossicologici, soprattutto quelli effettuati su animali da<br />
laboratorio. Essi infatti presentano i vantaggi <strong>di</strong> poter essere effettuati ex ante (prima<br />
che la sostanza oggetto <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o sia immessa nell’ambiente), <strong>di</strong> avere <strong>un</strong> costo più<br />
ridotto, <strong>di</strong> poter ridurre i tempi delle indagini, ad esempio sugli effetti a livello genetico<br />
(data la <strong>di</strong>versità dei parametri riproduttivi quali età al quale inizia la riproduzione,<br />
durata della gravidanza, numero dei “figli” <strong>per</strong> covata, che caratterizza gli animali<br />
rispetto all’uomo e che consente sia <strong>di</strong> lavorare su materiale <strong>di</strong> partenza geneticamente<br />
più omogeneo, sia <strong>di</strong> accorciare i tempi richiesti <strong>per</strong> rilevare gli effetti), <strong>di</strong> consentire<br />
test <strong>di</strong> laboratorio più accurati. In genere i test <strong>di</strong> laboratorio riguardano sia la tossicità<br />
cronica che quella <strong>di</strong> tipo acuto che possono anche essere <strong>di</strong>fferenziate rispetto alle vie<br />
<strong>di</strong> ingresso nell’organismo. In particolare si <strong>di</strong>stingue tra tossicità orale (<strong>per</strong> ingestione),<br />
tossicità <strong>per</strong> inalazione (quando si indagano gli effetti negativi <strong>di</strong> “respirare” la sostanza<br />
tossica), tossicità <strong>per</strong> contatto (quando penetra <strong>per</strong> via cutanea). Chiaramente, la via <strong>di</strong><br />
ingresso della sostanza non è neutrale rispetto alla sua <strong>per</strong>icolosità: se mi sto occupando<br />
<strong>di</strong> prodotti quali gli insettici<strong>di</strong>, sarà molto più probabile avere incidenti legati alla<br />
inalazione del prodotto (<strong>per</strong> mancato uso della cabina sul trattore o della maschera<br />
durante il trattamento) piuttosto che all’ingestione.<br />
94 R. Vismara, op. cit., p. 86<br />
Pag. 89 <strong>di</strong> 148<br />
89
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
In genere la <strong>per</strong>icolosità acuta <strong>di</strong> <strong>un</strong>a sostanza (<strong>di</strong>fferenziata a seconda che si tratti <strong>di</strong><br />
tossicità orale, cutanea, ecc.) viene espressa attraverso la DL50, che rappresenta la Dose<br />
Letale che causa la morte del 50% della popolazione ad essa esposta. Tale parametro in<br />
genere viene espresso in milligrammi <strong>per</strong> chilogrammo <strong>di</strong> peso vivo, <strong>per</strong> in<strong>di</strong>care che<br />
gli effetti che si avranno su <strong>un</strong> in<strong>di</strong>viduo <strong>di</strong>penderanno dalla concentrazione della<br />
sostanza tossica nel suo organismo e quin<strong>di</strong> saranno in relazione al suo peso.<br />
Per quanto riguarda i test <strong>di</strong> trasporto e <strong>di</strong> trasformazione biotica ed abiotica, questi<br />
sono relativi principalmente a due tipi <strong>di</strong> problematiche, che sono quelle relative agli<br />
effetti dei metaboliti <strong>di</strong> <strong>un</strong>a particolare sostanza inquinante ed alle sue vie <strong>di</strong> ingresso (e<br />
<strong>di</strong> “<strong>di</strong>stribuzione” nell’ambiente; le cosidette “vie critiche”). Infatti, <strong>un</strong>a sostanza<br />
immessa nell’ambiente può rimanere inalterata <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>per</strong>iodo più o meno l<strong>un</strong>go <strong>di</strong><br />
tempo (in <strong>di</strong>pendenza del suo grado <strong>di</strong> <strong>per</strong>sistenza) o può andare incontro a<br />
trasformazioni <strong>di</strong> entità <strong>di</strong>versa, che possono risultare nella sua degradazione in<br />
sostanze innocue o nella sua trasformazione in metaboliti che possono essere anche più<br />
<strong>per</strong>icolosi della sostanza <strong>di</strong> partenza. Inoltre, il tipo <strong>di</strong> meccanismo con il quale le<br />
sostanze o<strong>per</strong>ano e si trasformano può anche influenzare il tipo <strong>di</strong> “organo bersaglio”<br />
che verrà colpito in via prioritaria. Riassumendo, come mette in evidenza il Vismara,<br />
«l’effetto tossico può essere esercitato su organi o tessuti dalla sostanza originaria, da<br />
<strong>un</strong> suo derivato, da <strong>un</strong> suo metabolita, da <strong>un</strong> suo prodotto <strong>di</strong> degradazione. (…)<br />
L’azione del tossico non viene esercitata su tutti gli organi, ma soprattutto su quelli ove<br />
avviene <strong>un</strong>a attiva metabolizzazione o <strong>un</strong> bioaccumulo 95 , spesso a causa della<br />
somiglianza molecolare con composti naturali. Detti organi sono definiti come organi<br />
bersaglio.»<br />
95 Particolare importanza rivestono i problemi legati alla concentrazione <strong>di</strong> sostanze tossiche l<strong>un</strong>go le<br />
catene alimentari. Ad esempio il Vismara (citando Odum), p. 18, riporta il caso <strong>di</strong> concentrazione del<br />
DDT, in<strong>di</strong>cando i seguenti valori (espressi in ppm/peso in<strong>di</strong>viduo <strong>di</strong> residui del DDT): Acqua: 0,00005;<br />
Plancton: 0,04; Pesce ciprinide: 0,23; Altro pesce ciprinide: 0,94; Luccio (predatori): 1,33; Pesce ago<br />
(predatori): 2,07; Airone (si nutre <strong>di</strong> piccoli animali): 3,57; Ron<strong>di</strong>ne marina (si nutre <strong>di</strong> piccoli animali):<br />
3,91; Gabbiano (si nutre <strong>di</strong> rifiuti): 6,00; Uova <strong>di</strong> procellaria: 13,80; Smergo (si nutre <strong>di</strong> pesci): 22,80;<br />
Cormorano (si nutre <strong>di</strong> pesci): 26,40. Il fenomeno della concentrazione del DDT è dovuto al fatto che,<br />
ad ogni anello della catena trofica solo il 10% della biomassa viene conservata, mentre la sostanza<br />
tossica, essendo liposolubile, non viene eliminata con i processi <strong>di</strong> escrezione, ma tende ad accumularsi<br />
nei grassi. Quin<strong>di</strong>, ogni volta che si passa ad <strong>un</strong> livello su<strong>per</strong>iore nella catena trofica, la sostanza tende<br />
ad assumere concentrazioni 10 volte più elevate (se inizialmente c’era 1 parte <strong>di</strong> DDT su 100 <strong>di</strong><br />
biomassa, con <strong>un</strong>a concentrazione dell’1%, e passando al livello trofico su<strong>per</strong>iore si ha la <strong>per</strong><strong>di</strong>ta del<br />
90% <strong>di</strong> biomassa, della sostanza ingerita rimarra 1 parte <strong>di</strong> DDT e 10 <strong>di</strong> biomassa, con <strong>un</strong>a concentrazione<br />
del 10%, cioè <strong>di</strong> 10 volte su<strong>per</strong>iore. E così <strong>per</strong> ogni livello successivo della catena trofica.<br />
Questo può comportare che livelli <strong>di</strong> inquinamento dell’acqua assolutamente innocui rispetto ad <strong>un</strong><br />
utilizzo <strong>di</strong>retto umano, possano risultare in effetti molto gravi se la sostanza contenuta nell’ acqua viene<br />
a concentrarsi l<strong>un</strong>go la catena alimentare, in quanto l’uomo, come consumatore finale, ingerirà degli<br />
alimenti (pesci, uccelli, ecc.) in cui la sostanza risulta molto più concentrata.<br />
Pag. 90 <strong>di</strong> 148<br />
90
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
Per quanto riguarda i problemi relativi alla sorte della sostanza <strong>un</strong>a volta immessa<br />
nell’ambiente (che verranno riprese in parte nel secondo modulo, parlando dei “modelli<br />
<strong>di</strong> ripartizione”), in questa sede ci preme soprattutto concentrarci sulle vie <strong>di</strong> ingresso,<br />
ricordando come «la quantità <strong>di</strong> tossico che raggi<strong>un</strong>ge l’organo bersaglio, vi può<br />
<strong>per</strong>venire attraverso vie <strong>di</strong>verse, <strong>per</strong> cui, a fronte della necessità <strong>di</strong> stabilire valori<br />
soglia ammissibili <strong>per</strong> comparti settoriali (aria, acqua, cibo), è necessaria <strong>un</strong>a verifica<br />
della quantità totale ass<strong>un</strong>ta e assumibile» 96 .<br />
I parametri relativi alla tossicità, oltre che alla dose letale, possono essere legati ad<br />
<strong>un</strong> altro tipo <strong>di</strong> parametro, che è il NOAEL,cioè il NO OBSERVED ADVERSE<br />
EFFECT LEVEL, cioè il livello massimo <strong>di</strong> dose ass<strong>un</strong>ta che non causa effetti negativi<br />
osservati. Tale livello definisce (in relazione al peso corporeo) la massima quantità che<br />
<strong>un</strong> soggetto può assumere giornalmente senza avere effetti indesiderati. In altre parole,<br />
conoscendo questo parametro è possibile stabilire l’ADI , o ADMISSIBLE DAILY<br />
INTAKE, cioè la massima ass<strong>un</strong>zione giornaliera che non causa effetti. Da questo, <strong>per</strong><br />
risalire, ad esempio, alla concentrazione <strong>di</strong> <strong>un</strong>a determinata sostanza che può essere<br />
accettata in <strong>un</strong> alimento, bisognerebbe conoscere le vie <strong>di</strong> ass<strong>un</strong>zione <strong>di</strong> tale sostanza<br />
(che si presuppone legate alla <strong>di</strong>eta), tenendo presente che possono esservi gruppi <strong>di</strong><br />
popolazione particolarmente sensibili (<strong>per</strong> caratteristiche fisiologiche, ma anche <strong>per</strong>ché<br />
– <strong>per</strong> necessità o scelta – presentano delle <strong>di</strong>ete <strong>di</strong> tipo particolare, <strong>di</strong>verse dalle “<strong>di</strong>ete<br />
me<strong>di</strong>e”, si pensi ai lattanti o ai vegetariani) alla sostanza.<br />
In realtà, i parametri sopra ricordati vengono messi a p<strong>un</strong>to con test tossicologici<br />
sugli animali (o tramite test tossicologici) che hanno <strong>un</strong> grado <strong>di</strong> incertezza più o meno<br />
rilevante; <strong>per</strong> questo, in genere, si tiene conto <strong>di</strong> <strong>un</strong> fattore <strong>di</strong> sicurezza, che può variare<br />
a seconda del grado <strong>di</strong> fiducia ed affidabilità delle informazioni <strong>di</strong> partenza (ad<br />
esempio, la massima concentrazione ammissibile può essere ridotta in base ad <strong>un</strong> fattore<br />
pari a 10, 100 o 1000, cioè portandola ad <strong>un</strong> decimo, <strong>un</strong> centesimo, ecc. <strong>di</strong> quella<br />
calcolata in base ai parametri sopra descritti, <strong>per</strong> tenere conto, ad esempio, dei problemi<br />
<strong>di</strong> incertezza nel trasferimento dei risultati dei test sugli animali all’uomo).<br />
Per quanto riguarda la stima <strong>di</strong> <strong>un</strong> criterio <strong>di</strong> qualità biologico umano in f<strong>un</strong>zione<br />
dell’uso della risorsa, potremmo riferirci al fatto che <strong>un</strong>a stessa risorsa può avere utilizzi<br />
plurimi; ad esempio l’acqua non solo viene utilizzata ai fini potabili, ma ha anche <strong>un</strong>a<br />
sua rilevanza ai fini ricreazionali (balneazione), industriali, agricoli. Nella parte<br />
96 R. Vismara, op. cit., p. 90<br />
Pag. 91 <strong>di</strong> 148<br />
91
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
precedente noi ci siamo concentrati sull’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> <strong>un</strong>o standard legato alla<br />
salute umana riferendoci ad <strong>un</strong> prodotto destinato ad essere ingerito (quin<strong>di</strong>, legato<br />
all’alimentazione), ma è chiaro come ci possa essere la necessità <strong>di</strong> fissare degli<br />
standard anche legati ad <strong>un</strong> uso <strong>di</strong>verso dell’acqua. In questo caso, chiaramente, le<br />
sostanze prese in esame ed i livelli massimi <strong>di</strong> legge previsti potranno anche essere<br />
molto <strong>di</strong>versi.<br />
In <strong>di</strong>pendenza <strong>di</strong> quanto sopra esposto, il gruppo che ha effettuato la valutazione<br />
scientifica potrà proporre <strong>un</strong>o standard <strong>di</strong> legge (magari <strong>di</strong>fferenziandolo a seconda<br />
dell’uso della risorsa, in caso <strong>di</strong> usi plurimi).<br />
Come abbiamo visto dallo schema del Vismara, il problema non si ferma qui, nel<br />
senso che alla valutazione scientifica ne deve seguire <strong>un</strong>a <strong>di</strong> natura politica. Senza<br />
entrare nel dettaglio, mettiamo in evidenza come l’o<strong>per</strong>azione <strong>di</strong> implementazione degli<br />
standard non sia a costo zero, nel senso che già tutta la fase scientifica prevede <strong>un</strong> costo<br />
non in<strong>di</strong>fferente, ma anche la fase <strong>di</strong> “messa in forza” dello standard richiederà costi, se<br />
non altro <strong>per</strong> il controllo del rispetto degli standard stessi. A tal proposito ci potranno<br />
essere problemi <strong>di</strong> attribuzioni <strong>di</strong> competenze alle varie strutture ed anche <strong>di</strong><br />
ripartizione dei costi, costi che – a seconda della situazione contingente – potranno<br />
gravare sulle imprese (che devono sopportare costi maggiori <strong>per</strong> rispettare gli standard),<br />
sui consumatori (ad esempio, nel caso che le imprese siano in grado <strong>di</strong> scaricare il<br />
maggior costo sul prezzo <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta del prodotto) o sui citta<strong>di</strong>ni in complesso (nel caso<br />
che il gettito fiscale debba finanziare le ricerche e le attività <strong>di</strong> controllo). Tra l’altro<br />
esiste <strong>un</strong>a miriade <strong>di</strong> sostanze potenzialmente nocive, <strong>per</strong> cui non è pensabile che si<br />
possa applicare il sistema degli standard a tutte, <strong>per</strong>ché tale o<strong>per</strong>azione non sarebbe<br />
“realistica”. Al limite si potrebbe pensare che il costo <strong>di</strong> implementazione e gestione <strong>di</strong><br />
<strong>un</strong> sistema <strong>di</strong> standard che copra tutte le possibili sostanze inquinanti possa ad<strong>di</strong>rittura<br />
essere “più elevato” rispetto al danno creato dall’inquinamento. Bisogna, quin<strong>di</strong>, che a<br />
livello politico vengano fissate delle priorità che in<strong>di</strong>viduino quelli che sono le sostanze<br />
o i comparti ambientali su cui concentrare l’attenzione. Chiaramente, selezionando solo<br />
alc<strong>un</strong>i standard, bisogna verificare che non ci siano trasferimenti indebiti <strong>di</strong> inquina-<br />
mento da <strong>un</strong> comparto all’altro 97 e <strong>di</strong> essere in linea con le <strong>di</strong>rettive dell’Unione<br />
Europea, non solo <strong>per</strong> <strong>un</strong> problema <strong>di</strong> norme imposte, ma anche <strong>per</strong> i problemi <strong>di</strong><br />
97 E’ <strong>un</strong>o degli obiettivi della <strong>di</strong>rettiva 96/61/CE “IPPC” (Integrated Pollution Prevention Control), che ha<br />
come obiettivo proprio quello <strong>di</strong> considerare l’inquinamento in <strong>un</strong>a visione complessiva, impedendo il<br />
trasferimento <strong>di</strong> “pressioni” tra aria, acqua e suolo dovuto a normative a <strong>di</strong>verso grado <strong>di</strong> “severità” nei<br />
<strong>di</strong>versi comparti.<br />
Pag. 92 <strong>di</strong> 148<br />
92
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
concorrenza e <strong>di</strong> riallocazione delle attività produttive in specifici Paesi legati ad <strong>un</strong>a<br />
normativa più o meno restrittiva rispetto all’ambiente. Infine, non si potrà proporre <strong>un</strong><br />
raggi<strong>un</strong>gimento istantaneo dello standard (in genere non è possibile mettere fuori legge<br />
da <strong>un</strong> giorno all’altro delle attività produttive introducendo degli standard <strong>di</strong> emissione<br />
più restrittivi che entrino in forza da subito, senza prevedere <strong>un</strong> <strong>per</strong>iodo <strong>per</strong><br />
l’adeguamento degli impianti. A maggior ragione, se si parla <strong>di</strong> standard ambientali,<br />
sarà <strong>di</strong>fficile prevedere in forza <strong>di</strong> legge che la concentrazione <strong>di</strong> <strong>un</strong>a sostanza<br />
nell’ambiente venga ridotta “istantaneamente”. Infine, ci possono essere anche problemi<br />
<strong>di</strong> accettazione sociale delle conseguenze dell’introduzione <strong>di</strong> <strong>un</strong>o standard. Ad<br />
esempio, <strong>per</strong> quanto riguarda l’adeguamento “istantaneo” <strong>di</strong> cui sopra, si potrebbe<br />
pensare che questo non crea problemi, nel senso che se io – ad esempio – <strong>di</strong>minuisco la<br />
quantità <strong>di</strong> <strong>un</strong>a determinata sostanza accettata nell’acqua <strong>per</strong>ché questa possa essere<br />
considerata potabile, <strong>un</strong>’applicazione istantanea comporterebbe semplicemente la non<br />
potabilità <strong>di</strong> alc<strong>un</strong>e acque che prima lo erano. Solo che se questo comporta il fatto che<br />
vaste zone, precedentemente dotate <strong>di</strong> acqua potabile, si trovino <strong>di</strong> p<strong>un</strong>to in bianco a<br />
dover ricorrere ad altre fonti <strong>di</strong> approvvigionamento (autobotti, acqua minerale, ecc.) il<br />
forte <strong>di</strong>sagio può creare problemi <strong>di</strong> accettazione sociale. Ugualmente, come abbiamo<br />
messo in evidenza, problemi <strong>di</strong> accettazione sociale si possono avere nel caso che<br />
l’applicazione degli standard porti alla chiusura <strong>di</strong> attività produttive (<strong>per</strong> problemi<br />
occupazionali) o al <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> consumo care ai consumatori (ad esempio il<br />
<strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> fumo nei locali pubblici).<br />
Rispetto agli standard, inoltre, il decisore politico può utilizzare degli approcci<br />
<strong>di</strong>versi, può cioè definire:<br />
<strong>un</strong> valore im<strong>per</strong>ativo da non su<strong>per</strong>are in ogni caso, pena il sanzionamento,<br />
<strong>un</strong> valore guida (più basso rispetto al precedente), inteso come valore obiettivo che<br />
sarebbe meglio non su<strong>per</strong>are<br />
Un’ultima cosa che vale la pena <strong>di</strong> ricordare, anche se legata soprattutto all’ambito<br />
tecnico, è la <strong>di</strong>pendenza dei risultati delle analisi dalla strumentazione adottata in<br />
quanto, a seconda della strumentazione <strong>di</strong>sponibile, ci sono livelli <strong>di</strong> concentrazione<br />
minimi al <strong>di</strong> sotto dei quali non è possibile rilevare <strong>un</strong>a sostanza nell’ambiente.<br />
Chiaramente non avrà senso stabilire degli standard che fissano delle concentrazioni<br />
massime ad <strong>un</strong> livello che non è rilevabile dallo strumento. Inoltre si dovrà anche tenere<br />
conto che i <strong>di</strong>versi strumenti possono avere <strong>un</strong> <strong>di</strong>verso grado <strong>di</strong> precisione e <strong>di</strong><br />
accuratezza nella misura della concentrazione della sostanza (nel senso che, effettuando<br />
Pag. 93 <strong>di</strong> 148<br />
93
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
più rilievi su <strong>un</strong>o stesso campione, non necessariamente si otterra lo stesso risultato e<br />
non necessariamente i risultati ottenuti si <strong>di</strong>stribuiranno più o meno <strong>un</strong>iformemente<br />
intorno ad <strong>un</strong> valore centrale) 98 . Anche <strong>di</strong> questo bisognerà tenere conto in sede <strong>di</strong><br />
fissazione degli standard, in quanto <strong>un</strong>o standard del quale non è possibile controllare il<br />
rispetto è sicuramente <strong>un</strong>o standard irrazionale. Per concludere, il Vismara mette in<br />
evidenza le seguenti problematiche a proposito degli standard <strong>di</strong> qualità ambientale:<br />
«L’aspetto scientifico del problema è rappresentato dall’esigenza <strong>di</strong> co<strong>di</strong>ficare <strong>un</strong>a<br />
metodologia standar<strong>di</strong>zzata <strong>per</strong> i singoli sottocomparti ambientali onde arrivare a<br />
stime sempre più accurate, affidabili, veloci e previsionali, della dose o concentrazione<br />
<strong>di</strong> non effetto. Il secondo aspetto importante e fose mai completamente risolvibile, è<br />
costituito dalla ricerca <strong>di</strong> <strong>un</strong>a definizione accettata, concordemente da tutte le parti in<br />
causa (scientifiche, impren<strong>di</strong>toriali, politiche, sociali) <strong>di</strong> cosa si debba intendere <strong>per</strong><br />
soglia <strong>di</strong> livello <strong>di</strong> dose o concentrazione <strong>di</strong> ness<strong>un</strong> effetto indesiderato. Se è già <strong>di</strong>fficile<br />
stabilire tale soglia sulla base dei soli effetti sanitari sull’uomo, specie considerando<br />
quelli secondari, a l<strong>un</strong>go termine, e generazionali, appare <strong>un</strong>’impresa miracolosa<br />
tenere conto <strong>di</strong> tali effetti anche sull’ambiente bioltico globale (effetti fisiologici su altri<br />
organismi viventi). Ciò nonostante, la politica e la scienza dell’ambiente si muovono<br />
coraggiosamente in questa <strong>di</strong>rezione, pur mantenendo sempre come standard prioritari<br />
e maggiormente vincolanti quelli <strong>per</strong> la salute umana» 99 .<br />
Gli standard <strong>di</strong> emissione (mancato rispetto degli standard <strong>di</strong> legge <strong>per</strong> le emissioni)<br />
Il criterio degli standard <strong>di</strong> emissione è stato ed è tuttora applicato nell’ambito della<br />
legislazione ambientale, soprattutto <strong>per</strong> quanto riguarda la <strong>di</strong>fesa dall’inquinamento dei<br />
<strong>di</strong>versi macrocompartimenti ambientali (aria, acqua, suolo).<br />
Gli standard <strong>di</strong> emissione costituiscono, come abbiamo visto, delle soglie massime<br />
<strong>di</strong> emissione <strong>di</strong> determinate sostanze che possono essere accettate nei fumi, negli<br />
scarichi idrici, ecc. Come abbiamo visto in precedenza, il danno ambientale non è<br />
<strong>di</strong>rettamente conseguente dalla emissione, ma <strong>di</strong>pende dalla concentrazione<br />
dell’inquinante che causerà nell’ambiente in cui si viene a <strong>di</strong>s<strong>per</strong>dere e dalle<br />
98 Il Vismara dà le seguenti definizioni: «Limite <strong>di</strong> rilevamento: il valore minimo del parametro<br />
esaminato che può essere rilevato con i meto<strong>di</strong> in<strong>di</strong>cati. Valori inferiori a tale valore non sono<br />
tecnicamente significativi; Precisione: l’intervallo statistico entro cui deve trovarsi il 95% dei risultati<br />
delle misurazioni eseguite su <strong>un</strong>o stesso campione, seguendo sempre lo stesso metodo; Accuratezza: la<br />
<strong>di</strong>fferenza tra il valore reale del parametro esaminato e il valore me<strong>di</strong>o s<strong>per</strong>imentale ottenuto da<br />
<strong>di</strong>verse misure su <strong>un</strong>o stesso campione», op. cit., p. 85<br />
99 Vismara, op.cit., pp. 83-84<br />
Pag. 94 <strong>di</strong> 148<br />
94
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
caratteristiche dell’ambiente stesso (più o meno vulnerabile, caratterizzato da<br />
componenti più o meno rare, ecc.). E’, <strong>di</strong> conseguenza, <strong>di</strong>fficile in<strong>di</strong>viduare <strong>un</strong>a soglia<br />
<strong>di</strong> concentrazione che assicuri la mancata verifica <strong>di</strong> impatti negativi significativi senza<br />
imporre restrizioni eccessive o indebite alle attività produttive. In alc<strong>un</strong>i casi, inoltre, ci<br />
sono stati problemi <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>bilità delle soglie <strong>per</strong>ché spesso esse vengono stabilite a<br />
livello politico, senza tenere in adeguata considerazione la valutazione scientifica, <strong>per</strong><br />
cui in momenti <strong>di</strong> “pressione” sul decisore pubblico possono essere variate senza<br />
<strong>un</strong>’apparente giustificazione tecnica. Emblematico è il caso dell’atrazina, quando, <strong>per</strong><br />
gli elevati costi <strong>di</strong> rifornimento <strong>di</strong> acqua potabile in zone <strong>di</strong> pianura la cui falda era<br />
caratterizzata da contenuti in atrazina su<strong>per</strong>iori a quelli previsti dalla legge, si risolse il<br />
problema innalzando la soglia <strong>di</strong> atrazina che poteva essere contenuta nell’acqua<br />
potabile, rendendo l’acqua dei pozzi <strong>di</strong> nuovo utilizzabile.<br />
Il criterio in sé e <strong>per</strong> sé sembrerebbe <strong>di</strong> facile applicazione, in quanto impone<br />
soltanto <strong>di</strong> controllare che la concentrazione <strong>di</strong> determinate emissioni alla fonte (ad<br />
esempio, livelli <strong>di</strong> inquinanti negli scarichi idrici <strong>di</strong> <strong>un</strong>a fabbrica, livelli <strong>di</strong><br />
concentrazione <strong>di</strong> inquinanti nei fumi, livelli <strong>di</strong> inquinamento acustico) non su<strong>per</strong>i <strong>un</strong><br />
livello prestabilito. Il problema nasce dall’elevato numero <strong>di</strong> sostanze da sottoporre a<br />
limitazione e controllo, <strong>per</strong> le quali andrebbe verificata la concentrazione negli scarichi<br />
in tutti gli impianti potenzialmente inquinanti in maniera da poter garantire il rispetto<br />
dello standard nel tempo (ve<strong>di</strong>, ad esempio, revisione <strong>per</strong>io<strong>di</strong>ca delle caldaie da<br />
riscaldamento nelle abitazioni). In alc<strong>un</strong>i casi (ad esempio uso <strong>di</strong> depuratori <strong>per</strong><br />
garantire il rispetto degli standard) in assenza <strong>di</strong> controlli, se è possibile contenere i<br />
costi <strong>di</strong> gestione <strong>di</strong>sattivando gli impianti <strong>di</strong> depurazione, gli impren<strong>di</strong>tori possono<br />
essere tentati <strong>di</strong> farlo. Considerando il grande numero <strong>di</strong> <strong>un</strong>ità potenzialmente<br />
inquinanti, il problema del controllo non è trascurabile, sia in termini <strong>di</strong> impegno <strong>di</strong><br />
<strong>per</strong>sonale che <strong>di</strong> costi.<br />
Come abbiamo già accennato, il criterio è basato esclusivamente sul progetto, nel<br />
senso che sono le caratteristiche tecniche dell’impianto a determinare la concentrazione<br />
<strong>di</strong> inquinanti emessi; in altre parole, si esamina solo la fonte <strong>di</strong> emissione. Non andando<br />
a stu<strong>di</strong>are l’ambiente, ma solo la sorgente, gli standard <strong>di</strong> emissione non tengono conto<br />
degli effetti cumulativi, mentre invece l’impatto conseguente l’attività non sarà f<strong>un</strong>zione<br />
soltanto della concentrazione <strong>di</strong> inquinante nei reflui del singolo impianto, ecc., ma<br />
anche della <strong>di</strong>mensione dell’attività (e, quin<strong>di</strong>, dell’entità degli scarichi complessivi, che<br />
andranno a incidere – <strong>un</strong>itamente alla concentrazione – sul volume complessivo <strong>di</strong><br />
Pag. 95 <strong>di</strong> 148<br />
95
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
inquinante immesso nell’ambiente dalla singola attività) e del fatto che essa venga a<br />
localizzarsi, o meno, in <strong>un</strong>’area in cui esistono altre sorgenti <strong>di</strong> inquinamento il cui<br />
effetto andrà a sommarsi a quello dell’attività in esame. Inoltre, esso non è in grado <strong>di</strong><br />
tenere conto delle caratteristiche dell’ambiente in cui gli inquinanti vengono immessi,<br />
ad esempio del livello <strong>di</strong> pregio o <strong>di</strong> criticità. Se questo ne facilita l’applicazione, in<br />
quanto non è necessario <strong>un</strong>o stu<strong>di</strong>o della qualità ambientale specifica dei <strong>di</strong>versi<br />
ambienti ed <strong>un</strong>a <strong>di</strong>versificazione delle norme <strong>per</strong> le <strong>di</strong>verse aree, sicuramente rende<br />
meno sod<strong>di</strong>sfacente l’utilizzo del criterio (ed anche più <strong>di</strong>fficile la fissazione <strong>di</strong> <strong>un</strong>o<br />
standard che sia razionale, tenendo in considerazione i danni potenziali effettivi nei<br />
<strong>di</strong>versi ambienti).<br />
Non necessariamente questo criterio <strong>per</strong>mette <strong>di</strong> avere <strong>un</strong> uso “efficiente” dell’<br />
inquinamento, nel senso <strong>di</strong> raggi<strong>un</strong>gere <strong>un</strong> determinato obiettivo nel modo che impatta<br />
in misura minima l’ambiente nel suo complesso (cfr. criterio delle migliori tecnologie<br />
<strong>di</strong>sponibili).<br />
Il criterio è equo nei confronti <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi proponenti, cioè <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi soggetti che<br />
vogliano iniziare in tempi/luoghi <strong>di</strong>versi la loro attività, in quanto lo standard <strong>di</strong><br />
emissione non viene a mo<strong>di</strong>ficarsi nel tempo, se non <strong>per</strong> <strong>un</strong>a revisione dei limiti <strong>di</strong><br />
legge (cfr. criterio della Ricettività <strong>Ambientale</strong>)<br />
Come sottolinea il Malcevschi, il criterio non garantisce la prevenzione <strong>di</strong> effetti<br />
negativi <strong>di</strong> natura anche grave ed irreversibile, in quanto «qualora la situazione<br />
ambientale iniziale sia già molto critica, l’abbassamento della qualità provocato<br />
dall’emissione, ancorché rispettosa dei valori <strong>di</strong> legge, può essere tale da provocare il<br />
su<strong>per</strong>amento della soglia <strong>di</strong> sopportazione».<br />
Infine, facciamo rilevare come il criterio degli standard <strong>di</strong> emissione, visto come<br />
criterio <strong>per</strong> il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> compatibilità ambientale <strong>di</strong> <strong>un</strong>’o<strong>per</strong>a e non come strumento <strong>di</strong><br />
politica ambientale 100 , abbia due ulteriori <strong>di</strong>fetti:<br />
100 Come strumento <strong>di</strong> politica ambientale, gli standard <strong>di</strong> emissione possono essere particolarmente<br />
importanti <strong>per</strong> le fonti <strong>di</strong> inquinamento <strong>di</strong>ffuse, ad esempio quelle legate agli scarichi dei veicoli o agli<br />
impianti <strong>di</strong> riscaldamento, dove si ha <strong>un</strong> numero elevatissimo <strong>di</strong> sorgenti <strong>per</strong> le quali è importante più<br />
l’aspetto tecnologico (tipologia <strong>di</strong> sorgente) piuttosto che quello ambientale (sarebbe abbastanza<br />
<strong>di</strong>fficile tarare gli standard <strong>di</strong> emissione in base ai tipi <strong>di</strong> ambiente dove sarà utilizzato <strong>un</strong> autoveicolo,<br />
anche se in zone particolarmente sensibili, può essere <strong>per</strong>messo l’impiego soltanto <strong>di</strong> macchine che<br />
utilizzano <strong>un</strong> determinato tipo <strong>di</strong> tecnologia, ve<strong>di</strong> le eccezioni che vengono fatte in caso <strong>di</strong> blocco <strong>di</strong><br />
traffico <strong>per</strong> alc<strong>un</strong>e tipologie <strong>di</strong> macchine).<br />
Pag. 96 <strong>di</strong> 148<br />
96
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
Il primo è quello <strong>di</strong> vedere soltanto <strong>un</strong>a parte molto limitata <strong>di</strong> <strong>un</strong> problema<br />
che può essere anche molto più complesso, nel senso che <strong>di</strong>fficilmente gli<br />
impatti provocati da <strong>un</strong> intervento si limiteranno agli effetti delle emissioni;<br />
Il secondo è che il rispetto degli standard debba essere considerata <strong>un</strong>a<br />
con<strong>di</strong>zione necessaria (nel senso che non si potrà considerare compatibile<br />
con l’ambiente <strong>un</strong> impianto che <strong>di</strong>sattende quanto esplicitamente previsto dai<br />
limiti <strong>di</strong> legge vigenti), ma non sufficiente in quanto – come si è accennato al<br />
p<strong>un</strong>to precedente – il problema degli impatti <strong>di</strong> <strong>un</strong> intervento va affrontato in<br />
<strong>un</strong>’ottica <strong>di</strong> tipo complessivo. Inoltre può non essere su<strong>per</strong>fluo far rilevare<br />
come, se bastasse il rispetto degli standard <strong>di</strong> emissione a garantire la<br />
compatibilità <strong>di</strong> <strong>un</strong> intervento, non ci sarebbe bisogno <strong>di</strong> impiegare tempo e<br />
denaro in <strong>un</strong>a procedura <strong>di</strong> VIA, in quanto sarebbe sufficiente far rispettare<br />
la normativa esistente.<br />
«Livelli assoluti e relativi <strong>di</strong> pressione antropica<br />
Si confrontano i livelli <strong>di</strong> pressione sull’ambiente (ad esempio le emissioni in<br />
atmosfera) prodotti dal progetto con quelli <strong>di</strong> analoghi interventi già realizzati altrove,<br />
in modo da poter fare valutazioni comparative sugli effetti attesi. Sospensioni del<br />
giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> compatibilità si potranno avere, ad esempio, quando l’impianto in progetto<br />
e le relative interferenze risultano molto gran<strong>di</strong> rispetto ai normali interventi dello<br />
stesso tipo (nel caso <strong>di</strong> <strong>un</strong> inceneritore rispetto ad altri inceneritori costruiti in Italia ed<br />
all’estero). L’uso <strong>di</strong> tale criterio richiede la scelta <strong>di</strong> strumenti standard <strong>di</strong> confronto<br />
(es. valori <strong>di</strong> emissione <strong>per</strong> determinate sorgenti)» 101<br />
Migliori tecnologie (praticamente) <strong>di</strong>sponibili (mancato uso <strong>di</strong>..) 102<br />
«Il semplice rispetto degli standard <strong>di</strong> legge può non essere sufficiente quando<br />
l’evoluzione delle tecnologie fa sì che si possano risparmiare inquinamenti indebiti. La<br />
verifica dell’uso della migliore tecnica <strong>di</strong>sponibile può <strong>di</strong>ventare criterio <strong>di</strong>rimente <strong>per</strong><br />
considerare o meno <strong>un</strong> intervento ambientalmente compatibile. D’altronde gli stessi<br />
standard <strong>di</strong> emissione, che fanno riferimento a quelli che com<strong>un</strong>emente vengono definiti<br />
in<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> pressione, sono sempre più legati all’utilizzo delle migliori tecniche<br />
101 ANPA-MATT (2001), Linee guida VIA, p. 19<br />
102 A volte tali tecnologie sono meglio conosciute con l’acronimo inglese: B.A.T. (Best Available<br />
Technology) o B.A.P.T. (Best Available Pratically Technology)<br />
Pag. 97 <strong>di</strong> 148<br />
97
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
<strong>di</strong>sponibili. Per migliori tecniche <strong>di</strong>sponibili, si intende la più efficiente e avanzata fase<br />
<strong>di</strong> sviluppo <strong>di</strong> attività e relativi meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> esercizio in<strong>di</strong>canti l’idoneità pratica <strong>di</strong><br />
determinate tecniche a costituire, in linea <strong>di</strong> massima, la base dei valori limite <strong>di</strong><br />
emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo<br />
generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso 103 . Di <strong>per</strong> sé il<br />
mancato uso delle migliori tecniche <strong>di</strong>sponibili sotto il profilo ambientale <strong>per</strong><br />
determinati contenuti progettuali, comporta la produzione <strong>di</strong> impatti che avrebbero<br />
potuto essere evitati, quin<strong>di</strong> indebiti. Ad esempio l’utilizzo <strong>di</strong> tecniche non ottimali <strong>di</strong><br />
abbattimento dei fumi <strong>per</strong> <strong>un</strong> termo<strong>di</strong>struttore può creare <strong>un</strong> inquinamento aggi<strong>un</strong>tivo,<br />
ancorché rispettoso degli standard <strong>di</strong> legge, evitabile con l’adozione <strong>di</strong> tecnologie più<br />
avanzate (ove esistenti e compatibili con la struttura del mercato <strong>di</strong> settore); l’uso del<br />
calce-struzzo <strong>per</strong> o<strong>per</strong>e <strong>di</strong> consolidamento là ove avrebbero potuto essere usate<br />
tecniche <strong>di</strong> ingegneria naturalistica comporta <strong>un</strong>a <strong>per</strong><strong>di</strong>ta <strong>di</strong> ambiente evitabile;<br />
ecc.» 104<br />
Il criterio delle migliori tecnologie <strong>di</strong>sponibili è utilizzato dalla più recente<br />
normativa in campo <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> (quando, ad esempio, si<br />
richiede <strong>di</strong> fornire motivazioni rispetto alla scelte tecnologiche adottate, in relazione alle<br />
migliori tecnologie <strong>di</strong>sponibili, ed anche dalla <strong>di</strong>rettiva I.P.P.C. (Prevenzione e<br />
riduzione integrata dell’inquinamento).<br />
Il criterio prevede il confronto in termini <strong>di</strong> <strong>per</strong>formance ambientali tra la tecnologia<br />
proposta e le migliori tecnologie <strong>di</strong>sponibili. Problemi applicativi possono sorgere<br />
quando le tecnologie <strong>di</strong>fferiscono <strong>per</strong> <strong>un</strong>a serie <strong>di</strong> parametri i cui impatti a livello<br />
ambientale possono essere significativamente <strong>di</strong>versi (ad esempio, <strong>di</strong>versi valori <strong>di</strong><br />
inquinamento aria, acqua, consumo <strong>di</strong> risorse non rinnovabili, ecc.) in quanto può essere<br />
<strong>di</strong>fficile in<strong>di</strong>viduare qual è la tecnologia che è “complessivamente” migliore delle altre.<br />
Un ulteriore problema può derivare dall’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> quali siano le tecnologie<br />
effettivamente <strong>di</strong>sponibili in pratica, cioè quelle che siano re<strong>per</strong>ibili e sostenibili dal<br />
p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista economico, nel senso che non comportano <strong>un</strong> costo che rende la<br />
realizzazione dell’attività economicamente non conveniente.<br />
103 Il Malcevschi (1993) riporta invece la definizione <strong>di</strong> <strong>un</strong> documento del Directorate-General<br />
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection, Commission of the European Comm<strong>un</strong>ities, che<br />
definisce la migliore tecnologia <strong>di</strong>sponibile come la tecnologia (o il complesso <strong>di</strong> tecnologie) che<br />
l’es<strong>per</strong>ienza o<strong>per</strong>ativa ha sufficientemente <strong>di</strong>mostrato, tra quelle commercialmente <strong>di</strong>sponibili ed<br />
economicamente sostenibili quando applicate al settore industriale in oggetto, essere in grado <strong>di</strong><br />
minizzare le emissioni nell’atmosfera.<br />
104 ANPA-MATT (2001), Linee guida VIA, p. 20<br />
Pag. 98 <strong>di</strong> 148<br />
98
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
Com<strong>un</strong>que, rispetto ai problemi posti dall’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> standard <strong>di</strong> emissione<br />
che necessitano <strong>di</strong> <strong>un</strong>a valutazione del danno sociale legato all’inquinamento <strong>per</strong><br />
in<strong>di</strong>viduare il livello <strong>di</strong> emissioni “ottimale”, il prendere atto <strong>di</strong> quali spazi offra la<br />
tecnologia <strong>per</strong> raggi<strong>un</strong>gere le migliori prestazioni sul piano ambientale, e quin<strong>di</strong> <strong>per</strong><br />
minimizzare il degrado ambientale prodotto, può costituire <strong>un</strong> approccio più<br />
“semplice”. Inoltre il criterio risulta più flessibile <strong>per</strong>ché non necessariamente si limita a<br />
prendere in considerazione; potrebbe infatti considerare altri parametri, quali i consumi<br />
<strong>di</strong> risorse non rinnovabili, la <strong>per</strong>centuale <strong>di</strong> materie prime riciclabili nella produzione <strong>di</strong><br />
<strong>un</strong> prodotto, la durata ed il grado <strong>di</strong> im<strong>per</strong>meabilità <strong>di</strong> <strong>un</strong> telo che viene utilizzato <strong>per</strong><br />
<strong>un</strong>a <strong>di</strong>scarica.<br />
A <strong>di</strong>fferenza degli standard <strong>di</strong> emissione, <strong>per</strong> le quali ci può essere <strong>un</strong> controllo<br />
continuato nel tempo, nel caso delle migliori tecnologie <strong>di</strong>sponibili il controllo si<br />
esercita prevalentemente “<strong>un</strong>a tantum” al momento della decisione <strong>di</strong> realizzare<br />
l’impianto (o, com<strong>un</strong>que, ad intervalli <strong>di</strong> tempo relativamente l<strong>un</strong>ghi, ad esempio nel<br />
caso <strong>di</strong> ristrutturazioni che comportino cambiamenti significativi nell’o<strong>per</strong>a).<br />
Anche questo criterio è basato esclusivamente sul progetto, essendo <strong>di</strong> natura<br />
essenzialmente tecnologica. Di conseguenza ha in parte gli stessi <strong>di</strong>fetti degli standard<br />
<strong>di</strong> emissione. In particolare, essendo <strong>un</strong> criterio essenzialmente basato sulle caratte-<br />
ristiche tecnologiche, non tiene conto delle caratteristiche ambientali; inoltre non tiene<br />
conto degli effetti cumulativi conseguenti le <strong>di</strong>mensioni dell’impianto o la concomitante<br />
localizzazione nella stessa area <strong>di</strong> più fonti <strong>di</strong> emissione. Quin<strong>di</strong>, come nel caso<br />
precedente, in <strong>di</strong>pendenza del livello iniziale <strong>di</strong> criticità dell’ambiente e degli eventuali<br />
effetti cumulativi, il criterio non garantisce che non vengano su<strong>per</strong>ati livelli <strong>di</strong> criticità<br />
ambientale.<br />
Il criterio risulta equo nei confronti dei <strong>di</strong>versi proponenti in quanto, come nel caso<br />
precedente, li mette tutti sullo stesso piano.<br />
Rispetto agli standard <strong>di</strong> emissione, com<strong>un</strong>que, le migliori tecnologie <strong>di</strong>sponibili<br />
presentano il grosso vantaggio <strong>di</strong> garantire <strong>un</strong> “efficiente” uso dell’inquinamento in<br />
quanto prevedono che <strong>un</strong> determinato prodotto venga realizzato con la tecnologia meno<br />
inquinante tra quelle praticamente <strong>di</strong>sponibili. Di conseguenza, il criterio evidenzia qual<br />
è <strong>per</strong> la società il livello ineliminabile <strong>di</strong> impatto legato alla produzione <strong>di</strong> <strong>un</strong><br />
determinato bene/servizio.<br />
Vista la <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> trovare delle tecnologie che possano essere complessivamente<br />
“migliori” rispetto ai <strong>di</strong>versi parametri che hanno <strong>un</strong>’influenza sulla qualità dell’<br />
Pag. 99 <strong>di</strong> 148<br />
99
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
ambiente, la Com<strong>un</strong>ità Europea <strong>di</strong>ffonde <strong>per</strong>io<strong>di</strong>camente delle Linee Guida relative alle<br />
migliori tecnologie <strong>di</strong>sponibili nei <strong>di</strong>versi settori produttivi, linee guida che possono<br />
essere riprese, integrate e mo<strong>di</strong>ficate a livello nazionale.<br />
Il Malcevschi fornisce sia <strong>un</strong> modello teorico <strong>di</strong> riferimento <strong>per</strong> la valutazione del<br />
criterio della migliore tecnologia <strong>di</strong>sponibile (cfr. figura 12) ed <strong>un</strong> modello teorico <strong>di</strong><br />
riferimento <strong>per</strong> la valutazione dei criteri legati alla tecnologia (cfr. figura 13).<br />
Alta<br />
QUALITA’<br />
Q(x)<br />
Bassa<br />
a) Con<strong>di</strong>zioni iniziali <strong>di</strong>screte<br />
b) Con<strong>di</strong>zioni iniziali critiche<br />
c) Con<strong>di</strong>zioni iniziali molto critiche<br />
t(A) t(P)<br />
Figura 12 –Modello grafico della compatibilità ambientale<br />
(fig. 5.2 Malcevschi)<br />
«Qualora la situazione ambientale iniziale sia già molto critica, l’abbassamento della qualità<br />
provocato dall’emissione, ancorché minimizzato sul piano tecnologico, può essere tale da<br />
provocare il su<strong>per</strong>amento della soglia <strong>di</strong> accettabilità. L’adozione semplicistica del criterio può<br />
tradursi poi in ulteriori compromissioni <strong>di</strong> situazioni già inaccettabili in partenza».<br />
(Malcevschi)<br />
Se l’esame <strong>di</strong> figura 12 riba<strong>di</strong>sce il problema che l’adozione delle migliori<br />
tecnologie <strong>di</strong>sponibili non garantisce <strong>di</strong> rimanere al <strong>di</strong> sopra della soglia minima <strong>di</strong><br />
qualità ambientale ritenuta accettabile, figura 13 mette a confronto quelli che possono<br />
essere i possibili effetti sull’ambiente dei <strong>di</strong>versi criteri tecnologici.<br />
Pag. 100 <strong>di</strong> 148<br />
tempo<br />
100
Alta<br />
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
QUALITA’<br />
Q(x)<br />
Bassa<br />
t(A) t(P)<br />
Figura 13 –Modello teorico <strong>di</strong> riferimento <strong>per</strong> la valutazione <strong>di</strong> criteri legati alla tecnologia<br />
(fig. 5.1 Malcevschi)<br />
Legenda «In or<strong>di</strong>nata la scala <strong>di</strong> qualità adottata; in ascissa il tempo; t(A) rappresenta lo stato<br />
iniziale prima della realizzazione dell’intervento, t(P) lo stato <strong>di</strong> qualità a progetto realizzato.<br />
Q(x) costituisce la soglia al <strong>di</strong> sotto della quale lo stato <strong>di</strong> qualità è giu<strong>di</strong>cato inaccettabile.<br />
Rispetto a <strong>un</strong> decremento <strong>di</strong> qualità che si avrebba in assenza <strong>di</strong> limiti <strong>di</strong> emissione,<br />
rappresentato da c, prevedendo standard <strong>di</strong> emissione (caso b) il decremento può essere ridotto<br />
in <strong>un</strong>a situazione generalizzata <strong>di</strong> casi; nello stesso tempo l’abbassamento della qualità<br />
ambientale potrebbe essere ancora minore qualora venissero adottate le migliori tecnologie<br />
<strong>di</strong>sponibili (caso a). Qualora la situazione ambientale iniziale sia già molto critica,<br />
l’abbassamento della qualità provocato dall’emissione, ancorché rispettosa dei valori <strong>di</strong> legge,<br />
può essere tale da provocare il su<strong>per</strong>amento della soglia <strong>di</strong> accettabilità. L’adozione<br />
semplicistica del criterio può tradursi poi in ulteriori compromissioni <strong>di</strong> situazioni già<br />
inaccettabili in partenza». (Malcevschi)<br />
Esaurito l’elenco dei criteri <strong>di</strong> natura tecnologica, passiamo adesso ad esaminare i<br />
CRITERI AMBIENTALI, cioè quelli che, più che focalizzarsi sulla sorgente, si<br />
occupano del bersaglio.<br />
«Mancato rispetto degli standard ambientali<br />
Gli standard ambientali <strong>per</strong> le <strong>di</strong>verse componenti ambientali (es. aria, acqua,<br />
rumore) rappresentano lo stato <strong>di</strong> qualità considerato accettabile. Le variazioni<br />
Pag. 101 <strong>di</strong> 148<br />
a) Con le migliori<br />
tecnologie <strong>di</strong>sponibili<br />
b) Con standards <strong>di</strong><br />
emissione<br />
c) Senza limiti <strong>di</strong><br />
emissioni<br />
tempo<br />
101
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
ambientali attese non dovranno su<strong>per</strong>are i livelli esplicitamente previsti da limiti <strong>di</strong><br />
legge vigenti. Analogamente a quanto esposto <strong>per</strong> gli standard <strong>di</strong> emissione, è questo <strong>un</strong><br />
criterio primario (necessario e non sufficiente) che deve evidentemente essere rispettato<br />
<strong>per</strong> poter parlare <strong>di</strong> compatibilità del progetto. A maggior ragione, là ove i limiti <strong>di</strong><br />
legge siano già stati su<strong>per</strong>ati, non dovrà essere ulteriormente incrementato il livello <strong>di</strong><br />
criticità esistente; se l’o<strong>per</strong>a sarà considerata necessaria e produrrà nuovi impatti, non<br />
solo questi ultimi dovranno essere minimizzati attraverso le migliori tecnologie<br />
<strong>di</strong>sponibili, ma dovranno essere cercati interventi contestuali <strong>di</strong> riduzione delle criticità<br />
esistenti in modo da bilanciare tali nuovi contributi» 105<br />
Mettiamo in evidenza come, rispetto al criterio degli standard <strong>di</strong> emissione, il<br />
criterio degli standard ambientali presenti alc<strong>un</strong>i tipi <strong>di</strong> vantaggi, non trascurabili.<br />
Innanzitutto, è più facile risalire ai danni ambientali (o ai costi marginali sociali) legati a<br />
livelli <strong>di</strong>versi <strong>di</strong> standard ambientali piuttosto che a livelli <strong>di</strong>versi <strong>di</strong> standard <strong>di</strong><br />
emissione, in quanto nel primo caso controlliamo <strong>di</strong>rettamente lo stato dell’ambiente e<br />
non abbiamo bisogno <strong>di</strong> prevederne la variazione a fronte <strong>di</strong> livelli <strong>di</strong> emissione<br />
<strong>per</strong>messi <strong>di</strong>versi, come nel caso degli standard <strong>di</strong> emissione. In secondo luogo, è<br />
possibile con più facilità adattare gli standard a specifiche situazioni, nel senso che è<br />
teoricamente possibile prevedere standard <strong>di</strong>versi in ambienti <strong>di</strong>versi o a carico <strong>di</strong><br />
risorse con usi <strong>di</strong>versi. Ad esempio, rispetto ad <strong>un</strong>a immissione <strong>di</strong> <strong>un</strong> inquinante in<br />
ambiente idrico, <strong>per</strong> la quale non si sa se andrà ad incidere solo o prevalentemente su<br />
acque potabili od acque destinate ad usi <strong>di</strong>versi e <strong>per</strong> la quale, quin<strong>di</strong>, è più <strong>di</strong>fficile<br />
stabilire <strong>un</strong>o standard <strong>di</strong> emissione, il controllo del livello <strong>di</strong> inquinamento rispetto al<br />
ricettore risulta più razionale. Questo <strong>per</strong> quanto riguarda l’applicazione degli standard<br />
nell’ambito delle politiche ambientali, con possibilità <strong>di</strong> controllo ex post. Nel caso <strong>di</strong><br />
utilizzo all’interno <strong>di</strong> <strong>un</strong>a procedura <strong>di</strong> VIA, che lavora ex ante, rimane com<strong>un</strong>que il<br />
problema <strong>di</strong> dover prevedere le variazioni a livello delle <strong>di</strong>verse <strong>un</strong>ità ambientali <strong>per</strong> le<br />
quali esistono degli standard potenzialmente rilevanti, <strong>di</strong> quelli che saranno gli effetti<br />
indotti dall’o<strong>per</strong>a oggetto <strong>di</strong> VIA.<br />
Ricettività ambientale (su<strong>per</strong>amento della ricettività ambientale del territorio interessato)<br />
«L’accettabilità <strong>di</strong> <strong>un</strong> intervento in progetto può avvenire sulla base <strong>di</strong> soglie <strong>di</strong><br />
allarme riconosciute in sede tecnica, anche se non previste da specifici <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong><br />
105 ANPA-MATT (2001), Linee guida VIA, op. cit., p. 20<br />
Pag. 102 <strong>di</strong> 148<br />
102
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
legge. Ad esempio se, come attualmente in Italia, non vi sono standard con riferimento<br />
alla concentrazione in atmosfera <strong>di</strong> determinate sostanze potenzialmente <strong>per</strong>icolose, si<br />
possono utilizzare nella pratica, quale riferimento <strong>per</strong> le valutazioni <strong>di</strong> compatibilità,<br />
soglie <strong>di</strong> allarme suggerite da organismi internazionali (ad esempio l’Organizzazione<br />
Mon<strong>di</strong>ale della Sanità). Vi possono essere dei casi, legati a particolari sensibilità<br />
ambientali, <strong>per</strong> i quali è necessario porsi come obiettivo valori <strong>di</strong> concentrazione<br />
considerevolmente inferiori alle soglie <strong>di</strong> allarme in<strong>di</strong>viduate. Qualora usato in modo<br />
automatico, tale criterio potrebbe infatti portare al consumo completo da parte <strong>di</strong> <strong>un</strong><br />
singolo progetto della ricettività ambientale residua presente su <strong>un</strong>a determinata area.<br />
Si dovrà <strong>per</strong>tanto introdurre <strong>un</strong> correttivo basato sul criterio dell’evitare peggioramenti<br />
significativi rispetto alla situazione esistente (ve<strong>di</strong> più avanti)» 106 . Queste problema-<br />
tiche saranno <strong>di</strong> seguito riprese con maggior dettaglio. Ricor<strong>di</strong>amo, com<strong>un</strong>que, che non<br />
necessariamente si debba prendere a riferimento dei livelli <strong>di</strong> allarme, ma come possa<br />
avere significato anche riferirsi a valori guida, da considerare come “obiettivi”, o<br />
com<strong>un</strong>que soglie prudenziali. Infatti, come <strong>di</strong>ce il Malcevschi, «qualora sia stata<br />
raggi<strong>un</strong>ta attraverso i vari interventi approvati e realizzati la soglia <strong>di</strong> ricettività<br />
ambientale, il sistema <strong>di</strong>venta estremamente vulnerabile: basta <strong>un</strong> modesto incremento<br />
non previsto, o <strong>un</strong>a mo<strong>di</strong>fica delle con<strong>di</strong>zioni iniziali, magari dovuta a eventi<br />
in<strong>di</strong>pendenti dall’azione umana (ad esempio particolari situazioni meteo-climatiche)<br />
<strong>per</strong> far sì che la soglia <strong>di</strong> sopportazione dell’ambiente venga su<strong>per</strong>ata» Inoltre è bene<br />
ricordare come non necessariamente i valori soglia in<strong>di</strong>viduati debbano riferirsi a<br />
concentrazioni che, come abbiamo in<strong>di</strong>cato relativamente agli standard <strong>di</strong> emissione,<br />
non provocano effetti osservati. Vi sono, infatti, delle sostanze, in particolare quelle<br />
mutagene e più specificamente cancerogene, <strong>per</strong> le quali non è possibile stabilire <strong>un</strong><br />
livello <strong>di</strong> presenza nell’ambiente in grado <strong>di</strong> escludere effetti indesiderati. In questo<br />
caso, le soglie devono essere lette come degli strumenti <strong>per</strong> contenere il relativo rischio<br />
all’interno <strong>di</strong> margini ritenuti accettabili (visto che, anche con <strong>un</strong>a concentrazione<br />
minima nell’ambiente, non è possibile escludere il rischio <strong>di</strong> eventi avversi e visto che,<br />
com<strong>un</strong>que, non si parla mai <strong>di</strong> <strong>un</strong>a risposta certa all’esposizione, ma <strong>di</strong> <strong>un</strong>a risposta<br />
“probabile”).<br />
Il criterio della ricettività ambientale è spesso utilizzato come riferimento teorico<br />
negli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> impatto ambientale, in quanto <strong>per</strong>mette <strong>di</strong> stabilire <strong>un</strong>a soglia assoluta (<strong>di</strong><br />
106 ANPA-MATT (2001), Linee guida VIA, op. cit., pp. 20-21<br />
Pag. 103 <strong>di</strong> 148<br />
103
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
inquinamento, <strong>di</strong> qualità ambientale) che si presuppone <strong>di</strong> non poter oltrepassare,<br />
andando in questa maniera a correggere i problemi causati dall’uso <strong>di</strong> criteri tecnologici,<br />
dove <strong>di</strong>mensioni dell’intervento, effetti cumulativi e livello iniziale della qualità<br />
ambientale potevano, com<strong>un</strong>que, portare al su<strong>per</strong>amento delle soglie stabilite.<br />
Ciò nonostante, il criterio non è <strong>di</strong> facile applicazione in quanto comporta<br />
l’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> livelli soglia al <strong>di</strong> là dei quali si ritiene che il sistema raggi<strong>un</strong>ga<br />
livelli <strong>di</strong> criticità. Questo comporta <strong>un</strong> esame del livello <strong>di</strong> criticità ambientale nel<br />
complesso, ma legato a valori soglia <strong>di</strong> qualità ambientale spesso da esplicitare rispetto<br />
ad <strong>un</strong>a pluralità <strong>di</strong> parametri. Più facile è <strong>un</strong> controllo effettuato parametro <strong>per</strong><br />
parametro, che <strong>per</strong>ò non tiene conto <strong>di</strong> eventuali effetti sinergici. Uno dei problemi che<br />
viene <strong>per</strong> l’app<strong>un</strong>to messo in evidenza nella relazione degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong><br />
è proprio quello <strong>di</strong> cedere alla tentazione <strong>di</strong> <strong>un</strong> controllo “parametro <strong>per</strong> parametro”,<br />
soprattutto <strong>per</strong> quelli che sono esplicitamente previsti dalle normative, <strong>per</strong>dendo <strong>di</strong> vista<br />
la “situazione <strong>di</strong> insieme”. Inoltre l’applicazione del criterio rende necessario <strong>un</strong>o stu<strong>di</strong>o<br />
delle caratteristiche iniziali dell’ambiente, spesso molto oneroso, <strong>per</strong> poter prevedere<br />
come queste varieranno in conseguenza della realizzazione dell’intervento (questo è <strong>un</strong><br />
problema com<strong>un</strong>e ai criteri basati sull’ ambiente). Farsi carico <strong>di</strong> <strong>un</strong>’analisi preliminare<br />
dell’ambiente in cui l’intervento si inserisce, soprattutto durante i primi tempi <strong>di</strong><br />
applicazione della legge sulla VIA, quando non esistevano banche dati pubbliche<br />
accessibili (ricor<strong>di</strong>amo che al momento attuale, tramite l’o<strong>per</strong>ato delle agenzie regionali<br />
<strong>per</strong> l’ambiente, ed anche grazie ai monitoraggi <strong>di</strong> o<strong>per</strong>e e territorio, ci sono molte più<br />
informazioni facilmente <strong>di</strong>sponibili rispetto al passato) poteva risultare così oneroso da<br />
indurre il proponente al ri<strong>corso</strong> esclusivo a criteri <strong>di</strong> natura tecnologica, anche se<br />
abbiamo visto come questi, in molte situazioni, non siano in grado <strong>di</strong> garantire la<br />
compatibilità dell’intervento con l’ambiente.<br />
Come sopra accennato, il criterio prevede la verifica del mancato su<strong>per</strong>amento <strong>di</strong><br />
livelli <strong>di</strong> criticità <strong>per</strong> tutti i parametri selezionati, in conseguenza dello stato iniziale<br />
dell’ambiente e delle mo<strong>di</strong>fiche che saranno indotte dall’intervento. La verifica ex ante<br />
non è sicuramente <strong>di</strong> facile e veloce attuazione, mentre la verifica ex post può essere<br />
relativamente agevole se si <strong>di</strong>spone <strong>di</strong> specie “sensibili” al livello complessivo <strong>di</strong><br />
qualità ambientale (la cui <strong>per</strong>manenza nell’area può essere <strong>un</strong> in<strong>di</strong>catore dell’esistenza<br />
<strong>di</strong> <strong>un</strong> livello <strong>di</strong> qualità ambientale sod<strong>di</strong>sfacente, ad esempio il mantenimento della<br />
presenza <strong>di</strong> <strong>un</strong>a specie molto vulnerabile, quale la lontra, può essere in<strong>di</strong>catore <strong>di</strong> <strong>un</strong>a<br />
buona qualità del f<strong>un</strong>zionamento del sistema complessivo; in tal senso l’uso delle specie<br />
Pag. 104 <strong>di</strong> 148<br />
104
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
sensibili potrebbe essere utilizzato <strong>per</strong> <strong>un</strong>a “valutazione sintetica” dello stato iniziale, in<br />
assenza dell’o<strong>per</strong>a).<br />
Anche in questo caso, come già accennato sopra, l’applicazione del criterio prevede<br />
la determinazione <strong>di</strong> soglie <strong>di</strong> criticità. Tali soglie possono essere anche <strong>di</strong> natura<br />
prudenziale, cioè tenute intenzionalmente più basse rispetto ai valori che<br />
determinerebbero il collasso del sistema. Se si <strong>di</strong>spone <strong>di</strong> <strong>un</strong>a serie <strong>di</strong> casi <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o<br />
precedenti, i valori soglia possono basarsi su es<strong>per</strong>ienze pregresse e come tali avere <strong>un</strong>a<br />
loro giustificazione a livello tecnico.<br />
A <strong>di</strong>fferenza dei criteri <strong>di</strong> natura tecnologica, la ricettività tiene conto delle<br />
<strong>di</strong>fferenze a livello <strong>di</strong> ambienti impattati proprio <strong>per</strong>ché, come detto sopra, la capacità <strong>di</strong><br />
sopportazione <strong>di</strong> <strong>un</strong> ambiente <strong>di</strong>pende dalle sue caratteristiche in termini <strong>di</strong> fragilità,<br />
vulnerabilità, resilienza, ecc. Inoltre, come abbiamo detto, il criterio tiene conto degli<br />
effetti cumulativi, in quanto va a vedere il livello complessivo <strong>di</strong> qualità ambientale,<br />
come determinato non dal singolo intervento oggetto <strong>di</strong> valutazione, ma anche da tutte<br />
le altre concause che generano interferenze sulle stesse <strong>un</strong>ità ambientali.<br />
A fronte <strong>di</strong> <strong>un</strong>a serie <strong>di</strong> innegabili vantaggi, quale, non ultimo, quello che, se<br />
applicato correttamente, dovrebbe garantire che non vengano su<strong>per</strong>ati livelli <strong>di</strong> criticità,<br />
il criterio della ricettività ambientale presenta anche dei <strong>di</strong>fetti: infatti, in primo luogo<br />
non garantisce <strong>un</strong> “efficiente” uso dell’inquinamento. Anzi, questo è <strong>un</strong>o dei suoi<br />
principali p<strong>un</strong>ti deboli <strong>per</strong>ché, in presenza <strong>di</strong> ambienti con elevata ricettività ambientale,<br />
è possibile localizzare sugli stessi <strong>un</strong>a pluralità <strong>di</strong> interventi impattanti, in<strong>di</strong>pendente-<br />
mente dalla loro razionalità, fino al raggi<strong>un</strong>gimento della soglia critica (soprattutto in<br />
assenza <strong>di</strong> verifiche quali quelle previste dall’ANPA-MATT prima <strong>di</strong> iniziare a trattare<br />
dei criteri tecnologici propriamente detti). Al limite è possibile che <strong>un</strong>’<strong>un</strong>ica o<strong>per</strong>a<br />
(magari la prima) che si inserisce in <strong>un</strong> ambiente relativamente incontaminato possa<br />
consumare l’intero margine <strong>di</strong> ricettività esistente, magari anche impiegando tecnologie<br />
relativamente inquinanti. In secondo luogo, il criterio non è equo nei confronti dei<br />
<strong>di</strong>versi proponenti, in quanto i primi arrivati possono sfruttare, anche con impatti<br />
indebiti, gli elevati margini in termini <strong>di</strong> ricettività ambientale presenti, mentre – <strong>un</strong>a<br />
volta che sono state raggi<strong>un</strong>te le soglie <strong>di</strong> ricettività prestabilite – saranno rifiutati anche<br />
progetti “efficienti” dal p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista del rapporto immissione <strong>di</strong> inquinanti/effetto<br />
conseguito (in termini <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> <strong>un</strong> bene, <strong>di</strong> <strong>un</strong> servizio, ecc.), cioè anche<br />
eventuali interventi realizzati con le migliori tecnologie <strong>di</strong>sponibili.<br />
Pag. 105 <strong>di</strong> 148<br />
105
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
Riportiamo <strong>di</strong> seguito (cfr figura 14) il modello grafico proposto dal Malcevschi<br />
come modello teorico <strong>di</strong> riferimento <strong>per</strong> la valutazione del criterio della ricettività<br />
ambientale.<br />
Alta<br />
Q(x)<br />
QUALITA’<br />
Q(y)<br />
Bassa<br />
t(A) t(P)<br />
Figura 14 –Modello teorico <strong>di</strong> riferimento <strong>per</strong> la valutazione del criterio della ricettività<br />
ambientale<br />
(fig. 5.1 Malcevschi – MODIFICATA)<br />
Legenda «Nuove aggravamenti della qualità ambientale vengono rifiutati qualora la situazione<br />
ambientale iniziale sia già molto critica (caso d). Nello stesso tempo l’uso meccanico del<br />
criterio può portare a situazioni ad alto rischio (ve<strong>di</strong> caso c), vicine alla soglia <strong>di</strong><br />
inaccettabilità, o può consentire impatti indebiti <strong>di</strong> grande <strong>di</strong>mensione (entrambe le alternative<br />
<strong>di</strong> progetto che si traducono nei casi a e b rispettano il criterio», ma l’alternativa b è<br />
caratterizzata da <strong>un</strong> impatto molto forte termini <strong>di</strong> <strong>per</strong><strong>di</strong>ta <strong>di</strong> qualità ambientale. (Malcevschi)<br />
«Consumi ingiustificati <strong>di</strong> valori ambientali<br />
a)<br />
b)<br />
c)<br />
d) RICETTIVITA’<br />
Un altro aspetto fondamentale della valutazione è quello relativo all’importanza dei<br />
valori ambientali consumati (o interferiti), non completamente risolti dagli istituti <strong>di</strong><br />
conservazione (es. parchi e riserve) e dalle relative norme <strong>di</strong> tutela esistenti. Occorrerà<br />
<strong>per</strong>tanto entrare nel merito specifico dei valori e delle sensibilità ambientali esistenti<br />
(ve<strong>di</strong> appen<strong>di</strong>ce 2B), verificando che non vengano pregiu<strong>di</strong>cati. Impatti indebiti in<br />
qualche modo assimilabili possono configurarsi anche in casi <strong>di</strong> progetti che prevedano<br />
consumi eccessivamente elevati <strong>di</strong> risorse non rinnovabili (combustibili fossili, mate-<br />
Pag. 106 <strong>di</strong> 148<br />
tempo<br />
106
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
riali <strong>di</strong> cava) a fronte <strong>di</strong> alternative che potrebbero contenere a livelli inferiori tali<br />
consumi» 107 . Rispetto al consumo <strong>di</strong> risorse non rinnovabili, ad esempio i materiali <strong>di</strong><br />
cava, è interessante notare come alc<strong>un</strong>e amministrazioni si siano orientate verso <strong>un</strong>a<br />
programmazione dello sfruttamento che tenga in debito conto sia le esigenze specifiche<br />
del territorio, in base a quelli che sono i preve<strong>di</strong>bili fabbisogni <strong>per</strong> l’attività e<strong>di</strong>lizia<br />
“locale” (in altre parole, non si è <strong>di</strong>sposti a causare impatti ambientali <strong>per</strong> l’attività<br />
estrattiva solo <strong>per</strong> <strong>per</strong>mettere ad altri territori <strong>di</strong> portare avanti l’attività e<strong>di</strong>lizia<br />
rispettando il proprio territorio, a spese <strong>di</strong> altri dai quali vengono fatti <strong>per</strong>venire i<br />
materiali <strong>di</strong> cava), sia le ricadute in termini <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to ed occupazione locale,<br />
privilegiando le attività estrattive <strong>per</strong> le quali siano realizzate in zona anche le<br />
successive lavorazioni.<br />
Si riporta <strong>di</strong> seguito l’appen<strong>di</strong>ce 2B, sopra citata, tratta dalle Linee guida VIA <strong>di</strong><br />
ANPA-MATT 108 . E’ interessante notare, come venga de<strong>di</strong>cato particolare interesse da<br />
<strong>un</strong>a parte alle <strong>un</strong>ità ambientali con caratteristiche particolarmente positive (<strong>di</strong> pregio)<br />
e/o a quelle con caratteristiche particolarmente problematiche (vulnerabilità, criticità).<br />
Le Unità ambientali vengono classificate in grossi comparti che fanno riferimento<br />
all’ambiente biotico, abiotico ed antropizzato.<br />
Appen<strong>di</strong>ce 2B- Unità ambientali sensibili <strong>di</strong> cui verificare la presenza sulle aree<br />
interessate dal progetto, e da tradurre in apposite cartografie.<br />
Unità ambientali naturalistiche ed ecosistemiche pregiate, vulnerabili o com<strong>un</strong>que<br />
potenzialmente critiche:<br />
Terrestri:<br />
Siti con presenze floristiche rilevanti (specie rare e/o minacciate)<br />
Siti con presenze fa<strong>un</strong>istiche rilevanti (specie rare e/o minacciate)<br />
Habitat naturali con storia evolutiva specifica (es. presenti da oltre 50 anni)<br />
Zone <strong>di</strong> specifico interesse f<strong>un</strong>zionale <strong>per</strong> l’ecomosaico (corridoi biologici,<br />
gangli <strong>di</strong> reti ecologiche locali ecc.)<br />
Varchi in ambiti antropizzati, a rischio ai fini della <strong>per</strong>meabilità ecologica<br />
Ecosistemi fragili <strong>di</strong> alta e me<strong>di</strong>o-alta quota<br />
Prati polifici<br />
Boschi <strong>di</strong>setanei e polispecifici con presenza significativa <strong>di</strong> specie<br />
autoctone<br />
Aree con presenza generica <strong>di</strong> vegetazione arborea o arbustiva<br />
Zone umide (torbiere, prati umi<strong>di</strong>, canneti, lag<strong>un</strong>e ecc.)<br />
Laghi oligotrofi o com<strong>un</strong>que <strong>di</strong> interesse ecologico<br />
Corsi d’acqua con caratteristiche <strong>di</strong> naturalità residua<br />
Litorali marini e lacustri con caratteristiche <strong>di</strong> naturalità residua<br />
107 ANPA-MATT (2001), Linee guida VIA, op. cit., p. 21<br />
108 ANPA-MATT (2001), Linee guida VIA, op. cit., p. 54-55<br />
Pag. 107 <strong>di</strong> 148<br />
107
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
Fasce <strong>di</strong> <strong>per</strong>tinenza fluviale a ruolo polivalente (ecosistemico, buffer nei<br />
confronti dell’inquinamento <strong>di</strong> origine esterna)<br />
Sorgenti <strong>per</strong>enni<br />
Fontanili<br />
Altri elementi <strong>di</strong> interesse naturalistico-ecosistemico nell’ambito interessato<br />
dal progetto.<br />
Marine:<br />
Acque costiere basse (es. con profon<strong>di</strong>tà inferiore a 50 m)<br />
Zone costiere con caratteristiche residue <strong>di</strong> naturalità<br />
Coste rocciose in generale<br />
Aree con presenza <strong>di</strong> coralligeno<br />
Praterie <strong>di</strong> fanerogame marine<br />
Acque basse sottocosta<br />
Fondali organogeni<br />
Altri tratti <strong>di</strong> mare con presenze bentoniche naturalisticamente o<br />
ecologicamente significative<br />
Tratti <strong>di</strong> mare importanti <strong>per</strong> gli spostamenti stagionali dell’ittiofa<strong>un</strong>a<br />
Tratti <strong>di</strong> mare con presenze significative <strong>di</strong> cetacei<br />
Zone costiere importanti <strong>per</strong> la presenza <strong>di</strong> cheloni<br />
Altri ecosistemi fragili<br />
Unità ambientali idrogeomorfologiche pregiate, vulnerabili o com<strong>un</strong>que potenzialmente<br />
critiche:<br />
Terrestri:<br />
Faglie<br />
Aree a <strong>di</strong>ssesto idrogeologico attuale o potenziale (franosità ecc.)<br />
Aree a frequente rischio <strong>di</strong> esondazione (es. con tempi <strong>di</strong> ritorno<br />
in<strong>di</strong>cativamente inferiori a 20 anni)<br />
Aree a rischio <strong>di</strong> esondazione non trascurabile (es. con tempi <strong>di</strong> ritorno<br />
in<strong>di</strong>cativamente su<strong>per</strong>iori a 20 anni)<br />
Aree a rischio <strong>di</strong> esondazione non trascurabile (es. con tempi <strong>di</strong> ritorno<br />
in<strong>di</strong>cativamente su<strong>per</strong>iori a 20 anni)<br />
Aree a rischio <strong>di</strong> valanghe nell’ambito interessato dal progetto<br />
Aree oggetto <strong>di</strong> subsidenza nell’ambito interessato dal progetto<br />
Aree sotto il livello del mare nell’ambito interessato dal progetto<br />
Zone con falde acquifere su<strong>per</strong>ficiali e/o profonde importanti <strong>per</strong><br />
l’approvvigionamento idropotabile<br />
Pozzi <strong>per</strong> usi idropotabili<br />
Pozzi <strong>per</strong> altri usi<br />
Sorgenti <strong>per</strong> usi idropotabili<br />
Fonti idrotermali<br />
Coste in arretramento<br />
Coste in subsidenza attiva<br />
Geotopi <strong>di</strong> interesse (grotte, salse, pirami<strong>di</strong> <strong>di</strong> terra, massi erratici ecc.)<br />
Boschi con ruolo <strong>di</strong> protezione idrogeologica (stabilità dei versanti,<br />
contenimento <strong>di</strong> valanghe, <strong>di</strong>fese litorali)<br />
Altre aree vulnerabili dal p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista idro-geo-morfologico<br />
Marine:<br />
Zone costiere con linea <strong>di</strong> riva in arretramento<br />
Pag. 108 <strong>di</strong> 148<br />
108
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
Zone costiere in subsidenza attiva<br />
Unità ambientali antropiche pregiate, vulnerabili o com<strong>un</strong>que potenzialmente critiche:<br />
Terrestri:<br />
E<strong>di</strong>fici abitati in modo <strong>per</strong>manente o semi<strong>per</strong>manente<br />
E<strong>di</strong>fici abitati in modo <strong>per</strong>manente o semi<strong>per</strong>manente da soggetti vulnerabili<br />
(scuole, ospedali)<br />
Aree utilizzate <strong>per</strong> attività ricreative<br />
Aree oggetto <strong>di</strong> balneazione<br />
Strutture inse<strong>di</strong>ative storiche, urbane<br />
Strutture inse<strong>di</strong>ative <strong>di</strong> interesse storico, extra-urbane<br />
Aree <strong>di</strong> accertato interesse archeologico, ancorché non oggetti <strong>di</strong> specifiche<br />
tutele<br />
Zone <strong>di</strong> riconosciuta importanza storica e culturale (siti <strong>di</strong> battaglie, <strong>per</strong>corsi<br />
storici ecc.) anche se non tutelate<br />
Aree con coltivazioni <strong>di</strong> interesse storico (marcite, piantate <strong>di</strong> gelsi ecc.)<br />
Infrastrutture attuali (trasportistiche, energetiche, idrauliche ecc.) che non<br />
devono essere compromesse <strong>per</strong> la f<strong>un</strong>zionalità del territorio<br />
Stabilimenti potenzialmente origine <strong>di</strong> rischi tecnologici<br />
Suoli <strong>di</strong> prima e seconda classe <strong>per</strong> la Land Capability (U.S.G.S.)<br />
Aree agricole con prodotti destinati <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente all’<br />
alimentazione umana<br />
Aree agricole <strong>di</strong> particolare pregio agronomico (vigneti doc, uliveti secolari<br />
ecc.), interferite dal progetto<br />
Zone costiere oggetto <strong>di</strong> vallicoltura<br />
Zone con elevati livelli attuali <strong>di</strong> inquinamento atmosferico<br />
Zone con elevati livelli attuali <strong>di</strong> inquinamento da rumore<br />
Corpi idrici sottoposti ad utilizzo intensivo della risorsa idrica (rete irrigua,<br />
corsi d’acqua con significative derivazioni <strong>di</strong> portata ecc.)<br />
Corpi idrici già significativamente inquinati<br />
Altre aree vulnerabili in ragione delle presenze antropiche<br />
Zone <strong>di</strong> espansione inse<strong>di</strong>ativa<br />
Zone interessate da previsioni infrastrutturali<br />
Altre aree vulnerabili <strong>per</strong> la presenza <strong>di</strong> elementi antropici<br />
Marine:<br />
Tratti costieri <strong>di</strong> particolare valore paesaggistico<br />
Zone marine <strong>di</strong> particolare interesse turistico (es. <strong>per</strong> le attività subacquee)<br />
Zone costiere oggetto <strong>di</strong> balneazione<br />
Tratti <strong>di</strong> mare <strong>di</strong> elevato interesse <strong>per</strong> la pesca<br />
Aree costiere oggetto <strong>di</strong> vallicoltura<br />
Aree marine oggetto <strong>di</strong> maricoltura (mitilicoltura ecc.)<br />
Aree marine con correnti a <strong>di</strong>rezionalità potenzialmente critica in caso <strong>di</strong><br />
inquinamento<br />
Aree marine con presenza <strong>di</strong> relitti<br />
Aree con potenziale presenza <strong>di</strong> fanghi contaminati<br />
Aree con presenza potenziale <strong>di</strong> or<strong>di</strong>gni bellici<br />
Rotte <strong>di</strong> imbarcazioni trasportanti carichi <strong>per</strong>icolosi.<br />
Pag. 109 <strong>di</strong> 148<br />
109
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
«Su<strong>per</strong>amento della capacità <strong>di</strong> rigenerazione naturale delle aree considerate<br />
E’ questo <strong>un</strong> criterio che sta <strong>di</strong>ventando sempre più importante nelle valutazioni<br />
ambientali (ve<strong>di</strong> “Atto <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo” e Direttiva 97/11/CE)». Infatti l’atto <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo e<br />
coor<strong>di</strong>namento (DPR 12/04/1996) nell’allegato D, comma 2 recita: «La sensibilità<br />
ambientale delle zone geografiche che possono essere danneggiate dal progetto deve<br />
essere presa in considerazione, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:<br />
la qualità e la capacità <strong>di</strong> rigenerazione delle risorse naturali della zona; (…)»<br />
mentre la <strong>di</strong>rettiva 97/11/CE all’allegato III, comma 2. recita: «Localizzazione dei<br />
progetti. Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che<br />
possono risentire dell’impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:<br />
• dell’utilizzazione attuale del territorio;<br />
• della ricchezza relativa, della qualità e della capacità <strong>di</strong> rigenerazione delle<br />
risorse naturali della zona;<br />
• della capacità <strong>di</strong> carico dell’ambiente naturale (…)»<br />
Occorrerà accertarsi che, soprattutto nelle zone già ampiamente artificializzate, non si<br />
riduca ulteriormente la capacità naturale <strong>di</strong> assorbire impatti (attraverso le capacità <strong>di</strong><br />
assorbimento, <strong>di</strong> tamponamento, <strong>di</strong> filtro attivo dei flussi naturali e <strong>di</strong> quelli prodotti<br />
dall’uomo). Diventa essenziale definire a questo proposito il ruolo, ai fini delle<br />
valutazioni, delle proposte progettuali in tema <strong>di</strong> inserimento e riqualificazione<br />
ambientale» 109 .<br />
Come situazione limite, potremmo <strong>di</strong>re che, rimanendo all’inerno delle capacità<br />
definite da fenomeni quali l’omeostasi 110 , la resilienza, la capacità <strong>di</strong> rigenerazione delle<br />
risorse naturali della zona potremmo attuare <strong>un</strong> tipo <strong>di</strong> sviluppo che risulta com<strong>un</strong>que in<br />
<strong>un</strong> impatto nullo, in quanto non eccede le capacità dell’ambiente <strong>di</strong> “autoripararsi” <strong>per</strong> i<br />
potenziali danni causati da interferenze.<br />
Il criterio del peggioramento significativo<br />
Tra i criteri relativi all’ambiente potremmo inserire anche quello del peggioramento<br />
significativo, già nominato in più occasioni (parlando dell’impatto zero e <strong>di</strong> <strong>un</strong> possibile<br />
109 ANPA-MATT (2001), Linee guida VIA, op. cit., p. 21<br />
110 Come afferma il Vismara (op. cit., p. 8) «Gli ecosistemi, come del resto gli in<strong>di</strong>vidui e le popolazioni<br />
posseggono meccanismi <strong>di</strong> autoregolazione naturale che consentono loro <strong>di</strong> controbilanciare, entro certi<br />
limiti, cambiamenti e stimoli negativi o positivi che compromettono il loro naturale equilibrio: questa<br />
capacità cibernetica prende il nome <strong>di</strong> omeostasi (…). All’interno del plateau omeostatico le variabili si<br />
mantengono pressoché costanti, nonostante le azioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo provenienti dall’esterno. Oltre i limiti<br />
dell’omeostasi si va incontro a <strong>un</strong>a rapida <strong>di</strong>struzione del sistema (Odum)»<br />
Pag. 110 <strong>di</strong> 148<br />
110
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
metodo alternativo alla ricettività ambientale <strong>per</strong> impe<strong>di</strong>re impatti indebiti in aree con<br />
qualità ambientale ancora relativamente elevata. Nelle linee guida VIA dell’ANPA-<br />
MATT, questo viene classificato tra i CRITERI DI SIGNIFICATIVITÀ, ponendo più<br />
l’accento su questa caratteristica, piuttosto che vederlo come <strong>un</strong>a possibile evoluzione<br />
del criterio della ricettività ambientale, come fa il Malcevschi. In questa sede abbiamo<br />
preferito seguire l’approccio del Malcevschi, inserendone la trattazione tra i criteri<br />
ambientali.<br />
Il peggioramento significativo è <strong>un</strong> criterio che può essere ritenuto realistico in<br />
quanto corregge due dei principali <strong>di</strong>fetti del criterio dell’impatto nullo. Innanzitutto si<br />
passa da <strong>un</strong>a richiesta <strong>di</strong> impatto nullo ad <strong>un</strong>a richiesta <strong>di</strong> impatto negativo (ad<strong>di</strong>tivo<br />
rispetto alla situazione precedente, da qui il concetto <strong>di</strong> peggioramento) non<br />
significativo (in quanto i peggioramenti significativi sarebbero da scartare); in secondo<br />
luogo si passa da <strong>un</strong>’ottica basata sul progetto (incapace <strong>di</strong> tenere conto <strong>di</strong> problemi<br />
cumulativi) ad <strong>un</strong>’ottica basata sull’ambiente, in cui si va a vedere il peggioramento <strong>di</strong><br />
parametri ambientali complessivi indotto dall’o<strong>per</strong>a.<br />
Ciò nonostante, il criterio non è <strong>di</strong> facile applicazione, in quanto prevede che venga<br />
effettuato <strong>un</strong> preciso stu<strong>di</strong>o delle con<strong>di</strong>zioni ambientali <strong>di</strong> partenza onde poter<br />
in<strong>di</strong>viduare il peggioramento indotto dalla nuova o<strong>per</strong>a. In questo caso, come messo in<br />
evidenza <strong>per</strong> la ricettività ambientale, lo stu<strong>di</strong>o p<strong>un</strong>tuale delle con<strong>di</strong>zioni iniziali <strong>di</strong><br />
partenza può essere particolarmente oneroso. C’è da <strong>di</strong>re, come sarà più chiaro in<br />
seguito, come il peggioramento venga in genere riferito allo stato dell’ambiente in<br />
relazione ai bersagli primari (ad esempio, concentrazione <strong>di</strong> <strong>un</strong> determinato inquinante<br />
nell’aria, nell’acqua, ecc.) senza andare a vedere gli effetti sui bersagli secondari, più<br />
<strong>di</strong>fficili da stimare, ma che danno <strong>un</strong>a misura più realistica della <strong>per</strong><strong>di</strong>ta <strong>di</strong> qualità<br />
ambientale causata dall’intervento. Infatti, come vedremo meglio in seguito, <strong>un</strong><br />
peggioramento a carico della qualità ambientale <strong>di</strong> <strong>un</strong> bersaglio primario relativamente<br />
contenuto, può portare anche ad effetti “<strong>di</strong>rompenti” in termini <strong>di</strong> <strong>per</strong><strong>di</strong>ta <strong>di</strong> qualità<br />
complessiva dei <strong>di</strong>versi sistemi ambientali.<br />
Se si prevede il monitoraggio delle <strong>di</strong>verse componenti ambientali <strong>per</strong> poter<br />
verificare se le stime effettuate ex ante erano atten<strong>di</strong>bili e, <strong>di</strong> conseguenza, se il livello<br />
<strong>di</strong> peggioramento effettivo è non significativo come era atteso, in concomitanza della<br />
realizzazione <strong>di</strong> più interventi che possono aver dato luogo a peggioramento, può essere<br />
<strong>di</strong>fficile in<strong>di</strong>viduare qual è da ritenersi responsabile dell’ “eccesso” <strong>di</strong> peggioramento<br />
rispetto all’attesa.<br />
Pag. 111 <strong>di</strong> 148<br />
111
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
Il criterio prevede la definizione <strong>di</strong> soglie limite al <strong>di</strong> sotto del quale <strong>un</strong><br />
peggioramente non è da ritenersi peggiorativo; in genere si tratta <strong>di</strong> valori <strong>per</strong>centuali<br />
(ad esempio il 5%) al <strong>di</strong> sotto dei quali si ritiene <strong>di</strong> poter trascurare il peggioramento.<br />
Anche in questo caso, com<strong>un</strong>que, sorge il problema <strong>di</strong> <strong>un</strong>a determinazione razionale<br />
delle soglie e della loro cre<strong>di</strong>bilità. In secondo luogo, come abbiamo già messo in<br />
evidenza, questi peggioramenti vengono in genere valutati relativamente alla situazione<br />
<strong>di</strong> partenza dei bersagli primari.<br />
Se come parametro <strong>di</strong> riferimento <strong>per</strong> determinare il peggioramento significativo si<br />
tiene conto del livello <strong>di</strong> interferenza che esso provoca (ad esempio dell’aumento <strong>di</strong><br />
concentrazione nell’ambiente) ma non dei danni ai possibili bersagli finali (uomo,<br />
ecosistemi, ecc.), il criterio tiene solo parzialmente conto delle caratteristiche<br />
ambientali. Questo in quanto la valutazione del peggioramento significativo in termini<br />
<strong>di</strong> concentrazione dell’inquinante in <strong>un</strong> bersaglio primario (ad esempio ppm <strong>di</strong> <strong>un</strong>a<br />
sostanza inquinante nell’aria) <strong>di</strong>pende non soltanto dalle caratteristiche della fonte, ma<br />
anche da alc<strong>un</strong>e caratteristiche (ventosità, ecc.) dell’ambiente, <strong>di</strong> cui quin<strong>di</strong> si tiene<br />
conto, ma non considera le caratteristiche <strong>di</strong> rarità, fragilità, ecc., che - a parità <strong>di</strong><br />
concentrazione - possono dare luogo a impatti molto <strong>di</strong>versi. Inoltre <strong>un</strong> peggioramento<br />
<strong>di</strong> <strong>un</strong>a eguale entità, a partire da livelli iniziali <strong>di</strong> qualità ambientale <strong>di</strong>versi, può<br />
provocare effetti molto <strong>di</strong>versi.<br />
Come vedremo meglio in seguito, anche se non esplicitato se non dalle linee guida<br />
ANPA-MATT (che mettono in guar<strong>di</strong>a contro <strong>un</strong>a applicazione semplicistica del<br />
criterio) il livello iniziale <strong>di</strong> “qualità dell’ambiente” è <strong>di</strong> fondamentale importanza, <strong>per</strong> il<br />
problema degli impatti cumulativi. Infatti, il criterio del peggioramento significativo<br />
tiene conto degli effetti cumulativi nello spazio (in quanto tiene conto del peggio-<br />
ramento rispetto alla situazione preesistente, vista nel suo complesso) ma non nel<br />
tempo. Una serie <strong>di</strong> peggioramenti non significativi può dar luogo, nel tempo, ad <strong>un</strong><br />
peggioramento che significativo lo è sicuramente. In altre parole, variazioni <strong>di</strong><br />
concentrazione <strong>di</strong> <strong>un</strong> inquinante, anche se contenute all’interno <strong>di</strong> <strong>un</strong> aumento<br />
relativamente ridotto (ad es. il 3%), se si ripetono regolarmente nel tempo possono<br />
portare ad <strong>un</strong>a situazione finale che <strong>di</strong>fferisce sensibilmente da quella iniziale. Inoltre,<br />
nel caso che il peggioramento, sia pure <strong>di</strong> entità trascurabile, si verifichi a partire da <strong>un</strong>a<br />
situazione <strong>di</strong> criticità iniziale, esso può com<strong>un</strong>que avere effetti notevoli.<br />
Il criterio del peggioramento significativo non garantisce <strong>un</strong> efficiente uso dell’<br />
inquinamento (come accade <strong>per</strong> le migliori tecnologie <strong>di</strong>sponibili), anche se dovrebbe<br />
Pag. 112 <strong>di</strong> 148<br />
112
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
ridurre la possibilità <strong>di</strong> impatti indebiti, limitando all’interno <strong>di</strong> <strong>un</strong>a valore <strong>di</strong> variazione<br />
massimo il peggioramento dovuto ad <strong>un</strong> singolo intervento.<br />
Il criterio è, inoltre, equo nei confronti dei <strong>di</strong>versi proponenti, <strong>per</strong>ché tutti dovranno<br />
garantire l’assenza <strong>di</strong> peggioramenti significativi rispetto ad <strong>un</strong>a soglia che è la stessa<br />
<strong>per</strong> tutti i proponenti (anche se si potrebbe obiettare che <strong>un</strong>a stessa variazione<br />
<strong>per</strong>centuale può essere dovuta a variazioni assolute molto <strong>di</strong>verse, in <strong>di</strong>pendenza del<br />
livello iniziale che si prende a riferimento <strong>per</strong> misurare la variazione).<br />
Come vedremo meglio in seguito, <strong>un</strong>’applicazione semplicistica del criterio non<br />
garantisce che, se si è già vicini a livelli <strong>di</strong> criticità, essi non vengano su<strong>per</strong>ati.<br />
Alta<br />
QUALITA’<br />
Q(x)<br />
Bassa<br />
t(A) t(P)<br />
Figura 15 –Modello teorico <strong>di</strong> riferimento <strong>per</strong> la valutazione del criterio del<br />
peggioramento significativo<br />
(fig. 5.4 Malcevschi)<br />
a)<br />
b)<br />
c)<br />
d)<br />
Legenda «Qualora la situazione ambientale iniziale sia già molto critica (casi c e d),<br />
l’abbassamento della qualità provocato dall’emissione, ancorché minimizzato sulla base <strong>di</strong><br />
criteri ambientali, può essere tale da provocare il su<strong>per</strong>amento della soglia <strong>di</strong> accettabilità.<br />
L’adozione semplicistica del criterio può tradursi in ulteriori compromissioni <strong>di</strong> situazioni già<br />
inaccettabili in partenza». (Malcevschi)<br />
Riportiamo <strong>di</strong> seguito quanto previsto dalle Linee guida ANPA-MATT, anche <strong>per</strong><br />
mettere in evidenza i problemi legati ad <strong>un</strong>a applicazione semplicistica del criterio.<br />
Pag. 113 <strong>di</strong> 148<br />
tempo<br />
113
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
«Alc<strong>un</strong>i tra i criteri precedenti presuppongono specifiche soglie su<strong>per</strong>ate le quali<br />
scattano valutazioni <strong>di</strong> inaccettabilità basate su criteri progettuali, tecnologici,<br />
ambientali. Spesso ai fini dell’accettabilità è conveniente associare a ogni impatto<br />
considerato – prima e dopo le misure <strong>di</strong> mitigazione – <strong>un</strong>a valutazione in termini <strong>di</strong><br />
significatività. Infatti anche qualora dall’analisi dei livelli dell’inquinamento <strong>di</strong> fondo<br />
risultino ancora consistenti margini <strong>di</strong> ricettività ambientale, non possono <strong>di</strong> regola<br />
essere considerati accettabili nuovi impatti che si traducono in peggioramenti<br />
significativi della situazione esistente. Potrebbero <strong>per</strong>ciò essere <strong>di</strong>chiarati a priori<br />
limiti <strong>di</strong> peggioramento (ad esempio non oltre il 5%) dei livelli esistenti che non devono<br />
essere su<strong>per</strong>ati. Pur essendoci dei margini <strong>di</strong> soggettività in tale <strong>per</strong><strong>corso</strong>, si offre<br />
com<strong>un</strong>que alla valutazione <strong>un</strong> riferimento <strong>per</strong> stimare le variazioni intervenute.<br />
A tal fine <strong>un</strong> impatto verrà <strong>di</strong> regola considerato:<br />
Non significativo (ininfluente)<br />
se il suo effetto sull’ambiente non è <strong>di</strong>stinguibile dagli effetti preesistenti<br />
(<strong>per</strong> esempio se le emissioni in atmosfera dell’o<strong>per</strong>a non comportano<br />
variazioni apprezzabili <strong>di</strong> concentrazioni in aria degli inquinanti se<br />
paragonate con le fluttuazioni esistenti si <strong>di</strong>ce che l’impatto delle emissioni<br />
dell’o<strong>per</strong>a, in termini <strong>di</strong> concentrazione in aria, non è significativo);<br />
Scarsamente significativo<br />
Significativo<br />
se le stime effettuate portano alla conclusione che esso sarà chiaramente<br />
apprezzabile sulla base <strong>di</strong> meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> misura <strong>di</strong>sponibili, e che <strong>per</strong>ò – anche<br />
tenuto conto dell’incertezza della stima – il suo contributo non porterà a <strong>un</strong><br />
peggioramento significativo della situazione esistente (<strong>per</strong> esempio <strong>un</strong><br />
peggioramento inferiore al 5% dei livelli <strong>di</strong> inquinamento attuali);<br />
se la stima del suo contributo alla situazione esistente porta – tenuto conto<br />
dell’incertezza della stima – a livelli che implicano <strong>un</strong> peggioramento<br />
significativo (<strong>per</strong> esempio <strong>un</strong> peggioramento su<strong>per</strong>iore al 5% dei livelli <strong>di</strong><br />
inquinamento attuali); parimenti <strong>un</strong> impatto può <strong>di</strong>rsi significativo se, in<br />
<strong>un</strong>a situazione già critica, caratterizzata cioè da su<strong>per</strong>amenti dei limiti <strong>di</strong><br />
legge, contribuisce a innalzare in misura sensibile la frequenza e l’entità <strong>di</strong><br />
detti su<strong>per</strong>amenti;<br />
Pag. 114 <strong>di</strong> 148<br />
114
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
Molto significativo<br />
se il suo contributo alla situazione esistente porta a livelli su<strong>per</strong>iori a limiti<br />
stabiliti <strong>per</strong> legge o tramite altri criteri ambientali – qualora in assenza<br />
dell’o<strong>per</strong>a tali limiti non vengono raggi<strong>un</strong>ti; parimenti <strong>un</strong> impatto può <strong>di</strong>rsi<br />
molto significativo se, in <strong>un</strong>a situazione già critica, caratterizzata cioè da<br />
su<strong>per</strong>amenti dei limiti, contribuisce a innalzare in misura rilevante la<br />
frequenza e l’entità <strong>di</strong> detti su<strong>per</strong>amenti» 111 .<br />
Il criterio del miglioramento compensativo<br />
Il criterio del miglioramento compensativo viene classificato dalle Linee guida VIA<br />
dell’ANPA-MATT, come <strong>un</strong>o dei CRITERI FONDATI SU BILANCI AMBIENTALI<br />
COMPLESSIVI DEGLI EFFETTI ATTESI. «Secondo questi criteri le singole<br />
valutazioni vanno inserite in <strong>un</strong> quadro complessivo che tenga conto, accanto agli<br />
impatti negativi, anche degli impatti positivi prodotti dal progetto <strong>di</strong>rettamente o<br />
in<strong>di</strong>rettamente attraverso azioni <strong>di</strong> alleggerimento delle pressioni esterne attualmente<br />
esistenti.<br />
Molteplici metodologie sono state proposte <strong>per</strong> parametrazioni complessive dell’<br />
ambiente utilizzabili <strong>per</strong> bilanci ambientali (in<strong>di</strong>ci ambientali sintetici, analisi multi-<br />
criteri, <strong>di</strong>verse forme <strong>di</strong> contabilità ambientale, in<strong>di</strong>catori riass<strong>un</strong>tivi quali l’impronta<br />
ecologica). Anche limitandosi ad utilizzare semplici tabelle comparative, il criterio<br />
valutativo <strong>di</strong> fondo è in questo caso quello <strong>di</strong> confrontare su basi coerenti i costi ed i<br />
benefici sul piano ambientale prodotti dal progetto e dalle sue alternative consi-<br />
derate» 112 . Nella parte successiva del <strong>corso</strong> riprenderemo le problematiche relative all’<br />
utilizzo <strong>di</strong> tecniche <strong>di</strong> analisi multicriteriale nell’ambito <strong>di</strong> <strong>un</strong> V.I.A.<br />
Il criterio del miglioramento compensativo è <strong>un</strong> criterio realistico e molto applicato,<br />
anche se a volte in maniera impropria. Esso può essere interpretato come riferito all’<br />
ambiente in senso lato, in quanto tiene in considerazione anche problematiche <strong>di</strong> natura<br />
socio-economica (che potrebbero costituire compensazioni in caso <strong>di</strong> peggioramenti alla<br />
qualità ambientale in senso stretto). Infatti, <strong>per</strong> la prima volta, si tiene conto sia <strong>di</strong><br />
impatti negativi che <strong>di</strong> impatti positivi, mentre con i precedenti criteri ci si poneva in<br />
<strong>un</strong>’ottica <strong>di</strong> analisi dei soli effetti negativi, in genere riferiti ad <strong>un</strong> concetto <strong>di</strong> ambiente<br />
inteso in senso stretto. Prevedendo la possibilità <strong>di</strong> miglioramento <strong>di</strong> alc<strong>un</strong>i parametri, il<br />
111 ANPA-MATT (2001), Linee guida VIA, op. cit., p. 22<br />
112 ANPA-MATT (2001), Linee guida VIA, op. cit., p. 21<br />
Pag. 115 <strong>di</strong> 148<br />
115
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
criterio è suscettibile <strong>di</strong> razionale utilizzazione anche nel caso <strong>di</strong> situazioni iniziali<br />
molto vicine o, al limite, al <strong>di</strong> sotto delle soglie <strong>di</strong> accettabilità, mentre gli altri criteri<br />
non erano in grado <strong>di</strong> fornire molte in<strong>di</strong>cazioni nel caso che si partisse da <strong>un</strong> livello<br />
iniziale <strong>di</strong> qualità ambientale già ritenuto “inaccettabile”.<br />
La sua facilità <strong>di</strong> applicazione e <strong>di</strong> fornire risposte che possano essere accettate<br />
anche al solo “livello tecnico” <strong>di</strong>pende dal fatto se si tratti <strong>di</strong> <strong>un</strong> miglioramento<br />
compensativo omogeneo, o meno.<br />
Nel caso che il miglioramento compensativo sia completamente omogeneo (a carico<br />
dello stesso parametro, nello stesso luogo e tempo) il criterio dà in<strong>di</strong>cazioni <strong>per</strong>fetta-<br />
mente atten<strong>di</strong>bili e risulta relativamente facile da controllare. Ad esempio, se chiedo <strong>di</strong><br />
ampliare <strong>un</strong>a linea produttiva impegnandomi nel contempo a cambiare tecnologia, in<br />
maniera che l’incremento <strong>di</strong> emissioni <strong>di</strong> SO2 dovuto all’ampliamento della scala<br />
produttiva sia più che compensato dalla riduzione delle stesse emissioni, dovuto al<br />
cambiamento <strong>di</strong> tecnologia, il bilancio complessivo della SO2 prevederà <strong>un</strong>a<br />
<strong>di</strong>minuzione delle emissioni della stessa, con <strong>un</strong>a situazione post-intervento migliore <strong>di</strong><br />
quella pre-intervento. Chiaramente, la positività dell’intervento non è così chiara se<br />
legata alla <strong>di</strong>smissione <strong>di</strong> <strong>un</strong> vecchio impianto e alla realizzazione <strong>di</strong> <strong>un</strong> nuovo impianto<br />
che ha localizzazione <strong>di</strong>versa (in quanto la cessazione <strong>di</strong> emissioni in <strong>un</strong> determinato<br />
ambiente può avere <strong>un</strong> impatto positivo che non basta a compensare l’immissione <strong>di</strong> <strong>un</strong><br />
ammontare <strong>di</strong> inquinanti, anche in quantità inferiore, in <strong>un</strong> ambiente <strong>di</strong>verso, e<br />
com<strong>un</strong>que le due cose non sono comparabili, a meno che i problemi che l’inquinante<br />
crea non siano esclusivamente a livello “globale”) oppure tempistiche <strong>di</strong>verse, nel senso<br />
che si possono avere momenti in cui le due fonti <strong>di</strong> emissione (vecchia e nuova)<br />
cumulano il loro effetto (con possibili effetti <strong>di</strong>rompenti, e com<strong>un</strong>que <strong>di</strong>versi da quelli<br />
che si avrebbero in assenza <strong>di</strong> cumulo).<br />
Nel caso <strong>di</strong> miglioramento compensativo <strong>di</strong>somogeneo (ad esempio la realizzazione<br />
<strong>di</strong> <strong>un</strong> parco a valle <strong>di</strong> <strong>un</strong> intervento <strong>di</strong> recu<strong>per</strong>o produttivo <strong>di</strong> <strong>un</strong>a cava, <strong>un</strong> aumento <strong>di</strong><br />
occupazione a valle <strong>di</strong> <strong>un</strong> deterioramento della qualità ambientale, ecc.) valutare se il<br />
miglioramento è in grado <strong>di</strong> compensare, o meno, il nuovo impatto negativo è <strong>di</strong>fficile,<br />
in quanto impatti positivi e negativi si possono verificare a carico <strong>di</strong> parametri <strong>di</strong>versi,<br />
in momenti <strong>di</strong>versi e in localizzazioni <strong>di</strong>verse. Chiaramente, più i parametri sono<br />
eterogenei e più può essere <strong>di</strong>fficile confrontarli ed ammettere <strong>un</strong>a “compensazione” tra<br />
effetti positivi ed effetti negativi. Inoltre, ai fini <strong>di</strong> poter bilanciare il peggioramento a<br />
carico <strong>di</strong> <strong>un</strong> parametro o criterio con <strong>un</strong> miglioramento a carico <strong>di</strong> <strong>un</strong> altro, bisogna aver<br />
Pag. 116 <strong>di</strong> 148<br />
116
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
prima verificato che in ness<strong>un</strong> momento <strong>un</strong> singolo parametro su<strong>per</strong>i i valori <strong>di</strong> criticità.<br />
In altre parole, non si possono ammettere compensazioni <strong>per</strong> peggioramenti che portano<br />
alc<strong>un</strong>e variabili al <strong>di</strong> sotto della soglia <strong>di</strong> accettabilità (quin<strong>di</strong>, non sarà possibile<br />
prevedere <strong>un</strong>a compensazione monetaria <strong>per</strong> interventi che portano la qualità<br />
ambientale in senso stretto al <strong>di</strong> sotto della soglia <strong>di</strong> accettabilità).<br />
I problemi <strong>di</strong> soggettività che abbiamo visto caratterizzare alc<strong>un</strong>i dei criteri<br />
precedenti soprattutto in termini <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>bilità/accettabilità delle soglie (le soglie degli<br />
standard, il valore <strong>di</strong> riferimento <strong>per</strong> <strong>di</strong>scriminare se <strong>un</strong> peggioramento è significativo, o<br />
meno) in questo caso si riferiscono soprattutto alla necessità <strong>di</strong> esprimere <strong>un</strong> giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong><br />
importanza relativa tra i <strong>di</strong>versi criteri (rispetto ai quali si verificano gli impatti negativi<br />
o i miglioramenti compensativi). In altre parole, bisogna verificare se <strong>un</strong> miglioramento<br />
della qualità dell’aria riveste esattamente la stessa importanza <strong>di</strong> <strong>un</strong> peggioramento a<br />
carico della qualità dell’acqua, o se gli obiettivi che mi pongo in termini <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa della<br />
salute umana hanno <strong>per</strong> me la stessa importanza <strong>di</strong> quelli <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa dell’occupazione e<br />
del red<strong>di</strong>to. Oltre ad essere valutazioni soggettive, quelle relative all’importanza dei<br />
criteri sono valutazioni che – anche in termini me<strong>di</strong> statistici – possono variare <strong>di</strong> molto<br />
a seconda della situazione iniziale. In altre parole, volendo “estremizzare”, mentre in<br />
<strong>un</strong>a situazione <strong>di</strong> paese sviluppato verrà dato <strong>un</strong> maggior peso alla <strong>di</strong>fesa della salute<br />
rispetto al red<strong>di</strong>to, in <strong>un</strong> paese in via <strong>di</strong> sviluppo, dove la gente muore <strong>di</strong> fame,<br />
l’obiettivo <strong>di</strong> sfamarsi (red<strong>di</strong>to) può essere ritenuto relativamente più importante <strong>di</strong><br />
quello della <strong>di</strong>fesa della salute (se rischio <strong>di</strong> morire oggi <strong>di</strong> fame, non mi preoccupo<br />
molto del rischio <strong>di</strong> morire <strong>di</strong> tumore tra 10 anni). Un altro fattore che influenza le<br />
importanze relative dei <strong>di</strong>versi effetti, positivi e negativi, è la <strong>di</strong>stribuzione degli stessi<br />
tra i vari gruppi. Se la creazione <strong>di</strong> <strong>un</strong> certo impianto favorisce lo sviluppo industriale<br />
ma crea problemi <strong>di</strong> salute alla popolazione (soprattutto se in assenza <strong>di</strong> ricadute<br />
occupazionali), i gruppi legati agli “industriali” tenderanno a dare molta importanza<br />
all’incremento <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to (al quale sono <strong>di</strong>rettamente interessati) e poca alla <strong>per</strong><strong>di</strong>ta <strong>di</strong><br />
qualità ambientale (della quale non subiscono le conseguenze), mentre la popolazione<br />
tenderà ad enfatizzare la <strong>per</strong><strong>di</strong>ta <strong>di</strong> qualità ambientale (della quale subisce gli effetti<br />
negativi) e ad attribuire <strong>un</strong> ruolo secondario all’incremento <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to o <strong>di</strong> produzione<br />
(soprattutto se questo va a vantaggio <strong>di</strong> gruppi che vivono al <strong>di</strong> fuori dell’area).<br />
Di nuovo, come abbiamo prima messo in evidenza, il valore iniziale <strong>di</strong> “qualità” <strong>di</strong><br />
<strong>un</strong> parametro o il livello iniziale <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfacimento <strong>di</strong> <strong>un</strong> obiettivo possono avere <strong>un</strong>a<br />
notevole influenza in termini <strong>di</strong> possibilità <strong>di</strong> compensazione/negoziazione tra obiettivi.<br />
Pag. 117 <strong>di</strong> 148<br />
117
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
QUALITA’<br />
Q(x)<br />
QUALITA’<br />
Q(x)<br />
A B<br />
Intervento senza<br />
azioni compensative<br />
Q(x)<br />
C D<br />
a) Impatti e compensazioni<br />
si equivalgono<br />
b) recu<strong>per</strong>i in situazioni<br />
critiche<br />
c) Recu<strong>per</strong>i in situazioni<br />
molto critiche<br />
Q(x)<br />
Figura 16 –Modello teorico <strong>di</strong> riferimento <strong>per</strong> la valutazione del criterio del bilancio<br />
ambientale<br />
(fig. 5.5 Malcevschi)<br />
Legenda «Rispetto ai decrementi <strong>di</strong> qualità attesi qualora l’intervento venga realizzato in<br />
con<strong>di</strong>zioni non compensate (schema A), si possono trovare azioni compensative contestuali ed<br />
equivalenti (schema B). In con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a qualità si possono ipotizzare casi in cui impatti e<br />
compensazioni si equivalgono, o in cui com<strong>un</strong>que non vi sono peggioramenti significativi<br />
(schema C, caso a); in situazioni critiche possono essere accettate solo proposte che si<br />
traducano in <strong>un</strong> bilancio ambientale positivo (schema C, casi b e c). Ciò che non può essere<br />
accettato è la compensazione <strong>di</strong> impatti <strong>di</strong> <strong>un</strong> certo tipo con benefici <strong>di</strong> tipo <strong>di</strong>verso: in questo<br />
caso si possono avere casi in cui vengono su<strong>per</strong>ate le soglie <strong>di</strong> accettabilità (schema D)».<br />
(Malcevschi)<br />
QUALITA’<br />
QUALITA’<br />
Pag. 118 <strong>di</strong> 148<br />
Azioni compensative<br />
contestuali<br />
t(A) t(P) t(A)<br />
t(P)<br />
Compensazioni <strong>di</strong> natura<br />
<strong>di</strong>versa dagli impatti<br />
t(A) t(P) t(A)<br />
t(P)<br />
118
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
Nel senso che, ad ulteriori peggioramenti a carico <strong>di</strong> situazioni già critiche dovrebbe<br />
essere de<strong>di</strong>cata <strong>un</strong>a notevole enfasi (fino ad arrivare al cosidetto livello <strong>di</strong> “red flag”,<br />
cioè quello in cui la situazione è talmente critica da non essere ritenuta accettabile, <strong>per</strong><br />
cui l’alternativa caratterizzata da <strong>un</strong>a o più “red flag” dovrebbe essere scartata, in<br />
assenza <strong>di</strong> misure <strong>di</strong> mitigazione che consentano <strong>di</strong> riportare i valori all’interno <strong>di</strong> soglie<br />
<strong>di</strong> accettabilità), mentre a situazioni <strong>di</strong> ulteriore miglioramento <strong>di</strong> parametri già con<br />
valori più che sod<strong>di</strong>sfacenti, potrebbe essere de<strong>di</strong>cata <strong>un</strong>’importanza minore. Il<br />
problema dei pesi sarà ripreso nella seconda parte del <strong>corso</strong>.<br />
Se il criterio viene visto, come dovrebbe, in <strong>un</strong>’ottica ambientale, sia pure in senso<br />
ampio, esso dovrebbe essere in grado <strong>di</strong> considerare sia gli effetti degli impatti<br />
cumulativi (cioè dovuti al cumulo delle interferenze prodotte dall’o<strong>per</strong>a rispetto a quelle<br />
che com<strong>un</strong>que si avrebbero anche in sua assenza), sia <strong>di</strong> verificare l’entità degli impatti<br />
in relazione allo specifico ambiente in cui si suppone <strong>di</strong> inserire l’intervento (ad<br />
esempio, l’impatto sul paesaggio sarà strettamente <strong>di</strong>pendente dalla localizzazione).<br />
Da notare, infine, come il La Camera (1998, op. cit.), <strong>per</strong> mettere in evidenza come<br />
il criterio possa essere riferito (analogamente a molti dei precedenti) a <strong>un</strong>a concezione<br />
<strong>di</strong> ambiente in senso stretto (cioè legato a parametri fisici-naturalistici più che a variabili<br />
<strong>di</strong> natura socio-economica) parli <strong>di</strong> “riequilibrio ambientale compensativo” piuttosto<br />
che <strong>di</strong> “miglioramento compensativo”.<br />
Il modello relativo al criterio del miglioramento compensativo riportato in figura 16<br />
dovrebbe mettere in evidenza come non sempre le compensazioni siano da considerarsi<br />
completamente “accettabili”, con la conseguenza <strong>di</strong> non poter procedere ad <strong>un</strong>a<br />
valutazione basata sulla somma algebrica <strong>di</strong> effetti positivi ed effetti negativi.<br />
Ricor<strong>di</strong>amo, infine, come – analogamente a quanto accade <strong>per</strong> l’Analisi Costi Benefici<br />
– può esistere <strong>un</strong> problema <strong>di</strong> equità (cioè <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione ineguale <strong>di</strong> effetti positivi e<br />
negativi tra i <strong>di</strong>versi gruppi interessati) del quale si dovrebbe tenere conto.<br />
Il criterio dell’accettazione sociale<br />
Pur non costituendo sicuramente <strong>un</strong> criterio rispetto al quale – soprattutto nel caso <strong>di</strong><br />
utilizzo esclusivo – è possibile decidere della auspicabilità, o meno, <strong>di</strong> <strong>un</strong> intervento,<br />
sottolinea <strong>un</strong>a problematica <strong>di</strong> importanza non secondaria in quanto, soprattutto negli<br />
ultimi tempi, risulta <strong>di</strong>fficile far realizzare interventi <strong>per</strong> cui non esista <strong>un</strong> pubblico<br />
consenso. Se si considera che la procedura <strong>di</strong> VIA prevede al suo interno come<br />
Pag. 119 <strong>di</strong> 148<br />
119
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
elemento caratterizzante la partecipazione del pubblico, risulta chiaro come la verifica<br />
dell’accettazione sociale non possa essere trascurata.<br />
Ciò nonostante, non sempre è facile stimolare il consenso. Alc<strong>un</strong>i <strong>di</strong>cono che il<br />
proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> VIA dovrebbe proprio <strong>per</strong>mettere il coagularsi del consenso su<br />
posizioni che siano anche tecnicamente razionali, oltre che politicamente e socialmente<br />
accettabili.<br />
Questo criterio è basato essenzialmente sulle posizioni degli attori 113 , soprattutto<br />
quelli passivi (citta<strong>di</strong>ni). Chiaramente, a seconda delle situa-zioni, possono essere <strong>di</strong><br />
fondamentale importanza anche le posizioni degli attori attivi (decisori pubblici, ad<br />
esempio coinvolti a livello locale)<br />
Essendo <strong>un</strong> criterio basato sull’accettazione sociale, soprattutto in presenza <strong>di</strong> <strong>un</strong>a<br />
citta<strong>di</strong>nanza scarsamente informata e “manovrabile” facendo leva su fattori <strong>di</strong> natura<br />
emotiva (la paura delle catastrofi che possono essere legate alla cattiva gestione <strong>di</strong><br />
determinati impianti; le tensioni sociali legate a problemi <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione, ecc.), il<br />
criterio non è in grado <strong>di</strong> assicurare decisioni <strong>di</strong> natura razionale. Spesso e volentieri,<br />
infatti, l’opinione dei <strong>di</strong>versi gruppi <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>ni è molto <strong>di</strong>versa da quella espressa dai<br />
tecnici, come è facilmente desumibile dall’esame della tabella 2 tratta dal Malcevschi.<br />
La tabella dovrebbe illustrare due tipi <strong>di</strong> problematiche:<br />
a) la prima è quella relativa alla <strong>per</strong><strong>di</strong>ta <strong>di</strong> fiducia da parte della popolazione nei<br />
giu<strong>di</strong>zi espressi dagli es<strong>per</strong>ti, messa in evidenza parlando del cambiamento <strong>di</strong><br />
mentalità avvenuto tra gli anni 60 e 90, <strong>per</strong> cui anche la realizzazione <strong>di</strong> <strong>un</strong>’o<strong>per</strong>a<br />
che – nell’opinione degli es<strong>per</strong>ti – non causa impatti rilevanti può dare luogo ad<br />
<strong>un</strong>a vivace opposizione da parte della popolazione locale;<br />
b) la seconda è che non è tanto o soltanto importante il rischio oggettivo (desumibile,<br />
magari, facendo uso <strong>di</strong> analisi statistiche storiche che leghino la realizzazione <strong>di</strong><br />
<strong>un</strong>a determinata attività agli effetti negativi che le possono essere attribuiti),<br />
quanto la <strong>per</strong>cezione del rischio che i <strong>di</strong>versi soggetti hanno. Chiaramente questa<br />
<strong>per</strong>cezione, essendo <strong>di</strong> natura soggettiva, potrà essere influenzata in maniera più o<br />
meno rilevante. Una corretta informazione al pubblico dovrebbe limitare l’area<br />
della soggettività nei giu<strong>di</strong>zi relativi agli effetti indesiderati <strong>di</strong> <strong>un</strong>’o<strong>per</strong>a.<br />
113 le alternative ad <strong>un</strong> intervento derivano da quattro componenti principali: il progetto, con le sue<br />
alternative <strong>di</strong> natura tecnologica e <strong>di</strong>mensionale, l’ambiente, ad esempio con le alternative localizzative,<br />
gli attori, con i problemi <strong>di</strong> accettazione sia da parte delle istituzioni pubbliche che dei privati citta<strong>di</strong>ni e<br />
gli scenari, che ad esempio possono avere influenza sulle scelte <strong>di</strong> alternative che si <strong>di</strong>fferenziano <strong>per</strong><br />
grado <strong>di</strong> flessibilità e/o rischiosità<br />
Pag. 120 <strong>di</strong> 148<br />
120
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
Tabella 2 – Or<strong>di</strong>namento del rischio <strong>per</strong>cepito e stima <strong>di</strong> mortalità annua <strong>per</strong> 30<br />
<strong>di</strong>verse attività (cfr. Malcevschi, pag. 66)<br />
Or<strong>di</strong>namento del rischio <strong>per</strong>cepito (*)<br />
relativamente a 30 attività e tecnologie<br />
Stime <strong>di</strong> mortalità annue<br />
Donne Studenti Marchi Es<strong>per</strong>ti Stime Donne Studenti<br />
<strong>di</strong> Club<br />
tecniche<br />
Centrali nucleari 1 1 8 20 16-600 20 27<br />
Veicoli a motore 2 5 3 1 50000 28000 10500<br />
Armi da fuoco 3 2 1 4 17000 3000 1900<br />
Fumo 4 3 4 2 150000 6900 2400<br />
Motocicletta 5 6 2 6 3000 1600 1600<br />
Bevande alcooliche 6 7 5 3 100000 12000 2600<br />
Aviazione privata 7 15 11 12 1300 550 650<br />
Lavoro <strong>di</strong> Polizia 8 8 7 17 160 460 390<br />
Pestici<strong>di</strong> 9 4 15 8 n.d. 140 84<br />
Chirurgia 10 11 9 5 2800 2500 900<br />
Sparatorie 11 10 6 18 195 220 390<br />
E<strong>di</strong>lizia 12 14 13 13 1000 400 379<br />
Caccia 13 18 10 23 800 380 410<br />
Bombolette spray 14 13 23 26 n.d. 56 38<br />
Attività alpinistiche 15 22 12 29 30 50 70<br />
Biciclette 16 24 14 15 1000 910 420<br />
Aviazione commerc. 17 16 18 16 130 280 650<br />
Centrali elettriche 18 19 19 9 14000 660 500<br />
Nuoto 19 30 17 10 3000 930 370<br />
Contraccettivi 20 9 22 11 150 180 120<br />
Sci 21 25 16 30 18 55 72<br />
Raggi X 22 17 24 7 2300 90 40<br />
Football scolastico 23 26 21 27 23 39 40<br />
Ferrovie 24 23 20 19 1950 190 210<br />
Conservanti <strong>per</strong> cibi 25 12 28 14 n.d. 61 63<br />
Coloranti <strong>per</strong> cibi 26 20 30 21 n.d. 38 33<br />
Falciatrici meccaniche 27 28 25 28 24 40 33<br />
Prescrizione antibiot. 28 21 26 24 n.d. 160 290<br />
Apparecchi domestici 29 27 27 22 200 200 240<br />
Vaccinazioni 30 29 29 25 10 65 52<br />
(*) L’or<strong>di</strong>namento si basa sulla me<strong>di</strong>a geometrica delle valutazioni <strong>di</strong> rischio all’interno <strong>di</strong> ogni gruppo. Il<br />
livello “1” rappresenta l’attività o la tecnologia considerata a maggior rischio<br />
Per illustrare il <strong>per</strong>icolo non solo <strong>di</strong> dare informazioni false, ma anche <strong>di</strong> presentare<br />
informazioni corrette in maniera che possano essere fuorvianti, può essere interessante<br />
ricordare il caso <strong>di</strong> <strong>un</strong>o studente americano che, debitamente assistito da <strong>un</strong> notaio che<br />
verificasse la correttezza del suo o<strong>per</strong>ato, riusci a raccogliere non sono <strong>un</strong> notevole<br />
numero <strong>di</strong> firme <strong>per</strong> mettere al bando <strong>di</strong> monossido <strong>di</strong> <strong>di</strong>idrogeno, ma anche <strong>di</strong> avere<br />
<strong>un</strong>a risposta positiva al bando su <strong>un</strong>a <strong>per</strong>centuale estremamente elevata delle <strong>per</strong>sone<br />
che aveva contattato. In breve, se non erro, le principali ragioni da lui addotte <strong>per</strong><br />
<strong>di</strong>mostrare la <strong>per</strong>icolosità <strong>di</strong> tale sostanza erano le seguenti:<br />
Pag. 121 <strong>di</strong> 148<br />
121
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
è <strong>un</strong>a sostanza che può causare notevoli problemi, fino alla morte, se<br />
accidentalmente introdotta nelle vie respiratorie,<br />
è <strong>un</strong>a sostanza che, nel caso <strong>di</strong> contatto con i suoi vapori, può causare ustioni anche<br />
gravi,<br />
è <strong>un</strong>a delle componenti principali delle piogge acide,<br />
viene regolarmente rinvenuta in gran<strong>di</strong> proporzioni nei tessuti tumorali <strong>di</strong> pazienti<br />
terminali;<br />
contribuisce all’effetto serra.<br />
Tutte le precedenti informazioni sono esatte, solo che il monossido <strong>di</strong> <strong>di</strong>idrogeno è<br />
la com<strong>un</strong>issima acqua ed anche se – introdotta nei polmoni – può causare la morte, se<br />
allo stato <strong>di</strong> vapore provoca ustioni, se è <strong>un</strong>a delle componenti principali delle piogge<br />
acide e se è contenuta nei tessuti tumorali, sicuramente non la si può considerare <strong>un</strong>a<br />
sostanza inquinante il cui uso deve essere ban<strong>di</strong>to. Quin<strong>di</strong>, anche fornendo informazioni<br />
corrette, la maniera con cui esse vengono presentate non è ininfluente in termini <strong>di</strong><br />
<strong>per</strong>cezione del rischio, ecc.<br />
Tra le altre problematiche che può essere interessante ricordare, c’è quella che il<br />
grado <strong>di</strong> accettazione sociale <strong>di</strong> <strong>un</strong>’o<strong>per</strong>a spesso <strong>di</strong>pende dalla <strong>di</strong>stanza da cui è<br />
collocata rispetto alla popolazione oggetto degli impatti. Se in alc<strong>un</strong>i casi questo è<br />
comprensibile in quanto esiste <strong>un</strong>a relazione oggettiva abbastanza stretta tra la <strong>di</strong>stanza<br />
dalla fonte <strong>di</strong> interferenza e la natura dell’impatto negativo che ne può risultare (ad<br />
esempio nel caso del rumore, che non si propaga oltre determinate <strong>di</strong>stanze), in altri casi<br />
questa relazione può essere meno stretta, nel senso che si possono avere ricadute<br />
negative notevoli (anche se non “<strong>di</strong>sastrose”) anche ad <strong>un</strong>a <strong>di</strong>stanza relativamente<br />
elevata dall’o<strong>per</strong>a (ve<strong>di</strong> il caso delle deposizioni <strong>di</strong> Cesio proveniente da Chernobyl). A<br />
tal proposito può essere interessante richiamare il concetto <strong>di</strong> NIMBY. «E’ invalso, in<br />
questi ultimi anni, l’uso <strong>di</strong> <strong>un</strong>a formula riass<strong>un</strong>ta nell’acronimo “NIMBY (Not In My<br />
BackYard”, non nel mio giar<strong>di</strong>no”), <strong>per</strong> designare fenomeni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssenso, manifestato<br />
dalla popolazione più <strong>di</strong>rettamente interessata o dai suoi rappresentanti, verso o<strong>per</strong>e o<br />
interventi che sono riconosciuti generalmente <strong>di</strong> interesse pubblico, ai quali <strong>per</strong>ò è<br />
com<strong>un</strong>emente atribuito <strong>un</strong> rilevante grado <strong>di</strong> impatto locale negativo». Si tratta dei casi<br />
in cui, ad esempio, pur avendo la popolazione chiara coscienza della necessità <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>sporre dei rifiuti prodotti, si oppone anche in maniera drastica alla realizzazione <strong>di</strong><br />
<strong>un</strong>a <strong>di</strong>scarica o <strong>di</strong> <strong>un</strong> inceneritore sul proprio territorio. «La formula, dotata senza<br />
dubbio dell’illuminante potere descrittivo che hanno le battute ed i motti <strong>di</strong> spirito<br />
riusciti, tende ad essere usata come se fosse <strong>un</strong>o strumento esplicativo utile <strong>per</strong> la<br />
Pag. 122 <strong>di</strong> 148<br />
122
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
comprensione profonda e <strong>per</strong> la gestione del fenomeno considerato. Per quanto l’uso<br />
da parte degli addetti ai lavori conferisca a tale locuzione <strong>un</strong> senso tecnico, scevro da<br />
giu<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> valore, essa tende tuttavia ad assumere, nell’uso com<strong>un</strong>e, <strong>un</strong> senso negativo,<br />
che bolla il <strong>di</strong>ssenso come egoistico, irrazionale e privo <strong>di</strong> utilità sociale. La formula<br />
dovrebbe essere ovviamente applicabile solo al caso in cui chi si oppone ad <strong>un</strong><br />
determinato intervento riconosca <strong>di</strong> non avere ness<strong>un</strong> altro motivo <strong>di</strong> opposizione oltre<br />
la mera e casuale prossimità dell’intervento alla propria area <strong>di</strong> interesse. Anche in<br />
quel caso, a <strong>di</strong>re il vero, l’opposizione può avere <strong>un</strong>a sua fisiologica utilità, in quanto<br />
obbliga a verificare quanto siano razionali e fondate le motivazioni delle scelte<br />
progettuali , e quin<strong>di</strong> non sembra opport<strong>un</strong>o squalificarla ocn <strong>un</strong>a formula carica <strong>di</strong><br />
connotazioni denigratorie. Nel caso poi in cui il <strong>di</strong>ssenso sia motivato anche da altre<br />
ragioni, il relevare che la critica viene da chi è <strong>di</strong>rettamente coinvolto spiega poco (non<br />
aggi<strong>un</strong>ge quasi nulla al dato <strong>di</strong> fatto costituito dal <strong>di</strong>ssenso in se stesso). Infatti, è<br />
naturale che ad in<strong>di</strong>viduare <strong>per</strong> primo e con più acutezza la scarsa sostenibilità<br />
ambientale <strong>di</strong> <strong>un</strong> progetto sia colui che è più <strong>di</strong>rettamente interessato dai potenziali<br />
impatti» «Un modo <strong>per</strong> prevenire il conflitto, o aiutare a gestirlo in <strong>un</strong>a fase precoce, è<br />
introdurre fattori <strong>di</strong> maggiore razionalità e trasparenza nei processi decisionali e<br />
assicurare momenti <strong>di</strong> partecipazione nelle attività valutative che fanno parte del<br />
processo autorizzativo degli interventi. Non sembra giustificato, in altre parole,<br />
ricorrere a spiegazioni basate su pretese irrazionalità ed egoismi irriducibili <strong>di</strong> <strong>un</strong>a<br />
parte in causa, quando ci sono ancora da eliminare vastissimi margini <strong>di</strong> carenze, <strong>di</strong><br />
irrazionalità, <strong>di</strong> opacità, nei processi attraverso i quali si o<strong>per</strong>ano le scelte progettuali,<br />
si raggi<strong>un</strong>gono accor<strong>di</strong> e decisioni, si autorizzano gli interventi» 114 .<br />
Il principio <strong>di</strong> precauzione<br />
Ai criteri sopra descritti il La Camera (1998, op.cit) ne affianca <strong>un</strong> altro.<br />
«Un altro criterio che può essere utilizzato fa riferimento al precautionary principle<br />
mutuato dal paragrafo 15 della Dichiarazione <strong>di</strong> Rio sullo sviluppo e l'ambiente: “In<br />
or<strong>di</strong>ne alla protezione dell'ambiente, il precautionary principle dovrà <strong>per</strong> quanto<br />
possibile essere applicato. Dove esistono minacce <strong>di</strong> seri ed irreversibili danni<br />
all'ambiente, la mancanza <strong>di</strong> piena certezza scientifica non deve essere utilizzata <strong>per</strong><br />
114 Questa citazione, come quelle imme<strong>di</strong>atamente precedenti, è presa da: f. Zita (2005), Apparato<br />
normativo e linee guida a supporto del processo partecipativo nella VIA: l’es<strong>per</strong>ienza della Regione<br />
Toscana, in <strong>Valutazione</strong> <strong>Ambientale</strong>, n. 07<br />
Pag. 123 <strong>di</strong> 148<br />
123
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
posporre appropriate misure <strong>per</strong> prevenire il degrado dell'ambiente”. Come riportato<br />
nello stu<strong>di</strong>o internazionale sull'efficacia della valutazione ambientale (Sadler, 1996)<br />
(...) sono possibili tre interpretazioni o<strong>per</strong>ative <strong>di</strong> detto principio, che in parte si<br />
intersecano con i criteri appena suesposti. (...)<br />
Comparando le tre interpretazioni possono essere estratti concetti <strong>di</strong> equità<br />
intergenerazionale che possono assistere la valutazione finale e la decisione:<br />
• quando il costo del degrado può essere molto grave o irreversibile, e vi è poca<br />
es<strong>per</strong>ienza scientifica circa gli effetti ambientali del progetto, può essere seguito<br />
strettamente il precautionary principle;<br />
• quando il costo del degrado può essere serio, ma reversibile, occorre mantenere <strong>un</strong><br />
largo margine <strong>di</strong> sicurezza ed utilizzare la migliore tecnologia <strong>di</strong>sponibile;<br />
• quando vi è <strong>un</strong>a maggiore confidenza con gli effetti del progetto, sarà possibile fare<br />
riferimento alla migliore tecnologia <strong>di</strong>sponibile che non richieda costi eccessivi;<br />
• quando gli effetti ambientali non sono né irreversibili, né considerati gravi, può<br />
essere usata l'analisi costi-benefici tra<strong>di</strong>zionale».<br />
L’uso integrato dei criteri<br />
Abbiamo visto in precedenza come l’uso <strong>di</strong> <strong>un</strong> singolo criterio comporti sempre dei<br />
problemi. Per questo, nell’esprimere <strong>un</strong> giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> compatibilità ambientale,<br />
bisognerebbe utilizzare non <strong>un</strong> solo criterio, ma più criteri. In particolare, ai criteri che<br />
si basano sull’ambiente andrebbe associato il criterio della BAT o BAPT <strong>per</strong> evitare<br />
impatti indebiti. In tutti i casi, inoltre, bisognerebbe tenere conto delle problematiche<br />
legate all’accettazione sociale (in assenza della quale potrà risultare impossibile<br />
realizzare <strong>un</strong> progetto anche se questo è stato giu<strong>di</strong>cato compatibile), anche se il ruolo<br />
del pubblico andrebbe accresciuto prevedendo <strong>un</strong>a partecipazione attiva in <strong>un</strong>a fase<br />
precoce, in maniera che da essa possano scaturire informazioni e suggerimenti. Anche<br />
la situazione iniziale in termini <strong>di</strong> qualità ambientale può influenzare la scelta del crite-<br />
rio. In presenza <strong>di</strong> elevata qualità ambientale, ad esempio, il criterio del peggioramento<br />
significativo sarà più utile <strong>per</strong> contenere impatti eccessivi rispetto a quello della<br />
ricettività ambientale. Se il livello <strong>di</strong> criticità è stato già su<strong>per</strong>ato, come abbiamo già<br />
detto, l’<strong>un</strong>ico criterio utilizzabile è quello del miglioramento compensativo.<br />
In <strong>un</strong> proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> VIA bisognerebbe essere in grado <strong>di</strong> tenere conto – sia pure<br />
con modalità ed in momenti <strong>di</strong>versi – <strong>di</strong> tutti i criteri <strong>di</strong> compatibilità ambientale ritenuti<br />
rilevanti<br />
Pag. 124 <strong>di</strong> 148<br />
124
QUALITA’<br />
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
Molto<br />
critica Critica Discreta Eccezionale<br />
Q(y)<br />
Q(x)<br />
Uso delle migliori<br />
tecnologie <strong>di</strong>sponibili<br />
Valore limite<br />
Uso delle migliori tecnologie<br />
e <strong>di</strong> recu<strong>per</strong>i contestuali<br />
Figura 17 –Modello teorico <strong>per</strong> <strong>un</strong> possibile uso integrato dei <strong>di</strong>versi criteri <strong>di</strong><br />
compatibilità ambientale<br />
(fig. 5.7 Malcevschi)<br />
Legenda «Qualora la situazione iniziale sia <strong>di</strong> qualità eccezionale è presumibile che, in linea <strong>di</strong><br />
massima, sia del tutto inopport<strong>un</strong>o localizzarvi nuove o<strong>per</strong>e che provochino impatti<br />
significativi; d’altronde se la situazione è considerata “eccezionale” vuol <strong>di</strong>re che essa<br />
costituisce solo <strong>un</strong>a parte <strong>di</strong> contesto territoriale complessivo più degradato, e la zona in<br />
questione svolge presumibilmente f<strong>un</strong>zioni che non devono essere pregiu<strong>di</strong>cate. Qualora la<br />
situazione iniziale sia critica, <strong>per</strong>icolosamente vicina alle soglie <strong>di</strong> accettabilità e com<strong>un</strong>que al<br />
<strong>di</strong> sotto <strong>di</strong> valori guida Q(x), il criterio ottimale è quello <strong>di</strong> <strong>un</strong> riequilibrio ambientale in cui gli<br />
effetti positivi su<strong>per</strong>ino quelli negativi, in modo da produrre <strong>un</strong> miglioramento della situazione<br />
complessiva che la riporti almeno a livello dei valori guida. Il criterio del massimo riequilibrio<br />
possibile è da <strong>per</strong>seguirsi (nei limiti del possibile) fino a quando la qualità ambientale sia<br />
tornata a livelli accettabili (ad esempio a livello dei valori guida). A questo p<strong>un</strong>to le decisioni in<br />
merito a nuovi interventi possono avvenire attraverso <strong>un</strong>a formula R.A.M.T. (uso combinato<br />
delle migliori tecnologie <strong>di</strong>sponibili e del rispetto dei margini <strong>di</strong> ricettività ambientale). E’<br />
evidente che tutto quanto detto ha <strong>un</strong> valore solamente teorico se è limitato alla fase decisionale<br />
(in cui si valuta se realizzare o meno <strong>un</strong> dato intervento). Deve infatti anche essere previsto <strong>un</strong><br />
attento monitoraggio sull’evoluzione reale del sistema ambientale. Qualora si verifichino<br />
abbassamenti eccezionali della qualità ambientale (ad esempio situazioni molto critiche <strong>di</strong><br />
inquinamento atmosferico determinate da particolari eventi meteo-climatici), è necessario<br />
<strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> misure adeguate <strong>per</strong> fronteggiare tali emergenze; specifiche mitigazioni dovrebbero<br />
essere sempre preventivate <strong>per</strong> le con<strong>di</strong>zioni critiche in fase <strong>di</strong> esercizio, ad esempio la<br />
riduzione temporanea della capacità produttiva degli impianti interessati». (Malcevschi)<br />
Pag. 125 <strong>di</strong> 148<br />
Valore guida<br />
Mitigazioni in fase <strong>di</strong><br />
esercizio preventivate<br />
<strong>per</strong> le con<strong>di</strong>zioni critiche<br />
Tempo<br />
125
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
4. Le problematiche generali legate alla <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> impatto ambientale ed i<br />
<strong>di</strong>versi passi che la compongono<br />
Una volta esaminate, sia pure in sintesi, le problematiche relative alle componenti<br />
ambientali, alla qualità ambientale ed ai criteri <strong>di</strong> valutazione della compatibilità<br />
ambientale, riteniamo interessante andare ad esaminare le principali problematiche<br />
relative all’adozione <strong>di</strong> procedure <strong>di</strong> VIA. Riteniamo utile ricordare come <strong>di</strong> VIA si<br />
possa parlare in termini “teorici” (procedura <strong>di</strong> VIA ideale) ed applicati (alla specifica<br />
normativa vigente). Vedremo, infatti, come molto spesso, soprattutto con le prime<br />
normative a livello com<strong>un</strong>itario e nazionale, si siano avute delle in<strong>di</strong>cazioni<br />
relativamente <strong>di</strong>stanti da quelle che venivano suggerite in varie se<strong>di</strong>.<br />
In particolare, se vengono confrontate molte delle affermazioni contenute nel primo<br />
capitolo del Manuale della Regione Lombar<strong>di</strong>a con quanto previsto dalla <strong>di</strong>rettiva<br />
com<strong>un</strong>itaria del 1985 e dalla legislazione nazionale del 1988, ci si accorgerà che su<br />
molti p<strong>un</strong>ti esistono delle notevoli <strong>di</strong>vergenze.<br />
Altra cosa che vorremmo ricordare, prima <strong>di</strong> procedere, è come la VIA sia <strong>un</strong><br />
proce<strong>di</strong>mento complesso che può integrare (e spesso integra al suo interno) anche<br />
alc<strong>un</strong>e delle tecniche precedentemente descritte, quali l’analisi multi-criteri e l’analisi<br />
costi-benefici, inserendole in <strong>un</strong>a procedura che dovrebbe garantire anche<br />
partecipazione da parte dei soggetti interessati a vario titolo e trasparenza nelle<br />
decisioni.<br />
Prima <strong>di</strong> iniziare a parlare <strong>di</strong> quelle che possono essere in<strong>di</strong>viduate come le<br />
principali problematiche relative all'applicazione <strong>di</strong> <strong>un</strong>a <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong><br />
<strong>Ambientale</strong>, riteniamo utile fornire <strong>un</strong>o schema sintetico <strong>di</strong> quali siano – in teoria – i<br />
<strong>di</strong>versi passi che compongono <strong>un</strong>a procedura <strong>di</strong> VIA, mentre nella parte successiva del<br />
<strong>corso</strong> affronteremo con maggior dettaglio quali sono i passi che vengono effettivamente<br />
previsti a livello <strong>di</strong> normativa. Lo schema dei passi ideali, ripreso da Gerelli e Laniado<br />
(Terra, n. 2, 1987 – ve<strong>di</strong> FOTOCOPIA ARTICOLO).<br />
Pag. 126 <strong>di</strong> 148<br />
126
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
In tale schema ideale <strong>di</strong> <strong>un</strong>a procedura <strong>di</strong> VIA, le parti evidenziate in corsivo<br />
rappresentano i possibili momenti <strong>di</strong> partecipazione. Si tratta <strong>di</strong> <strong>un</strong>o schema ideale,<br />
elaborato circa 15 anni fa e non necessariamente coincidente con lo schema procedurale<br />
che esamineremo relativamente alla normativa nazionale, mentre è possibile trovare<br />
maggiori analogie con lo schema relativo alla procedura regionale riportato sul Manuale<br />
della Regione Lombar<strong>di</strong>a.<br />
L’indagine preliminare serve <strong>per</strong> orientare la VIA (cfr. fase <strong>di</strong> scoping) dopo aver<br />
deciso se <strong>un</strong> progetto va sottoposto o meno a tale procedura (cfr. fase <strong>di</strong> screening). Con<br />
la definizione degli obiettivi progettuali si mette a fuoco il problema da risolvere,<br />
mentre le caratteristiche del territorio ed il quadro legislativo forniscono, in <strong>un</strong> certo<br />
senso, i vincoli all’interno dei quali il problema si muove. Combinando obiettivi<br />
prefissati e sistema (ambientale e giuri<strong>di</strong>co) in cui ci si muove è possibile in<strong>di</strong>viduare<br />
<strong>un</strong>a serie <strong>di</strong> possibili soluzioni (alternative, varianti) che <strong>per</strong>mettono <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfare al<br />
meglio tali obiettivi. Segue <strong>un</strong>a fase <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o tecnico, in cui si cerca <strong>di</strong> valutare i<br />
probabili impatti. Una volta terminata la fase <strong>di</strong> stima dei probabili impatti, si cerca <strong>di</strong><br />
limitare quelli troppo alti (con misure <strong>di</strong> mitigazione). Ci sono, com<strong>un</strong>que, o<strong>per</strong>e che<br />
vanno necessariamente fatte e che possono dare luogo ad impatti significativi non<br />
mitigabili, magari a carico <strong>di</strong> specifici gruppi (ad esempio i residenti che abitano vicino<br />
ad <strong>un</strong>a <strong>di</strong>scarica o ad <strong>un</strong> inceneritore, o ad <strong>un</strong>a strada <strong>di</strong> grande scorrimento, ecc.).<br />
Questi gruppi che verranno a subire l’impatto dovranno essere in qualche maniera<br />
compensati. In altre parole, si tratta <strong>di</strong> inserire l’o<strong>per</strong>a in <strong>un</strong> quadro più ampio, magari<br />
limitando la realizzazione <strong>di</strong> ulteriori o<strong>per</strong>e ad impatto negativo su quello stesso<br />
territorio o prevedento interventi <strong>di</strong> valorizzazione (ad esempio, creazione <strong>di</strong> spazi ver<strong>di</strong><br />
<strong>per</strong> attività ricreative a valle <strong>di</strong> <strong>un</strong> intervento <strong>di</strong> recu<strong>per</strong>o produttivo <strong>di</strong> <strong>un</strong>a cava). Da<br />
notare – nel successivo esame delle leggi – come si parli sempre <strong>di</strong> prevenire gli impatti<br />
(evitare l’impatto limitando le fonti <strong>di</strong> interferenza), <strong>di</strong> mitigare gli impatti che non è<br />
possibile prevenire (ad esempio, prevedendo barriere visive in presenza <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici con <strong>un</strong><br />
impatto negativo sul paesaggio, oppure barriere anti-rumore in prossimità <strong>di</strong> <strong>un</strong>a strada<br />
<strong>di</strong> grande traffico), compensare gli impatti residui <strong>un</strong>a volta attuate le eventuali misure<br />
<strong>di</strong> mitigazione (con forme <strong>di</strong> compensazione non omogenea, in <strong>un</strong>’ottica <strong>di</strong><br />
miglioramento compensativo). Come si può vedere, questi tre concetti <strong>di</strong> prevenzione,<br />
mitigazione e compensazione si ricollegano a quanto esposto in sede <strong>di</strong> descrizione<br />
dello schema emissione-danno ambientale e dei costi ad esso legati: costo del mancato<br />
Pag. 127 <strong>di</strong> 148<br />
127
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
inquinamento (prevenzione), costo <strong>per</strong> la rimozione degli effetti dell’inquinamento<br />
(mitigazione), costo <strong>per</strong> la compensazione dell’impatto residuo (compensazione). A<br />
valle della pubblicazione <strong>di</strong> <strong>un</strong> documento iniziale (draft) si potranno avere – in base<br />
alle emergenze del <strong>di</strong>battito conseguente l’inchiesta pubblica – <strong>un</strong>a serie <strong>di</strong><br />
approfon<strong>di</strong>menti dell’analisi ed eventuali mo<strong>di</strong>fiche. Questo mette in evidenza come,<br />
nonostante lo schema presentato possa far pensare ad <strong>un</strong> processo lineare, debbano<br />
esistere dei meccanismi <strong>di</strong> retroazione <strong>per</strong> cui – nel caso che alc<strong>un</strong>i dei passi<br />
precedentemente fatti risultino insod<strong>di</strong>sfacenti <strong>per</strong> vari motivi – si possa tornare<br />
in<strong>di</strong>etro, mo<strong>di</strong>ficare l’analisi ed anche le risultanti della stessa (ad esempio le varianti/<br />
alternative considerate). Una volta integrato il documento iniziale con tutte le<br />
osservazioni emerse dalla fase <strong>di</strong> partecipazione e con tutti gli approfon<strong>di</strong>menti ad essa<br />
conseguenti, può essere redatto il documento finale, in base al quale il decisore pubblico<br />
dovrà decidere sull’auspicabilità, o meno, della realizzazione dell’o<strong>per</strong>a. Si tratta,<br />
quin<strong>di</strong>, <strong>di</strong> <strong>un</strong>a procedura con aspetti tecnici, ma che fa i conti anche con la<br />
partecipazione ed i problemi da essa posti. Il proce<strong>di</strong>mento non si chiude con<br />
l’approvazione, ma prosegue con l’esecuzione del progetto (durante la quale si possono<br />
manifestare imprevisti che possono portare a delle mo<strong>di</strong>fiche, che andrebbero fatte<br />
tenendo presenti le problematiche <strong>di</strong> impatto ambientale) e con le verifiche a posteriori,<br />
consistenti nella fase <strong>di</strong> monitoraggio e controllo. Controllo <strong>per</strong>ché gli impatti saranno<br />
quelli previsti soltanto se l’o<strong>per</strong>a verrà realizzata come in<strong>di</strong>cato in progetto (in alc<strong>un</strong>i<br />
casi, inoltre, il parere espresso dal Ministero può essere positivo con prescrizioni, cioè<br />
positivo soltanto a con<strong>di</strong>zione che vengano seguite <strong>un</strong>a serie <strong>di</strong> in<strong>di</strong>cazioni<br />
esplicitamente dettate, e delle quali va controllata l’effettiva attuazione); monitoraggio<br />
<strong>per</strong>ché essendo l’impatto ambientale stimato in base a dati e modelli caratterizzati da <strong>un</strong><br />
grado <strong>di</strong> probabilità ed accuratezza più o meno elevato, anche rispettando esattamente le<br />
specifiche del progetto si potrebbero avere impatti su<strong>per</strong>iori a quelli previsti, ed in<br />
questo caso può essere necessario intervenire con adeguate misure <strong>di</strong> mitigazione.<br />
Inoltre le informazioni resesi <strong>di</strong>sponibili me<strong>di</strong>ante la fase <strong>di</strong> monitoraggio potranno<br />
andare a costituire <strong>un</strong>a parte del quadro ambientale iniziale <strong>per</strong> <strong>un</strong> successivo progetto<br />
da sottoporre a VIA e le informazioni relative a quanto le stime effettuate con i modelli<br />
siano state, o meno, realistiche, possono aiutare a mettere a p<strong>un</strong>to strumenti <strong>di</strong><br />
previsione sempre migliori.<br />
Pag. 128 <strong>di</strong> 148<br />
128
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
Ma quali possono essere definite come le principali problematiche relative<br />
all’applicazione della VIA a livello com<strong>un</strong>itario e nazionale? Ne forniamo <strong>di</strong> seguito<br />
alc<strong>un</strong>i esempi, in parte tratti dal già citato articolo <strong>di</strong> Gerelli e Laniado 115 :<br />
1. VIA come “procedura” <strong>per</strong> ottimizzare il processo decisionale o come “fase<br />
tecnica”. Secondo il manuale della Regione Lombar<strong>di</strong>a (cfr. Pag. 43):
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
f<strong>un</strong>zione del “vecchio allegato tecnico” sulle conseguenze ambientali che<br />
veniva previsto ad integrazione dell'Analisi Costi Benefici.<br />
– La seconda che vede la VIA come <strong>un</strong> proce<strong>di</strong>mento all'interno del quale dare<br />
<strong>un</strong>a valutazione complessiva dell'auspicabilità <strong>di</strong> <strong>un</strong>'o<strong>per</strong>a, sia dal p<strong>un</strong>to <strong>di</strong><br />
vista economico che sociale ed ambientale. In questo senso, <strong>per</strong> poter ottenere<br />
la soluzione <strong>di</strong> “compromesso” migliore, bisogna che tutti gli aspetti vengano<br />
valutati contemporaneamente e non in momenti successivi (cfr. Parte su in<br />
che momento collocare la VIA). Inoltre si prevede che le valutazioni<br />
ambientali accompagnino tutto il processo decisionale, tanto da costituire non<br />
<strong>un</strong>a valutazione esterna nei processi <strong>di</strong> progettazione-realizzazione, ecc., ma<br />
<strong>un</strong>a valutazione “interna”. Vedremo come questo tipo <strong>di</strong> accezione abbia<br />
come conseguenza <strong>un</strong>a definizione allargata del concetto <strong>di</strong> “ambiente”, in<br />
cui vengono ricompresi non solo gli aspetti fisici e naturalistici, ma anche<br />
quelli <strong>di</strong> natura socio-economica.<br />
2. Campo <strong>di</strong> applicazione della VIA. A livello com<strong>un</strong>itario la VIA nasce con la<br />
<strong>di</strong>rettiva 85/337/CEE, che verrà descritta nella parte relativa alla legislazione. Tale<br />
<strong>di</strong>rettiva prevede l’applicazione della VIA soltanto alle o<strong>per</strong>e, cioè a dei singoli<br />
progetti (quali quelli relativi alla realizzazione <strong>di</strong> aereoporti, strade, raffinerie, ecc.)<br />
fornendo <strong>un</strong>a lista <strong>di</strong> 9 116 tipologie <strong>di</strong> o<strong>per</strong>e <strong>per</strong> le quali la procedura <strong>di</strong> VIA doveva<br />
essere obbligatoriamente applicata in tutti gli Stati membri. La legislazione<br />
americana precedentemente citata (NEPA), viceversa, aveva <strong>un</strong> approccio molto più<br />
ampio in quanto essa prevede <strong>di</strong>
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
progettazione ambientale nella pianificazione e nei processi decisionali che possono<br />
avere <strong>un</strong> impatto sull’ambiente umano>> (citato in F. La Camera, pag. 10). Come è<br />
facile vedere, il NEPA non si limita alle o<strong>per</strong>e, ma parla anche <strong>di</strong> pianificazione,<br />
progettazione ambientale e <strong>per</strong>fino genericamente <strong>di</strong> processi decisionali. In altre<br />
parole, a <strong>di</strong>fferenza della legislazione americana, la <strong>di</strong>rettiva com<strong>un</strong>itaria<br />
85/337/CEE prevede l’assoggettamento a VIA della singola o<strong>per</strong>a (ad esempio la<br />
realizzazione <strong>di</strong> <strong>un</strong>a centrale), ma non della relativa programmazione <strong>di</strong> settore<br />
(piano energetico nazionale) o della pianificazione territoriale in cui essa si inseriva<br />
(ad esempio, la in<strong>di</strong>viduazione delle aree da destinare ad uso industriale non andava<br />
sottoposto a VIA, mentre lo erano le realizzazioni <strong>di</strong> acciaierie con determinate<br />
caratteristiche). Inoltre, prevedendo <strong>di</strong> sottoporre a VIA qualsiasi decisione che<br />
possa avere <strong>un</strong> impatto sull’ambiente umano, la legislazione americana estende<br />
l’obbligo <strong>di</strong> considerare le conseguenze ambientali anche a decisioni che vanno oltre<br />
la realizzazione <strong>di</strong> singole o<strong>per</strong>e, la pianificazione e la programmazione <strong>di</strong> settore,<br />
quali – ad esempio – quelle relative alla s<strong>per</strong>imentazione in campo <strong>di</strong> clonazione<br />
umana, all’introduzione <strong>di</strong> OGM, ecc. Nel tempo, come sarà chiaro dall’esame della<br />
parte legislativa, il campo <strong>di</strong> applicazione della VIA è andato via via estendendosi,<br />
ad esempio – a livello nazionale – allargando l’obbligo <strong>di</strong> VIA ai programmi <strong>di</strong><br />
intervento e accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> programma nel settore dei sistemi <strong>di</strong> trasporto rapido <strong>di</strong><br />
massa (legge 26 febbraio 1992, n. 211), agli interventi <strong>per</strong> la <strong>di</strong>fesa del mare (legge<br />
28 febbraio 1992, n. 220), ecc. Inoltre, nel <strong>di</strong>cembre 2001, la com<strong>un</strong>ità europea ha<br />
emanato <strong>un</strong>a <strong>di</strong>rettiva che introduce la <strong>Valutazione</strong> <strong>Ambientale</strong> Strategica, o come<br />
potrebbe essere più correttamente definita – <strong>Valutazione</strong> <strong>Ambientale</strong> delle Decisioni<br />
Strategiche - (o VAS), cioè la valutazione <strong>di</strong> impatto ambientale legata a<br />
programmazione e pianificazione. Da notare come su questa strada si fossero mosse<br />
già alc<strong>un</strong>e Regioni, tra cui la Toscana, che già nel 1995 ha promulgato <strong>un</strong>a Legge<br />
Regionale (la legge regionale n. 5/1995, recentemente mo<strong>di</strong>ficata dalla legge<br />
1/2005) che introduce i principi della valutazione ambientale nel processo <strong>di</strong><br />
pianificazione territoriale a livello regionale.<br />
E' interessante notare come, con l'introduzione della VAS, si siano – ad esempio –<br />
cominciate a valutare le implicazioni ambientali a livello <strong>di</strong> DOCUP (documento<br />
<strong>un</strong>ico <strong>di</strong> programmazione), previsti <strong>per</strong> l'utilizzo a livello nazionale dei Fon<strong>di</strong><br />
strutturali europei. L'Unione Europea sta ulteriormente procedendo nel cammino <strong>per</strong><br />
l'inserimento delle valutazioni ambientali ai <strong>di</strong>versi livelli decisionali ed ha<br />
Pag. 131 <strong>di</strong> 148<br />
131
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
attualmente allo stu<strong>di</strong>o <strong>un</strong>a proposta relativa all'utilizzo <strong>di</strong> <strong>un</strong>a <strong>Valutazione</strong><br />
<strong>Ambientale</strong> Estesa, che dovrebbe prevedere la valutazione da parte degli organi<br />
com<strong>un</strong>itari degli impatti ambientali che potranno avere – ad esempio – le <strong>di</strong>rettive<br />
ed i regolamenti dell'Unione. In questa maniera il <strong>per</strong><strong>corso</strong> verrebbe ad estendersi<br />
ulteriormente a monte, nel processo decisionale che parte dai regolamenti<br />
com<strong>un</strong>itari che fissano le regole <strong>per</strong> l'utilizzo dei fon<strong>di</strong> strutturali, <strong>per</strong> passare al<br />
documento <strong>di</strong> programmazione messo a p<strong>un</strong>to dai <strong>di</strong>versi Stati membri/Regioni<br />
relativamente all'impiego dei fon<strong>di</strong> strutturali, <strong>per</strong> arrivare alla realizzazione dei<br />
singoli interventi.<br />
Come vedremo meglio in seguito, il problema del campo <strong>di</strong> applicazione della<br />
<strong>Valutazione</strong> ambientale è in stretta correlazione con quello delle alternative in<br />
quanto, <strong>per</strong> <strong>un</strong>o stesso tipo <strong>di</strong> problema (ad esempio l'approvigionamento in campo<br />
energetico) possono essere definite sia alternative a livello strategico (contenimento<br />
dei consumi, incentivi alle tecnologie pulite, ecc.) sia a livello o<strong>per</strong>ativo (ad es. VIA<br />
relativa ad <strong>un</strong> singolo impianto, <strong>di</strong> cui si deve decidere <strong>di</strong>mensioni e localizzazione<br />
ottimale). D'altra parte, molte delle problematiche elencate possono essere fatte<br />
afferire a due “scuole <strong>di</strong>verse”, che spingono <strong>per</strong> <strong>un</strong>a applicazione più o meno estesa<br />
delle valutazioni ambientali nel processo decisionale.<br />
Riportiamo <strong>di</strong> seguito <strong>un</strong>o schema esemplificativo delle principali <strong>di</strong>fferenze tra<br />
VIA e VAS.<br />
Analogie, <strong>di</strong>fferenze e complementarietà tra VIA e VAS<br />
VAS VIA<br />
Dati <strong>di</strong> vario tipo, descrittivi e quantificati principalmente<br />
quantificati<br />
Obiettivi/portata degli globali, nazionali e regionali principalmente locali<br />
impatti<br />
Alternative ad es. uso più efficace dell’infrastruttura<br />
esistente, misure fiscali, equilibrio<br />
Meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> previsione<br />
degli impatti<br />
spaziale della localizzazione, ecc….<br />
semplici (spesso basati su matrici e<br />
impiego <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> es<strong>per</strong>ti),<br />
caratterizzati da elevato livello <strong>di</strong><br />
incertezza<br />
Risultati generali dettagliati<br />
Pag. 132 <strong>di</strong> 148<br />
ad es. localizzazione,<br />
varianti tecniche,<br />
progettazione, ecc…<br />
complessi, (e solitamente<br />
basati su dati quantificati)<br />
Fonte: T. Nadalutti, Lo sviluppo sostenibile nel passaggio dalla via alla vas: la pianificazione<br />
territoriale nelle normative regionali, elaborato finale <strong>per</strong> la laurea triennale in Scienze Agrarie,<br />
Pisa, ottobre 2003.<br />
132
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
3. Il problema delle alternative. In più parti <strong>di</strong> questo <strong>corso</strong> è stato messo e verrà messo<br />
in evidenza come sia <strong>di</strong>fficile prendere <strong>un</strong>a decisione razionale se si ha a<br />
<strong>di</strong>sposizione <strong>un</strong>a sola alternativa, problema che può essere letto in connessione con<br />
quello precedente (campo <strong>di</strong> applicazione) e quello successivo (momento al quale<br />
applicare <strong>un</strong>a VIA). Se è vero che esiste sempre almeno <strong>un</strong>a alternativa in quanto,<br />
essendo possibile emettere <strong>un</strong> giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> compatibilità negativo, si prende in<br />
considerazione almeno implicitamente l’alternativa 0, cioè quella <strong>di</strong> non realizzare<br />
alc<strong>un</strong> tipo <strong>di</strong> intervento, non sempre questa decisione è politicamente sostenibile ed<br />
a volte non è nemmeno praticabile (ad esempio, nel caso della pianificazione, non è<br />
pensabile <strong>di</strong> poter procedere semplicemente rigettando le norme <strong>di</strong> governo del<br />
territorio proposte, senza approvarne altre alternative). Inoltre, non sempre la legge<br />
prevede <strong>un</strong>a esplicita considerazione dell'alternativa zero e dei suoi impatti<br />
ambientali, <strong>per</strong> cui tale alternativa potrebbe essere “scelta in<strong>di</strong>rettamente” me<strong>di</strong>ante<br />
rigetto dell'alternativa proposta, senza averne in realtà valutato le caratteristiche in<br />
termini <strong>di</strong> impatto ambientale. Interessante è quanto esposto in Alberti et. Al<br />
(1988) 117 a proposito delle alternative
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
essere utile <strong>per</strong> facilitare la selezione delle alternative classificarle come nello<br />
schema che proponiamo:<br />
a. Alternative strategiche (definibili a livello <strong>di</strong> programmazione o <strong>di</strong><br />
pianificazione; consistono nella in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> misure <strong>per</strong> prevenire la<br />
domanda, in misure alternative <strong>per</strong> realizzare lo stesso obiettivo, ecc.).<br />
b. Alternative <strong>di</strong> processo o strutturali (definibili essenzialmente nella fase <strong>di</strong><br />
progetto; consistono nella definizione <strong>di</strong> progetti alternativi, <strong>di</strong> alternative <strong>di</strong><br />
processo e nell’impiego <strong>di</strong> materie prime alternative).<br />
c. Alternative <strong>di</strong> localizzazione (definibili sia a livello <strong>di</strong> piano che <strong>di</strong> progetto<br />
in base alla conoscenza dell’ambiente, alla in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> potenzialità<br />
d’uso dei suoi ed ai limiti rappresentati da aree critiche e sensibili).<br />
d. Misure alternative <strong>per</strong> la minimizzazione degli effetti negativi (definibili in<br />
fase <strong>di</strong> progetto <strong>di</strong> massima ed esecutivo; consistono nei possibili<br />
accorgimenti <strong>per</strong> limitare gli impatti negativi).<br />
e. Alternativa zero (non realizzazione dell’o<strong>per</strong>a).>> (Alberti et al. , pag. 93)<br />
Alc<strong>un</strong>e esemplificazioni relative alle alternative nel campo dei trasporti (tabella 3) e<br />
al campo dello smaltimento dei rifiuti (tabella 4) sono riportati nel Manuale della<br />
Regione Lombar<strong>di</strong>a (Parte II, capitolo 4, La fase <strong>di</strong> descrizione, pagg. 70 e 71).<br />
Come vedremo meglio in seguito nella parte relativa alla legislazione, il problema<br />
delle alternative è stato inizialemente molto trascurato. Infatti la Direttiva CEE<br />
337/1985 parlava soltanto, elencando le infomazioni che devono essere fornite dal<br />
proponente, <strong>di</strong> <strong>un</strong>a “eventuale” (quin<strong>di</strong> non obbligatoria) descrizione sommaria<br />
delle principali alternative prese in esame ed anche la normativa nazionale richiede<br />
in pratica soltanto lo Stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> della alternativa prescelta,<br />
riferito al progetto <strong>di</strong> massima. Un <strong>di</strong>verso approccio è quello adottato dalla Regione<br />
Lombar<strong>di</strong>a, visto che al capitolo 1 del Manuale si trova quanto segue: Anche la<br />
più recente normativa in materia (<strong>di</strong>rettiva 97/11/CE) ha rivalutato la f<strong>un</strong>zione delle<br />
alternative, rendendo obbligatoria la descrizione sommaria delle alternative (è infatti<br />
scomparso il termine “eventualmente”) e richiedendo l’in<strong>di</strong>cazione delle principali<br />
Pag. 134 <strong>di</strong> 148<br />
134
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
ragioni della scelta (<strong>di</strong> richiedere il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> compatibilità ambientale <strong>per</strong> <strong>un</strong>a<br />
determinata alternativa e non <strong>per</strong> altre) sotto il profilo dell’impatto ambientale.<br />
Da notare come la possibilità <strong>di</strong> esprimere <strong>un</strong> giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> compatibilità ambientale<br />
negativo (sempre teoricamente presente) non sia esattamente equivalente al dover<br />
tenere in esplicita considerazione l’alternativa 0. Infatti <strong>un</strong> intervento potrebbe dar<br />
luogo ad <strong>un</strong> livello <strong>di</strong> impatto considerato compatibile (e quin<strong>di</strong> essere giu<strong>di</strong>cato<br />
positivamente se esaminato da solo), ma risultare al tempo stesso <strong>un</strong>a alternativa<br />
complessivamente meno sod<strong>di</strong>sfacente dell’alternativa 0. Se si ritorna all’esame<br />
della Figura 6 (tratta dal Manuale della Regione Lombar<strong>di</strong>a; fonte Malcevschi), sia<br />
la situazione con intervento che quella senza l’intervento risultano in ogni momento<br />
su<strong>per</strong>iori al livello considerato inaccettabile, e quin<strong>di</strong> anche l’alternativa con<br />
intervento, pur causando <strong>un</strong> impatto <strong>di</strong> <strong>un</strong>a certa entità, sarebbe considerata<br />
accettabile. Bisogna vedere se tale impatto (soprattutto se considerato a carico<br />
dell’ambiente in senso stretto) è giustificato da altre caratteristiche del progetto, in<br />
termini <strong>di</strong> effetti indotti, ad esempio, a carico <strong>di</strong> variabili socio-economiche.<br />
4. In quale momento deve essere collocata la VIA?. Come dovrebbe essere chiaro<br />
dall’analisi delle alternative sopra presentate, <strong>di</strong>fficilmente è possibile prendere in<br />
considerazione alternative strategiche in fatto <strong>di</strong> redazione <strong>di</strong> progetto <strong>di</strong> massima,<br />
come pure non è in genere possibile effettuare <strong>un</strong>a VIA legata ai problemi <strong>di</strong><br />
localizzazione, quando si è ancora in fase <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> fattibilità. (Gerelli e<br />
Laniado, 1987). In altre parole, anche se la procedura <strong>di</strong> VIA (almeno quella <strong>per</strong> le<br />
o<strong>per</strong>e, a livello nazionale) prevede che lo stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> impatto ambientale sia effettuata<br />
a livello <strong>di</strong> progetto <strong>di</strong> massima, l’ideale sarebbe ideale che la filosofia della VIA<br />
seguisse tutto l’iter del processo. Infatti, in fase <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> fattibilità, esistono i<br />
massimi gra<strong>di</strong> <strong>di</strong> libertà in termini <strong>di</strong> scelte <strong>per</strong>ché i costi sostenuti ed i vincoli sono<br />
al livello minimo. Però sono al livello più basso anche le informazioni relative ai<br />
possibili impatti, in quanto in sede <strong>di</strong> ideazione il progetto non è ancora ben<br />
definito, <strong>per</strong> cui è <strong>di</strong>fficile valutarne esattamente le ri<strong>per</strong>cussioni. Man mano che<br />
dallo stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> fattibilità si scende al progetto esecutivo, aumentano i vincoli relativi<br />
Pag. 135 <strong>di</strong> 148<br />
135
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
ai costi sostenuti ed alle decisioni prese (tant’è vero che in sede <strong>di</strong> progetto<br />
esecutivo ormai si può intervenire solo con misure <strong>di</strong> mitigazione), ma aumenta<br />
anche il grado <strong>di</strong> conoscenza dei possibili impatti. In altre parole, anche se lo stu<strong>di</strong>o<br />
<strong>di</strong> impatto ambientale ed il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> compatibilità ambientale si riferiscono al<br />
progetto <strong>di</strong> massima, l’approccio della VIA dovrebbe accompagnare tutto l’iter <strong>di</strong><br />
progettazione, fino ad estendersi all’implementazione del progetto stesso. Inoltre<br />
non dovrebbero essere visti come <strong>un</strong>a procedura “esterna” (quin<strong>di</strong>, <strong>un</strong>a valutazione<br />
del progetto, sia essa ex ante, in itinere o ex post), ma come <strong>un</strong>a valutazione interna<br />
(NEL progetto) nel senso che <strong>di</strong> essa si tiene conto nel processo <strong>di</strong> progettazione e<br />
realizzazione <strong>di</strong> <strong>un</strong> intervento.<br />
Questo, soprattutto in passato, si verificava raramente e la procedura più com<strong>un</strong>e<br />
era quella che vedeva la stesura del progetto dal p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista tecnico e la richiesta<br />
ad <strong>un</strong> gruppo esterno <strong>di</strong> realizzare lo stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> impatto ambientale su quel<br />
determinato progetto. Ciò nonostante, come messo in evidenza da Alberti et al. (Alberti et. Al., pag. 90). In presenza <strong>di</strong><br />
più alternative . Alberti et al.,<br />
pag. 91. Quanto sopra esposto è riba<strong>di</strong>to anche nel Manuale della Regione<br />
118 Il grassetto è nostro<br />
Pag. 136 <strong>di</strong> 148<br />
136
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
Lombar<strong>di</strong>a (pag. 43, p<strong>un</strong>to d.) <br />
Da questo p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista, i più recenti interventi del Governo che <strong>per</strong> le<br />
infrastrutture e gli inse<strong>di</strong>amenti produttivi strategici spostano la VIA in fase<br />
preliminare, potrebbero essere considerati positivamente se non fosse che con questi<br />
si esaurisce l’iter <strong>di</strong> legge previsto <strong>per</strong> la VIA, mentre <strong>un</strong>o stu<strong>di</strong>o accurato del<br />
potenziale impatto <strong>di</strong> <strong>un</strong>’o<strong>per</strong>a richiederebbe <strong>un</strong>’analisi anche a valle degli stu<strong>di</strong><br />
preliminari <strong>di</strong> fattibilità (progetto <strong>di</strong> massima, ecc.).<br />
5. VIA e concetto <strong>di</strong> Ambiente: abbiamo messo in evidenza nelle parti precedenti<br />
come il fatto <strong>di</strong> voler introdurre elementi <strong>di</strong> valutazione ambientale in tutto l'iter <strong>di</strong><br />
progettazione e decisionale in maniera da arrivare alla miglior soluzione dal p<strong>un</strong>to<br />
<strong>di</strong> vista sia ambientale in senso stretto che socio-economico implica come, nel<br />
proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong>, al concetto <strong>di</strong> ambiente debba<br />
venire attribuita <strong>un</strong>a accezione “allargata”. Da questo p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista può essere<br />
interessante andare a confrontare quanto previsto: a) in sede <strong>di</strong> <strong>di</strong>rettiva com<strong>un</strong>itaria<br />
337/1985, in sede <strong>di</strong> D.P.C.M. <strong>di</strong> recepimento della stessa (1988) ed in sede <strong>di</strong><br />
legislazione regionale (legge Regione Toscana n. 79 del 1998). Per quanto riguarda<br />
le prime due fonti legislative, Zeppetella ed altri 119 mettono in evidenza quanto<br />
segue:
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
D.P.C.M. Per quanto riguarda le “<strong>di</strong>menticanze”, esse riguardano le componenti<br />
antropiche della lista, conseguenti alla scelta, fatta dal ministero dell'Ambiente, <strong>di</strong><br />
non chiedere l'analisi degli impatti socio-economici.>><br />
Tabella 3: Componenti ambientali<br />
______________________________________________________________________<br />
Direttiva CEE D.P.C.M. 1988<br />
Uomo Salute pubblica<br />
Rumore e vibrazioni<br />
Ra<strong>di</strong>azioni ionizzanti e non ionizzanti<br />
Fa<strong>un</strong>a Fa<strong>un</strong>a<br />
Flora Flora e vegetazione<br />
Ecosistemi<br />
Suolo Suolo<br />
Sottosuolo<br />
Acqua Ambiente idrico<br />
Aria Atmosfera<br />
Clima<br />
Paesaggio Paesaggio<br />
Beni materiali<br />
Patrimonio culturale<br />
Fonte: Zeppetella, Bresso, Gamba, NIS, 1992, Tab. 1.2<br />
Da notare come, invece, nella legislazione della Regione Toscana, gli impatti socio-<br />
economici siano specificatamente previsti, come esplicitato dall'art. 2, comma 2<br />
della Legge regionale n. 79 del 1998, <strong>di</strong> seguito riportato:<br />
<br />
6. Chi deve fare la VIA? Se lo stu<strong>di</strong>o viene fatto da chi propone il progetto, egli<br />
tenderà a mettere in evidenza - volutamente o meno - gli aspetti positivi dello stesso<br />
e sarà molto <strong>di</strong>fficile in<strong>di</strong>viduare e correggere eventuali <strong>di</strong>storsioni. D'altra parte se<br />
lo stu<strong>di</strong>o fosse a carico dell'Ente pubblico (come era inizialmente negli USA),<br />
Pag. 138 <strong>di</strong> 148<br />
138
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
questo comporterebbe la necessità <strong>di</strong> tante spese e della creazione e mantenimento<br />
<strong>di</strong> tanti staff tecnici (com<strong>un</strong>que alc<strong>un</strong>i legislatori a livello locale hanno scelto questa<br />
strada, almeno nelle prime normative uscite prima della legislazione nazionale del<br />
1988). E poi è chi vuole fare il progetto che lo conosce a fondo e che ha il <strong>per</strong>sonale<br />
competente. Secondo la <strong>di</strong>rettiva CEE, e la legge italiana che l'ha recepita, lo stu<strong>di</strong>o<br />
lo fa il proponente. Come sopra evidenziato, questo può portare a problemi <strong>di</strong><br />
notevole entità, ad esempio, ritornando alle alternative, Alberti et al. mettono in<br />
evidenza come . Alberti et al., pag 91; si pone, quin<strong>di</strong>, il problema <strong>di</strong>:<br />
7. Chi e come controlla lo stu<strong>di</strong>o del proponente. Il proponente deve fornire <strong>un</strong>o stu<strong>di</strong>o<br />
su cui si possa intervenire <strong>per</strong> valutare la bontà dei dati, dei modelli, delle ipotesi,<br />
cioè bisogna avere strumenti <strong>per</strong> poter entrare nel merito. Questo comporta la<br />
creazione <strong>di</strong> staff tecnici a livello regionale (molte <strong>di</strong> queste competenze possono<br />
essere ass<strong>un</strong>te dalle Agenzie Regionali <strong>per</strong> la Protezione dell’Ambiente, in Toscana<br />
dall’ARPAT). Per poter controllare lo stu<strong>di</strong>o, bisogna <strong>di</strong>re come va fatto ed anche<br />
aiutare il proponente. L’alleggerimento del compito del proponente può essere fatto<br />
secondo due linee <strong>di</strong>rettive principali. In primo luogo con la messa a <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong><br />
<strong>un</strong>a maggior massa <strong>di</strong> dati relativamente alle problematiche dell’impatto ambientale.<br />
Con l’assoggettamento a valutazione <strong>di</strong> impatto ambientale <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong><br />
pianificazione e programmazione settoriale, l’Ente pubblico deve dotarsi delle<br />
informazioni su cui basare le proprie decisioni, informazioni che potranno costituire<br />
<strong>un</strong>’utile base <strong>di</strong> partenza anche <strong>per</strong> gli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> impatto ambientale dei proponenti<br />
delle singole o<strong>per</strong>e, che così vedranno ridursi i costi a loro carico <strong>per</strong> la<br />
realizzazione <strong>di</strong> <strong>un</strong> SIA (stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> impatto ambientale). Inoltre l’Ente pubblico potrà<br />
raccogliere informazioni anche durante l’o<strong>per</strong>a <strong>di</strong> monitoraggio <strong>di</strong> progetti già<br />
realizzati, anche se prevalentemente mirata a verificare se le previsioni <strong>di</strong> impatto<br />
del SIA sono state rispettate e, nel caso che questo non avvenga, a prevedere<br />
Pag. 139 <strong>di</strong> 148<br />
139
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
adeguate misure <strong>di</strong> mitigazione. In secondo luogo, prevendendo la possibilità <strong>di</strong><br />
seguire il proponente durante lo stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> impatto ambientale. Già dagli anni ’80 la<br />
legislazione nazionale prevedeva che il proponente potesse chiedere l’intervento <strong>di</strong><br />
es<strong>per</strong>ti da parte del Ministero dell’Ambiente <strong>per</strong> verificare che i rilievi dei dati <strong>per</strong><br />
lo Stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> era attuato in maniera corretta. In seguito, con<br />
l’introduzione della fase <strong>di</strong> orientamento (grosso modo corrispondente alla fase <strong>di</strong><br />
scoping) è stata prevista <strong>un</strong>a maggiore collaborazione tra i <strong>di</strong>versi attori interessati<br />
alla procedura <strong>di</strong> VIA (proponente, ente preposto al controllo del SIA, pubblico,<br />
ecc.) in maniera da impostare in maniera ottimale lo stu<strong>di</strong>o fin dalle sue prime fasi,<br />
riducendo così anche <strong>per</strong> il proponente il rischio che lo stu<strong>di</strong>o venga rigettato (e<br />
venga emesso <strong>un</strong> parere negativo rispetto alla compatibilità ambientale) <strong>per</strong>ché non<br />
ritenuto correttamente svolto.<br />
8. C'è il rischio che, all<strong>un</strong>gando troppo i tempi, si incorra in gravi problemi. Ma se non<br />
si mette in evidenza il conflitto prima, questo viene messo in evidenza dopo, quando<br />
sono stati già sostenuti molti costi (ad esempio, ve<strong>di</strong> la centrale nucleare <strong>di</strong> Montalto<br />
<strong>di</strong> Castro e gli enormi costi che si sono dovuti sostenere <strong>per</strong> la sua riconversione).<br />
D<strong>un</strong>que tempi e costi sono strettamente correlati. Se gli Enti pubblici non aiutano i<br />
proponenti a procurarsi i dati ed i modelli, la VIA rischia <strong>di</strong> <strong>di</strong>ventare <strong>per</strong> loro<br />
<strong>un</strong>’o<strong>per</strong>a insostenibile. Bisogna, quin<strong>di</strong>, creare banche dati e banche modelli e,<br />
com<strong>un</strong>que, fornire tutti quei tipi <strong>di</strong> informazioni che possono risultare utili. Per<br />
esempio fornire in<strong>di</strong>cazioni su dove sono re<strong>per</strong>ibili i dati. Senza questo, <strong>per</strong><br />
abbattere tempi e costi, <strong>un</strong>a seria applicazione della VIA non è attuabile. Queste<br />
<strong>di</strong>fficoltà, <strong>un</strong>ite al fatto che molto spesso la VIA è stata vista come <strong>un</strong> ulteriore<br />
aggravio burocratico, con il solo fine <strong>di</strong> fornire giustificazione a decisioni già prese<br />
in altra sede, hanno portato molti ad avere <strong>un</strong>a visione molto negativa della legge.<br />
Per quanto riguarda la tempistica, com<strong>un</strong>que, in relazione anche alla partecipazione<br />
prevista nel proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> VIA, Gerelli e Laniado fanno notare quanto segue:<br />
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
sospensione o ad<strong>di</strong>rittura l’annullamento. In questi casi, l’utilizzo della VIA quale<br />
metodo corretto <strong>per</strong> esplicare le scelte e raggi<strong>un</strong>gere <strong>un</strong> consenso, può determinare<br />
<strong>un</strong>a riduzione <strong>di</strong> tempi e <strong>di</strong> costi nella fase <strong>di</strong> esecuzione del progetto, pur<br />
provocando <strong>un</strong> ritardo e qualche maggior costo in quella precedente l’inizio dei<br />
lavori>> Inoltre, <strong>un</strong>a maggiore efficienza potrebbe essere conseguita se la<br />
procedura <strong>di</strong> VIA ed il conseguente giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> compatibilità ambientale potessere<br />
<strong>di</strong>ventare, almeno in parte, sostitutivi <strong>di</strong> altri obblighi previsti da legge e non solo <strong>un</strong><br />
compito agggi<strong>un</strong>tivo. Questo è molto <strong>di</strong>fficile nel caso che le competenze<br />
autorizzative siano a livelli amministrativi <strong>di</strong>versi (ad es., VIA a livello nazionale<br />
che richiede autorizzazioni a livello Regionale), ma può essere possibile nel caso<br />
che il livello amministrativo sia lo stesso. Ad esempio, la Regione Toscana ha<br />
previsto la possibilità <strong>di</strong> <strong>un</strong>a Procedura <strong>un</strong>ica integrata, descritta all Art. 17 della<br />
L.R. 79/98, <strong>di</strong> cui riportiamo <strong>di</strong> seguito il comma 1: Cfr. PARTE SU CONFERENZA<br />
SERVIZI SU LINEE GUIDA VIA – ANPA-MATT<br />
Non si può negare, com<strong>un</strong>que, che – in<strong>di</strong>pendentemente dal fatto se i ritar<strong>di</strong> siano<br />
stati causati, o meno, dal proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> VIA – l’iter delle gran<strong>di</strong> o<strong>per</strong>e sia spesso<br />
l<strong>un</strong>go e <strong>di</strong>fficoltoso. Alc<strong>un</strong>i, da questo p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista, sembrano s<strong>per</strong>are che il<br />
compito <strong>di</strong> valutare la compatibilità con l’ambiente sia spostato prevalentemente a<br />
livello pubblico, me<strong>di</strong>ante la VAS, in maniera che – <strong>un</strong>a volta esaminate le<br />
implicazioni ambientali a livello <strong>di</strong> pianificazione e programmazione settoriale – lo<br />
stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> impatto ambientale richiesto al proponente <strong>di</strong> <strong>un</strong>a singola o<strong>per</strong>a risulti<br />
fortemente ri<strong>di</strong>mensionato. Da non trascurare, inoltre, come l’all<strong>un</strong>gamento dei<br />
tempi e costi <strong>per</strong> la realizzazione <strong>di</strong> molte o<strong>per</strong>e abbia portato il Governo attuale ad<br />
emettere provve<strong>di</strong>menti volti a semplificare la VIA e rivedere l’iter autorizzativo nel<br />
Pag. 141 <strong>di</strong> 148<br />
141
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
caso <strong>di</strong> o<strong>per</strong>e pubbliche e centrali elettriche 120 (cfr., ad esempio, legge 21 <strong>di</strong>cembre<br />
2001 n. 443, Delega al Governo in materia <strong>di</strong> infrastrutture ed inse<strong>di</strong>amenti<br />
produttivi strategici ed altri interventi <strong>per</strong> il rilancio delle attività produttive e legge<br />
9 aprile 2002 n. 55, Conversione in legge, con mo<strong>di</strong>ficazioni, del decreto-legge 7<br />
febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti <strong>per</strong> garantire la sicurezza del sistema<br />
elettrico nazionale).<br />
9. Tra le problematiche principali del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> VIA c’è anche il ruolo della<br />
partecipazione: infatti la consultazione del pubblico dovrebbe essere vista in forma<br />
più attiva, ed inserita più a monte del processo <strong>di</strong> VIA <strong>di</strong> quello che è stato fatto<br />
inizialmente 121. Questo in quanto: a) il pubblico può avere accesso ad informazioni a<br />
livello locale più <strong>di</strong>fficilmente (od onerosamente) re<strong>per</strong>ibili da parte del proponente,<br />
b) mettendo in evidenza più precocemente i conflitti è forse più facile mettervi<br />
riparo 122 . Il problema dell’accettazione sociale è, com<strong>un</strong>que, <strong>di</strong>venuto <strong>di</strong> notevole<br />
importanza e numerosi sono i casi in letteratura dove si lamenta che il maggior<br />
coinvolgimento dei citta<strong>di</strong>ni ha portato allo stallo completo <strong>di</strong> qualsiasi tipo <strong>di</strong><br />
decisione. Per quanto riguarda le modalità <strong>di</strong> partecipazione del pubblico riportiamo<br />
120 Non tutti concordano nell’attribuire l’all<strong>un</strong>gamento <strong>di</strong> tempi e costi alla procedura <strong>di</strong> VIA. Si veda, ad<br />
esempio, M. Zambrini, il quale conclude la <strong>un</strong>a sua relazione (Aspetti dell’attuale rapporto tra VIA e<br />
processo decisionale (relazione presentata al convegno AAA del 24 gennaio 2003) come segue: “La<br />
sintetica rassegna proposta rende conto <strong>di</strong> alc<strong>un</strong>i casi in cui la <strong>di</strong>latazione dei tempi necessarei alla<br />
approvazione <strong>di</strong> progetti riconducibili alla VIA rappresenta solamente <strong>un</strong>a parte (generalmente nemmeno<br />
la più consistente) <strong>di</strong> <strong>un</strong> <strong>per</strong><strong>corso</strong> nei fatti molto più l<strong>un</strong>go, faticoso ed incerto. Limitare l’attenzione ai<br />
tempi tecnicamente necessari al completamento della procedura può portare, sotto questo profilo, a<br />
sottovalutare o ad<strong>di</strong>rittura ignorare elementi ben più rilevanti <strong>di</strong> contrasto e rallentamento. In altri termini,<br />
quando passano interi anni dalla conclusione della procedura all’a<strong>per</strong>tura dei cantieri, è quanto meno<br />
lecito domandarsi <strong>per</strong> quale motivo preoccuparsi sempre e solamente dei mesi necessari allo svolgimento<br />
della stessa procedura. Non solo. In alc<strong>un</strong>i casi, come si è visto, progetti già assentiti vengono ritirati e<br />
completamente riformulati a valle della VIA, laddove la richiesta <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fiche anche marginali da<br />
inserire nei progetti in istruttoria si scontra, spesso, con la forte resistenza dei proponenti motivata, <strong>per</strong><br />
l’app<strong>un</strong>to, dall’esigenza <strong>di</strong> “fare presto”.”<br />
121 Lucia Piani (Il processo <strong>di</strong> partecipazione nella <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong>, Genio Rurale, n.<br />
12, 1992) parlando del Friuli Venezia Giulia mette in evidenza quanto segue: “Si è trattato <strong>di</strong> progetti il<br />
più delle volte presentati ad <strong>un</strong> livello ormai esecutivo, quin<strong>di</strong> definiti già in maniera p<strong>un</strong>tuale e non<br />
raramente anche già finanziati. Alc<strong>un</strong>i <strong>di</strong> questi giacciono ancora sul tavolo dei proponenti in attesa <strong>di</strong> <strong>un</strong><br />
avvio impe<strong>di</strong>to da <strong>un</strong>a partecipazione talora inaspettata ma talvolta, forse, assolutamente preve<strong>di</strong>bile. (…)<br />
Per alc<strong>un</strong>e o<strong>per</strong>e il momento partecipativo è stato particolarmente interessante <strong>per</strong> il contributo che ha<br />
saputo fornire anche da <strong>un</strong> p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista tecnico-scientifico gi<strong>un</strong>gendo alla definizione e alla successiva<br />
proposta <strong>di</strong> vere e proprie alternative <strong>di</strong> progetto. Per altre si è limitato ad <strong>un</strong>a opposizione alla<br />
realizzazione in toto del progetto, non avendo in<strong>di</strong>viduato alternative e valide possibilità <strong>di</strong> negoziazione.<br />
122 “Sarebbe stato ottimale (…) aver proceduto nella costituzione <strong>di</strong> <strong>un</strong>a sorta <strong>di</strong> tavolo <strong>di</strong> consultazione<br />
anche nelle prime fasi, se non <strong>di</strong> progetto <strong>per</strong> lo meno <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong>. Ciò avrebbe consentito <strong>di</strong><br />
arrivare ad <strong>un</strong>a esplicitazione dei conflitti in <strong>un</strong> momento tale da <strong>per</strong>mettere, se in fase progettuale, <strong>di</strong><br />
in<strong>di</strong>rizzare meglio gli sforzi verso la ricerca <strong>di</strong> soluzioni progettuali ai problemi così evidenziati, se nelle<br />
prime fasi dello Stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong>, <strong>di</strong> porre <strong>un</strong>a particolare attenzione nella valutazione <strong>di</strong> questi aspetti<br />
<strong>per</strong> la scelta delle alternative migliori o <strong>per</strong> l’in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> eventuali misure mitigative.” (L. Piani, op.<br />
cit.)<br />
Pag. 142 <strong>di</strong> 148<br />
142
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
<strong>di</strong> seguito alc<strong>un</strong>i degli obiettivi e quin<strong>di</strong> dei benefici della partecipazione, con<br />
riferimento al pubblico, ai proponenti i progetti, alle autorità pubbliche (da F. La<br />
Camera, 1998). Di essi bisognerebbe tenere conto in sede <strong>di</strong> decisione delle tecniche<br />
<strong>per</strong> promuovere la partecipazione del pubblico e degli altri soggetti interessati.<br />
Per il pubblico<br />
avere maggiori informazioni sui progetti;<br />
aumentare la propria influenza nel processo decisionale;<br />
offrire informazioni sui rischi derivanti dalla realizzazione dei progetti;<br />
verificare come le proprie valutazioni ed attività siano tenute in conto dai<br />
decisori.<br />
Per i proponenti i progetti<br />
Aumentare le proprie conoscenze sui possibili impatti delle attività proposte;<br />
Assicurare maggiori dettagli ai propri approfon<strong>di</strong>menti dal p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista della<br />
tutela ambientale;<br />
Ridurre i contenziosi e quin<strong>di</strong> evitare l’all<strong>un</strong>gamento dei tempi;<br />
Favorire, me<strong>di</strong>ante il coinvolgimento del pubblico, l’interesse delle autorità<br />
pubbliche.<br />
Per le autorità pubbliche<br />
Aumentare il livello delle conoscenze ambientali fra la popolazione, aumentare<br />
l’informazione, migliorare la “qualità” delle decisioni;<br />
Risparmiare tempo e denaro nell’acquisire ed analizzare le informazioni;<br />
Aumentare “l’influenza” delle autorità ambientali rispetto le altre;<br />
Aumentare la possibilità del consenso sulle scelte pubbliche;<br />
Facilitare la conoscenza dell’ “importanza” o del “valore” attribuito dal pubblico<br />
alle variazioni <strong>di</strong> qualità ambientale;<br />
Migliorare nelle decisioni la <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> costi e benefici del progetto.<br />
10. Rapporti tra VIA e pianificazione: abbiamo precedentemente messo in evidenza sia<br />
come <strong>di</strong>fficilmente possa essere ritenuto razionale sottoporre a VIA la singola o<strong>per</strong>a<br />
(ad esempio, <strong>un</strong> impianto industriale) e non la relativa pianificazione del territorio<br />
(scelta delle aree <strong>per</strong> inse<strong>di</strong>amento industriale) e come si s<strong>per</strong>a che l’introduzione<br />
della VAS abbia <strong>un</strong> impatto positivo (in termini <strong>di</strong> minore onerosità dell’impegno)<br />
anche sulle procedure <strong>di</strong> VIA. In questa sede vorremmo far notare come – in alc<strong>un</strong>i<br />
casi – sia <strong>di</strong>fficile stimare l’impatto <strong>di</strong> <strong>un</strong>a o<strong>per</strong>a se non si conosce la pianificazione<br />
Pag. 143 <strong>di</strong> 148<br />
143
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
dell’area in cui essa si inserisce. Se pren<strong>di</strong>amo ad esempio il caso <strong>di</strong> <strong>un</strong>a<br />
infrastruttura lineare, ad esempio <strong>un</strong>a strada, infatti, gli impatti <strong>di</strong>retti causati dalla<br />
realizzazione della strada stessa (rumore, emissioni dei tubi <strong>di</strong> scarico, ecc.)<br />
potranno essere minori degli impatti in<strong>di</strong>retti, causati dal localizzarsi <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amenti<br />
industriali e civili in prossimità della strada stessa. E’ chiaro che <strong>un</strong>a regola o<br />
limitazione a tali inse<strong>di</strong>amenti non può essere decisa a livello <strong>di</strong> progettazione <strong>di</strong><br />
strada, ma a livello <strong>di</strong> pianificazione territoriale.<br />
11. VIA e territorio: nella sua formulazione iniziale la procedura <strong>di</strong> VIA introdotta con<br />
la <strong>di</strong>rettiva com<strong>un</strong>itaria del 1985 era strettamente basata sulla tipologia <strong>di</strong> o<strong>per</strong>a; in<br />
altre parole non si richiedevano proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong>fferenziati a seconda del tipo <strong>di</strong><br />
contesto ambientale in cui l’o<strong>per</strong>a stessa veniva inserita. Questo approccio, anche<br />
negli anni ottanta, non fu accettato a livello <strong>di</strong> legislazioni regionali, che in alc<strong>un</strong>i<br />
casi previdero modalità <strong>di</strong> applicazioni <strong>di</strong>verse della VIA a seconda delle<br />
caratteristiche (in termini <strong>di</strong> ricettività ambientale, fragilità, rarità, ecc.)<br />
dell’ambiente in cui l’o<strong>per</strong>a andava a collocarsi, ad esempio andando a prevedere<br />
regole più stringenti <strong>per</strong> gli interventi localizzati in aree a Parco o com<strong>un</strong>que<br />
ritenute <strong>di</strong> elevato pregio a livello ambientale. Con l’Atto <strong>di</strong> In<strong>di</strong>rizzo e<br />
Coor<strong>di</strong>namento il principio della <strong>di</strong>fferenziazione delle soglie in base ad alc<strong>un</strong>e<br />
gran<strong>di</strong>ssime tipologie <strong>di</strong> territorio è stato recepito a livello nazionale (<strong>per</strong> la<br />
legislazione che detta le norme alle quali devono adeguarsi tutte le normative<br />
regionali).<br />
Prima <strong>di</strong> entrare più in dettaglio nel proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> VIA, che sarà affrontate nel<br />
secondo modulo, ma del quale <strong>un</strong> primo quadro sintetico è desumibile dalle LINEE<br />
GUIDA VIA <strong>di</strong> ANPA e MATT, vogliamo riportare quelli che, secondo il Malcevschi,<br />
costituiscono gli elementi <strong>di</strong> <strong>un</strong>a VIA.<br />
a) meto<strong>di</strong> <strong>per</strong> la corretta descrizione delle componenti ambientali <strong>di</strong> <strong>un</strong> dato territorio<br />
nonché del sistema ambientale nel suo complesso;<br />
b) meto<strong>di</strong> <strong>per</strong> la caratterizzazione degli aspetti <strong>di</strong> qualità e <strong>di</strong> criticità <strong>di</strong> <strong>un</strong> dato<br />
territorio;<br />
c) meto<strong>di</strong> <strong>per</strong> l’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> impatti significativi;<br />
d) modelli <strong>per</strong> la previsione degli impatti in<strong>di</strong>viduati; i modelli devono affrontare sia<br />
specifiche componenti ambientali (aria, il sottosuolo, ecc.), sia il sistema ambientale<br />
nel suo complesso;<br />
Pag. 144 <strong>di</strong> 148<br />
144
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
e) elementi <strong>per</strong> <strong>un</strong>a corretta analisi dello stato e delle prospettive della pianificazione<br />
territoriale e <strong>di</strong> settore;<br />
f) elementi <strong>per</strong> <strong>un</strong>a corretta descrizione dei progetti <strong>di</strong> intervento, selezionando le<br />
informazioni necessarie ai fini degli obiettivi;<br />
g) selezione e sviluppo <strong>di</strong> tecniche <strong>per</strong> la riduzione degli impatti indotti sull’ambiente;<br />
h) conoscenze e meto<strong>di</strong> <strong>per</strong> la messa a p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> programmi ottimali <strong>di</strong> monitoraggio e<br />
controllo;<br />
i) meto<strong>di</strong> <strong>per</strong> la valutazione della compatibilità delle o<strong>per</strong>e con l’ambiente;<br />
j) meto<strong>di</strong> della teoria delle decisioni applicata alla scelta tra alternative;<br />
k) meto<strong>di</strong> <strong>per</strong> la trasmissione delle informazioni al pubblico coinvolto;<br />
l) tecniche <strong>per</strong> ottimizzare i momenti <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione e <strong>di</strong> negoziazione tra i <strong>di</strong>versi<br />
soggetti sociali interessati;<br />
m) elementi conoscitivi <strong>per</strong> <strong>un</strong> corretto inserimento dei casi trattati nel quadro<br />
amministrativo <strong>di</strong> riferimento.<br />
Fonte: Malcevschi, Qualità e impatto ambientale, pag. 21<br />
Come è facile capire da <strong>un</strong> esame me<strong>di</strong>tato della lista precedente, <strong>un</strong>a procedura <strong>di</strong><br />
VIA, <strong>per</strong> essere portata a termine, richiede <strong>un</strong>a serie <strong>di</strong> professionalità <strong>di</strong>verse che<br />
richiedono che lo stu<strong>di</strong>o e la valutazione vengano fatte non dal singolo es<strong>per</strong>to, ma da<br />
<strong>un</strong> team comprendente figure <strong>di</strong>verse. Questo, chiaramente, finché si parla <strong>di</strong> progetti <strong>di</strong><br />
VIA <strong>di</strong> <strong>un</strong>a certa <strong>di</strong>mensione; vedremo, infatti, come le procedure <strong>di</strong> VIA stabilite a<br />
livello regionale possano interessare anche interventi <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni relativamente<br />
ridotte ed impatti relativamente circoscritti, <strong>per</strong> i quali il singolo professionista può<br />
essere in grado <strong>di</strong> effettuare l’analisi.<br />
Il seguente schema – tratto dai luci<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> sulla VIA organizzato presso il<br />
Politecnico <strong>di</strong> Milano – riporta le competenze tecniche e metodologiche necessarie <strong>per</strong><br />
<strong>un</strong> proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> VIA.<br />
Pag. 145 <strong>di</strong> 148<br />
145
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
Schema 1 - Inter<strong>di</strong>sciplinarietà (da <strong>corso</strong> Politecnico <strong>di</strong> Milano)<br />
i. competenze metodologiche<br />
il giurista: - integra le procedure VIA nella legislazione<br />
- stu<strong>di</strong>a gli strumenti autorizzativi/attuativi<br />
ambientali: - interagisce con gli es<strong>per</strong>ti <strong>di</strong> settore<br />
l’analista - descrive il sistema tramite in<strong>di</strong>catori<br />
<strong>di</strong> sistemi tecnologici - interagisce con i progettisti<br />
- descrive le caratteristiche del progetto<br />
l’economista - propone scenari<br />
- pesa i criteri in fase <strong>di</strong> valutazione<br />
il pianificatore - esamina il processo decisionale e i suoi strumenti<br />
- propone alternative e le valuta<br />
l’organizzatore della - propone, organizza e gestice la partecipazione<br />
partecipazione - <strong>di</strong>vulga<br />
il modellista - realizza/coor<strong>di</strong>na modelli <strong>di</strong> settore<br />
- realizza strumenti <strong>di</strong> supporto alle decisioni<br />
l’es<strong>per</strong>to <strong>di</strong> sistemi - sa quali dati esistono<br />
informativi - interfaccia banche-dati e banche-modelli<br />
il coor<strong>di</strong>natore - mette in contatto le varie metodologie<br />
- è l’es<strong>per</strong>to <strong>di</strong> VIA<br />
il decisore - formalizza le procedure <strong>di</strong> VIA<br />
- decide sul singolo caso<br />
ii. competenze tecniche<br />
es<strong>per</strong>ti <strong>di</strong> settore - (sono molto numerosi)<br />
progettisti<br />
Pag. 146 <strong>di</strong> 148<br />
146
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
Alc<strong>un</strong>e prime conclusioni<br />
Al termine <strong>di</strong> questo modulo ci sembra importante richiamare quelli che il Manuale<br />
della Regione Lombar<strong>di</strong>a definisce i concetti base relativia alle problematiche della<br />
procedura <strong>di</strong> VIA e con i quali apre la trattazione delle <strong>di</strong>verse problematiche. Il fatto <strong>di</strong><br />
averli riportati a conclusione, piuttosto che all’inizio, dovrebbe servire – a nostro parere<br />
– a leggerle con <strong>un</strong> <strong>di</strong>verso grado <strong>di</strong> apprezzamento e consapevolezza. «<br />
a. la VIA è <strong>un</strong>o strumento-processo <strong>per</strong> l’attuazione <strong>di</strong> <strong>un</strong>a politica preventiva e<br />
rappresenta <strong>un</strong>a applicazione del principio “la migliore politica ecologica consiste<br />
nell’evitare sin dall’inizio inquinamenti ed altri inconvenienti, anchiché<br />
combatterne successivamente gli effetti;<br />
b. la procedura <strong>di</strong> VIA è <strong>un</strong> sistema <strong>di</strong> supporto alle decisioni; gli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> impatto non<br />
possono <strong>per</strong>tanto ridursi alla fase <strong>di</strong> descrizione, ma devono com<strong>un</strong>que arrivare ad<br />
<strong>un</strong>a valutazione <strong>per</strong> fornire all’autorità competente gli elementi sui quali decidere,<br />
avendo stabilito in modo scientificamente coerente quali sono i possibili effetti che<br />
l’azione da intraprendere può avere sull’ambiente; ciò pone due problemi: quello<br />
della trasparenza dei passi che hanno prodotto la decisione e quello della<br />
ri<strong>per</strong>corribilità dell’intero processo (da parte <strong>di</strong> chi se sia interessato);<br />
c. <strong>un</strong>a VIA, in quanto processo <strong>di</strong> decisione, cioè <strong>di</strong> scelta, esplica le sue maggiori<br />
potenzialità in presenza <strong>di</strong> <strong>un</strong>a pluralità <strong>di</strong> alternative, fra le quali scegliere; ciò<br />
pone il problema <strong>di</strong> definire le alternative <strong>di</strong> progetto, ivi compresa ovviamente<br />
l’alternativa zero, <strong>di</strong> analizzarne gli impatti tenendo conto della durata prevista <strong>per</strong><br />
il progetto, e <strong>di</strong> comparare le alternative entro <strong>un</strong> dato sistema <strong>di</strong> obiettivi e/o<br />
vincoli;<br />
d. esistono VIA con livelli <strong>di</strong>versi <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>mento a seconda del momento del<br />
processo decisionale in cui il proce<strong>di</strong>mento viene collocato: la fase iniziale (stu<strong>di</strong>o<br />
<strong>di</strong> fattibilità), la fase interme<strong>di</strong>a (progetto <strong>di</strong> massima), la fase finale (progetto<br />
esecutivo); non esiste <strong>un</strong> “momento giusto” <strong>per</strong> la VIA: in linea generale essa<br />
andrebbe collocata il più a monte possibile del processo decisionale; è chiaro,<br />
<strong>per</strong>altro, che è <strong>di</strong>verso o<strong>per</strong>are su <strong>un</strong> progetto esecutivo, in cui le alternative sono<br />
molto spesso solo le misure <strong>di</strong> mitigazione, oppure su <strong>un</strong> progetto <strong>di</strong> massima, in cui<br />
si esaminano le alternative tecnologiche e/o <strong>di</strong> localizzazione, o, invece, lavorare su<br />
Pag. 147 <strong>di</strong> 148<br />
147
<strong>Materiali</strong> <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Valutazione</strong> <strong>di</strong> <strong>Impatto</strong> <strong>Ambientale</strong> – parte introduttiva<br />
Bozza provvisoria e non corretta<br />
<strong>un</strong>o stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> fattibilità, in cui il confronto avviene tra le gran<strong>di</strong> opzioni strategiche,<br />
estremamente a<strong>per</strong>te;<br />
e. <strong>per</strong> interventi o azioni da assoggettare a VIA vanno intesi non solo le o<strong>per</strong>e, ma<br />
anche gli strumenti <strong>di</strong> piano, i programmi, le norme, le decisioni che interferiscono<br />
<strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente con l’ambiente; il livello <strong>di</strong> maturazione della VIA nel<br />
caso delle o<strong>per</strong>e è certamente più avanzato; è possibile <strong>di</strong>stinguere fra le o<strong>per</strong>e che<br />
richiedono decisioni riguardanti la localizzazione, la tecnologia e le <strong>di</strong>mensioni e<br />
quelle che prevedono, invece, soltanto <strong>un</strong>a decisione relativa a tecnologia e<br />
<strong>di</strong>mensioni;<br />
f. esistono figure <strong>di</strong>verse nel processo <strong>di</strong> VIA; tra esse è opport<strong>un</strong>o <strong>di</strong>stinguere: il<br />
proponente/committente, soggetto che richiede il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> approvazione,<br />
autorizzazione o concessione che consente in via definitiva la realizzazione del<br />
progetto; l’autorità proponente, nel caso sia la pubblica autorità a promuovere<br />
l’iniziativa relativa al progetto; l’autorità competente, ovvero l’amministrazione o<br />
l’organo che provvede alla valutazione <strong>di</strong> impatto ambientale; il pubblico, ossia i<br />
soggetti interessati a vario titolo al progetto;<br />
g. la VIA va intesa come processo <strong>di</strong> partecipazione del pubblico e questa è <strong>un</strong>a delle<br />
f<strong>un</strong>zioni principali della procedura; l’informazione e la partecipazione sono<br />
momenti <strong>di</strong> conoscenza della complessità ambientale e sociale, che consente ai<br />
soggetti sociali <strong>di</strong> controllare la coerenza e l’efficacia dell’o<strong>per</strong>ato delle autorità<br />
competenti;<br />
h. ai fini <strong>di</strong> <strong>un</strong>a seria verifica scientifica e <strong>di</strong> <strong>un</strong>a partecipazione costruttiva, lo<br />
svolgimento <strong>di</strong> <strong>un</strong>a VIA, come già detto, deve sempre risultare <strong>un</strong> processo<br />
ri<strong>per</strong>corribile e d<strong>un</strong>que quanto più possibile trasparente; questa esigenza rimanda<br />
alla chiarezza dei dati e dei meto<strong>di</strong> ed alla necessità <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> fonti informative<br />
e <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> gestione affidabili, il tutto inserito in <strong>un</strong>o schema metodologico<br />
riconoscibile e accettato.<br />
Lo scopo <strong>di</strong> <strong>un</strong>a metodologia generale sta nel “forzare” il proponente, l’autorità<br />
competente, chi<strong>un</strong>que altro sia interessato, a <strong>per</strong>correre <strong>un</strong>a serie <strong>di</strong> passi chiari e<br />
definiti, lasciando ovviamente alc<strong>un</strong>i gra<strong>di</strong> <strong>di</strong> libertà affinché la metodologia proposta e<br />
con essa la VIA non <strong>di</strong>ventino <strong>un</strong>a “gabbia” fatta <strong>di</strong> adempimenti formali puramente<br />
autorizzativi, ma consentano <strong>di</strong> inquadrare questi gra<strong>di</strong> <strong>di</strong> libertà all’interno <strong>di</strong> <strong>un</strong>a<br />
struttura logica sufficientemente precisa».<br />
Pag. 148 <strong>di</strong> 148<br />
148