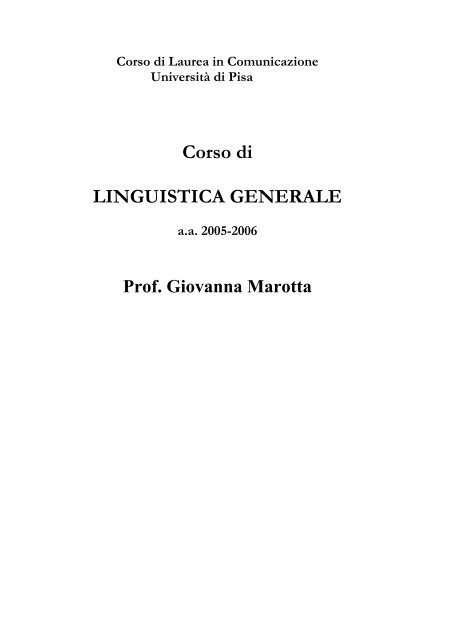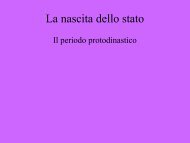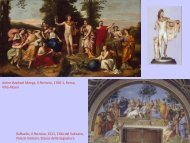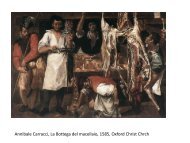appunti lezioni - Omero - Università di Pisa
appunti lezioni - Omero - Università di Pisa
appunti lezioni - Omero - Università di Pisa
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Corso <strong>di</strong> Laurea in Comunicazione<br />
Università <strong>di</strong> <strong>Pisa</strong><br />
Corso <strong>di</strong><br />
LINGUISTICA GENERALE<br />
a.a. 2005-2006<br />
Prof. Giovanna Marotta
Sezione II<br />
N. Chomsky<br />
e la Grammatica Generativa
COMPETENZA<br />
Ambiguità del termine Grammatica in Chomsky<br />
a) Grammatica delle singole lingue; essenzialmente, la struttura<br />
morfosintattica; NB Centralità della sintassi; la morfologia è stata poco<br />
trattata, può <strong>di</strong>rsi marginale in Grammatica Generativa;<br />
b) Grammatica Universale: insieme <strong>di</strong> princìpi e parametri, presenti in tutte<br />
le lingue naturali;<br />
c) Grammatica come norma grammaticale: Chomsky non ne parla, in linea<br />
con la sua scarsa considerazione per gli aspetti sociali del lggio.<br />
NB ogni parlante <strong>di</strong> una lingua naturale conosce perfettamente la grammatica<br />
della sua lingua, nel senso a), anche se non ha acquisito la norma grammaticale in<br />
senso c).<br />
Per Chomsky – che ha introdotto il termine in linguistica - la competenza<br />
grammaticale è la competenza linguistica in senso proprio; si basa su principi<br />
logico-razionali <strong>di</strong> carattere generale, propri solo della specie umana.<br />
Chomsky riconosce anche l’esistenza <strong>di</strong> una competenza pragmatica, tuttavia<br />
meno interessante per la sua prospettiva, anche se negli ultimi anni si nota una<br />
certa apertura in questo senso (cfr. Chomsky et al. 2002).<br />
Tutti gli uomini possiedono una competenza linguistica, che fa parte dle loro<br />
corredo biologico, geneticamente trasmesso (NB si sottolinea l’aspetto genetico,<br />
e non quello storico-sociale), mentre non tutti hanno competenza pragmatica.<br />
Basta pensare a quanti ‘non hanno il senso della situazione’.<br />
Es. Che bella, questa festa!!<br />
Questo enunciato è suscettibile <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse nterpretazioni pragmatiche, a parità <strong>di</strong><br />
struttura sintattica, morfologica e fonetica (ma non proso<strong>di</strong>ca!!):<br />
- interpretazione letterale, <strong>di</strong> ‘verità’<br />
- interpretazione ironica<br />
- interpretazione enfatica<br />
In ogni caso, le <strong>di</strong>verse interpretaz. semantico-pragmatiche non mo<strong>di</strong>ficano la<br />
struttura morfosintattica della frase; infatti, se cambio l’or<strong>di</strong>ne delle parole,<br />
ottengo frasi agrammaticali;<br />
ad es. *Che festa bella questa!*Festa che questa bella! *Bella che questa festa!
CRITICHE a Chomsky da parte della SOCIOLINGUISTICA (cfr. LABOV):<br />
a) sia la langue che la parole come pure la competence e la performance<br />
presentano aspetti sociali, ideologici e politici, oltre che in<strong>di</strong>viduali; lo stu<strong>di</strong>o<br />
delle lingue soltanto nel loro assetto formale è riduttivo.<br />
b) la lingua va stu<strong>di</strong>ata nel suo costante intreccio tra in<strong>di</strong>viduo e società.<br />
il carattere razionalistico della grammatica non può far <strong>di</strong>menticare la<br />
<strong>di</strong>mensione sociale e comunicativa <strong>di</strong> ogni singolo enunciato o atto linguistico.<br />
c) il ‘parlante-nativo’ <strong>di</strong> Chomsky è un’idealizzazione.<br />
I parlanti sono <strong>di</strong>versi l’uno dall’altro, perché esiste la variazione linguistica, e<br />
dunque esistono competenze <strong>di</strong>verse.<br />
La lingua non è monolitica e compatta al suo interno, ma variegata e sfaccettata,<br />
per cui i giu<strong>di</strong>zi dei parlanti possono <strong>di</strong>fferire.<br />
NB <strong>di</strong>fferenza tra frase (unità della competence), enunciato (performance) e atto<br />
linguistico (unità della pragmatica).<br />
Competence I-Language (lingua interna)<br />
Performance E-Language (lingua esterna).<br />
Per Chomsky, è lo stu<strong>di</strong>o della lingua-I che solo può attingere il livello della<br />
adeguatezza esplicativa, tipica della scienza. Lo strutturalismo, anche ai suoi<br />
massimi livelli, ha attinto soltanto all’adeguatezza descrittiva, perché mancava il<br />
riferimento <strong>di</strong>retto alla competenza, raggiungibile solo me<strong>di</strong>ante l’analisi<br />
introspettiva da parte del parlante.<br />
Grammatica Generativa: La LINGUA è un prodotto della mente umana, in<br />
quanto tale è un sistema logico <strong>di</strong> regole e <strong>di</strong> princìpi; è il prodotto del ‘modulo<br />
linguaggio’ mente modulare.<br />
Contra: cognitivismo non chomskiano, PDP, connessionismo e modelli collegati.<br />
Conseguenze della modularità della mente:<br />
1) afasia: soggetti afasici per lesioni traumatiche, possono mantenere<br />
inalterate altre capacità cognitive, oltre che motorie; MA in realtà, spesso,<br />
non è solo il lggio ad essere compromesso.<br />
2) “<strong>di</strong>sturbo specifico del lggio”: il ‘modulo lggio’ è compromesso, senza che<br />
lo siano anche altri moduli cognitivi, per es. quello responsabile della<br />
capacità <strong>di</strong> computazione numerica.
M. D. HAUSER, N. CHOMSKY & W. TECUMESH FITCH<br />
The Faculty of Language : What is it, Who Has It, and How Did it Evolve?<br />
“Science” n. 298, 2002, pp. 1569-1579.<br />
Nell'articolo recentemente pubblicato, gli AA. (Chomsky e due psicologi <strong>di</strong><br />
Harvard) cercano <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrare come lo stu<strong>di</strong>o della facoltà del linguaggio<br />
richieda una cooperazione inter<strong>di</strong>sciplinare stretta, costante e sostanziale.<br />
Gli sviluppi nel campo della <strong>di</strong>sciplina linguistica possono fornire utili<br />
suggerimenti ed in<strong>di</strong>cazioni per lo stru<strong>di</strong>o della biologia evolutiva, così come per<br />
l'antropologia, la psicologia ele neuroscienze.<br />
L'idea <strong>di</strong> base <strong>di</strong> questo articolo è che vi sia una facoltà del lggio in senso largo<br />
(FLB), con<strong>di</strong>visa dall'uomo e da altre specie animali, e che vi sia una facoltà del<br />
lggio in senso stretto (FLN), tipica ed esclusiva della specie umana.<br />
La facoltà del linguaggio in senso largo include un sistema senso-motorio, un<br />
sistema concettuale, un sistema intenzionale, e meccanismi computazionali che<br />
sono in grado <strong>di</strong> generare numerose espressioni a partire da un numero ristretto <strong>di</strong><br />
elementi.<br />
Tuttavia, la facoltà del linguaggio in senso stretto riguarda in maniera specifica e<br />
esclusiva la specie umana.<br />
Nello schema seguente dell’art. (cfr. fotocopia <strong>di</strong>stribuita a lezione), ve<strong>di</strong>amo a<br />
sinistra i numerosi con<strong>di</strong>zionamenti che il sistema <strong>di</strong> comunicazione umano ed<br />
animale subisce dall'ambiente esterno:<br />
- con<strong>di</strong>zionamenti ecologici, fisici, culturali, sociali.<br />
Nella parte centrale dello schema, sono invece riprodotti i componenti della<br />
facoltà del lggio, sia quelli della FLB che quelli della FLN.
Vi sono almeno tre problemi teorici che riguardano il <strong>di</strong>battito sull’evoluzione<br />
del linguaggio umano.<br />
1) il primo ed il più antico riguarda l'opposizione 'con<strong>di</strong>viso' vs. 'unico'<br />
(shared- unique).<br />
Sebbene la danza delle api, i canti degli uccelli, i grugniti degli shimpanzee<br />
presentino dei tratti in comune con il lggio umano, ciò nonostante i sistemi <strong>di</strong><br />
comunicazione animale sono <strong>di</strong>versi dalle lingue naturali, sia sul piano<br />
quantitativo che su quello qualitativo.<br />
Il problema evolutivo (un vero e propio puzzle) è capire come l'uomo abbia<br />
potuto sviluppare un sistema <strong>di</strong> comunicazione verbale così sofisticato e<br />
profondamente <strong>di</strong>verso da quello degli altri animali.<br />
2) il secondo problema è strettam. connesso con il primo, e riguarda la<br />
DISCONTINUITA'<br />
L'evoluz. linguistica umana ha proceduto in modo <strong>di</strong>scontinuo, per salti, oppure<br />
in maniera continua e graduale?<br />
Al momento non sembrano esserci forti argomenti a favore dell'una o dell'altra<br />
ipotesi.<br />
3) il terzo problema riguarda un altro aspetto della questione della<br />
CONTINUITY vs. EXAPTATION:<br />
Il linguaggio umano si è evoluto tramite l'estensione graduale e progressiva <strong>di</strong><br />
sistemi <strong>di</strong> comunicazione preesistenti (per es. lggio gestuale), oppure tramite<br />
adattamento <strong>di</strong> elementi e sistemi che avevano in origine una funzione <strong>di</strong>versa?<br />
Ad es., che rapporto c'è tra il lggio umano e il ragionamento matematico?<br />
o con lo sviluppo degli utensili da lavoro nella società umana?<br />
o con l'organizzazione della società stessa?<br />
Le posizioni espresse dai ricercatori in merito sono state varie e <strong>di</strong>verse, ma non<br />
c'è dubbio alcuno che per rispondere a qs domande è necessario uno sforzo <strong>di</strong><br />
totale collaborazione tra linguisti da un lato, e biologi, antropologi e psicologi<br />
dall'altro.<br />
Per gli autori che hanno scritto l'articolo comparso su Science il bersaglio <strong>di</strong><br />
questo intervento concerne la produzione <strong>di</strong> una ricerca comune sempre più forte<br />
tra biologi e linguisti, volta ad identificare dei punti <strong>di</strong> contatto e <strong>di</strong> accordo tra<br />
questi due <strong>di</strong>versi campi del sapere.<br />
Ch. e gli altri due autori definiscono in primo luogo la facoltà del linguaggio alla<br />
luce del modello generativo standard; ma passano poi ben presto a proporre la<br />
loro nuova visione della facoltà del linguaggio, in cui la <strong>di</strong>stanza tra lggio<br />
animale e l. umane è ridotto.
La FACOLTA' del LINGUAGGIO è <strong>di</strong>visa in due parti fondamentali:<br />
1) la facoltà del linguaggio in senso largo<br />
2) la facoltà del linguaggio in senso stretto<br />
La facoltà del linguaggio in senso stretto è il sistema computazionale astratto,<br />
totalmente linguistico, che è in<strong>di</strong>pendente da tutti gli altri sistemi computazionale<br />
con cui interagisce la facoltà del linguaggio in senso largo.<br />
La facoltà del lggio in senso stretto è dunque un componente della facoltà del<br />
linguaggio in senso largo.<br />
I meccanismi che sono soggiacenti alla facoltà del linguaggio in senso stretto<br />
sono una parte <strong>di</strong> quei meccanismo che soggiacciono alla facoltà del linguaggio<br />
in senso largo.<br />
Naturalmente vi sono stati altri autori, come ad es. Liberman, che hanno preso<br />
atto <strong>di</strong> come il sistema senso motorio tipico dell'uomo sia stato adattato per gli<br />
aspetti funzionali del linguaggio e che hanno quin<strong>di</strong> pensato che lo stesso sistema<br />
senso-motorio fosse in qualche modo parte della facoltà del linguaggio in senso<br />
stretto.<br />
In realtà, secondo Ch. e i due psicologi che firmano con lui l'articolo, la facoltà<br />
del linguaggio in senso stretto (FLN) è un sistema computazionale<br />
fondamentalmente sintattico, che niente o ben poco ha a che vedere con il sistema<br />
senso-motorio.<br />
In effetti, il sistema senso-motorio si è evoluto in modo da rendere il più efficace<br />
possibile la comunicazione verbale. Ma una parte integrante <strong>di</strong> quella facoltà<br />
linguistica in senso stretto che è tipica dell'uomo soltanto è data dalla sintassi e<br />
dalle proprietà tipiche della sintassi.<br />
Infatti, mentre molti aspetti della facoltà del linguaggio in senso largo<br />
appartengano all'uomo, ma sono con<strong>di</strong>visi da altri vertebrati, vi sono alcune<br />
proprietà della facoltà del linguaggio umano che appartengono solo alle lingue<br />
naturali. In particolare, la proprietà che caratterizza la facoltà del linguaggio in<br />
senso stretto è la ricorsività.<br />
Percezione: costitituisce un aspetto importante degli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> etologia animale;<br />
per molto tempo, si è ritenuto che gli animali fossero dotati soltanto <strong>di</strong> una<br />
percezione continua, non categoriale.<br />
In realtà, stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> etologia animale hanno mostrato come anche gli animali siano<br />
capaci <strong>di</strong> categorizzare in modo simile a quanto fa l'uomo, <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinguere e<br />
classficare in mod <strong>di</strong>verso stimoli <strong>di</strong>versi. Gli esperimenti che sono stati condotti<br />
sugli uccelli in primo luogo, e anche su altre specie hanno mostrato che in effetti<br />
anche gli animali possono categorizzare la loro esperienza reale.
Un'altra caratteristica tipica del nuovo quadro etologico emerso dagli stu<strong>di</strong><br />
sperimentali recenti riguarda la capacità imitativa vocale, che un tempo veniva<br />
considerata esclusiva dell'uomo, e che adesso viene riconosciuta anche per<br />
alcune specie animali.<br />
Alcune specie, in particolare alcuni mammiferi (i delfini) o alcuni uccelli (i<br />
pappagalli o gli uccelli canterini) mostrano una spiccata capacità <strong>di</strong> imitazione<br />
vocale, comparabile a qlla degli uomini. I delfini possono inventare giochi<br />
vocali, possono imitare le voci che sentono intorno a loro.<br />
Da sottolineare che questa capacità imitativa, che si osserva non solo nell’uomo<br />
ma anche in altri mammiferi (in particolare nei delfini e anche in alcuni uccelli),<br />
è pressoché assente nei primati.<br />
I primati ed anche gli scimpanzè non mostrano una capacità imitativa vocale<br />
parallela a quella che si osserva presso altri animali mammiferi.<br />
PARADOSSO: da un lato noi osserviamo che alcune scimmie in particolare le<br />
scimmie <strong>di</strong> tipo Macaco nico mostrano - così come accade nella nella specie<br />
umana - i cosiddetti neuroni-specchio nella corteccia pre-motoria; ciò<br />
nonostante questi stessi animali non ci mostrano una sviluppata capacità <strong>di</strong><br />
initazione vocale.<br />
Si è molto parlato in questi ultimi anni dei neuroni specchio, che sembrano<br />
attivarsi quando l'animale non solo compie un'azione, ma anche soltanto la vede<br />
compiere da altri o, per l’uomo, se la evoca nella propria mente.<br />
Gli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> neuroimaging consentono <strong>di</strong> indagare il funzionamento e la'ttivazione<br />
delle <strong>di</strong>verse aree cerebrali, nei primati come negli uomini.<br />
Chomsky e i due AA. ritengono che sia importante <strong>di</strong>stinguere tra i correlati<br />
neurali e le capacità e le funzioni attivate concretamente dagli esseri animali.
CONTINUITÀ<br />
Tornando alle questioni che si erano poste all'inizio dell'articolo, gli Autori<br />
ritengono che alla luce degli esperimenti condotti nel campo della etologia<br />
animale, l'ipotesi relativa alla continuità tra esseri umani da un lato e da altri<br />
animali già l'altro sia al momento la più probabile.<br />
Quin<strong>di</strong>, continuità e non <strong>di</strong>scontinuità, ma questo riguarda solo la facoltà del<br />
linguaggio in senso largo (FLB), e non la facoltà del linguaggio in senso stretto<br />
(FLN), tipica dell'uomo.<br />
In effetti gli animali - scrivono gli autori - sono del tutto privi della capacità <strong>di</strong><br />
creare sistemi comunicativi aperti, non limitati, il che che conferisce a questa<br />
capacità <strong>di</strong> linguaggio in senso stretto l'esclusivo valore del linguaggio ai sistemi<br />
comunicativi umani.<br />
L'articolo si conclude proprio ribadendo quella facoltà linguistica in senso<br />
stretto (FLN), che deve essere considerata come unica della specie umana<br />
soprattutto perché la facoltà del linguaggio in senso stretto si basa su una<br />
proprietà essenziale tipica delle lingue naturali: la ricorsività.<br />
Gli autori che si chiedono anche quale sia il motivo che ha condotto alla<br />
ricorsività.<br />
Sostenengono in merito che probabilmente la ricorsività si è imposta e si è<br />
evoluta, nel corso della storia della specie umana, per risolvere problemi<br />
cognitivi e computazionali in origine <strong>di</strong>versi da quelli propriamente linguistici.<br />
E’ probabile che la ricorsività sia nata, ad esempio, all'interno della risoluzione <strong>di</strong><br />
problemi <strong>di</strong> natura matematica relativi ad es. alla computazione <strong>di</strong> numeri;<br />
oppure per risolvere problemi relati alle relazioni sociali.<br />
In tal senso, è possibile che anche altre specie animali abbiano avuto quest'abilità,<br />
ma la loro evoluzione è stato <strong>di</strong>versa rispetto a quella umana, poiché al momento<br />
solo gli esseri umani hanno sviluppato la proprietà della ricorsività.<br />
Lo stu<strong>di</strong>o della comunicazione animale sembra agli autori <strong>di</strong> primario interesse<br />
proprio perché consente <strong>di</strong> svolgere una ricerca comparativa sui sistemi<br />
comunicativi, il che rappresenta una delle frontiere attuali più interessanti degli<br />
stu<strong>di</strong> in campo etologico evolutivo.