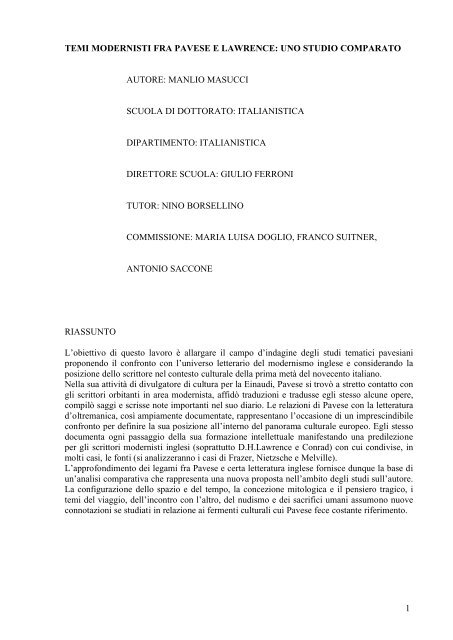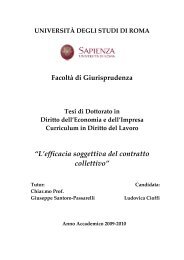Documento in Research-Desk - tesi vers def PADIS - Padis - Sapienza
Documento in Research-Desk - tesi vers def PADIS - Padis - Sapienza
Documento in Research-Desk - tesi vers def PADIS - Padis - Sapienza
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
TEMI MODERNISTI FRA PAVESE E LAWRENCE: UNO STUDIO COMPARATO<br />
RIASSUNTO<br />
AUTORE: MANLIO MASUCCI<br />
SCUOLA DI DOTTORATO: ITALIANISTICA<br />
DIPARTIMENTO: ITALIANISTICA<br />
DIRETTORE SCUOLA: GIULIO FERRONI<br />
TUTOR: NINO BORSELLINO<br />
COMMISSIONE: MARIA LUISA DOGLIO, FRANCO SUITNER,<br />
ANTONIO SACCONE<br />
L’obiettivo di questo lavoro è allargare il campo d’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e degli studi tematici pavesiani<br />
proponendo il confronto con l’uni<strong>vers</strong>o letterario del modernismo <strong>in</strong>glese e considerando la<br />
posizione dello scrittore nel contesto culturale della prima metà del novecento italiano.<br />
Nella sua attività di divulgatore di cultura per la E<strong>in</strong>audi, Pavese si trovò a stretto contatto con<br />
gli scrittori orbitanti <strong>in</strong> area modernista, affidò traduzioni e tradusse egli stesso alcune opere,<br />
compilò saggi e scrisse note importanti nel suo diario. Le relazioni di Pavese con la letteratura<br />
d’oltremanica, così ampiamente documentate, rappresentano l’occasione di un impresc<strong>in</strong>dibile<br />
confronto per <strong>def</strong><strong>in</strong>ire la sua posizione all’<strong>in</strong>terno del panorama culturale europeo. Egli stesso<br />
documenta ogni passaggio della sua formazione <strong>in</strong>tellettuale manifestando una predilezione<br />
per gli scrittori modernisti <strong>in</strong>glesi (soprattutto D.H.Lawrence e Conrad) con cui condivise, <strong>in</strong><br />
molti casi, le fonti (si analizzeranno i casi di Frazer, Nietzsche e Melville).<br />
L’approfondimento dei legami fra Pavese e certa letteratura <strong>in</strong>glese fornisce dunque la base di<br />
un’analisi comparativa che rappresenta una nuova proposta nell’ambito degli studi sull’autore.<br />
La configurazione dello spazio e del tempo, la concezione mitologica e il pensiero tragico, i<br />
temi del viaggio, dell’<strong>in</strong>contro con l’altro, del nudismo e dei sacrifici umani assumono nuove<br />
connotazioni se studiati <strong>in</strong> relazione ai fermenti culturali cui Pavese fece costante riferimento.<br />
1
Indice<br />
Introduzione e Metodologia p. 3<br />
1 Il Modernismo: la storia e la critica p. 13<br />
2 L’età del “Neomitologismo”<br />
2.1 Un’era mitologica p. 31<br />
2.2 Tempi della modernità p. 56<br />
2.3 Spazi della modernità p. 72<br />
3 Temi modernisti <strong>in</strong> Pavese e Lawrence: il viaggio e l’<strong>in</strong>contro con l’altro<br />
3.1 Il viaggio come momento topico della letteratura modernista p. 83<br />
3.2 L’<strong>in</strong>contro con l’altro: il primitivismo modernista p. 112<br />
3.3 Nudismo e sacrifici umani p. 128<br />
3.4 It<strong>in</strong>erari critici tra America e Europa:<br />
Pavese e Lawrence leggono Melville p. 153<br />
3.5 Pavese: la modernità e la possibilità del tragico p. 166<br />
Bibliografia p. 182<br />
2
Introduzione e Metodologia<br />
L’obiettivo di questo lavoro è, primariamente, quello di allargare il campo d’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e degli<br />
studi tematici pavesiani proponendo il confronto con l’uni<strong>vers</strong>o letterario del modernismo<br />
<strong>in</strong>glese. Un approfondimento della poetica dell’autore porta, <strong>in</strong> primo luogo, a riconoscerne<br />
l’assoluta orig<strong>in</strong>alità; nondimeno si vuole mettere <strong>in</strong> evidenza come tale poetica si sia costruita<br />
nel tempo attra<strong>vers</strong>o una sovrapposizione di materiali di di<strong>vers</strong>a orig<strong>in</strong>e. Se la costruzione è<br />
del tutto orig<strong>in</strong>ale, sarà uno sforzo proficuo quello di riconoscere la provenienza di alcuni dei<br />
materiali utilizzati da Pavese. Lo scopo di questo studio non è quello di cercare di <strong>in</strong>serire<br />
Pavese all’<strong>in</strong>terno di un “ismo” letterario, ma è quello di voler considerare la posizione dello<br />
scrittore all’<strong>in</strong>terno del panorama culturale della prima metà del novecento italiano, alla luce di<br />
quelli che furono i suoi rapporti con il modernismo <strong>in</strong>glese. In questo senso lo studio assume<br />
un carattere storico volendo tracciare delle l<strong>in</strong>ee, stabilire delle connessioni, <strong>in</strong>dividuare delle<br />
parentele anche attra<strong>vers</strong>o l’esposizione dei contrasti.<br />
Il modernismo <strong>in</strong>glese è un fenomeno complesso, difficilmente collocabile. Si parlerà,<br />
<strong>in</strong>somma, più volentieri di scrittori modernisti, come gruppo di <strong>in</strong>tellettuali che condivisero<br />
sensibilità e idee, che di modernismo, come movimento letterario conforme a generi e statuti.<br />
L’approccio tematico-comparatistico sarà utile, <strong>in</strong> questo caso, a verificare l’attendibilità delle<br />
categorie di modernità e di modernismo.<br />
Nella sua attività di divulgatore di cultura per la E<strong>in</strong>audi, Pavese si trovò a stretto contatto con<br />
gli scrittori orbitanti <strong>in</strong> area modernista, affidò traduzioni e tradusse egli stesso alcune opere,<br />
compilò saggi e scrisse note importanti sul suo diario. Le relazioni di Pavese con la letteratura<br />
d’oltremanica, così ampiamente documentate, rappresentano l’occasione di un impresc<strong>in</strong>dibile<br />
confronto. La posizione di Pavese, nell’ambito della cultura europea, sarà sicuramente resa più<br />
chiara nel momento <strong>in</strong> cui sarà rilevata l’entità del suo rapporto con la letteratura modernista<br />
<strong>in</strong>glese. Tale rapporto implicherà <strong>in</strong>fluenze e posizioni contrastanti, accettazioni e rifiuti,<br />
comunanza di visioni e disaccordi. Ciò che mi è sembrato andasse tutelato è l’<strong>in</strong>dipendenza di<br />
uno scrittore come Pavese che mal si concilia con qualsiasi movimento codificato e<br />
aprioristicamente regolato. Piuttosto un <strong>in</strong>tellettuale libero e curioso che, proprio per questa<br />
sua libertà e curiosità, seppe allacciare contatti col mondo della cultura europea ufficialmente<br />
esclusa dall’Italia fascista. La posizione di Pavese cont<strong>in</strong>ua ad apparire, anche alla f<strong>in</strong>e delle<br />
ricerche, contraddist<strong>in</strong>ta più dall’autonomia che dall’affiliazione. Quello che è importante<br />
sottol<strong>in</strong>eare è, <strong>in</strong> tutti i casi, la pregnanza dell’accostamento, il riconoscimento dell’effettiva<br />
possibilità di “portare Pavese fuori dalle Langhe” ed <strong>in</strong>serirlo <strong>in</strong> un più vasto contesto europeo.<br />
L’approfondimento dei legami fra Pavese e certa letteratura <strong>in</strong>glese fornisce la base di<br />
un’analisi comparativa che rappresenta una nuova proposta nell’ambito degli studi sull’autore:<br />
studiare Pavese <strong>in</strong> relazione ai fermenti culturali europei dell’epoca può gettare nuova luce su<br />
alcuni dei temi che costituirono il materiale della sua scrittura.<br />
La prima necessità, a cui si è voluto far fronte, è stata quella di disegnare le corrette coord<strong>in</strong>ate<br />
storiche che permettessero, e giustificassero, la possibilità di una comparazione letteraria. Il<br />
modernismo è stato un movimento vario e complesso che si è sviluppato lungo direttrici<br />
storiche ben <strong>def</strong><strong>in</strong>ibili. Scrivere sul modernismo non è stato dunque solo un problema di critica<br />
letteraria. Essendo un fenomeno molto legato alle evoluzioni della società e della politica, si è<br />
resa subito necessaria la <strong>def</strong><strong>in</strong>izione di una base storica da cui far partire le <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>i<br />
successive. Allo stesso modo si è dovuto sottol<strong>in</strong>eare come la storia dell’Italia sia stata<br />
sostanzialmente differente da quella del resto d’Europa. Non si vorrà postulare la<br />
contemporaneità di Pavese agli scrittori del modernismo trattatati, o la sua affiliazione presso<br />
movimenti artistici a lui relativamente coevi. La prospettiva storica mi è sembrata comunque<br />
rilevante nel momento <strong>in</strong> cui si sono voluti <strong>in</strong>dividuare temi che si sono riproposti, con lo<br />
scarto di alcune decadi, sia <strong>in</strong> Inghilterra sia <strong>in</strong> Italia. Anche <strong>in</strong> questo caso si metteranno <strong>in</strong><br />
rilievo non solo le comunanze ma anche le differenze proprio perché non si vuole perdere di<br />
3
vista il contesto storico-sociale <strong>in</strong> cui i lavori di Pavese furono prodotti. La constatazione che<br />
l’evoluzione dei paesi europei di f<strong>in</strong>e Ottocento-prima metà del Novecento si sia mossa nella<br />
medesima direzione, ma con tempistiche e modalità differenti, è basilare. Secondo Mart<strong>in</strong><br />
Tra<strong>vers</strong> 1 il modernismo letterario si sarebbe configurato <strong>in</strong> primo luogo come risposta ad un<br />
disagio sociale e culturale derivato da d<strong>in</strong>amiche storiche che trovarono la loro prima<br />
espressione <strong>in</strong> Inghilterra per poi propagarsi a tutto il resto dell’Europa. Il riferimento al<br />
fascismo, come movimento nazionalista, si <strong>in</strong>quadra <strong>in</strong> questa ottica e spiega <strong>in</strong> parte la<br />
chiusura del nostro paese a livello economico, sociale, culturale. Il fascismo viene dunque<br />
osservato nelle sue componenti conservatrici più che rivoluzionarie e nel suo tentativo di voler<br />
<strong>def</strong><strong>in</strong>ire un modello nazionale, sociale e culturale, che preservasse la propria autonomia nei<br />
confronti dell’evoluzione europea. Come vedremo, la barriera eretta dal regime non fu<br />
impermeabile ma ebbe solo l’effetto di ritardare il propagarsi della modernità nel nostro paese.<br />
E’ dunque ipotizzabile che l’evoluzione sociale, che caratterizzò l’Inghilterra di f<strong>in</strong>e Ottocento<br />
ed <strong>in</strong>izio Novecento, si ripropose, con differenti modalità, nell’Italia della formazione<br />
pavesiana. La critica anglosassone ha stabilito che la poetica degli scrittori modernisti nacque<br />
da un senso di sradicamento nei confronti di un mondo mutato dalla modernità e sentito<br />
improvvisamente lontano. L’imporsi del sistema <strong>in</strong>dustriale, l’urbanizzazione, la<br />
massificazione sono fenomeni che avvengono <strong>in</strong> Inghilterra una generazione prima, forse due,<br />
rispetto all’Italia. Gli <strong>in</strong>tellettuali italiani, con alcune decadi di ritardo, risentirono delle stesse<br />
crisi di cui si fecero portatori i loro colleghi europei che divennero, di conseguenza, i loro<br />
precursori e, <strong>in</strong> molti casi, i loro ispiratori. Quanto di orig<strong>in</strong>ale ci fu <strong>in</strong> un ipotetico<br />
modernismo italiano e quanto di “ispirato” è da rimandare a successivi approfondimenti ma è<br />
<strong>in</strong>dubbio che questi fattori ebbero una certa rilevanza. Gli scrittori italiani recepirono la crisi<br />
della modernità con alcuni anni di ritardo rispetto agli <strong>in</strong>glesi ma i processi che si <strong>in</strong>nescarono<br />
furono di simile portata.<br />
Questa <strong>in</strong>terpretazione storica fornisce una chiave di lettura che nello studio è approfondita ma<br />
che non può, proprio per il suo carattere ipotetico, esaurire il discorso. Ciò che appare più<br />
verificabile, ed è la direzione <strong>in</strong> cui questo studio si muove prevalentemente, è la presenza di<br />
alcuni temi che gli scrittori italiani ebbero <strong>in</strong> comune con gli scrittori <strong>in</strong>glesi. In questo caso lo<br />
studio di Cesare Pavese è molto facilitato da di<strong>vers</strong>i fattori. Pavese scrisse una mole<br />
impressionante di appunti riguardanti personali riflessioni su questioni di poetica propria ed<br />
altrui, impressioni ricavate dalla lettura di scrittori stranieri, esplicite dichiarazioni relative a<br />
veri e propri <strong>in</strong>flussi che dichiarò di aver ricevuto da scrittori come Lawrence. Il lavoro di<br />
traduttore e saggista, che Pavese svolgeva presso la E<strong>in</strong>audi offre ulteriori possibilità di<br />
approfondimento. Come ha sottol<strong>in</strong>eato Maria Stella 2 , il lavoro che lo scrittore espletava<br />
presso la E<strong>in</strong>audi aveva la funzione primaria di porlo <strong>in</strong> contatto con nuove opere che potevano<br />
così essere studiate nei loro meccanismi narrativi più reconditi. Attra<strong>vers</strong>o le traduzioni e i<br />
saggi <strong>in</strong>troduttivi alle opere, Pavese approfondì gli studi di letteratura perfezionando la sua<br />
poetica.<br />
Questo lavoro non fu comunque agevole. E proprio questo suo non essere agevole rappresenta<br />
un altro punto di enorme <strong>in</strong>teresse per la formazione <strong>in</strong>tellettuale di Pavese, che <strong>in</strong> questo<br />
studio trova un circoscritto approfondimento. Cercare di stabilire un contatto con l’estero nel<br />
momento <strong>in</strong> cui il regime fascista imponeva il suo programma di nazionalizzazione della<br />
letteratura espose Pavese a costanti pericoli. La politica fascista dell’”asservire e reprimere”<br />
lasciava giusto lo spazio di trattare quei pochi autori che non avevano un immediato impatto<br />
politico. Tradurre un romanzo straniero significava dover attra<strong>vers</strong>are <strong>in</strong>denni le fitte maglie<br />
della censura. Per questo motivo l’opposizione di Pavese fu soprattutto “estetica”. Il regime<br />
fascista aveva <strong>in</strong>fatti nel progetto di nazionalizzazione della cultura l’asservimento delle<br />
1<br />
Mart<strong>in</strong> Tra<strong>vers</strong>, An <strong>in</strong>troduction to modern European Literature-from Romanticism to Postmodernism,<br />
Macmillan Press LTD, London, 1998.<br />
2<br />
Maria Stella, Cesare Pavese traduttore, Bulzoni Editore, Roma, 1977.<br />
4
categorie estetiche ai propri f<strong>in</strong>i e benefici. L’operato di Pavese si strutturò come il pr<strong>in</strong>cipio di<br />
un sovvertimento culturale che non sarebbe passato <strong>in</strong>osservato al regime.<br />
Ma non furono solamente i problemi politici a rendere difficile la fruizione della letteratura<br />
straniera <strong>in</strong> Italia. La critica di stampo crociano fu <strong>in</strong>fatti un altro <strong>in</strong>tralcio, così come ha<br />
osservato Mario Praz, al diffondersi di questo tipo di tematiche. Il tipo di estetica prodotta dal<br />
modernismo, così legata all’extratesto (composto di tutti gli elementi della cultura letteraria<br />
scientifica filosofica storica etc. e di tutti quelli relativi al sociale e al politico), doveva essere<br />
necessariamente av<strong>vers</strong>ata da Croce che applicava modelli di giudizio differenti considerandoli<br />
esclusivi e non affiancabili ad analisi di altro genere.<br />
Il caso di Pavese mi è sembrato particolarmente adatto ad un tipo di analisi di questo tipo <strong>in</strong><br />
quanto egli stesso documenta ogni s<strong>in</strong>golo passaggio della sua formazione <strong>in</strong>tellettuale. Sarà<br />
così utile mettere <strong>in</strong> risalto come non solo Pavese manifesti una predilezione per gli scrittori<br />
modernisti <strong>in</strong>glesi ma ne condivida addirittura le fonti.<br />
Nel primo capitolo si vuole fornire lo studio di un’<strong>in</strong>troduzione storica. L’Europa, tra la<br />
seconda metà dell’Ottocento e la prima del Novecento, subì una serie di trasformazioni<br />
capitali. Gli anni <strong>in</strong> questione sono senz’altro da considerarsi <strong>in</strong>dicativi. Non sarebbe possibile<br />
stabilire date precise per cambiamenti strutturali che <strong>in</strong>vestirono non una sola regione o paese<br />
ma l’<strong>in</strong>tera Europa. Ciò nonostante, come vedremo, sia gli studiosi sia gli stessi scrittori<br />
cercarono di essere abbastanza circostanziati nelle loro analisi quasi che l’evoluzione moderna<br />
avvenisse tanto velocemente da poter essere riconosciuta ad occhio nudo nelle sue<br />
manifestazioni pr<strong>in</strong>cipali. La perentoria affermazione di Lawrence nell’<strong>in</strong>troduzione a<br />
Kangaroo del 1923 è esemplificativa della percezione che gli <strong>in</strong>tellettuali potevano avere dei<br />
cambiamenti <strong>in</strong> atto <strong>in</strong>dipendentemente dalle cont<strong>in</strong>genze belliche: “It was <strong>in</strong> 1915 the old<br />
world ended”. Modelli economici e di produzione, modelli politici e sociali trovarono, <strong>in</strong><br />
questa epoca, improvvise quanto visibili evoluzioni che provocarono non pochi disagi nelle<br />
persone appartenenti alle classi meno abbienti (la maggior parte della popolazione) e fra gli<br />
<strong>in</strong>tellettuali borghesi. La crisi, relativa a questa emergenza sociale e politica, trovò nella<br />
speculazione <strong>in</strong>tellettuale una voce autorevole. Questo modello sociale, basato<br />
sull’appiattimento dell’<strong>in</strong>dividualità <strong>in</strong> un’entità lavoratrice e giustificato dalla propaganda di<br />
una morale borghese di ispirazione cristiana, è contam<strong>in</strong>ato, per Nietzsche, dal germe del<br />
nichilismo che ne segna il dest<strong>in</strong>o di progressiva decadenza. Nietzsche scaglierà i suoi dardi<br />
contro la religione, colpevole di <strong>in</strong>culcare il concetto di ubbidienza e di sottomissione, contro<br />
la morale, pianificata dal calcolo della borghesia materialistica ed ipocrita, contro l’etica, rea di<br />
giustificare un’esistenza basata sullo sfruttamento del lavoro umano, contro la politica, <strong>in</strong><br />
grado di donare unità ad elementi eterogenei attra<strong>vers</strong>o il concetto artificiale di Stato. Altri<br />
filosofi e scienziati si cimentarono, <strong>in</strong> questo periodo, nella critica della civiltà contemporanea.<br />
Per Karl Marx, come è noto, la crisi era dovuta ad un sistema economico dom<strong>in</strong>ato dalle classi<br />
borghesi e, proprio attra<strong>vers</strong>o la rivoluzione del sistema di produzione, l’uomo sarebbe potuto<br />
tornare ad un esistenza pacifica e serena. Il ruolo di Freud fu <strong>in</strong>vece quello di rilevare lo stato<br />
di crisi all’<strong>in</strong>terno dell’<strong>in</strong>dividuo. In tutti e tre i casi le soluzioni proposte alla crisi non<br />
trovarono alcuno sbocco pratico.<br />
Def<strong>in</strong>ire il concetto di modernità non è certo operazione agevole. Nell’ambito di questo studio<br />
ci si è voluti soffermare sul cambiamento nella concezione del tempo e dello spazio che tale<br />
modernità portò. Insomma si cerca, <strong>in</strong> questo caso, di <strong>def</strong><strong>in</strong>ire la modernità attra<strong>vers</strong>o gli effetti<br />
che essa ebbe sulla produzione letteraria. Nel suo saggio sulla categoria dello spazio, che<br />
andava riconfigurandosi all’<strong>in</strong>izio del XX° secolo, Eugenio Turri parla di “natura rifatta” 3<br />
mentre Vittoria Borsò, <strong>in</strong> un <strong>in</strong>tervento sulla riformulazione della categoria di tempo <strong>in</strong> epoca<br />
3 Eugenio Turri, Lo spazio europeo: alla ricerca di una geografia mitica, contenuto <strong>in</strong> Carlo Ossola, Europa:<br />
miti di identità, Saggi Marsilio, Venezia, 2001, p. 28.<br />
5
moderna, parla di “rottura totale con la natura” 4 . La modernità sembra configurarsi come<br />
rigetto del vecchio e promozione del nuovo sostenuto dal concetto capitalista di progresso.<br />
L’immag<strong>in</strong>e di questo mondo “costruito” si rende immediatamente distante nello spazio e nel<br />
tempo. Si crea un divario fra quella che era sentita come la vera natura dell’uomo e che si<br />
esprimeva nelle culture rurali (vedremo come uno degli sviluppi più <strong>in</strong>teressanti del Ramo<br />
d’oro di Frazer sarà proprio quello di stabilire una connessione fra le culture rurali europee e<br />
quelle primitive) e il mondo artificiale moderno. La percezione di questa distanza, che si<br />
<strong>in</strong>terpone fra l’uomo moderno e la natura, si esprime a livello spaziale tramite le scritture di<br />
viaggio, a livello temporale con il ricorso a poetiche della memoria e del ricordo. E’ una<br />
distanza disegnata narrativamente attra<strong>vers</strong>o la descrizione di spazi lontani, semanticamente<br />
non correlabili agli spazi artificiali della modernità. A differenza dei molti resoconti di viaggio,<br />
che andavano di moda all’epoca e che cercavano di rendere immediatamente fruibile e<br />
comprensibile il lontano e l’esotico agli uom<strong>in</strong>i occidentali, questo tipo di letteratura tende a<br />
fare della distanza una categoria portante di tutta la narrazione. La distanza non va ridotta ma<br />
approfondita. La crisi dell’uomo moderno, la visione del suo peccato orig<strong>in</strong>ale ha, nella<br />
letteratura modernista, una rappresentazione spaziale e crea, attra<strong>vers</strong>o l’<strong>in</strong>contro con l’altro,<br />
un ulteriore scarto temporale. La distanza dell’uomo primitivo dall’uomo moderno implica una<br />
difficoltà di questo ultimo a rapportarsi alla sua orig<strong>in</strong>e remota e barbarica ora che la sua<br />
essenza è considerata culturale.<br />
La percezione moderna del tempo e dello spazio empirici sancisce la drammatica<br />
<strong>in</strong>adeguatezza del soggetto di fronte allo spazio e al tempo assoluti. Il modernismo, reazione<br />
<strong>in</strong>tellettuale alla decadenza della modernità, fa del mito, spazio assoluto e tempo assoluto, una<br />
delle pr<strong>in</strong>cipali categorie esplicative del reale. La riflessione sulle categorie mitiche fu, fra gli<br />
<strong>in</strong>tellettuali modernisti, <strong>in</strong>tensa e rimise <strong>in</strong> gioco le stesse teorie della conoscenza; il fenomeno<br />
fu talmente vasto e complesso che Jurij Lotman ha <strong>def</strong><strong>in</strong>ito l’età moderna come l’età del<br />
neomitologismo.<br />
Le riflessioni <strong>in</strong>torno al mito furono di fondamentale importanza per gli scrittori modernisti e<br />
rappresentarono, al contempo, oggetto di speculazione assidua per Pavese. Per quanto riguarda<br />
il modernismo, si tenderà a stabilire delle l<strong>in</strong>ee guida su cui l’<strong>in</strong>terpretazione del mito, del rito<br />
e del simbolo si mossero. All’<strong>in</strong>terno del quadro generale così tracciato, si isoleranno le<br />
s<strong>in</strong>gole posizioni di quegli scrittori modernisti, <strong>in</strong> particolar modo Lawrence, che furono più<br />
vic<strong>in</strong>i a Pavese. L’analisi sui testi permetterà successivamente di constatare come la scrittura si<br />
ponga <strong>in</strong> relazione alle dialettiche fra spazio empirico e spazio mitico e fra tempo empirico e<br />
tempo mitico. Il r<strong>in</strong>venimento di uno spazio mitico personale e dei luoghi dell’<strong>in</strong>fanzia, come<br />
nel caso delle Langhe di Pavese o le Midlands di Lawrence, è dunque parte di un più grande<br />
disegno che riguarda il r<strong>in</strong>venimento di uno spazio mitico europeo. In questo senso gli spazi,<br />
contemplati dai di<strong>vers</strong>i autori europei, apparterrebbero ad una comune mitologia che proprio<br />
nella coscienza europea avrebbe le sue basi. Anche i luoghi mitici esterni all’Europa, i luoghi<br />
esotici descritti dal Conrad di Almayer’s folly o Heart of Darkness o dal Lawrence di The<br />
Plumed Serpent o ancora dal primo Pavese de I mari del sud, rientrerebbero di diritto <strong>in</strong><br />
questa categoria dello spazio mitologico occidentale europeo nel momento <strong>in</strong> cui ogni luogo<br />
esotico è descritto attra<strong>vers</strong>o gli occhi di un personaggio occidentale. E non è un caso che le<br />
descrizioni di questi luoghi esotici possano apparire a volte misteriosi ma vagamente familiari<br />
oppure che i personaggi, il Kurtz di Conrad o il cug<strong>in</strong>o di Pavese, li trov<strong>in</strong>o talmente distanti<br />
ed <strong>in</strong>commensurabili da non poter trovare le parole adatte alla descrizione, parole che il nostro<br />
vocabolario occidentale non contiene perché riguardanti lo sconosciuto, l’immemoriale, il<br />
soppresso, il cancellato appunto.<br />
L’ipo<strong>tesi</strong> di questo tipo di studio è quella di approfondire la modernità di Pavese attra<strong>vers</strong>o un<br />
implicito comparativismo. L’approfondimento è improntato a mettere <strong>in</strong> evidenza come<br />
4 Vittoria Borsò, Temporalità e alterità. Il nuovo rapporto tra uomo e natura nella poesia moderna, contenuto <strong>in</strong><br />
D. Conte, E. Mazzarella, Il concetto di tipo tra ottocento e Novecento. Letteratura, filosofia, scienze umane,<br />
Napoli, Liguori, 2001, p. 10.<br />
6
Pavese non solo abbia condiviso questi tratti “modernisti” ma vi si sia rapportato, attra<strong>vers</strong>o la<br />
comunanza delle fonti, e se ne sia avvalso f<strong>in</strong>o ad arrivare a conclusioni funzionali alla sua<br />
scrittura, <strong>in</strong> molti casi simili a quelle dei suoi predecessori. Attra<strong>vers</strong>o questo procedimento si<br />
vorrebbe, <strong>in</strong> primo luogo, dimostrare la “modernità” di Pavese e, <strong>in</strong> secondo luogo, come<br />
questa modernità sia rapportabile, sotto molti aspetti, al fenomeno letterario del modernismo<br />
europeo, ed <strong>in</strong> particolar modo <strong>in</strong>glese, <strong>in</strong>teso come espressione letteraria della modernità. Fra<br />
i cosiddetti “modernisti <strong>in</strong>glesi”, Lawrence e Conrad sembrano quelli che con più facilità<br />
possono essere accostati a Pavese. L’accostamento non è arbitrario ma nasce dalle <strong>in</strong>dicazioni<br />
dello stesso Pavese che cita più volte i due scrittori anglosassoni dichiarandosi, <strong>in</strong> alcuni<br />
momenti, <strong>in</strong>fluenzato dai loro scritti. L’opera di Conrad sarà utilizzata, all’<strong>in</strong>terno di questo<br />
studio, come riferimento costante mentre l’opera di Lawrence sarà oggetto di una<br />
comparazione diretta con il lavoro di Pavese. Questa impostazione deriva da una serie di<br />
considerazioni che prospettano un fruttuoso accostamento tra Lawrence e Pavese. Pavese era<br />
<strong>in</strong>fatti lettore di Lawrence e si impegnò presso l’E<strong>in</strong>audi al f<strong>in</strong>e di promuovere traduzioni delle<br />
sue opere. Alcuni degli scritti di Lawrence furono recepiti attivamente da Pavese così come<br />
egli stesso ci comunica nelle note del suo diario. I motivi pavesiani del nudismo e dei sacrifici<br />
umani trovano, nello scrittore <strong>in</strong>glese, un an<strong>tesi</strong>gnano e un modello. Lawrence fu anche un<br />
uomo di paese, proveniente dalla campagna delle Midlands <strong>in</strong>glesi; egli si impegnò, al pari di<br />
Pavese, <strong>in</strong> un <strong>in</strong>cessante confronto <strong>in</strong>tellettuale tra la dimensione “civile” cittad<strong>in</strong>a e quella<br />
rurale “bestiale”. Anche <strong>in</strong> questo contesto le similarità fra i due, imprigionati <strong>in</strong> una<br />
dimensione “di mezzo”, appaiono evidenti: il “classicismo rustico”, teorizzato da Pavese, non<br />
sembra molto distante dalla mitologia campagnola di Lawrence.<br />
E’ dunque importante sottol<strong>in</strong>eare come questi accostamenti, che mirano ad arricchire gli studi<br />
sulla poetica di Pavese, non siano arbitrari ma giustificati, se non esplicitamente suggeriti,<br />
dallo stesso autore. La possibilità di accostare l’opera di Pavese a quella di grandi scrittori del<br />
modernismo <strong>in</strong>glese rappresenta senza dubbio un tratto caratteristico della modernità dello<br />
scrittore. Modernità che lo scrittore sempre rivendicò per sé <strong>in</strong> virtù della grande attenzione<br />
che sempre dimostrò nei confronti della letteratura europea e mondiale. Pavese, traduttore di<br />
professione, fu estremamente consapevole dei fenomeni culturali a lui contemporanei e non<br />
les<strong>in</strong>ò appunti e considerazioni sull’argomento, specialmente nel suo diario Il Mestiere di<br />
Vivere. La capacità di Pavese di far scorrere parallela alla sua produzione poetica un’attenta<br />
riflessione su quelli che erano i compiti e gli impegni di un <strong>in</strong>tellettuale moderno a diretto<br />
contatto con le istanze culturali dell’epoca, rappresenta un elemento di impresc<strong>in</strong>dibile<br />
importanza per comprendere al meglio il suo “mestiere di scrittore”. Denis Ferraris 5 <strong>in</strong>dividua<br />
nella caratteristica di portare avanti contemporaneamente la scrittura e la riflessione sulla<br />
scrittura il primo dei c<strong>in</strong>que criteri che <strong>def</strong><strong>in</strong>iscono la modernità dello scrittore. E’ una<br />
modernità che si può riscontrare dunque a più livelli. A fianco di una modernità storica, che si<br />
confronta con i fenomeni del fascismo, della rivoluzione <strong>in</strong>dustriale e dell’urbanizzazione, si<br />
dovrà riscontrare e <strong>def</strong><strong>in</strong>ire la presenza di una modernità culturale, al f<strong>in</strong>e di studiare le<br />
relazioni tra Pavese e tale modernità. Il saggio di Ferraris si pone come obiettivo quello di<br />
stabilire dei criteri per la <strong>def</strong><strong>in</strong>izione di una modernità pavesiana. Pavese rivendicò, nell’<strong>in</strong>tero<br />
svolgersi della sua carriera di <strong>in</strong>tellettuale, la sua appartenenza ad una modernità europea.<br />
Soprattutto attra<strong>vers</strong>o gli appunti sul diario e i saggi letterari, Pavese tentò da un lato di<br />
<strong>def</strong><strong>in</strong>ire il significato di modernità, dall’altro di rivendicare la propria appartenenza a tale<br />
modernità. La sua formazione classica fu scientemente messa al servizio delle esigenze del<br />
moderno. Trovare un equilibrio fra il classico e il moderno, sottol<strong>in</strong>ea Ferraris, rappresentò<br />
quasi un’ossessione per lo scrittore e ne direzionò tutta la produzione: “L’esigenza di<br />
modernità lo costr<strong>in</strong>se, nel breve giro della sua carriera artistica, a tentare di non abbandonare<br />
mai recisamente i materiali teorici o tecnici acquisiti con pazienza e rigore e, nello stesso<br />
5 Denis Ferraris, Lo “sguardo alla f<strong>in</strong>estra” e il “laborioso caos”: sulla modernità narrativa di Cesare Pavese,<br />
<strong>in</strong> Centre de recherches italiennes, Narrativa, a cura di Marie-Helene Caspar, Uni<strong>vers</strong>itè Paris X – Nanterre, n°<br />
22, Janvier 2002.<br />
7
tempo, a ri<strong>def</strong><strong>in</strong>irli <strong>in</strong> stretta dipendenza delle nuove condizioni imposte dai tempi, a ricercare<br />
cioè con costanza un equilibrio tra l’uni<strong>vers</strong>ale imperituro e il s<strong>in</strong>golare transeunte” 6 . La<br />
costruzione di personaggi assoluti che agiscono all’<strong>in</strong>terno di vicende esemplari, ovvero la<br />
trasposizione dell’uni<strong>vers</strong>ale all’<strong>in</strong>terno del s<strong>in</strong>golare, rappresenta un tratto prioritario della<br />
modernità di Pavese che lo accosta a molti narratori modernisti. E’ personaggio, Pavese<br />
escluderà volontariamente ogni implicazione psicologica, costruito come essenza statica che<br />
pone il suo essere di fronte alle sollecitazioni del mondo moderno. Le risposte a queste<br />
sollecitazioni non si del<strong>in</strong>eano come successivi stadi di un percorso di crescita del personaggio<br />
ma rappresentano le tappe di un progressivo r<strong>in</strong>venimento all’essere obliato. L’operazione<br />
svolta da Pavese si connette al recupero di una dimensione mitica <strong>in</strong> cui il personaggio svolge<br />
una funzione simbolica: “L’arte del XIX sec. s’<strong>in</strong>centra sullo sviluppo delle situazioni<br />
(Bildungsroman, cicli storici, carriere ecc.); l’arte del XX sulle essenza statiche. L’eroe al<br />
pr<strong>in</strong>cipio era di<strong>vers</strong>o che alla f<strong>in</strong>e della storia; ora è sempre uguale” 7 .<br />
La creazione di personaggi assoluti si configura dunque come il primo passo <strong>vers</strong>o<br />
l’edificazione di una concezione mitica che regola i significati di un uni<strong>vers</strong>o simbolico. E’ <strong>in</strong><br />
questo uni<strong>vers</strong>o mitico-simbolico che prende forma la poetica dell’immag<strong>in</strong>e. Pavese fu più<br />
volte portato a rivedere la sua <strong>in</strong>iziale <strong>def</strong><strong>in</strong>izione di “immag<strong>in</strong>e-racconto” ma, anche se<br />
gradualmente vorrà dim<strong>in</strong>uire la centralità di questo concetto nell’ambito dei suoi progetti<br />
narrativi, non abbandonerà mai completamente i suoi assunti di base. Istanza tipicamente<br />
moderna è quella di dare importanza ad altri elementi della narrazione che non siano il punto<br />
di vista del personaggio che osserva e getta il suo occhio critico sul reale. Le poetiche<br />
moderniste dell’immag<strong>in</strong>e assegnano una nuova importanza al mondo che circonda il soggetto<br />
narrante. Le immag<strong>in</strong>i, di cui il mondo si compone, vengono dotate di una voce che si affianca,<br />
a volte sovrapponendosi, a quella del personaggio razioc<strong>in</strong>ante. Se l’ironia e l’autoironia<br />
divengono una caratteristica del personaggio novecentesco, che vede la sua autorità e la sua<br />
credibilità messe <strong>in</strong> discussione, così non potrà accadere con le immag<strong>in</strong>i che godono <strong>in</strong>vece di<br />
un’autonomia e di un’autorevolezza che le sottraggono alle mutevoli logiche culturali: “Le<br />
sole realtà che godano di un discreto privilegio espressivo parzialmente privo di ironia sono<br />
quelle immemoriali legate all’immag<strong>in</strong>ario elementare e alla mitologia personale dell’autore:<br />
aria, acqua, sole, terra, coll<strong>in</strong>a, corpo della donna e sangue” 8 . Vedremo <strong>in</strong> seguito come queste<br />
immag<strong>in</strong>i, a cui viene data nuova e autorevole voce, si <strong>in</strong>quadr<strong>in</strong>o nell’uni<strong>vers</strong>o miticosimbolico<br />
di Pavese rappresentando un nuovo punto di contatto con il modernismo <strong>in</strong>glese e,<br />
<strong>in</strong> particolar modo, con Lawrence. Il libero gioco delle immag<strong>in</strong>i sembra <strong>in</strong>serirsi<br />
perfettamente all’<strong>in</strong>terno di quella che Ferraris <strong>def</strong><strong>in</strong>isce “una rete simbolica” <strong>in</strong> grado di<br />
gettare “elementi di verità sull’uni<strong>vers</strong>ale umano” 9 . Le immag<strong>in</strong>i si caricano di significati<br />
simbolici e si <strong>in</strong>quadrano all’<strong>in</strong>terno di un grande disegno mitico. Analizzando il tema del<br />
nudismo, presente sia <strong>in</strong> Lawrence che <strong>in</strong> Pavese, si potrà notare quanto queste immag<strong>in</strong>i siano<br />
legate le une alle altre <strong>in</strong> una fitta rete simbolica. I quattro elementi (acqua, terra, aria, fuoco),<br />
si <strong>in</strong>nestano all’<strong>in</strong>terno di una geografia mitica (le coll<strong>in</strong>e, i corsi d’acqua, il mare) <strong>in</strong> cui<br />
alternano la loro presenza i totem primordiali (alberi, animali) e <strong>in</strong> cui gli astri svolgono una<br />
funzione attiva (sole, luna, stelle), così come lo scorrere delle stagioni e l’alternarsi delle albe e<br />
dei crepuscoli 10 . Il corpo nudo dei personaggi si <strong>in</strong>serisce <strong>in</strong> questo contesto subendo delle<br />
6<br />
Ivi, p. 121.<br />
7<br />
Cesare Pavese, Il Mestiere di Vivere, Diario 1935-1950, 21 Dicembre 1948, E<strong>in</strong>audi, Tor<strong>in</strong>o, 2000, p. 359.<br />
8<br />
D. Ferraris, Lo “sguardo alla f<strong>in</strong>estra” e il “laborioso caos”: sulla modernità narrativa di Cesare Pavese, cit.<br />
p. 124.<br />
9<br />
Ivi, p. 127.<br />
10<br />
Il “naturalismo estetico” qui espresso è senz’altro derivato da Nietzsche. Zarathustra è un viaggiatore che<br />
ritorna <strong>vers</strong>o zone <strong>in</strong>contam<strong>in</strong>ate dell’esistente dove si consuma l’ultimo scontro fra la coscienza civile<br />
dell’uomo moderno e i suoi ist<strong>in</strong>ti che trovano nella figura del selvaggio dionisiaco una perfetta <strong>in</strong>carnazione.<br />
Lo svolgersi delle stagioni rimanda, metaforicamente, alla concezione del tempo mitico e alla legge dell’eterno<br />
ritorno. Il ritorno ad una dimensione naturalistica simboleggia, al contempo, il ritorno ad una di<strong>vers</strong>a<br />
comprensione del tempo. Le stagioni si ripetono e così come i miti ripropongono le loro leggi eternamente.<br />
8
trasformazioni che sembrano atte a favorirne l’<strong>in</strong>corporazione da parte dell’elemento naturale.<br />
Dopo queste considerazioni si dovrà constatare come una delle pr<strong>in</strong>cipali implicazioni della<br />
scrittura di Pavese sia quella ontologica, implicazione che si configura, così come sottol<strong>in</strong>ea<br />
ancora Ferraris, come un ulteriore criterio di modernità. La <strong>def</strong><strong>in</strong>izione di un’ “essenza<br />
dell’essere umano afferrato nella sua uni<strong>vers</strong>alità” 11 appare come uno dei compiti che si<br />
prefigge Pavese nel momento della composizione delle sue narrazioni. E’ un punto ricco di<br />
implicazioni. La modernità di Pavese è difatti ribadita nel momento <strong>in</strong> cui si r<strong>in</strong>traccia la<br />
prossimità dei suoi scritti alla filosofia, soprattutto di matrice tedesca, che si occupò di<br />
ri<strong>def</strong><strong>in</strong>ire una dimensione esatta dell’uomo dopo l’artificializzazione della conoscenza operata<br />
da Kant a ridosso dell’Illum<strong>in</strong>ismo. In questo contesto l’opera di Pavese si <strong>in</strong>serisce <strong>in</strong> un<br />
nuovo filone che comprende quegli scrittori che si possono rapportare alla filosofia di<br />
Nietzsche, citato spesso da Pavese nei suoi saggi teorici, e di Heidegger, citato nel saggio di<br />
Ferraris e contemporaneo a Pavese. Per John Burt Foster Jr. 12 , l'analisi comparativa è la<br />
migliore via per comprendere il fermento culturale della prima metà del Novecento, proprio<br />
perchè Nietzsche rappresenta quasi sempre un'<strong>in</strong>fluenza più che uno studio sistematico<br />
<strong>in</strong>trapreso dagli scrittori di questo periodo. Gli studi culturali <strong>in</strong>crociati permettono notevoli<br />
progressi da questo punto di vista <strong>in</strong> quanto la letteratura si <strong>in</strong>serisce appieno tra la storia delle<br />
idee, la storia della filosofia e la storia <strong>in</strong>tellettuale. Se Lawrence punterà risoluto alla<br />
riscoperta di forze primordiali ed ist<strong>in</strong>tuali <strong>in</strong>dicate da Nietzsche, i personaggi pavesiani<br />
vacilleranno sempre sul conf<strong>in</strong>e che separa Apollo da Dioniso. Anche se Lawrence <strong>in</strong>dica nel<br />
ritorno ad un primitivismo dionisiaco la via per il superamento del nichilismo, è da sottol<strong>in</strong>eare<br />
come la vena del modernismo fu più tragica che utopica ed è questo l'aspetto che prevale<br />
nell’opera Pavese. La riscoperta di una dimensione tragica dell’esistente avviene attra<strong>vers</strong>o il<br />
recupero dell’irrazionale che rappresentò un’altra caratteristica della modernità pavesiana,<br />
come sottol<strong>in</strong>ea Gioanola:<br />
E’ vero che Pavese appare dom<strong>in</strong>ato dalle esigenze di razionalizzazione, e questo è certo un debito nei confronti<br />
del suo ambiente di formazione, ma si tratta pur sempre di un razionalizzare all’<strong>in</strong>terno dell’irrazionale, un portare<br />
alla consapevolezza che non esaurisce le risorse <strong>in</strong>f<strong>in</strong>ite dell’Altro (è il problema del classicismo di Pavese, che<br />
trova un modello eccellente <strong>in</strong> Thomas Mann, un decadente classicista per <strong>def</strong><strong>in</strong>izione). Che lo si voglia o meno<br />
Pavese s’<strong>in</strong>serisce a pieno diritto su quella l<strong>in</strong>ea irrazionalistica che troppa cultura nostrana, per troppo tempo, ha<br />
Nietzsche celebra la teoria dell’eterno ritorno come affermazione di vita. Il mito dell’eterno ritorno è, qu<strong>in</strong>di, il<br />
mito dei miti, <strong>in</strong> quando comprende nella sua legge, le condizioni di esistenza di qualsiasi mitologia. Il tema dei<br />
ritorni, del dest<strong>in</strong>o e delle stagioni umane e terrestri trovarono nel selvaggio dionisiaco il miglior araldo.<br />
All’<strong>in</strong>terno di questo naturalismo estetico è da sottol<strong>in</strong>eare un fenomeno, <strong>in</strong> questo studio appena accennato, che<br />
si potrà riscontrare <strong>in</strong> molta produzione modernista. Insieme a Frazer, Nietzsche fornì gli scrittori modernisti di<br />
una serie di immag<strong>in</strong>i simboliche che trovarono puntualmente spazio nelle pag<strong>in</strong>e delle loro composizioni. John<br />
Burt Foster Jr. discute del potere simbolico delle immag<strong>in</strong>i utilizzate da Nietzsche e della valenza delle<br />
metafore. Alcuni elementi furono ampliamente riutilizzati dagli scrittori modernisti. Le ambientazioni naturali<br />
sono tipiche della scrittura niciana. In questi paesaggi ogni elemento naturale si carica di una forte carica<br />
simbolica. Zarathustra deve scalare i monti, allontanandosi dalla civiltà, per acquisire sapienza. Il suo tornare al<br />
mondo degli uom<strong>in</strong>i implica un movimento di discesa dopo che il percorso di ascesa era stato ultimato. Anche le<br />
stagioni con i loro corsi sono spesso presenti nelle pag<strong>in</strong>e del filosofo così come la simbologia legata all’alba e<br />
ai tramonti. Luna, sole e stelle sono altresì importanti nell’ambito della <strong>def</strong><strong>in</strong>izione di una simbologia<br />
cosmologica. Tra gli elementi naturali particolare importanza riveste l’albero con le sue radici che affondano nel<br />
terreno. Per Foster è questo un simbolo dell’impossibilità, per qualsiasi essere vivente, di negare la propria<br />
appartenenza alla terra: “a picture that suggests the naturalistic imperative of rema<strong>in</strong><strong>in</strong>g true to the earth” (John<br />
Burt Foster Jr., Heir to Dionysus, a Nietzschian <strong>in</strong> Literary Modernism, Pr<strong>in</strong>ceton Uni<strong>vers</strong>ity Press, 1988, p.<br />
133). Allo stesso modo la fontana si pone come uno dei simboli prediletti da Nietzsche per il suo flusso di<br />
energia, la sua orig<strong>in</strong>e misteriosa sotterranea e il suo ri<strong>vers</strong>arsi <strong>in</strong> un tutto naturale. I personaggi di molti<br />
romanzi modernisti si troveranno spesso ad agire <strong>in</strong> un uni<strong>vers</strong>o simbolico che aveva avuto <strong>in</strong> Nietzsche un<br />
primo osservatore e teorizzatore.<br />
11 Ivi, p. 129.<br />
12 John Burt Foster Jr., Heir to Dionysus, a Nietzschian <strong>in</strong> Literary Modernism, Pr<strong>in</strong>ceton Uni<strong>vers</strong>ity Press, 1988.<br />
9
considerato come la causa di tutti i mali, isolandola come una malattia romantica da superare al più presto: ma<br />
Pavese era troppo dentro al problema per non sapere che proprio sull’irrazionale si giocava la sua modernità di<br />
scrittore 13 .<br />
Nella narrativa di Pavese questa riscoperta avviene tramite una forma oppositiva b<strong>in</strong>aria che<br />
trae le sue orig<strong>in</strong>i dalle teorie espresse nella Nascita della Tragedia e che ci pone di fronte allo<br />
scontro fra Dioniso e Apollo nel momento <strong>in</strong> cui un personaggio razionale e lucente sprofonda<br />
nelle tenebre delle sue orig<strong>in</strong>i abissali. La costruzione di tale dimensione tragica avviene<br />
sempre attra<strong>vers</strong>o un viaggio. E’ un viaggio a ritroso, nel buio della memoria e delle orig<strong>in</strong>i,<br />
che si <strong>in</strong>traprende non per scoprire qualcosa di nuovo ma per r<strong>in</strong>venire qualcosa di perduto. Il<br />
luogo dell’orig<strong>in</strong>e ancestrale si identifica spesso con il luogo dell’<strong>in</strong>fanzia: si tratta di un<br />
percorso mitico che vede un personaggio logocentrico scontrarsi con l'<strong>in</strong>congetturabile<br />
patetico. Il fatto che la Nascita della Tragedia sia una delle opere che più <strong>in</strong>fluenzò gli scrittori<br />
modernisti assume una certa importanza nell'ambito della ricerca su Pavese, che trasse da<br />
questo libro più di un’ispirazione: l’elaborazione di una struttura agonista-antagonista, l’uso di<br />
immag<strong>in</strong>i metaforiche o simboliche, la rottura dei rapporti con il recente passato per riscoprire<br />
l’importanza del mito, appaiono tutti elementi di derivazione niciana 14 . Pavese stesso cercherà<br />
di rivendicare per sé questa appartenenza alla grande arte moderna del novecento; è un’arte<br />
che batte sull’irrazionale e che riscopre il selvaggio che si annida nell’animo umano: “Perché<br />
l’irrazionale solleva al tutti, all’uni<strong>vers</strong>ale? […] Le tue creazioni le trai dall’<strong>in</strong>forme,<br />
dall’irrazionale, e il problema è come portarle a consapevolezza.[…] La tua modernità sta tutta<br />
nel senso dell’irrazionale” 15 .<br />
Il richiamo alla filosofia si unisce a quello all’antropologia nella <strong>def</strong><strong>in</strong>izione di un ulteriore<br />
criterio di modernità <strong>in</strong> Pavese. Pavese assegna un ruolo importante al personaggio-<strong>in</strong>dividuo<br />
che porta <strong>in</strong> sé tutte le implicazioni culturali e ontologiche proprie dell’uomo moderno. Il<br />
soggetto pavesiano sarà questo crogiolo di elementi esterni, la cultura del passato che vive un<br />
suo <strong>in</strong>timo dibattito con la cultura moderna, ed elementi <strong>in</strong>terni, primitivi ed ist<strong>in</strong>tuali che<br />
riaffiorano improvvisamente da sotto le macerie del moderno. E’ dal rapporto fra queste due<br />
dimensioni che si costruisce un l<strong>in</strong>guaggio che ricerca il proprio ritmo, l’equilibrio fra<br />
l’esterno e l’<strong>in</strong>terno. E’ una tensione che per Ferraris è riferibile alla metafora del sangue che<br />
pulsa nel corpo, metafora di lawrenciana memoria, come <strong>in</strong>tima sapienza che viene<br />
naturalmente a contatto con stimoli esterni. Il ritmo si costruirebbe accordando il tempo<br />
naturale della terra a quello artificiale del mondo ed assicurerebbe unità e coerenza all’opera.<br />
Lo scopo pr<strong>in</strong>cipale di Pavese sembra quello di poter raggiungere, attra<strong>vers</strong>o la scrittura, una<br />
dimensione esistenziale più vera e genu<strong>in</strong>a che dimostri allo scrittore stesso il valore del<br />
condurre un’esistenza umana nell’ambito della decadenza: “da un lato, la conv<strong>in</strong>zione che<br />
l’unico oggetto di ricerca per il creatore sta nella ricerca della verità recondita, <strong>in</strong>quietante e<br />
labile del soggetto umano come essenza dell’uni<strong>vers</strong>o e, dall’altro, la tacita esaltazione nel<br />
lavoro <strong>in</strong>cessante di decantazione della l<strong>in</strong>gua che contiene tutti i segreti e i misteri del<br />
13 Elio Gioanola, Cesare Pavese, La realtà, l’altrove, il silenzio, Jaca Book, Milano, 2003, p. 102.<br />
14 Dal 1890 al 1930, Nietzsche esercitò un notevole <strong>in</strong>flusso a <strong>in</strong> tutta Europa. Alla base dell’<strong>in</strong>fluenza del<br />
filosofo tedesco sui modernisti europei vi è il concetto di una “radicale ri<strong>def</strong><strong>in</strong>izione della verità” (“Radical<br />
re<strong>def</strong><strong>in</strong>ition of truth”) così come scrive Ra<strong>in</strong>er Emig che <strong>def</strong><strong>in</strong>isce l’apporto del filosofo tedesco alla formazione<br />
della cultura moderna secondo solo a quello dell’Illum<strong>in</strong>ismo. La filosofia di Nietzsche si legò f<strong>in</strong> dal pr<strong>in</strong>cipio<br />
alla letteratura. Soprattutto La Nascita della Tragedia rappresentò un libro molto importante per i modernisti<br />
europei così come conferma F. Kuna <strong>in</strong> The Janus Faced Novel: Conrad, Musil, Kafka, Mann, contenuto <strong>in</strong> The<br />
English Modernist Reader 1910-1930, edited by Peter Faulkner, Uni<strong>vers</strong>ity of Ioawa Press, Ioawa City, 1986, p.<br />
443: “Thus, as a systematic aesthetic theory, Nietzsche’s book had only limited <strong>in</strong>fluence; but as philosophy of<br />
life, a notion of myth and ritual, as a radical counter doctr<strong>in</strong>e […] it exercised the profoundest <strong>in</strong>fluence<br />
possible. Its ideas spread through the turn of the century m<strong>in</strong>d; its <strong>in</strong>sights seem essential to the ideas of modern<br />
poets and novelists; and the dialectical scheme that Nietzsche offered seemed to become a bluepr<strong>in</strong>t, an<br />
aesthetic prototype, for nearly every major twentieth century novel”.<br />
15 C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, 8 Febbraio 1944, cit. p. 274.<br />
10
mondo” 16 . I Dialoghi con Leucò rappresentano il punto di approdo delle speculazioni<br />
<strong>in</strong>tellettuali di Pavese, <strong>in</strong> cui le implicazioni ontologiche, antropologiche e l<strong>in</strong>guistiche trovano<br />
una loro <strong>def</strong><strong>in</strong>itiva unità.<br />
La dimensione moderna di Pavese non è d’altra parte un argomento nuovissimo. L’<strong>in</strong>tento di<br />
questo studio è quello di configurarsi come tentativo di accostare la modernità pavesiana alla<br />
modernità europea che trovò un’espressione privilegiata nel modernismo letterario.<br />
Nell’ambito di un raffronto che implicherebbe <strong>in</strong>numerevoli prospettive di studio, si è voluto,<br />
<strong>in</strong> questa ricerca, privilegiare alcuni sviluppi tematici che furono tipici del modernismo<br />
letterario, soprattutto <strong>in</strong>glese, e che trovarono, nelle composizioni di Pavese un’eco profonda e<br />
un’attenta rielaborazione. Privilegiare un approccio tematico, e implicitamente comparatistico,<br />
non ha potuto non sollevare questioni di carattere metodologico 17 .<br />
Prefiggendosi di <strong>in</strong>dividuare la presenza di temi comuni tra i modernisti <strong>in</strong>glesi e Cesare<br />
Pavese questo lavoro si è basato sulla selezione e sul confronto. I temi sono analizzati<br />
parallelamente <strong>in</strong> modo da trattare <strong>in</strong> maniera implicita le differenze e le convergenze. In<br />
questo modo non si <strong>in</strong>tende tanto approfondire i temi <strong>in</strong>dividuati quanto segnalarne la presenza<br />
e constatare come una comune sensibilità fra gli autori portò allo sviluppo di scritture aff<strong>in</strong>i.<br />
Lo stesso autore ci aiuta <strong>in</strong> questo compito grazie alle note dedicate ai modernisti <strong>in</strong>glesi. Lo<br />
studio sui temi del nudismo e dei sacrifici umani sono suggeriti dallo stesso Pavese che <strong>in</strong> una<br />
nota del Mestiere di Vivere datata 1 Dicembre 1949 riporta: “Scoperto l’altra sera quanto mi<br />
abbia plasmato la lettura di Sun e The woman who rode away di Lawrence (’36 –’37?)”.<br />
La ricerca tematica-comparatistica su Pavese si avvale di alcuni precedenti. Gli studi di<br />
Gregory Lucente 18 e quelli di Bruno Basile 19 rappresentano un primo importante tentativo di<br />
approccio tematico-comparatistico all’opera di Pavese. Soprattutto lo studio di Basile sembra<br />
<strong>in</strong>dicativo, nel momento <strong>in</strong> cui non solo <strong>in</strong>dividua la presenza di un tema comune a più autori<br />
ma ipotizza come il tema abbia l’effettiva possibilità di evol<strong>vers</strong>i per mezzo delle di<strong>vers</strong>e<br />
<strong>in</strong>terpretazioni che gli autori ne offrono attra<strong>vers</strong>o un processo produttivo di riscrittura. Il tema<br />
acquisisce, <strong>in</strong> questa <strong>in</strong>terpretazione, quasi una vita autonoma che si sviluppa attra<strong>vers</strong>o<br />
l’opera degli scrittori che decidono di farsene carico.<br />
Una delle r<strong>in</strong>unce di questo studio, per la quale ho dovuto optare al f<strong>in</strong>e di circoscrivere<br />
l’analisi, è stata il riferimento sistematico all’opera di Melville. Trattando di viaggi, di<br />
selvaggi, di luoghi lontani e <strong>in</strong>civili, il riferimento a Melville sarebbe quasi scontato. La<br />
decisione di circoscrivere la ricerca all’Europa, e <strong>in</strong> particolar modo alla Gran Bretagna, mi<br />
hanno portato a tenere l’opera di Melville ai marg<strong>in</strong>i, pur considerandola un punto di<br />
riferimento basilare a cui più volte si farà riferimento. L’<strong>in</strong>teresse di Pavese per la cultura e la<br />
letteratura americana è stato, d’altra parte, argomento ampiamente dibattuto mentre meno<br />
<strong>in</strong>teresse hanno f<strong>in</strong>o ad ora suscitato i suoi legami con la letteratura <strong>in</strong>glese moderna.<br />
Concentrarsi sul modernismo <strong>in</strong>glese ha dunque significato dover r<strong>in</strong>unciare ad un<br />
approfondimento su Melville; questa r<strong>in</strong>uncia appare ancor più significativa nel momento <strong>in</strong><br />
cui si dedica molto spazio a Lawrence che fu un altro appassionato lettore dello scrittore<br />
americano. Tuttavia, proprio per questa ennesima comunanza di fonti tra Pavese e Lawrence,<br />
Melville rientrerà <strong>in</strong> gioco nell’ultimo capitolo quando si analizzeranno i saggi dei due scrittori<br />
europei relativi al loro maestro americano. La ricerca, pur mirando all’approfondimento del<br />
modernismo <strong>in</strong>glese, non potrà presc<strong>in</strong>dere da brevi rimandi, f<strong>in</strong>anche nella forma di citazione,<br />
16<br />
D. Ferraris, Lo “sguardo alla f<strong>in</strong>estra” e il “laborioso caos”: sulla modernità narrativa di Cesare Pavese, cit.<br />
p. 134.<br />
17<br />
In questo caso i testi di riferimento sono stati Werner Sollors, The return of thematic criticism, Harvard<br />
Uni<strong>vers</strong>ity Press, Cambridge, Massachussets, London, England, 1993, e il saggio di P<strong>in</strong>o Fasano, Il ritorno della<br />
critica tematica, contenuto <strong>in</strong> L’umana compagnia, Studi <strong>in</strong> onore di Gennaro Bavarese, a cura di Rosanna<br />
Alhoique Pett<strong>in</strong>elli, Bulzoni editore, Roma, 1999, che proprio da Sollors prende le mosse.<br />
18<br />
Gregory Lucente, The narrative of realism and Myth. Verga, Lawrence, Faulkner, Pavese. The John Hopk<strong>in</strong>s<br />
Uni<strong>vers</strong>ity Press, Baltimore and London, 1981.<br />
19<br />
Bruno Basile, La f<strong>in</strong>estra socchiusa. Ricerche tematiche su Dostoevskij, Kafka, Moravia e Pavese, Patron<br />
Editore, Bologna, 1982.<br />
11
a <strong>in</strong>tellettuali europei, soprattutto francesi e tedeschi il cui apporto fu <strong>in</strong>estimabile per la<br />
formulazione di un concetto di modernismo europeo. Autori come Musil, Mann e Kafka, <strong>in</strong><br />
area germanica, o Bergson e Proust, <strong>in</strong> area francese, furono patrimonio comune sia degli<br />
<strong>in</strong>tellettuali modernisti <strong>in</strong>glesi sia di Pavese. Un discorso a parte meriterà <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e la filosofia di<br />
Vico 20 . Anche se questo studio non si potrà addentrare <strong>in</strong> questa direzione, mi sembra<br />
comunque necessario sottol<strong>in</strong>eare la presenza forte di questi <strong>in</strong>tellettuali nel panorama della<br />
cultura europea.<br />
Il modernismo si configura dunque come una ragnatela che si svolge sull’Europa <strong>in</strong>tera. E’ una<br />
ragnatela che si costruì come l’ammontare di s<strong>in</strong>gole scritture che contribuirono a creare una<br />
fitta trama di idee e di sensibilità. Cercare il centro di questo tessuto appare operazione<br />
difficile. Ciò che appare più plausibile è l’osservazione degli <strong>in</strong>trecci, lo scioglimento delle<br />
trame, la ricerca dei punti nodali dove i fili amano sovrapporsi ed aggrovigliarsi. La forma<br />
geometrica regolare della ragnatela è solo apparente. In realtà il caos regna sovrano all’<strong>in</strong>terno<br />
di un sistema dove è possibile, al massimo, riconoscere i s<strong>in</strong>goli percorsi nel loro procedere <strong>in</strong><br />
equilibrio su fili tortuosi sospesi sul baratro. L’impressione che ho ricavato dallo studio di<br />
questo fenomeno culturale è che esso si formò e sopravvisse veramente come una ragnatela<br />
che si <strong>in</strong>erpica <strong>in</strong> un angolo di soffitto dimenticato. In questa ragnatela confluì tutto lo sporco,<br />
tutto il rimosso, tutto ciò che si voleva dimenticare e nascondere di un sistema <strong>in</strong> decadenza,<br />
di un sistema del nichilismo; ma questa ragnatela, costruendosi come negativo di un modello<br />
putrescente, approntò forme geometriche nuove, f<strong>in</strong>anche astratte ed <strong>in</strong>comprensibili per la<br />
borghesia benpensante e positivista moderna, forme capaci di rappresentare lo spettro di<br />
un’antica, perduta, unità. Percorrere un tratto di queste geometrie, studiarne forme, evoluzioni<br />
e nodi, mi sembra che possa essere <strong>def</strong><strong>in</strong>ito il proposito di questo studio.<br />
20 Lo studio delle antiche pratiche rituali e le riflessioni riguardo la collocazione storica del mito, che implicava<br />
direttamente il discorso della riattivazione di una coscienza mitopoietica <strong>in</strong> epoca moderna, non poterono fare a<br />
meno dell’apporto della Scienza Nuova. Il ruolo che Giambattista Vico ebbe <strong>in</strong> Europa con le sue teorie espresse<br />
nella Scienza Nuova (1725), è importante per la diffusione del pensiero mitico <strong>in</strong> Europa tra l’Ottocento e il<br />
Novecento. L’<strong>in</strong>flusso che il filosofo napoletano ebbe su Cesare Pavese fu di notevole portata e rappresenta uno<br />
dei capisaldi nell’approccio critico allo scrittore. La lettura della Scienza Nuova colpì ed <strong>in</strong>fluenzò<br />
profondamente Pavese che sviluppò la sua concezione mitologica e le riflessioni sul personaggio mitico del<br />
selvaggio proprio a partire dagli assunti vichiani. Che ci sia una connessione tra le teorie storiche, e quelle<br />
<strong>in</strong>corporate del mito e del selvaggio, di Vico e quelle di molti scrittori romantici e modernisti è fatto appurato.<br />
12
1 IL MODERNISMO: LA STORIA E LA CRITICA<br />
La modernità è il transitorio, il fuggitivo, il<br />
cont<strong>in</strong>gente, la metà dell’arte, di cui l’altra metà è<br />
l’eterno e l’immutabile. (Charles Baudelaire, La<br />
pe<strong>in</strong>tre de la vie moderne, 1863)<br />
La parola modernismo risulta, per uno studioso di letteratura italiana, un term<strong>in</strong>e di difficile<br />
collocazione. Se si parla di letteratura mondiale si potrà far riferimento al modernismo<br />
<strong>in</strong>glese, a quello americano, a quello spagnolo e sudamericano, solo per citare quelli più<br />
importanti. Se si parla di letteratura italiana, un qualsiasi riferimento ad un modernismo di<br />
tipo letterario sembra del tutto fuori luogo e <strong>in</strong>giustificato. Di più ci sarà chi, e giustamente,<br />
farà riferimento al modernismo religioso che fu una corrente di pensiero, all’<strong>in</strong>izio del secolo<br />
XX nell'ambito della chiesa cattolica, che propose un r<strong>in</strong>novamento dell’approccio<br />
ecclesiastico per armonizzare progresso scientifico e fede religiosa 21 . Il modernismo <strong>in</strong> Italia<br />
non si è avuto. O perlomeno si potrebbe dire che una somma di eventi storici e culturali, che<br />
hanno avuto luogo nel nostro paese tra la seconda metà dell’Ottocento e la prima metà del<br />
Novecento, non sono stati ufficialmente collocati all’<strong>in</strong>terno di questo fenomeno culturale. La<br />
domanda che sorge spontanea, a cui cercheremo di rispondere, è come un paese quale<br />
l’Italia, <strong>in</strong> un momento storico <strong>in</strong> cui il modernismo letterario si diffondeva <strong>in</strong> Europa e nel<br />
resto del mondo, possa essere rimasto impermeabile ad un fenomeno di tale portata, o se<br />
piuttosto non si è creata una situazione per cui il modernismo è stato recepito e rielaborato<br />
<strong>in</strong>dividualmente dagli scrittori del nostro paese. L’ipo<strong>tesi</strong> che il problema del modernismo <strong>in</strong><br />
Italia sia pr<strong>in</strong>cipalmente nom<strong>in</strong>ativo è avvalorata da Franco Moretti che ipotizza come la<br />
nostra critica sia portata a confondere il term<strong>in</strong>e con quello di avanguardia: “Il term<strong>in</strong>e<br />
modernismo, <strong>in</strong> Italia, ha corso solo nella storia del pensiero religioso; ma sarebbe il caso di<br />
usarlo anche nella critica letteraria (come già avviene nel mondo anglosassone), lasciando al<br />
term<strong>in</strong>e Avanguardia il suo significato più proprio, e più ristretto” 22 . E' importante<br />
sottol<strong>in</strong>eare, prima di <strong>in</strong>com<strong>in</strong>ciare questo tipo di analisi, come il modernismo non<br />
rappresentò una semplice moda letteraria. Il modernismo fu piuttosto un'esigenza culturale,<br />
una posizione <strong>in</strong>tellettuale forte che, <strong>in</strong> Europa, nacque all'<strong>in</strong>domani della grande rivoluzione<br />
<strong>in</strong>dustriale. L'analisi storica ci porta a comprendere come questa tendenza si sia diffusa <strong>in</strong><br />
Europa parallelamente all'avanzare del progresso <strong>in</strong>dustriale. Il paese <strong>in</strong> cui tale fenomeno<br />
nacque, e velocemente si sviluppò, è, per l'appunto, il paese della grande rivoluzione<br />
<strong>in</strong>dustriale ottocentesca: l'Inghilterra.<br />
Quello che gli studiosi <strong>in</strong>glesi usano <strong>def</strong><strong>in</strong>ire modernismo è, prima di tutto, un fenomeno<br />
storico. E' ipotizzabile che le condizioni storiche che si verificarono <strong>in</strong> Inghilterra fra la<br />
seconda metà dell'Ottocento e la prima del Novecento si siano riproposte nel resto del<br />
cont<strong>in</strong>ente con uno scarto temporale di una o più decadi. E’ questa un’ipo<strong>tesi</strong> suffragata da<br />
Tra<strong>vers</strong> che così si esprime sulla questione:<br />
21 Il movimento “modernista”, che si sviluppò <strong>in</strong>torno alla rivista “R<strong>in</strong>novamento”, non ebbe grande seguito<br />
anche per l’opposizione della Chiesa. Il suo esponente maggiore fu Antonio Fogazzaro. Il romanzo Il Santo<br />
(1905), <strong>in</strong> cui le istanze “moderniste” erano espresse con maggior risoluzione, venne messo all’<strong>in</strong>dice. L’<strong>in</strong>tero<br />
movimento rappresentò poco più che un esperimento e non ebbe maggior seguito.<br />
22 Franco Moretti, Segni e stili del Moderno, Giulio E<strong>in</strong>audi Editore, 1987, Tor<strong>in</strong>o, p. 235.<br />
13
From the very beg<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g of the century, it had become <strong>in</strong>creas<strong>in</strong>gly evident that traditional agrarian Europe was<br />
be<strong>in</strong>g rapidly replaced by a new type of society founded on urban, pluraristic, and materialist values, at a pace<br />
driven by technological change. Between 1870 and 1914, that process, start<strong>in</strong>g <strong>in</strong> England, spread first to France<br />
and Belgium and then to Germany and Italy, gather<strong>in</strong>g a startl<strong>in</strong>g momentum 23 .<br />
E' uno schema semplice e generalizzante che ammette <strong>in</strong>numerevoli varianti. Ma procediamo<br />
con ord<strong>in</strong>e partendo, per l’appunto, dall’Inghilterra.<br />
Nel 1851 si tenne a Londra The Great Exhibition, una grande esibizione che doveva<br />
testimoniare di fronte al mondo l'evoluzione e i successivi orizzonti della moderna<br />
tecnologia. Charles K<strong>in</strong>gsley, popolare scrittore e uomo di chiesa di quel periodo, si sentì <strong>in</strong><br />
grado di dichiarare di aver assistito alla prova materiale che il voler realizzare il regno di Dio<br />
<strong>in</strong> terra non era più da considerarsi un'utopia. L’immag<strong>in</strong>e dei risultati ottenuti dal genio<br />
umano e la prospettiva <strong>in</strong>f<strong>in</strong>ita degli sviluppi ulteriori di questa evoluzione lasciarono<br />
ammirato lo scrittore che, con il suo <strong>in</strong>tervento, diede una voce, poetica e mistica, al pensiero<br />
corrente dell’élite culturale europea. L’idea che l’uomo potesse essere <strong>in</strong> grado di estendere il<br />
suo potere a dismisura sul creato, rendendo il mondo un posto migliore nel quale vivere, fece<br />
realmente breccia fra la popolazione europea. L'<strong>in</strong>tuizione che lo scopo dell'uomo <strong>in</strong> questa<br />
terra non fosse semplicemente quello di sopravvivere, ma fosse quello di progredire<br />
raggiungendo tramite la tecnica la realizzazione di un'idea del mondo basato su pr<strong>in</strong>cipi<br />
morali-evangelici, sembrò assurgere, per una frazione di secolo, al rango di una nuova<br />
fondamentale rivelazione. Sentimenti di stupore, meraviglia, euforia per la costruzione di<br />
questo futuro, potremmo così dire “ideale”, com<strong>in</strong>ciarono a serpeggiare, e non senza<br />
giustificazioni, tra la popolazione europea. La belle époque, a cavallo dei due secoli,<br />
rifletteva l’ottimismo della classe borghese che vedeva un effettivo progresso materiale alla<br />
portata di tutti. Ma la bellezza di quest’epoca fu soprattutto di facciata: “La belle époque fu <strong>in</strong><br />
realtà un periodo di crescita complessiva della società europea, ma anche di forti contrasti<br />
politici e di grandi conflitti sociali” 24 . La disillusione doveva, qu<strong>in</strong>di, seguire l'illusione. I<br />
cambiamenti troppo repent<strong>in</strong>i non poterono che lasciare degli strascichi importanti o,<br />
potremmo dire, provocare delle crisi di rigetto. In una parola l'impatto della tecnica mutò<br />
l'equilibrio del mondo che <strong>in</strong>iziò a traballare pericolosamente. I cambiamenti a livello sociale,<br />
politico, economico e culturale segnarono l'<strong>in</strong>izio di quello che gli studiosi <strong>in</strong>glesi hanno<br />
appunto <strong>in</strong>dicato come il periodo della modernità (modernity). Tale periodo, <strong>in</strong> cui si assiste a<br />
un vero e proprio cambiamento strutturale, fu caratterizzato da un crescente pessimismo fra<br />
gli <strong>in</strong>tellettuali attenti alle questioni sociali. Sull’altro <strong>vers</strong>ante, l’evoluzione delle tecniche e<br />
dei profitti sviluppò un eccessivo ottimismo fra le classi egemoni. Ma l’impatto <strong>in</strong>dustriale e<br />
tecnologico fu troppo forte per non <strong>in</strong>cidere negativamente sulla maggioranza della<br />
popolazione europea. Non pochi studiosi hanno parlato, per questo periodo, di una vera<br />
rivoluzione antropologica. Il senso di disagio di fronte al nuovo sistema economico e sociale<br />
si manifestò immediatamente e divenne subito oggetto d’<strong>in</strong>teresse da parte degli <strong>in</strong>tellettuali.<br />
Il potere <strong>in</strong>dustriale trovò il suo migliore alleato nella classe politica che a sua volta str<strong>in</strong>se<br />
accordi con i proprietari terrieri, con la vecchia aristocrazia e con la Chiesa. Si venne dunque<br />
a creare una situazione per cui il potere si accumulò nelle mani di pochi i quali, professando<br />
ideali di libertà e giustizia, non fecero altro che cercare di aumentare la loro forza politica ed<br />
economica a danno del resto della popolazione. Insomma una nuova classe politica,<br />
“economically open, but politically closed” 25 , pronta a far fronte a qualsiasi m<strong>in</strong>accia che<br />
avesse provato a privarla dell'autorità appena conseguita. I veri scopi di questa élite liberale<br />
non tardarono a manifestarsi e a rendersi evidenti agli occhi di tutti. Il massacro di 30.000<br />
lavoratori che avevano dato vita alla Comune di Parigi nel 1871, le leggi antisocialiste<br />
23 M. Tra<strong>vers</strong>, An <strong>in</strong>troduction to modern European Literature-from Romanticism to Postmodernism, cit. p. 97.<br />
24 A. Giard<strong>in</strong>a, G, Sabbatucci, V. Vidotto, L’età contemporanea, Editori Laterza, Bari, 1990, p. 388.<br />
25 M.Tra<strong>vers</strong>, An <strong>in</strong>troduction to modern European Literature-from Romanticism to Postmodernism, cit. p. 94.<br />
14
promulgate da Bismarck <strong>in</strong> Germania tra il 1878 e il 1890, il caso di corruzione e <strong>in</strong>granaggio<br />
politico svelato dal caso Dreyfus nel 1894, rappresentano alcuni esempi che furono recepiti,<br />
da una buona parte della popolazione, come segnali di una strategia pianificata dalle élite<br />
politiche europee tutte dedite a considerare i loro affari e molto poco <strong>in</strong>cl<strong>in</strong>i a lavorare per il<br />
bene del popolo che, al contrario, era sfruttato e privato dei diritti fondamentali. La retorica<br />
dell'uguaglianza, della libertà e della fratellanza, aveva ispirato la nascita degli stati laici<br />
borghesi che propugnavano il liberismo come la strategia di economia politica ispirata a tali<br />
ideali. Ma tale modello si scontrò presto contro la realtà della conquista e della sopraffazione<br />
a f<strong>in</strong>i di lucro e di espansioni territoriali.<br />
Il passaggio dal secolo XIX al secolo XX si rivelò, dunque, come un passaggio<br />
particolarmente critico. Il cambiamento fu troppo veloce e il sistema, che subì una vera e<br />
propria rivoluzione, non riuscì ad assorbire l'impatto del “nuovo”. Lo scenario sociale<br />
europeo cambiò profondamente nel giro di poche decadi. Il sistema agrario tradizionale<br />
venne soppiantato dal nuovo modello <strong>in</strong>dustriale e il fenomeno dell'urbanizzazione si diffuse<br />
<strong>in</strong> tutta Europa. Il passaggio dalla campagna alla città, che avvenne come una vera ondata,<br />
comportò una serie di conseguenze che, avvertite dapprima <strong>in</strong> Inghilterra, non tardarono a<br />
manifestarsi, con molte similitud<strong>in</strong>i e poche varianti, <strong>in</strong> tutto il resto d'Europa. Si può<br />
ragionevolmente asserire che tra il 1870 e il 1914 tale fenomeno trovò, <strong>in</strong> Inghilterra, la sua<br />
<strong>def</strong><strong>in</strong>itiva collocazione. Il passaggio fu segnato, come si può facilmente <strong>in</strong>tuire, da una serie<br />
di ripercussioni sugli <strong>in</strong>dividui che andarono al di là del semplice disagio ambientale.<br />
Questo particolare sviluppo della società <strong>in</strong>dustriale fu attentamente seguito dagli <strong>in</strong>tellettuali<br />
e ampiamente elaborato dagli scrittori. Il momento del passaggio da un tipo di vita rurale ad<br />
un tipo di vita urbana poteva lasciare l'impressione non solo di trovarsi <strong>in</strong> un luogo “non<br />
proprio” ma anche quella di aver “tradito” la propria stessa orig<strong>in</strong>e, aver r<strong>in</strong>negato un sistema<br />
di vita che, attra<strong>vers</strong>o le generazioni, poteva considerarsi centenario. La vita rurale, con i suoi<br />
luoghi usitati e conosciuti profondamente, con le sue cose piene di un senso accumulato negli<br />
anni, con le persone conosciute, con il tempo scandito sui ritmi delle stagioni, con il lavoro<br />
umile ma <strong>in</strong> qualche modo appagante, venne scalzata da un nuovo modello fatto di luoghi<br />
sconosciuti e <strong>in</strong>ospitali, di immag<strong>in</strong>i straniere prive di un qualsiasi senso, di orde di volti<br />
anonimi, di un tempo scandito macch<strong>in</strong>almente dagli orologi, di un lavoro alienante e<br />
umiliante. Le ripercussioni furono dunque di carattere ambientale e temporale. Moretti,<br />
citando il saggio di Rimmel, La metropoli e la vita spirituale, nota come la velocità, che<br />
caratterizzava il flusso con cui le immag<strong>in</strong>i del mondo moderno scorrevano di fronte<br />
all’<strong>in</strong>dividuo, rappresentò un vero shock psicologico: “Il problema psicologico fondamentale<br />
del cittad<strong>in</strong>o moderno deriva dal mutare rapido e <strong>in</strong>cessante degli stimoli esterni […]<br />
dall’<strong>in</strong>treccio velocissimo e <strong>in</strong> districabile di immag<strong>in</strong>i mutevoli […] da stimoli che sono<br />
<strong>in</strong>sieme violenti e <strong>in</strong>at<strong>tesi</strong>” 26 . Se l'uomo comune trovò nello sradicamento e nell’alienazione<br />
le sue pr<strong>in</strong>cipali caratteristiche, gli <strong>in</strong>tellettuali arriveranno ad ipotizzare un effettivo<br />
tradimento nei confronti della reale condizione umana. L'uomo diviene una sorta di automa.<br />
Il lavoro e la fabbrica lo plasmano a loro piacimento spersonalizzandolo e offrendogli il ruolo<br />
di <strong>in</strong>granaggio all'<strong>in</strong>terno del grande, <strong>in</strong>arrivabile, meccanismo.<br />
La riflessione teorica modernista nacque, dunque, da un disagio sociale reale che derivava, <strong>in</strong><br />
buona parte, dai processi di <strong>in</strong>dustrializzazione e urbanizzazione. E’ di questo disagio, che la<br />
gente comune provava di fronte all’improvvisa nuova organizzazione del mondo, che i<br />
modernisti si fecero portavoce prendendo posizione nei confronti della modernità <strong>in</strong>calzante<br />
che, attra<strong>vers</strong>o le superiori leggi dell’economia, sembrò acquisire un potere coercitivo senza<br />
limiti. Sulla dimensione di quello che ho <strong>def</strong><strong>in</strong>ito disagio non mancano documentazioni<br />
precise. Anche se è spesso sconsigliabile fare riferimento a date quando si parla di <strong>in</strong>teri<br />
fenomeni culturali, nel caso del modernismo si può forse fare un'eccezione. Furono gli stessi<br />
scrittori a rendersi pienamente conto del momento di passaggio che l'<strong>in</strong>tera società stava<br />
26 F. Moretti, Segni e stili del moderno, cit. p. 237.<br />
15
vivendo e di come questo passaggio potesse essere segnato da date, se non precise,<br />
perlomeno <strong>in</strong>dicative. Si può asserire con una certa sicurezza che qualcosa <strong>in</strong> Europa,<br />
all'<strong>in</strong>izio del Novecento, effettivamente cambiò <strong>in</strong> maniera radicale e nel giro di pochi anni.<br />
Quello che tale cambiamento rappresentò può essere studiato attra<strong>vers</strong>o i documenti storici<br />
per comprendere l'evoluzione della società e attra<strong>vers</strong>o gli scrittori che, partecipi di questa<br />
svolta epocale, furono testimoni di un ulteriore passo nell'evoluzione dell'uomo. E di<br />
evoluzione si deve parlare nel momento <strong>in</strong> cui Virg<strong>in</strong>ia Woolf dichiarava: “In or around 1910<br />
human nature changed”. La sensazione di vivere una svolta epocale sembrava essere ben<br />
radicata negli <strong>in</strong>tellettuali europei che potevano essere divisi fra il gusto del nuovo e la<br />
nostalgia del vecchio, ma che comunque riconoscevano <strong>in</strong> questo passaggio l'oggetto della<br />
loro speculazione. Per Lawrence il passaggio è ancora più netto quando, <strong>in</strong> Kangaroo (1923)<br />
dichiara: “It was <strong>in</strong> 1915 the old world ended”. La modernità, così detta, fu dunque un<br />
fenomeno ampiamente visibile, di cui gli <strong>in</strong>tellettuali furono pienamente coscienti e che<br />
chiamò <strong>in</strong> causa, direttamente, analisi di tipo antropologico ed etnologico.<br />
Il fenomeno culturale del modernismo si diffuse <strong>in</strong> Europa come reazione a una modernità<br />
dilagante. Si può ragionevolmente asserire che l'elaborazione letteraria dell'impatto di questo<br />
cambiamento epocale rappresentò il motore del modernismo. Le analisi portate avanti da<br />
storici, filosofi, sociologi, psicologi, etnologi sembrarono convenire tutte nel medesimo<br />
punto: constatare il disagio dell'uomo moderno di fronte a un mondo che progressivamente si<br />
faceva più lontano e ostile 27 . L'approfondimento di questi temi a livello letterario fu <strong>in</strong>gente.<br />
Un tema <strong>in</strong>teressante di questo periodo, sul quale questo studio si soffermerà <strong>in</strong> seguito, è<br />
quello del viaggio <strong>vers</strong>o terre sconosciute. L'imperialismo, espressione territoriale di un<br />
sistema basato sullo sfruttamento economico, diede nuovo vigore alla produzione della<br />
letteratura di viaggio. La pratica coloniale, con lo scopo dichiarato di portare il progresso<br />
presso i selvaggi, fece del ricorso sistematico a violenze e delitti la sua pr<strong>in</strong>cipale<br />
caratteristica. In questo contesto è il carattere essenzialmente barbarico dell'uomo a venire<br />
alla luce, così come ci riportano i testi di Kipl<strong>in</strong>g e Conrad. Nell'ambito della letteratura di<br />
viaggio non si può non gettare un'occhiata fuori dai conf<strong>in</strong>i europei per riconoscere alla<br />
letteratura americana un esito particolarmente felice <strong>in</strong> questo campo come testimonia, su<br />
tutti, il capolavoro di Melville, Moby Dick. In questo caso è il rapporto conflittuale dell'uomo<br />
con la natura ad essere il motore del romanzo <strong>in</strong> un momento <strong>in</strong> cui si scopre tale lotta essere<br />
eterna, mitica. In entrambi i casi l'uomo, il protagonista, verrà posto di fronte al buio delle<br />
proprie orig<strong>in</strong>i, di fronte alla consistenza di quella forma barbarica che lo contraddist<strong>in</strong>gue e<br />
che viene costantemente r<strong>in</strong>negata dal mondo borghese. La riscoperta di questi mondi esotici,<br />
paradisi terrestri per antonomasia, avvenne <strong>in</strong> primo luogo tramite la lettura dei resoconti di<br />
viaggio e degli studi antropologici. Ma il fenomeno del primitivismo, la riscoperta del<br />
selvaggio come depositario degli ist<strong>in</strong>ti umani non repressi, avvenne, anche e soprattutto, <strong>in</strong><br />
ambito teorico. Il concetto di selvaggio ebbe una lunga gestazione ma, <strong>in</strong> questo periodo,<br />
l'<strong>in</strong>teresse per questo personaggio non si legò esclusivamente ai viaggi di esplorazione e<br />
d'avventura. Il selvaggio divenne un personaggio complesso che si pose al centro<br />
dell'attenzione di molti scrittori i quali si prefissero di compiere un percorso a ritroso <strong>vers</strong>o<br />
l’orig<strong>in</strong>e dell’umanità. Non solo aborigeni o cannibali dunque. I personaggi di Lawrence<br />
sono spesso persone normali che scoprono il selvaggio che è <strong>in</strong> loro stessi tramite<br />
un'operazione di anamnesi. Lo scontro dei personaggi con la dimensione civile è una naturale<br />
implicazione di questo modello di scrittura e porta <strong>in</strong> una dimensione della scrittura che<br />
27 La presenza di un disagio diffuso di fronte le novità della tecnica è documentato anche da alcune grandi<br />
produzioni c<strong>in</strong>ematografiche dell’epoca. Alcuni esempi emblematici possono essere Metropolis (1926) di Fritz<br />
Lang <strong>in</strong> cui il dramma dell’uomo si svolge al cospetto di una struttura sociale disumana e coercitiva, The<br />
General (1926) di Buster Keaton <strong>in</strong> cui la civiltà delle macch<strong>in</strong>e è ridicolizzata, Modern Times (1936) di Charlie<br />
Chapl<strong>in</strong> <strong>in</strong> cui il rapporto uomo-<strong>in</strong>dustria si ammanta di una tragica comicità. Anche <strong>in</strong> quesi casi è l’alienazione<br />
dell’uomo moderno ad essere al centro di ogni trattazione. Il suo soccombere di fronte le prepotenze della<br />
tecnica sembra sfociare necessariamente <strong>in</strong> una drammatica svolta antropologica.<br />
16
Tra<strong>vers</strong> <strong>def</strong><strong>in</strong>isce “a gentle melancholia, [...] a nostalgia for a land of lost content that ho<strong>vers</strong><br />
just beyond the consciousness, <strong>in</strong> a dimly remembered past” 28 .<br />
Il modernismo non può essere, però, <strong>def</strong><strong>in</strong>ito come un vero e proprio movimento letterario<br />
conforme a regole e a statuti. Quella di modernismo è <strong>in</strong> effetti una <strong>def</strong><strong>in</strong>izione a posteriori<br />
che vuole dare un’identità ad un periodo storico caratterizzato da un grande sommovimento<br />
culturale, sociale, politico. Gli scrittori modernisti trassero il materiale per le loro<br />
composizioni dal periodo storico della modernità. Tra<strong>vers</strong> offre questa <strong>def</strong><strong>in</strong>izione di<br />
modernismo:<br />
Although the notion of “the modern” found its way <strong>in</strong>to a number of cultural studies <strong>in</strong> the late n<strong>in</strong>eteenth<br />
century, for example Georg Brandes Men of the modern Breaktrought (1883) and Samuel Lubliski's Assess<strong>in</strong>g<br />
the Moderns (1904), modernism as a recognisable literary mode did not ga<strong>in</strong> currency until the 1920s, when it<br />
found favour amongst writers and scholars try<strong>in</strong>g to make sense of a new type of literature that represented not<br />
only aesthetic novelty and <strong>in</strong>novation, but also (for many) obscurity and the divorce of advanced contemporary<br />
poetry from the common-sense standards of ord<strong>in</strong>ary <strong>in</strong>telligence 29 .<br />
Nell’ambito delle <strong>def</strong><strong>in</strong>izioni e delle dist<strong>in</strong>zioni che si possono proporre del modernismo<br />
letterario prevale quella di High Modernism e Low Modernism. Questa dist<strong>in</strong>zione sembra<br />
tuttavia legata pr<strong>in</strong>cipalmente al valore delle opere <strong>in</strong>serite nell’una o nell’altra delle<br />
categorie; l’idea che l’High Modernism rappresenti un gruppo di scrittori che, anche se<br />
formalmente non aff<strong>in</strong>i, si confrontarono con le medesime tematiche può, per il momento,<br />
essere accettata. Tra gli scrittori appartenenti all’High Modernism spiccano Eliot, Pound,<br />
Conrad, Joyce, Lawrence e altri che, nell'ambito di quest'analisi possono, per il momento,<br />
rimanere ai marg<strong>in</strong>i. Sono senz’altro questi gli scrittori che esercitarono il maggior <strong>in</strong>flusso <strong>in</strong><br />
Europa e sono questi gli scrittori che, nell’ambito di questo studio, sarà utile approfondire.<br />
Tali scrittori, confrontandosi con le stesse problematiche, dotarono il modernismo letterario<br />
di un pur ufficioso statuto. Le riflessioni sul tempo, sullo spazio, sull'uomo e sulle sue forme<br />
di comunicazione rappresentarono oggetto di riflessione <strong>in</strong> un momento <strong>in</strong> cui la modernità<br />
sembrava rimettere tutto <strong>in</strong> gioco: l’<strong>in</strong>tero mondo moderno sembrò, improvvisamente,<br />
divenire artificiale, costruito <strong>in</strong> maniera arbitraria. I dati salienti della modernità potrebbero<br />
essere così schematizzati: un nuovo concetto di tempo <strong>def</strong><strong>in</strong>ibile solamente <strong>in</strong> base ai<br />
meccanismi che lo scandiscono; una nuova idea di spazio non più percepito come distesa<br />
libera e possibilità aperta, alla Cervantes diciamo, ma come chiusura, come urbe pre<strong>def</strong><strong>in</strong>ita e<br />
<strong>in</strong>violabile; un nuovo modello di uomo che, totalmente <strong>in</strong>corporato nel meccanismo sociale,<br />
deve a questo meccanismo adeguarsi anche a condizione di forzare la propria natura; un<br />
nuova difficoltà nella comunicazione tra uomo ed uomo nel momento <strong>in</strong> cui l’uso del<br />
l<strong>in</strong>guaggio diviene standardizzato e superficiale. Le ricerche sul tempo mitico, sugli spazi<br />
esterni alla città, e <strong>in</strong> un certo senso mitici anch'essi, sull'<strong>in</strong>tima essenza dell'uomo e sulla sua<br />
ontologia, sulle primarie forme di comunicazione, che suggeriscono agli scrittori di tornare a<br />
pensare metaforicamente tramite l'utilizzo di immag<strong>in</strong>i e simboli, rappresentarono la risposta<br />
<strong>in</strong>tellettuale dei modernisti alle novità del secolo. Le risposte che i vari scrittori diedero a<br />
queste problematiche furono, <strong>in</strong>evitabilmente, di<strong>vers</strong>e e orig<strong>in</strong>ali, alcune contrastanti fra loro<br />
ma la base di partenza della loro speculazione appare comune ed è ciò che ci fa identificare<br />
questi scrittori come modernisti.<br />
Una debita importanza va attribuita senz’altro alle avanguardie storiche che, del modernismo,<br />
rappresentano uno sviluppo caratteristico. Sono questi gli unici casi <strong>in</strong> cui si sono volute<br />
tirare le fila di un movimento culturale altrimenti dispersivo e caotico al pari della materia<br />
28 M.Tra<strong>vers</strong>, An <strong>in</strong>troduction to modern European Literature-from Romanticism to Postmodernism, cit. p. 99.<br />
29 Ivi, p. 101.<br />
17
trattata 30 . Per Tra<strong>vers</strong> la differenza tra gli avanguardisti e quelli che <strong>def</strong><strong>in</strong>isce “ma<strong>in</strong>-stream<br />
Modernists” (Woolf, Lawrence, Yeats, Proust, Gide, Mann, Musil, Kafka, Svevo) 31 , consiste<br />
nell'approccio differente ad una identica materia. Percependo lo stesso disagio esistenziale e<br />
ponendosi <strong>in</strong> maniera critica nei confronti della modernità, entrambi gli schieramenti<br />
proposero soluzioni alternative. Gli avanguardisti si basarono sull'energia iconoclasta e<br />
dissacratoria del loro approccio, ponendosi <strong>in</strong> maniera risoluta <strong>vers</strong>o ogni forma di<br />
“passatismo”. I “ma<strong>in</strong>-stream Modernists” cercarono la loro via partendo dal sapere classico,<br />
da una base erudita, rielaborandone forme e contenuti. La <strong>def</strong><strong>in</strong>izione proposta da Tra<strong>vers</strong><br />
tiene conto di quelle che potevano rappresentare commistioni ed <strong>in</strong>fluenze tra i due filoni. A<br />
titolo di esempio si può citare il tema del primitivismo caro ai modernisti maggiori e comune<br />
a molte delle avanguardie storiche, dai Dada agli espressionisti. Per Tra<strong>vers</strong> lo sforzo artistico<br />
delle avanguardie è comunque funzionale allo sviluppo del modernismo maggiore di cui<br />
questo studio si occupa: “The goal of the ma<strong>in</strong>stream Modernists was, <strong>in</strong> short, the absorpion<br />
of novelty <strong>in</strong>to custom; they sought not the destruction of the latter, but the retention of its<br />
vital elements to enrich the traditions of their perspective literary cultures” 32 . Altrettanto<br />
importante per comprendere la genesi del modernismo è il riferimento all’esperienza del<br />
decadentismo di f<strong>in</strong> de siècle 33 .<br />
Il modernismo letterario nacque, dunque, <strong>in</strong> stretta relazione ad una situazione storica e come<br />
espressione di un disagio primariamente sociale. Se si volesse <strong>in</strong>dicare un comune<br />
denom<strong>in</strong>atore, una cifra che accomunò sotto un sentire diffuso tutti gli <strong>in</strong>tellettuali che<br />
<strong>def</strong><strong>in</strong>iamo modernisti, si potrebbe forse <strong>in</strong>dicare nell’osservazione quanto mai critica del<br />
reale, di ciò che la morale borghese pretendeva fosse il reale. Gli atteggiamenti e le strategie<br />
d’azione furono variegate e, spesso, difficilmente rapportabili ma si potrebbe identificare<br />
come un atteggiamento diffuso fra gli <strong>in</strong>tellettuali modernisti proprio quello di un di<strong>vers</strong>o<br />
metodo di approccio alla realtà convenzionale, una messa <strong>in</strong> discussione di tale realtà. Come<br />
vedremo, le poetiche dell’irrazionalità nacquero proprio dal rifiuto di un reale che si fondava<br />
su un modello logico deduttivo. Il modernismo fu, primariamente, disagio di fronte al<br />
modello di reale che la società moderna cercava di imporre all’<strong>in</strong>tera umanità. Questo disagio<br />
si diffuse presto <strong>in</strong> tutt’Europa accompagnato dalle voci degli scrittori anglosassoni.<br />
Il ruolo che le letterature straniere giocarono <strong>in</strong> questo periodo nella formazione di alcuni dei<br />
nostri autori maggiori è primario e lascia spazio a riflessioni ed approfondimenti di vario<br />
genere. Nell’ambito di una cultura italiana tendenzialmente chiusa nei confronti di <strong>in</strong>flussi<br />
esterni, la posizione di Cesare Pavese è del tutto particolare. E’ una posizione che<br />
meriterebbe di essere approfondita a livello di <strong>in</strong>fluenze e di rielaborazione dei materiali. La<br />
voce “fuori del coro” di Pavese rappresenterebbe, da questo punto di vista, un aspetto del<br />
30<br />
I movimenti dell'Immag<strong>in</strong>ismo e del Vorticismo <strong>in</strong> Inghilterra, l'Espressionismo <strong>in</strong> Germania,<br />
l'Impressionismo <strong>in</strong> Francia, il Futurismo <strong>in</strong> Italia, il Surrealismo <strong>in</strong> Francia, il Dadaismo <strong>in</strong> Svizzera, il<br />
Costruttivismo <strong>in</strong> Russia, rappresentano derivazioni e deviazioni della matrice pr<strong>in</strong>cipale del modernismo<br />
letterario di cui costituirono una sorta di contro altare.<br />
31<br />
M.Tra<strong>vers</strong>, An <strong>in</strong>troduction to modern European Literature-from Romanticism to Postmodernism, cit. p. 106.<br />
32<br />
Ivi, p. 107.<br />
33<br />
Le esperienze dei poeti simbolisti francesi costituiscono un patrimonio per lo sviluppo del modernismo.<br />
Baudelaire appare <strong>in</strong> questo caso un precursore. Nella sua poetica il contrasto tra vita naturale e vita artificiale<br />
viene costantemente sottol<strong>in</strong>eato nel momento <strong>in</strong> cui l'uomo moderno può ritrovare se stesso solo nell'evasione<br />
da una realtà divenuta opprimente tramite l'approfondimento della parte oscura che cela <strong>in</strong> se stesso, dei suoi più<br />
remoti desideri, del l<strong>in</strong>guaggio simbolico. La figura del Dandy si pone risolutamente <strong>in</strong> contrasto con la figura<br />
del borghese che, con la sua morale utilitaristica, sembra adeguarsi perfettamente alla modernità. Tale morale,<br />
perbenista e ipocrita, è al centro degli attacchi di Rimbaud che, fornendo un modello poetico alle teorie di<br />
Nietzsche, situa il poeta e il suo operato “al di là del bene e del male” nel momento <strong>in</strong> cui riconosce che il suo<br />
ruolo è proprio quello di scard<strong>in</strong>are le false certezze e le illusorie verità della società borghese. Per Mallarmè il<br />
disadattamento dell'uomo nel mondo contemporaneo nasce dall'<strong>in</strong>capacità di un l<strong>in</strong>guaggio, soprattutto<br />
denotativo, di espletare il reale. La sua poesia, tramite l'utilizzo di un l<strong>in</strong>guaggio connotativo e musicale, cercò di<br />
scard<strong>in</strong>are i limiti della comunicazione moderna per scoprire quel mondo orig<strong>in</strong>ario che il l<strong>in</strong>guaggio moderno<br />
nega <strong>in</strong> cont<strong>in</strong>uazione e che solo tramite le corrispondenze musicali può essere riscoperto. Il simbolismo<br />
francese <strong>in</strong>fluenzò le letterature di tutta Europa e si pose come pr<strong>in</strong>cipale referente del primo modernismo.<br />
18
tutto orig<strong>in</strong>ale nella storia della letteratura italiana. La ricezione di <strong>in</strong>flussi stranieri da parte<br />
di un autore che operava <strong>in</strong> un contesto culturale “classicista”, ha portato allo sviluppo di una<br />
poetica complessa e ricca di riferimenti. Se vogliamo poi analizzare il periodo che<br />
maggiormente ci <strong>in</strong>teressa nell'ambito di questo studio, cioè il periodo fra le due guerre che<br />
rappresentò il momento della formazione e della prima produzione di Pavese, dovremo<br />
riconoscere che il rivolgere la propria attenzione all’estero fu un passo importante <strong>in</strong> un<br />
momento politico <strong>in</strong> cui le classi <strong>in</strong>tellettuali si sentivano rivestite del compito di riscoprire,<br />
r<strong>in</strong>verdire, esaltare, la letteratura e la cultura nazionali. Rivolgere il proprio <strong>in</strong>teresse<br />
all'estero rappresentava, dunque, non solo una scelta artistica ma, anche e soprattutto, una<br />
scelta politica. Ciò non significa che Pavese rivolse il suo sguardo all'estero per una forma di<br />
protesta o per anticonformismo <strong>in</strong>tellettuale; il riconoscere l'<strong>in</strong>adeguatezza della letteratura<br />
italiana di fronte ai grandi movimenti letterari europei e americani rappresentò, <strong>in</strong> quel<br />
periodo, una scelta forte e coraggiosa che Pavese non ebbe paura di fare pubblicamente.<br />
Le scelte di Pavese apparvero d’altra parte sempre motivate. L’<strong>in</strong>teresse per l’etnologia, che<br />
lo accompagnò per tutta la sua esistenza, trovò, per esempio, sbocco nella collaborazione con<br />
De Mart<strong>in</strong>o nell’ambito del progetto della Collana Viola. Questo punto è particolarmente<br />
importante considerando il rilievo che gli studi etnologici ebbero nell’ambito del modernismo<br />
europeo. Pavese si dimostrò un precursore non solo per lo studio di tematiche estranee alla<br />
tradizione letteraria italiana ma anche per l’approccio <strong>in</strong>terdiscipl<strong>in</strong>are che seppe<br />
promuovere. La letteratura non vive <strong>in</strong> se stessa ma <strong>in</strong> un mondo strutturato e complesso ed è<br />
per questo, sembra suggerire Pavese, che lo scrittore deve assorbire tutti gli stimoli più<br />
significativi della propria epoca. Molto si è discusso di Pavese etnologo. I suoi <strong>in</strong>teressi per la<br />
discipl<strong>in</strong>a sono documentati ampliamente dagli scritti e dalla collaborazione con De Mart<strong>in</strong>o<br />
nell'ambito del progetto-E<strong>in</strong>audi <strong>in</strong>titolato la Collana Viola. Molto si è discusso anche dei<br />
risvolti poetici che gli studi etnologici ebbero sulla sua opera. Un <strong>in</strong>teresse per le forme<br />
arcaiche di pensiero, per i comportamenti dell'uomo che sembrano avere matrici antiche, è<br />
documentabile <strong>in</strong> tutti i lavori di Pavese e sfocerà, nel 1947, nei Dialoghi con Leucò che<br />
rappresenta un punto di arrivo, una maturazione <strong>def</strong><strong>in</strong>itiva del pensiero mito-etnologico dello<br />
scrittore.<br />
L’etnologia rappresentò un campo di studio privilegiato per gli <strong>in</strong>tellettuali modernisti che<br />
trassero, dai materiali di Darw<strong>in</strong> e Frazer, più di uno spunto per i loro lavori. L'<strong>in</strong>gresso<br />
dell'etnologia nel campo dello scibile come scienza accreditata rivestì un significato ben<br />
preciso nell'ambito dell'evoluzione del pensiero occidentale. L’importanza che tale materia<br />
ebbe per lo sviluppo del modernismo letterario fu grandissima ed è equiparabile solamente<br />
all’apporto della filosofia. Molte tematiche erano, d’altra parte, strettamente connesse: il<br />
pensiero mitico, l’eterno ritorno, il ruolo dell’ist<strong>in</strong>to, il primitivismo. Le cronache di viaggi,<br />
le descrizioni di uom<strong>in</strong>i che vivevano allo stato selvaggio, la composizione di opere che<br />
avevano per oggetto i mondi esotici e <strong>in</strong>contam<strong>in</strong>ati, avevano sempre riscosso un certo<br />
<strong>in</strong>teresse ma mai avevano preteso di nutrire, con il loro operato, una scienza. La letteratura di<br />
viaggio, i resoconti, le descrizioni dettagliate, avevano sempre rappresentato un vero e<br />
proprio filone letterario. A partire dall'Ottocento, però, assistiamo ad un connubio molto<br />
stretto tra la scienza dell’etnologia e il movimento letterario del modernismo. Il selvaggio<br />
cessa di essere un personaggio pittoresco per divenire un personaggio filosofico, i mondi<br />
esotici cessano di essere visti come terre lontane, curiose, eventualmente oggetto di<br />
conquista, di assimilazione, per divenire oggetto di contemplazione, di osservazione e<br />
meditazione, profonda, filosofica, quasi nostalgica. F<strong>in</strong>o a qualche anno prima ipotetici<br />
naviganti avrebbero sorriso di fronte al fare goffo dei selvaggi e avrebbero pensato a<br />
conquistare la loro terra per edificare la loro civiltà. In questo momento storico, l'uomo<br />
occidentale si ferma <strong>in</strong>vece a riflettere su quanto sta avvenendo. Quegli uom<strong>in</strong>i, che erano<br />
stati f<strong>in</strong>o ad allora esseri da disprezzare, e quei luoghi, visti come terre da conquistare,<br />
divengono ora oggetti di confronto e da questo confronto nascono molte delle tematiche<br />
moderniste. Il nuovo <strong>in</strong>teresse per l'etnologia rappresentò uno dei tratti salienti della<br />
19
modernità e l'analisi di questo rapporto tra scienza e scrittura serve ad approfondire<br />
ulteriormente l'oggetto del nostro studio.<br />
Nel suo lavoro editoriale all'E<strong>in</strong>audi, Pavese cercò di far circolare <strong>in</strong> Italia le opere straniere<br />
più significative, ben conscio dei limiti e dei pericoli che il sistema politico del fascismo<br />
comportava. Accanto all’opera dell’editore e del traduttore si colloca quella del lettore e dello<br />
studioso di letteratura. Pavese fu un poeta che cercò nelle opere straniere nuove forme, nuovi<br />
contenuti, nuove risposte e nuove domande. Il suo <strong>in</strong>teresse editoriale sembrò associarsi<br />
naturalmente a quello <strong>in</strong>tellettuale sempre stimolato da nuove letture. Nel suo studio su<br />
Pavese traduttore, Maria Stella mette <strong>in</strong> evidenza questo aspetto, notando come lo scrittore<br />
avesse un duplice <strong>in</strong>teresse nel tradurre un testo. L’<strong>in</strong>teresse primario fu <strong>in</strong>fatti quello poetico<br />
quasi che i lavori, attra<strong>vers</strong>o la traduzione, venissero <strong>in</strong> qualche maniera <strong>in</strong>corporati da<br />
Pavese. A questo proposito l’importanza degli autori <strong>in</strong>glesi fu basilare. Dal 1933 al 1939<br />
l’attenzione dello scrittore sembrò spostarsi molto sul <strong>vers</strong>ante della letteratura britannica.<br />
Parte di questo <strong>in</strong>teresse è rapportabile alle traduzioni eseguite personalmente. Nel 1934<br />
traduce il Portrait dell’irlandese Joyce cambiando il titolo <strong>in</strong> Dedalus e pubblicandolo presso<br />
la casa editrice Frass<strong>in</strong>elli di Tor<strong>in</strong>o. Per molti critici, tra cui Gorlier e Stella, il cambiamento<br />
del titolo del romanzo di Joyce è proprio relativo all’<strong>in</strong>tenzione di Pavese di andare al di là<br />
del ruolo canonico di traduttore per immedesimarsi <strong>in</strong> quello del creatore dell’opera. Dedalus<br />
conferma il crescente <strong>in</strong>teresse dell’autore per il mito che si proietta, <strong>in</strong> questo caso,<br />
sull’opera di Joyce. Per Stella le traduzioni erano selezionate da Pavese <strong>in</strong> relazione ad un<br />
tipo di <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e personale. Il rifiuto che Pavese espresse nei confronti della traduzione<br />
dell’Ulisse di Joyce, a seguito del Dedalus, rappresenterebbe, per Stella, la necessità di<br />
proseguire la sua ricerca <strong>in</strong>dirizzandosi <strong>vers</strong>o altri autori. La ricerca di Pavese proseguirà<br />
<strong>in</strong>fatti attra<strong>vers</strong>o nuove traduzioni che comprenderanno, fra i narratori (ci sono <strong>in</strong>fatti anche<br />
storici britannici tra le traduzioni pavesiane), Daniel Defoe, con Fortune e sfortune della<br />
famosa Moll Flanders edito da E<strong>in</strong>audi nel 1938, Charles Dickens con La storia e le<br />
personali esperienze di David Copperfield uscito presso la medesima casa editrice nel 1939 e<br />
Percy Shelley con il Prometeo Slegato pubblicato recentemente da E<strong>in</strong>audi (1997). Per Stella,<br />
l’<strong>in</strong>teresse che Pavese dimostrò nei confronti della letteratura <strong>in</strong>glese fu enorme e andrebbe<br />
considerato come vero e proprio momento formativo dello scrittore:<br />
Per quanto non si possa parlare di una precisa messa a fuoco critica di Pavese sul romanzo <strong>in</strong>glese, possediamo<br />
tutta una serie di elementi, nel diario, nelle lettere, nei suoi scritti critici, che attestano come quasi<br />
spontaneamente, sul filo di una meditazione personale, lo scrittore ripercorresse le tappe fondamentali della<br />
narrativa anglosassone di ogni tempo, e come questa problematica fosse <strong>in</strong> relazione diretta con il suo travaglio<br />
narrativo e con il suo rapporto con la tradizione americana. Anche per la letteratura <strong>in</strong>glese, come già per quella<br />
americana, Pavese si mantiene <strong>in</strong> equilibrio costante tra classici e contemporanei, e <strong>in</strong>daga criticamente su<br />
entrambi, mosso dalla conv<strong>in</strong>zione che, anche <strong>in</strong> campo letterario, avere una tradizione è meno che nulla è solo<br />
cercandola che si può viverla 34 .<br />
L’<strong>in</strong>teresse di Pavese per le letterature d’oltralpe e d’oltreoceano venne a rappresentare un<br />
punto card<strong>in</strong>ale della sua formazione artistica. Conscio della peculiarità della sua posizione,<br />
egli non esitò a rivendicarla come parte fondante della sua poetica e a prenderla come spunto<br />
di critica nei confronti della cultura italiana reputata spesso troppo prov<strong>in</strong>ciale e asservita. La<br />
rivendicazione di questa posizione assume, spesso, i toni di una vera e propria protesta <strong>vers</strong>o<br />
la cultura di regime. Nell'articolo Ritorno all’uomo, pubblicato il 20 Maggio 1945 sull’Unità,<br />
tale posizione si rende evidente ed <strong>in</strong>equivocabile ponendosi come voce ideale di un’<strong>in</strong>tera<br />
generazione di <strong>in</strong>tellettuali:<br />
34 M. Stella, Cesare Pavese traduttore, cit. pp. 75-76.<br />
20
Nei nostri sforzi per comprendere e per vivere ci sorressero voci straniere: ciascuno di noi frequentò e amò<br />
d'amore la letteratura di un popolo, di una società lontana, e ne parlò, ne tradusse, se ne fece una patria ideale.<br />
Tutto ciò <strong>in</strong> l<strong>in</strong>guaggio ufficiale si chiamava esterofilia. I più miti ci accusavano di vanità esibizionistica e di<br />
fatuo esotismo i più austeri dicevano che noi cercavamo nei gusti e nei modelli d'oltreoceano e d'oltralpe uno<br />
sfogo alla nostra <strong>in</strong>discipl<strong>in</strong>a sessuale e sociale. Naturalmente non potevano ammettere che noi cercassimo <strong>in</strong><br />
America, <strong>in</strong> Russia, <strong>in</strong> C<strong>in</strong>a e chi sa dove, un calore umano che l'Italia ufficiale non ci dava. Meno ancora, che<br />
cercassimo semplicemente noi stessi. Invece fu proprio così. Laggiù noi cercammo e trovammo noi stessi 35 .<br />
In questo esemplificativo passo si r<strong>in</strong>tracciano una serie di motivi che giustificano l'<strong>in</strong>teresse<br />
dello scrittore per la letteratura straniera. Il poter guardare all'estero come punto di<br />
riferimento, come term<strong>in</strong>e di confronto, come fonte di ispirazione, assume, nel pensiero<br />
dell’autore, prima di tutto una connotazione morale. Pavese aveva per anni coltivato i suoi<br />
studi letterari fornendo gli scaffali della sua biblioteca di libri provenienti da tutto il mondo.<br />
La formazione <strong>in</strong>tellettuale <strong>in</strong>dividuale passava attra<strong>vers</strong>o un necessario confronto con le<br />
altre culture. Alle problematiche morali ed etiche si affiancarono quelle esistenziali nel<br />
momento <strong>in</strong> cui divenne chiaro che una cultura come quella italiana, chiusa <strong>in</strong> se stessa e<br />
<strong>in</strong>capace di progredire, non potesse fornire agli <strong>in</strong>tellettuali mezzi adeguati di ricerca. Il<br />
superamento dei conf<strong>in</strong>i nazionali ebbe prima di tutto questo significato: superare il blocco<br />
imposto dal regime sulla cultura italiana. La retorica di un’arte nazionale italiana non era,<br />
d’altra parte, una novità <strong>in</strong>trodotta dal regime fascista. Le radici di una concezione dell’arte<br />
nazionalista vanno r<strong>in</strong>tracciate all’<strong>in</strong>izio del secolo quando i movimenti nazionalisti mossero<br />
i primi decisi passi legandosi alla propaganda colonialistica dell’epoca 36 . E’ <strong>in</strong>teressante<br />
notare lo scarto tra lo scritto sopraccitato di Pavese e quelli di Prezzol<strong>in</strong>i <strong>in</strong> riferimento ai<br />
contatti con la cultura straniera. Il disprezzo che Prezzol<strong>in</strong>i esprime nei confronti di una<br />
qualsiasi comunione fra culture straniere è totalmente ribaltato nello scritto di Pavese che, al<br />
contrario, cerca all’estero una possibilità di fuga dalle strettoie della cultura italiana.<br />
L’affermazione dell’idea di letteratura nazionale fu, nella prima parte del secolo, perentorio e<br />
si accompagnò al disprezzo per forme di cultura straniere. Le formulazioni <strong>in</strong>tellettuali di<br />
Pap<strong>in</strong>i e Prezzol<strong>in</strong>i fornirono un primo importante modello alle successive speculazioni<br />
sull’argomento che trovarono <strong>in</strong> epoca fascista un <strong>def</strong><strong>in</strong>itivo assestamento.<br />
Dopo la conquista del potere, Mussol<strong>in</strong>i adottò una serie di accorgimenti che avrebbero<br />
dovuto condizionare l’<strong>in</strong>tera sfera culturale italiana. Il rafforzamento e il radicamento del<br />
regime <strong>in</strong> Italia fu uno degli obiettivi primari del Duce che delegò a questo compito gli uffici<br />
della propaganda. Tutti i settori della società furono <strong>in</strong>vestiti dalla pressione della propaganda<br />
fascista ma fu il ruolo degli <strong>in</strong>tellettuali a destare, nei gerarchi fascisti, le più serie<br />
preoccupazioni. Guadagnare il sostegno degli <strong>in</strong>tellettuali non era operazione agevole ma, al<br />
35<br />
Cesare Pavese, Ritorno all’uomo, contenuto <strong>in</strong> La letteratura americana e altri saggi, Giulio E<strong>in</strong>audi Editore,<br />
Tor<strong>in</strong>o, 1951, p. 217.<br />
36<br />
Nel suo Programma Nazionalista, un discorso tenuto nel 1904, Giovanni Pap<strong>in</strong>i richiamava le coscienze degli<br />
italiani a cercare un significato più profondo nella vita e ad accordare questo nuovo significato allo spirito della<br />
nazione. Adrian Lyttelton, nei suoi studi storici sul fascismo, ha messo <strong>in</strong> evidenza come la retorica dell’arte<br />
italiana, che attra<strong>vers</strong>o la letteratura doveva edificare un modello di nazione, affonda le sue radici a <strong>in</strong>izio<br />
secolo. Lyttelton, riportando stralci del Programma nazionalista, <strong>in</strong>dividua <strong>in</strong> Pap<strong>in</strong>i un precursore di tale<br />
atteggiamento: “[…] we shall see great art and literature flourish, as we so ardently desire, as the supreme<br />
culm<strong>in</strong>ation of Italian art. Then eroic deeds and superhuman passions, nature <strong>in</strong> all its light and all its mistery,<br />
proud thoughts that wreathe the world with iron bonds, will once more reappear <strong>in</strong> the music and drama, the<br />
poetry and the metaphysics of the ris<strong>in</strong>g generation”. Lo stesso sentire e la stessa ideologia furono condivisi dal<br />
collega di Pap<strong>in</strong>i, Giuseppe Prezzol<strong>in</strong>i, che postulava “operazioni <strong>in</strong>tellettuali” <strong>in</strong> grado di mostrare agli italiani<br />
la vera natura del loro modo di pensare. Ancora Lyttelton riporta stralci degli <strong>in</strong>terventi di Prezzol<strong>in</strong>i per<br />
dimostrare come il processo della nazionalizzazione della letteratura fosse da considerarsi un processo di lunga<br />
durata e non esclusivamente di matrice fascista: “It would <strong>in</strong>deed be strange and, let us add, ridicoulus if our<br />
nationalism were a borrowed one, based on a foreign tradition and on ideas not stemm<strong>in</strong>g from our own race;<br />
[…] we must prefer ideas that have sprung from Italian m<strong>in</strong>ds and are nourished on observations based on<br />
th<strong>in</strong>gs Lat<strong>in</strong>. We have no need to hire our ideas from the French or the English […]”. Tratto da Italian<br />
Fascisms, ed. Adrian Lyttelton, Cape, London, 1973, p. 119-20.<br />
21
contempo, si reputò necessario agire nei loro confronti con attenzione e con decisione. Il<br />
fascismo dovette riconsiderare più volte la sua politica nei confronti degli <strong>in</strong>tellettuali non<br />
all<strong>in</strong>eati e, <strong>in</strong> molti casi, dovette r<strong>in</strong>unciare all’uso della forza che <strong>in</strong> altri settori si lasciava<br />
preferire ad ogni altro metodo di coercizione. Anche <strong>in</strong> questo caso la strategia<br />
“dell’<strong>in</strong>globare e reprimere” fu applicata ma con più circospezione rispetto ad altri campi;<br />
spesso e volentieri il fascismo si limitò a controllare gli <strong>in</strong>tellettuali preferendo agire nei loro<br />
confronti <strong>in</strong> modo dimostrativo piuttosto che <strong>in</strong> modo punitivo. La strategia fascista<br />
prevedeva uno stretto controllo sui mezzi d’<strong>in</strong>formazione ma lasciava una relativa libertà di<br />
pensiero agli <strong>in</strong>tellettuali <strong>in</strong>dipendenti. Il controllo sui mezzi di <strong>in</strong>formazione era, d’altra<br />
parte, molto più agevole che la censura preventiva. Fu reputato, <strong>in</strong>somma, più vantaggioso<br />
controllare i mezzi di comunicazione piuttosto che cercare il consenso o la repressione di<br />
ogni s<strong>in</strong>golo <strong>in</strong>tellettuale. Cesare Pavese, all’<strong>in</strong>domani della caduta del regime, così<br />
rievocava quei giorni <strong>in</strong> cui i contatti fra <strong>in</strong>tellettuali e popolo erano impediti: “In fondo<br />
l’<strong>in</strong>telligenza umanistica - le belle arti e le lettere - non patì sotto il fascismo; poté<br />
sbizzarrirsi, accettare c<strong>in</strong>icamente il gioco. Dove il fascismo vigilò fu nel passaggio tra<br />
<strong>in</strong>tellighenzia e popolo; tenne il popolo all’oscuro” 37 . La strategia fascista, d’altra parte,<br />
faceva notevole affidamento sulla produzione artistica e sull’appoggio degli <strong>in</strong>tellettuali. La<br />
fascistizzazione dell’arte era considerata un passo fondamentale per lo sviluppo di una<br />
coscienza fascista nella popolazione. Si può notare come, ad un certo punto della storia<br />
italiana, il dibattito artistico andò di pari passo a quello politico tanto che un <strong>in</strong>tellettuale del<br />
calibro di Walter Benjam<strong>in</strong> fu portato a parlare di “esteticizzazione della politica” 38 coniando<br />
una formula che ebbe immediato riscontro fra gli <strong>in</strong>tellettuali di opposizione. Il progetto<br />
“culturale” fascista culm<strong>in</strong>ò nel 1925 con l’organizzazione di un Congresso della Cultura<br />
Fascista <strong>in</strong> cui 250 <strong>in</strong>tellettuali italiani, fra cui Pirandello, Mar<strong>in</strong>etti e Soffici, firmarono un<br />
manifesto redatto dal filosofo Giovanni Gentile. In questo modo il progetto totalitario fascista<br />
svelò i suoi veri propositi. Tutti gli elementi della società e della cultura italiana dovevano<br />
essere fusi <strong>in</strong> una superiore unità: un’unità fascista. Gli artisti italiani ebbero il compito di<br />
dare un’immag<strong>in</strong>e “artistica” a questa predetta unità. Jeffrey T. Shapp offre una s<strong>in</strong><strong>tesi</strong> di<br />
questo processo tipico dei regimi dittatoriali:<br />
Confus<strong>in</strong>g superstructure with structure, private with public, the state with civil society, Fascism may thus be<br />
said to have ushered <strong>in</strong> a new dispensation <strong>in</strong> which all the oppositions between aesthetics and politics are swept<br />
up <strong>in</strong>to a new image politics. Neither monolithic nor homogeneous, fascism’s aesthetic overproduction relied on<br />
the ability of images to susta<strong>in</strong> contradiction and to make of paradox a productive pr<strong>in</strong>ciple 39 .<br />
La reazione degli <strong>in</strong>tellettuali che si opponevano a questo manifesto si concretizzò nella<br />
pubblicazione di un contro-manifesto redatto da Croce. Il regime non poté impedire la<br />
pubblicazione del manifesto ma da allora <strong>in</strong> poi la vita degli <strong>in</strong>tellettuali che lo firmarono fu<br />
resa particolarmente difficile e lo stesso Croce fu relegato ai marg<strong>in</strong>i dei dibattiti culturali.<br />
Mussol<strong>in</strong>i, parlando del filosofo napoletano, amava ripetere di non aver mai letto nessuno dei<br />
suoi lavori suggerendo <strong>in</strong> questo modo che Croce fosse un <strong>in</strong>tellettuale di seconda categoria.<br />
Ufficialmente Croce era dunque una voce poco importante nel panorama politico italiano e<br />
non si può, a questo punto, non ripensare alle affermazioni di Pavese riguardo le strategie di<br />
emarg<strong>in</strong>azione fasciste. Come Pavese aveva notato, la preoccupazione del regime non era<br />
tanto nei confronti del pensiero degli <strong>in</strong>tellettuali dissidenti, quanto nell’impedire loro di<br />
37 C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, cit. p. 348.<br />
38 Walter Benjam<strong>in</strong>, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, E<strong>in</strong>audi, Tor<strong>in</strong>o, 1991.<br />
39 Jeffrey T. Shapp, Epic demonstrations: Fascist Modernity and the 1931 Exhibition of the Fascist Revolution,<br />
<strong>in</strong> Fascism, Aesthetics and culture, <strong>in</strong> Richard Golsan, Fascism, Aesthetics and Culture, New England Press,<br />
Hanover, NH 1992, p.3.<br />
22
aggiungere la massa. Questo impedimento avveniva tramite i mezzi della censura e, come<br />
abbiamo visto, del discredito degli <strong>in</strong>tellettuali. Relegare gli <strong>in</strong>tellettuali ai marg<strong>in</strong>i,<br />
preferendo l’azione diretta solo nei casi più pericolosi e gravi, e lavorare per la radicazione di<br />
una cultura fascista, rappresentò la strategia del regime. Iniziative come quella della<br />
creazione dell’Istituto Nazionale di Cultura nel 1925, la creazione dell’Accademia Reale e<br />
dell’Opera Nazionale Balilla nel 1926, il progetto, capeggiato da Gentile, di scrivere una<br />
nuova Enciclopedia Italiana, hanno permesso a storici come Shapp di parlare della creazione<br />
di un’armatura istituzionale per lo sviluppo della cultura fascista (“istituzional framework for<br />
the propagation of the fascist culture” 40 ). Agire al di là di questa architettura poteva<br />
significare, per molti <strong>in</strong>tellettuali, essere totalmente esclusi da ogni tipo di comunicazione<br />
con il popolo. Molti di questi <strong>in</strong>tellettuali, come Pavese suggerisce, dovettero “accettare<br />
c<strong>in</strong>icamente il gioco”, per non essere ridotti al silenzio. Il loro consenso fu, ovviamente, solo<br />
di facciata al f<strong>in</strong>e di rimanere <strong>in</strong> contatto con un mondo dell’editoria severamente vigilato<br />
dagli uom<strong>in</strong>i del regime.<br />
Il regime fascista si dimostrò immediatamente ostile a qualsiasi tipo di contatto con le<br />
letterature straniere. Soprattutto le traduzioni erano viste con particolare diffidenza. Eppure fu<br />
proprio tramite le traduzioni che molti <strong>in</strong>tellettuali poterono esprimere il loro dissenso nei<br />
confronti del partito. Il caso di Pavese fu emblematico. Le sue traduzioni di letteratura <strong>in</strong>glese<br />
e, soprattutto, americana, si posero, s<strong>in</strong> dall’<strong>in</strong>izio, <strong>in</strong> aperta opposizione alle politiche del<br />
regime che com<strong>in</strong>ciò a sorvegliare lo scrittore attentamente 41 . V.C. Ferme ha studiato le<br />
traduzioni di Pavese proprio <strong>in</strong> relazione alla politica di nazionalizzazione della letteratura di<br />
Mussol<strong>in</strong>i <strong>in</strong>dividuando nella pratica delle traduzioni una vera e propria strategia politica:<br />
“[…] the practice of translat<strong>in</strong>g from American literature became a sub<strong>vers</strong>ive act that<br />
destabilized the dom<strong>in</strong>ant political and aesthetic discourse of the fascist era <strong>in</strong> Italy” 42 . Da<br />
questo punto di vista è da notare come Cesare Pavese fu uno dei primi <strong>in</strong>tellettuali italiani ad<br />
impegnarsi nella traduzione di testi anglo-americani e questo suo impegno può essere letto<br />
come testimonianza storica, come esperienza <strong>in</strong>dividuale e collettiva, come sfida <strong>in</strong>tellettuale<br />
e politica. Così lo stesso Pavese, a regime fascista caduto, guardava <strong>in</strong>dietro a quegli anni:<br />
Nel giro di un decennio, dal 1930 al 1940, l’Italia non solo ha fatto conoscenza di almeno mezza dozz<strong>in</strong>a di<br />
scrittori nordamericani contemporanei i cui nomi resteranno, ma ha riesumato qualcuno dei classici<br />
ottocenteschi di quella letteratura […]. Alla scoperta non mancò nemmeno quel brivido di liberazione e di<br />
scandalo, ch’è <strong>in</strong>separabile da ogni <strong>in</strong>contro con una nuova realtà e che il clima politico italiano ed europeo<br />
faceva del suo meglio per <strong>in</strong>cutere 43 .<br />
Aver a che fare con la letteratura anglo-americana rappresentava un atto sov<strong>vers</strong>ivo <strong>in</strong> se<br />
stesso, foriero di molti pericoli ma, nelle parole di Pavese, troviamo quel senso di sfida che lo<br />
portò a superare i timori:<br />
40 J. T. Shapp, Epic Demonstrations, cit. p.2.<br />
41 Procurarsi i libri, tradurli, e diffonderli non doveva rappresentare la più facile delle operazioni <strong>in</strong> quel periodo.<br />
Un programma editoriale basato sulla traduzione e sulla divulgazione di testi potenzialmente sov<strong>vers</strong>ivi doveva<br />
risultare necessariamente sospetto per il regime. Il sistema impiantato dal regime prevedeva, <strong>in</strong>fatti, una prima<br />
cernita di libri da parte del M<strong>in</strong>istero della Cultura che erano poi affidati a traduttori “fidati” (il maggior<br />
traduttore degli anni Venti era Gian Dauli), mentre il giornale Critica Fascista aveva il compito di offrire agli<br />
italiani l’esatta <strong>in</strong>terpretazione dei testi tradotti.<br />
42 Valerio Cristiano Ferme, Cesare Pavese's and Elio Vittor<strong>in</strong>i's translations from American literature: The<br />
Americanization of aesthetics and the sub<strong>vers</strong>ion of culture under the Fascist regime (Italy), Uni<strong>vers</strong>ity of<br />
California, Berkeley, 1998, p.3.<br />
43 Cesare Pavese, Richard Wright, sono f<strong>in</strong>iti i tempi <strong>in</strong> cui scoprivamo l’America, <strong>in</strong> La letteratura americana e<br />
altri saggi, cit. p. 189.<br />
23
Verso il 1930, quando il fascismo com<strong>in</strong>ciava a essere la speranza del mondo, accadde ad alcuni giovani italiani<br />
di scoprire nei suoi libri l’America, una America pensosa e barbarica, felice e rissosa, dissoluta, feconda, greve<br />
di tutto il passato del mondo, e <strong>in</strong>sieme giovane, <strong>in</strong>nocente. Per qualche anno questi giovani lessero tradussero e<br />
scrissero con una gioia di scoperta e di rivolta che <strong>in</strong>dignò la cultura ufficiale, ma il successo fu tanto che<br />
costr<strong>in</strong>se il regime a tollerare, per salvare la faccia. Si scherza? Eravamo il paese della risorta romanità dove<br />
perf<strong>in</strong>o i geometri studiavano il lat<strong>in</strong>o, il paese dei guerrieri e dei santi, il paese del Genio per grazia di Dio, e<br />
questi nuovi scalzacani, questi mercanti coloniali, questi villani miliardari osavano darci una lezione di gusto<br />
facendosi leggere discutere ammirare? Il regime tollerò a denti stretti, e stava <strong>in</strong>tanto sulla breccia, sempre<br />
pronto a profittare di un passo falso, di una pag<strong>in</strong>a più cruda, d’una bestemmia più diretta, per pigliarci sul fatto<br />
e menare la botta. Il sapore di scandalo e di facile eresia che avvolgeva i nuovi libri e i loro argomenti, il furore<br />
di rivolta e di s<strong>in</strong>cerità che anche i più sventati sentivano pulsare <strong>in</strong> quelle pag<strong>in</strong>e tradotte, riuscirono irresistibili<br />
a un pubblico non ancora del tutto <strong>in</strong>tontito dal conformismo e dall’accademia. Si può dir francamente, che<br />
almeno nel campo della moda e del gusto la nuova mania giovò non poco a perpetuare e alimentare<br />
l’opposizione politica, sia pure generica e futile, del pubblico italiano che leggeva. Per molta gente l’<strong>in</strong>contro<br />
con Caldwell, Ste<strong>in</strong>beck, Saroyan, e perf<strong>in</strong>o col vecchio Lewis, aperse il primo spiraglio di libertà, il primo<br />
sospetto che non tutto nella cultura del mondo f<strong>in</strong>isse coi fasci 44 .<br />
In questo passo si possono identificare le motivazioni di Pavese, f<strong>in</strong>anche le speranze, che<br />
animavano il suo lavoro di divulgatore di cultura. La letteratura estera, nella fattispecie del<br />
discorso quella americana, poteva ricollegarsi direttamente ad un sentimento di opposizione<br />
politica che, solo <strong>in</strong>direttamente, poteva essere manifestato. Contrastare il fascismo su un<br />
campo culturale rappresentava una possibilità effettiva di opposizione <strong>in</strong> un momento storico<br />
<strong>in</strong> cui ogni esplicito dissenso era proibito. In più combattere il regime su questo <strong>vers</strong>ante<br />
rappresentava una sfida importante nel momento <strong>in</strong> cui grossa parte della propaganda si<br />
svolgeva proprio negli ambiti culturali. Il riferimento all’America rappresentò, d’altra parte,<br />
non solo una violazione all’<strong>in</strong>terdetto fascista nei confronti della letteratura straniera ma fu<br />
anche funzionale alla proiezione della situazione italiana nella storia di un popolo che, a quei<br />
tempi, era idealmente visto come garante delle libertà:<br />
Ci si accorse, durante quegli anni di studio, che l’America non era un altro paese, un nuovo <strong>in</strong>izio della storia,<br />
ma soltanto il gigantesco teatro dove con maggiore franchezza che altrove veniva recitato il dramma di tutti. E<br />
se per un momento c’era apparso che valesse la pena di r<strong>in</strong>negare noi stessi e il nostro passato per affidarci<br />
corpo e anima a quel libero mondo, ciò era stato per l’assurda e tragicomica situazione di morte civile <strong>in</strong> cui la<br />
storia ci aveva per il momento cacciati. La cultura americana ci permise <strong>in</strong> quegli anni di vedere svolgersi come<br />
su uno schermo gigante il nostro stesso dramma. Ci mostrò una lotta accanita, consapevole, <strong>in</strong>cessante, per dare<br />
un senso un nome un ord<strong>in</strong>e alle nuove realtà e ai nuovi ist<strong>in</strong>ti della vita <strong>in</strong>dividuale e associata, per adeguare ad<br />
un mondo vertig<strong>in</strong>osamente trasformato gli antichi sensi e le antiche parole dell’uomo. Com’era naturale <strong>in</strong><br />
tempi di ristagno politico, noi tutti ci limitammo allora a studiare come quegli <strong>in</strong>tellettuali d’oltremare avessero<br />
espresso questo dramma, come fossero giunti a parlare questo l<strong>in</strong>guaggio, a narrare, a cantare questa favola.<br />
Parteggiare nel dramma, nella favola, nel problema non potevamo apertamente, e così studiammo la cultura<br />
americana un po’ come si studiano i secoli del passato, i drammi elisabettiani o la poesia dello stil nuovo 45 .<br />
L’opposizione di Pavese si costruiva dunque attra<strong>vers</strong>o i riferimenti, i rimandi, le <strong>in</strong>dirette e<br />
velate connessioni. Il regime, nella sua vigilanza, era perfettamente al corrente di tutto ciò.<br />
“Menare la botta”, così come scrive Pavese, poteva significare censura, prigione, conf<strong>in</strong>o.<br />
Pavese fu conf<strong>in</strong>ato <strong>in</strong> Calabria nel 1935 per circa 7 mesi. Ma il regime non sembrò sempre<br />
sicuro delle strategie da adottare e <strong>in</strong> più di un’occasione svelò la sua <strong>in</strong>tr<strong>in</strong>seca debolezza 46 .<br />
44<br />
Cesare Pavese, Ieri e oggi, <strong>in</strong> La letteratura americana e altri saggi, cit. pp. 193-94.<br />
45<br />
Ivi, pp. 194-95.<br />
46<br />
Il tentativo di abbracciare all’<strong>in</strong>terno dell’orbita fascista la cultura americana non portò a buoni risultati. Il<br />
primo sfortunato tentativo risale al 1920 quando l’<strong>in</strong>dustria del c<strong>in</strong>ema italiano, <strong>in</strong> grave difficoltà, lasciò spazio<br />
alle produzioni americane che, <strong>in</strong> qualche maniera, dovevano rispecchiare i valori eroici e populisti centrali nella<br />
mentalità fascista. Ferme così s<strong>in</strong>tetizza il primo affacciarsi dell’arte americana nella nostra società <strong>in</strong> quel<br />
momento storico: “(American movies) portrayed the heroic and populist values that were central to Fascist<br />
political agenda, they became immensely popular and displaced the bourgeois vision represented <strong>in</strong> most Italian<br />
24
La ricerca esistenziale di Pavese proseguì negli anni scontrandosi più volte con le direttive<br />
del regime. Per Ferme, l’opposizione politica di Pavese avvenne solo ed esclusivamente per<br />
mezzo di un’opposizione estetica. La <strong>def</strong><strong>in</strong>izione di una propria estetica, ispirata da modelli<br />
anglo-americani, si sviluppò quasi naturalmente nella direzione dell’opposizione politica:<br />
[…] (translation work) reflects a desire to experiment with a literary language that juxtaposes tradition and<br />
modernity while subvert<strong>in</strong>g the aesthetic models offered by ma<strong>in</strong>stream fascist <strong>in</strong>tellectuals.[…] Pavese used<br />
this aesthetic sub<strong>vers</strong>ion to counter not only the literary but also the political standards of his time and, for this<br />
reason, was eventually imprisoned and sent to political conf<strong>in</strong>ement 47 .<br />
Pavese elaborò dunque “un’estetica sov<strong>vers</strong>iva” che costituì uno dei mezzi di opposizione<br />
politica. Questo sovvertimento estetico, di cui Pavese non fu l’unico propugnatore, causò non<br />
pochi problemi al regime. Un gran numero di letterati e studenti si <strong>in</strong>teressarono alla<br />
letteratura anglo-americana sperimentando, direttamente, le angherie del fascismo 48 . Il<br />
regime fascista si rese immediatamente conto del pericolo di un approccio “non<br />
convenzionale” alla letteratura straniera, soprattutto americana. Lo studio della letteratura<br />
straniera si poneva come implicita espressione di un dissenso politico che altrimenti non si<br />
sarebbe potuto esprimere. Insomma si correva il pericolo di una rivoluzione culturale che<br />
avrebbe potuto, nel medio lungo term<strong>in</strong>e, sfociare, o semplicemente alimentare, un<br />
rivoluzione politica. Aver a che fare con le letterature straniere rappresentava, riprendendo gli<br />
assunti di Shapp, un nuovo modo di porsi di fronte alle sovrastrutture imposte dallo stato<br />
totalitario e di svelare il paradosso alla base dell’estetica e della politica fascista. Edw<strong>in</strong><br />
Fussel ipotizza come Pavese non si tirò <strong>in</strong>dietro dalla tentazione di utilizzare le traduzioni<br />
come vere e proprie “armi politiche” contro la fascistizzazione della cultura: “(Pavese) had,<br />
<strong>in</strong> the first <strong>in</strong>stance, the purpose of us<strong>in</strong>g American literature to subvert Italian literature,<br />
thought, sensibility, and culture” 49 .<br />
Il saggio su Melville è esemplificativo di tale atteggiamento. Pavese si espresse molto<br />
productions. The popularity of American c<strong>in</strong>ema spurred parallel <strong>in</strong>terests <strong>in</strong> other American art forms, such as<br />
jazz and blues <strong>in</strong> music and adventure novel <strong>in</strong> literature”. V.C. Ferme, Cesare Pavese's and Elio Vittor<strong>in</strong>i's<br />
translations from American literature: The Americanization of aesthetics and the sub<strong>vers</strong>ion of culture under the<br />
Fascist regime (Italy), cit. p.11.<br />
47 Ivi, p.13.<br />
48 La testimonianza di Fernanda Pivano (riportata <strong>in</strong> Fernanda Pivano, La balena bianca ed altri miti, Il<br />
Saggiatore, Milano, 1995), allieva di Pavese, mi sembra <strong>in</strong>teressante al f<strong>in</strong>e di mettere a fuoco le difficoltà<br />
pratica che la diffusione della letteratura straniera poteva <strong>in</strong>contrare <strong>in</strong> Italia. Consigliata da Pavese di lavorare<br />
sulla letteratura americana per la sua <strong>tesi</strong> la Pivano fu, da pr<strong>in</strong>cipio, ostacolata dai professori che sostenevano che<br />
“una signor<strong>in</strong>a perbene non deve <strong>in</strong>teressarsi ad argomenti così scabrosi”. Solo <strong>in</strong> seguito la Pivano poté<br />
ottenere un permesso di comporre una dissertazione su Moby Dick di Melville ma anche <strong>in</strong> questo caso le<br />
difficoltà rimasero <strong>in</strong>genti: “[…] ma mi accorsi subito che studiare gli autori americani <strong>in</strong> quegli anni era un<br />
gesto fanatico più che accademico: nelle biblioteche non c’erano testi […]. Quando dovetti compilare una<br />
bibliografia mi accorsi che non ero <strong>in</strong> grado di farlo […]. La dissertazione fu completata nel 1941 ed attirò<br />
l’attenzione dei giornali fascisti: “Un giornale fascista mi fece il complimento della sua attenzione deplorando<br />
che certa gioventù italiana trascurasse i nostri classici per dedicarsi a siffatta letteratura plutodemocratica,<br />
giudaicomassonica e così via”. Da questo episodio si ev<strong>in</strong>ce come gli <strong>in</strong>tellettuali italiani che si <strong>in</strong>teressavano di<br />
letteratura americana erano automaticamente proiettati <strong>in</strong> un contesto politico. Il clima che si respirava <strong>in</strong> quel<br />
periodo <strong>in</strong> Italia è ben riprodotto da un altro aneddoto della Pivano sul lavoro di traduttrice che svolgeva <strong>in</strong>sieme<br />
a Pavese riguardante, nella fattispecie, le peripezie affrontate per pubblicare l’Antologia di Spoon River: “Con<br />
molta fatica l’editore (E<strong>in</strong>audi) ottenne il permesso dal m<strong>in</strong>istero della Cultura Popolare: Pavese mi disse che<br />
l’autorizzazione era stata richiesta per una Antologia di S. River, confidando di conv<strong>in</strong>cere qualche funzionario<br />
che si trattasse di un’antologia di uno sconosciuto Santo River. […] Spoon River uscì <strong>in</strong> piena guerra e Pavese<br />
mi portò la prima copia <strong>in</strong> un caffè dove c’<strong>in</strong>contrammo imbacuccati f<strong>in</strong>o al naso per farci riconoscere il meno<br />
possibile”.<br />
49 Edw<strong>in</strong> Fussel, Forward to: Cesare Pavese, American Literature Essays and op<strong>in</strong>ions, Uni<strong>vers</strong>ity of California<br />
Press, Los Angeles-London, 1970, p.VI.<br />
25
criticamente <strong>in</strong> relazione all’appropriazione <strong>in</strong>debita del fascismo della sfera mitica e rigettò<br />
le teorie del primitivo di Maccari. Il motivo del primitivismo, come vedremo, fu caro non<br />
solo a Pavese ma anche ad altri <strong>in</strong>tellettuali antifascisti come Lawrence:<br />
Ora, che da qualche tempo noi si provi un gran bisogno di imbarbarimento, è pacifico. Stanno a dimostrarlo il<br />
gusto r<strong>in</strong>novato dei viaggi e dello sport, il c<strong>in</strong>ema, il jazz, l’<strong>in</strong>teresse per i negri e tutto il resto che è pers<strong>in</strong><br />
banale ricordare e che con una parola s<strong>in</strong>tetica chiamiamo antiletteratura. Ed è senza dubbio molto bello tutto<br />
ciò. Ma è il modo che offende. Poiché mi pare che, nel fervore antiletterario, si tenda a un tal primitivismo che è<br />
quasi imbecillità. Debolezza, voglio dire: è vile fuggire le complicazioni <strong>in</strong> un paradiso semplicistico che dopo<br />
tutto, come è <strong>in</strong>teso, non è che uno dei tanti raff<strong>in</strong>amenti della civiltà 50 .<br />
Sull’altro <strong>vers</strong>ante Melville e gli americani erano depositari di un reale primitivismo che si<br />
ricollegava direttamente al concetto di una primaria e <strong>in</strong>corrotta conoscenza del mondo:<br />
Loro sì, hanno saputo r<strong>in</strong>novarsi, passando la cultura attra<strong>vers</strong>o l’esperienza primitiva, reale, ma non, com’è<br />
l’andazzo da noi, r<strong>in</strong>negando un term<strong>in</strong>e per l’altro, bensì, attra<strong>vers</strong>o ciò che si chiama la vita, arricchendo,<br />
temprando e potenziando la letteratura. Un pensiero non significa nulla di nulla se non è pensato con tutto il<br />
corpo, questa è bene una sentenza americana e a quest’ideale tutta la tradizione degli Stati, da Thoreau a<br />
Sherwood Anderson, consciamente o <strong>in</strong>consciamente mira, riuscendo alla creazione di poderosi <strong>in</strong>dividui che<br />
passano un buon numero d’anni barbaramente, vivendo e assorbendo, e poi si danno alla cultura, rielaborando la<br />
realtà sperimentata <strong>in</strong> pensieri ed immag<strong>in</strong>i che per la loro dignità e per la schiettezza serena e virile, han<br />
qualcosa di quell’equilibrio che usiamo chiamar greco. Siamo ben lontani dai paradisi artificiali che accolgono<br />
<strong>in</strong> capo al mondo i nostri rimbarbariti schizz<strong>in</strong>osi 51 .<br />
Un primitivo che Pavese pose immediatamente a confronto con quello <strong>in</strong>tellettualoide e<br />
autocompiacente tanto di moda <strong>in</strong> Italia:<br />
Poiché questo è curioso <strong>in</strong> Moby Dick e Melville: benché si tratti di un’opera ispirata da esperienze di vita quasi<br />
barbarica, ai conf<strong>in</strong>i della terra, Melville non è mai un pagliaccio che si metta a f<strong>in</strong>gere anche lui il barbaro e il<br />
primitivo, ma, dignitoso, coraggioso, non si spaventa di rielaborare quella vita verg<strong>in</strong>e attra<strong>vers</strong>o tutto lo scibile<br />
della terra. Poiché credo ci voglia meno coraggio ad affrontare un capodoglio o un tifone che a rischiare di<br />
passar per un pedante o un letterato 52 .<br />
I riferimenti al mito e alle sue figure simboliche, tra cui il selvaggio, erano utilizzati dagli<br />
<strong>in</strong>tellettuali fascisti per l’edificazione di una vera arte nazionale. Il mito dell’antica Roma e<br />
della razza italica rappresentarono, per Pavese, degenerazioni <strong>in</strong>tellettuali dettate da un<br />
preciso progetto politico e da malcelati <strong>in</strong>teressi pratici: “Fessi gli etnologi che credono basti<br />
accostare le masse alle varie culture del passato -e del presente- per avvezzarle a capire e<br />
tollerare e uscire dal razzismo, dal nazionalismo, dall’<strong>in</strong>tolleranza. Le passioni collettive sono<br />
mosse da esigenze d’<strong>in</strong>teressi che si travestono di miti razziali e nazionali. E gli <strong>in</strong>teressi non<br />
si cancellano” 53 . Il mito dell’antichità è dunque funzionale, nella speculazione fascista, alla<br />
giustificazione della propaganda nazionalistica. Il riferimento a Melville è, sotto questo<br />
aspetto, sottilmente centrato. La stessa ciurma del Pequod è, <strong>in</strong>fatti, un progetto<br />
<strong>in</strong>ternazionalista <strong>in</strong> se stesso. Individui da ogni parte del mondo, <strong>in</strong> rappresentazione<br />
dell’umanità <strong>in</strong>tera, partecipano alla caccia. Buona parte del libro è dedicata alla descrizione<br />
50<br />
Cesare Pavese, Herman Melville, Il baleniere letterato, <strong>in</strong> Letteratura americana e altri saggi, cit. p. 77.<br />
51<br />
Ivi, p. 78.<br />
52<br />
Ivi, pp. 94-95.<br />
53<br />
C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, 1 Marzo 1946, cit. p. 311.<br />
26
di questa multi-etnicità e alle relazioni fra le persone. Umanità e natura sono dunque i<br />
personaggi pr<strong>in</strong>cipali del capolavoro di Melville. La caccia a Moby Dick assume i toni di una<br />
caccia mitica <strong>in</strong> cui tutta l’umanità è co<strong>in</strong>volta. La decadenza della cultura europea fa sì che<br />
gli <strong>in</strong>tellettuali si rivolgano a scrittori come Melville per esprimere la loro ansia di<br />
riconciliazione e d’amore per la vita: “Noi, figli dell’Ottocento, abbiamo nelle ossa il gusto<br />
delle avventure, del primitivo, della vita reale, che seguono e succedono alla cultura e ci<br />
liberano dalle complicazioni facendo da cataplasma all’animuccia decadente, malata di<br />
civiltà: i nostri eroi si chiamano ancora Rimbaud, Gaugu<strong>in</strong> e Stevenson” 54 .<br />
Quella di Pavese è dunque una fuga, l’ennesimo viaggio, da una cultura, quella fascista che si<br />
riteneva depositaria della verità e che imponeva la propria s<strong>in</strong>gola idea al di sopra della<br />
complessità dell’esistente. Moby Dick divenne un “poema del dest<strong>in</strong>o” <strong>in</strong> cui i protagonisti<br />
non erano eroi sovraumani ed ideali. L’unico protagonista di questo romanzo, romanzo della<br />
vita, “è il rottame umano” 55 che, con una “fiera sete di libertà <strong>in</strong>teriore” 56 , va <strong>in</strong>contro al suo<br />
dest<strong>in</strong>o. Anche <strong>in</strong> questo caso si può riscontrare il parallelo fra <strong>in</strong>teressi <strong>in</strong>dividuali e<br />
collettivi nel momento <strong>in</strong> cui il romanzo di Moby Dick viene colto nella sua possibilità di<br />
sondare il lato oscuro, la metà del mondo che “deve restare un mistero” 57 . L’enigma<br />
dell’essere umano e la tragedia della vita contemporanea sono contemplati <strong>in</strong> piena libertà;<br />
approfondire la crisi <strong>in</strong>teriore dell’<strong>in</strong>dividuo può apparire una pratica del tutto decadente per<br />
l’uomo fascista costruito su artificiali certezze.<br />
L’arte di regime e il prov<strong>in</strong>cialismo della cultura italiana rappresentarono i più grandi ostacoli<br />
alla formazione di Pavese e alla diffusione della sua opera. Nonostante gli <strong>in</strong>numerevoli<br />
impedimenti, lo scrittore assunse un ruolo che potremmo dire di mediazione. Pavese<br />
rappresentò la s<strong>in</strong><strong>tesi</strong> dell’<strong>in</strong>tellettuale italiano del periodo che, chiuso nel prov<strong>in</strong>cialismo e<br />
nel classicismo del suo paese, espresse delle esigenze che trovarono risposte nella letteratura<br />
straniera. La sua poetica composita è <strong>in</strong>quadrata da Sal<strong>in</strong>ari nell’ambito del più grande<br />
scenario europeo:<br />
Pavese è il punto di approdo del decadentismo italiano, la conclusione del processo di revisione della nostra<br />
cultura letteraria che ebbe <strong>in</strong>izio negli ultimi decenni del secolo scorso. Alludiamo a quel processo cosi detto di<br />
sprov<strong>in</strong>cializzazione, di assorbimento cioè delle esperienze decadenti della letteratura europea (francese, russa,<br />
<strong>in</strong>glese e americana) [...] che bruciò f<strong>in</strong>o <strong>in</strong> fondo le esperienze e i miti decadenti soltanto con Pavese 58 .<br />
Pavese perse presto <strong>in</strong>teresse nei confronti della letteratura americana. America e fascismo si<br />
svelarono essere entità strettamente legate rappresentando, abbastanza ironicamente, la stessa<br />
coppia di <strong>in</strong>separabili che erano Ahab e la balena bianca nel romanzo di Melville. La morte di<br />
uno dei due poli poteva costituire una seria m<strong>in</strong>accia alla sopravvivenza dell’altro. Pavese,<br />
all’<strong>in</strong>terno di uno di quegli schemi mitici che amava disegnare, espresse così questa idea:<br />
A esser s<strong>in</strong>ceri <strong>in</strong>somma ci pare che la cultura americana abbia perduto il magistero, quel suo <strong>in</strong>genuo e sagace<br />
furore che la metteva all’avanguardia del nostro mondo <strong>in</strong>tellettuale. Né si può non notare che ciò co<strong>in</strong>cide con<br />
la f<strong>in</strong>e, o sospensione, della sua lotta antifascista. […] Ma senza un fascismo a cui opporsi, senza cioè un<br />
pensiero storicamente progressivo da <strong>in</strong>carnare, anche l’America, per quanti grattacieli e automobili e soldati<br />
produca, non sarà più all’avanguardia di nessuna cultura. Senza un pensiero e senza lotta progressiva, rischierà<br />
anzi di darsi essa stessa a un fascismo, e sia pure nel nome delle sue tradizioni migliori 59 .<br />
54<br />
C. Pavese, Herman Melville, Il baleniere letterato, <strong>in</strong> Letteratura americana e altri saggi, cit. p. 77.<br />
55<br />
Ivi p. 78.<br />
56<br />
Ivi, p. 80.<br />
57<br />
Ivi, p. 83.<br />
58<br />
Mauro Ponzi, La critica e Pavese, Cappelli Editore, Bologna, 1977.<br />
59<br />
Cesare Pavese, Ieri e ogg , cit. pp. 195-96.<br />
27
L’operazione culturale di Pavese, il suo rivolgersi <strong>vers</strong>o una letteratura <strong>in</strong>ternazionale, <strong>in</strong><br />
primo luogo americana e <strong>in</strong>glese, ebbe dunque importanti implicazioni politiche. Il suo<br />
impegno mirò a scard<strong>in</strong>are il regime dalle fondamenta attra<strong>vers</strong>o una strategia di<br />
sovvertimento culturale. Un’operazione culturale che non cercò lo scontro frontale ma che,<br />
tramite il riferimento ad “un altro mondo”, <strong>in</strong>tendeva far <strong>in</strong>travedere agli italiani un “primo<br />
spiraglio di libertà” e <strong>in</strong>culcar loro “il primo sospetto che non tutto nella cultura del mondo<br />
f<strong>in</strong>isse coi fasci”.<br />
Il ruolo dell’Italia, nell'ambito dell’evoluzione di un’ipotetica scuola modernista, fu, dunque,<br />
del tutto orig<strong>in</strong>ale e legato alla sua particolare evoluzione storica. Se si volesse <strong>def</strong><strong>in</strong>ire il<br />
“modernismo” come movimento <strong>in</strong>tellettuale legato al disagio provocato a livello sociale e<br />
culturale dal fenomeno della “modernità” non si potrebbe negare l’esistenza di un “filone<br />
italiano”. Il ruolo troppo spesso marg<strong>in</strong>ale, anche <strong>in</strong> relazione all’isolamento politico e al<br />
progetto fascista di nazionalizzazione della letteratura, tenuto dall’Italia <strong>in</strong> quegli anni,<br />
giustifica una fondamentale estraneità ai grandi movimenti culturali europei. Eppure, anche<br />
se a questo stadio della nostra analisi non si può parlare di un vero e proprio movimento<br />
modernista <strong>in</strong> Italia, si ha l'impressione che il nostro paese e i suoi <strong>in</strong>tellettuali non furono del<br />
tutto tagliati fuori dalla kermesse europea. In questo senso sono più i modi della critica<br />
tradizionale italiana di stampo idealistico a isolare la nostra letteratura dal contesto europeo.<br />
L’ipo<strong>tesi</strong> è che gli scrittori italiani ebbero un ruolo comunque importante nell'ambito del<br />
movimento modernista. Ci si riferisce, <strong>in</strong> questo caso, a scrittori quali Pirandello, Svevo,<br />
Moravia, Primo Levi, che furono considerati veri e propri “modernisti” da una parte della<br />
critica estera. Nel caso di Cesare Pavese ci si troverà a fare i conti con un autore che, dopo<br />
aver recepito e rielaborato gli <strong>in</strong>flussi del modernismo europeo (soprattutto quello<br />
anglosassone), non vide riconosciuto il suo sforzo a livello europeo. La sua opera rimarrà<br />
conf<strong>in</strong>ata <strong>in</strong> Italia ma non per questo i suoi legami con il modernismo appaiono più<br />
superficiali.<br />
Un ulteriore tratto da sottol<strong>in</strong>eare riguardo “l'isolamento italiano” è senz’altro quello relativo<br />
ai modi della critica. La critica ebbe il ruolo fondamentale di <strong>in</strong>fluenzare la ricezione delle<br />
opere letterarie ponendosi il compito di educare il lettore alla fruizione 60 . L’anomalia italiana<br />
sembra essere costituita dal fatto che i lettori, abituati ad un determ<strong>in</strong>ato tipo di lettura delle<br />
opere, non abbiano condiviso lo stesso orizzonte d’attesa europeo. La concezione di un<br />
romanzo come espressione dell’uomo di fronte al suo mondo, come ricerca esistenziale,<br />
sociale e morale, non sembrò prendere piede <strong>in</strong> Italia dove vigeva una critica idealista di<br />
stampo crociano. La “poetica modernista” nacque e si sviluppò <strong>in</strong> relazione ai disagi<br />
dell’<strong>in</strong>dividuo di fronte al dilagare della modernità; i testi letterari modernisti rimandavano,<br />
di conseguenza, <strong>in</strong> cont<strong>in</strong>uazione all’extraletterario e da questo non potevano presc<strong>in</strong>dere. La<br />
presenza di temi ricorrenti all’<strong>in</strong>terno della letteratura europea rende possibile uno studio<br />
comparato delle opere, ma l’impressione è che la critica ufficiale italiana abbia rappresentato<br />
una sorta di ostacolo allo sviluppo di “tematiche europee” 61 . La poetica di un autore si<br />
60<br />
La produzione letteraria si basa anche su quello che H.R. Jauss ha <strong>def</strong><strong>in</strong>ito l’“orizzonte d'attesa”. H.R. Jauss,<br />
Estetica della ricezione, Napoli, Guida, 1988.<br />
61<br />
Sulla necessità di una, pur arbitraria periodizzazione, sul rifiuto dello studio dell'opera <strong>in</strong> se stessa per uno<br />
sguardo più ampio, generico ed uni<strong>vers</strong>ale sulla storia dell'uomo e delle sue manifestazioni, mi sembra<br />
assolutamente significativa la polemica di Mario Praz nei confronti della critica ufficiale italiana all'epoca<br />
dell'uscita del suo La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica (1930). L'idea che la critica<br />
italiana <strong>in</strong>fluenzasse la ricezione e la produzione letteraria italiana <strong>in</strong> modo univoco, limitando quella che poteva<br />
rappresentare una fondamentale apertura <strong>vers</strong>o altre culture, era ben presente all'epoca dell'uscita del fortunato<br />
volume di Praz. Il paradosso nasce, <strong>in</strong> questo caso, dal fatto che il testo di critica di Praz rappresenti il “primo<br />
modello degli studi tematici <strong>in</strong>tertestuali” che riscosse, a livello europeo, una fama e un successo del tutto<br />
<strong>in</strong>aspettati. Il ruolo svolto da questo libro nell'Italia degli anni Trenta fu particolarmente importante al f<strong>in</strong>e delle<br />
nostre riflessioni <strong>in</strong> quanto si schierò apertamente contro la critica estetico-idealista di stampo crociano mettendo<br />
<strong>in</strong> discussione un modello che f<strong>in</strong>o a quel momento non aveva temuto attacchi. Nel saggio <strong>in</strong>titolato Costanti<br />
tematiche, varianti estetiche e precedenti storici (1996) contenuto <strong>in</strong> Mario Praz, La carne, la morte e il diavolo,<br />
28
doveva analizzare nel contesto della sua sensibilità personale e alla luce del suo talento.<br />
Contro questo tipo di <strong>in</strong>terpretazione si mossero critici quali Mario Praz sottol<strong>in</strong>eando che il<br />
vero limite della critica idealistica era quello di voler escludere altri tipi di <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e, come<br />
quella tematica 62 . Scrittori e critici non potevano non correlarsi, positivamente e<br />
negativamente, a quelle che erano le posizioni di Croce. E’ possibile che l’<strong>in</strong>fluenza di questo<br />
tipo di critica sia stato uno degli elementi che ostacolò il diffondersi del modernismo <strong>in</strong> Italia<br />
e che di conseguenza limitò il campo d’azione degli scrittori italiani che a tale movimento si<br />
potevano, <strong>in</strong> qualche modo, relazionare. Ma quanto si possono collegare i maggiori scrittori<br />
italiani della prima metà del Novecento al movimento europeo del modernismo? E' questa<br />
una domanda a cui si cercherà parzialmente di rispondere tramite l’approfondimento del caso<br />
di Cesare Pavese. La frequentazione degli scrittori modernisti da parte degli italiani risultava<br />
<strong>in</strong>visa al regime mentre la critica ufficiale sposava altri modelli estetici.<br />
Nonostante le difficoltà descritte f<strong>in</strong>ora, le connessioni tra il modernismo europeo ed alcuni<br />
dei nostri maggiori scrittori sono spesso evidenti. Spesso queste connessioni vengono<br />
sottol<strong>in</strong>eate ma non sempre approfondite nella direzione della comparazione dei temi. Troppo<br />
spesso, <strong>in</strong>somma, gli scrittori italiani vengono descritti come isole di ispirazione: senza voler<br />
<strong>in</strong>dagare l’extratesto che circonda i loro testi tali scrittori cont<strong>in</strong>ueranno a rimanere delle<br />
Sansoni, Milano, 1996, Francesco Orlando sottol<strong>in</strong>ea il ruolo di “rottura” svolto da un testo di critica letteraria<br />
che si occupasse, <strong>in</strong> maniera programmatica, di un extratesto, <strong>in</strong> un paese <strong>in</strong> cui il crocianesimo aveva<br />
rappresentato il fondamentale modello di giudizio estetico:[...] qualsiasi letteratura -non ci dissuada dal<br />
riconoscerlo nessuno dei due opposti pregiudizi- deriva nello stesso tempo da precedente letteratura e da<br />
precedente realtà extraletteraria. Studi formali hanno a che fare soltanto col primo tipo di derivazione, studi<br />
tematici anche col secondo. Gli uni hanno il gioco meno difficile degli altri <strong>in</strong> quanto il rapporto fra letteratura e<br />
letteratura è omogeneo, mentre il rapporto fra letteratura e realtà non lo è. Gli uni si connotano facilmente come<br />
rigorosi e gli altri come sospetti, <strong>in</strong> Italia dove è documentabile con nomi di maestri una cont<strong>in</strong>uità per<br />
trasfusione fra il mezzo secolo d'idealismo crociano e la prevalenza di vari formalismi i questa f<strong>in</strong>e di secolo”.<br />
La consapevolezza dell'esistenza di tematiche “uni<strong>vers</strong>ali”, costituenti oggetto privilegiato di <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e<br />
<strong>in</strong>tellettuale ed elaborazione artistica, si contrappose, <strong>in</strong> maniera risoluta e provocatoria, al cospetto della critica<br />
ufficiale italiana: “All'estremo di quel rigore idealistico per cui non contava nessuna costante se non il giudizio<br />
di valore, una m<strong>in</strong>accia di afasia viene denunciata dopo una pag<strong>in</strong>a: “Che questa poi [l'opera], ai f<strong>in</strong>i del<br />
godimento estetico, costituisca un mondo unico <strong>in</strong> se conchiuso, esaurito e perfetto, un <strong>in</strong>dividum <strong>in</strong>effabile, è<br />
una verità che non lascerebbe al critico altra alternativa di un mistico silenzio ammirativo”. La necessità di<br />
riconsegnare l'opera letteraria al suo contesto storico, e di studiarla <strong>in</strong> relazione al mondo dal quale scaturisce e<br />
sul quale getta il suo sguardo critico, rappresentava un nuovo attacco all'estetica idealista: “Un altro postulato<br />
crociano di cui Praz è costretto a scuotere la paralisi, nella frase stessa che gli rende omaggio formale, è<br />
l'uni<strong>vers</strong>alità o “eterna contemporaneità” dell'opera d'arte. Quel postulato rischia di secondare “<strong>in</strong>terpretazioni<br />
arbitrarie e fantastiche” [...]. La difficoltà era di ammettere che la grande poesia non si spalanchi sull'uni<strong>vers</strong>ale<br />
senza nutrirsi di tutto ciò che segna la sua data e la sua congiuntura, e svelarlo, e farlo durare”. Il punto di un<br />
critico letterario “europeo” come Praz nei confronti della critica “ufficiale italiana” della prima metà del<br />
Novecento mi sembra particolarmente <strong>in</strong>teressante al f<strong>in</strong>e di comprendere quanto l'estetica idealistica fosse<br />
radicata <strong>in</strong> Italia e quanto esercitasse un ruolo direi quasi coercitivo nei confronti del gusto e della produzione<br />
letteraria. Un <strong>in</strong>tellettuale <strong>in</strong>teressato ai movimenti letterari europei, <strong>in</strong>teressato alle tematiche che queste culture<br />
producevano al f<strong>in</strong>e di poter r<strong>in</strong>tracciare delle costanti, non può non trovarsi <strong>in</strong> enorme disagio nei confronti di<br />
tale critica. Ancora nell' Avvertenza alla seconda edizione (1942) di La carne la morte e il diavolo nella<br />
letteratura romantica Praz si trova a polemizzare <strong>in</strong> questo modo: “Occorrerà avvertire f<strong>in</strong> dall'<strong>in</strong>izio, che la<br />
presente opera non può <strong>in</strong>teressare che <strong>in</strong>direttamente la critica estetica, almeno nella forma <strong>in</strong> cui questa critica<br />
s'è venuta precisando <strong>in</strong> Italia nel nostro tempo” mentre <strong>in</strong> una Nota alla qu<strong>in</strong>ta edizione (1976) si legge: “La<br />
presente opera ha avuto molta fortuna all'estero, specialmente nei paesi anglosassoni [...]. Va tenuto presente che<br />
quest'opera è stata scritta prima del 1930, quando di tipologie ed archetipi poco o punto si parlava; ha perciò,<br />
sotto quest'aspetto, un carattere pioneristico. [...]. In Italia la penetrazione è stata assai più lenta, ostacolata <strong>in</strong> un<br />
primo tempo dalla critica d'<strong>in</strong>dirizzo idealistico”.<br />
62 Lo studio estetico di un'opera letteraria è senz'altro da affiancare agli studi tematici ed extratestuali così come<br />
Praz sottol<strong>in</strong>ea nell' Avvertenza del 1942: “[...] bisogna pure riconoscere che lo studio di uno di codesti aspetti<br />
non vuole negare la presenza di altri; quel che mi pare discutibile è il modo <strong>in</strong> cui il Croce vorrebbe fissarne<br />
l'<strong>in</strong>dipendenza”.<br />
Tramite lo studio di questa documentazione che riporta la polemica, sul <strong>vers</strong>ante critico-letterario, di due grosse<br />
personalità del panorama <strong>in</strong>tellettuale italiano, si è voluto mettere <strong>in</strong> luce quanto il pensiero crociano fosse<br />
importante ed impresc<strong>in</strong>dibile.<br />
29
immag<strong>in</strong>i ideali, <strong>in</strong> perenne attesa di collocazione. L’idea che l’esclusione degli scrittori<br />
italiani dal movimento letterario del modernismo europeo sia dovuto più ai modi della critica<br />
ufficiale coeva ed a una serie di cont<strong>in</strong>genze politico-sociali che ad un effettivo loro<br />
dis<strong>in</strong>teresse nei confronti della grande kermesse culturale europea, sembra trovare più di una<br />
giustificazione. Insomma la domanda che sorge spontanea è questa: <strong>in</strong> che misura si può<br />
parlare di una modernità <strong>in</strong> Italia? Si può parlare di scrittori italiani che si rapportarono al<br />
fenomeno del modernismo europeo rielaborandone forme e contenuti? La critica<br />
contemporanea sta rivalutando e riscoprendo molti degli scrittori che segnarono, <strong>in</strong> Italia, le<br />
tappe di un nuovo sentire che si potrebbe, per l'appunto, <strong>def</strong><strong>in</strong>ire moderno.<br />
30
2 L’ETA’ DEL “NEOMITOLOGISMO”<br />
2.1 Un’era mitologica<br />
L’elaborazione delle concezioni mitiche fu di enorme importanza per molti scrittori<br />
modernisti. Tutta la riflessione sul mito si pone alla base dell’ipo<strong>tesi</strong> di voler <strong>def</strong><strong>in</strong>ire le<br />
direttrici pr<strong>in</strong>cipali di un movimento così difficilmente <strong>in</strong>quadrabile. La centralità di questo<br />
argomento si riassume nella <strong>def</strong><strong>in</strong>izione di Lotman che ha parlato dell’età moderna come<br />
dell’età del neomitologismo.<br />
Per Lotman gli <strong>in</strong>flussi che la speculazione mitologica ebbe sugli <strong>in</strong>tellettuali dell’epoca<br />
furono importantissimi e riguardano non solo coloro i quali <strong>in</strong>trapresero studi specifici sul<br />
mito ma anche coloro i quali subirono <strong>in</strong>direttamente l’<strong>in</strong>fluenza di questa kermesse<br />
<strong>in</strong>tellettuale ritrovandosi a “mitologizzare” il loro materiale quasi <strong>in</strong>consapevolmente.<br />
Insomma si potrebbe parlare di una vera coscienza mitopoietica che molti <strong>in</strong>tellettuali<br />
modernisti ebbero <strong>in</strong> comune. Questo appunto “generalizzante” di Lotman fa comprendere<br />
quanto il dibattito <strong>in</strong>torno alle categorie del mito fosse forte al passaggio dei secoli XIX e XX<br />
<strong>in</strong> un momento <strong>in</strong> cui la coscienza mitopoietica si basò <strong>in</strong> parte su una reazione al modello<br />
positivista e <strong>in</strong> parte sull’evoluzione del modello romantico:<br />
Un nuovo sviluppo dell’<strong>in</strong>teresse culturale per il mito si ha nella seconda metà del secolo XIX, soprattutto negli<br />
ultimi anni dell’800 e all’<strong>in</strong>izio del 900. La crisi del Positivismo, la delusione prodotta dalla metafisica e dalle<br />
vie di conoscenza analitiche, la critica che partiva già dal Romanticismo contro il mondo borghese considerato<br />
antieroico e antiestetico per eccellenza, hanno prodotto il tentativo di resuscitare una percezione del mondo<br />
<strong>in</strong>tegrale, arcaica, immersa nel mito 63 .<br />
Soprattutto l’aggettivo <strong>in</strong>tegrale, sottol<strong>in</strong>eato col corsivo dallo stesso Lotman, appare<br />
importante al proseguo dello studio. Negli scritti dei modernisti <strong>in</strong>glesi, così come <strong>in</strong> quelli di<br />
Pavese, si r<strong>in</strong>traccia una tendenza <strong>vers</strong>o questa <strong>in</strong>tegralità che verrebbe <strong>in</strong>tesa come un<br />
pr<strong>in</strong>cipio unitario posto alle basi dello scibile umano. In questo modo qualsiasi impressione ed<br />
espressione dell’essere umano, verrebbe a trovare un senso ultimo, basilare, <strong>in</strong> regole<br />
preesistenti al mondo moderno che, al contrario, stabilisce regole arbitrarie. L’<strong>in</strong>tegrazione,<br />
per gli <strong>in</strong>tellettuali modernisti, sarebbe dunque rappresentata dalla riscoperta delle leggi della<br />
natura e dalla loro <strong>in</strong>terpretazione tramite il ricorso al mito. La ricerca di una nuova unità<br />
esistenziale si espleta, come vedremo nei casi di Lawrence e Pavese, nel tentativo di <strong>def</strong><strong>in</strong>ire<br />
una nuova concezione spazio-temporale e una nuova “filosofia della vita” 64 che avrebbero<br />
dovuto confluire nell’unico grande disegno artistico dell’opera d’arte mitologica. Queste<br />
nuove posizioni <strong>in</strong>tellettuali, che “generano il tentativo di organizzare tutte le forme della<br />
coscienza come mitopoietiche” 65 , trovarono uno sbocco privilegiato proprio nella<br />
composizione artistica. Gli <strong>in</strong>tellettuali modernisti, forti delle ricerche <strong>in</strong>tegralizzanti condotte<br />
nei vari campi del sapere, si avviarono a stabilire un pr<strong>in</strong>cipio di panestetismo che entra <strong>in</strong><br />
diretto rapporto con il neomitologismo. E’ un rapporto che Lotman così <strong>def</strong><strong>in</strong>isce: “l’idea cioè<br />
della natura estetica dell’esistenza e del mito estetizzato come mezzo per penetrare più<br />
63 Jurij M. Lotman – Z. M<strong>in</strong>c, Letteratura e Mitologia, <strong>in</strong> Jurij Lotman, La semiosfera, Marsilio editori,<br />
Venezia, 1985, p. 218.<br />
64 Ivi, p. 219.<br />
65 Ibidem.<br />
31
profondamente nel suo segreto” 66 . Il neomitologismo impegna l’epoca della modernità e<br />
estende la sua <strong>in</strong>fluenza nella prima metà del XX secolo:<br />
[…] la specificità del modo contemporaneo di rivolgersi alla mitologia si è rivelata alla f<strong>in</strong>e del secolo XIX –<br />
<strong>in</strong>izio del secolo XX – <strong>in</strong> particolare negli anni trenta e dopo – nella creazione di opere come i romanzi miti, i<br />
drammi miti, i poemi miti. In queste opere propriamente neomitologiche il mito non appare <strong>in</strong> l<strong>in</strong>ea di pr<strong>in</strong>cipio<br />
l’unica l<strong>in</strong>ea della narrazione, né l’unico punto di vista del testo. Esso si <strong>in</strong>contra ed entra <strong>in</strong> rapporti complessi<br />
sia con altri miti, che danno altro colorito alla narrazione, sia con temi della storia o della contemporaneità. […]<br />
Il nucleo delle opere neomitologiche è tuttavia composto da quelle <strong>in</strong> cui il mito ha la funzione di l<strong>in</strong>guaggio<br />
<strong>in</strong>terpretante della storia e della contemporaneità, e questi ultimi svolgono il ruolo di quel materiale caotico ed<br />
eterogeneo, che è oggetto di un’<strong>in</strong>terpretazione sistematizzante 67 .<br />
L’analisi di Lotman presenta di<strong>vers</strong>i punti di <strong>in</strong>teresse. Andando oltre l’analisi specifica delle<br />
s<strong>in</strong>gole opere e dei s<strong>in</strong>goli autori, Lotman parla di neomitologismo come di un fenomeno<br />
generico che, <strong>in</strong> di<strong>vers</strong>e forme e con di<strong>vers</strong>i modelli, fu attivo lungo i b<strong>in</strong>ari dell’<strong>in</strong>tera cultura<br />
occidentale. Questa considerazione, <strong>in</strong>sieme alla precedente per cui ci furono scrittori che<br />
adottarono sistemi mitici quasi <strong>in</strong>consapevolmente, ci pone di fronte alla considerazione che il<br />
fenomeno culturale del neomitologismo abbia avuto una portata <strong>in</strong>gente. L’altra<br />
considerazione che nasce dalla lettura di questo passaggio è proprio <strong>in</strong>torno alla parola<br />
neomitologismo. Lotman non parla di semplice ritorno alla mitologia ma implica, nella sua<br />
<strong>def</strong><strong>in</strong>izione, un forte elemento di novità. La peculiarità del fenomeno risiede dunque nel<br />
miscelare sapientemente, artisticamente, le strutture della mitologia classica con le nuove<br />
esigenze conoscitive della realtà contemporanea. E’ un rapporto, quello tra classico e<br />
moderno, a cui fu particolarmente attento Pavese così come si potrà vedere nel proseguo dello<br />
studio e <strong>in</strong> particolar modo nel capitolo dedicato alla composizione dei Dialoghi con Leucò.<br />
L’<strong>in</strong>contro tra le strutture classiche del mito e quelle della modernità condurrà gli autori a<br />
differenti risultati. A livello tematico la vena apocalittica-utopica, che tale <strong>in</strong>contro alimenta<br />
<strong>in</strong> Lawrence, non si riscontrerà, per esempio, <strong>in</strong> Pavese che lascerà poco spazio alle utopie per<br />
approfondire f<strong>in</strong>o <strong>in</strong> fondo (anche <strong>in</strong> questo caso però si potrebbe parlare di tendenza<br />
apocalittica) il lato tragico dell’esistenza. La differenza che si può riscontrare negli approcci<br />
degli autori ad un comune materiale mitico non fa che rafforzare l’idea espressa da Lotman di<br />
un <strong>in</strong>teresse <strong>in</strong>tellettuale diffuso per il recupero e la rielaborazione di un pensiero mitologico<br />
nell’epoca moderna:<br />
Nell’arte del XX secolo il neomitologismo ha elaborato anche la sua poetica <strong>in</strong>novatrice, che è il risultato<br />
dell’<strong>in</strong>fluenza delle strutture dei riti e del mito e <strong>in</strong>oltre delle teorie etnologiche e folkloriche contemporanee.<br />
Alla sua base c’è la concezione ciclica del mondo, l’eterno ritorno (Nietzsche). Nel mondo degli eterni ritorni <strong>in</strong><br />
ogni fenomeno del presente traspaiono le sue <strong>in</strong>carnazioni passate e future. Il mondo è pieno di corrispondenze<br />
(Blok): bisogna solo essere capaci di vedere negli <strong>in</strong>numerevoli guizzi delle maschere (la storia, la<br />
contemporaneità) l’Immag<strong>in</strong>e che <strong>in</strong> essi si <strong>in</strong>travede dell’unità uni<strong>vers</strong>ale (<strong>in</strong>carnata nel mito). Proprio per<br />
questo ogni s<strong>in</strong>golo fenomeno segnala l’<strong>in</strong>numerevole quantità di altri fenomeni, appare la loro immag<strong>in</strong>e, il loro<br />
simbolo 68 .<br />
Lo stesso ruolo del mito potrà variare a seconda dell’<strong>in</strong>terpretazione personale dell’autore: “il<br />
mito è portatore della coscienza naturale, non alterata della civiltà, e dell’uomo primigenio, il<br />
mito è l’immag<strong>in</strong>e del mondo dei Primi eroi e dei Primi avvenimenti, che variano nelle<br />
<strong>in</strong>f<strong>in</strong>ite collisioni della storia; la mitologia è la materializzazione dell’<strong>in</strong>conscio collettivo<br />
66 Ibidem.<br />
67 Ivi, p. 222.<br />
68 Ivi, p. 223.<br />
32
secondo Jung e un’eterogenea enciclopedia di archetipi ecc.” 69 . All’<strong>in</strong>terno di questo sistema,<br />
<strong>def</strong><strong>in</strong>ito per grandi l<strong>in</strong>ee, si può avere una prima idea della consistenza di una nuova coscienza<br />
mitopoietica che si diffuse <strong>in</strong> Europa tra la seconda metà dell’Ottocento e la prima metà del<br />
Novecento. Considerati tutti i contributi che <strong>in</strong>tervennero alla formazione di questa nuova<br />
coscienza (etnologia, filosofia, psicologia etc.), si può facilmente comprendere quanto vari<br />
potessero essere i risultati artistici prodotti dall’approccio <strong>in</strong>dividuale dei di<strong>vers</strong>i autori.<br />
La genesi della concezione modernista di mito è di lungo corso ma l’evoluzione più<br />
significativa, nell’ambito di questo studio, è quella che prende le mosse dall’Ottocento. Per<br />
molti aspetti il modernismo si configurò come una cont<strong>in</strong>uazione ed una complicazione del<br />
fenomeno del romanticismo; la sua <strong>in</strong>terpretazione del mito fu <strong>in</strong> contrasto con<br />
l’<strong>in</strong>terpretazione romantica ma ne segnò, al contempo, un’evoluzione di cui sarà utile cogliere<br />
alcuni aspetti significativi. Se il periodo vittoriano rappresentò una seconda fase<br />
dell’illum<strong>in</strong>ismo, con il suo bagaglio di scetticismo e razionalismo, è pur vero che fu uno dei<br />
suoi prodotti letterari-scientifici più importanti, Il ramo d’oro, a risvegliare l’<strong>in</strong>teresse per il<br />
mito. Il capolavoro di ricerca etnologica di Frazer che tanto ispirò lo stesso Cesare Pavese, è,<br />
fondamentalmente, un’opera che risente delle teorie evoluzioniste di Darw<strong>in</strong>. Il libro, che<br />
avrebbe dovuto fare dei miti primitivi dei fenomeni lontani e pittoreschi, contribuì, <strong>in</strong> maniera<br />
capitale, al recupero della mitologia come categoria produttiva <strong>in</strong> epoca moderna. La<br />
produttività della categoria mitologica è, al contempo, la pr<strong>in</strong>cipale differenza che si può<br />
tracciare tra l’<strong>in</strong>terpretazione romantica e quella modernista. L’<strong>in</strong>terpretazione romantica del<br />
mito, e la sua rivalutazione, avvenne ad un livello ideale e fu concepita come reazione<br />
all’illum<strong>in</strong>ismo. Tra le reazioni romantiche agli assunti dell’illum<strong>in</strong>ismo si possono elencare il<br />
ritorno all’apprezzamento dei sentimenti, il fasc<strong>in</strong>o per il gotico ed il sublime, l’idealizzazione<br />
dell’uomo primitivo, ovvero il buon selvaggio, e la rivalutazione delle culture autoctone.<br />
Pavese seguì questo percorso molto da vic<strong>in</strong>o. Il movimento romantico, pur rappresentando la<br />
radice della sua ispirazione, si caricava di un idealismo che fu rigettato <strong>in</strong> epoca moderna:<br />
E’ curioso come il Romanticismo, che passa per la scoperta e la protesta dell’<strong>in</strong>dividuo, dell’orig<strong>in</strong>alità, del<br />
genio, sia tutto pervaso di un’ansia di unità, di totalità cosmica; e abbia <strong>in</strong>ventato i miti della caduta dalla<br />
primitiva Unità e ricercato i mezzi (poesia, amore, progresso storico, contemplazione della natura, magia, ecc.)<br />
per ricomporla. Prova di questa tendenza è la creazione di tanti concetti collettivi (la nazione, il popolo, il<br />
cristianesimo, il germanesimo, il gotico, la lat<strong>in</strong>ità, ecc.) 70 .<br />
Il passaggio ad una visione pragmatica della mitologia <strong>in</strong>tesa come categoria estetica<br />
produttiva avvenne ad opera di molti modernisti che rifiutarono l’idealismo romantico<br />
re<strong>in</strong>terpretando, o sviluppando, i loro materiali:<br />
Il modo <strong>in</strong> cui ci si è rivolti alla mitologia alla f<strong>in</strong>e del secolo XIX – <strong>in</strong>izio secolo XX era sostanzialmente<br />
di<strong>vers</strong>o da quello romantico, anche se <strong>in</strong>izialmente poteva essere <strong>in</strong>terpretato come Neoromanticismo. Esso<br />
nasceva nell’ambito della tradizione realistica e della concezione del mondo positivista, ed era sempre <strong>in</strong><br />
rapporto con questa tradizione, anche se spesso <strong>in</strong> modo polemico 71 .<br />
Per Bell il romanticismo raggiunge il suo punto culm<strong>in</strong>e con una concezione del classicoprimitivo<br />
e del primitivo-classico <strong>in</strong> un momento <strong>in</strong> cui il caos orig<strong>in</strong>ario è visto come una<br />
forza generatrice ben lontana da quella forza primordiale selvaggia e distruttrice che, per<br />
69 Ivi, p. 222.<br />
70 C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, 24 Maggio 1941, cit. p. 225.<br />
71 J.M. Lotman – Z. M<strong>in</strong>c, Letteratura e Mitologia, cit. p. 218.<br />
33
Nietzsche, si <strong>in</strong>carnava nella figura tragica di Dioniso 72 . Elim<strong>in</strong>ando dalla loro visione ogni<br />
implicazione metafisica, i modernisti ritennero che la fondazione e le possibilità ricreatrici<br />
legate al mito riposassero sul mito stesso, ovvero sulla cultura che l’aveva prodotto. I<br />
modernisti riscoprirono la possibilità di <strong>in</strong>terrogare i miti come prodotti dell’<strong>in</strong>gegno umano,<br />
come espressioni privilegiate di un’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e a ritroso di stampo ontologico. Bell sottol<strong>in</strong>ea<br />
come il rifiuto dell’idealismo romantico e il rigetto della metafisica avvennero sullo sfondo di<br />
uno dei periodi storici più burrascosi della nostra storia moderna; gli sviluppi drammatici e<br />
sangu<strong>in</strong>ari della Rivoluzione Francese disillusero un’<strong>in</strong>tera generazione di <strong>in</strong>tellettuali che si<br />
posero <strong>in</strong>terrogativi che andavano al di là del s<strong>in</strong>golo evento. La critica serrata che Nietzsche<br />
<strong>in</strong>traprese nei confronti di tutta la tradizione e la civiltà occidentale sembrava stesse trovando<br />
le sue puntuali e tragiche conferme. Era una critica che implicava tutta la civiltà europea:<br />
“[…] by the turn of the twentieth century, the whole enterprise of European civilization was<br />
under a newly radical scrut<strong>in</strong>y” 73 . Fu lo stesso Nietzsche ad accostare gli studi di storia a<br />
quelli di mitologia legandoli <strong>in</strong> una riflessione serrata che avrebbe costituito la parte fondante<br />
delle Considerazioni <strong>in</strong>attuali. La storia era stata, f<strong>in</strong>o all’immediata vigilia della modernità,<br />
il referente privilegiato per la comprensione del mondo e delle sue leggi. La discussione<br />
<strong>in</strong>trapresa da Nietzsche nelle Inattuali prendeva di mira proprio la tendenza a considerare la<br />
storia una scienza e l’analisi storica un metodo di ricerca e di comprensione quasi <strong>in</strong>fallibile.<br />
Criticando questo sistema di pensiero, e <strong>def</strong><strong>in</strong>endolo come un altro aspetto nefasto della<br />
civiltà occidentale, Nietzsche poneva, direttamente e <strong>in</strong>direttamente, le basi per la promozione<br />
di una nuova metodologia atta a svelare, o semplicemente ad <strong>in</strong>dagare, i misteri dell’uomo e<br />
della sua storia che si condensavano nel sapere mitologico. Il mito divenne, nelle riflessioni<br />
moderniste ispirate dal filosofo tedesco, il background su cui si sviluppava la storia stessa. I<br />
miti non erano <strong>in</strong>venzioni fantasiose di poeti ma rappresentarono una consistente parte della<br />
realtà umana, forse la più importante ed antica. Solo tramite il discernimento di questo<br />
background mitico, solo tramite la riproposizione dei miti nell’ambito della modernità, anche<br />
la storia poteva guadagnare un senso. La mitologia r<strong>in</strong>uncia ad essere un’opzione e diviene la<br />
tappa obbligata per la comprensione del mondo 74 .<br />
72 Lo stesso sviluppo romantico del concetto di mito è un’evoluzione delle teorie espresse nel circolo di Jena da<br />
Schlegel e Schell<strong>in</strong>g. Il Dialogo sulla poesia (1800) di Schlegel è <strong>in</strong>dicato da Bell come uno dei testi<br />
fondamentali per lo sviluppo del concetto romantico di mito, ma è anche il testo da cui prenderanno le mosse i<br />
modernisti, rielaborandone i contenuti, per forgiarne una nuova concezione. Per il pensatore tedesco alla base del<br />
concetto di mito vi è un qualcosa di orig<strong>in</strong>ale, di <strong>in</strong>imitabile e di irriducibile, luogo dell’assurdo, della follia e di<br />
ogni semplicità. La poesia si struttura dunque come risalita <strong>vers</strong>o questo orig<strong>in</strong>ario ideale. Si tratta di ripercorrere<br />
a ritroso le tappe della civiltà che la ragione dell’uomo ha costruito per poter ricongiungersi, idealmente, al caos<br />
orig<strong>in</strong>ario della natura umana rappresentato simbolicamente dagli antichi dei. L’idealismo di questa posizione è<br />
rappresentato dall’<strong>in</strong>dicazione di un obiettivo, stabilito a priori, piuttosto che di un metodo di r<strong>in</strong>venimento. La<br />
poesia mitologica diviene, nelle pag<strong>in</strong>e di Schlegel, un ponte per il raggiungimento di uno stato ideale, quello<br />
primitivo-classico. Mentre per i modernisti il mito rappresentava una condizione <strong>in</strong>terpretativa dell’essere si può<br />
notare, dall’espressione di questa filosofia, come per i romantici fosse una dimensione perduta, da r<strong>in</strong>venire<br />
tramite la pratica estetica. Nel Sistema dell’idealismo trascendentale, Schell<strong>in</strong>g auspica l’avvento di una “nuova<br />
mitologia” <strong>in</strong> cui tutta una generazione di poeti “mitologizzasse” come se fosse una sola <strong>in</strong>dividualità poetica.<br />
Bell ipotizza come la differenza pr<strong>in</strong>cipale fra i romantici e i modernisti si possa cogliere nel concetto di<br />
“ground<strong>in</strong>g”. Seguendo questa ipo<strong>tesi</strong> il modernismo si differenzierebbe dal romanticismo pr<strong>in</strong>cipalmente per<br />
l’esclusione della componente idealistica. Il mito, per i romantici, aveva il suo “ground” nell’assoluto, nel fuori<br />
da sé e nel mondo ideale. A tale assoluto tendeva ed era legato. Per i modernisti il mito si struttura piuttosto sul<br />
“self ground<strong>in</strong>g”.<br />
73 M. Bell, Literature modernism and myth, cit. p.19.<br />
74 Fra i vari apporti che le teorie <strong>in</strong>torno al mito ebbero, quello di C. G. Jung fu di fondamentale importanza. Le<br />
sue <strong>def</strong><strong>in</strong>izioni di archetipo e di <strong>in</strong>conscio collettivo si legarono direttamente alle riflessioni degli <strong>in</strong>tellettuali<br />
modernisti: “There are types of situations and types of figures that repeat themselves frequentely and have a<br />
correspond<strong>in</strong>g mean<strong>in</strong>g. I therefore employ the term motif to designate these repetitions. Thus there are not only<br />
typical dreams but typical motifs <strong>in</strong> the dreams. These may, as we have said, be situations or figures. Among the<br />
latter there are human figures that can be arranged under a series of archetypes, the chief of them be<strong>in</strong>g […] the<br />
shadow, the wise old man, the child (<strong>in</strong>clud<strong>in</strong>g the child hero), the mother (Primordial Mother and Earth Mother)<br />
as a supraord<strong>in</strong>ate personality (daemonic because supraord<strong>in</strong>ate) and her counterpart the maiden, and lastly the<br />
34
Stabilita una serie di posizioni che contribuirono alla creazione di una vera e propria<br />
coscienza mitopoietica modernista, sarà <strong>in</strong>teressante constatare come tale dibattito si legò alle<br />
speculazioni di alcuni scrittori dell’epoca. Cesare Pavese e D.H. Lawrence furono due<br />
<strong>in</strong>tellettuali particolarmente <strong>in</strong>teressati alle teorie sul mito tanto che si potrebbe parlare della<br />
condivisione di una vera coscienza mitopoietica. Pavese, oltre ad aver dato un impianto<br />
mitologico a molte delle sue opere, ci ha lasciato una mole impressionante di scritti teorici che<br />
si dividono fra i suoi saggi e le sue note sul diario. In questo contesto sarà <strong>in</strong>teressante notare<br />
come le sue riflessioni, cui prevalentemente questo capitolo è fondato, riechegg<strong>in</strong>o, con<br />
importanti e personali sviluppi, le teorie mitologiche europee.<br />
Lawrence amò esprimere la sua filosofia, come lui stesso ammette, prevalentemente<br />
attra<strong>vers</strong>o i romanzi che vengono privilegiati, all’<strong>in</strong>terno di questo capitolo, rispetto alle<br />
riflessioni presenti nelle opere teoriche. Nell’ambito dell’<strong>in</strong>teresse che il modernismo<br />
letterario dedicò alla categoria del mito, l’<strong>in</strong>terpretazione di Lawrence fu particolarmente<br />
orig<strong>in</strong>ale e approfondita. Nella sua poetica, il riferimento al mito è costante ed elementi<br />
mitologici classici e biblici sono cont<strong>in</strong>uamente riscontrabili così come sono frequenti le<br />
connessioni alle div<strong>in</strong>ità ctonie dei luoghi campestri. Per Michael Bell la concezione mitica di<br />
Lawrence è <strong>in</strong>separabile non solo dalla sua poetica ma anche dall’<strong>in</strong>tera sua vita: “D. H.<br />
Lawrence had an <strong>in</strong>ward understand<strong>in</strong>g of mythopoeia <strong>in</strong>separabile from his whole view of<br />
life” 75 . L’esplorazione dell’esistente da parte di Lawrence, il legare strettamente<br />
quest’esplorazione alle esperienze dei s<strong>in</strong>goli personaggi e al contempo il saper estrarre dagli<br />
episodi di vita ciò che risulta essere più grande, una legge dell’essere appunto, fa di Lawrence<br />
uno scrittore essenzialmente mitopoietico. L’esperienza di Lawrence si configurò dunque <strong>in</strong><br />
una costante ricerca delle categorie del mitico non solo nella sua produzione poetica ma anche<br />
nell’esperienza di tutti i giorni. La sua opera più biografica, Sons and Lo<strong>vers</strong>, testimonia<br />
questo gioco di rimandi fra arte e vita. Le leggi della vita, che possono essere ricavate<br />
anima <strong>in</strong> man and the animus <strong>in</strong> woman. The prymordial image, or archetype, is a figure […] that constantly<br />
recurs <strong>in</strong> the course of history and appears whenever creative fantasy is freely expressed. Essentially, therefore, it<br />
is a mythological figure”. Per Jung l’arte non ha la sua fonte nell’<strong>in</strong>conscio personale dell’artista ma <strong>in</strong> quello<br />
collettivo <strong>in</strong> quanto sfera di mitologia <strong>in</strong>conscia <strong>in</strong> cui le immag<strong>in</strong>i primordiali sono retaggio del genere umano.<br />
Jung parla di una forza irrazionale che non può essere né canalizzata né soppressa dalla razionalità o<br />
dall’educazione. La forza dell’arte è quella del r<strong>in</strong>venimento delle fonti della vita, il risalire all’orig<strong>in</strong>e attra<strong>vers</strong>o<br />
la riattivazione dell’immag<strong>in</strong>e archetipica: “The creative process, so far as we are able to follow it at all, consists<br />
<strong>in</strong> the uncounscious activation of an archetypical image, and <strong>in</strong> elaborat<strong>in</strong>e and shap<strong>in</strong>g this image <strong>in</strong>to the<br />
f<strong>in</strong>ished work. By giv<strong>in</strong>g it shape, the artist translates it <strong>in</strong>to the language of the present, and so makes it possible<br />
for us to f<strong>in</strong>d our way back to the deepest spr<strong>in</strong>gs of life. There lies the social significance of art: it is constantly<br />
at work educat<strong>in</strong>g the spirit of the age, conjur<strong>in</strong>g up the forms <strong>in</strong> which the age is most lack<strong>in</strong>g. The unsatisfied<br />
yearn<strong>in</strong>g of the artist reaches back to the primordial image <strong>in</strong> the uncounscious which is best fitted to<br />
compensate the <strong>in</strong>adequacy and one-sideness of the present. The artist seizes on this image, and <strong>in</strong> rais<strong>in</strong>g it from<br />
deepest uncounsciousness he br<strong>in</strong>gs it <strong>in</strong>to relation with counscious values, thereby transform<strong>in</strong>g it until it can be<br />
accepted by the m<strong>in</strong>ds of his contemporaries accord<strong>in</strong>g to their powers”. C.G. Jung, The psychological aspects of<br />
the Kore (1941), contenuto <strong>in</strong> Gregory Lucente, The narrative of realism and Myth. Verga, Lawrence, Faulkner,<br />
Pavese. The John Hopk<strong>in</strong>s Uni<strong>vers</strong>ity Press, Baltimore and London, 1981, pp.34-37. Pavese, che era al corrente<br />
degli studi di Jung, si <strong>in</strong>teresserà a lui <strong>in</strong> maniera specifica nel primo dopoguerra <strong>in</strong> occasione della fondazione<br />
della Collana Viola, la Collezione di studi psicologici, etnologici e religiosi tenuta <strong>in</strong>sieme ad Ernesto Di<br />
Mart<strong>in</strong>o. L’importanza di Jung nella <strong>def</strong><strong>in</strong>izione del concetto di mito <strong>in</strong> epoca modernista è basilare e si collega,<br />
appunto, al dibattito sulla produttività della mitologia moderna. Per Jung la mitologia può essere altrettanto<br />
produttiva <strong>in</strong> epoca moderna così come lo era stata <strong>in</strong> epoca classica. Questa posizione era la risposta agli<br />
studiosi che concepivano la mitologia come una categoria fondamentale per poter comprendere il nostro passato<br />
ma che, <strong>in</strong> questo passato, rimaneva arg<strong>in</strong>ata. In questo senso Jung risponde allo scetticismo di studiosi quali<br />
Mircea Eliade che postulavano come la crisi della div<strong>in</strong>ità <strong>in</strong> epoca moderna alienasse la produttività<br />
dell’approccio mitologico alla realtà contemporanea. Robert A. Segal <strong>in</strong> Myth and the mak<strong>in</strong>g of modernity. The<br />
problem of ground<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Early Twentieth Century Literature, Edited by M.Bell and P.Poellner, Rodopi,<br />
Amsterdam-Atlanta, GA, 1998, pp. 123-24, offre una s<strong>in</strong><strong>tesi</strong> chiara di questa diatriba: “Because he (Jung)<br />
psychologizes the mean<strong>in</strong>g of all myths, he circumvents Eliade’s dilemma that myths acceptable to moderns lack<br />
the element necessary for their efficacy: gods. For Jung gods are merely the symbols that ancient myths used to<br />
represent archetypes. Modern myths, us<strong>in</strong>g other symbols, are equally efficacious”.<br />
75 M. Bell, Literature, Modernism and Myth – belief and responsability <strong>in</strong> the twentieth century, cit. p. 93.<br />
35
dall’esperienza f<strong>in</strong>zionale e da quella reale, vanno ricercate al di là dello psicologico e del<br />
sociale:<br />
The story is typical of Lawrence <strong>in</strong> that its full force eludes a purely naturalistic explanation at the level of the<br />
social, ethical and personal psychology although, moment by moment, the action seems to be conducted <strong>in</strong> these<br />
terms. Some sort of transformation of the abitual and the everyday, a transformation for which miracle is a good<br />
popular term, is of the essence. […] Lawrence’s mythopoeic consciousness is most crucially to be found not <strong>in</strong><br />
his overt allusions to myth, but <strong>in</strong> this way of relat<strong>in</strong>g the personal and the impersonal, the conscious and the<br />
uncounscious, <strong>in</strong> a holistic, flexible exploration of human be<strong>in</strong>g-<strong>in</strong>-the-world 76 .<br />
La caratteristica che differenzia Lawrence dai suoi contemporanei, che si rifacevano al mito<br />
come pr<strong>in</strong>cipale fonte di ispirazione e scrivevano basandosi su schemi mitici, è che Lawrence<br />
aveva, è op<strong>in</strong>ione di Bell, una vera “coscienza mitopoietica” 77 . Lo stesso Lawrence rivendica<br />
questa posizione <strong>in</strong> Fantasia dell'Inconscio subito dopo aver espresso le sue posizioni rispetto<br />
al mito e la storia:<br />
Questa mia pseudofilosofia […] è dedotta dalle novelle e dalle poesie, non l’<strong>in</strong><strong>vers</strong>o. Le novelle e le poesie<br />
nascono spontaneamente dalla penna. E solo allora l’assoluta necessità <strong>vers</strong>o se stessi e le cose <strong>in</strong> generale ci fa<br />
tentare di trarre qualche conclusione dalle proprie esperienze come scrittore e come uomo. Le novelle e le poesie<br />
sono esperienza pura ed appassionata 78 .<br />
Pavese, attento lettore di Lawrence, si pone dunque <strong>in</strong> un ideale parallelo con lo scrittore<br />
<strong>in</strong>glese da cui, come lui stesso ammette, ricavò più di un’ispirazione.<br />
La riflessione di Cesare Pavese sul mito è forse la più importante per la <strong>def</strong><strong>in</strong>izione della sua<br />
poetica o, perlomeno, è senz’altro il punto di partenza. La riflessione sul mito si protrasse per<br />
tutto il periodo della sua attività di scrittore e <strong>in</strong>fluenzò le sue attitud<strong>in</strong>i <strong>in</strong>tellettuali <strong>in</strong> maniera<br />
<strong>in</strong>equivocabile. La sua attività di studioso fu <strong>in</strong>centrata sulla lettura dei testi classici per<br />
att<strong>in</strong>gere il mito alle sue fonti e sulla lettura dei critici e degli studiosi contemporanei al f<strong>in</strong>e<br />
di <strong>in</strong>nestare più propriamente la teoria mitica nel contesto dell’attualità. F<strong>in</strong> dal 1936 Pavese<br />
si fece attento lettore di Lèvy-Bruhl, con il testo Mythologie primitive, mentre di pochi anni<br />
successivi fu l’approfondimento dell’opera del Vico. Anche la sua attività di traduttore fu <strong>in</strong><br />
parte <strong>in</strong>fluenzata da questo <strong>in</strong>teresse mentre, per quanto riguarda il suo ruolo di diffusore di<br />
cultura nell’Italia del primo dopoguerra, è da registrare l’avventura della Collana Viola, una<br />
serie di studi a carattere etnologico ideata e realizzata con Ernesto De Mart<strong>in</strong>o, che lo<br />
avvic<strong>in</strong>arono agli studi di Kerenyi già mediati, precedentemente, dalla lettura dei lavori di<br />
Mario Unterste<strong>in</strong>er. Per Marziano Guglielm<strong>in</strong>etti gli studi che portarono Pavese<br />
all’elaborazione di una propria teoria mitologica, sono di particolare importanza <strong>in</strong><br />
considerazione del fatto che non si possono <strong>in</strong>dicare predecessori, <strong>in</strong> Italia, che pens<strong>in</strong>o e<br />
utilizz<strong>in</strong>o il mito nel modo dello scrittore: “Dunque, non predecessori significativi, ma, se<br />
mai, sperimentatori coetanei ed esperti di scienze umane […] sembrano chiamati da Pavese ad<br />
esercitare un’azione di conforto e, soprattutto, d’illum<strong>in</strong>azione all’<strong>in</strong>terno di un processo<br />
creativo, che si <strong>def</strong><strong>in</strong>isce estraneo al naturalismo […] 79 . In questo contesto l’<strong>in</strong>tento di Pavese<br />
sembrò proprio quello di uscire dalle ristrettezze della cultura classicistica italiana, che non<br />
vedeva nel mito una possibile applicazione nell’arte contemporanea se non come rimando<br />
colto e prezioso, e dalle similari ristrettezze dell’estetismo di stampo dannunziano che faceva<br />
76 Ivi, p. 110.<br />
77 Ivi, p. 116.<br />
78 D. H. Lawrence, Fantasia dell’<strong>in</strong>conscio, Newton Compton Editori, Roma, 1995, p. 24.<br />
79 Marziano Guglielm<strong>in</strong>etti, Cesare Pavese romanziere, contenuto <strong>in</strong> Cesare Pavese, Tutti i romanzi, E<strong>in</strong>audi,<br />
Tor<strong>in</strong>o, 2000, p. XI.<br />
36
del mito un utilizzo del tutto personale. Procurarsi <strong>in</strong>terlocutori all’estero, soprattutto <strong>in</strong> un<br />
momento <strong>in</strong> cui la riflessione sul mito, nell’ambito del movimento culturale del modernismo,<br />
trovava <strong>in</strong> Europa l’apporto di molti <strong>in</strong>tellettuali, rappresenta un carattere del tutto particolare<br />
da attribuire a Pavese. La concezione di Pavese del mito si compone di una lunga serie di<br />
<strong>in</strong>flussi che vanno al di là dei pure basilari Vico, Nietzsche, Frazer. Il fondamento della<br />
concezione mitica dello scrittore riposa, per Guido Guglielmi, sull'opera di Nietzsche, e <strong>in</strong><br />
particolar modo sulla Nascita della Tragedia, ma anche sul folclore acquisito soprattutto dalla<br />
letteratura americana.<br />
I legami di Pavese alla cultura modernista si svelano anche attra<strong>vers</strong>o i riferimenti a Proust e<br />
Baudelaire che entrambi contribuirono alla formulazione della sua concezione mitica. Ma<br />
l’approccio di Pavese alle teorie del mito ha un’orig<strong>in</strong>alità che lo mette direttamente <strong>in</strong><br />
confronto con un altro mitologo della tradizione letteraria italiana, D’Annunzio: “Lo sforzo di<br />
Pavese è dunque quello di sottrarre i materiali mitici alla loro aurea di preziosità e di<br />
esclusività culturale per <strong>in</strong>serirli <strong>in</strong> un più ampio contesto, <strong>in</strong> “una dimensione etica o<br />
comunicativa” 80 . Insomma Pavese “mira a riconvertire l'uso estetico dei miti -quale gli<br />
giungeva direttamente già da D'Annunzio- <strong>in</strong> uso etico. E cioè a fare dei miti la base di un<br />
r<strong>in</strong>novato e ritrovato senso comune: di una classicità rustica, fondata sulla città-<strong>in</strong>-campagna.<br />
Un'espressione <strong>in</strong> cui campagna equivale a <strong>in</strong>fanzia e preistoria, e città a mondo<br />
contemporaneo. E tutto questo secondo una direzione propria dei ritornanti primitivismi della<br />
modernità” 81 . La mitologia di Pavese va dunque ad <strong>in</strong>contrarsi con i temi dell'etnologia, <strong>in</strong><br />
quello che lui stesso <strong>def</strong><strong>in</strong>iva un “classicismo rustico” 82 . Questo sforzo <strong>vers</strong>o la <strong>def</strong><strong>in</strong>izione di<br />
un nuovo modello di classicismo è dettata, per Guglielmi, dal progetto di accordare cultura<br />
moderna e mito: l’<strong>in</strong>tenzione primaria di Pavese era quella di “rivitalizzare i miti, ma <strong>in</strong> un<br />
contesto contemporaneo” 83 . Nell’<strong>in</strong>contro della mitologia classica con quelli che erano i<br />
dettami, o meglio gli <strong>in</strong>teressi, della “nuova” scienza etnologica, si situa buona parte<br />
dell’orig<strong>in</strong>alità del pensiero di Pavese. Lo stesso scrittore, sempre prodigo di riflessionidelucidazioni<br />
sulla sua poetica, rivendica un ruolo di primo piano nell’evoluzione, considerata<br />
ancora <strong>in</strong> corso, del pensiero mitico:<br />
Formazione rustica, cioè non contad<strong>in</strong>a, proletaria, ma ragazze col parasole. Piacciono i ruderi di Roma perché<br />
gerbidi, perché papaveri e siepi secche sui colli ne fanno cosa dell’<strong>in</strong>fanzia –e anche la storia (Roma antica) e la<br />
preistoria (Vico, | il sangue sparso sulla siepe o sul solco) s’adattano a questa rusticità, ne fanno un mondo <strong>in</strong>tero<br />
e coerente dalla nascita alla morte. La tua classicità: le Georgiche, D’Annunzio, la coll<strong>in</strong>a del P<strong>in</strong>o. Qui si è<br />
<strong>in</strong>nestata l’America come l<strong>in</strong>guaggio rustico§uni<strong>vers</strong>ale (Anderson, An Ohio pagan), e la barriera (il Campo di<br />
grano) che è riscontro di città e campagna. Il tuo sogno alla stazione di Alba (i giovani albesi che creano le<br />
forme moderne) è la fusione del classicismo con la città§<strong>in</strong>§campagna. Recentemente hai aggiunto la scoperta<br />
dell’<strong>in</strong>fanzia (campagna = forma mentale), valorizzando gli studi di etnografia (il Dio caprone, la teoria<br />
dell’immag<strong>in</strong>e racconto). Il tuo è un classicismo rustico che facilmente diventa etnografia preistorica 84 .<br />
Il classicismo rustico così elaborato da Pavese si <strong>in</strong>nesta, al contempo, <strong>in</strong> un territorio<br />
<strong>in</strong>tellettuale vasto che risente sia della sapienza <strong>in</strong>dividuale dei luoghi rurali, <strong>in</strong> cui Pavese<br />
crebbe ed ebbe la prima educazione, sia della cultura moderna di cui lo scrittore si nutrì ad<br />
ampie dosi. L’attenzione per la natura è, <strong>in</strong>somma, precedente a quella per la cultura e lo<br />
studio del mito e delle sue implicazioni <strong>in</strong>tellettuali sembra atto a svelare i misteri di<br />
entrambe:<br />
80<br />
Guido Guglielmi, La prosa Italiana del Novecento, tra romanzo e racconto, Piccola Biblioteca E<strong>in</strong>audi,<br />
Tor<strong>in</strong>o, 1998, p. 116.<br />
81<br />
Ivi, p. 117.<br />
82<br />
Ivi, p. 116.<br />
83<br />
Ivi, p. 115.<br />
84<br />
C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, 3 Giugno 1943, cit. pp. 244-45.<br />
37
Notare che più dei poemi (Iliade, Commedia, Leopardi, ecc.) ti compiacevi di geologia e astronomia, cioè il<br />
materiale <strong>in</strong>differenziato da cui doveva nascere il gusto mitico§rustico, saziato poi dagli sparsi accenni dei poemi<br />
[…]. Alla letteratura, al gusto della parola§mezzo sei giunto più tardi, attra<strong>vers</strong>o tediosa ricerca culturale (letture<br />
obbligate) e poi scoppio baudelairiano 85 .<br />
Questo <strong>in</strong>teresse per il rustico, il folklorico, è caratteristico di molti scrittori modernisti. Sons<br />
and Lo<strong>vers</strong> (1913) è un vero romanzo “classico-rustico” 86 . In questo romanzo autobiografico<br />
scritto nella fase <strong>in</strong>iziale della sua carriera di scrittore, Lawrence svolge l’azione nella<br />
campagna <strong>in</strong>glese delle Midlands dove, <strong>in</strong> una comunità di m<strong>in</strong>atori, una famiglia conduce<br />
una vita difficile e colma di tensioni reciproche e con il mondo esterno. Le vicende della<br />
famiglia Morel sono calate <strong>in</strong> un’ambientazione rurale che implica tutte le d<strong>in</strong>amiche<br />
“classiche” di un luogo di conf<strong>in</strong>e <strong>in</strong> cui l’elemento civile si scontra con i modi di vivere e le<br />
mentalità arcaiche. Le dimensioni della scrittura e del pensiero di Lawrence potrebbero<br />
<strong>def</strong><strong>in</strong>ire <strong>in</strong> questo contesto, prendendo <strong>in</strong> prestito le parole di Pavese, le coord<strong>in</strong>ate di una<br />
nuova mitologia rustica. Le caratteristiche della narrazione sono l’ambientazione rurale, che<br />
si confronta cont<strong>in</strong>uamente con quella cittad<strong>in</strong>a, l’<strong>in</strong>contro-scontro di personaggi spontanei ed<br />
ist<strong>in</strong>tivi, che potremmo <strong>def</strong><strong>in</strong>ire di terra, con quelli razionali ed idealisti, che potremmo<br />
<strong>def</strong><strong>in</strong>ire di mondo. La storia del protagonista, l’artista Paul, si svolge soprattutto nella<br />
campagna che è descritta come un crogiolo di simboli e di significati. Il paesaggio diviene<br />
effettivo protagonista del libro ma è un paesaggio immobile che parla attra<strong>vers</strong>o la sua<br />
simbologia, le sue leggi eterne. Il romanzo si struttura come un’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e socio-psicologica<br />
all’<strong>in</strong>terno di una comunità che spende la sua vita <strong>in</strong> una terra di conf<strong>in</strong>e, combattuta tra i<br />
valori centenari della vecchia società agricola e quelli ammalianti del nuovo <strong>in</strong>sediamento<br />
<strong>in</strong>dustriale. L’uso prem<strong>in</strong>ente del dialogo conta numerose immissioni gergali e dialettali.<br />
Come lo stesso Lawrence confermerà nel suo saggio Nott<strong>in</strong>gham and the Mean<strong>in</strong>g<br />
Countryside, il punto nodale del romanzo è l’irruzione della nuova mentalità <strong>in</strong>dustriale <strong>in</strong> un<br />
mondo agricolo, il cui significato più profondo si può trarre dalle opere dei più grandi scrittori<br />
<strong>in</strong>glesi che avevano saputo così bene dare un senso al mistero di quella natura. La rivoluzione<br />
<strong>in</strong>dustriale sembra lasciare l’uomo moderno orfano dell’<strong>in</strong>segnamento dei maestri. Il recupero<br />
dei significati mitici del luogo potrebbe agire <strong>in</strong> primo luogo proprio <strong>in</strong> questa direzione:<br />
come recupero dei vecchi valori che il mondo moderno disprezza, <strong>in</strong> quanto non produttivi, e<br />
promette di elim<strong>in</strong>are. In questo contesto Lawrence rifiutò e contestò le prime recensioni al<br />
libro che vi vollero leggere l’espressione artistica delle moderne teorie freudiane. Per<br />
Lawrence il significato della sua opera raggiungeva ben altri territori che non quelli<br />
dell’<strong>in</strong>conscio dell’<strong>in</strong>dividuo e del complesso di Edipo che si poteva r<strong>in</strong>tracciare nel rapporto<br />
tra Walter Morel, la moglie e il figlio Paul. Per Lawrence il significato più profondo era da<br />
ricercarsi nella forza del sangue che unisce le generazioni e gli uom<strong>in</strong>i tutti <strong>in</strong> una comune<br />
unità <strong>in</strong>divisibile e di come la bieca ragione e il calcolo razionale port<strong>in</strong>o <strong>in</strong>vece alla divisione<br />
e all’isolamento. Il recupero di un paesaggio rustico e mitico sembra esser funzionale al<br />
recupero di una tematica ritenuta a sua volta mitica. Questa vicenda, come conferma l’autore,<br />
ha ben poco di documentario. Gli stessi riferimenti biografici, che vengono costantemente<br />
sottol<strong>in</strong>eati nella lettura di quest’opera, servono a dimostrare come anche una vicenda così<br />
personale, come la vita di un <strong>in</strong>dividuo, si possa calare perfettamente <strong>in</strong> uno schema mitico.<br />
Lotman <strong>def</strong><strong>in</strong>isce quella del folklore una sfera <strong>in</strong>termedia, depositaria dell’antica sapienza che<br />
si rivela attra<strong>vers</strong>o il mito e si esprime attra<strong>vers</strong>o forme artistiche (quello che noi <strong>def</strong><strong>in</strong>iremmo<br />
85 Ivi, 4 Luglio 1943, p. 256.<br />
86 Pavese cita il romanzo di Lawrence <strong>in</strong> una lettera a Bona Alterocca datata Tor<strong>in</strong>o, Dicembre1948. Nella<br />
lettera Pavese sollecita la collaboratrice a tradurre il romanzo dello scrittore <strong>in</strong>glese: “È stata così scandalizzata<br />
da Figli e amanti che lo ha buttato nel fiume? Si muova”.<br />
38
artistico <strong>in</strong> quanto <strong>in</strong> queste società rurali il tempo del rito, lo svolgimento del mito, è<br />
soprattutto fatto religioso):<br />
Un’azione reciproca fra la letteratura come fatto artistico e il mito, per il quale la funzione estetica è <strong>in</strong>vece<br />
soltanto un aspetto, si compie <strong>in</strong> modo particolarmente attivo nella sfera <strong>in</strong>termedia del folklore. La poesia<br />
popolare ha un tipo di coscienza che tende <strong>vers</strong>o il mondo della mitologia; tuttavia come fenomeno artistico è<br />
contiguo alla letteratura. La doppia natura del folklore lo rende sotto questo aspetto un <strong>in</strong>termediario culturale 87 .<br />
Il mito diviene una forma di conoscenza che travalica l’esperienza e si proietta nell’assoluto.<br />
Per Pavese è attra<strong>vers</strong>o l'esplorazione del mondo mitico che si può superare quel primo stadio<br />
di ricordi, quelli consci, per raggiungere l'immemoriale, il preculturale, il vero e sfuggente<br />
nulla che cela il mistero delle orig<strong>in</strong>i. Il ricordo, la memoria, il risalire <strong>vers</strong>o l’orig<strong>in</strong>ario,<br />
vengono discusse da Pavese nel saggio L’Adolescenza, contenuto <strong>in</strong> Feria d’Agosto. L’analisi<br />
è condotta tenendo a mente i raggiungimenti delle riflessioni moderniste che, per quanto<br />
riguardo le teorie relative ai ricordi e alla memoria, fanno riferimento a Proust:<br />
Occorre per ciò non tanto risalire il fiume della memoria, quanto rimettersi con abnegazione nello stato ist<strong>in</strong>tivo,<br />
o <strong>in</strong> ciò che ne resta. Con che si viene a dire che il modo proustiano di affidarsi alla sensazione impensata, non<br />
basta. Non basta perché la sensazione, sia pur bruta, <strong>in</strong> quanto ricordo è tutt’altro che immune da compiaciute<br />
coloriture di gusto; non basta perché il difficile non è risalire il passato bensì soffermarcisi; non basta <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e<br />
perché noi <strong>in</strong>tendiamo per stato ist<strong>in</strong>tivo quello stampo schietto che <strong>in</strong>fluisce sull’<strong>in</strong>tera nostra realtà <strong>in</strong>tima. E’<br />
per ritrovare questo stato, più che sforzo mnemonico si richiede scavo della realtà attuale, denudamento della<br />
propria essenza.[…] A questo punto della nostra <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e il tempo dilegua. La nostra fanciullezza, la molla di<br />
ogni nostro stupore, è non ciò che fummo ma ciò che siamo da sempre. […] Qui ricordare non è muo<strong>vers</strong>i nel<br />
tempo, ma uscirne e sapere che siamo. L’<strong>in</strong>fanzia a ripensarla suggerisce nostalgia non tristezze. Di essa ci<br />
manca unicamente quella maggior facilità – la purezza <strong>in</strong>iziale – di vivere nell’essere genu<strong>in</strong>o. Invece la<br />
mal<strong>in</strong>conia del passato si svolge sul piano evidente dei giorni, si attacca alle parvenze; per essa il ricordo è tutto<br />
fatto di durate e con crescenze, di scoperte di gusto che come viticci c’impigliano agli altri, alle cose, alla<br />
storia 88 .<br />
Il ricorso al mito è dunque <strong>in</strong>dispensabile nel momento <strong>in</strong> cui l’<strong>in</strong>dividuo non è più <strong>in</strong> grado<br />
di fruire direttamente della realtà che lo circonda. Per Pavese l’osservazione diretta della<br />
realtà viene meno nel momento <strong>in</strong> cui l’<strong>in</strong>dividuo accetta la mediazione culturale. Il ritorno al<br />
mito è relativo alla necessità di tornare <strong>in</strong> contatto con tutto ciò che la cultura moderna cerca<br />
di cancellare delle nostre orig<strong>in</strong>i. Il mito accade una volta per sempre e cela una rivelazione<br />
vitale prima che poetica. Il mito non è altro che forma di conoscenza. L’espressione del<br />
concetto “della seconda volta” così come avviene <strong>in</strong> Stato di Grazia, un altro saggio compreso<br />
<strong>in</strong> Feria d’Agosto, esclude l’uomo da una conoscenza diretta della realtà: “I simboli che<br />
ciascuno di noi porta <strong>in</strong> sé, e ritrova improvvisamente nel mondo e li riconosce e il suo cuore<br />
ha un sussulto, sono i suoi autentici ricordi. Sono anche vere e proprie scoperte. Bisogna<br />
sapere che noi non vediamo mai le cose una prima volta, ma sempre la seconda. Allora le<br />
scopriamo e <strong>in</strong>sieme le ricordiamo” 89 . L’ambiguità del ricordo-simbolo, il suo darsi e<br />
sottrarsi, questo rivelarsi improvvisamente, quasi come fugace illum<strong>in</strong>azione, nelle vesti di<br />
“una realtà enigmatica e tuttavia familiare, tanto più prepotente <strong>in</strong> quanto sempre sul punto di<br />
rivelarsi e mai scoperta” 90 , riflette la tensione esistenzialista dello scrittore che riecheggia <strong>in</strong><br />
questo passo la Lichtung, la mezza luce, forma della conoscenza per Heidegger che si dà <strong>in</strong><br />
87<br />
J.M. Lotman – Z. M<strong>in</strong>c, Letteratura e Mitologia, cit. p. 201.<br />
88<br />
Cesare Pavese, L’Adolescenza, contenuto <strong>in</strong> Cesare Pavese, Feria d’Agosto (1945), E<strong>in</strong>audi, Roma, pp. 152-<br />
153.<br />
89<br />
Cesare Pavese, Stato di Grazia, contenuto <strong>in</strong> C. Pavese, Feria d’Agosto, cit. p. 145.<br />
90 Ibidem.<br />
39
foggia di abbaglio ed oscuramento 91 . In questo caso Pavese deve att<strong>in</strong>gere, per ottenere la<br />
conoscenza, alla sfera dell’ist<strong>in</strong>tivo-irrazionale, sfera che travalica i moderni canoni culturali<br />
e att<strong>in</strong>ge nell’immemoriale:<br />
Che i nostri ricordi nascondano il capo, vuol dire appunto che att<strong>in</strong>gono alla sfera dell’ist<strong>in</strong>tivo-irrazionale. In<br />
questa sfera – la sfera dell’essere e dell’estasi – non esiste il prima e il dopo, la seconda volta e la prima, perché<br />
non esiste il tempo, Ciò che <strong>in</strong> essa è, è: qui l’attimo equivale all’eterno, all’assoluto. […] Qui ogni volta è una<br />
seconda volta, o diciamo un ritrovamento, soltanto perché profondandoci <strong>in</strong> essa ritroviamo noi stessi. E’<br />
evidente che non può avere <strong>in</strong>izio il simbolo di una realtà – noi stessi – la quale per il nostro ist<strong>in</strong>to non ha avuto<br />
mai <strong>in</strong>izio, ma è. Essa è, secondo modi che non sempre o quasi mai siamo <strong>in</strong> grado di risalire e comprendere. Ne<br />
tocchiamo <strong>in</strong> istanti <strong>in</strong>aspettati la piena sostanza come al buio si tocca un corpo o come un barbaglio guizza alla<br />
luce. […] Sappiamo che <strong>in</strong> noi l’immag<strong>in</strong>e <strong>in</strong>aspettata non ha avuto <strong>in</strong>izio: dunque la scelta è avvenuta di là dalla<br />
nostra coscienza, di là dai nostri giorni e concetti; essa si ripete ogni volta, sul piano dell’essere, per grazia, per<br />
ispirazione, per estasi <strong>in</strong>somma 92 .<br />
In questa analisi delle forme e delle modalità della conoscenza <strong>in</strong> epoca moderna, il rigetto<br />
dell’idealismo, come nel caso di Lawrence, è netto. Il mito non è un ideale: “Questi simboli<br />
del nostro essere sono altro dall’ ideale di vita, che qualcuno potrebbe scorgervi” 93 . La<br />
differenza tra l’idealismo e la mitologia è proprio lo “sforzo conoscitivo” che implica<br />
un’analisi serrata sui simboli condotta attra<strong>vers</strong>o “la tensione delusa e sempre vivace di tutto<br />
il nostro essere per afferrarli, <strong>in</strong>capsularli, <strong>in</strong>corporarceli nel sangue e conoscerli<br />
f<strong>in</strong>almente” 94 . Le verità costruite idealmente non appartengono <strong>in</strong>somma al dom<strong>in</strong>io della<br />
mitologia. A partire dall’evento unico lo sforzo dell’<strong>in</strong>dividuo deve essere quello di scavarne<br />
il significato profondo alla luce della propria esistenza. Il mito si configura come punto di<br />
contatto tra la memoria personale e quella collettiva, tra il passato dell’uomo e quello<br />
dell’umanità. E’ il momento della libertà metafisica, il momento <strong>in</strong> cui l’uomo si emancipa<br />
dal mondo, dal suo tempo empirico, dalla sua cultura: “E per ciò diremo che i simboli, le<br />
scoperte-ricordo della nostra sostanza, […] sono la risposta del nostro ist<strong>in</strong>to alle<br />
sollecitazioni della cultura” 95 . La separazione tra l’uomo e il suo mondo è sancita dal ricorso<br />
al mito che comporta una nuova visione del tempo, dell’uomo e di tutto l’esistente: “Si tratta<br />
di cogliere nella sua estasi, nel suo eterno, un altro spirito” 96 . Si tratta di un ritorno <strong>vers</strong>o<br />
l’orig<strong>in</strong>e <strong>in</strong> cui il rapporto tra l’uomo e il mondo era concepito <strong>in</strong> maniera del tutto differente<br />
da come è concepito nell’epoca della modernità: “Sarà un discendere nella tenebra feconda<br />
delle orig<strong>in</strong>i dove ci accoglie l’uni<strong>vers</strong>ale umano […]” 97 . L’uni<strong>vers</strong>ale umano sembra essere<br />
uno degli <strong>in</strong>teressi primari della ricerca di Pavese che conclude il saggio riferendosi alla<br />
percezione comune che tutta l’umanità detiene: “Si tratta di respirarne un istante l’atmosfera<br />
rarefatta e vitale, e confortarci alla magnifica certezza che nulla la differenzia da quella che<br />
stagna nell’anima nostra o del contad<strong>in</strong>o più umile” 98 . Guglielm<strong>in</strong>etti <strong>in</strong>dividua, <strong>in</strong> questo<br />
atteggiamento di fronte alla percezione collettiva, un tratto moderno di Pavese che,<br />
riallacciandosi a Faulkner, O’Neill, Proust, si accosta alle meditazioni moderniste sul<br />
91 Il pensiero di Heidegger <strong>in</strong>fluenzò notevolmente gli <strong>in</strong>tellettuali europei soprattutto attra<strong>vers</strong>o la sua opera<br />
maggiore Se<strong>in</strong> und Zeit (Essere e Tempo) del 1927. La sua ferma posizione contro la modernità, i modelli<br />
positivistici e idealistici del sapere possono essere ricollegate direttamente alle posizioni della maggior parte<br />
degli <strong>in</strong>tellettuali modernisti.<br />
92 C. Pavese, Stato di Grazia, cit. p. 146.<br />
93 Ibidem.<br />
94 Ibidem.<br />
95 Ivi, p. 148.<br />
96 Ivi, p. 149.<br />
97 Ivi, p. 149.<br />
98 Ivi, p. 149.<br />
40
personaggio-tipo 99 :<br />
L’arte moderna che sembra sfuggire alla trama, semplicemente sostituisce a quella <strong>in</strong>genua dei fatti di cronaca,<br />
una sottilissima miriade di avvenimenti <strong>in</strong>teriori <strong>in</strong> cui ai personaggi si sostituisce un solo personaggio (average<br />
man) che chiunque di noi può essere – anzi, è, sotto le antiche grossolane schematizzazioni psicologiche 100 .<br />
Nelle future riflessioni, il personaggio-tipo si arricchirà di nuove caratteristiche ispirate da<br />
Vico e dai suoi “eroi contad<strong>in</strong>i” 101 . All’<strong>in</strong>terno del tempo mitico si assiste dunque al<br />
tentativo di creare personaggi mitici che nel tempo possano trovare pieno <strong>in</strong>serimento. La<br />
creazione di un personaggio medio e simbolico, rientra nell’<strong>in</strong>teresse di Pavese per il<br />
r<strong>in</strong>venimento delle categorie mitiche essenziali, eterne e uni<strong>vers</strong>almente valide. Il personaggio<br />
così creato diviene portatore di un tempo assoluto, dunque mitico. Così come avviene per<br />
l’attimo, anche il personaggio viene posto fuori dal tempo e diviene estatico 102 . La necessità<br />
di dedurre una legge uni<strong>vers</strong>ale al f<strong>in</strong>e di farvi appartenere tutti gli elementi della sua<br />
scrittura, questo sforzo di mediazione che consiste nel tirare le fila fra tutti i componenti per<br />
legarli <strong>in</strong> un’unità <strong>in</strong>dissolubile di frammenti, rappresentò una priorità per lo scrittore. Nei<br />
saggi di Feria d’Agosto, si può scorgere uno dei problemi alla base della poetica di Pavese:<br />
“come mediare tempo estatico e tempo profano, citazione mitica e vita contemporanea” 103 .<br />
Nel saggio Il Tempo la quotidianità trova un proprio spazio nell’orizzonte mitico di Pavese:<br />
“Questa vita era fatta di visi e di cose, di schianti di voci, era un <strong>in</strong>cessante <strong>in</strong>contro, un<br />
movimento che non aveva passato” 104 . Guglielmi <strong>in</strong>dividua <strong>in</strong> questo passo un’ulteriore<br />
espressione della concezione mitologica di Pavese:<br />
E' qui <strong>def</strong><strong>in</strong>ito il tempo della festa. E bere, suonare, ballare, compiere <strong>in</strong>contri sono altrettanti tòpoi della<br />
narrativa di Pavese. Ci si ritrova nelle fiere e nelle osterie. E lì la vita è <strong>in</strong>tensa e unanime. Lì il calendario non<br />
vige più. E cadono le barriere tra l'io e l'altro. Festa è celebrazione di un rito, sospensione del tempo, ritorno allo<br />
stesso giorno. Ora Pavese aveva <strong>in</strong> mente un romanzo di cose, povero di trama, e tutto fondato sulla magia del<br />
ritmo, sul ritorno di voci e personaggi. Qu<strong>in</strong>di riduzione dell'elemento descrittivo-naturalistico <strong>in</strong> favore del<br />
movimento del racconto 105 .<br />
La modernità dell’<strong>in</strong>terpretazione del mito di Cesare Pavese risiede tutta <strong>in</strong> questo motivo: la<br />
ricerca costante di accordare sapienza classica a sapienza moderna, di portare il mito dalle<br />
aule uni<strong>vers</strong>itarie di studi di lat<strong>in</strong>o e greco al livello della gente comune. Il mito diviene nuova<br />
forma di conoscenza e, al contempo, nuova forma di comunicazione.<br />
Le motivazioni che sp<strong>in</strong>sero Pavese all’approfondimento degli studi di mitologia furono,<br />
qu<strong>in</strong>di, di di<strong>vers</strong>a natura: da quelle puramente <strong>in</strong>tellettuali, che riconoscevano nel mito una<br />
possibilità <strong>in</strong>terpretativa del reale, a quelle esistenziali, che utilizzavano il mito come ancora<br />
di salvezza, come concreta possibilità di fuga da un presente rifiutato, f<strong>in</strong>o ad arrivare<br />
all’importanza della mitologia per la composizione delle sue opere narrative. Buona parte<br />
della critica <strong>in</strong>dica nel desiderio di Pavese di considerarsi un classico a tutti gli effetti un buon<br />
99 M. Guglielm<strong>in</strong>etti, Cesare Pavese romanziere, cit. p. XI.<br />
100 C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, 28 Luglio 1938, cit. p. 114.<br />
101 Ivi, 5 Novembre, 1943, p. 269.<br />
102 Questo sforzo di legare tutte le tematiche della composizione fra loro sotto l’egida di un’unica legge, quella<br />
della poesia mitica o classicismo rustico, e qu<strong>in</strong>di legare il personaggio alle tematiche temporali, risente degli<br />
<strong>in</strong>flussi delle letture degli <strong>in</strong>tellettuali moderni tra cui Lukàcs. In riferimento al critico ungherese, Pavese scrive<br />
il seguente appunto: “L’arte del XIX sec. s’<strong>in</strong>centra sullo sviluppo delle situazioni […]; l’arte del XX sulle<br />
essenze statiche. L’eroe al pr<strong>in</strong>cipio era di<strong>vers</strong>o che alla f<strong>in</strong>e della storia; ora è sempre uguale”. C. Pavese, Il<br />
Mestiere di Vivere, 21 Dicembre 1948, cit. p. 359.<br />
103 G. Guglielmi, La prosa Italiana del Novecento, tra romanzo e racconto, cit. p. 130.<br />
104 Cesare Pavese, Il tempo, contenuto <strong>in</strong> C. Pavese, Feria d’Agosto, cit. p. 95.<br />
105 G. Guglielmi, La prosa Italiana del Novecento, tra romanzo e racconto, cit. pp. 130-31.<br />
41
motore di questa attività di riscoperta mitologica mentre ancora altri studiosi sottol<strong>in</strong>eano<br />
nell’<strong>in</strong>teresse per il mito un vero segno di appartenenza dello scrittore alla cultura del suo<br />
tempo, soprattutto a quella europea. La concezione del tempo, sentita come basilare per la<br />
<strong>def</strong><strong>in</strong>izione di una propria poetica, impegna la ricerca di Pavese che si condensa <strong>vers</strong>o una<br />
concezione ciclica della storia. Tale concezione non arriverà mai ad una <strong>def</strong><strong>in</strong>izione f<strong>in</strong>ale,<br />
sarà al contrario sofferta e cont<strong>in</strong>uamente ripensata. Guglielmi parla del tentativo, operato<br />
dallo scrittore nei suoi scritti teorici, di approfondire e sottol<strong>in</strong>eare il nesso cultura-letteratura<br />
all’<strong>in</strong>terno del dibattito contemporaneo del modernismo europeo:<br />
Le sue opere sono costruite, pensate, volute, sempre sostenute da una tensione ragionativa. La sua ambizione era<br />
quella di riuscire ad essere uno scrittore del proprio tempo. E proprio nella cultura del proprio tempo trovò<br />
quell'<strong>in</strong>teresse per il mito, rivalutato come forma di conoscenza, che Vico e i romantici avevano <strong>in</strong>augurato [...] a<br />
un'organizzazione del racconto non naturalistica, il racconto mitico-simbolico doveva <strong>in</strong>vero offrirsi come<br />
modello. E Pavese elaborò una poetica del mito 106 .<br />
Giambattista Vico viene comunemente considerato la prima fonte d’ispirazione di Pavese per<br />
l’elaborazione della teoria del mito. Il riferimento a Vico rappresentava per lo scrittore un<br />
elemento di grossa novità ed importanza nell’ambito del suo lavoro. In Vico, Pavese<br />
riconosceva una forte modernità che lo emancipava, <strong>in</strong> qualche maniera, dalla cultura<br />
classicistica italiana: “Vico è il solo scrittore italiano che senta la vita rustica fuori<br />
d’Arcadia” 107 . L’idea che La Scienza Nuova contenesse al suo <strong>in</strong>terno un forte elemento di<br />
novità e che fosse più rapportabile al pensiero romantico e post-romantico europeo che a<br />
quello classicista e idealista italiano, era ben radicata <strong>in</strong> Pavese che non tarda a trovare<br />
conferme storiche da parte di autori e critici. Fra le idee che Pavese att<strong>in</strong>se dalla Scienza<br />
Nuova, e che sono funzionali all’analisi <strong>in</strong> corso, si possono annoverare proprio quelle relative<br />
al tempo cosmico, alla concezione della storia e qu<strong>in</strong>di alla teoria del mito. La concezione del<br />
mito come forma di conoscenza ha notevole spazio nel pensiero di Pavese e deve all’<strong>in</strong>flusso<br />
del Vico la prima formulazione 108 . La connessione fra mito e conoscenza storica si fa evidente<br />
106 Ivi, p. 114.<br />
107 C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, 5 Novembre 1943, cit. p. 267.<br />
108 La Teoria della cognizione elaborata da Vico si basava sul pr<strong>in</strong>cipio della separazione tra il campo della<br />
metafisica e quello della fisica, <strong>in</strong> cui gli uom<strong>in</strong>i stabilivano, e di conseguenza potevano <strong>in</strong>terpretare al meglio, le<br />
proprie leggi. Il mondo della natura, creato da Dio e a lui esclusivamente comprensibile, si contrapponeva al<br />
mondo della nazioni che era <strong>in</strong>vece di matrice umana. In questo senso le scienze storiche hanno veramente la<br />
possibilità di produrre conoscenza <strong>in</strong> quanto l’uomo, <strong>in</strong>terrogando la sua storia, può risalire f<strong>in</strong>o alle proprie<br />
orig<strong>in</strong>i. L’uomo medesimo si fa carico di tutta la storia della sua specie. Interrogando se stesso l’uomo ha la<br />
possibilità di comprendere anche la propria storia: “[…] we are capable of re-vok<strong>in</strong>g human history from the<br />
dept of our consciousness” (E. Auerbach, Vico and Aesthetic Historism, cit. p.190). L’analisi storica scientifica<br />
era dunque affiancata da una nuova forza che si potrebbe <strong>def</strong><strong>in</strong>ire poetica con pieno statuto di svolgere un suo<br />
ruolo affianco ai procedimenti documentari e scientifici: “He comb<strong>in</strong>ed an almost mystical faith <strong>in</strong> the eternal<br />
order of human history with a tremendous power of productive imag<strong>in</strong>ation <strong>in</strong> the <strong>in</strong>terpretation of myth, ancient<br />
poetry, and law” 108 . In questa nuova visione della storia e dei suoi metodi d’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e, l’uomo primario venne ad<br />
essere descritto sotto tutt’altra luce rispetto alle idilliache visioni, di lì a venire, del buon selvaggio di Rosseau. Il<br />
concetto di società primitiva venne a spogliarsi, nelle analisi del Vico, di ogni pregiudiziale ideologica così che<br />
anche l’idea che l’uomo, ai suoi primordi, fosse una sorta di terribile bestia sangu<strong>in</strong>aria fu rigettata. Per Vico<br />
l’età primitiva fu un’età <strong>in</strong> cui l’uomo, orig<strong>in</strong>ariamente appartenente a comunità nomadi, era governato<br />
dall’immag<strong>in</strong>azione e dalle sensazioni piuttosto che dalla ragione. In questo mondo caotico <strong>in</strong> cui gli ist<strong>in</strong>ti<br />
primari non erano soppressi da alcuna legge, l’uomo viveva <strong>in</strong> promiscuità con i suoi simili ed <strong>in</strong> comunione con<br />
la natura. Era comunque una comunione che non significava idillio. Era anzi una relazione tragica quella che si<br />
<strong>in</strong>staurava fra l’uomo e la natura. Ma era comunque una relazione vitale ed impresc<strong>in</strong>dibile che legava<br />
<strong>in</strong>dissolubilmente la natura, l’uomo e la sua storia. Proprio per porre un arg<strong>in</strong>e alla forza dirompente della natura<br />
i primi uom<strong>in</strong>i crearono le prime forme di religione che differivano sostanzialmente dalle attuali. Le div<strong>in</strong>ità<br />
create, <strong>in</strong> seno a quelle che vengono comunemente <strong>def</strong><strong>in</strong>ite religioni animistiche, rappresentavano le volontà e le<br />
potenzialità dell’essere umano. I riti e miti scaturivano dalla visione che l’uomo aveva del suo mondo e del suo<br />
essere. La società che si venne a formare, strettamente patriarcale, rimase legata <strong>in</strong>dissolubilmente a questo<br />
42
s<strong>in</strong> dai primi appunti di Pavese che riguardano Vico sul Mestiere di Vivere così come appare<br />
evidente l’importanza che la riflessione del mito ha a livello di vita privata dell’autore e<br />
potremmo anche aggiungere, a livello esistenziale, e sulla teoria della composizione narrativa<br />
e poetica:<br />
Ciò che si trova grande <strong>in</strong> Vico –oltre il noto- è quel carnale senso che la poesia nasce da tutta la vita storica;<br />
<strong>in</strong>separabile da religione, politica, economica; > vissuta da tutto un popolo prima di<br />
diventare mito stilizzato, forma | mentale di tutta una cultura. In particolare, il senso che ci vuole una particolare<br />
disposizione (>) per farne. Ed è ancora <strong>in</strong> fondo la teoria che meglio rivive e spiega le epoche<br />
creatrici di poesia, il mistero per cui tutte le forze vive di una nazione sgorgano ad un dato momento <strong>in</strong> miti e<br />
visioni. […] Le mie storie non sono che st. d’amore o st. di solitud<strong>in</strong>e. Per me pare che non esista altro modo<br />
d’uscire dalla solitud<strong>in</strong>e che una ragazza. Possibile che non m’<strong>in</strong>teressi d’altro? O è perché il<br />
rapporto erotico riesce più facilmente mitologizzabile senza particolareggiare? 109<br />
L’<strong>in</strong>flusso del Vico fu tra i più importanti per la formazione di un pensiero storico <strong>in</strong> Pavese.<br />
Pavese, nei suoi appunti, tendeva a accomunare pensatori ed artisti di epoche e culture di<strong>vers</strong>e<br />
traendo da ognuno un <strong>in</strong>segnamento che arricchisse la sua ricerca e che la protendesse <strong>vers</strong>o<br />
un’orig<strong>in</strong>ale s<strong>in</strong><strong>tesi</strong> tra classico e moderno. Nel Settembre del 1943 è <strong>in</strong>teressante notare<br />
come, nella formulazione della legge del ritorno, gli appunti su Thomas Mann <strong>in</strong>tegr<strong>in</strong>o quelli<br />
presi dalla Scienza Nuova: “Prima ancora di rileggere Th. Mann Giacobbe. Hai concluso con<br />
la scoperta del mito-unicità, che fonde | così tutti i tuoi antichi rovelli psicologici e i tuoi più<br />
vivi <strong>in</strong>teressi mitico§creativi. E’ assodato che il bisogno di costruzione nasce per te su questa<br />
legge del ritorno.[…] Tutto è ripetizione, ripercorso, ritorno” 110 . La riflessione sulla categoria<br />
del mito implica <strong>in</strong> Pavese una rivisitazione di buona parte della letteratura contemporanea<br />
così che nelle formulazioni che appaiono più <strong>def</strong><strong>in</strong>itive si possono cogliere elementi di di<strong>vers</strong>a<br />
provenienza. Ovviamente il tentativo di Pavese fu sempre quello di equilibrare una s<strong>in</strong><strong>tesi</strong><br />
sensata che potesse portare a nuove implicazioni atte ad arricchire la sua teoria mitologica:<br />
Il ritorno degli eventi <strong>in</strong> Th. Mann […] è <strong>in</strong> sostanza una concezione evoluzionista. Gli eventi si provano ad<br />
accadere, e ogni volta accadono più soddisfacenti, più perfetti. Gli stampi mitici sono come le forme della specie.<br />
Ciò che pare staccare questa concezione dal determ<strong>in</strong>ismo naturalistico è il fatto che i suoi fattori non sono la<br />
scelta sessuale o la lotta per l’esistenza, ma una volontà costante di Dio che un certo progetto si realizzi. Del<br />
resto, il modo di enunciare di Mann pare sottendere che ciò che determ<strong>in</strong>a via via gli eventi è lo spirito umano<br />
che, secondo le sue leggi, li percepisce e fa accadere ogni volta sostanzialmente uguali ma più ricchi. Un<br />
formalismo kantiano, calato nella materia mitologica, a <strong>in</strong>terpretarla <strong>in</strong> modo unitario. C’è, qui dietro, Vico 111 .<br />
corpo mitologico tanto da farne una vera e propria legge. I giganti, così chiama Vico i primi uom<strong>in</strong>i, si<br />
esprimevano con immag<strong>in</strong>i e attra<strong>vers</strong>o un l<strong>in</strong>guaggio metaforico. L’ord<strong>in</strong>e da loro creato era magico, poetico<br />
come lo stesso filosofo lo <strong>def</strong><strong>in</strong>iva, ma mai razionale. Questa, che fu la prima età dell’uomo, fu battezzata da<br />
Vico l’età degli dei. L’età che successe a questa prima fu quella dal Vico <strong>def</strong><strong>in</strong>ita eroica. In quest’età gli uom<strong>in</strong>i<br />
formarono le prime comunità sedentarie a regime oligarchico <strong>in</strong> cui i fondatori, gli eroi appunto, detenevano il<br />
potere economico, politico e religioso di fronte al resto degli uom<strong>in</strong>i che vennero soggiogati a quest’ord<strong>in</strong>e.<br />
Questa è propriamente, nel pensiero di Vico, un’età di passaggio <strong>in</strong> cui gli uom<strong>in</strong>i, ancora mentalmente legati ai<br />
vecchi schemi, facevano i primi passi <strong>vers</strong>o concezioni più prettamente razionalistiche. Gli eroi applicarono i<br />
vecchi schemi dell’età precedente alla nuova società. Questo procedimento creò una società di <strong>in</strong>eguali <strong>in</strong> cui<br />
discipl<strong>in</strong>e crudeli e sangu<strong>in</strong>arie avevano luogo. Ma gli eroi, legati ancora strettamente ad un pensiero mitico,<br />
sostituirono se stessi agli dei, <strong>in</strong>staurando un dom<strong>in</strong>io sul resto della specie. La pratica di un pensiero poetico,<br />
anche se nella degenerazione del sistema sociale corrente, era però ancora predom<strong>in</strong>ante. La terza età vide la<br />
rivalsa di coloro che erano stati soggiogati e si impose come età democratica basata sui pr<strong>in</strong>cipi della razionalità.<br />
In quest’età la poesia perse <strong>def</strong><strong>in</strong>itivamente il suo ruolo per diventare poco più di un passatempo e di una<br />
decorazione. Nella ricostruzione storica del Vico vi è una differenza fondamentale che lo dissocia dall’idealismo<br />
romantico e lo associa, al contrario, alle speculazioni degli <strong>in</strong>tellettuali modernisti.<br />
109 C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, 30 Agosto 1938, cit. pp. 115-116.<br />
110 Ivi, 6 Novembre 1943, p. 269.<br />
111 Ivi, 18 Febbraio 1945, p. 298.<br />
43
Le teorie della ciclicità storica e del ripetersi degli eventi furono funzionali alla teoria della<br />
composizione di Pavese. La riflessione dello scrittore non proseguì, <strong>in</strong>somma, <strong>in</strong> maniera<br />
esaustiva sul significato ultimo della storia anche se, accettando l’impostazione mitica, ci si<br />
trova di fronte ad un rifiuto delle teorie della storia l<strong>in</strong>eare, dell’idealismo e del progresso. Il<br />
rifiuto dell’idea di progresso è correlata all’idea del mito che privilegia una struttura circolare<br />
della storia. L’idealismo di matrice hegeliana estese la sua <strong>in</strong>fluenza <strong>in</strong> molti campi, alcuni dei<br />
quali importanti per questo studio 112 . La riflessione <strong>in</strong>torno alla storia e al concetto di<br />
progresso fu centrale <strong>in</strong> quest’epoca e rappresenta il fulcro di un revival del pensiero<br />
mitico 113 . Tempo l<strong>in</strong>eare e tempo ciclico si misero <strong>in</strong>somma <strong>in</strong> competizione e i risultati della<br />
tensione si posero come capisaldi della teoria compositiva di molti scrittori modernisti 114 . La<br />
112 L’idealismo di Hegel aveva portato, nell’ottocento, a costruire un modello di storia l<strong>in</strong>eare e progressiva. Il<br />
tempo poteva essere dispiegato su una l<strong>in</strong>ea retta che procedeva all’<strong>in</strong>f<strong>in</strong>ito. La direzione di questa l<strong>in</strong>ea era<br />
segnata dallo spirito della storia stessa che si componeva di elementi umani ed elementi div<strong>in</strong>i. Questa<br />
concezione del tempo l<strong>in</strong>eare diede adito a svariate critiche tra cui quella di voler supportare il modello di civiltà<br />
europea e il concetto di progresso che portava ad una <strong>in</strong>evitabile espansione imperialista del mondo occidentale.<br />
Questa concezione di tempo l<strong>in</strong>eare ebbe notevole riscontro anche <strong>in</strong> Italia. La storia della letteratura italiana del<br />
De Sanctis si basò su questo concetto: la storia d’Italia e quella della sua letteratura fu segnata da un divenire<br />
razionale e direzionato governato da quello che fu <strong>def</strong><strong>in</strong>ito il genio italiano. Questo metodo d’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e consentì<br />
di disegnare una storia razionale, priva di <strong>in</strong>toppi, che permise di far tornare tutti calcoli <strong>in</strong> relazione alla realtà<br />
politica del momento. E’ una storia che tende a marg<strong>in</strong>alizzare le differenze, le m<strong>in</strong>oranze, gli strappi e le<br />
contraddizioni per poter assecondare un modello ideale. La rottura con tale schema partì da basi filosofiche,<br />
quelle stabilite da Nietzsche, ma trovò la sua attuazione soprattutto a livello estetico. Furono <strong>in</strong>somma gli artisti<br />
a contestare, diffusamente nelle loro opere, un modello che sembrava fare perfettamente il gioco delle classi<br />
politiche egemoni ma che, proprio nel campo della politica, aveva trovato f<strong>in</strong>o a quel momento pochi<br />
antagonisti. La concezione del tempo mitico non fu dunque opposta programmaticamente o addirittura<br />
politicamente a quella l<strong>in</strong>eare storicistica ma espletò la sua funzione <strong>in</strong> ambito estetico <strong>in</strong>carnando una realtà<br />
alternativa. Era una realtà che scorreva parallela ma che comunque, nelle opere di f<strong>in</strong>zione, amò scontrarsi con la<br />
realtà “reale”. Lo scontro, nelle opere di f<strong>in</strong>zione moderniste, tra tempo mitico e tempo storico è un topos<br />
ricorrente che sfocia spesso <strong>in</strong> tragedia.<br />
113 Solo <strong>vers</strong>o la metà dell’ottocento l’Europa com<strong>in</strong>ciò a scoprire Vico. Nell’area anglo-americana gli scrittori<br />
modernisti, come Joyce e Pound, ne trassero un importante <strong>in</strong>segnamento. Per Auerbach, l’eredità filosofica che<br />
Vico lascia all’epoca della modernità, si può riassumere <strong>in</strong> tre punti. Il primo punto riguarda un certo formalismo<br />
magico che il filosofo napoletano attribuiva alle società primitive. Tale formalismo permetteva loro di creare e<br />
mantenere le proprie istituzioni attra<strong>vers</strong>o la creazione e il ricorso al mito. Questa <strong>def</strong><strong>in</strong>izione implica un’unità<br />
<strong>in</strong>tr<strong>in</strong>seca alla mitologia che è <strong>in</strong> grado di relazionarsi alla struttura politica, sociale ed economica. L’unità che la<br />
realtà umana trovava nel mito era espressa da un l<strong>in</strong>guaggio concreto, vitale e poetico, immag<strong>in</strong>ifico e<br />
metaforico che, per Auerbach, trovò immediato riscontro nell’epoca moderna: “[…] the concept of concrete<br />
realism <strong>in</strong> primitive language and myth are extremely suggestive of certa<strong>in</strong> modern tendencies”. Il secondo<br />
punto è quello della teoria della cognizione. L’uomo è creatore della propria vicenda storica ed <strong>in</strong> virtù di ciò<br />
egli ha la possibilità di comprendere il proprio essere risalendo alle orig<strong>in</strong>i della storia della propria civiltà: “The<br />
entire development of human history, as made by men, is potentially conta<strong>in</strong>ed <strong>in</strong> the human m<strong>in</strong>d, and may<br />
therefore, by a process of research and re-evocation, be understood by men” pp.195-6. Il terzo punto è per<br />
Auerbach quello della prospettiva storica. La natura e la storia non sono, per Vico, <strong>in</strong> contrapposizione ma<br />
rappresentano una la funzione dell’altra. La natura storica dell’uomo viene ad essere affermata. L’uomo diviene<br />
un tutt’uno con la sua storia. Michael Bell così s<strong>in</strong>tetizza il ruolo di Vico <strong>in</strong> relazione ai fermenti europei<br />
romantici e modernisti:Mythopoeia, without loos<strong>in</strong>g its archaic overtones, became the paradigmatic capacity of<br />
the human m<strong>in</strong>d. On this view, <strong>in</strong>stead of myth be<strong>in</strong>g the early stage out of which the sophisticated <strong>in</strong>tellectual<br />
discipl<strong>in</strong>es of modern culture developed, it is rather the permanent ground on which they rest, or even the soil <strong>in</strong><br />
which their roots are <strong>in</strong>visibly nourished. And idea long propounded by Giambattista Vico <strong>in</strong> his The new<br />
science, and rehearsed <strong>in</strong> much romantic thought, came fully <strong>in</strong>to its own with the new science of the twentieth<br />
century. […] The <strong>in</strong>ternal criteria of scientific discipl<strong>in</strong>es are themselves conta<strong>in</strong>ed with<strong>in</strong> a larger language and<br />
culture whose nature is seen to be ultimately mythopoeic (M.Bell, Literature, modernism and myth, cit. pp. 16-<br />
17).<br />
114 La concezione di tempo mitico, <strong>in</strong> opposizione al tempo storico fondante della nostra civiltà occidentale,<br />
venne analizzata all’epoca da Oswald Spengler nel suo Decl<strong>in</strong>e of the West (1918). Spengler studiò la storia del<br />
mondo come una serie <strong>in</strong><strong>in</strong>terrotta di alternarsi di civiltà nel loro percorso canonico di nascita, vita e morte. Il<br />
processo, che attualmente era <strong>in</strong> atto nella civiltà occidentale, era riflesso, nell’op<strong>in</strong>ione di Spengler, nelle<br />
proiezioni di tempo mitico che gli scrittori modernisti disegnavano nelle loro opere.<br />
44
dist<strong>in</strong>zione fra le dimensioni del tempo empirico, dove regnava un tempo razionale e dove<br />
poteva essere concepita un’idea di progresso, e la dimensione di un mondo metafisico del<br />
tempo assoluto, <strong>in</strong> cui vigeva una concezione mitologica dell’esistente, si affacciò già nel<br />
1939 nella mente di Pavese. Partendo da un <strong>in</strong>terrogativo che, per G. Isotti Rosowsky, viene<br />
tratto direttamente dal diario di Baudelaire, Mon coeur mis a nu, Pavese si pone il problema<br />
del progresso storico proiettando la conclusione della riflessione, come di consueto, dal piano<br />
collettivo a quello <strong>in</strong>dividuale:<br />
C’è o non c’è progresso nella storia? Insolubile, perché mentre tu <strong>in</strong>tendi per progresso l’<strong>in</strong>gresso<br />
nell’assolutezza dei valori morali, e tutto il resto la chiami tecnica (astuzia), altri s’accontentano appunto di<br />
quest’arricchimento TECNICO delle condizioni del benessere e lo chiamano progresso. Non si può giungere<br />
all’assoluto per gradi. Qu<strong>in</strong>di non si può trovare l’assoluto <strong>in</strong> fondo a un’evoluzione storica. Qu<strong>in</strong>di il progresso<br />
(<strong>in</strong>negabile) non | è <strong>vers</strong>o l’assoluto, ma è quantitativo. Lo stesso <strong>in</strong> un <strong>in</strong>dividuo. C’è progresso tecnico, di<br />
astuzia, d’esperienza, ma la portata del ponte è quella dei sette anni. Tal era allora, <strong>in</strong> assoluto, tale è a<br />
trentac<strong>in</strong>que 115 .<br />
Il tempo della narrazione si dissocia dunque dal tempo empirico. Il primo è tempo mitico,<br />
che non sa di progresso. A livello narrativo il rapporto si condensa nella nota dell’Aprile del<br />
1941 quando Pavese r<strong>in</strong>traccia nel sistema della scansione razionale del tempo del racconto,<br />
che si svolge a partire da un <strong>in</strong>izio ben identificabile per poi esaurirsi <strong>in</strong> un f<strong>in</strong>ale che doti di<br />
senso compiuto l’<strong>in</strong>tera narrazione, un s<strong>in</strong>tomo della corrispondenza che <strong>in</strong>tercorre tra il<br />
tempo empirico e quello della f<strong>in</strong>zione:<br />
Uno dei meno osservati gusti umani è quello di prepararsi degli eventi a scadenza, di organizzarsi un gruppo di<br />
accadimenti che abbiano una costruzione, una logica, un pr<strong>in</strong>cipio e una f<strong>in</strong>e. La f<strong>in</strong>e è avvistata sempre come<br />
un’acme sentimentale, una lieta e lus<strong>in</strong>gante crisi di consapevolezza di sé. Ciò si stende dalla costruzione di una<br />
botta e risposta a quella di una vita. E che cos’è ciò se non la premessa del narrare? L’arte narrativa appaga<br />
appunto questo gusto profondo. Il piacere del narrare e dell’ascoltare è vedere disporsi dei fatti secondo questo<br />
grafico. A metà di un racconto si risale alle premesse e si gode di ritrovare delle ragioni, delle chiavi, delle mosse<br />
causali. Che altro si fa ripensando al proprio passato e compiacendosi di riconoscerci i segni del presente o del<br />
successivo? Questa costruzione dà <strong>in</strong> sostanza un significato al tempo. E il narrare è <strong>in</strong>somma soltanto un<br />
mitologizzarlo, uno sfuggirgli 116 .<br />
Il dibattito che si svolgeva <strong>in</strong> Europa all’<strong>in</strong>izio del secolo circa la decadenza della civiltà<br />
occidentale, che si esprimeva filosoficamente nelle teorie niciane <strong>in</strong>torno al nichilismo,<br />
produsse un nuovo montante <strong>in</strong>teresse nei confronti delle teorie della ciclicità. Per Fjagesund,<br />
la concezione temporale modernista è <strong>in</strong> diretta correlazione con il dibattito filosofico<br />
dell’epoca e trova con Lawrence una brillante s<strong>in</strong><strong>tesi</strong> nell’elaborazione di un tempo<br />
<strong>in</strong>dividuale <strong>in</strong> relazione a un tempo uni<strong>vers</strong>ale. Fjagesund ripercorre la storia degli studi di<br />
Lawrence a proposito e mostra come la visione del tempo ciclico fu promossa nello scrittore<br />
dalle letture <strong>in</strong>crociate dei classici dell’antichità e dei moderni filosofi che riecheggiavano<br />
quelle teorie. Primo fra questi ultimi quel Nietzsche che, f<strong>in</strong> dal 1914, seppe impressionare<br />
Lawrence soprattutto con la teoria dell’Eterno Ritorno. Le teorie della ciclicità storica sono<br />
spesso espresse nelle opere di Lawrence: “[…] the Plumed Serpent also shows that ideas of<br />
cyclical movement were a constant presence <strong>in</strong> Lawrence’s m<strong>in</strong>d when writ<strong>in</strong>g the book. As<br />
Kate says to her <strong>in</strong>dian servant Juana: “Ah, the dark races! … The dark races belong to a<br />
bygone cycle of humanity” 117 . In Sons and Lo<strong>vers</strong> le concezioni temporali cicliche di<br />
115 C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, 30 Luglio 1939, cit. p. 156.<br />
116 Ivi, 12 Aprile 1941, p.222.<br />
117 Ibidem.<br />
45
Lawrence trovano un corrispettivo nello svolgersi dei tempi naturali dei giorni e delle<br />
stagioni. Consapevolmente o no i personaggi si trovano a legare i loro atti e i loro amori a<br />
quelli della terra e Lawrence non si stanca di sottol<strong>in</strong>eare questa corrispondenza come, per<br />
esempio, nel momento <strong>in</strong> cui la passione di Paul per Miriam si rivivifica con l’avvento della<br />
primavera: “With the spr<strong>in</strong>g came aga<strong>in</strong> the old madness and battle. Now he knew he would<br />
have go to Miriam” 118 . La visione ciclica di Lawrence trova espressione <strong>in</strong> questo<br />
procedimento letterario e rappresenta una caratteristica riconosciuta della sua poetica: “The<br />
cyclical element is particularly evident <strong>in</strong> the use of analogy. Historical and <strong>in</strong>dividual<br />
processes are systematically expressed <strong>in</strong> imagery relat<strong>in</strong>g to the life of plants, the seasons of<br />
the year, the movements of the planets and so forth” 119 .<br />
La concezione storica di Lawrence, che così spesso trapela dai suoi romanzi, può trovare una<br />
piena formulazione teorica nel tardo Fantasia dell’<strong>in</strong>conscio. La storia dell’uomo è vista <strong>in</strong><br />
un’ampia prospettiva che consente all’osservatore di derivarne leggi cosmiche desunte dai<br />
miti classici e “dalle reliquie che i nostri scienziati (tra i quali viene citato Frazer con il suo<br />
Ramo d’oro) hanno così meravigliosamente raccolto dal passato dimenticato” 120 :<br />
Mi piace il grande mondo dei secoli e delle vaste epoche, il tempo preistorico prima dei nostri giorni, l’umanità<br />
così meravigliosa osservata <strong>in</strong> lontananza, la sua storia senza <strong>in</strong>izi, eppure la pompa e la magnificenza dello<br />
splendore umano si dispiega sempre nei periodi di mutazione della terra. Diluvi, fuoco, cambiamenti della terra<br />
ed arresti glaciali <strong>in</strong>terferiscono con la grande ed affasc<strong>in</strong>ante civilizzazione dell’umanità. Ma mai nulla impedirà<br />
all’umanità e alla potenzialità umana di sviluppare qualcosa di magnifico da un caos r<strong>in</strong>novato. Io non credo<br />
nell’evoluzione, ma nella stranezza e nel cambiamento iridato di una civilizzazione creativa e sempre<br />
r<strong>in</strong>novata 121 .<br />
Il tratto più caratteristico di Lawrence, <strong>in</strong> riferimento alle teorie della ciclicità e del tempo<br />
mitico, sembra quello di voler sempre e comunque trasporre la vicenda cosmica <strong>in</strong> vicenda<br />
<strong>in</strong>dividuale. I personaggi divengono veri e propri correlativi dell’uni<strong>vers</strong>o. Le leggi che<br />
regolano il loro <strong>in</strong>teragire trovano un cont<strong>in</strong>uo corrispettivo nelle leggi della natura e un<br />
adeguato impedimento <strong>in</strong> quelle sociali. I romanzi di Lawrence giocano su questa costante e<br />
sempre <strong>in</strong>stabile relazione fra piano <strong>in</strong>dividuale, sociale e cosmico: “This seems the only way<br />
to grasp Lawrence’s constant preoccupation with death and rebirth on the <strong>in</strong>dividual level, and,<br />
on the cosmic level, with doom and destruction alongside a vision of a resurrected<br />
humanity” 122 . Le leggi dell’uni<strong>vers</strong>o sono poste <strong>in</strong> costante relazione con quelle della vita,<br />
entrambe stagliate sul pr<strong>in</strong>cipio attivo del mito che si struttura come vera forma di conoscenza.<br />
A fianco a questa <strong>in</strong>terpretazione personale si riscontrano <strong>in</strong> Lawrence una serie di posizioni<br />
che permettono di parlare di un’ansia d’attesa, che lo scrittore esprime attra<strong>vers</strong>o i suoi studi<br />
teorici e attra<strong>vers</strong>o le sue produzioni letterarie, nei confronti dell’avvento di un’imm<strong>in</strong>ente età<br />
dell’oro. Questa posizione, che Kermode aveva appunto <strong>def</strong><strong>in</strong>ito escatologica, si correla<br />
appieno ai fermenti culturali del periodo e alla <strong>in</strong>gente mole di letteratura prodotta <strong>in</strong>torno ai<br />
temi dell’ist<strong>in</strong>to, degli impulsi umani, dell’<strong>in</strong>conscio, dell’irrazionalismo, dell’<strong>in</strong>fanzia, del<br />
primitivismo e del sangue. E’ un guardare al futuro come riscoperta del passato collettivo,<br />
<strong>in</strong>dividuale e, f<strong>in</strong>almente, mitico. Il mito, come ricorda Lotman nel suo saggio Letteratura e<br />
Mitologia, non prevede un <strong>in</strong>izio o una f<strong>in</strong>e. La struttura circolare del mito permette di <strong>in</strong>iziare<br />
ovunque e f<strong>in</strong>ire ovunque anzi, ancor meglio, f<strong>in</strong>ire nello stesso punto da cui si era partiti:<br />
118<br />
D. H. Lawrence, Sons and Lo<strong>vers</strong> (1913), Pengu<strong>in</strong> Books, 1966, p. 339.<br />
119<br />
P.Fjagesund, The Apocaliptic World of D. H. Lawrence, cit. p. 14.<br />
120<br />
D. H. Lawrence, Fantasia dell’<strong>in</strong>conscio, cit. p. 23.<br />
121<br />
Ibidem.<br />
122<br />
P. Fjagesund, The Apocaliptic World of D. H. Lawrence, cit. p. 26.<br />
46
Una proprietà del mito uni<strong>vers</strong>almente riconosciuta è la sua subord<strong>in</strong>azione al tempo ciclico. Gli avvenimenti non<br />
hanno uno svolgimento l<strong>in</strong>eare, ma si ripetono eternamente <strong>in</strong> un ord<strong>in</strong>e dato. Perciò <strong>in</strong> l<strong>in</strong>ea di pr<strong>in</strong>cipio <strong>in</strong><br />
questo caso non sono applicabili i concetti di <strong>in</strong>izio e di f<strong>in</strong>e.[…] La narrazione mitologica non è basata sul<br />
pr<strong>in</strong>cipio della catena, come è tipico del testo letterario, ma si sfoglia come un cespo di cavolo, dove ogni foglia<br />
ripete con note varianti tutte le altre e un’eterna ripetizione dello stesso nucleo profondo di <strong>in</strong>treccio si sviluppa <strong>in</strong><br />
un <strong>in</strong>tero aperto all’accrescimento 123 .<br />
La narrativa mitologica è dunque uno sfuggire ai dettami del tempo empirico per affermare la<br />
validità del modello mitico. Il concetto di progresso, che pure ha molto spazio nelle opere di<br />
f<strong>in</strong>zione ricollegandosi direttamente alla concezione idealista della storia, viene dunque<br />
rifiutato su tutti i livelli. Sarà impossibile ritrovare negli scritti di Pavese la classica situazione<br />
romanzesca che prevede lo sviluppo di una situazione e la crescita di un personaggio. Tutto<br />
rimarrà, al contrario, fermo su stesso, vorticando su stesso, nient’altro che approfondendo e<br />
portando a chiarezza, ovvero al livello della ragione, la legge di vita da cui si era partiti. C’è<br />
ancora un grosso sforzo di approfondire i riferimenti culturali, atti a motivare questa teoria,<br />
nell’appunto di Pavese datato Novembre 1948:<br />
Che chi non tende a un f<strong>in</strong>e non capisca la realtà, cioè non ci veda un ord<strong>in</strong>e razionale, pare significhi molte cose.<br />
Significa che la razionalità è soltanto uno strumento per l’azione (Bergson) o che la nostra natura è razionale e<br />
l’azione tende alla verità (S. Tommaso e Marx)? Non conta il prima e il poi. Noi esistiamo <strong>in</strong> una sfera razionale.<br />
A ciò non si sfugge. Logica dell’irre<strong>vers</strong>ibilità della cultura, del progresso, della conoscenza. Lamento<br />
leopardiano che non si sfugge all’amaro vero 124 .<br />
L’artificialità del mondo, della cultura e delle sue nozioni ideali, soprattutto quella del<br />
progresso, viene oramai considerata una realtà tangibile con cui fare i conti. Lo sforzo<br />
primario di Pavese non sembra allora tanto quello di dover <strong>def</strong><strong>in</strong>ire ulteriormente i caratteri di<br />
questo mondo artificiale o approfondire la teoria del mito f<strong>in</strong>o a creare un’alternativa<br />
plausibile. Una soluzione utopica alla Lawrence. Lo sforzo di Pavese sembra piuttosto quello<br />
di voler mettere <strong>in</strong> comunicazione questi due mondi, creare un l<strong>in</strong>guaggio, una narrativa, un<br />
piglio poetico, <strong>in</strong> grado di <strong>in</strong>serirsi fra queste due sfere, quella che potremmo <strong>def</strong><strong>in</strong>ire della<br />
terra e quella del mondo, ed agire <strong>in</strong> questo spazio alla ricerca di un equilibrio sempre e<br />
comunque da riprist<strong>in</strong>are. Nessuno dei due ord<strong>in</strong>i, seguiti pedissequamente, porterebbe a dei<br />
risultati conv<strong>in</strong>centi. Ciò non toglie che la resistenza alle categorie artificiali del mondo si<br />
deve attuare, attra<strong>vers</strong>o il ricorso alle categorie del mito, al f<strong>in</strong>e di scongiurare ulteriori<br />
evoluzioni negative. In un momento storico <strong>in</strong> cui naturalismo e positivismo impegnavano<br />
gran parte della scena, l’esigenza di ripensare i modi della scienza si fece spazio fra gli<br />
<strong>in</strong>tellettuali 125 . La confutazione dei paradigmi di onnipotenza che la scienza, al pari della<br />
religione, propugnava, avvenne, <strong>in</strong> ambito filosofico, ancora per mezzo di Nietzsche. La<br />
scienza e la religione divennero due facce della stessa medaglia, costruzioni umane e non<br />
verità assolute. Il concetto di progresso e l’idea della modernità venivano improvvisamente<br />
ad <strong>in</strong>ciampare su questo punto. Il mito non rappresentava più uno stadio primitivo della storia<br />
dell’umanità ma una vera e propria categoria esplicativa della stessa. La scienza e la religione<br />
erano ulteriori eventi che cadevano all’<strong>in</strong>terno della storia umana, all’<strong>in</strong>terno della sua<br />
mitologia 126 . Il contrasto tra scienza e religione facilitò l’affermarsi di una tendenza estetica<br />
123 J. M. Lotman – Z. M<strong>in</strong>c, Letteratura e Mitologia, cit. p.204.<br />
124 C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, 19 Novembre 1948, cit. p. 356.<br />
125 Karl Pearson, <strong>in</strong> The grammar of Science (1892), sostenne come la scienza non fosse effettivamente <strong>in</strong> grado<br />
di spiegare il funzionamento della natura ma si limitasse a registrare ciò che accadeva sotto determ<strong>in</strong>ate<br />
condizioni. La scienza moderna era da considerarsi, <strong>in</strong>somma, una descrizione e non certo una spiegazione.<br />
126 In un’analisi storica del pensiero mitico, che si radicò <strong>in</strong> Europa nell’ottocento per poi proiettarsi risoluto nel<br />
novecento, va registrato l’apporto di Sigmund Freud, <strong>def</strong><strong>in</strong>ito da Bell come uno tra i “mythopoetic de-<br />
47
mitopoietica: le due discipl<strong>in</strong>e subirono le conseguenze dell’affermarsi di un pensiero mitico<br />
trovandosi risucchiate nel vortice della mitologia nel momento <strong>in</strong> cui furono riconosciute<br />
come ulteriori prodotti della cultura umana. Cultura umana che poteva esprimersi <strong>in</strong>teramente<br />
solo esteticamente, tramite il ricorso al mito, tramite il suo disvelamento e il suo<br />
scioglimento 127 . Se la religione doveva essere <strong>in</strong>terpretata <strong>in</strong> maniera differente, non un<br />
dest<strong>in</strong>o dissimile doveva scontare la sua rivale storica. La scienza, al pari della religione, fu<br />
analizzata e posta sotto osservazione, fu storicizzata e venne a far parte dell’uni<strong>vers</strong>o umano,<br />
rientrò, potremmo dire, nella mitologia piuttosto che costituirne un fattore esterno e super<br />
partes. Bell offre una <strong>def</strong><strong>in</strong>izione esemplare di questo processo:<br />
Both religion and science had now to be understood as active creations of human culture rather than as direct<br />
accounts of external reality. This is the sense <strong>in</strong> which they each took a step towards myth. Mythopoeia, without<br />
los<strong>in</strong>g its archaic overtones, became the paradigmatic capacity of the human m<strong>in</strong>d. On this view, <strong>in</strong>stead of myth<br />
be<strong>in</strong>g the early stage out of which the sophisticated <strong>in</strong>tellectual discipl<strong>in</strong>es of modern culture developed, it is<br />
rather the permanent ground on which they rest, or even the soil <strong>in</strong> which their roots are <strong>in</strong>visibly nourished 128 .<br />
L’appunto del Marzo del 1940, contenuto nel Mestiere di Vivere, ricorda, nel suo pessimismo,<br />
molti scrittori modernisti che amavano costruire i loro romanzi sull’immag<strong>in</strong>e di futuri<br />
alienanti come Orwell, 1984, o Huxley, Brave New World. In Italia, Svevo costruì un romanzo,<br />
La Coscienza di Zeno, basato su un personaggio che non ne voleva sapere di evolvere,<br />
<strong>in</strong>capace di progredire o di regredire. Immobile nella sua posizione Zeno poté scorgere,<br />
nell’immag<strong>in</strong>e dello stadio f<strong>in</strong>ale del progresso moderno, un’apocalittica previsione. Quella<br />
che esprime Svevo è, <strong>in</strong>somma, un’ansia diffusa che co<strong>in</strong>volge tutti gli scrittori della<br />
modernità e che accomuna, nuovamente le posizioni di Pavese e Lawrence:<br />
Devi riconoscere che le magnifiche promesse della scienza avvenire ti atterriscono e le vedresti volentieri<br />
abortire. Non per la ragione che la scienza crea micidiali armamenti […], ma perché la scienza potrà fornire un<br />
giorno mezzi tali di controllo sulla vita <strong>in</strong>teriore e sulla vita fisica dell’<strong>in</strong>dividuo (s<strong>in</strong>cerity test, sterilizzazione), o<br />
surrogati dell’<strong>in</strong>dividuo stesso (robots) o <strong>in</strong>tervento nell’attività <strong>in</strong>teriore e fisica <strong>in</strong>dividuale (<strong>in</strong>oculazione di<br />
sperma artificiale, classificazione delle attitud<strong>in</strong>i, controllo statistico dei gesti alla Taylor, ecc.), che la vita non<br />
varrà più la pena di essere vissuta. La conclusione tipica dei romanzi avveniristici è, <strong>in</strong>fatti, dopo una descrizione<br />
del meccanismo controllatissimo di quella vita, un climax di rottura di coglioni per cui le masse si scatenano<br />
uccidendosi e impazzendo, pur di uscire dall’<strong>in</strong>cubo. Insomma, morire (sia di spada, sia di raggio mortale) non è<br />
nulla; vivere scientificamente appare spaventoso 129 .<br />
mythologisers” , ed <strong>in</strong>serito di diritto nella storia del pensiero mitico dell’ottocento. Pur operando <strong>in</strong> campi<br />
differenti, Freud e i modernisti condividevano uno stesso pr<strong>in</strong>cipio: “conscious and apparent mean<strong>in</strong>gs are often<br />
an unwitt<strong>in</strong>g mask for a true state of affaire which has to be raised to counsciousness”. Freud, nella formulazione<br />
delle sue teorie e nell’organizzazione dei suoi esperimenti, fece costante riferimento alla mitologia. Il substrato<br />
del reale veniva ad essere <strong>in</strong>terpretato attra<strong>vers</strong>o il riferimento al substrato mitico sott<strong>in</strong>teso alle coscienze<br />
occidentali: “In this respect, his read<strong>in</strong>ess to claim the poets as his predecessors, and his use of a mythic<br />
nomenclature for psychological complexes, rightly suggest that his <strong>in</strong>fluential mapp<strong>in</strong>g of the human psyche as<br />
conscious, unconscious and superego was essentially mythic”. M. Bell, Literature modernism and myth, cit. pp.<br />
17-18.<br />
127 Per Bell si assiste, a cavallo dei due secoli, all’entrata <strong>in</strong> scena di un’altro ord<strong>in</strong>e significante, quello<br />
dell’estetica. In un momento storico <strong>in</strong> cui religione e scienza si battevano per l’egemonia nel campo dello<br />
scibile, si assistette alla nascita di una terza categoria, quella dell’estetica, che si pose come alternativa<br />
<strong>in</strong>tellettuale al potere esercitato dalle prime due. La concezione del tempo mitico, esulando dal contesto politico<br />
sociale, pose le sue basi nel campo dell’estetica dove, comunque, un discorso politico e sociale si teneva <strong>in</strong> un<br />
<strong>in</strong>cessante gioco di riflessi tra il mondo della realtà e quello della f<strong>in</strong>zione. L’<strong>in</strong>terpretazione del mito risentì di<br />
queste speculazioni e si formò come prodotto congenito <strong>in</strong> cui si assommavano le esperienze degli scettici<br />
positivisti e dei sostenitori romantici.<br />
128 M. Bell, Literature modernism and myth, cit. p. 16.<br />
129 Ivi, 29 Marzo 1940, p. 182.<br />
48
Lawrence, <strong>in</strong> Fantasia dell’Inconscio, accusa la scienza di aspirare al monopolio dello scibile<br />
umano. Lo scrittore <strong>in</strong>glese <strong>in</strong>serisce la categoria del mito <strong>in</strong> una visone globale che si<br />
potrebbe <strong>def</strong><strong>in</strong>ire un’abbozzata teoria della conoscenza. Proprio dalla polemica condotta nei<br />
confronti della scienza moderna parte il rifiuto di Lawrence per la modernità e la sua riscoperta<br />
delle categorie mitiche:<br />
Non ho nulla contro la nostra scienza. E’ perfetta entro i suoi limiti. Ma considerarla meta esaustiva della nostra<br />
capacità umana di sapere mi sembra affatto puerile. La nostra è una scienza del mondo morto. Neanche la<br />
biologia considera la vita, ma solo le funzioni meccaniche e l’apparato della vita. Onestamente credo che il<br />
grandioso mondo pagano che un tempo precedette la nostra era, aveva una sua vasta e probabilmente scienza<br />
propria, una scienza <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i di vita.[…] Sono conv<strong>in</strong>to che quella grandiosa scienza precedente alla nostra e<br />
così di<strong>vers</strong>a nella sua natura e nella sua costituzione dalla nostra, una volta era uni<strong>vers</strong>ale, valida per tutto l’allora<br />
globo esistente. Credo che era esoterica, <strong>in</strong>vestita di un ampio sacerdozio.[…] Poi si sciolsero i ghiacciai e la terra<br />
fu sommersa. Gli uom<strong>in</strong>i che fuggivano dai cont<strong>in</strong>enti <strong>in</strong>ondati si rifugiarono sulle vette d’America, Europa, Asia,<br />
e delle isole del Pacifico. Alcuni degenerarono naturalmente […] altri conservarono la loro meravigliosa ed <strong>in</strong>nata<br />
bellezza e perfezione della vita,[…] si rifiutarono di dimenticare e cont<strong>in</strong>uarono ad <strong>in</strong>segnare la loro vecchia<br />
sapienza solo nelle sue forme per metà dimenticate e simboliche. Come sapere era più o meno dimenticato,<br />
tuttavia veniva ricordato come rituale, nei gesti e nella mitologia. Così almeno l’<strong>in</strong>tensa potenza dei simboli fa<br />
parte della memoria. E’ per questo che tutti i grandi miti e simboli, che dom<strong>in</strong>avano la terra quando ebbe <strong>in</strong>izio la<br />
nostra storia, si somigliano tanto <strong>in</strong> ogni regione e per ogni popolazione, I grandi miti si ricollegano l’un l’altro.<br />
Ed è per questo che adesso questi miti com<strong>in</strong>ciano di nuovo ad ipnotizzarci, dal momento che il nostro impulso<br />
<strong>vers</strong>o il nostro modo di fare scienza sta languendo 130 .<br />
La concezione del tempo mitico di Lawrence viene teoricamente espressa <strong>in</strong> un articolo<br />
<strong>in</strong>titolato Surgery of the Novel - or a bomb? pubblicato sul Reader's Digest dell'Aprile 1923.<br />
Per Lawrence il tempo del mito è il tempo <strong>in</strong> cui letteratura e filosofia si esprimevano<br />
attra<strong>vers</strong>o le antiche tragedie greche. In questo articolo lo scrittore auspica un ritorno alle<br />
modalità di scrittura antiche. La filosofia e la letteratura trovavano, nella forma mitologica, la<br />
loro espressione più profonda. La ricerca delle leggi della vita attra<strong>vers</strong>o la letteratura<br />
potrebbe recuperare, nell’idea di Lawrence, un’effettiva valenza <strong>in</strong> epoca moderna:<br />
If you wish to look <strong>in</strong>to the past for what next book, you can go back to the Greek Philosophers. Plato’s<br />
Dialogues are queer little novels. It seems to me it was the greatest pity <strong>in</strong> the world when philosophy and fiction<br />
got split. They used to be one, right from the days of myth. Then they went and parted, like a nagg<strong>in</strong>g married<br />
couple, with Aristotle and Thomas Aqu<strong>in</strong>os and that beastly Kant. So the novel went sloppy, and philosophy<br />
went abstract-dry. The two should come together aga<strong>in</strong> <strong>in</strong> the novel 131 .<br />
Nella sua visione storica e nell’ansia di recuperare un passato mitico attra<strong>vers</strong>o un<br />
r<strong>in</strong>novamento dell’umanità, Lawrence utilizza il mito come un modello ma riconosce nelle<br />
attuali espressioni vitali il vero motore della sua ricerca: “La sc<strong>in</strong>tilla deriva dalla sapienza<br />
antica, ma il fuoco è la vita” 132 . L’<strong>in</strong>sistenza sull’attualità delle problematiche espresse tramite<br />
l’utilizzo di categorie mitiche è da considerarsi un tratto comune a molti scrittori modernisti.<br />
Il passo precedente risente ancora della formazione culturale romantica, tesa ad idealizzare il<br />
passato mitico, ma le soluzioni sono del tutto orig<strong>in</strong>ali: “Quello che <strong>in</strong>tendiamo fare è<br />
130 D. H. Lawrence, Fantasia dell’<strong>in</strong>conscio, cit. pp. 22-23.<br />
131 D. H. Lawrence, Surgery of the novel – or a bomb? (1923), pubblicato <strong>in</strong> The Reader’s Digest International<br />
Book Review April 1923, contenuto <strong>in</strong> The English Modernist Reader 1910-1930 , edited by Peter Faulkner,<br />
Uni<strong>vers</strong>ity of Ioawa Press, Ioawa City, 1986.<br />
132 Ibidem.<br />
49
ipercorrere il motivo creativo o religioso dalla sua fonte nell’essere umano, tenendo sempre a<br />
mente la stretta relazione tra il motivo religioso e quello sessuale” 133 . Il r<strong>in</strong>novamento<br />
auspicato da Lawrence non è semplicemente un r<strong>in</strong>novamento sessuale ma implica una totale<br />
rigenerazione culturale. La religione diviene creativa nel momento <strong>in</strong> cui diviene religione<br />
terrestre ed <strong>in</strong>segna all’uomo la fede nella sua terra: “La terra promessa, se esiste da qualche<br />
parte, giace sotto i nostri piedi. Mai più saltare <strong>vers</strong>o l’alto. Mai più elevarsi” 134 .<br />
Nei suoi studi relativi all’<strong>in</strong>flusso della mitologia biblica sul pensiero occidentale, Frank<br />
Kermode, per il quale tutta la storia dell’occidente avrebbe potuto prendere una piega di<strong>vers</strong>a<br />
se solamente il f<strong>in</strong>ale della Bibbia, l’Apocalisse, fosse stato differente, <strong>in</strong>dividua <strong>in</strong> Lawrence<br />
un esempio particolarmente significativo. Per Kermode la mitologia biblica ebbe un deciso<br />
<strong>in</strong>flusso sulla poetica di Lawrence soprattutto nel momento della commistione con la<br />
mitologia classica e gli <strong>in</strong>teressi antropologici dell’epoca: “[…] he f<strong>in</strong>ds evidence of a<br />
deepen<strong>in</strong>g despair, a sense of doom qualified by the old desperate hope that decadence, that<br />
br<strong>in</strong>gs an end, might give way to renovation, that the new age would provide its utopia” 135 . Il<br />
senso di decadenza, la sensazione dell’<strong>in</strong>evitabilità della sconfitta, di cui risentono i romanzi<br />
di Lawrence, sono dunque <strong>in</strong> stretta correlazione con la mitologia biblica così come la fede<br />
per il r<strong>in</strong>novamento che si esaurisce, spesso, <strong>in</strong> utopie. Per Kermode la sensazione che si<br />
ricava leggendo le pag<strong>in</strong>e di Lawrence è quella di essere arrivati alla f<strong>in</strong>e di una fase della<br />
civilizzazione che aspetta solo di perire <strong>def</strong><strong>in</strong>itivamente per poter poi rigenerarsi. Il viatico di<br />
questo percorso “dest<strong>in</strong>ato” nasce dalla presa di coscienza della “morte di Dio”, così come<br />
aveva preconizzato Nietzsche, e può venir portato a piena consapevolezza solo tramite il<br />
riferimento alla mitologia biblica. In questo senso la visione storica di Lawrence,<br />
fondamentalmente ciclica, non entra <strong>in</strong> contrasto con quella l<strong>in</strong>eare della storiografia<br />
ottocentesca di ispirazione cristiana anzi se ne associa nel momento <strong>in</strong> cui la morte di una<br />
civiltà conduce necessariamente alla nascita di una nuova. Apocalypse, l’ultimo scritto di<br />
Lawrence risalente al 1930, è s<strong>in</strong>tomatico di questa visione e rappresenta per Harold Bloom<br />
un passo estremamente significativo che non solo costituisce il punto f<strong>in</strong>ale del percorso<br />
teorico <strong>in</strong>trapreso dallo scrittore ma addirittura supera, <strong>in</strong> profondità ed espressività, molti dei<br />
capolavori narrativi precedenti. In questo passo Lawrence esprime la piena consapevolezza di<br />
vivere <strong>in</strong> un’età di transizione: egli preconizza la rov<strong>in</strong>a della presente civiltà e l’accesso ad<br />
una nuova epoca <strong>in</strong> cui l’uomo tornerà a ristabilire una “connessione organica” con il<br />
cosmo 136 . In Fantasia dell’Inconscio, <strong>in</strong> cui si tenta di offrire una teoria globale della storia<br />
dell’umanità, lo scrittore così <strong>in</strong>terpreta il ruolo e la posizione degli uom<strong>in</strong>i nel mondo:<br />
Gli uom<strong>in</strong>i vivono e vedono secondo una visione che si sviluppa gradualmente e gradualmente decade. Questa<br />
visione esiste anche come idea d<strong>in</strong>amica o metafisica, anzi esiste anzitutto così. Poi si spiega nella vita e<br />
nell’arte. La nostra visione, la nostra fede, la nostra metafisica si sta assottigliando e l’arte sta appassendo e<br />
diventa assolutamente spoglia. Non abbiamo futuro; nè per le nostre speranze nè per le nostre mete, nè per la<br />
nostra arte. Tutto è diventato grigio e opaco. Dobbiamo strappare il vecchio velo della visione e scoprire quello<br />
che il cuore crede realmente, dopo tutto: e quello che il cuore vuole realmente per il prossimo futuro. E noi<br />
dobbiamo ricondurre la cosa <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i di fede e sapere. Poi riprendere ad avanzare nel compimento della vita e<br />
dell’arte 137 .<br />
133<br />
D. H. Lawrence, Fantasia dell’<strong>in</strong>conscio, cit. p. 26.<br />
134<br />
Ivi, p. 27<br />
135<br />
Frank Kermode, Foreword to P. Fjagesund, The Apocaliptic World of D. H. Lawrence, cit. p. IX.<br />
136<br />
Harold Bloom, Introduction to D. H. Lawrence, Modern Critical Views, Chelsea House Publishers, New<br />
York – Philadelphia, 1986, pp. 1-17.<br />
137<br />
D. H. Lawrence, Fantasia dell’<strong>in</strong>conscio, cit. p. 24.<br />
138<br />
Frank Kermode, Apocalyptic Types, contenuto <strong>in</strong> D. H. Lawrence, Modern Critical Views, Chelsea House<br />
Publishers, New York – Philadelphia, 1986, pp. 59-71.<br />
50
Per Frank Kermode la posizione di Lawrence contiene dei netti tratti escatologici. L’attesa di<br />
una nuova era, al limitare dell’era dell’uomo bianco occidentale, si preannuncia nei tratti di<br />
una vera r<strong>in</strong>ascita sessuale così come avviene <strong>in</strong> L’amante di lady Chatterley 138 . La visione<br />
ciclica della storia viene dunque riconsiderata, nelle teorie dello scrittore, alla luce della<br />
mitologia biblica. In Apocalypse Lawrence esprime così il concetto: “Time still moves <strong>in</strong><br />
cycles, not <strong>in</strong> a straight l<strong>in</strong>e. And we are at the end of the Christian cycle. And the Logos, the<br />
good dragon of the beg<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g of the cycle is now the evil dragon of today” 139 . Nel romanzo<br />
The Ra<strong>in</strong>bow si vede una vera e propria dichiarazione di come il mito sia l’ultima categoria di<br />
comprensione del reale a cui l’uomo possa far riferimento. Il mito è visto come un’effettiva<br />
possibilità da parte dei personaggi di comprendere la loro esistenza. La caratteristica di<br />
Lawrence appare dunque quella di fornire gli stessi personaggi di una coscienza problematica<br />
che li porta a ripercorrere, tramite il loro agire, l’esperienza mitica: “The mythic is present for<br />
them not as an idea, or even as a story, but at a pre-reflective level <strong>in</strong> their way of be<strong>in</strong>g” 140 . Il<br />
ricorso al mito si fa dunque, nella poetica di Lawrence, una vera esperienza storica,<br />
un’effettiva possibilità esistenziale e non un mero gioco <strong>in</strong>tellettuale. Il riferimento ai di<strong>vers</strong>i<br />
miti che formarono l’educazione di Lawrence sono costanti e compongono l’orig<strong>in</strong>alità<br />
dell’approccio dello scrittore <strong>in</strong>glese: “Lawrence double myth of orig<strong>in</strong>s comb<strong>in</strong>es the<br />
ascend<strong>in</strong>g Darw<strong>in</strong>ian evolution from the Marsh with a fall from Eden. The struggle between<br />
these two pr<strong>in</strong>ciples, and the struggle to prevent them fall<strong>in</strong>g apart, is the liv<strong>in</strong>g myth of The<br />
Ra<strong>in</strong>bow” 141 . La concezione mitica di Lawrence si forma nell’espressione di questo contrasto:<br />
il mito delle orig<strong>in</strong>i della Genesi di fronte a quello che la moderna antropologia stava creando<br />
partendo dalle teorie evoluzioniste di Darw<strong>in</strong> per arrivare a quelle relativiste di Lucien Lèvy-<br />
Bruhl. La mitologia biblica si correla a quella classica e a quella rustica-pagana <strong>in</strong> una s<strong>in</strong><strong>tesi</strong><br />
che certifica l’orig<strong>in</strong>alità dell’apporto di Lawrence nell’ambito del modernismo letterario.<br />
La mitologia biblica ebbe nella poetica di Lawrence una grande importanza. I riferimenti al<br />
mito biblico della creazione dell’uomo sono costanti all’<strong>in</strong>terno di Sons and Lo<strong>vers</strong> mentre la<br />
campagna ivi descritta appare come l’immag<strong>in</strong>e trasfigurata del giard<strong>in</strong>o dell’Eden. Il senso di<br />
colpa, che ogni personaggio porta nei confronti dell’altro e che ne limita costantemente<br />
l’azione, viene messo <strong>in</strong> diretta associazione con il mito del peccato orig<strong>in</strong>ale. L’agire umano<br />
trova, nelle pag<strong>in</strong>e di Lawrence, la propria orig<strong>in</strong>e e la propria spiegazione proprio nel<br />
substrato mitico. La relazione fra Paul e Clara viene trasposta da Lawrence <strong>in</strong> vicenda mitica:<br />
“You don’t feel crim<strong>in</strong>al, do you? ”<br />
She looked at him with startled grey eyes.<br />
“ Crim<strong>in</strong>al! “ she said. “No”.<br />
“But you seem to feel you have done a wrong? “<br />
“No” she said. “I only th<strong>in</strong>k, if they knew! “<br />
“ If they knew, they’d cease to understand. As it is, they do understand, and they like it. What do they matter?<br />
Here, with only the trees and me, you don’t feel not the least bit wrong, do you? “<br />
He took her by the arm, held her fac<strong>in</strong>g him, hold<strong>in</strong>g her eyes with his. Someth<strong>in</strong>g fretted him.<br />
“ Not s<strong>in</strong>ners, are we? “he said, with an uneasy little frown.<br />
“No” she replied.<br />
He kissed her laugh<strong>in</strong>g.<br />
“You like your little bit of guilt<strong>in</strong>ess, I believe”, he said. “I believe Eve enjoied it, when she went cower<strong>in</strong>g out of<br />
Paradise” 142 .<br />
139<br />
P. Fjagesund, The Apocaliptic World of D. H. Lawrence, cit. p. 18.<br />
140<br />
M. Bell, Literature, Modernism and Myth – belief and respnsability <strong>in</strong> the twentieth century, cit. p. 116.<br />
141<br />
Ibidem.<br />
142<br />
D.H. Lawrence, Sons and Lo<strong>vers</strong>, cit. pp. 381–82.<br />
51
La risoluzione di tutta la vicenda di Paul <strong>in</strong> vicenda mitica assume contorni <strong>def</strong><strong>in</strong>itivi<br />
nell’ultima parte del libro. In queste ultime pag<strong>in</strong>e Lawrence svela come il romanzo non sia<br />
semplicemente la storia di una famiglia delle Midlands <strong>in</strong>glesi. Sons and Lo<strong>vers</strong> aspira <strong>in</strong>vece<br />
alla mitologia, aspira al ritrovamento di quelle leggi che l’uomo moderno stava dimenticando:<br />
When they stood up they saw other lo<strong>vers</strong> steal<strong>in</strong>g down the opposite edge. It seemed natural they were there; the<br />
night conta<strong>in</strong>ed them. And after such an even<strong>in</strong>g they both were very still, hav<strong>in</strong>g known th eimmensity of<br />
passion. They felt small, half afraid, childish, and wonder<strong>in</strong>g, like Adam and Eve when they lost their <strong>in</strong>nocence<br />
and realised the magnificence of the power which drove them out of the Paradise and across the grat night and the<br />
great day of humanity. It was for each of them an <strong>in</strong>itiation and a satisfaction. To know their own noth<strong>in</strong>gness, to<br />
know the tremendous liv<strong>in</strong>g flood which carried them always, gave them rest with<strong>in</strong> themselves. If so great<br />
magnificent power could overwhelm them, identify them altogheter with itself, so that they knew they were only<br />
gra<strong>in</strong>s <strong>in</strong> the tremendous heave that lifted every glass-blade its little height, and every tree, and liv<strong>in</strong>g th<strong>in</strong>g, then<br />
why fret about themselves? They could let themselves be carried by life, and they felt a sort of peace each <strong>in</strong><br />
other. There was a verification which they had togheter. Noth<strong>in</strong>g could nullify it, noth<strong>in</strong>g could take it away; it<br />
was almost their believe <strong>in</strong> life 143 .<br />
Per Fiona Becket, Lawrence miscela sapientemente gli elementi della mitologia biblica con<br />
quelli della mitologia pagana 144 . Miriam rappresenta, a seconda delle circostanze, una dea<br />
pagana, una strega gotica, a volte una sacerdotessa dei boschi. Il substrato mitico presente<br />
nella cultura occidentale affiora costantemente confermando e contraddicendo le esperienze<br />
dei personaggi.<br />
Nella concezione modernista del tempo mitico le implicazioni religiose rimasero forti e<br />
sostanziali. L’importanza della Bibbia nella teoria compositiva degli scrittori mitopoietici<br />
appare estremamente evidente non solo nel caso di Lawrence ma anche <strong>in</strong> quello di Pavese.<br />
Lo scrittore piemontese studiò attentamente la Bibbia e i riferimenti a questa mitologia sono<br />
presenti lungo tutta la sua opera così come nei suoi appunti. E’ <strong>in</strong>teressante notare come<br />
l’autore tentò di cimentarsi direttamente, al pari di Lawrence, con il tema della cacciata dal<br />
Paradiso terrestre. Il racconto breve Si parva licet, composto nel 1938, documenta l’<strong>in</strong>teresse<br />
di Pavese per questo tema biblico. Il racconto si svolge nella cornice dell’Eden. Adamo ed<br />
Eva appaiono imprigionati nel giard<strong>in</strong>o del Signore. Anche <strong>in</strong> questo caso, e vedremo <strong>in</strong><br />
seguito come questo sarà il tema portante dei Dialoghi con Leucò, è l’aspirazione dell’uomo<br />
alla deità a decretarne la rov<strong>in</strong>a. La volontà dell’uomo di porsi al centro dell’uni<strong>vers</strong>o, <strong>in</strong><br />
competizione con Dio e con la natura, ne decreta la cacciata dal Paradiso terrestre e un dest<strong>in</strong>o<br />
di sofferenza.<br />
L’<strong>in</strong>teresse per la Bibbia ha un significato specifico <strong>in</strong> epoca moderna; la valenza simbolica<br />
degli episodi biblici non sfuggì a molti scrittori modernisti. E’ un significato di cui Pavese<br />
apparve ben conscio così come dimostrano i suoi appunti a riguardo dai quali traspare un<br />
<strong>in</strong>teresse storico e filosofico sull’argomento. Egli fu ben consapevole del ruolo culturale del<br />
cristianesimo e questa consapevolezza <strong>in</strong>fluenzò non poco la sua opera. Nondimeno questo<br />
tratto non è una caratteristica specifica di Pavese. L’<strong>in</strong>teresse per la mitologia biblica è<br />
caratteristico del periodo che si vuole <strong>def</strong><strong>in</strong>ire modernista. L’evoluzione di questa nuova<br />
sensibilità si può far scaturire dal secolo dei lumi. L’epoca dell’illum<strong>in</strong>ismo europeo, con i<br />
suoi credo razionalisti, aveva ridotto la religione ad un sistema di superstizioni e false<br />
credenze 145 . Alla visione estremamente razionalista, propugnata dall’illum<strong>in</strong>ismo europeo, si<br />
143 Ivi, pp. 430-31.<br />
144 Fiona Becket, The complete guide to D. H. Lawrence, Routledge, London and New York, 2002, pp. 46-47.<br />
145 Lotman registra questo dato per certi <strong>vers</strong>i paradossale: “[…] la coscienza europea dell’epoca del<br />
razionalismo aveva assolutizzato se stessa <strong>in</strong> modo tale che il mito era paragonato all’ignoranza e veniva di<br />
solito escluso dagli oggetti di osservazione. Questo modo di pensare è degno di nota perché proprio il XVIII<br />
secolo si presenta <strong>in</strong> Europa come un’epoca mitologica”. J. M. Lotman – Z. M<strong>in</strong>c, Letteratura e Mitologia, cit. p.<br />
203.<br />
52
affiancò presto una nuova <strong>in</strong>terpretazione, quella romantica, che si accompagnava ad un nuovo<br />
<strong>in</strong>teresse per lo studio dell’uomo e della sua evoluzione storica. Il nuovo credo romantico,<br />
alimentato <strong>in</strong> buona parte dagli studi di antropologia, rivalutò la religione nei suoi aspetti<br />
essenziali esulando da un discorso prettamente metafisico. La religione, si potrebbe dire, venne<br />
riportata tra gli uom<strong>in</strong>i e com<strong>in</strong>ciò ad essere studiata come un prodotto culturale. Credenze e<br />
superstizioni vennero analizzate come espressioni culturali della razza umana e com<strong>in</strong>ciarono<br />
ad essere considerate come un vero strumento d’<strong>in</strong>terpretazione dell’uomo e del suo mondo.<br />
La cristianità com<strong>in</strong>ciò ad essere compresa, già dalla f<strong>in</strong>e dell’Ottocento, come un presupposto<br />
fondamentale alla cultura moderna. L’<strong>in</strong>tera cultura occidentale si reggeva sui presupposti<br />
della dottr<strong>in</strong>a cristiana per cui r<strong>in</strong>negarne l’importanza apparve, a breve, una presa di posizione<br />
arbitraria e preconcetta. Apparve <strong>in</strong>somma chiaro, dopo gli eccessi della rivoluzione francese,<br />
come la cultura cristiana non fosse altro, ma una parte <strong>in</strong>tegrante e fondante del mondo<br />
occidentale tanto da non poter evitare di tornare a considerare la sua funzione nell’ambito di<br />
qualsiasi queque <strong>in</strong>tellettuale. Cesare Pavese rifletté a lungo sul ruolo centrale della cristianità<br />
nell’ambito della storia della cultura occidentale 146 . Il 24 Gennaio del 1938 appunta sul<br />
Mestiere di Vivere:<br />
Hanno ragione gli idioti, i pazzi, i testardi, i violenti, tutti – meno le persone ragionevoli. Che cosa altro si fa<br />
nella storia, se non <strong>in</strong>ventare spiegazioni ragionevoli per le proprie pazzie? Che è come evocare dei nuovi pazzi<br />
che metteranno tutto a soqquadro. […] Il Cristianesimo non può morire perché contiene la possibilità di tutte le<br />
discipl<strong>in</strong>e 147 .<br />
Cristianesimo come parte fondante della nostra essenza di uom<strong>in</strong>i occidentali, come<br />
condizione irr<strong>in</strong>unciabile a qualsiasi ricerca <strong>in</strong>tellettuale. Fu per primo William Blake, nel<br />
momento della storicizzazione e letterarizzazione del cristianesimo, ad associare l’idea del<br />
mito a quella della religione di Cristo. Il cristianesimo, nella sua fase di trapasso da dogma a<br />
religione storica, si ammantò di un’ambivalenza che seppe tormentare gli <strong>in</strong>tellettuali.<br />
Michael Bell s<strong>in</strong>tetizza così un momento di profonde riflessioni <strong>in</strong>tellettuali su un argomento<br />
che, per la sua presa sulla coscienza della gente, non si poteva ancora dichiarare un vero e<br />
proprio oggetto di studio scientifico:<br />
Hence, for many educated persons, an essential ambivalence surrounded Christian belief through much of the<br />
n<strong>in</strong>eteenth century. While it was be<strong>in</strong>g exploded at the level of its literal historical claims, and its associated<br />
<strong>in</strong>stitutional authority, it reta<strong>in</strong>ed its power as a source of ethical understand<strong>in</strong>g and as social cultural form. On<br />
this view, the discard<strong>in</strong>g of its literal claims was precisely what might have given Christianity its proper truth<br />
value, although that was hardly a recognition that Christians could be expected to embrace 148 .<br />
L’<strong>in</strong>teresse che suscitò il cristianesimo nell’Ottocento portò molti storici a confrontarsi con le<br />
problematiche espresse dalla Bibbia e dalla figura del Cristo. Questo confronto animò le<br />
discussioni degli <strong>in</strong>tellettuali, motivò le ricerche degli storici e <strong>in</strong>fluenzò non poco gli scrittori<br />
modernisti 149 . Per Bell la storia dell’<strong>in</strong>terpretazione della Bibbia e del cristianesimo prese, a<br />
146<br />
E’ da notare come il saggio di Benedetto Croce, Perché non possiamo non dirci cristiani, <strong>in</strong> cui si espongono<br />
posizioni molto simili, risalga al 1945.<br />
147<br />
C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, 24 Gennaio 1938, cit. p. 84.<br />
148<br />
M. Bell, Myth <strong>in</strong> the age of the world view, cit. p. 13.<br />
149<br />
George Eliot tradusse personalmente The life of Jesus (1835) di David Strauss che si impegnava a <strong>def</strong><strong>in</strong>ire la<br />
dimensione storica del cristianesimo mentre Matthew Arnold, con il suo Literature and dogma (1873), fu il<br />
53
questo punto, due direzioni di<strong>vers</strong>e. Interpretare la Bibbia come pura e semplice letteratura,<br />
così come suggeriva Matthew Arnold, poteva sembrare alquanto riduttivo e non teneva conto<br />
delle enormi implicazioni legate a questo testo letterario. Implicazioni che potevano essere<br />
<strong>def</strong><strong>in</strong>ite culturali nella più ampia accezione del term<strong>in</strong>e così come ci spiegano gli studi di<br />
Frank Kermode che analizza il nostro immag<strong>in</strong>ario, le categorie con le quali <strong>in</strong>terpretiamo il<br />
reale, proprio a partire dal testo scritto della Bibbia. La posizione espressa da Arnold sulla<br />
Bibbia non soddisfece gli <strong>in</strong>tellettuali modernisti che vedevano nella Bibbia qualcosa di più<br />
che un testo letterario. La Bibbia poteva <strong>in</strong>vece rappresentare, oltre un’opera letteraria, una<br />
vera e propria dimensione della mitologia moderna? Poteva essere quest’opera, così come<br />
suggerisce Kermode, la vera base dell’<strong>in</strong>terpretazione del reale? Si poteva parlare di un mito<br />
biblico dalla cui <strong>in</strong>terpretazione prendere le mosse per le ricerche <strong>in</strong>tellettuali moderniste? Il<br />
concetto di mito veniva ad assumere, <strong>in</strong> questo contesto, un nuovo ruolo. Non più una forma<br />
di pensiero e d’espressione arcaica ma una vera e nuova possibilità conoscitiva del reale:<br />
Myth, <strong>in</strong> so far as it represents an <strong>in</strong>terpretation of life, reflects the enigmatic visage of life itsel and <strong>in</strong>creas<strong>in</strong>gly<br />
the true mean<strong>in</strong>g of myth seemed to lie at a more uncounscious level, and even perhaps to be the opposit of its<br />
apparent significance. This leads to the second factor: a shift <strong>in</strong> evaluation. Nietzsche attacked Christianity, not<br />
just as a means of priestly or establishment power, but as monumental uncounscious fraud perpetrated by the<br />
psyche on itself; a diagnosis which was to be echoed by many <strong>in</strong> the modernist generation. Christianity was now<br />
not merely a life enhanc<strong>in</strong>g fiction, someth<strong>in</strong>g to enrich the Arnoldian cultural shock, but a damag<strong>in</strong>g collective<br />
illusion throw<strong>in</strong>g the very basis of the culture <strong>in</strong>to question. As the value sign changed, so the question of truth<br />
status became newly urgent and myth became an active, rather than <strong>in</strong>ert, category 150 .<br />
La visione mitica di Cesare Pavese, come quella di molti altri scrittori modernisti, fu<br />
<strong>in</strong>fluenzata dagli studi biblici e del cristianesimo che fiorirono <strong>in</strong> Europa tra l’Ottocento e il<br />
primo Novecento. La figura del Cristo, la sua dottr<strong>in</strong>a, il messaggio biblico rappresentarono<br />
motivi di profonda riflessione per Pavese ed <strong>in</strong>fluenzarono non poco la sua produzione.<br />
Cristo, al di là della realtà storica, venne <strong>in</strong>terpretato come un personaggio mitico, un vero<br />
archetipo per l’uomo moderno. Nel Giugno del 1938, il figlio di Dio, venne <strong>def</strong><strong>in</strong>ito come “il<br />
nostro div<strong>in</strong>o modello” 151 . La forza del modello cristiano, la sua portata mitica, venne<br />
associata alla mitologia per eccellenza, quella greca, e sembra, negli scritti di Pavese,<br />
condividere lo stesso dest<strong>in</strong>o. Il dest<strong>in</strong>o di forgiare le categorie <strong>in</strong>terpretative moderne:<br />
Prima del Cristo e del Logos greco, la vita era un cont<strong>in</strong>uo contatto e ricambio magico con la natura: di qui<br />
uscivano forze, determ<strong>in</strong>azioni, dest<strong>in</strong>i; a lei si tornava, ci si rigenerava. Dopo Cr. e dopo il Logos, la natura si fa<br />
staccata dalla sorgente mistica della forza e della vita (che viene ora dallo Spirito). E’ pronto il campo per la<br />
scienza moderna che constata e codifica la materialità l’<strong>in</strong>differenza della natura 152 .<br />
La mitologia diviene per Pavese una possibilità di <strong>in</strong>terpretare il reale attra<strong>vers</strong>o lo<br />
scioglimento di quei miti che ne nascondono l’essenza. Un risalire <strong>vers</strong>o le fondamenta della<br />
primo a studiare la Bibbia come una vera e propria opera letteraria. Michael Bell così descrive questo momento<br />
storico: “For Arnold, the Bible expressed a profound, collective moral experience aris<strong>in</strong>g from a specific history.<br />
The Bible, read as literature, gives access to this; as does all great literature. Literature becomes a fundamental<br />
mode of cultural understand<strong>in</strong>g and authority”. Ivi, p. 13.<br />
150 Ivi, p. 14.<br />
151 C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, 11 Giugno 1938, cit. p. 106.<br />
152 Ivi, 3 Aprile 1949, cit. pp. 366-7.<br />
54
nostra cultura che nasconde, ma al contempo rivendica, una volontà precisa di oltrepassare le<br />
stesse barriere che la cultura pone per impedire il disvelamento. Il mito diviene la chiave del<br />
regno del possibile, ciò che ne consente l’<strong>in</strong>terpretazione 153 . Nel saggio Il Mito, contenuto <strong>in</strong><br />
Letteratura americana ed altri saggi Pavese svela questo carattere ambiguo del mito. Da un<br />
lato è ciò che ci divide dalla nostra orig<strong>in</strong>e, l’<strong>in</strong>carnazione poetica di tutta la nostra cultura,<br />
dall’altra un nodo da sciogliere, un arcano da portare a chiarezza. Nel mito è <strong>in</strong>carnato il<br />
segreto dell’uomo e del suo essere:<br />
Far poesia significa portare a evidenza e a compiutezza fantastica un germe mitico. Ma significa anche, dando una<br />
corposa figura a questo germe, ridurlo a materia contemplativa, staccarlo dalla materna penombra della memoria,<br />
ed <strong>in</strong> <strong>def</strong><strong>in</strong>itiva abituarsi a non crederci più, come a un mistero che non è più tale 154 .<br />
153 Così come constata Giovanni Cillo, La distruzione dei miti, Nuovedizioni E.Vallecchi, Firenze,1972.<br />
154 C. Pavese, Letteratura Americana e altri saggi, cit., pp. 350-51.<br />
55
2.2 Tempi della modernità<br />
Nell’ambito della riflessione modernista sul mito sono da <strong>in</strong>dicare due momenti dist<strong>in</strong>ti ma<br />
<strong>in</strong>dubbiamente legati: la ricerca della comprensione e della <strong>def</strong><strong>in</strong>izione di un tempo cosmico,<br />
relativa alle leggi uni<strong>vers</strong>ali applicabili a tutto il genere umano, e la ricerca di un tempo più<br />
<strong>in</strong>dividuale, storico appunto, relativa esclusivamente all’<strong>in</strong>dividuo e al suo rapporto di<br />
immediata fruizione con la realtà circostante. Le ricerche di tempo cosmico e storico non sono<br />
semplicemente legate ma sembrano configurarsi una come la proiezione dell’altra. Le leggi<br />
cosiddette “uni<strong>vers</strong>ali” attribuite al tempo cosmico, che si manifestano nell’elaborazione e nel<br />
dispiegamento del mito, sono <strong>in</strong> qualche maniera collegabili al tempo cosiddetto “<strong>in</strong>teriore”.<br />
La concezione del tempo <strong>in</strong>teriore viene dunque a configurarsi, nel pensiero modernista, come<br />
una vera e propria mitologia personale. Se la ricerca di un tempo mitico uni<strong>vers</strong>ale era dettata<br />
per i romantici da un desiderio di ricongiungimento alla natura e alle sue leggi, per i<br />
modernisti nasce da un desiderio di prendere coscienza della distanza che li divide dalle<br />
orig<strong>in</strong>i. La ricerca di quello che potremmo <strong>def</strong><strong>in</strong>ire un tempo mitico <strong>in</strong>teriore derivava dalla<br />
necessità di riscoprire l’immag<strong>in</strong>e di un se stesso ritenuto irrimediabilmente perduto. La<br />
percezione di una lontananza temporale appare come una delle caratteristiche fondamentali<br />
del modernismo. Tale percezione si espleta <strong>in</strong> una poetica della distanza configurata<br />
letterariamente con la designazione di spazi stranieri da percorrere. L’io anela al<br />
ricongiungimento con la terra attra<strong>vers</strong>o il r<strong>in</strong>venimento di un tempo mitico. E’ un tempo ben<br />
lontano da quello della modernità scandito macch<strong>in</strong>almente e a cui l’uomo si deve adeguare.<br />
La scansione del tempo sociale, che avviene attra<strong>vers</strong>o nuovi sistemi, come la sirena della<br />
fabbrica o come gli orologi, appare come un tratto di enorme importanza nella concezione del<br />
tempo moderno 155 . Se l’architettura della società è qualcosa di ovviamente costruito, l’uomo<br />
moderno non potrà non sentirsi figlio di questa costruzione. Essendo il tempo uni<strong>vers</strong>ale la<br />
categoria fondamentale per la giustificazione storica di un ord<strong>in</strong>e morale e sociale ed essendo<br />
il tempo <strong>in</strong>dividuale la corrispettiva categoria fondamentale per una giustificazione politica di<br />
un ord<strong>in</strong>e sociale, risulta naturale come quest’ultimo fu il primo imputato del processo che gli<br />
<strong>in</strong>tellettuali modernisti stavano conducendo nei confronti del mondo. Lo strappo che si creò<br />
<strong>in</strong> questo periodo tra la concezione <strong>in</strong>dividuale e quella sociale del tempo portò alla creazione<br />
di un rapporto conflittuale fra l’uomo e il suo mondo. Vittoria Borsò mette <strong>in</strong> luce l’evidenza<br />
di questa frattura. Riferendosi alle teorie di R. Koselleck, la Borsò constata che “alla f<strong>in</strong>e del<br />
‘700, l’avvenimento della coscienza storicistica porta a una frattura nell’ambito della<br />
cont<strong>in</strong>uità temporale che comporta la scoperta dell’alterità storica da parte del soggetto” 156 .<br />
Per Peter Nicholls “la problematica del tempo occupa uno spazio centrale” 157 nella riflessione<br />
modernista; per molti modernisti, soprattutto quelli appartenenti all’area anglo-americana, “il<br />
tempo veniva percepito creativamente attra<strong>vers</strong>o l’esperienza traumatica dell’esilio e del<br />
contrasto culturale” 158 . Rivendicazione di una “memoria culturale discont<strong>in</strong>ua” 159 dunque, per<br />
cui lo scrittore rifiuta l’unità artificiale del mondo moderno per ricercare una nuova unità<br />
recuperando i materiali culturali nella storia dell’umanità. L’uomo moderno si dissocia dal<br />
mondo circostante a cui non sente più di appartenere. Si genera una frattura che nell’uso<br />
modernista del l<strong>in</strong>guaggio trova piena espressione. Il l<strong>in</strong>guaggio dello scrittore modernista<br />
non è più modellato sulla necessità di comunicare <strong>in</strong> un mondo a lui estraneo. Il dialogo tra<br />
155 Per N. Luhmann, Liebe als passion. Zur codierung von <strong>in</strong>timitat, Frankfurt am Ma<strong>in</strong>, 1994, una caratteristica<br />
basilare del mondo moderno, e al contempo un dato paradossale, è come tutta la vita dell’<strong>in</strong>dividuo si caratterizzi<br />
sugli schemi e sui meccanismi della società, al contrario dell’uomo premoderno che si relazionava maggiormente<br />
alle leggi di natura.<br />
156 V. Borsò, Temporalità e alterità. Il nuovo rapporto tra uomo e natura nella poesia moderna, cit. p. 1.<br />
157 Peter Nicholls, La forma e le scritture, Una lettura critica del modernismo, Armando Editore, Roma, 2000, p.<br />
235.<br />
158 Ibidem<br />
159 Ibidem.<br />
56
uomo e uomo e tra uomo e mondo si <strong>in</strong>terrompe. Come nota Richard Sheppard 160 , gli scrittori<br />
modernisti rifiutano la mimesis <strong>in</strong> quanto riproduzione della superficie del mondo attra<strong>vers</strong>o<br />
un l<strong>in</strong>guaggio che, al pari del mondo, porta i segni della decadenza 161 . Le parole vengono<br />
associate <strong>in</strong> modi nuovi per scoprire potenzialità secondarie, proprietà connotative e ritmiche,<br />
similitud<strong>in</strong>i con altre parole: i significati dimenticati divengono primari. Anche il ruolo<br />
tradizionale dell’aggettivo diviene sospetto. Il poeta modernista mira a liberare le energie<br />
espressive represse del l<strong>in</strong>guaggio, cessa di celebrare l’ord<strong>in</strong>e umano e diviene lo<br />
sperimentatore di immag<strong>in</strong>i redente e redimenti. Il l<strong>in</strong>guaggio, con cui si costruisce la poesia,<br />
diviene un mezzo di risalita, constatazione della perdita e r<strong>in</strong>verdimento del ricordo. I<br />
modernisti <strong>in</strong>seriscono il problema l<strong>in</strong>guistico nel pieno della riflessione sulla modernità, sulle<br />
nuove possibilità di comprensione e sulle nuove forme di espressione così come spiega<br />
Nicholls:<br />
In questa doppia immag<strong>in</strong>e della realtà, <strong>in</strong> bilico fra transitorietà e fuggevolezza da una parte, e immutabilità ed<br />
eternità dall’altra, anche l’artista si sente <strong>in</strong>vestito della necessità di do<strong>vers</strong>i impregnare nella creazione di<br />
prodotti culturali nei quali egli ha distillato, dal caos della realtà, fissandole, le qualità essenziali ed immutabili<br />
della vita. Lo strumento che consentiva agli scrittori questo tipo di selezione fu la creazione di nuovi codici<br />
espressivi che <strong>in</strong>cidevano sulle modalità del l<strong>in</strong>guaggio. E’ così che <strong>in</strong> quegli anni gli scrittori si orientarono<br />
<strong>vers</strong>o l’<strong>in</strong>novazione l<strong>in</strong>guistica e la sperimentazione nelle modalità di rappresentazione, spesso allontanandosi da<br />
ogni possibile mimesis della realtà a favore di un ripiegamento dell’opera su se stessa 162 .<br />
I modernisti si misero dunque alla ricerca di forme d’espressione alternative che potessero<br />
acuire la “percezione della distanza”, misurarabile tra il mutevole mondo della frenesia<br />
moderna e l’immutabilità delle eterne leggi della natura. I l<strong>in</strong>guaggi che presentavano ancora<br />
forti connotazioni arcaiche, come i dialetti, furono spesso ri-considerati. Tali l<strong>in</strong>guaggi non<br />
ispirarono ai modernisti un semplice recupero antiquario, ma dovevano arricchire il<br />
160 Richard Sheppard, The Crisis of language, contenuto <strong>in</strong> Modernism, a guide to European Literature 1890-<br />
1930, edited by M.Broadbury and J. McFarlane, Pengu<strong>in</strong> Books, 1991.<br />
161 Postulando l’artificialità del reale, realtà come creazione umana, Nietzsche rivoluzionò ogni canonico<br />
approccio alle categorie conoscitive. Lo stesso concetto di conoscenza venne ad essere ripensato. Questo nuovo<br />
approccio alla materia filosofica, soprattutto <strong>in</strong> riferimento alle teorie della conoscenza, <strong>in</strong>vestì direttamente le<br />
teorie dell’espressione di tale “r<strong>in</strong>novata conoscenza”. Il l<strong>in</strong>guaggio, con cui gli scrittori esprimono se stessi e il<br />
mondo che li circonda, è <strong>in</strong>vestito di un nuovo potere. L’approccio mimetico, che presuppone l’esistenza di una<br />
realtà oggettiva da riportare su pag<strong>in</strong>a, viene scalzato da un approccio simbolico che sposta l’<strong>in</strong>dividuo dal ruolo<br />
di osservatore di una realtà data a priori a quello di attore <strong>in</strong>serito <strong>in</strong> una dimensione che egli stesso contribuisce<br />
attivamente a creare. Se il collasso del reale, <strong>in</strong>teso adesso come categoria <strong>in</strong>stabile ed artificiale, è il punto di<br />
partenza della modernità, la crisi del l<strong>in</strong>guaggio mimetico, teso a “rispecchiare” il reale, potrebbe essere<br />
considerato il punto di partenza del modernismo letterario. L’importanza che viene data <strong>in</strong> questo periodo alla<br />
poetica dell’immag<strong>in</strong>e è s<strong>in</strong>tomo di questo processo. L’idea dell’uomo che si impone sul reale è la causa<br />
dell’artificilizzazione dell’uomo e del suo mondo. Gli scrittori modernisti si misero alla ricerca dell’immag<strong>in</strong>e<br />
pura, la parvenza del mito e l’archetipo, che si trova dietro l’architettura del reale. La ricerca di un immag<strong>in</strong>e<br />
pura, non contam<strong>in</strong>ata dalla ragione dell’uomo, si legò ai modi di utilizzazione delle nuove categorie<br />
conoscitive da parte degli <strong>in</strong>tellettuali modernisti. Ridare la voce alla terra, alla natura e all’essere dell’uomo, da<br />
troppo tempo obliati, da troppo tempo sepolti sotto una ricca edificazione di sovrastrutture, appare uno degli<br />
obiettivi di questi nuovi scrittori. L’immag<strong>in</strong>e non scaturisce dunque da un costrutto mentale, da una deduzione<br />
logica; l’immag<strong>in</strong>e scaturisce, al contrario, dall’osservazione estatica della natura, dall’ascolto immediato delle<br />
tracce dell’essere. L’elaborazione di una poetica che elevasse l'immag<strong>in</strong>e oltre l'idea venne a configurarsi presto<br />
come una caratteristica primaria del modernismo letterario. La metafora divenne, gradualmente, sostitutiva del<br />
concetto e la conoscenza del poeta prima di tutto visiva: è il ritorno del l<strong>in</strong>guaggio alla sua natura orig<strong>in</strong>aria.<br />
Anche <strong>in</strong> questo caso ciò che si volle mettere <strong>in</strong> evidenza fu l'<strong>in</strong>adeguatezza delle categorie conoscitive della<br />
modernità. Solo tramite un l<strong>in</strong>guaggio “altro”, distante da quello semplificato e standardizzato della società<br />
consumistica moderna, un l<strong>in</strong>guaggio che potesse richiamare l’orig<strong>in</strong>arietà dell'espressione e l'<strong>in</strong>canto di fronte<br />
al mondo, solo tramite questo tipo di l<strong>in</strong>guaggio puro, simbolico, il vero significato dell'esistenza poteva essere<br />
svelato.<br />
162 P. Nicholls, La forma e le scritture, Una lettura critica del modernismo, cit. p.13.<br />
57
l<strong>in</strong>guaggio convenzionale e standardizzato della modernità di nuove possibilità espressive. In<br />
molte opere moderniste le espressioni arcaiche, o dialettali, fanno “capol<strong>in</strong>o” nel tessuto della<br />
narrazione proprio a far sentire questa presenza dal “sottofondo”. La narrazione piana e<br />
convenzionale ama spesso ospitare queste irruzioni che rimandano ad un altro tipo di<br />
l<strong>in</strong>guaggio, forme dimenticate di espressione e di visione della vita. Considerando gli autori di<br />
cui questo studio si occupa maggiormente è da sottol<strong>in</strong>eare l’<strong>in</strong>cessante ricerca l<strong>in</strong>guistica di<br />
Pavese il quale partì dal dialetto per arrivare alla forma matura del l<strong>in</strong>guaggio come appare<br />
nei Dialoghi con Leucò, mentre per Lawrence il riferimento ai l<strong>in</strong>guaggi locali fu sempre<br />
prem<strong>in</strong>ente così come dimostra, primo fra tutti, il romanzo Sons and Lo<strong>vers</strong> <strong>in</strong> cui il<br />
personaggio “di terra”, il primitivo Walter Morel, assume una propria connotazione attra<strong>vers</strong>o<br />
l’uso del gergo. A questo riguardo la riflessione di Vico sul l<strong>in</strong>guaggio risulta importante. I<br />
l<strong>in</strong>guaggi primitivi, così come sono descritti da Vico, rappresentano una nuova possibilità per<br />
l’io <strong>in</strong>dividuale modernista. Heidegger, <strong>in</strong> L’orig<strong>in</strong>e dell’opera d’arte (1936), <strong>in</strong>dica <strong>in</strong> Vico<br />
un precursore delle teorie moderne su come il l<strong>in</strong>guaggio racchiuda i segreti dell’essere<br />
proprio nella sua caratteristica di orig<strong>in</strong>arietà. L’arte, essendo un risalire <strong>vers</strong>o l’essere<br />
piuttosto che una conquista o un’edificazione dell’essere medesimo, trova nel l<strong>in</strong>guaggio un<br />
mezzo proprio di ricerca. La teoria di Vico voleva che i primi l<strong>in</strong>guaggi fossero sostenuti da<br />
una stretta connessione tra parola e cosa. I l<strong>in</strong>guaggi primitivi si basavano su una conoscenza<br />
diretta del fenomeno naturale. Tali l<strong>in</strong>guaggi, fondamentalmente metaforici, costituivano<br />
l’espressione di un’umanità con una coscienza poetica differente rispetto ai moderni. Tale<br />
differenza si basava appunto sulla comunione parola-cosa che equivaleva alla comunione<br />
dell’uomo con la sua natura. Per David Lodge l’utilizzo di metafore e metonimie è una<br />
costante <strong>in</strong> tutti gli scrittori modernisti, tanto da dover considerare questo tratto come uno tra i<br />
più specifici dell’<strong>in</strong>tero fenomeno culturale 163 .<br />
Sarebbe difficile sostenere che la predilezione degli scrittori modernisti per l’immag<strong>in</strong>e e per<br />
l’uso di un l<strong>in</strong>guaggio metaforico miri ad un ideale ricongiungimento con lo spirito poetico<br />
delle orig<strong>in</strong>i. Questo atteggiamento sembra più esser proprio degli scrittori romantici che<br />
elaborarono le stesse teorie mitiche <strong>in</strong>serendole <strong>in</strong> altri contesti e dando loro differenti<br />
collocazioni <strong>in</strong>tellettuali. L’utilizzo da parte dei modernisti di un l<strong>in</strong>guaggio che potremmo<br />
<strong>def</strong><strong>in</strong>ire mitico, tende <strong>in</strong>vece a sondare la distanza, a scavare ancor di più il baratro per portare<br />
a consapevolezza la tragedia dell’umanità. E’ una poesia nostalgica che preferisce disperare<br />
piuttosto che stabilire soluzioni ideali (che non siano quelle utopiche di Lawrence).<br />
L’idealismo romantico fu d’altra parte uno dei punti più criticati dai modernisti. Specialmente<br />
Lawrence <strong>in</strong>dicò nell’idealismo un apogeo della razionalità, un <strong>def</strong><strong>in</strong>itivo s<strong>in</strong>tomo della<br />
decadenza dell’epoca moderna:<br />
La prima cosa <strong>in</strong> assoluto da riconoscere è il pericolo dell’idealismo. E’ il peccato ricorrente della razza umana.<br />
Significa cadere nell’automatismo, nel meccanismo e nella nullità.[…] Adesso non accetto più nessuna<br />
plausibilità ideale.[…] Alla lunga, per conto mio, so che la vita, solo la vita, è la chiave dell’uni<strong>vers</strong>o. E che<br />
l’<strong>in</strong>dividuo vivente è la chiave della vita. Che è sempre così, e che sarà sempre così.[…] Dobbiamo vivere di<br />
vita, non di macch<strong>in</strong>e e di ideali 164 .<br />
Idealismo come ultimo stadio della razionalità. Irrazionalità come rivendicazione propria di<br />
un pensiero considerato decadente proprio per un gusto del rifiuto e della ricerca di modelli<br />
alternativi. I modernisti si pongono <strong>in</strong> un’altra dimensione rispetto al mondo cosiddetto reale.<br />
La loro arte agisce <strong>in</strong> una dimensione nuova, parallela a quella dell’arte ufficiale, l’arte<br />
vittoriana <strong>in</strong> Inghilterra o l’arte fascista <strong>in</strong> Italia. La ricerca di un tempo <strong>in</strong>dividuale, <strong>in</strong>teriore,<br />
che non sia assoggettato alle regole ideali della modernità, è parte <strong>in</strong>tegrante di questa ricerca.<br />
163 David Lodge, The language of modernist fiction: Metaphor and Metonimy, contenuto <strong>in</strong> Modernism, a guide<br />
to European Literature 1890-1930, Edited by M.Broadbury and J. McFarlane, Pengu<strong>in</strong> Books, 1991.<br />
164 D. H. Lawrence, Fantasia dell’<strong>in</strong>conscio, cit. pp. 108, 124-25.<br />
58
Per la Borsò, questo processo, che porterà alla rivendicazione di un tempo personale<br />
autonomo, affonda le sue radici nelle espressioni artistiche della premodernità: “L’arte<br />
diventa una natura secondaria che porta <strong>in</strong> sé, accanto alla analogia, anche la cicatrice<br />
dell’alterità e della differenza. Non potrà più ignorare – come faceva l’arte premoderna – il<br />
momento fenomenologico della mediazione temporale” 165 . Il primo scrittore, che cercò nella<br />
mediazione tra il tempo classico dell’imitazione del mondo esterno e quello moderno<br />
dell’<strong>in</strong>dividualità che esprime se stessa, fu Goethe. La ricerca dell’oggettivizzazione di questa<br />
mediazione doveva lasciar libero corso al concepimento di una determ<strong>in</strong>ata ed adeguata<br />
simbologia al pr<strong>in</strong>cipio della modernità. Citando le Romische Elegien, la Borsò nota come,<br />
per Goethe “l’idillio dell’istante sensibile è marcato dalla distanza dell’osservatore e dal<br />
sentimento della perdita” 166 . Il divorzio fra il tempo oggettivo della classicità e quello<br />
personale della modernità registra, <strong>in</strong> questa fase storica, il suo atto di nascita. Si tratterà per i<br />
successori di Goethe di approfondire questa distanza, di ripensare il proprio essere <strong>in</strong><br />
relazione ad una natura che si è fatta improvvisamente lontana:<br />
La velocità del cambio porta ad una rottura totale con la natura. Per l’occhio irritabile di Baudelaire, la distanza<br />
dalla natura fa vedere i segni dell’alienazione e dell’alterità, marcata nell’arrangiamento artificiale che, nella<br />
città, tiene assieme i residui del mondo naturale. L’alterità del soggetto entra a far parte del l<strong>in</strong>guaggio.[…] Il<br />
dramma della temporalità nella solitud<strong>in</strong>e esistenziale del soggetto del primo Novecento diventa un gioco<br />
pericoloso […] 167 .<br />
Il motivo del tempo <strong>in</strong>dividuale diviene un importante elemento di riflessione. La concezione<br />
del tempo, che si arricchisce nel corso dell’Ottocento delle riflessioni del filosofo francese<br />
Bergson, si legò direttamente all’estetica del romanzo. La frattura nella catena spaziale è<br />
evidente nei romanzi modernisti tanto da <strong>in</strong>fluenzarne la struttura. Marziano Guglielm<strong>in</strong>etti<br />
<strong>in</strong>dividua nel 1889 (anno dell’uscita degli Essai sur les donnés immediates de la coscience di<br />
Bergson) un anno di grande importanza per le sorti del romanzo europeo. La nuova<br />
concezione del tempo modernista entrò, con questo testo, ufficialmente nell’estetica del<br />
romanzo. Il filosofo francese proclama come la stagione del romanzo naturalista sia morta:<br />
La struttura del romanzo postnaturalistico, al pari della sua s<strong>in</strong>tassi, dovrà portare ben visibili i segni di questa<br />
comprensione <strong>in</strong>completa della realtà, <strong>in</strong> modo da non <strong>in</strong>gannare mai il lettore sul valore assoluto dell’oggetto che<br />
deve riprodurre e comunicare. Bergson ritiene possibile che il romanzo futuro abbia una funzione demistificatrice<br />
radicale <strong>in</strong> grado di fare <strong>in</strong>tuire al lettore il velo <strong>in</strong>terposto dalle parole fra lui e la sua coscienza 168 .<br />
Le nuove teorie relative al tempo acuiscono la frattura fra l’uomo e il suo mondo e fra l’uomo<br />
e la sua coscienza. La nuova visione del tempo <strong>in</strong>dividuale e dell’istante, così come appare<br />
nella filosofia di Bergson e nei testi degli scrittori modernisti, fu un altro tassello nella<br />
barriera che divise l’io moderno dal mondo circostante. Ma se il tempo si costituisce di attimi<br />
separati, il cui senso viene riconosciuto e designato nel tempo empirico, il lavoro dello<br />
scrittore diviene proprio quello di fornire la successione degli attimi di un nuovo senso, un<br />
senso alternativo, che solo nel tempo mitico può trovare riscontro. Un appunto di Cesare<br />
Pavese relativo alla lettura di Bergson è illum<strong>in</strong>ante a questo proposito:<br />
165<br />
V. Borsò, Temporalità e alterità. Il nuovo rapporto tra uomo e natura nella poesia moderna,cit. p. 10.<br />
166<br />
Ibidem.<br />
167<br />
Ivi, p. 10 – 11.<br />
168<br />
Marziano Guglielm<strong>in</strong>etti, Struttura e s<strong>in</strong>tassi, Silva Editore, Parma, 1964, p. 13.<br />
59
Se la società non può realizzare l’assoluto, <strong>in</strong> quanto un suo <strong>in</strong>dividuo può sempre recalcitrare, nemmeno<br />
l’<strong>in</strong>dividuo lo può nel tempo, poiché, raggiunto l’assoluto <strong>in</strong> un suo momento, un istante dopo può decadere.[…]<br />
e <strong>in</strong>somma nega che una vita, colta nella successione meccanica dei suoi istanti, anche più coscienti, possa<br />
configurarsi a costruzione metafisica. Infatti, la successione meccanica dei pensieri cade nello schema –<br />
riconosciuto empirico – del tempo. Perché un’esperienza abbia un valore metafisico deve sfuggire al tempo:<br />
Nella vita pratica ciò pare che accada soltanto nell’attimo isolato – evasione dal tempo -. La – sostituzione del tempo assoluto al tempo empirico – riesce più affasc<strong>in</strong>ante del ,<br />
perché questo si realizza solo <strong>in</strong> attimi e quella <strong>in</strong> costruzioni che, benché valgano come un solo attimo assoluto,<br />
si distendono però gradevolmente e abbracciano a volte lunghi lassi empirici. L’unità dell’opera consisterà<br />
dunque nell’appartenenza di tutti i suoi momenti a uno stesso periodo assoluto o metafisico che si dica 169 .<br />
Questa riflessione di Pavese, se da una parte testimonia l’attenzione che lo scrittore pose nei<br />
confronti delle tematiche temporali e la sua visione personale della questione, dall’altra è<br />
<strong>in</strong>dice di quello che fu l’atteggiamento complessivo degli <strong>in</strong>tellettuali modernisti nei confronti<br />
di quest’argomento. In questo senso sia Nietzsche che Bergson, i due filosofi <strong>in</strong>dicati come i<br />
maggiori teorici del campo, si rifacevano a categorie classiche per esprimere un rifiuto, o<br />
perlomeno <strong>in</strong>dicare la decadenza, dei modelli della civiltà contemporanea. In questo recupero<br />
del sepolto, Nietzsche e Bergson potevano trovare una similarità di vedute: “What Nietzsche,<br />
for <strong>in</strong>stance admired <strong>in</strong> the pre-socratic Greek culture was the very fusion of the Dionysian<br />
and Apoll<strong>in</strong>ian elements, that is, a bilance between free-flow<strong>in</strong>g energy and rational restra<strong>in</strong>t.<br />
And Bergson’s <strong>in</strong>tuition was similarly the product of a collaboration between <strong>in</strong>tellect and<br />
<strong>in</strong>st<strong>in</strong>ct” 170 . La necessità di <strong>def</strong><strong>in</strong>ire l’attimo, per poi metterlo <strong>in</strong> relazione al tempo esteriore,<br />
assoluto ed empirico, e l’esigenza di applicare immediatamente le riflessioni filosofiche alla<br />
teoria della composizione, sono da considerarsi le due priorità degli <strong>in</strong>tellettuali modernisti <strong>in</strong><br />
questo contesto.<br />
Con il modernismo letterario la rappresentazione artistica supera la fase mimetica. L’arte si<br />
dissocia dalla realtà sensibile e si mette <strong>in</strong> competizione con essa stabilendo un modello<br />
alternativo, nuovo ed antico allo stesso momento. L’unità di un’opera letteraria consiste<br />
nell’appartenenza di ogni sua parte ad un senso complessivo che non va ricercato tanto nella<br />
realtà esterna all’opera quanto <strong>in</strong> quella che l’autore decide arbitrariamente di creare. La realtà<br />
che l’autore ri-crea è, per i modernisti, quella del mito che si pone a confronto con il tempo<br />
storico esterno all’opera. Nell’ambito di una produzione letteraria spesso frammentaria, i<br />
modernisti riconoscono il valore dei frammenti, come espressione somma del tempo<br />
<strong>in</strong>dividuale, ma, al contempo, cercano di amalgamare questi frammenti all’<strong>in</strong>terno di una<br />
r<strong>in</strong>venuta unità mitica. Ogni parte dell’opera deve necessariamente appartenere al tutto, ogni<br />
frammento è parte di una costruzione perfettamente dotata di senso. All’<strong>in</strong>terno di questa<br />
riflessione i modernisti sottol<strong>in</strong>eano come l’espressione del tempo <strong>in</strong>dividuale, l’espressione<br />
letteraria del riconoscimento e dell’isolamento dell’attimo, che si configura nella<br />
composizione del frammento, sia una rappresentazione del tempo assoluto e ne conservi il<br />
medesimo senso. Ogni frammento, di cui si costituisce l’opera, rappresenta dunque un tassello<br />
del grande mosaico ma, al contempo, è dotato di senso autonomo. L’identità dell’opera deve<br />
poter essere riscontrata <strong>in</strong> ogni passaggio. In questa maniera i modernisti potevano dotare di<br />
senso sia il tempo assoluto <strong>in</strong>dividuale sia il tempo assoluto mitico <strong>in</strong> un gioco di proiezioni<br />
<strong>in</strong>cessanti <strong>in</strong> cui il particolare era simbolo ed immag<strong>in</strong>e dell’uni<strong>vers</strong>ale e vice<strong>vers</strong>a. Il già<br />
citato passo del Mestiere di Vivere mette <strong>in</strong> evidenza quest’aspetto della poetica modernista:<br />
“L’unità dell’opera consisterà dunque nell’appartenenza di tutti i suoi momenti a uno stesso<br />
periodo assoluto o metafisico che si dica”. L’<strong>in</strong>teresse sull’unità dell’opera si fa<br />
particolarmente importante nel momento <strong>in</strong> cui l’opera letteraria, non rispettando più le regole<br />
della mimesi e non rispettando più l’unità di senso che il mondo esterno può offrire, deve<br />
poter elaborare un senso <strong>in</strong>terno, artificiale (Pavese non a caso parla della “falsità della<br />
169 C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, 24 Febbraio 1940, cit. p. 177.<br />
170 P. Fjagesund, The Apocaliptic World of D. H. Lawrence, cit. p. 73.<br />
60
poesia” che si <strong>in</strong>carica di disegnare un tempo assoluto per l’opera), che si metta <strong>in</strong><br />
competizione con il senso che il mondo stabilisce. Quello dell’unità fra tempo <strong>in</strong>dividuale e<br />
tempo assoluto si configura come problema card<strong>in</strong>e della riflessione modernista. L’abilità<br />
dell’artista sembra dunque essere quella di saper ricreare quest’unità che il mondo non<br />
concede più, di poterla rendere evidente per mezzo di una poesia frammentaria.<br />
Nella descrizione dei tratti peculiari di cui il modernismo anglo-americano si faceva portatore,<br />
Nicholls riconosce nella centralità delle problematiche relative alla temporalità un argomento<br />
centrale di tutto il movimento. Le tematiche relative al tempo <strong>in</strong>dividuale e uni<strong>vers</strong>ale e a<br />
quell’eterno presente, di cui anche Pavese era alla ricerca, divengono caratteristiche proprie di<br />
un modernismo anglosassone che si <strong>def</strong><strong>in</strong>isce anche attra<strong>vers</strong>o il contrasto con quelle che<br />
erano le posizioni “moderniste” di opposta matrice, come, nel caso dell’Italia, il futurismo<br />
mar<strong>in</strong>ettiano:<br />
In contrasto con il Futurismo e i suoi derivati, questo modernismo si propose di correggere l’apparente amnesia<br />
delle tendenze della modernità, ricollegando quest’ultima a una stimata tradizione culturale. Per il modernismo<br />
angloamericano, la concezione avanguardistica di rottura tra passato e presente fu soppiantata da un’attenzione<br />
per le figure dell’anacronia e dello scarto temporale che riportarono all’ord<strong>in</strong>e del giorno le questioni della<br />
narrazione. Questa <strong>vers</strong>ione del modernismo ascrisse le fantasie di un presente assoluto alla tradizione<br />
romantico-decadente, abbagliata dalle idee di orig<strong>in</strong>alità e spontaneità 171 .<br />
Le tematiche della temporalità affondano dunque le loro radici <strong>in</strong> epoca romantica per essere<br />
poi riprese e sviluppate dagli scrittori modernisti. Pavese, <strong>in</strong> questo contesto, sembrò essere<br />
affasc<strong>in</strong>ato soprattutto da Conrad. Joseph Conrad constatò come l’abilità dell’artista moderno<br />
sia proprio quella di poter tenere assieme la sua opera, di legare i frammenti <strong>in</strong> un’unità<br />
<strong>in</strong>dissolubile: “A work of art that aspires, however humbly, to the condition of art should<br />
carry it’s justification <strong>in</strong> every l<strong>in</strong>e” 172 . E’ un’unità che si ottiene al di fuori della logica del<br />
mondo. L’appello di Conrad è alle facoltà irrazionali dell’uomo viste, ancora una volta, come<br />
facoltà generative. Generative di un nuovo ord<strong>in</strong>e che sembra ancora co<strong>in</strong>cidere con quello<br />
del mito e che non sembra poter trovare altra espressione che nella tragedia di cui vengono<br />
riportate, nella prefazione a The Nigger of the Narcissus, le fondamentali categorie tragiche di<br />
“wonder and pity”: “[…] the artist appeals to that part of our be<strong>in</strong>g which is not dependent on<br />
wisdom; to that <strong>in</strong> us which is a gift and not an acquisition – and, therefore, more permanently<br />
endur<strong>in</strong>g. He speaks to our capacity for delight and wonder, to the sense of mistery<br />
surround<strong>in</strong>g our lives […] to the latent feel<strong>in</strong>g of fellowship with all creation” 173 . Nella stessa<br />
prefazione Conrad discute il problema del tempo parlando dell’unità m<strong>in</strong>ima dell’opera<br />
letteraria come di un “rescued moment” 174 , un momento salvato dalla valanga del tempo e<br />
posto come nucleo vitale dell’opera: “to snatch <strong>in</strong> a moment of courage, from the remorsless<br />
rush of time, a pass<strong>in</strong>g phase of life, is only the beg<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g of the task” 175 . Il momento salvato<br />
detiene, nella sua assolutezza, l’<strong>in</strong>tera rappresentazione del mistero che si vuole esprimere.<br />
L’isolamento e l’apertura di questo momento sono alla base della scrittura: “(the rescued<br />
moment) discloses its <strong>in</strong>spir<strong>in</strong>g secret: the stress and passion with<strong>in</strong> the core of each<br />
conv<strong>in</strong>c<strong>in</strong>g moment” 176 . Se l’opera d’arte nasce dal salvataggio di questo momento, l’<strong>in</strong>tera<br />
composizione dipenderà dall’estensione di questo tempo <strong>in</strong>dividuale a un tempo assoluto che,<br />
nelle pag<strong>in</strong>e di Conrad sembra configurarsi come tempo mitico: “[…] the presented vision of<br />
regret or pity, of terror or mirth, shall awaken <strong>in</strong> the hearts of the beholders that feel<strong>in</strong>g of<br />
171 P. Nicholls, La forma e le scritture, una lettura critica del modernismo, cit. p. 237-38.<br />
172 Joseph Conrad, Preface to The Nigger of Narcissus (1897), contenuto <strong>in</strong> Modernism, an anthology of sources<br />
and documents, edited by V. Kolocotrami, J.Goldman, O. Toxidov, Edimburgh, Uni<strong>vers</strong>ity Press, 1998, p. 131.<br />
173 Ivi, p. 132.<br />
174 Ivi, p. 133.<br />
175 Ibidem.<br />
176 Ibidem.<br />
61
unavoidable solidarity; of the solidarity <strong>in</strong> misterious orig<strong>in</strong>, <strong>in</strong> toil, <strong>in</strong> joy, <strong>in</strong> hope, <strong>in</strong><br />
uncerta<strong>in</strong> fate, which b<strong>in</strong>ds men to each other and all mank<strong>in</strong>d to the visibile world” 177 .<br />
L’<strong>in</strong>tento di Conrad sembra quello di poter mettere <strong>in</strong> relazione il momento salvato con il<br />
tempo assoluto tramite il ricorso al mito. In questa nuova corrispondenza tra tempo <strong>in</strong>teriore e<br />
tempo esteriore, non più quello artificiale del mondo ma quello orig<strong>in</strong>ario della natura, si cela<br />
il segreto della composizione artistica. Il ricorso al mito offre la possibilità di scandagliare un<br />
tempo orig<strong>in</strong>ario, naturale, offre la possibilità di ripensare le misteriosi orig<strong>in</strong>i dell’uomo. E’<br />
la via che porta alla composizione della tragedia, vero modello estetico per la composizione<br />
narrativa modernista. Conrad si pone al centro del flusso temporale, nel mezzo della corsa<br />
impazzita del tempo moderno, per isolarne un frammento, per salvarne una particella. Tale<br />
salvataggio può avvenire solo contrastando il flusso, solo fermandosi nella contemplazione<br />
del vortice che attanaglia l’uomo allo scopo di estrarne una s<strong>in</strong>gola m<strong>in</strong>ima unità. In quel<br />
frammento, m<strong>in</strong>uscolo, sottratto al flusso del tempo moderno, si nasconde tutta la verità della<br />
vita che appare essere eterna ed obliata:<br />
To arrest, for the space of a breath, the hands busy about the work of the heart, and compel men entranced by the<br />
sight of distant goals to glance for a moment at the surround<strong>in</strong>g vision of form and color, of sunsh<strong>in</strong>e and<br />
shadows; to make them pause for a look, for a sight, for a smile – such is the aim, difficult and evanescent, and<br />
reserved only for a few to achieve. But sometimes, by the deserv<strong>in</strong>g and the fortunate, even the task is<br />
accomplished. And when it is accomplished – behold- all the truth of life is there: a moment of vision, a sigh, a<br />
smile – and the return to an eternal past 178 .<br />
La riflessione modernista sul tempo <strong>in</strong>dividuale prosegue per tutta la durata del movimento.<br />
Nella prefazione a New Poems, del 1920, Lawrence vi dedica ancora gran parte della sua<br />
riflessione. La ricerca dell’attimo e la conquista di un puro presente sono i traguardi che lo<br />
scrittore si prefigge. La pr<strong>in</strong>cipale fonte di Lawrence è, per questa riflessione Whitman che,<br />
tramite il ricorso al <strong>vers</strong>o libero, riesce ad emancipare l’istante dal flusso <strong>in</strong><strong>in</strong>terrotto del<br />
tempo:<br />
Such is the rare new poetry. One realm we have never conquered: the pure present. One great mistery of time is<br />
< terra <strong>in</strong>cognita > to us: the istant. The most superb mistery we have hardly recognised: the immediate, istant<br />
self. The quick of all time is the istant.. The quick of all the uni<strong>vers</strong>e, of all creation, is the <strong>in</strong>carnate, carnal self.<br />
Poetry gave us the clue: free <strong>vers</strong>e: Whitman. Now we know 179 .<br />
Come si può constatare, la <strong>def</strong><strong>in</strong>izione del tempo <strong>in</strong>dividuale, costituito di attimi, è centrale<br />
nella riflessione degli scrittori modernisti così come centrale è la necessità di associare il<br />
tempo <strong>in</strong>dividuale a quello uni<strong>vers</strong>ale, costituito di secoli e di epoche.<br />
In Letteratura Americana e altri saggi, Cesare Pavese sottol<strong>in</strong>ea l’ambiguità temporale della<br />
scrittura di Conrad, apprezzandone la composizione e utilizzando per il suo saggio critico una<br />
term<strong>in</strong>ologia familiare alla sua stessa teoria compositiva. Pavese riconosce a Conrad la<br />
capacità di andare oltre la “materialità” della “cosa vista”, per <strong>in</strong>serire le sue immag<strong>in</strong>i <strong>in</strong> “una<br />
monotona ma sempre magica atmosfera presente”: “la presenza di questo altrove, di questa<br />
memoria, che ci pare <strong>in</strong> sostanza muo<strong>vers</strong>i nella cerchia <strong>in</strong>cantata di un simbolo, di un<br />
mito” 180 . La riflessione di Cesare Pavese riguardo il tempo impegna tutta la sua attività di<br />
scrittore trovando spazio sia negli scritti teorici sia nella produzione narrativa. La riflessione<br />
177 Ibidem.<br />
178 Ivi, p. 134.<br />
179 D. H. Lawrence, New Poems (1920), contenuto <strong>in</strong> The English modernist reader 1910 – 1930, edited by Peter<br />
Faulkner, Ioawa City, Uni<strong>vers</strong>ity of Ioawa Press, 1986, p. 133.<br />
180 C. Pavese, Letteratura Americana e altri saggi, cit. p. 208.<br />
62
elativa al tempo <strong>in</strong>dividuale si struttura sul concetto di attimo estatico. La <strong>def</strong><strong>in</strong>izione più<br />
propria dell’attimo estatico viene cercata con assiduità da Pavese. Anche <strong>in</strong> questo caso, come<br />
nel caso dei modernisti <strong>in</strong>glesi, una precisa <strong>def</strong><strong>in</strong>izione del segmento m<strong>in</strong>imo della<br />
temporalità, l’attimo, è strettamente correlato alla <strong>def</strong><strong>in</strong>izione dei macrosegmenti temporali, la<br />
storia e il mito. Come gli scrittori modernisti <strong>in</strong>glesi, Pavese lesse Bergson e Nietzsche ma un<br />
particolare <strong>in</strong>flusso su di lui ebbe la scuola di Heidegger e Jaspers che trovò espressione e<br />
riformulazione <strong>in</strong> Italia negli scritti di Cesare Lupor<strong>in</strong>i. L’attenzione che Cesare Pavese<br />
dedicò alla categoria del tempo è testimoniata attra<strong>vers</strong>o tutta la sua produzione. Riflessioni<br />
esplicite sul tempo sono frequentissime nel Mestiere di Vivere, attra<strong>vers</strong>o il quale si può<br />
ricavare una cronologia dell’evoluzione del pensiero di Pavese, mentre nei saggi contenuti <strong>in</strong><br />
Feria d’Agosto le considerazioni si fanno più elaborate e precise. Il tempo diviene dunque un<br />
elemento fondamentale dell’<strong>in</strong>tero percorso epistemologico di Pavese così come una<br />
consistente parte della critica ha rilevato. Tra le considerazioni più pregnanti al tipo di<br />
<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e <strong>in</strong> corso quella di Gian Luigi Beccaria che analizza la questione mettendo <strong>in</strong><br />
relazione la concezione del tempo con i problemi relativi alla composizione e allo stile:<br />
La narrazione non è <strong>in</strong>treccio, ma segmenti come autonomi di narrazione. Pavese […] ci viene anzi <strong>in</strong>contro oggi<br />
con una dimensione del classico che ha trasceso l’immediato, il realismo narrativo, la verità storica del coevo.<br />
L’astoricità, del resto, è quanto <strong>in</strong> genere si imputa allo scrittore classico […] il classico […] è l’<strong>in</strong>capace di<br />
vivere l’attimo, la storia: sente il presente più distante del passato, come lacerazione apocalittica, pal<strong>in</strong>genesi, o<br />
come stasi, non come una fase di sviluppo […] su questo punto Pavese ha speso molto <strong>in</strong>chiostro nel Diario:<br />
sull’<strong>in</strong>capacità non solo di vivere il presente, ma di non volerlo vivere, per eseguire l’opera classica […]. Tra se<br />
e il passato vuol restaurare l’unità e l’immobilità della storia e delle lettere […] la convenzione classica […] ha<br />
costituito una sorta di pedale profondo, stabilendo il fondamento e lo stacco di distanza dal coevo, dall’effimero,<br />
dall’immediato.[…] vuole conservare il distacco contemplativo e formale, il gusto delle strutture<br />
<strong>in</strong>tellettualistiche, il mondo stilisticamente chiuso e <strong>in</strong> <strong>def</strong><strong>in</strong>itiva simbolico. Come a dire che soltanto ciò che è<br />
fondato (<strong>in</strong> una fissazione lapidaria delle strutture, <strong>in</strong> forme astratte, immobili e tendenti all’<strong>in</strong>corruttibile e si<br />
sostanzia di passato mitico, di lontana stabilità del simbolo) può avere un futuro. Il passato non è sepolto ma<br />
fondazione sotterranea 181 .<br />
L’importanza della riflessione <strong>in</strong>torno al tempo si svela essere basilare dell’<strong>in</strong>tera concezione<br />
poetica di Pavese ed un passo epistemologico fondamentale nella composizione dell’unità<br />
dell’opera d’arte. La <strong>def</strong><strong>in</strong>izione del tempo <strong>in</strong>dividuale diviene importante nel momento <strong>in</strong> cui<br />
<strong>in</strong>veste direttamente il campo della teoria della composizione di Pavese. Tutta la riflessione<br />
sul tempo <strong>in</strong>dividuale dello scrittore risentirà di questo <strong>in</strong>tento: svelare la relazione tra il<br />
tempo <strong>in</strong>teriore e quello dell’opera narrativa. Il punto di partenza della riflessione è proprio<br />
l’unità m<strong>in</strong>ima del tempo: l’attimo. Questo elemento m<strong>in</strong>imale viene subito posto <strong>in</strong> relazione<br />
all’elemento m<strong>in</strong>imo della narrazione: il frammento. La ricerca f<strong>in</strong>zionale e quella esistenziale<br />
sul tempo sembrano legarsi f<strong>in</strong> da pr<strong>in</strong>cipio della riflessione teorica di Pavese. Già dalle prime<br />
pag<strong>in</strong>e del Mestiere di Vivere si avverte l’attenzione dello scrittore per quest’argomento<br />
ritenuto fondamentale per la sua scrittura. Quello dell’unità dell’opera è un problema che<br />
Pavese affronta f<strong>in</strong> dall’<strong>in</strong>izio della sua carriera di scrittore così come testimonia un appunto<br />
datato 16 Novembre 1935: “Il problema estetico, mio e dei miei tempi, più urgente è<br />
senz’altro quello dell’unità di un’opera di poesia” 182 . La risoluzione di questo problema passa<br />
necessariamente attra<strong>vers</strong>o la soluzione preventiva della <strong>def</strong><strong>in</strong>izione del m<strong>in</strong>imo segmento<br />
temporale di cui è composta la narrazione. La stessa opera di f<strong>in</strong>zione si compone di questi<br />
attimi sottratti al flusso del tempo empirico. Sono gli attimi che verranno poi a ricomporre il<br />
tempo assoluto del mito. L’attimo estatico, il simbolo, diviene “quel momento velato <strong>in</strong><br />
favolosa <strong>in</strong> temporalità, quando ricevemmo l’impronta che doveva dom<strong>in</strong>are il nostro<br />
181 Gian Luigi Beccaria, Le forme della lontananza, Garzanti, Milano, 1989, p. 93.<br />
182 C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, 16 Novembre 1935, cit. p. 18.<br />
63
avvenire secondo i modi appunto del mito” 183 . Lo sforzo dell’artista è dunque quello di creare<br />
un’opera che rappresenti l’unità di tutti gli attimi sottratti al flusso del tempo tramite l’estasi<br />
della contemplazione: “La poesia nasce non dall’our life’s work, dalla normalità delle nostre<br />
occupazioni, ma dagli istanti <strong>in</strong> cui leviamo il capo e scopriamo con stupore la vita. (Anche la<br />
normalità diventa poesia quando si fa contemplazione, cioè cessa di essere normalità e diventa<br />
prodigio)” 184 . Dall’unione dei vari attimi, secondo uno schema adeguato e sensato, si ottiene,<br />
dunque, l’unità dell’opera:<br />
[…] l’unità del poema non consiste nelle scene-madri, ma nella sottile corrispondenza di tutti gli attimi creativi.<br />
Vale a dire, l’unità non deve tanto alla costruzione grandiosa, all’ossatura identificabile della trama quanto<br />
all’abilità scherzosa dei piccoli contatti, delle riprese m<strong>in</strong>ute e quasi illusorie, alla trama dei ritorni <strong>in</strong>sistenti<br />
sotto ogni di<strong>vers</strong>ità 185 .<br />
Come si può constatare, la connessione tra concezione del tempo cosmico e concezione del<br />
tempo storico è un punto fermo della poetica di Pavese. La ricerca di questa connessione<br />
occupa, negli anni a venir, buona parte della sua riflessione:<br />
E’ un sofisma ricordare che i secoli letterari sono <strong>in</strong>esistenti nella storiografia concreta: un secolo è un ente<br />
empirico, astratto, ma un <strong>in</strong>dividuo/una vita è qualcosa di più. Certamente, qualcosa di più <strong>in</strong> quanto <strong>in</strong>tende<br />
esserlo e costruirsi; ma di per sé, <strong>in</strong> successione meccanica di giorni, <strong>in</strong> quanto s’<strong>in</strong>daga après coup, ha dunque<br />
un’unità§costruzione implicita? Quella che tu chiami unità metafisica? In<strong>vers</strong>amente. Un’opera s<strong>in</strong>gola,<br />
costruita, vien forse fatta <strong>in</strong> altro modo che saldando après coup – magari prima della stesura, ben<strong>in</strong>teso – i<br />
di<strong>vers</strong>i pezzi? 186<br />
La risoluzione della dicotomia fra tempo assoluto e tempo empirico avviene dopo pochi<br />
giorni, il 24 Febbraio 1940, e nega la possibilità al tempo empirico di configurarsi, al<br />
contempo, come tempo assoluto. Lo scarto fra il tempo <strong>in</strong>dividuale e il tempo empirico è<br />
<strong>in</strong>colmabile. La composizione dell’opera d’arte, che si basa su categorie spazio-temporali,<br />
rifiuta ciò che il mondo mette, empiricamente, a disposizione dello scrittore. La frattura tra il<br />
poeta e il mondo è di nuovo alla ribalta nel momento <strong>in</strong> cui si vede consumata la frattura tra<br />
mondo e natura. La categoria del tempo empirico viene riconosciuta come falsa ed arbitraria.<br />
La categoria del tempo <strong>in</strong>dividuale rappresenta la liberazione dalla tirannia del tempo<br />
empirico. La riflessione <strong>in</strong>torno alla categoria del tempo abbraccia, nelle pag<strong>in</strong>e di Pavese,<br />
anche il campo morale e dimostra come l’autore sentisse le regole di composizione che stava<br />
discutendo come vere e proprie regole di vita. La ricerca delle leggi della vita <strong>in</strong>veste ogni<br />
campo della speculazione dello scrittore che tenterà di dare un senso unitario e compiuto a<br />
tutta la sua produzione:<br />
Ideale morale è una nozione collettiva. L’<strong>in</strong>dividuo non ha ideale morale, perché nella sua assolutezza (eterno<br />
presente) non si adegua a una norma ma è. (Bergson, Les deux sources ecc.). Se la società non può realizzare<br />
l’assoluto, <strong>in</strong> quanto un <strong>in</strong>dividuo può sempre recalcitrare, nemmeno l’<strong>in</strong>dividuo lo può nel tempo, perché,<br />
raggiunto l’assoluto <strong>in</strong> un suo momento, un istante dopo può decadere. Ciò riprende il pr. del 22 febb. ’40, e<br />
<strong>in</strong>somma nega che una vita, colta nella successione meccanica dei suoi istanti, anche i più coscienti, possa<br />
configurarsi a costruzione metafisica. Infatti, la successione meccanica dei pensieri cade nello schema –<br />
riconosciuto empirico – del tempo. Perché un’esperienza abbia valore metafisico deve sfuggire al tempo. Nella<br />
vita pratica ciò appare che accada soltanto nell’attimo isolato – evasione dal tempo -. La “falsità della poesia” -<br />
183 C. Pavese, Stato di Grazia, cit. p. 147.<br />
184 C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, 16 Aprile 1940, cit. p. 184.<br />
185 Ivi, 28 Febbraio 1936, p. 29<br />
186 Ivi, 22 Febbraio 1940, pp. 175-176.<br />
64
sostituzione del tempo assoluto al tempo empirico – riesce più affasc<strong>in</strong>ante del “regno dei cieli” perché questo si<br />
realizza solo <strong>in</strong> attimi e quella <strong>in</strong> costruzioni che, benché valgano come un solo attimo assoluto, si distendono<br />
però gradevolmente e abbracciano a volte lunghi lassi empirici. || L’unità di un’opera consisterà dunque<br />
nell’appartenenza di tutti i suoi momenti a uno stesso periodo assoluto o metafisico che si dica. Di qui la<br />
difficoltà di determ<strong>in</strong>arla fuori dello sviluppo determ<strong>in</strong>istico dei suoi casi e fenomeni, per noi che siamo avvezzi<br />
a sperimentare la vita sempre secondo lo schema del tempo empirico e a conoscere – praticamente – quello<br />
assolutoselo come negazione del tempo empirico, negli atti morali. (Di qui <strong>in</strong>tanto il carattere <strong>in</strong>dividuale<br />
dell’opera d’arte, come dell’atto morale: esperienze per loro natura non§collettive perché assolute). E’ facile<br />
creare un’opera d’arte “istantanea” ( il “frammento”), come è relativamente facile vivere | un attimo di moralità,<br />
ma creare un’opera che superi l’attimo è difficile […] 187 .<br />
In una successiva nota, Pavese ammetterà come esista l’effettiva possibilità che un’opera si<br />
saldi <strong>in</strong> un senso f<strong>in</strong>ale riprendendo il concetto platonico dell’anima del mondo. Ciò che<br />
rimane è che Pavese <strong>in</strong> queste pag<strong>in</strong>e cerchi di comporre una propria poetica attra<strong>vers</strong>o il<br />
ripensamento della categoria temporale mettendo <strong>in</strong> opposizione il suo metodo di fare poesia<br />
assoluta con il metodo, comunque plausibile, della poesia empirica. Il dubbio sorto <strong>in</strong>torno a<br />
questa meditazione si risolverà il 25 Marzo successivo quando l’ord<strong>in</strong>e empirico dei fatti è<br />
messo <strong>in</strong> contrasto-equilibrio con l’ord<strong>in</strong>e <strong>in</strong>teriore assoluto che è descritto nei term<strong>in</strong>i di una<br />
memoria:<br />
L’equilibrio vivente di un’opera nasce dal contrasto fra la logica naturalistica dei fatti che si svolgono sotto la<br />
penna, e la nozione presupposta, e ricordata, di una logica <strong>in</strong>teriore che dom<strong>in</strong>a come una meta. La prima si<br />
dibatte nelle strettoie della seconda, e vi si carica di sensi simbolici, o stilistici che si dica. Quanto più lontani i<br />
due modi d’essere, tanto più appassionante e vivace la stesura dell’opera 188 .<br />
L’<strong>in</strong>teresse di questa tormentata riflessione sull’unità dell’opera <strong>in</strong> relazione al mito<br />
testimonia la profonda attenzione che Pavese dedicò ad un argomento che, come dimostra il<br />
passaggio riportato, chiamava direttamente <strong>in</strong> causa i modi d’essere dello scrittore. In questo<br />
modo il fulcro dell’opera si basa su un assoluto che riguarda direttamente l’essere. La<br />
cosiddetta azione della narrazione, <strong>in</strong>somma, non si basa più sull’agire dei personaggi ma sul<br />
loro essere. Nel solito parallelo fra arte e vita, Pavese così spiega questo concetto: “Forse si<br />
deve piuttosto dire: nell’ambito complessivo della vita il primato <strong>def</strong><strong>in</strong>. deve averlo non<br />
l’agire, ma l’essere.[…] Non nel tempo, ma nell’eternità, nell’eterno presente stanno le radici<br />
e si trova il compimento di ogni cosa” 189 . Il ruolo della narrazione è quello appunto di creare<br />
questo assoluto che si metta <strong>in</strong> contrapposizione al tempo empirico, che ne sveli <strong>in</strong>somma la<br />
falsità. La costruzione dell’opera d’arte ha questo senso: l’uomo non può creare un assoluto<br />
nella propria vita ma può creare un corrispettivo f<strong>in</strong>zionale della tensione <strong>vers</strong>o un’unità<br />
costantemente contraddetta:<br />
Uno dei meno osservati gusti umani è quello di prepararsi degli eventi a scadenza, di organizzarsi un gruppo di<br />
accadimenti che abbiano una costruzione, una logica, un pr<strong>in</strong>cipio e una f<strong>in</strong>e. La f<strong>in</strong>e è avvistata sempre come<br />
un’acme sentimentale, una lieta e lus<strong>in</strong>gante crisi di consapevolezza di sé. Ciò si stende dalla costruzione di una<br />
botta e risposta a quella di una vita. E che cos’è ciò se non la premessa del narrare? L’arte narrativa appaga<br />
appunto questo gusto profondo. Il piacere del narrare e dell’ascoltare è vedere disporsi dei fatti secondo questo<br />
grafico. A metà di un racconto si risale alle premesse e si gode di ritrovare delle ragioni, delle chiavi, delle mosse<br />
causali. Che altro si fa ripensando al proprio passato e compiacendosi di riconoscerci i segni del presente o del<br />
successivo? Questa costruzione dà <strong>in</strong> sostanza un significato al tempo. E il narrare è <strong>in</strong>somma soltanto un<br />
mitologizzarlo, uno sfuggirgli 190 .<br />
187 Ivi, 24 Febbraio 1940, p. 178.<br />
188 Ivi, 25 Marzo 1940, p. 181.<br />
189 Ivi, 30 Marzo 1944, p. 277.<br />
190 Ivi, 12 Aprile 1941, p. 222.<br />
65
L’idea di creare un modello di tempo artistico differente dal tempo empirico, un modello che<br />
sia al contempo artificiale solo nella costruzione ma non nell’essenza, al f<strong>in</strong>e di liberare<br />
l’uomo dalle catene temporali del mondo, troverà la sua <strong>def</strong><strong>in</strong>izione f<strong>in</strong>ale <strong>in</strong> seguito alla<br />
lettura di Cesare Lupor<strong>in</strong>i 191 . La priorità di Pavese sembra dunque quella di voler <strong>def</strong><strong>in</strong>ire<br />
l’attimo del tempo <strong>in</strong>dividuale <strong>in</strong> relazione al tempo empirico. L’importanza di questa<br />
<strong>def</strong><strong>in</strong>izione permette allo scrittore di poter mettere <strong>in</strong> relazione il tempo <strong>in</strong>dividuale e quello<br />
mitico attra<strong>vers</strong>o il riferimento al simbolo. Proprio nel riferimento al simbolo si trova la<br />
possibilità di legare tempo mitico e tempo <strong>in</strong>dividuale. Al contempo, tale connessione<br />
permette all’autore di <strong>in</strong>dividuare nella sospensione dell’attimo, al di fuori del flusso del<br />
tempo empirico, la libertà dalle catene del mondo e dall’artificialità del tempo empirico: “La<br />
novità di quest’oggi è che l’attimo estatico corrisponda al simbolo, che sarebbe dunque la<br />
pura libertà” 192 . Essere <strong>in</strong> grado di isolare e <strong>def</strong><strong>in</strong>ire l’attimo diviene dunque il momento<br />
fondamentale della ricerca <strong>in</strong>tellettuale dello scrittore nel momento <strong>in</strong> cui tale operazione<br />
promette l’emancipazione dal mondo dell’artificiale tempo empirico che str<strong>in</strong>ge il suo cappio<br />
sulla libertà dell’uomo. La questione del tempo è dunque analizzata nella sua <strong>in</strong>terezza e il<br />
tempo <strong>in</strong>dividuale dell’attimo estatico si ricollega alla riflessione sul mito. Givone spiega così<br />
il nesso: “[…] ora <strong>in</strong> questione è l’attimo estatico <strong>in</strong> cui è dato a ciascuno di raccogliere la<br />
molteplicità dispersiva degli eventi <strong>in</strong> un simbolo. Tutto, dice Pavese, accade nel tempo: cose,<br />
fatti, gesti. Ma l’accadere non ha senso per noi se non a partire dalla sospensione del tempo<br />
stesso” 193 . Il blocco del flusso temporale, il r<strong>in</strong>venimento dell’attimo estatico, rappresenta la<br />
liberazione dell’<strong>in</strong>dividuo dalle catene temporali che il mondo moderno str<strong>in</strong>ge ai polsi<br />
dell’uomo. L’<strong>in</strong>dividuo può f<strong>in</strong>almente godere una nuova libertà nell’isolamento dell’attimo<br />
di tempo assoluto nel flusso implacabile del tempo relativo:<br />
Viviamo nel mondo delle cose, dei fatti, dei gesti, che è il mondo del tempo. Il nostro sforzo <strong>in</strong>cessante e<br />
<strong>in</strong>consapevole è un tendere fuori dal tempo, all’attimo estatico che realizza la nostra libertà. Accade che le cose i<br />
fatti i gesti – il passare del tempo – ci promettono questi attimi, li rivestono , li <strong>in</strong>carnano. Essi divengono<br />
simboli della nostra libertà. Ognuno di noi ha una ricchezza di cose fatti e gesti che sono i simboli della sua<br />
felicità – essi non valgono per sé, per la loro naturalità, ma c’<strong>in</strong>vitano, ci chiamano, sono simboli. Il tempo<br />
arricchisce meravigliosamente questo mondo di segni, <strong>in</strong> quanto crea un gioco di prospettive che moltiplica il<br />
significato supertemporale di questi simboli. Che è quanto dire che non esistono | simboli negativi, pessimistici,o<br />
semplicemente banali: il simbolo è sempre attimo estatico, affermazione, centro 194 .<br />
La liberazione dal mondo avviene tramite la delegittimizzazione delle sue categorie spaziotemporali.<br />
L’<strong>in</strong>dividuo si trova ad essere <strong>in</strong>gaggiato <strong>in</strong> una vera e propria battaglia contro il<br />
tempo empirico al f<strong>in</strong>e di poter disporre di quell’attimo di tempo <strong>in</strong>dividuale che lo metta <strong>in</strong><br />
contatto con il tempo assoluto.<br />
La <strong>def</strong><strong>in</strong>izione dell’attimo estatico, nelle conclusioni di Pavese, sembra connettersi <strong>in</strong> qualche<br />
maniera a quella del mito soprattutto nella sua vocazione a sottrarsi al flusso del tempo<br />
empirico. In Feria d’Agosto Pavese <strong>def</strong><strong>in</strong>isce come mitico “un evento che come fuori del<br />
tempo così si compie fuori dello spazio” 195 . L’attimo estatico, potrebbe addirittura<br />
configurarsi come la fase del tempo <strong>in</strong>dividuale all’<strong>in</strong>terno dell’<strong>in</strong>tera riflessione di Pavese<br />
191<br />
Cesare Lupor<strong>in</strong>i, che nel dopoguerra assunse l’<strong>in</strong>carico di direttore della rivista Società, pubblicò il suo libro<br />
più importante nel 1941, Situazione e libertà dell’esistenza umana. Questo testo è forse il testo filosofico che più<br />
<strong>in</strong>fluenzò Cesare Pavese nella costruzione delle sue teorie relative al tempo <strong>in</strong>dividuale e all’attimo estatico: “Il<br />
capitolo Responsabilità e persona <strong>in</strong> Ces. Lupor<strong>in</strong>i (Situazione e libertà dell’esistenza) sistema i tuoi pensieri<br />
sull’attimo estatico e sull’unità cont<strong>in</strong>uata […]”. C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, 17 Settembre 1942, cit. p. 244.<br />
192<br />
C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, 7 Settembre 1942, cit. p. 244.<br />
193<br />
Sergio Givone, Introduzione ai Dialoghi con Leucò, contenuto <strong>in</strong> Cesare Pavese, Dialoghi con Leucò (1947),<br />
E<strong>in</strong>audi, Tor<strong>in</strong>o, 1999, p. VII.<br />
194<br />
C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, 17 Settembre 1942, cit. p. 244.<br />
195<br />
Cesare Pavese, Feria d’Agosto, E<strong>in</strong>audi, Roma, 1946 (quarta edizione), p. 140.<br />
66
sulla categoria del mito. Pavese auspica dunque una vera emancipazione dal tempo empirico<br />
del mondo moderno per ritrovare il contatto diretto con le cose, per trovare il significato che<br />
appare <strong>in</strong>att<strong>in</strong>gibile dal mondo empirico. Ancora nel Mestiere appunta: “L’<strong>in</strong>dividuo liberato<br />
scopre la realtà cosmica – una corrispondenza tra le cose e lo spirito, un gioco di simboli che<br />
trasfigurano le cose quotidiane e danno loro un valore e un significato, altrimenti il mondo<br />
sarebbe ischeletrito” 196 . In questo contesto si chiarisce ulteriormente il carattere della<br />
contemplazione, atteggiamento estatico atto ad isolare l’attimo dal flusso temporale per<br />
renderlo unità m<strong>in</strong>ima da cui scaturirà e su cui si <strong>in</strong>centrerà tutta l’opera: “Quello che tu<br />
chiami contemplazione (il tuo carattere poetico) è il passaggio dal piano empirico a quello<br />
poetico” 197 . In Feria d’Agosto il carattere della contemplazione viene successivamente meglio<br />
<strong>def</strong><strong>in</strong>ito. L’estasi della contemplazione porta al riconoscimento dell’eternità e dell’assoluto.<br />
Pavese sollecita il lettore all’osservazione dell’essere dell’evento piuttosto che<br />
dell’accadimento dell’evento. Con questo nuovo atteggiamento si verifica un fatto <strong>def</strong><strong>in</strong>itivo:<br />
“la scomparsa del tempo” 198 .<br />
La netta contrapposizione tra tempo <strong>in</strong>dividuale assoluto e tempo empirico relativo, su cui<br />
Pavese scrive negli appunti del Mestiere di Vivere, nelle opere di narrativa e nei saggi,<br />
rimanda direttamente alle teorie sul tempo espresse dai teorici modernisti europei<br />
arricchendosi, <strong>in</strong> questo caso, di spunti e riflessioni del tutto orig<strong>in</strong>ali. Se il modello di tempo<br />
empirico è messo <strong>in</strong> discussione <strong>in</strong>sieme ai concetti di evoluzione e progresso, nuovo spazio<br />
verrà concesso ai concetti di dest<strong>in</strong>o e libertà. Guglielmi, citando questo passo tratto da La<br />
poetica del Dest<strong>in</strong>o, pubblicato postumo nel 1950, nota come i problemi del dest<strong>in</strong>o e della<br />
libertà siano <strong>in</strong> netta connessione con la ricerca che Pavese <strong>in</strong>traprese sul mito:<br />
[...] dest<strong>in</strong>o è la direzione presa orig<strong>in</strong>ariamente da una vita, il suo tratto esistenziale. E <strong>in</strong> questo senso sta ad<br />
<strong>in</strong>dicare una libertà, il progetto che ognuno di noi è. Un progetto che si articola secondo forme di significato che<br />
si ripetono: Un dest<strong>in</strong>o non è altro che un ritmo, una cadenza di ritorni previsti nel gioco di una libertà tutta tesa.<br />
Dest<strong>in</strong>o è lo schema trascendentale di una biografia, la figura che le azioni del personaggio riempiranno. Esso<br />
ricorda la sentenza di un oracolo... ma dest<strong>in</strong>o è anche demonico schema. E' libertà <strong>in</strong>catenata alla necessità. Ed<br />
ecco costituirsi allora un classico b<strong>in</strong>omio esistenziale. Dest<strong>in</strong>o è libertà e scacco della libertà 199 .<br />
Il concetto di scacco della libertà, di evidente ispirazione esistenzialista, è un motivo<br />
ricorrente all’<strong>in</strong>terno della poetica di Pavese. Lotman <strong>in</strong>dividua, nel problema del dest<strong>in</strong>o e<br />
della libertà, un tratto caratteristico della coscienza mitopoietica moderna che si traspose nelle<br />
opere di letteratura f<strong>in</strong> dall’illum<strong>in</strong>ismo. Gli stessi illum<strong>in</strong>isti, nonostante la fede nella<br />
razionalità che dist<strong>in</strong>se la loro produzione, si appellarono al mito per spiegare certi passaggi<br />
dell’evoluzione umana: “L’affermazione di Rousseau, secondo la quale nel dest<strong>in</strong>o di ogni<br />
s<strong>in</strong>golo <strong>in</strong>dividuo si riproduce sempre il sistema del contratto sociale e dell’eterna rob<strong>in</strong>sonata<br />
dell’Uomo e dell’Altro Uomo, ha prodotto ad esempio una grande quantità di opere letterarie<br />
con le evidenti caratteristiche del mito” 200 . Il mito a cui fa riferimento Lotman, e che <strong>in</strong><br />
qualche maniera è collegato agli <strong>in</strong>teressi dei modernisti, è quello dell’<strong>in</strong>iziazione, ovvero il<br />
passaggio dell’uomo dalla sua condizione naturale a quella civile. Tale passaggio, ritenuto<br />
necessario da Rousseau, implica, per l’appunto, la perdita della libertà. Così Lotman descrive il<br />
dispiegarsi di questo schema mitico nella letteratura del XVIII sec.:<br />
All’<strong>in</strong>izio davanti a lui c’erano due <strong>in</strong>dividui, il cui comportamento era dettato dalle leggi del diritto naturale,<br />
cioè dalla Libertà e dalla Felicità (le leggi del mondo esterno erano imposto loro <strong>in</strong> modo forzato e i protagonisti<br />
potevano appellarsi ai diritti naturali dell’uomo <strong>in</strong> conflitto rispetto alle leggi). Tuttavia alla f<strong>in</strong>e del romanzo i<br />
196 C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, 8 Gennaio 1949, cit. p. 361.<br />
197 Ivi, 26 Febbraio 1940, p. 178.<br />
198 C. Pavese, Feria d’Agosto, cit. p. 155.<br />
199 G. Guglielmi, La prosa Italiana del Novecento, tra romanzo e racconto, cit. pp. 131-32.<br />
200 J. M. Lotman-Z.M<strong>in</strong>c, Letteratura e Mitologia, cit. p. 212.<br />
67
due eroi formano una microsocietà, le cui leggi vengono considerate volentieri necessarie. Secondo Rosseau, <strong>in</strong><br />
queste condizioni essi abbandonano lo stato di Uomo e acquistano i diritti e i doveri del cittad<strong>in</strong>o. A regolare le<br />
loro azioni non è più la Libertà, ma la Volontà comune.[…] Questo riduce molti testi ad un’unica <strong>in</strong>variante,<br />
mettendoli <strong>in</strong> rapporto reciproco e sottol<strong>in</strong>eando nello stesso tempo il loro isomorfismo rispetto al mito del secolo<br />
XVIII sull’Uomo e il Cittad<strong>in</strong>o. Epoche storiche e tipi di cultura di<strong>vers</strong>i producono orientamenti, personalità e<br />
testi di<strong>vers</strong>i come generatori di miti 201 .<br />
Lo schema mitico dell’<strong>in</strong>iziazione è dunque stato ampiamente utilizzato nel periodo<br />
dell’illum<strong>in</strong>ismo per giustificare la bontà delle teorie riguardanti la nuova socialità nei term<strong>in</strong>i<br />
<strong>in</strong> cui veniva descritta nel “contratto sociale”. Il mito della libertà perduta a scapito della<br />
volontà cont<strong>in</strong>uerà ad essere attivo per tutto il romanticismo che, criticando l’elemento<br />
razionale presente nel concetto illum<strong>in</strong>istico di volontà, prefigurava un ritorno ad uno stato<br />
ideale naturale. Non fu prima di Nietzsche che il concetto stesso di volontà fu rimesso <strong>in</strong> gioco<br />
e a partire da questo il concetto di libertà. La riflessione sulla libertà preculturale e la perdita<br />
della medesima avvenuta per mezzo della dittatura della ragione si affacciò tra le teorie dei<br />
modernisti. Il dest<strong>in</strong>o dell’uomo, il mistero relativo alla sua libertà, apparve per molti<br />
modernisti sempre più legato allo svolgimento dei miti. La riflessione sulla libertà a cui l’uomo<br />
può aspirare <strong>in</strong> un mondo determ<strong>in</strong>ato, appare, nelle riflessioni di Pavese un problema su cui<br />
riflettere già dal 1937 quando appuntava sul diario: “Se fosse vero che l’uomo possiede il<br />
libero arbitrio, se ne parlerebbe tanto?” 202 . La riflessione sulla libertà dell’uomo si configura<br />
come ideale proseguimento del dibattito filosofico che partì da Sp<strong>in</strong>oza e che, proseguendo per<br />
tutto l’illum<strong>in</strong>ismo, si chiedeva se si potesse parlare di effettiva libertà <strong>in</strong> un mondo<br />
strettamente regolato dalle leggi del determ<strong>in</strong>ismo naturale. Le leggi naturali, che il mito<br />
tendeva a rappresentare e a portare a livello cognitivo, si contrappongono, nelle riflessioni di<br />
Pavese, a quelle della società contemporanea. Per Pavese, seguendo una chiara ispirazione<br />
niciana, la libertà dell’<strong>in</strong>dividuo consiste proprio nel riconoscere come proprie le leggi di<br />
natura, così come il mito ce le svela. La libertà consisterebbe nel tornare a seguire le leggi<br />
della natura, <strong>in</strong>terpretabili attra<strong>vers</strong>o l’azione conoscitiva del mito, riconoscendosi <strong>in</strong> un<br />
dest<strong>in</strong>o proprio dell’essere umano. Anche <strong>in</strong> questo caso il rifiuto delle categorie artificiali è il<br />
primo passo <strong>vers</strong>o questa sorta di ricongiungimento. L’elemento razionale è difatti il primo<br />
imputato che si frappone al riconoscimento della natura dell’uomo: “Il dest<strong>in</strong>o è abbandonarsi<br />
e vivere la pienezza, che poi si chiarisce coerente e costruttiva. E’ dest<strong>in</strong>o ciò che si fa senza<br />
saperlo, abbandonandosi. In un dato senso tutto è dest<strong>in</strong>o: non si sa mai quel che si fa. C’è una<br />
piccola e razionale consapevolezza che morde <strong>in</strong> superficie | e noi abbiamo il dovere di<br />
profondire al possibile. Ciò che resta <strong>in</strong>conoscibile […] è il dest<strong>in</strong>o” 203 .<br />
Il rapporto dest<strong>in</strong>o - mito - libertà è per Pavese un nodo da sciogliere. Lo scrittore sembra<br />
dest<strong>in</strong>ato ad <strong>in</strong>dagare e chiarire questo rapporto con la malcelata speranza di poter riconoscere<br />
la propria libertà nello schema mitico di un dest<strong>in</strong>o. Il romanzo Il Carcere, del 1948, è forse il<br />
momento della narrativa di Pavese che meglio illustra questo rapporto “pericoloso”. Il<br />
carcere, il luogo fisico <strong>in</strong> cui viene conf<strong>in</strong>ato Stefano, è proprio la mediazione tra la libertà<br />
fisica, preclusa nel mondo del tempo empirico, e la libertà metafisica perseguibile attra<strong>vers</strong>o<br />
la ricerca del tempo assoluto dell’attimo che diviene, appunto, simbolo di libertà. Il tempo<br />
empirico diviene quasi un ostacolo, un av<strong>vers</strong>ario da sconfiggere per il r<strong>in</strong>venimento di una<br />
vera libertà metafisica.<br />
La vicenda de Il Carcere è emblematica rappresentazione del rapporto tragico tra dest<strong>in</strong>o e<br />
libertà. Nel romanzo appare evidente come la libertà non sia una categoria a sé stante; la<br />
libertà di cui l’uomo può disporre appare legata ad un sottile gioco di differenze all’<strong>in</strong>terno<br />
della grande gabbia del mondo. Ci sono, <strong>in</strong> altre parole, all’<strong>in</strong>terno della gabbia zone di<br />
201 Ivi, p. 213.<br />
202 C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, 7 Dicembre 1937, cit. p. 64.<br />
203 Ivi, 2 Gennaio, 1950, p. 384.<br />
68
massima esposizione che si contrappongono ai settori più bui. Il conf<strong>in</strong>o a cui è condannato<br />
Stefano appare, all’<strong>in</strong>izio, una salvezza dall’orrore della prigione: “Per lui che usciva dal<br />
carcere era la libertà” 204 . Nel paese <strong>in</strong> cui è conf<strong>in</strong>ato, sospeso fuori dal tempo, la giornata del<br />
protagonista è scandita nei m<strong>in</strong>imi particolari. Nella realtà alienante del conf<strong>in</strong>o il<br />
protagonista deve ricorrere ad espedienti che possano r<strong>in</strong>verdire il sentimento di una libertà<br />
più grande, una libertà perduta di cui però si sente ancora il ricordo. Alla f<strong>in</strong>e della giornata,<br />
l’osteria rappresenta un riparo “dove Stefano entrava a sedersi e sentire la sua libertà” 205 . La<br />
parete “mutevole “ del mare, una volta simbolo di libertà, è vista con sospetto da Stefano che<br />
sembra ribellarsi alla situazione di prigionia <strong>in</strong> una maniera del tutto <strong>in</strong>timistica, riconoscendo<br />
nella libertà una potenzialità propria dell’essere umano legata molto più all’<strong>in</strong>dividualità che<br />
al mondo esterno. L’utilizzo cont<strong>in</strong>uato dell’aggettivo possessivo, di fronte alla parola libertà,<br />
nell’ambito di una situazione di detenzione, testimonia quasi una spaccatura tra il mondo<br />
<strong>in</strong>tellettuale del protagonista e quello oggettivante della realtà. Così, nonostante la detenzione,<br />
Stefano “ascoltava la sua libertà, parendogli di uscire ogni matt<strong>in</strong>a dal carcere” 206 . La<br />
percezione della libertà perduta, il ricordo di questa perdita, che si configura come scacco<br />
esistenziale, rende Stefano particolarmente nervoso, soprattutto durante la notte quando “la<br />
stranezza del giorno lo assaliva agitandolo, come un formicolio nel sangue” 207 .<br />
Non è la prima volta che il sangue assurge ad elemento topico nella letteratura di Pavese. E’<br />
un elemento tipico di molta produzione modernista e che particolarmente <strong>in</strong> Lawrence trova<br />
un suo corso. Anche il sangue è un simbolo all’<strong>in</strong>terno del cosmo disegnato dai modernisti. E’<br />
il simbolo della forza vitale e della conoscenza non razionale ed <strong>in</strong>nata che l’uomo possiede.<br />
In quest’occasione è il sangue, prima che il cervello, che accusa una sensazione di disagio. Il<br />
sangue com<strong>in</strong>cia a formicolare nelle vene, a muo<strong>vers</strong>i <strong>in</strong>somma, al contrario di ciò che fa il<br />
protagonista che è essenzialmente fermo, sembra voler uscire dal corpo o perlomeno<br />
sollecitarlo alla ribellione. Anche la notte fa parte dell’uni<strong>vers</strong>o simbolico modernista e,<br />
associandosi all’immag<strong>in</strong>e del sangue, svolge <strong>in</strong> questo episodio un ruolo ben preciso. E’ la<br />
percezione di una conoscenza perduta che, al calar della luce del giorno, riaffiora. La notte,<br />
dionisiaca ed irrazionale, diviene il luogo del r<strong>in</strong>venimento, del ricordo, il ruolo <strong>in</strong> cui si può<br />
ricordare, più nel sangue che nella mente, il mistero dell’orig<strong>in</strong>e: “La tenebra chiudendo<br />
l’orizzonte ampliava la sua libertà e ridava campo ai suoi pensieri” 208 .<br />
L’esperienza di privazione della libertà che Pavese ci racconta per mezzo della vicenda di<br />
Stefano, raramente si esplicita direttamente <strong>in</strong> riflessioni politiche. L’attitud<strong>in</strong>e dello scrittore<br />
è piuttosto quella di voler fare del carcere materiale una rappresentazione del carcere<br />
esistenziale <strong>in</strong> cui è imprigionato lo spirito del protagonista. I sentimenti che Pavese descrive<br />
sono sentimenti tipici della letteratura esistenzialistica come l’“angoscia” 209 che spesso viene<br />
associata a Stefano. Le sensazioni di Stefano raramente si proiettano all’esterno ma sono, al<br />
contrario, accompagnate da riflessioni <strong>in</strong>trospettive. Le barriere del carcere materiale<br />
divengono presto barriere metafisiche e c<strong>in</strong>gono il protagonista di “pareti <strong>in</strong>visibili” 210 . La<br />
forma del mondo viene riconosciuta come apparente. Il protagonista si rende conto ben presto<br />
dell’<strong>in</strong>consistenza del mondo della realtà: “Ma Stefano ben presto si accorse che il gioco di<br />
quella vita poteva svanire, come un’illusione che era” 211 . Il problema esistenziale consiste<br />
allora nella trasposizione tra il mondo fenomenologico e quello metafisico ovvero la<br />
consapevolezza che l’uomo moderno altro non è che creazione del mondo moderno,<br />
scimmiottatura paradossale di un essere umano. Se la forma dell’uomo è modellata sulla<br />
forma del mondo, allora l’uomo stesso diviene carcere: “Ogni dolcezza, ogni contatto, ogni<br />
204<br />
C. Pavese, Il Carcere, cit. p. 285.<br />
205<br />
Ivi, p. 286.<br />
206<br />
Ibidem.<br />
207<br />
Ibidem<br />
208<br />
Ivi, p. 289.<br />
209<br />
Ivi, p. 296.<br />
210<br />
Ivi, p. 292.<br />
211<br />
Ivi, p. 305.<br />
69
abbandono, andava serrato nel cuore come <strong>in</strong> un carcere e discipl<strong>in</strong>ato come un vizio, e più<br />
nulla doveva apparire all’esterno, alla coscienza. Più nulla doveva dipendere dall’esterno: né<br />
le cose né gli altri dovevano potere più nulla. […] (Stefano) non doveva credere a nessuna<br />
speranza, ma prevenire ogni dolore accettandolo e divorandolo nell’isolamento. Considerarsi<br />
sempre <strong>in</strong> carcere” 212 . E’ evidente <strong>in</strong> questo passo come la condizione di conf<strong>in</strong>ato del<br />
protagonista si rapporti direttamente ad una condizione esistenziale. Il sentimento di<br />
esclusione si rapporta a quello di reclusione creando una situazione emotiva peculiare nel<br />
personaggio di Stefano. Il mondo è <strong>in</strong> questo caso il primo imputato e la prigione del<br />
protagonista, la sua solitud<strong>in</strong>e, è <strong>in</strong> stretta connessione con il mondo: “La cella era fatta di<br />
questo: il silenzio del mondo” 213 . La libertà è, allora, altrove forse nella terra: “Girò gli occhi<br />
sui campi, sugli alberi brulli lontano, per sentire la sua libertà” 214 . Ma è uno sguardo<br />
nostalgico privo di qualsiasi speranza. E’ lo sguardo diretto <strong>vers</strong>o qualcosa di perduto. E’<br />
<strong>in</strong>teressante notare come, a differenza dei personaggi di Lawrence, i personaggi di Pavese<br />
tendano molto più alla disperazione, all’autocompiangimento. L’atteggiamento di Stefano è di<br />
chiusura, di mancanza di fiducia nel prossimo, nel mondo, un progressivo raggomitolarsi <strong>in</strong> se<br />
stesso. Il mondo diviene a sua volta simbolo di una condizione esistenziale: “Fantasticava il<br />
mondo <strong>in</strong>tero come un carcere dove si è chiusi per le ragioni più di<strong>vers</strong>e ma tutte vere, e <strong>in</strong> ciò<br />
trovava un conforto” 215 . E’ una condizione <strong>in</strong> cui il protagonista trova un sadico piacere, una<br />
sorta di rivalsa nei confronti del mondo che lo tiene a distanza: “Le nuvole, i tetti, le f<strong>in</strong>estre<br />
chiuse, tutto <strong>in</strong> quell’attimo era dolce e prezioso, tutto era come uscire dal carcere. Ma poi?<br />
Meglio restarci per sognare di uscirne, che non uscirne davvero” 216 . E’ una soluzione che<br />
consuma la tragedia nella sua <strong>in</strong>terezza senza assecondare alcuna fantasia utopica. Il carcere è<br />
la condizione <strong>in</strong>iziale e la condizione f<strong>in</strong>ale, nulla cambia <strong>in</strong> quanto condizione esistenziale.<br />
E’ la situazione della tragedia classica ove il dest<strong>in</strong>o è accettato come legge dell’essere. La<br />
riflessione di Pavese sul dest<strong>in</strong>o riaffiora nel romanzo: “Pensavo che di tutta l’estate i<br />
momenti più belli li ho passati qua dentro, solo come <strong>in</strong> un carcere. La sorte più brutta diventa<br />
un piacere: basta sceglierla noi. […] Non mi direte che l’avete scelto voi, di venire quaggiù.<br />
Non si sceglie il dest<strong>in</strong>o […]. Basta volerlo, prima ancora che ci venga imposto […] non c’è<br />
dest<strong>in</strong>o, ma soltanto dei limiti. La sorte peggiore è subirli. Bisogna <strong>in</strong>vece r<strong>in</strong>unciare” 217 . I<br />
pensieri di Stefano <strong>in</strong>terrompono cont<strong>in</strong>uamente la narrazione. Sono pensieri che dal<br />
particolare conducono all’uni<strong>vers</strong>ale cercando di riflettere sulle leggi della vita: “Lo prese di<br />
sprovvista il pensiero che ogni giorno entra qualcuno nel carcere, come ogni giorno qualcuno<br />
muore” 218 . Le meditazioni di Stefano sembrano maturare <strong>in</strong> relazione alla consapevolezza<br />
f<strong>in</strong>ale di aver vissuto una situazione esemplare capace di approfondire i temi dell’esistenza. Il<br />
romanzo, che f<strong>in</strong>o a quel momento si era basato sulla percezione dello spazio, descritto <strong>in</strong><br />
term<strong>in</strong>i di chiusura o limitatezza, si svela, alla f<strong>in</strong>e, vicenda esemplare, mitica, <strong>in</strong> cui anche il<br />
tempo trova la sua collocazione assoluta: “Forse la prigione non è altro che questo:<br />
l’impossibilità di ubriacarsi, di distruggere il tempo, di vivere un’<strong>in</strong>solita sera” 219 .<br />
Nel proseguo della sua meditazione sul tempo Pavese svela presto di condurre un’analisi<br />
omnicomprensiva. I rimandi tra tempo <strong>in</strong>dividuale e tempo empirico e fra orizzonte poetico e<br />
orizzonte morale sono stati f<strong>in</strong>o ad ora netti e precisi. La ricerca di una teoria completa della<br />
composizione che contemplasse i rapporti con il mondo empirico e le sue categorie ha portato<br />
l’autore, già prima della lettura del testo di Cesare Lupor<strong>in</strong>i, a consistenti risultati. La<br />
riflessione è pronta ad abbracciare ora l’altra grande categoria che, all’<strong>in</strong>terno di un’opera<br />
d’arte, costituisce un altro grosso nodo da sciogliere per ogni artista: la categoria dello spazio.<br />
212 Ivi, p. 324.<br />
213 Ivi, p. 341.<br />
214 Ivi, p. 344.<br />
215 Ivi, p. 356.<br />
216 Ivi, p. 349.<br />
217 Ivi, p. 330.<br />
218 Ivi, p. 345.<br />
219 Ivi, p. 357.<br />
70
Anche <strong>in</strong> questo caso le regole uni<strong>vers</strong>ali, stabilite da Pavese per il tempo, sembrano adattarsi<br />
alla concezione dello spazio. Anche <strong>in</strong> questo caso lo spazio empirico si trova <strong>in</strong> contrasto con<br />
lo spazio assoluto ma, come nel caso della riflessione sulla categoria del tempo, gli assunti di<br />
Pavese sono accurati: “Come del tempo, così dello spazio. Poesia e Pittura. Non deve esistere,<br />
<strong>in</strong> una poesia, tempo empirico così come <strong>in</strong> un quadro non deve esistere spazio empirico” 220 .<br />
Risolvendo il problema dello spazio tramite questo rimando alla riflessione precedentemente<br />
condotta sul tempo, Pavese costituisce una solida base teorica per le sue composizioni. La<br />
composizione dell’opera aspira ad un’unità composta da frammenti. Il senso unitario<br />
dell’opera si ottiene dalla composizione di questi frammenti <strong>in</strong> una costruzione <strong>in</strong>dividuale,<br />
propria dell’artista, che ne decreta l’assolutezza ovvero la non empiricità: “Creare un’opera è<br />
dunque trasformare <strong>in</strong> assoluti il suo tempo e il suo spazio” 221 . Creare un’opera è dunque<br />
rendere assoluti il tempo e lo spazio portandoli fuori dal flusso spazio-temporale del mondo<br />
moderno, facendoli significare <strong>in</strong> quanto simboli.<br />
220 C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, 26 Febbraio 1940, cit. p. 178.<br />
221 Ibidem.<br />
71
2.3 Spazi della modernità<br />
Così come avvenuto nel caso del tempo anche lo spazio viene posto sotto una serrata<br />
osservazione <strong>in</strong> epoca moderna. La categoria dello spazio viene analizzata e ripensata e,<br />
seguendo la stessa sorte della categoria del tempo, viene <strong>in</strong> qualche maniera resa assoluta,<br />
mitica. Gli scrittori del modernismo sottraggono lo spazio alla misurazione, così come il<br />
tempo era stato sottratto alla scansione, assecondando il desiderio <strong>in</strong>tellettuale di voler trovare<br />
una nuova unità a forme che lentamente ma <strong>in</strong>esorabilmente si avviavano alla decadenza<br />
nell’ambito di un dest<strong>in</strong>o del nichilismo che Nietzsche aveva predetto.<br />
Lo spazio, nella composizione narrativa, ha sempre rappresentato un vero e proprio ord<strong>in</strong>e<br />
significante. Nel romanzo moderno lo spazio rafforza questa sua funzione. Dalla geografia<br />
sconf<strong>in</strong>ata dei romanzi storici o d’esplorazione o al chiuso dei salotti <strong>in</strong> cui si consuma il<br />
dramma borghese contemporaneo, il ruolo dello spazio circostante sembra passare, <strong>in</strong> molti<br />
casi, dal ruolo di cornice più o meno significante a vero e proprio personaggio attivo della<br />
narrazione. Per Franco Moretti “ogni spazio determ<strong>in</strong>a, o quanto meno <strong>in</strong>coraggia, un di<strong>vers</strong>o<br />
tipo di storia […]: nel romanzo moderno quello che accade dipende strettamente dal dove<br />
esso accade” 222 . Questa particolarità per cui il romanzo moderno dota lo spazio di un nuovo<br />
ruolo e, conseguentemente, di nuove possibilità significanti, è dovuta proprio all’enorme<br />
scarto, nel modo di pensare lo spazio, che separa l’epoca moderna da quella premoderna.<br />
Di<strong>vers</strong>i fattori contribuirono a creare una nuova concezione di spazio nelle coscienze moderne<br />
occidentali. La scoperta di nuovi mondi e le conseguenti imprese imperialiste sono da<br />
annoverare fra i primi fattori per quanto riguarda la concezione di uno spazio extraeuropeo.<br />
La modificazione del paesaggio, dovuto all’impatto della rivoluzione <strong>in</strong>dustriale e<br />
all’accorciarsi delle distanze, dovuto ai nuovi mezzi di trasporto, <strong>in</strong>fluenzò il modo di<br />
rapportarsi allo spazio europeo. Il paesaggio europeo ha subito nei millenni dei cont<strong>in</strong>ui<br />
cambiamenti. Nella fase della modernità questi cambiamenti hanno però avuto una velocità<br />
superiore a quella delle epoche precedenti così come sottol<strong>in</strong>ea Eugenio Turri <strong>in</strong> un recente<br />
studio:<br />
Altra caratteristica che <strong>def</strong><strong>in</strong>isce lo spazio europeo per chi viene da fuori è l’estrema densità delle aree coltivate<br />
ed urbanizzate, la presenza cont<strong>in</strong>ua di manufatti umani, come se l’antropizzazione con i suoi segni e le sue<br />
opere fosse un manto avvolgente il suolo, o una “seconda natura” <strong>in</strong> senso leopardiano, una natura rifatta.<br />
Ovviamente la costruzione dell’ord<strong>in</strong>e antropico è il risultato di un’opera millenaria, di un’azione protratta nel<br />
tempo. In Europa essa ha ricevuto impulsi eccezionali nella fase culm<strong>in</strong>ante della modernità, con l’imporsi cioè<br />
del sistema <strong>in</strong>dustriale […]. Paradossalmente, nonostante i rapporti comunicativi dell’Europa vengano favoriti<br />
ora dai nuovi mezzi tecnici (dalle ferrovie alle telecomunicazioni), non si sviluppano processi unificanti, ma si<br />
accendono al contrario feroci conflitti tra gli stati <strong>in</strong>dustrializzati per il dom<strong>in</strong>io, <strong>in</strong>sieme politico ed economico,<br />
dello spazio europeo. Essi porteranno alle lacerazioni su cui un’<strong>in</strong>tera cultura piangerà e rifletterà, con O.<br />
Spengler, P. Valey (“Sentiamo che una civiltà possiede la stessa fragilità di una vita…”) e altri uom<strong>in</strong>i che<br />
avvertono il senso della f<strong>in</strong>e 223 .<br />
Anche nel senso dello spazio, non solo del tempo, la modernità sarebbe stata dunque percepita<br />
come strappo, come collasso di un sistema significante a vantaggio di un nuovo ord<strong>in</strong>e<br />
reputato artificiale e lontano dalla vera natura dell’uomo. L’esperienza dell’esclusione sembra<br />
<strong>in</strong> questo caso prendere il sopravvento. I mezzi di comunicazione veloci non fanno altro che<br />
escludere lo spazio fra il punto di partenza e il punto di arrivo. La distanza spaziale è<br />
percepita <strong>in</strong> maniera differente e viene quasi esclusa dall’orizzonte del viaggiatore oramai<br />
abituato a “saltarla”. La velocità, come pure avviene nel caso del tempo, non è avvertita da<br />
222 Franco Moretti, Atlante del Romanzo Europeo, E<strong>in</strong>audi, Tor<strong>in</strong>o, 1997, p. 75.<br />
223 Eugenio Turri, Lo spazio europeo: alla ricerca di una geografia mitica, contenuto <strong>in</strong> Carlo Ossola, Europa:<br />
miti di identità, Saggi Marsilio, p. 28-29.<br />
72
molti <strong>in</strong>tellettuali come un cambiamento marg<strong>in</strong>ale. Essa è al contrario la rappresentazione<br />
della volontà dell’uomo di sottomettere il tempo e lo spazio naturale alle esigenze della<br />
società moderna giustificando questo procedimento attra<strong>vers</strong>o i meccanismi culturali:<br />
La costruzione dello spazio antropico, detto <strong>in</strong> altro modo, corrisponde all’annessione della natura alla cultura, è<br />
il risultato di una serie di imprese di cui sono protagonisti non solo i costruttori di strade, di città, di fabbriche e<br />
di paesaggi agrari, ma anche tutti gli studiosi, gli artisti, i filosofi ecc. che danno contributi alla cultura nel suo<br />
rapportarsi alla natura, nel creare l’ambiente di vita più adatto alle esigenze della società che essa rappresenta 224 .<br />
La modificazione delle categorie naturali di spazio e tempo sembra assurgere a tratto<br />
caratteristico dell’uomo occidentale ed implica un discorso culturale che va alle radici della<br />
nostra civiltà. Il rapporto dell’uomo occidentale con l’ambiente circostante sembra essere<br />
viziato da una mentalità “di conquista” che trova una giustificazione identificabile per Turri a<br />
livello spaziale, così come era stato per Kermode a livello temporale, nella Bibbia, il testo<br />
mitologico che è alla base della cultura occidentale:<br />
[…] atteggiamento propriamente europeo che ha fondato la sua ideologia della natura partendo dal pr<strong>in</strong>cipio<br />
biblico, antico, subicite terram, re<strong>in</strong>terpretato nel R<strong>in</strong>ascimento come idealizzazione dell’ord<strong>in</strong>e umano (specchio<br />
di quello div<strong>in</strong>o) al cospetto dell’ord<strong>in</strong>e naturale, poi <strong>in</strong> senso hegeliano come <strong>in</strong>veramento dello Spirito del<br />
Mondo, come grande fattore di Storia (“Quando lo Spirito dom<strong>in</strong>a, tace ed ubbidisce la natura”), f<strong>in</strong>o<br />
all’ideologizzazione borghese dell’Herrshaftwissen, il sapere per dom<strong>in</strong>are la natura e assecondare al meglio le<br />
richieste <strong>in</strong>saziabili del capitalismo 225 .<br />
Ma è proprio <strong>in</strong> questa caratteristica di discorso culturale che gli <strong>in</strong>tellettuali modernisti<br />
cercano e trovano la possibilità, se non dell’emancipazione, almeno della risalita <strong>vers</strong>o una<br />
nuova possibilità conoscitiva data da un nuovo rapporto con l’essere. Se la cultura ha fatto sì<br />
che l’essere venisse obliato, è proprio tramite un’operazione culturale, quella dello<br />
svolgimento del mito, che l’uomo può riconsiderare la propria esistenza sotto una nuova luce.<br />
La cultura occidentale si scopre essere come un unicum che ha avuto un’evoluzione che ha<br />
espresso, attra<strong>vers</strong>o i secoli, una costante sete di dom<strong>in</strong>io non solo nei confronti delle altre<br />
culture o civiltà ma anche nei confronti delle categorie naturali dello spazio e del tempo.<br />
Quello della modernità è stato un periodo <strong>in</strong> cui questa evoluzione avrebbe subito una brusca<br />
accelerazione favorendo la reazione degli <strong>in</strong>tellettuali che scorgevano, nel dest<strong>in</strong>o di questo<br />
processo, un futuro di morte, necessaria conseguenza all’epoca del nichilismo preconizzata da<br />
Nietzsche 226 . La storia dell’Occidente si manifesta dunque come progetto culturale direzionato<br />
che ha allontanato l’uomo dal suo essere. La possibilità di venire a conoscenza di questo<br />
dramma della separazione è <strong>in</strong>sita nell’approccio cognitivo: “la filosofia espressa<br />
dall’Occidente non sarà il soggetto da seguire, ma l’oggetto da <strong>in</strong>dagare per scoprire il senso<br />
224 Ivi, p. 40.<br />
225 Ivi, p. 30.<br />
226 Umberto Galimberti assegna a questa progressiva separazione tra la natura e la cultura il segno più marcato<br />
della decadenza dei tempi moderni. La scienza e la religione fanno parte di un progetto culturale che porta<br />
l’uomo a creare e a giustificare un proprio mondo artificiale, <strong>in</strong> quanto oramai <strong>in</strong>capace di poter rientrare <strong>in</strong><br />
comunicazione con il suo mondo naturale, il suo essere: “(lo) smarrirsi della filosofia nella scienza e nella<br />
religione non è casuale, ma denuncia un carattere di fondo dell’uomo occidentale che, <strong>in</strong>capace di soggiornare<br />
nella sospensione e nell’<strong>in</strong>certezza che caratterizzano l’attesa affretta i tempi della sicurezza <strong>in</strong> cui poter<br />
esercitare tranquillamente il proprio dom<strong>in</strong>io. […] Il senso del tempo moderno è qu<strong>in</strong>di antico; solo la modalità<br />
del dom<strong>in</strong>io è mutata, non la direzione della via che, dall’<strong>in</strong>sicurezza <strong>in</strong>teriore, ha condotto l’uomo al<br />
rassicurante dom<strong>in</strong>io delle cose”. Umberto Galimberti, Heidegger, Jaspers e il Tramonto dell’Occidente, Il<br />
Saggiatore, Milano, 1996, p. 14.<br />
73
del suo evento, contenuto nei tratti fondamentali della nostra cultura” 227 . Il concetto espresso<br />
da Turri riguardo l’antropizzazione del paesaggio si scopre essere una tendenza riguardante<br />
non solo lo spazio ma l’<strong>in</strong>tero uni<strong>vers</strong>o culturale dell’uomo: “l’uomo, <strong>in</strong>vece di ascoltare<br />
l’essere, ha ideato l’essere, ovvero l’ha pensato a sua misura […]” 228 . Se la concezione<br />
moderna dello spazio è qu<strong>in</strong>di solo un aspetto del progetto culturale occidentale, è facile<br />
comprendere come la proposizione del concetto di spazio assoluto mitico, e l’eventuale<br />
confronto con lo spazio relativo moderno, da parte degli scrittori modernisti, assuma una<br />
valenza simbolica tesa a contestare l’<strong>in</strong>tero sistema culturale. Ed è qu<strong>in</strong>di proprio dal sistema<br />
culturale che gli <strong>in</strong>tellettuali della modernità <strong>in</strong>iziano la loro ricerca, così come Vico aveva<br />
<strong>in</strong>segnato attra<strong>vers</strong>o la sua teoria della cognizione parlando della storia. Se la cultura<br />
occidentale si basa sul testo mitologico della Bibbia, anche la riflessione su Dio appartiene<br />
all’analisi culturale:<br />
In Occidente l’uomo ha curato solo se stesso e anche il Dio che ha pensato, l’ha pensato al proprio servizio. […]<br />
L’onnipotenza che l’uomo aveva attribuito a Dio nei tempi della sua radicale impotenza, oggi la rivendica per sé,<br />
decidendo di gestire <strong>in</strong> proprio il processo creativo che la sua impotenza aveva affidato a Dio. […] L’umanità<br />
occidentale oggi possiede quelle prerogative che un tempo erano pensate come proprie di Dio. L’apparato tecnico<br />
di cui dispone le consente di determ<strong>in</strong>are la f<strong>in</strong>e del mondo 229 .<br />
L’aff<strong>in</strong>amento della tecnica, l’antropizzazione del paesaggio che trova la sua massima<br />
espressione nel fenomeno dell’urbanesimo dotano l’uomo occidentale di uno spirito di<br />
onnipotenza tragica che lo pone a sostituirsi a Dio così come l’ambiente circostante è<br />
modellato sull’iconografia classica del paradiso terrestre. Lo spazio cambia radicalmente<br />
forma seguendo i dettami che la cultura occidentale gli impone:<br />
L’immag<strong>in</strong>e è ormai quella di un’Europa totalmente artificializzata. Dagli spazi compressi, costruita per<br />
agevolare al massimo grado l’uomo, per elim<strong>in</strong>are ogni ostacolo fisico, costruire l’utopia del paradiso <strong>in</strong> terra, <strong>in</strong><br />
realtà accentuando al massimo, attra<strong>vers</strong>o il consumo (consumo di spazio e risorse), lo stordimento<br />
dell’<strong>in</strong>dividuo, nell’illusione di v<strong>in</strong>cere la solitud<strong>in</strong>e <strong>in</strong>dotta dalla totale laicizzazione della natura 230 .<br />
Vi è dunque una connessione tra la volontà dell’uomo occidentale di modellare il paesaggio<br />
idealmente e la sua provenienza culturale. Il mito biblico e la figura di Adamo rappresentano,<br />
per Galimberti, la spiegazione tangibile di un atteggiamento: “Alla base di tutte le <strong>in</strong>iziative<br />
dell’uomo occidentale c’è dunque il tentativo palese o nascosto di dom<strong>in</strong>are l’essere, di<br />
signoreggiarlo. Il tentativo è sostenuto dalla passione adamitica che sp<strong>in</strong>ge l’uomo ad essere<br />
come Dio” 231 . A questo punto è chiara la rilevanza che la formulazione del concetto di spazio<br />
ha nella tradizione culturale occidentale. La concezione moderna di spazio è parte <strong>in</strong>tegrante,<br />
nonché fondante, di tutta la concezione di modernità nel momento <strong>in</strong> cui l’aff<strong>in</strong>amento delle<br />
tecniche ha portato negli ultimi due secoli a cambiamenti molto repent<strong>in</strong>i della geografia<br />
europea. La crisi del soggetto moderno, espressa nell’ideazione del personaggio romanzesco,<br />
è studiata da Nietzsche <strong>in</strong> riferimento al fenomeno del nichilismo, <strong>def</strong><strong>in</strong>ito da Galimberti<br />
come tragica sorte della civiltà occidentale: “L’Occidente è la terra che ha ospitato l’oblio<br />
dell’essere, ovvero lo smarrimento del suo senso; il nichilismo ne è qu<strong>in</strong>di la sorte, il<br />
tramonto il suo dest<strong>in</strong>o” 232 . In questo orizzonte di crisi, <strong>in</strong> cui lo spazio naturale diviene la<br />
227 Ivi, p. 15.<br />
228 Ivi, p. 16.<br />
229 Ivi, p. 18.<br />
230 E. Turri, Lo spazio europeo: alla ricerca di una geografia mitica, cit. p. 31.<br />
231 U. Galimberti, Heidegger, Jaspers e il Tramonto dell’Occidente, cit. p. 18.<br />
232 Ivi p. 12.<br />
74
appresentazione ultima e tangibile del nichilismo, si crea una necessaria relazione tra l’uomo<br />
e lo spazio. Lo spazio assume dunque, nell’ambito delle opere artistiche e delle speculazioni<br />
filosofiche, una notevole importanza nel momento <strong>in</strong> cui si riconosce la sua relazione<br />
culturale con l’uomo:<br />
Di ciò è rivelatrice l’importanza assunta, nella cultura europea, dal paesaggio, soprattutto se lo <strong>in</strong>tendiamo come<br />
scoperta da parte dell’uomo di sé e del mondo, come specchio del proprio essere e agire nella natura, dei modi <strong>in</strong><br />
cui questa è annessa dalla cultura: come riferimento, <strong>in</strong> altre parole, di quell’autocomprendersi che si è posto<br />
come fattore fondamentale della cultura europea 233 .<br />
Si potrebbe ipotizzare, <strong>in</strong> questo senso, un legame particolare fra le poetiche dei secoli XIX e<br />
XX e la descrizione dei paesaggi nella loro connotazione di spazio mitico. Già illum<strong>in</strong>ismo e<br />
romanticismo ridisegnarono un ruolo per il paesaggio nell’orizzonte conoscitivo dell’uomo.<br />
Per la sensibilità moderna, e per l’impatto che la rivoluzione <strong>in</strong>dustriale ebbe <strong>in</strong> quel periodo,<br />
è senz’altro da notare come i romantici e i modernisti ebbero una concezione dello spazio<br />
aff<strong>in</strong>e che si sublimò nella riscoperta dei paesaggi naturali anche se poi l’utilizzo fu differente.<br />
La connessione tra cultura e natura, ipotizzata da Galimberti e Turri <strong>in</strong> riferimento alle<br />
tematiche dello spazio, sembra trovare riscontro anche <strong>in</strong> un appunto di Pavese le cui<br />
implicazioni ontologiche sono state postulate a più riprese soprattutto da Gioanola. L’appunto<br />
del 1948 sembra s<strong>in</strong>tetizzare molte delle tematiche f<strong>in</strong> qui esposte. Pavese scrive:<br />
“L’Occidente ha sempre preferito l’uomo alla natura. Poesia narrativa con eroi. Scoprì il<br />
paesaggio col romanticismo, cioè l’identificazione (magica) con la natura (Schell<strong>in</strong>g ecc.)” 234 .<br />
Per Pavese il tempo del romanticismo sembra aver riproposto all’uomo la possibilità di<br />
riscoprire la valenza simbolica del paesaggio. Nelle righe di Pavese la riscoperta del<br />
paesaggio si pone come alternativa-reazione alla preferenza che l’uomo occidentale ha sempre<br />
accordato a se stesso e alla sua edificazione piuttosto che alla natura. Questa concezione<br />
troverà spazio nella mitologizzazione dei luoghi unici che avverrà <strong>in</strong> Feria d’Agosto. La<br />
mitizzazione del luogo unico, così come viene teorizzata da Pavese nel libro, solleva il<br />
problema della qualità di questo luogo unico e se esso possa considerarsi significante per<br />
culture non locali trattandosi, nella fattispecie, di aspetti paesaggistici delle Langhe<br />
piemon<strong>tesi</strong>. Nell’op<strong>in</strong>ione di Turri questa disposizione di fronte al luogo mitico locale è<br />
caratteristico della cultura europea e non sottoscrive di certo un aspetto prov<strong>in</strong>ciale dello<br />
scrittore <strong>in</strong> questione:<br />
Certo il paesaggio rimanda al locale, non all’Europa. Ma la “lettura” del locale, la sua celebrazione mitica e la<br />
sua conoscenza si ispirano <strong>in</strong> Europa a valori non strettamente locali: ossia il Genius loci è, <strong>in</strong> Europa, un Genius<br />
Europae, perché i processi culturali risentono dei movimenti che percorrono il cont<strong>in</strong>ente grazie all’<strong>in</strong>tensa<br />
comunicazione.[…] è caratteristico della cultura europea di annettere il particolare al generale, di fare dei miti<br />
locali dei miti globali.[…] Celebrare, dip<strong>in</strong>gere o cercare comunque i valori <strong>in</strong>siti <strong>in</strong> un paesaggio fa parte di un<br />
atteggiamento che è proprio di chi sospende l’azione, di chi si sofferma a guardare e descrivere lo scenario <strong>in</strong> cui<br />
poco prima era semplice attore. Da ciò la metafora del paesaggio come teatro, come specchio di una società,<br />
della sua cultura, del suo modo di rapportarsi alla natura. Si comprende perciò come ogni esercizio di studio,<br />
rappresentazione o contemplazione che leghi gli uom<strong>in</strong>i al teatro della propria esistenza generi riflessività,<br />
consapevolezza, caricando di significati simbolici quel paesaggio o quel luogo 235 .<br />
D’altra parte fu proprio Frazer a supportare una visione globale europea, <strong>in</strong> riferimento alle<br />
tradizioni popolari, grazie al suo approccio comparatistico. Discutendo dei rituali della<br />
233 E. Turri, Lo spazio europeo: alla ricerca di una geografia mitica, p. 32.<br />
234 C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, 1 Maggio 1948, cit. p. 350.<br />
235 E. Turri, Lo spazio europeo: alla ricerca di una geografia mitica, cit. p. 33-34.<br />
75
primavera e della mietitura nelle campagne europee, Frazer, attra<strong>vers</strong>o la comparazione dei<br />
comportamenti di vari popoli europei, fu <strong>in</strong> grado di scrivere una lista di regole generiche che<br />
furono riscontrate come vere e proprie costanti. L’immedesimazione fra la persona e i covoni<br />
di grano è considerata una costante di molte popolazioni arcaiche europee così come il ricorso<br />
a riti magici e propiziatori scanditi dalle stagioni naturali. Frazer poté concludere che il<br />
substrato culturale delle popolazioni europee era senz’altro da considerarsi come primitivo:<br />
“Visti sotto quest’ottica, i riti tradizionali della primavera e della mietitura nelle nostre<br />
campagne europee meritano di essere classificati come primitivi” 236 .<br />
Lo spazio mitico trova dunque una propria precisa collocazione nel momento <strong>in</strong> cui si collega<br />
direttamente al tempo mitico. Lo spazio <strong>def</strong><strong>in</strong>ito dunque “come rete o <strong>in</strong>sieme dei luoghi della<br />
memoria, di luoghi e paesaggi simbolici del tempo e dello spazio” 237 è parte della mitologia<br />
occidentale. Al suo <strong>in</strong>terno ogni elemento diviene simbolico e funzionale alla<br />
rappresentazione artistica. Tale rappresentazione sarà senz’altro metaforica proprio per quella<br />
difficoltà di <strong>def</strong><strong>in</strong>ire precisamente, attra<strong>vers</strong>o il vocabolario della modernità, una dimensione<br />
atemporale. Il disegno di uno spazio mitico rappresentò un punto fondamentale nel pensiero<br />
di Pavese che si cimentò spesso col problema associandolo, il più delle volte, a quello del<br />
tempo mitico. Spazio e tempo devono sfuggire alla convulsa relatività dei tempi moderni per<br />
cercare una propria assolutezza, un proprio significato simbolico: “Come del tempo, così<br />
dello spazio. Poesia e Pittura. Non deve esistere, <strong>in</strong> una poesia, tempo empirico così come <strong>in</strong><br />
un quadro non deve esistere spazio empirico” 238 . Lo spazio trova il suo significato solo <strong>in</strong><br />
quanto simbolo rifiutando di esistere <strong>in</strong> una dimensione esclusivamente empirica. La distanza<br />
dalla realtà delle cose, che prevede uno spazio antropizzato, è però notevole. Ma <strong>in</strong> questo<br />
frangente si scopre la possibilità della scrittura artistica che deve lavorare per la costruzione, o<br />
il r<strong>in</strong>venimento, di uno spazio assoluto, mitico, altro rispetto allo spazio empirico del mondo<br />
moderno: “Creare un’opera è dunque trasformare <strong>in</strong> assoluti il suo tempo e il suo spazio” 239 .<br />
Lo spazio diviene dunque il luogo fuori dal tempo empirico, un luogo <strong>in</strong> cui si può svolgere<br />
una vicenda romanzesca che si situi <strong>in</strong> una dimensione temporale di mezzo, tra quella del<br />
tempo empirico e quella del tempo assoluto. Il romanzo modernista si situa su questo conf<strong>in</strong>e<br />
tra spazio assoluto e spazio mitico, tra tempo assoluto e tempo mitico. L’empiria del mondo<br />
moderno piuttosto che essere rifiutata è messa a confronto con la dimensione del tempo e<br />
dello spazio assoluto creando un conflitto che si combatte sul terreno del mito. Moretti<br />
<strong>in</strong>dividua nella capacità del romanzo di porsi al conf<strong>in</strong>e fra le due dimensioni spaziotemporali<br />
un tratto caratteristico del romanzo moderno:<br />
Il nostro mondo dis<strong>in</strong>cantato non contiene dei ben dist<strong>in</strong>ti reami morali, ma solo una geografia, e nulla più. E<br />
proprio qui, sul cr<strong>in</strong>ale fra le due culture, il romanzo ha giocato e v<strong>in</strong>to la sua partita più ambiziosa: fare da ponte<br />
tra il vecchio e il nuovo, str<strong>in</strong>gendo un compromesso geniale tra il mondo un po’ troppo freddo della conoscenza<br />
moderna e la topografia <strong>in</strong>cantata della favola di magia 240 .<br />
Lontano dall’essere un compromesso armonico, l’<strong>in</strong>contro fra le due dimensioni, quella<br />
empirica e quella mitica, sfocia il più delle volte, <strong>in</strong> tragedia. Ma la presenza di luoghi<br />
geografici “fuori dal tempo” è classico di certa produzione modernista ed è estremamente<br />
funzionale allo sviluppo della sua poetica. L’ambientazione di molti romanzi modernisti <strong>in</strong><br />
questi spazi, <strong>def</strong><strong>in</strong>iti da Braudel come luoghi “la cui storia sta nel non avere una storia, nel<br />
restare ai marg<strong>in</strong>i delle grandi correnti civilizzatrici”, permette allo scrittore di muo<strong>vers</strong>i <strong>in</strong><br />
una dimensione alternativa a quella del reale che diviene, <strong>in</strong>direttamente, oggetto di<br />
236<br />
James G. Frazer, Il Ramo d’oro, Newton Compton Editori, Roma, 1992, pp. 466-67.<br />
237<br />
E. Turri, Lo spazio europeo: alla ricerca di una geografia mitica, cit. p. 35.<br />
238<br />
C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, 26 Febbraio 1940, cit. p. 178.<br />
239<br />
Ibidem.<br />
240<br />
F. Moretti, Atlante del Romanzo Europeo, cit. p. 76.<br />
76
osservazione critica 241 . La presenza, nei romanzi modernisti, di luoghi marg<strong>in</strong>ali, <strong>in</strong>scritti <strong>in</strong><br />
una dimensione spazio-temporale autonoma, stabilisce la possibilità, per l’autore, di portare<br />
avanti un confronto, una vera ricerca basata, il più delle volte, su un personaggio “civile” che<br />
si trova a proiettare se stesso, e qu<strong>in</strong>di il suo mondo, <strong>in</strong> uno spazio lontano e di<strong>vers</strong>o. E’ un<br />
luogo mitico che proprio <strong>in</strong> quanto fuori dalla civiltà e dalla sua storia empirica è depositario<br />
di una sapienza antica e feconda che si contrappone a quella razionale della società moderna.<br />
Per Jurij Lotman i luoghi ai marg<strong>in</strong>i della storia, i luoghi che vivono la storia come riflesso di<br />
ciò che accade nei centri pr<strong>in</strong>cipali, sopperiscono a questa carenza semiotica tramite il<br />
potenziamento delle componenti mitologiche. Il vuoto semiotico, a cui le civiltà rurali erano<br />
state condannate dal progresso civile, che aveva privilegiato lo sviluppo delle città, sarebbe<br />
stato dunque colmato dalla antica sapienza del luogo tanto che si può assistere al fenomeno<br />
per il quale “l’assenza di storia ha portato ad una crescita impetuosa della mitologia” 242 . La<br />
presenza nel romanzo modernista di spazi, <strong>in</strong> cui le categorie spazio-temporali sono poste<br />
nuovamente <strong>in</strong> gioco, dà vita ad un bipolarismo che <strong>in</strong>veste gli stessi personaggi.<br />
Il sistema bipolare sembra assurgere a schema privilegiato nella narrativa modernista. Lo<br />
spazio assoluto mitico si oppone a quello relativo empirico così come avvenuto per il tempo e<br />
così come avverrà per i personaggi. Questa struttura bi-polare, che riveste una fondamentale<br />
importanza nella teoria della composizione dei modernisti, è spiegata da Moretti <strong>in</strong> relazione<br />
alla risonanza europea della Morfologia della Fiaba di Vladimir Propp <strong>def</strong><strong>in</strong>ita dal critico<br />
come “l’opera chiave della narrativa moderna”. Moretti <strong>in</strong>siste “sull’esistenza di due campi<br />
av<strong>vers</strong>i (il mondo <strong>in</strong>iziale e l’altro reame), dalla cui opposizione scaturiscono tutti gli eventi<br />
fondamentali del racconto. Ora, nel corso del Novecento, lo schema di Propp è stato criticato<br />
e modificato più d’una volta: la sua natura bipolare, però, non è stata mai messa <strong>in</strong><br />
discussione” 243 . Cesare Pavese, che era lettore di Propp, sembra rientrare <strong>in</strong> questa categoria.<br />
La conoscenza di uno spazio straniero sembra attra<strong>vers</strong>are, <strong>in</strong> molti romanzi modernisti,<br />
l’<strong>in</strong>tera evoluzione culturale degli ultimi secoli riguardante il rapporto dell’uomo con la<br />
natura 244 . La conoscenza <strong>in</strong>iziale si <strong>in</strong>augura con la curiosità per il pittoresco e lo spirito di<br />
esplorazione. L’esempio del Serpente Piumato è emblematico. Lawrence ambienta la<br />
narrazione <strong>in</strong> uno spazio ibrido. Lo spazio della corrida, i peones vestiti all’occidentale, sono<br />
elementi di uno spazio di conf<strong>in</strong>e pittoresco. Tutto è una scimmiottatura del mondo<br />
occidentale ma, proprio attra<strong>vers</strong>o il grottesco, si rivela l’esistenza di un mistero. Kate, dopo<br />
aver disdegnato la barbara rappresentazione, rimarrà affasc<strong>in</strong>ata dal mistero di quei luoghi che<br />
si esprime attra<strong>vers</strong>o la descrizione di paesaggi <strong>in</strong>quietanti ma, al contempo, affasc<strong>in</strong>anti.<br />
Insomma il paesaggio da grottesco si trasforma presto <strong>in</strong> immag<strong>in</strong>e misteriosa o addirittura<br />
orrorifica, che rievoca <strong>in</strong> parte il sublime romantico. La terza fase è quella propria del<br />
riconoscimento. Quel mondo, reputato così di<strong>vers</strong>o e così lontano, si scopre <strong>in</strong>vece prossimo<br />
ed affasc<strong>in</strong>ante. Pavese e Lawrence, assecondando spesso questo schema tripartito, si<br />
differenziano molto per l’esito delle loro narrazioni, spesso tragiche per il primo, spesso<br />
utopiche per il secondo. Il punto comune sembra però questo: ciò che <strong>in</strong> un primo momento<br />
appare strutturarsi come conoscenza di un mondo, si rivela essere un riconoscimento, che si<br />
attua gradualmente, di quello stesso mondo. E’ un riconoscimento che avviene proprio <strong>in</strong> base<br />
alle leggi della cultura e che trova nella teoria della cognizione di Vico un’ottima<br />
formulazione. Per Turri i legami dell’uomo con il territorio sono <strong>in</strong>controvertibili:<br />
241 Ivi, p. 37.<br />
242 Jurij Lotman, La Semiosfera, Marsilio Editore, 1985, p. 232.<br />
243 F.Moretti, Atlante del Romanzo Europeo, cit. p.113.<br />
244 Nel Settecento all’epoca dell’esplorazione il luogo sconosciuto era uno spazio da colonizzare, da annettere<br />
alla sfera della cultura occidentale, ma era anche l’immag<strong>in</strong>e dell’idea che l’uomo aveva di stesso nel suo stadio<br />
di perfezione morale e sociale: uno spazio <strong>in</strong>contam<strong>in</strong>ato, puro, <strong>in</strong>nocente, <strong>in</strong> cui le persone vivevano <strong>in</strong> armonia<br />
fra loro e con la natura. Il Romanticismo ricom<strong>in</strong>ciò a guardare gli spazi naturali con gusto del sublime, una sorta<br />
di suggestione mistica che doveva lasciare presto il posto alle problematiche moderniste che, elaborando le<br />
ricerche effettuate nel campo dell’antropologia, postularono il legame essenzialmente tragico che lega l’uomo<br />
alla natura.<br />
77
Ogni cultura elegge i propri topos, privilegia e celebra dei paesaggi che le sono congeniali, espressivi del<br />
momento storico che essa rappresenta. Ma ogni cultura ha legami genetici che attra<strong>vers</strong>ano la storia e qu<strong>in</strong>di è<br />
<strong>in</strong>dotta a non dimenticare i simboli e i miti delle epoche passate, tanto più quando sono impiantati sul suolo, cioè<br />
nel territorio 245 .<br />
La terra ha dunque una sapienza mitica che il personaggio dei romanzi modernisti sembra<br />
condannato a dover riconoscere. La riflessione di Lawrence sul mito rivestì una decisiva<br />
importanza nell’ambito della poetica dell’autore. Nella sua produzione non ci sono esempi di<br />
lavori che richiamano direttamente l’uni<strong>vers</strong>o mitico greco, come nell’esempio dei Dialoghi<br />
con Leucò di Cesare Pavese, o biblico, come nell’esempio di The Waste Land di Eliot. Eppure<br />
tutta l’opera di Lawrence risente di una preventiva riflessione sulle categorie mitiche. L’opera<br />
che più di tutte le altre viene associata al mito è senz’altro Il Serpente Piumato. Il romanzo,<br />
ambientato nel Messico di <strong>in</strong>izio secolo, fa riferimento esplicito alla mitologia locale che si<br />
basa sul mito del dio Quetzalcoatl. La protagonista del romanzo, l’irlandese Kate, è colei la<br />
quale si trova a confrontarsi con le potenze oscure della terra e con l’<strong>in</strong>esplicabile mistero del<br />
mito di Quetzalcoatl. Lo schema base del romanzo è quello che si può oramai riconoscere<br />
classico <strong>in</strong> una certa produzione modernista. Un personaggio proveniente dalla cosiddetta<br />
“civiltà” parte alla ricerca di avventure esotiche e f<strong>in</strong>isce con il porsi alla ricerca di se stesso.<br />
Il contatto con l’altro, il di<strong>vers</strong>o, il lontano, si sviluppa nella consueta maniera. Si passa da<br />
un’<strong>in</strong>iziale scontro di culture, <strong>in</strong> cui la superiorità della cultura civile occidentale è rivendicata<br />
come superiore ad un f<strong>in</strong>ale ripensamento di tutte le categorie che avevano portato a questi<br />
aprioristici assunti. Gli autoctoni vengono guardati dall’alto al basso, scherniti, sono oggetto<br />
di disprezzo <strong>in</strong> quanto <strong>in</strong>capaci di assimilare completamente il dono della civiltà che<br />
l’occidente porta loro. Nella scena della corrida, <strong>in</strong> cui la vista del sangue risveglia gli ist<strong>in</strong>ti<br />
repressi degli autoctoni, gli occhi di Kate si riempiono di disprezzo per uno spettacolo<br />
grottesco, <strong>in</strong> cui la natura contam<strong>in</strong>ata, meticcia, di quella popolazione viene a galla <strong>in</strong> modo<br />
quasi ridicolo:<br />
In gran parte, erano uom<strong>in</strong>i di aspetto rozzo vestiti con abiti di città, meticci di una terra meticcia. Due di loro<br />
or<strong>in</strong>avano contro il muro, riprendendosi per un momento dall’eccitazione che li prendeva. […] Almeno per quei<br />
bamb<strong>in</strong>i le corride non sembravano spettacoli naturali; ma a poco a poco ne avrebbero recuperato il piacere.<br />
C’erano altri bamb<strong>in</strong>i tuttavia e grasse madri <strong>in</strong> raso nero, divenuto unto e grigio alla scollatura per la troppa<br />
cipria. Avevano uno sguardo esaltato e compiaciuto, quasi sessuale, spregevolmente <strong>in</strong> contrasto con i loro molli<br />
corpi passivi. […] Kate era spaventata da questa sordidezza. Aveva visto tante cose al mondo, ma lì, a Città del<br />
Messico, persisteva una <strong>def</strong>ormità sotterranea, una sorta di squallida malvagità tutta particolare. Era <strong>in</strong>timidita da<br />
qualcosa che potesse toccarla <strong>in</strong> una città del genere, e potesse contagiarla con la sua crudeltà da rettile. E sapeva<br />
anche che cera ben poco da fare, se non conservare il proprio sangue freddo 246 .<br />
Di lì a poco, nel processo di maturazione della protagonista, si avvertirà un deciso<br />
cambiamento nel metodo di giudizio. La repulsione che <strong>in</strong>izialmente i peones suscitavano <strong>in</strong><br />
Kate viene gradualmente sostituita dalla curiosità, dall’<strong>in</strong>teresse, dal riconoscimento<br />
dell’esistenza di un vero segreto nascosto nell’anima degli autoctoni. La contemplazione di<br />
questo mistero è anche la contemplazione di un abisso (abisso niciano): “Tutto mi str<strong>in</strong>ge il<br />
cuore. Gli occhi degli uom<strong>in</strong>i dai grandi capelli, - i peones voglio dire. Occhi senza centro,<br />
senza un vero io. C’è come un tempestoso abisso nero, al centro, il vortice di un<br />
maelstrom” 247 .<br />
245 E.Turri, Lo spazio europeo: alla ricerca di una geografia mitica, cit. p. 41.<br />
246 D. H. Lawrence, Il serpente piumato, Roma, Newton Compton Editore, 1995, pp. 30-31.<br />
247 Ivi, p. 46.<br />
78
Nelle parole di Kate si notano tutti gli elementi basilari della strategia del romanzo modernista.<br />
La percezione della distanza fra il mondo civilizzato e quello degli autoctoni, il senso di<br />
disprezzo e di orrore <strong>vers</strong>o un mondo che viene giudicato dall’alto <strong>in</strong> basso ma che suscita<br />
un’<strong>in</strong>discutibile attrazione nel personaggio, la sensazione, già al primo capitolo del romanzo,<br />
di essere entrati nel campo d’attrazione che risucchierà il personaggio. La tragedia si compirà e<br />
non ci sarà alcuna possibilità, o volontà, di evitarla. Il personaggio viene attirato nel gioco<br />
mitico e non ne può uscire che sconfitto. La tragedia per Kate è quella di trovarsi di fronte alla<br />
percezione del proprio essere smarrito, di poterlo riconoscere, ist<strong>in</strong>tivamente, ma di non<br />
poterlo accettare razionalmente. Ma il male oramai è presente nell’animo di Kate. E’ un male<br />
che non si può dire sia stato contratto, lì nel Messico, quanto risvegliato. Il germe, presente<br />
nell’animo del personaggio, viene riportato a vita e il suo scavare l’organismo è oramai un<br />
processo <strong>in</strong>evitabile. Un processo il cui risultato sembra scontato, la condanna già scritta: “[…]<br />
sentiva entrare il Messico dentro di sé come una condanna. Qualcosa di opprimente come le<br />
spire di un enorme serpente <strong>in</strong>capace di sollevarsi.[…] Non riusciva a cancellare dalla mente la<br />
visione dell’arena, le sembrava di avere una ferita, dentro” 248 . Kate associa ist<strong>in</strong>tivamente gli<br />
eventi che accadono <strong>in</strong> quel luogo lontano, nello spazio e nel tempo, a quello che sta<br />
accadendo nel suo animo. La lontananza si colma improvvisamente ma la prossimità è ora<br />
tragica. Kate torna ad avere un rapporto diretto con il mondo che la circonda ma è un rapporto<br />
malsano viziato da anni, forse secoli, di menzogne. La forza dell’immag<strong>in</strong>e di un mondo<br />
straniero, così lontano e al contempo così vic<strong>in</strong>o, entra nella coscienza della protagonista e<br />
riapre un’antica ferita, rimuove una cicatrice di cui si era dimenticata l’esistenza. Nella<br />
costruzione dell’immag<strong>in</strong>e che deve provocare il turbamento, Lawrence ricorre a parametri<br />
classici della composizione modernista, parametri che ricordano quelli utilizzati da Conrad <strong>in</strong><br />
Cuore di tenebra quando Kurtz, di fronte allo spettacolo agghiacciante delle proprie orig<strong>in</strong>i,<br />
non riesce ad esprimere le sue sensazioni se non attra<strong>vers</strong>o la ripetizione di una sola parola:<br />
l’orrore:<br />
Non riuscì a chiudere occhio per tutta la notte. Rimase ad ascoltare i rumori di Città del Messico, e ancora i<br />
silenzi orrendi, e quell’<strong>in</strong>s<strong>in</strong>uante paura che striscia al fondo oscuro delle notti messicane. Dentro di sé avvertiva<br />
un sordo rancore per Città del Messico. E timore. Di giorno, la città aveva un suo fasc<strong>in</strong>o – ma di notte tutto<br />
emergeva <strong>in</strong> superficie, quanto possedeva di sotterraneo, di sordido, di malevolo 249 .<br />
Il paesaggio, così come accade nella foresta <strong>in</strong>esplorata di Conrad, sembra assurgere a parte<br />
<strong>in</strong>tegrante della rappresentazione modernista. Il paesaggio è l’espressione della natura che si<br />
riflette nell’animo dei peones. Anche il paesaggio naturale, ben lontano dall’essere l’idillica<br />
campagna arcadica <strong>in</strong> cui i romantici immag<strong>in</strong>avano agire un uomo <strong>in</strong>corrotto e puro, diviene<br />
espressione di questo orrore che si scava spazio nell’animo dell’uomo civile. L’orrore che<br />
nasce dal ricordo delle proprie sangu<strong>in</strong>arie orig<strong>in</strong>i: “In lontananza, pesanti, le due montagne<br />
<strong>in</strong>nevate sembrava emettessero un profondo suono, troppo profondo, nel suo mormorio,<br />
perché orecchio umano lo udisse, eppure tale da venir ascoltato dal sangue: un suono di<br />
terrore” 250 . Il paesaggio diviene parte <strong>in</strong>tegrante della rappresentazione modernista. La natura<br />
si proietta m<strong>in</strong>acciosa sull’animo degli esseri umani, li soggioga, ne diviene essa stessa parte.<br />
Il mistero che i paesaggi naturali suggeriscono alla protagonista è la proiezione dell’orrore che<br />
oramai alberga nella sua anima. L’uomo r<strong>in</strong>viene le tracce, che sembravano svanite nel<br />
tempo, di un legame ancestrale, ma il nuovo rapporto, la possibilità di un nuovo rapporto, è<br />
presago di morte: “Inutilmente Kate si chiedeva perché era venuta lì. Dall’Inghilterra,<br />
dall’Irlanda, dalla sua Europa, aveva avvertito il consummatum est del suo spirito consumato<br />
248 Ivi ,pp. 33-35.<br />
249 Ivi, p. 37.<br />
250 Ivi, p. 53.<br />
79
<strong>in</strong> una letale agonia. Tuttavia questo pesante luogo dell’anima presaga di morte era per lei<br />
molto più di quanto fosse <strong>in</strong> grado di sopportare” 251 . Nell’ambito della descrizione di questo<br />
paesaggio che si carica, come tutta la narrazione del romanzo, di simboli, anche la notte<br />
assume una valenza differente. Quasi a voler richiamare l’antica mitologia greca che<br />
assegnava ad Apollo il giorno, come regno della ragione, e a Dioniso la notte, come regno<br />
dell’irrazionale. Nell’ambito della descrizione di un paesaggio <strong>in</strong>quietante, orrorifico,<br />
portatore del ricordo e della m<strong>in</strong>accia di morte, giorno e notte assumono proprie connotazioni<br />
simboliche e si vestono di nuovi profondi significati. Il regno della ragione, <strong>in</strong> un luogo così<br />
lontano dalla civilizzata Europa, sembra m<strong>in</strong>acciato di cont<strong>in</strong>uo dagli umori sotterranei della<br />
terra. L’immag<strong>in</strong>e di un sole velato descritto da Lawrence sembra esprimere al meglio questa<br />
sensazione portatrice di un presentimento di morte: “La splendente luce del sole era come<br />
velata da un’oscura coltre di sangue rabbioso di impotenza e gli stessi fiori sembrava che<br />
fossero nutriti di sangue alle radici. Uno spirito crudele era lì a reprimere, distruggere, quel<br />
luogo” 252 . Ma è la notte il momento <strong>in</strong> cui, <strong>in</strong>sieme alle tenebre, i misteri di quella terra<br />
lontana si rendono manifesti. E’ una notte profonda che rivela la presenza di una m<strong>in</strong>accia<br />
<strong>in</strong>combente:<br />
Si mossero <strong>vers</strong>o il lontano sobborgo, <strong>in</strong> tram, che passò veloce nel mezzo della notte tra un luccichio<br />
m<strong>in</strong>accioso delle grandi stelle chiare, remote al fondo del cielo. Tlalpam promanava un pesante profumo di fiori<br />
notturni. Tutt’<strong>in</strong>torno, un senso di pesante oscurità, sc<strong>in</strong>tillio di lucciole <strong>in</strong>termittente. E ancora, il greve<br />
richiamo d’odore dei fiori notturni. Kate percepiva come un soffio di sangue nel profumo dei fiori tropicali; e<br />
anche di sudore. La notte era calda 253 .<br />
Il valore simbolico del paesaggio si lega all’immag<strong>in</strong>e che la protagonista ne ha nei vari<br />
momenti della giornata. Anche la scansione temporale della giornata, tempo naturale, viene a<br />
far parte, nel suo simbolismo, del grande affresco mitologico disegnato da Lawrence. La<br />
stessa rappresentazione simbolica del paesaggio si aveva nelle opere di Nietzsche e rimane un<br />
corollario per molti dei romanzi modernisti. L’ora del crepuscolo, il passaggio sfumato tra il<br />
giorno e la notte, si ammanta di un particolare significato. E’ il momento <strong>in</strong> cui il giorno<br />
matura, è il momento del trapasso. In un dialogo tra Cipriano e Kate la forza misterica del<br />
paesaggio messicano assume proporzioni più precise:<br />
“Che strana oscurità c’è nel Messico!”, esclamò lei.<br />
“Vi piace?, egli chiese.<br />
“Molto. Ma ancora di più mi piace l’ora <strong>in</strong> cui il giorno tramonta e la notte si fa strada come qualcuno che<br />
camm<strong>in</strong>a. Ci si sente più liberi <strong>in</strong> quel momento, non vi pare? Proprio come quei fiori che esalano il loro<br />
profumo di notte, mentre nel giorno contemplano il sole senza odore”.<br />
“Forse ho paura della notte qui”, affermò Kate ridendo.<br />
“Si? Perché no? Anche l’odore dei fiori, la notte, dà un po’ di paura, eppure è una paura buona, gradevole, non vi<br />
sembra?” 254 .<br />
Il tempo, nella scrittura di Lawrence, si lega dunque al paesaggio e al suo mito. Kate,<br />
provenendo dalla città, scopre una differente modalità di correlarsi al passare del tempo <strong>in</strong><br />
quella terra. E’ quasi una riappropriazione mistica di una categoria, quella del tempo, che<br />
nella civiltà moderna viene ad essere sepolta per essere poi assoggettata alla necessità degli<br />
uom<strong>in</strong>i che la sezionano e la riorganizzano a secondo delle esigenze della macch<strong>in</strong>a produttiva.<br />
251 Ivi, p. 54.<br />
252 Ivi, p. 53.<br />
253 Ivi, p. 62.<br />
254 Ivi, p. 68.<br />
80
Kate trova, <strong>in</strong> questo uni<strong>vers</strong>o mitico, una nuova unità. Un’unità con tutti gli elementi della<br />
terra che nella società civile le era stata preclusa: “Terra, acqua aria convivevano sotto il<br />
silenzio della luce nuova del giorno […] 255 . E’ una nuova unità <strong>in</strong> cui il tempo perde il suo<br />
valore, il suo ruolo <strong>in</strong>dipendente di metronomo dell’esistenza umana, per ritirarsi nel seno del<br />
tutto. Ma è unità ritrovata che promette vendetta : “Persisteva una condanna sotto quel cielo<br />
tanto limpido: condanna e orrore” 256 . Il ritrovare l’unità all’<strong>in</strong>terno dell’uni<strong>vers</strong>o mitico <strong>in</strong> cui<br />
Lawrence ambienta il suo romanzo non può che costituire un preludio alla tragedia imm<strong>in</strong>ente.<br />
Tragedia a cui Kate è dest<strong>in</strong>ata. L’ambientazione del romanzo, l’utilizzo che Lawrence ha dei<br />
paesaggi e del tempo, lo stesso ruolo ad ognuno dei personaggi assegnato, possono far parlare<br />
di una storia calata <strong>in</strong> un tempo mitico fuori dalla portata dei costrutti occidentali a cui è <strong>in</strong>vece<br />
assegnato il ruolo di antagonisti. Per Walter Mauro, nella prefazione all’edizione italiana del<br />
libro, il paesaggio svolge una funzione essenziale nel romanzo 257 così come essenziale è la<br />
scelta della terra di conf<strong>in</strong>e del Messico “[…] primordiale e sprovveduto, una terra verg<strong>in</strong>e <strong>in</strong><br />
cui l’ondata dell’<strong>in</strong>telligenza, delle umane sorti e progressive, non ha com<strong>in</strong>ciato ad operare<br />
sulla verg<strong>in</strong>e <strong>in</strong>nocenza di comunità umane ancora fortemente ancorate alle tradizioni, ai riti ai<br />
miti degli avi lontani” 258 . La descrizione del paesaggio è dunque solo apparentemente una<br />
derivazione della vecchia scuola vittoriana che con tali descrizioni impegnava buona parte<br />
della narrazione nei romanzi di prov<strong>in</strong>cia. Il paesaggio diviene vivo e torna a far parte della<br />
narrazione al pari di un personaggio. Il paesaggio naturale e il tempo ciclico delle stagioni<br />
divengono, nella narrazione di Sons and Lo<strong>vers</strong>, parte <strong>in</strong>tegrante del romanzo e ne scandiscono<br />
ambientazione e ritmo. Le pulsioni di Paul sembrano guidate da una forza esterna, quella del<br />
sangue, e sembrano conciliarsi con le leggi della natura. Le motivazioni ragionevoli, che Paul<br />
cerca e trova di volta <strong>in</strong> volta per legittimare le proprie azioni e i propri sentimenti, appaiono<br />
come giustificazioni razionali a pulsioni ist<strong>in</strong>tive. La vita di Paul, come quella degli altri<br />
protagonisti, sembra regolata da forze ben più grandi che non quelle razionali. Una di queste<br />
forze è senz’altro la natura. Queste forze, che Paul all’<strong>in</strong>izio percepisce ma non riesce ad<br />
identificare, si configurano più precisamente nella parte f<strong>in</strong>ale del libro dove, razionalizzate,<br />
assumono la forma del mito. L’esperienza mitica che i due giovani vivono si staglia sullo<br />
sfondo di una natura onnipresente che espleta, a sua volta, un ruolo mitico. Le vicende dei<br />
protagonisti si svolgono, <strong>in</strong> predom<strong>in</strong>anza, di fronte al paesaggio naturale che ha un ruolo<br />
attivo nello svolgersi della vicenda. La costante presenza dell’elemento naturale sembra aver la<br />
funzione di testimoniare, di fronte ai personaggi, l’esistenza di una legge superiore e<br />
<strong>in</strong>eluttabile. Le leggi della natura sono differenti da quelle dell’uomo moderno e questo scarto<br />
sembra approfondito da Lawrence attra<strong>vers</strong>o la sua tecnica narrativa. Se per descrivere le<br />
azioni dei personaggi lo scrittore adotterà una tecnica espressionista tutta dedita a mettere <strong>in</strong><br />
luce i sentimenti più profondi, nella descrizione dei paesaggi adotterà una tecnica<br />
impressionista tesa a svelare l’impassibilità, ma al contempo l’implacabilità, della natura. Il<br />
rapporto che stabilisce Lawrence fra la natura e i suoi personaggi è <strong>in</strong>tenso. La natura,<br />
<strong>in</strong>izialmente <strong>in</strong>tesa come luogo idillico e ideale, rivela spesso, attra<strong>vers</strong>o segnali quasi<br />
impercettibili, il suo vero volto tragico. I simboli naturali, che si svolgono di fronte agli occhi<br />
dei due amanti, subiscono, di volta <strong>in</strong> volta, repent<strong>in</strong>e trasformazioni <strong>in</strong> simboli di morte. Il<br />
passaggio dalla concezione romantica della natura a quella modernista è <strong>in</strong> questo contesto<br />
pienamente visibile:<br />
He looked across at every tree-foot. At last he found what he wanted. Two beech trees side by side on the hill held<br />
a little level on the upper face between their roots. It was littered with damp leaves, but it would do. The<br />
fisherman were perhaps sufficiently out of sight. He threw down his ra<strong>in</strong>proof and waved to her to come. She<br />
255 Ivi, p. 86.<br />
256 Ivi, p. 95.<br />
257 W. Mauro sottol<strong>in</strong>ea “[…] la concentrazione sul mito del paesaggio, sulla fasc<strong>in</strong>azione di una natura densa di<br />
segnali carichi di religiosità laica, oltre che di culto […]”. Ivi, p. 10.<br />
258 Ivi, p. 11.<br />
81
toiled to his side. Arriv<strong>in</strong>g there, she looked at him heavily, dumbly, and laid her head on his shoulder. He held<br />
her fast as he looked round. They were safe enough from all but the small, lonely cows over the river. He sunk his<br />
mouth on her throat, where he felt her heavy pulse beat under his lips. Everyth<strong>in</strong>g was perfectly still. There was<br />
noth<strong>in</strong> g <strong>in</strong> the afternoon but themselves. When she arose, he, look<strong>in</strong>g on the ground all the time, saw suddenly<br />
spr<strong>in</strong>kled on the back wet beech-roots many scarlet carnation petals, like splashed drops of blood; and red, small<br />
splashes fell from her bosom, stream<strong>in</strong>g down her dress to her feet 259 .<br />
L’importanza dello spazio geografico nella composizione dei romanzi moderni ha portato<br />
Lotman ad associarlo alle sue teorie relative ai campi semiotici. In epoca moderna si assiste<br />
alla vera e propria rappresentazione geografica degli spazi culturali. Il concetto di semiosfera,<br />
espresso da Lotman, si riferisce alla capacità e alla possibilità di uno spazio circoscritto di<br />
essere portatore di significati di<strong>vers</strong>i, a volte opposti, allo spazio che è a esso limitrofo. Di<br />
particolare <strong>in</strong>teresse al f<strong>in</strong>e della nostra ricerca sono i punti di contatto, quelli che, utilizzando<br />
ancora una metafora geografica, Lotman chiama “conf<strong>in</strong>i” <strong>def</strong><strong>in</strong>iti come “l’<strong>in</strong>sieme dei punti<br />
che appartengono nello stesso tempo allo spazio <strong>in</strong>terno e a quello esterno” 260 . Vi è allora un<br />
luogo del significato ibrido dove i discorsi culturali si <strong>in</strong>trecciano. Il concetto di spazio,<br />
espresso <strong>in</strong> questa prima fase della riflessione, è ampio. Ingloba anche gli spazi culturali e si<br />
serve della geografia come serbatoio di metafore atte a spiegare i concetti espressi. Lotman,<br />
tuttavia, analizza di seguito espressamente il caso <strong>in</strong> cui gli stessi scrittori, per esprimere<br />
questo scontro-<strong>in</strong>contro di culture, si rifanno a metafore spaziali <strong>in</strong>trecciandole al tessuto della<br />
narrazione. In questo caso l’ord<strong>in</strong>e spaziale diviene fondante dell’opera narrativa e al<br />
contempo estremamente simbolico:<br />
Nei casi <strong>in</strong> cui lo spazio culturale acquista carattere territoriale, il conf<strong>in</strong>e assume un senso spaziale nel<br />
significato elementare. Così, ad esempio, quando la semiosfera si identifica con uno spazio culturale e il mondo<br />
esterno col dom<strong>in</strong>io di elementi caotici e disord<strong>in</strong>ati, la distribuzione spaziale delle formazioni semiotiche<br />
assume <strong>in</strong> molti casi questa forma. Persone che, grazie a doti particolari (come lo stregone) e al tipo di lavoro<br />
che svolgono (come il fabbro, il mugnaio, il boia) appartengono a due mondi e appaiono come traduttori, si<br />
stabiliscono nella periferia territoriale, al conf<strong>in</strong>e fra il mondo culturale e quello mitologico. Il tempio delle<br />
div<strong>in</strong>ità culturali che organizzano il mondo si dispone <strong>in</strong>vece al centro. Si può vedere ad esempio nella cultura<br />
del XIX secolo l’opposizione fra il centro della città, che rappresenta la struttura sociale dom<strong>in</strong>ante, e l’elemento<br />
distruttivo della zona periferica 261 .<br />
L’analisi della semiosfera da parte di Lotman mette <strong>in</strong> risalto come lo spazio abbia un significato e rappresenti<br />
una parte importante di tutto il progetto narrativo. Nell’epoca moderna questo significato diviene ancora più<br />
evidente nel momento <strong>in</strong> cui si disegna una netta divisione tra le aree urbanizzate, detentrici delle regole della<br />
civiltà, e le aree rurali per quanto riguarda l’Europa, selvagge per quanto riguarda il resto del mondo, che si<br />
pongono agli antipodi delle prime aiutandole a potersi <strong>def</strong><strong>in</strong>ire <strong>in</strong> base alle differenze. I conf<strong>in</strong>i, come constata<br />
Lotman, non sono però marcati. Sono, al contrario, entità mobili, <strong>in</strong>stabili, e abbastanza ampie. Molti scrittori<br />
modernisti ambienteranno i loro romanzi <strong>in</strong> queste aree di conf<strong>in</strong>e altri, come Conrad, varcheranno il conf<strong>in</strong>e per<br />
proiettarsi direttamente <strong>in</strong> territori sconosciuti e <strong>in</strong>traducibili, non significanti <strong>in</strong> quanto non conf<strong>in</strong>anti con la<br />
semiosfera europea.<br />
259 D. H. Lawrence, Sons and Lo<strong>vers</strong>,cit. pp. 378-379.<br />
260 J. M. Lotman, La Semiosfera, cit. p. 58.<br />
261 Ivi, p. 61.<br />
82
3 TEMI MODERNISTI IN PAVESE: IL VIAGGIO E L’INCONTRO CON L’ALTRO<br />
3.1 Il viaggio come momento topico della letteratura modernista<br />
E se vai per le strade, sai che la terra è tutta<br />
piena di div<strong>in</strong>o e di terribile. Se ti parlo è<br />
perché, come viandanti e sconosciuti,<br />
anche noi siamo un poco div<strong>in</strong>i. (Cesare<br />
Pavese, Dialoghi con Leucò).<br />
Non si tratta <strong>in</strong>fatti di affrontare una nuova<br />
strada, ma di liberare l’antica, custodendo<br />
con la massima cura le orme che ancora vi<br />
si trovassero impresse. (Umberto<br />
Galimberti, Heidegger, Jaspers e il<br />
Tramonto dell’Occidente).<br />
All’<strong>in</strong>terno del grande spazio significante i personaggi dei romanzi modernisti si muovono<br />
passando da una semiosfera all’altra, ancor più spesso, esplorando le terre di conf<strong>in</strong>e. E’ un<br />
movimento che implica possibilità conoscitive ulteriori e che rende il personaggio una sonda<br />
mobile studiata per l’esplorazione. Lo stesso romanzo moderno, <strong>def</strong><strong>in</strong>ito da Kundera come<br />
un’esplorazione dell’esistenza, si struttura nella forma narrativa del viaggio. Vi è un rapporto<br />
<strong>in</strong>somma fra il camm<strong>in</strong>are e lo scrivere 262 . Nell’ambito dello spazio assoluto, <strong>in</strong> cui si<br />
riconosce un nuovo ord<strong>in</strong>e significante, la scrittura dei modernisti si imbatte spesso <strong>in</strong> due<br />
topoi letterari che, come lo spazio, tendono a divenire degli assoluti, dei simboli. Il topos del<br />
viaggio è alla base del concetto stesso di narrazione e si collega direttamente al concetto di<br />
mito.<br />
Per A. Reim Natale non solo “la metafora del viaggio è all’orig<strong>in</strong>e di tutto il narrare” 263 , ma<br />
anche le storie che non parlano esplicitamente di viaggi hanno la possibilità di essere<br />
strutturate su questo modello. Il viaggio, come la scrittura, non si <strong>in</strong>traprende per scoprire<br />
qualcosa di nuovo ma si <strong>in</strong>traprende per r<strong>in</strong>venire le tracce di qualcosa che l’uomo ha perduto.<br />
E’ questa la caratterizzazione orig<strong>in</strong>ale, mitica, dei racconti di viaggio nell’op<strong>in</strong>ione di Leed<br />
che ipotizza come il viaggiatore non <strong>in</strong>traprenda la sua avventura alla ricerca di elementi<br />
nuovi ma per il r<strong>in</strong>venimento di tracce sepolte nel passato della sua stessa cultura, componenti<br />
dispersi di un’unità dimenticata che siano comunque reperibili nel fondo dell’<strong>in</strong>dividualità<br />
dello stesso soggetto che li <strong>in</strong>tenderebbe come fattori obliati ma profondamente radicati del<br />
sé. La metafora del viaggio diviene una metafora altamente produttiva per molti scrittori<br />
modernisti 264 . Se si accetta il punto di vista avallato da buona parte dei critici che si sono<br />
262<br />
Antonella Reim Natale, La gabbia <strong>in</strong>naturale l’opera di Bruce Chatw<strong>in</strong>, Campanotto, Ud<strong>in</strong>e, 1993, p. 26.<br />
263<br />
Ivi, p. 29.<br />
266<br />
Il nesso tra la narrazione e il viaggio è stato messo <strong>in</strong> rilievo da P<strong>in</strong>o Fasano, <strong>in</strong> Letteratura e Viaggio, che<br />
riprende i Racconti di Canterbury di Chaucer per fornire un esempio di come viaggiare e raccontare sia<br />
un’esperienza antica che fa parte della nostra cultura, per arrivare ai temi del viaggio del “cittad<strong>in</strong>o” Baudelaire,<br />
che associa, nella poesia Le voyage il tema del viaggio a quello dello svolgersi della vita umana la cui meta è la<br />
morte. Il tema del viaggio è stato dunque altamente produttivo <strong>in</strong> ogni fase della nostra cultura ma è nel periodo<br />
del modernismo che sembra assurgere a topos eletto dalla maggior parte degli scrittori. Anche <strong>in</strong> questo caso è la<br />
valenza metaforica ad essere prediletta e ad essere ampiamente sfruttata dagli artisti. Si potrebbe anzi ipotizzare<br />
che siano gli stessi schemi mitici dei racconti di viaggio antichi ad esser riproposti e riconsiderati attuali. Il<br />
83
occupati del modernismo letterario e filosofico, il distacco dell’uomo moderno dalla natura, e<br />
qu<strong>in</strong>di dal proprio essere, apparirà come uno dei punti sostanziali della crisi della modernità.<br />
Il mito adamitico, sviluppato teoricamente e narrativamente da molti scrittori dell’epoca (tra<br />
cui gli stessi Lawrence e Pavese), diviene una parte <strong>in</strong>tegrante, simbolica all’<strong>in</strong>terno<br />
dell’uni<strong>vers</strong>o mitico modernista. Il peccato orig<strong>in</strong>ale, la cacciata dell’uomo dal paradiso<br />
terrestre, segna un dest<strong>in</strong>o che si espleta nella dialettica fuga-ritorno. La conoscenza diviene<br />
r<strong>in</strong>venimento di ciò che è stato perduto: “Il tentativo di riprist<strong>in</strong>are una coesione perduta tra<br />
l’uomo e la natura non è <strong>in</strong>nocente, è ripetizione del peccato orig<strong>in</strong>ale.[…] Il rientro<br />
dell’uomo nel paradiso corrisponde alla distruzione di quel paradiso […] la coscienza affonda<br />
le sue radici nella perdita che crea le condizioni di una conoscenza di ciò che è perduto” 265 .<br />
L’ipo<strong>tesi</strong> che il movimento privilegiato, nei romanzi modernisti, sia un’operazione di<br />
conoscenza attra<strong>vers</strong>o il r<strong>in</strong>venimento delle tracce perdute, trova nell’analisi di Leed una<br />
s<strong>in</strong>tetica <strong>def</strong><strong>in</strong>izione. Il viaggio cosiddetto “filosofico” non è certo un’<strong>in</strong>venzione della<br />
modernità, ma è il modernismo che sembra, più di altri movimenti, riscoprirne la valenza<br />
simbolica. Leed, nella sua analisi della semiotica del viaggio, spiega come, a livello<br />
figurativo, i movimenti di partenza- transito- arrivo, nascondano una simbologia ben <strong>def</strong><strong>in</strong>ita.<br />
Il movimento a ritroso descritto da Conrad rientra appieno <strong>in</strong> questo contesto esaurendosi<br />
nell’eterna dialettica della fuga e del ritorno. Fuga da una civiltà moderna corrotta e<br />
corrompente, ritorno all’orig<strong>in</strong>e del mondo e dell’uomo. I simboli della natura <strong>in</strong>corrotta e<br />
dell’<strong>in</strong>fanzia rientrano di diritto <strong>in</strong> questo uni<strong>vers</strong>o. La partenza, <strong>in</strong>trapresa alla scoperta del<br />
nuovo, si espleta come r<strong>in</strong>venimento del vecchio, dell’immemoriale e del sepolto. E’ un<br />
ritorno che non può però essere direzionato, ovvero idealizzato. Il fiume di Conrad si svolge<br />
come un serpente nel cuore nero del mondo. E’ un flusso che agisce <strong>in</strong>dipendentemente dalla<br />
volontà umana, <strong>in</strong>dipendentemente dalla volontà del personaggio “<strong>in</strong> crisi” della letteratura<br />
modernista, ma “secondo una logica <strong>in</strong>terna che non sembra esigere un <strong>in</strong>tervento cosciente<br />
del soggetto” 266 . Ma questo tipo di viaggio rimane pur sempre un movimento a ritroso nel<br />
tempo, alla ricerca delle radici dell’essere che si annidano nel cuore della natura selvaggia e<br />
che non possono che dirigere l’osservatore occidentale <strong>vers</strong>o un profondo senso di<br />
straniamento. Per Umberto Galimberti il viaggio rappresenta un vero topos della speculazione<br />
<strong>in</strong>tellettuale dell’epoca moderna. Non solo le opere narrative dunque ma anche le opere<br />
filosofiche ne riconoscono l’alta valenza metaforica e strutturano le proprie teorie <strong>in</strong>torno ai<br />
temi del movimento. A partire dal pensiero esistenzialista espresso da Heidegger, Galimberti<br />
nota come l’<strong>in</strong>oltrarsi all’<strong>in</strong>terno di territori sconosciuti fitti di vegetazione rappresenti una<br />
metafora riconosciuta dell’epoca moderna. E’ un percorso di allontanamento dalla civiltà<br />
<strong>vers</strong>o un luogo più naturale dove il senso dell’esistenza umana è stato smarrito molto tempo<br />
fa. L’<strong>in</strong>oltrarsi attra<strong>vers</strong>o questi percorsi sconosciuti non può essere direzionato dalla logica<br />
dell’uomo che non ha alcun riscontro <strong>in</strong> luoghi dom<strong>in</strong>ati da leggi non umane. Il r<strong>in</strong>venimento,<br />
all’<strong>in</strong>terno di questo di-vagare, avviene dunque per illum<strong>in</strong>azioni ottenute lasciandosi<br />
trasc<strong>in</strong>are dal flusso che <strong>in</strong> nessuna maniera appare direzionato. La stessa conoscenza non si<br />
pone degli obiettivi ideali ma detiene, nel suo smarrirsi, il proprio senso ultimo. Spesso il<br />
viaggio non conduce neanche <strong>vers</strong>o una meta ben <strong>def</strong><strong>in</strong>ita ma si perde, utilizzando la stessa<br />
immag<strong>in</strong>e di Heidegger, <strong>in</strong> un labir<strong>in</strong>to di sentieri <strong>in</strong>terrotti all’<strong>in</strong>terno del bosco della<br />
conoscenza:<br />
viaggio di Conrad nel cuore di tenebra è un esempio di quante implicazioni questo tema possa sopportare: “E<br />
<strong>in</strong>fatti risalire quel fiume era come viaggiare all’<strong>in</strong>dietro <strong>vers</strong>o i lontani primordi del mondo. Ma la ricerca di<br />
questo viaggio regressivo non è la redenzione. Non c’è redenzione possibile da quello che Baudelaire chiamava<br />
l’eterno peccato dell’uomo”. P<strong>in</strong>o Fasano, Letteratura e Viaggio, Editori Laterza, Bari, 1999, p. 61.<br />
265 Eric J. Leed, La mente del viaggiatore, Il Mul<strong>in</strong>o, Bologna, 1991, p. 247.<br />
266 Ivi, p.104.<br />
84
Il loro errare nel bosco (Holzwege), che accoglie e custodisce il senso di quei sentieri, non conosce direzione,<br />
conosce però i passi compiuti che hanno condotto a quel punto <strong>in</strong> cui si trova o si è arrestato il loro avanzare. Da<br />
loro non si devono attendere risposte, ma <strong>in</strong>dicazioni lungo la via (Wegmarken) del pensiero che, se non vuole<br />
smarrire se stesso, deve ritrovare la dimora da cui è partito. Accompagnarli lungo il sentiero significa<br />
ripercorrere la storia del pensiero occidentale […] 267 .<br />
Il riferimento che Galimberti fa al tema del viaggio filosofico, come una delle metafore<br />
favorite da uno dei movimenti filosofici che più ispirò il modernismo letterario, appare<br />
significativo. E’ probabilmente proprio lo strappo che l’uomo moderno avverte nei confronti<br />
di un mondo che non sente più suo, a far sviluppare un serbatoio di metafore che postulano,<br />
come condizione per l’acquisizione della conoscenza, l’allontanamento nelle zone periferiche<br />
della civiltà dove il senso non sia più dato ma debba essere r<strong>in</strong>venuto attra<strong>vers</strong>o<br />
l’osservazione. Il perdersi <strong>in</strong> questo spazio mitico ha proprio, nelle pag<strong>in</strong>e che Galimberti<br />
dedica all’esistenzialismo di Heidegger, il senso di r<strong>in</strong>venire l’essere nella sua <strong>in</strong>terezza senza<br />
imporgli l’idea dell’uomo. L’essere <strong>in</strong> balia del flusso significa, per l’uomo moderno, passare<br />
“da dom<strong>in</strong>atore <strong>in</strong> ascoltatore dell’essere” 268 . E’ un percorso a ritroso lungo i b<strong>in</strong>ari della<br />
cultura occidentale che mette a confronto l’uomo con l’oscurità delle proprie orig<strong>in</strong>i: “Il<br />
sentiero aperto muove così dall’essenza dell’alienazione occidentale per scoprire la terra<br />
perduta” 269 . Il tema del viaggio sembra dunque svilupparsi, <strong>in</strong> epoca moderna, come vera e<br />
propria metafora di conoscenza. E’ una conoscenza che prevede allontanamento,<br />
smarrimento, straniamento e <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e r<strong>in</strong>venimento attra<strong>vers</strong>o un procedimento di acquisizione<br />
di consapevolezza che esula dalle metodologie razionalistiche tipiche della civiltà moderna.<br />
Che la filosofia e la scrittura creativa si siano appropriate simultaneamente del tema del<br />
viaggio <strong>in</strong> epoca moderna non deve stupire più di tanto se si considera il viatico culturale che<br />
ha portato alla maturazione di un tale atteggiamento. Il parallelo tra conoscenza filosofica e<br />
scrittura narrativa è realmente un classico della cultura occidentale e si può ipotizzare,<br />
evidentemente, un <strong>in</strong>vigorimento del tema tra l’Ottocento e il Novecento 270 . Nel tentativo di<br />
affermare la ragione e la cultura occidentale come misura di tutte le cose si può r<strong>in</strong>venire la<br />
pr<strong>in</strong>cipale differenza con lo sviluppo del tema del viaggio <strong>in</strong> epoca modernista dove la<br />
ragione civilizzatrice è la prima imputata.<br />
L’apporto dell’antropologia, per quanto riguarda lo sviluppo del tema tra gli scrittori<br />
modernisti, è stato di basilare importanza. I primi studi scientifici-antropologici furono d’altra<br />
parte di matrice evoluzionista. La stessa opera di Frazer, il Ramo d’oro, si situa <strong>in</strong> questa<br />
categoria e fu solamente attra<strong>vers</strong>o una ricollocazione dei materiali da lui proposti che gli<br />
<strong>in</strong>tellettuali modernisti poterono elaborare le loro teorie. Il viaggio di Frazer è ancora<br />
<strong>in</strong>trapreso per <strong>def</strong><strong>in</strong>ire non tanto le culture primitive r<strong>in</strong>venute <strong>in</strong> luoghi lontani, quanto per<br />
<strong>def</strong><strong>in</strong>ire la civiltà occidentale come positività a confronto della negatività dei selvaggi. Lo<br />
stato “<strong>in</strong>civile” di quei paesi lontani viene descritto con spregio e utilizzato come suggestiva<br />
rappresentazione delle orig<strong>in</strong>i della civiltà occidentale; questo tipo di approccio alla materia si<br />
può leggere anche come monito nei confronti di ogni eventuale fallimento del progetto<br />
capitalista e borghese della modernità. Frazer si limitò a considerare queste culture antiche<br />
attra<strong>vers</strong>o gli aspetti più aspri ma al contempo fornì un materiale di <strong>in</strong>estimabile valore per gli<br />
<strong>in</strong>tellettuali che scorsero, <strong>in</strong> quelle descrizioni, altri motivi piuttosto che l’esaltazione della<br />
civiltà occidentale. La direzione che prese la letteratura di viaggio fu, <strong>in</strong> una fase <strong>in</strong>iziale,<br />
decisamente assoggettata alle esigenze di una politica imperialista che giustificava se stessa<br />
267<br />
U. Galimberti, Heidegger, Jaspers e il tramonto dell’Occidente, cit. p. 12.<br />
268<br />
Ivi, p. 21.<br />
269<br />
Ivi, p. 17.<br />
270<br />
A questo proposito basti pensare al mito dell’Odissea per il quale Ulisse diviene una figura ampiamente<br />
riutilizzata dagli <strong>in</strong>tellettuali modernisti. Il viaggio raccontato da Omero possiede molte delle caratteristiche f<strong>in</strong><br />
qui elencate per gli scrittori del modernismo. Prima fra tutte la dialettica, già più volte sottol<strong>in</strong>eata, tra fuga e<br />
ritorno.<br />
85
attra<strong>vers</strong>o lo smercio di una letteratura che celebrava il gusto per l’esotico e per la missione<br />
civilizzatrice occidentale. Levi-Strauss si proclamava terribilmente annoiato dalla letteratura<br />
di viaggio proprio per la mancanza di una dimensione filosofica. La piatta descrizione di<br />
immag<strong>in</strong>i esotiche, di cui la cultura di massa com<strong>in</strong>ciava ampiamente a cibarsi, non poteva<br />
avere quel potere evocativo e simbolico su cui lo scrittore modernista basava le sue opere. Il<br />
viaggiare a ritroso di Conrad mal si associava ai tentativi della cultura dom<strong>in</strong>ante di <strong>def</strong><strong>in</strong>ire<br />
se stessa attra<strong>vers</strong>o il confronto con mondi “<strong>in</strong>civili”. Il gusto per l’esotico e per il pittoresco,<br />
la cui matrice <strong>in</strong>tellettuale rimandava alla decadenza della cultura di massa ma non<br />
prospettava nuovi orizzonti conoscitivi per l’uomo moderno, fu criticata anche da Pavese che,<br />
<strong>in</strong> un appunto del 1942, sembra ricalcare le medesime posizioni di Levi-Strauss:<br />
La noia <strong>in</strong>dicibile che ti danno nei diari le pag<strong>in</strong>e di viaggio. Gli ambienti nuovi, esotici, che hanno sorpreso<br />
l’autore. Nasce senza dubbio dalla mancanza di radici che queste impressioni avevano, dal loro esser sorte come<br />
dal nulla, dal mondo esterno, e non essere cariche di un passato. All’autore piacquero come stupore, ma lo<br />
stupore vero è fatto di memoria, non di novità 271 .<br />
Nel caso della narrazione di viaggio modernista è la qualità del movimento ad essere<br />
significante piuttosto che la quantità dei paesaggi collezionati e successivamente descritti per<br />
soddisfare gli appetiti e la curiosità dei lettori europei. La qualità del movimento implica una<br />
relativizzazione del concetto stesso di viaggio 272 . Se si volesse fare un discorso generale sul<br />
tema del viaggio fra gli scrittori modernisti sarebbe di conseguenza <strong>in</strong>utile stilare delle<br />
categorie basate sui luoghi visitati (europei o extraeuropei) o sull’entità della distanza<br />
percorsa. Romanzi modernisti che descrivono viaggi avvenuti su lunghe distanze sono più<br />
rapportabili a romanzi che descrivono viaggi avvenuti sulle brevi o brevissime distanze<br />
piuttosto che ai resoconti che narrano di luoghi esotici al f<strong>in</strong>e di ammaliare il lettore. Insomma<br />
all’<strong>in</strong>terno dello spazio assoluto le distanze chilometriche sono del tutto relative e le vere<br />
connessioni sono quelle che si possono stabilire fra se stessi e l’altro, fra lo spazio mitico e<br />
quello empirico.<br />
L’<strong>in</strong>teresse di Pavese per la letteratura di viaggio è ampio e documentato. Ma se si volessero<br />
<strong>in</strong>dicare dei possibili paralleli o anche derivazioni, difficilmente si potrebbe far riferimento<br />
alla tradizione letteraria italiana. Pavese fu <strong>in</strong>vece lettore di Conrad e Lawrence ed è forse alla<br />
letteratura di viaggio anglosassone che bisognerebbe far riferimento volendo parlare del tema<br />
del viaggio nello scrittore tor<strong>in</strong>ese. Volendo stabilire dei paralleli fra la letteratura di viaggio<br />
anglosassone e quella italiana si dovrà per prima cosa notare come le modalità siano, al<br />
pr<strong>in</strong>cipio, del tutto differenti. In realtà è pers<strong>in</strong>o difficile parlare di una letteratura di viaggio<br />
italiana. Musumeci constata come tale tema sia addirittura visto con ansia dalla tradizione<br />
letteraria italiana. Ansia che trova voce <strong>in</strong> romanzi quali i Promessi Sposi, P<strong>in</strong>occhio, I<br />
Malavoglia, <strong>in</strong> cui i viaggi, forieri di <strong>in</strong>quietud<strong>in</strong>e e <strong>in</strong>certezza, assumono delle caratteristiche<br />
negative:<br />
271 C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, 2 Agosto 1942, cit. p. 241.<br />
272 Xavier De Maistre compone, nel 1795, il suo Viaggio <strong>in</strong>torno alla mia camera, <strong>in</strong> cui il concetto di spazio<br />
convenzionale subisce uno sconvolgimento radicale. In uno spazio estremamente ridotto, paradossalmente lo<br />
scrittore compose il libro nella cella <strong>in</strong> cui era prigioniero, le dimensioni degli oggetti vengono <strong>in</strong>gigantite f<strong>in</strong>o<br />
alla creazione di una vera e propria geografia mitica dove molte delle implicazioni, che lo schema della<br />
narrazione del viaggio comporta, vengono soddisfatte con una modernità che ha del sorprendente soprattutto<br />
nell’episodio dell’<strong>in</strong>contro con l’altro. Il concetto di viaggio filosofico, che <strong>in</strong> questo studio si tenta di accostare<br />
ai viaggi narrati dagli scrittori modernisti, può essere, paradossalmente, un viaggio immobile. Ma l’esempio di<br />
De Maistre è significativo di come, <strong>in</strong> epoca moderna, il tema del viaggio sia stato detentore di una notevole<br />
connotazione metaforica. I viaggi di Heidegger all’<strong>in</strong>terno di boschi selvosi immag<strong>in</strong>ari, quelli di Conrad <strong>vers</strong>o<br />
l’Africa lontana e misteriosa, quelli di De Maistre lungo le pareti della propria stanza, sembrano possedere un<br />
comune denom<strong>in</strong>atore: il viaggio si <strong>in</strong>traprende per r<strong>in</strong>venire le tracce di tutto ciò che la civiltà moderna ha<br />
sepolto allontanando l’uomo dal proprio essere.<br />
86
[…] nella letteratura italiana del secolo diciannovesimo, per varie ragioni di ord<strong>in</strong>e culturale e sociologico, la<br />
mobilità sia costantemente deprecata come categoria che comporta una valutazione morale negativa […]. Il<br />
concetto di mobilità come fattore di piacere, di arricchimento culturale, di soddisfacente avventura è<br />
significativamente assente; <strong>in</strong>vece, non ha mai un ruolo salvifico e spesso è connesso, <strong>in</strong> funzione direttamente<br />
causativa, a modalità di violenza 273 .<br />
Di conseguenza, nel Novecento, l’”ansia modernista” si sviluppò, <strong>in</strong> Italia, nel chiuso dei<br />
salotti borghesi o nei palcoscenici delle città. Una delle ragioni per cui la letteratura di viaggio<br />
si è sviluppata maggiormente nei paesi anglosassoni è probabilmente legata alla storia<br />
differente che la Gran Bretagna e l’Italia hanno vissuto. Peter L. Thorslev 274 mette <strong>in</strong> risalto<br />
come tutta la letteratura di viaggio anglosassone sia strettamente legata alla politica<br />
imperialista promossa dal paese. Una politica che, nel caso della Gran Bretagna, entrò<br />
stabilmente nella mentalità dei cittad<strong>in</strong>i e ne <strong>in</strong>fluenzò le attitud<strong>in</strong>i. Le narrazioni di viaggio di<br />
autori come Conrad e Lawrence furono supportate dai loro cont<strong>in</strong>ui spostamenti. Ma la<br />
costruzione letteraria-filosofica sembra comunque mantenere la prem<strong>in</strong>enza su quella<br />
documentaristica come ci svela l’atteggiamento dello stesso Lawrence nei confronti degli<br />
<strong>in</strong>digeni messicani: “Anthropological evidence shows that the primitives described by<br />
Lawrence <strong>in</strong> Morn<strong>in</strong>gs <strong>in</strong> Mexico and other travel writ<strong>in</strong>gs did not exist” 275 .<br />
Cesare Pavese non fu, al contrario di molti scrittori britannici, un viaggiatore. Egli non varcò<br />
mai i conf<strong>in</strong>i italiani anche se tutta la sua esistenza fu accompagnata da un’<strong>in</strong>cessante “ansia<br />
di partire”. L’<strong>in</strong>iziale passione per l’America, alimentata dalle letture e dalla musica, si<br />
tramuta presto <strong>in</strong> rifiuto totale per una nazione <strong>def</strong><strong>in</strong>ita dapprima come il Paese di Dio (God’s<br />
country) e di seguito come un ricettacolo di politiche neofasciste. Nelle lettere viene anche<br />
auspicato un viaggio attra<strong>vers</strong>o il “mitico” mediterraneo al f<strong>in</strong>e di raggiungere la misteriosa<br />
Africa ma anche questo progetto sarà dest<strong>in</strong>ato a naufragare così come il più modesto<br />
programma di recarsi a Parigi. Gli it<strong>in</strong>erari di Pavese saranno, lungo l’arco della sua esistenza,<br />
sempre gli stessi. Dalle Langhe a Tor<strong>in</strong>o e vice<strong>vers</strong>a con la variante, ricorrente, di Roma e la<br />
Toscana. E’ lo schema città-campagna che fungerà più volte da struttura per i suoi romanzi.<br />
Per la Muniz l’<strong>in</strong>tera formazione culturale di Pavese è da considerare <strong>in</strong> relazione alle correnti<br />
di pensiero più attive durante il modernismo europeo, come l’esistenzialismo e l’antropologia.<br />
In questo contesto l’approccio di Pavese alla materia fu del tutto personale tanto che la Muniz<br />
parla della riduzione ad un medesimo schema della letteratura scientifica e fiabesca 276 . La<br />
letteratura di viaggio, quella scientifica e quella di f<strong>in</strong>zione, rappresentarono un vero serbatoio<br />
di immag<strong>in</strong>i e pensieri e dunque di materiali per lo scrittore. Le letture della formazione di<br />
Pavese furono <strong>in</strong> buona parte orientate <strong>vers</strong>o questo tipo di letteratura 277 . Muniz sottol<strong>in</strong>ea<br />
ancora come Pavese ripercorra arbitrariamente i grandi miti della storia rievocando i temi del<br />
viaggio e del ritorno desunti dai grandi classici. Nella geografia di uno spazio mitico così<br />
disegnata, la ricerca del luogo orig<strong>in</strong>ario si <strong>in</strong>staura come motivo fondante della ricerca dello<br />
273<br />
Anton<strong>in</strong>o Musumeci, L’impossibile ritorno La fisiologia del mito <strong>in</strong> Cesare Pavese, Il Portico Longo editore,<br />
Ravenna, 1980, p. 14.<br />
274<br />
Peter L. Thorslev Jr. The wild man revenge, <strong>in</strong> Dudley, Edward og Maximillian E. Novak: The Wild Man<br />
With<strong>in</strong> - An Image <strong>in</strong> Western Thought From Renaissance to Romanticism. Uni<strong>vers</strong>ity of Pittsburgh Press,<br />
Pittsburgh, 1972, p. 281.<br />
275<br />
John Mc Govern, Like water <strong>in</strong> water, primitivism and modernity, contenuto <strong>in</strong> Michael Bell, D.H. Lawrence:<br />
language and be<strong>in</strong>g, Cambridge Uni<strong>vers</strong>ity Press, 1992, p. 171.<br />
276<br />
M. de las Nieves Muniz Muniz, Introduzione a Pavese, cit. p. 8.<br />
277<br />
Muniz ipotizza la notevole <strong>in</strong>fluenza esercitata su Pavese dal libro di Camille Flammarion, Le monde avant<br />
l’apparition de l’homme, <strong>in</strong>centrato sulla storia del nostro pianeta prima dell’apparizione dell’uomo <strong>in</strong>sieme ai<br />
numerosi libri di avventura che leggeva da ragazzo. Altri momenti importanti che certificano l’<strong>in</strong>teresse di<br />
Pavese per queste tematiche sono la lettura del Ramo d’oro di Frazer, riletto a più volte tra il 1933 e il 1946, e la<br />
Mitologia Primitiva di Levy-Buhl presente sugli scaffali dello scrittore già dal 1936.<br />
87
scrittore e si espleta nella dialettica città-campagna (coll<strong>in</strong>e). Anche se i romanzi di Pavese si<br />
baseranno, per buona parte, sullo sviluppo proprio della dialettica città-campagna, è<br />
<strong>in</strong>teressante notare come, attra<strong>vers</strong>o lo studio delle opere che gli provenivano d’oltralpi e<br />
d’oltreoceano, egli acquisì una certa sensibilità comune con i romanzieri ardimentosi e<br />
avventurieri dell’Otto-Novecento <strong>in</strong>glese. In una lettera a Fernanda Pivano, datata 25/6/1942,<br />
la matrice del proprio immag<strong>in</strong>ario viene fatta risalire all’identificazione fra l’ignoto e il<br />
viaggio per mare. Il mare diviene simbolo di lontananze mitiche <strong>in</strong> una corrispondenza<br />
<strong>in</strong>cessante fra paesaggi esotici e paesaggi dell’anima: “[…] presentivo al di là del salto, a<br />
grande distanza dopo la valle che si espande come un mare, una barriera remota (picc<strong>in</strong>a,<br />
tanto è remota) di coll<strong>in</strong>e assolate e fiorite, esotiche. Quello era il mio Paradiso, i miei Mari<br />
del Sud, la Prateria, i coralli, Ophir, l’Elefante bianco ecc” 278 . Gioanola <strong>in</strong>dividua nel tema<br />
uno sviluppo proprio della poetica pavesiana anche se sottol<strong>in</strong>ea immediatamente la<br />
differenza fra una concezione realistica del mare, estranea all’autore, e la concezione mitica<br />
attra<strong>vers</strong>o la quale Pavese poté effettivamente trovare una dimensione più consona per le sue<br />
ricerche e per le sue <strong>in</strong>quietitud<strong>in</strong>i:<br />
E’ un tema frequentissimo <strong>in</strong> Pavese quello del mare, ma poco giova alla fantasia allorché viene assunto come<br />
luogo d’ambientazione delle storie, quando è realtà visibile, concreta dimensione naturale (come ne il Carcere e<br />
la Spiaggia). Il mare diventa autentico vivaio di immag<strong>in</strong>i quando è soltanto una realtà sognata e <strong>in</strong>visibile, e<br />
perciò racchiude il fasc<strong>in</strong>o del mondo sconosciuto, è voce dell’<strong>in</strong>f<strong>in</strong>ito al di là della siepe, dolce sirena che<br />
chiama all’evasione della vita avventurosa 279 .<br />
Non a caso la poesia <strong>in</strong>augurale di Cesare Pavese si <strong>in</strong>titola I mari del sud (1931) e si basa sul<br />
vagheggiamento di distanze remote, paesaggi affasc<strong>in</strong>anti e misteriosi. Questa poesia rimarrà<br />
negli anni a venire un punto di riferimento per lo scrittore (“Dal giorno della composizione<br />
dei Mari del Sud, <strong>in</strong> cui per la prima volta espressi me stesso <strong>in</strong> forma recisa e assoluta,<br />
com<strong>in</strong>ciai a costruire una persona spirituale che non potrò mai più sostituire […] 280 ) anche se<br />
lo stile con cui si compone sarà presto superato:<br />
Mari del sud è la prima poesia di Lavorare stanca. Non si tratta unicamente di un accidente editoriale, di una<br />
scelta fortuita della composizione strutturale della prima produzione artistica di Pavese. Si tratta <strong>in</strong>vece di<br />
quell’evento orig<strong>in</strong>ario, unico, che nel sistema pavesiano acquista una veste mitica e <strong>def</strong><strong>in</strong>isce per lo scrittore, <strong>in</strong><br />
modo analogo all’esperienza fondamentale dell’<strong>in</strong>fanzia nell’ambito dell’evol<strong>vers</strong>i del fatto esistenziale,<br />
l’<strong>in</strong>evitabilità del proprio dest<strong>in</strong>o artistico. In tal senso, questa prima poesia della raccolta verrà <strong>in</strong>sistentemente<br />
considerata da Pavese come una composizione di un’importanza controllante per tutto il suo lavoro successivo,<br />
l’<strong>in</strong>discusso punto di partenza per la sua creazione artistica, il concreto term<strong>in</strong>e di paragone valutativo per ogni<br />
susseguente sviluppo, la norma con cui assicurare fedeltà al proprio nucleo orig<strong>in</strong>ale 281 .<br />
278 Cesare Pavese, Lettere 1926-1950, a cura di Lorenzo Mondo e Italo Calv<strong>in</strong>o, E<strong>in</strong>audi, Tor<strong>in</strong>o, 1982.<br />
279 Elio Gioanola, Cesare Pavese, La realtà, l’altrove, il silenzio, Jaca Book, Milano, 2003, p. 18.<br />
280 C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, 6 Ottobre 1935, cit. p. 8.<br />
281 A. Musumeci, L’impossibile ritorno La fisiologia del mito <strong>in</strong> Cesare Pavese, cit.p. 21. Musumeci stabilisce<br />
uno schema per questa poesia che, vista l’importanza del componimento, mi sembra opportuno riportare:<br />
1 Una necessità impellente, non razionalizzabile e non compresa da chi non accetti le proprie premesse<br />
assiomatiche mitiche, sp<strong>in</strong>ge alla fuga ed al conseguente <strong>in</strong>evitabile ritorno.<br />
2 La fuga, come atto apparentemente immotivato, gratuito, rivela la necessità di una dimensione mitica, e perciò<br />
postula un eventuale ritorno. La fuga, come chiamata all’avventuroso, all’altro, ribadisce la ricchezza e<br />
l’<strong>in</strong>sostuibilità dello stato orig<strong>in</strong>ario: come se solo nell’abbandono di tale stato, nell’altro da noi, si possa<br />
scoprire il significato profondo della propria esistenza, nell’apparente vistosità dell’esotico traspaia l’unicità del<br />
luogo d’orig<strong>in</strong>e – lasciare le Langhe per capire che non si possono perdere.<br />
3 Il ritorno, <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e, rivela l’impossibilità del recupero del passato, e con questo anche l’<strong>in</strong>f<strong>in</strong>ita distanza del<br />
mondo mitico – perché anche se le Langhe non si perdono, è pur vero che al ritorno è tutto nuovo. Il mito, come<br />
El Dorado, come l’Età dell’oro, esiste solo, sfortunatamente, <strong>in</strong> frammenti oscuri del proprio <strong>in</strong>conscio, come<br />
necessità di un’<strong>in</strong>nocenza e d’una felicità perdute per sempre.<br />
88
Il materiale utilizzato da Pavese nella composizione di questa poesia sembra provenire <strong>in</strong><br />
buona parte proprio da quella letteratura di viaggio che tanto lo aveva affasc<strong>in</strong>ato. Se si<br />
confronta la prefazione a L<strong>in</strong>ea d’Ombra, composta il 28 Agosto del 1946, si possono<br />
senz’altro trovare echi del giovanile <strong>in</strong>teresse di Pavese per questo tipo di letteratura: “Il Mare<br />
del Sud è veramente per Conrad il luogo dell’anima […] il perenne <strong>in</strong>quieto viavai della<br />
costa, del mare e della costa, l’esitazione che può fare di ogni approdo, di ogni saputo, banale,<br />
previsto approdo, l’<strong>in</strong>izio di una stupenda e assurda avventura di giov<strong>in</strong>ezza di passione e di<br />
dest<strong>in</strong>o” 282 . Motivi che <strong>in</strong> qualche maniera rimandano alle composizioni di Conrad sono<br />
anche ravvisabili all’<strong>in</strong>terno della stessa poesia: la solitud<strong>in</strong>e, le atmosfere trasognate e quasi<br />
irreali (“Sentii poi parlarne da donne, come <strong>in</strong> una favola, talvolta ma gli uom<strong>in</strong>i, più gravi, lo<br />
scordarono” 283 ), i misteri di un silenzio perpetuato da quello che Gioanola chiama<br />
“<strong>in</strong>carnazione della co<strong>in</strong>cidenza di lontananza e radicatezza, spirito d’avventura e fedeltà<br />
all’orig<strong>in</strong>i” 284 , l’“orig<strong>in</strong>ario” cug<strong>in</strong>o che, calandosi nelle vesti di un redivivo Kurtz (“Tacere è<br />
la nostra virtù” 285 ), tace, <strong>in</strong>ducendo Pavese a chiedersi: “Mio cug<strong>in</strong>o non parla dei viaggi<br />
compiuti” 286 . Per Muniz l’avventura nei mari del sud rappresenta una forma ideale e<br />
vagheggiata da Pavese che si riallaccia alle stesse tematiche espresse da molti scrittori<br />
modernisti riguardanti la riemersione, da sotto una veste esotica, della realtà ancestrale della<br />
terra. Eppure anche <strong>in</strong> questo caso, i temi che Pavese svilupperà nel seguito della sua<br />
produzione, sembrano affiorare decisi <strong>in</strong> questa composizione. La dialettica fuga-ritorno è<br />
perfettamente espletata nella poesia (“La vita va vissuta lontana dal paese: si profitta e si gode<br />
e poi, quando si torna, come me, a quarant’anni, si trova tutto nuovo. Le Langhe non si<br />
perdono” 287 ) nella quale si può anche scorgere la presenza di di<strong>vers</strong>i temi tipici come quello<br />
dell’<strong>in</strong>fanzia e della paura che <strong>in</strong>cute la città tentacolare moderna (“La città mi ha <strong>in</strong>segnato<br />
<strong>in</strong>f<strong>in</strong>ite paure” 288 ). Pavese riconosce, <strong>in</strong> questa dialettica di fuga e di ritorno, e dunque <strong>in</strong> una<br />
struttura “<strong>in</strong> movimento” della sua narrazione, un tratto caratteristico della sua poetica.<br />
Questo concetto è espresso proprio <strong>in</strong> relazione alla poesia de I mari del sud:<br />
Se figura c’è nelle mie poesia, è la figura dello scappato di casa che ritorna con gioia al paesello, dopo averne<br />
passate d’ogni colore e tutte pittoresche, pochissima voglia di lavorare, molto godendo di semplicissime cose,<br />
sempre largo e bonario e reciso nei suoi giudizi, <strong>in</strong>capace di soffrire a fondo, contento di seguir la natura e<br />
godere una donna, ma anche contento di sentirsi solo e disimpegnato, pronto ogni matt<strong>in</strong>o a ricom<strong>in</strong>ciare: i Mari<br />
del Sud <strong>in</strong>somma 289 .<br />
Il mare rimane, per Pavese, un elemento misterioso, portatore di conoscenza ma al contempo<br />
di oblio. Raggiungerlo per sondarne i misteri, per sviscerarne i segreti, svelarne il mito, è uno<br />
sforzo dest<strong>in</strong>ato ad essere frustrato. Roberto Gigliucci 290 sottol<strong>in</strong>ea come l’impossibilità di ricongiungersi<br />
idealmente a questo elemento dalla immensa valenza mitica rappresentò un<br />
4 Il viaggio esperienzale del ritorno, la quest mitica, consiste <strong>in</strong> questa acquisita maturità: che nella scoperta<br />
stessa del proprio sostrato mitico sta pure la sua dissoluzione.<br />
Mari del sud è la poesia di uno che è ritornato, visto da uno che probabilmente se ne andrà ed eventualmente<br />
ritornerà. (pp. 27-28)<br />
282<br />
Cesare Pavese, Joseph Conrad, contenuto <strong>in</strong> C. Pavese, Letteratura americana e altri saggi, cit. p. 208.<br />
283<br />
Cesare Pavese, I Mari del Sud, contenuto <strong>in</strong> Cesare Pavese, I Racconti, E<strong>in</strong>audi, Tor<strong>in</strong>o, 1994, p. 27.<br />
284<br />
E. Gioanola, Cesare Pavese, La realtà, l’altrove, il silenzio, cit. p. 134.<br />
285<br />
C. Pavese, I Mari del Sud, cit. p. 27.<br />
286<br />
Ivi, p. 29.<br />
287<br />
Ivi, p. 27.<br />
288<br />
Ivi, p. 28.<br />
289<br />
C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, 10 Novembre 1935, cit. p. 17.<br />
290<br />
Roberto Gigliucci, Cesare Pavese, Bruno Mondatori, Milano, 2001.<br />
89
motivo di profonda frustrazione per lo scrittore. Gli elementi dell’antica mitologia greca che<br />
si associavano al mare furono mediati a Pavese dall’<strong>in</strong>segnamento di Unterste<strong>in</strong>er che, nel<br />
considerare l’acqua il simbolo della femm<strong>in</strong>ilità e della fertilità, sosteneva implicitamente le<br />
teorie di Jung a riguardo. A questa formulazione classica va aggiunto senz’altro il ruolo che il<br />
mare ricopriva nei romanzi d’avventura anglosassoni che Pavese leggeva. Nel racconto<br />
<strong>in</strong>titolato Il Mare (1932), contenuto <strong>in</strong> Ciau Mas<strong>in</strong>o, la necessità di partire e varcare i mari è<br />
direttamente ispirata dall’autore di Cuore di Tenebra: “I romanzi di Conrad hanno messo di<br />
moda la Sonda… sì le isole olandesi sotto la C<strong>in</strong>a” 291 . Il mare è promettente, ispira il<br />
protagonista del racconto che chiede un <strong>in</strong>carico di corrispondente al direttore del suo giornale<br />
per poter ricalcare le orme dei personaggi di Conrad ma l’ansia del viaggio lungo è<br />
<strong>in</strong>sopprimibile: “Cercò di sonnecchiare per sopire il noioso fervore <strong>in</strong>timo e l’ansia. Non più<br />
parlare italiano. Ma era bello il Piemonte. Maiale! Bello è andare altrove. Così si fa,<br />
Mas<strong>in</strong>o” 292 . Ma la ferma volontà del protagonista di <strong>in</strong>traprendere il viaggio per mare si<br />
scontra contro un senso di ansia, una paura atavica <strong>vers</strong>o un elemento sconosciuto che proprio<br />
per il mistero che cela sembra <strong>in</strong>cutere il più profondo orrore. Mas<strong>in</strong>o ripercorre un processo<br />
che si potrebbe <strong>def</strong><strong>in</strong>ire sveviano e che prevede la somatizzazione di un male psicologico:<br />
“Chi sa se patisco il mal di mare? Voglio vedere. Dico di no, che non lo patisco -no- e poi<br />
basta mangiare” 293 . Il racconto di Mas<strong>in</strong>o diviene una vera metafora dell’impossibilità di<br />
<strong>in</strong>traprendere un viaggio per mare, l’<strong>in</strong>capacità di affrontare il mito di fronte alla modernità<br />
<strong>in</strong>calzante: “Un negozio che <strong>in</strong> vetr<strong>in</strong>a aveva ramponi. Bello. Ma è f<strong>in</strong>ito il tempo dei<br />
ramponi. Le balene ora le ammazzano a cannonate. Che freddo faceva! Chissà il mare com’è<br />
freddo” 294 . Il mare rimane oggetto di un’attrazione-repulsione. L’impossibilità di affrontare il<br />
suo mito pesa come un macigno sulle spalle dello scrittore. Una impossibilità che diviene<br />
quasi una metafora di impotenza. La voglia di partire, di solcare i flutti <strong>vers</strong>o i paesi esotici,<br />
esplorare il mistero del mondo si sublima, per Mas<strong>in</strong>o, nel whisky ord<strong>in</strong>ato al Sailor’s Inn,<br />
luogo di ritrovo dei mar<strong>in</strong>ai. Mas<strong>in</strong>o cerca, <strong>in</strong> questo ritrovo, di att<strong>in</strong>gere alle storie che lui<br />
non potrà mai vivere <strong>in</strong> prima persona. La figura del mar<strong>in</strong>aio di colore si staglia nella bettola<br />
come quella di un moderno Quiqueg, un selvaggio scaturito dalle profondità degli abissi che<br />
biascica un <strong>in</strong>glese con “pronuncia barbarica” 295 . Ma l’<strong>in</strong>terrogazione di Mas<strong>in</strong>o rimarrà senza<br />
risposta, lasciando il mistero <strong>in</strong>tatto, mentre la figura del “gigantesco” mar<strong>in</strong>aio si ritira<br />
nell’oscurità, risprofondando nello stesso abisso di mistero dal quale era miracolosamente<br />
scaturito, concludendo così il racconto:<br />
-Where are you from?<br />
Il negro non staccò il bicchiere dalle labbra.<br />
-Goody,- disse poi. E tese la mano a Mas<strong>in</strong>o.<br />
-Good-bye,- disse Mas<strong>in</strong>o.<br />
Una mano nuda, da scimmia.<br />
- S’ long,- rispose l’altro e se ne andò 296 .<br />
Quello del mito mar<strong>in</strong>o è dunque una dimensione sostanzialmente irraggiungibile come si<br />
ev<strong>in</strong>ce dal racconto Il Mare (1942) contenuto <strong>in</strong> Feria d’Agosto. In questo racconto, che porta<br />
lo stesso titolo del precedente contenuto <strong>in</strong> Ciau Mas<strong>in</strong>o, il mare è visto come possibilità<br />
291 Cesare Pavese, Il Mare, contenuto <strong>in</strong> C. Pavese, I Racconti, cit. p. 129.<br />
292 Ivi, p. 131.<br />
293 Ivi, p. 130.<br />
294 Ivi, p. 132.<br />
295 Ibidem.<br />
296 Ivi, p. 133.<br />
90
aperta, come ultima speranza. Nello stesso tempo il protagonista, pur vagheggiandolo e pur<br />
agognando l’azzurra distesa, non riuscirà nell’impresa di raggiungerla:<br />
Ancora adesso non vuol credere che lo stradone non ha f<strong>in</strong>e, come non han f<strong>in</strong>e le strade ferrate, e di paese <strong>in</strong><br />
paese gira f<strong>in</strong> che c’è terra senza mai <strong>in</strong>terrompersi. Dice che, se fosse così, la gente non smetterebbe di<br />
camm<strong>in</strong>are e tutti girerebbero il mondo. E sul nostro stradone sarebbe un viavai di stranieri d’ogni paese. –Tutte<br />
le strade f<strong>in</strong>iscono al mare, -gli dicevo- dove ci sono i porti. Di là ci si imbarca e si va nelle isole, dove gli<br />
stradoni riprendono. Non era conv<strong>in</strong>to che per andare <strong>vers</strong>o il mare bastasse <strong>in</strong>camm<strong>in</strong>arsi 297 .<br />
Anche <strong>in</strong> questo caso si può notare come il mare assuma le caratteristiche di un vero e proprio<br />
spazio mitico. Ma Pavese rimarrà sempre sui marg<strong>in</strong>i di questo spazio mitico, costantemente<br />
sulla riva meditando l’impossibile tra<strong>vers</strong>ata. Nel racconto Storia Segreta (1942), ancora<br />
contenuto <strong>in</strong> Feria d’Agosto, sono ancora i motivi della lontananza e dell’irraggiungibilità ad<br />
essere associati al mare. Del mare si parla come cosa lontana, fantasticata, poetica. È una<br />
dimensione mitica che il poeta non sembra essere <strong>in</strong> grado di raggiungere:<br />
Così parlavamo del mare; conoscevo di<strong>vers</strong>i che d’estate ci andavano, lei stava a sentire e mi chiedeva se da<br />
uomo ci avrei condotti i miei bamb<strong>in</strong>i. Ma io non pensavo ai bamb<strong>in</strong>i, pensavo a me stesso su coste lontane e<br />
lunghi viaggi; passavamo davanti ai portoni e così i fiori più ricchi e nascosti si confondevano col mare nel mio<br />
cuore. Pensavo allora alla f<strong>in</strong>estra dei gerani come a uno sfondo di luoghi mar<strong>in</strong>i 298 .<br />
La parabola di Pavese “mar<strong>in</strong>aio” sulle orme dei miti di Melville e Conrad si esaurisce<br />
idealmente, come Gigliucci nota, con il racconto Il Signor Pietro (1942). Il vecchio amico di<br />
famiglia, il Signor Pietro appunto, è un viaggiatore che torna <strong>in</strong> Italia dopo molti anni. La<br />
figura del vecchio uomo di mare è descritta come fasc<strong>in</strong>osa e carismatica. E’ un fasc<strong>in</strong>o<br />
maturato <strong>in</strong> anni di viaggi e avventure: “Notai che gli occhi scuri e vivaci erano pieni<br />
d’energia, e alto stempiato vigoroso com’era tutt’ora, più che <strong>in</strong>vecchiato il signor Pietro<br />
appariva uno di quegli uom<strong>in</strong>i che hanno raggiunto un equilibrio così solido da durarci<br />
<strong>in</strong>alterati.[…] capivo che un uomo che è sempre vissuto all’albergo, nelle stazioni e <strong>in</strong><br />
viaggio, doveva avere quella faccia e quell’energia.[…] Era davvero vecchio, ma i capelli<br />
biondicci e gli occhi pronti ne facevano un uomo vivo” 299 . Il Signor Pietro diviene il prototipo<br />
del viaggiatore, il simbolo dell’uni<strong>vers</strong>o sconosciuto del viaggio marittimo la cui esperienza si<br />
può acquisire solo direttamente. Così come, ricordando il Kurtz di Conrad, era accaduto per il<br />
cug<strong>in</strong>o de I mari del sud e per il barbarico mar<strong>in</strong>aio di colore de Il Mare, la conoscenza non si<br />
può acquisire attra<strong>vers</strong>o la parola, che è negata, ma solo attra<strong>vers</strong>o l’immag<strong>in</strong>e: “Del Signor<br />
Pietro non vidi neanche una valigia perché lo <strong>in</strong>contrai sempre nell’atrio, né lui amava<br />
raccontare dei suoi viaggi tranne il poco <strong>in</strong>dispensabile” 300 . Il fasc<strong>in</strong>o del mare agisce di<br />
conseguenza sul giovane protagonista del racconto che sente di essere dest<strong>in</strong>ato ad una vita di<br />
avventure:<br />
In casa nostra si era sempre detto che il babbo, se fosse vissuto, voleva fare di me un mar<strong>in</strong>aio, un comandante,<br />
perché girassi e vedessi il mondo. Dentro di me gli ero riconoscente per avermi dest<strong>in</strong>ato a una vita bella, e se<br />
anche la sorte aveva voluto altrimenti non lasciavo per questo di fantasticare matt<strong>in</strong>o e sera, da solo, quando<br />
uscivo di casa, che f<strong>in</strong>almente com<strong>in</strong>ciava il mio gran viaggio, che mi bastava camm<strong>in</strong>are camm<strong>in</strong>are f<strong>in</strong>o <strong>in</strong><br />
297 C.Pavese, Feria d’Agosto, cit. p. 64.<br />
298 Ivi, pp. 184-85.<br />
299 Cesare Pavese, Il Signor Pietro, contenuto <strong>in</strong> C. Pavese, Racconti, cit. pp. 429-33.<br />
300 Ivi, pp. 431-32.<br />
91
fondo alla città, f<strong>in</strong>o agli <strong>in</strong>colti dei sobborghi, e qualcosa sarebbe accaduto: voltato l’angolo dell’ultima casa,<br />
nel cielo fresco o nei rossori della sera, mi sarebbe apparso il mare, un mare mai visto, immenso e fumante di<br />
porti, di spiagge, di fragori 301 .<br />
L’ansia del giovane di partire per mare lo porta a domandare al Signor Pietro un imbarco:<br />
Gli dissi che io chiedevo soltanto di lasciare la riva, di respirare con un altro fiato e raccontai del vecchio sogno<br />
di mio padre, raccontai dei miei sogni […]. Quando sentì che il mare non l’avevo mai veduto, cambiò faccia di<br />
botto, fu costernato. Mi str<strong>in</strong>se la spalla e mi chiese perché l’<strong>in</strong>domani non partivo con lui.[…] Quella notte non<br />
tornai a casa. Entrai <strong>in</strong>vece nel caffè della stazione, per godermi, da solo, il mio avvenire e gustare la mia nuova<br />
<strong>in</strong>dipendenza. Ero ubriaco ma non di v<strong>in</strong>o, sentivo anzi <strong>in</strong> me una chiarezza e un ardire che poi non ho provato<br />
mai più 302 .<br />
In questo racconto il protagonista riesce dunque, f<strong>in</strong>almente, a procurarsi un imbarco per<br />
lasciare la riva ed avventurarsi nell’ignoto del mare. La visione trasognata che il giovane ha<br />
del mare, che non ha mai visto, è <strong>in</strong>coraggiata dal Signor Pietro che gli promette di aiutarlo. Il<br />
protagonista sente una nuova libertà da questa risoluzione e com<strong>in</strong>cia a fantasticare sul suo<br />
prossimo <strong>in</strong>contro con il mare che purtroppo, anche questa volta, non avverrà. Il racconto<br />
rimane <strong>in</strong>compiuto lasciando il protagonista immerso nel sogno del viaggio.<br />
Cesare Pavese rimase dunque legato, per tutta la sua attività di scrittore, alla possibilità di<br />
svolgere il mito del mare. Questa possibilità non si concretizzò mai. Ma proprio <strong>in</strong> questo suo<br />
essere irraggiungibile, <strong>in</strong> questo suo essere altrove, il mare può considerarsi un topos della<br />
letteratura pavesiana. Citando la nota riportata sul Mestiere di Vivere del 5/4/1945 (“Vivere <strong>in</strong><br />
un ambiente è bello quando l’anima è altrove. In città quando si sogna la campagna, <strong>in</strong><br />
campagna quando si sogna la città. Dappertutto quando si sogna il mare”.), Gioanola scrive:<br />
“Il mare diventa addirittura, <strong>in</strong> tale prospettiva, la figura per eccellenza dell’altrove, trovando<br />
la funzione di lievito immag<strong>in</strong>ativo proprio <strong>in</strong> virtù del suo non essere qui” 303 .<br />
Ciò che appare evidente, nella considerazione di questi viaggi letterari basati sui grandi<br />
spostamenti, è la relativizzazione del concetto di distanza. Il viaggio letterario sembra aver<br />
come primo scopo quello di voler porre una distanza prima di tutto esistenziale che svolga la<br />
funzione di mettere il personaggio di fronte al di<strong>vers</strong>o, allo sconosciuto e all’<strong>in</strong>comprensibile.<br />
Questo procedimento non è tanto <strong>in</strong>teso per studiare i comportamenti o le caratteristiche del<br />
di<strong>vers</strong>o - qui la grande differenza con i romanzi d’esplorazione che tanto annoiavano Levi-<br />
Strauss e Pavese - ma quanto per svelare i misteri di quell’osservatore occidentale che<br />
improvvisamente si trova a fare i conti con l’<strong>in</strong>consistenza del progetto culturale di cui è<br />
portatore. Le distanze dei mari possono essere equivalenti a quelle che separano le pareti di<br />
una stanza o a quelle che <strong>in</strong>tercorrono fra l’ambiente metropolitano e quello rurale.<br />
Il tema del viaggio nella narrativa di Cesare Pavese, come già accennato, è stato riconosciuto<br />
come basilare da buona parte della critica. I personaggi pavesiani attra<strong>vers</strong>ano conf<strong>in</strong>i<br />
semiotici, stabilendosi spesso ai marg<strong>in</strong>i, per constatare come l’ultimo barlume di senso sia da<br />
r<strong>in</strong>tracciarsi proprio all’<strong>in</strong>terno di spazi ibridi e per <strong>in</strong>terrogare con ansia lo spazio mitico che<br />
li <strong>in</strong>corpora e i personaggi simbolici che <strong>in</strong>contrano. Impossibilitato a svolgere movimenti<br />
sulle grandi distanze, come quelle del mare, Pavese preferirà volgere la sua attenzione al<br />
viaggio breve, al simbolico movimento città-campagna. E’ un percorso m<strong>in</strong>imo, se<br />
paragonato alle leghe percorse dal cug<strong>in</strong>o de I mari del sud o alle lunghe distanze percorse dai<br />
mar<strong>in</strong>ai di Conrad, ma le implicazioni sono altrettanto suggestive rimandando, <strong>in</strong> molti casi, a<br />
tematiche moderniste. Per Musumeci il viaggiare “diventerà la metafora card<strong>in</strong>ale e il codice<br />
301 Ivi, p. 430.<br />
302 Ivi, p. 434.<br />
303 E. Gioanola, Cesare Pavese, La realtà, l’altrove, il silenzio, cit. p. 138.<br />
92
genetico dello scrivere pavesiano” 304 proprio a seguito dell’esperienza de I mari del sud. Il<br />
viaggio diviene una vera forma di conoscenza e la stessa struttura narrativa appare legata al<br />
suo tema <strong>in</strong> maniera <strong>in</strong>dissolubile. Riferendosi ai romanzi della maturità, considerati quelli<br />
scritti dal 1947 <strong>in</strong> poi, Muniz scrive: “[…] Pavese tendeva <strong>in</strong>somma a confondere il piano<br />
della narrazione e quello del viaggio, anzi a ridurre l’esperienza umana a un b<strong>in</strong>omio<br />
perfettamente re<strong>vers</strong>ibile: la narrazione di un viaggio/il viaggio della narrazione, sicché<br />
scoprire, dibattere e camm<strong>in</strong>are saranno d’ora <strong>in</strong> poi perfettamente s<strong>in</strong>onimi nei romanzi<br />
pavesiani” 305 .<br />
E’ un viaggio che, per quanto riguarda Pavese, si struttura come ritorno nella sua ultima<br />
istanza: ”[…] ritorno che rappresenta la figura fondamentale dei libri pavesiani della maturità;<br />
i protagonisti de La casa <strong>in</strong> coll<strong>in</strong>a, de Il diavolo sulle coll<strong>in</strong>e, de La luna e i falò ritornano<br />
tutti compiendo un viaggio dalla città alla campagna, dalla cultura alla natura, dalla prassi<br />
all’estasi, dalla storia al mito, dall’<strong>in</strong>autentico all’autenticità” 306 . Lo schema applicato da<br />
Musumeci alla poesia I mari del sud sembra, con qualche variante, applicabile a la maggior<br />
parte dei componimenti pavesiani. Il viaggio si <strong>in</strong>traprende per una crisi esistenziale, una<br />
necessità di maturazione che, <strong>in</strong> qualche maniera, riprende i viaggi mitici dell’<strong>in</strong>iziazione. E’<br />
per questo che il più delle volte si struttura come fuga da un luogo che per certo si vuole<br />
lasciare, spesso questo luogo è la città, per un luogo <strong>in</strong> cui non si sa precisamente cosa cercare<br />
e, soprattutto, se alla f<strong>in</strong>e si potrà trovare qualcosa. Spesso questo luogo è la campagna con le<br />
sue coll<strong>in</strong>e misteriose e materne e con la sua essenza mitica da svelare attra<strong>vers</strong>o<br />
l’<strong>in</strong>terpretazione del simbolo. Nel momento dell’arrivo a dest<strong>in</strong>azione avviene il<br />
riconoscimento del luogo mitico che è il luogo del ritorno. Ritorno alla natura, ritorno<br />
all’orig<strong>in</strong>e, ritorno all’essere. “Impossibile ritorno”, come suggerisce il titolo del libro di<br />
Musumeci, nel momento <strong>in</strong> cui il viaggiatore si scopre straniero alla terra e malato di civiltà.<br />
La scoperta del mito diviene presto consapevolezza di perdita. Il viaggiatore torna al punto dal<br />
quale era partito. Solo, alienato, <strong>in</strong> un ambiente che non riesce a decifrare e <strong>in</strong> cui non riesce<br />
ad <strong>in</strong>serirsi. L’epilogo tragico, che caratterizza gli <strong>in</strong>contri dei personaggi di Pavese con i<br />
luoghi del mito e con i personaggi “ibridi”, portatori di una cultura arcaica, segna la sconfitta<br />
della ricerca che non porta all’<strong>in</strong>staurarsi di un ord<strong>in</strong>e razionale che possa sopraffare e<br />
controllare quello mitico, ma che conduce senz’altro ad una visione più profonda e<br />
consapevole del reale. Il riconoscimento delle leggi della natura, che sovrastano quelle<br />
dell’uomo e che il mito tenta di portare a chiarezza, rappresenta la vera crescita dei<br />
personaggi pavesiani. Il viaggio di Pavese è, dunque, un movimento ciclico che riporta<br />
costantemente il personaggio al punto da cui era partito, da ciò che era prima dell’<strong>in</strong>izio della<br />
ricerca. L’arricchimento del personaggio, il guadagno che il viaggio comporta, è il<br />
raggiungimento di una tragica consapevolezza impossibile da ottenere nella città, regno delle<br />
sovrastrutture mistificanti. Questa nuova tragica consapevolezza è la vera e unica crescita del<br />
personaggio pavesiano <strong>in</strong> relazione al movimento <strong>in</strong>staurato tra città e campagna. Non si parla<br />
dunque di un viaggio l<strong>in</strong>eare ma ciclico che implica un movimento vorticoso che Musumeci<br />
così spiega:<br />
Il suo movimento non è orizzontale, ma verticale (scavo è il term<strong>in</strong>e pavesiano preferito per tale operazione), con<br />
un processo che non è l<strong>in</strong>eare ma ripetitivo, sulla struttura di cerchi concentrici. Una nozione che non viene<br />
acquisita per mezzo di sforzi mentali, ma è data; è raggiunta <strong>in</strong>tuitivamente, epifanicamente. La sua presenza è di<br />
sempre; non è conquistata come un premio, né è ottenuta meritoriamente alla f<strong>in</strong>e di un lungo percorso<br />
<strong>in</strong>tellettivo; <strong>in</strong>vece, è parte di quel bagaglio mitologico che dallo scrittore con il suo stesso dest<strong>in</strong>o <strong>in</strong> pr<strong>in</strong>cipium.<br />
[…] Scopo ultimo non è tanto la scoperta di un sostrato di mitologia, personale o collettiva, quanto la riduzione<br />
di questo a chiarezza, a logos. Il monolito di Pavese scrittore, sia rispetto alla sua ossessiva presenza che alla sua<br />
funzione di privilegio nella totalità della produzione artistica pavesiana, è il mito del ritorno: lo sforzo<br />
<strong>in</strong>tenzionale del protagonista di staccarsi dalla condizione esistenziale presente e , attra<strong>vers</strong>o un ritorno fisico ad<br />
304 A.Musumeci, L’impossibile ritorno La fisiologia del mito <strong>in</strong> Cesare Pavese, cit. p. 20.<br />
305 M. de las Nieves Muniz Muniz, Introduzione a Pavese, cit. p. 134.<br />
306 E. Gioanola, Cesare Pavese, La realtà, l’altrove, il silenzio, cit. pp. 89-90.<br />
93
una geografia mitica, ricuperare una qualità mitica di vita identificata con l’<strong>in</strong>fanzia. […] Da allora <strong>in</strong> poi, (mari<br />
del sud), la struttura del ritorno sarà stabilita per sempre, e verrà sottoposta ad un persistente e monotono<br />
scavo 307 .<br />
I teatri di questo vorticoso viaggiare saranno, nella maggior parte dei casi, e soprattutto nei<br />
romanzi “della maturità”, la città e la campagna. Il movimento fra questi due poli è segnato da<br />
tutte le implicazioni che caratterizzano i conf<strong>in</strong>i semiotici, così come sono stati descritti da<br />
Lotman. E’ il vero passaggio da un ord<strong>in</strong>e significante ad un altro che caratterizza i viaggi dei<br />
personaggi di Pavese così come constata Gioanola: “[…] passare da una località all’altra è<br />
come passare da un uni<strong>vers</strong>o rustico ad uno civile e fare esperienza della distanza che esiste<br />
tra campagna e città” 308 . Il concetto di distanza qui proposto mi sembra si possa legare<br />
senz’altro a quello della “tragica consapevolezza” poc’anzi esposto nel momento <strong>in</strong> cui la<br />
tragedia si <strong>in</strong>nesca, come kafkiano processo, proprio nel momento <strong>in</strong> cui si prende atto della<br />
distanza che <strong>in</strong>tercorre fra l’uomo moderno e l’orig<strong>in</strong>ario, fra il mondo metropolitano civile e<br />
quello rurale primitivo. Si parla dunque, come lo stesso Gioanola sostiene, di distanza<br />
ontologica che proprio nella metafora del viaggio-narrazione si svela come categoria di<br />
<strong>in</strong>vestigazione impresc<strong>in</strong>dibile per l’<strong>in</strong>tellettuale moderno. Il tema del viaggio dalla città <strong>in</strong><br />
campagna è dunque funzionale a rivelare e a sondare la distanza; esso si svelerà ricco di<br />
implicazioni e fornirà a Pavese la possibilità di svolgerne il mito e sviscerarne il simbolismo<br />
<strong>in</strong> connessione con le istanze artistiche più moderne: “[…] fare dei miti la base di un<br />
r<strong>in</strong>novato e ritrovato senso comune: di una classicità rustica, fondata sulla città-<strong>in</strong>-campagna.<br />
Un'espressione <strong>in</strong> cui campagna equivale a <strong>in</strong>fanzia e preistoria, e città a mondo<br />
contemporaneo. E tutto questo secondo una direzione propria dei ritornanti primitivismi della<br />
modernità” 309 .<br />
Pavese sviluppò la sua scrittura proprio tentando di risolvere la dialettica della città e della<br />
campagna. I suoi viaggi letterari, così come quelli reali, furono concepiti su questo schema. E’<br />
una relazione che si stabilisce all’<strong>in</strong>terno di molti romanzi modernisti e che si basa, anche se<br />
non esclusivamente, sul riconoscimento della città come simbolo della decadenza della civiltà<br />
moderna. E’ comunque nel rapporto fra i due poli opposti, <strong>in</strong>teso come sequenza di<br />
contrapposizioni, che la distanza ha la possibilità di essere rilevata. La struttura b<strong>in</strong>aria della<br />
narrativa pavesiana trova <strong>in</strong> questa nuova coppia di opposti un’ulteriore applicazione. Muniz<br />
così spiega questa struttura <strong>in</strong> rapporto al tema del viaggio:<br />
In questo modo si era andato configurando un modello assai preciso di racconto, metà naturalistico, metà<br />
simbolico, al cui centro appariva un personaggio misto (attore-spettatore) capace di raggiungere l’<strong>in</strong>dispensabile<br />
equilibrio, tra chi sa e chi ignora, mentre la storia complessiva tendeva a costruirsi come un’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e (una vita<br />
ri-pensata) la cui scoperta f<strong>in</strong>ale combacia con la nozione presupposta (il dest<strong>in</strong>o oscuramente <strong>in</strong>tuito), venendo<br />
così a descrivere una sorta di dantesco camm<strong>in</strong>o dell’anima. Ma, nella misura <strong>in</strong> cui questo camm<strong>in</strong>o implica<br />
uno sforzo conoscitivo che si compie nell’attrito fra il presente e il passato o, se vogliamo, fra l’<strong>in</strong>cosciente e la<br />
realtà, l’equilibrio risultante implicherà il superamento di una fortissima tensione <strong>in</strong>terna […]: La tua poetica è<br />
forzatamente drammatica perché il suo messaggio è l’<strong>in</strong>contro di due persone – il mistero e il fasc<strong>in</strong>o e<br />
l’avventura di questi <strong>in</strong>contri – non la confessione della tua anima (Mestiere di Vivere, 21 Giugno 1940). […]<br />
Ci vuole la ricchezza d’esperienze del realismo e la profondità di sensi del simbolismo […] tutta l’arte è un<br />
problema di equilibrio fra due opposti ( Mestiere di Vivere, 14 Dicembre 1939). […] lo sviluppo della tecnica<br />
pavesiana segna un’evoluzione che si avvic<strong>in</strong>a gradatamente al modello ideale riducendo man mano gli<br />
scompensi <strong>in</strong>iziali fra voce dei personaggi e voce del narratore o fra tempo materiale e tempo immag<strong>in</strong>ario, cioè,<br />
<strong>in</strong> ultima istanza, fra trama realista e trama simbolica 310 .<br />
307<br />
A.Musumeci, L’impossibile ritorno La fisiologia del mito <strong>in</strong> Cesare Pavese, cit. pp. 11-13.<br />
308<br />
E. Gioanola, Cesare Pavese, La realtà, l’altrove, il silenzio, cit. p. 145.<br />
309<br />
Guido Guglielmi La prosa italiana del Novecento, Tra romanzo e racconto, Piccola Biblioteca E<strong>in</strong>audi, 1998,<br />
p. 117.<br />
310<br />
M. de las Nieves Muniz Muniz, Introduzione a Pavese, cit. pp. 55-56.<br />
94
Per Guglielmi il problema alla base della poetica di Pavese è proprio quello dello stabilire un<br />
rapporto fra gli opposti, trovare nuove possibilità di movimento nell’ambito della distanza:<br />
“[...] come mediare tempo estatico e tempo profano, citazione mitica e vita<br />
contemporanea?” 311 . La scrittura di Pavese si risolve, <strong>in</strong> buona parte, nella “conciliazione” o<br />
nella “guerra” degli opposti che trovano, nella città e nella campagna, i due simboli orig<strong>in</strong>ari<br />
da cui tutto scaturisce e prende forma:<br />
Pavese spiega questo concetto nel saggio <strong>in</strong>titolato La Selva (1946):<br />
La selva sconfigge l'ord<strong>in</strong>e magico del mito. Essa è l'imprevisto che sta nel cuore dei nostri compagni uom<strong>in</strong>i.<br />
Ed è un mistero, l'unico veramente <strong>in</strong>tollerabile, il mistero del contrasto delle volontà. Se la campagna re<strong>in</strong>tegra<br />
l'uomo nell'ord<strong>in</strong>e naturale, scandito dall'avvicendamento delle stagioni, la città è la selva, il luogo della guerra<br />
dell'uomo contro l'uomo [...] il dest<strong>in</strong>o è dunque massima conciliazione (armonia degli uom<strong>in</strong>i e degli dei) e<br />
contemporaneamente demonico schema 312 .<br />
La difficoltà, forse l’impossibilità, di risolvere questo rapporto <strong>in</strong> direzione non tragica, è<br />
dunque evidente dalla considerazione di aver a che fare con elementi ibridi. La<br />
“conciliazione” è impossibile e il dest<strong>in</strong>o assume la forma di un “demonico schema”. La<br />
campagna non è più luogo dell’orig<strong>in</strong>ario ma ne conserva al massimo le tracce; la città non è<br />
semplicemente il luogo dell’artificiale <strong>in</strong> quanto gli uom<strong>in</strong>i che la abitano conservano la<br />
memoria dell’orig<strong>in</strong>e:<br />
Dal punto di vista figurativo il contrasto di partecipazione-distacco trova immag<strong>in</strong>i efficaci nell’antico rapporto<br />
città-campagna, che qui come non mai compongono due semi mondi perfettamente <strong>in</strong>tegratisi e proprio mentre<br />
<strong>in</strong>trecciano strettissimi legami d’<strong>in</strong>terferenza e sono appena divisi da un’esigua soglia, sono anche lontanissimi<br />
tra loro e permettono due modi d’esistenza completamente di<strong>vers</strong>i.[…] La città come spazio umano e la coll<strong>in</strong>a<br />
come spazio naturale (le cose che accadono e le cose che sono) si scoprono a vicenda contrapponendosi 313 .<br />
Il ruolo che viene affidato alla città, <strong>in</strong>dipendentemente dalle successive complicazioni, è<br />
<strong>in</strong>izialmente quello ereditato dalla tradizione modernista. Baudelaire, poeta studiato e<br />
apprezzato dallo stesso Pavese, <strong>in</strong>dividuava nella città il ricettacolo di tutti i mali della<br />
contemporaneità. Per Paolo Proietti la città diviene simbolo di un nuovo ord<strong>in</strong>e significante<br />
che sta guadagnando progressivamente spazio. Il riconoscimento di questa nuova “dimensione<br />
metropolitana” dell’esistenza “consente osservare da una nuova prospettiva estetica le<br />
premesse ed i primi sviluppi di una società protocapitalistica che si lascia tradurre <strong>in</strong> un nuovo<br />
sistema di corrispondenze semiotiche fondate sui valori della produttività e del commercio,<br />
sul conv<strong>in</strong>cimento ideologico nelle possibilità del miglioramento sociale e politico attra<strong>vers</strong>o<br />
l’impegno materiale del s<strong>in</strong>golo per il miglioramento della collettività e del sistema” 314 .<br />
L’analisi di Proietti ha il merito di s<strong>in</strong>tetizzare alcune delle pr<strong>in</strong>cipali tensioni che<br />
attra<strong>vers</strong>arono l’Europa nel periodo <strong>in</strong> cui si avviava risoluta <strong>vers</strong>o un sistema capitalistico.<br />
La crisi di rigetto, dovuta alla velocità e alla spregiudicatezza delle trasformazioni, può<br />
trovare una sua rappresentazione nell’uni<strong>vers</strong>o caotico metropolitano <strong>in</strong> cui le nuove forze <strong>in</strong><br />
gioco si combattono, si r<strong>in</strong>corrono, si ostacolano, lasciando l’uomo <strong>in</strong> una situazione di ansia<br />
permanente dovuta all’<strong>in</strong>stabilità del mondo e dei suoi rapporti con esso. L’uomo moderno è<br />
disperso <strong>in</strong> un contesto non più significante e vaga alla ricerca di un nuovo senso o, come nel<br />
311 G.Guglielmi La prosa italiana del Novecento, Tra romanzo e racconto, cit. p. 130.<br />
312 Cesare Pavese, La selva, <strong>in</strong> C. Pavese, Letteratura americana e altri saggi, cit. p. 132.<br />
313 E.Gioanola, Cesare Pavese, La realtà, l’altrove, il silenzio, cit. p. 32.<br />
314 Paolo Proietti, Introduzione a P. Nicholls, La forma e le scritture, cit. p.7.<br />
95
caso di Pavese, fugge alla ricerca della dimensione rurale:<br />
Queste caratteristiche della modernità, implicano una rottura – un’ulteriore frammentazione! – con le condizioni<br />
storiche precedenti, per cui l’architettura sociale ereditata dal passato, nella quale il soggetto ha costruito la<br />
propria identità ed il proprio senso di appartenenza, non può più fornire un adeguato supporto morale ed<br />
emotivo. E’ così che un assetto sociale <strong>in</strong>tero, sotto la sp<strong>in</strong>ta della prima <strong>in</strong>dustrializzazione e dei risvolti da essa<br />
implicati, vive un periodo di profonda e radicale trasformazione, ed il disagio <strong>in</strong>tellettuale di quella nuova,<br />
moderna realtà può essere trovato soprattutto nella realtà urbana 315 .<br />
Già nella prima raccolta di Pavese, Lavorare Stanca, si può r<strong>in</strong>tracciare questo tema così<br />
come nota Musumeci: “In Fumatori di Carta le coll<strong>in</strong>e e la città sono polarizzate <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i<br />
di movimento. La città è il locus dell’<strong>in</strong>giustizia; ma un ritorno alle coll<strong>in</strong>e, benché desiderato,<br />
non può essere realizzato a causa dell’<strong>in</strong>abilità del protagonista a rompere i propri legami<br />
sociali ed umani […]” 316 .<br />
Le reazioni degli scrittori modernisti di fronte alle nuove sfide della modernità furono<br />
ovviamente di di<strong>vers</strong>o genere. A scrittori che decisero di esplorare l’uni<strong>vers</strong>o urbano per<br />
sviscerarne i motivi di decadenza, basti pensare a Thomas Hardy o Thomas Mann, se ne<br />
affiancarono altri che decisero di partire <strong>vers</strong>o terre ignote, come Conrad, mentre altri ancora<br />
decisero di esplorare la dimensione rurale, quella dimensione che si può situare ai conf<strong>in</strong>e<br />
della città <strong>in</strong> una situazione di prossimità spaziale ma di lontananza temporale. Nel caso di<br />
Pavese, lo svolgimento della dialettica città-campagna non implica necessariamente, anche se<br />
questo sviluppo fu privilegiato, un giudizio negativo sulla città. Le due dimensioni sono<br />
messe a confronto come due spazi mitici differenti. La ricerca del senso si espleta <strong>in</strong>somma su<br />
entrambi i fronti. Gigliucci mette <strong>in</strong> risalto come l’attitud<strong>in</strong>e di Pavese <strong>vers</strong>o la città fu<br />
complessa 317 . Luogo di decadenza ma al contempo spazio culturale dove avvengono gli<br />
<strong>in</strong>contri con i personaggi più <strong>in</strong>teressanti, la città non sembra assumere, nelle pag<strong>in</strong>e degli<br />
appunti dello scrittore, una connotazione <strong>def</strong><strong>in</strong>itiva, sia essa positiva e negativa. La città<br />
rimane dunque per Pavese una dimensione <strong>in</strong>stabile, oggetto di cont<strong>in</strong>ua <strong>in</strong>terpretazione e<br />
re<strong>in</strong>terpretazione. La città, nell’ambito della sua poetica, può trovare una collocazione<br />
esauriente esclusivamente nell’ambito del rapporto con le coll<strong>in</strong>e e la campagna, spazi esterni<br />
<strong>in</strong> cui si sviluppano differenti modalità di approccio al reale. La città è dunque simbolica e<br />
non allegorica. Il tema del movimento città-campagna è una costante di tutta la produzione di<br />
Cesare Pavese e trova, nell’op<strong>in</strong>ione di Muniz, una sua chiara formulazione nel rapporto cittàcampagna<br />
<strong>in</strong> La casa <strong>in</strong> coll<strong>in</strong>a che rappresenta “il suo primo scontro con le contraddizioni<br />
della società moderna <strong>in</strong>naturalmente divisa fra città e campagna” 318 . Il rapporto cittàcampagna<br />
è dunque visto <strong>in</strong> maniera problematica, quasi che dalla sua risoluzione possa<br />
affiorare il barlume di una impresc<strong>in</strong>dibile verità. Se nei romanzi della modernità il rapporto è<br />
evidente e articolato, è da notare come la riflessione <strong>in</strong>torno a questa problematica risalga già<br />
ai tempi di Lavorare Stanca. F<strong>in</strong> da allora il carattere simbolico dei due opposti poteva<br />
apparire ben chiaro. L’approccio di Pavese non appare quello di uno scrittore dedito a creare<br />
una propria allegoria, dove la città e la campagna possano assumere dei significati ben precisi.<br />
Al contrario il movimento città-campagna è vissuto come movimento esistenziale, dunque<br />
sempre tutto da scoprire e ri<strong>def</strong><strong>in</strong>ire. L’ansia di portare alla luce i simboli, le implicazioni<br />
esistenziali più nascoste che tale rapporto cela, lo conducono a sviluppare il tema <strong>in</strong> maniera<br />
varia e imprevedibile. Muniz constata l’importanza del tema <strong>in</strong> Pavese e al contempo la sua<br />
ambivalenza:<br />
315 Ivi, p.8.<br />
316 A. Musumeci, L’impossibile ritorno La fisiologia del mito <strong>in</strong> Cesare Pavese, cit. p. 32.<br />
317 R. Gigliucci, Cesare Pavese, cit. pp. 50-52.<br />
318 M. de las Nieves Muniz Muniz, Introduzione a Pavese, cit. p. 145.<br />
96
In esso (il primo libro di poesie Lavorare Stanca) appare raffigurata una parabola ulisseica di cui sono<br />
protagonisti il ragazzo contad<strong>in</strong>o che attratto dalla città sogna il distacco dal paese (Città <strong>in</strong> campagna), e il<br />
giovane lavoratore <strong>in</strong>urbato che, sentendo improvvisamente il richiamo della terra, si prepara a fuggire dalla<br />
prigione urbana (Atlantic Oil, Gente che non capisce). Ma v’è un altro modo <strong>in</strong> cui questo tema prende forma, ed<br />
è quello che potremmo chiamare della città-foresta. Dove la natura ricompare come un residuo ancestrale che la<br />
civiltà urbana non riesce ad assorbire pienamente.[…] Ma la città <strong>in</strong> campagna assume anche l’aspetto di uno<br />
spazio lim<strong>in</strong>are (la barriera, la stazione, il fiume, il r<strong>in</strong>g, l’ambigua casa senza tetto, i viali aperti) dove i<br />
personaggi patiscono uno stato di sdoppiamento alienante.[…] Questa sovrapposizione di città e campagna ha,<br />
<strong>in</strong>somma, quale implicito trait d’union, l’oscura attrazione che l’uomo civile prova per la natura selvaggia, i cui<br />
tratti ricorrenti sono il sangue e il sesso 319 .<br />
Il rapporto fra città e campagna è dunque talmente complesso che non sarà difficile scorgere<br />
tutta una serie di proiezioni che daranno l’impressione costante di trovarsi di fronte a mondi<br />
ibridi, mondi che i due poli si contendono a vicenda. Lo sforzo dei personaggi sarà quello di<br />
dover dist<strong>in</strong>guere fra la massa dei dati che caoticamente si assommano nella ricerca di un<br />
assoluto che è cont<strong>in</strong>uamente promesso ma giammai concesso. Come Muniz nota, a riguardo<br />
del viaggio che i protagonisti de Il Diavolo sulle coll<strong>in</strong>e <strong>in</strong>traprendono, la possibilità di<br />
ritrovare una dimensione mitica sarà cont<strong>in</strong>uamente <strong>in</strong>terdetta e il percorso ascensionale <strong>vers</strong>o<br />
la coll<strong>in</strong>a cont<strong>in</strong>uamente vanificato: “Arrivati <strong>in</strong> alto, troveranno un mondo ibrido – né città<br />
né campagna -, ancor più <strong>in</strong>quietante della conca del fiume” 320 . E’ la dimostrazione di come<br />
lo spazio mitico, designato da Pavese, preveda <strong>in</strong>tromissioni di spazio storico e vice<strong>vers</strong>a. Lo<br />
stesso accadrà con i personaggi antagonisti del cittad<strong>in</strong>o e del selvaggio. Insomma la città <strong>in</strong><br />
campagna e la campagna <strong>in</strong> città; il cittad<strong>in</strong>o nel selvaggio e il selvaggio nel cittad<strong>in</strong>o. Il<br />
Diavolo sulle coll<strong>in</strong>e è dunque il luogo dell’ibrido, della “scoperta del selvaggio cittad<strong>in</strong>o” 321<br />
la dimostrazione di “come il selvaggio – la donna – covi dentro ogni uomo, <strong>in</strong> città come <strong>in</strong><br />
campagna, nella vetta più alta o <strong>in</strong> mezzo a una sala da ballo, e anzi, trovi la sua espressione<br />
più ributtante nel mondo civilizzato” 322 .<br />
La geografia mitica di Pavese è ben disegnata ed è funzionale allo sviluppo dei temi del mito.<br />
Il rapporto città-campagna diviene produttivo solo all’<strong>in</strong>terno dello spazio mitico e della<br />
geografia simbolica: “La qualificazione della geografia, come Pavese scoprirà più tardi nelle<br />
sue letture etnologiche, e l’<strong>in</strong>tenzionalità dell’atto, sono <strong>in</strong>gredienti essenziali del significato<br />
del ritorno: solo il ritorno ad un luogo mitico può costituire un evento mitico” 323 . Lo spazio<br />
mitico e la sua proiezione geografica divengono un elemento basilare nella costruzione del<br />
romanzo “d’esplorazione”: “[…] sarà con la mitizzazione della geografia che le sue categorie<br />
mitiche si organizzeranno <strong>in</strong> un sistema operante e coerente” 324 . Città e campagna divengono<br />
due opposti “esistenziali” e si configurano come ibridi. Il loro rientrare <strong>in</strong> una geografia<br />
mitica è estremamente funzionale al tema del viaggio e al motivo del ritorno: “[…] città e<br />
coll<strong>in</strong>a come simboli esistenziali, <strong>in</strong> costante stato di tensione irrisolta, e postulano perciò,<br />
nella loro stessa <strong>in</strong>capacità a superarsi, a stabilirsi <strong>in</strong> cont<strong>in</strong>uità, l’eventuale necessità di un<br />
ritorno” 325 . Sarà una mitizzazione estremamente complessa, ricca di simbologie, sulla quale<br />
dom<strong>in</strong>a dall’alto la coll<strong>in</strong>a. Il viaggio di Corrado, <strong>in</strong> La casa <strong>in</strong> coll<strong>in</strong>a, si struttura come<br />
viaggio dalla dimensione storica a quella mitica. La differenza con le scritture romantiche, che<br />
postulavano un movimento molto simile a questo, risiede tutto nell’estrema<br />
problematizzazione delle argomentazioni tramite le quali si potrà constatare la sconfitta<br />
dell’uomo nel suo mitico periplo di ritorno:<br />
319 Ivi, pp. 32-33.<br />
320 Ivi, p. 147.<br />
321 Ivi, p. 149.<br />
322 Ivi, p. 147.<br />
323 A. Musumeci, L’impossibile ritorno La fisiologia del mito <strong>in</strong> Cesare Pavese, cit. p. 34.<br />
324 Ivi, p. 73.<br />
325 Ivi, p. 33.<br />
97
Se l’odissea di Ulisse va dall’impresa mitica alla domesticità del quotidiano, quella di Corrado è <strong>in</strong>vece il ritorno<br />
da una quotidianità m<strong>in</strong>acciata e perciò m<strong>in</strong>acciante <strong>vers</strong>o il mito considerato aprioristicamente come spazio<br />
salvifico. […] Corrado <strong>in</strong>vece ritorna a casa, alle coll<strong>in</strong>e, a cercare la salvezza lontano dagli uom<strong>in</strong>i. Il suo<br />
ritorno è un exit dalla storia <strong>vers</strong>o il mito. L’odissea di Corrado è predicata sulla dicotomia fondamentale tra città<br />
e coll<strong>in</strong>a 326 .<br />
La coll<strong>in</strong>a, che si struttura nei romanzi pavesiani come “autentica metafora dell’essere” 327 ,<br />
diviene uno dei simboli pr<strong>in</strong>cipali della sua mitologia. Simbolo dell’essere, del tempo<br />
naturale, del selvaggio, la coll<strong>in</strong>a si pone fuori dalla storia per assurgere ad elemento mitico<br />
privilegiato all’<strong>in</strong>terno dello spazio mitico di Pavese: “[…] coll<strong>in</strong>a come equivalente di<br />
essenza, di durata sapienzale, di autenticità, contro i traumi e i rivolgimenti storici, la<br />
precarietà delle ideologie, l’effimera consistenza degli atti e dei fatti umani” 328 . Proprio <strong>in</strong><br />
quanto metafora dell’essere, la coll<strong>in</strong>a svolge il suo simbolo testimoniandone la<br />
di<strong>vers</strong>ificazione e l’impossibilità della cristallizzazione allegorica <strong>in</strong> significati unici.<br />
All’<strong>in</strong>terno dello spazio mitico della campagna, la coll<strong>in</strong>a rappresenta una presenza costante<br />
ed <strong>in</strong>att<strong>in</strong>gibile, misteriosa ed attraente. Diventa stessa parte del mito ed <strong>in</strong> questo si<br />
contrappone alla modernità <strong>in</strong>calzante rappresentata dagli ambienti urbani: “Viene subito<br />
postulato un necessario rapporto dicotomico tra città e coll<strong>in</strong>a, ed un moto direzionale<br />
determ<strong>in</strong>ato <strong>in</strong> modo univoco. Il ritorno alla coll<strong>in</strong>a è visto come transito da cont<strong>in</strong>genza –<br />
predicata a riguardo della città <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i di luce, a permanenza – predicata a riguardo della<br />
coll<strong>in</strong>a <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i di atemporalità e di uni<strong>vers</strong>alità: dalla storia al mito” 329 .<br />
Oggetto d’amore e odio la coll<strong>in</strong>a, attra<strong>vers</strong>o gli scritti di Pavese, potrà assumere le sembianze<br />
delle mammelle di una donna pronte all’allattamento ma esprimerà anche l’erotismo di un<br />
seno rigoglioso; assumerà qu<strong>in</strong>di le vesti della madre e quelle dell’amante. Queste due<br />
antropizzazioni, diffuse e basilari della scrittura pavesiana, saranno però complicate da<br />
<strong>in</strong>f<strong>in</strong>ite implicazioni. La donna, oggetto di attrazione e repulsione, la madre terra affasc<strong>in</strong>ante<br />
impenetrabile ed orrenda, trova, nella coll<strong>in</strong>a, un suo corrispettivo come segno della terra e<br />
qu<strong>in</strong>di del selvaggio. Maria Luisa Premuda r<strong>in</strong>traccia questo rapporto tra donna e selvaggio<br />
nel momento <strong>in</strong> cui la coll<strong>in</strong>a diviene simbolo della terra e qu<strong>in</strong>di dell’essere: “Nella fantasia<br />
di Pavese la figura femm<strong>in</strong>ile si colora di tutta la complessità della donna-madre etnologica: è<br />
l’<strong>in</strong>carnazione stessa del mondo titanico, un tumulto di sangue che vive l’attimo con<br />
semplicità primordiale […]” 330 . Ma proprio nel simboleggiare una donna madre-amante,<br />
feconda e con seni gonfi di latte, la coll<strong>in</strong>a associa sempre più la sua funzione a quella<br />
dell’essere. La guerra, che si svolge fra le sue pendici <strong>in</strong> La casa <strong>in</strong> Coll<strong>in</strong>a, è vista come una<br />
vera violenza carnale nei suoi confronti, una profanazione dell’essere, l’ennesimo tentativo<br />
dell’uomo di appropriarsi del sacro che quel luogo rappresenta. Eppure è proprio l’esplosione<br />
di questa violenza, metà selvaggia e metà umana, che conduce il protagonista a riflettere sulla<br />
propria esistenza: “L’approfondimento del rapporto città-campagna avviene come<br />
trasposizione della violenza e del sangue dalla natura alla storia. La guerra offre il motivo<br />
dell’ultima decantazione della campagna come primitivo e selvaggio, riconducendola alla<br />
dimensione di luogo delle memorie <strong>in</strong>fantili, luogo delle essenze e dell’orig<strong>in</strong>alità” 331 .<br />
Dalla vicenda di Corrado si potrà ricavare nient’altro che una ancora più approfondita<br />
consapevolezza esistenziale:<br />
326<br />
Ivi, p. 98.<br />
327<br />
E. Gioanola, Cesare Pavese, La realtà, l’altrove, il silenzio, cit. p. 8.<br />
328<br />
Ivi, p. 29.<br />
329<br />
A. Musumeci, L’impossibile ritorno La fisiologia del mito <strong>in</strong> Cesare Pavese, cit. p. 97.<br />
330<br />
Maria Luisa Premuda, Annali della scuola superiore di Pisa, vol. XXVI, 1957, pp. 238-242.<br />
331<br />
E. Gioanola, Cesare Pavese, La realtà, l’altrove, il silenzio, cit. p. 33.<br />
98
[…] il suo essere fuori dal tempo nell’<strong>in</strong>calzare degli eventi storici, la certezza che esistono realtà di valore<br />
assoluto, la coll<strong>in</strong>a appunto, la grande immag<strong>in</strong>e al di là di tutte le esperienze, germ<strong>in</strong>ata da un passato di<br />
memoria ma <strong>in</strong>caricata nella sua favolosa <strong>in</strong> temporalità, di simboleggiare tutto il futuro.[…] E la vera<br />
partecipazione del protagonista non sta forse nel non essere direttamente co<strong>in</strong>volto nei fatti, ma nel doloroso<br />
tormento dell’assistervi impotente e nella coscienza che <strong>in</strong> quella vicenda di orrore e di sangue si riflette una<br />
condizione eterna dell’esistere? 332 .<br />
Il luogo dell’essere, la coll<strong>in</strong>a, diviene a sua volta un luogo di “impossibile ritorno”; i<br />
personaggi rimangono sempre <strong>in</strong>vischiati nell’<strong>in</strong>terpretazione della sua simbologia, alla<br />
ricerca di un significato che sembra dest<strong>in</strong>ato a non esser rilasciato. Lo schema del viaggio<br />
sembra esser funzionale a quello del ritorno nel momento <strong>in</strong> cui la campagna diviene<br />
depositaria dei simboli dell’essere. E’ lo stesso ritorno <strong>in</strong> cui più volte ci si è imbattuti <strong>in</strong><br />
questo studio. Ritorno, pur dest<strong>in</strong>ato ad esser frustrato, alla natura, all’orig<strong>in</strong>ario, all’essere,<br />
all’<strong>in</strong>fanzia. Quella dell’<strong>in</strong>fanzia è un’ulteriore implicazione a cui si deve associare la coll<strong>in</strong>a,<br />
la campagna e, soprattutto, il selvaggio. In riferimento a La casa <strong>in</strong> Coll<strong>in</strong>a, Gioanola scrive:<br />
La coll<strong>in</strong>a è la metafora efficace dell’essere, <strong>in</strong> rapporto alla labilità angosciosa del fare e del divenire; scoperta<br />
della coll<strong>in</strong>a, cioè della campagna-<strong>in</strong>fanzia, significa l’approdo all’autentica coesistenza esistenziale, a ciò che si<br />
è orig<strong>in</strong>ariamente, nella nativa ricchezza precedente tutte le esperienze storiche. […] Sotto gli aspetti della realtà<br />
e della storia, c’è una consistenza misteriosa e autentica […] La coll<strong>in</strong>a è appunto figurata struttura di ciò che<br />
vale prima di tutte le cose e dà senso a tutte le cose 333 .<br />
Il viaggio di ritorno <strong>vers</strong>o la campagna è, dunque, anche viaggio nel tempo quando l’essere<br />
umano ancora non aveva formato la sua coscienza e viveva a stretto contatto con la natura<br />
stabilendo con lei un rapporto privilegiato troncato sul nascere: “C’è sempre nei libri migliori<br />
di Pavese un ritorno, ed è il ritorno ai luoghi dell’<strong>in</strong>fanzia, un ritorno attra<strong>vers</strong>o lo spazio che<br />
corrisponde a un ritorno attra<strong>vers</strong>o il tempo al punto <strong>in</strong> cui il tempo non esiste più, dove i<br />
ricordi lasciano trapelare l’abisso di essere e nulla che li ha generati e fatti tanto pregnanti di<br />
senso” 334 .<br />
E’ proprio nel romanzo La casa <strong>in</strong> coll<strong>in</strong>a che questo rapporto trova probabilmente la sua<br />
applicazione più evidente. La caratterizzazione geografica del luogo è particolarmente<br />
marcata, attra<strong>vers</strong>o le descrizioni delle valli, delle coll<strong>in</strong>e, della città di Tor<strong>in</strong>o, ma è subito<br />
l’implicazione mitica che si rende evidente, e il motivo del ricordo-ritorno trasposto <strong>in</strong> una<br />
dimensione vagamente onirica porta la Muniz ad associare le atmosfere create da Pavese a<br />
quelle di Conrad: “il racconto - improntato a un tono rammemorante t<strong>in</strong>to di rimorso simile a<br />
quello che Pavese aveva attribuito a Conrad <strong>in</strong> un saggio del 1946 - <strong>in</strong>izia <strong>in</strong> medias res sotto<br />
il segno del ritorno” 335 . Sono le stesse atmosfere conradiane, che la stessa Muniz evocherà per<br />
<strong>in</strong>trodurre Il Diavolo sulle coll<strong>in</strong>e, parlando di “un viaggio di scoperta”, di “viaggio nel cuore<br />
del mistero” e di “viaggio nell’ignoto” 336 . I motivi legati al tema del viaggio, analizzati<br />
f<strong>in</strong>ora, si ripropongono puntualmente <strong>in</strong> La casa <strong>in</strong> coll<strong>in</strong>a: “Sarà dunque la storia di Corrado<br />
un viaggio attra<strong>vers</strong>o la guerra che è nel contempo una ricerca a ritroso nei ricordi più oscuri<br />
della sua psiche alla scoperta delle orig<strong>in</strong>i della propria viltà. Così, di ricordo <strong>in</strong> ricordo, egli<br />
approderà allo stampo che foggiò <strong>in</strong> passato la sua fantasia: il mito della natura come mistero<br />
selvaggio” 337 . Sotto questa luce, dopo aver constatato come il desiderio di riscoperta<br />
332 Ivi, p. 31.<br />
333 Ivi, p. 30.<br />
334 E. Gioanola, Cesare Pavese, La realtà, l’altrove, il silenzio, cit. pp. 35-36.<br />
335 M. de las Nieves Muniz Muniz, Introduzione a Pavese, cit. p. 140.<br />
336 Ivi, pp. 145-46.<br />
337 Ivi, p. 141.<br />
99
ontologica sia ben diffuso fra gli <strong>in</strong>tellettuali modernisti, non sarà difficile scorgere la<br />
connessione con il tema del viaggio e, di conseguenza, comprendere il motivo della sua estesa<br />
diffusione fra gli scrittori della modernità 338 . Il viaggio diviene metafora preferita, con il suo<br />
bagaglio di simboli, per una messa <strong>in</strong> discussione del progetto della civiltà occidentale<br />
nell’epoca del nichilismo. Le implicazioni ontologiche relative al motivo del ritorno, uno<br />
degli aspetti senz’altro fondamentali all’<strong>in</strong>terno del tema del viaggio, sono state<br />
abbondantemente discusse da Gioanola che <strong>in</strong>dica <strong>in</strong> Heidegger la fonte europea di questa<br />
tendenza. La geografia mitica disegnata da Pavese, colma di simboli da <strong>in</strong>terpretare,<br />
rimanderebbe, dunque, a <strong>in</strong>quietitud<strong>in</strong>i esistenziali. Gli stessi simboli si caricano di<br />
implicazioni ontologiche f<strong>in</strong>o a diventare metafore dell’essere. All’<strong>in</strong>terno della geografia<br />
mitica la campagna sembra dunque avere un ruolo ben preciso, un ruolo metaforico e<br />
fondante per tutta la poetica di Pavese:<br />
La nuova stagione poetica di Pavese nasce quando la campagna diventa un valore assoluto […]. La poetica del<br />
mito attribuisce alla campagna il valore di essenza, <strong>in</strong>dividuandola come il luogo <strong>in</strong> cui sono nate e hanno preso<br />
forma le strutture costitutive dell’io, come il vivaio immag<strong>in</strong>ativo capace di simboleggiare la sostanza autentica<br />
della persona, quella dest<strong>in</strong>ata natura che stabilisce una direzione e una qualità a tutta l’esistenza 339 .<br />
La campagna diviene dunque luogo privilegiato all’<strong>in</strong>terno dello spazio mitico di Pavese. E’<br />
un luogo mitico depositario dell’essere dove il selvaggio “accade” e si struttura come<br />
possibilità propria di quell’essere. La sua implicazione nell’ambito della dialettica cittàcampagna<br />
è svelata dallo stesso Pavese:<br />
Il selvatico che ci <strong>in</strong>teressa non è la natura il mare la selva ma l’imprevisto nel cuore dei nostri compagni uom<strong>in</strong>i.<br />
E’ il selvatico che con un semplice sforzo d’attenzione può diventare volontà deliberata. La città e la donna ci<br />
usano una ferocia della quale ogni campagna <strong>in</strong>colta è soltanto un simbolo […]. La solitud<strong>in</strong>e di un bosco, <strong>in</strong> un<br />
campo di grano , può essere paurosa, può uccidere, ma non ci spaventa né uccide come uom<strong>in</strong>i, come volontà<br />
appassionate. Solamente gli altri sanno farci questo – gli altri, il prossimo, le donne , i compagni, i nostri figli. Di<br />
fronte a costoro, di fronte alla città, soffriamo sempre, soffriamo a fondo.[…] Tanto vale accettare il mistero e<br />
popolare la città di simboli, e la campagna di presenze. E amare tutto questo – con cautela disperata 340 .<br />
E’ un essere che non è immediatamente fruibile ma va colto solo grazie all’<strong>in</strong>terpretazione del<br />
simbolo. La campagna di Pavese diviene il luogo del “proibito” nel momento <strong>in</strong> cui tale<br />
proibito si identifica con il rimosso, con ciò che la civiltà moderna si è abituata a nascondere.<br />
Essendo luogo di conf<strong>in</strong>e, questa campagna ospita dunque il tragico r<strong>in</strong>venimento del<br />
proibito: il selvaggio appunto.<br />
338 Che proprio a livello ontologico, e qu<strong>in</strong>di attra<strong>vers</strong>o l’uso speculativo dell’irrazionale, si possa r<strong>in</strong>tracciare<br />
grossa parte della modernità di Pavese, è sostenuto con vigore da Gioanola che, nel capitolo “Pavese tra<br />
esistenzialità ed ontologia, rileva: “E’ vero che Pavese appare dom<strong>in</strong>ato dalle esigenze di razionalizzazione, e<br />
questo è certo un debito nei confronti del suo ambiente di formazione, ma si tratta pur sempre di un<br />
razionalizzare all’<strong>in</strong>terno dell’irrazionale, un portare alla consapevolezza che non esaurisce le risorse <strong>in</strong>f<strong>in</strong>ite<br />
dell’Altro (è il problema del classicismo di Pavese, che trova un modello eccellente <strong>in</strong> Thomas Mann, un<br />
decadente classicista per <strong>def</strong><strong>in</strong>izione). Che lo si voglia o meno Pavese s’<strong>in</strong>serisce a pieno diritto su quella l<strong>in</strong>ea<br />
irrazionalistica che troppa cultura nostrana, per troppo tempo, ha considerato come la causa di tutti i mali,<br />
isolandola come una malattia romantica da superare al più presto: ma Pavese era troppo dentro al problema per<br />
non sapere che proprio sull’irrazionale si giocava la sua modernità di scrittore”. Contenuto <strong>in</strong> E. Gioanola,<br />
Cesare Pavese, La realtà, l’altrove, il silenzio, cit. p. 102.<br />
324 E.Gioanola, Cesare Pavese, La realtà, l’altrove, il silenzio, cit. p. 15.<br />
340 C. Pavese, La selva, cit. pp- 321-323.<br />
100
Il tema del viaggio, come visto, diviene funzionale all’esposizione di motivi tipici della<br />
modernità. L’<strong>in</strong>sanabilità dei contrasti che gli elementi opponenti svolgono sul campo<br />
rimanda a quel male di vivere che fu una caratteristica impresc<strong>in</strong>dibile delle poetiche del<br />
modernismo. “Inconciliabilità” e “demonico schema” divengono i fattori impresc<strong>in</strong>dibili di<br />
cui si compone la consapevolezza che i personaggi pavesiani raggiungono attra<strong>vers</strong>o lo<br />
svolgimento della loro tragedia. Il selvaggio e il cittad<strong>in</strong>o, la campagna e la città, il tempo<br />
mitico e quello storico, divengono gli attori della tragedia dell’umanità. Non ci sarà mai un<br />
lieto f<strong>in</strong>e ai romanzi di Pavese così come Muniz nota <strong>in</strong> riferimento a La casa <strong>in</strong> Coll<strong>in</strong>a:<br />
“Merito di Pavese fu anche la r<strong>in</strong>uncia a trovare un lieto f<strong>in</strong>e dichiarando conclusa la guerra e<br />
superato lo stato di angoscia del protagonista. Invece la scoperta ultima di Corrado è che la<br />
guerra non f<strong>in</strong>isce mai proprio perché ha fatto affiorare il selvaggio alla coscienza […]” 341 . Il<br />
viaggio dei personaggi pavesiani sembra dunque configurarsi, <strong>in</strong> ultima istanza, come viaggio<br />
esistenziale. Il r<strong>in</strong>venimento delle tracce di un tempo assoluto e di un’essenza orig<strong>in</strong>aria non<br />
<strong>in</strong>dicano tanto l’anelito di un passato mitico e di un utopico ricongiungimento, quanto la<br />
sconfitta del presente, la presa di coscienza, nuova consapevolezza storica, che la distanza è<br />
oramai troppo marcata e dunque impercorribile. Ma è proprio su questo chiaroscuro, sulla<br />
serie di contrasti <strong>in</strong>sanabili da cui scaturisce una visone della modernità come <strong>in</strong>conciliabile<br />
contraddizione, sulla costruzione di una poetica della distanza <strong>in</strong>somma, che si situa la<br />
modernità dello scrittore:<br />
In questo mondo della perenne durata, l’azione violenta degli uom<strong>in</strong>i acquista un senso strano e quasi<br />
<strong>in</strong>comprensibile e il distacco tra i piani della realtà e del mito raggiunge <strong>in</strong> queste pag<strong>in</strong>e il massimo sviluppo. La<br />
narrazione degli <strong>in</strong>contri coi partigiani, della strage dei fascisti, della fuga per le casc<strong>in</strong>e, è sempre<br />
contrappuntata, a segnare questa distanza, dalla notazione del tempo e dell’ora del giorno: il sole, la luna che<br />
nasce, le stelle, il colore del cielo sono collegamenti cont<strong>in</strong>ui al senso dell’eterno durare della natura di fronte ai<br />
traumi sconvolgenti del presente. Ed è <strong>in</strong> virtù di questo distacco che si scopre il nucleo autentico del<br />
drammatico rapporto tra mito e storia: la realtà att<strong>in</strong>ta della coll<strong>in</strong>a fa balenare l’abisso nascosto dietro di essa; la<br />
coll<strong>in</strong>a è il simbolo estremo che nasconde-rivela la consistenza dell’essere prima di ogni determ<strong>in</strong>azione<br />
storica 342 .<br />
Questa è la tragedia della modernità dove i r<strong>in</strong>venimenti di brandelli di tempo e delle tracce<br />
del selvaggio si configurano come espressione più propria del fallimento esistenziale<br />
dell’uomo moderno: “Così il ritorno alle coll<strong>in</strong>e native, teatro delle atrocità tremende della<br />
guerra civile, anziché proporre una qualsiasi soluzione, o la decisiva assunzione di<br />
responsabilità, o lo smembramento nell’atemporalità della natura, ribadisce per l’ultima volta<br />
la dicotomia <strong>in</strong>sanabile, risolvendo nell’elogio dell’eterno dolore umano la storica urgenza<br />
delle decisioni e delle scelte” 343 .<br />
La dimensione mitica della campagna trova la sua ultima <strong>def</strong><strong>in</strong>izione <strong>in</strong> La luna e i falò. Il<br />
viaggio di ritorno di Anguilla si svela immediatamente essere un percorso di conoscenza, una<br />
volontà di risalire <strong>vers</strong>o le orig<strong>in</strong>i. Il suo stesso partire, come dichiara il personaggio, altro non<br />
è che una premessa del ritorno. La conoscenza si fa memoria che si riacquista attra<strong>vers</strong>o il<br />
ritorno ad una dimensione mitica. La campagna diviene il luogo privilegiato del ritorno, il<br />
luogo della consapevolezza e della maturità dell’uomo che ritrova la sua orig<strong>in</strong>e: “Così questo<br />
paese, dove non sono nato, ho creduto per molto tempo che fosse tutto il mondo. Adesso che<br />
il mondo l’ho visto davvero e so che è fatto di tanti piccoli paesi, non so da ragazzo mi<br />
sbagliavo poi di molto” 344 .<br />
Lo spazio mitico costituito dai poli contrapposti e s-conf<strong>in</strong>anti di città e campagna diviene<br />
un’arena prediletta per lo svolgimento di molti romanzi che potremmo <strong>def</strong><strong>in</strong>ire modernisti.<br />
342<br />
E. Gioanola, Cesare Pavese, La realtà, l’altrove, il silenzio, cit. p. 36.<br />
343<br />
Ivi, p. 27.<br />
344<br />
Cesare Pavese, La luna e i falò (1950), E<strong>in</strong>audi, Tor<strong>in</strong>o, 1999, p. 9.<br />
101
Lawrence seppe utilizzare magistralmente questo schema per dar vita alle sue vicende<br />
mitiche-contemporanee. Il romanzo Sons and Lo<strong>vers</strong> è costruito proprio sulla<br />
contrapposizione della città e della campagna. Ambientato nelle Midlands <strong>in</strong>glesi, presso un<br />
paese di m<strong>in</strong>atori, il romanzo di Lawrence verte prevalentemente su questo contrasto. I<br />
personaggi che si confrontano all’<strong>in</strong>terno del romanzo sembrano corsi da un’ansia di tipo<br />
esistenziale. Essi si configurano, al pari di molti personaggi pavesiani, come portatori del<br />
civile e del selvaggio nello stesso momento. Il loro vacillare sul conf<strong>in</strong>e fra queste due<br />
dimensioni li rende personaggi tragici per eccellenza. Soprattutto il personaggio pr<strong>in</strong>cipale,<br />
Paul, è deputato al r<strong>in</strong>venimento di una dimensione tragica dell’esistente. E’ una tragedia che<br />
prende corpo nell’ambito di un processo di conoscenza a ritroso che sembra impegnare molti<br />
dei personaggi degli scrittori modernisti; la consapevolezza si acquisisce, così come avvenuto<br />
per Corrado <strong>in</strong> La casa <strong>in</strong> coll<strong>in</strong>a o per Anguilla <strong>in</strong> La luna e i falò, attra<strong>vers</strong>o il graduale<br />
reperimento di tracce. Sono tracce che usualmente vengono rimosse dall’io cosciente<br />
moderno ma che si possono riscoprire <strong>in</strong> una dimensione ibrida, come quella campagnola, e al<br />
contatto di personaggi “terrestri”. Il viaggio di Paul, e <strong>in</strong> questo troviamo una netta<br />
similitud<strong>in</strong>e con i personaggi di Pavese, si trasforma dunque <strong>in</strong> ricerca ontologica. I poli<br />
contrapposti di questa ricerca sono, per l’appunto, la città e la campagna che si costituiscono<br />
come elementi opponenti ed ibridi. Anche <strong>in</strong> questo caso si può parlare di spazio mitico nel<br />
momento <strong>in</strong> cui città e campagna assumono delle caratteristiche ben del<strong>in</strong>eate. All’<strong>in</strong>terno<br />
della geografia designata da Lawrence la simbologia di questi due poli opposti è<br />
cont<strong>in</strong>uamente <strong>in</strong>terpretabile e cont<strong>in</strong>uamente si offre ai personaggi a questo scopo.<br />
Paul, durante l’adolescenza, fa esperienza della decadenza che la modernità sta immettendo<br />
nell’uni<strong>vers</strong>o rurale. La madre di Paul, Miss Morel, auspica che il figlio possa uscire dalla<br />
comunità di m<strong>in</strong>atori ed accetti le regole delle “middle classes”. Ma il significato che la<br />
borghesia attribuisce alla vita è svilente per il giovane che, soprattutto, detesta le costruzioni<br />
ideali che governano la vita delle classi medie. Quella della felicità è una di queste costruzioni<br />
ideali che non trova riscontro nella sensibilità “naturale” di Paul. Seguire la propria natura e il<br />
proprio dest<strong>in</strong>o è una operazione che si situa <strong>in</strong> un’altra dimensione, <strong>in</strong> cui le leggi della classe<br />
borghese non si applicano. La pienezza di vita, a cui Paul aspira, non ha niente a che vedere<br />
con i raggiungimenti che gli uom<strong>in</strong>i moderni si prefiggono. La felicità appare una categoria ad<br />
uso e consumo della classe borghese che niente ha a che vedere con le leggi della natura. Nel<br />
seguente colloquio, tra madre e figlio, la distanza delle posizioni appare impercorribile:<br />
“My boy”, said his mother to him, “all your cleverness, your break<strong>in</strong>g away from old th<strong>in</strong>gs, and tak<strong>in</strong>g life <strong>in</strong><br />
your own hands, doesn’t seem to br<strong>in</strong>g you much happ<strong>in</strong>ess”.<br />
“What is happ<strong>in</strong>ess!” he cried. “It’s noth<strong>in</strong>g to me! How am I to be happy?” […]<br />
“You meaneasy , mother”, he cried. “That’s a woman’s whole doctr<strong>in</strong>e of life – ease of soul and physical comfort.<br />
And I do despise it”.<br />
“Oh, do you! Replied his mother. “And do you call yours a div<strong>in</strong>e discontent?”<br />
“Yes. I don’t care about its div<strong>in</strong>ity. But damn your happ<strong>in</strong>ess! So long as life’s full, It doesn’t matter whether it’s<br />
happy or not. I’m afraid your happ<strong>in</strong>ess would bore me”.<br />
“You never give it a chance”, she said. Then suddenly all her passion of grief over him broke out. “But it does<br />
matter!” she cried. “And you ought to be happy, you ought to try to be happy, to live to be happy. How could I<br />
bear to th<strong>in</strong>k your life wouldn’t be a happy one!” […]<br />
“[…] Battle – battle – and suffer. It’s about all you do, as far as I can see”.<br />
“But why not, my dear? I tell you it’s the best - - “<br />
“It isn’t. And one ought to be happy, one ought”. […]<br />
“But I want you to be happy”, she said pathetically.<br />
“Eh, my dear – say rather you want me to live” 345 .<br />
345 D.H. Lawrence, Sons and lo<strong>vers</strong>, cit. pp. 314-315.<br />
102
Il paese di campagna, dove la famiglia Morel vive, è il luogo rurale dove la civiltà fa il suo<br />
<strong>in</strong>gresso attra<strong>vers</strong>o la fabbrica, gli orari disumani di lavoro, l’alcol, la malattia. Paul, passata<br />
l’adolescenza, tenterà l’esperienza di lavorare proprio nella città per sottrarsi alla decadenza e<br />
all’abbandono che la campagna nativa gli ispirava. Ma non è ovviamente la città la<br />
risoluzione dei mali di Paul che svolge una vita da pendolare. La famiglia Morel si trova<br />
dunque a vivere <strong>in</strong> un uni<strong>vers</strong>o ibrido dove città e campagna formano, <strong>in</strong>sieme, un <strong>in</strong>dist<strong>in</strong>to e<br />
caotico amalgama da cui è difficile discernere un senso. In un mondo, quello rurale, colmo<br />
ancora di simboli e di significati mitici, la civiltà avanza con la sua <strong>in</strong>dustria modificando i<br />
paesaggi e gli uom<strong>in</strong>i:<br />
Then he looked wistfully out of the w<strong>in</strong>dow. Already he was a prisoner of <strong>in</strong>dustrialism. Large sunflowers stared<br />
over the old red wall of the garden opposite, look<strong>in</strong>g <strong>in</strong> their jolly way down on the women who were hurry<strong>in</strong>g<br />
with someth<strong>in</strong>g for d<strong>in</strong>ner. The valley was full of corn, brighten<strong>in</strong>g <strong>in</strong> the sun. Two collieries, among the fields,<br />
waved their small white plumes of steam. Far off on the hills were the woods of Annesley, dark and fasc<strong>in</strong>at<strong>in</strong>g.<br />
Already his heart went down. He was be<strong>in</strong>g taken <strong>in</strong>to bondage. His freedom <strong>in</strong> the beloved home valley was<br />
go<strong>in</strong>g now 346 .<br />
E’ la stessa sensazione che si esprime nel saggio Nott<strong>in</strong>gham and the mean<strong>in</strong>g countryside<br />
dove l’esperienza moderna si struttura <strong>def</strong><strong>in</strong>itivamente come dislocamento. Il processo di<br />
deterioramento non è però ancora completo e l’autore spiega la sua strana impressione di<br />
vivere <strong>in</strong> un mondo di conf<strong>in</strong>e dai significati <strong>in</strong>certi, <strong>in</strong> cui qualcosa sta cambiando molto<br />
rapidamente, ma che cont<strong>in</strong>ua a serbare tracce di un senso più antico e genu<strong>in</strong>o che aveva<br />
trovato espressione nelle pag<strong>in</strong>e dei grandi autori classici <strong>in</strong>glesi: “[…] the life was a curious<br />
cross between <strong>in</strong>dustrialism and the old agricultural England of Shakespeare and Milton and<br />
Field<strong>in</strong>g and George Eliot” 347 . Verso metà della vicenda, quando Paul <strong>in</strong>tende portare la<br />
madre nella grande città, il gioco dei contrasti si rende particolarmente evidente. Nel giro di<br />
una pag<strong>in</strong>a Lawrence passa dalla descrizione di un paesaggio campestre, fitto di misteri<br />
selvaggi, alla descrizione della città poliforme e sconosciuta. La descrizione del paesaggio<br />
naturale è condotta attra<strong>vers</strong>o una serie di contrasti. I colori dei fiori si stagliano sull’oscurità<br />
della foresta:<br />
At the edge of the wood the bluebells had flowed over <strong>in</strong>to the field and stood there like flood-water. But they<br />
were fad<strong>in</strong>g now. Clara strayed up to them. He wandered after her. The bluebells pleased him. "Look how<br />
they've come out of the wood!" he said 348 .<br />
Il loro aspetto gentile e raff<strong>in</strong>ato è associato dal protagonista a visioni di popolazioni arcaiche<br />
che fuoriescono dal magma caotico della vegetazione:<br />
His blood beat up.<br />
"It makes me th<strong>in</strong>k of the wild men of the woods, how terrified they would be when they got breast to breast<br />
with the open space."<br />
346 D. H. Lawrence, Sons and Lo<strong>vers</strong>, cit. pp. 113-14.<br />
347 D. H. Lawrence, Nott<strong>in</strong>gham and the mean<strong>in</strong>g countryside, contenuto <strong>in</strong> Fiona Beckett, The complete guide to<br />
D. H. Lawrence, Routledge, London and New York, 2002, p.43.<br />
348 D. H. Lawrence, Sons and Lo<strong>vers</strong>, cit. pp. 292-95.<br />
103
"Do you th<strong>in</strong>k they were?" she asked.<br />
"I wonder which was more frightened among old tribes -- those burst<strong>in</strong>g out of their darkness of woods upon all<br />
the space of light, or those from the open tiptoe<strong>in</strong>g <strong>in</strong>to the forests" 349 .<br />
Così come Clara era stata associata poche righe prima ai fiori del campo, descritta quasi come<br />
fosse parte di quella natura floreale (“The chill flowers fell on her neck. She looked up at him,<br />
with almost pitiful, scared grey eyes, wonder<strong>in</strong>g what he was do<strong>in</strong>g. Flowers fell on her face,<br />
and she shut her eyes”), allo stesso modo viene ora messa <strong>in</strong> relazione all’immag<strong>in</strong>e di<br />
primitiva bellezza evocata da Paul:<br />
"I should th<strong>in</strong>k the second," she answered.<br />
"Yes, you do feel like one of the open space sort, try<strong>in</strong>g to force yourself <strong>in</strong>to the dark, don't you?" 350<br />
E’ il carattere assoluto della natura, la categoria tragica del selvaggio che comprende <strong>in</strong> sé,<br />
<strong>in</strong>differentemente, tutto ciò che la cultura moderna <strong>def</strong><strong>in</strong>isce <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i di bellezza o di<br />
bruttezza, di bontà di cattiveria. La violenza delle orig<strong>in</strong>i, il nesso sangue-sesso, è<br />
approfondita <strong>in</strong> seguito da Lawrence che trova nei simboli naturali il miglior tramite per<br />
esprimere questo rapporto. I petali rossi cadono a terra dal seno di Clara come gocce di<br />
sangue:<br />
Everyth<strong>in</strong>g was perfectly still. There was noth<strong>in</strong>g <strong>in</strong> the afternoon but themselves. When she arose, he, look<strong>in</strong>g<br />
on the ground all the time, saw suddenly spr<strong>in</strong>kled on the black wet beech-roots many scarlet carnation petals,<br />
like splashed drops of blood; and red, small splashes fell from her bosom, stream<strong>in</strong>g down her dress to her<br />
feet 351 .<br />
La rete di rapporti che Lawrence crea tra donna, natura e selvaggio avviene sullo sfondo di<br />
misteriose coll<strong>in</strong>e che trattengono <strong>in</strong> loro profondi <strong>in</strong>decifrabili significati:<br />
The even<strong>in</strong>g was deepen<strong>in</strong>g over the earth. Already the valley was full of shadow. One t<strong>in</strong>y square of light stood<br />
opposite at Crossleigh Bank Farm. Brightness was swimm<strong>in</strong>g on the tops of the hills. Miriam came up slowly,<br />
her face <strong>in</strong> her big, loose bunch of flowers, walk<strong>in</strong>g ankle-deep through the scattered froth of the cowslips.<br />
Beyond her the trees were com<strong>in</strong>g <strong>in</strong>to shape, all shadow. […] They were all silent. Go<strong>in</strong>g down the path they<br />
could see the light of home right across, and on the ridge of the hill a th<strong>in</strong> dark outl<strong>in</strong>e with little lights, where<br />
the colliery village touched the sky 352 .<br />
Nel giro di poche righe Paul si ritrova però nella città di L<strong>in</strong>coln dove la simbologia appare<br />
di<strong>vers</strong>a ma non meno profonda:<br />
349 Ibidem.<br />
350 Ibidem.<br />
351 Ivi, p. 379.<br />
352 Ibidem.<br />
104
They drew near to the city. Both were at the w<strong>in</strong>dow look<strong>in</strong>g for the cathedral.<br />
"There she is, mother!" he cried.<br />
They saw the great cathedral ly<strong>in</strong>g couchant above the pla<strong>in</strong>.<br />
"Ah!" she exclaimed. "So she is!"<br />
He looked at his mother. Her blue eyes were watch<strong>in</strong>g the cathedral quietly. She seemed aga<strong>in</strong> to be beyond him.<br />
Someth<strong>in</strong>g <strong>in</strong> the eternal repose of the uplifted cathedral, blue and noble aga<strong>in</strong>st the sky, was reflected <strong>in</strong> her,<br />
someth<strong>in</strong>g of the fatality. What was, was. With all his young will he could not alter it. He saw her face, the sk<strong>in</strong><br />
still fresh and p<strong>in</strong>k and downy, but crow's- feet near her eyes, her eyelids steady, s<strong>in</strong>k<strong>in</strong>g a little, her mouth<br />
always closed with disillusion; and there was on her the same eternal look, as if she knew fate at last. He beat<br />
aga<strong>in</strong>st it with all the strength of his soul 353 .<br />
La cattedrale che sovrasta la città è questa volta associata alla figura immobile ed altera della<br />
madre di Paul. La simbologia è ancora <strong>in</strong> questo caso complessa e impossibile da risolvere,<br />
f<strong>in</strong>anche nello spazio di una vita così come avviene appunto per la signora Morel:<br />
"Look, mother, how big she is above the town! Th<strong>in</strong>k, there are streets and streets below her! She looks bigger<br />
than the city altogether." "So she does!" exclaimed his mother, break<strong>in</strong>g bright <strong>in</strong>to life aga<strong>in</strong>. But he had seen<br />
her sitt<strong>in</strong>g, look<strong>in</strong>g steady out of the w<strong>in</strong>dow at the cathedral, her face and eyes fixed, reflect<strong>in</strong>g the<br />
relentlessness of life. And the crow's-feet near her eyes, and her mouth shut so hard, made him feel he would go<br />
mad 354 .<br />
Città e campagna vengono dunque caratterizzate da Lawrence come due luoghi significanti, la<br />
cui simbologia è da <strong>in</strong>terpretare di volta <strong>in</strong> volta. I due poli si scontrano senza che lo scrittore<br />
offra chiavi <strong>in</strong>terpretative, senza che venga espresso alcun giudizio di gusto che svii il lettore<br />
dall’<strong>in</strong>terpretazione dei simboli. Il simbolismo, funzionale allo svolgimento di una poetica del<br />
mito, è dunque preferito all’allegoria: “You must look through the surface […] and see the<br />
<strong>in</strong>ner diabolism of the symbolic mean<strong>in</strong>g” 355 . Mondo e terra si contrappongono attra<strong>vers</strong>o gli<br />
uni<strong>vers</strong>i simbolici della città e della campagna e trovano, nell’<strong>in</strong>teragire dei personaggi<br />
un’ulteriore possibilità significante. Vickery constata come questi fasci di relazioni non si<br />
esauriscono a vicenda ma vivono e si riproducono attra<strong>vers</strong>o una serie di commistioni tese a<br />
creare un uni<strong>vers</strong>o ibrido. In questo <strong>in</strong>contro-scontro fra mondi si situa lo sguardo ironico di<br />
Lawrence:<br />
For him, myth functions as a satiric device by offer<strong>in</strong>g contrast between the mythico-realistic life of ancient man<br />
and that of contemporary man, which is profane because commonplace and ord<strong>in</strong>ary. It also affords an ironic<br />
sense of the cont<strong>in</strong>uity between the two worlds that shows how the one may be both a degeneration and an<br />
adaptation of the other 356 .<br />
353<br />
Ibidem.<br />
354<br />
Ibidem.<br />
355<br />
D. H. Lawrence, Studies <strong>in</strong> Classic American Literature, contenuto <strong>in</strong> F.Beckett, The complete guide to D. H.<br />
Lawrence, cit. p.85.<br />
339<br />
J. B. Vickery, The literary Impact of The Golden Bough, cit. p. 322.<br />
105
La città si lega dunque alla campagna nello stessa maniera <strong>in</strong> cui vi si oppone e, attra<strong>vers</strong>o<br />
l’agire dei personaggi, questo gioco di proiezioni svela tutta la sua importanza: “[…] <strong>in</strong> the<br />
tension of opposites all th<strong>in</strong>gs have their be<strong>in</strong>g” 357 . Così come l’amante Clara, sotto i paesaggi<br />
coll<strong>in</strong>ari, era stata descritta come una n<strong>in</strong>fa tempestata di fiori, salvo poi specificare che<br />
quegli stessi fiori erano simbolo del selvaggio, alla stessa maniera la madre viene adornata di<br />
fiori comprati ad un chiosco cittad<strong>in</strong>o. Il gioco delle corrispondenze e dei simboli si fa a<br />
questo punto sempre più denso:<br />
And he bought her some blue violets.<br />
"Stop it at once, sir!" she commanded. "How can I do it?"<br />
"You've got noth<strong>in</strong>g to do. Stand still!"<br />
And <strong>in</strong> the middle of High Street he stuck the flowers <strong>in</strong> her coat 358 .<br />
Che il rapporto tra città e coll<strong>in</strong>a qui del<strong>in</strong>eato abbia delle profonde implicazioni ontologiche,<br />
è lo stesso Lawrence a confermarlo. La ricerca dell’essere, dell’orig<strong>in</strong>e, avviene attra<strong>vers</strong>o lo<br />
svolgimento della simbologia su cui la vicenda è costruita, attra<strong>vers</strong>o la vicenda mitica dei<br />
personaggi che agiscono su spazi mitizzati. Così come per Conrad il cuore di tenebra<br />
rappresentava quel centro <strong>vers</strong>o il quale l’uomo viaggiava a ritroso per riscoprire le sue<br />
orribili orig<strong>in</strong>i, così per Lawrence l’essere orig<strong>in</strong>ario è un’ombra che sa di morte:<br />
To him now, life seemed a shadow, day a white shadow; night, and death, and stillness, and <strong>in</strong>action, this seemed<br />
like be<strong>in</strong>g. To be alive, to be urgent and <strong>in</strong>sistent -- that was not-to-be. The highest of all was to melt out <strong>in</strong>to the<br />
darkness and sway there, identified with the great Be<strong>in</strong>g.<br />
"The ra<strong>in</strong> is com<strong>in</strong>g <strong>in</strong> on us," said Miriam.<br />
He rose, and assisted her.<br />
"It is a pity," he said.<br />
"What?"<br />
"To have to go. I feel so still."<br />
"Still!" she repeated.<br />
"Stiller than I have ever been <strong>in</strong> my life."<br />
He was walk<strong>in</strong>g with his hand <strong>in</strong> hers. She pressed his f<strong>in</strong>gers, feel<strong>in</strong>g a slight fear. Now he seemed beyond her;<br />
she had a fear lest she should lose him.<br />
"The fir-trees are like presences on the darkness: each one only a presence."<br />
She was afraid, and said noth<strong>in</strong>g.<br />
357<br />
D. H. Lawrence, Birds, beast and Flowers (1923), contenuto <strong>in</strong> F. Beckett, The complete guide to D. H.<br />
Lawrence, cit. p. 45.<br />
358<br />
D. H. Lawrence, Sons and Lo<strong>vers</strong>, cit. p. 379.<br />
106
"A sort of hush: the whole night wonder<strong>in</strong>g and asleep: I suppose that's what we do <strong>in</strong> death-sleep <strong>in</strong><br />
wonder" 359 .<br />
In questo passaggio è evidente non solo l’implicazione ontologica presente nel romanzo di<br />
Lawrence ma soprattutto la relazione simbolica che si stabilisce tra gli elementi della<br />
geografia mitica, i paesaggi campestri, le stagioni, la luce, e l’essere stesso 360 . Così come<br />
avvenuto con Conrad, l’essere è descritto come mistero (darkness), come mezza luce<br />
heideggeriana (white shadow), come possibilità aperta ma terrorizzante. La natura parla<br />
all’uomo, lo <strong>in</strong>serisce nel suo stesso discorso che avviene tramite lo scorrere del giorno e delle<br />
stagioni, lo scorrere della pioggia e il brillare del sole. I personaggi di Lawrence si sperdono<br />
<strong>in</strong> questo uni<strong>vers</strong>o significante riuscendo a percepire il senso che gli si offre esclusivamente a<br />
frammenti, <strong>in</strong> una successione di bagliori che emergono dall’oscurità. Entrare <strong>in</strong> contatto con<br />
l’eternità della natura, lasciarsi fluire nelle sue vene, r<strong>in</strong>unciare alla pretesa di <strong>in</strong>dividualità<br />
moderna, per ritrovare una comunione con il tutto che vive, è l’utopia espressa da Lawrence:<br />
There was a sound of ra<strong>in</strong> everywhere, smother<strong>in</strong>g everyth<strong>in</strong>g.<br />
"I feel so strange and still," he said; "along with everyth<strong>in</strong>g."<br />
"Ay," she answered patiently.<br />
He seemed aga<strong>in</strong> unaware of her, though he held her band close.<br />
"To be rid of our <strong>in</strong>dividuality, which is our will, which is our effort -- to live effortless, a k<strong>in</strong>d of curious sleep -<br />
- that is very beautiful, I th<strong>in</strong>k; that is our after-life -- our immortality."<br />
"Yes?"<br />
"Yes -- and very beautiful to have" 361 .<br />
In questo spazio mitico altamente significante, l’<strong>in</strong>flusso di Frazer è evidente così come nota<br />
Vickery: “[…] the <strong>in</strong>calculable nature of human m<strong>in</strong>d, and the mistery of the natural but<br />
liv<strong>in</strong>g world further demonstrate the extent to which he was imbued with the material of The<br />
Golden Bough” 362 . Per Vickery il sistema letterario di Lawrence si basa su un impresc<strong>in</strong>dibile<br />
contrasto fra la coscienza e i modi della razionalità e l’<strong>in</strong>conscio e i modi dell’ist<strong>in</strong>tualità:<br />
“[…] the novels, many of which may be viewed, at least <strong>in</strong> part, as patterns of tension<br />
between the ord<strong>in</strong>ary, common-sense mode of consciousness and the blood-counsciouusness<br />
which, as we have already seen, Lawrence l<strong>in</strong>ked so closely to the contents of Frazer’s<br />
359 D. H. Lawrence, Sons and Lo<strong>vers</strong>, cit. pp. 350-51.<br />
360 Per Michael Bell quello dell’ontologia è un riferimento costante <strong>in</strong> tutta la produzione di Lawrence:<br />
“Lawrence was possessed by an ontological vision; a responsiveness to Be<strong>in</strong>g. He expressed this repeatedly <strong>in</strong><br />
fiction, criticism, essays, plays, poems and travel writ<strong>in</strong>g. His successful works across these genres would make<br />
up a substantial oevre. Of its nature such an ontological vision lay essentially <strong>in</strong> the proto-ethical sphere, and part<br />
of Lawrence’s restlessness lay <strong>in</strong> his seek<strong>in</strong>g always to relate it to the more ord<strong>in</strong>ary processes of everyday life,<br />
both <strong>in</strong>dividually and socially. This is where many of his creative problems arose, as well as his achievements.<br />
He was <strong>in</strong>creas<strong>in</strong>gly at odds with his culture, and his rhetoric became at times empty or private while his novels,<br />
as I have shown elsewhere, are <strong>in</strong>creas<strong>in</strong>gly struggles with the realist novel form itself”. M.Bell, Literature,<br />
modernism and myth, belief and responsibility <strong>in</strong> the twentieth century, cit. p. 97.<br />
361 D. H. Lawrence, Sons and Lo<strong>vers</strong>, cit. pp. 350-51.<br />
362 J. B. Vickery, The literary Impact of The Golden Bough, cit. p. 308.<br />
107
work” 363 . Molti degli elementi simbolici presenti nel Ramo d’oro sono riproposti qui da<br />
Lawrence. Essi costituiscono lo sfondo <strong>in</strong> cui si svolge la narrazione ma la loro importanza<br />
non è m<strong>in</strong>ore di quella dei personaggi che <strong>in</strong> tale sfondo si muovono. La luna piena, il campo<br />
di grano, la coll<strong>in</strong>a, divengono parte <strong>in</strong>tegrante, fondamentale, di tutta la narrazione. Vickery<br />
associa soprattutto i cont<strong>in</strong>ui riferimenti ai campi di grano operati da Lawrence allo “Spirito<br />
del Grano” di cui parla Frazer. Il grano si pone dunque come immag<strong>in</strong>e di fertilità e di<br />
rigogliosità e come tramite privilegiato tra la natura e l’uomo: “Their associations<br />
(charachters) with the fertility deities of the ancient world are accentuated by the images of<br />
vegetative fertility which run through many of the tales and novels. […] The majority of these<br />
<strong>in</strong>stances reveal the natural flourish<strong>in</strong>g of lives that ma<strong>in</strong>ta<strong>in</strong> contact with the underly<strong>in</strong>g<br />
rhythms of the physical world” 364 . Gli uom<strong>in</strong>i divengono parte di quest’uni<strong>vers</strong>o significante<br />
ma non possono estendere il loro dom<strong>in</strong>io su di esso. Al contrario non potranno far altro che<br />
rimanere estasiati <strong>in</strong> contemplazione consapevoli che qualsiasi <strong>in</strong>terrogazione - qualsiasi<br />
volontà di farsi io pensante e superiore di fronte alla natura - è dest<strong>in</strong>ata ad essere frustrata:<br />
The beauty of the night made him want to shout. A half-moon, dusky gold, was s<strong>in</strong>k<strong>in</strong>g beh<strong>in</strong>d the black<br />
sycamore at the end of the garden, mak<strong>in</strong>g the sky dull purple with its glow. Nearer, a dim white fence of lilies<br />
went across the garden, and the air all round seemed to stir with scent, as if it were alive. He went across the bed<br />
of p<strong>in</strong>ks, whose keen perfume came sharply across the rock<strong>in</strong>g, heavy scent of the lilies, and stood alongside the<br />
white barrier of flowers. They flagged all loose, as if they were pant<strong>in</strong>g. The scent made him drunk. He went<br />
down to the field to watch the moon s<strong>in</strong>k under. A corncrake <strong>in</strong> the hay-close called <strong>in</strong>sistently. The moon slid<br />
quite quickly downwards, grow<strong>in</strong>g more flushed. Beh<strong>in</strong>d him the great flowers leaned as if they were call<strong>in</strong>g.<br />
And then, like a shock, he caught another perfume, someth<strong>in</strong>g raw and coarse. Hunt<strong>in</strong>g round, he found the<br />
purple iris, touched their fleshy throats and their dark, grasp<strong>in</strong>g hands. At any rate, he had found someth<strong>in</strong>g.<br />
They stood stiff <strong>in</strong> the darkness. Their scent was brutal. The moon was melt<strong>in</strong>g down upon the crest of the hill. It<br />
was gone; all was dark. The corncrake called still 365 .<br />
La natura è una presenza forte nel romanzo di Lawrence. Essa è del tutto <strong>in</strong>differente ai<br />
personaggi quasi che agisca <strong>in</strong> una dimensione di<strong>vers</strong>a rispetto a quella dell’umano agire. La<br />
sua presenza è rimarchevole e autoritaria e cont<strong>in</strong>uamente ricorda ai protagonisti della<br />
vicenda che esiste qualcosa di superiore, qualcosa di <strong>in</strong>eluttabile che travalica la ragione<br />
umana. Le azioni umane non agiscono attivamente sulle eterne leggi della natura. L’uomo si<br />
scopre parte <strong>in</strong>tegrante di quella realtà e concepisce la sua sofferenza come volontario<br />
coscienzioso allontanamento dal suo essere. La vicenda di Paul e Clara assume presto i<br />
contorni del mito. La loro storia è significante <strong>in</strong> quanto parte della storia assoluta<br />
dell’umanità, non parte della storia relativa dell’<strong>in</strong>dividualità. La natura si svela dunque<br />
essere, <strong>in</strong> tutte le sue reali ed orrende implicazioni, un paradiso terrestre dove Paul e Clara<br />
ripropongono il mito adamitico:<br />
Clara was rather quiet and uncomfortable. As they walked along, he said:<br />
"You don't feel crim<strong>in</strong>al, do you?"<br />
She looked at him with startled grey eyes.<br />
363 Ivi, p. 307.<br />
364 Ivi, p. 318.<br />
365 D. H. Lawrence, Sons and Lo<strong>vers</strong>, cit. pp. 358-59.<br />
108
"Crim<strong>in</strong>al!" she said. "No."<br />
"But you seem to feel you have done a wrong?"<br />
"No," she said. "I only th<strong>in</strong>k, 'If they knew!'"<br />
"If they knew, they'd cease to understand. As it is, they do understand, and they like it. What do they matter?<br />
Here, with only the trees and me, you don't feel not the least bit wrong, do you?"<br />
He took her by the arm, held her fac<strong>in</strong>g him, hold<strong>in</strong>g her eyes with his. Someth<strong>in</strong>g fretted him.<br />
"Not s<strong>in</strong>ners, are we?" he said, with an uneasy little frown.<br />
"No," she replied.<br />
He kissed her, laugh<strong>in</strong>g.<br />
"You like your little bit of guilt<strong>in</strong>ess, I believe," he said. "I believe Eve enjoyed it, when she went cower<strong>in</strong>g<br />
out of Paradise" 366 .<br />
E’ <strong>in</strong> questa sua potenza che la natura si svela essere dest<strong>in</strong>o per i protagonisti della vicenda<br />
obbligandoli a vivere la propria esistenza come fosse una favola mitica. Ma i protagonisti si<br />
rendono presto conto di essere <strong>in</strong> balia di forze più grandi di loro e che l’unica loro saggezza è<br />
quella di r<strong>in</strong>unciare alla loro <strong>in</strong>dividualità per divenire parte di un tutto che li sovrasta. Gli<br />
stessi personaggi divengono mitici: “She could not help herself; she was <strong>in</strong> the grip of<br />
someth<strong>in</strong>g bigger than herself. A k<strong>in</strong>d of eternal look about her, as if she were a wistful<br />
sph<strong>in</strong>x […]” 367 . Nella conclusione della vicenda i protagonisti sembrano aver raggiunto una<br />
nuova consapevolezza. La natura ha preso possesso della loro esistenza che si è sviluppata,<br />
nell’arco della vicenda narrata da Lawrence, come fosse una parabola mitica. Alla f<strong>in</strong>e del<br />
romanzo i protagonisti si sentono contenuti nel mistero (the night) che all’<strong>in</strong>izio della storia<br />
<strong>in</strong>cuteva <strong>in</strong> loro timore. I miti della genesi e della successiva <strong>in</strong>iziazione si sono perpetrati per<br />
l’ennesima volta attra<strong>vers</strong>o di loro e nonostante la loro <strong>in</strong>consapevolezza:<br />
And after such an even<strong>in</strong>g they both were very still, hav<strong>in</strong>g known the immensity of passion. They felt small,<br />
half-afraid, childish and wonder<strong>in</strong>g, like Adam and Eve when they lost their <strong>in</strong>nocence and realised the<br />
magnificence of the power which drove them out of Paradise and across the great night and the great day of<br />
humanity. It was for each of them an <strong>in</strong>itiation and a satisfaction. To know their own noth<strong>in</strong>gness, to know the<br />
tremendous liv<strong>in</strong>g flood which carried them always, gave them rest with<strong>in</strong> themselves. If so great a magnificent<br />
power could overwhelm them, identify them altogether with itself, so that they knew they were only gra<strong>in</strong>s <strong>in</strong> the<br />
tremendous heave that lifted every grass blade its little height, and every tree, and liv<strong>in</strong>g th<strong>in</strong>g, then why fret<br />
about themselves? They could let themselves be carried by life, and they felt a sort of peace each <strong>in</strong> the other.<br />
There was a verification which they had had together. Noth<strong>in</strong>g could nullify it, noth<strong>in</strong>g could take it away; it was<br />
almost their belief <strong>in</strong> life. […] In the morn<strong>in</strong>g he had considerable peace, and was happy <strong>in</strong> himself. It seemed<br />
almost as if he had known the baptism of fire <strong>in</strong> passion, and it left him at rest. But it was not Clara. It was<br />
someth<strong>in</strong>g that happened because of her, but it was not her. They were scarcely any nearer each other. It was as<br />
if they had been bl<strong>in</strong>d agents of a great force 368 .<br />
Che i temi legati al dest<strong>in</strong>o fossero caratteristici di un certo tipo di modernismo ci è<br />
366 Ivi, pp. 381-82.<br />
367 Ivi, p. 403.<br />
368 Ivi, pp. 430-31.<br />
109
confermato da Lawrence. Dest<strong>in</strong>o, determ<strong>in</strong>ismo e libero arbitrio divengono temi fondanti di<br />
Sons and Lo<strong>vers</strong>. Lawrence riflette sul significato di tutta la vicenda amorosa del suo<br />
protagonista chiamando <strong>in</strong> gioco forze esterne alla volontà degli stessi protagonisti. L’uomo si<br />
scopre governato non esclusivamente dalle leggi morali e sociali che il mondo gli impone ma<br />
anche da quelle, forse più potenti e v<strong>in</strong>colanti, della natura. Al contempo trova nella<br />
comprensione delle forze a lui esterne un nuovo modo di correlarsi ad esse e qu<strong>in</strong>di anche a se<br />
stesso:<br />
In the morn<strong>in</strong>g he had considerable peace, and was happy <strong>in</strong> himself. It seemed almost as if he had known the<br />
baptism of fire <strong>in</strong> passion, and it left him at rest. But it was not Clara. It was someth<strong>in</strong>g that happened because of<br />
her, but it was not her. They were scarcely any nearer each other. It was as if they had been bl<strong>in</strong>d agents of a great<br />
force 369 .<br />
In questa nuova correlazione del se stesso alle forze della natura, <strong>in</strong> questo consapevole<br />
legame che è dopotutto accettazione del proprio dest<strong>in</strong>o di essere umano, Paul trova un nuovo<br />
senso alla propria vita, un senso dettato da un ist<strong>in</strong>to e da una conoscenza delle leggi arcaiche.<br />
E’ una scelta che presuppone l’accettazione della dimensione tragica dell’esistenza e che pone<br />
il protagonista <strong>in</strong> un territorio di conf<strong>in</strong>e.<br />
Le tematiche dell’ontologia, la filosofia dell’essere, si <strong>in</strong>crociano qui con quelle<br />
dell’etnologia. Per Vickery, Lawrence fa agire i suoi personaggi come attori all’<strong>in</strong>terno dello<br />
svolgimento di un mito. La loro <strong>in</strong>dividualità è messa <strong>in</strong> discussione. Il loro agire diviene un<br />
modo di agire primitivo ed <strong>in</strong> loro riaffiora quel selvaggio dionisiaco, tratto caratteristico del<br />
modernismo letterario. La stessa vicenda mitica diviene l’esposizione di un rituale nel<br />
momento <strong>in</strong> cui Lawrence accetta il dettame frazeriano per cui il rito altro non è che la<br />
drammatizzazione del mito: “[…] Lawrence adapts Frazer’s notion that ritual is dramatized<br />
myth, for <strong>in</strong> these actions there resides the qu<strong>in</strong>tessenzial story of the character’s nature and<br />
life” 370 :<br />
Beyond their physical and mental qualities Lawrence’s characters share other th<strong>in</strong>gs with Frazer’s primitive<br />
peoples. Like Frazer, Lawrence possessed a deep and persistent <strong>in</strong>terest <strong>in</strong> those human actions whose<br />
importance derives as much from their be<strong>in</strong>g performed by the majority of people as from their be<strong>in</strong>g essential to<br />
human existence. He focused on death, marriage, fornification, <strong>in</strong>itiation, danc<strong>in</strong>g, sacrifice, departure and<br />
arrival, and many other actions not merely because the conventions of fiction demand a k<strong>in</strong>d of loose realism but<br />
because they are performed, counsciously or not, <strong>in</strong> ritualistic fashion. The very manner of their performance<br />
testifies to their connection with the sacred existence, that is, the order <strong>in</strong> which the mysterious potency of life<br />
itself resides 371 .<br />
369 D.H. Lawrence, Sons and Lo<strong>vers</strong>, cit. p. 431.<br />
370 J. B. Vickery, The literary Impact of The Golden Bough, p. 316.<br />
371 Ivi, p. 309.<br />
110
L’<strong>in</strong>tenzione di Lawrence, dopo aver constatato l’esistenza di una dimensione storica e di una<br />
dimensione mitica, sembra quello di voler conciliare questi due poli che si contrappongono<br />
ma che risentono ognuno dell’<strong>in</strong>fluenza dell’altro. Partire dal racconto della vita di personaggi<br />
“normali”, che gradualmente riscoprono una dimensione mitica, appare funzionale a questo<br />
tentativo di rientrare nel flusso vitale della natura e dell’essere così come ipotizza Bell:<br />
“Lawrence’s creative difficulty was to f<strong>in</strong>d the proper relation between the div<strong>in</strong>e and the<br />
everyday” 372 . I personaggi di Lawrence si scontrano dunque con i problemi della quotidianità,<br />
arrancano alla ricerca di un senso attra<strong>vers</strong>o l’esperienza della vita di tutti i giorni. Ma la<br />
sensazione che ci sia qualcosa di più grande di loro che li sovrasta e che decide delle loro<br />
esistenze <strong>in</strong>dipendentemente dalla loro volontà è sempre presente e scorre parallela agli<br />
eventi narrati dall’autore:<br />
The story is typical of Lawrence <strong>in</strong> that its full force eludes a purely naturalistic explanation at the level of the<br />
social, ethical and personal psycology although, moment by moment, the action seems to be conducted <strong>in</strong> these<br />
terms. Some sort of transformation of the habitual and the everyday, a transformation for which miracle is a<br />
good popular term, is the essence 373 .<br />
E’ dunque il rapporto tra mito e storia ad essere centrale nelle opere dello scrittore. I<br />
personaggi si fanno <strong>in</strong>volontari portatori di questo messaggio. Il loro svolgere un’azione<br />
nell’<strong>in</strong>stabile e fugace mondo della quotidianità rimanda costantemente al suo corrispettivo:<br />
l’eternità del mito che governa le loro esistenze: “Lawrence’s mythopoetic consciousness is<br />
most crucially to be found not <strong>in</strong> his overt allusions to myth, but <strong>in</strong> this way of relat<strong>in</strong>g the<br />
personal and the impersonal, the conscious and the unconscious, <strong>in</strong> a holistic, flexible<br />
exploration of human be<strong>in</strong>g <strong>in</strong> the world” 374 .<br />
372 M. Bell, Literature, modernism and myth, belief and responsibility <strong>in</strong> the twentieth century, cit. p. 109.<br />
373 Ivi, p. 110.<br />
374 Ibidem.<br />
111
3.2 L’<strong>in</strong>contro con l’altro: il primitivismo modernista<br />
Così come il viaggio si <strong>in</strong>traprende alla ricerca di un “altrove” allo stesso modo, e allo stesso<br />
tempo, si <strong>in</strong>traprende alla ricerca dell’”altro”. Il motivo del selvaggio diviene estremamente<br />
funzionale nell’ambito del tema del viaggio e all’<strong>in</strong>terno dello spazio mitico. All’<strong>in</strong>terno di<br />
questo motivo sarà <strong>in</strong>teressante considerare come <strong>in</strong> epoca moderna, dall’illum<strong>in</strong>ismo f<strong>in</strong>o al<br />
tardo modernismo, l’<strong>in</strong>contro con l’altro si svilupperà come <strong>in</strong>contro con il di<strong>vers</strong>o. E’ un<br />
di<strong>vers</strong>o che, come vedremo assumerà di<strong>vers</strong>e forme soprattutto per quanto riguarda il<br />
modernismo poiché, come ricorda Michael Bell, il modernismo non fu una scuola di pensiero<br />
quanto una comune sensibilità. Bell parla di “primitivismo modernista” e di selvaggio come<br />
punto di approdo della speculazione modernista sul mito e sulle orig<strong>in</strong>i immemoriali<br />
dell’essere umano. Il selvaggio è difatti, nelle narrazioni moderniste, colui il quale è distante<br />
nel tempo e nello spazio, personaggio simbolico che richiama immediatamente una realtà<br />
mitica.<br />
Pavese utilizzò ampiamente questo motivo all’<strong>in</strong>terno dello spazio mitico designato, anzi ne<br />
divenne aspetto fondamentale: “Questa sovrapposizione di città e campagna ha, <strong>in</strong>somma,<br />
quale implicito trait d’union, l’oscura attrazione che l’uomo civile prova per la natura<br />
selvaggia, i cui tratti ricorrenti sono il sangue e il sesso. Di qui un’altra, decisiva scoperta del<br />
1933, il nesso uomo-belva, che prenderà corpo nella poesia <strong>in</strong>titolata Il dio-caprone […]” 375 .<br />
L’identificazione fra il fer<strong>in</strong>o e l’umano <strong>in</strong> ambito rustico si può dunque far risalire alla prima<br />
raccolta di Lavorare Stanca: “La vita sanguigna e segreta, lo sprigionarsi di energie primitive,<br />
la presenza quasi costante, anche se spesso sott<strong>in</strong>tesa, di tradizioni e rituali quasi barbarici,<br />
quella rusticità <strong>in</strong>somma, che caratterizzerà la campagna nelle realizzazioni più mature di<br />
Pavese, compare per la prima volta con evidenza nella poesia Il Dio-Caprone” 376 . Premuda<br />
constata la pregnanza del motivo riconducendolo alle letture frazeriane di Pavese. Il Dio-<br />
Caprone viene composto appunto nell’anno della prima lettura di Frazer, il 1933:<br />
(Il dio caprone) <strong>in</strong> cui motivi irrazionalistici nel violento primitivismo del sangue e del sesso sono mescolati a<br />
spunti di più immediata e limpida poesia campestre, dom<strong>in</strong>ati però sempre dall'immag<strong>in</strong>e del Dioniso pregreco,<br />
dio sfrenato della vegetazione: nè tale vena resta isolata <strong>in</strong> Lavorare Stanca: basta ricordare Gente che c'è stata,<br />
Donne appassionate e specialmente Luna d'Agosto che sono rappresentative di quello che poi il Pavese chiamerà<br />
il suo gusto mitico-rustico 377 .<br />
La campagna diviene dunque luogo privilegiato all’<strong>in</strong>terno dello spazio mitico di Pavese. E’<br />
un luogo mitico depositario dell’essere dove il selvaggio “accade” e si struttura come<br />
possibilità propria di quell’essere. La sua implicazione nell’ambito della dialettica cittàcampagna<br />
è svelata dallo stesso Pavese:<br />
Il selvatico che ci <strong>in</strong>teressa non è la natura il mare la selva ma l’imprevisto nel cuore dei nostri compagni uom<strong>in</strong>i.<br />
E’ il selvatico che con un semplice sforzo d’attenzione può diventare volontà deliberata. La città e la donna ci<br />
375<br />
M. de las Nieves Muniz Muniz, Introduzione a Pavese, cit. pp. 32-33.<br />
376<br />
Ivi.<br />
377<br />
M. L. Premuda, Annali della scuola superiore di Pisa, cit. pp. 238-242.<br />
112
usano una ferocia della quale ogni campagna <strong>in</strong>colta è soltanto un simbolo […]. La solitud<strong>in</strong>e di un bosco, <strong>in</strong> un<br />
campo di grano , può essere paurosa, può uccidere, ma non ci spaventa né uccide come uom<strong>in</strong>i, come volontà<br />
appassionate. Solamente gli altri sanno farci questo – gli altri, il prossimo, le donne , i compagni, i nostri figli. Di<br />
fronte a costoro, di fronte alla città, soffriamo sempre, soffriamo a fondo. […] Tanto vale accettare il mistero e<br />
popolare la città di simboli, e la campagna di presenze. E amare tutto questo – con cautela disperata 378 .<br />
E’ un essere che non è immediatamente fruibile ma va colto solo grazie all’<strong>in</strong>terpretazione<br />
del simbolo. La campagna di Pavese diviene il luogo del “proibito” nel momento <strong>in</strong> cui tale<br />
proibito si identifica con il rimosso, con ciò che la civiltà moderna si è abituata a nascondere.<br />
Essendo luogo di conf<strong>in</strong>e questa campagna ospita dunque il tragico r<strong>in</strong>venimento del<br />
proibito: il selvaggio appunto.<br />
Il motivo del selvaggio ha avuto una lunga gestazione nell’ambito della cultura occidentale.<br />
L’analisi storica del motivo viene a porsi <strong>in</strong> parallelo con le riflessioni di Pavese. E’ un<br />
percorso che condurrà <strong>vers</strong>o l’elaborazione letteraria del selvaggio che, nel caso di Pavese e<br />
Lawrence, si legherà ai motivi del nudismo e dei sacrifici umani. La funzione dell’”altro” ha<br />
assunto, nel tempo, forme e d<strong>in</strong>amiche differenti. Volendo <strong>def</strong><strong>in</strong>ire questo motivo<br />
nell’ambito del modernismo letterario si dovrà <strong>in</strong>trodurre il concetto di “primitivismo”. In<br />
questo contesto non si potrà, ovviamente e come del resto accaduto per tutte le tendenze del<br />
movimento, <strong>in</strong>dicare un approccio nei confronti della materia che riguardi tutti gli<br />
<strong>in</strong>tellettuali e gli scrittori dell’epoca. L’atteggiamento primitivista di molti scrittori<br />
modernisti fu più che altro dettato da una comune sensibilità di cui cercheremo, per prima<br />
cosa, di tracciare un’evoluzione storica. Il motivo dell’<strong>in</strong>contro con l’altro è, d’altra parte,<br />
presente <strong>in</strong> ogni cultura. E’ un altro che viene costruito dalla stessa cultura per poter <strong>def</strong><strong>in</strong>ire<br />
se stessa <strong>in</strong> base alle differenze r<strong>in</strong>tracciabili fra sé stessa e l’altro da sé:<br />
Poiché la cultura è un concetto chiuso, essa presuppone necessariamente una non cultura ai suoi antipodi, che si<br />
colloca all’esterno del suo conf<strong>in</strong>e […] Ogni cultura si crea il suo tipo di barbaro. […] Il fatto che questo ruolo<br />
presupponga il trovarsi fuori favorisce spesso un’<strong>in</strong>terpretazione spaziale. Di solito, secondo le idee della cultura<br />
data, le forze extraculturali si trovano fuori dai suoi conf<strong>in</strong>i territoriali. L’appartenenza ad un’altra cultura è così<br />
<strong>in</strong>terpretata spesso come assenza di cultura 379 .<br />
In epoca moderna l’<strong>in</strong>contro con l’altro avviene, spesso, nelle periferie e nelle zone di<br />
conf<strong>in</strong>e. Il protagonista dei romanzi modernisti si muove usualmente da un luogo all’altro<br />
<strong>in</strong>ducendo la narrazione a “spaziare” <strong>in</strong>sieme all’<strong>in</strong>terno di una geografia mitica.<br />
L’evoluzione del selvaggio modernista assume forme particolari <strong>in</strong>globando <strong>in</strong> se<br />
implicazioni non solo letterarie ma storiche, filosofiche, antropologiche, psicologiche. La<br />
genesi del motivo del selvaggio “moderno” si può facilmente r<strong>in</strong>tracciare con l’<strong>in</strong>izio della<br />
politica imperialista europea. Le prime formulazioni precise del motivo risalgono a prima<br />
dell’illum<strong>in</strong>ismo quando la ragione “illum<strong>in</strong>ata” com<strong>in</strong>ciò a <strong>def</strong><strong>in</strong>ire se stessa attra<strong>vers</strong>o il<br />
confronto con altre realtà culturali reputate <strong>in</strong>feriori e barbariche. La descrizione di un<br />
personaggio distante e di<strong>vers</strong>o, da educare e da salvare dagli orrori dell’ignoranza, aiutò la<br />
cultura illum<strong>in</strong>istica a stabilire i propri valori e a disegnare una propria morale. La figura del<br />
selvaggio subì nei secoli profonde trasformazioni f<strong>in</strong>o al ribaltamento totale delle posizioni.<br />
Per i modernisti, <strong>in</strong> molti casi, sarà l’uomo civile ad essere reputato <strong>in</strong>feriore. Lotman spiega<br />
così le possibilità evolutive del motivo del selvaggio:<br />
La costruzione semiotica del barbaro si realizza di solito secondo una di queste due possibilità. La prima è<br />
quella di un raddoppiamento riflesso, che fa sì che l’anticultura si costruisca come immag<strong>in</strong>e rovesciata, che ha,<br />
rispetto alla cultura, segni opposti. Passano così all’anticultura i segni arcaici del mondo rovesciato delle forze<br />
378 Cesare Pavese, La selva, <strong>in</strong> C. Pavese, Letteratura americana e altri saggi, cit. pp. 321-323.<br />
379 J. M. Lotman, La Semiosfera, cit. pp. 138-145.<br />
113
mitologiche impure e malvagie. Tuttavia, a seconda della posizione del creatore del testo, questa immag<strong>in</strong>e del<br />
mondo extraculturale, può essere valutata non solo negativamente, ma anche positivamente (ad esempio nel caso<br />
<strong>in</strong> cui la cultura stessa a cui il testo appartiene diventi oggetto di critica).[…] Così, al di fuori della l<strong>in</strong>ea esterna<br />
della civiltà, esiste un collettivo particolare, che senza questa vic<strong>in</strong>anza non può sorgere. Esso è destrutturato e<br />
non può esistere <strong>in</strong> modo <strong>in</strong>dipendente. Il modo di essere, che gli era proprio e che aveva f<strong>in</strong>o all’<strong>in</strong>contro con la<br />
civiltà, è distrutto […] il barbaro viene sottoposto a semiotizzazione, gli viene attribuito un determ<strong>in</strong>ato ruolo 380 .<br />
Il selvaggio è dunque dest<strong>in</strong>ato a mutare forma. Il suo statuto dipende unicamente dal creatore<br />
del testo che a sua volta si <strong>in</strong>serisce all’<strong>in</strong>terno di una cultura. Il selvaggio, pur essendo realtà<br />
storica, assume, a livello letterario, una estrema forza simbolica. Diviene, prima di ogni altra<br />
cosa, personaggio rappresentante dell’altro qu<strong>in</strong>di, sia nel bene che nel male, legato<br />
geneticamente e semanticamente alla cultura che lo elabora. Daniel Defoe vedeva nell’”altro”<br />
un essere <strong>in</strong>feriore, rappresentazione dello stato <strong>in</strong>civile da cui l’uomo moderno proveniva 381 .<br />
Il passaggio all’età del romanticismo fu segnata da un’ulteriore evoluzione del concetto di<br />
primitivo 382 . L’<strong>in</strong>flusso degli studi antropologici fu, <strong>in</strong> questo caso, determ<strong>in</strong>ante. La natura è<br />
ora vista come una massa caotica da cui è sempre più difficile, per l’uomo moderno, trarre<br />
regole attendibili. Le leggi della natura, che il “buon selvaggio” seguiva, com<strong>in</strong>ciano ad<br />
essere osservate obiettivamente e perdono quell’aura di benignità con cui gli illum<strong>in</strong>isti le<br />
avevano ammantate. L’uomo moderno si trova ora ad osservare lo spettacolo di una natura<br />
misteriosa di cui si sente figlio perduto:<br />
When nature is conceived as be<strong>in</strong>g not geometrically ordered, but <strong>in</strong>f<strong>in</strong>itely fecund and varied, not subject to<br />
f<strong>in</strong>ite reason, but sublimely disruptive of it, then the wild Man becomes Nature’s Child. […] The Child of Nature<br />
does not reason, he feels; he does not preach, as does the Noble Savage, but he breaks spontaneously <strong>in</strong>to poetry<br />
and song especially when confronted by his mother nature <strong>in</strong> her wilder and sublimer moods. It is <strong>in</strong> this guise<br />
that the Wild Man became for a time dom<strong>in</strong>ant <strong>in</strong> the Romantic Movement, and he surely survives, even if <strong>in</strong> a<br />
debased form, <strong>in</strong>to the twentieth century 383 .<br />
380 Ibidem<br />
381 Il selvaggio <strong>in</strong>contrato da Rob<strong>in</strong>son viene “nom<strong>in</strong>ato”, ovvero battezzato col nome di Venerdì, ed <strong>in</strong>iziato alla<br />
vita civile. E’ un’<strong>in</strong>iziazione che prevede soprattutto la soggiogazione dell’<strong>in</strong>digeno. Il selvaggio Venerdì può<br />
essere <strong>in</strong>terpretato, <strong>in</strong> alcuni suoi tratti, anche come un fanciullo. Ma la rappresentazione dell’età <strong>in</strong>fantile non<br />
rappresentava <strong>in</strong> quell’epoca storica, al contrario di quanto doveva accadere di lì a poco, positività o comunque<br />
produttività. Al contrario era s<strong>in</strong>tomo di giov<strong>in</strong>ezza, <strong>in</strong>esperienza, immaturità. Questo stato di selvaggiobamb<strong>in</strong>o<br />
andava <strong>in</strong> qualche modo superato attra<strong>vers</strong>o l’educazione. Tale educazione si basava sugli<br />
<strong>in</strong>segnamenti morali espressi nella Bibbia, l’unico libro che il mar<strong>in</strong>aio Rob<strong>in</strong>son aveva salvato dopo il<br />
naufragio. La vicenda di Rob<strong>in</strong>son può dunque essere letta come una metafora della Genesi della nostra stessa<br />
civiltà occidentale che, attra<strong>vers</strong>o un libro come quello di Defoe, non puntava alla descrizione dell’altro, quanto<br />
alla <strong>def</strong><strong>in</strong>izione di sé stessa attra<strong>vers</strong>o le differenze con un mondo ritenuto aprioristicamente <strong>in</strong>feriore.<br />
382 Peter L. Thorslev per <strong>def</strong><strong>in</strong>ire al meglio il fenomeno del primitivismo <strong>in</strong> epoca moderna parte proprio<br />
dall’illum<strong>in</strong>ismo. Nel suo saggio The Wild Man’s Revenge, l’ipo<strong>tesi</strong> è quella di un’evoluzione del motivo che<br />
parte proprio dall’ideazione del “buon selvaggio” da parte degli illum<strong>in</strong>isti francesi ed <strong>in</strong> particolar modo da<br />
Rosseau. Questa evoluzione è riassunta nel titolo del primo paragrafo: From Noble Savage to Dionysian Man. La<br />
civiltà moderna, nelle pag<strong>in</strong>e del pensatore francese, ha più un ruolo di corruttrice che di educatrice. Nell’opera<br />
L’Emile, un bamb<strong>in</strong>o viene risparmiato dall’educazione civile per esser cresciuto solo tramite le regole di natura.<br />
Per opera di Rosseau il concetto di <strong>in</strong>fanzia come stato privilegiato dell’esistenza umana si fece presto spazio e<br />
viene associato al concetto di selvaggio Il parallelo bamb<strong>in</strong>o-selvaggio si svelerà ricco di implicazioni.Thorslev<br />
<strong>in</strong>dividua dunque una l<strong>in</strong>ea di cont<strong>in</strong>uità nell’evoluzione che ha portato dal “primitivo illum<strong>in</strong>ista” al “primitivo<br />
modernista”. Il primo è caratterizzato da sensibilità, <strong>in</strong>nocenza, coraggio, e ogni tipo di virtù che spesso lo<br />
portano alla facile moralizzazione delle argomentazioni. Questo modello di “buon selvaggio” è costruito<br />
idealmente come controparte del cittad<strong>in</strong>o civile che sconta con la satira la sua <strong>in</strong>capacità di adeguarsi alle<br />
artificialità della società moderna. La civiltà moderna, nelle pag<strong>in</strong>e del pensatore francese, ha più un ruolo di<br />
corruttrice che di educatrice. Nell’opera L’Emile, un bamb<strong>in</strong>o viene risparmiato dall’educazione civile per esser<br />
cresciuto solo tramite le regole di natura. Il parallelo bamb<strong>in</strong>o-selvaggio si svelerà ricco di implicazioni.<br />
383 P. L. Thorslev Jr., The Wild Man’s Revenge, cit. p. 283.<br />
114
Questa evoluzione del concetto è abbastanza importante per la nostra analisi. Passando da<br />
“buon selvaggio” a “figlio della natura”, il primitivo si sottrae alle generalizzazioni dell’età<br />
romantica ed esce dal giard<strong>in</strong>o fiorito del paradiso terrestre <strong>in</strong> cui era stato conf<strong>in</strong>ato. Il<br />
ricongiungimento del primitivo con una natura “neutra”, una natura dalle caratteristiche<br />
<strong>in</strong>tr<strong>in</strong>seche che mal si associano a quelle “culturali” di bene e male, permette al motivo di<br />
svilupparsi e di complicarsi ulteriormente. Se il “buon selvaggio” era r<strong>in</strong>tracciabile <strong>in</strong> territori<br />
idealizzati, presumibilmente ubicati agli antipodi del mondo occidentale fra atolli cristall<strong>in</strong>i ed<br />
isole verg<strong>in</strong>i, il “figlio della natura” si posiziona molto più vic<strong>in</strong>o all’uomo moderno: “Quello<br />
del barbaro non è soltanto un ruolo semiotico, ma anche una realtà storica. La realtà è<br />
<strong>in</strong>evitabilmente co<strong>in</strong>volta nei processi <strong>in</strong>terni della cultura: il barbaro di ieri, che si trovava<br />
fuori dei suoi conf<strong>in</strong>i, appare oggi alla periferia della cultura e sarà domani al centro<br />
dell’attività culturale, che ha subito cambiamenti. Il barbaro è una creazione della civiltà non<br />
solo <strong>in</strong> senso semiotico, ma anche reale” 384 . E’ l’<strong>in</strong>izio della riscoperta dell’Europa rurale. I<br />
tratti primitivi che <strong>in</strong>teressano i poeti romantici possono essere r<strong>in</strong>tracciati nei montanari delle<br />
Highlands scozzesi, fra i m<strong>in</strong>atori delle Midlands <strong>in</strong>glesi, f<strong>in</strong>anche nei contad<strong>in</strong>i delle Langhe<br />
piemon<strong>tesi</strong>. Questo figlio della natura che “prorompe <strong>in</strong> poesie e canti soprattutto quando si<br />
confronta con madre natura nei suoi più selvaggi e sublimi umori” ricorda molto da vic<strong>in</strong>o il<br />
primitivo descritto da Vico che esercitava lo stesso tipo di sensibilità tramite la quale riusciva<br />
ad <strong>in</strong>tessere una relazione privilegiata con la natura di cui poteva conoscere le leggi 385 . Anche<br />
<strong>in</strong> questo caso si potrà far riferimento ai contad<strong>in</strong>i europei descritti dal filosofo napoletano<br />
come portatori di questi tratti primitivi. Sono gli stessi contad<strong>in</strong>i che ispireranno la concezione<br />
di “classicismo rustico” <strong>in</strong> Pavese. L’<strong>in</strong>troduzione del concetto di “figlio della natura”<br />
rafforza, al contempo, quello della “maternità” della natura 386 . La “madre terra” diviene una<br />
384 J. M. Lotman, La Semiosfera, cit. pp. 138-145.<br />
385 Per i romantici la visione dell’uomo primitivo era da contrapporre, nel bene, alla visione di decadenza della<br />
società ottocentesca europea. Tutti gli ideali romantici si esprimevano e si <strong>in</strong>carnavano nella visione ideale di un<br />
<strong>in</strong>corrotto mondo ancestrale. L’età dell’oro per Vico aveva caratteristiche del tutto differenti e trovava i suoi<br />
riscontri positivi <strong>in</strong> ben altri campi. La crudeltà delle pratiche arcaiche, l’orrore (horror nelle pag<strong>in</strong>e di Auerbach<br />
ma anche <strong>in</strong> quelle di Conrad) che l’uomo civile non può che provare di fronte il dispiegamento di tutti i<br />
meccanismi sociali arcaici, erano punti importanti nella concezione del Vico ma erano anche le premesse allo<br />
sviluppo di un grande l<strong>in</strong>guaggio creativo e di una sconf<strong>in</strong>ata percezione poetica. Gli ideali di libertà, fratellanza<br />
ed uguaglianza poco avevano a che fare con le società arcaiche: “But that is the Vico’s idea; it is the very<br />
essence of his system. The aim of primitive imag<strong>in</strong>ation, <strong>in</strong> his view, is not liberty, but, on the contrary,<br />
establishment of fixed limits, as a psycological and material protection aga<strong>in</strong>st the chaos of the surrond<strong>in</strong>g world.<br />
And later on, mythical imag<strong>in</strong>ation serves as base of a political system and as a weapon <strong>in</strong> the struggle for<br />
political and economic power. The age of the gods and the heroes, with their all pervad<strong>in</strong>g “poetry”, are not at all<br />
poetical <strong>in</strong> the romantic sense, although, <strong>in</strong> both cases, poetry means imag<strong>in</strong>ation opposed to reason. […] In<br />
Vico’s system the old contrast of natural aga<strong>in</strong>st positive law, of physis aga<strong>in</strong>st thesis, of orig<strong>in</strong>al nature aga<strong>in</strong>st<br />
human <strong>in</strong>stitutions, becomes mean<strong>in</strong>gless; Vico’s poetical age, the golden age, is not an age of natural freedom,<br />
but an age of <strong>in</strong>stitutions”. (Erich Auerbach, Vico and Aesthetic Historism, tratto da Scenes from the drama of<br />
European literature , cit. p.195)<br />
386 Le teorie evoluzionistiche, che vedevano nel mondo primitivo uno stadio ancora non sviluppato dell’essere<br />
umano, <strong>in</strong>carnata premessa di un imm<strong>in</strong>ente progresso, subirono gli attacchi di una nuova concezione relativista<br />
che riconosceva uno specifico valore ad ogni periodo della nostra storia: “La scienza positivista del secolo XIX<br />
riteneva che si dovesse cercare la mitologia soltanto fra le popolazioni arcaiche o <strong>in</strong> un lontano passato. Non la<br />
ritrovava nelle culture moderne contemporanee […]” (J. M. Lotman – Z. M<strong>in</strong>c, Letteratura e Mitologia, cit. p.<br />
203). Il ruolo della Scienza Nuova, ruolo che acquisì <strong>def</strong><strong>in</strong>itivamente dopo quasi duecento anni dalla sua prima<br />
pubblicazione, fu dunque quello di assegnare una vera ed attuale funzione conoscitiva alla scienza mitologica<br />
che, f<strong>in</strong>o a quel momento, era stata considerata poco più che una pittoresca curiosità storica. Erich Auerbach ha<br />
parlato a riguardo di “revival of the ancient concept of absolute human nature” 386 : The worthlessness of such<br />
<strong>in</strong>stitutions seemed to be proved sufficiently by their variety; and the task of mank<strong>in</strong>d seemed to be to replace<br />
them all by absolute standards accord<strong>in</strong>g to the law of nature. There were <strong>in</strong>deed very different op<strong>in</strong>ion about the<br />
nature of this nature; between those who identified human nature with enlightened reason, there were all k<strong>in</strong>ds of<br />
shades and gradations. But the static and absolute character of this human nature, as opposed to the changes of<br />
history, is common to all these theories of human nature and natural law (Erich Auerbach, Vico and Aesthetic<br />
Historism, tratto da Scenes from the drama of European literature, cit. pp.184-85).<br />
115
presenza quasi costante nei romanzi modernisti. La concezione modernista del primitivo deve<br />
dunque molto alle speculazioni romantiche. Tra modernismo e romanticismo si possono<br />
<strong>in</strong>dividuare molte cont<strong>in</strong>uità come nel caso appena discusso. La visione del selvaggio<br />
modernista, prima ancora di arricchirsi delle componenti dionisiache attribuitegli da<br />
Nietzsche, è una derivazione e una complicazione del selvaggio romantico. Michael Bell<br />
ritiene che il comune denom<strong>in</strong>atore fra i differenti approcci al tema è quello del richiamo<br />
all’irrazionalismo, che affondava le radici nel periodo romantico, come forma di conoscenza<br />
propria dell’epoca moderna. La nuova enfasi che si accordò <strong>in</strong> questo periodo ai temi del subcosciente<br />
e agli aspetti ist<strong>in</strong>tivi ed <strong>in</strong>tuitivi della personalità, fu una base comune da cui molti<br />
scrittori modernisti svilupparono le loro scritture. Cesare Pavese, studioso attento di storia<br />
letteraria e filosofia, s<strong>in</strong>tetizzò, <strong>in</strong> un appunto del Mestiere di Vivere, questi processi: “Perché<br />
l’irrazionale solleva al tutto, all’uni<strong>vers</strong>ale? Idea romantica. Ma è forse da dare ai cani per<br />
questo? Senza dubbio l’irrazionale è l’enorme reservoir dello spirito, come i miti lo sono delle<br />
nazioni” 387 . L’eredità che i romantici lasciarono fu dunque riconosciuta e riutilizzata,<br />
attra<strong>vers</strong>o complicazioni e nuove elaborazioni, dagli scrittori moderni. Nell’ambito di questa<br />
evoluzione vi sono, però, anche delle discont<strong>in</strong>uità che si espletarono soprattutto nella<br />
<strong>def</strong><strong>in</strong>izione del rapporto tra l’uomo moderno e l’uomo primitivo. Nella sua analisi delle<br />
orig<strong>in</strong>i del primitivismo modernista Michael Bell, riprendendo le teorie che Edith A. Ruge<br />
espresse <strong>in</strong> Primitivism and Related Ideas <strong>in</strong> Sturm und Drang Literature (1946), parla di un<br />
importante “salto” nella concezione del primitivo avvenuto <strong>in</strong> epoca romantica. La<br />
concezione illum<strong>in</strong>istica vedeva <strong>in</strong>fatti nel primitivismo, di cui il “buon selvaggio” era<br />
l’<strong>in</strong>carnazione, una relazione esterna all’uomo civile. Un fenomeno dalla cui osservazione si<br />
poteva discernere il viatico della formazione di un uomo attra<strong>vers</strong>o l’educazione occidentale.<br />
Questo stato di “osservazione” fu sostituito, all’epoca del romanticismo, da una vera e propria<br />
“implicazione”. Quello del primitivismo non era più un fenomeno esterno, rappresentazione<br />
dell’evoluzione culturale dell’uomo moderno, ma una vera e propria condizione esistenziale.<br />
Lo stato del primitivo diveniva <strong>in</strong>somma qualcosa che l’uomo cont<strong>in</strong>uava a portare dentro sé<br />
e fu <strong>in</strong> questa relazione che gli <strong>in</strong>tellettuali romantici trovarono un proprio <strong>in</strong>teresse. Il tema<br />
del primitivismo passava dunque dall’essere uno stato “esterno” all’umanità ad essere uno<br />
stato “<strong>in</strong>terno” all’<strong>in</strong>dividuo stesso. La cultura primitiva poteva rappresentare nuove<br />
possibilità di conoscenza, una nuova luce su misteri che il razionalismo moderno non era <strong>in</strong><br />
grado di risolvere. E’ un discorso che implica direttamente i modi del l<strong>in</strong>guaggio e che si<br />
ricollega direttamente alla riscoperta della conoscenza mitica, del simbolismo e di tutte le<br />
forme d’espressione primitive considerate f<strong>in</strong>o a pochi anni prima, alla luce del canone<br />
occidentale, di cattivo gusto. I primitivismi dell’età del modernismo devono dunque molto<br />
all’eredità romantica anche se lo sviluppo delle idee relative ai suoi motivi furono del tutto<br />
orig<strong>in</strong>ali. Così come tra l’età dell’illum<strong>in</strong>ismo e quella del romanticismo si poteva r<strong>in</strong>tracciare<br />
un vero e proprio “salto” che permetteva di stabilire delle coord<strong>in</strong>ate precise <strong>in</strong> cui si<br />
sarebbero mossi gli <strong>in</strong>tellettuali, anche per il passaggio dalla concezione romantica alla<br />
concezione modernista del primitivismo si può ipotizzare un’analoga evoluzione s<strong>in</strong>tetizzata<br />
magistralmente da Bell:<br />
The romantic movement provided the precedent for the literary recreation of psychological states whose<br />
qualities, putatively at least, were commonly lack<strong>in</strong>g <strong>in</strong> the civilized personality. Later primitivism is the heir to<br />
this tradition except that were the romantics generally sought a unification of sensibility primitivist works have<br />
tended to dramatize the dis<strong>in</strong>tegration. Even when attempt<strong>in</strong>g to assimilate or come to sympathetic terms with th<br />
<strong>in</strong>st<strong>in</strong>ctual self primitivist literature generally presents it under an alien, frequently horrifyng, aspect 388 .<br />
387 C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, 8 Febbraio 1944, cit. p. 274.<br />
388 Michael Bell, Primitivism, Cox & Wyman Ltd, Fakenham, Norfolk, 1972, p. 61.<br />
116
Questo motivo della “dis<strong>in</strong>tegrazione” fu affrontato <strong>in</strong> molti modi fra gli scrittori modernisti.<br />
L’orrore, di cui parla Kurtz <strong>in</strong> Cuore di Tenebra, è solo una delle rappresentazioni di questa<br />
improvvisa consapevolezza della crisi che si sviluppa nell’opera letteraria modernista. La<br />
connotazione simbolica del “selvaggio” venne dunque a caricarsi di nuovi significativi aspetti.<br />
Il “selvaggio modernista” si strutturò <strong>in</strong> parte come evoluzione del “selvaggio romantico” <strong>in</strong><br />
parte come reazione allo stesso f<strong>in</strong>o a raggiungere una conformazione ben del<strong>in</strong>eata. La nuova<br />
evoluzione doveva alle nuove connotazioni dionisiache, di cui il selvaggio modernista si<br />
arricchì, la sua peculiarità:<br />
Nature may be conceived not as rational, uniform, and ordered, nor as cruel and slothful, to be ref<strong>in</strong>ed and<br />
overcome. As fecund, spontaneous, sublime, yes, but as more than that: as “mother mysterious”, a dark and<br />
amoral force from under earth, thrust<strong>in</strong>g up <strong>in</strong>differently foul weeds or fragile flowers; a “blood-consciuousness”<br />
ranged forever aga<strong>in</strong>st sterile rational order and efficiency, and creative of all that is lustful, much that is<br />
destructive, and all that is beautiful.[…] The rational Noble Savage is Apollonian, for all his sensibilities; this<br />
naked savage is Dionysan.[…] He is a product of an earthward mysticism, a radical denial not only of a rational<br />
order, but of all otherworldl<strong>in</strong>ess and trascendentalism 389 .<br />
La concezione del dionisiaco <strong>in</strong> epoca moderna contribuì notevolmente alla <strong>def</strong><strong>in</strong>izione del<br />
carattere letterario del “selvaggio”. La parabola di Dioniso era stata divulgata da Nietzsche<br />
che lo mise al centro dello sviluppo di tutta la sua filosofia. Sia Pavese che Lawrence, lettori<br />
di Nietzsche, risentirono delle lezioni del filosofo tedesco. Nella analisi delle caratteristiche<br />
del “suo primitivo”, Nietzsche fu ben consapevole di entrare all’<strong>in</strong>terno di un percorso storico<br />
segnato dall’evoluzione di una figura centenaria. Lo stesso filosofo giustifica la presenza<br />
storica di Dioniso che raccoglie e supera l’eredità romantica. Attra<strong>vers</strong>o la disam<strong>in</strong>a del<br />
pensiero di Schiller e dell’opera romantica, Nietzsche descrive la natura e il primitivo nei<br />
term<strong>in</strong>i che furono successivamente cari a molti scrittori modernisti:<br />
Secondo questo sentire ci fu un’età primitiva dell’uomo <strong>in</strong> cui egli viveva nel cuore della natura e <strong>in</strong> questo stato<br />
naturale aveva <strong>in</strong>sieme raggiunto l’ideale dell’umanità, <strong>in</strong> una bontà e artisticità paradisiache: da questo perfetto<br />
uomo primitivo noi tutti discendemmo, e anzi ne saremmo ancora il fedele ritratto. […] L’uomo colto del<br />
r<strong>in</strong>ascimento si lasciò ricondurre nella sua imitazione operistica della tragedia greca ad una siffatta armonia tra<br />
natura e ideale, ad una realtà idillica […] passando da un’imitazione della suprema forma d’arte greca ad un<br />
“ristabilimento di tutte le cose”, ad una riproduzione del mondo artistico orig<strong>in</strong>ario dell’uomo. […] questo è<br />
solamente il frutto di quell’ottimismo che dalle profondità della concezione socratica del mondo sale <strong>in</strong> alto<br />
come una colonna di profumo dolciastro ed allettante. Nei l<strong>in</strong>eamenti dell’opera non è dunque possibile scorgere<br />
affatto il dolore elegiaco di una perdita eterna, bensì la serenità di un eterno ritrovamento, il comodo piacere per<br />
una realtà idillica, che perlomeno si può <strong>in</strong> ogni istante immag<strong>in</strong>are come reale: sebbene a tal proposito si abbia<br />
forse il sospetto che questa presunta realtà non sia altro che un fantastico e puerile trastullarsi, di fronte a cui<br />
chiunque volesse fare un confronto con la tremenda serietà della vera natura e paragonare tutto ciò con le vere<br />
scene primitive degli <strong>in</strong>izi dell’umanità, dovrebbe gridare con disgusto: via i fantasmi! 390<br />
Fu soprattutto attra<strong>vers</strong>o la Nascita della Tragedia, uno dei testi filosofici che più <strong>in</strong>fluenzò<br />
gli <strong>in</strong>tellettuali modernisti e <strong>in</strong> particolar modo Cesare Pavese, che il filosofo tedesco<br />
promosse la simbologia legata a Dioniso <strong>in</strong>augurando una forma di “naturalismo estetico” 391<br />
dest<strong>in</strong>ato a esercitare una profonda <strong>in</strong>fluenza sugli scrittori del periodo. Il confronto che<br />
avviene tra l’uomo moderno e il primitivo si lega al rapporto di attrazione-repulsione espresso<br />
389 P. L. Thorslev Jr., The Wild Man’s Revenge, cit. p. 285-86.<br />
390 Friedrich W. Nietzsche, La Nascita della Tragedia (19), Newton Compton Editori, Roma, 1991, p. 182-83.<br />
391 Il concetto di “naturalismo estetico” è espresso da John Burt Foster Jr., Heir to Dionysus, a Nietzschian <strong>in</strong><br />
Literary Modernism, Pr<strong>in</strong>ceton Uni<strong>vers</strong>ity Press, 1988.<br />
117
dalla coppia Apollo-Dioniso 392 . Il romanzo modernista sembra vivere sulla riproposizione di<br />
questo schema mitico: l’eterno confronto tra le forze razionali e irrazionali della natura che si<br />
<strong>in</strong>carnano nella figura tragica di Dioniso: “[…] the dialectical scheme that Nietzsche offered<br />
seemed to become a bluepr<strong>in</strong>t, an aesthetic prototipe, for nearly every major twentieth-century<br />
novel” 393 .<br />
Nella Nascita della Tragedia, Nietzsche offre un quadro ben circostanziato di Dioniso<br />
legandolo, attra<strong>vers</strong>o le sue <strong>def</strong><strong>in</strong>izioni, alle maggiori istanze del modernismo letterario.<br />
Dioniso è il primitivo, colui che vive <strong>in</strong> simbiosi con la natura; la sua personalità si situa al di<br />
là della coscienza <strong>in</strong>dividualista dell’uomo moderno: “O per l’<strong>in</strong>flusso delle bevande<br />
narcotiche, cantate da tutti gli uom<strong>in</strong>i e da tutti i popoli primitivi, o per il portentoso<br />
avvic<strong>in</strong>arsi della primavera, che gioiosamente pervade l’<strong>in</strong>tera natura, si risvegliano quegli<br />
impulsi dionisiaci nella cui accentuazione svanisce la soggettività, <strong>in</strong> un totale oblio di sé” 394 .<br />
La riscoperta di questo primitivo div<strong>in</strong>o è legata alla possibilità dell’uomo di riscoprire il<br />
senso della sua esistenza. E’ un r<strong>in</strong>venimento, un procedimento a ritroso, un lasciarsi rapire<br />
dal flusso di irrazionalità sprigionato da Dioniso che, come il fiume che conduceva Marlow<br />
392 La polarità espressa da Dioniso e da Apollo fu ripresa da molti scrittori modernisti che la posero a modello<br />
per la struttura delle loro opere. La struttura dualistica di molti romanzi modernisti trovò, nell’<strong>in</strong>contro-scontro di<br />
Dioniso con Apollo descritto da Nietzsche nella Nascita della Tragedia, il pr<strong>in</strong>cipale modello. Lo scontro tra<br />
razionale ed irrazionale, tra civile e primitivo, tra ragionevole e fer<strong>in</strong>o, simboleggiato dalle due figure<br />
mitologiche, è r<strong>in</strong>tracciabile <strong>in</strong> buona parte della narrativa modernista. Il nuovo <strong>in</strong>teresse che si esprime nella<br />
Nascita nei confronti delle forze obliate che presuppongono l'uomo, il ritorno allo stato fer<strong>in</strong>o naturale la<br />
riscoperta degli ist<strong>in</strong>ti come forze positive sottese all'<strong>in</strong>dividuo sono, d’altra parte, i punti basilari di quest'opera<br />
niciana. Per Kuna nel libro The Janus faced novel lo schema dialettico offerto da Nietzsche nella Nascita della<br />
tragedia divenne un prototipo estetico per tutti i maggiori romanzi della prima metà del novecento. Giano, con il<br />
suo volto bifronte, rappresenta Dioniso ed Apollo: il romanzo moderno tende a sondare la sua maschera. Il volto<br />
di Giano è quello dell'uomo moderno che scopre la tragicità del suo esistere superando così le cosmologie<br />
razionali e la fossilizzata struttura della civiltà. Il primo <strong>in</strong>tento di quest'arte è quello di scavare la superficie del<br />
mondo moderno, dom<strong>in</strong>ato dalla conoscenza scientifica, al f<strong>in</strong>e di risalire le energie vitali che si scoprono essere,<br />
ed è questo un motivo tragico dom<strong>in</strong>ante, selvagge, primitive, prive di ogni pietà. Il personaggio del selvaggio si<br />
ammanta di aspetti tragici rappresentando l’uomo primitivo ( Kuna parla di primary man), il vero simbolo degli<br />
aspetti dionisiaci dell’esistente. L’ist<strong>in</strong>to viene riscoperto come materia fondamentale della natura umana. Il<br />
selvaggio dionisiaco, che conserva questi ist<strong>in</strong>ti, viene posto <strong>in</strong> competizione con i personaggi civili proprio per<br />
svelare la distanza che <strong>in</strong>tercorre fra loro. L’<strong>in</strong>contro fra l’umano Apollo e il bestiale Dioniso avvenne, a livello<br />
letterario, a due livelli. L’<strong>in</strong>contro con l’altro, <strong>in</strong> cui un personaggio civile e uno selvaggio si scoprono a<br />
vicenda, e l’<strong>in</strong>contro con l’altro se stesso, <strong>in</strong> cui l’uomo moderno scopre l’<strong>in</strong>conscio <strong>in</strong> cui sopravvivono i suoi<br />
tratti fer<strong>in</strong>i. L’<strong>in</strong>flusso di Nietzsche sugli <strong>in</strong>tellettuali modernisti potrebbe essere dunque relativo alla<br />
teorizzazione di una dimensione del confronto che si stabilisce attra<strong>vers</strong>o il recupero delle energie primordiali<br />
dell’uomo e della natura. La riscoperta di una dimensione dell’orig<strong>in</strong>ario da contrapporre ad una dimensione del<br />
moderno apparve come un tratto caratteristico della filosofia di Nietzsche che troverà applicazione <strong>in</strong> molte<br />
opere moderniste. La figura del selvaggio dionisiaco si struttura come il distruttore della dimensione moderna,<br />
come dispensatore di sapienza antica ed orig<strong>in</strong>aria: “Nietzsche fed the sense of confrontation with anarchistic<br />
forces; beneath the surface of modern life, dom<strong>in</strong>ated by knowledge and science, he discerned vital energies<br />
which were wild, primitive and completely merciless. At the appropriate hour, man , he proposed, would raise<br />
himself to titanic proportions and conquer his own civilization; the vital forces will be released <strong>in</strong> revenge, and<br />
produce a new barbarism” (F. Kuna, The Janus Faced Novel: Conrad, Musil, Kafka, Mann, cit. p. 446). Il<br />
barbarismo è materia fondamentale dell’uomo moderno che non ne può presc<strong>in</strong>dere. Per Nietzsche, attra<strong>vers</strong>o il<br />
confronto con le orig<strong>in</strong>i, l'epoca moderna potrebbe realmente segnare la r<strong>in</strong>ascita del pensiero tragico attra<strong>vers</strong>o<br />
“il graduale risveglio dello spirito dionisiaco nel mondo presente” così come postula nel paragrafo 19 della<br />
Nascita della Tragedia. La retorica del progresso e della civiltà non <strong>in</strong>ganna Nietzsche che vede <strong>in</strong>vece nei<br />
dogmi della modernità i segni della decadenza. L’uomo moderno porta dentro di se i segni della propria orig<strong>in</strong>e<br />
che tanto più verranno repressi tanto più saranno dest<strong>in</strong>ati ad esplodere con forza. Il confronto dell’uomo<br />
moderno con il selvaggio che racchiude è, spesso, espresso narrativamente attra<strong>vers</strong>o il viaggio <strong>in</strong> luoghi lontani<br />
e l’<strong>in</strong>contro con l’altro che si impone come specchio <strong>def</strong>ormante del protagonista civile all’<strong>in</strong>terno della<br />
narrazione. La filosofia di Nietzsche parte dunque dall'osservazione del mondo moderno per riscoprire le tracce<br />
di Dioniso.<br />
393 Franz Kuna, The Janus Faced Novel: Conrad, Musil, Kafka, Mann, contenuto <strong>in</strong> Modernism a guide to<br />
european literature 1890-1930, edito da M. Bradbury and J. Mc Farlane, Pengu<strong>in</strong> Books, London, 1991, p. 444.<br />
394 F. W. Nietzsche, La Nascita della Tragedia (1), cit. p. 122.<br />
118
nel cuore delle tenebre, propone all’uomo moderno di ripercorrere i suoi passi, r<strong>in</strong>venire le<br />
orme che lo hanno portato al buio della civiltà moderna. E’ un metodo di risalita,<br />
riacquisizione dell’immemoriale, un “processo <strong>in</strong><strong>vers</strong>o” 395 a quello del progresso: “il graduale<br />
risveglio dello spirito dionisiaco nel mondo presente!” 396 . Le questioni moderne<br />
dell’<strong>in</strong>comunicabilità, dell’alienazione dell’uomo dal suo mondo e dalla sua natura<br />
verrebbero, <strong>in</strong> altre parole, superate dal riferimento a Dioniso: “Con l’<strong>in</strong>canto del dionisiaco<br />
non solo si r<strong>in</strong>salda il legame fra uomo e uomo: anche la natura estraniata, nemica o<br />
soggiogata, celebra nuovamente la sua festa di conciliazione con il proprio figlio perduto,<br />
l’uomo” 397 . L’uomo moderno viene messo a confronto con il simbolo delle sue orig<strong>in</strong>i; egli<br />
stesso si trova ad essere <strong>def</strong><strong>in</strong>ito come <strong>in</strong>consapevole <strong>in</strong>carnazione dello sviluppo della<br />
tragedia classica. E’ la tragedia espressa dalla risoluzione del mito di Apollo e Dioniso che<br />
convivono nel medesimo corpo. Kuna esprime questa condizione esistenziale attra<strong>vers</strong>o la<br />
metafora del volto bipartito di Giano:<br />
It is the modern novel which has embodied most eagerly Nietzsche’s formula of the “Janus face” of modern<br />
man, who is doomed to exist tragically. The attempt to absorb and distil such a view of human existence has<br />
tended to make the modern novel itself Janus-faced and paradoxical, and to make many modern writers employ<br />
tragic, or tragic-comic, myths as the underly<strong>in</strong>g patterns or plots <strong>in</strong> their works 398 .<br />
La riproposizione del mito di Dioniso fu dunque particolarmente importante per lo sviluppo<br />
delle scritture moderniste. L’implicazione della simbologia e il contrasto degli opposti fanno<br />
si possa ipotizzare che l’<strong>in</strong>tero romanzo modernista ruoti <strong>in</strong>torno alle contrapposizioni<br />
b<strong>in</strong>arie. La forma del romanzo modernista diverrebbe a questo punto essa stessa bipartita,<br />
“Janus faced novel” per l’appunto. Il romanzo si costruirebbe dunque su una serie di<br />
<strong>in</strong>solubili e tragici contrasti: un personaggio apoll<strong>in</strong>eo si <strong>in</strong>contra-scontra con un personaggio<br />
dionisiaco, ma lo stesso personaggio apoll<strong>in</strong>eo vive, dentro sé, il medesimo <strong>in</strong>contro-scontro<br />
fra il suo io cosciente e il suo subcosciente. Anche il luogo <strong>in</strong> cui è ambientata l’azione entra<br />
<strong>in</strong> questa dialettica nell’ambito della contrapposizione tra la terra e il mondo. Questo<br />
generico schema potrebbe essere applicato a molte delle narrazioni moderniste.<br />
La struttura della contrapposizione è basilare nell’opera di Pavese. Elementi messi spesso a<br />
contrasto nella narrativa dello scrittore sono campagna-città, <strong>in</strong>fanzia-età adulta, italianodialetto,<br />
ord<strong>in</strong>e-caos. Il motivo del contrasto e dell’opposizione dialettica rivestono una<br />
fondamentale importanza all’<strong>in</strong>terno della concezione mitica di Pavese: “Anche nelle opere<br />
non mitiche la struttura dualistica non viene mai meno e si precisa sempre più chiaramente<br />
come struttura mitica nella misura <strong>in</strong> cui progressivamente si rivela struttura simbolica” 399 .<br />
L'opposizione b<strong>in</strong>aria dialogica, dove ognuno dei personaggi ha una forte carica simbolica e<br />
tende a sviscerare il suo simbolo tramite il confronto con l'opponente, si ripete <strong>in</strong> molti dei<br />
romanzi di Pavese e trova nei Dialoghi con Leucò la sua massima espressione 400 . Nel<br />
rapporto tra Berto, il cittad<strong>in</strong>o, e Tal<strong>in</strong>o, il contad<strong>in</strong>o, protagonista e antagonista <strong>in</strong> Paesi<br />
Tuoi, si possono rilevare gli elementi costitutivi di questo <strong>in</strong>stabile rapporto sempre da<br />
riequilibrare e sempre sull’orlo del tragico fallimento. L’opposizione b<strong>in</strong>aria dialogica qui<br />
proposta, si ripete <strong>in</strong> tutti i romanzi di Pavese per cui sarebbe giusto dire che ognuno dei<br />
395<br />
F. W. Nietzsche, La Nascita della Tragedia (19), cit.p. 183.<br />
396<br />
Ibidem.<br />
397<br />
F. Nietzsche, La Nascita della Tragedia (1), cit. p. 122.<br />
398<br />
F. Kuna, The Janus Faced Novel: Conrad, Musil, Kafka, Mann, cit. p. 444.<br />
399<br />
G.Cillo, La distruzione dei miti, cit. p.17.<br />
400<br />
Nel contesto delle teorie freudiane è anche importante il valore che Pavese attribuisce all'<strong>in</strong>fanzia, un mondo<br />
idealmente a contatto con le cose reali. Guglielmi nota, a riguardo, che la coppia speculare ragazzo-adulto si<br />
trova <strong>in</strong> molti romanzi: La spiaggia (studente-professore), La casa <strong>in</strong> coll<strong>in</strong>a (D<strong>in</strong>o-Corrado), La luna e i falò<br />
(C<strong>in</strong>to-Anguilla). Per Pavese il riferimento all’<strong>in</strong>fanzia è necessario ai f<strong>in</strong>i della conoscenza. E’ il momento di<br />
passaggio privilegiato, il momento <strong>in</strong> cui la cultura fa il suo <strong>in</strong>gresso nell’esistenza dell’essere umano.<br />
119
personaggi ha una forte carica simbolica che tende a sviscerare tramite il confronto con<br />
l'opponente. Il selvaggio Tal<strong>in</strong>o espleta la sua funzione non tanto nella rappresentazione del<br />
selvaggio quanto nella funzione di medium nel riconoscimento dell’elemento selvatico di cui<br />
è senz’altro portatore il suo opponente. Per Guglielmi il gioco degli opposti architettato da<br />
Pavese è basato appunto su questa complessità della relazione; questo meccanismo è<br />
evidente <strong>in</strong> Paesi Tuoi dove “il protagonista (Berto) proietta l'elemento demonico - il<br />
selvaggio- nell’altro personaggio (Tal<strong>in</strong>o)” 401 . Nello spazio mitico di mondi ibridi gli stessi<br />
personaggi si fanno ibridi assecondando un modello storico che Pavese direttamente recepiva<br />
dalle teorie del Vico: “Quel che t’<strong>in</strong>canta <strong>in</strong> Vico è l’aggirarsi perpetuo tra il selvaggio e il<br />
contad<strong>in</strong>esco, e i loro sconf<strong>in</strong>amenti reciproci, e la riduzione di tutta la storia a questo<br />
germe” 402 . Il mondo dell’assoluto mitico si scontra con l’empiria del tempo storico dando<br />
vita ad un tragico conflitto che trasc<strong>in</strong>a con se i personaggi. Il rapporto fra gli opposti si svela<br />
ricco di implicazioni che sveleranno di volta <strong>in</strong> volta la loro portata simbolica.<br />
La figura del selvaggio diviene dunque basilare per l’<strong>in</strong>tera teoria compositiva degli scrittori<br />
modernisti. Egli è il simbolo del lontano e del vic<strong>in</strong>o, del perduto e del r<strong>in</strong>tracciabile, della<br />
coscienza e del rimosso. Il selvaggio dionisiaco esprime un contrasto atavico <strong>in</strong>terno all’uomo<br />
che elabora, attra<strong>vers</strong>o la tragedia che il mito esprime, una comprensione del sé stesso e del<br />
proprio mondo che si <strong>def</strong><strong>in</strong>isce come distanza. Distanza dall’orig<strong>in</strong>e ma anche, dopo<br />
l’<strong>in</strong>tervento di Dioniso, dal mondo moderno e dal sé stesso che tale mondo ha forgiato.<br />
L’uomo si trova <strong>in</strong> un nuovo, tragico, territorio di conf<strong>in</strong>e, alla ricerca di un senso che sembra<br />
sfuggire <strong>in</strong> cont<strong>in</strong>uazione. Il selvaggio di Nietzsche ha avuto la capacità di riconsiderare tutta<br />
la teoria della conoscenza di fronte al crollo delle “fossilizzate strutture della<br />
civilizzazione” 403 . Dioniso diviene allora la controparte dell’uomo moderno, il simbolo del<br />
primitivismo di fronte alla civiltà. Egli diviene al contempo sfida mortale e speranza vitale:<br />
Nietzsche fed the sense of confrontation with anarchistic forces; beneath the surface of modern life, dom<strong>in</strong>ated<br />
by knowledge and science, he discerned vital energies which were wild, primitive and completely merciless. At<br />
the appropriate hour, man, he proposed, would raise himself to titanic proportions and conquer his own<br />
civilization; the vital forces will be released <strong>in</strong> revenge, and produce a new barbarism 404 .<br />
La conclusione di Nietzsche, che preannuncia l’avvento di un nuovo barbarismo, si presta a<br />
svariate <strong>in</strong>terpretazioni che, nell’ambito della scrittura modernista, possono essere r<strong>in</strong>tracciate<br />
<strong>in</strong> due filoni: quello utopico e quello apocalittico. Lawrence si mosse su entrambi i <strong>vers</strong>anti<br />
mentre Pavese, lontano da visioni utopiche, sviluppò maggiormente gli aspetti apocalittici.<br />
Entrambe le <strong>in</strong>terpretazioni, e qu<strong>in</strong>di il ruolo stesso del primitivismo dionisiaco niciano, si<br />
muovono sullo sfondo del fenomeno del nichilismo <strong>def</strong><strong>in</strong>ito dal filosofo tedesco come dest<strong>in</strong>o<br />
proprio della civiltà occidentale: “Tutto ciò che ora chiamiamo cultura, educazione, civiltà,<br />
dovrà comparire un giorno di fronte all’<strong>in</strong>fallibile giudice Dioniso” 405 . La carica e<strong>vers</strong>iva di<br />
Dioniso, la sua volontà distruttrice, è forse uno degli aspetti che più risultarono congeniali alle<br />
poetiche decadenti moderne. La sua controparte non è esclusivamente l’<strong>in</strong>dividuo moderno,<br />
magari colto nei suoi difetti e nelle sue degenerazioni, ma tutta la sua civiltà, tutta la sua<br />
cultura. Per Lotman l’aspetto dionisiaco è l’evoluzione f<strong>in</strong>ale del selvaggio la cui carica<br />
e<strong>vers</strong>iva sembra direttamente proporzionale alla decadenza della civiltà moderna. Il selvaggio<br />
dionisiaco è, di fatto, l’ultima creatura del nichilismo occidentale:<br />
401<br />
G. Guglielmi La prosa italiana del Novecento, Tra romanzo e racconto, cit. p. 129.<br />
402<br />
C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, 19 Agosto 1944, cit. p. 288.<br />
403<br />
F. Kuna, The Janus Faced Novel: Conrad, Musil, Kafka, Mann, cit. p. 445: “[…] the fossillized structure of<br />
civilization itself”.<br />
404<br />
Ivi, p. 446.<br />
405<br />
F. La Nascita della Tragedia (19), cit. p. 184.<br />
120
Quanto più il sistema delle regole socio-culturali di un determ<strong>in</strong>ato collettivo è complicato, tanto più pericoloso,<br />
distruttore o al contrario utile e lungamente atteso appare chi, non avendo alcuna norma, distrugge queste regole.<br />
A lui vengono attribuiti i segni delle forze diaboliche o escatologiche, la funzione di flagello di Dio, di chi<br />
compie la missione di vendicatore dei peccati di una civiltà. La civiltà, f<strong>in</strong>o alla sua effettiva disgregazione, si<br />
basa, soprattutto per bocca dei suoi ideologi, sull’idea di <strong>in</strong>evitabilità e <strong>in</strong> particolare sulla giustificazione di chi<br />
aspetta il suo castigo 406 .<br />
Lo sviluppo delle tematiche relative al selvaggio nella direzione del primitivismo dionisiaco<br />
può essere imputato a di<strong>vers</strong>i fattori, storici e culturali. Dal punto di vista culturale l’apporto<br />
delle scienze antropologiche e psicanalitiche ebbero, senz’altro, un prem<strong>in</strong>ente <strong>in</strong>flusso. Il<br />
loro ruolo fu reso ancora più <strong>in</strong>cisivo dalla possibilità di legare i risultati delle ricerche nei due<br />
campi. Uno dei primi risultati fu quello di concepire la psicologia del primitivo come<br />
differente rispetto a quella dell’uomo moderno. La percezione e il disegno di questa distanza,<br />
fra lo stato di natura del selvaggio e quello civile dell’uomo moderno, rimise <strong>in</strong> gioco gli<br />
ideali di unità che i romantici pensavano di poter ricostituire: “[…] the primitive is a<br />
psycological potentiality the realization of which would imply the destruction of the civilized<br />
psyche. The romantic wholeness seems less and less possible” 407 .<br />
Come detto lo studio dell’antropologia fu essenziale all’elaborazione di questa nuova<br />
concezione del selvaggio. Ma l’antropologia non fornì una visione organica e completa della<br />
materia trattata tanto da offrire una giustificazione teorica e scientifica alle opere degli<br />
scrittori. Al contrario il materiale che gli studi antropologici misero a disposizione fu<br />
ampiamente re<strong>in</strong>terpretato dagli artisti che poterono valorizzarne gli aspetti simbolici. Lo<br />
stesso Frazer faceva parte della scuola dell’evoluzionismo e la sua figura di selvaggio è quella<br />
di un essere <strong>in</strong>feriore che praticava delle pratiche e dei rituali orrendi 408 . Pur riconoscendo la<br />
comune discendenza da questo essere Frazer era pur sempre <strong>in</strong> grado di proclamare la<br />
superiorità della civiltà occidentale. Nonostante ciò la consapevolezza che ci sia una<br />
406 J. M. Lotman, La Semiosfera, cit. pp. 138-145.<br />
407 M. Bell, Primitivism, cit. p.64.<br />
408 La moderna etnologia prende le mosse dagli studi di Darw<strong>in</strong>. Pur essendo il caposcuola di una corrente<br />
evoluzionista del pensiero, Darw<strong>in</strong> portò alla luce elementi che sarebbero stati, di lì a poco, al centro<br />
dell'attenzione dei dibattiti modernisti. Affianco la filosofia della storia, che prevedeva appunto<br />
un'<strong>in</strong>terpretazione evoluzionista delle scoperte di Darw<strong>in</strong>, emergevano elementi che lo stesso studioso non<br />
poteva non considerare. Nello studio del 1871 <strong>in</strong>titolato The descent of Man si r<strong>in</strong>tracciano queste importanti<br />
riflessioni: The ma<strong>in</strong> conclusion arrived at <strong>in</strong> this work, namely, that man is descended from some lowly<br />
organised form, will be highly distasteful to many. But there can hardly be a doubt that we are descended from<br />
barbarians. The astonishment which I felt on forst see<strong>in</strong>g a party of Feugians on a wild and broken shore will<br />
never be forgotten by me, for the reflection at once rushed <strong>in</strong>to my m<strong>in</strong>d -such were our ancestors. These men<br />
were absolutely naked and bedaubed with pa<strong>in</strong>t, their long hair was tangled, their mouths frothed with<br />
excitement, and their expression was wild, startled, and distrustful. They possessed hardly any arts, and like<br />
wild animals lived on what they could catch; they had no goverment, and were merciless to every one not of<br />
their own small tribe. He who as seen a savage <strong>in</strong> his native land will not feel much shame, if forced to<br />
ackknowledge that the blood of some humble creature flows <strong>in</strong> his ve<strong>in</strong>s. For my own part I would as soon be<br />
descended from that eroic little monkey, who braved his dreaded enemy <strong>in</strong> order to save the life of his keeper, or<br />
from that old baboon, who descend<strong>in</strong>g from the mounta<strong>in</strong>s, carried away <strong>in</strong> triumph his young comrade from a<br />
crowd of astonished dogs -as from a savage who delights to torture his enemies, offers up bloody sacrifices,<br />
practises <strong>in</strong>fanticide without remorse, treats his wives like slaves, knows no decency, and is haunted by the<br />
grossest superstitions. Man may be excused for feel<strong>in</strong>g some pride at hav<strong>in</strong>g risen, though not trough his own<br />
exertions, to the very summit of the organic scale; and the fact of hav<strong>in</strong>g thus risen, <strong>in</strong>stead of hav<strong>in</strong>g been<br />
aborig<strong>in</strong>ally placed there, may give him hope for a still higher dest<strong>in</strong>y <strong>in</strong> the distant future. But we are not here<br />
concerned with hopes or fears, only wwith the truth as far as our reason permits us to discover it; and I have<br />
given the evidence to the best of my ability. We must, however, acknoledge, as it seems to me, with man with<br />
all his noble qualities, with simpaty which feels for the most debased, with benevolence which extends not only<br />
to other men but to the humblest liv<strong>in</strong>g creature, with his god-like <strong>in</strong>tellect which has penetrated <strong>in</strong>to the<br />
movementss and costitutions of the solar system -with all these exalted powers -. Man still bears <strong>in</strong> his bodily<br />
frame the <strong>in</strong>delible stamp of his lowly orig<strong>in</strong>” (Charles Darw<strong>in</strong>, The descent of the man, contenuto <strong>in</strong> The<br />
modern tradition, backgrounds of modern literature, edito da Richard Ellmann and Charles Feidelson jr.,<br />
Oxford Uni<strong>vers</strong>ity Press, 1965, pp. 528-29).<br />
121
cont<strong>in</strong>uità e un legame fra l’uomo civile e quello primitivo, trapela dalle pag<strong>in</strong>e del Ramo<br />
d’Oro ed è riconosciuta dallo stesso autore che a più riprese nota come le somiglianze che tra<br />
l’uomo moderno e il selvaggio siano superiori alle di<strong>vers</strong>ità. L’<strong>in</strong>tera cultura civile moderna è<br />
derivata ed è legata a quella primitiva: “Parallelamente all’immag<strong>in</strong>e di un mondo pervaso da<br />
forze spirituali, il selvaggio ha una concezione di<strong>vers</strong>a, e forse anche più antica, nella quale<br />
possiamo <strong>in</strong>dividuare il germe della concezione moderna delle leggi naturali” 409 . Anche se i<br />
“punti di contatto” erano studiati da Frazer come un passaggio dell’evoluzione occidentale<br />
<strong>vers</strong>o la civiltà, il loro r<strong>in</strong>venimento fu importante per molti degli scrittori modernisti che si<br />
fecero rapire dalle conseguenti suggestioni che tali argomentazioni possono far scaturire.<br />
Conrad, uno degli autori che probabilmente fu maggiormente <strong>in</strong>fluenzato dagli studi di<br />
Frazer, <strong>in</strong>serisce nella prefazione de La follia di Almayer, un’ulteriore complicazione del<br />
concetto di “legame” fra uomo moderno e primitivo entrando <strong>in</strong> polemica con quanti<br />
vedevano nell’evoluzione modernista del concetto di selvaggio un vero affronto alla morale<br />
civile e al buon gusto borghese:<br />
Ed esiste un legame tra noi e quella umanità così lontana. Parlo di uom<strong>in</strong>i e di donne – non dei graziosi<br />
<strong>in</strong>cantevoli fantasmi che si aggirano nel nostro fango e nel fumo e, pallidi, riflettono lo splendore delle nostre<br />
virtù; che sono dotati di ogni raff<strong>in</strong>atezza, ogni sensibilità, ogni saggezza – ma, non essendo che dei fantasmi,<br />
non hanno un cuore. […] Io mi accontento di simpatizzare con i comuni mortali, dovunque essi vivano; <strong>in</strong> case o<br />
<strong>in</strong> capanne, nelle vie sommerse nella nebbia, o <strong>in</strong> foreste oltre la l<strong>in</strong>ea nera di s<strong>in</strong>istre mangrovie che orlano la<br />
vasta solitud<strong>in</strong>e del mare. […] I loro cuori – come i nostri – devono sostenere il fardello dei doni celesti: la<br />
maledizione degli eventi e la felicità delle illusioni, l’amaro della saggezza e l’<strong>in</strong>gannevole consolazione della<br />
nostra follia 410 .<br />
Questo senso di cont<strong>in</strong>uità, questo legame, come lo <strong>def</strong><strong>in</strong>isce Conrad, tra l’uomo civile e<br />
l’uomo primitivo si svela ricco di implicazioni: per Conrad il selvaggio rappresenta uno<br />
spunto di ricerca nella speranza di acquisire una conoscenza che travalichi le categorie,<br />
ritenute non più adeguate, imposte dalla civiltà moderna; per un evoluzionista come Frazer il<br />
selvaggio è motivo di perenne tensione nella consapevolezza di non poter tenere a bada una<br />
natura umana che prepotentemente ribolle dal profondo. Le ricerche comparate che Frazer<br />
sviluppa nel suo testo portano alla luce come le pratiche primitive siano ancora presenti <strong>in</strong><br />
buona parte della popolazione rurale europea:<br />
Non è nostro compito considerare qui quale impatto la permanente esistenza di un tale sordido strato di barbarie<br />
sotto la superficie sociale, immune dai mutamenti epidermici di religioni e culture, potrà avere sul futuro<br />
dell’umanità. L’osservatore distaccato, i cui studi lo hanno condotto a sondarne le profondità, non può vedere <strong>in</strong><br />
essa se non una m<strong>in</strong>accia permanente per la civiltà. E’ come se ci muovessimo su una crosta sottile che, da un<br />
momento all’altro, può frantumarsi a causa delle forze sotterranee sopite sotto di essa. Di quando <strong>in</strong> quando, un<br />
cupo brontolio dal sottosuolo, o una fiamma che divampa improvvisa nell’aria, rivelano quanto sta accadendo<br />
sotto i nostri piedi 411 .<br />
Nelle pag<strong>in</strong>e di Frazer il legame tra l’uomo civile e l’uomo primitivo è dunque considerato<br />
tragicamente. La natura selvaggia dell’uomo è ancora lì, sotto il primo strato della coscienza<br />
civile ed è lontano dal poter essere rimosso <strong>def</strong><strong>in</strong>itivamente. L’uomo moderno convive<br />
dunque con questo “altro da sé” così come l’<strong>in</strong>tera sua società civile vive <strong>in</strong> simbiosi con lo<br />
spettro delle sue orig<strong>in</strong>i arcaiche. Questo substrato è, <strong>in</strong> tutti i casi presente e vivo,<br />
probabilmente anche più reale delle costruzioni artificiali moderne. Robert Hampson<br />
409 James Frazer, Il Ramo d’oro, cit. p. 30.<br />
410 Joseph Conrad, La follia di Almayer, Bompiani, Milano 1994, p. 6.<br />
411 J. Frazer, Il Ramo d’oro, cit. p. 80.<br />
122
considera l’opera di Conrad <strong>in</strong>teramente condotta su questo conf<strong>in</strong>e dove, il lato “nascosto”<br />
viene considerato come più fruttuoso e ricco di implicazioni di quello civile:<br />
Indeed, the "heart of darkness" can be read as precisely that "solid layer of savagery beneath the surface of<br />
society" to which Frazer refers. Conrad's novella is more than just a piece of anti-colonial reportage: work<strong>in</strong>g<br />
across that aspect of the text is an <strong>in</strong>terrogation of the cont<strong>in</strong>uity between the "primitive" and the "civilised".<br />
This is true not only for Kurtz, who goes <strong>in</strong>to Africa believ<strong>in</strong>g <strong>in</strong> the white man's civilis<strong>in</strong>g mission, only to<br />
experience "the awaken<strong>in</strong>g of forgotten and brutal <strong>in</strong>st<strong>in</strong>cts". It is also true for Marlow, who frankly<br />
acknowledges his "remote" k<strong>in</strong>ship" with "the night of first ages" and is prepared to recognise that the African<br />
drums have "as a profound a mean<strong>in</strong>g as the sound of bells <strong>in</strong> a Christian country" . Indeed, Marlow asserts that<br />
this "layer of savagery" represents the "truth" concealed or denied by European society [...]. The narrative<br />
structure also embodies this view: what seems, at the outset, an opposition between the Thames and the Congo<br />
ends as an equation 412 .<br />
Il romanzo Cuore di Tenebra sarebbe dunque giocato sullo sviluppo delle coppie contrastive.<br />
Tale sviluppo sarebbe a sua volta basato sulla dialettica primitivo-civile. Questo schema<br />
compositivo è una delle applicazioni più proprie ed <strong>in</strong>teressanti legate al tema del<br />
primitivismo <strong>in</strong> epoca moderna. E’ uno schema che si ripropone <strong>in</strong> molti romanzi modernisti<br />
e che verrà rielaborato, come abbiamo potuto constatare, anche da Pavese.<br />
Conrad è probabilmente l’autore di area <strong>in</strong>glese che più si avvic<strong>in</strong>a ai materiali antropologici<br />
proposti da Frazer ma il Ramo d’oro <strong>in</strong>fluenzò profondamente un’<strong>in</strong>tera generazione di<br />
scrittori così come constata Giuseppe Cocchiara per il quale il mito del primitivismo ha avuto<br />
un notevole rilievo nell'ambito della recente storia letteraria. Per Cocchiara è di fondamentale<br />
importanza, proprio per l'<strong>in</strong>fluenza che esercitò sugli scrittori, proprio il libro di Frazer capace<br />
di agire non solo a livello contenutistico ma anche a livello formale per la ricchezza di<br />
suggestive e misteriose immag<strong>in</strong>i che seppe collezionare nel suo libro: “Il Golden Bough e, <strong>in</strong><br />
genere, gli studi di etnologia hanno dato <strong>in</strong>dubbiamente una nuova vita alla poetica<br />
dell'immag<strong>in</strong>e-poesia-racconto” 413 . Nell’ambito degli studi di antropologia Frazer è dunque lo<br />
studioso che decretò la nuova posizione del selvaggio nella storia: “Non il barbaro da una<br />
parte ed il civile dall'altra, ma l'uno <strong>in</strong> funzione dell'altro; il barbaro e l’uomo civile come<br />
appartenenti alla stessa umanità <strong>in</strong> camm<strong>in</strong>o” 414 . Per Frazer, studioso da tavol<strong>in</strong>o, il selvaggio<br />
andava rivalutato alla luce delle rassomiglianze con l’uomo moderno. In questo senso Frazer<br />
si <strong>in</strong>teressò di etnologia, folklore e civiltà classiche. Frazer si avvic<strong>in</strong>a nella sua ricerca al<br />
Vico per il quale “la storia non è e non resta morta notizia di un morto passato, ma si<br />
trasforma <strong>in</strong> vivente esperienza del nostro presente” 415 . Per Bell la vera importanza<br />
dell’apporto dell’antropologia fu quella di fornire gli scrittori modernisti del metodo della<br />
comparazione culturale che sfociava a sua volta <strong>in</strong> un relativismo assoluto che rimetteva <strong>in</strong><br />
gioco tutte le categorie di pensiero del mondo occidentale. Lo sviluppo dell’antropologia e del<br />
modernismo letterario furono dunque due processi paralleli:<br />
The effect of such scientific material is not that the primitivist work of literature becomes an anthropological,<br />
scientific thesis but that it acquires a new and sub<strong>vers</strong>ive freedom of perspective. The range of attitudes and<br />
imag<strong>in</strong>ative modes exemplified by the writers considered <strong>in</strong> this study may be associated with the fact that they<br />
almost all make use of anthropological knowledge without the <strong>in</strong>termediary of a recognised primitivist<br />
convention. The common factor <strong>in</strong> so many of these works is their anguished exploration of a dilemma rather<br />
than the conventionalized exposition of an established position and this consciously heuristic emphasis <strong>in</strong> the use<br />
of the primitivist motif is an attitude that parallels the rise of anthropology 416 .<br />
412 Robert Hampson, Frazer and Conrad, contenuto <strong>in</strong> Robert Fraser, Sir James Frazer and the literary<br />
imag<strong>in</strong>ation, essays <strong>in</strong> aff<strong>in</strong>ity and <strong>in</strong>fluence, Macmillian, London, 1990, pp. 71-177.<br />
413 Giuseppe Cocchiara, L’eterno selvaggio, S.F. Flaccovio Editore, Palermo, 1972, p. 283.<br />
414 Ivi, p. 135.<br />
415 Ivi, p. 138.<br />
416 M.Bell, Primitivism, cit. p. 69.<br />
123
Il primitivismo nell’epoca del modernismo rappresenta dunque una tendenza, una nuova<br />
sensibilità derivata dal romanticismo e dagli studi antropologici e psicanalitici. Non si<br />
potrebbe mai <strong>def</strong><strong>in</strong>ire una scuola e questo, nelle pag<strong>in</strong>e di Bell, sembra essere veramente un<br />
fattore positivo nel momento <strong>in</strong> cui si riconosce la circolazione di un determ<strong>in</strong>ato tipo di<br />
materiale da cui più scrittori att<strong>in</strong>sero a piene mani per proporre soluzioni estremamente<br />
personali. Il primitivismo sembra potersi <strong>def</strong><strong>in</strong>ire come una tendenza diffusa presso gli<br />
<strong>in</strong>tellettuali tra la seconda metà dell’Ottocento e la prima del Novecento. Quella del selvaggio<br />
diviene una figura ricorrente nell’arte moderna e proprio nel suo aspetto vago, non codificato,<br />
<strong>in</strong> grado di far capol<strong>in</strong>o ovunque, f<strong>in</strong> anche nelle pag<strong>in</strong>e di un Nietzsche preso a disegnare i<br />
caratteri del suo Dioniso.<br />
L’evoluzione del motivo del selvaggio si avvalse di un ulteriore apporto rappresentato dagli<br />
studi di psicologia. Il concetto di “altro” si era già da tempo sviluppato <strong>in</strong> ulteriori direzioni<br />
che potremmo <strong>def</strong><strong>in</strong>ire più <strong>in</strong>timistiche. Il riconoscimento dell’altro come una proiezione del<br />
sé stesso è un difatti altro topos letterario 417 . L’idea di un’identità “frammentata”, come<br />
caratteristica propria dell’uomo moderno, trovò particolare vigore presso i simbolisti francesi,<br />
<strong>in</strong> particolar modo Laforgue e Rimbaud il quale riassunse la questione nel celebre motto: “Io è<br />
un altro”. L’eredità dei simbolisti fu raccolta da quelli scrittori del modernismo che<br />
rappresentarono artisticamente questo “altro” attra<strong>vers</strong>o l’<strong>in</strong>contro con un personaggio che<br />
agiva al di fuori del conf<strong>in</strong>e semiotico del loro spazio di provenienza. D. H. Lawrence già nel<br />
1914 spiegava nelle sue lettere come non fosse più attuale la concezione di un “io” stabile e<br />
unitario. Il vero “io” agisce piuttosto <strong>in</strong> un'altra dimensione rispetto a quella del reale ed<br />
affiora dalle profondità dell’<strong>in</strong>conscio. E’ una dimensione dell’essere che va r<strong>in</strong>venuta<br />
attra<strong>vers</strong>o il superamento delle categorie imposte dalla civiltà moderna. Il modello del<br />
Dioniso elaborato da Nietzsche fornì una rappresentazione poetica a queste istanze nella sua<br />
rivalutazione dell’ist<strong>in</strong>to e degli aspetti irrazionalistici e vitali dell’esistenza. Le teorie di<br />
Nietzsche trovarono un parallelo <strong>in</strong> quelle di Freud che avallò l’equazione fra l’<strong>in</strong>conscio<br />
dell’essere umano e il selvaggio. Questa equazione rappresenta un motivo ricorrente <strong>in</strong> molta<br />
letteratura modernista. Lotman riconosce nell’<strong>in</strong>teriorizzazione del selvaggio una<br />
caratteristica specifica della cultura moderna: “La cultura del XX secolo nel suo <strong>in</strong>sieme ha<br />
creato il suo barbaro sottoforma d’<strong>in</strong>conscio, ponendo il conf<strong>in</strong>e fra cultura e non cultura<br />
all’<strong>in</strong>terno dell’<strong>in</strong>dividuo” 418 . Il selvaggio diviene la rappresentazione del subcosciente ancora<br />
non corrotto dall’educazione civile occidentale. L’uomo primitivo disegnato da Freud<br />
risponde, come quello di Nietzsche, alle sollecitazioni dell’ist<strong>in</strong>to e si sente essenzialmente<br />
libero dalle costrizioni e dalle regole artificiali della civiltà moderna al f<strong>in</strong>e di privilegiare ed<br />
assecondare il “pr<strong>in</strong>cipio di piacere”. Nel saggio, di gusto etnologico, Totem e Taboo, Freud<br />
isolò dei tratti caratteristici dell’essere primitivo riscontrabili ancora nell’uomo moderno.<br />
Come F. J. Hoffman ha sottol<strong>in</strong>eato nel suo Freudianism and the literary m<strong>in</strong>d (1957), i<br />
risultati degli studi di Freud seguirono la stessa sorte degli studi di antropologia e vennero<br />
utilizzati dagli scrittori come riserva di materiali da costruzione per le loro opere. Le<br />
caratteristiche primitive che l’uomo moderno possiede ancora, <strong>in</strong>vestigate da Freud, non<br />
furono <strong>in</strong>terpretate come s<strong>in</strong>tomi delle nevrosi contemporanee ma come veri e propri<br />
salvacondotti <strong>vers</strong>o le parti più remote e obliate della personalità umana:<br />
417 L’esempio di De Maistre è essenziale. Il protagonista del racconto che <strong>in</strong>traprende il viaggio all’<strong>in</strong>terno di una<br />
cella <strong>in</strong> cui è isolato, <strong>in</strong>contra l’”altro” all’<strong>in</strong>terno di sé stesso. Questo personaggio r<strong>in</strong>venuto quasi casualmente<br />
nell’ambito di un viaggio mentale è descritto come un vero e proprio selvaggio, dalle caratteristiche animalesche.<br />
Il protagonista è <strong>in</strong>capace di dare una spiegazione di questo mostro r<strong>in</strong>venuto così come non sarà più <strong>in</strong> grado,<br />
dalla scoperta del buio della sua orig<strong>in</strong>e <strong>in</strong> poi, di dare un significato all’<strong>in</strong>tera propria esistenza.<br />
418 J. M. Lotman, La Semiosfera, cit. pp. 138-145.<br />
124
Primitive beliefs and practices rather than be<strong>in</strong>g regarded as neuronic manifestations take on the positive<br />
importance of giv<strong>in</strong>g access to the most ancient and hidden parts of the personalità. Psychology <strong>in</strong> general then<br />
endorses that <strong>in</strong>ternazionalization of the primitive state that we have seen to be characteristic of modern or postromantic<br />
primitivism 419 .<br />
Gli scrittori modernisti att<strong>in</strong>sero a piene mani dal serbatoio della psicanalisi per i loro lavori.<br />
Pavese fu particolarmente attratto dalle teorie psicoanalitiche e <strong>in</strong> special modo su come<br />
queste potessero mediare tra il livello dell’<strong>in</strong>fanzia e quello del selvaggio. La lettura del libro<br />
di A Begu<strong>in</strong>, L’ame romantique et le reve, sull’equivalenza fra l’<strong>in</strong>fanzia, l’<strong>in</strong>conscio e la<br />
verità è di particolare importanza per la formazione dello scrittore. Nel Maggio del 1941<br />
Pavese scrive una serie di note a riguardo riportando il motivo dell’<strong>in</strong>fanzia all’<strong>in</strong>terno del suo<br />
uni<strong>vers</strong>o mitico:<br />
Il gusto di K. P. Moritz (scrittore discusso da Begu<strong>in</strong>) per i RICORDI DELL’INFANZIA è un modo di ritrovare<br />
testimonianze di uno stato anteriore alla vita che nell’<strong>in</strong>fanzia è ancora fresco e lascia tracce. Rappresenta cioè la<br />
fuga non soltanto dal reale contemporaneo, ma dal reale <strong>in</strong> blocco.[…] Così si cercano i SOGNI non soltanto<br />
come fuga dalla realtà diurna, ma come appiglio a una prenatale esperienza. Così si anela a immedesimarsi NEL<br />
TUTTO che appare come realtà prenatale 420 .<br />
L’<strong>in</strong>fanzia entra nello stesso gioco di rapporti tra l’orig<strong>in</strong>ario, il selvaggio, la campagna.<br />
Anche <strong>in</strong> questo caso, l’<strong>in</strong>fanzia è <strong>in</strong>terpretata come un’età mitica, fuori dal tempo, la mitica<br />
genesi dell’essere umano: “L’<strong>in</strong>fanzia non conta naturalisticamente, ma come occasione al<br />
bat<strong>tesi</strong>mo delle cose, bat<strong>tesi</strong>mo che ci <strong>in</strong>segna a commuo<strong>vers</strong>i davanti a ciò che abbiamo<br />
battezzato” 421 . La formulazione delle teorie psicanalitiche riguardo le caratteristiche del<br />
selvaggio e i suoi rapporti con la civiltà occidentale furono da subito accostate agli studi<br />
sull’<strong>in</strong>fanzia, argomento privilegiato dalla psicanalisi e soprattutto da Freud. Per Guglielmi c'è<br />
anche un parallelo da porre tra il mondo delle orig<strong>in</strong>i e il mondo onirico: “il mondo del sogno<br />
è il mondo del caos, <strong>in</strong>fernale-div<strong>in</strong>o, immobile e turb<strong>in</strong>oso [...] al contrario il mondo della<br />
veglia è il mondo dell'apparenza e dell'<strong>in</strong>certezza” 422 . La connessione tra selvaggio e<br />
bamb<strong>in</strong>o, <strong>in</strong> quanto uomo ancora non educato, si rende sempre più manifesta. Tale<br />
connessione si esplicita <strong>in</strong> un appunto di Pavese che come prima aveva legato lo sviluppo<br />
dell’arte moderna al motivo del selvaggio, allo stesso modo la lega ora alle tematiche relative<br />
all’<strong>in</strong>fanzia, visto come stato pre-civile dell’uomo, primitivo appunto:<br />
L’arte moderna è – <strong>in</strong> quanto vale – un ritorno all’<strong>in</strong>fanzia. Suo motivo perenne è la scoperta delle cose, scoperta<br />
che può avvenire, nella sua forma più pura, soltanto nel ricordo dell’<strong>in</strong>fanzia.[…] E <strong>in</strong> arte si esprime bene<br />
soltanto ciò che fu assorbito <strong>in</strong>genuamente. Non resta, agli artisti, che rivolgersi e ispirarsi all’epoca <strong>in</strong> cui non<br />
erano ancora artisti, e questa è l’<strong>in</strong>fanzia 423 .<br />
Ma è <strong>in</strong> questa ulteriore capacità di simboleggiare l’immemoriale, il pre-conscio (“selvaggio<br />
è il superato dalla coscienza” 424 ), che la campagna trova un ulteriore importante sviluppo.<br />
Discutendo di Feria d’Agosto, raccolta di saggi che rappresentano la vera e propria stesura<br />
della poetica dell’autore, Gioanola <strong>in</strong>troduce il concetto di <strong>in</strong>fanzia <strong>in</strong>serendolo nel<br />
419 M.Bell, Primitivism, cit. p. 70.<br />
420 C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, 22 Maggio 1941, cit. p. 224.<br />
421 Ivi, 15 Giugno 1943, cit. p. 255.<br />
422 G.Guglielmi La prosa italiana del Novecento, Tra romanzo e racconto, cit. p. 124.<br />
423 C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, 12 Febbraio 1942, cit. p.233.<br />
424 Ivi, 23 Agosto 44, p. 289.<br />
125
complesso di relazioni che sott<strong>in</strong>tendono l’<strong>in</strong>tero uni<strong>vers</strong>o mitico pavesiano: “Siamo già<br />
nella dimensione del mito, e mitica è la sostanza dei ricordi dell’<strong>in</strong>fanzia e della campagna<br />
perché si presenta come immobile, sottratta al tempo, eternamente fissata come valore<br />
costitutivo della coscienza” 425 . L’idea di Pavese sembra quella di voler legare <strong>in</strong> una rete,<br />
geometricamente irregolare, i vari elementi del suo uni<strong>vers</strong>o mitico, stabilendo una serie di<br />
corrispondenze e di rimandi <strong>tesi</strong> alla costruzione di un centro nevralgico da cui far scaturire<br />
la poesia. E’ un rapporto che Musumeci, all’<strong>in</strong>terno dello spazio mitico, <strong>in</strong>dica <strong>in</strong>staurarsi<br />
proprio tra l’età <strong>in</strong>fantile dell’uomo e quella dell’umanità: “Il locus unicus è il luogo<br />
dell’<strong>in</strong>fanzia come risulta modellato nella memoria e dagli eventi che vi ebbero luogo <strong>in</strong><br />
pr<strong>in</strong>cipio.[…] L’unicità del luogo dell’<strong>in</strong>fanzia deriva dal fatto che esso è il depositario del<br />
selvaggio” 426 . Cocchiara, discutendo del concetto di unità della personalità, mette <strong>in</strong> risalto<br />
come il selvaggio sia simbolo di una personalità dissociata. Sul discorso dell'<strong>in</strong>dividualità<br />
primitiva Cocchiara estrae un passaggio da Ame primitive 427 :<br />
Un <strong>in</strong>dividuo per complesso che sia ha per carattere primordiale ed essenziale l'unità. Se non possedesse<br />
quest'unità non sarebbe più un <strong>in</strong>dividuo, ma un complesso di <strong>in</strong>dividui. Tuttavia, presso il primitivo, il<br />
sentimento <strong>in</strong>teriore e vivace della propria persona, non si accompagna del pari con il concetto rigoroso<br />
dell'unità <strong>in</strong>dividuale. Non soltanto le frontiere dell'<strong>in</strong>dividualità permangono vaghe e imprecise, dato che le<br />
appartenenze all'<strong>in</strong>dividuo, il suo duplicato, la sua immag<strong>in</strong>e, il suo riflesso si identificano <strong>in</strong> lui; [...] L'<strong>in</strong>dividuo<br />
non è se stesso che a condizione di essere un altro da se stesso. Sotto questo aspetto, lungi dall'essere uno, come<br />
noi lo concepiamo, è ancor uno e più <strong>in</strong>sieme 428 .<br />
Il motivo dell’<strong>in</strong>contro con le forze oscure della natura e dell’uomo per mezzo del contatto<br />
con il “primitivo” è basilare alla composizione di Cuore di Tenebra (1902). Kurtz è colui che,<br />
ritiratosi dalla vita civile, si trova <strong>in</strong>trappolato nella reviviscenza degli ist<strong>in</strong>ti più brutali e<br />
delle passioni più selvagge. L’orrore di questa scoperta è per Conrad <strong>in</strong>descrivibile attra<strong>vers</strong>o<br />
il l<strong>in</strong>guaggio codificato della società moderna. La conoscenza di questo processo di<br />
“r<strong>in</strong>venimento” può esclusivamente essere visuale. La riscoperta del se stesso attra<strong>vers</strong>o il<br />
confronto con l’elemento primitivo avviene sullo sfondo del buio delle orig<strong>in</strong>i e del mistero<br />
della natura umana così come spiega Tra<strong>vers</strong>:<br />
The darkness that is the self-as-other cannot be described, but only <strong>in</strong>voked <strong>in</strong> metaphors, which will perhaps<br />
speak to the <strong>in</strong>itiated, but will rema<strong>in</strong> to others (such as Kurtz’s fiancèe) forever <strong>in</strong>accessible. In Conrad’s story,<br />
the conventional self, sociable, practical and rational, confronts its opposite <strong>in</strong> <strong>in</strong>credulity and <strong>in</strong>comprehension.<br />
But the two realms of reason and unreason are <strong>in</strong>timately, if obscurely connected, Conrad leaves us little doubt,<br />
evok<strong>in</strong>g <strong>in</strong> the f<strong>in</strong>al words of his tale that “tranquil waterway” which allows light and darkness to flow, quite<br />
literally, <strong>in</strong>to one another 429 .<br />
L’<strong>in</strong>contro con l’ “altro” diviene dunque anche e soprattutto un nuovo modo di rapportarsi a<br />
se stesso, un nuovo modo per comprendere la natura dell’uomo moderno occidentale così<br />
come aveva notato George Eliot r<strong>in</strong>tracciando l’Africa nera di Conrad nel cuore<br />
dell’Inghilterra. E’ un <strong>in</strong>contro che può avvenire con il selvaggio che è “altro”, il contad<strong>in</strong>o<br />
delle Langhe ne rappresenta un prototipo, ma anche con il selvaggio che è il “sé stesso”.<br />
425 E. Gioanola, Cesare Pavese, La realtà, l’altrove, il silenzio, cit. pp. 14-15.<br />
426 A. Musumeci, L’impossibile ritorno La fisiologia del mito <strong>in</strong> Cesare Pavese, cit. p. 75.<br />
427 Le teorie che successivamente espresse C. G. Jung riguardo l’uomo arcaico e sui residui che l’uomo civile<br />
<strong>in</strong>delebilmente possiede di questo suo antico antenato resero ancora più importante il ruolo che la psicoanalisi<br />
svolse nei confronti degli <strong>in</strong>tellettuali modernisti mentre il ruolo di mediatore tra istanze della psicanalisi e<br />
istanze dell’antropologia fu giocato da Levy-Bruhl.<br />
428 Levy-Bruhl, Ame Primitive, contenuto <strong>in</strong> G. Cocchiara, L’eterno selvaggio, cit. p. 181.<br />
429 M.Tra<strong>vers</strong>, An <strong>in</strong>troduction to modern European Literature-from Romanticism to Postmodernism, cit. p. 118.<br />
126
L’<strong>in</strong>contro con il selvaggio avviene, <strong>in</strong> quanto <strong>in</strong>contro con il proibito e il rimosso, a questo<br />
duplice livello. Pavese sembra poter r<strong>in</strong>venire tracce di selvaticità <strong>in</strong> ognuno dei personaggi<br />
ivi compreso il protagonista che <strong>in</strong>augura la sua esperienza conoscitiva proprio <strong>in</strong> virtù di<br />
questo tragico riconoscimento. Il selvaggio è dunque “tragico” e non “pittoresco” come<br />
Pavese ebbe a dire nel Mestiere di Vivere. Per lo scrittore la figura del selvaggio si svela,<br />
prima di tutto, promettente di implicazioni filosofiche ed artistiche. La sua aspirazione è<br />
quella di poter sfruttare artisticamente la sua potenzialità simbolica: “Il selvaggio ti <strong>in</strong>teressa<br />
come mistero, non come brutalità storica. Non ti piacciono le storie partigiane o terroristiche,<br />
sono troppo spiegabili. Selvaggio vuol dire mistero, possibilità aperta” 430 . Non è un<br />
atteggiamento casuale. Pavese traccia un’evoluzione ideale dell’arte moderna <strong>in</strong>torno a questo<br />
motivo e tenta di elaborare una posizione <strong>in</strong>dividuale che lo rapporti alla grande corrente<br />
artistica del Novecento:<br />
L’arte del Novecento batte tutta sul selvaggio. Prima come argomenti (Kipl<strong>in</strong>g, D’Annunzio ecc.), poi come<br />
forma (Joyce, Ricasso ecc.). Leopardi con le illusioni poetiche giovanili ha vagheggiato questo selvaggio, come<br />
forma psicologica. Anderson, a modo suo, ha toccato questo selvaggio, nella naturalità della vita del Centroovest.<br />
Tutto ciò che ti ha colpito <strong>in</strong> modo creativo nelle letture, sapeva di questo (Nietzsche col suo Dioniso…).<br />
Con la scoperta dell’etnologia sei giunto a storicizzare questo selvaggio. […] Il selvaggio t’<strong>in</strong>teressa come<br />
mistero, non come brutalità storica. Non ti piacciono le storie partigiane o terroristiche, sono troppo spiegabili.<br />
Selvaggio vuol dire mistero, possibilità aperta 431 .<br />
430 C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, 10 Luglio 1947, p. 335.<br />
431 Ivi, 10 Luglio 1947, p. 334.<br />
127
3.3 Nudismo e sacrifici umani<br />
Nel cielo chiaro, sulle canne, la falce bianca<br />
della luna dava un’aria magica, emblematica<br />
al giorno. Perché c’è un rapporto tra i corpi<br />
nudi, la luna e la terra? (Cesare Pavese, Il<br />
Diavolo sulle coll<strong>in</strong>e)<br />
Il selvaggio diviene dunque il mezzo della risalita, il mezzo del ritorno, “possibilità aperta”.<br />
Attra<strong>vers</strong>o l’<strong>in</strong>contro con l’altro si stabiliscono, all’<strong>in</strong>terno della narrazione modernista, una<br />
serie di rimandi <strong>tesi</strong> a mettere il protagonista della vicenda di fronte all’enigma del proprio<br />
essere. L’altro diviene se stesso nel momento <strong>in</strong> cui il protagonista, proveniente dal mondo<br />
civile, dalla città, si mette a confronto con un antagonista proveniente dal mondo barbaro<br />
della campagna. E’ <strong>in</strong> questo specifico confronto che l’uomo civilizzato discerne le tracce del<br />
proprio essere all’<strong>in</strong>terno di se stesso. I personaggi di Pavese si trovano spesso di fronte a<br />
questo altro-se stesso che <strong>in</strong>nesca un processo di risalita <strong>vers</strong>o l’orig<strong>in</strong>ario. Eppure questo<br />
processo non si <strong>in</strong>nesca esclusivamente con l’<strong>in</strong>contro con un altro essere umano. Proprio per<br />
la sua postulata orig<strong>in</strong>aria appartenenza all’elemento naturale, il personaggio pavesiano si<br />
trova spesso a confronto con il selvaggio che egli stesso è. Ad <strong>in</strong>nescare questo ritorno basta<br />
un viaggio nella campagna <strong>in</strong>contam<strong>in</strong>ata, un corso d’acqua, il sole. Il personaggio,<br />
riconoscendosi parte di quella natura, avvia un percorso che lo porta direttamente nell’orbita<br />
del selvaggio dionisiaco. E’ questo uno degli sviluppi più orig<strong>in</strong>ali del selvaggio pavesiano<br />
che trova corrispondenze <strong>in</strong> certo modernismo letterario.<br />
Il motivo del nudismo appare estremamente funzionale all’espressione delle tematiche del<br />
ritorno e del selvaggio dionisiaco. E’ un motivo sovente utilizzato da Pavese che non ebbe<br />
difficoltà, <strong>in</strong> un appunto datato 1 Dicembre 1949, ad ammetterne la derivazione lawrenciana:<br />
“Scoperto l’altra sera quanto mi abbia plasmato la lettura di Sun e The woman who rode away<br />
di Lawrence (’36 – 37?)”. Sun, l’epoea lawrenciana del nudismo, ebbe dunque un <strong>in</strong>flusso<br />
prem<strong>in</strong>ente sullo sviluppo di questo motivo <strong>in</strong> Pavese che seppe comunque sviluppare aspetti<br />
personali ed orig<strong>in</strong>ali nei suoi scritti.<br />
Alla base del tema del nudismo, così presente nell’opera di Pavese, c’è senz’altro la riscoperta<br />
del corpo. E’ una riscoperta che r<strong>in</strong>traccia nel ritorno alla dimensione corporale tutta una serie<br />
di possibilità conoscitive che la ragione non sembra più poter offrire nell’epoca della<br />
modernità. Il corpo diviene un mezzo di conoscenza del reale <strong>in</strong> un momento <strong>in</strong> cui la ragione<br />
non sembra più essere <strong>in</strong> grado di fornire risposte adeguate alle domande degli <strong>in</strong>tellettuali<br />
modernisti. Il ritorno ad una conoscenza corporale è, <strong>in</strong> prima istanza, una necessità di<br />
stabilire nuove forme di apprendimento e nuove forme di comunicazione. La riscoperta del<br />
corpo implica un ritorno <strong>vers</strong>o forme di conoscenza obliate, soppresse ad un certo punto della<br />
storia della civiltà occidentale. Il ritrovamento del corpo obliato è un’ulteriore operazione di<br />
anamnesi, un recupero di categorie conoscitive <strong>in</strong>debitamente sottratte all’uomo. Anche <strong>in</strong><br />
questo caso si potrebbe postulare un ritorno <strong>vers</strong>o una dimensione obliata della nostra<br />
esistenza. Il corpo nudo diviene dunque un simbolo. E’ il simbolo del ritorno alla terra e del<br />
recupero di remote forme di conoscenza. Il personaggio spogliato dei suoi vestiti troverà, o si<br />
limerà a cercare, una nuova forma di comunicazione con la natura che, <strong>in</strong> molti casi, evolverà<br />
<strong>in</strong> simbiosi. Saranno <strong>in</strong> tutti i casi, procedimenti di r<strong>in</strong>venimento tragico. A differenza<br />
dell’immediata comunione che il personaggio lawrenciano di Juliet trova con gli elementi<br />
naturali, i personaggi di Pavese vivono spesso la possibilità di simbiosi <strong>in</strong> maniera tragica<br />
demarcando l’elemento di crisi dell’uomo moderno di fronte alla possibilità di un ritorno alla<br />
terra. Nel suo essere simbolo, il corpo nudo trova un riferimento privilegiato nel selvaggio.<br />
Proprio il selvaggio è colui che, non conoscendo l’utilizzo dei vestiti, rappresenta una<br />
128
possibilità vivente del contatto dell’uomo con la natura. Lo sviluppo del tema prevede, <strong>in</strong><br />
prima istanza, la riscoperta di una dimensione corporale e, <strong>in</strong> seconda istanza, la ricerca di una<br />
comunicazione con l’elemento naturale.<br />
Il motivo della corporalità, alla base del tema del nudismo, aveva avuto numerose<br />
teorizzazioni nell’ambito del dibattito modernista. Nietzsche fu tra i primi ad <strong>in</strong>sistere su<br />
questo motivo percependone la plausibilità e le forti implicazioni simboliche. Il corpo si pone,<br />
da subito, nella riflessione di Nietzsche come antagonista della coscienza. L’io moderno,<br />
<strong>in</strong>trappolato nella sua coscienza, trova, nella sapienza corporale, un degno simbolico<br />
av<strong>vers</strong>ario. Il corpo diviene simbolo della conoscenza preculturale dell’uomo, degli ist<strong>in</strong>ti<br />
oppressi, della vita naturale perduta. Il corpo, conf<strong>in</strong>ato ed imprigionato “<strong>in</strong> una orgogliosa e<br />
illusoria coscienza, lontano dal viluppo delle <strong>in</strong>teriora, dal rapido flusso del sangue, dai<br />
nascosti brividi delle fibre” 432 , diviene il simbolo di tutto ciò che l’uomo ha perduto. Il corpo,<br />
nel suo essere terra, simboleggia anche l’essere stesso, essere obliato e rimosso dalle<br />
coscienze moderne. In questa lontananza ontologica il selvaggio dionisiaco rappresenta una<br />
nuova possibilità. Il superamento dell’<strong>in</strong>dividualità moderna per un ricongiungimento ad una<br />
primordiale unità è simboleggiato dall’azione di Dioniso e dalla sua comunione con gli<br />
elementi della natura. Si stabilisce dunque un parallelo tra la crisi dell’uomo moderno e la<br />
speranza di cui si fa portatore il selvaggio dionisiaco. Il dionisiaco rappresenta la riscoperta<br />
degli impulsi vitali serbati <strong>in</strong>delebilmente nel profondo della coscienza dell’uomo: “L’uomo,<br />
nelle sue forze più alte e nobili, è tutto natura […]” 433 . La funzione propria di Dioniso è<br />
dunque quella di rimettere <strong>in</strong> contatto l’uomo con la natura così come si spiega nella Nascita<br />
della Tragedia:<br />
Con l’<strong>in</strong>canto del dionisiaco non solo si r<strong>in</strong>salda il legame fra uomo e uomo: anche la natura estraniata, nemica o<br />
soggiogata, celebra nuovamente la sua festa di conciliazione con il proprio figlio perduto, l’uomo. Liberamente<br />
offre la terra i suoi doni e pacificamente si avvic<strong>in</strong>ano i feroci animali delle rocce e dei deserti. Con fiori e<br />
ghirlande è coperto il carro di Dioniso: sotto il suo giogo avanzano la pantera e la tigre 434 .<br />
E’ questo il percorso, <strong>in</strong>dicato da Nietzsche attra<strong>vers</strong>o il quale anche l’uomo moderno, per<br />
quanto contam<strong>in</strong>ato e sotto molti aspetti perduto, può riguadagnare un contatto con la<br />
“misteriosa unità orig<strong>in</strong>aria” 435 . Il processo alla civiltà e alla cultura moderna è serrato da<br />
parte del filosofo tedesco. La crisi della modernità è tutta <strong>in</strong> quel fenomeno del nichilismo<br />
ripetutamente prospettato da Nietzsche che altro non è che la percezione della decadenza e la<br />
previsione del collasso di tutta la cultura della modernità. Gli stessi modi della conoscenza<br />
moderna sono av<strong>vers</strong>ati dal filosofo e sono propriamente gli elementi da cui l’uomo deve<br />
fuggire per ritrovare se stresso e la sua natura: “La punta della sapienza si rivolta contro il<br />
sapiente: la sapienza è un delitto contro la natura” 436 . La riscoperta del corpo può condurre<br />
l’uomo al ricongiungimento con la sua terra. Questo processo implica un ritorno e un<br />
r<strong>in</strong>venimento. La riscoperta del corpo, per molti <strong>in</strong>tellettuali modernisti e per lo stesso cesare<br />
Pavese, si configurò come un crogiolo di significati che si esprimevano con la potenza del<br />
simbolo. Il ritorno alla natura attra<strong>vers</strong>o il r<strong>in</strong>venimento delle tracce dell’essere per mezzo<br />
della nudità del corpo umano, metteva implicitamente <strong>in</strong> discussione molti tratti della cultura<br />
moderna e ne prendeva le distanze. La ragione non poteva più porsi come strumento di<br />
conoscenza e comunicazione mentre nuova fiducia veniva data all’ist<strong>in</strong>to e alla componente<br />
irrazionale dell’uomo. E’ qui <strong>in</strong> gioco buona parte della crisi dell’<strong>in</strong>dividualità nel mondo<br />
moderno. L’<strong>in</strong>dividualità, <strong>def</strong><strong>in</strong>ita nei term<strong>in</strong>i di razionalità e coscienza, subisce un attacco<br />
432<br />
Friedrich Nietzsche, Verità e menzogna <strong>in</strong> senso extramorale, Newton Compton Editori, Roma, 1991, p. 94.<br />
433<br />
Ivi, p. 86.<br />
434<br />
F. Nietzsche, La nascita della tragedia, cit. p. 122.<br />
435 Ivi, p. 123.<br />
436 Ivi, p. 146.<br />
129
deciso da coloro i quali, a seguito di Nietzsche, ne postulavano l’<strong>in</strong>adeguatezza e la<br />
decadenza. L’uomo si trova ora di fronte a un altro grande <strong>in</strong>terlocutore che non sia la<br />
ragione: si trova di fronte al proprio corpo. Nel Così parlò Zarathustra, Nietzsche offre una<br />
esemplare s<strong>in</strong><strong>tesi</strong> di questo processo e di come il motivo della riscoperta del corpo si leghi alla<br />
crisi dell’<strong>in</strong>dividualità moderna:<br />
Il corpo è una grande ragione, una pluralità con un solo senso, una guerra ed una pace, un gregge e un pastore.<br />
Strumento del tuo corpo è anche la tua piccola ragione, fratello, che tu chiami spirito, un piccolo strumento e<br />
zimbello della tua grande ragione. Io dici e sei orgoglioso di questa parola. Ma la cosa più grande – cui non vuoi<br />
credere – è il tuo corpo e la sua grande ragione; questa non dice io ma fa da io.[…] Dietro i tuoi pensieri e<br />
sentimenti, fratello, sta un potente sovrano, un saggio sconosciuto – si chiama Se stesso. Abita nel tuo corpo, è il<br />
tuo corpo. C’è più ragione nel tuo corpo che nella tua migliore saggezza. E chissà mai perché il tuo corpo ha<br />
bisogno proprio della tua miglior saggezza? 437<br />
Le implicazioni filosofiche delle teorie di Nietzsche riguardo la “conoscenza corporale”<br />
furono recepite appieno da molti scrittori modernisti. Pavese ne da una sua personale<br />
<strong>in</strong>terpretazione f<strong>in</strong> dall’esordio poetico così come nota Gioanola <strong>in</strong> relazione a Lavorare<br />
Stanca. Gioanola nota come Pavese acquisisca la conoscenza del mondo, <strong>in</strong> questa prima<br />
raccolta poetica, attra<strong>vers</strong>o i sensi. Il mondo si percepisce e si conosce attra<strong>vers</strong>o il gusto,<br />
l’olfatto, i sapori. Il corpo, f<strong>in</strong> dall’esordio poetico dello scrittore, ha un ruolo di primo piano<br />
tra le sue composizioni:<br />
Corpo come soggetto, grammaticale o logico, significa sensorialità della conoscenza, con il filtraggio di tutti gli<br />
aspetti della realtà attra<strong>vers</strong>o la griglia dei sensi.[…] Siamo <strong>in</strong> pieno clima di oralità e il tramite privilegiato del<br />
contatto tra il soggetto e la realtà è costituito proprio da questi term<strong>in</strong>i nell’identificazione orale, per cui il<br />
mondo conosciuto <strong>in</strong> quanto è mangiato, appartiene al soggetto <strong>in</strong> quanto <strong>in</strong>corporato e contiene il soggetto <strong>in</strong> un<br />
contatto pelle a pelle che annulla ogni <strong>in</strong>dividuabilità.[…] E tutto implica, come <strong>in</strong> tutti i miti, sospensione del<br />
tempo, così che il matt<strong>in</strong>o, questo spazio senza conf<strong>in</strong>i di lavorare stanca, diventa luogo dell’abolizione di ogni<br />
prassi (tutto si ferma e matura), secondo l’andamento tipico di questo realismo, pieno di cose ma privo di<br />
avvenimenti 438 .<br />
Gioanola <strong>in</strong>serisce la riscoperta della dimensione corporale e i temi del nudismo all’<strong>in</strong>terno<br />
del fenomeno del nichilismo di cui parla Nietzsche. Il corpo diviene il simbolo del sapere<br />
orig<strong>in</strong>ario, della comunicazione <strong>in</strong>corrotta, della comunione con la natura e, nell’ambito di<br />
questa simbologia, si oppone alla decadente cultura della modernità. Così come postulava<br />
Nietzsche, al corpo si ritorna e <strong>in</strong> questo ritorno si r<strong>in</strong>viene l’orig<strong>in</strong>ario perduto. Per Gioanola,<br />
l’aggettivo nudo è uno dei term<strong>in</strong>i chiave della prima raccolta di Pavese:<br />
Il corpo è strumento privilegiato delle identificazioni <strong>in</strong> quanto, dentro la cultura, parla ancora il l<strong>in</strong>guaggio della<br />
natura, non conosce i limiti conoscitivi della razionalità per causas, partecipa alla circolazione degli umori, delle<br />
l<strong>in</strong>fe, delle voglie proprie della vita animale e vegetale.[…] il contrasto natura-cultura è spesso <strong>in</strong>dicato <strong>in</strong><br />
Lavorare stanca e <strong>in</strong> tutta l’opera, dalle metafore del contrasto tra essere nudi/essere vestiti.[…] L’abito, <strong>in</strong> certo<br />
senso, abolisce il corpo perché serve all’identificazione sociale, ai ruoli della vita adulta, alla costituzione dell’io<br />
<strong>in</strong> quanto <strong>in</strong>dividuo 439 .<br />
437 Friedrich Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Newton Compton Editori, Roma, 1980, pp. 24-25.<br />
438 E. Gioanola, Cesare Pavese, la realtà, l’altrove, il silenzio, cit. pp. 80-82.<br />
439 Ivi, pp. 82-83.<br />
130
Proprio la crisi dell’io, espressa a più riprese nell’ambito delle produzioni artistiche della<br />
modernità, assurge a sbocco privilegiato del simbolismo legato al nudo e al corpo.<br />
L’<strong>in</strong>dividuo, nella ricerca della comunione con la natura, r<strong>in</strong>uncia alla sua personale<br />
<strong>in</strong>dividualità per entrare <strong>in</strong> contatto con il tutto che lo circonda. E’ questo uno sviluppo di<br />
Lavorare Stanca di cui Gioanola elenca i motivi ricorrenti: “[…] ritualistica della nudità, del<br />
corpo annerito dal sole, della solitud<strong>in</strong>e e della comunione con la terra.[…] Il corpo annerito,<br />
appunto, è tramite all’annullamento dei soggetti e ai conseguenti rispettivi rapporti” 440 . La<br />
centralità del motivo <strong>in</strong> Pavese è testimoniata dal protrarsi delle riflessioni per tutta l’attività<br />
dello scrittore. Gioanola può r<strong>in</strong>tracciare un percorso di formazione riguardo l’approccio a<br />
queste tematiche:<br />
[…]il corpo e la corporeità, che si connotano ambivalentemente tra Lavorare Stanca e Paesi Tuoi nel gioco di<br />
attrazione e repulsione per la campagna, sentita prevalentemente come il selvaggio, il pre-umano (mentre la città<br />
è punto d’arrivo, luogo della maturità e della coscienza), assumono a partire da Feria d’Agosto valore nettamente<br />
positivo e configurano i term<strong>in</strong>i di una ricerca dell’autenticità, nel sovrapporsi di campagna e <strong>in</strong>fanzia e nel<br />
configurarsi di questa, <strong>in</strong> prospettiva memoriale, come ambito della verità orig<strong>in</strong>aria, dell’essere autentico, della<br />
felicità. Per questo il rito ambiguo della blackness tende a perdere le connotazioni negative, di concessione al<br />
selvaggio e al proibito, e si fa ritrovamento della compiutezza esistenziale e ontologica 441 .<br />
Il tema del nudismo è r<strong>in</strong>tracciabile <strong>in</strong> un altro importante racconto del 1941, <strong>in</strong>titolato La<br />
Famiglia, che costituirà lo spunto per la composizione de La casa <strong>in</strong> coll<strong>in</strong>a. Corrad<strong>in</strong>o, il<br />
protagonista, occupa le sue giornate estive recandosi <strong>in</strong> campagna dove, nascosto da una fitta<br />
vegetazione, prende il sole sul greto di un fiume <strong>in</strong> una parte dove si formava un ristagno.<br />
L’ambientazione naturale è messa al confronto con il corpo nudo del protagonista che si<br />
annerisce ed irrobustisce sotto i raggi del sole: “Ben presto il suo corpo com<strong>in</strong>ciò ad<br />
abbronzare, e ciò gli pareva desse un senso a quelle giornate, come la muda di certe bestie dà<br />
un senso alle loro stagioni” 442 . Il paragone fra l’uomo e l’animale, nella fattispecie il rimando<br />
più immediato è al rettile che cambia la pelle, non è casuale. Così come l’animale trova un<br />
senso nel cambiare la pelle mano a mano che le stagioni si alternano, così anche il<br />
protagonista spera di r<strong>in</strong>venire nell’abbronzatura, il suo cambio di pelle, un senso alla sua<br />
esistenza turbata. La ricerca di un senso nell’ambito della riscoperta della dimensione del<br />
corpo e della natura, è decisamente legata al tema del nudismo. Il riferimento alla situazione<br />
esistenziale del protagonista, attra<strong>vers</strong>o la descrizione del corpo abbronzato, è immediato. Il<br />
rapporto si chiarisce nelle righe immediatamente seguenti quando Pavese stabilisce le<br />
coord<strong>in</strong>ate esistenziali <strong>in</strong> cui l’esperienza di Corrad<strong>in</strong>o va posta: “Ma la muda di quell’anno –<br />
mi disse sovente – gli pareva qualcosa di più che un’igiene: era un ritorno, un ripiegamento su<br />
se stesso, condizione attiva di qualche avvenimento che lui sentiva imm<strong>in</strong>ente” 443 . Il motivo<br />
del ritorno, che Gioanola <strong>in</strong>dividua come “la figura fondamentale dei libri pavesiani della<br />
maturità” 444 , trova dunque uno sviluppo privilegiato all’<strong>in</strong>terno del tema del nudismo. Il<br />
motivo del ritorno, che <strong>in</strong> molti romanzi modernisti avviene sullo sfondo di una natura<br />
simbolica che vede spesso fiumi scorrere a ritroso e animali totemici accostarsi all’uomo, si<br />
associa, anche <strong>in</strong> questo caso, ai flussi di memoria. Il nudismo può dunque simboleggiare<br />
440<br />
Ivi, p. 84.<br />
441<br />
Ivi, p. 89.<br />
442<br />
Cesare Pavese, La Famiglia, contenuto <strong>in</strong> C. Pavese, Racconti, cit. p. 370.<br />
443<br />
Ibidem.<br />
444<br />
E. Gioanola, Cesare Pavese, la realtà, l’altrove, il silenzio, cit. p. 89.<br />
131
anche il ritorno al preculturale, all’<strong>in</strong>fanzia, “a un desiderio di solitud<strong>in</strong>e antico” 445 : ”La<br />
solitud<strong>in</strong>e dei salici gli dava una specie d’orgoglio, un bisogno di fare il vuoto <strong>in</strong>torno a sé,<br />
che non aveva più provato dagli anni dell’adolescenza. – Invece di <strong>in</strong>vecchiare, ridivento<br />
ragazzo, - mi disse” 446 .<br />
Anche questo racconto è colmo di riferimenti etnologici di frazeriana memoria. Il protagonista<br />
si rapporta ai salici attra<strong>vers</strong>o la comune solitud<strong>in</strong>e, ma il salice è anche un albero<br />
estremamente importante fra le culture primitive ed è al centro di discreta attenzione da parte<br />
di Frazer. Conducendo studi fra le popolazioni della Transilvania e del Giappone, Frazer nota<br />
come il salice sia sempre associato alla fertilità delle donne. Le donne <strong>in</strong>c<strong>in</strong>te caucasiche lo<br />
implorano per avere un buon parto mentre presso gli A<strong>in</strong>u giapponesi si chiedeva il dono della<br />
gravidanza: “Sembra anche che le donne sterili mangiassero del vischio per riuscire ad avere<br />
figli: il più efficace era il vischio che cresceva sul salice, ritenuto dagli A<strong>in</strong>u un albero<br />
particolarmente sacro” 447 . Corrad<strong>in</strong>o prende il sole sotto il salice, vi si sdraia <strong>in</strong> prossimità ed<br />
acquisisce il colore della terra, diventa tutt’uno con la natura. Potrebbe <strong>in</strong> questo senso<br />
diventare lui stesso il vischio che rende feconde le donne. L’ipo<strong>tesi</strong> è sostenuta dal proseguo<br />
della storia che vede Corrad<strong>in</strong>o scoprire di aver messo <strong>in</strong>c<strong>in</strong>ta una donna.<br />
Nel romanzo La Spiaggia, i temi del nudismo e della nerezza si sviluppano <strong>in</strong>torno al<br />
personaggio di Clelia. Il lettore è al cospetto di un paesaggio mediterraneo, arido, colmo di<br />
sole e mare <strong>in</strong> cui la pianta dell'olivo primeggia fra le altre. La dimensione della spiaggia è<br />
lontana rispetto a quella della coll<strong>in</strong>a da cui il narratore proviene. Clelia, nella sua comunione<br />
con il paesaggio, detiene i segreti del mito mar<strong>in</strong>o da sempre agognato da Pavese. La sua<br />
abbronzatura, messa <strong>in</strong> risalto dall’autore è il simbolo di questa comunione. Il tema del<br />
nudismo è, <strong>in</strong> questo romanzo, appena accennato ma è comunque <strong>in</strong>teressante registrare<br />
questo passaggio evolutivo della scrittura di Pavese che si svelerà, di lì a poco, ricco di<br />
implicazioni e sviluppi:<br />
Di giorno sulla spiaggia era un’altra cosa. Si parla con una strana cautela quando si è sem<strong>in</strong>udi: le parole non<br />
suonano più nello stesso modo, a volte si tace e sembra che il silenzio schiuda da se parole ambigue. Clelia<br />
aveva un modo estatico di godersi il sole stesa sulla roccia, di fondersi con la roccia e appiattirsi al cielo,<br />
rispondendo appena con un sussurro, con un sospiro, con un sussulto del g<strong>in</strong>occhio o del gomito, alle brevi<br />
parole di chi le fosse accanto. Mi accorsi ben presto che, stesa così, Clelia non ascoltava veramente nulla.[...] Ma<br />
non si era mai soli. Tutta la spiaggia brulicava e vociava- per questo Clelia alla sabbia di tutti preferiva gli scogli,<br />
la pietra dura e sdrucciolevole. Nei momenti che si rialzava, scuotendo i capelli <strong>in</strong>tontita e ridente, ci chiedeva di<br />
che cosa avevamo parlato, guardava che c'era 448 .<br />
Da questa descrizione si ricava subito l’idea di aver varcato una dimensione. Siamo già <strong>in</strong> un<br />
altro campo semantico dove le stesse parole, come sottol<strong>in</strong>ea l’autore, hanno un significato<br />
differente da quello consueto. Allo stesso modo, Clelia non recepisce le parole che gli altri<br />
dicono. La comunione estatica che si stabilisce con il luogo è dunque profonda ed è attivata<br />
dal corpo sem<strong>in</strong>udo che diviene un tutt’uno con le rocce su cui è steso. La caratteristica<br />
pr<strong>in</strong>cipale di Clelia sembra essere quella di sapersi <strong>in</strong>serire nell’ambiente naturale fatto di<br />
scogli, di sole e di mare. Clelia, che preferisce appartarsi su uno scoglio, sembra <strong>in</strong> grado di<br />
compenetrare e farsi compenetrare dall’elemento naturale che con gentilezza, e al contempo<br />
decisione, si re-impadronisce del suo corpo. La comunione estatica che si stabilisce con la<br />
natura ribadisce il valore del corpo sem<strong>in</strong>udo di Clelia che si configura come vero strumento<br />
di ritorno. Il racconto <strong>in</strong>titolato Nudismo, <strong>in</strong>serito <strong>in</strong> Feria d’Agosto, è forse quello <strong>in</strong> cui il<br />
445<br />
C. Pavese, La Famiglia, cit. p. 372.<br />
446<br />
Ivi, p. 371.<br />
447<br />
J. Frazer, Il ramo d’oro, cit. p. 727.<br />
448<br />
Cesare Pavese, La spiaggia, contenuto <strong>in</strong> C. Pavese, Tutti i romanzi, cit. p. 111.<br />
132
tema è più sviluppato e che si avvic<strong>in</strong>a all’ispirazione di Sole di Lawrence. L’<strong>in</strong>cipit di questo<br />
racconto è altamente significativo e racchiude <strong>in</strong> sè molte delle successive implicazioni del<br />
tema:<br />
Son tornato al torrente dove venivo quest’<strong>in</strong>verno, e come succede <strong>in</strong> quest’ore calde mi è venuta l’idea di<br />
mettermi nudo. Non mi vedevano che gli alberi e gli uccelli. Il torrente è <strong>in</strong>cassato <strong>in</strong> uno spacco della<br />
campagna. Se si ha un corpo, tanto vale esporlo al cielo. Le radici che sporgono dalla parete, sono nude 449 .<br />
Gli elementi f<strong>in</strong>o ad ora sottol<strong>in</strong>eati, come tipici dello sviluppo di questo tema, sono presenti<br />
già dalle primissime righe. Pavese <strong>in</strong>troduce per prima cosa l’idea del “ritorno”. Per denudarsi<br />
bisogna andare <strong>in</strong> un luogo appartato, selvatico, lontano dagli occhi <strong>in</strong>discreti. Ma questo<br />
andare non è mai un semplice andare. Al contrario l’accento è posto sul ritorno. E’ un andare<br />
che significa prima di tutto tornare. Ci troviamo <strong>in</strong>somma, già dalla seconda parola del<br />
racconto, proiettati nella dimensione mitica del “viaggio a ritroso”.<br />
L’ambientazione selvatica, fuori dal mondo civile e proiettata <strong>vers</strong>o lo spazio mitico di un<br />
giard<strong>in</strong>o dell’Eden, è <strong>in</strong>trodotta attra<strong>vers</strong>o l’immediato riferimento agli uccelli e agli alberi<br />
che sono gli unici testimoni dello svestimento. Pavese <strong>def</strong><strong>in</strong>isce da subito lo spazio mitico<br />
della sua contemplazione e stabilisce un parallelo tra il corpo e le radici che sporgono dalle<br />
pareti. Corpo e radici sono nudi. Il corpo è nudo come una radice. Il corpo è una radice. Lo<br />
scrittore riscopre, attra<strong>vers</strong>o una serie di analogie, il suo stesso appartenere alla terra e come<br />
l’antico contatto sia, anche se per brevi momenti, riprist<strong>in</strong>abile: “Mi bagnai nella pozza, dove<br />
disteso toccavo fondo. E’ un’acqua tiepida, che sa di terra. Di tanto <strong>in</strong> tanto ci tornavo; cocevo<br />
al sole tutto il tempo, buttato sull’erba, scorrendomi addosso le stille come sudore. Non<br />
sapevo più di carne ma d’acqua e terra” 450 . Il ritorno <strong>in</strong> una dimensione di unità orig<strong>in</strong>aria è<br />
un percorso mitico che si <strong>in</strong>traprende a ritroso, lungo il fiume della memoria dell’uomo, per<br />
riscoprire la possibilità di riprist<strong>in</strong>are un contatto con la natura e r<strong>in</strong>venire tracce dell’essere<br />
obliato. Lo scrittore cerca un’immedesimazione nel contatto con la natura. L’essere nudo<br />
offre la possibilità di ritornare ad una unità orig<strong>in</strong>aria. Anche nel seguente passaggio il<br />
simbolo del serpente è presente. Nell’ambito dell’unità orig<strong>in</strong>aria, lo scrittore è <strong>in</strong> grado di<br />
identificarsi anche con il rettile che la tradizione biblica ha demonizzato: “Ogni volta che<br />
stendo sull’erba le mie lunghe gambe e rovescio la nuca, so che il sole mi vede e mi fruga<br />
quale sono dalla testa ai piedi e non c’è nulla di di<strong>vers</strong>o da me a un sasso, a un tronco, a una<br />
biscia screziata, se non appunto il turbamento che provo a mostrarmi” 451 . Gioanola così<br />
<strong>def</strong><strong>in</strong>isce questo processo di anamnesi e le sue implicazioni:<br />
Attra<strong>vers</strong>o il corpo si accede alla terra e si riprist<strong>in</strong>a la comunione con l’antica madre: non per nulla la sequenza<br />
corpo-nudità richiama immediatamente le immag<strong>in</strong>i dell’acqua, del sole, della terra, della coll<strong>in</strong>a. La nudità<br />
procura al corpo la nerezza che è necessaria per il ricongiungimento con la madre, come se la bianchezza della<br />
pelle, che testimonia l’uso dei vestiti, fosse di ostacolo al contatto pelle a pelle 452 .<br />
Eppure l’elemento umano è sempre presente e l’anamnesi dest<strong>in</strong>ata a rimanere <strong>in</strong>completa. In<br />
questo caso l’unica cosa che differenzia lo scrittore dalla natura che lo circonda è proprio quel<br />
“turbamento” dovuto alla bianchezza della sua pelle, marchio di <strong>in</strong>famia di fronte la terra. La<br />
terra, come dice lo scrittore, non sopporta il corpo dell’uomo bianco e lo riveste di sole per riappropriarsene:<br />
“Ormai l’acqua e il sole mi han tornito e velato, e anche <strong>in</strong> questo mi par di<br />
449<br />
Cesare Pavese, Nudismo, contenuto <strong>in</strong> C. Pavese, Feria d’Agosto, cit. p. 159.<br />
450<br />
Ibidem.<br />
451<br />
C. Pavese, Nudismo, cit. p. 160.<br />
452<br />
E. Gioanola, Cesare Pavese, la realtà, l’altrove, il silenzio, cit. pp. 83-84.<br />
133
capire che la natura non sopporta il nudo umano e con tutti i suoi mezzi si sforza, come fa coi<br />
cadaveri, di appropriarselo” 453 . Il divenire abbronzati, significa assumere i colori della terra,<br />
significa tornare a far parte della terra. In questo senso, dopo la riscoperta del corpo nella sua<br />
nuda bellezza, quella dell’abbronzatura diviene un’altra figura molto importante <strong>in</strong> relazione<br />
al tema trattato così come sottol<strong>in</strong>ea Gioanola: “Ma la figura della corporeità dest<strong>in</strong>ata a<br />
maggiore sviluppo nell’opera pavesiana è quella della blackness, della nerezza del corpo che<br />
<strong>in</strong>troduce alla comunione con la terra” 454 . E’ una comunione che si esprime, così come<br />
abbiamo già constatato, attra<strong>vers</strong>o una serie di analogie con gli elementi della natura. Lo<br />
scrittore, divenendo un elemento re<strong>in</strong>tegrato nello spazio e nel tempo mitici naturali, descrive<br />
il suo corpo “nudo come un tronco” e le sue parole “erba e radici”. Ma, <strong>in</strong> questa dimensione<br />
mitica, le parole non servono più. La conoscenza non è razionale, non si ottiene cerebralmente<br />
e non si esprime verbalmente. Al contrario tutto si riduce a sensazioni che si ottengono di<br />
fronte a una materia ricca, caotica e senza nome che, proprio <strong>in</strong> virtù del non essere<br />
battezzata, rivendica la propria orig<strong>in</strong>arietà: “Questa conca è una materia senza nome; bisogna<br />
muo<strong>vers</strong>i, sentirla, toccarla” 455 . E’ un passo importante della critica al mondo che tira <strong>in</strong> ballo<br />
molte delle categorie conoscitive esaltate al tempo della modernità. La conoscenza non si<br />
ottiene razionalmente. La vera conoscenza è quella che si ottiene attra<strong>vers</strong>o tutti i sensi del<br />
corpo umano: “Il corpo è <strong>in</strong>fatti una modalità conoscitiva che condiziona l’approccio di<br />
Pavese alla realtà e qu<strong>in</strong>di è alla base delle scelte l<strong>in</strong>guistiche, tematiche e stilistiche: e<br />
conoscere la realtà attra<strong>vers</strong>o il corpo significa, da un punto di vista psicologico, regredire alle<br />
forme di conoscenza dei primi livelli orali, nell’esaltazione dei sensi primitivi dell’odorato,<br />
dell’udito, del tatto” 456 . Nel momento del ritrovamento dell’unità orig<strong>in</strong>aria si perde, dunque,<br />
il marchio d’<strong>in</strong>famia che la civiltà impone agli <strong>in</strong>dividui. Il primo elemento ad entrare <strong>in</strong><br />
competizione con la natura, nel momento dell’unità con tutti i suoi elementi, è proprio l’io. E’<br />
lo stesso io presente come protagonista pr<strong>in</strong>cipale <strong>in</strong> molti dei romanzi modernisti <strong>in</strong>centrati<br />
sulla crisi dell’<strong>in</strong>dividuo. Nello spazio e nel tempo mitico descritti da Pavese (“Chiudo gli<br />
occhi, e tutta quanta la campagna, le frutte, i viottoli, le coste, i viandanti, riprendono di là<br />
dagli alberi esistenza e spazio, ogni cosa un sentore, un sapore, la sua realtà” 457 ), non c’è<br />
posto per l’io moderno. La riscoperta del corpo porta ad una frattura fra questo e l’io visto<br />
come entità governata dalla ragione. Lo scrittore è ancora ancorato alla sua <strong>in</strong>dividualità ma<br />
ne sente l’<strong>in</strong>sufficienza e la crisi di fronte alla forza delle orig<strong>in</strong>i: “Gli strilli e le voci di<br />
uccelli sul mio capo mi dicono che non conto gran che. Qui tutto cont<strong>in</strong>ua come se io non ci<br />
fossi, e dal fondo di questo burrone levando lo sguardo vedo passare qualche nuvola e<br />
stormire le punte degli alberi, quasi tra noi fosse un abisso” 458 . La distanza, fra l’io dello<br />
scrittore e la dimensione mitica <strong>in</strong> cui egli si trova è descritta attra<strong>vers</strong>o la metafora<br />
dell’abisso che è, ancora una volta, di derivazione niciana. Gli elementi simbolici presenti nel<br />
racconto sono numerosi. Quelli riferiti a Dioniso - <strong>in</strong> questo caso bisogna far riferimento sia a<br />
Frazer sia a Nietzsche - primeggiano fra gli altri: “Lo stesso sole che matura le campagne e fa<br />
frutto, e che qui devono nel v<strong>in</strong>o. L’uva annerisce anche coperta dalle foglie. L’importante è<br />
che sotto sia il corpo” 459 . Il v<strong>in</strong>o diviene il simbolo dell’unione con la terra. E’ terra da bere,<br />
liquida come il sangue. La conoscenza della campagna si acquisisce, oltre che attra<strong>vers</strong>o i<br />
sensi, anche attra<strong>vers</strong>o l’<strong>in</strong>corporamento dei suoi frutti. Così come la natura si appropria del<br />
corpo dell’uomo annerendolo, così l’uomo si appropria della natura mangiandola e bevendola.<br />
E’ questo il momento <strong>in</strong> cui la comunione con l’antica madre è <strong>def</strong><strong>in</strong>itivamente consumata e<br />
453 C. Pavese, Nudismo, cit. p. 160.<br />
454 E. Gioanola, Cesare Pavese, la realtà, l’altrove, il silenzio, cit. p. 87.<br />
455 C. Pavese, Nudismo, cit. p. 160.<br />
456 E. Gioanola, Cesare Pavese, la realtà, l’altrove, il silenzio, cit. pp. 79-80.<br />
457 C. Pavese, Nudismo, cit. p. 161.<br />
458 Ivi, p. 160.<br />
459 Ivi, p. 163.<br />
134
si può guardare al tempo storico e allo spazio civile da un’altra dimensione, come se non vi si<br />
appartenesse più. Gioanola nota a riguardo:<br />
Dunque la vera saggezza è quella del corpo, se la conoscenza è ritrovare ciò che si è oralmente <strong>in</strong>corporato; <strong>in</strong><br />
questo senso nulla è significativo di ciò che non è stato assimilato col cibo <strong>in</strong> un tempo mitico, e tutte le<br />
conoscenze successive, la vita <strong>in</strong>tera e la storia e la cultura possono offrire soltanto altezze prospettiche dalle<br />
quali affacciarsi a una ricchezza a cui nulla può essere aggiunto 460 .<br />
La dimensione che occupa lo scrittore non è, però, quella del mito. La contemplazione lo<br />
sp<strong>in</strong>ge a <strong>in</strong>travedere nella campagna e nella pratica del nudismo un’effettiva possibilità di<br />
ritorno alla terra. Ma il racconto si costruisce su una serie di contrasti che rendono evidente<br />
come per l’uomo moderno il ritorno sia precluso; egli può r<strong>in</strong>venire le tracce di un passato<br />
mitico a cui giammai gli sarà concesso di ricongiungersi. La campagna diviene un luogo di<br />
conf<strong>in</strong>e dove l’uomo moderno si scontra con il selvaggio. Il vero essere è, per Pavese,<br />
<strong>in</strong>att<strong>in</strong>gibile nella sua totalità ma è percepibile a momenti, per successive illum<strong>in</strong>azioni, nella<br />
mezza luce della vegetazione. La situazione dello scrittore è essenzialmente tragica. Egli<br />
scopre di non appartenere al mondo della civiltà moderna ma al contempo ogni ritorno è<br />
precluso. Lo spazio lim<strong>in</strong>are della campagna diviene una prigione da cui è impossibile<br />
evadere. Queste sono le righe f<strong>in</strong>ali del racconto:<br />
La campagna è tutt’altro che semplice. Basta pensare quanta gente c’è passata. Ogni riva, ogni macchia ha<br />
veduto qualcosa.[…] Ogni luogo ha un suo nome. E’ qui, <strong>in</strong> questi luoghi selvatici – sovente un cespuglio, una<br />
pietra – che terra e campo sono nudi e si rivelano.[…] Mi chiedo se c’è un fosso, una costa, un pezzo solo di<br />
terra che mani non abbiano scavato o rifatto. Dappertutto è segnato di sguardi e parole umane.[…] Io ogni giorno<br />
ci trovo la vita, ma poi mi stendo, corpo nero, come un morto 461 .<br />
La campagna è dunque imbarbarita dalla civiltà. Ha perso la sua verg<strong>in</strong>ità così come lo<br />
scrittore che, nel suo animo, non trova elementi che non siano stati toccati dalla malattia<br />
dell’umanità. Nella campagna si può dunque trovare la vita e la morte, il puro e l’impuro. Lo<br />
stesso accade per lo scrittore che, all’<strong>in</strong>terno di questa tragica zona lim<strong>in</strong>are, si scopre vivo o<br />
morto a seconda delle tracce che r<strong>in</strong>viene. Questo accentuato contrasto tra ciò che è vivo, e<br />
conduce alla vita, e ciò che è morto, e promette morte, <strong>in</strong>seriscono il racconto di Pavese <strong>in</strong><br />
una dimensione fondamentalmente tragica. La realtà tragica di quella dimensione si svela<br />
nelle ultime righe del romanzo, dopo la descrizione dell’idillio, così come capita <strong>in</strong> Sole di<br />
Lawrence. E’ forse questa una delle caratteristiche che più accomuna le narrazioni del<br />
modernismo letterario. In questo caso si può isolare il fenomeno <strong>in</strong> riferimento al tema del<br />
nudismo ma, descrizioni e situazioni che spesso possono rivelare una matrice romantica,<br />
mancano, <strong>in</strong> ultima analisi, di concludersi nell’espressione di una idealità. Al contrario, per<br />
molte delle narrazioni moderniste, la dimensione tragica dell’esistenza è <strong>in</strong>controvertibile. Il<br />
conflitto, che si esprime nelle composizioni moderniste, è dest<strong>in</strong>ato a rimanere irrisolto. Il<br />
disvelamento della dimensione tragica dell’esistenza appare essere una priorità di molti<br />
scrittori modernisti che preferiscono <strong>in</strong>terrogare il reale f<strong>in</strong>o al suo collasso piuttosto che<br />
r<strong>in</strong>correre <strong>in</strong>soddisfacenti idealità.<br />
Rispetto al racconto di Lawrence, Nudismo di Pavese presenta un’altra similarità tematica e<br />
strutturale. L’<strong>in</strong>contro con l’altro, il selvaggio, il contad<strong>in</strong>o, essere di terra e di sesso opposto<br />
(una contad<strong>in</strong>a per Pavese, un contad<strong>in</strong>o per Juliet), distante nello spazio e nel tempo. I<br />
460 E. Gioanola, Cesare Pavese, la realtà, l’altrove, il silenzio, cit. p. 94.<br />
461 C. Pavese, Nudismo, cit. p. 165.<br />
135
contad<strong>in</strong>i, che si aggirano nella zona, sono descritti come esseri quasi soprannaturali, esseri di<br />
terra, spiriti dei boschi che ben poco hanno di umano. La descrizione che Pavese da di loro è<br />
molto precisa e significativa:<br />
Ciò che mostrano del corpo è color del tabacco, e perf<strong>in</strong>o la camicia e i calzoni hanno aspetto di terra come<br />
scorza di tronchi. Questa è gente che può tralasciare di mettersi nuda; è già nuda da sé. Quando passo tra loro, mi<br />
pesa il vestito che <strong>in</strong>dosso, mi sento festivo come un bue <strong>in</strong>fiocchettato. Vorrei che sapessero che sotto son nero.<br />
Che, <strong>in</strong>somma, sono nudo 462 .<br />
La contad<strong>in</strong>a che lo scrittore descrive sgorga da una campagna deserta e, allo stesso modo, si<br />
dilegua nella vegetazione. La contad<strong>in</strong>a si aggira nella campagna senza nessuna meta<br />
apparente e viene descritta come div<strong>in</strong>ità silvana: “Era grande, una sposa, con un fascio di<br />
frasche sul fianco” 463 . La contad<strong>in</strong>a non dimostra alcun <strong>in</strong>teresse nei confronti dello scrittore<br />
che sottol<strong>in</strong>ea come, probabilmente, ella abbia <strong>in</strong>terpretato la nudità del suo corpo come<br />
“come una cosa naturale”. La contad<strong>in</strong>a, pure essendo vestita, è un’immag<strong>in</strong>e di nudità ancor<br />
più potente di quella dello scrittore che nota subito questo particolare importante: “Era<br />
scalza” 464 .<br />
Il tema del nudismo cont<strong>in</strong>ua ad essere sviluppato da Pavese nel Diavolo sulle coll<strong>in</strong>e. Anche<br />
<strong>in</strong> questo caso, ulteriore elemento di cont<strong>in</strong>uità, con i racconti precedenti e quello di Lawrence<br />
riguardanti il nudismo, la presenza dell’acqua. Gioanola spiega: “Arrivati alle coll<strong>in</strong>e natie, i<br />
giovani del Diavolo vanno a bagnarsi e ad annerirsi <strong>in</strong> una pozza d’acqua dentro a uno spacco<br />
della terra (è un topos frequentissimo: l’acqua è l’umore profondo, è dentro il grembo della<br />
terra, come la l<strong>in</strong>fa o il sangue che circola sotto la superficie)” 465 . Come abbiamo già avuto<br />
modo di constatare più di una volta i viaggi dei personaggi pavesiani si <strong>in</strong>traprendono per<br />
raggiungere luoghi mitici dove altri ord<strong>in</strong>i di significati sono presenti e riscontrabili.<br />
Nell’ambito della descrizione del viaggio, tutti gli elementi e tutte le azioni si caricano di un<br />
significato simbolico, come riscontrato da Gioanola che osserva: “Attra<strong>vers</strong>o il corpo è dato<br />
entrare nella dimensione mitica, cogliendo rapporti <strong>in</strong>editi tra le cose e impadronendosi di un<br />
analogismo che comb<strong>in</strong>a colori, odori, sapori, sensazioni tattili nell’orig<strong>in</strong>arietà della<br />
condizione <strong>in</strong>fantile […]” 466 . In questo uni<strong>vers</strong>o di simboli ritornanti è dato scorgere svariate<br />
figure topiche. Il simbolo del serpente è ancora presente <strong>in</strong> questo romanzo e si associa,<br />
ancora una volta, al mito biblico della Genesi. Il serpente, <strong>in</strong> forma di biscia, fa la sua<br />
apparizione già nel primo capitolo del libro dove è descritto come essere sotterraneo, che si<br />
nasconde all’avanzare del civile: “[…] le bisce sono ridotte sottoterra e hanno paura di chi<br />
passa. L’odore che regna è la benz<strong>in</strong>a. Dov’è più la campagna che piacerebbe a voialtri?” 467 .<br />
L’idea della perdita di un paradiso terrestre è associata a quella dell’avanzamento della civiltà.<br />
Il nudismo, che i protagonisti praticano, ridesta l’immag<strong>in</strong>e biblica del peccato orig<strong>in</strong>ale: “-<br />
Ma nudo, -disse Oreste,- nel pantano ci stai? Confessai che ci stavo, ma col fiato <strong>in</strong> gola. -Mi<br />
sembra di fare un peccato, -ammisi,- forse è bello per questo” 468 .<br />
Una delle direttrici pr<strong>in</strong>cipali nella struttura narrativa de Il Diavolo sulle coll<strong>in</strong>e appare essere<br />
la condizione della vita moderna di cui si riconosce, come proprio sviluppo, l’<strong>in</strong>sanabile<br />
dicotomia tra peccato orig<strong>in</strong>ale e <strong>in</strong>nocenza umana. Se Poli sarà il personaggio che più<br />
462<br />
Ivi, p. 162.<br />
463<br />
Ivi, p. 163.<br />
464<br />
Ibidem.<br />
465<br />
E. Gioanola, Cesare Pavese, la realtà, l’altrove, il silenzio, cit. p. 90.<br />
466<br />
Ivi, p. 91.<br />
467<br />
Cesare Pavese, Il Diavolo sulle coll<strong>in</strong>e, contenuto <strong>in</strong> Cesare Pavese, La bella estate, E<strong>in</strong>audi, Tor<strong>in</strong>o, 1949, p.<br />
96.<br />
468 Ivi, p. 146.<br />
136
appresenterà la dimensione nichilistica della vita moderna (“La vita è debolezza e<br />
peccato” 469 ), ai tre giovani, riguardo i quali la critica è d’accordo nell’<strong>in</strong>dividuare tre aspetti e<br />
caratterizzazioni differenti di una medesima <strong>in</strong>dividualità, è lasciata la possibilità di risolvere<br />
la dicotomia peccato-<strong>in</strong>nocenza (“Disse Pieretto: - Discorsi importanti. L’<strong>in</strong>nocenza e la<br />
libera scelta” 470 ) e la speranza di un possibile ritorno. Il segno dell’<strong>in</strong>famia, l’abbronzatura del<br />
busto e l’esclusione delle parti <strong>in</strong>time, è ancora <strong>in</strong>dice di questa situazione peccam<strong>in</strong>osa:<br />
- Facci vedere l’ombelico, - disse Oreste. Scostai per gioco la c<strong>in</strong>ghia dei calzoni, mostrando una striscia di<br />
ventre pallido. Quelli sghignazzarono e urlarono: - L’<strong>in</strong>fame! Anche lui! Si capisce! – Sei ancora segnato, -<br />
ghignò Pieretto <strong>in</strong> quel suo modo sputacchiante. Verrai nel pantano anche tu. Qui non si hanno riguardi. Al sole<br />
non si deve nascondere niente 471 .<br />
La pratica del nudismo si configura qu<strong>in</strong>di come un rituale capace di riportare i giovani<br />
all’<strong>in</strong>izio dei tempi, <strong>in</strong> una dimensione mitica, e cancellare il peccato orig<strong>in</strong>ario che pesa sulla<br />
loro esistenza. Si assiste quasi all’<strong>in</strong>nescarsi di un processo irre<strong>vers</strong>ibile per cui il protagonista<br />
è trasc<strong>in</strong>ato dai suoi compagni <strong>vers</strong>o un ritorno alle orig<strong>in</strong>i dell’esistenza umana. Così<br />
Musumeci mette <strong>in</strong> relazione gli elementi f<strong>in</strong>o ad ora osservati denotando come il tema del<br />
nudismo e i motivi della corporeità e della blackness siano parte del processo di ritorno:<br />
Il bianco della pelle significa appartenenza alla città, a ciò che deve essere lasciato; è un segno d’<strong>in</strong>famia.<br />
L’oscuro <strong>in</strong>vece è il colore della campagna, la prova dell’<strong>in</strong>iziazione nella vita di essa. Dato che l’<strong>in</strong>nocenza<br />
pastorale è stata persa per sempre, ed il rapporto tra natura ed uomo s’è fatto cacofonico, la nudità ha acquistato<br />
una connotazione peccam<strong>in</strong>osa, di tabù, di violazione del limite, di vizio. Il ritorno alla coll<strong>in</strong>a, al mito, implica,<br />
f<strong>in</strong>o ad un certo punto, un processo di disumanizzazione, di assorbimento dell’<strong>in</strong>dividualità nell’anonimo<br />
archetipo ed ancestrale, che è evidente nel rito del nero. La nudità postula disponibilità <strong>vers</strong>o la natura,<br />
assimilazione nella natura, la perdita della propria identità per diventar parte del mondo mitico 472 .<br />
I protagonisti <strong>in</strong>dividuano nella ritualità del nudismo il mezzo del ritorno alla dimensione<br />
orig<strong>in</strong>aria. Il sole è un altro simbolo potente dell’uni<strong>vers</strong>o narrativo pavesiano. In questo, e<br />
molti altri casi, è <strong>in</strong>teressante notare come il sole si spogli della simbologia classica che lo<br />
vedeva associato ad Apollo e alla ragione illum<strong>in</strong>ante. Il sole è <strong>in</strong>vece un grande occhio<br />
naturale, elemento purificatore (“Al sole non si deve nascondere niente” 473 ), che guarda e<br />
battezza i personaggi attra<strong>vers</strong>o la nerezza. I protagonisti si recano nella conca dove ristagna<br />
l’acqua. Acqua e sole svolgono una funzione simbolica similare e si associano ai temi della<br />
coll<strong>in</strong>a e del ritorno:<br />
La coll<strong>in</strong>a sovrastante era bella al ritorno […] capii che il piacere dell’acqua e della terra cont<strong>in</strong>ua al di là<br />
dell’<strong>in</strong>fanzia, di là da un orto e da un frutteto. Tutta la vita, pensavo <strong>in</strong> quei matt<strong>in</strong>i, è come un gioco sotto il sole.<br />
[…] Le volte che sudavo sull’acqua, mi restava poi per tutto il giorno il sangue fresco, r<strong>in</strong>vigorito dall’urto col<br />
469 Ivi, p. 206.<br />
470 Ivi, p. 113.<br />
471 Ivi, p. 133.<br />
472 A. Musumeci, L’impossibile ritorno, cit. p. 121.<br />
473 C. Pavese, Il Diavolo sulle coll<strong>in</strong>e, cit. p. 133.<br />
137
fiume. Era come se il sole e il peso vivo della corrente mi avessero <strong>in</strong>triso di una loro virtù, una forza cieca,<br />
gioiosa e sorniona, come quella di un tronco o di una bestia dei boschi 474 .<br />
Il posto dove svolgere il rito del nudismo è scelto con attenzione. E’ un posto isolato, lontano<br />
da sguardi umani, che esprime parimenti una simbologia precisa e che rimanda all’immag<strong>in</strong>e<br />
dello scendere nelle viscere della terra, nel suo cuore e tra i suoi vasi l<strong>in</strong>fatici: “- Che paese, -<br />
diceva Pieretto, - per mettersi nudi bisogna entrare sottoterra” 475 . Il sole svolge la sua azione<br />
annerente dall’alto della conca: “Nelle ore bruciate ci batteva il sole a perpendicolo.[…]<br />
passavano laggiù un’ora o due, nudi come le bisce, a bagnarsi e voltolarsi nel sole dentro la<br />
terra screpolata. Lo scopo era arrostirsi anche l’<strong>in</strong>gu<strong>in</strong>e e le natiche, cancellare l’<strong>in</strong>famia,<br />
annerir tutto” 476 . La dimensione mitica del selvaggio si r<strong>in</strong>traccia attra<strong>vers</strong>o il gioco di<br />
analogie fra corpo umano ed elementi naturali. Anche <strong>in</strong> questo caso i protagonisti vengono<br />
assimilati dalla natura circostante e, nelle ore di sole, divengono parte di quella realtà antica:<br />
“Quel brivido di starcene nudi e saperlo, di nasconderci a tutti gli sguardi, e bagnarci,<br />
annerirci come tronchi, era qualcosa di s<strong>in</strong>istro: più bestiale che umano. Scorgevo nell’alta<br />
parete dello spacco affiorare radici e filamenti come tentacoli neri: la vita <strong>in</strong>terna, segreta<br />
della terra” 477 . La comunione, seppur momentanea, fra i protagonisti e la terra non fa altro che<br />
acuire la percezione della distanza fra loro e il mondo civile che viene percepito come lontano<br />
e di<strong>vers</strong>o: “Era strano pensare di laggiù al mondo <strong>in</strong> alto, alla gente, alla vita” 478 . I giochi<br />
prospettici <strong>tesi</strong> a dare l’impressione della distanza tra il civile e il campagnolo è, d’altra parte,<br />
un leit motiv di questo romanzo. La coll<strong>in</strong>a, altro simbolo già discusso, ne offre una visione<br />
privilegiata: “Tra<strong>vers</strong>ai la stoppia riarsa e li raggiunsi sul cocuzzolo. Sembrava di essere nel<br />
cielo. Ai nostri piedi, impicciolita, era la piazza del paese e una giungla di tetti, di scalette di<br />
pagliai” 479 . Il Diavolo sulle coll<strong>in</strong>e è effettivamente strutturato per mettere <strong>in</strong><br />
contrapposizione differenti gradi dell’evoluzione umana nella campagna 480 . Il luogo dove i<br />
giovani praticano il nudismo è quello più lontano dal civile e segna effettivamente il momento<br />
del ritorno. Mombello (monte bello), come nota Musumeci, è un calco <strong>in</strong> italiano per locus<br />
amoenus, e il rituale del nudismo, qui praticato, non fa che confermarne la connotazione di<br />
luogo mitico, paradiso terrestre: “(Mombello) […] rappresenta uno stato di grazia, la<br />
condizione orig<strong>in</strong>ale antecedente il peccato. Nella visone pastorale c’è un’elim<strong>in</strong>azione<br />
<strong>in</strong>tenzionale di ogni senso di rimorso, ed un’affermazione di <strong>in</strong>nocenza nella felicità” 481 .<br />
Pavese ritorna nuovamente al procedimento dell’assolutizzazione di spazio e tempo per<br />
esprimere la valenza simbolica che tale ritorno implica. Appena arrivato al Greppo, il<br />
protagonista cerca di riprist<strong>in</strong>are la comunione con la natura svolgendo il rito della nudità. Il<br />
protagonista trova un luogo isolato dove riprist<strong>in</strong>are l’armonia con la terra:<br />
Era un ricordo d’altri tempi, forse lassù c’era stata una vigna. Sulla bocca della grotta mi misi nudo e presi il<br />
sole. Dai giorni del pantano non l’avevo più fatto. Mi stupì di trovarmi così nero, quasi nero come gli steli del<br />
capelvenere. Pensai molte cose vagando con gli occhi qua e là. Dalla macchia che chiudeva e riparava la natura<br />
poteva sbucare qualcuno, ma chi? Non le cuoche, non Poli. Gli spiriti delle rupi e dei boschi, forse, o una<br />
bestiola del Greppo – esseri nudi e selvaggi come me. Nel cielo chiaro, sulle canne, la falce bianca della luna<br />
dava un’aria magica, emblematica al giorno. Perché c’è un rapporto tra i corpi nudi, la luna e la terra? 482<br />
474<br />
Ivi, pp. 120-21.<br />
475<br />
Ivi, p. 134.<br />
476<br />
Ibidem.<br />
477<br />
Ivi, p. 137.<br />
478<br />
Ivi, p. 138.<br />
479<br />
Ivi, p. 141.<br />
480<br />
A. Musumeci, L’impossibile ritorno, cit. p. 113.<br />
481<br />
Ivi, p. 119.<br />
482<br />
C. Pavese, Il Diavolo sulle coll<strong>in</strong>e, cit. p. 185.<br />
138
Il paesaggio che c<strong>in</strong>ge la nudità del protagonista diviene vivo, sensibile: “Stamatt<strong>in</strong>a prendevo<br />
il sole alla grotta, e mi pareva che la coll<strong>in</strong>a avesse un sangue una voce, vivesse…” 483 . La<br />
tragedia non tarda però a manifestarsi nel momento <strong>in</strong> cui il ritorno non conduce alla<br />
riconciliabilità dell’uomo con la sua terra e non alimenta la speranza di una mitica età<br />
dell’oro. Questa ricerca a ritroso serve piuttosto a mettere <strong>in</strong> risalto come ogni ritorno sia<br />
tragico e ad approfondire la distanza fra il mondo naturale e quello civile. Musumeci<br />
<strong>in</strong>dividua uno dei temi portanti del libro proprio nella tragicità di questo “impossibile<br />
ritorno”: “La rivelazione ottenuta è che la coll<strong>in</strong>a non è per se salvifica […]. Mombello<br />
rappresenta la visione pastorale. La sezione dedicatagli è molto breve, perché il pastoralismo<br />
come modus vivendi non è più fattibile – l’Età dell’oro non può più essere ricostituita. Esiste<br />
solo come un sogno irrealizzabile, come term<strong>in</strong>e di paragone, come <strong>in</strong>dicazione di una<br />
perdita” 484 . In questo senso il tema del nudismo e del ritorno alla terra non sono postulati<br />
come elementi di una moderna utopia. Essi servono, al contrario, ad isolare, sottol<strong>in</strong>eare ed<br />
alimentare i motivi della crisi esistenzialistica dell’uomo moderno. Il viaggio di ritorno dei<br />
protagonisti, il rituale del nudismo e la comunione riprist<strong>in</strong>ata con la terra non sarebbero altro<br />
che elementi da leggersi <strong>in</strong> relazione al mondo civile. Lo stesso viaggio dei protagonisti<br />
sarebbe basato su questa coscienza della perdita e della distanza così come testimonia<br />
Pieretto: “- Un uomo <strong>in</strong> crisi zappa sempre la terra, - disse Pieretto. – E’ la madre comune,<br />
che non <strong>in</strong>ganna i suoi figli” 485 .<br />
Il Greppo è dunque il luogo della campagna contam<strong>in</strong>ato dalla civiltà e rappresenta, attra<strong>vers</strong>o<br />
le feste tediose che vi hanno luogo, “la celebrazione <strong>in</strong>naturale sulla coll<strong>in</strong>a dei riti della<br />
città” 486 . Il rituale del nudismo non può aver luogo. Pavese esprime il contrasto fra le di<strong>vers</strong>e<br />
dimensioni attra<strong>vers</strong>o la voce di Pieretto:<br />
- Mi piace poco questa p<strong>in</strong>eta, - disse una sera Pieretto avvic<strong>in</strong>andosi con Poli fra i tronchi. – E’ un paese<br />
troppo poco selvatico. Rospi e bisce non se ne trovano. […]<br />
- Era meglio il pantano. Qui nemmeno ci si può mettere nudi. Troppa civiltà. […]<br />
- Ma Poli disse: - Se vuoi metterti nudo, puoi farlo.<br />
- Impossibile - disse Pieretto. – Qui ci si sente troppo civili. [..]<br />
- Il fatto è, - disse <strong>in</strong>caponito Pieretto, - che star nudo come stanno le bestie, non ci riesce nessuno. Mi<br />
domando perché… […]<br />
- Intendiamoci. Vivere nudi, - disse Pieretto. – Non spogliarsi per gioco. […]<br />
- Per me, - disse Poli, -siamo tutti nudi senza saperlo. La vita è debolezza e peccato. La nudità è<br />
debolezza, è come avere una ferita aperta … 487<br />
Si esprime <strong>in</strong> questo passaggio gran parte del significato che Pavese attribuisce al tema del<br />
nudismo. Il rito del nudismo è svolto dai protagonisti per r<strong>in</strong>venire le tracce delle orig<strong>in</strong>i ma il<br />
ricongiungimento con la terra appare impossibile dopo la contam<strong>in</strong>azione del civile. Il rito del<br />
nudismo non esprime una possibilità salvifica ma assume caratteristiche del tutto tragiche.<br />
Nessuno dei protagonisti potrebbe viver nudo come le bestie, ritornare alle proprie orig<strong>in</strong>i e<br />
vivere secondo le leggi della natura. Non di meno quella della nudità, come dice Poli, è una<br />
483 Ivi, p. 187.<br />
484 A. Musumeci, L’impossibile ritorno, cit. pp. 121-22.<br />
485 C. Pavese, Il Diavolo sulle coll<strong>in</strong>e, cit. p. 172.<br />
486 A. Musumeci, L’impossibile ritorno, cit. p. 121.<br />
487 C. Pavese, Il Diavolo sulle coll<strong>in</strong>e, cit. p. 205.<br />
139
ferita aperta. La consapevolezza, anche <strong>in</strong>conscia, di ogni uomo riguardo la propria nudità, lo<br />
porterà alla crisi esistenziale tipica dell’umanità moderna.<br />
Gli sviluppi pavesiani <strong>in</strong>torno al motivo del nudismo presentano similarità agli sviluppi<br />
lawrenciani. Questo motivo rappresenta un importante trait d’union fra i due scrittori.<br />
Similarità tematiche e strutturali sono presenti negli scritti dei due autori. I personaggi<br />
<strong>in</strong>traprendono un viaggio <strong>vers</strong>o luoghi campestri ed appartati dove la loro “civiltà” viene<br />
posta <strong>in</strong> questione. In questi luoghi avviene un processo di anamnesi che porta i protagonisti a<br />
desiderare il riprist<strong>in</strong>o di una comunione con gli elementi naturali. Il gesto dello svestimento<br />
si configura come una precisa volontà di r<strong>in</strong>uncia nei confronti delle sovrastrutture<br />
mistificanti della civiltà moderna. I vestiti offrono quasi l’idea di un velo che viene strappato<br />
dagli occhi dell’osservatore che può f<strong>in</strong>almente riacquistare la visione della madre terra<br />
perduta. E’ <strong>in</strong> questo caso <strong>in</strong>teressante notare come l’atteggiamento di Lawrence sia più<br />
spregiudicato a confronto di quello di Pavese. La nudità dei personaggi di Lawrence esprime<br />
una decisa sensualità e fa del riferimento al sesso un motivo prioritario. I personaggi di<br />
Pavese si spogliano con cautela ed ansia quasi stessero commettendo un nuovo peccato<br />
orig<strong>in</strong>ale nel giard<strong>in</strong>o dell’Eden. Ma questi ritorni rappresentano veramente un rovesciamento<br />
del mito biblico <strong>in</strong> cui lo stesso peccato orig<strong>in</strong>ale viene re<strong>in</strong>terpretato dagli autori. I<br />
personaggi si spogliano del loro abito civile per rientrare nelle grazie della div<strong>in</strong>ità che<br />
avevano abbandonato all’alba dei tempi. Il “sensuale” Lawrence e il “casto” Pavese sembrano<br />
essere consapevoli che è sul campo del mito biblico che si gioca il valore dei rispettivi<br />
racconti riguardanti il nudismo.<br />
Il racconto di Lawrence, Sole, è uno dei racconti che più risentì degli <strong>in</strong>flussi di Frazer e che<br />
più sviluppò gli <strong>in</strong>teressi per il mito e per i simboli da parte dell’autore. Lo stesso sole, il vero<br />
protagonista del racconto, si carica di significati simbolici tratti dallo studio dell’etnologia<br />
<strong>in</strong>trapreso dallo scrittore. Il sole, che gioca un ruolo importante <strong>in</strong> molti dei lavori di<br />
Lawrence, tra cui anche La donna che andò via a cavallo, si lega alla visione mitica<br />
dell’esistenza e alle speranze di r<strong>in</strong>novamento che lo scrittore espresse più volte. Il sole è,<br />
prima di tutto, un simbolo di r<strong>in</strong>novamento capace di riportare sulla terra “un’armonia<br />
cosmica”. E’ un r<strong>in</strong>novamento che agisce a livello <strong>in</strong>dividuale e collettivo, ed implica <strong>in</strong><br />
ultima istanza tutto il creato così come nota Fjagesund: “Here it is not only a personal renewal<br />
of the <strong>in</strong>dividual, but also a renovation of the earth” 488 . Ed è proprio nel r<strong>in</strong>novato rapporto<br />
con la terra, di cui il sole si fa mediatore, che l’uomo può riscoprire il tempo ciclico e<br />
ritrovare se stesso come parte della grande natura. In Fantasia dell’<strong>in</strong>conscio il rapporto tra<br />
<strong>in</strong>dividuo e sole è rappresentato dall’immag<strong>in</strong>e del plesso solare. Vedremo <strong>in</strong> seguito come il<br />
sole abbia la capacità non di far conoscere all’uomo cose nuove ma di risvegliare <strong>in</strong> lui<br />
conoscenze ataviche. Al cospetto del sole l’uomo riacquista la sua antica sapienza, la<br />
consapevolezza dell’orig<strong>in</strong>e che è comunque <strong>in</strong>sita <strong>in</strong> lui, <strong>in</strong>sopprimibile, nella forma di un<br />
plesso solare:<br />
Per primo ed <strong>in</strong>nanzitutto, tu possiedi un plesso solare, caro lettore; ed il plesso solare è un grande centro<br />
nervoso che è situato dietro il tuo stomaco. […] Ora, il tuo plesso solare, gentilissimo tra i lettori, sta dove sei tu.<br />
E’ il primo, il più grande ed il più profondo centro dell’io cosciente. […] Al tuo plesso solare sei conscio <strong>in</strong><br />
modo primario: là, dietro il tuo stomaco. Là possiedi la profonda ed orig<strong>in</strong>aria consapevolezza conscia che sei tu.<br />
[…] Dal plesso solare sai che tutto il mondo è tuo, e che tutto è div<strong>in</strong>o 489 .<br />
Nell’ambito della cosmologia simbolica disegnata da Lawrence <strong>in</strong> questo libro si può dedurre<br />
l’importanza che lo scrittore riservava al sole: “[…] penso che sia giusto dire che noi tutti<br />
488 P. Fjagesund, The apocalyptic world of D. H. Lawrence, cit. p. 76.<br />
489 D. H. Lawrence, Fantasia dell’<strong>in</strong>conscio, cit. p. 33.<br />
140
abbiamo la nostra identità <strong>in</strong>f<strong>in</strong>ita nel sole” 490 . L’esperienza di Juliet, protagonista del<br />
racconto Sole, si configura, dunque, come la narrazione di un’esperienza esistenziale.<br />
L’<strong>in</strong>izio del racconto è <strong>in</strong> città dove Juliet, la protagonista, vive l’oramai classica situazione di<br />
crisi procurata dalla vita nella società moderna. Per Fjagesund la protagonista ricalca uno<br />
stereotipo tipico di Lawrence che è appunto quello del personaggio <strong>in</strong> crisi che abbandona la<br />
società civile per luoghi ai conf<strong>in</strong>i del mondo conosciuto: “Juliet, a typically Lawrentian<br />
ero<strong>in</strong>e suffer<strong>in</strong>g from the deadly burden of civilization, receives a new life from the sun” 491 .<br />
Il racconto di Lawrence <strong>in</strong>izia con la descrizione di una distanza: “-La porti lontano al sole-,<br />
disse il dottore” 492 . Il sole è dunque lontano, fuori dalla città, al riparo dagli sguardi degli<br />
uom<strong>in</strong>i civili. Il sole è lontano come una memoria che da troppo tempo non si richiama alla<br />
mente. La distanza di questo sole è sottol<strong>in</strong>eata da Fjagesund che nota come la sua lontananza<br />
sia equiparata da Lawrence a quella dell’età dell’oro: “The symbol of the sun is like a<br />
memory of that Golden Age […]” 493 . Siamo ancora una volta nel dom<strong>in</strong>io del mito. Il “sole<br />
lontano” non <strong>in</strong>dica esclusivamente un luogo geografico ma anche una dimensione temporale.<br />
Il viaggio che la protagonista <strong>in</strong>traprende è dunque ancora una volta viaggio mitico. E’ un<br />
viaggio, che dopo il simbolico <strong>in</strong>cipit, lo scarno responso del dottore, <strong>in</strong>izia su un fiume, così<br />
come era <strong>in</strong>iziato il viaggio di Marlow <strong>in</strong> Cuore di tenebra. Il fiume Hudson, come un<br />
serpente, sembra <strong>in</strong>filtrarsi negli accessi più remoti della memoria umana:<br />
La nave salpò a mezzanotte […]. Era una notte scura, l’Hudson era gonfio di una pesante oscurità e scosso da<br />
spruzzi di luce che si rovesciavano. Si sporse dal parapetto, e guardando <strong>vers</strong>o il basso, pensò: questo è il mare, è<br />
più profondo di quanto lo immag<strong>in</strong>iamo e ancor più pieno di ricordi. In quel momento il mare parve gonfiarsi<br />
come il serpente del caos che vive per sempre 494 .<br />
Il racconto <strong>in</strong>izia dunque con un notturno. I riflessi di luce sull’acqua rendono visivamente le<br />
squame del serpente a cui è associato il fiume. La luce sembra dunque provenire, a sprazzi,<br />
dal fiume della memoria che la protagonista decide di ripercorrere. L’oscurità <strong>in</strong> cui è calato<br />
l’<strong>in</strong>izio del racconto è ovviamente simbolica. Il camm<strong>in</strong>o di Juliet procederà dall’oscurità<br />
della notte newyorchese alla luce della costa mediterranea: “E per quanto l’Atlantico fosse<br />
grigio come lava, alla f<strong>in</strong>e lei arrivò al sole” 495 . Il percorso disegnato da Lawrence per la sua<br />
ero<strong>in</strong>a la conduce direttamente sulle sponde del Mediterraneo, luogo descritto <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i<br />
mitici come il posto “dove i siculi avevano già bevuto prima dell’arrivo dei greci” 496 . In<br />
questo luogo baciato dal sole, Juliet prova, all’<strong>in</strong>izio della sua permanenza, una sorta di<br />
disagio. E’ <strong>in</strong> questo momento che si <strong>in</strong>troduce il motivo del nudismo: “Fu così che spuntò<br />
segretamente <strong>in</strong> lei il desiderio di andarsene nuda nel sole; ed ella nutrì questo suo desiderio<br />
come un segreto” 497 . La vita di Juliet si struttura <strong>in</strong> funzione del sole. I suoi ritmi vitali si<br />
accordano a quelli della natura: “Dentro di sé pensava al sole <strong>in</strong> tutto il suo splendore, e a<br />
stare con lui. La sua vita ora era tutto un rituale. Si svegliava prima dell’alba per osservare il<br />
grigio che mutava colore e si trasformava <strong>in</strong> pallido oro, per sapere se c’erano nuvole<br />
sull’orizzonte. E si riempiva di felicità quando il sole sorgeva fuso nella sua nudità […]” 498 .<br />
La scoperta di un tempo naturale, scandito dal movimento del sole, e di una condizione fisica<br />
r<strong>in</strong>vigorita, rimandano direttamente alla situazione dell’anima di Juliet:<br />
490<br />
Ivi, p. 132.<br />
491<br />
P. Fjagesund, The apocalyptic world of D. H. Lawrence, cit. p. 76.<br />
492<br />
D. H. Lawrence, Sole, contenuto <strong>in</strong> D.H. Lawrence, Tutti i racconti e i romanzi brevi, Newton Compton<br />
Editori, Roma, 1995, p. 832.<br />
493<br />
P. Fjagesund, The apocalyptic world of D. H. Lawrence, cit. p. 77.<br />
494<br />
D. H. Lawrence, Sole, cit. p. 832.<br />
495 Ibidem.<br />
496 Ivi, p. 833.<br />
497 Ibidem.<br />
498 Ivi, p. 834.<br />
141
Riusciva a sentire il sole che le penetrava f<strong>in</strong> nelle ossa; no, ancora più <strong>in</strong> fondo, f<strong>in</strong>o alle emozioni e ai pensieri.<br />
L’oscura tensione delle sue emozioni com<strong>in</strong>ciò ad allentarsi, i nodi freddi e scuri dei suoi pensieri <strong>in</strong>iziarono a<br />
dissol<strong>vers</strong>i. Iniziava a riscaldarsi sempre di più.[…] Oramai ogni fibra del suo corpo conosceva il sole, non era<br />
rimasta nemmeno un’ombra fredda. Ed era scomparso ormai anche il suo cuore, quel cuore ansioso, oppresso,<br />
come un fiore che cade al sole, e lascia dietro di sé soltanto semi maturi 499 .<br />
E’ una condizione vitale che la allontana dal mondo degli uom<strong>in</strong>i; questi sono visti vivere <strong>in</strong><br />
una condizione disperata di prepotenza e debolezza e paragonati a vermi. La conoscenza della<br />
natura, rappresentata dall’armonia raggiunta con il sole, crea uno scarto, una distanza, oramai<br />
<strong>in</strong>colmabile tra la sua condizione e quella degli uom<strong>in</strong>i civili: “La sua conoscenza del sole e la<br />
conv<strong>in</strong>zione che il sole la conoscesse, nel senso cosmico, carnale della parola, le fece provare<br />
una sensazione di distacco dalla gente, e anche un certo disprezzo per gli esseri umani.<br />
Mancavano di elementarità, di solarità. Erano come i vermi dei cimiteri” 500 . L’esperienza del<br />
nudismo diviene un viatico esistenziale <strong>in</strong> cui la malattia della civiltà moderna è messa a<br />
confronto con la naturalità di una vita “solare”:<br />
Non era come fare dei semplici bagni di sole. Era molto di più. Qualcosa nel profondo di lei si dispiegava e si<br />
rilassava, e lei si scioglieva. Attra<strong>vers</strong>o qualche misteriosa forza dentro lei, più profonda della volontà e della<br />
consapevolezza che si conosceva, venne messa <strong>in</strong> comunicazione con il sole, e la corrente fluiva da sola, dal suo<br />
grembo. E lei, il suo io stesso, erano di secondo piano, una persona di secondo piano, quasi uno spettatore. La<br />
vera Juliet era questo flusso oscuro che sgorgava dalla profondità del corpo f<strong>in</strong>o al sole. Era sempre stata<br />
padrona di sé, consapevole di quello che faceva, e tesa nella volontà. Adesso sentiva dentro di lei tutto un altro<br />
tipo di volontà, qualcosa più grande di lei, che fluiva spontaneamente 501 .<br />
Ci si trova dunque di fronte a un processo di anamnesi nel momento <strong>in</strong> cui Juliet, per mezzo<br />
del sole, riesce a recuperare la percezione di una forza <strong>in</strong>terna sempre posseduta ma obliata<br />
per lungo tempo. Lo stesso concetto di <strong>in</strong>dividualità, di personalità e di volontà subiscono<br />
trasformazioni profonde. Anche <strong>in</strong> questo caso l’episodio descritto da Lawrence è da leggersi<br />
come term<strong>in</strong>e di confronto con l’attitud<strong>in</strong>e moderna alla vita. Il ritorno ad una vita semplice e<br />
naturale comporta un miglioramento delle condizioni psico-fisiche della protagonista che<br />
sviluppa una nuova <strong>in</strong>terpretazione del suo rapporto con il mondo. Il modello di vita moderna<br />
costruito dalla civiltà occidentale è implicitamente, ma <strong>in</strong>equivocabilmente, al centro della<br />
critica di Lawrence. Juliet segue oramai un percorso scandito dal ritmo della natura e<br />
organizzato come un rito magico. Il confronto fra questo nuovo mondo e quello della civiltà<br />
moderna si rende sempre più manifesto:<br />
Juliet aveva smesso di preoccuparsi di qualsiasi cosa. Adesso, per la maggior parte della giornata, se ne stava<br />
nuda al sole, e questo era tutto quello che desiderava.[…] Madre e figlio erano ora entrambi abbronzati con<br />
un’abbronzatura d’oro rosato dappertutto. - Sono un’altra persona! - diceva Juliet a sé stessa, guardandosi i seni<br />
e le cosce d’oro rosso.[…] Com<strong>in</strong>ciava ad avvertire la consapevolezza che stava sorgendo <strong>in</strong> lei un’attività<br />
<strong>in</strong>teriore che l’avrebbe condotta a un nuovo modo di vivere. Tuttavia non voleva avere questa consapevolezza.<br />
Conosceva a sufficienza il grande, freddo apparato della civiltà, dal quale era tanto difficile evadere 502 .<br />
499 Ibidem.<br />
500 Ivi, p. 835<br />
501 Ivi, p. 837.<br />
502 Ibidem.<br />
142
Con l’arrivo del marito di Juliet, Maurice, il racconto di Lawrence assume la sua forma f<strong>in</strong>ale.<br />
Juliet era andata lontano, al sole, ma ora la distanza era troppa e non sarebbe mai potuta<br />
tornare <strong>in</strong>dietro. L’immag<strong>in</strong>e del cittad<strong>in</strong>o, Maurice, si contrappone a quella della donna. La<br />
sua immag<strong>in</strong>e “vestita” si contrappone a quella della moglie completamente nuda. Ma ad<br />
essere a disagio è il marito che, con i suoi abiti americani da bus<strong>in</strong>ess man, appare<br />
estremamente goffo <strong>in</strong> quell’ambiente, tanto che il figlio lo <strong>in</strong>viterà a spogliarsi. La figura<br />
dell’uomo vestito e goffo si contrappone a quella di Juliet che è <strong>in</strong>vece assolutamente a suo<br />
agio, quasi <strong>in</strong>dossasse degli <strong>in</strong>visibili vestiti: “In qualche modo lei non sembrava così<br />
terribilmente nuda. L’abbronzatura d’oro rosato del sole la vestiva” 503 . Il contrasto è evidente<br />
e marcato dallo scrittore che è impietoso nei confronti dell’“uomo civile”: “Ma aveva l’odore<br />
del mondo, di tutti i ceppi e delle bastarde umiliazioni del mondo. Era marchiato con il<br />
marchio che non dichiarava una buona orig<strong>in</strong>e” 504 . Nel racconto di Lawrence c'è questa<br />
<strong>in</strong>sanabile scissione tra persone solari e persone oscure. Juliet, ritirata sul suo eremo <strong>in</strong>sieme<br />
al figlioletto, <strong>def</strong><strong>in</strong>isce il marito “come un verme che non ha mai visto il sole” 505 mentre usa<br />
per se l'appellativo di “gatta selvatica” 506 e per il figlio “un giovane animale assorto” 507 . La<br />
distanza fra il mondo civile e quello primitivo appare il vero tema del racconto. Il viaggio si<br />
compie come fuga dalla città. Il mondo rurale e ancestrale che viene r<strong>in</strong>venuto sembra voler<br />
comunicare a Juliet i suoi segreti, i suoi ricordi. Il punto di contatto, il ritorno, è segnato dal<br />
motivo del nudismo che mette <strong>in</strong> evidenza, ancora una volta, la vera problematica di tutta la<br />
composizione: la crisi esistenziale dell’uomo moderno.<br />
Il rapporto di Juliet con il paesaggio naturale è un altro motivo degno di nota nel racconto. Il<br />
luogo prescelto per denudarsi è uno scoglio, luogo impervio, quasi <strong>in</strong>accessibile agli altri<br />
uom<strong>in</strong>i. Juliet non solo si <strong>in</strong>serisce nell’ambiente che la circonda, ma si lascia compenetrare<br />
dall’elemento naturale che, con gentilezza e decisione, si re-impadronisce del suo corpo. Juliet<br />
sceglie la solitud<strong>in</strong>e di un luogo appartato, uno scoglio sul mare, per entrare <strong>in</strong> comunione la<br />
natura. La donna matura come un frutto sotto il sole, raggiungendo uno stato d’estasi che la<br />
isola dal mondo reale:<br />
Si fece scivolare di dosso tutti i vestiti e si stese nuda al sole, e così sdraiata guardò su attra<strong>vers</strong>o le dita al sole,<br />
alla sua pulsante azzurra rotondità, i cui bordi esterni emanavano brillantezza.[...] Si rivolse giù, <strong>vers</strong>o di lei con<br />
il suo sguardo di fuoco azzurro e avvolse i suoi seni, il suo volto, la sua gola, il suo grembo stanco, le g<strong>in</strong>occhia,<br />
le cosce e i piedi.[...] Riusciva a sentire il sole che le penetrava f<strong>in</strong> nelle ossa; no, ancora più a fondo, f<strong>in</strong>o alle<br />
emozioni e ai pensieri.[...] quasi stordita tornò a casa vedendo solo a metà accecata e stordita dal sole. E la sua<br />
cecità era per lei una ricchezza come la calda, oscura, pesante semi-<strong>in</strong>coscienza che la avvolgeva 508 .<br />
A protezione di questo scoglio, un cipresso <strong>def</strong><strong>in</strong>ito da Lawrence come un “guardiano”. Per<br />
Vickery il riferimento al cipresso è di chiara derivazione frazeriana. I popoli primitivi<br />
reputavano gli alberi esseri viventi possessori di un’anima. Il selvaggio, nel bene o nel male,<br />
non poteva non dare un ruolo all’albero che rientrava nel suo uni<strong>vers</strong>o unitario e unificante.<br />
L’albero è anche relazionato direttamente alle condizioni metereologiche tanto che lo<br />
spogliarsi di Juliet e il suo sdraiarsi alle pendici dell’albero sono gesti che potrebbero essere<br />
<strong>in</strong>terpretati come una sorta di venerazione e di supplica al “guardiano” aff<strong>in</strong>ché le conceda il<br />
sole 509 . Lawrence descrive un paesaggio mediterraneo, colmo di sole e mare, <strong>in</strong> cui le piante<br />
503 Ivi, p. 839.<br />
504 Ivi, p. 843.<br />
505 Ivi, p. 834.<br />
506 Ivi, p. 836.<br />
507 Ivi, p. 837.<br />
508 Ivi, pp. 834-36.<br />
509 J. Frazer, Il ramo d’oro, cit. pp.139-150.<br />
143
dell’olivo e del limone primeggiano fra le altre. Juliet è descritta come essere <strong>in</strong> totale<br />
simbiosi con la natura a differenza del marito che si muove con impaccio nel groviglio della<br />
vegetazione. Il luogo così descritto assume le caratteristiche del luogo eterno, mitico,<br />
rapportandosi ad un’antica civiltà ideale. E’ il riferimento, spesso presente nei testi di<br />
Lawrence, alla mitica età dell’oro: “I sentieri erano coperti di erba, fiori e nepitella, tanto da<br />
sembrare tracce di uccelli <strong>in</strong> un luogo eternamente selvatico. Che strana, la vivida<br />
selvatichezza dei luoghi antichi della civiltà, una selvatichezza che non è desolazione” 510 .<br />
All’<strong>in</strong>terno di questa lussureggiante vegetazione Juliet si <strong>in</strong>serisce come una n<strong>in</strong>fa dei boschi<br />
ed è descritta da Lawrence come fosse parte <strong>in</strong>tegrante di quella natura. Come una n<strong>in</strong>fa la<br />
protagonista si adorna di vegetali, richiamando le antiche div<strong>in</strong>ità pagane della fertilità<br />
descritte da Frazer, e lo stesso scrittore utilizza metafore vegetali per cogliere aspetti del suo<br />
agire: “Si allungò per prendere delle foglie e se le mise sugli occhi. Poi si distese di nuovo,<br />
come una lunga zucca al sole, che deve maturarsi e diventare dorata.[…] e si strof<strong>in</strong>ava la<br />
pelle con un po’ d’olio d’oliva, e vagava un momento nell’oscuro sottobosco dei limoni,<br />
tenendo <strong>in</strong> equilibrio all’ombellico un fiore di limone” 511 . Il luogo naturale, diventato per<br />
Juliet il luogo della rigenerazione, assume presto i tratti mitici del giard<strong>in</strong>o dell’Eden dove, la<br />
figura simbolica del serpente, già preannunciata nelle prime righe del racconto, fa la sua<br />
apparizione per riappacificarsi con l’uomo, per sancirne il bentornato nel paradiso terrestre.<br />
Lawrence svolge il mito della cacciata dall’Eden a ritroso, attra<strong>vers</strong>o la memoria di quel<br />
peccato che, come un immenso fiume squamoso, si svolge all’<strong>in</strong>dietro nel tempo. E’ un<br />
viaggio <strong>vers</strong>o le orig<strong>in</strong>i, al pr<strong>in</strong>cipio del tempo, alle fonti del mito, alla Genesi. Il ritorno<br />
mitico di Juliet avviene attra<strong>vers</strong>o i rituali della nudità. Il ritorno alla terra da parte della<br />
protagonista non sancirà un’effettiva riunione, un <strong>def</strong><strong>in</strong>itivo riprist<strong>in</strong>o dell’unità smarrita.<br />
Questo ritorno tende <strong>in</strong>vece a sancire, per l’ennesima volta, il dest<strong>in</strong>o tragico dell’essere<br />
umano. La parte f<strong>in</strong>ale del racconto è costruita da Lawrence proprio <strong>in</strong> questa forma. Le<br />
forme <strong>in</strong>vitanti della natura, che f<strong>in</strong>o a quel momento avevano circondato la protagonista,<br />
assumono un aspetto umano. E’ l’<strong>in</strong>contro con l’altro, il contad<strong>in</strong>o. Questo contad<strong>in</strong>o è<br />
l’umanizzazione di tutti gli attributi che f<strong>in</strong>o a quel momento erano state attribuiti alla natura.<br />
Egli è il selvaggio che esce dalla terra per tentare Juliet. Questo personaggio terrestre è<br />
descritto come un perfetto messaggero, colui che potrebbe riprist<strong>in</strong>are <strong>def</strong><strong>in</strong>itivamente la<br />
comunicazione fra Juliet e la terra: “Juliet cont<strong>in</strong>uò a camm<strong>in</strong>are svelta; ma aveva<br />
riconosciuto subito la generosità violenta del suo sangue, e l’altrettanto violenta selvaggia<br />
timidezza” 512 . I due personaggi si configurano come i rappresentanti delle rispettive<br />
dimensioni. La lontananza che divide le due realtà è ampia ma, se anche senza l’<strong>in</strong>staurarsi di<br />
una comunicazione, era evidente che ognuno dei due non poteva ignorare l’esistenza<br />
dell’altro: “A poco a poco tra Juliet e lui era sorta una certa <strong>in</strong>timità, attra<strong>vers</strong>o la distanza.<br />
Sapevano l’uno dell’altra” 513 . Questo sapere l’uno dell’altra rimanda alle tematiche della<br />
memoria, all’impossibilità di cancellare o r<strong>in</strong>venire completamente le tracce dell’essere<br />
perduto. Il contad<strong>in</strong>o è simbolo della terrestrità che riaffiora dal sottosuolo come una<br />
fiammata improvvisa, <strong>in</strong>cendiando l’animo della protagonista. Il rapporto fra i due è sempre<br />
descritto da Lawrence sullo sfondo di uno spazio profondo e impercorribile. I due cont<strong>in</strong>uano<br />
ad osservarsi da lontano, a studiarsi con curiosità e paura. Ma la distanza sembra dest<strong>in</strong>ata a<br />
rimanere tale:<br />
Egli la vide, sollevando il viso accaldato, mentre lei si allontanava. Una fiamma attra<strong>vers</strong>ò gli occhi dell’uomo, e<br />
una fiamma <strong>in</strong>vase il corpo di lei, fondendole le ossa. Ma ella si ritrasse silenziosamente dietro i cespugli, e tornò<br />
da dove era venuta. Un po’ risentita si chiese perché egli dovesse lavorare <strong>in</strong> silenzio, nascosto tra i cespugli.<br />
Egli aveva questa selvaggia capacità animalesca. Da allora i loro corpi avevano percepito una reciproca dolorosa<br />
510<br />
D. H. Lawrence, Sole, cit. p. 839.<br />
511<br />
Ivi, p. 834.<br />
512<br />
Ivi, p. 842.<br />
513<br />
Ibidem.<br />
144
consapevolezza, anche se nessuno di loro voleva ammetterla, e non ne davano segno 514 .<br />
La dimensione tragica dell’<strong>in</strong>tero racconto com<strong>in</strong>cia a chiarirsi <strong>in</strong> questo passaggio. La<br />
“dolorosa consapevolezza” che i personaggi, così distanti, acquisiscono, segnerà la condanna<br />
a rimanere chiusi nelle rispettive dimensioni. L’esperienza di Juliet non si risolverà <strong>in</strong> un<br />
ritorno ma nella tragica consapevolezza di non poter sfuggire al proprio dest<strong>in</strong>o:<br />
Lei, adesso che era matura, e scura di sole, e che il suo cuore era sfogliato come una rosa, lei era voluta andare<br />
con il timido, focoso contad<strong>in</strong>o, ed essere <strong>in</strong>c<strong>in</strong>ta di lui. I suoi sentimenti erano caduti come petali. Aveva visto<br />
affluire il sangue <strong>in</strong> quella faccia bruciata, e la fiamma negli occhi azzurri del Sud, e la risposta, da parte di lei,<br />
era stato un getto di fuoco. Egli per lei avrebbe potuto essere un bagno di sole procreativo, e lei lo voleva.<br />
Nonostante ciò, il suo prossimo figlio sarebbe stato di Maurice. La fatale catena della cont<strong>in</strong>uità lo avrebbe<br />
determ<strong>in</strong>ato 515 .<br />
La ricerca degli <strong>in</strong>tellettuali modernisti <strong>in</strong>torno al rapporto tra sapienza antica e sapienza<br />
moderna, tra ragioni del corpo e dell’io cosciente moderno, procede serrata alla ricerca di<br />
nuovi motivi che sond<strong>in</strong>o la distanza tra la natura umana e la condizione dell’uomo moderno.<br />
Il motivo dei sacrifici umani si <strong>in</strong>serisce appieno <strong>in</strong> questo filone di ricerca. Pavese si<br />
<strong>in</strong>teressò al motivo desumendolo direttamente da Lawrence.<br />
Il motivo del sacrificio umano è ampiamente presente nella letteratura modernista.<br />
Nell’ambito della ricerca di una nuova comunione con la terra, il sacrificio umano diviene<br />
un’immag<strong>in</strong>e privilegiata rimandando, al contempo, alle antiche usanze primitive delle<br />
popolazioni rurali. L’<strong>in</strong>flusso di Frazer fu, sugli scrittori modernisti, talmente profondo che<br />
non pochi decisero di cimentarsi con questo scomodo motivo. Sia Pavese che Lawrence<br />
svilupparono il motivo proprio partendo dall’etnologo scozzese. Lawrence fece un elevato uso<br />
di riferimenti al Ramo d’oro e alle pratiche sangu<strong>in</strong>arie dei riti primitivi. In Sons and lo<strong>vers</strong> il<br />
motivo del sacrificio scorre parallelo a quello della narrazione, proiettando la sua <strong>in</strong>quietante<br />
ombra sullo svolgimento della vita dei protagonisti. L’ambientazione naturale ricorda i<br />
paesaggi descritti da Frazer. Sono gli stessi paesaggi dove avvenivano i sacrifici umani nei<br />
tempi arcaici. L’<strong>in</strong>contro fra Miriam, <strong>def</strong><strong>in</strong>ita da Fiona Becket come una “sacerdotessa<br />
pagana” 516 , e Paul avviene nei campi di grano al cospetto della mezza luna:<br />
The beauty of the night made him want to shout. A half-moon, dusky gold, was s<strong>in</strong>k<strong>in</strong>g beh<strong>in</strong>d the black<br />
sycamore at the end of the garden, mak<strong>in</strong>g the sky dull purple with its glow. Nearer, a dim white fence of lilies<br />
went across the garden, and the air all round seemed to stir with scent, as if it were alive. He went across the bed<br />
of p<strong>in</strong>ks, whose keen perfume came sharply across the rock<strong>in</strong>g, heavy scent of the lilies, and stood alongside the<br />
white barrier of flowers. They flagged all loose, as if they were pant<strong>in</strong>g. The scent made him drunk. He went<br />
down to the field to watch the moon s<strong>in</strong>k under. A corncrake <strong>in</strong> the hay-close called <strong>in</strong>sistently. The moon slid<br />
quite quickly downwards, grow<strong>in</strong>g more flushed. Beh<strong>in</strong>d him the great flowers leaned as if they were call<strong>in</strong>g.<br />
And then, like a shock, he caught another perfume, someth<strong>in</strong>g raw and coarse. Hunt<strong>in</strong>g round, he found the<br />
purple iris, touched their fleshy throats and their dark, grasp<strong>in</strong>g hands. At any rate, he had found someth<strong>in</strong>g.<br />
They stood stiff <strong>in</strong> the darkness. Their scent was brutal. The moon was melt<strong>in</strong>g down upon the crest of the hill. It<br />
was gone; all was dark. The corncrake called still 517 .<br />
514<br />
Ibidem.<br />
515<br />
Ivi, p. 843.<br />
516<br />
“A priestess, subtly pagan, Miriam might draw his soul out of him” da F. Beckett, The complete guide to D.<br />
H. Lawrence, cit. p. 46.<br />
517<br />
D. H. Lawrence, Sons and Lo<strong>vers</strong> , cit. 358-59.<br />
145
Il profumo “brutale” dei fiori, la forma “a falce” della luna, l’oscurità <strong>in</strong>combente e il<br />
richiamo <strong>in</strong>sistente del campo di grano, sono tutti elementi che rimandano ai luoghi dei<br />
sacrifici descritti da Frazer. Paul sembra seguire la prassi del rito conducendo la giovane<br />
ragazza, adornata di fiori, nei campi. Miriam, di fronte alla luce della luna, perde ogni<br />
caratteristica umana divenendo personaggio assoluto, simbolico, una trasfigurazione:<br />
Here they wandered, pick<strong>in</strong>g still a few marsh-marigolds and many big blue forget-me-nots. Then she sat on the<br />
bank with her hands full of flowers, mostly golden water- blobs. As she put her face down <strong>in</strong>to the marigolds, it<br />
was all overcast with a yellow sh<strong>in</strong>e.<br />
"Your face is bright," he said, "like a transfiguration" 518 .<br />
Il corpo di Miriam, denudato, svela tutta la sua bellezza mentre Paul è pronto a svolgere il rito<br />
dell’<strong>in</strong>iziazione che verrà <strong>in</strong>evitabilmente legato, alla f<strong>in</strong>e dell’amplesso, a sentimenti di<br />
morte e ricongiungimento:<br />
She had the most beautiful body he had ever imag<strong>in</strong>ed. He stood unable to move or speak, look<strong>in</strong>g at her, his<br />
face half-smil<strong>in</strong>g with wonder. And then he wanted her, but as he went forward to her, her hands lifted <strong>in</strong> a little<br />
plead<strong>in</strong>g movement, and he looked at her face, and stopped. Her big brown eyes were watch<strong>in</strong>g him, still and<br />
resigned and lov<strong>in</strong>g; she lay as if she had given herself up to sacrifice: there was her body for him; but the look<br />
at the back of her eyes, like a creature await<strong>in</strong>g immolation, arrested him, and all his blood fell back.[…] She lay<br />
to be sacrificed for him because she loved him so much. And he had to sacrifice her. For a second, he wished he<br />
were sexless or dead. Then he shut his eyes aga<strong>in</strong> to her, and his blood beat back aga<strong>in</strong>.[…] As he rode home he<br />
felt that he was f<strong>in</strong>ally <strong>in</strong>itiated. He was a youth no longer. But why had he the dull pa<strong>in</strong> <strong>in</strong> his soul? Why did the<br />
thought of death, the after-life, seem so sweet and consol<strong>in</strong>g? 519<br />
Anche <strong>in</strong> questo caso, il riferimento al motivo del sacrificio umano è da <strong>in</strong>tendersi <strong>in</strong><br />
riferimento e <strong>in</strong> contrapposizione all’impellente modernità. Attra<strong>vers</strong>o una <strong>vers</strong>ione ironica di<br />
un antico rito di fertilità, Lawrence svolge l’<strong>in</strong>iziazione del suo personaggio <strong>in</strong> un contesto <strong>in</strong><br />
cui queste pratiche hanno perso il loro senso. E’ come se i protagonisti agissero <strong>in</strong> una<br />
determ<strong>in</strong>ata maniera nel ricordo di un’antica sapienza che il mondo moderno ha sottratto loro.<br />
Da qui il sentimento di <strong>in</strong>completezza che alberga <strong>in</strong> Paul, l’<strong>in</strong>iziato, e la speranza, dest<strong>in</strong>ata<br />
ad essere delusa, di Miriam, la sacerdotessa, che spera, attra<strong>vers</strong>o quel rito, di sancire il<br />
proprio possesso sull’amante. Ci troviamo, per l’ennesima volta, <strong>in</strong> una narrazione modernista<br />
a due flussi temporali, quello storico l<strong>in</strong>eare e quello mitico circolare, che si contrastano e si<br />
<strong>in</strong>tersecano confermando la loro <strong>in</strong>conciliabilità. Vickery spiega la sovrapposizione dei piani<br />
che Lawrence disegna per questo romanzo 520 :<br />
518 Ivi, pp. 352-53.<br />
519 Ivi, pp. 353-54.<br />
520 Vickery <strong>in</strong>serisce <strong>in</strong> questa categoria non solo Sons and Lo<strong>vers</strong> ma altri romanzi che ne condividono la<br />
struttura b<strong>in</strong>aria.<br />
146
In effect, Lawrence here uses what he has learned from The Golden Bough about the religious role, the sacrifical<br />
character, and the fertility associations of virg<strong>in</strong>s to a twofold end. On the one hand, he endeavors to picture<br />
contemporary virg<strong>in</strong>s who possess just these qualities so that the sense of regard<strong>in</strong>g life with reverence, awe, and<br />
delight, as he thought Frazer’s early civilizations did, will be borne <strong>in</strong> upon his readers. On the other hand, he<br />
also sketches pitilessly the virg<strong>in</strong>s of the modern world who lack the div<strong>in</strong>e potency of their predecessors and<br />
whose lives are therefore compounded of hesitant timidity and self-centered arrogange 521 .<br />
L’utilizzo degli elementi di etnologia derivati direttamente da Frazer è dunque funzionale allo<br />
stabilirsi di quella distanza, tra il mondo e la terra, tra l’umanità moderna e il suo essere, che<br />
dovrebbe dimostrare all’uomo quanto egli si stia allontanando dalle sue orig<strong>in</strong>i. I romanzi di<br />
Lawrence si costruiscono prevalentemente sulla rappresentazione di questi <strong>in</strong>sanabili contrasti<br />
che traggono, dal materiale frazeriano che parla di lontananze remote e di vic<strong>in</strong>anze<br />
impercettibili, un’ottima possibilità di resa narrativa. Vickery <strong>in</strong>dividua <strong>in</strong> una irrisolta<br />
tensione fra gli opposti uno schema consistente della scrittura di Lawrence: “[…] the novels,<br />
many of which may be viewed, at least <strong>in</strong> part, as patterns of tension between the ord<strong>in</strong>ary,<br />
common-sense mode of counsciousness and the blood-counsciousness which, as we have<br />
already seen, Lawrence l<strong>in</strong>ked so closely to the contents of Frazer’s work” 522 . Ma così come<br />
avviene <strong>in</strong> molti dei romanzi modernisti, questa tensione non si può risolvere semplicemente<br />
nel rapporto degli opposti assoluti nel momento <strong>in</strong> cui i personaggi agiscono <strong>in</strong> terre di<br />
conf<strong>in</strong>e e sono essi stessi ibridi portatori <strong>in</strong> loro stessi dell’irrisolvibile conflitto: “Like Frazer,<br />
Lawrence sees that some manners of th<strong>in</strong>k<strong>in</strong>g go back to the dimmest reaches of man’s<br />
existence and that they persist dimly and confusedly <strong>in</strong>to the present” 523 .<br />
Cesare Pavese elaborò ampiamente il motivo dei sacrifici umani traendo spunto dalla lettura<br />
di Frazer. E’ <strong>in</strong>teressante constatare come il motivo del sacrificio umano si possa r<strong>in</strong>tracciare<br />
sia nel primo romanzo, Paesi tuoi, sia nell’ultimo, La luna e i falò. Questa co<strong>in</strong>cidenza è<br />
senz’altro <strong>in</strong>dice di un’attenzione particolare nei confronti del motivo, attenzione che da<br />
subito si tramutò <strong>in</strong> suggestione tanto da affiorare sovente nelle pag<strong>in</strong>e dello scrittore lungo<br />
tutto l’arco della sua produzione. Gli appunti de Il Mestiere di Vivere confermano l’attenzione<br />
dello scrittore <strong>vers</strong>o questo motivo: “La natura ritorna selvaggia quando vi accade il proibito:<br />
sangue o sesso. Parrebbe un’illusione suggerita dall’idea che ti fai delle culture primitive – riti<br />
sessuali o sangu<strong>in</strong>ari” 524 . Il proibito diviene dunque ciò che sfugge al civile e rappresenta, di<br />
conseguenza, una sottile forma di distruzione di tutta la morale moderna. Per sottol<strong>in</strong>eare la<br />
pregnanza del motivo dei sacrifici umani nell’ambito della poetica di Pavese, fa bene<br />
Gioanola a citare Calv<strong>in</strong>o che si era <strong>in</strong>teressato a questo aspetto della poetica dell’amico<br />
scrittore: “Tutto quel che (Pavese) dice converge <strong>in</strong> una direzione sola, immag<strong>in</strong>i e analogie<br />
gravitano su una preoccupazione ossessiva: i sacrifici umani” 525 . In Paesi Tuoi il sacrificio di<br />
Gisella avviene <strong>in</strong> occasione della trebbiatura del grano. E’ la riproposizione del rito della<br />
fecondazione della terra così come descritto da Frazer <strong>in</strong> riferimento alle popolazioni<br />
primitive. Berto, il cittad<strong>in</strong>o, diviene <strong>in</strong>consapevolmente parte di questo rito. Il suo orrore è<br />
scarsamente condiviso dal resto dei contad<strong>in</strong>i che anzi cont<strong>in</strong>uarono la trebbiatura come se<br />
poco o nulla fosse accaduto. La morte della giovane per mano di Tal<strong>in</strong>o assume solo<br />
apparentemente le sembianze di un <strong>in</strong>cidente all’<strong>in</strong>terno della struttura narrativa architettata<br />
da Pavese. Per Muniz il motivo del sacrificio umano “costituirà <strong>in</strong>fatti il terzo (per Muniz gli<br />
altri due motivi sono l’azione <strong>in</strong> senso stretto e le riflessioni di Berto sul mistero che avvolge<br />
Tal<strong>in</strong>o) e più sotterraneo filo conduttore del romanzo, <strong>vers</strong>o il quale anzi tenderanno<br />
521<br />
J. B. Vickery, The literary Impact of The Golden Bough, cit. pp. 304-05.<br />
522<br />
Ivi, p. 307.<br />
523<br />
Ibidem.<br />
524<br />
C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, 13 Luglio 1944, cit. p. 284.<br />
502<br />
E. Gioanola, Cesare Pavese, La realtà, l’altrove, il silenzio, cit. p. 54.<br />
503<br />
M. de las Nieves Muniz Muniz, Introduzione a Pavese, cit. pp. 68-69.<br />
147
fatalmente gli altri due man mano che si avvic<strong>in</strong>a l’<strong>in</strong>izio della trebbiatura” 526 . Il motivo del<br />
sacrificio umano sembra dunque essere estremamente legato allo svolgimento dell’opera.<br />
Anche <strong>in</strong> questo caso assistiamo alla composizione di una struttura b<strong>in</strong>aria. Il cittad<strong>in</strong>o cerca<br />
di scoprire i misteri relativi alla campagna e ai contad<strong>in</strong>i facendo affidamento su una logica<br />
deduttiva. L’analisi di Berto, essendo il protagonista narratore, si svolge <strong>in</strong> modo logico<br />
l<strong>in</strong>eare; la sua storia tende a ricercare un senso f<strong>in</strong>ale e liberatorio ma nel momento<br />
dell’uccisione di Gisella ci si rende improvvisamente conto che un’altra storia si stava<br />
svolgendo parallela a quella l<strong>in</strong>eare e razionale raccontata da Berto. E’ la storia della terra <strong>in</strong><br />
attesa del suo sacrificio di sangue che, puntuale, arriva nel momento della trebbiatura del<br />
grano. E’ il tempo del mito che attra<strong>vers</strong>o lo svolgimento dei suoi riti diverge sensibilmente<br />
da quello storico. Per Muniz la discrepanza fra i due piani temporali della storia è evidente:<br />
Pavese creava così una struttura <strong>in</strong> cui azione e <strong>in</strong>terpretazione co<strong>in</strong>cidevano senza uscire dal piano prettamente<br />
naturalistico di un mondo reale per quanto primitivo. Tale co<strong>in</strong>cidenza però avveniva sulla base dell’equivalenza<br />
fra il moto progressivo dell’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e che tende a far chiarezza del mistero e quello regressivo del segreto svelato,<br />
che riporta l’<strong>in</strong>dagatore (e con esso la civiltà urbana da lui rappresentata) alle sue radici più selvagge 527 .<br />
Ancora una volta ci troviamo di fronte alla contrapposizione di tempo storico e tempo mitico<br />
che trovano un’espressione narrativa nei contrasti fra civiltà moderna e civiltà rurale; la<br />
dimensione tragica si disegna tramite lo speculare confronto tra cittad<strong>in</strong>o e selvaggio.<br />
Gioanola si occupa <strong>in</strong> particolar modo di questo aspetto della poetica pavesiana r<strong>in</strong>tracciando<br />
proprio nell’etnologo scozzese la fonte primaria dell’ispirazione dello scrittore. La luna e i<br />
falò sarebbe da questo punto di vista un libro decisamente frazeriano: “[…] La luna e i falò<br />
segnerebbe un it<strong>in</strong>erario simile a quello tracciato dal celebre libro di Frazer, tanto caro allo<br />
scrittore, che è una specie di giro del mondo alla ricerca delle orig<strong>in</strong>i dei sacrifici umani e<br />
delle feste del fuoco” 528 . Il riferimento è alla morte di Santa che, dopo essere stata uccisa<br />
durante la guerra, viene bruciata nei campi. Così come accaduto con la Clara di Lawrence,<br />
Santa viene spesso descritta tramite riferimenti floreali. Il suo essere è <strong>in</strong> qualche maniera<br />
legato ai cicli della natura come sottol<strong>in</strong>ea Gioanola: “Come accade per le stagioni, la vicenda<br />
di queste ragazze è ciclica e ritornante, ripete uno schema fisso” 529 . In questo senso la morte<br />
di Santa assume un duplice significato. L’entrata della storia dell’uomo all’<strong>in</strong>terno<br />
dell’uni<strong>vers</strong>o mitico segna l’<strong>in</strong>izio di un processo di morte <strong>in</strong>esorabile che si condensa<br />
nell’assass<strong>in</strong>io, da parte dei soldati, della contad<strong>in</strong>a. Ma è anche la riscoperta di un l<strong>in</strong>guaggio<br />
arcaico, da molti dimenticato, e che solo <strong>in</strong> un occasione tragica come la morte di Santa, viene<br />
riadoperato. La giovane contad<strong>in</strong>a viene sottratta agli uom<strong>in</strong>i che, come Pavese suggerisce,<br />
avrebbero potuto cont<strong>in</strong>uare a fare scempio del suo corpo anche dopo la morte, per restituirla<br />
alla madre terra: “i sacrifici umani non rappresentano che l’atto attra<strong>vers</strong>o cui si attua la<br />
comunione tra la creatura e l’antica madre, e la terra ne riceve una nuova fecondità e tutto<br />
custodisce trasformando” 530 . E’ <strong>in</strong> fondo un ritorno quello operato da Santa che dona le sue<br />
ceneri alla terra rientrando nel ciclo della natura: “Il morire è diventare terra, cioè durata,<br />
ripetizione, immobilità: il morire, paradossalmente, non è morire ma assimilarsi all’eterno<br />
durare, è l’estrema forma del ritorno, il vero senso del paese, luogo dove si nasce e si viene a<br />
morire” 531 .<br />
Sono però forse i Dialoghi con Leucò il libro dove il selvaggio e la connessa pratica dei<br />
sacrifici umani segnano la loro presenza con maggior forza. Givone nella sua <strong>in</strong>troduzione<br />
527 Ivi, p. 69.<br />
528 E. Gioanola, Cesare Pavese, La realtà, l’altrove, il silenzio, cit. p. 54.<br />
529 Ibidem.<br />
530 Ivi, p. 55.<br />
531 Ivi, p. 55.<br />
148
all’ultima edizione del libro sottol<strong>in</strong>ea come Pavese riconobbe il vero carattere della natura<br />
che è per se stessa selvaggia. Il processo di r<strong>in</strong>venimento delle tracce, di “anamnesi” come<br />
suggerisce lo stesso Givone, che Pavese adotta <strong>in</strong> molte delle sue composizioni e soprattutto<br />
nei Dialoghi, non può che ricondurre a ciò che la civiltà moderna ha voluto obliare: “la<br />
violenza delle orig<strong>in</strong>i”, “ossia la violenza che str<strong>in</strong>ge <strong>in</strong> un nodo il sesso e il sangue, lo<br />
spargimento del seme e lo spargimento del sangue” 532 . Nel dialogo <strong>in</strong>titolato La Belva, la<br />
figura di Artemide appare di notte ad Endimione. E’ la rappresentazione della dea madre, e<br />
dunque della fertilità che, nell’iconografia classica, è raffigurata come giovane ricoperta di<br />
steli di grano. La sua selvaggia bellezza <strong>in</strong>cute terrore e fasc<strong>in</strong>o nell’osservatore: “Capisci<br />
questo? Un fiore che è come una belva? Compagno, hai mai guardato con spavento e con<br />
voglia la natura di una lupa, di una da<strong>in</strong>a, di una serpe?” 533 . Il dialogo della Belva si svolge<br />
nella contemplazione di questa belva ammaliante che diviene madre creatrice e distruttrice:<br />
“La sua voce ch’è rauca e materna è tutto quanto la selvaggia ti può dare” 534 . La<br />
consapevolezza della morte, forse prossima a venire, non impedisce ad Endimione di<br />
esprimere tutta la sua ammirazione per Artemide. Le sue ore trascorrono ora nell’attesa del<br />
ritorno della dea-belva: “So il sangue sparso, la carne dilaniata, la terra vorace, la<br />
solitud<strong>in</strong>e” 535 . La dimensione contemplativa dei personaggi non prevede necessariamente una<br />
dimensione psicologica. Le caratteristiche di Artemide sono contemplate <strong>in</strong>dipendentemente<br />
da qualsiasi metro di giudizio morale o razionale. La dea dei sacrifici umani è parte <strong>in</strong>tegrante<br />
della cultura dell’umanità che non può debellare il suo ricordo dalla memoria. Il dialogo<br />
L’Ospite è direttamente e direttamente desunto da Frazer che parla dell’antico rito frigio di<br />
Litierse che aveva l’usanza di costr<strong>in</strong>gere gli stranieri, che passavano per caso vic<strong>in</strong>o al suo<br />
campo, a mietere con lui per poi ucciderli e nutrire con il loro sangue la terra. Questa usanza<br />
durò f<strong>in</strong>o a che Litierse non s’imbattè <strong>in</strong> Ercole che lo decapitò con la falce e ne gettò il corpo<br />
nel fiume. Frazer constata come questo rito sia ancora presente nell’Europa moderna sia pure<br />
<strong>in</strong> forme meno cruente: “Qu<strong>in</strong>di, come il leggendario Litierse, anche nell’Europa moderna i<br />
mietitori si impossessano dello straniero di passaggio e lo legano nel covone. Naturalmente<br />
non arrivano al punto, come nell’antica leggenda, di mozzargli il capo; ma, pur astenendosi da<br />
misure così drastiche, il loro l<strong>in</strong>guaggio e i loro gesti sembrano <strong>in</strong>dicarne il desiderio” 536 .<br />
Pavese ripropone, nel suo dialogo, l’<strong>in</strong>contro fra Litierse ed Ercole che è dest<strong>in</strong>ato a portare il<br />
messaggio della vittoria degli dei dell’Olimpo sulla dea madre: “Sono una stirpe d’immortali.<br />
Hanno v<strong>in</strong>to la selva, la terra e i suoi mostri. Hanno cacciato nella grotta tutti quelli come te<br />
che spargevano il sangue per nutrire la terra” 537 . Con la sconfitta della terra e dei suoi riti si<br />
perde, al contempo, la conoscenza di quella terra, dei suoi misteri e delle sue orig<strong>in</strong>i. Litierse<br />
così rimprovera a Ercole la sua ignoranza nei confronti delle leggi della terra: “Tu non sei un<br />
contad<strong>in</strong>o. Lo vedo. Non sai nemmeno che la terra ricom<strong>in</strong>cia ad ogni solstizio e che il giro<br />
dell’anno esaurisce ogni cosa” 538 . L’allontanamento dalla terra, suggerisce Pavese, non fa<br />
altro che portare all’oblio delle orig<strong>in</strong>i e dell’essere mentre il funzionamento olimpico dei<br />
nuovi dei, più umani e razionali, non fa altro che perpetrare nuovi e forse più disumani<br />
sacrifici <strong>in</strong> nome di precisi <strong>in</strong>teressi e di falsi ideali. La differenza fra moderno ed arcaico<br />
sembra, nello spazio di questo dialogo, esser tutta qui. Una volta, nell’epoche arcaiche, si<br />
sapeva perfettamente il motivo per il quale si uccideva.<br />
Anche nel caso dei sacrifici umani, come nel caso del motivo del nudismo, la lettura di<br />
Lawrence fu <strong>in</strong>dispensabile a Pavese. Nel già citato appunto del 1 Dicembre 1949 [Scoperto<br />
l’altra sera quanto mi abbia plasmato la lettura di Sun e The woman who rode away di<br />
532<br />
S. Givone, Introduzione ai Dialoghi con Leucò, cit. p. IX.<br />
533<br />
C. Pavese, Dialoghi con Leucò, cit. p. 40.<br />
534<br />
Ivi, p. 42.<br />
535<br />
Ibidem.<br />
536<br />
J. Frazer, Il ramo d’oro, cit. p. 487.<br />
537<br />
C. Pavese, Dialoghi con Leucò, cit. p. 90.<br />
538 Ivi, p. 91.<br />
149
Lawrence (’36 –’37?)], Pavese <strong>in</strong>dica nel racconto La donna che andò via a cavallo un<br />
modello per la sua scrittura. E’ facile immag<strong>in</strong>are come il motivo dei sacrifici umani, presente<br />
nel racconto di Lawrence, abbia potuto <strong>in</strong>fluenzare Pavese. Il racconto di Lawrence asseconda<br />
molte delle caratteristiche di un certo tipo di scrittura modernista analizzata f<strong>in</strong>ora: rifiuto<br />
della modernità, fuga che si configura come un ritorno, ricongiungimento tragico all’elemento<br />
naturale primigenio. La protagonista del racconto vive, perennemente <strong>in</strong>soddisfatta, nella<br />
società moderna. Il marito è descritto come vero prototipo dell’uomo moderno: “Era uno<br />
schizz<strong>in</strong>oso rottame di un idealista, e odiava davvero il lato materiale della vita. Amava il<br />
lavoro, e poi il lavoro, e ancora il lavoro, e fare cose. Il suo matrimonio, i suoi figli, erano<br />
cose che lui faceva, una parte dei suoi affari, ma, <strong>in</strong> questo caso, con una rendita di tipo<br />
affettivo” 539 . Si ripropone <strong>in</strong> questo passaggio tutta la tensione che la società moderna è<br />
capace di produrre <strong>in</strong>vischiando l’<strong>in</strong>dividuo <strong>in</strong> una serie di categorie artificiali che lo tengono<br />
costretto all’etica del lavoro, alla morale benpensante borghese, ai sistemi di valori ideali.<br />
L’accento posto sulla categoria del “fare” rimanda ad un altro leit motiv modernista: quello<br />
dello scarto con il suo antagonista, ovvero “l’essere”, il cui significato e valore sembra oramai<br />
perduto. La donna, al colmo dello stress, è attratta dai paesaggi coll<strong>in</strong>ari nel cuore del<br />
cont<strong>in</strong>ente americano. Paesaggi misteriosi, “eterni” nella cui contemplazione la protagonista<br />
si perde scorgendo una dimensione alternativa a quella del reale: “Le eterne, immobili coll<strong>in</strong>e<br />
erano tutte verdi: era settembre, dopo le piogge.[…] -Sì ma cosa c’è di vivo su quelle coll<strong>in</strong>e e<br />
quelle montagne? Qualcosa di meraviglioso, non c’è dubbio! Hanno l’aria di non appartenere<br />
alla terra: come se fossero sulla luna-” 540 . Sono coll<strong>in</strong>e eterne e simboliche che contengono la<br />
promessa di un ritorno e di una libertà attualmente perduta: “Tuttavia lei aveva il suo cavallo<br />
e sognava di essere libera come lo era stata da ragazza, tra le coll<strong>in</strong>e della California” 541 .<br />
Dietro le coll<strong>in</strong>e si <strong>in</strong>travede, nei racconti del marito della protagonista, il primo riferimento al<br />
mistero del selvaggio. Gli <strong>in</strong>diani sono descritti come grotteschi selvaggi che nel loro apparire<br />
appaiono addirittura buffi all’osservatore civile. Il racconto è pregno di disprezzo per una<br />
civiltà reputata <strong>in</strong>feriore e irrecuperabile. La con<strong>vers</strong>azione tra il marito e un giovane collega<br />
sulle loro usanze si riproduce ancora quella percezione della distanza che spesso abbiamo<br />
riscontrato f<strong>in</strong>o ad ora. Il mondo arcaico degli <strong>in</strong>diani è messo addirittura a confronto con le<br />
grandi metropoli della modernità: “-Ma hanno di certo antiche religioni e misteri. Deve essere<br />
meraviglioso, ne sono sicuro.- -Non so nulla di questi misteri… Lamentazioni e pratiche<br />
pagane, più o meno <strong>in</strong>decenti. Non ci vedo nulla di meraviglioso <strong>in</strong> questa roba. E mi<br />
meraviglio che lei, che ha vissuto a Londra o a Parigi, o a New York, ce lo veda-“ 542 . La<br />
protagonista del racconto subisce il fasc<strong>in</strong>o di questi racconti e cova dentro di se il desiderio<br />
di partire alla scoperta dei misteri degli <strong>in</strong>diani: “Sentì che il suo vero dest<strong>in</strong>o era vagare tra i<br />
rifugi segreti di quegli <strong>in</strong>diani delle montagne, misteriosi e meravigliosi. […] i vecchi<br />
sacerdoti mantenevano ancora <strong>in</strong> vita l’antica religione, e offrivano sacrifici umani […]” 543 . Il<br />
viaggio <strong>in</strong>izia dopo non molto tempo ed è una fuga dal mondo moderno e dalla sua civiltà. Il<br />
viaggio si struttura come un’ascensione dalla valle alle coll<strong>in</strong>e; c’è un parallelo tra il percorso<br />
del cavallo e quello dell’anima della protagonista. E’ un percorso <strong>in</strong>iziatico che si <strong>in</strong>augura<br />
con la morte figurale della protagonista che può ora r<strong>in</strong>ascere a nuova vita: “Prima dell’alba<br />
fece molto freddo. Lei giaceva avvolta nella coperta, guardando le stelle e ascoltando i fremiti<br />
del cavallo, e si sentiva come una donna ormai morta e svanita. Non era certa di aver udito<br />
durante la notte un grande schianto al centro di se stessa, come lo schianto della sua morte. O<br />
forse era uno schianto che veniva dal centro della Terra, e significava qualcosa di grande e<br />
539 D. H. Lawrence, La donna che andò via a cavallo, contenuto <strong>in</strong> D.H. Lawrence, Tutti i racconti e i romanzi<br />
brevi, Newton Compton Editori, Roma, 1995, p. 809.<br />
540 Ivi, p. 810.<br />
541 Ivi, p. 811.<br />
542 Ivi, p. 810.<br />
543 Ibidem.<br />
150
misterioso” 544 . Lo stesso ruolo del cavallo non è marg<strong>in</strong>ale. Vickery r<strong>in</strong>traccia nel cavallo una<br />
simbologia di derivazione frazeriana:<br />
On the animal level, the mythic dimension of Lawrence’s fiction is conveyed through the weight of significance<br />
given to such creatures as the horse […] figures <strong>in</strong> the myths, rites, and superstitions explored by Frazer.[…]<br />
They are closely l<strong>in</strong>ked to the behaviour of the characters, who see <strong>in</strong> them not so much objects as omens,<br />
talismans, ritual modes, and mythical be<strong>in</strong>gs that lead them to a further and deeper participation <strong>in</strong> the drama of<br />
existence 545 .<br />
L’<strong>in</strong>contro con gli <strong>in</strong>diani rappresenta, per la protagonista del racconto, l’<strong>in</strong>contro con un’altra<br />
dimensione a lei sconosciuta. La donna verrà accolta nel villaggio e trattenuta. L’<strong>in</strong>diano<br />
<strong>in</strong>caricato di prendersi cura di lei esprime per la donna un fasc<strong>in</strong>o <strong>in</strong>comprensibile: “Lui non<br />
la guardava come un essere umano ne guarda un altro. Non sentiva affatto la resistenza e la<br />
sfida di lei; guardava al di là, <strong>vers</strong>o qualcosa che lei non conosceva. Capì che era <strong>in</strong>utile<br />
attendersi una qualche comunicazione umana con quella vecchia creatura” 546 . Ma il fasc<strong>in</strong>o<br />
del mistero sembra agire su di lei più attivamente che la volontà di tentare <strong>in</strong> qualche maniera<br />
la fuga. Il paesaggio rievocato <strong>in</strong>torno alla donna da Lawrence ricorda le descrizioni<br />
frazeriane dei luoghi del culto al tempo dei sacrifici umani: “L’amaca di lana fu poggiata a<br />
terra, lei ci si sedette e i due uom<strong>in</strong>i si issarono il palo sulle spalle.[…] Erano sbucati<br />
all’imboccatura della vallata. Proprio davanti c’erano i campi di granturco con le spighe<br />
mature” 547 . Non è difficile <strong>in</strong>contrare metafore di vegetazione nei romanzi e nei racconti di<br />
Lawrence. Spesso sono associati all’idea di fertilità <strong>in</strong> riferimento alle antiche div<strong>in</strong>ità della<br />
vegetazione descritte da Frazer. La funzione della vegetazione, che molto spesso è un campo<br />
di grano, svolge la funzione di ricordare l’esistenza di una vita naturale e ciclica che scorre<br />
parallela alla vita storica: “The majority of these <strong>in</strong>stances reveal the natural flourish<strong>in</strong>g of<br />
lives that manta<strong>in</strong> contact with the underly<strong>in</strong>g rhythms of the physical world” 548 .<br />
Il parallelismo tra gli elementi umani e quelli naturali è anche marcata nel racconto. Uom<strong>in</strong>i<br />
che vestono con pelli di leopardi si muovono sullo sfondo di paesaggi antropizzati che<br />
richiamano all’antica unità dell’uomo con la natura. La stessa voce dell’uomo diviene quella<br />
della natura:<br />
Poi un tamburo com<strong>in</strong>ciò a battere con sonorità, e giunse lo scoppio violento e fragoroso delle voci degli uom<strong>in</strong>i<br />
che cantavano una musica selvaggia e profonda, come un vento che urlasse <strong>in</strong> una foresta secolare.[…]<br />
L’<strong>in</strong>sistenza del tamburo, il suono di quel canto maschile, cavernoso e ruggente come una bufera, e il cont<strong>in</strong>uo<br />
dondolio delle pellicce di volpe dietro le gambe forti degli uom<strong>in</strong>i color bronzo dorato durarono tutto il giorno,<br />
mentre il sole autunnale si ri<strong>vers</strong>ava da un cielo di un azzurro purissimo sulla massa dei capelli neri degli uom<strong>in</strong>i<br />
e delle donne […] e <strong>in</strong> quel canto primitivo che echeggiava profondo, nel ritmo senza f<strong>in</strong>e della danza degli<br />
uom<strong>in</strong>i con la coda di volpe e nei passi delle donne con le tuniche nere e pesanti, dritte come uccelli, le parve di<br />
sentire la sua morte: il suo annientamento 549 .<br />
E’ un’unità che si ritrova nel tempo della festa rituale e delle danze magiche. Vickery<br />
r<strong>in</strong>traccia <strong>in</strong> questo aspetto un chiaro riferimento a Frazer: “The most susta<strong>in</strong>ed form of ritual<br />
partecipation <strong>in</strong> Lawrence, however, is found <strong>in</strong> the variety of dances whose significance is so<br />
heavely stressed throughout his work.[…] The result is <strong>in</strong>variably a trascendence of each<br />
544<br />
Ivi, p. 812.<br />
545<br />
J. B. Vickery, The literary Impact of The Golden Bough, cit. p. 321.<br />
546<br />
D. H. Lawrence, La donna che andò via a cavallo, cit. p. 817.<br />
547<br />
Ivi, pp. 817-18.<br />
548<br />
J. B. Vickery, The literary Impact of The Golden Bough, cit. p. 318.<br />
549<br />
D. H. Lawrence, La donna che andò via a cavallo, cit. p. 822-23<br />
151
one’s normal range of perception and a merg<strong>in</strong>g of personal feel<strong>in</strong>gs with someth<strong>in</strong>g<br />
larger” 550 .<br />
Il tempo del sacrificio è oramai maturo. La donna, oramai <strong>in</strong> balia delle forze primitive che la<br />
sovrastano, attende, senza alcuna sensazione particolare, il compiersi del suo dest<strong>in</strong>o: “Ma ciò<br />
che lei sentiva era quella lama di ghiaccio a forma di zanna, sospesa sull’orlo del buio<br />
precipizio. E dietro quel grande cordone di ghiaccio vedeva le figure dei sacerdoti, che come<br />
leopardi si arrampicavano sulla rupe <strong>in</strong>cavata […]” 551 . Il dest<strong>in</strong>o si compirà quando il sole<br />
rosso calerà dietro le coll<strong>in</strong>e: “Allora il vecchio avrebbe colpito, e avrebbe colpito al cuore,<br />
compiendo il sacrificio, per ottenere il potere” 552 . La consumazione del rito chiuderà la<br />
vicenda della protagonista che ha riattivato uno schema mitico molto caro allo scrittore. I<br />
personaggi di Lawrence <strong>in</strong> seguito ad una crisi esistenziale abbandonano spesso il mondo<br />
civile. Essi devono dunque morire nel tempo storico per r<strong>in</strong>ascere <strong>in</strong> quello del mito. Nella<br />
Donna che andò via a cavallo, gli <strong>in</strong>diani e lo stesso cavallo sono niente altro che gli agenti<br />
che accompagnano la protagonista <strong>in</strong> questo percorso di morte e r<strong>in</strong>ascita. Lawrence opera<br />
<strong>in</strong>somma lo svolgimento del mito del “Dy<strong>in</strong>g and reviv<strong>in</strong>g god” 553 descritto da Frazer nel suo<br />
Ramo d’oro <strong>in</strong> cui la donna rivive la parabola del dio morto e risorto.<br />
550<br />
J. B. Vickery, The literary Impact of The Golden Bough, cit. p. 317.<br />
551<br />
D. H. Lawrence, La donna che andò via a cavallo, cit. p. 829.<br />
552<br />
Ivi, p. 831.<br />
553<br />
J. B. Vickery, The literary Impact of The Golden Bough, cit. p. 325.<br />
152
3.4 It<strong>in</strong>erari critici tra America e Europa: Pavese e Lawrence leggono Melville<br />
Lawrence cercò di far seguire alle riflessioni sulla decadenza della civiltà moderna una sorta di<br />
pragmatismo che mai, però, si discostò dall’utopia. La vena apocalittica caratteristica di<br />
Lawrence scorre parallela a questa ansia di cambiamento, a questa speranza di salvezza. Per<br />
Pavese, al contrario, il nichilismo rappresentava un dest<strong>in</strong>o da cui ogni tentativo di evasione<br />
era dest<strong>in</strong>ato a fallire. Pavese espresse, nei suoi scritti e nella sua filosofia, un certo<br />
pessimismo che sfociò <strong>in</strong> una vena apocalittica <strong>in</strong> molte delle sue produzioni. Eppure, se si<br />
volesse <strong>in</strong>dicare una speranza nella filosofia dello scrittore piemontese, non si potrebbe non far<br />
riferimento a Melville. La vena utopica di Pavese fu, dunque, meno nutrita rispetto a quella di<br />
Lawrence. I due scrittori condivisero però una medesima speranza: l’America.<br />
L’America rappresentò, se pure per un breve periodo di tempo, qualcosa di più che un anelito<br />
per Pavese. Questa America, disegnata nelle opere di Melville, rappresentava un luogo dove la<br />
speranza di un r<strong>in</strong>novamento poteva dirsi concreta. Pavese fu affasc<strong>in</strong>ato dalla “vita barbara”<br />
americana così lontana dalla vita artificiale europea: “Loro sì, hanno saputo r<strong>in</strong>novarsi,<br />
passando la cultura attra<strong>vers</strong>o l’esperienza primitiva, reale, ma non, com’è l’andazzo da noi,<br />
r<strong>in</strong>negando un term<strong>in</strong>e per l’altro, bensì, attra<strong>vers</strong>o ciò che si chiama la vita, arricchendo,<br />
temprando e potenziando la letteratura”. Con la scoperta della letteratura americana il<br />
selvaggio diviene reale, concreto, raggiungibile, la vita mitica una possibilità aperta. Forse,<br />
sembra pensare Pavese per un attimo, la mitica età dell’oro è veramente r<strong>in</strong>tracciabile<br />
oltreoceano. Anche se le illusioni di Pavese erano det<strong>in</strong>ate ad essere <strong>in</strong>frante è <strong>in</strong>teressante<br />
notare come l’America e Melville potessero rappresentare l’<strong>in</strong>carnazione vivente di molte delle<br />
sue aspettative e delle sue teorie. Il confronto con Lawrence, che guardò all’America con<br />
<strong>in</strong>teresse e passione, è proficuo per sottol<strong>in</strong>eare quanto i due scrittori condividessero simili<br />
speranze e la medesima ansia di cambiamento. L’America assurge, nella mente dei due<br />
scrittori, a luogo mitico depositario di quella vita barbara e libera che agognavano nelle loro<br />
opere.<br />
Gli anni fra le due guerre mondiali rappresentano il periodo <strong>in</strong> cui la letteratura americana fece<br />
la sua prima decisa apparizione <strong>in</strong> Europa. La diffusione della letteratura americana ebbe una<br />
tempistica differente a seconda dello stato <strong>in</strong> cui veniva <strong>in</strong>trodotta. I pr<strong>in</strong>cipali fattori che<br />
determ<strong>in</strong>arono la sua diffusione furono prevalentemente l<strong>in</strong>guistici e politici. L’<strong>in</strong>troduzione e<br />
la diffusione della letteratura americana furono operazioni più agevoli <strong>in</strong> paesi come<br />
l’Inghilterra dove i libri potevano essere letti <strong>in</strong> l<strong>in</strong>gua orig<strong>in</strong>ale e dove non vi erano<br />
impedimenti di ord<strong>in</strong>e politico a limitarne la diffusione. In paesi come l’Italia, <strong>in</strong> cui il regime<br />
fascista perseguiva un programma di nazionalizzazione della letteratura, la diffusione della<br />
letteratura americana fu necessariamente più lenta e problematica. I problemi pr<strong>in</strong>cipali furono<br />
rappresentati dalla raccolta dei testi, dalla loro traduzione e dalla loro diffusione. Nell’ambito<br />
della politica di censura che il regime fascista aveva deciso di seguire nei confronti delle<br />
letterature reputate sov<strong>vers</strong>ive, questi problemi erano ovviamente da considerarsi grossi<br />
ostacoli. Nello studio dedicato a questo argomento, Ferme ha messo <strong>in</strong> risalto come la pratica<br />
di studiare la letteratura americana divenne un atto sov<strong>vers</strong>ivo <strong>in</strong> se stesso andando a<br />
contrastare con il progetto culturale fascista, parte <strong>in</strong>tegrante del progetto politico<br />
complessivo 554 . Pavese fu tra i primi a impegnarsi per <strong>in</strong>trodurre la letteratura americana <strong>in</strong><br />
Italia suscitando, <strong>in</strong> tal maniera, un senso di “scandalo” <strong>in</strong>torno ad un progetto che si poneva<br />
554 V. Valerio Cristiano Ferme, Cesare Pavese's and Elio Vittor<strong>in</strong>i's translations from American literature: The<br />
Americanization of aesthetics and the sub<strong>vers</strong>ion of culture under the Fascist regime (Italy), Uni<strong>vers</strong>ity of<br />
California, Berkeley, 1998, p. 3: “[…] the practice of translat<strong>in</strong>g from American literature became a sub<strong>vers</strong>ive<br />
act that destabilized the dom<strong>in</strong>ant political and aesthetic discourse of the fascist era <strong>in</strong> Italy”.<br />
153
deliberatamente <strong>in</strong> contrasto con le direttive del fascismo 555 . Gli anni ’30 rappresentarono un<br />
momento <strong>in</strong> cui i giovani italiani ebbero la possibilità di <strong>in</strong>contrare una nuova realtà che si<br />
poneva naturalmente <strong>in</strong> contrasto con quella teorizzata e imposta dal fascismo. L’impegno di<br />
traduzione e divulgazione delle opere americane si accompagnò ad “una gioia di scoperta e di<br />
rivolta che <strong>in</strong>dignò la cultura ufficiale” 556 , tanto che il fascismo fu costretto a scendere a<br />
compromessi con la nuova tendenza. L’<strong>in</strong>troduzione della letteratura americana <strong>in</strong> Italia<br />
rappresentò <strong>in</strong>somma una vera sfida al regime e servì a “perpetuare e alimentare l’opposizione<br />
politica, sia pure generica e futile, del pubblico italiano che leggeva” 557 . Lo studio della<br />
letteratura americana da parte di Pavese si configurò dunque come un sovvertimento estetico<br />
che non poteva non sconf<strong>in</strong>are nel campo della politica. Lo studio di Melville, <strong>in</strong> special modo,<br />
non era ben visto dalle gerarchie fasciste. E’ importante, nell’ottica di una analisi degli scritti<br />
critici che Pavese produsse su Melville, mettere <strong>in</strong> risalto questo aspetto al f<strong>in</strong>e di poterne<br />
cogliere tutte le implicazioni: aver a che fare con la letteratura americana rappresentava, <strong>in</strong><br />
epoca fascista, una sfida politica. Gli <strong>in</strong>teressi esistenziali ed estetici avevano dunque,<br />
nell’ambito dell’analisi che Pavese proponeva della letteratura americana, un immediato<br />
riscontro <strong>in</strong> ambito politico. La libertà di espressione, che gli scrittori americani detenevano, e<br />
la libertà <strong>in</strong>dividuale, che i personaggi delle loro narrazioni perseguivano, andava a scontrarsi<br />
spontaneamente con le rigide regolamentazioni imposte dal regime <strong>in</strong> ogni campo dello scibile.<br />
Questa precisazione è anche necessaria nel momento <strong>in</strong> cui si vogliono porre gli studi<br />
pavesiani su Melville accanto a quelli che svolse Lawrence sui medesimi argomenti.<br />
Anche per Lawrence il discorso sulla libertà è primario nell’ambito di uno studio su Melville<br />
ma, nel caso dello scrittore <strong>in</strong>glese, le implicazioni politiche non furono così immediate come<br />
nel caso di Pavese. L’<strong>in</strong>teresse di Lawrence per una dimensione della libertà, altamente<br />
riscontrabile fra i lavori degli scrittori americani, non ha a che vedere con uno specifico regime<br />
o sistema politico quanto con l’<strong>in</strong>tero sistema moderno delle relazioni umane. Si potrebbe<br />
ipotizzare che la ricerca di Lawrence fu <strong>in</strong>dirizzata pr<strong>in</strong>cipalmente a sondare i limiti della<br />
libertà dell’uomo <strong>in</strong>teso come <strong>in</strong>dividualità di fronte al mondo moderno; ogni tentativo di<br />
<strong>in</strong>quadrare politicamente il discorso dello scrittore <strong>in</strong>glese si scontra necessariamente con la<br />
constazione di tutte le istanze utopiche che furono caratteristiche del suo pensiero. La necessità<br />
di astrazione di regole uni<strong>vers</strong>ali rese spesso l’analisi politica di Lawrence superficiale. Le<br />
guerre e i conflitti politico-sociali furono costantemente messi <strong>in</strong> relazione al materialismo del<br />
mondo moderno, reo di impedire all’uomo una realizzazione personale <strong>in</strong> nome del falso<br />
traguardo della realizzazione economica. La cont<strong>in</strong>genza della I° Guerra Mondiale fu<br />
<strong>in</strong>terpretata, per esempio, come logico sviluppo della degenerazione dell’<strong>in</strong>tera società<br />
moderna. Sono questi i term<strong>in</strong>i <strong>in</strong> cui Cavitch spiega l’atteggiamento di Lawrence: (modern<br />
society) “diverts a man from his proper self-realization and b<strong>in</strong>ds him to the deathly purpose of<br />
economic ga<strong>in</strong>” 558 . Le catene dell’uomo andavano dunque spezzate, prima di tutto, a livello<br />
personale essendo l’uomo la prima cellula malata di una civiltà <strong>in</strong> decadenza. Recuperare tutti<br />
gli elementi orig<strong>in</strong>ari dell’essere umano, sepolti sotto le sovrastrutture della società moderna,<br />
si configurava dunque come primo e fondamentale passo della ricerca <strong>in</strong>tellettuale dello<br />
scrittore <strong>in</strong>glese. Lawrence apparve contrastato circa la possibilità di estendere un progetto per<br />
una nuova moralità <strong>vers</strong>o i settori della politica: la libertà dell’uomo poteva essere<br />
difficilmente raggiungibile da un punto di vista <strong>in</strong>dividuale; c’era un’effettiva possibilità di<br />
raggiungerla a livello politico? Lawrence provò a formulare ipo<strong>tesi</strong> <strong>in</strong> questo senso ma le sue<br />
proposte furono considerate utopiche e i suoi messaggi relegati sotto la categoria delle fantasie<br />
di un grande scrittore. L’appello generico a una ricostruzione sociale dell’Inghilterra e la vaga<br />
speranza di una rivoluzione basata su confusi ideali socialisti furono <strong>in</strong><strong>tesi</strong> come stravaganze di<br />
555<br />
Cesare Pavese, Richard Wright, sono f<strong>in</strong>iti i tempi <strong>in</strong> cui scoprivamo l’America, <strong>in</strong> La letteratura americana e<br />
altri saggi, cit. p. 189.<br />
556<br />
Cesare Pavese, Ieri e oggi, <strong>in</strong> La letteratura americana e altri saggi, cit. pp. 193-94.<br />
557<br />
Ibidem.<br />
558<br />
David Cavitch, D.H.Lawrence and the new World, New York Uni<strong>vers</strong>ity Press, New York, 1969, p. 33.<br />
154
un artista. Tutti gli sforzi per elaborare una condotta che agisse nel senso di un r<strong>in</strong>novamento<br />
sociale si condensarono nella proposta di costituire una comunità <strong>in</strong> un’isola deserta, idea tra<br />
l’altro sfruttata anche per la composizione di alcuni racconti. Questa proposta fu adornata con<br />
molti ideali ed argomentazioni suggestive ma non fu mai corredata di progetti pratici. Il suo<br />
sforzo primario apparve quello di liberare l’uomo da ogni tipo di costrizione, siano queste<br />
mentali, sociali, o politiche, ma il suo discorso si mantenne sempre nella sfera dell’idealità e<br />
della provocazione <strong>in</strong>tellettuale. Per Cavitch è addirittura improbabile che Lawrence avesse<br />
una visione globale e precisa di tutti le tensioni politiche durante la sua attività di scrittore:<br />
“It’s unlikely that Lawrence had any understand<strong>in</strong>g of the actual complexities of these<br />
measures or that he was <strong>in</strong> the programs of socialists or the labourists beyond the co<strong>in</strong>cidence<br />
of a few general pr<strong>in</strong>ciples on his part” 559 . Nonostante ciò l’attività di Lawrence fu tenuta<br />
costantemente sotto controllo da Scotland Yard e, anche nel suo caso, fu utilizzato dalle<br />
autorità lo strumento della censura come nel caso di The Ra<strong>in</strong>bow nel 1915. Così anche se<br />
Lawrence aveva postulato la difficoltà di raggiungere una libertà sociale attra<strong>vers</strong>o la libertà<br />
<strong>in</strong>dividuale, dovette riconoscere come le regole sociali potevano <strong>in</strong>cidere sulla sua libertà<br />
<strong>in</strong>dividuale. L’idea dell’America si fece spazio, nella mente di Lawrence <strong>in</strong> questo contesto.<br />
L’America si configurò, <strong>in</strong>izialmente, come luogo di opposizione, abbastanza distante dalla<br />
vecchia Europa da poter proporre nuove possibilità esistenziali e sociali. L’idea di un luogo<br />
dove la libertà di espressione si potesse associare alla libertà <strong>in</strong>dividuale e alla libertà sociale<br />
rappresentò, <strong>in</strong> certo momento della vita dello scrittore, la nuova speranza, la materializzazione<br />
delle sue utopie che, <strong>in</strong> Europa, non potevano trovare terreno fertile. America come speranza<br />
dunque. Luogo di vita barbarica che si contrapponeva all’esistenza artificiosa e decadente della<br />
vecchia Europa:<br />
I must see America. I th<strong>in</strong>k one can feel hope there. I th<strong>in</strong>k that there the life comes up from the roots, crude but<br />
vital. Here the whole tree of life is dy<strong>in</strong>g. It’s like to be dead: the underworld. I must see America. I believe it is<br />
beg<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g not end<strong>in</strong>g 560 .<br />
La ricerca di se stessi e della pienezza dell’esistente, topoi della produzione di Lawrence,<br />
apparivano altamente ostacolati da una civiltà, quella moderna occidentale, che prevaricava<br />
ogni tentativo di raggiungere una dimensione <strong>in</strong>dividuale libera e <strong>in</strong>dipendente. La<br />
connessione fra libertà <strong>in</strong>dividuale e libertà sociale apparivano al contempo troppo<br />
strettamente legate per poter essere scisse e trattate separatamente. L’idea dell’America nacque<br />
<strong>in</strong> questo contesto e privilegiò questa prospettiva: la ricerca di un luogo verg<strong>in</strong>e dove l’uomo<br />
potesse avere l’effettiva possibilità di tornare ad essere se stesso, di tornare ad essere libero.<br />
L’America rappresentò dunque una speranza, un ideale, un luogo di ritrovo per lo spirito<br />
umano che poteva ambire alla ricostruzione della sua civiltà, della sua razza, della sua<br />
<strong>in</strong>dividualità. Un nuovo <strong>in</strong>izio nella storia dell’umanità:<br />
They [Americans] are not younger than we, but older: a second childhood. But be<strong>in</strong>g so old, <strong>in</strong> senile decay and<br />
second childishness, perhaps they are nearer to the end, and the new beg<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g. Don’t have any illusion about the<br />
people, the life. The people and the life are monstrous.[…] But I also th<strong>in</strong>k that America, be<strong>in</strong>g so much worse,<br />
falser, further gone than England, is nearer to freedom 561 .<br />
559 Ivi, p.37.<br />
560 D. H. Lawrence, The Letters of D.H.Lawrence, edite da Harry T. Moore, Vik<strong>in</strong>g press, New York, 1932, pp.<br />
266-267.<br />
561 Ivi, pp. 481-482.<br />
155
La concezione ideale dell’America espressa qui da Lawrence fu <strong>in</strong> seguito supportata da studi,<br />
storici, etnografici ed estetici, atti ad <strong>in</strong>vestigare il nuovo mondo come fosse una grande e<br />
promettente unità. La storia americana e quella della sua letteratura furono studiate <strong>in</strong><br />
necessaria connessione con la storia europea. Ma, da una <strong>in</strong>iziale contrapposizione fra le due<br />
sponde dell’Atlantico, Lawrence passa presto ad una concezione evolutiva che vede l’Europa<br />
come il vecchio e il marcio, rappresentazione della condizione del nichilismo della civiltà<br />
contemporanea, e l’America come il nuovo e il promettente, luogo effettivo e non ideale dove<br />
una nuova civiltà poteva essere stabilita. L’America sembrò vivere, nella mente dello scrittore,<br />
come un opposto vivente alla decadenza europea; anche se il nuovo mondo non era<br />
necessariamente un paradiso terrestre, esso era pur sempre un luogo migliore rispetto<br />
all’Europa, un luogo dove la speranza della libertà era ancora <strong>in</strong>tatta. Nel primo saggio del<br />
libro Studies <strong>in</strong> Classic American Literature, pubblicato nel 1923, Lawrence vede il cont<strong>in</strong>ente<br />
americano come un luogo verg<strong>in</strong>e e <strong>in</strong>contam<strong>in</strong>ato dove la speranza di un r<strong>in</strong>novamento non<br />
era da considerarsi utopia. Un luogo dove nuove forme e idee potevano essere sviluppate<br />
lontano dalla “malattia” europea:<br />
It is natural that we should regard American literature as a small branch or prov<strong>in</strong>ce of English literature. None<br />
the less there is another view to be taken. The American art speech conta<strong>in</strong>s a quality that we have not calculated.<br />
It has a suggestive force which is not relative to us, not <strong>in</strong>herent <strong>in</strong> the English race. This alien quality belongs to<br />
the American cont<strong>in</strong>ent itself 562 .<br />
L’America, contrapponendosi all’Europa, stadio superato e decadente dell’evoluzione<br />
dell’uomo, diviene il luogo di una successiva evoluzione del genere umano e di una seconda<br />
fanciullezza. Lawrence fu senz’altro <strong>in</strong>teressato al ruolo della letteratura americana nell’ambito<br />
della storia letteraria occidentale ma il suo <strong>in</strong>teresse pr<strong>in</strong>cipale fu senz’altro quello di isolare<br />
dal contesto un’America simbolica, “a symbolic America” 563 , <strong>in</strong> grado di rappresentare un<br />
punto di snodo nella storia evolutiva del genere umano, “its crucial role <strong>in</strong> the history of man’s<br />
counsciousness” 564 . La letteratura americana diviene un campo d’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e privilegiato nel suo<br />
divenire simbolo dell’unione primordiale fra <strong>in</strong>conscio, natura e civilizzazione: “he f<strong>in</strong>ds that<br />
American literature and history substantiate his correlations between unconscious character,<br />
nature, and civilization” 565 . L’America e le sue forme d’espressione, <strong>in</strong> particolar modo quella<br />
letteraria, divengono strumentali alle ricerche <strong>in</strong>tellettuali di Lawrence; il mestiere di critico si<br />
trasforma immediatamente <strong>in</strong> quello del filosofo nichilista ed utopico, del moralista<br />
rivoluzionario, del sovvertitore estetico. Il ruolo del critico è ben <strong>def</strong><strong>in</strong>ito da Lawrence che<br />
postula come uno scrittore possa essere il miglior <strong>in</strong>terprete del lavoro di un altro scrittore.<br />
Nello stesso tempo l’approccio critico alla letteratura sembra essere relegato <strong>in</strong> una sfera<br />
<strong>in</strong>tellettuale <strong>in</strong> cui sensibilità, esistenza umana e moralità sono poste prima di ogni impegno<br />
politico. In un saggio su John Galsworthy del 1928, Lawrence dichiara:<br />
Literary criticism can be no more than a reasoned account of the feel<strong>in</strong>g produced upon the critic by the book he<br />
is criticiz<strong>in</strong>g. Criticism can never be a science: it is, <strong>in</strong> the first place, much too personal, and <strong>in</strong> the second, it is<br />
concerned with values that science ignores. The touchstone is emotion, not reason. We judge a work of art by its<br />
effect on our s<strong>in</strong>cere and vital emotion, and noth<strong>in</strong>g else. All the critical twiddle-twaddle about style and form, all<br />
this pseudo scientific classify<strong>in</strong>g and analyz<strong>in</strong>g of books <strong>in</strong> an imitation-botanical fashion, is mere impert<strong>in</strong>ence<br />
562 D.H.Lawrence, The symbolic Mean<strong>in</strong>g, the uncollected <strong>vers</strong>ions of studies <strong>in</strong> Classic American Literature,<br />
edited by Arm<strong>in</strong> Arnold, Centaur Press Limited, London, 1962, p.16.<br />
563 Cavitch, D.H.Lawrence and the new World, cit. p.80.<br />
564 Ibidem.<br />
565 Ibidem.<br />
156
and mostly dull jargon. A critic must be able to feel the impact of a work of art <strong>in</strong> all its complexity himself,<br />
which few critics are. A man with a paltry, impudent nature will never write anyth<strong>in</strong>g but paltry, impudent<br />
criticism. And a man who is emotionally educated is rare as a phoenix. The more scholastically educated man is<br />
generally, the more he is an emotional boor. [The critic] He must have the courage to admit what he feels, as well<br />
as the flexibility to know what he feels ….]. A critic must be emotionally alive <strong>in</strong> every fiber, <strong>in</strong>tellectually<br />
capable and skillful <strong>in</strong> essential logic, and then morally honest 566 .<br />
Appare evidente come l’argomentazione morale <strong>in</strong> Lawrence sia più forte di quella politica;<br />
l’<strong>in</strong>teresse per l’<strong>in</strong>dividuo diviene il primo grad<strong>in</strong>o di una rigenerazione morale vista come<br />
<strong>in</strong>dispensabile viatico <strong>vers</strong>o ogni ulteriore rivendicazione politica. Lo stesso sistema politico<br />
americano viene snobbato: l’America non è, <strong>in</strong> prima istanza, il luogo della libertà politica ma<br />
il luogo della libertà <strong>in</strong>dividuale. Il modello democratico americano è visto, al contrario, come<br />
un pericolo per la verg<strong>in</strong>ità del “nuovo mondo” e come un subdolo strumento per dom<strong>in</strong>are le<br />
masse. Nonostante il degrado politico, l’America è ancora il luogo dove la battaglia fra l’uomo<br />
e le forze oscure del mondo può essere v<strong>in</strong>ta <strong>in</strong> nome dell’uomo e della sua orig<strong>in</strong>aria natura.<br />
La letteratura americana rende visibile questa battaglia. L’America è il luogo dove l’uomo si<br />
può riappropriare del proprio essere senza scontrarsi con le barriere che la civiltà occidentale<br />
europea costantemente <strong>in</strong>terpone; la ricerca del significato orig<strong>in</strong>ario della vita, ovvero la<br />
“fullness of life”, altro topos della poetica di Lawrence, è, di fatto, impedita nel vecchio<br />
mondo. Nel caso americano, la libertà <strong>in</strong>dividuale non si associa direttamente a discorsi<br />
politici: libertà dell’<strong>in</strong>dividuo e discorso politico si estendono <strong>in</strong> due differenti dimensioni e<br />
raramente <strong>in</strong>trecciano i loro percorsi a differenza dell’Europa dove la società civile si è<br />
impossessata della libertà <strong>in</strong>dividuale trasformando l’uomo un cittad<strong>in</strong>o. La possibilità di<br />
conciliare le due dimensioni viene costantemente contraddetta nella speculazione <strong>in</strong>tellettuale<br />
di Lawrence; <strong>in</strong> questo stadio della sua ricerca, l’America è il luogo dove la libertà <strong>in</strong>dividuale,<br />
la libertà dell’essere, può essere ancora perseguita. In The Plumed Serpent, Ramon discute<br />
questo concetto dimostrando come gli uom<strong>in</strong>i dovrebbero battersi primariamente per la vita.<br />
L’uso della violenza contro le m<strong>in</strong>acce della politica è permessa nel momento <strong>in</strong> cui il bene più<br />
prezioso da salvaguardare è proprio la vita dell’<strong>in</strong>dividuo di cui lo stato si vorrebbe<br />
<strong>in</strong>debitamente appropriare. In una lettera ai socialisti Ramon scrive:<br />
What do you want? Would you make all men as you are? And when every peon <strong>in</strong> Mexico wears an American<br />
suit of clothes and sh<strong>in</strong>y black shoes, and looks for life <strong>in</strong> the newspaper and for his manhood to the government,<br />
will you be satisfied.[…] When men seek life first, they will not seek land nor gold.[…] And if the old communal<br />
system comes back, and the village and the land are one, it will be very good. For truly no man can possess<br />
lands 567 .<br />
Il disprezzo degli ideali borghesi postrivoluzionari, il rifiuto della proprietà privata e<br />
dell’organizzazione statale democratica, il biasimo del materialismo capitalista, posero<br />
Lawrence <strong>in</strong> una dimensione d’opposizione permanente <strong>vers</strong>o la maggior parte delle teorie<br />
politiche moderne. L’utopica prospettiva di un ritorno ad una dimensione comunale rese la sua<br />
posizione <strong>in</strong>dividualista ed anarchica. La battaglia di Ramon, che è il corrispettivo per molti<br />
<strong>vers</strong>i di quella di Lawrence, è per la libertà umana e non per un’ideologia politica. Quello che<br />
di politico traspare dagli scritti di Lawrence si configura come negazione e acquisisce una<br />
forma f<strong>in</strong>ale di rifiuto <strong>vers</strong>o le fitte trame della vita moderna. L’idea di una società comunale<br />
potrebbe essere difficilmente <strong>in</strong>terpretabile come una metafora del comunismo. Lawrence non<br />
prospetta alcun tipo di analisi economica e non parla di lotte di classe. Egli disquisisce <strong>in</strong>vece<br />
566<br />
D.H.Lawrence, Phoenix: The posthumous papers of D.H. Lawrence, edite da Edward D. Mc Donald, New<br />
York, 1936, pp. 539-540.<br />
567<br />
D.H.Lawrence, The plumed Serpent (1926), Cambridge Uni<strong>vers</strong>ity Press, Cambidge, 1987, pp. 362-63.<br />
157
di una libertà connessa alle antiche regole dell’umanità e ai suoi antichi dei che vennero prima<br />
di ogni moderna ideologia. Nell’ambito del pensiero dello scrittore appare dunque impensabile<br />
r<strong>in</strong>tracciare uno schema logico che rimandi deciso a qualsiasi ideologia politica. I suoi <strong>in</strong>teressi<br />
per le teorie espresse del fascismo vanno <strong>in</strong>quadrati <strong>in</strong> un largo contesto <strong>in</strong> cui i più disparati<br />
elementi potevano servire da materiale atto all’edificazione della sua utopia terrestre. Cavitch<br />
constata a riguardo: “His political viewpo<strong>in</strong>ts are ma<strong>in</strong>ly metaphors for the direction of his<br />
unconscious aspiration toward self-recognition or toward self-denial” 568 . Si potrebbe <strong>in</strong>somma<br />
concludere che la ricerca della libertà esistenziale, da parte di Lawrence, sia prioritaria rispetto<br />
ad ogni disegno politico e che egli, pur mancando di un’ideologia precostituita, non esiti a<br />
scontrarsi con le barriere culturali e sociali ogni qualvolta se ne presenti la necessità. La sua<br />
analisi procedette <strong>in</strong>dipendentemente prendendo le distanze dalla civiltà moderna. La<br />
letteratura americana si <strong>in</strong>serì <strong>in</strong> una dimensione ideale e simbolica. Così il primo passo per il<br />
reale apprezzamento dell’opera di Melville fu quello di cercare di limitare il più possibile il<br />
“punto di vista europeo” nel momento della lettura critica. In questo senso si sarebbe corso il<br />
rischio di privilegiare gli elementi consolidati e già presenti nella cultura europea piuttosto che<br />
discernere i fattori di novità per cui era <strong>in</strong>vece utile leggere la narrativa straniera. La mentalità<br />
europea doveva essere temporaneamente obliata nel momento della lettura di un’opera<br />
americana. Questo concetto che potremmo <strong>def</strong><strong>in</strong>ire di spersonalizzazione e che conduce, nelle<br />
<strong>in</strong>tenzioni dell’autore, ad una lettura esistenziale della letteratura americana, è espressa <strong>in</strong> un<br />
passo di Lawrence riportato da Cavitch:<br />
Now we must learn to th<strong>in</strong>k <strong>in</strong> terms of difference and otherness. There is a stranger on the face of the heart […]<br />
there is an unth<strong>in</strong>kable gulf between us and America, and across the space we see, not our own folk signal<strong>in</strong>g to<br />
us, but strangers, <strong>in</strong>comprehensible be<strong>in</strong>gs, simulacra perhaps of ourselves, but other, creatures of another<br />
world 569 .<br />
Pensare <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i di alterità e differenza appare un’ottima s<strong>in</strong><strong>tesi</strong> dell’approccio di Lawrence<br />
alla materia. La distanza fra Europa e America è profonda e lo studio della letteratura<br />
americana andava <strong>in</strong>teso proprio come valorizzazione della differenza. L’America divenne<br />
luogo di “esseri <strong>in</strong>comprensibili”, immag<strong>in</strong>i translate dei moderni europei che avevano,<br />
attra<strong>vers</strong>o quella letteratura “barbarica”, la possibilità di rientrare <strong>in</strong> contatto con una<br />
dimensione dell’essere <strong>in</strong>corrotta e vitale. La distanza è ampliata proprio per rendere più<br />
manifesta la crisi dell’Europa. Il tentativo di tradurre il l<strong>in</strong>guaggio e le idee provenienti<br />
dall’America fu criticato da Lawrence che vedeva nel nuovo mondo un luogo da raggiungere e<br />
non da importare. Così Cavitch riporta il pensiero dello scrittore a riguardo: “We read the<br />
English utterance without gett<strong>in</strong>g the alien American implication. We listen to our own speech<br />
<strong>in</strong> American mouths […]” 570 . Le preoccupazioni di Lawrence furono soprattutto di ord<strong>in</strong>e<br />
esistenziale e si riferirono prevalentemente al fenomeno del nichilismo che attanagliava<br />
l’<strong>in</strong>tera società europea <strong>in</strong>dipendentemente dalle di<strong>vers</strong>e situazioni politiche. La distanza fra<br />
Europa e America è evidente soprattutto ad un livello metodologico: la conoscenza si ottiene<br />
tramite l’esperienza di vita e non tramite l’elaborazione ideologica.<br />
La differenza pr<strong>in</strong>cipale che mi sembra si possa constatare fra Pavese e Lawrence è quella del<br />
di<strong>vers</strong>o approccio che i due autori condussero nei confronti della stessa materia. Pavese fu<br />
conscio delle implicazioni politiche che la traduzione della letteratura americana comportava<br />
ed anzi reputò tali implicazioni funzionali ai suoi propositi. La connessione tra America ed<br />
Europa è stabilita aprioristicamente e la distanza è ridotta al f<strong>in</strong>e di rendere la situazione<br />
culturale americana immediatamente traducibile e rapportabile alla situazione culturale<br />
568 D. Cavitch, D.H.Lawrence and the new World, cit. p. 141.<br />
569 Ivi, p. 17.<br />
570 Ivi p.16.<br />
158
italiana. Per Pavese, così come per Lawrence, l’ammirazione per gli americani, e soprattutto<br />
per Melville, era dovuta ad un m<strong>in</strong>or tasso di ideologismo che questi dimostravano di<br />
possedere. Come si spiega nel saggio su Melville, Pavese ammirò il fatto che lo scrittore<br />
americano avesse vissuto una vita “barbara” sperimentando il primitivismo, la sete di<br />
avventura e di nuove conoscenze che trasparivano dalla sua narrativa:<br />
Loro sì, hanno saputo r<strong>in</strong>novarsi, passando la cultura attra<strong>vers</strong>o l’esperienza primitiva, reale, ma non, com’è<br />
l’andazzo da noi, r<strong>in</strong>negando un term<strong>in</strong>e per l’altro, bensì, attra<strong>vers</strong>o ciò che si chiama la vita, arricchendo,<br />
temprando e potenziando la letteratura. Un pensiero non significa nulla di nulla se non è pensato con tutto il<br />
corpo, questa è bene una sentenza americana e a quest’ideale tutta la tradizione degli Stati, da Thoreau a<br />
Sherwood Anderson, consciamente o <strong>in</strong>consciamente mira, riuscendo alla creazione di poderosi <strong>in</strong>dividui che<br />
passano un buon numero d’anni barbaramente, vivendo e assorbendo, e poi si danno alla cultura, rielaborando la<br />
realtà sperimentata <strong>in</strong> pensieri ed immag<strong>in</strong>i che per la loro dignità e per la schiettezza serena e virile, han qualcosa<br />
di quell’equilibrio che usiamo chiamar greco. Siamo ben lontani dai paradisi artificiali che accolgono <strong>in</strong> capo al<br />
mondo i nostri rimbarbariti schizz<strong>in</strong>osi 571 .<br />
In questo senso Pavese <strong>in</strong>dica l’esempio negativo delle concezioni primitiviste-barbariche<br />
italiane, costrutti ideologici che cercavano di rispondere alle sollecitazioni delle mode<br />
letterarie europee con tentativi di emulazione e di rielaborazione particolarmente goffi:<br />
Ora, che da qualche tempo noi si provi un gran bisogno di imbarbarimento, è pacifico. Stanno a dimostrarlo il<br />
gusto r<strong>in</strong>novato dei viaggi e dello sport, il c<strong>in</strong>ema, il jazz, l’<strong>in</strong>teresse per i negri e tutto il resto che è pers<strong>in</strong><br />
banale ricordare e che con una parola s<strong>in</strong>tetica chiamiamo antiletteratura. Ed è senza dubbio molto bello tutto<br />
ciò. Ma è il modo che offende. Poiché mi pare che, nel fervore antiletterario, si tenda a un tal primitivismo che è<br />
quasi imbecillità. Debolezza, voglio dire: è vile fuggire le complicazioni <strong>in</strong> un paradiso semplicistico che dopo<br />
tutto, come è <strong>in</strong>teso, non è che uno dei tanti raff<strong>in</strong>amenti della civiltà 572 .<br />
La ricerca artistica, come ricerca esistenziale, appare ben altra cosa che un costrutto ideale.<br />
Questo rifiuto dell’ideologismo moderno per la riscoperta di una vera dimensione vitale,<br />
appare accomunare entrambi gli scrittori. Così Lawrence si esprime a proposito:<br />
But art-speech, art-utterance, is, and always will be, the greatest uni<strong>vers</strong>al language of mank<strong>in</strong>d […]. Art speech<br />
is also a language of pure symbols. But whereas the authorized symbol stands always for a though or an idea,<br />
some mental concept, the art-symbol or art term stands for a pure experience, emotional and passional, spiritual<br />
and perceptual, all at once. The <strong>in</strong>tellectual idea rema<strong>in</strong>s implicit, latent and nascent.[…] Therefore, when we<br />
reduce and dim<strong>in</strong>ish any work of art to its didactic capacity […] then we f<strong>in</strong>d that that work of art is a subtle and<br />
complex idea expressed <strong>in</strong> symbols.[…] for certa<strong>in</strong> purposes, it is necessary to degrade a work of art <strong>in</strong>to a th<strong>in</strong>g<br />
of mean<strong>in</strong>gs and reasoned exposition. This process of reduction is part of the science of criticism 573 .<br />
La riduzione dell’arte ad un sistema di idee è giustificato da Lawrence solo nel caso dello<br />
studio critico dell’opera che, come abbiamo visto, è appannaggio della comunità degli scrittori.<br />
Al di là di questa eccezione l’opera dovrebbe essere lasciata libera di vivere la sua vita e di<br />
espletare le sue <strong>in</strong>numerevoli funzioni significanti. Eppure Lawrence si trovò costretto ad<br />
ammettere che, allo stato attuale delle cose, non si poteva tracciare una storia della letteratura<br />
americana senza al contempo tracciare una storia delle idee che viaggiarono, <strong>in</strong> entrambi i<br />
sensi, tra il nuovo e il vecchio cont<strong>in</strong>ente. La rilevanza di uno studio delle idee fu riconosciuto<br />
571 C. Pavese, Herman Melville, Il baleniere letterato, cit. p. 78.<br />
572 C. Pavese, Herman Melville, Il baleniere letterato, cit. p. 77.<br />
573 D. Cavitch, D.H.Lawrence and the new World, cit. pp. 18-19.<br />
159
da Lawrence ma, dai suoi scritti, si ricava l’impressione di come questo studio rivestisse<br />
un’importanza m<strong>in</strong>ore rispetto a quello dei significati simbolici ed espletasse una funzione<br />
prettamente propedeutica: “But before we can undertake to criticize American books, to<br />
discover their symbolic mean<strong>in</strong>g, we must first trace the development of the orthodox<br />
European idea on American soil” 574 . L’<strong>in</strong>troduzione di Lawrence ai suoi Studies sembra<br />
f<strong>in</strong>alizzata a stabilire i parametri di raffronto fra America e Europa. Lawrence dimostrò<br />
un’<strong>in</strong>teresse storico-antropologico per la nascita di una nuova cultura che miscelava la<br />
“sapienza <strong>in</strong>tellettuale” della vecchia Europa con la “conoscenza terrestre” degli autoctoni.<br />
Una sorta di Genesi dunque o quello che Pavese <strong>def</strong><strong>in</strong>ì “un nuovo <strong>in</strong>izio della storia” 575 .<br />
La componente europea fu vista, da entrambi gli autori, come segno di decadenza, come germe<br />
pericoloso che m<strong>in</strong>acciava di contagio un’America che appariva ancora <strong>in</strong> buona salute. Il<br />
primitivismo degli americani ebbe una matrice culturale autoctona. I messicani sono descritti<br />
da Lawrence, nello scritto Not I but the w<strong>in</strong>d, attra<strong>vers</strong>o una serie di contrasti; la loro cultura<br />
tragica si oppone alle piatte e razionali idee europee: “(<strong>in</strong> Mexicans) someth<strong>in</strong>g wild and<br />
untamed, cruel and proud, beautiful and sometimes evil that is really America but not the<br />
America of the whites” 576 . Il contrasto si creava spontaneamente tra le culture rurali e/o<br />
primitive e gli avamposti della civiltà europea rei di aver importato il culto del denaro e il<br />
concetto di proprietà privata. La tragica situazione dell’America bianca, (that) “smashes your<br />
soul” (through the) “cult of dollar” 577 , riproponeva la genesi della civiltà europea. L’America,<br />
profondamente malata di europeismo, cercava di aver ragione dell’America autoctona. Nella<br />
rappresentazione attuale dell’eterno conflitto che si <strong>in</strong>staura tra natura e civiltà, Lawrence<br />
r<strong>in</strong>tracciava la valenza simbolica dell’America. Questo era il luogo dove ancora si combatteva<br />
e dove vi era ancora una speranza, al contrario dell’Europa dove la malattia della modernità<br />
aveva <strong>def</strong><strong>in</strong>itivamente preso piede. Si può <strong>in</strong> questo momento chiarire come la valenza<br />
simbolica di un’America, così <strong>def</strong><strong>in</strong>ita, sia estremamente funzionale all’architettura narrativa<br />
di Lawrence. Ma, anche <strong>in</strong> questo caso, dovremmo notare una differenza di posizioni con<br />
Cesare Pavese. Lawrence, tratteggiando una l<strong>in</strong>ea dal vecchio cont<strong>in</strong>ente all’America, esprime<br />
la tragicità del contrasto fra la vecchia e la nuova cultura e disegna una mitologia atta ad<br />
esprimere la crisi dell’uomo moderno. Sull’altro <strong>vers</strong>ante Pavese getta un’identica l<strong>in</strong>ea fra le<br />
due sponde atlantiche ma il vettore è differente. In questo caso il movimento procede<br />
dall’America all’Europa. Quanto di nuovo e vitale veniva attribuito alla cultura americana<br />
viene trasportato nel vecchio cont<strong>in</strong>ente per essere messo a confronto con la decadente cultura<br />
europea. Pavese cercò una voce straniera, vitale e foriera di speranze, che potesse travolgere, o<br />
perlomeno scuotere, la malata società europea:<br />
E se per un momento c’era apparso che valesse la pena di r<strong>in</strong>negare noi stessi e il nostro passato per affidarci<br />
corpo e anima a quel libero mondo, ciò era stato per l’assurda e tragicomica situazione di morte civile <strong>in</strong> cui la<br />
storia ci aveva per il momento cacciati 578 .<br />
Nell’operazione condotta da Pavese dovremmo qu<strong>in</strong>di riconoscere una duplicità di propositi: la<br />
letteratura americana fu parte di una ricerca personale che implicò un’urgenza esistenziale ma,<br />
nello stesso tempo, fu un’<strong>in</strong>vocazione ad un risollevamento <strong>in</strong>tellettuale collettivo. Libertà<br />
dell’<strong>in</strong>dividuo e libertà del cittad<strong>in</strong>o sono connesse così come connesse appaiono libertà<br />
<strong>in</strong>tellettuale e libertà politica. Quello del sovvertimento politico non fu il primo degli obiettivi<br />
che Pavese si prefisse; tuttavia l’<strong>in</strong>teresse per la letteratura americana contrastava con le<br />
574 Ivi, p. 19.<br />
575 C. Pavese, Ieri e oggi, cit. pp. 194-95.<br />
576 Frieda Lawrence, Not I but the w<strong>in</strong>d, The Vik<strong>in</strong>g press, New York, 1934, p.168.<br />
577 D.H.Lawrence,The Plumed Serpent, Mart<strong>in</strong> Secker, London, 1926, pp.46-47.<br />
578 C. Pavese, Ieri e oggi, cit. pp. 194-95.<br />
160
direttive del regime fascista 579 . Pavese, attra<strong>vers</strong>o l’approfondimento di argomenti prettamente<br />
letterari, svelò quello che Shapp ha <strong>def</strong><strong>in</strong>ito “il paradosso produttivo della cultura fascista” 580 .<br />
Solo attra<strong>vers</strong>o lo scioglimento della trama dei fili <strong>in</strong>tessuti, e la sovrapposizione dell’arte alla<br />
politica, la posizione di Pavese è identificabile e comprensibile.<br />
Così Pavese scriveva riguardo Melville nel primo saggio apparso sulla rivista La cultura nel<br />
Gennaio-Marzo del 1932: “Non a caso Melville è un nordamericano. Questi ultimi arrivati<br />
della cultura che, dai suoi difensori, sono tenuti responsabili del imbarbarimento dei nostri<br />
ideali e, biasimo escluso, con ragione, han molto da <strong>in</strong>segnarci a questo proposito” 581 . Il<br />
conf<strong>in</strong>e tra libertà <strong>in</strong>dividuale e libertà sociale, è facilmente attra<strong>vers</strong>ato da Pavese così come il<br />
conf<strong>in</strong>e tra America ed Europa. La caccia di Moby Dick assume i toni della caccia mitica,<br />
correlata alla ricerca europea di un r<strong>in</strong>novamento all’<strong>in</strong>terno della decadente cultura europea:<br />
“Noi, figli dell’Ottocento, abbiamo nelle ossa il gusto delle avventure, del primitivo, della vita<br />
reale, che seguono e succedono alla cultura e ci liberano dalle complicazioni facendo da<br />
cataplasma all’animuccia decadente, malata di civiltà” 582 . E’ la fuga da una cultura che vuole<br />
promuovere la verità oltre la realtà; la propria s<strong>in</strong>gola idea sopra la complessità della vita. Il<br />
mito di Moby Dick riguarda l’uomo di fronte alla sua natura misteriosa e terribile e riguardo il<br />
fasc<strong>in</strong>o <strong>vers</strong>o l’ignoto e l’impulso impresc<strong>in</strong>dibile per combatterlo e superarlo. Il ruolo<br />
dell’uomo è quello di porsi di fronte a questa alternativa esistenziale riconoscendo nessun altro<br />
eroe che “il rottame umano” 583 . L’accettazione e la condivisione di questo dest<strong>in</strong>o, “fiera sete<br />
di libertà <strong>in</strong>teriore” 584 , è ciò che guida al riconoscimento della condizione umana. La<br />
possibilità di <strong>in</strong>vestigare “il lato oscuro”, il mistero dell’uomo e la tragedia della vita moderna<br />
rappresentavano i gradi della libertà ricercata da Pavese. Erano questi i temi <strong>in</strong>visi al regime<br />
che esaltava le virtù dell’uomo nuovo fascista e postulava la positività dell’esistenza,<br />
<strong>in</strong>quadrata soprattutto <strong>in</strong> una dimensione ideale e civile. Moby Dick rappresentò per Pavese<br />
l’opera <strong>in</strong> grado di gettare uno sguardo profondo <strong>in</strong> “questa metà del mondo” 585 lasciando<br />
l’altra metà avvolta di un contagioso mistero. Tutte le referenze presenti nel libro, le<br />
etimologie, la fiera delle conoscenze umane e l’approccio scientifico a tutte le attività che si<br />
svolgevano nel Pequod, si svelano vane di fronte alla forza dirompente della natura. La<br />
battaglia mitica dell’uomo contro la natura si riflette all’<strong>in</strong>terno dell’umanità veicolata dal<br />
Pequod. La centralità di questa battaglia mitica è sottol<strong>in</strong>eata da Pavese che vede<br />
nell’antagonismo il vero motivo tra<strong>in</strong>ante del libro: “La ricchezza di una favola sta nella<br />
capacità ch’essa possiede di simboleggiare il maggior numero di esperienze. Moby Dick<br />
rappresenta un antagonismo puro, e perciò Achab e il suo Nemico formano una paradossale<br />
coppia d’<strong>in</strong>separabili” 586 .<br />
La stessa dimensione mitologica è riconosciuta da Lawrence nel suo saggio su Melville. Il<br />
libro è un agglomerato di significati simbolici che si condensano nella battaglia dell’uomo e<br />
dei suoi ideali contro la natura a lui esterna, il mistero delle orig<strong>in</strong>i, e quella a lui <strong>in</strong>terna,<br />
l’<strong>in</strong>conscio. Moby Dick è il simbolo della natura e dell’<strong>in</strong>conscio dell’uomo che devono essere<br />
soggiogati. E’ una battaglia tragica: “He (Moby Dick) is the last warm-blooded tenant of the<br />
waters, the greatest and last. He is the deep, free sacral consciousness <strong>in</strong> man. He must be<br />
579<br />
Edw<strong>in</strong> Fussel, Forward to: Cesare Pavese, American Literature Essays and op<strong>in</strong>ions, Uni<strong>vers</strong>ity of<br />
California Press, Los Angeles-London, 1970, p.VI: Pavese, “which had, <strong>in</strong> the first <strong>in</strong>stance, the purpose of us<strong>in</strong>g<br />
American literature to subvert Italian literature, thought, sensibility, and culture”<br />
580<br />
J. T. Shapp, Epic demonstrations: Fascist Modernity and the 1931 Exhibition of the Fascist Revolution, <strong>in</strong><br />
Fascism, Aesthetics and culture, cit. p.3.<br />
581<br />
C. Pavese, Herman Melville, Il baleniere letterato, cit. p. 78.<br />
582 Ivi, p. 77.<br />
583 Ibidem.<br />
584 Ivi, p. 80.<br />
585 Ivi, p. 83.<br />
586 Ivi, pp. 96-97.<br />
161
subdued” 587 . E’ quasi un paradosso per Lawrence che l’uomo si trovi a combattere una<br />
battaglia contro la sua stessa natura, contro la sua stessa libertà <strong>in</strong> nome di vuoti ideali che f<strong>in</strong>o<br />
ad ora non hanno fatto altro che rov<strong>in</strong>argli l’esistenza. Melville rappresenta l’esempio vivente<br />
di questa paradossale e tragica battaglia:<br />
[…] life must be an idea, essentially an idea. It must be a progression towards an ideal: a life dedicated to some<br />
process or goal of consciousness.[…] Man must be an ideal consciousness: this was a fixed pr<strong>in</strong>ciple <strong>in</strong> him.[…]<br />
Rarest of all th<strong>in</strong>gs to f<strong>in</strong>d is a man who can really accept life, without impos<strong>in</strong>g some theory or some arbitrary<br />
goal or some mechanistic vision 588 .<br />
Per Lawrence il conflitto fra il mondo costruito delle idee e quello della libertà naturale, è<br />
presente nell’attitud<strong>in</strong>e di Melville nel momento della composizione di Moby Dick. Il valore di<br />
Moby Dick, uno dei libri più strani e meravigliosi del mondo (“one of the strangest and most<br />
wonderful books <strong>in</strong> the world” 589 ), è, dunque, anche quello di una testimonianza personale di<br />
un uomo educato al puritanesimo e all’idealismo che cercò di guardare oltre i limiti che la sua<br />
cultura gli aveva imposto. La sconfitta degli uom<strong>in</strong>i del Pequod si configura dunque come la<br />
simbolica sconfitta di una cultura idealista (Pavese sosterrà a riguardo come Ismaele, il<br />
narratore lettore di Platone, sia il simbolo maggiore dell’idealismo notando come “l’ideale di<br />
Melville culm<strong>in</strong>a <strong>in</strong> Ismaele” 590 ). Melville si muove costantemente, nella sua narrazione, fra<br />
questi due poli, quello dell’idea e quello della natura, sottol<strong>in</strong>eando la tragica posizione di<br />
colui che è sul conf<strong>in</strong>e tra il conosciuto e l’abisso. Non sorprende vedere Lawrence discernere<br />
con lucidità la portata delle due dimensioni ed <strong>in</strong>dicare il suo punto di vista a riguardo:<br />
The author is never quite himself. He is always at the mercy of the rank, self-consciousness idealism which still<br />
rules white America, he always has to handle artificial values.[…] When however he forgets all audience, and<br />
renders us his sheer apprehension of the world, he is wonderful, his book commands a stillness <strong>in</strong> the soul, and<br />
awe 591 .<br />
Pavese e Lawrence ebbero <strong>in</strong> comune, riflettendo e scrivendo sulla letteratura americana,<br />
molte argomentazioni. Scelsero entrambi la letteratura americana come campo dove la<br />
battaglia mitica dell’uomo all’<strong>in</strong>terno del proprio mondo, e all’<strong>in</strong>terno del proprio stesso ego,<br />
poteva essere rappresentata <strong>in</strong> maniera più evidente. Le <strong>in</strong>numerevoli implicazioni di un libro<br />
come Moby Dick permisero ad entrambi gli autori di disquisire dello stesso argomento<br />
privilegiando di volta <strong>in</strong> volta punti di vista di<strong>vers</strong>i. Eppure gli obiettivi, f<strong>in</strong>anche i risultati<br />
della loro ricerca, sembrano, <strong>in</strong> molti casi, convergere. La ricerca degli spazi residui di libertà<br />
umana all’<strong>in</strong>terno del mondo moderno sembrò essere condivisa dai due scrittori. Il mondo<br />
moderno sviluppa i suoi mostri riconosciuti dagli autori nella vicenda mitica di Moby Dick.<br />
Questi mostri erano perpetrati dal fascismo, dall’assetto della società moderna basata<br />
sull’<strong>in</strong>dustrializzazione e sul capitalismo, dal processo di trasformazione dell’uomo <strong>in</strong> un altro<br />
prodotto, un prodotto produttivo di passioni e sentimenti derivati. Entrambi gli autori<br />
guardarono <strong>vers</strong>o gli antichi schemi di un sapere mitico al f<strong>in</strong>e di riguadagnare una visione<br />
propria dell’umanità.<br />
Lo studio di una letteratura capace di dar libero corso alle tematiche del mito e del<br />
primitivismo sembrò prestarsi <strong>in</strong> particolar modo agli <strong>in</strong>teressi artistici di Lawrence e Pavese. I<br />
587<br />
D.H.Lawrence, The symbolic mean<strong>in</strong>g. The uncollected <strong>vers</strong>ions of Studies <strong>in</strong> Classic American Literature<br />
(1923) , edito Arm<strong>in</strong> Arnold, Centaur Press Limited, London, 1962, p. 235.<br />
588<br />
Ivi, pp. 225-28.<br />
589<br />
Ivi, p. 250.<br />
590<br />
C. Pavese, Herman Melville, Il baleniere letterato, cit. p. 78.<br />
591<br />
D.H.Lawrence, The symbolic mean<strong>in</strong>g. The uncollected <strong>vers</strong>ions of Studies <strong>in</strong> Classic American Literature,<br />
cit. p. 237<br />
162
due scrittori affrontarono, <strong>in</strong> molte delle loro narrazioni, le medesime problematiche affrontate<br />
da Melville. Indipendentemente dai risultati poetici a cui Lawrence e Pavese giunsero, si può<br />
r<strong>in</strong>tracciare <strong>in</strong> loro un comune <strong>in</strong>teresse per i temi del primitivismo, di cui l’implicazione<br />
privilegiata fu quella di stampo ontologico, e per i temi <strong>in</strong>erenti al viaggio, <strong>in</strong>teso come<br />
viaggio filosofico di scoperta e di r<strong>in</strong>venimento. Il personaggio del primitivo è, <strong>in</strong> questo caso,<br />
un depositario di simboli che rimandano costantemente al discernimento delle tracce sepolte;<br />
la critica serrata del mondo moderno, attra<strong>vers</strong>o il confronto con l’<strong>in</strong>corrotto mondo<br />
dell’orig<strong>in</strong>e, si situa lontano dagli spazi codificati e immediatamente traducili della modernità.<br />
Entrambi gli autori portano avanti una sostanziale critica della civiltà moderna attra<strong>vers</strong>o la<br />
negazione delle mode letterarie dell’epoca come certo tipo di letteratura di viaggio, non <strong>in</strong><br />
grado di problematizzare la distanza, e certo tipo di letteratura primitivista, che si configurava<br />
come una delle tante frivolezze dell’epoca. Il primitivismo, a cui fanno riferimento Lawrence e<br />
Pavese, è a sfondo filosofico e r<strong>in</strong>traccia nel selvaggio un personaggio tragico. Per Pavese,<br />
l’Europa era il luogo dove questo primitivismo assumeva le forme più abiette dimostrando,<br />
ancora una volta, la decadenza della cultura occidentale. Questa situazione viene posta a<br />
confronto con l’esempio di Melville ancora fautore di un reale primitivismo:<br />
Poiché questo è curioso <strong>in</strong> Moby Dick e Melville: benché si tratti di un’opera ispirata da esperienze di vita quasi<br />
barbarica, ai conf<strong>in</strong>i della terra, Melville non è mai un pagliaccio che si metta a f<strong>in</strong>gere anche lui il barbaro e il<br />
primitivo, ma, dignitoso, coraggioso, non si spaventa di rielaborare quella vita verg<strong>in</strong>e attra<strong>vers</strong>o tutto lo scibile<br />
della terra. Poiché credo ci voglia meno coraggio ad affrontare un capodoglio o un tifone che a rischiare di passar<br />
per un pedante o un letterato 592 .<br />
L’<strong>in</strong>teresse per l’etnografia che Pavese espresse lungo tutto l’arco della sua carriera di<br />
scrittore, si configurò come lucido tentativo di sottrarre le tematiche del primitivismo alle<br />
strumentalizzazioni del pensiero idealista europeo. Per Pavese il primitivo è personaggio<br />
tragico <strong>in</strong> quanto simbolo di “quell’altra parte di mondo” che si oppone al mondo civilizzato.<br />
E’ lo stesso punto che Lawrence mette <strong>in</strong> risalto nel suo saggio su Melville:<br />
It is absurd to speak of savages as children, young, rudimentary people.[…] Of all childish th<strong>in</strong>gs, science is one<br />
of the most childish and amus<strong>in</strong>g. The savages, we may say all savages, are remnants of the once civilized worldpeople,<br />
who had their splendor and their be<strong>in</strong>g for countless centuries <strong>in</strong> the way of sensual knowledge, that<br />
conservative way which Egypt shows us at its conclusion, mysterious and long-endur<strong>in</strong>g.[…] The savages have<br />
grown older and older 593 .<br />
Gli studi di Pavese e Lawrence sulla letteratura americana sembrano <strong>in</strong>trecciarsi <strong>in</strong>torno a<br />
<strong>in</strong>teressi poetici e a <strong>in</strong>teressi critici comuni. Entrambi gli autori vedevano <strong>in</strong> Melville uno<br />
scrittore da studiare e da portare alla ribalta del grande pubblico non solo a f<strong>in</strong>i accademici ma<br />
anche politici. Pavese e Lawrence riconobbero nel maestro americano una fonte di ispirazione<br />
e un modello da seguire. Melville, <strong>in</strong>tellettuale di frontiera, rappresentava uno scrittore<br />
genu<strong>in</strong>o <strong>in</strong> lotta con una civiltà che tentava di soggiogarne lo spirito. Il gigantesco cetaceo<br />
Moby Dick è la rappresentazione di una natura mostruosa, da <strong>in</strong>seguire e da sconfiggere.<br />
Quello che Lawrence chiamava lo “spirito del luogo”, the spirit of the place, era m<strong>in</strong>acciato<br />
dalla cultura americana di matrice europea. La caccia mitica di Melville si configura come<br />
espressione di questa tragedia, espressione della lotta di una civiltà idealista che tenta di<br />
soggiogare la propria natura.<br />
592 Ivi, pp. 94-95.<br />
593 D.H.Lawrence, The symbolic mean<strong>in</strong>g. The uncollected <strong>vers</strong>ions of Studies <strong>in</strong> Classic American Literature,<br />
cit. p. 223.<br />
163
Entrambi gli autori maturarono una visione ferocemente critica nei confronti della cultura<br />
egemone americana che pretendeva di soppiantare le culture autoctone. Soprattutto la critica<br />
<strong>vers</strong>o il nuovo idealismo americano e l’ipocrisia dei gerarchi statunitensi fu al centro delle<br />
critiche di Pavese e Lawrence. Lawrence sviluppò un’acuta av<strong>vers</strong>ione contro la retorica<br />
americana che circondava il concetto di democrazia, riconoscendo <strong>in</strong> questo progetto politico<br />
una nuova m<strong>in</strong>accia contro la libertà dell’uomo. L’uomo moderno era condotto, attra<strong>vers</strong>o la<br />
demagogia e le “false speculazioni democratiche”, a divenire uno schiavo assenziente nel<br />
moderno sistema capitalista. La battaglia per la libertà sembrava <strong>in</strong> questo senso dest<strong>in</strong>ata a<br />
fallire: “Especially our fellow-men. We love to round them up <strong>in</strong>side the barbed-wire<br />
enclosure of FREEDOM, and make ‘em work. Work, you free jewel, WORK! Shouts the<br />
liberator, crack<strong>in</strong>g his whip. Benjam<strong>in</strong>, I will not work. I do not choose to be a free democrat. I<br />
am absolutely a servant of my own Holy Ghost” 594 . Ma la battaglia <strong>in</strong>teriore di Lawrence, per<br />
dare all’America una stabile dimensione, durò per tutta la sua esistenza accompagnata da<br />
dialettiche di negazione e speranza a cui l’idea di America non riusciva a sottrarsi: “dialects of<br />
negation and hope he had <strong>in</strong>vested <strong>in</strong> the image of America” 595 . L’America era il luogo dove<br />
l’<strong>in</strong>dividuo poteva ancora lottare per la sua libertà o un luogo dove si stava svolgendo<br />
l’ennesima tragedia della libertà?<br />
Si può costatare come problemi simili trovarono spazio nelle riflessioni di Pavese. Dopo la<br />
caduta del fascismo, Pavese perse molta della sua attenzione nei confronti della letteratura<br />
americana. L’americanismo, rivendicato f<strong>in</strong>o a pochi anni prima, si era sviluppato come<br />
negazione sistematica del fascismo. Questa relazione era talmente stretta che dobbiamo notare<br />
come la morte di uno dei due poli m<strong>in</strong>acciò seriamente la sopravvivenza dell’opponente.<br />
Pavese prese atto di questa evoluzione disegnando l’ennesimo schema mitico atto a<br />
<strong>in</strong>corporare lo sviluppo di questo processo:<br />
Sono f<strong>in</strong>iti i tempi <strong>in</strong> cui scoprivamo l’America.[…] Ci pare <strong>in</strong>somma che oggi dopo la guerra e l’occupazione,<br />
dopo avere passeggiato e chiacchierato a lungo tra noi, i giovani americani abbiano subito un <strong>in</strong>teriore processo<br />
di europeizzazione e perduto gran parte di quell’esotica e tragica schiettezza ch’era il loro dest<strong>in</strong>o. Ma anche<br />
questo può darsi che, nel gioco della storia, faccia parte del loro dest<strong>in</strong>o. 596<br />
A esser s<strong>in</strong>ceri <strong>in</strong>somma ci pare che la cultura americana abbia perduto il magistero, quel suo <strong>in</strong>genuo e sagace<br />
furore che la metteva all’avanguardia del nostro mondo <strong>in</strong>tellettuale. Né si può non notare che ciò co<strong>in</strong>cide con<br />
la f<strong>in</strong>e, o sospensione, della sua lotta antifascista.[…] Ma senza un fascismo a cui opporsi, senza cioè un<br />
pensiero storicamente progressivo da <strong>in</strong>carnare, anche l’America, per quanti grattacieli e automobili e soldati<br />
produca, non sarà più all’avanguardia di nessuna cultura. Senza un pensiero e senza lotta progressiva, rischierà<br />
anzi di darsi essa stessa a un fascismo, e sia pure nel nome delle sue tradizioni migliori 597 .<br />
L’America poteva rappresentare l’ideale di una forte opposizione, dunque, ma la a sua forza<br />
simbolica era molto più debole senza un opponente. Il discorso americano svelava la sua forte<br />
valenza oppositiva ma denunciava, al contempo, una carenza di qualità affermative. Le<br />
speranze di Pavese e Lawrence si scontrarono contro il muro della realtà americana ma questo<br />
non riduce l’importanza delle analisi da loro condotte. La questione importante da sollevare<br />
non appare molto relativa all’America come realtà ma all’America come idealità. Pavese e<br />
Lawrence ebbero, ad un certo punto del loro percorso <strong>in</strong>tellettuale, la necessità di appellarsi ad<br />
un opponente, un luogo lontano abitato da persone differenti che si potevano porre come<br />
immag<strong>in</strong>e alternativa dell’Europa. La retorica della libertà americana agì fondamentalmente <strong>in</strong><br />
questa direzione: mettere <strong>in</strong> risalto la “non libertà” dell’Europa. Pavese e Lawrence si<br />
<strong>in</strong>teressarono relativamente poco della storia americana deducendo un’immag<strong>in</strong>e ideale di quel<br />
594<br />
D. Cavitch, D.H.Lawrence anf the New World, cit. p. 143.<br />
595<br />
Ivi, p. 103.<br />
596<br />
C. Pavese, Richard Wright, sono f<strong>in</strong>iti i tempi <strong>in</strong> cui scoprivamo l’America, cit. pp. 189-190.<br />
597<br />
C. Pavese, Ieri e oggi , cit. pp. 195-96.<br />
164
paese attra<strong>vers</strong>o le letture di scrittori come Melville. La libertà di espressione di cui tali<br />
scrittori usufruivano <strong>in</strong> America era l’aspetto più significativo di quel mondo e, anche se le<br />
prospettive sociali non erano affatto <strong>in</strong>coraggianti, i due autori si persuasero che la situazione<br />
fosse ampiamente migliore di quella europea. La libertà di espressione si associò alla libertà<br />
<strong>in</strong>dividuale che sembrò essere l’<strong>in</strong>teresse pr<strong>in</strong>cipale dei due autori. La contraddizione fra la<br />
realtà politica dell’America e l’ideale dell’America si sarebbe presto resa evidente ma, <strong>in</strong> quel<br />
momento storico, poteva essere parzialmente accantonata. Nel caso di Lawrence il punto di<br />
maggior <strong>in</strong>teresse fu quello morale. L’<strong>in</strong>teresse per una libertà <strong>in</strong>dividuale fu propedeutico<br />
all’<strong>in</strong>teresse per la libertà politica. I due campi erano dest<strong>in</strong>ati ad entrare <strong>in</strong> collisione ma ciò<br />
non toglie che Lawrence postulò la rigenerazione morale come primo <strong>in</strong>eluttabile passo <strong>vers</strong>o<br />
la libertà sociale. Come si può notare nel Serpente piumato, la storia sembra muo<strong>vers</strong>i su b<strong>in</strong>ari<br />
propri divorando e digerendo le vite dei s<strong>in</strong>goli <strong>in</strong>dividui. La battaglia per la libertà è <strong>in</strong> primo<br />
luogo una battaglia <strong>in</strong>dividuale e si configura come lotta difensiva.<br />
Nel caso di Pavese possiamo notare come egli <strong>in</strong>contrò l’<strong>in</strong>carnazione vivente della decadenza<br />
dell’uomo moderno. Questa decadenza acquisì la forma politica del fascismo. La sua ricerca<br />
per una libertà <strong>in</strong>dividuale si trasformò quasi spontaneamente <strong>in</strong> una rivendicazione politica.<br />
L’America poteva rappresentare un simbolo, un mito, una voce dall’<strong>in</strong>terno. L’<strong>in</strong>terpretazione<br />
di Pavese fu senz’altro idealista ma, nel contesto politico del fascismo, divenne reale,<br />
consistente, sov<strong>vers</strong>iva:<br />
Ci si accorse, durante quegli anni di studio, che l’America non era un altro paese, un nuovo <strong>in</strong>izio della storia, ma<br />
soltanto il gigantesco teatro dove con maggiore franchezza che altrove veniva recitato il dramma di tutti. E se per<br />
un momento c’era apparso che valesse la pena di r<strong>in</strong>negare noi stessi e il nostro passato per affidarci corpo e<br />
anima a quel libero mondo, ciò era stato per l’assurda e tragicomica situazione di morte civile <strong>in</strong> cui la storia ci<br />
aveva per il momento cacciati. La cultura americana ci permise <strong>in</strong> quegli anni di vedere svolgersi come su uno<br />
schermo gigante il nostro stesso dramma. Ci mostrò una lotta accanita, consapevole, <strong>in</strong>cessante, per dare un senso<br />
un nome un ord<strong>in</strong>e alle nuove realtà e ai nuovi ist<strong>in</strong>ti della vita <strong>in</strong>dividuale e associata, per adeguare ad un mondo<br />
vertig<strong>in</strong>osamente trasformato gli antichi sensi e le antiche parole dell’uomo. Com’era naturale <strong>in</strong> tempi di ristagno<br />
politico, noi tutti ci limitammo allora a studiare come quegli <strong>in</strong>tellettuali d’oltremare avessero espresso questo<br />
dramma, come fossero giunti a parlare questo l<strong>in</strong>guaggio, a narrare, a cantare questa favola. Parteggiare nel<br />
dramma, nella favola, nel problema non potevamo apertamente, e così studiammo la cultura americana un po’<br />
come si studiano i secoli del passato, i drammi elisabettiani o la poesia dello stil nuovo 598 .<br />
La battaglia di Pavese e Lawrence per la libertà dell’uomo sembra cadere, paradossalmente,<br />
dentro un ulteriore schema mitico. E’ il mito dell’uomo che si <strong>in</strong>terroga circa la sua libertà<br />
sociale e <strong>in</strong>dividuale. La ricerca di una dimensione della libertà, considerata come status<br />
orig<strong>in</strong>ario dell’uomo, è il motivo per cui l’uomo <strong>in</strong>traprende il suo viaggio. E’ un viaggio che<br />
si compie nella distanza <strong>vers</strong>o luoghi lontani dallo spazio artificiale moderno e che porta<br />
l’uomo <strong>vers</strong>o una dimensione dell’esistere, anch’essa lontana, non più dom<strong>in</strong>ata dalla tirannia<br />
della coscienza. Questa ricerca fu condotta a livello esistenziale e si configurò come<br />
<strong>in</strong>iziazione mitica; le accuse di essere sov<strong>vers</strong>ivi o utopici furono una logica conseguenza per<br />
coloro i quali rivendicavano la loro libertà.<br />
598 C. Pavese, Ieri e oggi, <strong>in</strong> La letteratura americana e altri saggi, cit. pp. 194-95.<br />
165
3.5 Pavese: la modernità e la possibilità del tragico<br />
Il nostro tempo è essenzialmente tragico, qu<strong>in</strong>di<br />
ci rifiutiamo di prenderlo tragicamente. Il<br />
cataclisma s’è abbattuto, siamo tra le rov<strong>in</strong>e;<br />
com<strong>in</strong>ciamo a ricostruire nuovi piccoli centri di<br />
vita, a nutrire nuove piccole speranze. (D. H.<br />
Lawrence, L’amante di Lady Chatterley, 1928)<br />
Le riflessioni pavesiane sul mito e sul selvaggio confluirono nel tardo Dialoghi con<br />
Leucò. La novità di questo libro rispetto al resto della produzione pavesiana è evidente e<br />
sottol<strong>in</strong>eata dallo stesso autore che predilisse quest’opera su tutte le altre. La modernità<br />
dei Dialoghi è stata spesso al centro dei dibattiti. L’opera è stata spesso <strong>in</strong>tesa come un<br />
esercizio di classicismo. È nei Dialoghi con Leucò che, <strong>in</strong>vece, le teorizzazioni<br />
“moderniste” del mito e del selvaggio trovano la loro ultima formulazione e<br />
giustificazione. I Dialoghi rappresenterebbero, <strong>in</strong> questo senso la s<strong>in</strong><strong>tesi</strong> della<br />
speculazione di Pavese sul mito e sul selvaggio. E’ questa s<strong>in</strong><strong>tesi</strong> a veicolare l’artista<br />
<strong>vers</strong>o una piena sensibilità moderna.<br />
Guglielmi ascrive i Dialoghi nella loro dimensione più propria quando li associa ai<br />
“ritornanti primitivismi della modernità”. E’ un selvaggio che, proprio <strong>in</strong> quanto<br />
derivante dal filone modernista del primitivismo letterario, non vuole essere pittoresco<br />
ma tragico, problematico, portatore di un senso profondo e recondito. E’ un selvaggio che<br />
si pone con violenza di fronte all’orig<strong>in</strong>ario procurando straniamento e compassione. La<br />
tragedia, espressa dal selvaggio, assume la forma “classica” dei Dialoghi atti a rivelare le<br />
più profonde implicazioni <strong>in</strong> un f<strong>in</strong>zionale processo di risalita <strong>vers</strong>o le orig<strong>in</strong>i. Il<br />
selvaggio è il veicolo di tale risalire così come la tragedia è la forma adatta<br />
all’espressione dei suoi motivi. “La violenza è orig<strong>in</strong>aria e la tragedia si pone, con i suoi<br />
modi, di fronte a tale orig<strong>in</strong>e”, dirà Sergio Givone <strong>in</strong> riferimento ai Dialoghi. In questo<br />
senso l’opera di Pavese si pone come un tentativo di s<strong>in</strong><strong>tesi</strong> di tutte quelle d<strong>in</strong>amiche<br />
moderne su cui f<strong>in</strong>o ad ora lo abbiamo visto riflettere e discutere.<br />
I Dialoghi con Leucò, che Pavese <strong>in</strong>iziò a scrivere nel 1945 e pubblicò nel 1947,<br />
rappresentano il punto di arrivo della ricerca mito-etnologica dello scrittore o, come nella<br />
s<strong>in</strong>tetica e calzante <strong>def</strong><strong>in</strong>izione di Givone, “Episodio culm<strong>in</strong>ante della sua esplorazione del<br />
mondo delle orig<strong>in</strong>i, ossia di ciò che egli chiama il primitivo e il selvaggio e di quanto sul<br />
piano culturale gli appare <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i di simbolo, rito e mito […] 599 . La forma che tale<br />
esplorazione assume è quella dei Dialoghi, <strong>def</strong><strong>in</strong>ita come “nuova” dallo stesso Pavese, e che<br />
rimette <strong>in</strong> gioco le categorie del tragico trasponendole e riattivandole nell’epoca della<br />
modernità. La tragedia, “forma di re<strong>in</strong>cantamento e nello stesso tempo di razionalizzazione, di<br />
demitizzazione” 600 , si pone come mezzo atto allo scioglimento del mito, <strong>in</strong>teso come veicolo<br />
di conoscenza e di esplicazione del reale. La riflessione di Pavese, <strong>in</strong>torno alla forma classica<br />
della tragedia e sulla possibilità di riproporne forme e tematiche <strong>in</strong> epoca moderna, <strong>in</strong>veste<br />
gran parte della sua formazione e della sua attività di scrittore. Il tentativo di portare ad<br />
esempio i Dialoghi con Leucò, l’opera che più esplicitamente si ricollega a tale ricerca, può<br />
essere senz’altro fecondo, ma sarebbe riduttivo limitarsi alla sola analisi di questo testo poiché<br />
la maggior parte degli scritti pavesiani risente, <strong>in</strong> un modo o nell'altro, dello studio che<br />
l’autore condusse nei confronti del fenomeno tragico. Lo svolgimento e l’approfondimento<br />
599 S. Givone, Introduzione ai Dialoghi con Leucò, cit. p. V.<br />
600 Ivi, pp. V-VI.<br />
166
del “caso-Pavese” serviranno a mettere <strong>in</strong> luce come la tragedia classica sia stata <strong>in</strong>terpretata<br />
nella modernità da uno dei nostri autori maggiori. Questa impostazione del problema riveste<br />
un particolare <strong>in</strong>teresse se si pensa alla “morte della tragedia” preconizzata da Ste<strong>in</strong>er per il<br />
quale i tempi moderni sono <strong>in</strong>capaci di produrre vere e proprie tragedie. Eppure l’età moderna<br />
appare essere, fuori di ogni dubbio, una delle età più tragiche che l’umanità abbia mai vissuto.<br />
Nelle pag<strong>in</strong>e di Pavese, l’esercizio di un pensiero tragico diviene funzionale alla<br />
comprensione della “modernità” così come la forma classica della tragedia sembra poter<br />
esprimere al meglio le ansie e i timori dell’uomo moderno.<br />
L’analisi del pensiero tragico pavesiano si sviluppa attra<strong>vers</strong>o uno studio dei temi e delle<br />
forme classiche che trovarono, negli scritti dell’autore, la possibilità d’essere<br />
ricontestualizzate. Pavese, oltre essere uno scrittore, fu anche e soprattutto uno studioso e un<br />
divulgatore di cultura; lo studio e la riflessione sulla tragedia classica impegnarono buona<br />
parte del suo lavoro di ricerca. Si potrebbe avanzare l’ipo<strong>tesi</strong> che l’<strong>in</strong>tera poetica di Pavese fu<br />
<strong>in</strong>fluenzata da un cont<strong>in</strong>uo e costante ripensamento delle categorie del tragico desunte dai testi<br />
orig<strong>in</strong>ali (Pavese leggeva sia <strong>in</strong> greco che <strong>in</strong> lat<strong>in</strong>o), mediate dalle letture dei suoi<br />
tragediografi preferiti (come Shakespeare) e dei teorici del genere. I testi che Pavese studiò a<br />
tale riguardo e che maggiormente esercitarono <strong>in</strong>fluenza su di lui sono La Nascita della<br />
tragedia di Friederich Nietzsche e Le orig<strong>in</strong>i della tragedia di Mario Unterste<strong>in</strong>er. Si trovano<br />
riferimenti a questi libri nelle pag<strong>in</strong>e del Mestiere di Vivere così come riflessioni di poetica<br />
che testimoniano come Pavese non avesse un <strong>in</strong>teresse esclusivamente storico nel leggere<br />
questi libri. Il punto di partenza di quest’analisi, f<strong>in</strong>alizzata alla comprensione<br />
dell’<strong>in</strong>terpretazione del tragico di Pavese, è il profondo <strong>in</strong>teresse dell'autore per l'etnologia 601 .<br />
L’apporto dell’etnologia nell’<strong>in</strong>terpretazione del mito e della tragedia classica è, <strong>in</strong>fatti, uno<br />
dei tratti più moderni del suo approccio. Alcuni dei Dialoghi si possono direttamente<br />
ricollegare ad episodi descritti da Frazer nel Ramo d'oro mentre l’<strong>in</strong>teresse per il mito si<br />
relaziona immediatamente all’<strong>in</strong>teresse etnologico per la forma della festa che è, per Kerenyi,<br />
il momento <strong>in</strong> cui l’uomo dimostra di sapersi dare alla contemplazione <strong>in</strong> periodi<br />
ritmicamente ricorrenti. Unterste<strong>in</strong>er vede nel fenomeno religioso della festa il veicolo<br />
attra<strong>vers</strong>o cui il mito ha la possibilità di divenire tragedia attica. E’ il momento del rito, della<br />
partecipazione e della compartecipazione ed è, allo stesso modo, il momento della<br />
contemplazione e del discernimento così come Kerenyi riporta: “Per la festa è essenziale che<br />
essa causi un arresto nel corso del mondo rendendo possibile il manifestarsi di forme eterne,<br />
le quali, mostrandosi, allargano il momento quasi ad un’eternità immobile” 602 . Leggendo il<br />
testo di Unterste<strong>in</strong>er si può denotare l’<strong>in</strong>teresse dello studioso nell’<strong>in</strong>dividuare la base della<br />
tragedia greca nella grande div<strong>in</strong>ità femm<strong>in</strong>ile mediterranea. A testimonianza di tale<br />
asserzione la presenza della capra o caprone, altro elemento mediterraneo. Orig<strong>in</strong>ariamente lo<br />
stesso Dioniso, poliforme e polisimbolico, pare fosse figlio della grande dea e solamente <strong>in</strong><br />
seguito all’<strong>in</strong>vasione degli <strong>in</strong>doeuropei, con la loro civiltà patriarcale, si sarebbe fatto<br />
discendere direttamente da Zeus, <strong>in</strong> maniera da annullare il predom<strong>in</strong>io delle dee madri<br />
cre<strong>tesi</strong>. L’<strong>in</strong>fluenza di questo libro sulla poetica di Pavese è testimoniata dalla presenza<br />
d’elementi strutturali ben <strong>def</strong><strong>in</strong>iti lungo tutto l’arco della sua produzione: il momento della<br />
festa, la descrizione di una natura che assume le parvenze di una donna fertile, il riferimento a<br />
personaggi femm<strong>in</strong>ili che assumono l’aspetto e le prerogative di capre con la doppia identità<br />
di madri e di belve feroci così come avveniva nel seguito bacchico, la presenza del v<strong>in</strong>o<br />
portatore d’ebbrezza e dunque di gioia e tormento. Nell’appunto dell’11 Dicembre del 1947 si<br />
trova conferma dell’avvenuta assimilazione delle teorie di Unterste<strong>in</strong>er: “<br />
dicono i lat<strong>in</strong>i, parlando delle baccanti. Non è strano? No, se si pensa che l’orgiasmo bacchico<br />
601 Nel 1945 i primi contatti con Ernesto De Mart<strong>in</strong>o per avviare una "Collezione etnografica" presso l'E<strong>in</strong>audi.<br />
602 Mario Unterste<strong>in</strong>er, Le orig<strong>in</strong>i della tragedia, Milano, Fratelli Bocca Editore, 1942, p. 52.<br />
555 C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, 11 Dicembre 1947, cit. p. 340.<br />
556 Ivi, 20 Febbraio 1946, p. 309.<br />
167
è un rito d’<strong>in</strong>iziazione dei tempi matriarcali” 603 .<br />
Dioniso, l’orig<strong>in</strong>e della tragedia per Unterste<strong>in</strong>er e Nietzsche, viene dunque <strong>in</strong>terpretato<br />
come div<strong>in</strong>ità rurale, nella sua forma orig<strong>in</strong>aria che è quella mediterranea. Dioniso come dio<br />
della vegetazione capace di riassumere <strong>in</strong> sé l’idea della vita e della morte, il perenne<br />
contrasto degli opposti, colui che detiene il segreto dell’essere e del non essere. Il<br />
r<strong>in</strong>venimento delle gesta del dio avviene dunque tramite lo svolgimento del suo mito. Ma è<br />
uno svolgimento che non chiama <strong>in</strong> causa le capacità logiche e razionali dell’<strong>in</strong>dividuo <strong>in</strong><br />
quanto la poesia è “non un capire ma un essere” 604 . E’ un’immedesimazione, un essere un<br />
tutt’uno con l’oggetto della contemplazione, un raggiungere l’estasi nel momento rituale<br />
della festa che si basava sullo svolgimento del mito. Per Nietzsche il logos socratico non è <strong>in</strong><br />
grado di esplorare il mistero dell’esistenza. L’estasi tragica si ottiene attra<strong>vers</strong>o il pathos che<br />
si pone come anti<strong>tesi</strong> del fallace e fuorviante logos. Il pathos sembra veramente essere la<br />
base della tragedia, sia nelle pag<strong>in</strong>e di Nietzsche sia <strong>in</strong> quelle di Ste<strong>in</strong>er. La tragedia viene a<br />
morire nel momento <strong>in</strong> cui alle forze sovrumane che osteggiano l’<strong>in</strong>dividuo si sostituiscono<br />
quelle umane. A questo punto il logos entra <strong>in</strong> gioco svelando un <strong>in</strong>treccio che nella tragedia<br />
classica non è dato. Questo è ancora importante poichè il personaggio tragico, per esser tale,<br />
deve essere av<strong>vers</strong>ato da forze che sfuggono all’umana comprensione. Così come Ste<strong>in</strong>er<br />
suggerisce, non c’è una via razionale per sfuggire all’esistenza tragica e il vero personaggio<br />
tragico è colui che esprime la tragedia tramite il suo patire:<br />
Where the causes of disaster are temporal, where the conflict can be resolved through technical or social<br />
means, we may have serious drama, but not tragedy [...] social psychiatry is not an answer to Oedipus [...]<br />
tragedy is irreparabile [...] there is no use ask<strong>in</strong>g for rational explanation or mercy. Th<strong>in</strong>gs are as they are,<br />
unrelent<strong>in</strong>g and absurd. We are punished far <strong>in</strong> excess of our guilt 605 .<br />
Il dramma borghese, <strong>in</strong>somma, rimuove il concetto di colpa orig<strong>in</strong>aria per <strong>in</strong>trodurre<br />
quello di responsabilità morale e <strong>in</strong>dividuale; ciò è <strong>in</strong> netto contrasto con i dettami della<br />
tragedia classica che postulavano la responsabilità metafisica uni<strong>vers</strong>ale. La vera<br />
tendenza moderna è, dunque, quella di evadere dalla tragedia abolendo l’orig<strong>in</strong>e<br />
metafisica del male. E’ questo cambio di prospettiva che segna per Ste<strong>in</strong>er il decl<strong>in</strong>o della<br />
tragedia. Lo sviluppo dell’azione attra<strong>vers</strong>o l’<strong>in</strong>treccio, l’irruzione del logos e<br />
l’<strong>in</strong>dividualità prepotente dei personaggi, lo stesso uso del dialogo, rappresentano<br />
problemi su cui riflettere. Il 27 Settembre 1942 Pavese scrive:<br />
Tendenzialmente, nella trag. gr. le persone non si parlano mai, parlano a confidenti, al coro, a estranei. E'<br />
rappresentazione <strong>in</strong> quanto ognuno espone il suo caso al pubblico. La persona non scende mai a dialoghi<br />
con altre, ma è come è, statuaria, immutabile. Le uccisioni avvengono fuori scena, e se ne sentono gli urli,<br />
le esortazioni, le parole. Giunge il messaggero e racconta i fatti. L'avvenimento si risolve <strong>in</strong> parola, <strong>in</strong><br />
esposizione. Non dialogo: la trag. non è dialogo ma esposizione a un pubblico ideale, il coro. Con esso si<br />
attua il vero dialogo 606 .<br />
E ancora l’11 Marzo 1949:<br />
605 George Ste<strong>in</strong>er, The death of tragedy, The Faber Library London, Great Brita<strong>in</strong> 1961, pp.8-9.<br />
606 C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, 27 Settembre 1942 , cit. p.245.<br />
168
Non analizzare ma rappresentare. Ma <strong>in</strong> un modo tutto vivo secondo un'implicita analisi. Dare un'altra<br />
realtà, su cui potrebbe nascere una nuova analisi, nuove norme, nuova ideologia. E' facile enunciare nuove<br />
analisi, nuove norme ecc. Difficile è farle nascere da un ritmo, un piglio di realtà coerente e complesso 607 .<br />
L’utilizzo della componente mitologica da parte di Pavese si può ricondurre ad un altro<br />
passaggio della Nascita della tragedia. Nietzsche esprime la teoria per cui aff<strong>in</strong>ché il<br />
patire sia puro esso non debba essere <strong>in</strong>fluenzato dalla ragione. Lo sviluppo di un<br />
<strong>in</strong>treccio immetterebbe una componente razionale creando così una distanza<br />
impercorribile tra soggetto e oggetto. Tale distanza creerebbe una situazione tale per cui<br />
il soggetto sarebbe portato a giudicare l’oggetto da un punto di vista razionale. In tal<br />
modo non si otterrebbe un’immedesimazione e lo spirito della tragedia, la compassione<br />
fra soggetto e oggetto e l’abolizione dei conf<strong>in</strong>i che li separa, verrebbe a mancare.<br />
L’<strong>in</strong>tervento razionale e il giudizio morale rappresentano il tracollo d’ogni possibilità<br />
tragica.<br />
Il 26 Giugno 1944 si cita, nel Mestiere di vivere, Pierre Corneille, autore del Discorso<br />
sulla tragedia e sui modi di trattarla secondo il verosimile e il necessario (1660). La<br />
riflessione sulla tragedia moderna entra <strong>in</strong> questa fase nel vivo e, com’è facile ipotizzare,<br />
si tratta di una stroncatura, <strong>in</strong> quanto se ne <strong>in</strong>dividua, come caratteristica fondamentale, la<br />
punizione dei cattivi. E’ un segno <strong>in</strong>dubbio, per Pavese, di un processo di moralizzazione<br />
della tragedia <strong>in</strong>nescato da quella che è <strong>def</strong><strong>in</strong>ita dispregiativamente “psicologia<br />
cristiana” 608 . Nella tragedia classica i malvagi non erano visti <strong>in</strong> contrasto con i buoni ma<br />
rappresentavano la loro essenza di fronte al coro. Il 26 Giugno 1944 così scrive: “Per gli<br />
antichi hai già scritto una volta che conta l’eroe isolato, che fa un discorso-monologo, che<br />
è davanti al coro. Questi contrasti non esistono. I malvagi, non essendo visti <strong>in</strong> contrasto,<br />
non sono malvagi ma sono, semplicemente, come i buoni” 609 . E ancora il 12 Gennaio<br />
1946: “Nella trag. greca non ci sono i malvagi. Non vi si chiarisce una responsabilità, vi<br />
si constata un fatto-un dest<strong>in</strong>o” 610 . Queste riflessioni trovano applicazione nei Dialoghi<br />
dove Pavese, oltre che utilizzare figure mitico-simboliche att<strong>in</strong>te da un repertorio<br />
classico, pone all’<strong>in</strong>izio di ogni s<strong>in</strong>gola vicenda narrata un breve sunto, come se egli<br />
volesse <strong>in</strong>formare lo spettatore sul senso della storia <strong>in</strong> anticipo. Il dialogo non cerca,<br />
<strong>in</strong>fatti, il r<strong>in</strong>venimento razionale ma la partecipazione, la compenetrazione,<br />
l’immedesimazione. In ultimo la com-passione. Tale vicenda è d’altra parte mito, evento<br />
archetipico, impenetrabile ad ogni giudizio. Il patire è la risposta dell’uomo al dest<strong>in</strong>o su<br />
cui non ha potere. I personaggi si pongono di fronte a tale dest<strong>in</strong>o scavando, tramite il<br />
dialogo, l’ultima essenza della loro tragedia, compiangendosi e compatendosi, ma mai<br />
approntando soluzioni razionali o scappatoie illusorie. Nella riflessione del 26 Settembre<br />
1942 si legge:<br />
La situazione tragica greca è: ciò che deve essere sia. Di qui il meraviglioso dei numi che fanno accadere<br />
ciò che vogliono; di qui le forme magiche, i tabù o i dest<strong>in</strong>i, che devono essere osservati; di qui la catarsi<br />
f<strong>in</strong>ale che è l'accettazione del dover essere [...]. Il poetico dei Greci è che questo dest<strong>in</strong>o, questi tabù, queste<br />
norme, appaiono arbitrari, <strong>in</strong>ventati, magici. Forse simbolici 611 .<br />
L’<strong>in</strong>teresse che l’autore espresse <strong>in</strong>torno al significato del mito agisce proprio <strong>in</strong> questo<br />
senso. Il mito è il veicolo attra<strong>vers</strong>o il quale si può raggiungere l’atemporale, l’eterno, il<br />
607 Ivi, p.365.<br />
608 Ivi, p.283.<br />
609 Ibid.<br />
610 Ivi, p.306.<br />
611 Ivi, p. 245.<br />
169
significato unico ma sempre nuovamente <strong>in</strong>terpretabile della tragedia umana. Nel brano<br />
Del mito, del simbolo e d'altro, Pavese esprime al meglio la sua concezione del mito e<br />
quello che è l’oggetto della sua ricerca:<br />
Ora, carattere, non dico della poesia, ma della fiaba mitica è la consacrazione dei luoghi unici, legati a un<br />
fatto a una gesta a un evento. A un luogo, tra tutti, si dà un significato assoluto, isolandolo dal mondo [...]<br />
l'impresa dell'eroe mitico non è tale perché dissem<strong>in</strong>ata di casi soprannaturali o fratture della normalità [...]<br />
bensì perché essa att<strong>in</strong>ge a un valore assoluto di norma immobile che, proprio perché immobile, si rivela<br />
perennemente <strong>in</strong>terpretabile ex novo, polivalente, simbolica <strong>in</strong>somma [...]. Il mito è <strong>in</strong>somma una norma, lo<br />
schema di un fatto avvenuto una volta per tutte, e trae il suo valore da questa unicità assoluta che lo solleva<br />
fuori dal tempo e lo consacra rivelazione. Per questo esso avviene sempre all'orig<strong>in</strong>i, come nell'<strong>in</strong>fanzia: è<br />
fuori dal tempo [...]. Genu<strong>in</strong>amente mitico è un evento che come fuori dal tempo così si compie fuori dello<br />
spazio [...]. Un mito è sempre simbolico; per questo non ha mai un significato univoco, allegorico, ma vive<br />
di una vita <strong>in</strong>capsulata che, a seconda del terreno e dell'umore che l'avvolge, può esplodere nelle più<br />
di<strong>vers</strong>e e molteplici fioriture. Esso è un evento unico, assoluto; un concentrato di potenza vitale da altre<br />
sfere che non la nostra quotidiana, e come tale <strong>vers</strong>a <strong>in</strong> un’aura di miracolo <strong>in</strong> tutto ciò che lo presuppone e<br />
gli somiglia 612 .<br />
I miti portano l’irrazionale alla consapevolezza, ci parlano dell’assoluto che c’è dietro<br />
l’esperienza quotidiana. Il mito è l’uni<strong>vers</strong>ale irrazionale, tradotto <strong>in</strong> forma comunicabile.<br />
Svolgere il mito significa gettare un barlume di luce sull’irrazionale, l’<strong>in</strong>governabile, lo<br />
sfuggente, che si celano dietro l’uomo e la sua cultura. Il compito del poeta tragico è<br />
dunque di ricontestualizzare il mito, di svolgere tutti i suoi significati reconditi al f<strong>in</strong>e di<br />
portarne a chiarezza l’<strong>in</strong>tima essenza. L’arte tragica si configura come un rito che vede<br />
protagonista l’umanità che, <strong>in</strong> ogni fase della sua storia, si trova di fronte all’enigma<br />
dell’esistenza. Il mito ha la capacità di porsi come “rivelazione <strong>in</strong>audita come per il<br />
credente una festa rituale” 613 .<br />
L’importanza che la riflessione sul mito classico ebbe per Pavese si può costatare<br />
attra<strong>vers</strong>o il percorso disegnato lungo il Mestiere di Vivere. Il 9 Febbraio 1950, poche<br />
settimane prima della scomparsa dell’autore, si può trovare conferma di come tale<br />
<strong>in</strong>fluenza agisse nei confronti della ricerca poetica personale: “Corollario. Tema di<br />
un’opera d’arte non può essere una verità, un concetto, un documento ecc., ma sempre e<br />
soltanto un mito. Dal mito direttamente alla poesia, senza passare attra<strong>vers</strong>o la teoria o<br />
l'azione” 614 . Gli stessi personaggi dei Dialoghi sono personaggi mitici, unici, simbolici.<br />
Anche <strong>in</strong> questo caso la scelta di Pavese non è casuale ma si ricollega alle teorie espresse<br />
nella Nascita della tragedia. L’agonia della tragedia avviene, per Nietzsche, quando lo<br />
spettatore balza sulla scena, <strong>in</strong> altre parole quando i personaggi mitologici sono sostituiti<br />
dagli uom<strong>in</strong>i comuni e le vicende mitiche sono sostituite da quelle della quotidianità. In<br />
questo caso la tragedia è fornita di un <strong>in</strong>treccio divenendo, <strong>in</strong> molti casi, una partita a<br />
scacchi, apogeo della razionalità, dell’astuzia, del calcolo. E’ un’evoluzione che trova il<br />
suo culm<strong>in</strong>e nel periodo romantico così come spiega Ste<strong>in</strong>er: i romantici ebbero la<br />
responsabilità di porre l’io al centro del dramma promettendo al contempo un compenso<br />
e una giustizia alle sofferenze patite, una risposta ragionevole che nella tragedia non è<br />
data. Si potrebbe pensare ad un imborghesimento della tragedia per cui l’<strong>in</strong>dividuo medio<br />
viene messo al centro dell’agone al f<strong>in</strong>e di esercitare le sue capacità. La forza morale, la<br />
fede, l’<strong>in</strong>telligenza lo conducono risoluto a risolvere le problematiche poste. I romantici<br />
ereditarono da Rosseau la fede nell’orig<strong>in</strong>aria bontà dell’uomo e l’attenzione per l’orig<strong>in</strong>e<br />
sociale dei mali. Insomma si potrebbe affermare che il dramma romantico è un dramma<br />
personale, lontano da quella dimensione collettiva orig<strong>in</strong>aria e da quella ricerca di<br />
612<br />
C. Pavese, Feria d'Agosto (1942), cit. p. 139.<br />
613<br />
Ivi, p. 143.<br />
614<br />
C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, 9 Febbraio 1950, cit., p. 389.<br />
170
un’esposizione uni<strong>vers</strong>ale che ne costituisce la caratteristica fondamentale. L’irruzione di<br />
un personaggio medio, razioc<strong>in</strong>ante e v<strong>in</strong>cente rappresenta per Ste<strong>in</strong>er l’ultimo stadio<br />
dell’agonia della tragedia. Nietzsche scrive a riguardo: “L’effetto della tragedia antica<br />
non poggiava mai sulla tensione, sull’<strong>in</strong>quietante <strong>in</strong>certezza di ciò che sta per avvenire,<br />
ma piuttosto su quelle scene di pathos grandiosamente strutturate” 615 . Il dramma moderno<br />
è <strong>in</strong> questo senso contam<strong>in</strong>ato dall’ideologia borghese <strong>in</strong> quanto “l'eroe che deve<br />
difendere il suo operare con ragioni e controragioni, rischia di perdere la nostra<br />
compassione: giacché l’<strong>in</strong>felicità che poi, nonostante tutto, lo travolge, prova appunto<br />
soltanto che da qualche parte egli ha sbagliato i calcoli” 616 . Pavese s’impegna, dunque,<br />
nel recupero dei temi tragici ben comprendendo la necessità di ricontestualizzarli,<br />
adattarli a nuove forme che non ne deturp<strong>in</strong>o il significato. Il primato della coscienza, la<br />
superiorità dell’agire sul patire, il predom<strong>in</strong>io del logos, sono elementi da re<strong>in</strong>terpretare<br />
tramite l’esercizio di un pensiero prettamente tragico. Lo stesso atto del narrare la<br />
tragedia attra<strong>vers</strong>o dei dialoghi assume un significato tragico:<br />
La tragedia implica ciò che la nega e la dissolve. Nella tragedia l'agone tragico, cioè l'espressione del<br />
contrasto e del dissidio che s'annidano nel cuore della realtà e ne rappresentano l'essenza, è il dialogo,<br />
appunto, è la contraddizione che il logos scatena e <strong>in</strong>scena sottraendosi come <strong>in</strong>visibile cornice scenica,<br />
come <strong>in</strong>att<strong>in</strong>gibile orizzonte. Ora, se il non-essere presente nel logos giustifica la gioia profonda che è nel<br />
fondo della tragedia, nel momento che l'eroe, soccombendo, lascia apparire il profilo div<strong>in</strong>o della physis,<br />
(cioè della natura tuttogenerante attra<strong>vers</strong>o la morte, o dell'essere che appare come logos e qu<strong>in</strong>di come più<br />
profonda ragione), tuttavia questo apparire cade <strong>in</strong>evitabilmente preda del concetto non appena il concetto<br />
lo fissa, ne fa una presenza <strong>in</strong>controvertibile, <strong>in</strong>dividua <strong>in</strong> esso l'immutabile struttura della legge morale 617 .<br />
Il dialogo, forma prettamente socratica 618 , sembra adattarsi ad uno sviluppo logico delle<br />
vicende e sembra <strong>in</strong>trodurre l’azione. Nietzsche scrive: “L’azione fece il suo <strong>in</strong>gresso<br />
solo quando apparve il dialogo” 619 . Ma l’operazione di Pavese non è operazione<br />
archeologica. Egli è ben cosciente delle forme orig<strong>in</strong>arie della tragedia e non esita a<br />
rimetterle <strong>in</strong> gioco. L’<strong>in</strong>treccio della vicenda è svelato prima dell’azione sviluppata, <strong>in</strong><br />
seguito, da personaggi mitici che svolgono dei dialoghi che non cercano il progresso ma<br />
la rivelazione. La natura “ottimistica” 620 della dialettica viene a <strong>in</strong>ciampare<br />
sull’impossibilità di concettualizzare questi dialoghi, sull’impossibilità di ricavarne una<br />
morale o dei precetti, <strong>in</strong> ultimo una soluzione razionale. Lo sforzo della dialettica di<br />
Pavese, ma anche il suo ultimo orizzonte, è quello di portare a chiarezza i miti, svelarne<br />
l’arcano ricontestualizzando l’evento archetipico. I Dialoghi si svolgono, dunque,<br />
tragicamente, <strong>in</strong> una perenne tensione fra la nascita della tragedia e la sua morte, nel<br />
segno dello scontro/<strong>in</strong>contro di Dioniso con Apollo. Il ruolo della dialettica è, <strong>in</strong> questo<br />
caso, non quello di confutare il mito quanto quello di compenetrarlo. E’ un ruolo che<br />
potremmo <strong>def</strong><strong>in</strong>ire tragico <strong>in</strong> quanto teso a superare le sue stesse misure. I Dialoghi sono<br />
fermi nel tempo, non progrediscono, non evolvono ma scavano le profondità del mito.<br />
Non è possibile sviluppare un’azione da questa dialettica. Domanda e risposta<br />
costituiscono un unico oggetto, non entrano <strong>in</strong> competizione ma contribuiscono al<br />
completamento del quadro. E’ un logos che logicizza la sua <strong>in</strong>adeguata logicità<br />
rimanendo immobile come personaggio tragico. Il ruolo del personaggio antagonista<br />
riflette quello del coro: non vi è sviluppo dialettico nei Dialoghi: “Ciò che deve essere<br />
615<br />
F. Nietzsche, La Nascita della tragedia , cit. p.45.<br />
616<br />
Ivi, p.51.<br />
617<br />
Sergio Givone, Dis<strong>in</strong>canto del mondo e pensiero tragico, Milano, Il Saggiatore, 1988, p.94.<br />
618<br />
Il modello cui s’ispira Pavese è quello platonico così come scrive il 4 Giugno 1942 sul Mestiere di Vivere.<br />
619<br />
F. Nietzsche, La Nascita della tragedia, cit. p.38.<br />
620 Ivi, p. 51.<br />
171
sia. Il coro constata questo. (Ecco perché è il perenne <strong>in</strong>terlocutore degli agonisti)” 621 .<br />
Nell’Immag<strong>in</strong>e arguta, Mutterle argomenta quest’uso paradossale del dialogo per cui si<br />
ottiene “non dialettica ma tragica <strong>in</strong>sanabilità” che si manifesta <strong>in</strong> un “trionfo della<br />
circolarità”:<br />
Le battute [...] sono ciascuna sviluppate secondo anti<strong>tesi</strong> e negazioni [...] considerate complessivamente<br />
non generano contraddizione, ma piuttosto un allargamento concentrico e graduale, dato che<br />
sostanzialmente svolgono e raccontano un medesimo concetto [...] il filo unitario del dialogo risiede <strong>in</strong><br />
quello che sta accadendo a un'idea stereotipata (accettare o meno il dest<strong>in</strong>o) che via via arricchisce il<br />
proprio spessore di nuovi strati 622 .<br />
Il discutere dell'’gonista è dunque un cont<strong>in</strong>uo discernimento ed approfondimento di ciò<br />
che è già dato da sempre. E’ una forma, questa del dialogo pavesiano, che si sviluppa<br />
anche attra<strong>vers</strong>o la riflessione sul wit. Il wit è un elemento tipico della tragediografia<br />
<strong>in</strong>glese che Pavese studiò e apprezzò <strong>in</strong> particolar modo soprattutto per mezzo delle opere<br />
di Shakespeare. La riflessione sull'argomento si sviluppa attra<strong>vers</strong>o gli appunti del diario<br />
ed è tesa a conciliare la forma del wit con i dettami della tragedia classica. Il 31 Ottobre<br />
1942 scrive:<br />
Tutte queste burle, questi tricks, queste witty <strong>in</strong>ventions, che nel tragico sono agguati, vendette, imprese,<br />
sono la forma entro cui si agita la verità psicologica delle persone ma la superano, la <strong>in</strong>corniciano e la<br />
sorreggono, <strong>in</strong> stilizzazione tra sociale e mitologica. Il wit <strong>in</strong>somma non è psicologia, è stile 623 .<br />
Pavese riconosce <strong>in</strong> tale tecnica il miglior metodo di fusione tra rappresentazione scenica<br />
e racconto. Il 7 Ottobre 1943 appunta <strong>in</strong> relazione all'Enrico VI: “Qui il wit si configura<br />
specialmente come immag<strong>in</strong>e illum<strong>in</strong>atrice della narrazione [...]. Qui al dialogo si<br />
sostituisce il wit descrittivo e narrativo. Le commedie contemporanee sono già teatro,<br />
mentre questa cronica è tutta racconto” 624 . Il riferimento a Shakespeare appare sempre<br />
più impresc<strong>in</strong>dibile dal momento che il concetto di “immag<strong>in</strong>e dialogata” che esprime il<br />
9 Ottobre, e che Pavese <strong>in</strong>dividua nello scrittura shakespeariana della maturità, sembra<br />
<strong>in</strong>fluenzare non poco la composizione dei Dialoghi con Leucò. In questo caso il<br />
riferimento va alla teoria compositiva pavesiana che ruota <strong>in</strong>torno alla riflessione <strong>in</strong>torno<br />
alla cosiddetta “immag<strong>in</strong>e racconto”. Considerando che “essenza della poesia è<br />
l'immag<strong>in</strong>e” 625 , Pavese sembra essere particolarmente <strong>in</strong>teressato a come Shakespeare<br />
costruisca queste immag<strong>in</strong>i attra<strong>vers</strong>o una forma di dialogo che travalica le barriere che il<br />
dialogo stesso, nella sua forma socratica, erge di fronte al disvelamento della tragedia<br />
umana. Per Mutterle i Dialoghi rappresentano “il testo dell’acquisizione <strong>def</strong><strong>in</strong>itiva del wit<br />
tragico, impegnato a sondare la profondità dell'esistenza umana non esponendo<br />
avvenimenti, ma emettendo giudizi che suonano assoluti e <strong>def</strong><strong>in</strong>itivi” 626 . Come si può<br />
constatare l’elaborazione pavesiana di questa tecnica narrativa è strettamente correlata ai<br />
temi fondanti del tragico. Il wit narrativo permette la fusione degli opposti nell’ambito di<br />
un gioco macabro teso al raggiungimento di una gioia atroce di stampo niciano:<br />
“Co<strong>in</strong>cidenza dei contrari e possibilità di sostituirli l’uno all’altro è dunque l’essenza del<br />
621<br />
C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, 18 Ottobre 1942, cit. p.246.<br />
622<br />
Anco Marzio Mutterle, L'immag<strong>in</strong>e arguta. L<strong>in</strong>gua stile retorica di Pavese, Tor<strong>in</strong>o, E<strong>in</strong>audi,<br />
1977, p.37.<br />
575<br />
C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, 31 Ottobre 1942, cit. p.246.<br />
624 Ivi, 7 Ottobre 1943, p.261.<br />
625 Ivi, 5 Aprile 1945, p.299.<br />
626 A.M. Mutterle, L’Immag<strong>in</strong>e arguta, cit. p.76.<br />
172
wit tragico, che del contraddittorio fa una ragion d’essere e di stile” 627 . La contraddizione<br />
è tema e caratteristica portante della tragedia così che il wit shakespeariano appare la<br />
tecnica narrativa adeguata al suo svolgimento:<br />
Univoco è il sapere filosofico, doppio il sapere tragico: perciò sono <strong>in</strong>compatibili. Se da una parte si tratta<br />
d'un alethes logos, d'un discorso di verità che presuppone la perfetta trasparenza dell'ord<strong>in</strong>e div<strong>in</strong>o entro cui<br />
tutto si lascia disporre secondo giustizia, dall'altra <strong>in</strong>vece si ha a che fare con i dissoi logoi, discorsi che<br />
legittimano quelle ambiguità contraddittorie per cui lo stesso <strong>in</strong>dividuo appare giusto e <strong>in</strong>giusto, <strong>in</strong>nocente<br />
e colpevole, vittima e carnefice 628 .<br />
Passo fondamentale al f<strong>in</strong>e dell’acquisizione di tale tecnica narrativa è quello<br />
dell’elaborazione di un l<strong>in</strong>guaggio pert<strong>in</strong>ente. Quello del l<strong>in</strong>guaggio è un problema che<br />
Pavese si pose lungo tutto l’arco della sua ricerca <strong>in</strong>tellettuale e qu<strong>in</strong>di, <strong>in</strong> particolar<br />
modo, <strong>in</strong> relazione ai Dialoghi con Leucò che rappresentano un unicum nella sua<br />
produzione. Ste<strong>in</strong>er discute della differenza tra una tragedia scritta <strong>in</strong> <strong>vers</strong>i e una scritta <strong>in</strong><br />
prosa. La tragedia non è democratica: si occupa di personaggi alti, di forti passioni e usa<br />
un l<strong>in</strong>guaggio adeguato come il <strong>vers</strong>o. In una tragedia classica non vedremo mai il<br />
protagonista soffrire di mal di stomaco. Per Ste<strong>in</strong>er il <strong>vers</strong>o si libera dall’<strong>in</strong>flusso del caso<br />
e del tempo mentre la prosa rimane aderente alla vita di tutti i giorni. In questo senso si<br />
r<strong>in</strong>traccia un altro spunto <strong>in</strong>teressante per la discussione sull’<strong>in</strong>terpretazione tragica<br />
pavesiana. Pavese ricerca, s<strong>in</strong> dalla prima esperienza di Lavorare stanca, un l<strong>in</strong>guaggio<br />
aderente al reale, come può essere quello della prosa, ma al contempo capace di suggerire<br />
al lettore un it<strong>in</strong>erario metafisico, così com’è caratteristica del <strong>vers</strong>o. Pavese sperimenta il<br />
genere della poesia racconto per poi cont<strong>in</strong>uare il suo percorso con un tipo di<br />
composizione che si potrebbe <strong>def</strong><strong>in</strong>ire racconto-poesia. In questo tipo di composizione si<br />
adottano elementi della prosa per poterli addizionare a quelli del <strong>vers</strong>o al f<strong>in</strong>e di ottenere<br />
un l<strong>in</strong>guaggio ritmicoessenziale, fruibile. Nel particolare caso dei Dialoghi con Leucò la<br />
ricerca l<strong>in</strong>guistica sembra ancora una volta tesa ad <strong>in</strong>contrare le tematiche espresse. Non<br />
r<strong>in</strong>unciando alle ricerche precedenti, Pavese elabora un tipo di l<strong>in</strong>guaggio <strong>in</strong> grado di<br />
fondere “il tono alto dell’enunciazione con l’esigenza del parlato colloquiale” 629 . Ma<br />
questo, che sembra il punto di partenza della sperimentazione pavesiana, s’<strong>in</strong>contra<br />
presto con quelle che sono le esigenze stilistiche e ideologiche del pensiero tragico: “la<br />
l<strong>in</strong>gua disdegna sempre più l’<strong>in</strong>treccio e la registrazione narrativa e aspira a raccontare<br />
tramite la recitazione, a costruire trapassi <strong>in</strong>avvertiti e nascosti” 630 . Pavese sembra<br />
dunque concentrarsi sulla riscoperta della dimensione simbolica del l<strong>in</strong>guaggio e sul<br />
superamento di un livello prettamente mimetico. I Dialoghi con Leucò rappresentano una<br />
tappa fondamentale della sperimentazione formale pavesiana. Il 1 Gennaio 1946 così<br />
scrive riferendosi ai Dialoghi: “scoperta una nuova forma che s<strong>in</strong>tetizza molti filoni” 631 .<br />
L’<strong>in</strong>teresse per la mitologia e quello per l’etnologia convergono <strong>in</strong> questa “nuova forma”.<br />
L’8 Maggio 1946 scrive: “Maturato tutto il mondo mito-etnologico, ecco che torno a<br />
Roma, e <strong>in</strong>vento il nuovo stile dei dialoghi e li scrivo” 632 .<br />
Il nuovo stile nasce dunque da una profonda meditazione sulle forme ma anche sui<br />
contenuti della tragedia classica. I Dialoghi con Leucò sono calati <strong>in</strong> un’ambientazione<br />
classica dove gli dei dell’Olimpo rappresentano la legge della ragione che viene ad<br />
627<br />
Ivi, p. 86.<br />
628<br />
S. Givone, Dis<strong>in</strong>canto del mondo e pensiero tragico, cit., p.113.<br />
629<br />
A.M. Mutterle, L’Immag<strong>in</strong>e arguta, cit. p.84.<br />
630<br />
Ivi, p.76.<br />
631<br />
C. Pavese, Il Mestiere di vivere, 1 Gennaio 1946, cit. p.306.<br />
632<br />
Ivi, 8 Maggio 1946, p.315.<br />
173
<strong>in</strong>staurarsi prepotentemente <strong>in</strong> un mondo dom<strong>in</strong>ato dalle leggi di natura 633 . Per Pavese il<br />
lavorare su questa contrapposizione significa ripercorrere le età culturali dell’uomo f<strong>in</strong>o<br />
al r<strong>in</strong>venimento dell’orig<strong>in</strong>ario. Il 24 Febbraio 1947 così scrive a riguardo della sua<br />
concezione mitologica fondamentale: “L’età titanica (mostruosa e aurea) è quella di<br />
uom<strong>in</strong>i-mostri-dèi <strong>in</strong>differenziati. Tu consideri la realtà come sempre titanica, cioè come<br />
caos umano-div<strong>in</strong>o (= mostruoso), ch’è la forma perenne della vita. Presenti gli dèi<br />
olimpici, superiori, felici, staccati, come i guastafeste di questa umanità [...]” 634 . Questa<br />
contrapposizione assume spesso la forma di un vero e proprio conflitto <strong>in</strong> cui si sferra un<br />
attacco deciso agli dèi olimpici, troppo umani, rei di aver <strong>in</strong>trodotto una legge che<br />
allontana l’uomo dalla sua natura. Il 4 agosto del 1947 la posizione di Pavese si rende<br />
evidente:<br />
Gli olimpici si occupano altrettanto poco del Prima che del Poi; non sono né la sorgente di vita né il suo<br />
f<strong>in</strong>e. Inoltre, altra caratteristica è che, con le più rigide limitazioni, sono umani. Non sono una cosa sola con<br />
la vita che è nelle bestie, nelle correnti, nei boschi come nell'uomo [...].
Ciò significa, ed è questo il tema tragico del libro, che il caos è <strong>in</strong>sopprimibile e che la<br />
figura del primitivo, che di tale caos si fa esponente, è ben lontana dal modello del buon<br />
selvaggio descritto da Rosseau:<br />
La natura ritorna selvaggia, e questo significa che la natura orig<strong>in</strong>ariamente non è quello che noi crediamo<br />
che sia: <strong>in</strong>nocente, comunque <strong>in</strong>differente. Questa è un’illusione, un’<strong>in</strong>venzione rousseiana. Più orig<strong>in</strong>aria<br />
dell’<strong>in</strong>nocenza è la colpa, e <strong>in</strong>fatti risalendo <strong>vers</strong>o le orig<strong>in</strong>i si ricade nella violenza <strong>in</strong>condizionata,<br />
perseguita senza remore, e soprattutto <strong>in</strong> modo assolutamente gratuito. La poesia che non ha altro oggetto,<br />
altra radice, altra fonte, che il mito (sia il mito personale sia il mito collettivo), ne rivela la cifra misteriosa e<br />
crudele 639 .<br />
La legge dell’uomo <strong>in</strong>terviene per dimenticare, nascondere, sconfessare ma non può<br />
rimuovere né cambiare la natura umana. Il r<strong>in</strong>venimento di tale natura avviene dunque<br />
tramite lo scontro fra la volontà umana (che aspira al div<strong>in</strong>o) e l’implacabile dest<strong>in</strong>o che<br />
riporta l’uomo, tragicamente, al suo stato fer<strong>in</strong>o.<br />
[…] la violenza è orig<strong>in</strong>aria e la tragedia si pone, con i suoi modi, di fronte a tale orig<strong>in</strong>e [...] perché non c'è<br />
rimozione che non la alimenti e non la riproduca. Ma <strong>in</strong> cosa consiste l'ambiguità del tragico se non nel fatto che<br />
la tragedia re<strong>in</strong>tegra, risacralizza, restituisce alla festa la violenza, ma allo stesso tempo la demistifica e la<br />
schiude a un <strong>in</strong>contenibile esplosione? 640 .<br />
La categoria del tragico <strong>in</strong> Pavese si espleta tramite il discernimento e l’approfondimento di<br />
tale scontro. Dall’<strong>in</strong>sanabilità della contraddizione e dall’<strong>in</strong>conciliabilità degli opposti, nasce<br />
quella visione tragica dell’esistenza che pervade i Dialoghi con Leucò. Gli opposti si pongono<br />
cont<strong>in</strong>uamente a confronto tramite un dialogo che non vuole pianificare razionali soluzioni<br />
quanto costatare la dimensione tragica dell’esistenza umana. All’<strong>in</strong>terno di questo cont<strong>in</strong>uo<br />
contrasto, l’operazione di Pavese è di scavare e approfondire la distanza che ci separa dalla<br />
verità delle orig<strong>in</strong>i. Il significato della tragedia si espleta nell’approfondimento patetico di un<br />
<strong>in</strong>sanabile conflitto, da sempre dato, che si riduce alla perenne lotta fra la componente<br />
ist<strong>in</strong>tiva e quella razionale, fra il subconscio e l’ego, fra la natura e la cultura. L’equilibrio,<br />
che si crea fra gli opposti, vacilla <strong>in</strong> cont<strong>in</strong>uazione ed è questo vacillare che genera la poesia.<br />
Dal cont<strong>in</strong>uo <strong>in</strong>teragire degli opposti e dalla perpetua opposizione di facoltà razionali e<br />
irrazionali, scaturisce una parte consistente della tragedia dell’uomo moderno. Premuda<br />
<strong>in</strong>dividua l’espressione maggiore di questo motivo tragico nel dialogo La belva:<br />
Ma è soprattutto la strana dea di La belva a esprimere <strong>in</strong> momenti di vera poesia la ferocia tranquilla di un<br />
mondo che non conosce valori perché non conosce dist<strong>in</strong>zioni, dove un fiore, una bacca è il selvaggio<br />
nell’elementarità di un contatto emozionale. E l’uomo che vuol possederlo deve r<strong>in</strong>unciare alla parte più cara di<br />
sé, la sua razionalità; ma questa non si dissolve senza lasciargli l’<strong>in</strong>quietitud<strong>in</strong>e di un implicito term<strong>in</strong>e di<br />
639 S. Givone, Introduzione ai Dialoghi con Leucò, cit., pp. IX-X.<br />
640 S. Givone, Dis<strong>in</strong>canto del mondo e pensiero tragico, cit., p.102.<br />
593 M. L. Premuda, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, vol.XXVI, 1957, contenuto <strong>in</strong> C. Pavese,<br />
Dialoghi con Leucò, cit., pp. 202-203.<br />
175
confronto. Torna qui, espresso <strong>in</strong> parole piene di echi, il fondamentale dissidio tra le lus<strong>in</strong>ghe di un’esperienza<br />
irrazionalistica e lo sforzo di un conoscere razionale […] 641 .<br />
Pavese pone <strong>in</strong> gioco i temi esistenziali di quest’umanità <strong>in</strong>trecciandoli <strong>in</strong> un sapiente gioco<br />
mitico. Nei Dialoghi con Leucò la libera volontà si scontra contro il muro del dest<strong>in</strong>o mentre<br />
il tentativo d’emancipazione dal caos atavico trova nell’<strong>in</strong>sufficienza della ragione il suo<br />
limite.<br />
L’idea di Pavese appare, dunque, quella di riprist<strong>in</strong>are il significato della tragedia attra<strong>vers</strong>o<br />
una rielaborazione delle sue forme. Quale può essere il senso di tale operazione nel panorama<br />
della modernità è un altro argomento che impegnò la riflessione dello stesso autore. Per capire<br />
al meglio quali fossero le reali aspettative dell’autore, <strong>in</strong> relazione a un recupero dei temi<br />
della tragedia classica, occorrerà partire nuovamente dal Mestiere di vivere. Nel Febbraio del<br />
1944 Pavese scrive una serie di note che sono particolarmente <strong>in</strong>teressanti <strong>in</strong> vista del<br />
chiarimento del rapporto mito-modernità. Non è una riflessione esauriente, certo, ma<br />
attra<strong>vers</strong>o una serie di schizzi si può avere un’idea del rapporto fra i vari elementi che<br />
compongono la concezione mitica pavesiana:<br />
L'etnologia dissem<strong>in</strong>a di sangue <strong>vers</strong>ato irrazionalmente e miticamente questi luoghi familiari […]. Il<br />
sangue è sempre <strong>vers</strong>ato irrazionalmente. Ogni cosa è un miracolo, ma nel caso del sangue lo si sente più<br />
acutamente, perché di là c'è il mistero. Piangere è irrazionale. Soffrire è irrazionale [...]. Il tuo problema è<br />
dunque valorizzare l'irrazionale. Il tuo problema poetico è valorizzarlo senza smitizzarlo. Quando si<br />
sangu<strong>in</strong>a o si piange, lo stupore è che proprio noi si faccia questo che solleva all'uni<strong>vers</strong>ale, al tutti, al mito<br />
[…]. Le tue creazioni le trai dall'<strong>in</strong>forme, dall'irrazionale, e il problema è come portarle a consapevolezza<br />
[...]. La tua modernità sta tutta nel senso dell'irrazionale 642 .<br />
I miti portano l’irrazionale alla consapevolezza parlandoci dell’assoluto che c’è dietro<br />
l’esperienza quotidiana. Lo svolgimento del mito è lo sforzo di gettare un barlume di luce<br />
sull’irrazionale, l’<strong>in</strong>governabile, lo sfuggente. La legittimazione dell’approccio tragico è<br />
dovuta alla conv<strong>in</strong>zione che il mito, espressione privilegiata dell’uomo e della sua<br />
cultura, rappresenti una cont<strong>in</strong>uità che si rivela attra<strong>vers</strong>o le di<strong>vers</strong>e <strong>in</strong>terpretazioni che i<br />
secoli ne danno.<br />
In epoca moderna assistiamo all’entrata <strong>in</strong> scena dell’etnologia di cui Pavese fu cultore. Il<br />
rapporto impresc<strong>in</strong>dibile che lo scrittore constata fra mitologia ed etnologia segna gran<br />
parte della sua ricerca poetica. In questo contesto l’<strong>in</strong>fluenza del Vico, che Pavese studiò,<br />
appare la fonte pr<strong>in</strong>cipale dell’“<strong>in</strong>terpretazione della storia e della letteratura <strong>in</strong> chiave<br />
etnologica” 643 . La mediazione tra antico e moderno e l’<strong>in</strong>teresse per la poesia tragica<br />
classica e l’etnologia sembrano condividere una stessa direzione: risalire <strong>vers</strong>o<br />
l’orig<strong>in</strong>ario. E’ questo che Pavese <strong>in</strong>tende quando parla di “selvaggio” come figura<br />
tragica per eccellenza ma possono essere ancora una volta le pag<strong>in</strong>e dello stesso autore a<br />
spiegare al meglio tale rapporto. Tra l’Agosto e il Settembre 1944 Pavese scrive:<br />
642 C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, Febbraio 1944, cit. pp. 273-274.<br />
643 Eugenio Cors<strong>in</strong>i, Orfeo senza Euridice: i Dialoghi con Leucò e il classicismo di Pavese, <strong>in</strong> Sigma, 3-4, 1964,<br />
pp. 121-46.<br />
176
Cadere dal fico e giacere nel sangue [...] non è selvaggio <strong>in</strong> quanto evento, ma diviene tale se veduto come<br />
legge della vita. Che il sangue sgorghi, <strong>in</strong> un modo o nell'altro, a torrenti sulla terra, che naturalmente le<br />
bestie si divor<strong>in</strong>o, e che il caduto non abbia diritti da <strong>in</strong>vocare, questo è il selvaggio perché il nostro<br />
sentimento lo vorrebbe proibito, mero evento e non legge […]. La natura impassibile celebra un rito;<br />
l'uomo impassibile o commosso celebra i suoi riti più spaventosi; tutto ciò è superstizione soltanto se ci<br />
giunge come <strong>in</strong>giusto, proibito dalla coscienza, selvaggio. Qu<strong>in</strong>di selvaggio è il superato dalla coscienza<br />
[…]. Il selvaggio non è pittoresco ma tragico […]. Poesia è, ora, lo sforzo di afferrare la superstizione -il<br />
nefando- e dargli un nome, cioè conoscerlo, farlo <strong>in</strong>nocuo. Ecco perché l'arte vera è tragica -è uno sforzo.<br />
La poesia partecipa di ogni cosa proibita dalla coscienza-ebbrezza, amore&passione, peccato- ma tutto<br />
riscatta con la sua esigenza contemplativa cioè conoscitiva 644 .<br />
L’idea alla base dei Dialoghi, e quella su cui Pavese lavora con maggior <strong>in</strong>teresse<br />
nell’ambito della sua ricerca poetica, è qu<strong>in</strong>di l’approfondimento del rapporto che lega<br />
etnologia e mitologia attra<strong>vers</strong>o l’elaborazione di un personaggio tragico che è il<br />
selvaggio. Questo sembra essere uno degli sviluppi più <strong>in</strong>teressanti ed orig<strong>in</strong>ali della<br />
poetica pavesiana <strong>in</strong> quanto capace di legare due scienze, quella del mito e quella<br />
dell’etnologia, una relativamente antica, l’altra relativamente recente. Se si pongono<br />
questi Dialoghi con Leucò all’<strong>in</strong>terno del panorama culturale coevo si potrà notare come<br />
l’operazione di Pavese non appaia arbitraria e f<strong>in</strong>e a sé stessa ma ben correlata a certa arte<br />
europea che, con non venate sfumature decadentiste, condivideva i suoi stessi <strong>in</strong>teressi.<br />
Guglielmi sottol<strong>in</strong>ea come l’<strong>in</strong>tera opera di Pavese sia da ricondurre alla cultura del suo<br />
tempo:<br />
E proprio nella cultura del proprio tempo trovò quell’<strong>in</strong>teresse per il mito, rivalutato come forma di<br />
conoscenza, che Vico e i romantici avevano <strong>in</strong>augurato […]. A un’organizzazione del racconto non<br />
naturalistica, il racconto mitico-simbolico doveva <strong>in</strong>vero offrirsi come modello […]. La poetica di Pavese<br />
punta a una comunicazione simbolica, capace di riprist<strong>in</strong>are strutture profonde e arcaiche della cultura, a<br />
livello dell’uomo moderno 645 .<br />
Per Guglielmi, lo sforzo di Pavese è quello di sottrarre i materiali mitici dalla loro aura di<br />
preziosità e di esclusività culturale per <strong>in</strong>serirli <strong>in</strong> un più ampio contesto, <strong>in</strong> “una<br />
dimensione etica e comunicativa”. Insomma Pavese “mira a riconvertire l’uso estetico dei<br />
miti – quale gli giungeva direttamente da D’Annunzio – <strong>in</strong> uso etico […] e tutto questo<br />
secondo una direzione propria dei ritornanti primitivismi della modernità”. In un seguente<br />
passaggio, Guglielmi arriverà ad ipotizzare come tutta la poetica dell’autore si basasse sul<br />
problema di consegnare i materiali della tragedia classica ai tempi moderni e qu<strong>in</strong>di<br />
“mediare tempo estatico e tempo profano, citazione mitica e vita contemporanea” 646 . Il<br />
10 luglio del 1947 Pavese scrive:<br />
Notato che Paesi tuoi e Dialoghi con Leucò nascono dal vagheggiamento del selvaggio- la campagna e il<br />
titanismo [...]. L'arte del novecento batte tutta sul selvaggio. Prima come argomenti (Kipl<strong>in</strong>g, D'Annunzio<br />
ecc.), poi come forma (Joyce, Picasso ecc.) [...]. Tutto ciò che ti ha colpito <strong>in</strong> modo creativo nelle letture,<br />
sapeva di questo. (Nietzsche col suo Dioniso...). Con la scoperta dell'etnologia sei giunto a storicizzare<br />
questo selvaggio. La città-campagna dei primi libri è diventata il titanismo-olimpico dell'ultimo [...]. Il<br />
selvaggio ti <strong>in</strong>teressa come mistero non come brutalità storica. Non ti piacciono le storie partigiane o<br />
terroristiche, sono troppo spiegabili. Selvaggio vuol dire mistero, possibilità aperta 647 .<br />
644<br />
C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, cit. pp. 288-291.<br />
645<br />
G. Guglielmi, La prosa italiana del Novecento tra romanzo e racconto, cit. pp. 114-16.<br />
646<br />
Ivi, pp. 114-117.<br />
647<br />
C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, 10 Luglio del 1947, cit. pp. 334-335.<br />
177
Il lavoro di Pavese sembra trarre ispirazione e, al contempo, contribuire alla ricerca<br />
artistica contemporanea. La ricerca è diretta al discernimento-svelamento di quelle “leggi<br />
della vita” che non sono esclusivamente quelle create dall’uomo ma soggiacciono<br />
nell’irrazionale, <strong>in</strong> quel terreno che i greci usavano sondare tramite lo svolgimento del<br />
mito. La riproposizione del tragico avviene senz’altro <strong>in</strong> questo senso dal momento che si<br />
può constatare come il rendere fruibile il materiale dei Dialoghi con Leucò, di<br />
modernizzare, <strong>in</strong>somma, il materiale classico, sia uno dei primi obiettivi dello scrittore.<br />
Il 28 Luglio 1947, Pavese scrive un’importante nota a riguardo: “I Dialoghetti<br />
conservano gli elementi, i gesti, gli attributi, i nodi del mito, ma ne aboliscono la realtà<br />
culturale radicata <strong>in</strong> una storia d’<strong>in</strong>nesti, calchi, derivazioni, ecc. (che ce li rende<br />
comprensibili) [...]. Quello che resta è il problema, che la tua fantasia risolve” 648 . Cercare<br />
di <strong>in</strong>terpretare i Dialoghi con Leucò partendo dal classico sarebbe, dunque, un errore che<br />
si corre il rischio di commettere ogni qualvolta ci si avvic<strong>in</strong>a ad un’opera come questa.<br />
Lo stesso autore scrive a riguardo <strong>in</strong> una nota del 18 Febbraio 1950: “La cultura deve<br />
com<strong>in</strong>ciare dal contemporaneo e documentario, dal reale, per salire -se è il caso- ai<br />
classici. Errore umanistico: com<strong>in</strong>ciare dai classici. Ciò abitua all’irreale alla retorica, e<br />
<strong>in</strong> <strong>def</strong><strong>in</strong>itiva al disprezzo c<strong>in</strong>ico della cult. classica [...]” 649 . I Dialoghi con Leucò non<br />
rappresentano un’opera erudita o uno sfoggio di cultura classica ma sono una risposta<br />
concreta alle istanze culturali di quel periodo.<br />
L’orig<strong>in</strong>alità dello scritto pavesiano lasciò <strong>in</strong>terdetto più di un critico nel momento della<br />
pubblicazione e si dovettero aspettare parecchie settimane prima di poter leggere le prime<br />
recensioni. Lo stesso autore lamentava il fatto che nessuno comprendesse a pieno il<br />
valore di quest’opera che rimaneva, tra l’altro, una delle sue preferite. Il problema<br />
pr<strong>in</strong>cipale sembrava essere quello di poter <strong>def</strong><strong>in</strong>ire i Dialoghi con Leucò. Se non erano<br />
un’opera erudita totalmente volta al recupero dei temi classici come poteva essere<br />
ricollegata e collocata nel panorama artistico contemporaneo? Una delle prime critiche,<br />
che lo stesso autore salutò con entusiasmo, fu proprio quella di Unterste<strong>in</strong>er che<br />
riconobbe nei Dialoghi con Leucò il felice tentativo di modernizzare le tematiche<br />
classiche. Nell’articolo apparso su “Educazione Politica”, Unterste<strong>in</strong>er così si esprime:<br />
Questi dialoghi sono sempre a due e hanno per centro un momento o il momento significativo,<br />
paradigmatico di ogni mito. Ognuno è preceduto da una <strong>in</strong>cisiva didascalia <strong>in</strong>formativa e, spesso, esegetica,<br />
<strong>in</strong> quanto l'A., con una frase e talora anche con una sola parola va alla radice perenne del mito, quella che<br />
pur oggi è vitale e che viene scoperta <strong>in</strong> qualche caso, col nuovo spirito moderno [...]. Il tormento<br />
speculativo moderno s'<strong>in</strong>gigantisce risalendo nei secoli f<strong>in</strong>o alle età primève del mito, che prende un<br />
aspetto orig<strong>in</strong>ale <strong>in</strong> questo, che non è travestimento moderno, ma sguardo di un moderno, consapevole che<br />
il mito dell'Ellade non si può violare 650 .<br />
Il tentativo di Pavese appare, dunque, quello di s<strong>in</strong>tetizzare istanze prettamente moderne<br />
tramite il ricorso al mito. Probabilmente è proprio dalla distanza modernità-classicità che<br />
si ottiene una prima possibilità conoscitiva. Lo sguardo che Pavese getta sulla storia del<br />
mondo è omnicomprensivo ed è teso al disvelamento delle leggi che lo governano.<br />
L’approccio tragico consiste nel prendere coscienza di quello che Sergio Givone 651<br />
648 Ivi, 28 Luglio 1947, p. 336.<br />
649 Ivi, 18 Febbraio 1950, p. 390.<br />
650 In Educazione Politica n° I (nov.-dic. 1947) p. 344, contenuto <strong>in</strong> C. Pavese, Dialoghi con Leucò, cit. p. 197.<br />
651 Givone scrive l'<strong>in</strong>troduzione sia alla Nascita della tragedia di Nietzsche nell'edizione Newton 1995 sia ai<br />
Dialoghi con Leucò nell'edizione E<strong>in</strong>audi 1999.<br />
178
chiama “il dis<strong>in</strong>canto del mondo” e che si lega alle nozioni di secolarizzazione 652 ,<br />
demitizzazione, razionalizzazione:<br />
Il mondo moderno ha dato a se stesso la propria legge di formazione, autoleggittimandosi, al punto che<br />
l’<strong>in</strong>negabile processo di secolarizzazione e di demitizzazione non farebbe che mettergli a disposizione<br />
materiali per il proprio mito […]. Il dis<strong>in</strong>canto del mondo, <strong>in</strong> ogni caso, è caratterizzato da <strong>def</strong><strong>in</strong>itività e<br />
irre<strong>vers</strong>ibilità, perché rappresenta la memoria storica del non più, del tratto che separa per sempre,<br />
addirittura dell'immemoriale. Come ricordare, <strong>in</strong>fatti, il tempo <strong>in</strong> cui il div<strong>in</strong>o abitava la terra e str<strong>in</strong>geva <strong>in</strong><br />
comunione uom<strong>in</strong>i e natura [...] e come dimenticare, vice<strong>vers</strong>a, quel tempo, se il costituirsi del tempo, nella<br />
terra abbandonata da Dio, implica precisamente che quella comunione è tramontata [...] 653 .<br />
Se la storia del mondo è un progressivo allontanarsi dalle orig<strong>in</strong>i, il pensiero tragico<br />
riproposto nella modernità potrebbe rappresentare un tentativo di recupero di tematiche<br />
esistenziali considerate basilari nella concezione pavesiana. Il 3 Aprile 1949, Pavese<br />
scrive:<br />
Prima di Cristo e del Logos greco, la vita era un cont<strong>in</strong>uo contatto e ricambio magico con la natura; di qui<br />
uscivano forze, determ<strong>in</strong>azioni, dest<strong>in</strong>i; a lei si tornava, ci si rigenerava. Dopo Cr. e dopo il Logos, la<br />
natura si fa staccata dalla sorgente mistica della forza e della vita (che viene ora dallo Spirito). E' pronto il<br />
campo per la scienza moderna che constata e codifica la materialità l'<strong>in</strong>differenza della natura 654 .<br />
Il pr<strong>in</strong>cipale obiettivo polemico di Pavese sembra dunque, <strong>in</strong> questo caso, l’eccesso di<br />
razionalità che impedisce all’uomo la strada della verità. Givone così <strong>def</strong><strong>in</strong>isce la verità che<br />
l’approccio tragico persegue: “Tragicamente, la verità non è che memoria di una orig<strong>in</strong>aria<br />
contraddizione [...]. Verità come contraddizione [...] <strong>in</strong>somma, se la poesia prende congedo<br />
dall’idea religiosa e metafisica della verità è per ritrovarla a un livello più orig<strong>in</strong>ario, dove la<br />
verità esibisce la sua natura orig<strong>in</strong>ariamente conflittuale e non è se non questa esibizione,<br />
questo teatro” 655 . Se lo studio sul tragico rappresenta il recupero di questa componente<br />
irrazionale dell’uomo, vista come componente conoscitiva, si potrà comprendere come e<br />
perché questi dialoghi siano estremamente moderni, nel momento <strong>in</strong> cui si pensa alla stessa<br />
<strong>def</strong><strong>in</strong>izione d’arte contemporanea che l’autore ci offre. Tratto moderno è il riconoscere<br />
all’uomo la colpa di avere spodestato l’essere al f<strong>in</strong>e di porsi al centro d’ogni discorso. Nella<br />
concezione tragica pavesiana quest’uomo si trova di fronte alla sua colpa: l’aspirare alla deità.<br />
E’ il momento <strong>in</strong> cui la legge della terra, la legge dell’essere, torna a far sentire la sua voce,<br />
violentemente, selvaggiamente, tragicamente così come aveva preconizzato Luckacs nella<br />
Metafisica della tragedia: “Mai come oggi la natura e il dest<strong>in</strong>o furono così terribilmente<br />
senz’anima, mai come oggi le anime umane percorsero <strong>in</strong> tanta solitud<strong>in</strong>e le loro strade<br />
abbandonate […]” e proprio per questo “[…] è possibile sperare <strong>in</strong> un ritorno della tragedia<br />
[…]” <strong>in</strong>fatti “[…] si sono dileguati del tutto gli <strong>in</strong>certi fantasmi di un ord<strong>in</strong>e di comodo, che la<br />
viltà dei nostri sogni ha proiettato sulla natura per crearsi un’illusione di sicurezza” 656 .<br />
Il recupero di un pensiero tragico <strong>in</strong> epoca moderna non è, d’altra parte, un fenomeno<br />
isolato e riveste una notevole importanza nell’ambito della letteratura del Novecento.<br />
Considerando la ricerca e l’<strong>in</strong>teresse di Pavese, si potrebbe mettere <strong>in</strong> correlazione tale<br />
recupero con il dibattito sul nichilismo che fu d’attualità <strong>in</strong> Europa tra la f<strong>in</strong>e<br />
dell’Ottocento e la prima metà del Novecento. La relazione che s’<strong>in</strong>staura tra questo<br />
652 S. Givone, Dis<strong>in</strong>canto del mondo e pensiero tragico, cit., p.126: “secolarizzazione significa anzitutto<br />
rimozione […] delle cose nascoste dalla fondazione del mondo.”<br />
653 Ivi, p. 4.<br />
654 C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, 3 Aprile 1949, cit. p. 367.<br />
655 S. Givone, Dis<strong>in</strong>canto del mondo e pensiero tragico, cit. p. 17.<br />
656 Ivi, p. 7.<br />
179
fenomeno e la tragedia è ben analizzata da Givone che argomenta come il pensiero<br />
tragico restituisca al mondo quel senso che il nichilismo gli sottrae. Questo avviene<br />
attra<strong>vers</strong>o l’esposizione al nulla che circonda, nonostante si tenti di rimuoverlo, la nostra<br />
esistenza. Il senso del tragico scaturisce dalle scoperte effettuate ponendo l’essere al<br />
cospetto del non essere, il tutto a cospetto del nulla. Si potrebbe addirittura arrivare ad<br />
ipotizzare, a tal riguardo, che gli stessi greci abbiano espresso la tragedia ma non un vero<br />
e proprio pensiero tragico 657 . In questo senso è senz’altro da sottol<strong>in</strong>eare l’orig<strong>in</strong>alità di<br />
quegli scrittori contemporanei, come Pavese, che hanno saputo ricontestualizzare e<br />
rielaborare nella modernità i dettami dell’arte classica della tragedia ponendosi<br />
problematicamente di fronte all’opposizione mithos-logos che genera la poesia tragica:<br />
[...] nella tragedia il mito fa del logos la sua controfigura concettuale: vero e proprio sosia resosi<br />
<strong>in</strong>dipendente, il logos si volge contro il mito, lo mette alla prova, lo usa strumentalmente, predispone così<br />
quel processo di razionalizzazione che è antimitico, antitragico, e che dal mondo della tragedia greca si<br />
proietta sulla modernità. Ma ciò non toglie che questo processo, al suo culm<strong>in</strong>e, appaia dest<strong>in</strong>ato a<br />
<strong>in</strong>vertirsi. Infatti quando il mito è stato assorbito dal logos senza residuo -il che accade nel mondo<br />
moderno- al logos non resta che svelare la sua provenienza, anzi, la sua essenza mitica. E' appunto<br />
razionalizzandosi all'estremo, è codificandosi <strong>in</strong> una s<strong>in</strong>tassi perfettamente omologa all'ord<strong>in</strong>e "metafisico"<br />
e "teoretico", benché "<strong>in</strong>gannevole" dei significati, è imponendosi come la struttura stessa del reale, nella<br />
sua perfetta artificiosità, che il logos, cioè il l<strong>in</strong>guaggio, si affaccia <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e sul suo vuoto e si mostra come<br />
una ragnatela non fondata su nulla o non fondata che sulla f<strong>in</strong>zione della corrispondenza di nomi e cose 658 .<br />
Se Dioniso è il dio che danza tra l’essere e il non essere, il poeta tragico è colui che<br />
<strong>in</strong>daga questa sovrapposizione cont<strong>in</strong>ua di dimensioni, colui il quale si pone <strong>in</strong><br />
cont<strong>in</strong>uazione l’enigma del nulla lasciandolo irrompere fra le sue pag<strong>in</strong>e. In questo senso<br />
l’operazione tragica moderna diviene <strong>in</strong>teressante poiché risposta all’<strong>in</strong>terdetto<br />
occidentale di pensare il nulla, di considerarlo come problema (da Parmenide <strong>in</strong> poi), e di<br />
rimuoverlo o sostituirlo con idee alternative (Dio per esempio). Pavese riscopre il mondo<br />
del paganesimo e dei riti ancestrali e barbarici per amore di quelle civiltà che, come<br />
attesta Nietzsche, erano <strong>in</strong> grado di rimanere fedeli al f<strong>in</strong>ito e sapevano riconoscere il loro<br />
limite più proprio nella morte. Pavese riscopre il mito di Dioniso come mito di sofferenza<br />
che solo un’arte tragica è <strong>in</strong> grado di esprimere. E’ la sperimentazione della<br />
contraddizione che la logica socratica, attaccata <strong>in</strong> questo senso da Nietzsche, tentava di<br />
superare. La contraddizione è altresì <strong>in</strong>sanabile e l’agone tragico è il luogo deputato a tale<br />
discernimento.<br />
Il tragico trae le sue orig<strong>in</strong>i dal culto <strong>in</strong> onore di Dioniso ma solo apparentemente rimane<br />
<strong>in</strong>dissolubilmente legato a schemi classici, così come ipotizza Ste<strong>in</strong>er nella Morte della<br />
Tragedia. Se proprio non si può parlare di r<strong>in</strong>ascita delle forme classiche della tragedia si<br />
può senz’altro ipotizzare l’evoluzione di un pensiero tragico che trova piena applicazione<br />
nella modernità nel momento <strong>in</strong> cui il suo svolgimento provoca, nel mondo della fissità e<br />
dell’<strong>in</strong>dividualità, uno “stupore” che così si manifesta nella <strong>def</strong><strong>in</strong>izione niciana: “il<br />
terreno vacilla, così come la fede nell’<strong>in</strong>dissolubilità e nella fissità dell’<strong>in</strong>dividuo” 659 . E’<br />
un pr<strong>in</strong>cipio, quanto mai attuale, per cui l’<strong>in</strong>dividuo mette <strong>in</strong> gioco se stesso ponendosi di<br />
fronte alle possibilità dell’essere e del non essere. La riproposizione dei motivi tragici<br />
avviene <strong>in</strong> Pavese <strong>in</strong> maniera del tutto orig<strong>in</strong>ale e s<strong>in</strong>tetizza molte delle istanze culturali<br />
di quel periodo tanto che Eugenio Cors<strong>in</strong>i può, a giusta ragione, parlare di un<br />
657 Così Givone <strong>def</strong><strong>in</strong>isce il pensiero tragico: “Pensiero che non eluda la contraddizione, ma, <strong>in</strong> qualche modo la<br />
faccia sua e rifluisca <strong>in</strong> essa, pensiero dell'ambiguità e dell'ambivalenza, pensiero <strong>in</strong>sieme dialettico e antidialettico.<br />
Pensiero distruttivo del mito e solidale con esso, pensiero doppio, pensiero tragico”. Ibidem.<br />
658 Ivi, p. 95.<br />
659 S. Givone, Introduzione alla Nascita della tragedia, cit. p.22.<br />
180
“classicismo <strong>in</strong>quieto e torbido [...] erede delle varie esperienze classicistiche del<br />
decadentismo” 660 .<br />
660 E. Cors<strong>in</strong>i, Orfeo senza Euridice: i Dialoghi con Leucò e il classicismo di Pavese, cit. pp- 206-14.<br />
181
Bibliografia critica<br />
Studi di carattere generale<br />
Vittoria Borsò, Temporalità e alterità. Il nuovo rapporto tra uomo e natura nella poesia<br />
moderna, contenuto <strong>in</strong> D. Conte, E. Mazzarella, Il concetto di tipo tra ottocento e Novecento.<br />
Letteratura, filosofia, scienze umane, Napoli, Liguori, 2001.<br />
Eugenio Turri, Lo spazio europeo: alla ricerca di una geografia mitica, contenuto <strong>in</strong> Carlo<br />
Ossola, Europa: miti di identità, Saggi Marsilio, Venezia, 2001.<br />
P<strong>in</strong>o Fasano, Il ritorno della critica tematica, contenuto <strong>in</strong> L’umana compagnia, Studi <strong>in</strong><br />
onore di Gennaro Bavarese, a cura di Rosanna Alhoique Pett<strong>in</strong>elli, Bulzoni editore, Roma,<br />
1999.<br />
P<strong>in</strong>o Fasano, Letteratura e Viaggio, Editori Laterza, Bari, 1999.<br />
Gnisci, S<strong>in</strong>opoli, Trocchi, Pant<strong>in</strong>i, Nucera, Guglielmi, Moll, Neri, Galeri, Introduzione alla<br />
letteratura comparata, a cura di Armando Gnisci, Edizioni Bruno Mondatori, Milano, 1999.<br />
Mart<strong>in</strong> Tra<strong>vers</strong>, An <strong>in</strong>troduction to modern European Literature-from Romanticism to<br />
Postmodernism, Macmillan Press LTD, London, 1998.<br />
Guido Guglielmi, La prosa Italiana del Novecento, tra romanzo e racconto, Piccola<br />
Biblioteca E<strong>in</strong>audi, Tor<strong>in</strong>o, 1998.<br />
Franco Moretti, Atlante del Romanzo Europeo, E<strong>in</strong>audi, Tor<strong>in</strong>o, 1997.<br />
Umberto Galimberti, Heidegger, Jaspers e il tramonto dell’Occidente, Il Saggiatore, Milano,<br />
1996.<br />
Francesco Orlando, Costanti tematiche, varianti estetiche e precedenti storici, contenuto <strong>in</strong><br />
Mario Praz, La carne, la morte e il diavolo, Sansoni, Milano, 1996.<br />
Fernanda Pivano, La balena bianca ed altri miti, Il Saggiatore, Milano, 1995.<br />
B.Magnus, S.Stewart, J.P. Mileur, Nietzsche’s Case, Philosophy as/and Literature,<br />
Routledge, New York-London, 1993.<br />
Werner Sollors, The return of thematic criticism, Harvard Uni<strong>vers</strong>ity Press, Cambridge,<br />
Massachussets, London, England, 1993.<br />
Antonella Riem Natale, La gabbia <strong>in</strong>naturale: l’opera di Bruce Chatw<strong>in</strong>, Campanotto, Ud<strong>in</strong>e,<br />
1993.<br />
Jeffrey T. Shapp, Epic demonstrations: Fascist Modernity and the 1931 Exhibition of the<br />
Fascist Revolution, <strong>in</strong> Richard Golsan, Fascism, Aesthetics and Culture, New England Press,<br />
Hanover, NH 1992.<br />
Richard Golsan, Fascism, Aesthetics and Culture, New England Press, Hanover, NH 1992.<br />
Eric J. Leed, La mente del viaggiatore, Il Mul<strong>in</strong>o, Bologna, 1991.<br />
A.Giard<strong>in</strong>a, G. Sabbatucci, V. Vidotto, L’età contemporanea, Editori Laterza, Bari, 1990.<br />
Robert Hampson, Frazer and Conrad, contenuto <strong>in</strong> Robert Fraser, Sir James Frazer and the<br />
literary imag<strong>in</strong>ation, essays <strong>in</strong> aff<strong>in</strong>ity and <strong>in</strong>fluence, Macmillian, London, 1990.<br />
Ulrich Simon, Pity and terror: christianity and tragedy, MacMillan, Uk, 1989.<br />
Gian Luigi Beccaria, Le forme della lontananza, Garzanti, Milano, 1989.<br />
Sergio Givone, Dis<strong>in</strong>canto del mondo e pensiero tragico, Il saggiatore, Milano, 1988.<br />
H.R.Jauss, Estetica della ricezione, Guida, Napoli, 1988.<br />
Harvey Birenbaum, Tragedy and <strong>in</strong>nocence, Uni<strong>vers</strong>ity press of America, Wash<strong>in</strong>gton<br />
D.C.,1983.<br />
Franco Moretti, Segni e stili del Moderno, Giulio E<strong>in</strong>audi Editore, Tor<strong>in</strong>o,1987.<br />
Jurij Lotman, La Semiosfera, Marsilio Editore, Venezia, 1985.<br />
Gregory Lucente, The narrative of realism and Myth. Verga, Lawrence, Faulkner, Pavese.<br />
The John Hopk<strong>in</strong>s Uni<strong>vers</strong>ity Press, Baltimore and London, 1981.<br />
182
Giorgio Barberi Squarotti, Le sorti del tragico. Il novecento italiano: romanzo e teatro, Longo<br />
Editore, Ravenna,1978.<br />
Adrian Lyttelton, Italian Fascisms, Cape, London, 1973.<br />
John B. Vickery, The literary Impact of The Golden Bough, Pr<strong>in</strong>ceton Uni<strong>vers</strong>ity Press, 1973.<br />
Peter L. Thorslev Jr. The wild man revenge, <strong>in</strong> Dudley, Edward og Maximillian E. Novak:<br />
The Wild Man With<strong>in</strong> - An Image <strong>in</strong> Western Thought From Renaissance to Romanticism.<br />
Uni<strong>vers</strong>ity of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 1972.<br />
Sergio Landucci, I filosofi e i selvaggi, 1580-1780, Laterza, Bari, 1972.<br />
Giorgio Barberi Squarotti, Il tragico nel mondo borghese, Giappichelli Editore,Tor<strong>in</strong>o, 1974.<br />
Michael Bell, Primitivism, Cox & Wyman Ltd, Fakenham, Norfolk, 1972.<br />
Giovanni Cillo, La distruzione dei miti, Nuovedizioni E.Vallecchi, Firenze,1972.<br />
Giuseppe Cocchiara, L’eterno selvaggio, S.F. Flaccovio Editore- Palermo, 1972.<br />
Frank Kermode, Il senso della f<strong>in</strong>e, studi sulla teoria del romanzo, Rizzoli, Milano, 1972.<br />
Furio Jesi, Letteratura e mito, E<strong>in</strong>audi, Tor<strong>in</strong>o, 1968.<br />
Paul Tillich, The mean<strong>in</strong>g of mean<strong>in</strong>glessness, contenuto <strong>in</strong> The modern Tradition<br />
backgrounds of modern literature, edito da Richard Ellmann and Charles Feidelson jr.,<br />
Oxford Uni<strong>vers</strong>ity Press, 1965.<br />
Marziano Guglielm<strong>in</strong>etti, Struttura e s<strong>in</strong>tassi, Silva Editore, Parma, 1964.<br />
George Ste<strong>in</strong>er, The death of tragedy, The Faber Library London, Great Brita<strong>in</strong>, 1961.<br />
Erich Auerbach, Vico and Aesthetic Historism, tratto da Scenes from the drama of European<br />
literature (1959), Meridian Books, USA, 1973.<br />
Benedetto Croce, Perchè non possiamo non dirci cristiani (1945), <strong>in</strong> Discorsi di filosofia, vol<br />
I, Laterza, Bari, 1959.<br />
Mario Unterste<strong>in</strong>er, Le orig<strong>in</strong>i della tragedia, Fratelli Bocca Editore, Milano, 1942.<br />
Walter Benjam<strong>in</strong>, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica (1936), E<strong>in</strong>audi,<br />
Tor<strong>in</strong>o, 1991.<br />
Mario Praz, La carne, la morte e il diavolo (1930), Sansoni, Milano, 1996.<br />
Studi sul modernismo<br />
D. Ellison, Ethics and Aesthetics <strong>in</strong> European Modernist Literature, Cambridge Uni<strong>vers</strong>ity<br />
Press, 2001.<br />
Peter Nicholls, La forma e le scritture, Una lettura critica del modernismo, Armando Editore,<br />
Roma, 2000.<br />
M.Bell and P.Poellner, Myth and the mak<strong>in</strong>g of modernity. The problem of ground<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Early<br />
Twentieth Century Literature, Rodopi, Amsterdam-Atlanta, GA, 1998.<br />
V.Kolocotroni, J.Goldman, O. Toxidov, Modernism, an anthology of sources and documents,<br />
Edimburgh Uni<strong>vers</strong>ity Press, 1998.<br />
Michael Bell, Literature, modernism and myth, belief and responsibility <strong>in</strong> the twentieth<br />
century, Cambridge Uni<strong>vers</strong>ity Press, Cambridge, 1997.<br />
Ra<strong>in</strong>er Emig, Modernism <strong>in</strong> Poetry, Motivations, Structures and Limits, Longman, London<br />
and New York, 1995.<br />
John Mc Govern, Like water <strong>in</strong> water, primitivism and modernity, contenuto <strong>in</strong> Michael Bell,<br />
D.H. Lawrence: language and be<strong>in</strong>g, Cambridge Uni<strong>vers</strong>ity Press, 1992.<br />
Franz Kuna, The Janus Faced Novel: Conrad, Musil, Kafka, Mann, contenuto <strong>in</strong> Modernism a<br />
guide to european literature 1890-1930, edito da M. Bradbury and J. Mc Farlane, Pengu<strong>in</strong><br />
Books, London, 1991.<br />
183
David Lodge, The language of modernist fiction: Metaphor and Metonimy, contenuto <strong>in</strong><br />
Modernism, a guide to European Literature 1890-1930, edito da M.Broadbury and J.<br />
McFarlane, Pengu<strong>in</strong> Books, 1991.<br />
Richard Sheppard, The Crisis of language, contenuto <strong>in</strong> Modernism, a guide to European<br />
Literature 1890-1930, edited by M.Broadbury and J. McFarlane, Pengu<strong>in</strong> Books, 1991.<br />
John Burt Foster Jr., Heir to Dionysus, a Nietzschian <strong>in</strong> Literary Modernism, Pr<strong>in</strong>ceton<br />
Uni<strong>vers</strong>ity Press, 1988.<br />
The English Modernist Reader 1910-1930, edito da Peter Faulkner, Uni<strong>vers</strong>ity of Ioawa<br />
Press, Ioawa City, 1986.<br />
Studi su Pavese<br />
Elio Gioanola, Cesare Pavese, la realtà, l’altrove, il silenzio, Jaca Book, Milano, 2003.<br />
Denis Ferraris, Lo “sguardo alla f<strong>in</strong>estra” e il “laborioso caos”: sulla modernità narrativa di<br />
Cesare Pavese, <strong>in</strong> Centre de recherches italiennes, Narrativa, a cura di Marie-Helene Caspar,<br />
Uni<strong>vers</strong>itè Paris X – Nanterre, n° 22, Janvier 2002.<br />
Centre de recherches italiennes, Narrativa, a cura di Marie-Helene Caspar, Uni<strong>vers</strong>itè Paris X<br />
– Nanterre, n° 22, Janvier 2002.<br />
Roberto Gigliucci, Cesare Pavese, Bruno Mondatori, Milano, 2001.<br />
B. Van Den Bossche, Nulla è veramente accaduto strategie discorsive del mito e dell'opera di<br />
Cesare Pavese, Leuven Uni<strong>vers</strong>ity Press e Franco Cesati Editore, 2001.<br />
Sergio Pautasso, Cesare Pavese oltre il mito, Marietti 1820, Genova, 2000.<br />
Marziano Guglielm<strong>in</strong>etti, Cesare Pavese romanziere, contenuto <strong>in</strong> Cesare Pavese, Tutti i<br />
romanzi, E<strong>in</strong>audi, Tor<strong>in</strong>o, 2000.<br />
Sergio Givone, Introduzione ai Dialoghi con Leucò, contenuto <strong>in</strong> Cesare Pavese, Dialoghi<br />
con Leucò (1947), E<strong>in</strong>audi, Tor<strong>in</strong>o, 1999.<br />
Valerio Cristiano Ferme, Cesare Pavese's and Elio Vittor<strong>in</strong>i's translations from American<br />
literature: The Americanization of aesthetics and the sub<strong>vers</strong>ion of culture under the Fascist<br />
regime (Italy), Uni<strong>vers</strong>ity of California, Berkeley, 1998.<br />
Gilberto F<strong>in</strong>zi, Come leggere la Luna e i Falò di Cesare Pavese, Mursia, Milano, 1996.<br />
Fabio Pierangeli, Pavese e i suoi miti toccati dal dest<strong>in</strong>o, Tirrenia Stampatori, Tor<strong>in</strong>o, 1995.<br />
Centro studi di letteratura italiana <strong>in</strong> Piemonte “Guido Gozzano”, Uni<strong>vers</strong>ità di Tor<strong>in</strong>o,<br />
Giornate Pavesiane, Tor<strong>in</strong>o 14 Febbraio 15 Marzo 1987, vol.11 a cura di Mariarosa Masoero,<br />
Leo S. Olschki-Firenze, 1992.<br />
Maria de las Nives Muniz Muniz, Introduzione a Pavese, Editori Laterza, Bari, 1992.<br />
Maria de las Nives Muniz Muniz, Poetiche della temporalità(Manzoni, Leopardi, Verga,<br />
Pavese), Palumbo, Palermo, 1990.<br />
Michela Rusi, Il tempo-dolore, per una fenomenologia della percezione temporale <strong>in</strong> Cesare<br />
Pavese, Francisci editore, 1985.<br />
Bruno Basile, La f<strong>in</strong>estra socchiusa. Ricerche tematiche su Dostoevskij, Kafka, Moravia e<br />
Pavese, Patron Editore, Bologna, 1982.<br />
Anton<strong>in</strong>o Musumeci, L’impossibile ritorno, La fisiologia del mito <strong>in</strong> Cesare Pavese, Il<br />
Portico Longo editore, Ravenna, 1980.<br />
Mauro Ponzi, La critica e Pavese, Cappelli Editore, Bologna, 1977.<br />
Maria Stella, Cesare Pavese traduttore, Bulzoni Editore, Roma, 1977.<br />
Anco Marzio Mutterle, L'immag<strong>in</strong>e arguta. L<strong>in</strong>gua stile retorica di Pavese, E<strong>in</strong>audi, Tor<strong>in</strong>o,<br />
1977.<br />
Edw<strong>in</strong> Fussel, Forward to: Cesare Pavese, American Literature Essays and op<strong>in</strong>ions,<br />
Uni<strong>vers</strong>ity of California Press, Los Angeles-London, 1970.<br />
184
Vittorio Stella, L’elegia tragica di Cesare Pavese, Edizioni Longo, Ravenna, 1969.<br />
Gian Paolo Bias<strong>in</strong>, The smile of the gods, a thematic study of Cesare Pavese works, Cornell<br />
Uni<strong>vers</strong>ity Press, Ithaca, New York, 1968.<br />
Eugenio Cors<strong>in</strong>i, Orfeo senza Euridice: i Dialoghi con Leucò e il classicismo di Pavese, <strong>in</strong><br />
Sigma, 3-4, 1964, pp.121-46.<br />
Studi su Lawrence<br />
Fiona Becket, The complete guide to D. H. Lawrence, Routledge, London and New York,<br />
2002.<br />
Walter Mauro, prefazione a D. H. Lawrence, Il serpente piumato, Roma, Newton Compton<br />
Editore, 1995.<br />
Michael Bell, D.H. Lawrence: language and be<strong>in</strong>g, Cambridge Uni<strong>vers</strong>ity Press, 1992.<br />
Carol Sklenicka, D. H. Lawrence and the child, Uni<strong>vers</strong>ity of Missouri press, Columbia and<br />
London, 1991.<br />
Frank Kermode, Foreword to Peter Fjagesund, The Apocaliptic World of D. H. Lawrence,<br />
Norvegian Uni<strong>vers</strong>ity Press, 1991.<br />
Peter Fjagesund, The Apocaliptic World of D. H. Lawrence, Norvegian Uni<strong>vers</strong>ity Press,<br />
1991.<br />
Col<strong>in</strong> Milton, Lawrence and Nietzsche a study <strong>in</strong> <strong>in</strong>fluence, Aberdeen Uni<strong>vers</strong>ity Press,<br />
Aberdeen, 1987.<br />
Harold Bloom, Modern Critical Views, D. H. Lawrence, Chelsea House Publishers, New<br />
York – Philadelphia, 1986.<br />
Frank Kermode, Apocalyptic Types, contenuto <strong>in</strong> D. H. Lawrence, Modern Critical Views,<br />
Chelsea House Publishers, New York – Philadelphia, 1986.<br />
Ross C. Murf<strong>in</strong>, The poetry of D.H. Lawrence, Uni<strong>vers</strong>ity of Nebraska Press, L<strong>in</strong>coln and<br />
London, 1983.<br />
Fernando Ferrara, Romanzo e profezia. L’amante di Lady Chatterley di D.H. Lawrence come<br />
mito e come predicazione, Roma, Offic<strong>in</strong>a, 1982.<br />
Frank Kermode, Lawrence, Bungag, Suffolk, 1973.<br />
Julian Moynahan, Sons and lo<strong>vers</strong>… criticism, New York, 1972.<br />
David Cavitch, D.H.Lawrence and the new World, New York Uni<strong>vers</strong>ity Press, New York,<br />
1969.<br />
Eugene Goodhearth, The utopian vision of D.H. Lawrence, Chicago, 1963.<br />
Lawrence Frieda, Not I, But the W<strong>in</strong>d, Santa Fè, New Mexico, 1934.<br />
Cather<strong>in</strong>e Carnswell, The savage pilgrimage, London, 1932.<br />
Testi<br />
Narratori<br />
Cesare Pavese, Tutti i romanzi, a cura di Marziano Guglielm<strong>in</strong>etti, E<strong>in</strong>audi, Tor<strong>in</strong>o, 2000.<br />
185
Cesare Pavese, Racconti, E<strong>in</strong>audi, Tor<strong>in</strong>o, 1994.<br />
Cesare Pavese, Lettere 1926-1950, a cura di Lorenzo Mondo e Italo Calv<strong>in</strong>o, E<strong>in</strong>audi, Tor<strong>in</strong>o,<br />
1982.<br />
Cesare Pavese, La letteratura americana e altri saggi, Giulio E<strong>in</strong>audi Editore, Tor<strong>in</strong>o, 1951.<br />
Cesare Pavese, Il Mestiere di Vivere. Diario 1935-1950, E<strong>in</strong>audi, Tor<strong>in</strong>o, 2000.<br />
Cesare Pavese, La luna e i falò (1950), E<strong>in</strong>audi, Tor<strong>in</strong>o, 1999.<br />
Cesare Pavese, La bella estate: La bella estate (1940), Il diavolo sulle coll<strong>in</strong>e (1948), Tra<br />
donne sole (1949), E<strong>in</strong>audi, Tor<strong>in</strong>o, 1949.<br />
Cesare Pavese, La casa <strong>in</strong> coll<strong>in</strong>a (1948), E<strong>in</strong>audi, Tor<strong>in</strong>o, 1990.<br />
Cesare Pavese, Feria d’Agosto (1945), E<strong>in</strong>audi, Roma, 1946.<br />
Cesare Pavese, Lavorare stanca (1943), E<strong>in</strong>audi, Roma, 1982.<br />
Cesare Pavese, Paesi Tuoi (1941), E<strong>in</strong>audi, Tor<strong>in</strong>o, 1992.<br />
D.H. Lawrence, Tutti i racconti e i romanzi brevi, Newton Compton Editore, Roma, 1995.<br />
D.H. Lawrence, Selected literary criticism, edito da Anthony Beal, He<strong>in</strong>emann, London,<br />
1978.<br />
D.H. Lawrence, D.H.Lawrence, The symbolic Mean<strong>in</strong>g, the uncollected <strong>vers</strong>ions of studies <strong>in</strong><br />
Classic American Literature, edite da Arm<strong>in</strong> Arnold, Centaur Press Limited, London, 1962.<br />
D.H. Lawrence, Studies <strong>in</strong> Classic American Literature, contenuto <strong>in</strong> Fiona Beckett, The<br />
complete guide to D. H. Lawrence, Routledge, London and New York, 2002.<br />
D.H. Lawrence, The Collected Letters of D.H. Lawrence, edite da Harry T. Moore, Vik<strong>in</strong>g<br />
Press, New York, 1962.<br />
D.H.Lawrence, Phoenix: The posthumous papers of D.H. Lawrence, ed. Edward D. Mc<br />
Donald, New York, 1936.<br />
D.H. Lawrence, L’amante di Lady Chatterley (1928), Istituto Geografico De Agost<strong>in</strong>i,<br />
Milano, 1985.<br />
D.H. Lawrence, Pan <strong>in</strong> America (1926), contenuto <strong>in</strong> The modern Tradition backgrounds of<br />
modern literature, edito da Richard Ellmann and Charles Feidelson jr., Oxford Uni<strong>vers</strong>ity<br />
Press, 1965.<br />
D.H. Lawrence, The plumed Serpent (1926), Cambridge Uni<strong>vers</strong>ity Press, Cambidge, 1987,<br />
D.H. Lawrence, Il serpente piumato (1926), Newton Compton Editore, Roma, 1995.<br />
D.H. Lawrence, Surgery of the novel – or a bomb? (1923), pubblicato <strong>in</strong> The Reader’s Digest<br />
International Book Review April 1923, contenuto <strong>in</strong> The English Modernist Reader 1910-<br />
1930, edito da Peter Faulkner, Uni<strong>vers</strong>ity of Ioawa Press, Ioawa City, 1986.<br />
D.H. Lawrence, Birds, beast and Flowers (1923), contenuto <strong>in</strong> Fiona Beckett, The complete<br />
guide to D. H. Lawrence, Routledge, London and New York, 2002.<br />
D.H. Lawrence, Fantasia dell’<strong>in</strong>conscio (1922) e Psicoanalisi dell’<strong>in</strong>conscio (1921), Newton<br />
Compton Editori, Roma, 1995.<br />
D.H. Lawrence, New Poems (1920), contenuto <strong>in</strong> The English modernist reader 1910 – 1930,<br />
edited by Peter Faulkner, Ioawa City, Uni<strong>vers</strong>ity of Ioawa Press, 1986.<br />
D.H. Lawrence, Sons and Lo<strong>vers</strong> (1913), Pengu<strong>in</strong> Books, London, 1966.<br />
Joseph Conrad, La l<strong>in</strong>ea d’ombra (1917), Newton Compton Editori, Roma, 1997.<br />
Joseph Conrad, Cuore di tenebra (1899), Edisco editrice, Tor<strong>in</strong>o, 1994.<br />
Joseph Conrad, Preface to The Nigger of Narcissus (1897), contenuto <strong>in</strong> Modernism, an<br />
anthology of sources and documents, edito da V. Kolocotrami, J.Goldman, O. Toxidov,<br />
Edimburgh, Uni<strong>vers</strong>ity Press, 1998.<br />
Joseph Conrad, La follia di Almayer (1895), Bompiani, Milano 1994.<br />
Filosofia-etnologia<br />
186
James G. Frazer, The scope and Method of Mental Anthropology (1921), contenuto <strong>in</strong> The<br />
modern Tradition backgrounds of modern literature, edito da Richard Ellmann and Charles<br />
Feidelson jr., Oxford Uni<strong>vers</strong>ity Press, 1965.<br />
James G. Frazer, Il ramo d’oro (1890-1915), Newton Compton Editori, Roma, 1992.<br />
Friederich Nietzsche, Opere di Friedrich Nietzsche, edizione critica a cura di G. Colli e M.<br />
Mont<strong>in</strong>ari, Adelphi, Milano, 1964.<br />
Friederich Nietzsche, Così parlò Zarathustra (1885), Newton Compton Editori, Roma, 1980.<br />
Friederich Nietzsche, Considerazioni <strong>in</strong>attuali (1876), Newton Compton Editori, Roma, 1993.<br />
Friederich Nietzsche, La nascita della tragedia (1872), Newton Compton Editori, Roma,<br />
1991.<br />
Charles Darw<strong>in</strong>, The descent of the man (1871), contenuto <strong>in</strong> The modern tradition<br />
backgrounds of modern literature, edito da Richard Ellmann and Charles Feidelson jr.,<br />
Oxford Uni<strong>vers</strong>ity Press, 1965.<br />
Friederich Nietzsche, Verità e menzogna (1870), Newton Compton Editori, Roma, 1991.<br />
187