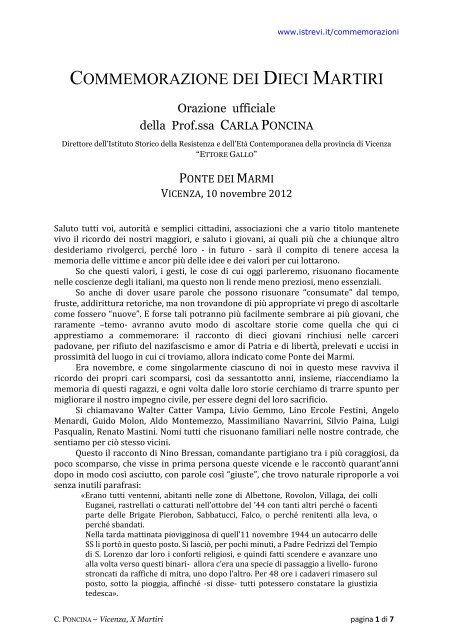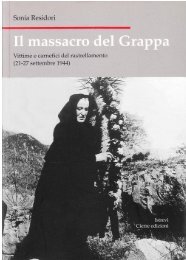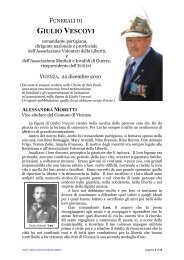Discorso tenuto dalla prof.a Carla Poncina, Direttore dell'ISTREVI ...
Discorso tenuto dalla prof.a Carla Poncina, Direttore dell'ISTREVI ...
Discorso tenuto dalla prof.a Carla Poncina, Direttore dell'ISTREVI ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
www.istrevi.it/commemorazioni<br />
COMMEMORAZIONE DEI DIECI MARTIRI<br />
Orazione ufficiale<br />
della Prof.ssa CARLA PONCINA<br />
<strong>Direttore</strong> dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea della provincia di Vicenza<br />
“ETTORE GALLO”<br />
PONTE DEI MARMI<br />
VICENZA, 10 novembre 2012<br />
Saluto tutti voi, autorità e semplici cittadini, associazioni che a vario titolo mantenete<br />
vivo il ricordo dei nostri maggiori, e saluto i giovani, ai quali più che a chiunque altro<br />
desideriamo rivolgerci, perché loro - in futuro - sarà il compito di tenere accesa la<br />
memoria delle vittime e ancor più delle idee e dei valori per cui lottarono.<br />
So che questi valori, i gesti, le cose di cui oggi parleremo, risuonano fiocamente<br />
nelle coscienze degli italiani, ma questo non li rende meno preziosi, meno essenziali.<br />
So anche di dover usare parole che possono risuonare “consumate” dal tempo,<br />
fruste, addirittura retoriche, ma non trovandone di più appropriate vi prego di ascoltarle<br />
come fossero “nuove”. E forse tali potranno più facilmente sembrare ai più giovani, che<br />
raramente –temo- avranno avuto modo di ascoltare storie come quella che qui ci<br />
apprestiamo a commemorare: il racconto di dieci giovani rinchiusi nelle carceri<br />
padovane, per rifiuto del nazifascismo e amor di Patria e di libertà, prelevati e uccisi in<br />
prossimità del luogo in cui ci troviamo, allora indicato come Ponte dei Marmi.<br />
Era novembre, e come singolarmente ciascuno di noi in questo mese ravviva il<br />
ricordo dei propri cari scomparsi, così da sessantotto anni, insieme, riaccendiamo la<br />
memoria di questi ragazzi, e ogni volta dalle loro storie cerchiamo di trarre spunto per<br />
migliorare il nostro impegno civile, per essere degni del loro sacrificio.<br />
Si chiamavano Walter Catter Vampa, Livio Gemmo, Lino Ercole Festini, Angelo<br />
Menardi, Guido Molon, Aldo Montemezzo, Massimiliano Navarrini, Silvio Paina, Luigi<br />
Pasqualin, Renato Mastini. Nomi tutti che risuonano familiari nelle nostre contrade, che<br />
sentiamo per ciò stesso vicini.<br />
Questo il racconto di Nino Bressan, comandante partigiano tra i più coraggiosi, da<br />
poco scomparso, che visse in prima persona queste vicende e le raccontò quarant’anni<br />
dopo in modo così asciutto, con parole così “giuste”, che trovo naturale riproporle a voi<br />
senza inutili parafrasi:<br />
«Erano tutti ventenni, abitanti nelle zone di Albettone, Rovolon, Villaga, dei colli<br />
Euganei, rastrellati o catturati nell’ottobre del ’44 con tanti altri perché o facenti<br />
parte delle Brigate Pierobon, Sabbatucci, Falco, o perché renitenti alla leva, o<br />
perché sbandati.<br />
Nella tarda mattinata piovigginosa di quell’11 novembre 1944 un autocarro delle<br />
SS li portò in questo posto. Si lasciò, per pochi minuti, a Padre Fedrizzi del Tempio<br />
di S. Lorenzo dar loro i conforti religiosi, e quindi fatti scendere e avanzare uno<br />
alla volta verso questi binari- allora c’era una specie di passaggio a livello- furono<br />
stroncati da raffiche di mitra, uno dopo l’altro. Per 48 ore i cadaveri rimasero sul<br />
posto, sotto la pioggia, affinché -si disse- tutti potessero constatare la giustizia<br />
tedesca».<br />
C. PONCINA – Vicenza, X Martiri pagina 1 di 7
www.istrevi.it/commemorazioni<br />
Due giorni sotto la pioggia, impedendo ai familiari di avvicinarsi per rendere loro le cure<br />
pietose che la circostanza richiedeva.<br />
Questa crudeltà nasceva da una scelta precisa dei nazisti e dei loro servizievoli<br />
amici fascisti: si cercava in questo modo di terrorizzare i partigiani, ma ancor più la<br />
popolazione civile, mettendola – per paura – contro i resistenti.<br />
In realtà la disumanità degli occupanti non fece che accrescere l’ostilità della<br />
popolazione nei confronti loro e di chi li sosteneva, i fascisti locali.<br />
Questo atteggiamento feroce risulta antitetico a quello di chi li combatteva non per<br />
amore della guerra e della violenza, ma per rispetto dell’uomo e della sua calpestata<br />
dignità. I canti partigiani nati in quegli anni ne sono testimonianza, tanto diversi da<br />
quelli grotteschi e cupi dei fascisti. Sono canti ingenui, senza pretese, eppure capaci di<br />
esprimere sentimenti veri:<br />
“Avevamo vent’anni e oltre il ponte,<br />
oltre il ponte ch’è in mano nemica, vedevam l’altra riva, la vita,<br />
tutto il bene del mondo oltre il ponte.<br />
La speranza era nostra compagna…<br />
Scalzi e laceri eppure felici”<br />
E più avanti:<br />
Vedevamo a portata di mano,<br />
Oltre il ponte, il cespuglio, il canneto,<br />
L’avvenire di un giorno più umano,<br />
E più giusto, più libero, lieto.<br />
Non è grande poesia 1 , ne siamo consapevoli, ma quando ho ascoltato questa canzone ho<br />
pensato che certo, quei versi erano stati scritti anche per loro, per questi dieci ragazzi<br />
fucilati al Ponte dei Marmi.<br />
Vorrei sottolineare con forza questo tema della differenza d’animo direi, prima<br />
ancora che politico-ideologica, tra partigiani e fascisti, visto che soprattutto in<br />
quest’ultimo, triste ventennio, si è fatto il possibile per confondere e mistificare I termini<br />
del feroce conflitto che contrappose i combattenti per la libertà e i fascisti, volonterosi<br />
alleati degli occupanti tedeschi. Lo si è presentato, nella migliore delle ipotesi, come una<br />
guerra tra opposte fazioni, entrambe ugualmente “rispettabili”. Nella peggiore -e la cosa<br />
mi indigna <strong>prof</strong>ondamente- parlando dei partigiani come di volgari ladri e assassini, e<br />
delle camicie nere e dei loro compari come di leali alleati dei tedeschi e sinceri patrioti.<br />
«Ci hanno chiamati fuorilegge, venduti al nemico. Nessuna offesa ci é stata<br />
risparmiata. Abbiamo sofferto la fame e la sete, abbiamo camminato nella neve con le<br />
scarpe rotte, e ci hanno chiamato ladri. Abbiamo regalato la vita a uomini che Dio stesso<br />
condannava e ci hanno chiamato assassini. Noi però siamo per la giustizia e l'onore. Per<br />
questo siamo generosi» 2 .<br />
Sono parole di Rinaldo Arnaldi, scritte nel vivo della guerra feroce in cui lottò e perse la<br />
vita.<br />
E Fiorenzo M. Costalunga, “Argiuna”, incarcerato a Vicenza, scrive: «È strano, non provo<br />
alcun odio, alcun rancore, mi raccolgo in me» 3 . E più Avanti, quando sta per essere<br />
liberato dal carcere, si sente paradossalmente in colpa, «quasi vergognoso d’essere<br />
prescelto <strong>dalla</strong> fortuna e di dover lasciare (in prigione) altri uomini con cui (ha) stretto<br />
1 In realtà questi versi, così volutamente semplici, appartengono ad un grande intellettuale, Italo<br />
Calvino. Non fu l’unico nella prima, fervida fase storica che seguì la fine del 2° conflitto mondiale,<br />
ad impegnarsi nel tentative di avvicinare il sentire delle masse popolari alla parte più viva della<br />
nostra cultura. Potrei fare molti esempi ma non è questa la sede in cui farlo.<br />
2 Mimma Arnaldi, Rinaldo Arnaldi, tip. S. Gaetano, Vicenza 1947, p. 56.<br />
3 Prime impressioni di carcere, Fiorenzo Mario Costalunga, Quaderni dell’Anpi 1945, p. 10.<br />
C. PONCINA – Vicenza, X Martiri pagina 2 di 7
www.istrevi.it/commemorazioni<br />
rapporti di cordialità e di amicizia» 4 . Morirà il 6 settembre del ’44.<br />
Questo è l’animo del partigiano “vero”, che niente ha a che fare col fanatismo violento dei<br />
fascisti.<br />
Purtroppo la macchina del fango non è stata inventata oggi, lavorava fin dal ’45, se non<br />
prima, a rimuovere, mascherare, stravolgere la realtà.<br />
Come una menzogna così palesemente smentita dai fatti abbia potuto attecchire tanto<br />
<strong>prof</strong>ondamente, è cosa che meriterebbe un lungo discorso sulla natura degli italiani, o<br />
quantomeno di una loro parte.<br />
Il fatto è che gli eroi veri mettono in luce la cattiva coscienza di molti, e allora meglio<br />
buttarli giù dal piedistallo, inventando su di loro le più ignobili menzogne.<br />
Un modo cinico di coprire la cattiva coscienza di tanti, che subito dopo la fine del<br />
conflitto seppero rifarsi una verginità infangando la memoria delle migliaia di giovani<br />
che, attraverso percorsi diversi, seppero scegliere la parte giusta, che guarda caso era la<br />
più scomoda, rischiosa, dura.<br />
Non che non si possano trovare tra le gesta dei partigiani azioni o uomini<br />
condannabili. Lo cantavano anche, nella stessa canzone già citata: “Non è detto che<br />
fossimo santi, l’eroismo non è sovrumano”, ma non dimentichiamo che si trattò di una<br />
guerra civile, la più crudele tra le guerre.<br />
Certo a favorire la falsificazione della realtà intervennero delle concause di carattere più<br />
generale, come lo scoppio, successivo alla fine del conflitto ma implicito già prima, della<br />
guerra fredda tra le due maggiori potenze che si erano alleate contro il nazifascismo: gli<br />
Stati Uniti d’America e l’URSS, e ciò provocò la violenta contrapposizione tra comunismo<br />
e anticomunismo.<br />
Su questa si inserì la polemica antipartigiana, che identificava subdolamente partigiani e<br />
comunisti, mentre noi sappiamo che alla Resistenza parteciparono tutte le forze<br />
antifasciste sulla spinta - come scrisse Primo Levi - di “un muto bisogno di decenza”.<br />
Parlo di cattolici, laici, comunisti, sacerdoti, dei molti militari, come gli alpini di<br />
Cefalonia, i bersaglieri di Montelupo, gli ufficiali e i soldati dell’esercito italiano che dopo<br />
l’8 settembre salirono in montagna per organizzare la resistenza contro il nazifascismo,<br />
dei moltissimi internati nei campi di concentramento in Germania per aver rifiutato di<br />
combattere a fianco dei nazifascisti.<br />
Purtroppo sostenere le tesi dei fascisti, degli opportunisti, dei trasformisti, è<br />
risultato molto redditizio anche sul piano pratico, consentendo ancor oggi a giornalisti<br />
disinvolti di arricchirsi con libri che non sono altro che scaltre rimasticature delle tesi<br />
repubblichine, riproponendo continuamente il peggio che ogni guerra civile<br />
inevitabilmente porta con sé, e consentendo di fare di ogni erba un fascio, mescolando<br />
confusamente gli ideali di chi ha combattuto per la giustizia e la libertà con le torbide<br />
aspirazioni alla supremazia di supposti forti contro i deboli, della razza superiore contro<br />
quelle giudicate inferiori.<br />
E a questo proposito non posso tacere il fatto che tra I dieci giovani uccisi al Ponte<br />
dei Marmi quattro erano Sinti, appartenenti ad una etnia che - seppure poco lo si ricordi<br />
- ha visto bruciare nei campi di sterminio nazisti un milione e mezzo dei suoi figli, e<br />
molti altri partecipare con coraggio e onore alla lotta di liberazione in tutta Europa.<br />
Ignorati al punto che, riguardo ai fatti che qui ricordiamo, solo nel 2007 è emerso che<br />
dei dieci martiri quattro erano “zingari”, come sprezzantemente vengono di norma<br />
chiamati. La memoria, nelle comunità Sinti e Rom, è essenzialmente orale e chiusa<br />
all’interno di gruppi isolati dal contesto entro cui vivono, e questo favorisce l’oblio.<br />
Oggi li ricordiamo con i loro nomi e le loro singolari, oserei dire poetiche,<br />
<strong>prof</strong>essioni, così come vennero indicate nei documenti ufficiali: Walter Catter, di<br />
<strong>prof</strong>essione circense, Lino Festini, musicista-teatrante, Silvio Paina, girovago-circense,<br />
4 Ivi, p. 24.<br />
C. PONCINA – Vicenza, X Martiri pagina 3 di 7
www.istrevi.it/commemorazioni<br />
Renato Mastini, di <strong>prof</strong>essione circense.<br />
Queste loro vite ai margini non ostacolarono l’impegno civile e la lotta coraggiosa<br />
contro il nazifascismo, impegno e lotta che molti bravi borghesi non seppero scegliere<br />
con altrettanto coraggio.<br />
L’Italia, il Paese per cui tutti costoro e moltissimi altri sono morti, in questi ultimi<br />
tempi sta vivendo momenti duri, i più duri <strong>dalla</strong> fine dell’ultima guerra, per cui il nostro<br />
ritrovarci insieme acquista un significato particolare: non si tratta solo di onorare –come<br />
dovuto- dieci giovani partigiani vittime della barbarie nazifascista. Dalle storie e dai volti<br />
semplici dei dieci martiri vorremmo, vogliamo, trarre esempio, forza, animo, per<br />
affrontare con più coraggio e generosità e soprattutto insieme, la decadenza del nostro<br />
Paese che, prima ancora che economica, è civile ed etica.<br />
Mi piacerebbe che il ricordo che oggi ravviviamo ci spingesse a tornare a casa più<br />
consapevoli di noi stessi e dei nostri doveri nei confronti della comunità, ci aiutasse a<br />
guardare al futuro con più speranza, ci sollecitasse a tirar fuori il meglio da noi stessi<br />
non per fini personali, ma per la gioia che dà il sentirci parte di una comunità coesa.<br />
Dico questo per togliere subito <strong>dalla</strong> mente di tutti noi l’idea che queste ripetute<br />
commemorazioni risultino gravate da una fredda ritualità, da un sentore di retorica che<br />
rischia di allontanare soprattutto i giovani. Mentre invece è proprio per voi giovani che<br />
ha senso – è anzi doveroso – fare tutto questo.<br />
È a voi che dobbiamo proporre il racconto e l’esempio di comportamenti<br />
coraggiosi, nobili nel senso originario e ormai perduto del termine, riferito ad azioni<br />
compiute da uomini che si sentono parte di una più ampia cominità.<br />
Tutto questo l’abbiamo dimenticato negli ultimi decenni di trionfante, narcisistico<br />
individualismo, sospinti da un vento che spirava fortissimo, alimentato dal thatcherismo,<br />
dal reaganismo, dal neoconservatorismo americano, ideologie queste ultime che hanno<br />
trovato appassionati quanto mediocri cantori (alla Giuliano Ferrara…) nei nostri giornali<br />
e nelle televisioni, tutti a spingere ossessivamente verso la ricerca dell’appagamento<br />
personale a tutti i costi: successo e denaro come valori primari da proporre ai giovani.<br />
Il risultato è sotto gli occhi di tutti: una società disgregata, che ostenta senza<br />
vergogna ignoranza e volgarità. Una società in cui ognuno rema per sè, con il rischio di<br />
far andare a picco tutti.<br />
Diventa allora assai importante, direi vitale, tornare allo spirito che unì – negli anni<br />
della Resistenza – cattolici e comunisti, laici e credenti, nello sforzo comune di salvare, in<br />
primis, la dignità di questo Paese, imprimendo alla Resistenza stessa un sigillo di<br />
Italianità.<br />
Perché lo sappiamo bene che per la Liberazione furono indispensabili le forze<br />
alleate, ma per l’onore dell’Italia ancora più indispensabili furono quelle migliaia di<br />
italiani e di Italiane che – non dimentichiamolo mai – non se ne stettero ad attendere la<br />
salvezza dagli alleati, ma con le armi o senza, rischiarono la vita e in molti casi la<br />
perdettero, per rispetto di sé e amore per il proprio Paese.<br />
Quello spirito e quella lotta consentirono a uomini delle più diverse provenienze<br />
sociali e culturali, di scrivere in diciotto mesi una Costituzione bellissima, persino dal<br />
punto di vista formale.<br />
Una Costituzione che collocò il nostro Paese alla pari con quelli più avanzati sul<br />
piano dei diritti: al lavoro, allo studio, all’uguaglianza, alla parità di genere, e proprio per<br />
questo fortemente osteggiata <strong>dalla</strong> classe politica dominante nell’ultimo ventennio, la<br />
peggiore dall’Unità d’italia – fascismo a parte. Una classe politica che ignara di storia,<br />
priva di sapienza giuridica, ha ripetutamente tentato di cancellare una Costituzione che<br />
ai suoi occhi è macchiata dal peccato originale di essere nata <strong>dalla</strong> Resistenza.<br />
Una Costituzione che non va stravolta, semmai pienamente attuata.<br />
Ho già ricordato Nino Bressan, figura esemplare di partigiano, da poco scomparso.<br />
A lui – come già detto – si deve la ricostruzione più asciutta e viva della vicenda dei Dieci<br />
C. PONCINA – Vicenza, X Martiri pagina 4 di 7
www.istrevi.it/commemorazioni<br />
Martiri, contenuta nel discorso commemorativo pronunciato l’11 novembre 1984,<br />
quarantesimo anniversario dell’eccidio.<br />
Insieme a Nino mi piace ricordare Bene Galla, che firmò la prefazione al libretto<br />
che ne raccoglie il testo, stampato da Neri Pozza, perché anche Bene, “piccolo maestro”, è<br />
uno di quei vicentini un po’ dimenticati che meritano un ricordo affettuoso da parte di<br />
noi tutti, nonostante o proprio per la ritrosia con cui preservò -dopo la Liberazione- la<br />
sua personale memoria di quegli anni.<br />
Queste le parole di Bene: «il comandante Nino, il militare Nino, ci ha lasciato una<br />
pagina di storia, detta nell’unico modo in cui la storia può essere detta: con la forza della<br />
verità».<br />
E introduce subito il criterio cui si è at<strong>tenuto</strong>:<br />
«Non scorda[re] mai che i fatti che meritano di essere ricordati sono quelli che sono<br />
illuminati da un ideale, da una speranza, <strong>dalla</strong> convinzione che essi contribuiscono al<br />
progresso del consorzio civile».<br />
Commenta Galla: «quello (l’eccidio dei dieci martiri, n.d.r) era stato uno di quei fatti. Uno<br />
di quei fatti che indicavano senza equivoci, quasi “necessariamente”, i termini della<br />
guerra che allora si combatteva, la posta in gioco, i suoi problemi, il suo fine, il suo<br />
prezzo. Non una sbavatura retorica, non un cenno di trionfalismo: cose che si dovevano<br />
fare, che si facevano con I mezzi che c’erano, consapevoli che il rischio era quello della<br />
vita, carichi della responsabilità, dei rischi che, per quel fine, si doveva far correre anche<br />
ad innocenti».<br />
Di queste storie, di queste persone si dovrebbe parlare a scuola, nei giornali, in<br />
televisione, per uscire dal clima opaco, <strong>dalla</strong> condizione di sfiducia, dai falsi miti con cui<br />
sono stati ingannati i giovani e i meno giovani in questi ultimi, tristi tempi. Più tristi, dal<br />
punto di vista delle certezze morali, di quelli vissuti da Nino, Bene, dai dieci giovani qui<br />
brutalmente giustiziati e dalle altre centinaia di migliaia che videro con chiarezza da che<br />
parte stava il bene, la giustizia.<br />
E del resto questa chiarezza nella scelta traspare dalle testimonianze scritte dai<br />
veri patrioti, dai partigiani in prossimità della fine: «Sopporto rassegnato: il corpo potrà<br />
soffrire, l’anima potrà soffrire, ma una cosa non muore: l’Idea. E la Patria è l’idea divina».<br />
Lo scrive un giovane ventenne in partenza per Mauthausen, dove morirà.<br />
E suona amaro ai nostri orecchi quanto scrive un altro prigioniero destinato ai campi di<br />
sterminio: «Penso che è giusto che come la gran parte dell’umanità paghi anche io il mio<br />
tributo al destino comune che divide, allontana, ma infine ricongiungerà, perché<br />
attraverso il dolore gli uomini siano purificati e migliori e rinascano alla felicità di vivere<br />
insieme, gioire insieme, amare, godere della natura, delle stagioni, della vita insomma» 5 .<br />
Non è blasfemo porre sullo stesso piano gli ideali di questi giovani e quelli delle<br />
camice nere col teschio, che esaltavano la “bella morte” e i cui eredi sono lasciati<br />
impunemente sfilare urlando slogan osceni, davanti alle telecamere di quest’Italia atona,<br />
amorfa, incapace di reagire in nome di quel “muto bisogno di decenza” di cui parla Primo<br />
Levi, e che sta all’origine della lotta partigiana?<br />
Dico questo perché è di pochi giorni fa la macabra sceneggiata di fascisti ripresi da<br />
tutte le televisioni in chiesa, ai funerali di un loro capo considerato un ideologo del<br />
terrorismo nero, seppure mai condannato da un tribunale. Ci siamo visti riproporre<br />
tutto l’armamentario retorico del fascismo, senza che i media più influenti proponessero<br />
un commento, osassero una critica, come fosse “normale” quella sfacciata apologia di<br />
fascismo.<br />
Ripropongo le parole di uno dei pochissimi giornalisti che ne ha parlato con<br />
sdegno: «Questa è gente che ha continuato a vivere nel fascismo come i Mafiosi nella<br />
mafia, dopo che è stato processato e condannato <strong>dalla</strong> Storia come un delitto grave con<br />
5 Dal libro:Voci dal lager, a cura di M. Avagliano e M. Palmieri, Einaudi 2012.<br />
C. PONCINA – Vicenza, X Martiri pagina 5 di 7
www.istrevi.it/commemorazioni<br />
una vocazione ad uccidere. Da Gramsci a Gobetti, da Matteotti ai fratelli Rosselli, tutta la<br />
storia italiana del secolo scorso è testimonianza di delitti repellenti che hanno recato<br />
all’Italia danni immensi».<br />
Ma quanti italiani ne sono consapevoli, quanti giovani italiani conoscono i personaggi<br />
succitati?<br />
È da questa consapevolezza amara che bisogna ripartire.<br />
Confrontando la nostra situazione con quella vissuta dai dieci martiri, noi sentiamo<br />
che quelle vite, pur tragicamente troncate, hanno avuto un senso, e di questo ciascuno di<br />
loro era certo consapevole. Non intendo con questo rimpiangere gli anni durissimi,<br />
tragici della guerra di Liberazione –sarebbe folle- ma solo sottolineare come l’assenza di<br />
valori, speranze, senso di appartenenza ad una civitas, possono bruciare tante<br />
giovinezze e produrre danni gravissimi ad una comunità. Purtroppo è quello che stiamo<br />
vivendo oggi in Italia. È la grigia guerra cui sono condannate le nuove generazioni, ma<br />
cui dobbiamo reagire anche grazie all’esempio di Walter, Livio, Rino, Angelo, Guido,<br />
Aldo, Massimiliano, Silvio, Luigi, Renato.<br />
Un’ultima osservazione prima di concludere. Riprendo ancora una volta le parole<br />
di Nino Bressan, sempre allo scopo di ristabilire la verità smentendo le calunnie sulle<br />
rappresaglie “causate” dai partigiani. Colpisce quanto egli ci tenga a sottolineare la cura,<br />
nell’organizzare le azioni, volta ad evitare rappresaglie tra i civili, facendo in modo che<br />
gli attentati ostacolassero il controllo tedesco del nostro territorio senza provocare<br />
morti tra i soldati tedeschi che giustificassero le loro feroci rappresaglie. Ci sono molti<br />
passi dei suoi scritti che testimoniano della grande attenzione che i partigiani avevano<br />
per la vita dei civili: case di spie fasciste che avrebbero dovuto saltare in aria e che<br />
invece vennero preservate per aver sentito provenire di lì il pianto di un bambino. Mine<br />
pronte per essere fatte brillare, freneticamente disinnescate per l'apparire di un treno<br />
carico di civili. Costante era la cura per le vite degli altri, a volte anche dei fascisti,<br />
nonostante tutto.<br />
Al contrario, I morti che qui ricordiamo testimoniano della totale assenza di pietas<br />
in chi decide della vita dei propri simili non sulla base di una riflessione<br />
consapevolmente umana, ma servendosi della nuda casualità nel decidere della vita e<br />
della morte altrui, affidandola a una macabra scelta tra chi ha diritto di vivere e chi, per<br />
insindacabile e irrazionale volontà deve morire.<br />
Il fatto è, come ap<strong>prof</strong>onditi studi storici recenti hanno dimostrato 6 , che solo in<br />
pochi casi le cosiddette rappresaglie tedesche rispondevano ad atti di violenza dei<br />
partigiani.<br />
La semplice correlazione tra le innumerevoli stragi che soprattutto tra l’estate e<br />
l’autunno del ’44 e la primavera del '45 insanguinarono l’Italia centrale e settentrionale<br />
e le azioni partigiane, evidenzia sulla base della semplice cronologia come in realtà le<br />
rappresaglie venissero decise all'interno di una precisa strategia del terrore rivolta alla<br />
popolazione civile, che diversamente da quanto sos<strong>tenuto</strong> da una certa storiografia, non<br />
era composta in maggioranza <strong>dalla</strong> cosiddetta zona grigia, indifferente alle ragioni dei<br />
due contendenti e sostanzialmente attendista. La zona grigia è esistita – certo – ma non<br />
rappresentava la maggior parte degli italiani, quantomeno al Centro e al Nord, né era<br />
innocente.<br />
La neutralità fu in ogni caso colpevole, se condividiamo le parole del teologo<br />
tedesco Dietrich Bonhoeffer, ucciso dai nazisti nel campo di concentramento di<br />
Flossemburg a poche settimane <strong>dalla</strong> fine della guerra: «Il silenzio di fronte al male è<br />
esso stesso un male. Non parlare è parlare. Non agire è agire».<br />
I partigiani hanno parlato, hanno agito anche per chi se ne stava immobile,<br />
6 Cfr.: M. Battini, P. Pezzini, Guerra ai civili: occupazione tedesca e politica del massacro. Toscana<br />
1944, Marsilo 1997.<br />
C. PONCINA – Vicenza, X Martiri pagina 6 di 7
www.istrevi.it/commemorazioni<br />
salvando la dignità di tutto un popolo altrimenti condannato all’ignavia e alla vergogna.<br />
Ma il loro successo e la loro stessa vita -stiamo parlando di circa duecentomila uomini-<br />
erano legati a tutti quegli italiani e italiane che li sostennero nascondendoli, nutrendoli,<br />
rischiando la vita col loro muto appoggio, anche se non toccarono mai un’arma né<br />
combatterono in campo aperto.<br />
Gli studi più recenti hanno confermato ciò che era chiaro all'indomani della<br />
Liberazione e che fu in seguito coperto, e cioè che la gran parte della popolazione<br />
italiana, con più forza ovviamente nelle zone occupate dai nazifascisti, appoggiò i<br />
partigiani esponendosi a rischi enormi, nascose i soldati prigionieri dei tedeschi, aiutò<br />
gli ebrei nascondendoli o accompagnandoli al confine.<br />
I veleni diffusi in quegli anni purtroppo agiscono ancora, ed è lecito sospettare che<br />
l'ultimo ventennio, pur non avendo privato delle libertà nè oppressi con la violenza gli<br />
italiani, abbia modificato a fondo il loro carattere, immiserendo le antiche virtù di<br />
solidarietà ed esaltandone i difetti: individualismo, immoralità scarso senso del Bene<br />
Comune.<br />
La Resistenza fu un momento in cui il bisogno di “giustizia e libertà” si sostituì a<br />
ogni altro impulso, anche a quello della sopravvivenza; era quella l'ora in cui si era<br />
chiamati a testimoniare; «non era una scelta di morte, anche se si traduceva nel morire<br />
e nel far morire» 7 . Purtroppo: «gli uomini dell'antifascismo scoprirono presto che la<br />
scomparsa del loro nemico storico non coincideva affatto automaticamente con la loro<br />
vittoria [...] i venti mesi della lotta armata erano stati troppi per i lutti e le sofferenze che<br />
avevano causato, ma pochi, troppo pochi perché sulle lacerazioni non si formasse<br />
immediatamente la crosta della continuità» 8 .<br />
L'ennesima svolta trasformista si consumava «in questo povero paese che non ha mai<br />
avuto una vera rivoluzione, che non ha mai conosciuto il costruttivo tormento di una<br />
riforma religiosa». Un Paese in cui gli accordi tra partiti si sono realizzati «più che sul<br />
piano politico su un piano di compromesso e di fiacchezza morale», producendo l'eterno<br />
ritorno «all'Italietta delle cricche elettorali, dei protezionismi, delle pastette<br />
governative». (G. Agosti)<br />
Dio non voglia che che nei prossimi mesi ci tocchi assistere all’ennesima “pastetta<br />
governativa”. Per evitare la quale non resta che imitare il coraggio e l’impegno civile di<br />
questi giovani, assumere su di noi il loro bisogno di decenza e dignità, imporci sempre e<br />
ovunque di ristabilire almeno la verità dei fatti.<br />
Questo l’impegno cui il sacrificio di questi giovani ci chiama, per il bene dell’Italia.<br />
E dunque: ora e sempre, Resistenza!<br />
7 Dalla prefazione di G. De Luna al libro: Un filo tenace. Lettere e memorie 1944-1969, di Willy<br />
Jervis, Lucilla Jervis Rochat, Giorgio Agosti, Bollati-Boringnieri 2008.<br />
8 Ivi.<br />
C. PONCINA – Vicenza, X Martiri pagina 7 di 7