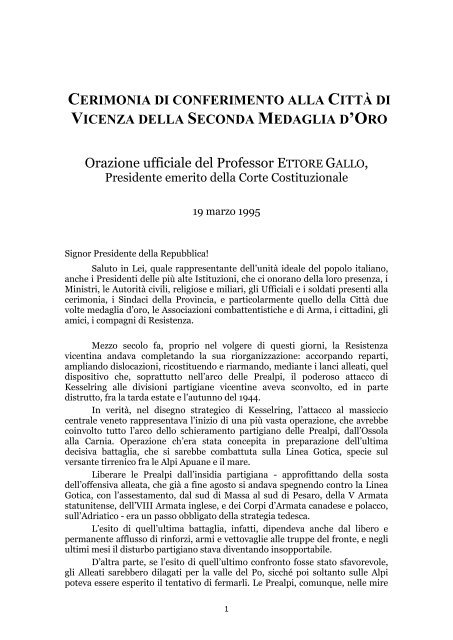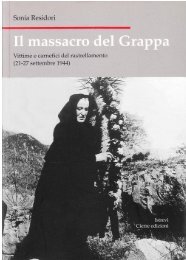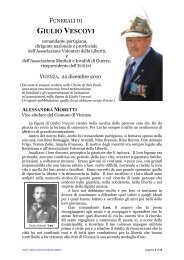Orazione ufficiale del Professor Ettore Gallo, presidente ... - ISTREVI
Orazione ufficiale del Professor Ettore Gallo, presidente ... - ISTREVI
Orazione ufficiale del Professor Ettore Gallo, presidente ... - ISTREVI
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
CERIMONIA DI CONFERIMENTO ALLA CITTÀ DI<br />
VICENZA DELLA SECONDA MEDAGLIA D’ORO<br />
<strong>Orazione</strong> <strong>ufficiale</strong> <strong>del</strong> <strong>Professor</strong> ETTORE GALLO,<br />
Presidente emerito <strong>del</strong>la Corte Costituzionale<br />
Signor Presidente <strong>del</strong>la Repubblica!<br />
19 marzo 1995<br />
Saluto in Lei, quale rappresentante <strong>del</strong>l‟unità ideale <strong>del</strong> popolo italiano,<br />
anche i Presidenti <strong>del</strong>le più alte Istituzioni, che ci onorano <strong>del</strong>la loro presenza, i<br />
Ministri, le Autorità civili, religiose e miliari, gli Ufficiali e i soldati presenti alla<br />
cerimonia, i Sindaci <strong>del</strong>la Provincia, e particolarmente quello <strong>del</strong>la Città due<br />
volte medaglia d‟oro, le Associazioni combattentistiche e di Arma, i cittadini, gli<br />
amici, i compagni di Resistenza.<br />
Mezzo secolo fa, proprio nel volgere di questi giorni, la Resistenza<br />
vicentina andava completando la sua riorganizzazione: accorpando reparti,<br />
ampliando dislocazioni, ricostituendo e riarmando, mediante i lanci alleati, quel<br />
dispositivo che, soprattutto nell‟arco <strong>del</strong>le Prealpi, il poderoso attacco di<br />
Kesselring alle divisioni partigiane vicentine aveva sconvolto, ed in parte<br />
distrutto, fra la tarda estate e l‟autunno <strong>del</strong> 1944.<br />
In verità, nel disegno strategico di Kesselring, l‟attacco al massiccio<br />
centrale veneto rappresentava l‟inizio di una più vasta operazione, che avrebbe<br />
coinvolto tutto l‟arco <strong>del</strong>lo schieramento partigiano <strong>del</strong>le Prealpi, dall‟Ossola<br />
alla Carnia. Operazione ch‟era stata concepita in preparazione <strong>del</strong>l‟ultima<br />
decisiva battaglia, che si sarebbe combattuta sulla Linea Gotica, specie sul<br />
versante tirrenico fra le Alpi Apuane e il mare.<br />
Liberare le Prealpi dall‟insidia partigiana - approfittando <strong>del</strong>la sosta<br />
<strong>del</strong>l‟offensiva alleata, che già a fine agosto si andava spegnendo contro la Linea<br />
Gotica, con l‟assestamento, dal sud di Massa al sud di Pesaro, <strong>del</strong>la V Armata<br />
statunitense, <strong>del</strong>l‟VIII Armata inglese, e dei Corpi d‟Armata canadese e polacco,<br />
sull‟Adriatico - era un passo obbligato <strong>del</strong>la strategia tedesca.<br />
L‟esito di quell‟ultima battaglia, infatti, dipendeva anche dal libero e<br />
permanente afflusso di rinforzi, armi e vettovaglie alle truppe <strong>del</strong> fronte, e negli<br />
ultimi mesi il disturbo partigiano stava diventando insopportabile.<br />
D‟altra parte, se l‟esito di quell‟ultimo confronto fosse stato sfavorevole,<br />
gli Alleati sarebbero dilagati per la valle <strong>del</strong> Po, sicché poi soltanto sulle Alpi<br />
poteva essere esperito il tentativo di fermarli. Le Prealpi, comunque, nelle mire<br />
1
dei tedeschi, dovevano restare sgombere anche per garantire, nella peggiore<br />
<strong>del</strong>le ipotesi la ritirata verso la Germania.<br />
Di ciò ben consapevoli, i tedeschi avevano fatto particolarmente <strong>del</strong>la<br />
pianura vicentina un‟autentica roccaforte. Per loro l‟importante era raggiungere<br />
dal sud il territorio trentino, ormai annesso al Reich e perciò ferramente<br />
controllato dalle forze germaniche sotto il governo dei Gauleiter e, venendo dal<br />
nord, raggiungere la valle padana. Gli attraversamenti <strong>del</strong>icati erano dunque le<br />
valli e la pianura vicentina e le parallele veronesi: anche se poi la Val d‟Adige e la<br />
riva veronese <strong>del</strong> Garda erano considerate troppo esposte alle incursioni aeree,<br />
sicché, salvo il caso di maltempo, la preferenza era data alle vie che da Vicenza,<br />
attraverso la Valsugana o la Vallarsa portavano a Trento da Bassano e da Schio e<br />
viceversa: e talvolta era stimato preferibile raggiungere Trento persino<br />
dall‟Altopiano, attraverso Lavarone.<br />
Queste essendo le condizioni viarie per loro irrinunciabili, si spiega<br />
perché Vicenza e tutta la pianura circostante fossero state munite di particolari<br />
dispositivi di sicurezza, coprendo anche gli abitati minori con esercito, SS e<br />
polizie fasciste. E quando poi Kesselring porrà il Quartier Generale alla stazione<br />
termale di Recoaro, dove si chiude la Valle <strong>del</strong>l‟Agno, tutte le misure verranno<br />
aggravate.<br />
A Vicenza, già sicuramente attorno alla metà <strong>del</strong> settembre ‟43, primo fra<br />
i veneti, si era costituito il Comitato provinciale di Liberazione. Ebbi l‟onore di<br />
essere tra i cofondatori, ma ero sicuramente la personalità più sbiadita, giacché<br />
avevo appena 29 anni, e attorno a me c‟erano i mostri sacri <strong>del</strong> tradizionale<br />
antifascismo vicentino: da Fraccon, democristiano (medaglia d‟argento alla<br />
memoria, caduto poi a Mauthausen nel 1945 assieme al giovanissimo figlio con<br />
lui arrestato e deportato), a Luigi Faccio, socialista, ultimo sindaco di Vicenza,<br />
defenestrato con la violenza dai fascisti, e poi primo sindaco <strong>del</strong>la città dopo la<br />
Liberazione, a De Maria, suo braccio destro, a Marchioro, ex deputato<br />
comunista, a Henry Da Rin, come me azionista, medaglia d‟argento e grande<br />
mutilato <strong>del</strong>la Julia, all‟ingegner Rigoni di Asiago. Dopo l‟arresto di Fraccon,<br />
subentrarono l‟avvocato Giacomo Rumor e il professor Nicoletti. In fondo, io<br />
avevo a mio favore soltanto il fatto di essere un giovane magistrato, titolare <strong>del</strong>la<br />
Pretura <strong>del</strong> mandamento di Lonigo. Purtroppo, sono rimasto unico superstite di<br />
quel gruppo di miei Maestri.<br />
Il Cln provinciale aveva provveduto ad organizzare e finanziare i primi<br />
nuclei partigiani, sia in pianura che in montagna: ma via via che andavano<br />
crescendo, anche in località lontanissime, espresse un Comando militare<br />
provinciale cui affidò organizzazione, intendenza e direzione esecutiva <strong>del</strong>la<br />
lotta.<br />
Ne fecero parte, dapprima, come Capo, il colonnello D‟Ajello,<br />
comandante il 32º Reggimento carristi di Verona, cui io appartenevo, e che io<br />
stesso avevo presentato.<br />
Ma, ricercato pericolosamente dai tedeschi, dovette eclissarsi, e gli<br />
subentrò il maggiore vicentino Malfatti, attorniato dal democristiano ingegner<br />
Prandina, medaglia d‟argento alla memoria, e da un gruppo di ardimentosi,<br />
come Gino Cerchio, Strazzabosco, Campagnolo e altri.<br />
I reparti operativi a disposizione <strong>del</strong> Comando militare provinciale erano,<br />
in pianura: i settori militari, più o meno corrispondenti ai vari mandamenti,<br />
oltre ai GAP e al Gruppo Guastatori, che fu poi protagonista di imprese<br />
leggendarie. Era stato organizzato da un giovane capitano <strong>del</strong>l‟Esercito, Nino<br />
2
Bressan, il quale avendo frequentato, da <strong>ufficiale</strong> subalterno, un corso di<br />
specializzazione alla Scuola Centrale di Civitavecchia, era diventato un ottimo<br />
esperto nell‟uso bellico degli esplosivi. Dopo essere stato impiegato come<br />
istruttore dal Comando regionale veneto anche in altre province, e lasciata una<br />
breve esperienza di comando in una divisione partigiana di pianura nella<br />
pedemontana, Nino Bressan assunse il comando dei Guastatori vicentini. Del<br />
Comando fece parte un gruppo di valorosi: Carlo Segato, Ermes Farina,<br />
Benedetto Galla ed Enrico Buratta: ideologicamente due marxisti, due di<br />
tendenza cattolica e uno azionista ma, nella gestione <strong>del</strong> Comando e nello<br />
sviluppo <strong>del</strong>le azioni, quelle ideologie non svolgono alcuna influenza e restano<br />
soltanto <strong>del</strong>le propensioni personali.<br />
Lo spiegamento <strong>del</strong> dispositivo montano vede, ad ovest, fino al suo<br />
scioglimento, la Divisione Pasubio comandata da Marozin, accanto le Brigate<br />
<strong>del</strong>la Divisione Garemi, al comando di Nello Boscagli (Alberto), al centro <strong>del</strong>lo<br />
schieramento, sull‟Altopiano di Asiago, la Divisione Settecomuni (in ricordo<br />
<strong>del</strong>l‟antica Comunità autonoma), comandata dall‟ingegner Giovanni Carli,<br />
medaglia d‟oro alla memoria, caduto nei giorni <strong>del</strong>l‟insurrezione, con il supporto<br />
<strong>del</strong>la Mazzini sulla fascia pedemontana, al comando <strong>del</strong>l‟ingegner Chilesotti, egli<br />
pure medaglia d‟oro alla memoria, caduto nella battaglia <strong>del</strong>l‟insurrezione.<br />
Infine ad est, sul Massiccio <strong>del</strong> Grappa, erano dislocate le quatto brigate<br />
autonome <strong>del</strong>la Divisione Italia libera. Per qualche tempo, poi, si aggirò per<br />
l‟Altopiano, impegnandosi anche in duri combattimenti, quel gruppo un po‟<br />
nomade degli studenti vicentini <strong>del</strong> Partito d‟Azione, comandato dalla medaglia<br />
d‟oro alla memoria Toni Giuriolo, che uno <strong>del</strong> gruppo, lo scrittore Gigi<br />
Meneghello, immortalò poi nel celebre romanzo I piccoli maestri.<br />
Benché non fossero mancati episodi significativi, come attacchi di<br />
pattuglie alle caserme di paesi montani per rifornimento di armi e munizioni, o<br />
atti di sabotaggio in pianura da parte dei Guastatori, tuttavia dall‟ottobre ‟43 al<br />
marzo ‟44 l‟attività fu prevalentemente organizzativa e di propaganda<br />
clandestina.<br />
Fra l‟altro in marzo si ebbe, sollecitata e coordinata dai sindacati<br />
clandestini e dal Cln provinciale, una grande prova di coraggio da parte <strong>del</strong>la<br />
popolazione operaia di alcune maggiori industrie controllate dai tedeschi. Gli<br />
opifici <strong>del</strong> Lanificio Rossi di Schio e Torrebelvicino, gli stabilimenti Marzotto di<br />
Valdagno, le Officine Pellizzari di Arzignano proclamarono lo sciopero in<br />
concomitanza con le astensioni di Milano.<br />
L‟allarme dei tedeschi fu pari alle gravi contromisure subito seguite.<br />
Alcuni operai ed operaie di Schio e Valdagno furono tradotti nei lager di<br />
Germania e di Polonia, mentre quattro operai <strong>del</strong>le Officine Pellizzari,<br />
identificati come sospetti partigiani sobillatori, furono fucilati al castello di<br />
Arzignano.<br />
Ma quando il battaglione Guastatori cominciò ad operare con tutte le sue<br />
trenta squadre disseminate per la provincia, l‟attraversamento <strong>del</strong>la nostra<br />
pianura divenne pericoloso per le truppe tedesche: che altri agguati trovavano<br />
poi nei tratti che si insinuano nelle valli (Valsugana, Vallarsa) o percorrono le<br />
zone montane <strong>del</strong>l‟Altopiano o <strong>del</strong> Pasubio. I reparti partigiani intercettavano i<br />
convogli con rapide puntate e fulminei sganciamenti con arroccamenti nelle loro<br />
zone stanziali.<br />
In pianura erano colpite soprattutto le comunicazioni telefoniche e<br />
telegrafiche, nonché il trasporto <strong>del</strong>l‟energia elettrica che fermava le industrie<br />
3
occupate o controllate dai tedeschi. Ma poi venne il turno <strong>del</strong>le comunicazioni<br />
ferroviarie e di quelle stradali: saltarono i ponti, vennero divelti binari, le linee<br />
ferroviarie restavano spesso interrotte per <strong>del</strong>le mezze giornate, e di notte i<br />
convogli, specie se di munizioni, esplodevano nelle stazioni. I trasporti su<br />
strada, poi, oltre che nella distruzione dei ponti, incappavano nelle mine,<br />
mentre spesso pattuglie partigiane attaccavano le scorte.<br />
Ovviamente queste continue operazioni, sia di pianura che di montagna,<br />
rallentavano il traffico verso il fronte e lo danneggiavano, e fra l‟altro salvavano<br />
le popolazioni civili dal pericolo dei bombardamenti indiscriminati, che<br />
purtroppo spesso cagionavano stragi senza tuttavia colpire il bersaglio. Per<br />
fortuna, lo stratagemma, ideato dal comandante Bressan, di provocare<br />
esplosioni contemporanee in punti lontanissimi, anche di altre province<br />
finitime, disorientava il nemico, che non trovava più sufficienti ragioni per<br />
giustificare rappresaglie sulle popolazioni di questo o quel territorio. Solo<br />
quando fu abbattuto il cosiddetto „Ponte dei marmi‟ nei pressi <strong>del</strong> campo<br />
sportivo, che cagionò la contemporanea interruzione di più linee e per più<br />
giorni, i nazisti prelevarono dieci giovani, sospetti di partigianesimo, dalla Casa<br />
di Pena di Padova, li portarono sul posto e li fucilarono ad uno ad uno sui binari.<br />
Esempio classico di inumana rappresaglia, proibita già allora dalle leggi<br />
di guerra e dalle Convenzioni internazionali, come si dimostrò poi nei processi<br />
per la strage <strong>del</strong>le Fosse Ardeatine, perché mancava il nesso che legasse quei<br />
giovani alle attività vicentine da loro ignorate. Alle vivaci proteste <strong>del</strong> coraggioso<br />
Vescovo di Vicenza che, fra l‟altro, contestava al Comandante tedesco <strong>del</strong>la<br />
Piazza di aver mancato alla parola che gli aveva dato di non commettere<br />
rappresaglie sulle popolazioni vicentine, il generale fece rilevare, con gelido<br />
cinismo, che quei giovani non erano vicentini.<br />
Nell‟estate <strong>del</strong> ‟44 ci fu l‟avvento <strong>del</strong>le Missioni alleate paracadutate nel<br />
territorio vicentino, mediante le quali si ottenevano i lanci per il rifornimento<br />
<strong>del</strong>le nostre formazioni. Prima fu la missione Icaro che ci istruì sulla tecnica dei<br />
lanci e <strong>del</strong> loro ricevimento; poi venne la missione MRS e infine la Missione<br />
Freccia, che era il nome di battaglia <strong>del</strong>l‟eroico maggiore Wilkinson, ucciso dalla<br />
banda Carità nel 1945. La lotta si andava così intensificando (anche perché in<br />
maggio le formazioni si erano accresciute <strong>del</strong>l‟apporto dei renitenti ai bandi<br />
Graziani), ma ormai Kesselring aveva messo a punto il suo piano di morte.<br />
Si ebbe un primo assaggio in agosto ‟44 quando due Divisioni<br />
germaniche, in parte corazzate ed in parte autotrasportate, attaccano la Garemi<br />
sul Pasubio. Una Divisione, salita dal trentino, cala dall‟Altopiano di Folgaria,<br />
l‟altra si apposta più a sud al passo <strong>del</strong>lo Xomo, giacché su quel versante l<br />
Garemi, negli ultimi tempi, l‟aveva fatta da padrona, scendendo ad occupare<br />
paesi pedemontani, come a Posina, dove aveva disarmato la caserma <strong>del</strong>la GNR,<br />
aggregandosi anche un intero reparto di bersaglieri di leva. Certo, la Garemi, di<br />
gran lunga impari per uomini e per mezzi, non avrebbe potuto sostenere<br />
quell‟urto. Ma fu salvata dall‟eroismo di un gruppetto di ragazzi, da poco arrivati<br />
in montagna, che sostavano, con poche armi, a Malga Zonta in attesa di un<br />
lancio.<br />
La Malga è sita in mezzo al bosco, in un largo spiazzo aperto, che deve<br />
essere necessariamente attraversato allo scoperto per proseguire oltre. All‟alba<br />
la sentinella svegliò i compagni perché aveva avvertito movimenti nel bosco. Il<br />
capo <strong>del</strong> gruppo, il marinaio Viola, appostati i partigiani alle finestre <strong>del</strong>la<br />
Malga, ordinava il fuoco ogniqualvolta le pattuglie tedesche si avvicinavano allo<br />
scoperto a portata <strong>del</strong> loro tiro. Furono così respinte successive ondate per<br />
4
alcune ore, fino a quando, ridotti con molti feriti e poche munizioni, Viola<br />
ordinò la resa.<br />
Furono allineati lungo il muro <strong>del</strong>la porcilaia e fucilati da un plotone di<br />
esecuzione: ma l‟<strong>ufficiale</strong> tedesco, colpito da tanto coraggio di quella povera<br />
gente lacera e pressoché inerme, prima di ordinare il fuoco fece rendere l‟onore<br />
<strong>del</strong>le armi. Viola, medaglia d‟oro alla memoria, morì gridando «W l‟Italia libera<br />
e indipendente!». Forse fu il solo episodio di reciproca nobiltà di<br />
comportamento: ma va rilevato che si trattava di truppe <strong>del</strong>la Wehrmacht.<br />
Quella piccola Termopili, col sacrificio di quei giovani, salvò l‟intera<br />
Divisione Garemi perché l‟assordante sparatoria, iniziata all‟alba e durata per<br />
ore, determinò l‟allarme successivo - propalato anche dalle staffette - di tutti i<br />
reparti, che ebbero così il tempo di dileguarsi secondo la tattica <strong>del</strong>la guerriglia<br />
partigiana.<br />
Ma, ai primi di settembre, fu sferrata la grande vera e propria offensiva di<br />
Kesselring che, con grande apparato di mezzi, di uomini e di armamenti, iniziò<br />
ancora una volta da occidente <strong>del</strong>lo schieramento vicentino.<br />
Marozin, ispirato dalla Missione RYE a iniziative autonome rispetto alle<br />
direttive <strong>del</strong> CLN provinciale, fu facilmente ingannato dal Comando tedesco, che<br />
aveva simulato di accettare una tregua. Invece, la pur valorosa Divisione<br />
Pasubio, attaccata a sorpresa, venne per gran parte dispersa o annientata. Il<br />
comandante Marozin, con parte <strong>del</strong>lo Stato Maggiore, riuscì a fuggire a Milano,<br />
dove riprese la lotta con le formazioni Matteotti mentre i resti <strong>del</strong>la divisione<br />
furono incorporati nella brigata Stella <strong>del</strong>la Garemi, finitima alla zona <strong>del</strong>la<br />
Pasubio.<br />
L‟attacco tedesco e fascista si diresse contemporaneamente all‟Altopiano<br />
di Asiago, investendo la Settecomuni e la Mazzini. Si verificarono varie<br />
scaramucce, ma nel bosco di Granezza, i partigiani furono sorpresi e impegnati<br />
dalle preponderanti forze nemiche. Si difesero eroicamente, ma il disimpegno<br />
lasciò sul campo sei morti e due feriti gravi, oltre a quattordici prigionieri che,<br />
assieme ai feriti, furono passati per le armi. Il resto si disperse.<br />
Ma la vera e propria ecatombe si ebbe nella terza fase <strong>del</strong>l‟operazione,<br />
quando quelle ingenti forze nemiche investirono il massiccio <strong>del</strong> Grappa. Qui<br />
l‟Italia Libera, con le sue brigate autonome, attendeva a piè fermo senza<br />
intenzione di abbandonare il terreno. Per alcuni giorni, salvo le brevi notti<br />
estive, quei partigiani accettarono e sostennero l‟impari e possente urto <strong>del</strong>le<br />
armatissime truppe germaniche, munite anche di cannoni autotrasportati.<br />
Vennero scompaginati e, pur infliggendo gravi perdite al nemico, lasciarono sul<br />
campo decine di morti. I prigionieri furono in parte impiccati agli alberi dei viali<br />
di Bassano e in parte deportati in Germania, donde pochi fecero ritorno.<br />
Le battaglie di Granezza e <strong>del</strong> Grappa furono criticate perché i Comandi<br />
non si erano attenuti alla tattica <strong>del</strong>la guerriglia.<br />
Certo, anche noi piangiamo le gravi perdite di tanti giovani, ma siamo<br />
consapevoli che la Resistenza, come spontaneo movimento popolare, non<br />
proveniva dalle Accademie né dalle Scuole di guerra. E tuttavia è immensa la<br />
lezione che viene da quel sacrificio: tanto grande che alla fine intimidisce.<br />
Ottocento giovani male armati che per vari giorni resistono, affamati, agli assalti<br />
<strong>del</strong>le divisioni di uno dei più potenti eserciti <strong>del</strong> mondo e alla fine si votano a<br />
cadere sul campo o a morire impiccati, ma non arretrano, è un esempio<br />
luminoso che dice al mondo di che tempra siano fatti questi benedetti italiani<br />
quando ritrovano la via <strong>del</strong>la libertà e <strong>del</strong>la solidarietà umana. La Resistenza è<br />
5
stupenda ed eroica proprio perché è fatta anche di questi spontanei episodi<br />
senza retorica, che mostrano un popolo ormai lacero e misero, percosso e<br />
umiliato, che ritrova nella sua stessa disperazione la forza per insorgere contro il<br />
sopruso e la barbarie, quasi per gridare ancora una volta al mondo, col poeta <strong>del</strong><br />
Primo Risorgimento «Tu solo, o ideal, sei vero» !<br />
Ma intanto il nostro dispositivo montano era rimasto sconvolto: due<br />
grandi formazioni disperse o distrutte (la Pasubio e l‟Italia Libera), e due<br />
gravemente colpite (la Settecomuni e la Mazzini); soltanto la Garemi, pur essa<br />
provata, era rimasta pressoché integra nei quadri, anche se aveva dovuto<br />
abbandonare le posizioni.<br />
Quello che imperturbabile aveva continuato, invece, la sua distruttiva<br />
azione era il battaglione Guastatori, che imperversava nella pianura vicentina<br />
pur durante le operazioni di Kesselring sulla montagna. Ma non sarà ancora per<br />
molto! Il 13 novembre il messaggio di Alexander raggela la Resistenza italiana<br />
perché rende evidente che l‟avanzata alleata si spegnerà per tutto l‟inverno sulla<br />
Linea Gotica; mentre poco dopo si scatena l‟offensiva tedesca sulle Argonne (16<br />
dicembre) e si parla <strong>del</strong>le armi atomiche con le quali i nazisti sperano di<br />
capovolgere le sorti <strong>del</strong>la guerra. Per maggiore sventura fra novembre e<br />
dicembre, i servizi segreti tedeschi, la SS e la SDB mettono le mani sul CLN<br />
provinciale e sul Comando militare provinciale. Ad eccezione di Malfatti e<br />
Fiandini che riuscirono a darsi alla latitanza, fummo tutti arrestati, io dalla SS e<br />
gli altri da un reparto di stanza a Vicenza <strong>del</strong>la Banda Carità. Per circa un mese<br />
ci trattennero in via Fratelli Albanese e poi ci tradussero a Padova a palazzo<br />
Giusti, affidati alle cure dirette <strong>del</strong> Seniore Carità, dove trovammo purtroppo al<br />
completo il Comitato regionale veneto.<br />
Il gruppo di uomini, che aveva organizzato e diretto, durante sedici<br />
durissimi mesi, la Resistenza vicentina, era ormai fuori gioco. Il Comando dei<br />
Guastatori non fu subito catturato, ma era braccato, sicché le operazioni<br />
restarono virtualmente interrotte.<br />
Successivamente, fra gennaio e marzo, anche Bressan, Segato e Farina<br />
furono presi, ma, per fortunati eventi evasivi, dopo alcune settimane erano di<br />
nuovo ai loro posti.<br />
Lentamente si ricostruiscono le formazioni di montagna che, nonostante<br />
Alexander, non avevano mai smobilitato e si ripristinano i contatti. Si<br />
ricostituisce anche un triumvirato ciellenistico, con Lievore, Magagnato e<br />
Cadore e il reparto Guastatori si scioglie per costituire con i vecchi Settori<br />
militari la divisione partigiana Vicenza che, con le sue sette brigate, formerà una<br />
capillare ragnatela sulla pianura vicentina.<br />
Le Divisioni di montagna passano alle dirette dipendenze <strong>del</strong> Comando<br />
regionale veneto. dislocate secondo lo schieramento primitiv: ad ovest c‟è<br />
sempre quello che ormai si chiama il Gruppo Divisioni Garemi, con un<br />
distaccamento addirittura sulle pendici <strong>del</strong> Baldo verso il lago di Garda; al<br />
centro, sull‟Altopiano, la Divisione Ortigara, risultato <strong>del</strong>la fusione dei resti <strong>del</strong>la<br />
Settecomuni con quelli <strong>del</strong>la Mazzini, e ad est l‟erede <strong>del</strong>l‟Italia Libera che, in<br />
onore dei caduti, prende il nome di divisione Martiri <strong>del</strong> Grappa.<br />
Come dicevamo all‟inizio, cinquant‟anni fa, di questi giorni, la Resistenza<br />
vicentina è di nuovo in piedi. Gli alleati occidentali hanno stroncato l‟offensiva<br />
<strong>del</strong>le Argonne e stanno progredendo a stritolare le armate tedesche in quella<br />
morsa di cui quelle sovietiche, convergenti su Berlino, rappresentano l‟altro lato.<br />
La Linea Gotica viene finalmente sfondata.<br />
6
Ormai siamo alla fase insurrezionale. Dal 10 al 20 aprile, mentre le<br />
formazioni di montagna intercettano le Divisioni tedesche in ritirata, la<br />
Divisione Vicenza in pianura mette in atto il piano operativo indicato dal Clnai:<br />
interrompe definitivamente le comunicazioni telegrafiche e telefoniche, elimina<br />
le indicazioni stradali, occupa a difesa i principali stabilimenti industriali.<br />
Dopodiché procede a neutralizzare i centri di comando nemici.<br />
Con azione congiunta fra Garemi e Vicenza, viene occupato a Montecchio<br />
Maggiore il Ministero <strong>del</strong>la Marina <strong>del</strong>la RSI, mentre dovunque vengono<br />
attaccati e disarmati reparti in transito e caserme. Il 27 aprile la brigata Martiri<br />
di Grancona, agendo in coordinazione con avanguardie <strong>del</strong>la V Armata<br />
americana (comandata dal generale Clark), libera Lonigo e il Basso Vicentino.<br />
A questa Armata, che veniva dal Sud, si sovrappone poi l‟VIII Armata<br />
inglese comandata da Alexander, che proveniva da Mantova e Verona. A quel<br />
punto, partigiani e angloamericani combattono insieme: lo scontro finale si<br />
verifica nei pressi di San Pietro in Gu‟ (29 aprile), dove i tedeschi si arrendono.<br />
Venezia Euganea e Venezia Giulia restano così liberate perché gli<br />
angloamericani possono liberamente dilagare, spesso - come a Padova -<br />
trovando le città già liberate dai partigiani insorti. Si concludeva così anche<br />
l‟atroce nostra prigionia presso i torturatori <strong>del</strong> maggiore Carità, e la sentenza di<br />
condanna a morte per quattro di noi, pronunziata nella prima decade di aprile<br />
dal Tribunale militare fascista sedente in Piove di Sacco, restò fortunatamente<br />
ineseguita.<br />
Purtroppo, nella fase insurrezionale, i nazisti inferociti e impauriti<br />
commisero gravi eccidi sulla popolazione civile.<br />
Ebbene, questi sono i dati <strong>del</strong>la gloria.<br />
In tutta la provincia su circa diecimila fra partigiani e patrioti<br />
riconosciuti, ben 2607 sono caduti in combattimento, oppure fucilati o<br />
impiccati, 1504 deportati e internati nei campi di sterminio. Nella sola città di<br />
Vicenza, i partigiani combattenti riconosciuti sono 650, di cui 144 caduti in<br />
combattimento. I decorati al Valor Militare <strong>del</strong>la città sono 64: tre medaglie<br />
d‟oro alla memoria, 13 medaglie d‟argento, 23 medaglie di bronzo, 21 croci di<br />
guerra al Valor Militare, tre encomi solenni, una Bronz Star americana conferita<br />
sul campo dal generale Clark al comandante Bressan. Del resto, <strong>del</strong>le medaglie<br />
d‟argento due riguardano ancora il comando <strong>del</strong>la Vicenza: Nino Bressan e<br />
Carlo Segato.<br />
Ma la Resistenza non fu soltanto quella dei combattenti nelle formazioni.<br />
Già abbiamo visto l‟apporto degli operai con gli scioperi, molti dei quali erano<br />
anche inquadrati nei Guastatori o nelle Unità GAP e SAP. Ciò che, però, ebbe<br />
davvero carattere eccezionale fu la partecipazione <strong>del</strong>la stragrande maggioranza<br />
<strong>del</strong>la popolazione che protesse, nascose, avvertì, aiutò in ogni modo i partigiani,<br />
spesso ospitandoli e nutrendoli con grave personale pericolo, in uno slancio <strong>del</strong><br />
tutto spontaneo, pur fra i gravi sacrifici e talvolta le privazioni e i lutti che la<br />
guerra aveva imposto (62 bombardamenti, 1735 vittime civili, 2557 case<br />
distrutte, sono cifre eloquenti). Ma si capisce il perché di quella partecipazione.<br />
Dopo che genitori, sorelle, figli avevano visto combattere lealmente e<br />
valorosamente i propri cari nella guerra ‟40-‟43, in tutti i Corpi e in tutte le<br />
Armi, con un eroismo che era stato riconosciuto da quattro medaglie d‟oro e<br />
centinaia di argento e di bronzo, ridotto il paese allo stremo e fuggiti Re e<br />
Governo, avevano appreso dei vicentini <strong>del</strong>la Divisione Acqui massacrati dall‟ex<br />
alleato a Cefalonia e Corfù, e avevano visto sotto i loro occhi deportare in<br />
Germania nei carri bestiame 1857 loro figli, e due ragazze vicentine uccise<br />
7
estialmente a fucilate solo perché avevano tentato di porgere a quegli infelici<br />
qualche conforto alimentare, e la loro città occupata militarmente sotto il ferreo<br />
tallone nazista, per di più assistito dal trionfale ritorno fascista, ebbene le<br />
famiglie vicentine a quel punto non ebbero più dubbi. E in quei ragazzi che non<br />
vollero arrendersi e che, pur provati, e taluni mutilati, dalla guerra,<br />
riprendevano generosamente le armi contro l‟oppressore, le famiglie<br />
riconobbero i loro figli: coloro che, frammezzo a tanta illegalità e tanto sopruso,<br />
rappresentavano la speranza per un futuro di pace e di solidarietà umana.<br />
Ecco: il grande divario etico fra i due Risorgimenti fu proprio questo:<br />
nella larga partecipazione popolare al secondo, che fu avvertito da tutti come<br />
„lotta di Liberazione‟. In questa risposta corale <strong>del</strong> popolo italiano alla Patria che<br />
chiamava disperata per l‟ultima riscossa, quella <strong>del</strong>l‟onore e <strong>del</strong>la libertà, è il<br />
superlativo valore <strong>del</strong>la Resistenza, che non è monopolio di nessuno perché<br />
appartiene al popolo italiano! Una Resistenza che così s‟inseriva nell‟immane<br />
conflitto dei popoli d‟Europa e <strong>del</strong> mondo contro la barbarie <strong>del</strong> „patto <strong>del</strong>le<br />
Dittature‟, decise a soggiogare le genti in un servaggio infame. Un servaggio che,<br />
negando l‟eguaglianza degli uomini nei fondamentali diritti umani, stabiliva<br />
gerarchie di razze e di stirpi da istituire mediante stragi e genocidi.<br />
Civiltà contro barbarie, questo fu l‟immane conflitto dei popoli per la<br />
Liberazione: e in questa prospettiva epocale, impallidisce il fallace concetto di<br />
„guerra civile‟ cui si vorrebbe ridurre la Resistenza. Perché se fummo costretti a<br />
combattere anche i fratelli italiani, lo fummo non per odio personale o di<br />
fazione, ma soltanto perché si erano messi a servizio <strong>del</strong>l‟occupante.<br />
Quell‟occupante che, fra l‟altro, nel disegno <strong>del</strong>la sua occhiuta rapina,<br />
aveva già annesso i territori che il sangue e la vita dei nostri padri aveva redento<br />
alla Patria, da Trento a Trieste italianissima. Anche la popolazione civile,<br />
dunque, ha avuto la sua Resistenza.<br />
Così come fu Resistenza quella combattuta dai soldati italiani sui territori<br />
stranieri, dove li colse l‟armistizio, dove subirono la feroce reazione dei nazisti,<br />
dalla Francia, alla Jugoslavia, alla Grecia, alle isole <strong>del</strong> Dodecanneso. C‟è una<br />
ricerca ed un documentario <strong>del</strong> Generale Muraca, che fu protagonista in<br />
Jugoslavia di quella Resistenza, che illumina sul comportamento eroico dei<br />
nostri militari di terra, di mare e di cielo in quei drammatici frangenti: perché<br />
questo è in realtà l‟autentico valore <strong>del</strong> soldato italiano, il quale, anziché<br />
“rompere le reni alla Grecia”, finì per morire anche per la libertà dei Greci, come<br />
«quei che a Sfacteria dorme, Santorre di Santarosa».<br />
E fu Resistenza anche quella di soldati, civili e politici che preferirono la<br />
lenta morte di fame, di stenti e di malattie nei campi di concentramento nazisti<br />
piuttosto che aderire alle lusinghe di chi li voleva riportare in Patria, ben nutriti<br />
e ben pagati, nella divisa <strong>del</strong>la RSI o <strong>del</strong> Reich nazista.<br />
E, infine, fu Resistenza quella di coloro che al Sud vollero rivestire la<br />
divisa di un Esercito Italiano che risorgeva. L‟Esercito <strong>del</strong>la Nuova Italia, quello<br />
<strong>del</strong>la Libertà e <strong>del</strong>la democrazia, quello che si ricostituiva a difesa <strong>del</strong>la<br />
Istituzioni di Libertà, e che, come prima prova, risalì combattendo la Penisola<br />
nei Gruppi di combattimento Friuli, Cremona, Folgore, Legnano, lasciando<br />
ovunque i segni <strong>del</strong>l‟eroismo e <strong>del</strong>l‟onore.<br />
Furono gli antesignani di questo Esercito <strong>del</strong>la Nuova Italia, che oggi è<br />
qui, in questa sua superba rappresentanza di soldati e ufficiali, ad onorare la<br />
nostra cerimonia, e che noi ringraziamo per il rispetto che ha saputo acquisire<br />
8
nel mondo per il suo umano, irreprensibile e coraggioso comportamento nelle<br />
operazioni di pace al servizio <strong>del</strong>l‟ONU.<br />
Signor Presidente, so di avere abusato <strong>del</strong>la Sua pazienza, e me ne dolgo,<br />
e me ne scuso con tutto il cuore: ma voglia benignamente considerare che oggi<br />
la Sua altissima presenza qui è stato il riconoscimento più ambito per la<br />
Resistenza vicentina: e la seconda medaglia d‟oro ch‟Ella si accinge ad<br />
appuntare fra poco su quella bandiera risorgimentale <strong>del</strong>la città (che, proprio<br />
perché tale, non poteva non avere i colori <strong>del</strong>la patria), rappresenta il momento<br />
più alto <strong>del</strong>la nostra festa e <strong>del</strong>la nostra gioia. In questo momento, tutto il<br />
popolo vicentino, e tutta la nostra Resistenza in particolare, nei suoi vivi e nei<br />
suoi morti, è qui attorno a Lei e con Lei in un abbraccio corale e affettuoso.<br />
Lei impersona, Signor Presidente, l‟espressione vivente di quella suprema<br />
garanzia costituzionale che la Legge fondamentale attribuisce, a favore di tutti,<br />
al Capo <strong>del</strong>lo Stato: nell‟interpretazione ferma e impeccabile, che Ella ne sta<br />
dando, riconosciamo la ragione <strong>del</strong>la nostra avversione a quella forma di<br />
governo, da taluno auspicata, che, facendo <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica il<br />
responsabile altresì <strong>del</strong> governo, priverebbe il Paese <strong>del</strong>l‟Autorità super partes, e<br />
<strong>del</strong> potere che gli compete, ammonendo, temperando, riequilibrando, di<br />
richiamare ogni altra Istituzione all‟osservanza dei principi costituzionali.<br />
Riconosciamo, Signor Presidente, che qualche revisione è necessaria alla<br />
Legge fondamentale per renderne più funzionali le Istituzioni all‟attuale realtà<br />
politica; e soprattutto per realizzare quell‟autentica autonomia <strong>del</strong>l‟articolazione<br />
regionale <strong>del</strong> Paese che era già nello spirito <strong>del</strong>l‟articolo 5: la si chiami, poi,<br />
come meglio si preferisce, „regionalismo forte‟ o „federalismo‟.<br />
Ma l‟impianto generale <strong>del</strong> sistema instaurato dai Padri Costituenti nel<br />
1948 deve essere rispettato, perché in questa Costituzione, Signor Presidente,<br />
c‟è tutto l‟amore nostro e dei nostri morti, c‟è tutto il supremo sacrificio <strong>del</strong><br />
popolo italiano che ha ripreso le armi per far guerra alla guerra, affinché Libertà<br />
e Giustizia fossero assicurate anche ai fratelli più deboli, nel loro diritto al lavoro<br />
e nella loro dignità di creature umane.<br />
Questo grido di dolore e di Amore, che viene dalla notte dei secoli, spesso<br />
misconosciuto ma sempre disperatamente riemergente, perché è l‟Amore che<br />
vivifica le religioni dei popoli civili, e illumina di luce divina la religione <strong>del</strong>la<br />
cristianità, questo grido, questo anelito, Signor Presidente, che la Costituzione<br />
ha consacrato negli articoli 2 e 3, elevandolo a vessillo e a spirito <strong>del</strong>la nostra<br />
civiltà, nessuno s‟illuda che furbizia di capopopolo o astuzia di manovra politica<br />
possano mai più cancellare dalla Legge fondamentale <strong>del</strong>lo Stato e dal cuore<br />
degli uomini di buona volontà.<br />
W la Resistenza!<br />
W l‟Italia!<br />
9