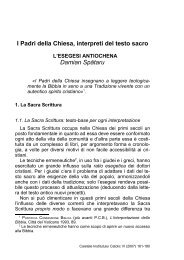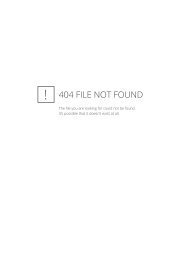Caietele Institutului.indb - Caietele Institutului Catolic
Caietele Institutului.indb - Caietele Institutului Catolic
Caietele Institutului.indb - Caietele Institutului Catolic
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Abstract<br />
Il sistema punitivo e penitenziario<br />
in epoca romana – II.<br />
Ettore TOMASSI 1<br />
It is reported throughout the literature on crime prevention in ancient<br />
Rome. The offenses in the historical evolution of ancient Rome. The prosecution<br />
and the formation of a practice procedural criminal. The penitentiary<br />
system between jail and custody.<br />
Keywords: Ancient Rome, punishment, crime, prison, jail,<br />
process, custody, jurisprudence.<br />
1. I reati nell’evoluzione storica della Roma antica<br />
1.1. Premessa<br />
Ricorda Edoardo Volterra 2 che, per indicare il termine reato, i<br />
Romani adoperavano altri vocaboli quali, scelus, fraus, peccatum,<br />
probrum, malefi cium, delictum, crimen e fl agitium. I primi quattro non<br />
hanno mai avuto un preciso signifi cato tecnico-giuridico (scelus,<br />
fraus, peccatum, probrum); i termini delictum e malefi cium indicano<br />
invece presso i giuristi classici, l’atto illecito punito dallo ius civile<br />
con pena privata; crimen l’atto illecito punito con pena pubblica;<br />
fl agitium indica, altresì, e in senso generale, una cosa turpe e vergognosa<br />
e in senso più ristretto il reato militare o quello contro<br />
il buon costume.<br />
1 Ettore Tomassi dottore in Scienze dei Servizi Giuridici per Operatore<br />
Giudiziario. Il presente studio prosegue quello comparso in questa rivista [2<br />
(14) / 2009, pp. 209-255].<br />
2 Alla voce Reato- diritto romano, in EI, XXVIII, 1935, pp. 941-943 ed ivi in<br />
particolare p. 942.<br />
<strong>Caietele</strong> <strong>Institutului</strong> <strong>Catolic</strong> IX (2010, 1) 131-168
132 ETTORE TOMASSI<br />
D’altra parte, aggiungeva il Volterra, fra i giuristi romani,<br />
abbiamo un concetto ben chiaro del reato: essi consideravano<br />
l’infrazione di una norma giuridica (D XXXXVIII, 4, 7, 3). Da<br />
qui discendeva il principio della retroattività della norma penale<br />
(Cicerone, In Verrem, 2, 1; Novella 7, 13 e 72, 2, 2).<br />
Il reato doveva consistere in un positivus voluntatis actus contrario<br />
alla norma o un’omissione (D 25, 3,4) riferita ad una norma giuridica<br />
generale che impone ad operare e che quindi non si ammette<br />
che per casi singoli determinati (così D 50, 16, 131, pr.).<br />
La pena quindi che segue all’atto positivo contrario, non va confusa<br />
con un atto–provvedimento di polizia. Questa volontà antigiuridica<br />
del soggetto agente diretta a ledere la norma e quindi il<br />
diritto altrui, deve essere chiara e precisa, deve cioè avvenire intenzionalmente,<br />
ad obtinendum effectum patrato: in altre parole, con<br />
dolo. Ma se ciò è vero, nel diritto delle origini a partire da Adriano<br />
intervengono ad attutire la presenza del dolo, i concetti di impetus,<br />
rixa ed ebrietas fi no a considerare l’omicidio colposo da punire<br />
extra ordinem.<br />
Soggetto del reato è solo la persona fi sica, per cui per l’operato<br />
delle persone giuridiche ne rispondono le sole persone fi siche<br />
che le costituiscono e le rappresentano.<br />
Alcune delle condizioni fi siche o giuridiche della persona possono<br />
costituire attenuanti in determinati reati, ma non l’ignorantia<br />
legis che viene presa in considerazione solo nel diritto postclassico<br />
come scusante per alcune categorie di persone. Esclude poi il reato,<br />
il consenso del danneggiato. Viene preso in considerazione anche<br />
il caso del concorso di più reati e il Volterra 3 ritiene che nei reati<br />
pubblici si riunissero di solito insieme i vari reati in una sola<br />
pronunzia.<br />
3 Cfr. ibidem.<br />
<strong>Caietele</strong> <strong>Institutului</strong> <strong>Catolic</strong> IX (2010, 1) 131-168
Il sistema punitivo e penitenziario in epoca romana (II)<br />
133<br />
E’ discusso nella dottrina se ci fossero i gradi del reato. Il Costa 4<br />
ritiene invece che la dottrina classica ravvivasse suffi ciente per<br />
applicare la pena, la volontà criminosa con atti concludenti di<br />
preordinazione ed esecuzione; mentre nel diritto giustinianeo<br />
occorresse il raggiungimento dell’esito criminoso voluto dall’agente<br />
o comunque la violazione del diritto tutelato dalla legge penale.<br />
1.2. I reati di diritto privato (delicta)<br />
I reati di diritto privato (delicta) sono, come si è già rilevato<br />
nella parte introduttiva, quattro: furto, rapina, iniuria, damnum iniuria<br />
datum.<br />
Per quanto riguarda la rapina va ricordato con Ugo Brasiello<br />
che questo istituto “non ha un nome specifi co in diritto romano,<br />
ma è indicata con la perifrasi bona vi rapta, onde l’actio vi bonorum<br />
raptorum. Essa è, in diritto romano, uno dei quattro delitti privati<br />
(furto, bona vi rapta, iniuria, damnum iniuria datum), perseguiti cioè<br />
con azione privata, e diretti ad una pena pecuniaria, che tiene<br />
forse luogo della vendetta primitiva.<br />
Mentre nel diritto greco la rapina era tenuta distinta dal furto,<br />
vedendosi in questo un reato contro la proprietà, in quella contro<br />
la persona, nel diritto romano più antico, essa è, viceversa, un<br />
caso di furto: furto commesso con violenza, il cui autore era<br />
particolarmente improbus (Gai., 3, 209). Diviene autonomo nel I<br />
secolo a. Cr per opera del pretore.<br />
Consta, infatti, che nel 66 a.C. il pretore Lucullo istituì una<br />
pena del quadruplo valore delle cose nelle ipotesi (secondo il<br />
riferimento del fr. 2, pr., D, de vi bon. rapt. et de turba, 47, 8) «si cui<br />
dolo malo hominibus coactis danni quid factum esse dicetur, sive cuius bona<br />
rapta esse dicentur...». Si è per altro dubitato se l’editto sulla rapina<br />
sia proprio quello di Lucullo, ritenendosi da alcuni che Lucullo<br />
4 In Crimini e pene da Romolo a Giustiniano, Bologna 1921 e in Il criminoso in<br />
diritto romano, in BIDR, 1921 ed ivi infra.<br />
<strong>Caietele</strong> <strong>Institutului</strong> <strong>Catolic</strong> IX (2010, 1) 131-168
134 ETTORE TOMASSI<br />
abbia voluto reprimere solo il danneggiamento fatto da bande<br />
armate, e più tardi, non potendosi distinguere danneggiamento<br />
da appropriazione, l’editto si sia dovuto estendere anche a queste:<br />
onde il riferimento ai bona vi rapta sarebbe un’aggiunta posteriore<br />
e non appartenente al testo edittale. Altri ha sostenuto che l’editto<br />
di Lucullo si riferisse anche alle rapine, ma solo a quelle che rappresentassero<br />
usurpazioni, fatte a scopo di sopraffazione rivoluzionaria,<br />
mentre la rapina vera e propria, individuale, sarebbe stata<br />
considerata da un editto posteriore (vi bonorum raptorum).<br />
Il Ferrini difende l’opinione che l’editto sia unico, adducendo<br />
a sostegno, tra l’altro, che già la lex Plautia, contemporanea<br />
all’editto di Lucullo, distingue, agli effetti dell’usucapione, le res vi<br />
possessae dalle furtivae, il che mostra che già vi era il concetto autonomo<br />
dei bona vi rapta. Certo è che in ogni caso dovette esservi<br />
una estensione, operata dalla giurisprudenza, e molto larga se<br />
l’editto fu uno solo, dato che questo, parlando di bona al plurale,<br />
conteneva in sé l’idea della usurpazione di un complesso di cose,<br />
mentre lo si applicò anche all’ablazione di una singola cosa.<br />
L’origine della rapina come autonoma è quindi in ogni caso<br />
praetoria. Essa venne però considerata fra le obligationes quae ex<br />
delicto nascuntur, e quindi fra i delitti del ius civile, perché si guardò<br />
la sua derivazione dal furto. L’azione è diretta al quadruplo valore<br />
delle cose estorte e, come tutte le azioni praetorie, è annuale; viene<br />
però sostituita dopo l’anno da un’azione in factum diretta al simplum.<br />
Per i principi generali delle azioni penali pare fosse cumulabile<br />
con l’actio furti, e che oltre di essa si potesse intentare l’azione<br />
rei persecutoria per il valore delle res. Ben presto però tali principi si<br />
attenuarono. Quanto all’azione di furto, la giurisprudenza, essendo<br />
la rapina, in fondo, compresa nel vasto concetto di furto, apportò<br />
delle limitazioni, vietando che il magistrato potesse concedere<br />
l’actio furti dopo di quella di rapina; è dubbio, viceversa se, intentata<br />
prima l’actio furti, fosse concessa l’actio vi bonorum raptorum<br />
<strong>Caietele</strong> <strong>Institutului</strong> <strong>Catolic</strong> IX (2010, 1) 131-168
Il sistema punitivo e penitenziario in epoca romana (II)<br />
135<br />
nella misura solita del quadruplo, o per il doppio. E’ stato detto<br />
che le due azioni sono concentriche nel senso che, intentata<br />
quella di rapina essa assorbe l’actio furti; intentata quella di furto,<br />
si possa sperimentare l’altra per il di più. Questo per la tendenza<br />
già dei giureconsulti classici, e di cui forse fu esponente Paolo, a<br />
limitare l’eccessivo arricchimento della parte lesa. Quanto<br />
all’azione rei persecutoria, già al tempo di Gaio si dubitava pure se<br />
essa non dovesse già ritenersi compresa nel quadruplo della vi<br />
bonorum raptorum.<br />
Giustiniano conserva il quadruplum, ma considera l’azione<br />
come mixta: diretta cioè al risarcimento per il simplum (che si<br />
perpetua oltre l’anno), e alla pena per il triplum (che si estingue<br />
nell’anno). Molti casi di rapina avevano una persecuzione pubblica,<br />
rientrando nel crimen vis. Altri l’assunsero più tardi, venendo<br />
repressi extra ordinem. Il pretore concesse un’azione in quadruplum<br />
(e in simplum se esperita oltre l’anno) contro chi commette delle<br />
rapine - e dei danneggiamenti - in occasione di incendi, terremoti,<br />
naufragi, assalti di pirati” 5 .<br />
Per quanto attiene al damnum iniuria datum, sottolinea l’Albanese,<br />
“con questa espressione si designa (i Romani in genere adoperano<br />
più brevemente: damnum iniuria; tuttavia, damnum iniuria datum si<br />
ritrova in D, 9, 2, 49, 1) la più importante fi gura di danneggiamento<br />
prevista dall’ordinamento giuridico romano, la quale concreta<br />
un illecito produttivo di obligatio, o, che è lo stesso, un delitto<br />
privato del ius civile. In età molto risalente, decemvirale e postdecemvirale,<br />
erari previsti e puniti numerosi comportamenti dannosi<br />
tipici.<br />
Una prescrizione più generale sul danneggiamento si ebbe<br />
solo con la lex Aquilia, un plebiscito di età incerta cui appunto fa<br />
capo la nozione di damnum iniuria. Questa legge non abrogò le<br />
5 Cfr. s.v. rapina, in Nov. Dig. It., XIV, 1967, rist. 1982, pp. 767-768.<br />
<strong>Caietele</strong> <strong>Institutului</strong> <strong>Catolic</strong> IX (2010, 1) 131-168
136 ETTORE TOMASSI<br />
precedenti disposizioni cui si accennava, ma le rese in pratica di<br />
scarsa importanza in età avanzata.<br />
Le ipotesi previste dalla lex Aquilia erano: a) occisio di un servo<br />
o di un quadrupede che fosse pecudum numero, cioè appartenente<br />
al comune bestiame domestico e agricolo. Il signifi cato tecnico<br />
di occisio fu quello di uccisione realizzata mediante contatto materiale<br />
tra danneggiante e vittima (corpore corpori), probabilmente<br />
per stabilire un criterio facile ed universale di imputabilità. La<br />
pena era costituita dall’obbligo di pagare il maggior prezzo della<br />
vittima nell’anno precedente all’uccisione: questa valutazione, in<br />
pratica, poteva essere assai rilevante anche tenuto conto di alcune<br />
circostanze caratteristiche (ad es.: servo istituito erede, cavallo<br />
facente parte d’una quadriga ..., cfr. Gai., 3, 212 e 214, D, 9, 2,<br />
21-23); b) urere, frangere, rumpere: cioè ogni distruzione di oggetti<br />
che non fossero servi o animali del tipo già visto e ogni materiale<br />
danneggiamento di cose (compresi i servi e gli animali indicati)<br />
che, pur senza distruggerle, ne annullasse o diminuisse il prezzo.<br />
Anche per questa ipotesi era richiesta l’azione corpore corpori. La<br />
pena era l’obbligo di pagare il maggior prezzo della cosa nei 30<br />
giorni precedenti al danneggiamento.<br />
Le due ipotesi riportate erano rispettivamente previste al capitolo<br />
I e al capitolo III della legge; esisteva un capitolo II che<br />
presto andò in desuetudine.<br />
Alcuni caratteri comuni ad entrambe le fattispecie riportate<br />
erano previsti dalla legge: a) l’azione deve essere compiuta iniuria,<br />
cioè contra ius; b) l’azione per il risarcimento spetta solo al dominus<br />
della cosa danneggiata.; c) la condanna è nel duplum dei valori<br />
indicati per il risarcimento se il convenuto nega, nel simplum si<br />
confessa; d) contro il danneggiante è data un’azione esecutiva, la<br />
manus iniectio. Carattere comune a tutte le azioni penali, alla cui<br />
categoria appartiene anche l’azione in questione, era quello della<br />
nossalità: l’azione era esperibile contro il padre o il padrone del<br />
<strong>Caietele</strong> <strong>Institutului</strong> <strong>Catolic</strong> IX (2010, 1) 131-168
Il sistema punitivo e penitenziario in epoca romana (II)<br />
137<br />
danneggiante se questi era fi liusfamilias o servo; in questo caso il<br />
convenuto aveva la scelta tra il subire la condanna o il consegnare<br />
l’autore del danno al danneggiato. L’azione si designa: actio damni<br />
iniuria, o actio damni iniuriae, o, meglio, actio legis Aquiliae o ex lege<br />
Aquilia: ex I vel ex III capite.<br />
Attorno alle regole brevemente richiamate si svolge per secoli<br />
un’intensissima e geniale interpretazione da parte della giurisprudenza<br />
repubblicana e imperiale che induce modifi cazioni<br />
pratiche di grande rilievo ad opera del pretore. Tale elaborazione<br />
- che è uno dei capolavori del senso giuridico romano - si può<br />
raccogliere fondamentalmente nei seguenti indirizzi: a) analisi del<br />
nesso di causalità: in particolare si contemplò la possibilità di una<br />
causalità omissiva e si previde una actio in factum ad exemplum legis<br />
Aquiliae per talune ipotesi di danno causato con omissione; b)<br />
superamento della nozione meramente obiettiva di «iniuria», mediante<br />
fi nissima analisi concreta della colpa; c) superamento del requisito<br />
della materialità dell’azione dannosa: si concesse una actio utilis ex lege<br />
Aquilia per ipotesi di danno non corpore (cfr. Gai., 3, 219); d) superamento<br />
del requisito della materialità del danno: si estese la tutela aquiliana<br />
a ipotesi di danno non corpori (o rebus integris), mediante la<br />
concessione di una actio in factum ad exemplum legis Aquiliae; e) estensione<br />
della legittimazione attiva, mediante actio utilis ex lege Aquilia,<br />
all’usufruttuario, al possessore di buona fede e al comodatario<br />
della cosa danneggiata, nonché al padre per le lesioni subite dal<br />
fi glio.<br />
Risultato di questa grandiosa opera di interpretazione è la<br />
formazione di una nozione di damnum iniuria ben più generale e<br />
vicina a quella moderna che non quella originariamente prevista<br />
dal plebiscito aquiliano. Tale elaborazione, nelle linee evolutive<br />
brevemente accennate, si compì tutta in età classica. Dal punto<br />
di vista dogmatico essa fu estremamente importante anche per il<br />
contributo che fornì alla sempre più netta precisazione di altre<br />
<strong>Caietele</strong> <strong>Institutului</strong> <strong>Catolic</strong> IX (2010, 1) 131-168
138 ETTORE TOMASSI<br />
fi gure di illecito assai vaghe (furtum e dolus, soprattutto), le quali<br />
videro sempre meglio determinarsi il rispettivo ambito in seguito<br />
al graduale estendersi della tutela aquiliana ad ipotesi già considerate<br />
furtum e dolus.<br />
Ben poco, sostanzialmente; aggiunse a questi risultati l’elaborazione<br />
post-classica e giustinianea: di origine non classica sono<br />
certamente le estensioni della legittimazione attiva aquiliana al<br />
creditore pignoratizio e al locatario (cfr. D, 9, 2, 11, 10; D, 9, 2,<br />
17; D, 9, 2, 30, 1; D, 9, 2, 27, 14, tutti gravemente interpolati). Più<br />
importante, sul piano formale, è la riforma giustinianea che; in<br />
conformità a mutate esigenze processuali, eliminò ogni distinzione<br />
tra actio legis Aquiliae, actio utilis ex lege Aquilia e actio in factum<br />
ad exemplum legis Aquiliae: infatti, l’indifferenziazione che ne<br />
risultò spianò la strada alla formazione - esplicitamente, peraltro,<br />
neppure tentata da Giustiniano - d’una generalissima fi gura di<br />
danno corrispondente, ad es., a quella dell’art. 2043 Codice Civile<br />
italiano. Importantissimi, comunque, a questo fi ne sono due testi<br />
di integrale fattura giustinianea, che mostrano come, implicitamente,<br />
una vastissima nozione di danno balenasse già in età<br />
giustinianea. Le basi essenziali di tale intuizione, tuttavia, si trovano<br />
interamente nell’elaborazione mirabile della giurisprudenza<br />
classica” 6 .<br />
Per quanto riguarda il furto, e sempre rifacendoci al Brasiello<br />
va innanzi tutto detto che esso è uno dei quattro delitti privati<br />
del ius civile: degli illeciti cioè repressi con pena patrimoniale, e<br />
perseguiti con le forme del processo cosiddetto privato. Ciò non<br />
esclude che, in epoca classica, affermatasi la cognitio extra ordinem<br />
alcune ipotesi più gravi formassero oggetto di repressione pubblica,<br />
straordinaria. “Nell’epoca decemvirale il furto veniva distinto<br />
in vari modi, collegantisi, a volte, con antichi riti ed antiche<br />
6 Cfr. s.v. Damnum iniuria datum, in Nov. Dig. It., V, 1960, rist. 1981, pp. 110<br />
– 111.<br />
<strong>Caietele</strong> <strong>Institutului</strong> <strong>Catolic</strong> IX (2010, 1) 131-168
Il sistema punitivo e penitenziario in epoca romana (II)<br />
139<br />
costumanze. Le classifi cazioni riguardavano soprattutto la posizione<br />
del colpevole nel momento in cui era scoperto. Si distingueva<br />
così il fur manifestus (cioè colto in fl agrante) dal nec manifestus;<br />
il furtum conceptum, quando vi era stata una solenne perquisizione<br />
lance licioque (cioè, in rispondenza forse di antichi riti magici, con<br />
un piatto in mano e in camicia); prohibitum, quando il ladro si rifi<br />
utava ad essere perquisito; oblatum, quando la cosa fosse stata<br />
trovata presso un terzo, il quale esercitasse la vendetta contro il<br />
vero ladro.<br />
Vi è notevole differenza tra la sanzione del furto fl agrante e<br />
quella del furto non fl agrante, in quanto nel primo caso il ladro<br />
poteva, in epoca più antica, essere messo a morte o consegnato<br />
al derubato, ed in epoca più recente era condannato al, quadruplo<br />
valore della cosa. Tale singolarità ha dato luogo a discussioni, e a<br />
molti tentativi di soluzione. È stato senz’altro escluso che nel<br />
furtum manifestum si vedesse un crimine pubblico, in quanto per la<br />
repressione del crimine pubblico occorre l’intervento degli organi<br />
dello Stato, mentre nella specie la persecuzione è sempre privata.<br />
Infatti anche pel furto notturno, che forse costituì sempre una<br />
ipotesi a parte, le XII Tavole affermano (Tab. 8, 12): «si nox furtum<br />
faxit, si im (= eum) occisit, iure caesus esto», riferendosi così sempre<br />
alla vittima che si vendica. Si è invece ritenuto che tale caratteristica<br />
differenza si connettesse alle più antiche forme processuali:<br />
nel caso del furtum manifestum, attraverso una procedura analoga<br />
alla manus iniectio (che è la apprensione materiale del debitore da<br />
parte del creditore, il quale ha diritto di tenerlo legato a casa sua<br />
per un certo tempo, e poi, se non sia soddisfatto da altri, di metterlo<br />
a morte), si faceva luogo alla immediata addictio, cioè assegnazione<br />
del colpevole al derubato, il quale può poi anche ucciderlo.<br />
Tale assegnazione si ebbe più tardi, anche in ipotesi di furto non<br />
fl agrante.<br />
<strong>Caietele</strong> <strong>Institutului</strong> <strong>Catolic</strong> IX (2010, 1) 131-168
140 ETTORE TOMASSI<br />
La pena del quadruplo si è ritenuto venisse raggiunta qualora<br />
il ladro colto in fl agrante, il quale, in quanto ladro, per una norma<br />
delle XII Tavole doveva essere già condannato al duplum del valore<br />
della cosa, invece di riconoscere il delitto commesso, si opponesse<br />
all’azione del danneggiato. In tale ipotesi, pel principio<br />
generale del raddoppiamento del valore della lite adversus infi tiantem,<br />
cioè adversus eum qui negat, la pena si raddoppiava ancora, raggiungendo<br />
il quadruplo.<br />
Nelle ipotesi di furto conceptum, o oblatum, o prohibitum, la pena<br />
raggiungeva il triplo.<br />
Il furto in epoca storica ha una comprensione piuttosto elastica,<br />
in quanto i testi lo confi gurano variamente. Certo è che<br />
esso non comprese soltanto l’amotio di cosa mobile altrui, ma il<br />
tangere, l’adtrectare, ed ogni contrectatío, cioè ogni illecita ingerenza<br />
sulla cosa. Da Gellio (N. A., XI, 18, 13) si ricaverebbe la notizia<br />
di furtum anche fundi o aedium. Si discute se Sabino ammettesse la<br />
possibilità di un furtum sine contrectatione, sola mente ac animo (Gell.,<br />
IX, 18, 23-24). Certo per alcuni veteres era furto anche il semplice<br />
animus infi tiandi depositum (D, 41, 2, 3, § 18); era furto la perdita<br />
delle mule prodotta chiamando in ius dolosamente il mulio (D, 47,<br />
2, 47, § 2); il nascondere il servus fugitivus; il fugare armentum panno<br />
rubro; il comando di rubare dato al servo dal padrone; la consegna<br />
del servo altrui al praefectus vigilum sotto falsa accusa (Proc. D,<br />
12, 4, 15).<br />
Vi può essere anche furto della cosa propria (furtum possessionis),<br />
qualora il debitore la sottragga al credi-tore pignoratizio. Per<br />
Celso sembra essere furto anche l’interversio possessionis (D, 47, 2,<br />
68, pr.).<br />
Se un concetto generico, vastissimo e obiettivo di furto rimase,<br />
devesi per altro ritenere che, per la creazione di nuove forme di<br />
illecito più precise e meno indeterminate, per l’introduzione del<br />
iudicium del dolo, per l’estensione della tutela aquiliana, per la<br />
<strong>Caietele</strong> <strong>Institutului</strong> <strong>Catolic</strong> IX (2010, 1) 131-168
Il sistema punitivo e penitenziario in epoca romana (II)<br />
141<br />
perfezionata tutela contrattuale di rapporti come il deposito, il<br />
pegno, il mandato, la compravendita (alcune ipotesi di inesecuzione<br />
dei quali erano prima perseguite con l’actio furti), pel processo<br />
evolutivo dell’actio servi corrupti, ecc., il concetto specifi co<br />
del furto si venne restringendo e precisando. Su tale fenomeno<br />
dovette infl uire anche l’affi narsi in genere della coscienza giuridica,<br />
e l’affermarsi dell’elemento subiettivo dell’animus furandi.<br />
Il furto viene commesso non solo ope, ma anche consilio, onde<br />
è reo di furto, oltre il favoreggiatore, anche l’istigatore. È considerato<br />
perseguibile con l’actio furti anche chi aiuta il ladro dopo il<br />
furto, per dare ricetto alle cose rubate, o per trasportarle (D, 47,<br />
2, 35, pr.; 48, § 1; C, 6, 2, 14).<br />
Occorre, da parte dell’agente, l’elemento intenzionale del dolus<br />
malus. Si richiede anche la scientia, e non si ammette reato putativo.<br />
A proposito della contrectatio, si dice che deve essere fraudulosa;<br />
occorre che sia realizzata invito domino.<br />
I testi richiedono poi il requisito dell’animus furandi e talora<br />
dell’aninius lucri faciendi. La critica interpolazionistica più radicale<br />
(specialmente Huvelin, Albertario) ha ritenuto non classici questi<br />
due requisiti, sostenendo che i Romani non guardassero lo scopo<br />
per il quale alcuno si ingeriva della cosa altrui contro la volontà<br />
del proprietario, se cioè fosse quello di lucro, e non guardassero<br />
nemmeno se la intenzione fosse quella di appropriarsi della cosa:<br />
ma che fosse suffi ciente che alcuno si comportasse, volontariamente,<br />
in modo non conforme al desiderio del dominus. Quindi<br />
nella defi nizione del furto di cui al fr. 1, § 3, D, de furtis, 47, 2<br />
(furtum est contrectatio rei fraudulosa lucri faciendi gratia vel ipsius rei vel<br />
etiam usus eius possessionísve. Quod lege naturali prohibitur est admittere)<br />
si ritennero come appartenenti sicuramente al giureconsulto<br />
Paolo solo le prime parole (furtum est contrectatio rei fraudulosa).<br />
Contro tale tesi - che si inquadra nella lotta, per dir così, condotta<br />
contro l’animus in tutti i suoi aspetti, e contro la quale vi è<br />
<strong>Caietele</strong> <strong>Institutului</strong> <strong>Catolic</strong> IX (2010, 1) 131-168
142 ETTORE TOMASSI<br />
stata la vigorosa reazione del Riccobono e di altri - si è levata una<br />
critica più recente, che ha riesaminato dettagliatamente i testi.<br />
Tenendo conto delle sue risultanze devesi dire con suffi ciente<br />
sicurezza che, se il concetto obiettivo - che si collega alla comprensione<br />
vastissima di furtum sopra accennata - dovette esservi<br />
certamente in epoca più antica, e se, dall’altro lato, i postclassici<br />
ed i compilatori hanno ancor più accentuato l’elemento subiettivo,<br />
certo è che questo fu preso (qui come altrove) in considerazione<br />
dai giureconsulti, e già da quelli della prima epoca classica. La<br />
dimostrazione non può darsi qui. La defi nizione sopra citata<br />
quindi, anche se ritoccata dai compilatori, rende per altro il pensiero<br />
di Paolo.<br />
L’actio furti, come ogni azione ex delicto, tende ad una pena<br />
pecuniaria, che costituisce una punizione pel colpevole, ed una<br />
riparazione per l’offeso. Essa è quindi diretta ad un multiplo del<br />
valore della cosa, conservandosi l’antico duplum, o triplum, o quadruplum.<br />
Essendo penale, è nossale: se il fatto è commesso da un sottoposto,<br />
il dominus può liberarsi dandolo a noxa, ammenocchè<br />
non sia sciens.<br />
L’azione è anche infamante, ed appunto per questo carattere<br />
in diritto giustinianeo fu sostituita, in omaggio al principio della<br />
reverentia tra coniugi, da una condictio ex iusta causa, fi nché durava<br />
il matrimonio, e da un’actio rerum amotarum, dopo lo scioglimento,<br />
qualora l’azione si dovesse intentare da uno di essi per cose sottratte<br />
dall’altro. Pel diritto classico, è dubbio se l’actio rerum amotarum<br />
non avesse essa pure carattere penale, e si adoperasse invece<br />
dell’actio furti non perché di diversa natura, ma per un derivato<br />
dal matrimonio cum manu. Perciò forse trovava applicazione solo<br />
nei riguardi della moglie.<br />
L’azione concorre poi con l’azione rei persecutoria diretta al risarcimento,<br />
detta condictio furtiva, lasciandosi salvo al derubato<br />
<strong>Caietele</strong> <strong>Institutului</strong> <strong>Catolic</strong> IX (2010, 1) 131-168
Il sistema punitivo e penitenziario in epoca romana (II)<br />
143<br />
anche, se possibile, l’esperimento della rei vindicatio. L’actio furti<br />
compete non solo al proprietario, ma a chiunque interest rem salvam<br />
esse. Quindi anche al comodatario, all’assuntore di opera, forse<br />
anche al creditore pignoratizio, al conduttore di cosa, e ad altri, i<br />
quali, essendo responsabili per custodia - il che faceva sì che non<br />
fossero esonerati pei casi fortuiti, tra cui è il furto - vigendo cioè<br />
per essi, secondo si ritiene, il principio della responsabilità obiettiva,<br />
hanno interesse a poter perseguire essi stessi il ladro.<br />
Nell’epoca antichissima dovette essere represso con pena<br />
pubblica oltre il furto commesso dallo schiavo, punito col lancio<br />
dalla rupe Tarpea, forse il solo furto notturno delle messi: ipotesi<br />
dubbia, e che in ogni caso, andò presto in desuetudine. Invece<br />
sotto l’Impero vennero puniti extra ordinem con sanzioni pubbliche<br />
molte ipotesi più gravi, come l’abigeato, il furto con effrazione o<br />
scalata, il furto balneario; ed il crimine speciale della expilatio hereditatis.<br />
Le pene sono varie, e vanno dalla relegazione e dalla remotio ab<br />
ordine per gli honestiores all’opus publicum per gli humiliores. Nelle<br />
ipotesi di repressione straordinaria già nell’epoca classica avanzata<br />
si dovè parlare di criminaliter agere: onde l’esperimento dell’azione<br />
privata si incominciò ad indicare come civiliter agere, vedendosi<br />
in essa la sola funzione di risarcimento” 7 .<br />
Ed infi ne, per quanto riguarda l’iniuria, l’Albanese così si<br />
esprime: “l’iniuria, nel senso vastissimo attribuito a questa parola,<br />
designa ogni atto contrario al diritto, ogni violazione dell’ordinamento<br />
giuridico, in contrapposto a ius. Questo signifi cato si conserva<br />
anche presso i giuristi dell’epoca più tarda nelle note defi nizioni<br />
del concetto di iniuria (I. 1 pr. D. 47, 10; Coll. 2, 5, 1: «Omne<br />
quod non iure fi t iniuria fi eri dicitur; generaliter dicitur iniuria quod non<br />
iure fi t»). In un senso più ristretto il termine iniuria designa il<br />
delitto o meglio molteplici e svariati delitti che si comprendono<br />
sotto questa denominazione e che riguardano in genere la lesione<br />
7 Cfr. s.v. Furto, in Nov. Dig. It, VII, 1961, rist. 1981, pp. 691-693.<br />
<strong>Caietele</strong> <strong>Institutului</strong> <strong>Catolic</strong> IX (2010, 1) 131-168
144 ETTORE TOMASSI<br />
personale con vie di fatto, e, più tardi, l’offesa all’onore di un<br />
individuo o alla sua condizione giuridica. Le controversie che<br />
attengono alla natura del delitto di iniuria sono diffi cili a risolversi.<br />
Questo delitto e uno dei più antichi ed oscuri del diritto romano<br />
e d’altro canto non è inteso nello stesso modo in ogni epoca.<br />
Occorre pertanto distinguere la nozione dell’iniuria secondo le<br />
XII Tavole da quella più lata ottenuta con l’Editto del pretore,<br />
con la lex Cornelia de iniuriis e, infi ne, con la giurisprudenza. Avvertiamo<br />
che il linguaggio tecnico adopera la parola iniuria nel<br />
senso ristretto.<br />
Quanto alla storia dell’iniuria in senso stretto:<br />
a) XII Tavole. - La legge decemvirale contempla tre fi gure delittuose<br />
che rientrano nell’iniuria: 1° La membri ruptio: «si membrum<br />
rupsit, ni cum eo pacit talio esto» (Tav. VIII-2). Essa riguarda la mutilazione<br />
di un membro del corpo punita col taglione. L’autore<br />
deve subire la stessa mutilazione cui egli ha dato causa. La determinazione<br />
dell’ammontare del danno era lasciata alla discrezione<br />
dell’offeso non esistendo alcuna norma in proposito; 2° l’os fractum<br />
(«si manu fustive libero os fregit CCC, si servo CL») dava luogo<br />
(Tavola VIII-3) ad una composizione legale nella misura di 300<br />
assi, se l’offeso era libero, e di 150, se l’offeso era uno schiavo; 3°<br />
l’iniura pura e semplice, certo di origine più recente, cioè lesioni<br />
minori che includono altre offese corporali. Per queste è fi ssata<br />
la pena di 25 assi. Non sembra dovesse rientrare nel concetto di<br />
iniuria, di cui sopra, il malum carmen incantare (inteso da Cicerone<br />
e anche da Orazio nel senso di un componimento poetico avente<br />
carattere diffamatorio) che molto probabilmente si riferiva a formule<br />
magiche per scongiurare potenze malefi che. L’azione d’iniuria è<br />
intrasmissibile agli eredi.<br />
b) Diritto pretorio. - Il delitto di ingiuria, quale appare nella più<br />
tarda repubblica e nel periodo del principato, ha trasformato<br />
completamente sia gli elementi di fatto sia gli effetti giuridici<br />
<strong>Caietele</strong> <strong>Institutului</strong> <strong>Catolic</strong> IX (2010, 1) 131-168
Il sistema punitivo e penitenziario in epoca romana (II)<br />
145<br />
derivanti dall’ingiuria. Per un lato appariva troppo rigorosa ed<br />
inumana la pena del taglione comminata per l’os fractum, e dall’altro<br />
troppo tenue quella infl itta per le lesioni più lievi e diventata<br />
ormai ridicola con la progressiva svalutazione del denaro. Sorgeva<br />
pertanto l’esigenza di sostituire altre pene pecuniarie che fossero<br />
adeguate al nuovo stato di cose, che attribuissero inoltre al giudicante<br />
una maggiore libertà di apprezzamento, da applicare perciò<br />
in diversa misura nei singoli casi. Oltre a ciò il senso dell’onore,<br />
sempre più suscettibile ed affi nato, condusse a comprendere nel<br />
concetto di iniuria, mediante una interpretazione estensiva dei<br />
singoli casi discussi dalla pratica e dalla giurisprudenza, tutti i<br />
casi di offesa dell’onore.<br />
Ad un generale edictum (D, 47, 10, 15, § 26) la cui fonte è l’actio<br />
iniuriarum esperibile dinanzi ai recuperatores, a quanto pare, seguono<br />
editti speciali che accennano a particolari presupposti di fatto: de<br />
convicio che contempla l’offesa all’onore di una persona mediante<br />
clamori ingiuriosi, un chiaro e pubblico insulto che cagiona l’odio<br />
ed il disprezzo altrui; de adtemptata pudicizia, diretto contro le offese<br />
al pudore delle donne e della gioventù, anche se consistevano<br />
in un semplice inseguimento o in parole non corrette o fuor di<br />
luogo rivolte ad esse mediante appellari, adsceptare, comitem abducere;<br />
ne quid infamandi causa fi at che riguarda l’offesa all’onore dell’individuo<br />
in più vasta misura, cioè contro atti nocivi alla considerazione<br />
altrui.<br />
La giurisprudenza riunì poi le azioni che derivavano dagli<br />
editti speciali sotto un’unica denominazione di actio iniuriarum<br />
aestimatoria perché in sostanza esse si ispiravano allo stesso punto<br />
di vista.<br />
Si sostiene da alcuni che l’Editto abbia in un periodo più antico<br />
introdotto un iudicium diretto alla sola stima in denaro<br />
dell’ingiuria patita, in luogo delle pene comminate nella legge<br />
delle XII Tavole; questo iudicium più tardi sarebbe venuto meno,<br />
<strong>Caietele</strong> <strong>Institutului</strong> <strong>Catolic</strong> IX (2010, 1) 131-168
146 ETTORE TOMASSI<br />
con la introduzione della nuova azione. Ma questa tesi non è da<br />
accogliere e non è del resto dimostrata.<br />
E’ assai probabile che il diritto del pretore in materia di iniuria<br />
sia di origine greca. La romana iniuria corrisponde alla hybris greca<br />
nel suo signifi cato più comprensivo (Inst. IV, 4, pr.). Il trapasso<br />
dalle norme fi sse delle XII Tavole all’ammenda privata, da stabilirsi<br />
dal giudice di volta in volta, è da ricondurre a modelli greci.<br />
Ciò trova conferma nel fatto che la parte dell’Editto che è<br />
riprodotta in Collatio, 2, 6, 1 riproduce, come è stato opportunamente<br />
osservato, una disposizione del diritto alessandrino le cui<br />
norme sono pervenute mediante il ritrovamento di un papiro in<br />
materia.<br />
Nel diritto pretorio l’antica idea dell’iniuria (lesione fi sica) cede<br />
il posto a quella della contumelia (offesa morale).<br />
L’estensione del concetto di iniuria ad ogni lesione del diritto<br />
di personalità, conduce a riconoscere una difesa ad es. contro<br />
all’uso delle cose publico usui destinatae. Così l’azione si accorda<br />
anche per l’ingiuria arrecata al servus, e l’azione, salvo qualche<br />
particolare caso di usufrutto e di possesso in buona fede dello<br />
schiavo presso altri, normalmente si esperimenta dal dominus.<br />
c) Questa tendenza si accentua ancora più con la lex Cornelia<br />
di Silla che sanziona non solo le offese materiali, il verberare e il<br />
pulsare, ma anche la violazione di domicilio. Sembra che la pena<br />
fosse fi ssata in danaro e avesse come conseguenza l’intestabilità.<br />
Il giudizio nelle forme del processo penale era affi dato ad una<br />
delle giurie denominate quaestiones perpetuae, diretto però ad una<br />
pena pecuniaria. L’iniuria presuppone l’animus e l’affectus iniurandi,<br />
cioè il proposito, l’intenzione di compiere il fatto ingiurioso,<br />
nonché l’effettiva esistenza di questo.<br />
d) Della direttiva accennata che conduceva per via indiretta a<br />
sanzionare diritti patrimoniali (ad es., nella pena infl itta a chi fosse<br />
reo colpevole di violazione di domicilio), ebbe a servirsi la<br />
<strong>Caietele</strong> <strong>Institutului</strong> <strong>Catolic</strong> IX (2010, 1) 131-168
Il sistema punitivo e penitenziario in epoca romana (II)<br />
147<br />
giurisprudenza a partire dalla fi ne della Repubblica. Così ogni<br />
individuo che turba altri nell’uso di cose in suo potere, non importa<br />
a qual titolo, commette una iniuria, così pure i passi in un<br />
terreno altrui nonostante opposizione. Il carattere però del delitto<br />
contro la persona si mantiene inalterato nonostante il rilievo<br />
dato all’idea e all’interesse patrimoniale. L’offesa al patrimonio<br />
intanto opera ai fi ni della pena in quanto la lesione di un diritto<br />
si ripercuote sul titolare e ne diminuisce la personalità.<br />
e) La legislazione imperiale, la cui opera è riassunta nella legislazione<br />
giustinianea, persegue il fi ne di ricondurre il delitto privato<br />
entro il concetto di pena pubblica. In tal modo l’ambito di<br />
natura privata di questa specie di delitto si va riducendo sempre<br />
più alle più lievi lesioni e contumelie, o alle meno gravi lesioni<br />
della personalità dell’individuo. I crimina extraordinaria che prendono<br />
il posto delle quaestiones agevolano e favoriscono questa trasformazione<br />
in quanto i casi di ingiuria sono largamente compresi<br />
tra questi.<br />
Nel diritto giustinianeo il carattere meramente penale dell’azione<br />
è alquanto oscurato per il motivo che l’azione da far valere<br />
comprende anche il risarcimento del danno che deriva dall’iniuria<br />
(Cod. 9, 35, 8). L’offeso ha la scelta fra l’azione di ingiuria e la<br />
pena corporale infl itta extra ordinem mediante il magistrato.<br />
Alle considerazioni già fatte è da aggiungere che la differenza<br />
che si riscontra presso i giuristi tra iniuria levis e iniuria atrox consiste<br />
in ciò, che nell’una il pretore ha facoltà di accordare o negare<br />
l’azione secondo le circostanze, nell’altra l’azione compete secondo<br />
la legge, nè il magistrato può denegarla.<br />
L’actio iniuriarum aestimatoria (la formula di essa è assai discussa)<br />
è un’azione infamante in bonum et aequum concepta. L’azione è trattata<br />
dinanzi ai recuperatores, ma spesso si parla anche di un giudice.<br />
L’attore poteva deferire al convenuto il giuramento con la formula<br />
iniuriam se non fecisse (D, 47, 10, 5, 8).<br />
<strong>Caietele</strong> <strong>Institutului</strong> <strong>Catolic</strong> IX (2010, 1) 131-168
148 ETTORE TOMASSI<br />
La misura massima della condanna è determinata mediante<br />
taxatio. L’actio è intrasmissibile attivamente e passivamente prima<br />
della litis contestatio. Se l’attore non riesce a vincere con l’actio iniuriarum,<br />
allora egli è condannato con un iudicium contrarium ad un<br />
decimo della somma controversa” 8 .<br />
1.3. I reati di diritto pubblico (crimina)<br />
I reati di diritto pubblico, crimina, della repressione ordinaria<br />
sono quelli che o rimontano all’epoca della procedura comiziale<br />
o vennero valutati più tardi, ma sempre con leggi pubbliche. Essi<br />
sono, nell’elencazione del Brasiello, dal reato di procurato aborto<br />
in poi):<br />
a) Perduellio (derivante da per e duellum, cattiva guerra: cioè<br />
guerra al popolo romano) che è la denominazione più antica, di<br />
cui le prime furono quelle di colludenza coi nemici, o diserzione,<br />
represse fi n dalle XII Tavole, secondo il fr. 11, D. ad leg. Jul., 48,<br />
4, o addirittura di assunzione indebita di pubblici poteri. Vennero<br />
per la repressione di essa istituiti speciali magistrati, i duoviri perduellionis,<br />
e la pena di morte. Più tardi sopravvenne la denominazione<br />
più ampia di crimen maiestatis. Maiestas (forse da maius riferito<br />
alla posizione superiore, maggiore) designò forse in origine la<br />
posizione dei tribuni della plebe, ai quali non si adattava la parola<br />
podestà; poi si ampliò per indicare la maestà de popolo romano.<br />
Onde il crimine indicò in un primo tempo l’attentato ai tribuni,<br />
poi quello alla sicurezza del popolo, cioè allo Stato e, secondo il<br />
Mommsen, l’offesa all’imperatore, in quanto era considerato tribuno.<br />
Introdottesi le quaestiones, questo crimine fu regolato da<br />
una lex Cornelia de maiestate (81 a.C.); poi, forse, da una legge di<br />
Cesare, e fi nalmente da una lex Julia, dell’8 a.C., che, dopo aver<br />
parlato in genere di coloro qui laedunt maiestatem populi romani,<br />
8 Cfr. s.v. Damnum iniuria datum, in Nov. Dig. It., V, 1960, rist. 1981, pp. 110-<br />
111.<br />
<strong>Caietele</strong> <strong>Institutului</strong> <strong>Catolic</strong> IX (2010, 1) 131-168
Il sistema punitivo e penitenziario in epoca romana (II)<br />
149<br />
considerò oltre i casi precedenti ancora l’attentato al principe e<br />
la usurpazione di poteri del principe(fare leve militari, o tenere<br />
forze armate senza il suo comando), l’attentato e l’oltraggio ai<br />
magistrati, la sedizione, ogni vantaggio apportato ai nemici o a<br />
stranieri ai danni di Roma. Comprese pure casi diversi, come il<br />
falso nelle tabulae publicae, o il far fuggire il reo confesso. Occorre<br />
sempre il dolus malus e ed il reato può commettersi ope consiliove.<br />
La giurisprudenza estese poi questo concetto ad altre ipotesi<br />
nuove. Come. rei di maiestas vennero considerati i Cristiani, non<br />
perché l’avere altra religione per i Romani, politeisti, fosse considerato<br />
reato, ma perché i Cristiani non volevano fare onore al<br />
principe come divinità, venerare gli dèi dell’Impero e partecipare<br />
alle cerimonie pagane. Perciò l’intensità dell’applicazione delle<br />
pene contro di essi dipese dalle tendenze dei magistrati, dall’ambiente,<br />
e dagli ordini dell’imperatore.<br />
La pena della perduellio prima di Silla era la crocifi ssione (la<br />
croce esisteva già, come arbor infelix di Cerere). Dopo fu la capitale,<br />
cioè l’aqua et igni interdictio. Seguono il divieto della sepoltura<br />
e del tutto, oltre, naturalmente, la confi sca dei beni. Mentre poi<br />
la persecuzione di ogni altro reato si estingue con la morte, il<br />
giudizio contro i perduelles può essere continuato e perfi no iniziato<br />
anche dopo, potendosi avere anche la damnatio memoriae. In tal<br />
caso la persecuzione spetta al fi sco, e gli eredi possono dimostrare<br />
l’innocenza del defunto.<br />
In epoca post-classica, vengono considerate come maiestas una<br />
serie di ipotesi, prima straordinarie, e la pena viene notevolmente<br />
inasprita (decapitazione, metalla, altre sanzioni gravi); mentre si<br />
vietano le concessioni ai fi gli dei condannati di parti del patrimonio<br />
confi scato, concessioni che solevano farsi largamente per altri<br />
crimini.<br />
b) Omicidio: era denominato anticamente parricidium espressione<br />
con la quale si intendeva non la uccisione del proprio padre, ma<br />
<strong>Caietele</strong> <strong>Institutului</strong> <strong>Catolic</strong> IX (2010, 1) 131-168
150 ETTORE TOMASSI<br />
quella di un qualunque pater familias. Fin da epoca antichissima fu<br />
perseguito da speciali quaestores e la pena da infl iggersi fu la morte.<br />
Non è chiaro il vero signifi cato dell’antico precetto delle XII<br />
Tavole («si quis hominem liberum dolo sciens morti duit, paricidas esto »),<br />
che è stato interpretato o nel senso passivo, che cioè l’omicida<br />
«sia. parimenti ucciso», o come «vi sia un vendicatore», nel senso<br />
cioè che ogni congiunto debba esercitare la vendetta.<br />
Nell’epoca delle quaestiones l’omicidio fu disciplinato da la lex<br />
Cornelia de sicariis et venefcis, di Silla, che comprende anche il brigantaggio<br />
(« ambulare cum telo hominis necandi furtive faciendi causa »),<br />
alcuni atti commessi dal magistrato, in seguito a cui derivi ingiustamente<br />
la morte del colpevole, o il falso testimonio da cui derivi<br />
la condanna a morte; il venefi cio; 1’incendio. La pena legale<br />
è la capitale, cioè l’aqua et igni interdictio, cui segue automaticamente<br />
la perdita della cittadinanza e la confi sca.<br />
Alcuni senatoconsulti e rescritti interpretativi estesero la legge<br />
Cornelia ad altre ipotesi (fecero rientrare, ad es., nel venefi cio l’uso<br />
dei pocula abortionis seu amatoria o anche dell’arte magica a scopo<br />
nocivo); assimilarono la falsa denuncia alla falsa testimonianza,<br />
colpirono la evirazione libidinis vel promercii causa, la circoncisione<br />
dei non Giudei, i delitti commessi in occasione di un naufragio.<br />
Elemento essenziale del reato è il dolo. Si è puniti egualmente<br />
se l’effetto sia mancato; l’istigatore o il complice sono parifi cati<br />
all’autore del fatto. Il padrone poteva in origine mettere a morte<br />
lo schiavo, ma sotto l’Impero occorre che l’omicidio non sia sine<br />
causa. E’ suffi ciente però un giudizio domestico. Il padre poteva<br />
mettere a morte il fi glio, fi no alla Costituzione di Costantino (c.<br />
1, C, 9, 17) che lo vietò.<br />
Nell’epoca post-classica una serie di casi, prima puniti extra<br />
ordinem, vengono attratti nell’orbita della lex Cornelia de sicariis. Il<br />
diritto giustinianeo punisce anche altre ipotesi, avvicinando<br />
all’omicidio il procurato aborto, che prima era punito solo in<br />
quanto si usassero veleni.<br />
<strong>Caietele</strong> <strong>Institutului</strong> <strong>Catolic</strong> IX (2010, 1) 131-168
Il sistema punitivo e penitenziario in epoca romana (II)<br />
151<br />
Pel parricidio vero e proprio le XII Tavole stabilirono la pena<br />
del culleus, cioè della sommersione in un sacco, con animali che<br />
martoriassero il colpevole. Più tardi fu regolato dalla lex Pompeia,<br />
che applicò la pena dell’interdictio aqua et igni, nei casi di uccisione<br />
non dei soli genitori, ma anche dei fratelli e sorelle, degli zii paterni,<br />
della moglie, dei suoceri e dei padroni. La legge appare lacunosa,<br />
ed è riferita in modo diverso da diverse fonti. Le lacune<br />
vennero colmate dalla giurisprudenza.<br />
c) Falso: le XII Tavole punivano solo il falso testimonio, con il<br />
lancio dalla rupe Tarpeia. Una lex Cornei «testamentaria nummaria»,<br />
detta più tardi de falsis, represse la falsifi cazione delle monete o<br />
qualsiasi falsifi cazione, cancellazione, soppressione di testamento<br />
o anche la fabbricazione di sigilli falsi.<br />
Il Senatoconsulto Liboniano e un editto di Claudio aggiunsero<br />
il caso dello scrivere nel testamento altrui una disposizione in<br />
proprio favore. Un altro senatoconsulto estese la legge Cornelia<br />
anche agli altri documenti giuridici. Una larga evoluzione si dové<br />
avere in tema di falso documentale, in rapporto alla sempre più<br />
larga estensione dell’uso del documento.<br />
Altri senatoconsulti repressero l’adulterazione e l’alterazione di<br />
monete. Alla legge Cornelia sono stati ricondotti ancora la corruzione<br />
di giudice, la pronuncia di una sentenza con cosciente<br />
trasgressione di nome, la venditio fumi, la corruzione di testimoni<br />
per far intentare accuse capitali o per far condannare, la consegna<br />
di documenti da parte del difensore, nonché le usurpazioni<br />
di falso nome o di falsi gradi. La pena è l’aqua et igni interdictio (v.),<br />
e più tardi, nella repressione straordinaria, la morte, il metallum, o<br />
in casi meno gravi la relegazione e la confi sca di una parte e beni.<br />
Nell’epoca post-classica anche altri casi che prima erano puniti<br />
extra ordinem vengono ricondotti al falso, e forse allora sorge,<br />
per ipotesi un po’ più lontane, il concetto del quasi falsum (quale<br />
il dare o ricevere danaro per promuovere azioni criminali).<br />
<strong>Caietele</strong> <strong>Institutului</strong> <strong>Catolic</strong> IX (2010, 1) 131-168
152 ETTORE TOMASSI<br />
Il falso non è quindi qualche cosa di omogeneo, ma consiste<br />
in una serie di ipotesi raggruppate; né è suffi ciente il semplice<br />
mendacio, ma occorre che sia reso concreto in forme esteriori<br />
(falsifi cazione di documenti o altro).<br />
Vari casi di frode costituivano il delitto di stellionato, di contenuto<br />
incerto, il quale abbia carattere surrogativo, come il dolo<br />
nel diritto privato.<br />
d) Stellionato: è un crimen (il nome deriva da stellio, tipo di rettile<br />
dalla pelle variegata che cambia continuamente colore) sconosciuto<br />
fi no ad epoca avanzata e appare a partire da Antonino Pio<br />
ed è un indice anche dell’attività imperiale. Esso neque publicis iudicus<br />
neque privatis actionebus continetur (Pap. D. 47, 20, 1), ma esercitionem<br />
extraordinariam habet (Ulp. D. 47, 20, 2). Non vi è alcuna<br />
pena legittima perché il crimen di stellionato non è legitimum<br />
(Ulp.D. 47, 20, 3, 2). Vi è l’accusatio, probabilmente per quella<br />
trasfusione di atti processuali relativi ai iudicia publica nella cognitio;<br />
ma non possibile la desistenza in base al senatoconsulto Turpillianum.<br />
I casi di stellionatus nel diritto classico sarebbero oltre quelli<br />
indicati in un noto testo di Ulpiano (D. 47, 20, 3) anche il caso di<br />
chi vende come schiavo uno statuliber simulando la sua vera condizione<br />
(D. 40, 7, 3, 1) e quello del debitore che dà in pegno al<br />
suo creditore un oggetto altrui, oppure un oggetto proprio già<br />
pignorato ad altri e che formi oggetto di una obligatio in publicum<br />
(D.13, 7, 16, 1; D. 47, 20; C. IX, 34, 2 e 4).<br />
E’, dunque, lo stellionatus, un crimen che ha per scopo precipuo<br />
quello di reprimere le frodi in commercio.<br />
Giustiniano trasformò completamente l’istituto perché affermò<br />
il principio di reprimere ubicumque titulus criminis defi cit, illio<br />
stellionatus obicemus. Si punisce quindi come colpevole di stellionato<br />
chiunque abbia commesso un qualsiasi atto doloso che non rientri<br />
in un’altra distinta fi gura criminosa.<br />
Il Codice Napoleonico, dopo che l’istituto cadde in disuso per<br />
tutta l’età di mezzo indicò nell’articolo 2059 due sole determinate<br />
<strong>Caietele</strong> <strong>Institutului</strong> <strong>Catolic</strong> IX (2010, 1) 131-168
Il sistema punitivo e penitenziario in epoca romana (II)<br />
153<br />
ipotesi: a) vendere o ipotecare dolosamente un immobile non<br />
proprio e presentare come libero un immobile ipotecato; b) dichiarare<br />
ipoteche minori di quelle che vi sono realmente. In questo<br />
ipotizzare i due casi si rimandava al Codice Civile delle Due Sicilie<br />
all’articolo 1934.<br />
e) Violenza: come crimine a sé (vis,quindi, distinta dalla nozione<br />
generale di violenza di cui abbiamo già discusso nell’introduzione<br />
a questo nostro lavoro), entra tardi nel sistemi romano. La violenza<br />
non si presenta infatti come qualche cosa di uniforme, ma<br />
come un complesso di manifestazioni, alcune delle quali erano<br />
considerate solo dall’editto pretorio, altre venivano represse penalmente,<br />
ma in quanto costituivano un mezzo per commettere<br />
altri reati. Nel II secolo a. Cr. si incominciò a distinguere, e dal<br />
furto commesso con violenza e con altre circostanze sorse il<br />
delitto privato di bona vi rapta (rapina), mentre per altre ipotesi<br />
furono istituite delle quaestiones. Si distinsero vis publica e vis privata.<br />
La vis publica fu repressa dalla lex Plotia (89 a. Cr.?) completata<br />
dalla Lutetia, e poi dalla lex Julia. Fu considerata in prima linea<br />
l’ipotesi della sedizione (senza l’idea della resistenza all’autorità,<br />
nel qual caso si rientra nella maiestas), poi quella del porto d’armi<br />
in pubblico, delle organizzazioni di bande, dell’ammasso di armi,<br />
del turbamento dei comizi elettorali. L pena è l’aqua et igni interdictio.<br />
Sono repressi poi tutti quegli atti di violenza che contrastano<br />
all’ordine dei giudizi pubblici: e perciò l’impedimento al cittadino<br />
di esercitare la provocatio ad populum o all’imputato di presentarsi a<br />
Roma pel giudizio (fr. 6, D. huius tit.), o, in genere, ogni turbamento<br />
de giudizi (fr. 10). È perciò che alcuni studiosi identifi cano<br />
questa legge con la lex Julia iudiciorum publicorum, la quale, mentre<br />
regolava la forma dei giudizi, li avrebbe anche tutelati da ogni<br />
violenza.<br />
La vis privata è repressa anch’essa da una lex Julia, e dalle fonti<br />
non appare chiaro se sia una legge diversa dalla precedente, ovvero<br />
<strong>Caietele</strong> <strong>Institutului</strong> <strong>Catolic</strong> IX (2010, 1) 131-168
154 ETTORE TOMASSI<br />
la stessa. È facile che sia diversa, e si debba a sua volta identifi -<br />
care con la lex Julia iudiciorum privatorum, che regolò i giudizi privati.<br />
Essa comprende in prima linea l’attentato al regolare svolgimento<br />
dei giudizi, e poi tutti gli atti che si potrebbero chiamare<br />
di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e gli altri atti di violenza.<br />
La pena è patrimoniale, la confi sca della terza parte dei<br />
beni, cui si giungono delle privazioni di dignitates e di cariche.<br />
Nell’epoca post-classica questo crimine subisce una profonda<br />
trasformazione, ancora non interamente chiara. Si tende a meglio<br />
determinare ad unifi care il crimine, pur tenendo separati i due<br />
tipi, con l’identifi care la vis publica con la vis armata, e la privata<br />
con vis sine armis; col fondere con esso un crimen violentiate sorto<br />
come straordinario nell’epoca classica, e con l’unire casi di violenza<br />
carnale che prima erano autonomi, applicandosi pene varie<br />
secondo i casi e secondo le persone (deportatio, metallum, ecc.).<br />
f) Adulterio: sono incerte le notizie dell’epoca repubblicana, in<br />
cui mancava una regolamentazione unica, alcuni casi rientrando<br />
nella violenza, altri rivestendo un carattere di empietà, ed essendo<br />
devoluti ai pontefi ci; e molte volte infi ne avendo applicazione i<br />
iudicia domestica, di cui si ha ancora traccia nelle relegazioni infl itte<br />
da Augusto. La legge che istituì una quaestio per questo reato fu<br />
la lex Julia de adulteriis, che si ricollega a tutta la legislazione di<br />
Augusto in materia matrimoniale. La legge contempla indistintamente<br />
adulterio e stupro, facendo rientrare in tali concetti anche<br />
la bigamia; attribuisce la pena anche al marito complice, contemplando<br />
quindi indirettamente il lenocinio; anzi fa obbligo al marito<br />
di rimandare immediatamente la moglie colta in fl agrante.<br />
Sembra che la fl agranza sia il solo caso in cui tale obbligo era<br />
tassativo.<br />
Il ratto entra nel concetto di violenza; il reato semplicemente<br />
tentato può considerarsi come iniuria.<br />
A parte il diritto alla vendetta privata, che la legge riconosce<br />
in alcuni casi di fl agranza, il padre può uccidere la fi glia, ed anche<br />
<strong>Caietele</strong> <strong>Institutului</strong> <strong>Catolic</strong> IX (2010, 1) 131-168
Il sistema punitivo e penitenziario in epoca romana (II)<br />
155<br />
l’estraneo, sempre che uccida anche a fi glia; il marito non può<br />
uccidere la moglie, ma soltanto l’estraneo, se sia un servo o un<br />
liberto, o una persona disonorata, e deve ripudiare subito la moglie,<br />
altrimenti viene accusato di lenocinio. A parte alcune punizioni<br />
speciali, infl itte, per es., da Augusto in virtù di poteri di<br />
coercizione familiare, la pena dell’adulterio è patrimoniale, la privazione<br />
di metà dei beni, e solo più tardi sopravviene la relegazione<br />
in insulam. L’accusa non è permessa a tutti, e può sperimentarsi<br />
anche nei 60 giorni dopo lo scioglimento del<br />
matrimonio.<br />
Il diritto imperiale tende a considerare come singoli reati i diversi<br />
casi di delitti contro il buon costume. Viene quindi represso<br />
da Costantino come reato a sé il ratto; sorge l’incesto, pel quale<br />
è talora anche comminata la pena capitale; la pederastia, già repressa<br />
da un’antica incerta lex Scantinia con una multa, viene punita<br />
poi, sotto gl’imperatori cristiani, o con la vivicombustione o<br />
con la decapitazione.<br />
Costantino per l’adulterio vero e proprio sancisce la pena di<br />
morte. Il diritto giustinianeo conferma tale sanzione; per lo stupro<br />
si è limitato alle relegazioni, aggiungendo la coercitio corporalis<br />
per gli humiliores, la confi sca di metà dei beni per gli honestiores<br />
(vedi «Honestiores» e «humiliores»). Si vengono così a distinguere le<br />
due forme.<br />
g) Ambitus: (che letteralmente signifi ca « giro », riferendosi<br />
forse al giro dei mercati e degli altri centri che facevano i candidati,<br />
i quali si dimostravano tali anche dal vestito «candido»), è il<br />
crimine pel quale vi è stata forse la legislazione più ricca e quindi<br />
più oscillante ed incerta, nell’ultima epoca repubblicana (leggi<br />
Cornelia, Calpurnia, Acilia, Licinia, Pompeia, Tullia). L’ultima fu<br />
Augustea (lex Julia de ambitu). Reprimeva ogni genere di corruzione<br />
elettorale (accaparramento di voti che avveniva attraverso terzi,<br />
o nei banchetti o negli spettacoli); la formazione di associazioni<br />
<strong>Caietele</strong> <strong>Institutului</strong> <strong>Catolic</strong> IX (2010, 1) 131-168
156 ETTORE TOMASSI<br />
elettorali (sodalicia, che organizzavano i votanti, ripartendo1i in<br />
gruppi e sottogruppi, ed esercitavano su di essi una rigorosa vigilanza).<br />
Si aggiunse poi anche la introduzione di nuove imposte,<br />
ed anche qualche forma di corruzione dei giudici. La pena della<br />
lex Julia fu pecuniaria, cioè una multa, mentre precedentemente,<br />
nell’epoca ciceroniana, pare vi sia stato un esilio di 10 anni. Si<br />
aggiunse l’esclusione dal Senato, e da altre cariche.<br />
Il reato, che dové essere comunissimo nell’ultima epoca repubblicana,<br />
venne perdendo importanza nell’epoca imperiale,<br />
dati l’assolutismo e la cessazione dell’elettività delle cariche, e si<br />
limitò soprattutto al campo municipale.<br />
h) Plagio: è l’usurpazione della potestà dominicale su persone<br />
libere e su schiavi altrui. Fu represso dalla lex Fabia (209 a.C.), la<br />
quale in un primo capitolo considerò l’ipotesi che alcuno abbia<br />
tenuto legato o abbia comprato o venduto un romano o un liberto,<br />
estendendo la punibilità al socio o al servo che abbia commesso<br />
il fatto con la scienza del padrone; in un secondo capo<br />
concerneva la sottrazione dello schiavo altrui, e la provocazione<br />
alla fuga. La pena fu di 50.000 sesterzi. Un senatoconsulto estese<br />
la lex Fabia contro chi venda, come soleva dirsi, la fuga del servo,<br />
cioè venda un servo fuggito, per un modico prezzo, da pagarsi<br />
indipendentemente dal se l’acquirente riuscisse a rintracciarlo.<br />
Sembra però che l’azione derivante dalla legge non avesse<br />
carattere criminale, e che il crimine vero proprio sia sorto con<br />
Caracalla, se non - come è stato ritenuto da ultimo - addirittura<br />
con Diocleziano, nella cognino extra ordinem. Ebbe pene varie: relegazione,<br />
metallo, ecc., e talora anche la morte. In diritto giustinianeo<br />
viene talora qualifi cato crimen capitale.<br />
i) Repentudae: è uno dei crimini su cui abbiamo maggiori fonti,<br />
possedendo numerosi frammenti, pervenutici direttamente su<br />
una tavola di bronzo conservata al Museo Nazionale di Napoli,<br />
della lex Acilia repentundarum (o, secondo altri, lex Sempronia iudiciaria),<br />
<strong>Caietele</strong> <strong>Institutului</strong> <strong>Catolic</strong> IX (2010, 1) 131-168
Il sistema punitivo e penitenziario in epoca romana (II)<br />
157<br />
di Caio Gracco, del 123 a.C. e ad esso riferendosi pure l’editto di<br />
Augusto ai Cirenei, trovato nel 1926 negli scavi di Cirene, che ripeté,<br />
per quella provincia, molte disposizioni di Roma, un fragmentum<br />
tarentinunim rinvenuto recentemente a Taranto, un frammento<br />
di papiro rinvenuto nella biblioteca di Leyda, proveniente<br />
forse da Fayum nell’Egitto, ove si riportano brani delle Sententiae<br />
cosiddette di Paolo. La grande importanza di tali fonti deriva<br />
soprattutto dal fatto che essi ci mostrano l’andamento del processo<br />
in materia di repetundae, e quindi, data l’affi nità tra le varie<br />
procedure, l’andamento in genere del processo criminale. L’esposizione<br />
del contenuto delle norme non va quindi fatta qui.<br />
Il crimen repetundarum presenta però un particolare interesse, in<br />
quanto fu il primo, secondo ogni probabilità pel quale si sia istituita<br />
una quaestio, con la lex Calpurnia, che forse fu la stessa che<br />
introdusse la condictio in diritto privato. Il tipo di sanzione che si<br />
limita a semplice valore delle cose estorte, ci fa vedere, poi, come i<br />
Romani, per stabilire se un fatto rivestisse il carattere di crimine,<br />
più che alla pena guardavano alla persecuzione, considerando<br />
crimine solo quello che era pubblicamente perseguito.<br />
Oltre la lex Calpurnia, e la successiva Acilia del 631-632 a.C.,<br />
vi furono altre leggi, Sempronia, due Serviliae, la Cornelia, e da ultimo<br />
una lex Julia. L’abbondanza della legislazione va spiegata col<br />
fatto che si vogliono aiutare i provinciali contro gli abusi dei<br />
magistrati romani, commessi nell’esercizio delle loro funzioni,<br />
ed anche dei senatori, nella partecipazione ai lavori, o nella qualità<br />
di giurati. Sono tenuti anche i fi gli pei vantaggi che conseguano<br />
approfi ttando della posizione paterna. Si reprime soprattutto<br />
l’acquisto di quelle pecuniae che il magistrato « in magistratu potestate<br />
curatione vel quo alio offi cio munere ministeriove publico accepit vel cum<br />
ex cohorte cuius eorum est ». La legge Acilia comprende l’auferre, cioè<br />
le usurpazioni dirette; il cogere, cioè gli acquisti che avvengono per<br />
intimidazione; il conciliare, cioè quelli che avvengono con lusinghe<br />
<strong>Caietele</strong> <strong>Institutului</strong> <strong>Catolic</strong> IX (2010, 1) 131-168
158 ETTORE TOMASSI<br />
o in cambio di favori. La condanna è alla restituzione del mal<br />
tolto, ma a tale pena si accompagnano varie incapacità (perdita<br />
dei diritti politici, rimozione dal Senato e ineleggibilità alle cariche<br />
pubbliche). Nell’epoca imperiale le ipotesi di repetundae vengono<br />
punite extra ordinem con altre sanzioni pi gravi (relegazione,<br />
ecc.) e probabilmente l’azione diretta alla pena patrimoniale divenne<br />
un’azione civile da risarcimento, trasmissibile contro gli<br />
eredi. Non considerandosi il motivo per cui il denaro viene<br />
estorto, questo crimine comprende non solo la nostra concussione,<br />
ma anche la corruzione, non esistendo un reato vero e<br />
proprio di corruptio, e la corruptio potendosi considerare piuttosto<br />
come un concetto generale.<br />
l) Peculato: originariamente è il delitto di chi si impossessa di<br />
pecus, cioè di capi di bestiame (antico mezzo di scambio); viene<br />
poi regolato con precisione dalla lex Julia, che punisce l’auferre,<br />
l’intercipere, il vertere in rem suam pecuniam, pecunia che può essere<br />
pubblica e sacra; onde l’affi nità delle due fi gure del peculato e del<br />
sacrilegio.<br />
Il peculato in senso stretto è un furtum publicae e pecuniae; eccede<br />
però la nozione del furto, e viene indicato con la frase populum<br />
fraudare; frode che consiste anche nel peggiorare la coniazione<br />
della moneta, o nel fabbricarne oltre il limite.<br />
Oggetto di sacrilegio sono le cose «rite» e «publicae consecratae»,<br />
più, tardi, anche quelle religiosae, cioè relative alla sepoltura. La<br />
pena in qualche ipotesi specialmente di sacrilegio dové essere<br />
l’interdizione dall’acqua e dal fuoco. Pel peculato normalmente<br />
fu pecuniaria e consisté nel quadruplo delle cose indebitamente<br />
prese.<br />
Un crimen speciale, represso da una lex Julia de residuis, è l’appropriazione<br />
dei denaro residuo che deve restituirsi al privato o<br />
all’ente pubblico che lo aveva concesso perché con esso si esercitasse<br />
un’attività.<br />
<strong>Caietele</strong> <strong>Institutului</strong> <strong>Catolic</strong> IX (2010, 1) 131-168
Il sistema punitivo e penitenziario in epoca romana (II)<br />
159<br />
Nell’epoca classica, varie ipotesi straordinarie vennero punite<br />
più gravemente e si fi nì col reprimere extra ordinem anche il peculato,<br />
ed il sacrilegio, giungendosi talora anche alla morte. Nel<br />
Codice giustinianeo i due titoli sono separati ed il sacrilegio ha<br />
un suo sviluppo autonomo. Anche pel peculato l’azione pecuniaria<br />
si distaccò dalla Penale, e fu diretta al semplice risarcimento.<br />
m) Annona: è il reato di chi produce artifi cialmente rincari sui<br />
pubblici mercati, represso da una lex Julia (di Cesare?) con una<br />
multa di 20.000 sesterzi. Ebbe presto una punizione più grave,<br />
extra ordinem (relegazione e opus publicum).<br />
n) Aborto: l’aborto diventa delitto solo al tempo dell’imperatore<br />
Selturnio Severo,venendo assimilato al malefi cium e punito<br />
con i lavori forzati o con il bando e la pena pecuniaria; se ne seguiva<br />
la morte della gestante la pena era quella capitale” 9 .<br />
Fino a Selturnio Severo l’aborto era una turpidutum e quindi<br />
non era classifi cato tra i reati, ciò in quanto il feto era considerato<br />
parte integrante delle viscere della madre. Per questa ragione<br />
mentre si riconosceva alla madre la facoltà di disporre liberamente<br />
del proprio corpo, e quindi dello stesso feto in esso contenuto,<br />
si riteneva, rispetto ai terzi, che l’uccisione del feto, salva<br />
l’offesa verso la donna, non potesse come tale rientrare tra i delitti<br />
contemplati dalla lex Cornelia (de sicarus et venefi cus) e in altre<br />
disposizioni complementari, che tutte presupponevano l’esigenza<br />
dell’essere umano distaccato dalle viscere materne. Così aggiunge<br />
il Perla “Le disposizioni punitive della legge Cornelia furono<br />
quindi, con un senatoconsulto, estese alla vendita e somministrazione<br />
dei pocula abortionis e matoris. Con ciò peraltro non si volle<br />
assimilare l’aborto al venefi cio per pecunie direttamente l’uccisione<br />
9 La presente voce è stata integrata dallo scrivente (per lo stellionato e per<br />
i reati dopo il punto m). Cfr. U. BRASIELLO, s.v. Crimina, in Nov. Dig. It., V<br />
1960, rist. 1981, pp. 1-4.<br />
<strong>Caietele</strong> <strong>Institutului</strong> <strong>Catolic</strong> IX (2010, 1) 131-168
160 ETTORE TOMASSI<br />
del feto ma si volle unicamente allargare la sfera repressiva dei<br />
delitti di venefi cio. Nell’epoca di maggior decadenza dei costumi,<br />
le pratiche abortive ebbero a Roma la più larga diffusione,<br />
essendo considerato come mezzo per sottrarsi ai dolori e ai pericoli<br />
del parto, al peso della fi gliolanza, e anche, solamente, per<br />
conservare la bellezza e la linea estetica del corpo. Contro di esso<br />
insorsero, in nome della morale, gli scrittori cristiani, tra cui particolarmente<br />
Tertulliano che nell’Apologetico sosteneva di riscontrare<br />
nel feto i caratteri essenziali della personalità umana<br />
(homo est qui est futurum). Si venne così preparando la completa e<br />
radicale trasformazione del delitto precedente, oltreché nella<br />
compilazione giustinianea, nella quale il procurato aborto fu<br />
considerato esplicitamente come delitto e avvicinato all’omicidio<br />
(fr. 8, Dig. 48, 8) 10 .<br />
o) Avvelenamento: i casi di avvelenamento erano diffusi in<br />
Roma antica. Lo confermano Quintiliano (Iust. Orat., 5, 11, 39),<br />
Tacito (Annales 3, 22 e ss), Svetonio (Tib. 49, 19) e papiri (P. Oxy.<br />
19, 1477).<br />
Silla istituì un tribunale permanente che si occupava esclusivamente<br />
di avvelenamenti. Diocleziano stabilì che fosse condannato<br />
a morte chi avesse procurato la morte per avvelenamento<br />
per succedere nell’eredità (Codex Iustinianeus, 6, 35, 9). D. 48, 1,<br />
14 riportò il caso di un padre che aveva accusato in modo del<br />
tutto infondato gli schiavi del genero (e quindi il genero stesso)<br />
dell’avvelenamento di sua fi glia, e per la sua accusa infondata<br />
l’accusatore da parte sua rischiava serie conseguenze, cioè l’accusa<br />
di calumnia. In questo caso Ulpiano afferma che non si può procedere<br />
per calumnia contro il padre perché i rapporti tra padre e<br />
fi glia giustifi cavano l’accusa, anche se falsa.<br />
10 L. PERLA, in Aborto (diritto – procurato aborto), in E.I., vol. I, 1929, p[p.<br />
111-112] 111.<br />
<strong>Caietele</strong> <strong>Institutului</strong> <strong>Catolic</strong> IX (2010, 1) 131-168
Il sistema punitivo e penitenziario in epoca romana (II)<br />
161<br />
p) Abigeato: l’abigeato è il furto del bestiame. Nel De re rustica<br />
2, 10, 3, Varrone (I secolo a. C.) dice che i pastori devono essere<br />
forti per difendere il bestiame non solo dalle belve feroci ma<br />
anche dai ladri. La frequenza di questo reato è provata da una<br />
legge del 395 (Cod. Theod. 2,1, 8) ed anche nei tribunali vescovili<br />
si discuteva frequentemente del possesso degli animali e del rischio<br />
che correva il proprietario circa la possibilità di essere oggetto di<br />
furto.<br />
Era ritenuto ladro di bestiame (abactor) chi rubava un cavallo,<br />
o due giumente, o dieci pecore (o capre) o cinque maiali. Al di<br />
sotto di questi limiti, l’abigeato era perseguito come furto semplice<br />
11 . Ulpiano è chiaro in tal senso. In D. 47, 14, 1 dice che c’è<br />
abigeato quando il furto è inteso come lavoro, e Columella, 7, 3,<br />
26 esorta il pastore ad essere attento che il gregge non si sparpagli<br />
“affi nché un ladro o una belva feroce non inganni il pastore<br />
che sogna”. Orazio (Epist. 1, 7,75 e ss) si lamentò dei continui<br />
furti di bestiame nelle classi patrizie e Agostino di Ippona, in<br />
Psalm, 37, 13 lamentava per il contadino nordafricano oltre la<br />
grandine il furto di bestiame. I Papiri in Egitto abbondano di tale<br />
reato e da Marziale a Palladio nella Historia Lusiaca 44, 5 c’è una<br />
preoccupazione intensa contro l’abigeato. Troiano minacciò con<br />
un esilio decennale chiunque aiutasse i ladri di bestiame (D.47,<br />
14, 3, 3),mentre Adriano volle la pena di morte per il furto di<br />
bestiame in Spagna, nella Betica. Fonti epigrafi che (CIL, IX,<br />
2438) e Codice Tedosiano, 9, 30, 1-5 testimoniano la diffusione<br />
dell’abigeato nell’Italia meridionale.<br />
q) Brigantaggio: non c’è dubbio che il brigantaggio diventa reato<br />
autonomo, cioè viene trattato in modo autonomo fra i reati<br />
in diritto romano solo tardi, e cioè con il Codice Teodosiano, ma non<br />
c’è dubbio altrettanto che il sistema del brigantaggio fu nettamente<br />
avversato nell’ordine pubblico. Un brigantaggio organizzato<br />
11 Cfr. J. U. KRAUSE, La criminalità del mondo antico, Roma, 2006, p. 134.<br />
<strong>Caietele</strong> <strong>Institutului</strong> <strong>Catolic</strong> IX (2010, 1) 131-168
162 ETTORE TOMASSI<br />
nasce e si diffonde in Cilicia e in Mauritania, ma un brigantaggio<br />
sommesso si diffonde in tutto l’impero dal II secolo a.C. al VI<br />
secolo d.C., e cioè dalla presenza di Pompeo prima e Cicerone<br />
dopo verso i briganti di Cilicia fi no alla legislazione giustinianea.<br />
Le fonti sono numerosissime: letterarie, epigrafi che, papiracee<br />
e normative fi no a quella del Vangelo di Luca 10, 25 e ss che<br />
riporta l’episodio del buon samaritano aggredito da rapinatori.<br />
L’organizzazione in bande autonome, fra tutte quella capitanata<br />
dal capobanda Bulla Felice, (cfr. J.-Uwe Krause, La criminalità<br />
nel mondo antico, cit., pp. 144-159) rese il fenomeno del brigantaggio<br />
gravissimo per tutto il III secolo d. C. tenuto soprattutto<br />
conto che Roma non raggiunse mai un controllo effettivo su alcuni<br />
monti come alcune zone del Nord Africa (Mauritania) o<br />
dell’Asia Minore (Cilicia).<br />
E ai briganti di terra vanno equiparati i briganti di mare, i pirati<br />
che solo nel 67 a.C. Pompeo riuscì a frenare per il mercato di<br />
schiavi cui si erano particolarmente dedicati. Il fenomeno era<br />
antico, e lo ricorda Senofonte Efesio 3, 2, 1, e ss e Cassio Dione<br />
74, 2, 4 e ss ma anche Apuleo, Metamorfosi 4, 23, 3 e ss. Le bande<br />
erano da schiavi fuggitivi (Cassio Dione 76, 0), disertori dell’esercito<br />
romano che si davano al furto, abigeato o tratta illegale<br />
degli schiavi (D. 49, 16, 5). Di questi scorsi chiarò Basilio di Cesarea<br />
(Epist. 268) e Zosimo (5, 22, 3) tanto che C. Th. 7, 18, 14<br />
invitava anche i privati a reagire con la forza fi no a uccidere i<br />
briganti.<br />
Caratteristica dei briganti erano le rapine (D. 48, 19, 27, 1 e ss;<br />
P. Ox. L., 3561; P. Fay 108) non solo nelle campagne ma anche<br />
tra i Monti della Mauritania (CIL VIII, 2728 = 18122 = ILS,<br />
5795; Plinio, Hist. Nat. 8, 142-144). Le loro ricchezze erano immense<br />
(Giovanni Crisostomo, De Lagaro 1, 12; Cod. Iust. 5, 17,<br />
8, 2; Petronio 111, 5 e ss). Le fonti giuridiche incitano a punire<br />
severamente coloro che aiutano i briganti (D. 47, 16, 2; D. 47, 16,<br />
<strong>Caietele</strong> <strong>Institutului</strong> <strong>Catolic</strong> IX (2010, 1) 131-168
Il sistema punitivo e penitenziario in epoca romana (II)<br />
163<br />
1 e 2; Apuleio, Metamorfosi, 4, 1, 1 e ss; Ite storia Monadorum in<br />
Aegypto 8, 30 e ss) anche, e forse più, se sono membri della polizia<br />
(D.47, 16, 1; Achille Tazio 7, 3; C I, 9, 41, 4; Ausonio, Epist.<br />
14, 22 e ss) fi no a Teodosio il Grande (379-395) quando ordina<br />
ai defensoris civitatum (uffi ciali che esercitavano una giurisdizione<br />
minima a livello urbano) di eliminare la protezione accordata ai<br />
briganti (Cth – 1, 29, 8), pena la distruzione stessa dell’Impero<br />
(Senofane, Benef. 4, 35, 2; Apuleio, Metamorfosi 1, 15; Plinio,<br />
Nat. Itist. 28, 115: 29, 77; Epiteto, 4, 1, 91 e ss; Cassio Dione 36,<br />
20, 1, 3). Di qui il numero enorme di postazioni militari (stationari)<br />
che difendono la sicurezza delle strade (Agostino, Epist. 46, 1;<br />
Ammiano Marcellino 27, 9, 6 e ss; 28, 2 11 e ss).<br />
r) rapimento: il rapimento è defi nito plagium in diritto romano<br />
ed è un reato a se stante. Era diretto ad alimentare il mercato<br />
degli schiavi tenuto conto che ogni anno dovevano subentrare<br />
500.000 nuovi schiavi 12 . La necessità di trovare nuovi schiavi è<br />
attestata dal fatto che Augusto e Tiberio si videro costretti a far<br />
perseguire le prigioni degli schiavi (ergastula) dei latifondi per<br />
scarcerare i liberi che vi erano rinchiusi (Svetonio, Aug. 32, 1;<br />
Tib. 8) e così si comportò Historia Augusta (Adriano, 18, 10).<br />
Ai governatori fu ordinato con mandata imperiali di perseguire<br />
duramente i rapitori (D. 48, 13, 4, 2) e occorse una Lex<br />
Fabia per trattare di questo reato, comminando i lavori in miniera<br />
se a rapire erano gli humiliores, l’esilio se a commettere questo<br />
reato erano gli honestiores (D. 48, 15, 7: Paulus, Sententiae, 5, 30).<br />
Diocleziano inasprì la pena portandola fi no alla condanna a<br />
morte (CI, 9, 20, 7).<br />
Il diritto intervenne anche sull’entità del riscatto (D. 24, 3, 21)<br />
fi no a stabilire l’entità della dote per una ragazza al posto del<br />
padre se questo era caduto prigioniero di guerra o era stato rapito<br />
dai briganti (D. 23, 3, 5, 4), ma Ulpiano dubitò, nel passo prima<br />
12 U. KRAUSE, La criminalità nel mondo antico, cit., p. 159<br />
<strong>Caietele</strong> <strong>Institutului</strong> <strong>Catolic</strong> IX (2010, 1) 131-168
164 ETTORE TOMASSI<br />
richiamato (D. 24, 3, 21) se un marito sia autorizzato a utilizzare<br />
la dote di sua moglie, di cui non può disporre liberamente, per<br />
riscattare i parenti della donna rapiti dai briganti. Agostino di<br />
Ippona si lamenta (Epist. 10, 2 e ss) per i numerosi rapimenti di<br />
bambini e di donne nel Nord Africa. Di ciò c’è un’eco in Costantino:<br />
gli schiavi e i liberti che si erano resi colpevoli di un tale<br />
delitto dovevano essere gettati alle belve feroci mentre gli uomini<br />
liberi dovevano essere uccisi con la spada durante i giochi gladiatori<br />
(C. Th. 9, 18, 1 e ss).<br />
I Padri della Chiesa si rendono portavoci di tale situazione e<br />
incitano gli Imperatori ad essere infl essibili. E c’è poi il problema<br />
del rapimento degli schiavi altrui come è testimoniato in D. 47,<br />
2, 68, 4 e in D. 47, 2, 75 che testimonia come il reato avveniva di<br />
frequente.<br />
s) Stupro: lo stuprum (le cui basi sono nel ricordo leggendario<br />
di Lucrezio, disonorati da Sesto Tarquinio, fi glio dell’ultimo re di<br />
Roma, Tarquinio il Superbo) era perseguito in età repubblicana<br />
per via di giustizia privata (Livio 1, 58). In epoca imperiale lo<br />
stupro era perseguito come atto di violenza (vis) secondo la Lex<br />
Julia de vi per cui il padre della famiglia era considerato colui che<br />
doveva punire il crimine per primo. Se si era lasciato convincere<br />
a rinunciare al suo proposito chiunque (extraneus) poteva sporgere<br />
denunzia (D. 48, 6, 5, 2; 48, 6, 3, 4).<br />
Chi violentava una donna estranea, sposata o meno, rischiava<br />
la pena di morte, che però non sempre veniva realizzata e che<br />
veniva sostituita con altra pena, come l’esilio (Ammiano Marcelluio,<br />
16, 5, 12).<br />
La violenza sessuale nelle città era diffusissima, soprattutto nei<br />
confronti delle donne di cattiva fama (Cicerone, Pro Roscio 30;<br />
Seneca, Controversiae, 5, 6).<br />
Spesso i colpevoli di violenze sessuali avvenivano nell’ambito<br />
della stessa famiglia. Fermico Materno, nel IV secolo riporta<br />
<strong>Caietele</strong> <strong>Institutului</strong> <strong>Catolic</strong> IX (2010, 1) 131-168
Il sistema punitivo e penitenziario in epoca romana (II)<br />
165<br />
come autori di uno stupro il padre, lo zio e il patrigno (dopo la<br />
morte del padre) di una vergine (6, 29, 23 e ss).<br />
Lo stupro di una schiava veniva risarcito secondo la Lex<br />
Aquilia. Le leggi augustee fi ssarono in modo defi nitivo (tanto<br />
miravano a porre un freno all’adulterio ma anche ai rapporti sessuali<br />
fra uomini e donne liberi al di fuori del matrimonio) che<br />
stuprum era qualunque rapporto sessuale con una donna non<br />
sposata facendo una grande distinzione tra seduzione e stupro.<br />
Compare nella tarda imperiale il numero di leggi sul rapimento<br />
di donne, cioè il rapimento con lo scopo di sposarla successivamente.<br />
A Roma un matrimonio legale presupponeva il consensus<br />
dei due coniugi ma anche il consensus del padre della sposa. Questo<br />
consenso era forzato con il rapimento della sposa, e questa<br />
prassi è citata spesso dai retori e da una legge di Costantino che<br />
minaccia pene disumane con quelli che prendono parte al rapimento<br />
di una vergine: i rapitori venivano giudicati immediatamente;<br />
le balie che avevano favorito il rapimento venivano punite<br />
versando oro in bocca del piombo fuso; la rapita avrebbe avuto<br />
la stessa punizione del rapitore anche se non era d’accordo perché<br />
comunque poteva gridare aiuto; i genitori dovevano essere<br />
condannati alla deportazione se potevano ma non hanno voluto<br />
perseguire il reato; tutti i complici dovevano essere puniti come<br />
i rapitori, indipendentemente dal loro sesso; gli schiavi complici<br />
dovevano essere arsi vivi.<br />
Gli schiavi che denunciavano il delitto dovevano essere premiati<br />
con il diritto di cittadinanza latina (C. Th. 9, 24, 1).<br />
t) Omosessualità: la Lex Scatinia di età repubblicana prevedeva<br />
una semplice ammenda per il rapporto sessuale con ragazzi liberi<br />
o eventualmente fra adulti solo per l’omosessualità passiva. Paolo nelle<br />
sue Sentenze, all’inizio del IV secolo (2, 26, 12 e ss) registra<br />
che l’omosessualità passiva veniva punita con la confi sca di metà<br />
del patrimonio; se c’era lo stuprum con un ragazzo si rischiava la<br />
<strong>Caietele</strong> <strong>Institutului</strong> <strong>Catolic</strong> IX (2010, 1) 131-168
166 ETTORE TOMASSI<br />
deportazione se era rimasto a livello di tentativo, la pena di morte<br />
se il rapporto sessuale era stato compiuto. Nel 342 fu introdotta<br />
la decapitazione per l’omosessuale passivo e nel 390 i prostituti<br />
maschili che lavoravano nei bordelli rischiavano di essere pubblicamente<br />
arsi sul rogo (C Th 9, 7, 3, 9, 10, 4 e Collatio Legum Mosaicarum<br />
et Romanorum 5, 3).<br />
Il Cristianesimo fu più rigoroso. Mentre prima ad essere colpiti<br />
erano prevalentemente gli omosessuali passivi (per quelli attivi si<br />
punivano solo quelli che avevano compiuti stuprum), Giustiniano<br />
introdusse la pena di morte per tutti gli omosessuali (Inst. Iust. 4,<br />
18, 4). Contro una tradizione, infatti, su cui l’omosessualità non<br />
era mai stata dichiarata contro natura e in cui si punivano solo gli<br />
omosessuali passivi alla stregua delle prostitute, il Cristianesimo<br />
introdusse la pena per tutti coloro che praticavano la sessualità<br />
non eterosessuale. I colpevoli erano spesso castrati e portati in<br />
giro per il ludibrio pubblico, come un secolo prima richiedeva<br />
l’autore Cristiano Salviano a metà del secolo prima. Verso la fi ne<br />
del suo regno, Giustiniano mitigò il suo rigore e in Nov. Iust. 141<br />
invitò (siamo nel 559) gli omosessuali a costituirsi e a fare penitenza<br />
presso i propri vescovi.<br />
u) Furto di raccolto: era un delitto capitale e veniva punito con<br />
la morte. Questo in età arcaica. Nell’età successiva fu ritenuto un<br />
reato di poco conto anche se preoccupava molto i proprietari<br />
terrieri. Così in Columella (I secolo d.C.) che consigliava di dare<br />
in affi tto i campi di cereali più lontani che il proprietario non<br />
può tenere protetti. Non sempre il furto di raccolto avveniva per<br />
necessità. Nelle Confessioni di Sant’Agostino 2, 4, 9 si dice che<br />
lo stesso Agostino compì furti pur non essendo mosso da bisogno.<br />
Ma più spesso come testimonia Gregorio Magno, Dialoghi<br />
1, 3, 2 e ss questi furti servivano al soddisfacimento di immediate<br />
esigenze alimentari.<br />
<strong>Caietele</strong> <strong>Institutului</strong> <strong>Catolic</strong> IX (2010, 1) 131-168
Il sistema punitivo e penitenziario in epoca romana (II)<br />
1.4. Estinzione dei reati<br />
167<br />
L’estinzione dei reati or ora descritti, si aveva secondo la classifi<br />
cazione descritta da Volterra 13 in sette modi: con la remissione,<br />
con la grazia, con la restituito (principalis e specialis), con l’espiazione<br />
della pena, tranne per quanto riguarda taluni effetti della condanna;<br />
con la prescrizione, e ovviamente con la morte del reo. L’estinzione<br />
del reato per prescrizione è sconosciuta nel diritto classico<br />
tranne alcuni casi tassativamente fi ssati, mentre nel diritto giustinianeo,<br />
sotto l’infl uenza del Cristianesimo (e il suo perdonismo)<br />
viene fi ssata una prescrizione generale ventennale.<br />
Nel caso della morte del reo, tuttavia, ancora Volterra precisa<br />
che vi sono cinque eccezioni:<br />
- i cadaveri dei condannati a morte non possono essere trasferiti<br />
per la sepoltura;<br />
- la morte non impedisce l’esecuzione delle pene pecuniarie<br />
già pronunciate;<br />
- il giudice può post mortem contro il perduellis e il colpevole di<br />
crimen maiestatis o del crimen repetundarum e, più tardi, anche contro<br />
il colpevole di manicheismo e altri reati religiosi;<br />
- il suicida è equiparato al damnatus quando sia postulatus o delatus<br />
o deprehensus in reatu e quando il suicidio sia compiuto allo<br />
scopo di sfuggire alla condanna;<br />
- si può agire contro gli eredi nel caso di contrabbando, di<br />
supposizioni di stato, di falso e nel caso della Lex Aulia repetundarum;<br />
- il patto remissorio estingue le azioni penali di furto e di ingiuria.<br />
13 Cfr. s.v. Reato (diritto romano), in E.I., XXVIII, 1935, p[p. 941-994]<br />
942.<br />
<strong>Caietele</strong> <strong>Institutului</strong> <strong>Catolic</strong> IX (2010, 1) 131-168
168 ETTORE TOMASSI<br />
1.5. Conclusione:<br />
i reati di diritto penale delle legislazioni occidentali<br />
redatto quelli elaborati sostanzialmente dal diritto romano<br />
Non c’è dubbio, da quanto fi no ad ora esaminato, che i reati<br />
di diritto penale delle legislazioni occidentali, ed in particolare<br />
della legislazione italiana, abbiano una stretta derivazione dalla<br />
dottrina generale dei reati di diritto romano.<br />
I punti su cui la dottrina futura dovrà vertere sono a mio avviso<br />
i seguenti:<br />
- la tendenza dell’illecito penale nel diritto romano a diventare<br />
illecito personale;<br />
- il raggiungimento del concetto di responsabilità penale per<br />
fatto proprio colpevole, così come viene ideato nel diritto romano;<br />
- il carattere personale dell’illecito penale a fronte degli illeciti<br />
extrapenali, fatto continuo all’interno della casistica dei reati penali<br />
nel diritto romano;<br />
- ricercare quanto della dottrina dell’illecito penale sia entrato<br />
nella dottrina europea, a partire da quella tedesca e poi da quella<br />
italiana e francese, ed anche iberica, e dei Paesi del cosiddetto<br />
socialismo irreale, prima e dopo il 1989.<br />
<strong>Caietele</strong> <strong>Institutului</strong> <strong>Catolic</strong> IX (2010, 1) 131-168