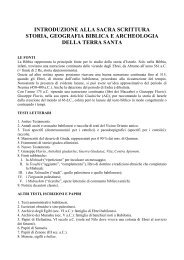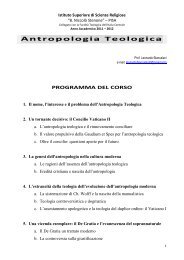ABSTRACT - Daras
ABSTRACT - Daras
ABSTRACT - Daras
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>ABSTRACT</strong><br />
The basic objective of this study is to focus the psychological, biological and<br />
bioethical implications of the Medical Assisted Procreation ( MAP).<br />
Starting from the couple infertility and analysing the diagnosis, the<br />
prognosis and the therapy involved, the analysis of the principal techniques of<br />
MAP, is reached and it is also underlined how these techniques reach the most<br />
intimate dynamics of the couple and of the single members that form the couple.<br />
As to be parents is a fundamental evolutive process, both from a biological<br />
(the maintenance of the species) and a psychological point of view, this study<br />
will analyse how the infertility of the couple interferes with the development of<br />
the species by interrupting it and provoking reactions and serious stress within<br />
the couple.<br />
As the values involved are very complex and as the Law must protect the<br />
couple. The principal rule of Law on MAP, in force in Italy, is examined in this<br />
study.<br />
1
RIASSUNTO<br />
Obiettivo di fondo di questa trattazione è quello di approfondire le<br />
implicazioni psicologiche, biologiche e bioetiche della Procreazione<br />
Medicalmente Assistita (PMA).<br />
Partendo dal fenomeno dell’infertilità di coppia ed entrando in merito alla<br />
diagnosi, prognosi e terapia ad essa associate, si giunge all’analisi delle principali<br />
tecniche della PMA, evidenziando come queste ultime vadano a toccare le più<br />
intime dinamiche di coppia e dei singoli individui che la compongono.<br />
Poiché la genitorialità è un processo evolutivo fondamentale, sia da un<br />
punto di vista biologico (mantenimento della specie) sia psicologico, verrà<br />
mostrato quali possano essere le reazioni e i vissuti di una coppia che, a causa<br />
della propria infertilità, vede interrotto questo sviluppo.<br />
Infine, vista la complessità dei valori in gioco e la necessità che la Legge<br />
tuteli tutti i soggetti coinvolti, verrà presa in esame la principale norma giuridica<br />
relativa alla PMA vigente nel nostro Paese.<br />
3
INTRODUZIONE<br />
La presente tesi, oggetto di discussione, tenderà ad approfondire, in maniera<br />
critica, le implicazioni psicologiche, biologiche e bioetiche della Procreazione<br />
Medicalmente Assistita (PMA).<br />
In particolare, muovendo dall’analisi del fenomeno “infertilità”, attraverso<br />
una approfondita distinzione nei due sessi, definendone i contorni specifici e le<br />
tipologie più ricorrenti, passando attraverso i suoi rimedi di carattere scientifico,<br />
si giungerà ad un’analisi delle principali tecniche della PMA, classificandole alla<br />
luce delle valutazioni di carattere psicologico, biologico e bioetico.<br />
Dovute queste premesse, si passa quindi ad illustrare in maniera<br />
argomentata le fasi che hanno delineato la costruzione di questo progetto di tesi.<br />
L’intenzione iniziale è quella di appurare con precisione rigorosa il concetto<br />
di “infertilità di coppia” partendo dalle origini di un fenomeno, in passato, quasi<br />
esclusivamente collegato al mondo animale e pressoché ripudiato a livello<br />
umano.<br />
Si tratterà quindi della sua etimologia semantica, della sua rilevanza nella<br />
storia, ma soprattutto della sua implicazione a livello psicologico nella coppia e<br />
nel contesto relazionale ad essa afferente.<br />
Si preferirà rivolgere lo sguardo all’umanità del problema, più che alla sua<br />
dissertazione accademico-scientifica, ritenendo che tale ostacolo al naturale<br />
concepimento vada inequivocabilmente a toccare e sollecitare le più intime<br />
dinamiche di una coppia e dei singoli individui che la compongono, ponendo<br />
serie e preoccupanti questioni intorno alla stabilità affettiva, psico-emotiva del<br />
binomio umano.<br />
5
Tale realizzazione non contiene in sé l’ambizione di sostituire o replicare<br />
tutte le innumerevoli tesi che ruotano intorno a questo argomento, di così<br />
scottante attualità.<br />
Essa si configura piuttosto come un contributo personale, possibile grazie<br />
ad una decennale esperienza lavorativa nel campo della PMA, critico e<br />
scientifico, al dibattito odierno.<br />
6
CAPITOLO I<br />
FERTILITÁ NELLA COPPIA: ANALISI GENDER<br />
ORIENTED<br />
7<br />
E Sara all’età di novanta anni potrà partorire?"<br />
Abramo disse a Dio: "Se almeno Ismaele<br />
potesse vivere davanti a te!”<br />
E Dio disse: "No, Sara, tua moglie,<br />
ti partorirà un figlio<br />
e lo chiamerai Isacco.<br />
(Genesi 17, 17-19)<br />
La sterilità, o impotentia generandi (in latino ”incapacità di generare”) è<br />
l’incapacità di concepire, gestire una gravidanza o partorire naturalmente un<br />
bambino.<br />
Una coppia è definita infertile quando non è in grado di concepire o portare<br />
a termine una gravidanza sino alla nascita di un individuo, entro 1-2 anni di<br />
rapporti frequenti e non protetti.<br />
La problematica della sterilità, e quindi della mancata capacità di riprodursi,<br />
è stata da sempre vissuta con paura e disgrazia presso quasi tutti i popoli. Non<br />
sappiamo esattamente in quale momento della sua evoluzione l’uomo si sia posto<br />
questo problema, ma studi antropologici hanno dimostrato che ci fu uno scarto<br />
notevole fra il diventare mammifero pensante e il mettere in relazione il coito con<br />
la fecondazione.<br />
Alcune documentazioni al riguardo risalgono all’antico Egitto e all’Antico<br />
Testamento, ma anche la tradizione indiana si è interessata all’argomento.<br />
E’ innegabile che il desiderio di un figlio, per quanto realizzabile in termini<br />
di “naturalità”, sia sottoposto a significative pressioni sociali e in senso più lato<br />
culturali, riempiendosi di significati, valori e simbologie che di naturale non
hanno più nulla, ma rispecchiano l’evoluzione della società, la storia del costume<br />
e della morale.<br />
In genere è il sesso femminile ad essere il più colpito da questa “calamità”,<br />
un po’ per retaggi storici, un po’ perché è la donna che vive appieno la maternità<br />
sia in senso fisico che psicologico: il desiderio di procreare appartiene ad<br />
entrambi i sessi, ma la donna appare quella che soffre di più nella situazione di<br />
incapacità.<br />
Andando con la memoria ai primordi dell’umanità, già nella Bibbia la<br />
sterilità è considerata una punizione di Dio e le donne che non possono avere<br />
figli permettono che la loro schiava giaccia col marito per poterne avere, per<br />
esempio la nascita di Ismaele da Abramo e dalla schiava Agar, caso che si<br />
ripeterà per Rachele e Giacobbe (Genesi 30, 1-13).<br />
Facendo un piccolo salto temporale, in Grecia la medicina ippocratica<br />
adduce a cause meccaniche la sterilità femminile (orifizio uterino otturato o<br />
troppo dilatato), ma anche a conformazioni fisiche particolari della donna.<br />
Non solo l’infertilità è stata storicamente considerata una “piaga sociale”,<br />
ma anche il sesso del nascituro ha avuto importanza storica come nel caso di<br />
Enrico VIII 1491–1547, re d’Inghilterra famoso per essersi sposato sei volte: la<br />
prima moglie, Caterina d'Aragona diede alla luce un figlio nato morto, poi un<br />
figlio, Enrico, ma questo visse soltanto un mese.<br />
La regina Caterina diede alla luce una bambina, Maria, facendo pensare ad<br />
Enrico che poteva ancora avere un erede maschio malgrado le precedenti<br />
gravidanze non positive di sua moglie (un nato morto, un aborto e due infanti<br />
vissuti brevemente), anche se la regina era stata incinta almeno sette volte, solo<br />
una bambina, la principessa Maria, era sopravvissuta all'infanzia.<br />
Quando divenne evidente che la regina Caterina non avrebbe potuto avere<br />
altri bambini, cominciò a corteggiare Anna Bolena mentre la figlia di Caterina fu<br />
8
dichiarata illegittima, ma anche Anna perse il favore del re non riuscendo a<br />
concepire il sospirato erede.<br />
In taluni casi, la vox populi ha trasformato in infertilità casi diversi, come<br />
l’origine dello scisma anglicano ad opera di Enrico VIII, in cui la regina Caterina<br />
d’Aragona passata alla storia come infertile, in realtà non lo era mai stata, ma<br />
solamente non aveva portato delle gravidanze a termine e non aveva garantito<br />
eredi maschi, futuri successori del re.<br />
Occorre giungere fino al Rinascimento per avere dei veri e propri trattati<br />
sull’argomento, in cui si trovano per la prima volta anche cause non prettamente<br />
organiche della sterilità: primieramente quando l’huomo, e la donna, non si<br />
portano amore non possono generare (Marinello, 1563 in Astruc, 1763), oppure<br />
la quarta e ultima causa è il disaccordo, la mancanza di amore fra i coniugi<br />
(Rodericus à Castro, 1659).<br />
P. Garnier (1883), in pieno clima romantico propose una classificazione<br />
della sterilità che si avvicinava molto alle teorie più moderne, con qualche<br />
sfumatura rosa: egli ne parla come della più grande calamità che possa capitare<br />
ad una coppia, “manca tutto, c’è solo tristezza” e in contrapposizione ai<br />
positivisti, per i quali il procreare è solo un atto fisico, si chiede se veramente<br />
l’amore, il sentimento, la passione, non possano influenzare la sterilità.<br />
Secondo questo Autore infatti, la sterilità può essere di tre tipi:<br />
a) essenziale, cioè derivante da cause organiche più o meno durature<br />
(diverse per l’uomo e per la donna)<br />
b) assoluta o definitiva<br />
c) relativa, definita come l’impossibilità di avere figli insieme, anche se<br />
separatamente sia l’uomo che la donna hanno dato prova di fertilità e malgrado la<br />
buona salute di entrambi.<br />
9
Alla fine dell’800, una volta comprovati vari studi di anatomia, si cominciò<br />
a dare prevalenza eziologica all’architettura dell’apparato genitale, perdendo<br />
queste strane, ma possibili spiegazioni “psicologiche”.<br />
Con l’apparizione del primo “Trattato Completo di Ginecologia” (Schauta,<br />
F,1898), la maggior parte della colpa veniva addossata all’apparato genitale<br />
femminile che per varie ragioni non riusciva ad accogliere il seme dell’uomo.<br />
Anche nella storia del ‘900 troviamo lo stesso problema: lo Scià di Persia<br />
Muhammad Reza Pahlavi ripudia la prima moglie perché gli ha dato solo una<br />
figlia femmina e non l’erede maschio; sposa Soraya ma i figli continuano a non<br />
arrivare finché, nel 1958, lo Scià dà al mondo l’annuncio del ripudio.<br />
1.1 Desiderare un figlio<br />
Mentre per gli animali la riproduzione è la conseguenza di un bisogno<br />
puramente istintivo, destinato ad assicurare la sopravvivenza della specie, il<br />
desiderio del figlio, per l’uomo e la donna, è al tempo stesso molto più profondo<br />
e molto più complesso: fa intervenire non soltanto tutta la struttura psicologica<br />
dell’individuo, ma anche il significato che si dà alla coppia, al sentimento e, più<br />
in generale, alla sua vita.<br />
Se si interrogano le persone sui motivi che li spingono a volere un figlio<br />
non è semplice, né le risposte sono ben articolate, “anche nei casi in cui le donne<br />
sembrano sapere perché vogliono un figlio le risposte sono difficili da<br />
interpretare, in quanto riferibili a due livelli: conscio e inconscio” (Acocella, et<br />
al., 1991, p.101).<br />
Il desiderio di un bambino, come tutti i nostri desideri, ha una storia, lo<br />
hanno preparato precedenti bisogni e fantasie e nel tempo si è trasformato in<br />
modo che la sua manifesta apparizione nel presente ha poco in comune con le<br />
immagini corrispondenti al bisogno da cui si è formato (Wyatt, 1967).<br />
10
La maternità comprende due fatti distinti se pur dipendenti: essere madre<br />
e avere un figlio.<br />
Essere madre, dal punto di vista psicodinamico, significa vivere un<br />
periodo in cui vengono riattivati antichi conflitti e vissuti dell’infanzia; se<br />
l’identificazione con la propria madre è stata positiva la transazione alla<br />
maternità sarà più semplice, altrimenti potranno subentrare problematiche che, se<br />
non vengono risolte, possono portare una cattiva gestione del maternage o in casi<br />
estremi anche una impossibilità di procreare.<br />
La sterilità inoltre implica tutti i problemi psico-affettivi ed emotivi legati<br />
allo spirito materno, dimensione psicologica che supera e oltrepassa il semplice<br />
fatto fisiologico che è la maternità (Pasini, Rouge, Meylan, 1975).<br />
La Deutsch (1945) distingue il desiderio di avere un figlio, legato a<br />
componenti emotive e narcisistiche, dallo “spirito materno” che rappresenta<br />
invece il grado più alto dell’emozione altruistica; sentimento sano quest’ultimo e<br />
patologico il primo.<br />
1.2 Definizione di sterilità<br />
Vista la confusione che c’è sull’argomento, l’Organizzazione Mondiale<br />
della Sanità (WHO,1993) ha stabilito una terminologia che si rifà a riferimenti<br />
temporali precisi:<br />
• sterilità primaria: mancato concepimento per un periodo di due anni<br />
nonostante la regolarità dei rapporti sessuali<br />
• sterilità secondaria: colpisce coppie che hanno già concepito e che per un<br />
periodo di due anni non riesce ad avere un’altra gravidanza<br />
• infertilità: definisce la situazione di una donna che arriva ad avere una<br />
gravidanza ma non riesce a portarla a termine.<br />
11
Secondo alcuni studiosi, il termine temporale di due anni risulta piuttosto<br />
lungo, riportando che, in base ad indagini statistiche già dopo un anno di rapporti<br />
sessuali infruttuosi una coppia può essere sospettata di sterilità.<br />
L’OMS stima attorno al 15-20% la percentuale di coppie con problemi di<br />
fertilità. Negli Stati Uniti si stima che almeno 5 milioni di persone abbiano<br />
questo problema (Mosher, Pratt, 1990), ma anche in Europa le stime sono<br />
elevate: ad esempio uno studio francese (Querleu, et al., 1990) ha rilevato una<br />
percentuale di coppie sposate sterili pari al 30%.<br />
In Italia è possibile fare una stima solo a partire da dati ISTAT, perché<br />
mancano ricerche epidemiologiche accurate, arrivando a postulare ogni anno da<br />
50.000 a 70.000 coppie sterili di cui solo il 42% si rivolge all’assistenza medica<br />
specialistica (Eurispes, 1996).<br />
1.3 Diagnosi di sterilità<br />
Molto importante è il colloquio iniziale, al quale la coppia giunge dopo<br />
incertezze, discussioni e ripensamenti: ci si trova davanti a persone con alti sensi<br />
di colpa, stati depressivi e notevole ambivalenza circa la gravidanza, inoltre si<br />
sentono inutili, improduttive e vivono questa loro condizione come uno stato di<br />
inferiorità (Cittadini et al., 1986).<br />
“Gli accertamenti e le terapie della sterilità sono, però lunghi, tormentosi e<br />
pieni di obblighi e la coppia che li intraprende deve esserne consapevole”<br />
(Acocella, et al., 1991, p.110).<br />
Il colloquio deve quindi creare un clima di fiducia e tranquillità, eliminando<br />
inutili timori e apprensioni, ma deve anche cercare di inquadrare la personalità<br />
dei due componenti della coppia, con particolare riguardo al comportamento<br />
sessuale e studiare la relazione coniugale e la sua storia.<br />
12
Cittadini e colleghi concludono però dicendo che è difficile stabilire con<br />
certezza se il problema della sfera psicologica preceda o sia conseguenza<br />
dell’infertilità, sottolineando come spesso una apparente infertilità sia dovuta<br />
all’ignoranza sulla fisiologia e meccanica degli apparati riproduttivi: ecco che in<br />
questo caso il colloquio può servire come momento chiarificatore delle abitudini<br />
sessuali della coppia e per dare eventuali spiegazioni in proposito.<br />
Prima di arrivare alla diagnosi di sterilità, la coppia deve sottoporsi a<br />
ulteriori colloqui (anamnesi personale e familiare) esami obiettivi e visita<br />
ginecologica.<br />
1.4 Eziologia e fattori che influenzano la fertilità umana<br />
Per quanto riguarda le cause, la sterilità non ha segreti nel 50% dei casi.<br />
Una coppia è definita infertile quando non è in grado di concepire o portare a<br />
termine una gravidanza sino alla nascita di un individuo, entro 1-2 anni di<br />
rapporti frequenti e non protetti.<br />
1.4.1 Fattori femminili<br />
femminile:<br />
Verranno di seguito elencati i più importanti fattori rilevanti nella fertilità<br />
• età anagrafica : è sicuramente uno dei fattori più importanti. Sebbene la<br />
fertilità femminile inizi a subire un declino dopo 28 anni di età, per<br />
convenzione si utilizza il 38° anno come soglia dopo la quale le possibilità<br />
di concepire diventano inversamente proporzionali all’età. La spiegazione<br />
più accettata è quella secondo cui si avrebbe una riduzione della qualità<br />
ovocitaria come conseguenza di errori durante la mitosi 1 e la meiosi 2 ;<br />
1<br />
mitosi : replicazione di una cellula somatica con formazione di due cellule figlie contenenti lo stesso<br />
corredo diploide di cromosomi.<br />
2<br />
meiosi: particolare tipo di divisione cellulare caratteristica delle cellule germinali, uovo e spermatozoo,<br />
in cui si verifica la riduzione in senso aploide del corredo cromosomico.<br />
13
• frequenza dei rapporti sessuali: è direttamente correlata alle possibilità di<br />
gravidanza. Una frequenza coitale a giorni alterni generalmente è accettata<br />
come ottimale;<br />
• tempo ricerca figli: la fertilità umana è per ogni ciclo pari a circa il 20%.<br />
Entro un anno di rapporti sessuali frequenti e non protetti, l’86% delle<br />
coppie ottiene una gravidanza. Le possibilità di concepimento si riducono in<br />
modo proporzionale con il trascorrere del tempo;<br />
• precedente contraccezione: gli IUD (dispositivi intrauterini di<br />
contraccezione) rappresentano un fattore di rischio per PID (Pelvic<br />
Infiammatory Disease) e quindi salpingiti per via ascendente, anche se<br />
recenti studi hanno notevolmente ridimensionato tale rischio;<br />
• caffeina: molti studi evidenziano la correlazione tra assunzione di caffeina<br />
e infertilità;<br />
• fumo di sigaretta: sembra ridurre la fertilità maschile e femminile;<br />
• stress: non esistono osservazioni scientifiche univoche che dimostrino un<br />
rapporto causa- effetto tra stress ed infertilità.<br />
1.4.2 Fattori maschili<br />
maschile:<br />
Verranno di seguito elencati i più importanti fattori rilevanti nella fertilità<br />
• l’incapacità o la diminuita capacità di produrre spermatozoi in grado di<br />
fecondare;<br />
• l’impossibilità di portare all’esterno il seme prodotto;<br />
• il criptorchidismo, la mancata discesa del testicolo nel sacco scrotale. Il<br />
criptorchidismo può associarsi ad altre anomalie del tratto genito-urinario e<br />
nel 70% dei casi riguarda il testicolo destro;<br />
14
• il varicocele che è una dilatazione varicosa delle vene nello scroto che<br />
drenano il sangue dal testicolo;<br />
• gli esiti di malattie infettive le alterazioni ormonali;<br />
• la formazione di anticorpi antispermatici e i traumi chirurgici.<br />
1.5 Cause dell’infertilità<br />
1.5.1 Infertilità inspiegata<br />
Quando i test diagnostici risultano negativi, per esclusione, si effettua la<br />
diagnosi di infertilità idiopatica. In realtà occorre riconoscere la nostra incapacità<br />
attuale di riuscire a valutare anomalie funzionali difficilmente esplorabili.<br />
Ad esempio, le tube possono essere studiate nella loro pervietà e<br />
macroscopica morfologia mediante isterosalpingografia o laparoscopia o solo<br />
salpingografia, ma gli aspetti funzionali rimangono esclusi. Probabilmente la<br />
categoria dell’infertilità inspiegata include una percentuale di coppie che<br />
presentano anomalie nel processo di formazione del gamete, nella fertilizzazione<br />
o nell’impianto.<br />
Tabella 1: Cause di infertilità (Collins,1995)<br />
Difetto ovulatorio<br />
Fattore maschile<br />
Fattore tubarico<br />
Etiologia sconosciuta<br />
Endometriosi<br />
Altro<br />
15<br />
27%<br />
25%<br />
22%<br />
17%<br />
5%<br />
4%<br />
Difetto ovulatorio. Rappresenta circa il 30% - 40% dei casi di infertilità<br />
femminile. I metodi per verificare l’ovulazione sono principalmente costituiti dal<br />
monitoraggio follicolare con ultrasuoni (consente di documentare lo sviluppo del<br />
follicolo dominante e dell’endometrio) e dalla valutazione del picco dell’LH.
Il metodo della temperatura basale, invece, si basa sul principio che, nel<br />
periodo post-ovulatorio, l’incremento della secrezione di progesterone, determina<br />
un incremento della temperatura basale che acquisisce quindi un andamento<br />
bifasico.<br />
Fattore maschile. E’necessario effettuare almeno due esami, distanziati nel<br />
tempo, del liquido seminale per valutare in particolare la concentrazione, la<br />
motilità e la morfologia nemaspermica.<br />
Sono stati riscontrati cambiamenti delle caratteristiche medie del seme negli<br />
ultimi venti anni che hanno indotto l’OMS a modificare i parametri minimi<br />
considerati normali.<br />
Alterazione della funzione tubarica. E’ possibile studiare la pervietà e la<br />
macroscopica morfologia, ma non gli aspetti funzionali delle salpingi, mediante<br />
isterosalpingografia, sonoisterografia, laparoscopia o salpingoscopia. In un<br />
prossimo futuro sarebbe auspicabile lo sviluppo di tecniche diagnostiche che<br />
consentano anche l’esplorazione della funzionalità tubarica.<br />
Fattori cervico-uterini. Anomalie della cavità uterina possono essere<br />
responsabili di meccanismi molecolari dell’endometrio e quindi di infertilità per<br />
effetti sfavorevoli sull’impianto.<br />
L’indagine diagnostica principale è rappresentata dalla isteroscopia che può<br />
evidenziare patologie come setti uterini, miomi sottomucosi, polipi endometriali<br />
e sinechie uterine (sindrome di Asherman).<br />
Fattore peritoneale. L’endometriosi può essere causa di danno tubarico od<br />
ovarico, ma i meccanismi patogenetici all’origine dell’infertilità non sono chiari.<br />
Probabilmente la produzione di mediatori dell’infiammazione come citochine,<br />
tumor factor necrosis, altera l’ambiente peritoneale, intratubarico e forse<br />
intrauterino, con effetti sfavorevoli per la fertilizzazione, l’impianto e lo sviluppo<br />
dell’embrione.<br />
16
La laparoscopia e l’ecografia pelvica con la valutazione del Ca 125 sierico<br />
rappresentano le indagini principali ai fini diagnostici.<br />
Rimane il 10% di casi in cui si parla di sterilità mista, ovvero quando può<br />
dipendere da entrambi i partner per cause immunologiche (incompatibilità a<br />
livello fisiologico fra marito e moglie).<br />
Esistono però anche casi in cui, dopo accurati accertamenti ed esami medici<br />
tutto appare normale e sano, eppure il figlio non riesce ad essere concepito; esso<br />
si presenta come uno stato di sterilità involontaria nella quale tutte le indagini<br />
appropriate hanno dato risultati negativi.<br />
In pratica si tratta di una incapacità a concepire determinata da<br />
problematiche di carattere psicologiche inconsce, un conflitto psicologico che si<br />
esprime a livello somatico; occorre supportare l’ipotesi con comprovati fattori<br />
eziopatogenetici specifici. Gli studi in letteratura, anche su questo argomento, si<br />
sono dedicati esclusivamente alle donne.<br />
In genere è proprio la donna che, erede delle tradizioni e presunta<br />
responsabile della sterilità della coppia, si decide a ricorrere al medico e va a<br />
farsi visitare per prima, manifestando un notevole disagio per la realtà delle cose.<br />
Questo significa che i fattori emotivi coscienti che possono impedire un<br />
concepimento sono poco apparenti. Cohen nel 1961 ha descritto due tipi di donne<br />
che per il loro atteggiamento ambivalente nei confronti della gravidanza possono<br />
sviluppare una sterilità psicogena:<br />
• la donna debole<br />
• la donna in carriera<br />
Studi a livello medico hanno dimostrato come i fattori emozionali abbiano<br />
effetti sia sulla spermatogenesi (Domar, Seibel, 1990; Giblin, et al., 1988) che<br />
sulle anovulazioni, le alterazioni tubariche e sull’impianto dell’embrione<br />
17
(Edelmann, Golombok, 1989; Seibel, Taymor, 1982), ma tutto ciò non è<br />
sufficiente per dimostrare una causa psicologica della sterilità (Froggio, 2000).<br />
Effettuare una diagnosi di sterilità psicogena non è affatto semplice e<br />
secondo più parti della letteratura, l’aver ricondotto in passato numerosi casi di<br />
sterilità alla sfera psicopatologica inconscia è stata una necessità dettata più dalle<br />
lacune presenti in campo medico che a una comprovata causa psicologica.<br />
In campo psicoanalitico però troviamo interessanti ipotesi eziologiche, nella<br />
teorizzazione espressa dalla Deutsch (1945), la quale vede nel senso di colpa<br />
inconscio la causa della sterilità psicogena.<br />
Essa ha descritto cinque tipi di donna:<br />
1. l’infantile: appare e si comporta come una bambina, sempre bisognosa di<br />
appoggiarsi a qualcuno (i genitori prima e il marito poi); se riesce a<br />
concepire un figlio, comunque non riesce a maturare e eliminare i suoi<br />
conflitti che si ripercuoteranno sulla funzione materna.;<br />
2. la materna: è la mamma per eccellenza, di solito ha un partner-bambino<br />
che cura come un figlio quindi a livello inconscio rifiuta la maternità per<br />
amore del marito che non è pronto per svolgere la funzione genitoriale.;<br />
3. l’indaffarata: è colei che dedica la sua vita ad altri interessi, come la<br />
carriera, un affetto di altro genere o semplicemente che è appagata da<br />
relazioni sessuali intense. Questo tipo di donna non è contraria alla<br />
maternità, ma diventa sterile per evitare il conflitto che si verrebbe a creare<br />
nel caso di scelta fra il diventare madre e continuare una vita piena di<br />
interessi e attività.;<br />
4. la virile aggressiva: rimane sterile perché rifiuta la sua femminilità.;<br />
5. l’emotiva: non riesce a concepire perché è cosciente della povertà della sua<br />
vita affettiva.;<br />
18
La sterilità, anche se psicogena, rappresenta una rinuncia forzata; si fa<br />
risalire le problematiche di fertilità al rapporto insoddisfacente con la madre-<br />
ambiente-contenitore di stampo winnicottiano.<br />
La maggior parte delle donne sterili non ha avuto un contatto positivo con<br />
la propria madre e questo ha creato reazioni di rancore e invidia che le porta a un<br />
senso di inferiorità. Inconsciamente sono bloccate a un periodo di sviluppo in cui<br />
non hanno ricevuto il consenso da parte della loro mamma di avere un bambino<br />
proprio, ma la rabbia e l’invidia le portano a provare e riprovare a restare incinta<br />
(Pines, 1972, 1990).<br />
La maggior parte della letteratura ha constatato che nelle donne sterili si<br />
trova il predominio della figura materna verso la quale nutrono aggressività<br />
repressa con una corrispondente assenza della figura paterna (debole, respinta o<br />
assente).<br />
Riassumendo, la psicoanalisi adduce in generale, come causa di sterilità<br />
psicogena la tensione dovuta alla paura inconscia della gravidanza, legata a sua<br />
volta a un senso di colpa verso la figura materna.<br />
In questa prospettiva, se la persona stessa rinuncia volontariamente alla<br />
gravidanza, ad esempio dopo una diagnosi di sterilità, può avvenire un<br />
allentamento di questa tensione che può portare al ripristinarsi delle funzioni<br />
fisiologiche alterate con un probabile e conseguente concepimento.<br />
Si trovano in letteratura (Menninger, 1942; Andrews, 1970) numerosi casi<br />
eccezionali in cui la sterilità si è risolta subito dopo un’adozione, intesa da questi<br />
analisti come manifestazione della cessazione della tensione su citata.<br />
Altri però non sono così ottimisti (Hans, Rock, 1950) visto che solo l’8%<br />
delle coppie riesce a concepire un figlio naturale dopo un’adozione (c’è da dire<br />
anche che vista la datazione di questi studi i loro risultati sono discutibilmente<br />
attendibili alla luce delle nuove scoperte scientifiche).<br />
19
Uno studio più recente (Sarrel, De Cherney, 1985) rende merito al<br />
trattamento psicanalitico della sterilità, dimostrando che dopo una breve analisi<br />
di risoluzione dei conflitti psichici ben 6 coppie su 10 del gruppo sperimentale<br />
avevano concepito un figlio; occorre sottolineare però che si trattava di coppie<br />
con una sterilità secondaria.<br />
Per Piscicelli (1979) la sterilità psicogena femminile crea una serie di<br />
condizioni organiche che sono:<br />
• disturbi della dinamica del rapporto sessuale in sé: non è presente<br />
nessuna alterazione endocrina, ma sembra che la donna attraverso spasmi<br />
muscolari riesca a impedire il passaggio degli spermatozoi fino all’uovo da<br />
fecondare.<br />
• fattori ovarici: può esserci anovulazione o produzione di ovuli immaturi<br />
quindi non fecondabili;<br />
• funzioni tubariche: l’ansia e la paura della gravidanza sembrano provocare<br />
la contrazione del collo dell’utero e delle tube rendendo impossibile la<br />
circolazione del seme maschile.<br />
A conferma di ciò si possono citare studi di fisiologia sugli animali, in cui è<br />
stato dimostrato che stati psicologici come l’ansia e il timore hanno un effetto<br />
diretto sulla funzione pituitaria e quindi sull’ovulazione (Racamier, 1955).<br />
Sempre a proposito di animali, la fecondazione artificiale praticata su di<br />
essi ha una percentuale di esito positivo molto più alta rispetto a quella umana, a<br />
testimonianza del fatto che nell’uomo si ha una influenza importante proprio del<br />
fattore psicologico (Benedek, 1953). Un interessante studio di Pasini e<br />
collaboratori (1975) ha confrontato le caratteristiche psicopatologiche di due<br />
gruppi di donne, sterili versus infertili: nei risultati di test proiettivi di<br />
personalità, le donne non fertili sono risultate più ansiose e insicure, ma con una<br />
affettività più viva.<br />
20
Le donne sterili invece hanno presentato una personalità rigida e arida con<br />
impulsi aggressivi mal dominati e rivolti contro se stesse; è apparso in questo<br />
caso anche un sentimento di odio verso la madre che ha notevolmente influito<br />
sull’organizzazione della personalità. Le donne non fertili sono risultate nel<br />
complesso più vicine alla norma, anche se con tratti fobici.<br />
1.6 Causa o effetto?<br />
E’ possibile, a volte, confondere gli effetti con le cause: è possibile che in<br />
alcune donne dei problemi psicologici impediscano di avere bambini, ma bisogna<br />
anche prendere in considerazione il caso contrario, ovvero che una situazione di<br />
infertilità comprovata getti l’individuo in una depressione e in una crisi profonda<br />
che prima non c’era.<br />
Attualmente si stima che i casi di influenza diretta dei conflitti psichici sulla<br />
riproduzione siano il 5% (Froggio, 2000), comunque da non sottovalutare, perché<br />
forse sono proprio le reazioni psicologiche all’incapacità di concepire che<br />
possono contribuire al mantenimento del problema e al suo cronicizzarsi.<br />
1.7 L’infertilità? Un problema anche dell’uomo<br />
L’infertilità è un evento di vita riconosciuto come tra i più stressanti, un<br />
problema estremamente delicato, che vede coinvolti due partner in relazione tra<br />
loro e con modalità di aggiustamento al problema, spesso molto differenti. La<br />
letteratura psicologica sperimentale risulta ricca di studi sull’infertilità<br />
femminile, ma decisamente povera sul fattore maschile.<br />
Risultati di studi che avevano lo scopo di indagare l’impatto dell’infertilità<br />
sull’uomo, qualora sia egli stesso il membro della coppia che porta il fattore<br />
d’infertilità, indicano che, in questi casi, l’uomo subisce un impatto negativo alla<br />
21
diagnosi, arrivando a mettere in crisi la propria identità di genere e la possibilità<br />
di vivere una sessualità soddisfacente e spontanea.<br />
Sebbene vi sia una consapevolezza, ormai generalmente condivisa dagli<br />
studiosi, sul fatto che la condizione di infertilità provochi grossi disagi a chi la<br />
vive, un’importante lacuna, presente nella letteratura, è rappresentata dal fatto<br />
che la maggior parte delle ricerche si sia concentrata sull’impatto di questo<br />
problema sulla donna della coppia infertile, relegando sullo sfondo la figura del<br />
partner maschile.<br />
Questo dato mostra come la donna sia stata a lungo ritenuta il membro della<br />
coppia che subiva le maggiori ripercussioni della diagnosi e dei trattamenti e che<br />
andava incontro a più elevati livelli di stress (Freeman, et al., 1985).<br />
Le donne sono da sempre considerate come coloro che, emotivamente,<br />
investono di più nella nascita di un figlio; inoltre sono più vulnerabili all’ansia e<br />
alla depressione (Newton, et al., 1990) e hanno una maggiore probabilità di<br />
sviluppare alti livelli di stress rispetto ai loro partner (Collins, et al., 1992).<br />
Il trattamento medico, ad esempio, è sempre riconosciuto stressante dalle<br />
donne. Di fatto sono loro che sottostanno alle procedure più invasive: in<br />
particolare, durante il prelievo dell’ovulo e, dopo il trasferimento in utero<br />
dell’embrione, durante l’attesa del risultato (Callan, 1988; Luisi, Righetti, Rizzo,<br />
Livi, 2002).<br />
Anche il supporto psicologico e sociale, di cui l’uomo gode, è scarso<br />
rispetto a quello dedicato alle donne (Abbey, et al., 1992).<br />
In realtà, anche la posizione dell’uomo all’interno del problema<br />
dell’infertilità è estremamente delicata: infatti alcune ricerche hanno dimostrato<br />
che anche l’uomo vive l’esperienza dell’infertilità con grande disagio e<br />
sofferenza arrivando, per di più, all’appuntamento con l’infertilità impreparato,<br />
sia da un punto di vista evolutivo che personale.<br />
22
Fino a pochi anni fa, quando i tentativi di una coppia di concepire un figlio<br />
fallivano, la colpa di questo insuccesso era quasi sempre attribuita alla donna, per<br />
cui le indagini mediche atte a scoprire le cause dell’infertilità venivano eseguite<br />
solo su di lei; al contrario, l’uomo quando si trova davanti ad una diagnosi di<br />
infertilità, deve affrontare una situazione per così dire “nuova”, in quanto non era<br />
stata veramente “pensata” a priori e “sperimentata” sul piano della fantasia.<br />
L’uomo è dunque seriamente afflitto da questo problema esattamente come<br />
la donna, sviluppa un uguale grado di stress, anche se questo viene vissuto e<br />
gestito in maniera differente. (Nachtigall, et al.,1992; Collins, et al., 1992; Luisi,<br />
Righetti, Rizzo, Livi, 2002). E’ proprio la diversa gestione dello stress da parte<br />
dell’uomo e della donna a causare i dolorosi e difficili conflitti che nascono nelle<br />
coppie infertili: apparentemente toccati dall’infertilità in modi differenti, i due<br />
partner rispondono al problema con coping diversi, che possono riflettere una<br />
risposta adattativa a livello personale, ma che danno origine ad un impatto<br />
negativo significativo sulla relazione di coppia (Mahlstesdt, 1985).<br />
Secondo alcune ricerche, gli uomini e le donne possono avere percezioni<br />
molto differenti della propria relazione di coppia tanto che le donne affermano di<br />
sentirsi più accudite sia su di un piano fisico che emotivo; l’uomo può infatti<br />
tendere ad allontanarsi dalle proprie emozioni focalizzandosi sui problemi della<br />
moglie (Mahlstesdt, 1985), mentre i loro compagni riportano di sentirsi<br />
controllati dalle loro mogli e dai loro bisogni di fertilità.<br />
E’ importante allora, tener conto di queste problematiche mentre si accede<br />
ad un protocollo di fecondazione assistita, in quanto il coinvolgimento dell’uomo<br />
nei trattamenti della sterilità è strettamente correlato al periodo ovulatorio della<br />
donna, al bisogno che l’emissione del liquido seminale avvenga in un<br />
determinato momento. Nell’uomo la mancanza di cura e accudimento reciproco<br />
unita alla sensazione di essere controllati, fa sì che la situazione divenga assai<br />
23
stressante (Luisi, Righetti, Rizzo, Livi, 2002). Non sentendosi così in grado di<br />
superare l’altrui e proprio dolore l’uomo entra in un lutto riservato, smette di<br />
ascoltare e alimenta nella moglie l’idea che egli non sia coinvolto quanto lei nella<br />
ricerca del figlio.<br />
Si può verificare così una diade psicologicamente negativa e distruttiva: da<br />
un lato la donna si sente “abbandonata” nel momento in cui ha maggiormente<br />
bisogno del compagno, dall’altro lato l’uomo si sente schiacciato e soffocato dal<br />
bisogno che lei ha di lui.<br />
E’ questo il motivo della depressione che fa seguito alle metodiche di PMA:<br />
se è vero che il fallimento nel concepimento porta ad uno stato depressivo, è<br />
altrettanto vero che la perdita della reciproca vicinanza e l’incapacità di<br />
comprendersi sono terreni fertili su cui il malessere psicologico si impianta e<br />
cresce.<br />
L’uomo e la donna tendono a differenziarsi anche nel coinvolgimento di<br />
altre persone al loro problema: mentre la donna cerca il supporto sociale<br />
all’esterno della coppia e quindi parla del problema, nel marito aumenta il senso<br />
di solitudine e “cresce” l’imbarazzo davanti alla società.<br />
Quindi il coping di evitamento e l’atteggiamento di chiusura, spesso tipici<br />
della reazione maschile all’infertilità, hanno certamente contribuito a legittimare<br />
e mantenere vivo il pensiero comune che ritiene l’uomo meno coinvolto nel<br />
problema “infertilità” rispetto alla donna e, di conseguenza, meno bisognoso di<br />
un supporto psicologico.<br />
A livello sperimentale però, i dati riguardanti la sofferenza psicologica<br />
dell’uomo infertile, trovano conferma solo ultimamente per due motivi:<br />
• il recente sviluppo dei trattamenti per l’infertilità, resi possibili dalle nuove<br />
tecniche di riproduzione assistita, ha portato ad un graduale aumento del<br />
coinvolgimento del partner maschile rispetto al passato;<br />
24
• una maggiore attenzione all’uomo e alle sue problematiche legate<br />
all’infertilità, ha permesso di capire che un errore era stato commesso nelle<br />
ricerche del passato; basti pensare che fino a dieci anni fa non si era mai<br />
fatto un parallelismo tra i componenti delle coppie infertili, tra gli uomini<br />
che portavano il fattore di infertilità, da quelli fertili.<br />
I risultati di una ricerca elaborata nel 1992 da Nachtigall et al., atta ad<br />
indagare le risposte di uomini e donne di coppie sterili di fronte ad una diagnosi<br />
genere-specifica, hanno chiarito il motivo per cui l’uomo non sempre sembrava<br />
risentire dell’esperienza dell’infertilità con la sua compagna: gli uomini sono sì<br />
colpiti dall’infertilità da un punto di vista psicologico quanto le donne, ma quello<br />
che cambia è la loro risposta che raggiunge valori similari a quelli della partner,<br />
solo se il fattore eziologico è di origine maschile.<br />
Le diverse risposte tra uomo e donna possono essere imputate alle diverse<br />
percezioni dei differenti ruoli procreativi specifici dei due generi: mentre le<br />
aspettative culturali per il ruolo sociale della donna riguardano la sua possibilità<br />
di essere madre, l’abilità di procreare è un’aspettativa culturale che investe<br />
maggiormente l’uomo, il quale basa dunque la propria identità di genere non<br />
sulla paternità, ma sulla capacità di fecondare la propria donna.<br />
I risultati delle ricerche passate trovano così una plausibile giustificazione<br />
nella differenza tra la tendenza femminile a sviluppare elevati livelli di stress, al<br />
di là di dove risieda il fattore eziologico dell’infertilità, e quella maschile, legata<br />
invece all’origine di quest’ultimo.<br />
Anche nello studio condotto da Bolis, Di Leo, Labadini (2007), viene messa<br />
in risalto la complessità della condizione dell’uomo infertile che è caratterizzata<br />
da vissuti, desideri e paure personali, aspettative sociali, culturali, e dalla qualità<br />
della relazione di coppia.<br />
25
Tale ricerca è stata condotta, prendendo in esame un campione di uomini<br />
infertili sottoposti alla tecnica ICSI, ed ha messo in luce come questa<br />
problematica mini la serenità dell’individuo per i condizionamenti negativi che<br />
l’espressione della sessualità subisce in fase di diagnosi e terapia; ed incrini la<br />
sicurezza della propria identità di genere.<br />
Per l’uomo infertile, la perdita della mascolinità rappresenta un dolore e una<br />
minaccia così grande e destabilizzante da superare la sofferenza per la perdita<br />
della paternità.<br />
1.8 La coppia dinanzi alla sterilità<br />
Le reazioni psicologiche possono influenzare lo stato d’animo dei coniugi,<br />
possono turbare i rapporti fra di loro e con il loro entourage amicale e familiare.<br />
Dagli anni Settanta ad oggi numerosi studi su coppie hanno dato risultati<br />
eterogenei per quel che riguarda eventuali legami fra stati psicopatologici e<br />
fertilità, ottenendo a volte risultati nella norma altre volte livelli leggermente più<br />
elevati di ansia e depressione nelle coppie sterili (soprattutto sul versante<br />
femminile).<br />
Per quanto riguarda invece gli effetti della diagnosi di sterilità sulla coppia,<br />
troviamo notizie più omogenee che si possono così riassumere:<br />
• effetti emotivi: shock, depressione, senso di lutto, rabbia e senso di colpa;<br />
• effetti sulla identità personale: senso di disistima, dubbi sull’identità di sé e<br />
su quella coniugale, perdita di significato dell’intera esistenza;<br />
• effetti sulla relazione coniugale: ostilità, paura dell’abbandono, isolamento<br />
dal partner, ma anche sostegno reciproco e avvicinamento;<br />
• effetti sulla vita sociale: senso di non accettazione, isolamento dalle<br />
amicizie o dalla famiglia di origine.<br />
26
Ad ogni modo, le coppie si rendono conto che in questo momento delicato è<br />
necessario avere un supporto psicologico, infatti il 97% di coloro che si<br />
rivolgono a un centro per il trattamento della sterilità afferma che il servizio<br />
psicologico è necessario, mentre il 50% richiede un’assistenza psicologica o<br />
psicoterapeutica in prima persona (Daniluk, 1988).<br />
Sussistono notevoli differenze di genere nella reazione alla dichiarazione di<br />
sterilità: i maschi sembrano reagire con maggiore ottimismo, assumono un<br />
atteggiamento possibilista che può risultare però ambiguo agli occhi della<br />
moglie: in realtà cercano di trattenere i propri sentimenti, parlando meno del<br />
problema perché si sentono in colpa e colpiti nella loro virilità, perdendo la stima<br />
di sé.<br />
La reazione della donna è invece drammatica: mostra apertamente<br />
delusione, depressione, disperazione. La capacità di procreare e la genitorialità<br />
sono per le donne fra gli aspetti più importanti per la definizione della propria<br />
identità, forse è per questo che queste dimostrano maggiore coraggio e costanza<br />
nel portare avanti le terapie, sono le prime a recarsi dallo specialista ed effettuare<br />
le indagini preliminari.<br />
Nella donna la sterilità può essere definita come assenza di un figlio, mai<br />
come inesistenza, infatti il bambino preesiste alla maternità reale e non si<br />
esaurisce con essa. Nel vissuto di sterilità convivono due opposte esperienze:<br />
quella di mancanza di figlio nel reale e quella di presenza di figlio<br />
nell’immaginario.<br />
Il sociologo Alberoni identifica invece nel figlio un prodotto di pregio, un<br />
lusso, un investimento affettivo ed emotivo che deve colmare un vuoto, un vuoto<br />
che troppo spesso è in realtà un vuoto di coppia: si vuole un figlio e si fa un figlio<br />
per tenere in vita un rapporto che altrimenti si esaurirebbe e che molte volte si<br />
esaurisce dopo la nascita (Cioni,2005).<br />
27
Per questo diventa estremamente importante in sede di colloquio pre-<br />
trattamento, provare ad accertare quali sono i motivi che spingono una coppia a<br />
volere un figlio ad ogni costo o tramite la fecondazione artificiale o con<br />
l’adozione, anche e soprattutto per il bene del bambino. A questo punto,<br />
concludendo, il problema rimane aperto, con quanto già visto sopra,<br />
“primieramente quando l’huomo, e la donna, non si portano amore non possono<br />
generare” (Marinello, 1563).<br />
1.9 In sintesi<br />
In questo capitolo è stata affrontata la problematica della sterilità, ossia la<br />
mancata capacità di riprodursi.<br />
Partendo da un excursus storico che porta a comprendere, non solo la<br />
vastità del problema, ma, anche quanto esso sia stato determinante in eventi ad<br />
esso correlati, sono stati definiti, in termini medici: prognosi, diagnosi, eziologia<br />
e cause che influenzano la fertilità umana di entrambi i componenti della coppia.<br />
Sin dall’inizio di questa trattazione si vuole sottolineare, vista la delicatezza<br />
del momento vissuto all’interno della coppia, la necessità e l’importanza di un<br />
supporto psicologico.<br />
Nel secondo capitolo verranno affrontate le principali ed attuali tecniche di<br />
PMA con i relativi rischi ad esse correlati.<br />
28
CAPITOLO II<br />
LE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE<br />
ASSISTITA<br />
29<br />
“Gli spermatozoi, l’unica forza, tutto ciò che hai,<br />
ma che uomo sei se non hai il cielo”<br />
(Renato Zero, “Il Cielo”,1977)<br />
Le tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) sono state<br />
messe a punto, sperimentate ed applicate in un arco di tempo relativamente breve<br />
(dal 1978).<br />
Rispetto alle tecniche di base della fecondazione in vitro sono state<br />
successivamente introdotte numerose variazioni, alcune delle quali hanno<br />
resistito alla prova del tempo (Soules,1997).<br />
Nelle pagine che seguono, parleremo delle principali tecniche di<br />
fecondazione assistita, tralasciandone alcune dai nomi fantasiosi, sostanzialmente<br />
simili alle altre o poco utilizzate( Righetti, Luisi, 2007).<br />
Tabella 2: Tecniche di riproduzione assistita<br />
• Inseminazione intracervicale ICI<br />
• Inseminazione intrauterina IUI<br />
• Inseminazione intratubarica ITI<br />
• Inseminazione intraperitoneale IPI<br />
• Fertilizzazione in vitro e trasferimento embrionale FIVET<br />
• Iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo ICSI<br />
• Trasferimento tubarico di gameti GIFT<br />
• Trasferimento tubarico di zigoti ZIFT<br />
• Trasferimento tratubarico di embrioni TET
2.1 L’Inseminazione Artificiale<br />
La storia dell’inseminazione artificiale è molto antica: era già menzionata<br />
nel Talmud ebraico, a uso veterinario, come si legge in un codice arabo del 1322.<br />
Sul piano della documentazione scientifica, la prima inseminazione<br />
artificiale in un mammifero fu eseguita e descritta dal sacerdote e filosofo<br />
italiano Lazzaro Spallanzani nel 1780.<br />
Nello stesso periodo, in Inghilterra, John Hunter, uno dei padri della<br />
chirurgia inglese, confidava in un diario di avere adottato la tecnica<br />
dell’inseminazione artificiale per una coppia di pazienti il cui partner maschile<br />
soffriva di una grave malformazione che gli impediva di eiaculare in vagina.<br />
Da allora, le tappe dell’inseminazione artificiale sono state lente e faticose;<br />
la comunità scientifica, infatti, accolse questo tipo di sperimentazioni con<br />
intolleranza e ostilità, e pesanti furono i condizionamenti di tipo etico e religioso<br />
(Righetti, Luisi 2007).<br />
2.1.1 La tecnica<br />
La fecondazione con il seme maschile è, attualmente, una tecnica<br />
ampiamente utilizzata nel trattamento dell’infertilità da fattore maschile, fattore<br />
cervicale e immunologico (Byrd,1997).<br />
La procedura è stata applicata anche nei casi di infertilità idiopatica.<br />
Esistono vari metodi di fecondazione, definiti dalla provenienza del liquido<br />
seminale (marito o donatore) e dal sito del tratto riproduttivo femminile in cui si<br />
deposita lo sperma.<br />
In caso di liquido seminale prodotto dal marito, la procedura è stata<br />
denominata fecondazione artificiale omologa; al contrario, quando il seme è<br />
prodotto da altri, si parla di fecondazione artificiale da donatore o fecondazione<br />
terapeutica da donatore (FTD). L’inseminazione può essere eseguita:<br />
30
1) intravaginalmente, utilizzando l’intero eiaculato o una sua parte<br />
opportunamente trattata tramite una tecnica detta di capacitazione, con<br />
cui vengono selezionati gli spermatozoi più mobili;<br />
2) intracervicalmente (inseminazione intracervicale, ICI);<br />
3) pericervicalmente, con eiaculato non elaborato o spermatozoi lavati.<br />
Collocando gli spermatozoi in qualsiasi punto al di sopra dell’orificio<br />
uterino interno, si esegue un’inseminazione intrauterina (IUI).<br />
Depositando lo sperma direttamente all’interno delle tube di Falloppio si<br />
esegue la cosiddetta inseminazione transuterotubarica.<br />
L’inseminazione intraperitoneale diretta consiste, invece, nel deposito dello<br />
sperma direttamente nella cavità peritoneale.<br />
La scelta della tecnica e del sito in cui depositare lo sperma dipende in gran<br />
parte dalle indicazioni cliniche relative all’infertilità.<br />
Di tutte le procedure di fecondazione disponibili, l’inseminazione<br />
intrauterina (IUI) è quella maggiormente considerata ed applicata.<br />
L’utilizzazione di questa metodica è stata favorita dalle tecniche progredite<br />
di preparazione degli spermatozoi, il cui sviluppo è in parte dovuto ai progressi<br />
della fecondazione umana in vitro. Gli altri fattori che hanno contribuito alla<br />
crescita dell’IUI sono la capacità di predire l’ovulazione utilizzando dei semplici<br />
test del livello dell’ormone luteinizzante (LH) da eseguire a casa, l’uso di terapie<br />
farmacologiche in grado di stimolare l’ovulazione con un adeguato monitoraggio<br />
contemporaneo e, infine, i progressi tecnici dei cateteri di trasferimento.<br />
Sebbene la popolarità dell’inseminazione intrauterina sia cresciuta dalla<br />
prima revisione della tecnica eseguita da Mastroianni e collaboratori<br />
(Mastroianni, 1957) la sua efficacia è ancora fonte di dubbi.<br />
La IUI permette di oltrepassare la barriera cervicale, producendo di<br />
conseguenza delle percentuali di gravidanza significativamente maggiori di<br />
31
quelle relative alla ICI nella maggior parte degli studi pubblicati (Cruz, Irvine,<br />
1986).<br />
Tuttavia, alcune indagini riportano che la differenza fra le due tecniche è<br />
minima o inesistente (Hughes, Collins, Garner, 1987).<br />
2.1.2 Rischi potenziali della inseminazione intrauterina<br />
dell’IUI.<br />
Vediamo in dettaglio quali sono i rischi più comuni legati alla tecnica<br />
A) Infezioni: la contaminazione da microrganismi è un reperto comune<br />
nell’eiaculato ed è possibile che la presenza di questi organismi nel campione di<br />
liquido seminale possa contribuire a diminuire la percentuale di<br />
fecondazione . (Bolton, Warren, Braude, 1986).<br />
Le percentuali di infezioni non vengono modificate dal lavaggio del seme<br />
con soluzioni antibiotiche o dalla profilassi antibiotica nelle donne prima della<br />
fecondazione. Sembra che le percentuali di infezione dopo l’inseminazione<br />
intrauterina siano tanto basse da non giustificare la somministrazione profilattica<br />
di antibiotici nelle pazienti.<br />
B) Dolore e coliche uterine: la letteratura riporta diversi casi di coliche<br />
uterine dopo l’inseminazione intrauterina (Allen, et al., 1985), il 6-17% delle<br />
pazienti soffrono di crampi molto forti a seguito della procedura, ma la<br />
separazione degli spermatozoi dal plasma seminale e la riduzione del volume del<br />
campione di inseminazione a 0,5 ml solitamente diminuiscono il problema.<br />
C) Aborto spontaneo: la percentuale generalmente accettata di aborti<br />
spontanei nelle prime 20 settimane è del 15% nelle coppie non sottoposte a<br />
tecniche di riproduzione assistita. Le prime statistiche relative alle percentuali di<br />
aborto spontaneo dopo la fecondazione artificiale indicano una percentuale media<br />
di circa il 26% (Bolton VN, Warren RE,Braude PR,1987). Sembra che la<br />
32
percentuale di aborto spontaneo sia approssimativamente il doppio dopo<br />
l’inseminazione intrauterina; non si sa se questo incremento dell’incidenza sia<br />
dovuto ai fattori di infertilità o ad errori di accertamento.<br />
D) Sviluppo di anticorpi antispermatozoi: la presenza di anticorpi<br />
antispermatozoi nel partner maschile o il numero di cicli di inseminazione<br />
intrauterina non incrementano il rischio di sviluppo di anticorpi antispermatozoi<br />
nella donna dopo l’inseminazione intrauterina.(Freidman, et al., 1991).<br />
E) Gravidanze multiple: l’incremento del numero o l’incidenza di<br />
gravidanze multiple dopo la stimolazione follicolare è probabilmente dovuto alla<br />
maturazione di un numero maggiore di follicoli e conseguentemente di oociti e<br />
ciò può comportare l’abbandono del trattamento. I cicli possono essere sospesi se<br />
c’è il sospetto che si verifichi la sindrome da iperstimolazione ovarica: per questo<br />
motivo, la terapia ormonale deve essere sempre attentamente controllata<br />
(Righetti, Luisi 2007).<br />
2.2 La Fertilizzazione in Vitro con Trasferimento dell’Embrione (FIVET)<br />
2.2.1 Storia della Fertilizzazione in Vitro<br />
La storia delle applicazioni cliniche del processo noto come fecondazione<br />
in vitro (In Vitro Fertilization, IVF) è un esempio straordinario dei benefici<br />
ottenibili dal sinergismo della ricerca di base con la pratica clinica.<br />
Come era lecito aspettarsi, il primo tentativo serio di applicazione clinica di<br />
ciò che ora noi conosciamo come IVF è stato condotto da un medico prima di<br />
essere a conoscenza di parametri fondamentali quali il pH e l’osmolarità.<br />
Per questo motivo il tentativo fallì.<br />
Il primo chiaro tentativo di fecondare in vitro un’oocita fresco di<br />
mammifero sembra essere stato quello riportato da Schenk nel 1880 che tentò di<br />
fecondare in vitro oociti di coniglio e di topo. Il tentativo fallì, e ciò ora non ci<br />
33
stupisce, infatti, oggi sappiamo che l’oocita di mammifero richiede durante la<br />
fecondazione un’osmolarità ed un pH costanti, per cui, il progresso della ricerca<br />
in vitro ha dovuto, quindi, attendere la comprensione di questi fattori di base.<br />
Devono passare quasi 100 anni prima che il fallito esperimento di Schenk<br />
del 1880 divenga un esperimento riuscito; infatti, fu nel 1978 che Steptoe e<br />
Edwards risolsero i problemi esposti sopra, con la nascita di Louise Brown, il<br />
primo essere umano concepito fuori dal grembo materno, appunto in “vitro”.<br />
Tuttavia, durante questi 100 anni, numerosi ricercatori hanno dato il loro<br />
contributo su molti punti, facendo si che il sistema funzionasse.<br />
Ad esempio, alla Fondazione Worcester, nel Massachusetts, un giovane<br />
ricercatore cinese di nome M.C.Chang riuscì a risolvere in modo inequivocabile<br />
il problema della fecondazione in vitro di oociti di coniglio. Dopo la<br />
dimostrazione di Chang sulla realizzabilità della fecondazione in vitro nel<br />
coniglio, molti altri ricercatori applicarono la tecnica ad altre specie, quali il topo,<br />
il ratto ed altri animali di laboratorio. Tra quelli che lavoravano sul topo c’era<br />
Robert Edwards, un giovane biologo inglese di Cambridge. Egli era di base un<br />
genetista interessato all’immunologia nel topo, sul quale era riuscito di realizzare<br />
il processo di fecondazione in vitro. Edwards pensò che il processo poteva essere<br />
applicato in campo umano ma, presso l’Università di Cambridge, all’epoca di<br />
Edwards non c’era la facoltà di medicina, per questo motivo, egli aveva scarso<br />
accesso a materiale umano; nel tentativo di trovare un posto dove potevano<br />
essere disponibili oociti umani, si recò come borsista presso il John Hopkins<br />
Hospital nel 1965. Tornato in Inghilterra, incontrò nel 1968, Patrick Steptoe, un<br />
ginecologo con il quale lavorò per circa 10 anni prima che tutti gli aspetti della<br />
fertilizzazione in vitro si dimostrassero di funzionare in modo soddisfacente con<br />
la nascita di Louise Brown nel 1978.<br />
34
Nel corso di questi anni sono state apportate molte modifiche alla procedura<br />
utilizzata allora, determinando una vera e propria rivoluzione in tale settore.<br />
Nel 1985, secondo i dati pubblicati su “Fertility and Sterility”, una delle<br />
riviste mediche più prestigiose che si occupano di riproduzione umana, furono<br />
337 i bambini nati dopo un intervento di FIVET (Fertilizzazione in Vitro con<br />
Embrio Transfer) negli Stati Uniti. Nel 1990, il numero delle nascite dopo<br />
FIVET saliva a 2345, e nel 1993 a 6870.<br />
Sempre negli Stati Uniti, nel 1990 le strutture che eseguivano tecnologie di<br />
secondo livello erano 180, ma nel 1993 il loro numero era già salito a 277. Anche<br />
in Europa ci fu un grande sviluppo di questa tecnica ed un conseguente aumento<br />
delle nascite. E’abbastanza sorprendente che la FIVET sia stata acquisita<br />
rapidamente nei paesi in via di sviluppo. Nel 1994, in più di trentotto nazioni era<br />
presente un centro d’applicazione di tecnologie riproduttive: tra queste, molti<br />
Paesi asiatici, africani e dell’America centro-meridionale.<br />
Le applicazioni della FIVET si sono progressivamente ampliate. Questa<br />
tecnica, messa a punto per superare la sterilità di tipo meccanico (quando vi è un<br />
impedimento all’incontro tra ovuli e spermatozoi, come nei casi di sterilità<br />
tubarica); è oggi impiegata in molte altre situazioni, come in presenza di<br />
endometriosi o quando non sia chiaramente diagnosticata una causa d’infertilità.<br />
Nel 1999, negli Stati Uniti sono stati eseguiti 70000 cicli di fecondazione in vitro<br />
e 10000 trasferimenti di embrioni congelati. C’è una tendenza, a livello<br />
mondiale, a ricorrere sempre più spesso a tecniche di fecondazione assistita,<br />
allargando in modo forse eccessivo le indicazioni (Righetti, Luisi 2007).<br />
35
2.2.2 Fasi della Fertilizzazione in Vitro con Trasferimento di Embrioni<br />
Un ciclo di riproduzione assistita prevede diverse fasi che vanno dalla<br />
necessità di produrre un maggior numero di follicoli e quindi di oociti, alla<br />
fertilizzazione in vitro o in vivo e quindi di trasferimento di embrioni.<br />
Tabella 3: Fasi delle Tecniche di riproduzione assistita<br />
a) “Down regulation” ipofisaria con agonisti o antagonisti del GnRH<br />
b) Iperstimolazione ovarica controllata (COH) con gonadotropine di<br />
estrazione urinaria o ricombinanti, monitorata attraverso ultrasuoni e<br />
dosaggio di livelli sierici di 17β-estradiolo. Maturazione ovocita ria<br />
mediante HCG.<br />
c) Recupero oocitario ecoguidato per via vaginale (pick-up)<br />
d) Fertilizzazione in vitro mediante inseminazione oocitaria (IVF) o iniezione<br />
intracitoplasmatica (ICSI) o fertilizzazione in vivo(GIFT)<br />
e) Trasferimento di embrioni utero (FIVET) o in tuba (TET) e successivo<br />
supporto farmacologico della fase luteale<br />
Prima di addentrarci in merito all’argomento occorre fare un breve excursus<br />
sull’anatomia funzionale dell’apparato della riproduzione nella specie umana.<br />
L’ipotalamo e l’ipofisi sono ghiandole presenti a livello dell’encefalo, che<br />
rilasciano ormoni direttamente interessati al processo riproduttivo (Palermo, et<br />
al., 1999). L’ipotalamo rilascia il GnRH, che stimola il rilascio da parte<br />
dell’ipofisi, delle gonadotropine: l’ormone follicolo-stimolante (FSH) e l’ormone<br />
luteinizzante (LH), responsabili a loro volta della stimolazione sull’ovaio che<br />
conduce al fenomeno dell’ovulazione. La produzione ormonale dell’ovaio<br />
dipende dalla stimolazione gonadotropica; gli ormoni prodotti dall’ovaio sono<br />
l’estradiolo ed il progesterone.<br />
36
Il primo è prodotto dai follicoli in crescita , la follicologenesi è infatti un<br />
processo ovarico in continua attività, dal menarca alla menopausa, che consente<br />
il reclutamento, la selezione di una coorte di follicoli e lo sviluppo di un solo<br />
follicolo dominante. All’interno del follicolo può essere presente l’oocita<br />
immerso nel liquido follicolare.<br />
Il progesterone è prodotto dal corpo luteo, quest’ultimo è il residuo<br />
follicolare dopo l’ovulazione (Berek, 1996).<br />
All’inizio del ciclo mestruale, l’incremento dei livelli di FSH provoca<br />
l’attivazione di una coorte di follicoli, che si trova ad uno stadio di crescita<br />
iniziale; i livelli di estrogeni cominciano a questo punto ad aumentare.<br />
Nel periodo intermedio di tale fase, un follicolo comincia a superare la<br />
crescita degli altri, la produzione di FSH viene meno ed i restanti follicoli vanno<br />
incontro ad un fenomeno di involuzione, definito “atresia”.<br />
Nonostante ciò, i livelli di estrogeni continuano ad aumentare, perché<br />
prodotti dal follicolo dominante che continua a crescere. Quando la<br />
concentrazione di estrogeni raggiunge un certo livello, si verifica il picco<br />
dell’LH; le cellule della granulosa si luteinizzano poco prima dell’ovulazione, ed<br />
incomincia la produzione di progesterone. In presenza di un follicolo maturo, per<br />
una serie di processi intrinseci al follicolo stesso e sotto lo stimolo dell’LH, si<br />
verifica la rottura del follicolo con la conseguente deiscenza dell’oocita, che<br />
verrà in seguito “catturato” dalla porzione terminale della tuba. Tale evento si<br />
verifica in genere 14 giorni dopo l’inizio del flusso mestruale. Dopo l’ovulazione<br />
il follicolo si trasforma in corpo luteo, responsabile della produzione di<br />
progesterone; in assenza di gravidanza, la produzione di progesterone da parte<br />
del corpo luteo comincia a declinare da 9 a 11 giorni dopo l’ovulazione, così<br />
come quella di estradiolo e tale declino è responsabile della desquamazione della<br />
mucosa endometriale, cioè della mestruazione.<br />
37
Le modificazioni ormonali che si verificano nel corso del ciclo inducono<br />
delle modificazioni anche a livello dell’endometrio, definendo il cosiddetto<br />
“ciclo endometriale”, direttamente regolato dalle variazioni di estrogeni e<br />
progesterone (Palermo, et al., 1999).<br />
a) “Down regolation” ipofisaria<br />
I protocolli più utilizzati, per la “Down regulation”, prevedono l’uso di<br />
agonisti del GnRH per sopprimere l’attività ipofisaria e quindi prevenire il picco<br />
endogeno dell’LH (Gardner, et al., 2004). Sono in genere somministrati durante<br />
la fase luteale (21°giorno) del ciclo precedente a quello di stimolazione ovarica.<br />
Per valutare l’avvenuta “Down regulation” dopo circa 15 giorni dalla<br />
somministrazione si dosano i livelli sierici del 17β estradiolo che devono<br />
risultare inferiori a 50pg/ml.<br />
b) Iperstimolazione ovarica controllata (COH)<br />
Dopo avere verificato i valori di 17β estradiolo, è possibile iniziare la<br />
somministrazione parenterale quotidiana di gonadotropine ricombinanti o di<br />
estrazione urinaria, con protocolli diversi a seconda del tipo di paziente (poor-<br />
hight o normo-responder) e dell’età.<br />
Il monitoraggio della crescita follicolare viene effettuato mediante<br />
ultrasuoni e dosaggio sierico del 17β estradiolo sierico. In genere, in presenza di<br />
almeno di 3-4 follicoli di diametro medio superiore a 17-18 mm si induce la<br />
maturazione oocitaria mediante hCG urinario o ricombinante per via<br />
intramuscolare o sottocutanea. Il recupero oocitario viene effettuato circa 34-36<br />
ore dalla somministrazione di hCG (Allahbadia, 2005).<br />
38
c) Recupero oocitario ecoguidato per via vaginale (pick-up)<br />
Il recupero oocitario viene effettuato circa 34-36 ore dalla somministrazione<br />
di hCG mediante prelievo ecoguidato per via vaginale, eseguito più<br />
comunemente tramite sedazione della paziente. Le complicanze più frequenti,<br />
correlate al pick-up sono rappresentate da emorragia, infezioni pelviche e più<br />
raramente da ascesso pelvico e lesioni di organi interni. Sotto visione stereo<br />
microscopica avviene il recupero degli oociti dal fluido follicolare ottenuto per<br />
aspirazione transvaginale eco guidata. Gli oociti vengono stoccati in opportuni<br />
terreni di coltura, in un incubatore a temperatura e ad atmosfera controllata.<br />
Contemporaneamente vengono trattati gli spermatozoi mediante una opportuna<br />
metodica atta a concentrare il maggior numero di spermatozoi dotati di buona<br />
morfologia e motilità (Gadner, et al., 2004).<br />
d) Fertilizzazione in vitro mediante inseminazione oocitaria (IVF) o iniezione<br />
intracitoplasmatica (ICSI) o fertilizzazione in vivo (GIFT)<br />
Gli oociti ottenuti tramite il pick-up, dopo circa 3-4 ore dal recupero<br />
vengono inseminati con un’opportuna concentrazione di spermatozoi (20.000-<br />
40.000) per oocita (IVF). I gameti (oocita e spermatozoi) vengono incubati<br />
insieme nel mezzo di coltura per 18-20 ore, e dopo tale intervallo di tempo viene<br />
effettuata la decoronizzazione, che consiste nella “pulitura” degli oociti dalle<br />
cellule della corona radiata e dagli spermatozoi in eccesso, mediante appositi<br />
capillari; in tale fase viene evidenziata la presenza dei due pronuclei (un nucleo<br />
proveniente dallo spermatozoo, con l’apporto paterno, e l’altro dall’oocita, con<br />
l’apporto materno) e l’espulsione del secondo globulo polare, indice di avvenuta<br />
fecondazione. In genere il tasso di fecondazione supera l’80% per gli oociti<br />
maturi, ma si riduce al 50% in presenza di oociti immaturi o in caso di sterilità da<br />
fattore maschile.<br />
39
Gli embrioni ottenuti vengono incubati per altre 24 ore circa; gli embrioni<br />
giungono allo stadio di 4-8 cellule 48-72 ore dopo il prelievo oocitario ed in<br />
questa fase può essere effettuato un transfer uterino o tubarico.<br />
Il trasferimento intrauterino può essere effettuato anche in tempi successivi,<br />
a 5-6 giorni dal pick-up, quando gli embrioni hanno raggiunto lo stadio di<br />
blastocisti (Palermo, et al., 1999).<br />
Qualora vi siano severe alterazioni dei parametri seminali (anomalie del<br />
numero, della motilità e della morfologia del liquido seminale), oppure bassa<br />
percentuale di fecondazione in vitro degli oociti, o addirittura mancata<br />
fecondazione apparentemente inspiegata degli oociti, viene utilizzata, in<br />
alternativa all’IVF, una tecnica di laboratorio che incrementa la probabilità di<br />
fecondazione: l’iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI).<br />
Nessuna tecnica sviluppatasi nel XX secolo ha affascinato più dell’ICSI<br />
(Palermo, et al, 1992) nell’ambito della riproduzione assistita.<br />
La ICSI è una tecnica di laboratorio e dunque essa riguarda semplicemente<br />
il trattamento dei gameti; le altre tappe delle metodiche di fecondazione in vitro<br />
(induzione della crescita follicolare, prelievo oocitario, trasferimento degli<br />
embrioni) sono pertanto analoghe a quella precedentemente riportata (Palermo, et<br />
al., 1999).<br />
Le tappe della ICSI sono:<br />
• preparazione del liquido seminale 3 ;<br />
• decoronizzazione e valutazione della maturità nucleare degli oociti;<br />
• iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo grazie all’utilizzo di un<br />
sistema di micromanipolazione montato su un inverto microscopio;<br />
3 (quando gli spermatozoi non sono presenti nel liquido seminale, è possibile tentare il recupero<br />
direttamente dal testicolo, tramite degli aghi sottili, (TESA), oppure a livello epididimario, tramite piccoli<br />
prelievi bioptici, (TESE).<br />
40
• stoccaggio all’interno dell’incubatore degli oociti iniettati;<br />
• verifica dell’avvenuta fertilizzazione come nell’IVF.<br />
I tassi di fecondazione e gravidanza dopo ICSI sono attualmente<br />
sovrapponibili a quelli ottenuti con l’IVF. Tali risultati sono estremamente<br />
incoraggianti, perché permettono di risolvere condizioni di sterilità in passato<br />
considerate non trattabili; va, comunque, tenuto presente che è opportuno<br />
utilizzare la ICSI in presenza di particolari indicazioni, sia perché si tratta pur<br />
sempre di una tecnica giovane ed i bambini nati da ICSI son ancora troppo pochi<br />
per poter concludere che si tratti di una tecnica sicura e troppo piccoli per dare<br />
garanzie su eventuali influenze della tecnica in tempi successivi dello sviluppo<br />
umano.<br />
Un brevissimo cenno sulla GIFT: tale tecnica prevede il trasferimento<br />
intratubarico dei gameti maschili e femminili (spermatozoi e oociti). E’ stata<br />
sviluppata da Ash e collaboratori nel 1984; dopo iperstimolazione ovarica e<br />
controllata si effettua il prelievo oocitario ecoguidato trans vaginale, anticipato<br />
dalla raccolta del liquido seminale. Generalmente 10.000-100.000 spermatozoi<br />
mobili per oocita vengono introdotti in un apposito catetere, separati mediante<br />
una bolla di aria dai gameti femminili e con questi trasferiti per via laparoscopica<br />
in una o in entrambe le tube.<br />
Poiché la GIFT necessita di un’anestesia generale e di solito di una<br />
laparoscopia, questa tecnica è stata accantonata in quanto troppo rischiosa ed<br />
invasiva.<br />
e) Trasferimento di embrioni utero (FIVET) o in tuba(TET) e successivo<br />
supporto farmacologico della fase luteale.<br />
Gli embrioni vengono classificati prima di essere trasferiti mediante un<br />
catetere. A differenza delle fasi principali, che possono essere modificate in base<br />
41
a quanto viene verificato durante i controlli, questa fase rappresenta una serie di<br />
eventi poco verificabili, ma motivo di grande attenzione, per tentare di<br />
incrementare le percentuali di impianto legate a variabili cruciali come l’età della<br />
paziente, numero e qualità degli embrioni trasferiti, ma anche della scelta del<br />
catetere, le modalità e la temporizzazione del transfer, nonché la distanza dal<br />
fondo e dall’orifizio uterino in cui vengono deposti gli embrioni.<br />
Attualmente, in Italia è in vigore la Legge 40/2004, che permette la<br />
fertilizzazione di un numero massimo di tre oociti e il trasferimento di tutti gli<br />
embrioni ottenuti.<br />
42
Ovocita in metafase II Spermatozoi<br />
Zigote Embrione a 8 cellule<br />
Divisione embrionale (embrioni a 2 cellule, 4 cellule e 8 cellule)<br />
43
Come si esegue la ICSI<br />
Fig.1<br />
1. Un ovocita maturo ( MII) viene tenuto da un lato con una particolare<br />
micropipetta chiamata holding (a sinistra nella Fig.1).<br />
2. Um microago dalla punta sottile e affilata chiamato micro-injection<br />
viene utilizzato per fermare lo spermatozoo, indicato dalla freccia nella<br />
Fig.1 ed aspirarlo al suo interno.<br />
Fig. 2<br />
3. Questo microago viene quindi inserito lentamente all’interno del<br />
citoplasma dell’ovocita ( Fig.2 lo spermatozoo è indicato dalla freccia).<br />
Fig.3<br />
4. Lo spermatozoo viene iniettato e depositato all’interno del citoplasma<br />
dell’ovocita ed il microago lentamente viene rimosso ( fig.3 la testa dello<br />
spermatozoo all’interno dell’ovocita è evidenziata dal cerchio).<br />
44
2.3 Rischi e risultati delle Tecniche di Riproduzione Assistita<br />
I rischi legati alle tecniche di PMA sono :<br />
• Sindrome da iperstimolazione ovarica (OHSS)<br />
• Gravidanze multiple<br />
• Abortività<br />
Le pazienti con elevato rischio di sviluppare la OHSS sono in primo luogo<br />
le donne con sindrome dell’ovaio policistico. Altri fattori a rischio sono la<br />
giovane età (Palermo, et al., 1999). Tra i parametri della stimolazione correlati<br />
con la OHSS risultano importanti il livello di 17β estradiolo ed il numero e le<br />
dimensioni dei follicoli preovulatori .<br />
La complicanza più frequente delle tecniche di riproduzione assistita è<br />
rappresentata dalle gravidanze multiple. Questo problema è strettamente<br />
collegato al numero di embrioni che vengono trasferiti. Questo rischio è<br />
notevolmente diminuito dopo l’introduzione delle linee guida della legge<br />
40/2004 che prevede il trasferimento di tre embrioni, cioè di quelli ottenuti dal<br />
clivaggio dei tre oociti utilizzabili.<br />
Complessivamente, circa il 20% delle gravidanze cliniche, ottenute con<br />
l’utilizzo di queste tecniche, si interrompono; le cause di ciò sono riferibili sia<br />
all’elevata incidenza di anomalie genetiche degli oociti e degli embrioni, ma<br />
anche alla maggiore sorveglianza a cui è sottoposta tale popolazione e, quindi,<br />
alla più precoce diagnosi di gravidanza.<br />
2.4 Il Congelamento di oociti e di embrioni<br />
I primi embrioni ad essere congelati e poi scongelati furono quelli di topo<br />
nel 1971. A questo risultato fece seguito, pochi anni dopo, la crioconservazione<br />
di embrioni di conigli, pecore, capre e mucche. Il 28 marzo 1984, a Melbourne,<br />
venne alla luce Zoe Leyland, il primo essere umano nato da un embrione<br />
45
congelato. Da allora, questa tecnica si è diffusa in tutto il mondo tramite gli stessi<br />
centri che praticano la FIVET.<br />
Ci si può domandare: “ L’embrione congelato è vivo?” Se prendiamo in<br />
esame gli attributi normalmente riconosciuti alla biovita, constatiamo che<br />
l’embrione congelato non utilizza energia con le stesse modalità degli altri esseri<br />
viventi, perché tutte le sue molecole sono immobili.<br />
Ma alla domanda se l’embrione congelato conservi la struttura e le<br />
informazioni tipiche degli esseri viventi, la risposta è affermativa: conserva<br />
questi attributi ed è in grado di farlo per molti anni.<br />
Alcuni embrioni però, subiscono danni durante il congelamento e quindi, al<br />
momento dello scongelamento, sono completamente morti; altri presentano<br />
alcune cellule degenerate ed altre vive.<br />
Lo scarto tra la vita e la morte è data da piccole differenze nel<br />
microambiente, tali da influenzare non solo ciascun embrione, ma ogni singola<br />
cellula. Finché un embrione è congelato, è impossibile sapere se, dopo lo<br />
scongelamento, sarà in grado di proseguire nello sviluppo.<br />
Con la stimolazione dell’ovulazione, spesso si ottiene un numero di oociti<br />
che porta ad un numero di embrioni superiore a quello che si può trasferire in<br />
utero (due o tre), per evitare gravidanze multi gemellari. Gli embrioni in più<br />
possono essere congelati; così, se non si è ottenuta la gravidanza, in un ciclo<br />
successivo si possono trasferire quegli embrioni che una volta scongelati hanno<br />
potenzialità vitali. In questo modo, si può evitare alla donna lo stress di ripetere<br />
la procedura di stimolazione dell’ovulazione e del prelievo degli oociti, con il<br />
rischio annesso dell’iperstimolazione.<br />
Se invece la gravidanza c’è stata, gli embrioni congelati possono essere<br />
richiesti per una seconda o terza gravidanza. Bisogna sottolineare che,<br />
congelando gli embrioni, si evita la ripetizione di tutte le procedure, con un<br />
46
evidente beneficio per la salute della donna e con una riduzione dei costi<br />
complessivi, dal momento che il trasferimento degli embrioni scongelati ha costi<br />
notevolmente inferiori ad un ciclo completo.<br />
Secondo la letteratura internazionale, il congelamento embrionario aumenta<br />
di circa il 10% la percentuale di gravidanza ottenuta in un ciclo di fertilizzazione<br />
in vitro o di iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi.<br />
2.5 In sintesi<br />
In questo capitolo sono state esaminate le tecniche messe a punto,<br />
sperimentate e attualmente utilizzate in PMA.<br />
Sebbene tali applicazioni cliniche siano uno straordinario esempio dei<br />
benefici ottenibili dal sinergismo della ricerca di base con la pratica clinica, non<br />
sono stai tralasciati i potenziali rischi più comuni collegati a tali metodiche.<br />
Nel prossimo capitolo, fulcro di questa trattazione, verranno<br />
approfonditamente analizzati gli aspetti psicologici legati al difficile percorso<br />
della PMA, fino ad ora sottovalutati.<br />
47
CAPITOLO III<br />
LA PROCREAZIONE ASSISTITA: ASPETTI<br />
PSICOLOGICI 4<br />
49<br />
“Ogni coppia merita un suo romanzo”,<br />
così come”“ogni bambino<br />
merita un suo romanzo”<br />
(Righetti,Ogni bambino merita un romanzo, 2005)<br />
3.1 La Procreazione Medicalmente Assistita: nuove “genitorialità”<br />
3.1.1 Introduzione<br />
Nella storia della coppia e di ogni individuo, il desiderio di un figlio e la<br />
possibilità di realizzarlo comportano un grande investimento emozionale e una<br />
molteplicità di significati. Ma nel momento in cui una coppia si scontra con la<br />
frustrazione di questo desiderio o addirittura con l’impossibilità di realizzarlo che<br />
cosa succede?<br />
L’infertilità e il ricorso a tecniche di riproduzione assistita sono esperienze<br />
uniche e irripetibili per ogni donna, per ogni uomo e per ogni coppia, così come<br />
unici e irripetibili sono i singoli individui e il loro vissuto e, di conseguenza,<br />
unica e irripetibile è la coppia.<br />
Poiché mente e corpo non costituiscono unità scisse e parallele nel singolo<br />
individuo, tale nella sua totalità, se, nell’infertilità e nel suo trattamento, ci si<br />
limita ad identificare e a curare “ciò che non funziona” nell’organismo, inteso<br />
come “corpo biologico semplice”, per arrivare all’obiettivo di procreare si viola<br />
la sacralità che la cultura attribuisce all’atto riproduttivo che diviene un evento<br />
esclusivamente freddo, distaccato e meccanico. Occorre, piuttosto, recuperare<br />
4 Questo capitolo è stato elaborato prendendo come riferimento il libro di Righetti, Luisi: La procreazione<br />
assistita: aspetti psicologici e medici (2007), in quanto ritenuto un testo particolarmente esaustivo<br />
riguardo agli aspetti psicologici e medici relativi al percorso di PMA, avendo il pregio di affrontare in<br />
modo aggiornato ed integrato le problematiche legate all’infertilità di coppia.
una dimensione olistica, perché è l’organismo nella sua interezza ad essere<br />
coinvolto nell’esperienza della procreazione.<br />
3.1.2 Il desiderio di un figlio<br />
3.1.2.1 Le Componenti Biologico-Istintuali<br />
Il desiderio di un figlio è oggetto di un’ormai ampia letteratura, in cui esiste<br />
sostanziale accordo nel riconoscere la complessità dei fattori che influiscono<br />
sulla decisione di procreare. Tale desiderio affonda le sue radici nell’infanzia<br />
dell’uomo e della donna; esso matura poi nella progettualità di coppia, all’interno<br />
della quale si intreccia con altri desideri, anche inconsapevoli, che provengono<br />
sia dall’individuo sia dalla coppia (Righetti , Sette, 2000).<br />
Già Freud (1915, 1931, 1932) aveva collocato l’origine del desiderio di<br />
maternità nella fase pregenitale dello sviluppo, arrivando ad affermare che la<br />
donna incontra il supremo compimento della sua femminilità nella realizzazione<br />
di questo desiderio. Il bambino avrebbe la funzione di completare quella<br />
mancanza d’essere che la donna sperimenta nell’infanzia, con la fase edipica, e<br />
nell’adolescenza, con “l’invidia del pene” nei confronti dell’uomo. Questa prima<br />
formulazione è stata in seguito riformulata da Freud, che ha ricondotto il<br />
desiderio di maternità alla fase preedipica di attaccamento alla madre: esso<br />
rappresenterebbe un tentativo di ricostruire il perduto stato di fusione originaria<br />
(Simonelli, Zancato, Calvo, 2000).<br />
3.1.2.2 Le Componenti Psicologiche e Fantasmatiche<br />
Vegetti Finzi (1997) legge nel desiderio di un figlio una complessa<br />
dinamica tra tensioni biologiche, richieste sociali e contenuti inconsci. La spinta<br />
istintuale a procreare per la conservazione della specie si connetterebbe con il<br />
desiderio inconscio di riparare all’angoscioso sentimento di caducità,<br />
50
sperimentato dall’uomo con il crollo dell’onnipotenza infantile e presentificato<br />
dall’esperienza della morte. La nascita di un figlio, quindi, è ricercata, al tempo<br />
stesso, come espressione del desiderio di continuità e della paura della morte. Da<br />
una parte, infatti, si appaga il bisogno di continuità con la nascita di una nuova<br />
generazione, dall’altra, si assiste al superamento della generazione precedente,<br />
evocando dunque il fantasma della morte.<br />
Il desiderio di un figlio parte da un progetto meta individuale, ma richiede<br />
un processo di maturazione che coinvolge l’individuo sin dalla prima infanzia.<br />
Nella donna, questo comporta la preparazione di un “grembo psichico”, che<br />
deriva dall’elaborazione di figure e costrutti fantastici. Si giunge alla<br />
fantasmatizzazione del bambino immaginario e all’anticipazione del processo<br />
generativo nelle sue fasi di contenimento e di espulsione, consentendo al<br />
bambino che nascerà di “essere atteso, pensato e amato prima ancora di venire<br />
alla luce” (Vegetti Finzi, 1997, p.87).<br />
3.1.3 La genitorialità: un percorso evolutivo<br />
Il figlio rappresenta per la donna un oggetto d’amore, un completamento di<br />
sé, una parte di lei che non è lei e che, come tale, vive nel suo immaginario prima<br />
della nascita e perfino dopo la morte del figlio stesso. Per l’uomo, invece, il figlio<br />
rappresenta un duplicato narcisistico si sé, l’immagine di sé stesso bambino<br />
conservata nella memoria, e acquisisce il valore simbolico di una riedizione del<br />
passato, così prolungato e riformulato. Di conseguenza “il desiderio di un figlio<br />
nasce per l’uomo e per la donna dal riconoscimento di una mancanza. Per l’uno<br />
si tratta soprattutto di ammettersi finito nel tempo, per l’altra di sentirsi<br />
incompleta nello spazio”(Vegetti Finzi, 1997, p.110).<br />
La diversa caratterizzazione dei due percorsi implica, comunque, che il<br />
desiderio di un figlio, così diversamente maturato, trovi espressione nel desiderio<br />
51
di coppia, terreno comune in cui maternità e paternità confluiscono<br />
compiutamente nel concetto di genitorialità. Il passaggio dal desiderio di<br />
maternità e paternità al desiderio di genitorialità rappresenta il segno<br />
dell’apertura all’altro, ricercato come fonte di arricchimento e sviluppo in un<br />
rapporto di reciproco scambio, di tolleranza e riconoscimento della diversità,<br />
all’interno del quale il figlio diviene simbolo d’amore.<br />
Secondo Freud (1931), l’amore parentale può essere definito narcisismo dei<br />
genitori tramutato in amore oggettuale; il narcisismo anima il desiderio di<br />
gravidanza inteso come mero bisogno di eguagliare la potenza generativa della<br />
propria madre (Pines, 1972, 1982). L’apertura è una tendenza evolutiva che<br />
conduce al riconoscimento dell’alterità.<br />
In questa prospettiva, la gravidanza è un evento determinante per il<br />
processo maturativo dell’individuo: essa rappresenta un momento di crisi, nel<br />
quale alle trasformazioni fisiche si accompagna un vero e proprio tumulto<br />
psichico. Quindi, è necessario trovare un nuovo equilibrio, una ristrutturazione<br />
sistematica in cui conciliare passato, presente e futuro, regressione e crescita.<br />
Racamier (1979), ha proposto il concetto di maternalità (motherhood) per<br />
descrivere le difficoltà del lavoro psichico che la futura madre deve fare quando<br />
sa di essere incinta, il modo con cui interagisce con il bambino, nonché i pensieri,<br />
le immaginazioni e i fantasmi che il neonato e il suo comportamento risvegliano<br />
in lei procurando a volte anche rotture deliranti. Alla mamma viene chiesto un<br />
doppio movimento psichico infatti se da una parte deve cercare quella bambina<br />
che è in lei (i suoi bisogni, i suoi piaceri etc.) dall'altra deve ritrovare le braccia<br />
materne con un vissuto di essere stata capita e tranquillizzata, potendo<br />
rintracciare dentro di sé quel sentimento che le permette di essere una madre<br />
sufficientemente buona.<br />
52
Viene anche definita come un percorso evolutivo di formazione che si<br />
compie grazie al superamento di conflitti intrapsichici e interpersonali (Cramer,<br />
Palacio-Espasa, 1995): ad esempio, la relazione passata con i propri genitori o<br />
l’interazione con il contesto sociale presente e il mondo fantasmatico, relativo<br />
soprattutto al bambino immaginario (Bordi, 1989).<br />
Le rappresentazioni materne evolvono a partire dalla gestazione e<br />
confluiscono concettualmente nella “costellazione materna”, definita da Stern<br />
(1995), come una nuova organizzazione psichica dominante, in genere non<br />
permanente, non universale e non innata, nonostante alcune influenze<br />
psicobiologiche. Questa nuova disposizione genera “una nuova serie di azioni,<br />
tendenze, sensibilità, fantasie, paure e desideri” (Stern, 1995, p.172), legati alla<br />
presenza reale del bambino e al suo bisogno di cure.<br />
Per quanto riguarda il versante paterno, intendendo quel versante che vede<br />
il padre coinvolto nelle cure primarie, è meno conosciuto il processo di<br />
paternalità anche se l'esperienza clinica in diversi casi ci fa confrontare con<br />
situazioni di scompenso del futuro padre spesso proprio alla nascita del figlio; in<br />
condizioni estreme si può arrivare alla rottura della relazione.<br />
Di fatto nelle prime settimane di vita del bambino, anche il padre effettua una<br />
regressione, che lo porta a svolgere il ruolo di un sostituto materno.<br />
Pertanto il desiderio della madre nei confronti del neonato è regolato dalla<br />
relazione con questo terzo.<br />
paterna.<br />
La madre è portatrice nel suo discorso, nei suoi fantasmi dell’immagine<br />
L'interazione tra la funzione paterna intrinseca alla vita rappresentativa della<br />
madre e il funzionamento del padre reale ha un posto fondamentale nella<br />
costituzione dell'ambiente del bambino (Winnicott, 1960).<br />
53
Quando si studiano ed analizzano, i processi del divenire genitore, in chiave<br />
di lettura fenomenologico-relazionale, con la convinzione che in ogni sviluppo<br />
maturativo, compresa la genitorialità, tutto sia centrato sulla relazione, sorgono<br />
spontanee queste domande:<br />
Quando inizia il desiderio di un figlio? Quale percorso compie il singolo nel<br />
divenire coppia per proiettarsi nella genitorialità? Quali sono le componenti<br />
psicologiche che entrano in gioco? Cosa significa passare da un Io (individualità)<br />
a un Tu (riconoscimento dell’altro) per un Noi (relazione di coppia)? (Righetti,<br />
2002, 2005).<br />
L’uomo è spinto alla relazione, modalità essenziale per la sua<br />
sopravvivenza, da un moto interno di bisogni, desideri, emozioni che producono<br />
specifiche intenzioni, per ricercare nell’ambiente la possibilità di soddisfare i<br />
corrispondenti bisogni. La vita, dunque, è il risultato di un complesso sistema di<br />
interazioni, sin dal momento del concepimento. Con la nascita, il neonato rompe<br />
la simbiosi con la madre e acquisisce con la separazione l’autonomia, ma deve<br />
entrare in relazione con il nuovo ambiente, i genitori, per soddisfare i propri<br />
bisogni e sopravvivere. E’ evidente che il bambino ha fin da subito una spinta e<br />
un forte interesse per la relazione.<br />
Essa richiede sempre un Io e un Tu e presuppone che l’individuo riconosca<br />
sé stesso come individualità dai confini ben definiti e l’altro come individuo di<br />
pari dignità e diverso da sé. In questa prospettiva, la relazione comporta la<br />
consapevolezza che ogni essere umano è unico e irripetibile, insieme al profondo<br />
rispetto per ciò che è l’altro è, o meglio, per ciò che di sé l’altro porta nella<br />
relazione.<br />
Le coppie infertili che affrontano protocolli PMA (spesso anche più cicli)<br />
sono coppie forti, mature, consapevoli della loro relazione; spesso è proprio la<br />
PMA che favorisce e determina questi aspetti. Dopo tutto il dato reale è proprio<br />
54
l’essere coppia, poiché il bambino per molto tempo rimane solamente il<br />
contenuto di un pensiero e di un desiderio. Se, durante il protocollo di PMA, tutte<br />
e due i partner “scoppiano”, c’è il rischio che la coppia “scoppi”; ecco, quindi,<br />
che il marito, comunque meno coinvolto dalle procedure del protocollo clinico,<br />
rappresenta un punto di appoggio fondamentale. Egli non può permettersi di<br />
crollare, ma avrà spazi e tempi “privati”, in cui dare libera espressione alle<br />
proprie emozioni.<br />
Nel passaggio dall’Io/Tu al Noi/Coppia, fino al Noi/Coppia genitoriale, in<br />
un continuo riaffiorare di figure e sfondi caratterizzati dalla relazione, si pongono<br />
le basi delle relazioni familiari.<br />
Solamente un amore di coppia potrà dare al bambino l’energia necessaria<br />
per la sua crescita.<br />
La coppia deve essere il più possibile flessibile, adattandosi alle situazioni<br />
delle diverse fasi evolutive, come la gravidanza; inoltre occorre avere quella<br />
complicità che permette alla coppia di andare avanti, crescendo, mettendosi in<br />
discussione, creando stimoli (Parigi, 1995). Così facendo vengono superate le<br />
difficoltà dell’ambiente in modo creativo e, certo, con una buona dose di<br />
autoironia del tipo “meglio prenderla con filosofia” (Sette, 1996, p.223).<br />
La genitorialità è un processo evolutivo fondamentale, sia da un punto di<br />
vista biologico (mantenimento della specie) sia psicologico. E’ facile quindi<br />
comprendere quali possano essere le reazioni e i vissuti di una coppia che, a<br />
causa della propria infertilità, vede interrotto questo sviluppo.<br />
La difficoltà sarà quella di pensare un percorso alternativo a quello che la<br />
coppia aveva inizialmente considerato nel suo progetto. Ad entrambi i partner<br />
viene chiesto di rimettere in gioco la propria individualità, appesantita dal lutto<br />
dell’infertilità, nello spazio comune della relazione, per dare inizio ad uno<br />
scambio dialettico che produrrà un nuovo progetto condiviso.<br />
55
3.1.4 L’infertilità<br />
3.1.4.1. Fondamenti psicologici<br />
Nella società odierna la donna riconosce la propria identità<br />
indipendentemente dall’assunzione del ruolo di madre.<br />
Al tempo stesso, però, si è alimentata la convinzione che il concepimento<br />
sia un atto puramente meccanico, raggiungibile appena cessano le condizioni che<br />
ne avevano impedito il verificarsi (Fiumanò, 1996, 2000; Vegetti Finzi, 1997). Di<br />
conseguenza si pensa che “la gravidanza possa instaurarsi a piacimento ed essere<br />
indotta o interrotta quando si vuole” (Fiumanò, 2000, p.61).<br />
Fiumanò (2000) sostiene che contraccettivi ed aborto, alla base della<br />
rivoluzione sociale degli ultimi decenni, hanno creato come contraccolpo<br />
soggettivo un sintomo: l’infertilità, e soprattutto la paura di esserne affetti. Essi<br />
hanno dunque contribuito a presentificare ancora l’antico fantasma della sterilità,<br />
che secondo Freud accompagna l’evoluzione della sessualità femminile dalla<br />
pubertà. Questa paura spinge le donne ad una autodiagnosi precoce, che<br />
contribuisce ad anticipare la frustrazione e i sentimenti di esclusione dal mondo<br />
femminile connessi al vissuto d’infertilità. L’esperienza clinica di coloro che<br />
entrano in contatto con coppie che presentano problemi di fertilità, fa emergere il<br />
ruolo preponderante delle dinamiche psichiche nell’etiologia dell’infertilità;<br />
quest’ultima, assieme agli attacchi di panico e a molti casi di anoressia-bulimia,<br />
può essere considerata “uno dei principali sintomi mutanti della femminilità”,<br />
ovvero un sintomo del disagio psichico tipico della società occidentale<br />
industrializzata della nostra epoca (Fiumanò, 2000, p.59).<br />
Tale disagio è riconducibile principalmente alla difficoltà di identificazione<br />
sessuale, “a una distinzione precaria dei ruoli paterno e materno, e in particolare<br />
alla fragilità della funzione paterna così come viene percepita socialmente e<br />
come viene sperimentata nella propria storia soggettiva” (Fiumanò, 2000, p.57).<br />
56
In questi termini, l’infencondità è la forma con cui si esprime, nei nostri<br />
tempi, l’isteria femminile, che ancora condensa e cela i nodi irrisolti della vita<br />
psichica della donna nel messaggio enigmatico del corpo.<br />
Fiumanò (2000) parla, dunque, di “infecondità”, per indicare la difficoltà a<br />
procreare che affonda le sue radici in conflitti rimasti al di qua della<br />
simbolizzazione e della parola. Tali conflitti possono nascondersi anche dietro<br />
l’apparente normalità della fecondità, e l’infertilità isterica può presentare un atto<br />
di riconoscimento, seppur inconscio, della propria impreparazione ad essere<br />
madre.<br />
Auhagen-Stephanos (1991), sostiene che la donna infertile debba in primo<br />
luogo guardare dentro di sé per assicurarsi che “il desiderio conscio di un figlio<br />
coincida con quello inconscio”, dal momento che “la paura inconscia del<br />
bambino desiderato è un anticoncezionale sicuro”(Auhagen-Stephanos, 1991,<br />
p.8).<br />
3.1.4.2 Le reazioni comuni all’esperienza di infertilità e alle tecniche di<br />
Procreazione Medicalmente Assistita<br />
L’esplicitarsi della potenzialità genitoriale è un momento fondante per il<br />
processo maturativo del singolo e della coppia, con la creazione dello spazio<br />
mentale per il figlio.<br />
L’uomo e la donna infertili mancano di una “possibilità evolutiva” non<br />
solo fisicamente, ma anche psicologicamente: questa “mancanza” può inficiare<br />
il benessere e l’equilibrio psichico fino a portare a psicopatologia (Righetti,<br />
2001, p.163).<br />
L’infertilità induce nell’uomo e nella donna un vissuto di forte<br />
menomazione narcisistica e rappresenta un attentato all’immagine di sé e<br />
all’ideale dell’Io. Questo si condensa in un senso di mancanza e d’incompletezza<br />
57
che, nella spasmodica ricerca di un proprio appagamento, induce angosce di<br />
abbandono e sentimenti d’inconsistenza, inferiorità, rabbia, depressione e<br />
mancanza di desiderio (Martinelli, 1999; Auhagen-Stephanos, 1991).<br />
Mahlstedt (1985) mette in rilievo che la condizione d’infertilità può<br />
condizionare il rapporto di coppia non solo nella sfera sessuale, ma anche sul<br />
piano della comprensione reciproca. Ciascuno dei partner ha una propria<br />
modalità di reagire alla frustrazione; si possono così generare, nel rapporto di<br />
coppia, crisi che conducono talvolta alla separazione.<br />
L’isolamento tenderebbe a mascherare sentimenti di invidia verso le coppie<br />
con figli e, soprattutto, un senso di vergogna ed inadeguatezza, scaturito<br />
dall’incapacità di assolvere alla richiesta di generazione che la società rivolge a<br />
ogni coppia.<br />
L’impatto psicologico, unito al coinvolgimento fisico in procedure mediche<br />
anche altamente invasive e comunque dal risultato incerto, ha permesso di<br />
giudicare la condizione della coppia infertile come altamente stressante e,<br />
dunque, capace di indurre vissuti depressivi. I molteplici vissuti di perdita,<br />
sperimentati simultaneamente dalla coppia infertile, configurano un quadro<br />
psicologico comparabile solo con l’esperienza di morte o di divorzio; inoltre, il<br />
dolore associato all’infertilità è paragonabile al dolore per la morte di un figlio ”<br />
(Auhagen-Stephanos, 1991; Vegetti Finzi, 1997).<br />
Quasi in risposta, Vegetti Finzi (1997) sostiene, invece, che l’infertilità si<br />
definisce come “assenza di figlio, mai come inesistenza”, dal momento che “il<br />
grembo materno può essere vuoto, mai la mente. Prima di esistere nel corpo il<br />
figlio vive nell’immaginario inconscio da dove nulla potrà espellerlo” (p.120).<br />
La coppia infertile vive, quindi, un’esperienza simile al lutto, in cui l’estinto<br />
è il bambino immaginario (Soulè, 1982; Guerrini Degl’Innocenti, Frassine,<br />
58
Pazzagli, 1992; Stern, 1995; Righetti, Sette, 2000; Righetti , 2001), fantasticato<br />
dall’infanzia e custodito nel mondo rappresentazionale.<br />
3.1.5 La Procreazione Medicalmente Assistita<br />
3.1.5.1 La domanda<br />
Quello che manca alla donna sterile non è un bambino qualsiasi ma, il suo<br />
bambino, da sempre amato e fantasticato; per questo dietro alla domanda di<br />
procreazione medicalmente assistita, si cela la richiesta di appagare un desiderio<br />
che esige una precisa realizzazione. Il ricorso alle biotecnologie diventa<br />
espressione di un bisogno complesso che condensa una varietà di pulsioni,<br />
desideri, immaginazioni in una commistione di storia individuale e collettiva.<br />
Fiumanò (1996, 2000) definisce “passione del materno” la tensione che<br />
spinge la donna “alla ricerca di un “sentire” il farsi della vita all’interno del<br />
proprio corpo” (Fiumanò, 2000, p.63). Martinelli (1999), invece, pone l’accento<br />
sull’importanza del legame di consanguineità, che assicura l’ideale superamento<br />
dei propri limiti fisici.<br />
Qualunque sia la spinta che motiva la domanda, occorre tener presente che<br />
si tratta di un desiderio particolare, da accogliere senza facili moralismi,<br />
considerando la complessità dell’esistenza umana e l’importanza che l’esperienza<br />
della gravidanza ha nel processo di maturazione psicologica per ogni individuo<br />
(Mahlstedt, 1985; Guerrini Degl’Innocenti, Frassine, Pazzagli, 1992; Vegetti<br />
Finzi, 1997; Righetti, Sette, 2000; Righetti , 2001).<br />
3.1.5.2 I vissuti psicologici: coinvolgimenti emozionali connessi al trattamento<br />
e alle aspettative in PMA<br />
L’inizio del periodo di terapie risulta estremamente ansiogeno, ma è<br />
animato al tempo stesso da aspettative ottimistiche, anche oltre misura. Spesso, si<br />
59
tende ad istaurare un rapporto di grande dipendenza dal medico, al quale si<br />
richiedono soluzioni onnipotenti, in un atteggiamento di delega che impedisce<br />
alla coppia di assumersi la piena responsabilità della propria scelta (Martinelli,<br />
1999).<br />
Dopo la fertilizzazione degli oociti, la coppia si stacca dal rapporto assoluto<br />
con il medico; questo favorisce una riassunzione del senso di responsabilità<br />
rispetto all’esito del trattamento, dal momento che la coppia, e la donna in<br />
particolare, deve gestire e modulare i propri comportamenti per evitare rischi che<br />
potrebbero compromettere il risultato. In questo periodo, si può riacutizzare<br />
l’ansia e si attenua l’ottimismo iniziale (Martinelli, 1999).<br />
Il risultato della procreazione medicalmente assistita è un evento che<br />
determina un grande coinvolgimento emozionale. Di fronte al successo, la coppia<br />
esprime emozioni di gioia, reazioni immediate che però possono essere<br />
successivamente turbate da fantasie negative sugli effetti devastanti del<br />
concepimento medicalizzato sul futuro del bambino. Tali timori possono nuocere<br />
all’elaborazione psicologica della gravidanza, che rischia di essere negata fino<br />
alla nascita reale del bambino, così da turbare anche tutto il processo che porta<br />
alla costruzione del legame relazionale con il figlio. In modo speculare,<br />
all’insuccesso fa seguito una forte reazione dolorosa per la perdita della speranza<br />
che aveva spinto la coppia ad affrontare il trattamento. A ciò si aggiunge il lutto<br />
per la perdita del bambino immaginato.<br />
Vegetti Finzi (1997) sostiene che non si tratta soltanto di “perdere” un<br />
bambino fantasticato o un figlio possibile, ma di restare a braccia vuote dopo un<br />
percorso ad ostacoli che ha promesso come premio di tanti sforzi la realizzazione<br />
di un progetto annunciato a lungo, perspicacemente perseguito e spesso imposto<br />
ad un marito recalcitrante. Secondo l’autrice, il fallimento rende palese<br />
l’incapacità del proprio corpo, vissuta con maggior pena per la consapevolezza di<br />
60
aver deluso anche le speranze di parenti e amici, e magari per il confronto con<br />
altre pazienti che hanno ottenuto invece il successo del trattamento (p.226).<br />
In questi casi, è la donna, rispetto al partner, a soffrire maggiormente per un<br />
dolore profondo e radicato. Per lo più, la coppia riesce a reagire adattativamente<br />
al dolore e a sentirsi pronta per richiedere un nuovo tentativo terapeutico.<br />
Altre volte, i membri della coppia possono mancare delle risorse necessarie<br />
per elaborare il carico emozionale.<br />
Se non si trova nella dinamica a due della coppia un’adeguata<br />
compensazione, la decisione di riprendere il trattamento diventa difficile.<br />
Ardenti (1999) nota l’accanimento da parte di alcune coppie che<br />
perseguono a ogni costo il desiderio di concepire anche a scapito del benessere<br />
proprio o altrui, nel tentativo di “super-compensare” sentimenti d angosciosa<br />
inadeguatezza e inferiorità, magari rafforzati da ripetuti fallimenti in precedenti<br />
trattamenti.<br />
In riferimento alla donna Auhagen – Stephanos (1991) definisce questa<br />
condizione “sindrome da desiderio di figli”. L’autrice indica con questo termine<br />
un vissuto psicologicamente opprimente, che diviene parte della personalità.<br />
Tale condizione, è contraddistinta da sofferenza e ripiegamento depressivo<br />
su sé stessi, la donna si inserisce in un vero e proprio “circolo diabolico”, da cui<br />
generalmente non riesce più a sottrarsi senza aver adempiuto alla promessa di<br />
concepire, nell’incapacità di riconoscere il fallimento. Il circolo si ripete, come<br />
una tossicodipendenza, nell’alternanza ripetitiva e uguale di “ebbrezza e<br />
disincanto”, rispettivamente in corrispondenza dell’ovulazione e delle<br />
mestruazioni.<br />
61
3.1.6 La fecondazione eterologa: un “segreto” avvolto nel silenzio<br />
L’avvento delle biotecnologie ha introdotto un’alterazione delle dinamiche<br />
e dei rapporti: nella scena che comprende concepimento, gestazione, parto e cura<br />
del figlio, sono state introdotte una molteplicità di figure diverse, quali la<br />
donatrice di ovuli, di embrioni, la madre uterina e la madre sociale. Anche la<br />
figura del padre si è resa ancor più incerta, così divisa tra donatore di sperma e<br />
padre sociale, dove quest’ultimo è presente.<br />
In questo groviglio diventa difficile rintracciare gli elementi che<br />
definiscono la famiglia, almeno nei ruoli oggi condivisi, senza ammettere di<br />
trovarsi di fronte alla necessità di modificarne il concetto (Marrama, Carani et.al,<br />
1987; Mieli, 1996; Vegetti Finzi, 1997).<br />
Ma, proprio perché l’elemento genetico è parte dell’unicità di ogni<br />
individuo, esso non può essere ignorato o eluso, come dimostrano i casi di<br />
bambini adottati che, pur cresciuti felicemente, desiderano incontrare i propri<br />
genitori biologici. Una confusione a livello del riconoscimento psicologico dei<br />
ruoli può risultare, dunque, deleteria per la crescita psicologica del bambino. E,<br />
ancor prima, essa può indurre disordini nell’equilibrio della donna e dell’uomo<br />
che richiedono la fecondazione eterologa.<br />
Al di là di ogni possibile interpretazione, la letteratura concordemente<br />
riconosce che la fecondazione eterologa rappresenta un campo in cui si<br />
estremizza la complessità dell’intreccio tra psiche e soma. La manipolazione<br />
delle sostanze corporee, prelevate, spostate, ricombinate fino ad ottenere un figlio<br />
che Ciambelli (2000) definisce “fabbricato”, può negare, in realtà, la dimensione<br />
psicologica soggettiva e relazionale inscritta in quei corpi, e la induce a un<br />
pesante silenzio. E’ ragionevole supporre, dunque, che questa condizione possa<br />
ripercuotersi sulla coppia, in primo luogo, e sul futuro del bambino, spesso<br />
vittima del “silenzio sull’origine” (Vegetti Finzi, 1997), cioè del segreto con cui i<br />
62
suoi stessi genitori continuano a negare la realtà del suo concepimento, a lui e a<br />
sé stessi.<br />
Occorre, quindi, sulla base di quanto esposto, oltre ogni prospettiva teorica,<br />
analizzare, esplicitare e supportare il volere e la decisione di ogni singola coppia.<br />
La relazione di coppia, infatti, è il contesto determinante nel quale entrambi<br />
i partner danno un proprio significato all’esperienza di procreazione<br />
medicalmente assistita, con la possibilità di elaborare in senso positivo i propri<br />
vissuti, senza rimanerne travolti.<br />
3.2 Studi sperimentali sugli aspetti psicologici nei protocolli di PMA<br />
Le ricerche sperimentali, che accompagnano l’esperienza clinica, aiutano a<br />
raccogliere indicazioni e sono predittori delle componenti psicologiche in gioco<br />
nella procreazione medicalmente assistita.<br />
3.2.1 Le componenti psicologiche dell’infertilità<br />
Non si esclude la possibilità che meccanismi psicosomatici possano influire<br />
in alcuni casi sulla fertilità. Rimane ancora da appurare il peso effettivo di<br />
problemi psicologici preesistenti nell’etiologia dell’infertilità. Risultano<br />
sicuramente evidenti, invece, le conseguenze psicologiche che seguono alla<br />
condizione di infertilità per alcune coppie.<br />
Alcuni studi (Noyes, Chapnick, 1964; Pepperell, Hudson, Wood, 1980),<br />
infatti, presentano proprio i fattori psicologici come causa primaria. Si ritiene che<br />
depressione, ansia o paura possano influenzare il funzionamento fisiologico,<br />
incluso quello endocrinologico, e ridurre perciò le probabilità di concepimento.<br />
Capita spesso che si associno all’infertilità un’inadeguata considerazione di<br />
sé e del proprio valore, una minor capacità di controllo sugli eventi e difficoltà di<br />
coppia più pronunciate. Queste difficoltà si traducono in problemi di<br />
63
comunicazione e di supporto reciproco, in disordini emozionali (più consistenti<br />
nelle donne rispetto ai loro partner), in senso di vuoto, solitudine e maggior<br />
infelicità, sino a forme di disinteresse e insoddisfazione esistenziale.<br />
3.2.2 Disagi e sofferenza nell’uomo infertile<br />
Nelle procedure di diagnosi e di trattamento dell’infertilità, sono le donne<br />
che devono sostenere un maggior coinvolgimento fisico ed emotivo nelle<br />
procedure di diagnosi e di trattamento dell’infertilità. Occorre, però, riconoscere<br />
che, con l’avvento delle tecniche di micromanipolazione, si è assistito a un<br />
sempre maggior coinvolgimento degli uomini nei protocolli di trattamento,<br />
rendendo più evidente il rischio che anche loro possano esperire lo stress<br />
psicologico associato all’infertilità con grande disagio e sofferenza. Gli uomini<br />
sembrano afflitti da questo problema esattamente come le donne e sarebbero<br />
capaci di sviluppare un uguale grado di stress, vissuto e gestito, però, con<br />
modalità differenti rispetto alle partner femminili (Nachtigall, Becker, Wozny,<br />
1992; Collins, Freedman et.al., 1992; Luisi, 2002).<br />
3.2.3 Identità e ruolo, vengono minati dall’infertilità?<br />
Uomini e donne dichiarano le stesse motivazioni alla ricerca di un figlio,<br />
ma conferiscono ad esse differenti priorità (Newton, Hearn et. al., 1992).<br />
Le differenti risposte di uomini e donne possono, dunque, essere imputate<br />
alle diverse percezioni dei ruoli procreativi specifici dei due generi (Nachtigall,<br />
Becker, Wozny,1992). Le aspettative culturali per il ruolo sociale delle donne<br />
riguardano la loro capacità di concretizzare il ruolo di madre all’interno della<br />
società, e cioè di portare a termine una gravidanza e di allevare un figlio; invece,<br />
la capacità di procreare, intesa come la capacità di fecondare la propria<br />
compagna, è un’aspettativa culturale che investe maggiormente l’uomo, ed è una<br />
64
dimensione significativa dell’identità di genere maschile. Infatti, essi non si<br />
sentono minacciati nella genitorialità, ma nella loro mascolinità e nel senso<br />
dell’identità (Hurst, Dye et. al., 1999).<br />
Tutti gli uomini, indistintamente, tendono però ad impegnarsi a capire in<br />
che modo l’infertilità possa essere una minaccia alla relazione, cioè alla capacità<br />
di essere un buon marito e di sostegno per la propria compagna, mobilitando,<br />
così, il loro investimento emozionale per cercare una soluzione. Inoltre, la<br />
tendenza a confermare il proprio ruolo di membro “supportante” della coppia, nel<br />
tentativo di dimostrare a sé e alla partner la sua forza, rende l’uomo restio a<br />
ricercare un appoggio esterno per affrontare meglio al problema dell’infertilità.<br />
Un altro aspetto centrale dell’identità maschile, minacciata in presenza di<br />
un problema d’infertilità, è il senso di virilità, con ripercussioni nella vita<br />
sessuale della coppia.<br />
3.2.4 Terapie contro l’infertilità:impatto sulla sessualità<br />
Occorre tenere presente che la relazione tra infertilità e sessualità può<br />
determinarsi in entrambi i sessi. Accade, infatti, che problemi sessuali (quali ad<br />
esempio, i disturbi del desiderio, seguiti, per quanto riguarda l’uomo, da<br />
impotenza, eiaculazione precoce, o ritardata e incapacità di eiaculare in vagina);<br />
possono essere causa di infertilità.<br />
Per questo, prima di ogni intervento, si consiglia al medico di indagare la<br />
frequenza e la soddisfazione dei rapporti sessuali della coppia. Infatti, i disturbi<br />
del desiderio porterebbero i partner ad avere rapporti sessuali poco soddisfacenti<br />
e troppo poco frequenti per permettere il concepimento (Costa, 2001).<br />
I problemi sessuali possono anche manifestarsi come conseguenza<br />
dell’infertilità. Le terapie stesse contro l’infertilità sono spesso lunghe e faticose<br />
65
e interferiscono con la sessualità coniugale comportando sofferenza e disagio<br />
emotivo.<br />
Quando la coppia decide di intraprendere un percorso clinico per la sua<br />
infertilità, può esserle richiesto, per completare la diagnosi, di avere rapporti<br />
sessuali prima di sottoporsi a visita medica (test post coidale); ciò porta a<br />
concepire il sesso come un compito da eseguire, in modo che qualcun altro possa<br />
valutarne i risultati. Queste pratiche da un lato possono facilitare l’associazione<br />
tra sessualità e concepimento, ma, rischiano di rendere la coppia incapace di<br />
apprezzare il piacere di stare insieme.<br />
Bisogna considerare, inoltre, che la pressione psicologica sulla prestazione<br />
dell’uomo è maggiore rispetto a quella sulla donna: egli è considerato la parte<br />
attiva che deve raggiungere una buona erezione e penetrare. L’ansia da<br />
prestazione e la paura di fallire, portano all’aumento di adrenalina, che agisce<br />
inibendo l’erezione. L’uomo si sente, dunque, sotto pressione, strettamente<br />
condizionato e controllato dal ciclo di ovulazione della compagna, responsabile<br />
di una buona erezione e di una prestazione sessuale soddisfacente.<br />
Spesso egli è anche incapace di assolvere alla richiesta di eiaculare in una<br />
boccetta, pratica che costituisce per lui un momento estremamente stressante e<br />
umiliante (Seibel, Taymor, 1982) e che arricchisce l’attività sessuale di ulteriori<br />
condizionamenti negativi.<br />
Non sorprende, quindi, che un uomo possa avere dubbi sulla riuscita della<br />
sua prestazione, soprattutto una volta che abbia già esperito un primo episodio di<br />
disfunzione sessuale. Del resto, tutte queste circostanze, insieme allo stress<br />
sperimentato a causa della situazione di infertilità e delle sue implicazioni<br />
personali, economiche e relazionali, costituiscono il background “ottimale”<br />
perché si sviluppi una problematica sessuale. L’infertilità non può essere trattata<br />
66
al pari di ogni altra “malattia”; perché tocca l’essenza della femminilità e della<br />
mascolinità (Link, Darling, 1986).<br />
3.2.5 Terapie contro l’infertilità:ripercussioni psicologiche<br />
L’interesse ad approfondire le ripercussioni psicologiche del trattamento<br />
medico dell’infertilità anima i più recenti lavori sperimentali, che mirano<br />
soprattutto ad appurare gli effetti dell’applicazione di tecniche di riproduzione<br />
assistita, anche altamente invasive, come la FIVET.<br />
Rimane ancora da accertare attraverso studi strutturati la possibile rilevanza<br />
della componente psicologica nell’etiologia dell’infertilità. Ma l’esperienza in<br />
ambito clinico è maturata, come confermano i risultati di ricerche sperimentali<br />
che forniscono dati sulle caratteristiche e sulla variabilità del vissuto psicologico<br />
che accompagna la condizione d’infertilità e il suo trattamento medico, con<br />
particolare riguardo all’esperienza della donna e alla procedura d’intervento<br />
FIVET.<br />
I risultati sono molteplici e spesso portano a conclusioni contraddittorie,<br />
così sintetizzabili (Righetti, Luisi, 2007, p.116 - 118):<br />
1. le coppie sterili non mostrano tratti psicopatologici importanti o peculiari<br />
caratteristiche personologiche, ma appaiono ben adattate e con relazioni<br />
stabili e positive rispetto ai gruppi di controllo (Downey, Yingling,<br />
et.al.,1989);<br />
2. l’esperienza d’infertilità risulta fonte di grande stress emozionale, che<br />
rischia di ripercuotersi, soprattutto per la donna, su ogni aspetto della vita<br />
personale e di coppia, fino a sfociare in disordini nel funzionamento<br />
psicologico e sessuale (Newton, Hearn, Yuzpe, 1990);<br />
3. i fattori legati alla condizione di sterilità, che minacciano il benessere<br />
psicologico della coppia, sono riconducibili alla durata dell’infertilità, alle<br />
67
procedure diagnostiche, all’attribuzione di piena responsabilità della<br />
diagnosi a uno dei membri della coppia, al tipo di diagnosi e alla prognosi<br />
(Edelmann, Connolly, 1986);<br />
4. l’invasività e la dolorosità delle procedure di trattamento, attuate sempre al<br />
termine di un lungo iter diagnostico, enfatizzano il disagio psicologico in<br />
termini di stress, ansia, depressione e difficoltà interpersonali e sessuali<br />
(Daniluk, 1988);<br />
5. nel trattamento FIVET, i livelli di ansia di stato sembrano aumentare<br />
soprattutto nella fase di prelievo oocitario e durante l’attesa dopo il transfer<br />
embrionario; lo stato di ansia pare condizionato dal tipo di diagnosi, mentre<br />
esistono risultati contraddittori sulla rilevanza di fattori come il tempo<br />
trascorso dalla diagnosi, che sembra produrre un effetto di abituazione, e il<br />
numero di cicli FIVET sostenuti. Tuttavia molti studi, considerando tre cicli<br />
di trattamento, riportano livelli di ansia più elevati in corrispondenza del<br />
primo e dell’ultimo ciclo (Ardenti, Campari, et.al., 1999);<br />
6. il numero di cicli di trattamento sostenuti sembra condizionare nelle donne<br />
livelli di depressione e la percentuale di depressione clinica, che aumenta<br />
anche durante un singolo trattamento (Berg, Wilson, 1991);<br />
7. il fallimento del trattamento FIVET provoca un incremento dei livelli di<br />
ansia e della sintomatologia depressiva, sentimenti di colpa, impotenza e<br />
perdita, un abbassamento dell’autostima, maggiori difficoltà sessuali e di<br />
coppia; questo vissuto permane anche a distanza di cinque settimane e<br />
condiziona il ricordo dell’esperienza (Leiblum, Kemmann, Lane, 1987);<br />
8. relativamente al fallimento, le donne risultano esposte a maggior rischio<br />
emozionale rispetto agli uomini; sembra, inoltre, che ansia e depressione<br />
preesistenti e l’assenza di figli costituiscano ulteriori fattori di vulnerabilità<br />
psicologica dopo un fallimento (Bringhenti, Martinelli, 1997) ;<br />
68
9. si evidenziano sostanziali differenze di genere nella risposta emozionale e<br />
psicologica all’infertilità e al suo trattamento, nel modo in cui questa si<br />
ripercuote sulla vita sessuale e di coppia, nei rapporti interpersonali e<br />
professionali e nella ricerca di supporto sociale, nonché nelle modalità di<br />
coping (Nachtigall, Becker, Wozny, 1992);<br />
10 . la scelta della coppia di sottoporsi a trattamento è una modalità efficace e<br />
adattativa di rispondere alla condizione di sterilità, quando associata a un<br />
certo grado di accettazione della propria condizione e ad aspettative<br />
realisticamente adeguate alle probabilità di riuscita (Hynes, Callan, et.al.,<br />
1992);<br />
11. rimane ancora da accertare se il profilo emozionale della coppia, e in<br />
particolare della donna, possa influenzare la riuscita del trattamento; lo<br />
stress, l’ansia e la depressione possono condizionare la funzionalità del<br />
sistema neuroendocrino e, dunque, interferire con la funzionalità<br />
uterotubale e il processo di impianto dell’embrione (Costa, 2001);<br />
3.2.6 Uno studio sperimentale:il vissuto psicologico delle coppie infertili nei<br />
protocolli di PMA (Righetti, Luisi, 2007) 5<br />
3.2.6.1 Introduzione<br />
In questi ultimi anni, l’incremento del ricorso alle tecniche di PMA ha<br />
contribuito a configurare un quadro complesso, in cui si intrecciano vissuti<br />
personali, familiari, sociali e culturali ed economici. Al centro si trova la coppia<br />
con la “malattia infertilità” e la domanda di “cura”.<br />
Questa ricerca nasce con l’intenzione di descrivere la condizione<br />
psicologica di pazienti infertili sottoposti a trattamento di PMA; essa, inoltre,<br />
5 Studio sperimentale in collaborazione con Bolis, Dileo, Labadini.<br />
69
vuole aprire un momento di riflessione sul concetto di genitorialità alla luce dei<br />
cambiamenti scientifici e tecnologici che coinvolgono il mondo del bambino e<br />
prima ancora, il percorso evolutivo del “divenire genitori”.<br />
Si tratta di uno studio longitudinale, effettuato su un campione italiano; tale<br />
ricerca ha l’obiettivo di valutare il vissuto degli uomini, insieme a quello delle<br />
donne, al fine di appurare, all’interno del contesto di coppia, come anche<br />
l’elemento maschile risente dell’esperienza del trattamento.<br />
Il contesto considerato, è stato esteso a protocolli di PMA che comportano<br />
l’esecuzione di tecniche minori, come quelle dell’inseminazione.<br />
3.2.6.2 L’ipotesi<br />
L’ipotesi della ricerca è quella di poter riscontrare una compromissione nel<br />
funzionamento psicologico determinata dal trattamento, in particolare quando<br />
non si ottiene la gravidanza, in quanto la delusione legata al fallimento incide<br />
maggiormente sulla condizione di disagio, rispetto all’invasività delle tecniche di<br />
PMA cui ci sottopone. Infatti, i ripetuti fallimenti incrementano il disagio<br />
psicologico, anche se in realtà, si presuppone l’incidenza di una sofferenza<br />
precedente alla scelta di ricorrere alla PMA magari condizionata dagli anni che la<br />
coppia ha trascorso nell’attesa del figlio vengono evidenziati, in questo studio, le<br />
differenze di genere nella risposta psicologica, supponendo che il maggior<br />
coinvolgimento fisico e psicologico della donna origini un maggior disagio<br />
rispetto all’uomo, anche per l’insieme di significati, culturalmente e socialmente<br />
determinati, che il figlio riveste nell’immaginario femminile. Anche se, nei casi<br />
di infertilità attribuibile al solo fattore maschile, questa responsabilità<br />
contribuisce a incrementare lo stato di sofferenza del membro della coppia su cui<br />
grava il peso della diagnosi.<br />
70
La ricerca, infine, ha valutato come l’infertilità, il trattamento e il fallimento<br />
incidano sulla percezione di sé e del coniuge, sulla figurazione di sé stessi e del<br />
partner come futuri genitori e sulle fantasie intorno al bambino desiderato.<br />
3.2.6.3 Metodologia<br />
I dati sono stati raccolti in un anno su un campione di 103 coppie, rivoltesi<br />
a 3 centri italiani per eseguire un trattamento a seguito della diagnosi di<br />
infertilità.<br />
Questa ricerca si è svolta prima della Legge 40/2004 e quindi il campione<br />
comprende casi di donazione di gameti.<br />
All’inizio del protocollo medico scelto, in una fase in cui il trattamento non<br />
comporta ancora un grande coinvolgimento per la coppia, a ognuno dei partner<br />
sono state consegnate due cartelle, contenenti cinque questionari di<br />
autosomministrazione: l’Adjective Check List (ACL) (Gough, Heilbrun,<br />
Fioravanti, 1980), il Beck Depression Inventory (BDI) (Beck, Steer, 1993), lo<br />
State- Trait Anxiet Inventory, forma Y (STAI-Y) (Spielberger, Gorsuch, Lushene,<br />
1983), il Symptom Questionnaire (SQ) (Kellner, 1976) e il Differenziale<br />
Semantico tratto dall’intervista Mate-R (Fava Vizziello, Invernizzi,1997), con<br />
una serie di scale di aggettivi per lo studio delle rappresentazioni genitoriali. La<br />
coppia li ha compilati separatamente a casa per poi riconsegnarli.<br />
Alla prima somministrazione, è seguita una seconda, al termine del<br />
trattamento di PMA, quando la coppia veniva a conoscenza del risultato del<br />
protocollo, o a seguito del test di gravidanza nel caso di trattamenti FIVET, o<br />
dopo la comparsa della mestruazione in caso di inseminazioni. Il tempo<br />
intercorso tra le due somministrazioni è stato di circa due mesi. Il disegno di<br />
ricerca inizialmente formulato prevedeva un confronto tra le due<br />
somministrazioni, distinguendo il campione in base al risultato del trattamento; in<br />
71
ealtà, però, problemi riscontrati nella raccolta dati non hanno consentito lo<br />
svolgersi di tale confronto, quindi, i risultati ottenuti, derivano sia dall’analisi<br />
statistica dei dati (i dati dell’intero campione, alla prima somministrazione e del<br />
gruppo delle 25 coppie con esito negativo del trattamento, sono stati elaborati<br />
statisticamente con programma SPSS: Statistical Package for the Social<br />
Sciences); sia dall’interpretazione qualitativa di grafici, impiegati per operare un<br />
confronto tra i soggetti in base al sesso e al risultato del trattamento.<br />
3.2.6.4 Difficoltà di campionamento e limiti della ricerca<br />
Una prima difficoltà è stata quella dell’individuazione del gruppo di<br />
controllo adeguatamente compatibile con il campione preso in esame. Quindi,<br />
dopo numerosi problemi, è stato preso come gruppo di controllo una “situazione”<br />
all’interno dello stesso campione esaminato, istituendo un confronto tra coppie<br />
distinte in due gruppi a seconda del risultato ottenuto a seguito del trattamento.<br />
Un’ulteriore difficoltà si è presentata al momento della raccolta, in quanto i<br />
pazienti sono a disagio nell’interrogarsi sui vissuti psicologici che accompagnano<br />
un problema considerato prevalentemente “medico”. Inoltre, l’esperienza del<br />
fallimento, induce la coppia a ritirarsi per trovare, nella propria intimità, lo spazio<br />
necessario all’elaborazione del lutto (Martinelli, 1999). Per le difficoltà emerse,<br />
l’analisi, è stata condotta, sui dati dell’intero campione di 103 coppie alla prima<br />
somministrazione e sul confronto tra le due somministrazioni, per il solo gruppo<br />
delle 25 coppie con esito negativo del trattamento; ciò, ha limitato i risultati della<br />
ricerca non permettendole di verificare l’ipotesi secondo la quale sul disagio<br />
psicologico incide più il peso del fallimento che il tipo di trattamento eseguito.<br />
72
3.2.6.5 Risultati<br />
In sintesi, i dati più significativi, emersi dalle ipotesi inizialmente<br />
formulate, sono:<br />
1) le coppie esaminate nella fase iniziale del trattamento mostrano livelli di<br />
depressione nella norma e alti livelli di ansia di stato associata alla<br />
preoccupazione per il trattamento in corso e all’incertezza del risultato, in<br />
accordo con Ardenti, Campari et. al.,(1999). Si riscontrano livelli di ansia di<br />
tratto superiori alla norma in quanto questi pazienti percepiscono gli stimoli<br />
come potenzialmente minacciosi e rispondono ad essi con reazioni di maggior<br />
intensità; ciò, li può portare allo sviluppo di forme di disagio psicologico;<br />
2) le donne esperiscono complessivamente livelli di ansia e depressione<br />
maggiori rispetto agli uomini, con tendenza marcata alla somatizzazione, forse<br />
per il coinvolgimento fisico maggiore e inevitabile ed anche per il diverso<br />
significato emozionale e sociale che la realizzazione del desiderio di un figlio<br />
riveste. Questo dato, concorda con la letteratura (Newton, Hearn, Yuzpe, 1990;<br />
Collins, Freeman e altri, 1992; Beaurepaire, Jones e altri, 1994). In realtà, anche<br />
nell’uomo, i livelli di ansia di stato sono superiori alla norma, ciò a<br />
dimostrazione del fatto di una loro forte partecipazione emozionale al<br />
trattamento, al vissuto della partner e per le aspettative di riuscita;<br />
3) le differenze di genere riscontrate sull’intero campione vengono<br />
mantenute nel gruppo di coppie che ha partecipato alla seconda fase della ricerca<br />
e non ha ottenuto la gravidanza.<br />
Dal confronto tra le due somministrazioni, non emergono significative<br />
variazioni nel vissuto psicologico, tali da poter determinare un fallimento del<br />
trattamento. I dati visualizzati attraverso grafici, consentono di trarre preziose<br />
informazioni qualitative, rispetto ai risultati dell’elaborazione statistica limitata<br />
dall’insufficiente numero di soggetti.<br />
73
E’ stato eseguito un confronto, nelle due somministrazioni di tutti i soggetti<br />
che avevano partecipato ad entrambe le fasi della ricerca (34 coppie), distinti in<br />
base al sesso e al risultato del trattamento:<br />
a) livelli di depressione dell’intero campione nel baseline rimangono sotto<br />
la media e non subiscono variazioni nel gruppo tra le due somministrazioni. Solo<br />
poco più della metà delle donne (18) ottiene punteggi compresi nella media<br />
normativa nei due tempi, mentre, per le restanti donne e per alcuni uomini si<br />
assiste, a un notevole incremento dei livelli di depressione a seguito del<br />
fallimento;<br />
b) l’ansia di stato permane a livelli elevati, nella seconda somministrazione<br />
e ciò può essere condizionato dal risultato negativo del trattamento, soprattutto<br />
negli uomini, per i quali la gestione del fallimento e le probabili ripercussioni<br />
sulla vita di coppia potrebbero essere all’origine degli stati ansiosi. Per le donne<br />
la media del gruppo con esito negativo scende a valori nella norma, benché<br />
ancora più della media dei casi rimangono a livelli superiori. Le donne in<br />
gravidanza, invece, mantengono punteggi elevati sia a causa della tensione<br />
accumulata nel trattamento appena concluso, sia per la preoccupazione per il<br />
mantenimento della gravidanza e i rischi di aborto;<br />
4) all’analisi dei profili percettivi del Differenziale Semantico emerge<br />
un’immagine idealizzata del futuro bambino: viene descritto con elementi di<br />
forte vitalità, quasi a compensare l’assenza di vita del bambino reale, così a lungo<br />
atteso e desiderato. I profili di entrambi i partner convergono, contrariamente<br />
all’ipotesi iniziale, anche sull’immagine di sé come futuri genitori. Entrambi<br />
descrivono sé stessi e il loro coniuge in termini molto positivi, anticipando<br />
sentimenti di felicità personale, di affetto verso il figlio, di soddisfazione e di<br />
orgoglio rispetto all’esperienza di genitorialità propria e del partner. Gli uomini<br />
si definiscono con termini che sottolineano vigore, determinazione, ottimismo ed<br />
74
energia, mentre le donne sottolineano aspetti emozionali, riflessivi e di apertura<br />
agli altri, quasi a voler ribadire la propria identità di genere, che potrebbero<br />
invece sentir vacillante per la condizione d’infertilità. Entrambi si percepiscono<br />
molto attivi e sani. Questa tendenza si riscontra anche nella descrizione che i<br />
partner danno del coniuge e alla percezione di sé come moglie o marito, ruolo<br />
entrambi si sentono molto felici e soddisfatti; ciò, è in accordo con l’ipotesi che<br />
la condizione d’infertilità accresca l’intimità e il sostegno reciproco della coppia;<br />
5) sebbene i profili delle prima somministrazione ricalchino quelli ottenuti<br />
sull’intero campione, dal re-test si nota un significativo cambiamento nel gruppo<br />
di coppie che ricevono un esito negativo del trattamento. Alcune scale, infatti, si<br />
capovolgono: a) il bambino sembra perdere la caratterizzazione di forte vitalità: il<br />
fallimento decreta la “morte” del “bambino fantasticato” (Mahlstedt, 1985;<br />
Auhagen-Stephanos, 1991; Vegetti Finzi , 1997). La delusione si ripercuote sulla<br />
soddisfazione e sull’orgoglio per la genitorialità e genera vissuti d’insicurezza,<br />
infelicità e atteggiamenti di passività anche nella relazione tra i partner. La<br />
coppia risente del fallimento: riferisce minor felicità, soddisfazione, orgoglio e<br />
chiusura alla relazione e agli affetti, una passività e un’insicurezza evidenziabili<br />
soprattutto negli uomini, a conferma del loro grande coinvolgimento. Anche la<br />
percezione di sé risulta deturpata dal fallimento si ha un abbassamento<br />
dell’autostima, una chiusura alla relazione e un atteggiamento di passività.<br />
3.2.6.6 Commento<br />
I dati ottenuti nonostante i limiti, e in accordo con la letteratura, consentono<br />
di sostenere che l’esperienza di trattamento di PMA può generare un disagio<br />
psicologico. Sono più suscettibili i soggetti che presentano aspetti di<br />
vulnerabilità, come si è esaminato dagli alti livelli di ansia di tratto.<br />
75
All’inizio del trattamento, non vi è una particolare condizione di disagio,<br />
però, va considerata la possibilità che una parte considerevole di soggetti presenti<br />
aspetti di sofferenza che vengono aumentati dal fallimento del trattamento. Le<br />
donne sono maggiormente soggette a sentimenti di tristezza, se non a veri e<br />
propri vissuti depressivi, su cui incidono, anche il senso di frustrazione e<br />
inadeguatezza derivanti dal fallimento.<br />
Concordemente con gli studi di Bringhenti, Martinelli et.al., (1997), questa<br />
ricerca ha evidenziato come in ogni caso, oltre a comuni fattori di rischio, la<br />
risposta emozionale alla condizione d’infertilità è influenzata dalla soggettività<br />
del vissuto personale dell’uomo e della donna coinvolti, dalla funzione di<br />
supporto della coppia al suo interno e dall’ambiente di riferimento all’esterno.<br />
Risulta di rilievo il ruolo della psicologia nella PMA:<br />
1) gestire il complesso intersecarsi delle dinamiche psicologiche con le<br />
offerte e le richieste della scienza;<br />
2) il garantire un equilibrio tra desiderio e tecniche, abbracciando tutto il<br />
contesto della PMA. Quindi lo psicologo non si deve limitare al processo di cura<br />
della psicopatologia individuale o di coppia, ma, deve spaziare fino a<br />
comprendere la formazione degli operatori di settore e di sostegno psicologico<br />
nella routine dei protocolli. In quest’ottica è rilevante il suo ruolo nella<br />
prevenzione del disagio e nell’educazione alla genitorialità.<br />
3.3 Il sostegno psicologico: parte integrante nel percorso della Procreazione<br />
Medicalmente Assistita<br />
Dal punto di vista medico-chirurgico-biologico, il protocollo PMA segue<br />
metodiche e direttive internazionalmente applicate, con minime differenze tra i<br />
clinici; mentre, da un punto di vista psicologico non può esistere un intervento<br />
generalizzabile per ogni persona, dal momento che le personalità stesse non lo<br />
76
sono. Occorre, inoltre, precisare che il sostegno psicologico è parte integrante di<br />
tutto il percorso della PMA: dalla diagnosi alla scelta dell’intervento, dalla firma<br />
del consenso informato e dall’acquisizione della consapevolezza verso il<br />
protocollo ai momenti di trasferimento embrionale, di pick-up, e così via.<br />
L’infertilità è una condizione che rischia di turbare l’equilibrio fisico e<br />
psicologico della coppia, ma, allo stesso tempo può costituire un’opportunità di<br />
crescita (Mahlstedt, 1985). A questo proposito ad avere ruolo fondante è il<br />
contesto di riferimento, con funzione di supporto per la coppia; è auspicabile il<br />
coinvolgimento della famiglia, degli amici, ma anche del personale medico,<br />
quest’ultimo dovrebbe essere disponibile e interessato sia a chiarire ogni aspetto<br />
della procedura medica sia a conoscere i vissuti di entrambi i partner in ogni fase<br />
del trattamento.<br />
Berg, Wilson (1991) ipotizzano un modello di reazioni acute e croniche<br />
all’infertilità e al suo trattamento e propongono un intervento psicologico<br />
adeguato alla tipologia e all’intensità del problema che si manifesta; la coppia va,<br />
quindi, seguita e sostenuta in tutte le fasi della sua storia clinica.<br />
Si prospetta così un range di modalità d’intervento che, nella fase acuta,<br />
vanno dall’intervento breve, mirato al sintomo psicologico o sessuale, al<br />
semplice supporto educativo che ridimensiona il vissuto della coppia<br />
sottolineando la normalità ella reazione.<br />
Per la fase cronica, invece, si può proporre un intervento psicoterapeutico, o<br />
psichiatrico, focalizzato sul problema psicologico, sessuale o coniugale emerso.<br />
Nonostante molte coppie, sembrano reagire bene alle procedure<br />
diagnostiche, il counselling e l’intervento psicologico non solo permettono di<br />
aiutare le coppie più vulnerabili ma, come sostengono Hammarberg, Astbury,<br />
Baker, 2001, sono fondamentali per renderle consapevoli dei rischi reali connessi<br />
al trattamento, ridimensionando le aspettative di successo, nella maggior parte<br />
77
dei casi sovrastimate e irrealistiche. Il couselling, viene ritenuto fondamentale,<br />
dalle donne esaminate, in momenti particolarmente stressanti quali: l’attesa di<br />
una nuova fecondazione, o quando si aspetta l’esito del trattamento, o i momenti<br />
dopo uno o più cicli di trattamento falliti o dopo una gravidanza interrotta.<br />
3.3.1 Il sostegno psicologico nei percorsi di PMA: il protocollo integrato<br />
medico-psicologico<br />
Righetti (2001) osserva che in Italia, negli ultimi anni, il mondo della<br />
medicina si è aperto verso gli aspetti che riguardano la salute non soltanto fisica,<br />
ma anche psicologica dei pazienti.<br />
Considerando l’ambiente medico-sanitario anche un “luogo del pensiero e<br />
dei vissuti”, Righetti propone di inserire la coppia che richiede un trattamento per<br />
l’infertilità all’interno di un protocollo d’integrazione multifocale medico-<br />
psicologico (Righetti, 2001, p.163) che permette di considerare l’esperienza della<br />
coppia avvalendosi di conoscenze e tecniche provenienti da diversi campi del<br />
sapere con la partecipazione di tutti coloro che entrano in contatto con la coppia:<br />
ginecologo, psicologo, chirurgico, biologo, personale paramedico e di segreteria.<br />
Quest’ottica consente di superare “la chiusura in un metodo a favore<br />
dell’apertura alla metodologia” (Canevaro, 1992).<br />
3.3.3 Il ruolo dello psicologo e di una psicologia “impegnata”nella pratica<br />
clinica della PMA<br />
Nell’ottica di una psicologia impegnata nell’area clinica e terapeutica, e<br />
nell’area di formazione del personale medico/paramedico oltre che nel settore<br />
della ricerca sperimentale, risulta di fondamentale importanza l’inserimento<br />
dello psicologo nella pratica clinica routinaria, come figura di un professionista<br />
specialista nel settore, atto ad occuparsi del vissuto della coppia in relazione<br />
78
all’esperienza di PMA, adottando una finalità terapeutica, ma anche di<br />
prevenzione (Righetti, 2007).<br />
In questo contesto, occorre valorizzare l’importanza del colloquio come<br />
offerta di uno “spazio psicologico”, in cui la coppia possa incontrare<br />
comprensione, sostegno, contenimento ed ascolto. Viene esposto, come esempio,<br />
un modello di protocollo di integrazione medico-psicologica:<br />
1) il primo gradino è il colloquio iniziale della coppia col ginecologo del<br />
centro PMA, si pongono, così due possibilità: nel primo caso siamo di fronte ad<br />
un’infecondità psicogena, il medico invia la coppia allo psicologo per la<br />
formulazione di un protocollo di “intervento psicologico particolare”<br />
(psicologico o psicoterapeutico) e solo in seguito, dopo il lungo percorso<br />
psicologico, la coppia verrà reinserita nel protocollo ginecologico di PMA solo<br />
se continuerà a non ottenere il risultato (la procreazione). Nel caso contrario, si<br />
procede direttamente con il protocollo di PMA;<br />
2) dopo il colloquio, la coppia esegue esami di laboratorio e clinici per la<br />
definizione del protocollo PMA da eseguire;<br />
3) la coppia viene ricevuta dal ginecologo per un secondo colloquio col<br />
ginecologo per la spiegazione del protocollo PMA deciso e in questo contesto<br />
avviene la firma del consenso informato;<br />
4) la coppia, incontra lo psicologo per un colloquio (“intervento<br />
psicologico generale”) finalizzato alla valutazione dei seguenti aspetti: a) vissuti<br />
psicologici; b) completamento del quadro anamnestico con anamnesi<br />
psicologica; c) livello della consapevolezza e del grado decisionale; d)livello<br />
della genitorialità; e) nuova spiegazione delle fasi del protocollo PMA scelto con<br />
la firma finale del consenso informato; f) proposta di un eventuale sostegno<br />
psicologico.<br />
79
Lo psicologo completa la cartella clinica con la scheda del colloquio<br />
avvenuto e il consenso informato completo. Infine, l’equipe deciderà i casi in cui<br />
è auspicabile la presenza dello psicologo anche nelle fasi di intervento in sala<br />
operatoria (pick-up, trasferimento embrionale). In un protocollo integrato<br />
medico-psicologico, è importante per la coppia di poter disporre sia di momenti<br />
“privati” individuali, sia di momenti “allargati” nel gruppo; infatti, l’esperienza<br />
clinica ha permesso di rilevare l’efficacia di esperienze di confronto in gruppo,<br />
gestite e guidate dallo psicologo (terapeuta) e da un medico (co-terapeuta)<br />
(Righetti, 2001).<br />
In questi momenti, alla coppia è data la possibilità di “uscire dal senso di<br />
segretezza che altera in modo consistente i vissuti e le emozioni” (Righetti,<br />
2001, p.165, grassetto aggiunto).<br />
3.3.4 Proposta di un percorso di Procreazione Psico-Medicalmente Assistita<br />
L’adozione di un protocollo multifocale e integrato medico-psicologico in<br />
un percorso di PMA può avere effetti positivi sulla qualità dell’esperienza per la<br />
coppia, per l’equipe medica, ed anche sulle percentuali di riuscita dei trattamenti.<br />
I vantaggi di un protocollo così strutturato sono molteplici:<br />
1) la figura dello psicologo non solo la sua figura è proposta accanto a<br />
quella del medico ma, il suo impegno si estende anche all’area della formazione<br />
degli operatori;<br />
2) la figura dello psicologo compresa in questo progetto garantisce una cura<br />
più completa della coppia e della persona; viene così realizzata l’espressione<br />
esortativa “curare la sterilità”, che invita a “prendersi cura”del paziente nella sua<br />
globalità (Flamigni, 2001) cercando di prevenire quella tendenza a scindere la<br />
mente dal corpo, riconosciuta dalla letteratura come fattore di rischio psicologico<br />
per le coppie che si sottopongono a PMA;<br />
80
3) il ruolo dello psicologo è fondamentale per la prevenzione, non solo nella<br />
patologia e nella sintomatologia psicologica, al fine di garantire l’impegno nei<br />
confronti della qualità di vita, per la persona e per la coppia (Righetti e Casadei,<br />
2005). Purtroppo, alla difficoltà insita nell’operare in un settore nuovo e<br />
peculiare come quello della PMA, si unisce la reticenza delle coppie sterili a<br />
riconoscere le rilevanti componenti psicologiche del loro problema, ottimale,<br />
sarebbe, la presenza di uno psicologo specializzato nel settore e non<br />
saltuariamente presente solo in casi particolari;<br />
4) l’intervento dello psicologo contribuisce a risolvere casi come quella di<br />
sterilità idiopatica o infertilità inspiegata, in cui si ipotizza che la funzionalità<br />
fisiologica sia compromessa indirettamente da problemi psicologici;<br />
5) la presenza dello psicologo rende il percorso di PMA “più naturale” e<br />
“meno medicalizzato” per la coppia.<br />
3.4 Dai genitori ai bambini PMA: i due divengono tre<br />
E’ necessario, alla fine di questo excursus focalizzare l’attenzione sul<br />
bambino nato da PMA.<br />
3.4.1 Dal tu e io alla coppia genitoriale: un lungo percorso emotivo<br />
Nelle coppie che si sottopongono a PMA, vi è la presenza di un sistema<br />
relazionale con quattro ordini di protagonisti: la donna, l’uomo, le procedure di<br />
PMA, il risultato, cioè il figlio; queste variabili procedono lungo un percorso<br />
emotivo, oltre che medico, che può durare anni. E’ un periodo di solitudine, di<br />
sofferenza, di possibile psicopatologia. Si ritrova un equilibrio quando la tecnica<br />
di PMA ottiene un risultato positivo. “L’esperienza peggiore della propria vita”<br />
si trasforma, a questo punto, “nell’esperienza più bella che abbia mai avuto”.<br />
81
3.4.2 I bambini nati da Procreazione Medicalmente Assistita: quale sarà il loro<br />
futuro?<br />
L’introduzione della fecondazione in vitro nel 1978, grazie a Edwards e<br />
Steptoe, si accompagnò all’idea che i bambini nati con questo metodo<br />
mostrassero delle anormalità. Mentre le paure riguardo lo sviluppo fisico dei<br />
bambini PMA è risultato infondato, rimane qualche preoccupazione sullo<br />
sviluppo psicologico dei bambini e sul ruolo dei genitori.<br />
Alcune ricerche, si sono preoccupate di osservare, in maniera longitudinale<br />
e controllata, famiglie che si sono sottoposte alla fecondazione omologa o<br />
eterologa.<br />
Esse delineano un quadro piuttosto rassicurante, senza problematiche<br />
significative, per le famiglie ricorse alla fecondazione omologa ed eterologa, in<br />
rapporto alle famiglie che hanno concepito naturalmente.<br />
Per quanto riguarda le famiglie ricorse alla fecondazione omologa, è<br />
possibile sostenere che (La Sala, Landini et.al., 2001):<br />
a) i bambini presentano un normale sviluppo cognitivo e sensomotorio, non<br />
mostrano particolari disturbi psicologici né difficoltà nello sviluppo sociale ed<br />
emotivo, non differiscono dai bambini concepiti naturalmente, da quelli adottati,<br />
né da quelli nati dalla fecondazione eterologa per quanto riguarda la qualità della<br />
relazione con i genitori, il calore e l’affetto provato nei loro confronti;<br />
b) i genitori presentano un elevato coinvolgimento emotivo verso i figli,<br />
anche se le madri PMA mostrano una quota maggiore di apprensione e ansia. Il<br />
concepimento e la gravidanza, a causa del lungo e complicato vissuto<br />
d’infertilità, sono percepiti come momenti difficili che vengono però superati nel<br />
tempo, di fronte al bambino reale. Il vissuto di genitori PMA è paragonabile a<br />
quello dei genitori di bambini prematuri: alla nascita del bambino sono presenti<br />
82
numerose paure e preoccupazioni, che sembrano però svanire durante la crescita<br />
del bambino.<br />
Per quanto riguarda le famiglie ricorse alla fecondazione eterologa, è<br />
possibile sostenere che (Golombok, Brewaeys et.al., 1996, 2002):<br />
a) i bambini non presentano particolari disturbi psicologici, né problemi<br />
comportamentali o emotivi; inoltre sviluppano buone relazioni all’interno della<br />
famiglia, a dimostrazione che l’assenza di un legame genetico con uno dei<br />
genitori non possa influire sul funzionamento familiare;<br />
b) tra i genitori emerge un grande coinvolgimento emotivo verso i bambini<br />
e una maggior tendenza a interagire rispetto alle altre tipologie familiari; sembra<br />
esserci inoltre un maggior coinvolgimento paterno nella crescita del figlio, come<br />
se il genitore non biologico dovesse recuperare rispetto alla madre o all’anonimo<br />
donatore. I genitori tendono a mantenere il segreto circa il concepimento, ma<br />
questo non sembra incidere in modo significativo sullo sviluppo psicologico ed<br />
emotivo dei bambini, né piccoli, né in età preadolescenziale.<br />
Da questi dati, si coglie anche un inaspettato anticipo dei bambini PMA sui<br />
figli naturali, riguardo al raggiungimento della tappa dell’alimentazione<br />
autonoma e alla comparsa del linguaggio.<br />
Dal punto di vista medico, i bambini PMA non mostrano particolari<br />
problemi alla nascita rispetto ai bambini nati da gravidanze naturali. Il rischio<br />
connesso alla nascita da PMA rimane legato alla maggior frequenza di<br />
gravidanze multigemellari, che più facilmente si accompagnano a parti prematuri<br />
con basso peso del neonato e richiedono più spesso il ricorso a cure intensive<br />
neonatali. Esclusi i casi di questo genere, anche la valutazione dei bambini PMA<br />
dal punto di vista dello sviluppo cognitivo e sensomotorio non ha riscontrato<br />
particolari deviazioni dalla normalità.<br />
83
Alla luce di questi dati, non è possibile affermare in modo assoluto che<br />
l’infertilità e il percorso PMA siano di per sé esperienze che si ripercuotono<br />
negativamente sul senso di genitorialità e sulla relazione genitore-bambino. La<br />
procreazione medicalmente assistita può rappresentare, da una parte una sorta di<br />
cortocircuito esperenziale che aggiunge complessità a un processo, quello del<br />
divenire genitori, già problematico per qualsiasi individuo e coppia; ma,<br />
dall’altra non viene meno la possibilità di gestire tale complessità e di giungere al<br />
termine di questa esperienza con un bagaglio di vissuti arricchenti.<br />
Il lungo percorso della PMA anche come momento di attesa emozionale è<br />
un periodo di “gestazione mentale”, durante il quale la coppia si rapporta al suo<br />
mondo interno senza mai negarlo totalmente. Probabilmente, per queste coppie è<br />
difficile parlare del loro problema al di fuori della considerazione degli aspetti<br />
medici, non volendo riconoscerne la rilevanza sul piano psicologico. Le coppie<br />
custodiscono una chiara rappresentazione del proprio futuro bambino e di sé<br />
stessi come genitori, tale desiderio è un sostegno nella motivazione e nella<br />
perseveranza con cui si affronta il peso fisico e psicologico del trattamento.dopo<br />
ripetuti fallimenti in più cicli di PMA, si può ipotizzare un’alternanza tra<br />
investimento e disinvestimento emozionali delle rappresentazioni genitoriali, al<br />
ripetersi dei cicli di trattamento, fino alla gravidanza, che consente finalmente di<br />
dare forma all’immagine del bambino.<br />
Il percorso di PMA e la gravidanza non sono caratterizzati necessariamente<br />
da “bassi livelli di vita fantasmatica con vuoto rappresentativo rispetto al feto e<br />
al ruolo genitoriale” (Andreotti, Bucci e Marozza, 2000, p.8) né da coartazione<br />
affettiva che inibisce le fantasie e i sogni sul bambino” (Guerrini Degl’Innocenti,<br />
Frassine, Pazzagli, 1992). Piuttosto, le rappresentazioni mentali seguono un<br />
percorso “alterato”, perché alla coppia, che non può “ procreare come gli altri”, si<br />
richiede di affrontare un contesto dai molteplici fattori esterni, estranei ad essa e<br />
84
alla sua storia evolutiva. La complessità della situazione e le difficoltà, per le<br />
ripercussioni, anche pesanti, sul vissuto psicologico probabilmente modificano il<br />
percorso della genitorialità, ma non precludono la possibilità di compiersi<br />
attraverso strade alternative.<br />
Il rapporto tra la coppia PMA e il suo bambino si può dunque caratterizzare<br />
per specifiche difficoltà derivanti dai trascorsi d’infertilità dei genitori, ma può<br />
anche trarre linfa vitale da nuove risorse di cui i genitori si sono arricchiti. Un<br />
bambino può essere in grado di adattarsi a un contesto così configurato e può<br />
giovarsi delle sue potenzialità, senza che la capacità di svilupparsi in modo sano<br />
sia pregiudicata. In definitiva, il bambino nato da PMA è un bambino come tutti<br />
gli altri, desideroso di stare e svilupparsi in una relazione, dove trova l’amore che<br />
lo aiuta a crescere.<br />
3.5 Procreazione Medicalmente Assistita: un valido contributo al divenire<br />
genitori<br />
In questi ultimi anni, in Italia, il dibattito pubblico sul ricorso alla<br />
procreazione medicalmente assistita ha contribuito a rendere nota l’esistenza<br />
delle tecniche con cui la medicina e la biotecnologia facilitano i processi di<br />
fecondazione dei gameti nella riproduzione umana.<br />
Benchè questo ramo della scienza sia relativamente giovane, in poco tempo<br />
si è verificato il passaggio da un’esperienza circoscritta all’ambito privato a una<br />
questione su cui l’intera società è chiamata a confrontarsi.<br />
Probabilmente, tale passaggio si è reso inevitabile non solo per il rapido<br />
perfezionarsi delle tecnologie e il progresso nell’efficacia dei trattamenti, ma<br />
anche per la crescente domanda seguita all’aumento dei casi di infertilità. Le<br />
cause ambientali, come l’inquinamento, o psicogene, come lo stress,<br />
85
contribuiscono a rendere l’infertilità un prodotto dei nostri tempi; e quindi, la<br />
società non può disinteressarsene.<br />
In questo capitolo, il desiderio è stato quello di avvicinarsi al mondo della<br />
PMA da un punto di vista forse ancora poco considerato e dibattuto, quello della<br />
coppia che vive quest’esperienza, con l’intento di recuperare il significato del<br />
vissuto personale, intendendo la genitorialità, non solo nel rapporto reale<br />
genitore-figlio, ma anche come anticipazione “fantasticata” di tale rapporto.<br />
Infatti, alla base del desiderio di un figlio, prima ancora che egli nasca o venga<br />
concepito, c’è la rappresentazione di sé con il futuro figlio.<br />
Nel processo del “divenire genitori” si inseriscono, quindi, sia l’esperienza<br />
dell’infertilità, ostacolo alla possibilità di concretizzare il desiderio di<br />
genitorialità individuale e della coppia, sia le tecniche di fecondazione assistita,<br />
mezzi attraverso cui è possibile aggirare tale ostacolo.<br />
Ripercorrendo il vissuto psicologico individuale e relazionale che<br />
accompagna il percorso della PMA, si giunge alla conclusione che quest’ultima<br />
rappresenti un’esperienza molto coinvolgente per il singolo e per la coppia, dal<br />
momento che ne mobilita le risorse contemporaneamente sul piano fisico,<br />
psicologico, relazionale e anche economico.<br />
Benchè quest’esperienza ponga l’individuo e la coppia di fronte a difficoltà<br />
nuove e spesso non previste, ne può derivare un adattamento positivo, che<br />
contribuisce anche a una maturazione sul piano della propria storia personale e<br />
del legame tra i partner.<br />
Il desiderio di maternità, è da considerarsi un diritto e come tale è da<br />
perseguire con le risorse che la medicina e la psicologia forniscono (nel rispetto<br />
dell’individualità di ognuno e dando attenzione e importanza anche<br />
all’adozione).<br />
86
3.6 In sintesi<br />
In questo capitolo sono stati trattati i diversi aspetti emozionali vissuti dalle<br />
coppie durante il lungo percorso che potrebbe portarle alla tanto desiderata<br />
genitorialità.<br />
Tali coppie spesso vivono questa loro grande problematica in termini<br />
strettamente medici, tralasciando o addirittura rifiutando la rilevanza del<br />
problema sul piano psicologico.<br />
Nonostante le numerose difficoltà, esse risultano essere coppie forti,<br />
mature, consapevoli della loro relazione, aspetti spesso favoriti dalla PMA stessa.<br />
Dopotutto, il dato reale è proprio l’essere coppia; infatti il bambino rimane<br />
a lungo il contenuto di un puro desiderio.<br />
A tal proposito, recentemente, in alcuni centri di PMA, alle coppie viene<br />
proposto un protocollo integrato medico-psicologico che permette di considerare<br />
l’esperienza della coppia avvalendosi di conoscenze provenienti da diversi campi<br />
del sapere.<br />
Nel successivo capitolo, partendo dall’analisi della bioetica e della<br />
sessualità, verrà spiegato come la loro interrelazione porti ad una sessualità ben<br />
integrata nella totalità della persona e della coppia.<br />
87
CAPITOLO IV<br />
BIOETICA: NUOVE SFIDE PER L’UOMO<br />
4.1 La Bioetica: introduzione<br />
“Tre cose sono troppo difficili per me e quattro non capisco:<br />
il volo dell’aquila nel cielo, la traccia del serpente sulla roccia,<br />
la scia della nave nel mare profondo e la via<br />
dell’uomo verso una ragazza”(Proverbi 30, 18-19)<br />
su intuizione di Don A.Biancalani.<br />
Il termine “bioetica” deriva dall’angloamericano bioethics, un neologismo<br />
coniato dal medico ed oncologo Van R. Potter nel 1970, divenuto<br />
successivamente di dominio pubblico dopo il 1971, l’anno di pubblicazione<br />
dell’opera più importante di questo ricercatore “ Bioethics, Bridge to the future”.<br />
Nello stesso anno, presso la Georgetown University di Washingon D.C.,<br />
venne inaugurato il Joseph and Rose Kennedy Institute for the Study of Human<br />
Reproduction and Bioethics, sancendo l’ufficializzazione di questa parola per<br />
indicare un nuovo, (sebbene già delineato da decenni di studi e di letteratura<br />
precedenti alla pubblicazione del saggio di Potter) dominio di studi.<br />
Il concetto di bioetica subì delle resistenze e delle critiche, ma nel 1978<br />
venne finalmente data alle stampe la Encyclopedia of Bioethics, un’opera che<br />
spianò la strada alla diffusione di questa area disciplinare e problematica<br />
avviandola verso l’unificazione in un’unica materia, caratterizzata, comunque,<br />
dall’esistenza di una matrice interdisciplinare ove Medicina, Giurisprudenza,<br />
Biologia, Psichiatria, Psicologia e, ultima ma non meno importante, la Filosofia<br />
Morale, contribuiscono allo sviluppo e alla vita di intensi dibattiti, spesso legati a<br />
doppio filo con le conseguenze reali di fatti di dominio pubblico o di cronaca, o<br />
importanti pronunciamenti di tipo politico (come è avvenuto in Italia con<br />
l’approvazione della legge 194 sull’interruzione di gravidanza).<br />
89
Assumiamo dall’Encyclopedia of Bioethics, nell’edizione del 1995, la<br />
seguente definizione di Bioetica ossia “lo studio sistematico delle dimensioni<br />
morali, comprendenti la visione morale, le decisioni, la condotta, le politiche<br />
delle scienze della vita e della cura della salute, attraverso una varietà di<br />
metodologie etiche in un contesto interdisciplinare” (Reich, 1995, vol.1, p. XXI).<br />
Come è stato fatto osservare da più parti, la bioetica, proprio partendo dal<br />
suo intrinseco carattere fondamentalmente interdisciplinare, pur rivendicando la<br />
sua novità e la sua dignità all’interno delle discipline etiche non può,<br />
sicuramente, essere elevata al rango di “scienza”. Infatti, pur attingendo, e<br />
costantemente, alle novità e agli aggiornamenti, specie quelli più elevati sotto il<br />
profilo del loro utilizzo tecnologico, delle scienze empiriche, in special modo<br />
della genetica e della medicina sperimentale, la bioetica è una disciplina di<br />
carattere prescrittivo e normativo e non semplicemente descrittivo come le altre<br />
scienze empiriche.<br />
4.2 Etica e sessualità: un rapporto da ricostruire<br />
4.2.1 La sessualità e i suoi significati umani<br />
La bioetica, come immaginabile, ha delle ripercussioni in numerosi settori<br />
della scienza: nel campo della sessualità, si è verificata nel nostro tempo una<br />
vera e propria rivoluzione culturale paragonabile per la sua incidenza alle grandi<br />
rivoluzioni che hanno segnato la modernità.<br />
Un approccio alla dimensione etica della sessualità sarebbe inevitabilmente<br />
destinato a rimanere astratto se non si confrontasse con gli atteggiamenti più<br />
significativi che hanno preso corpo all’interno dell’attuale cultura per l’appunto<br />
della sessualità.<br />
Da una parte, la sessualità appare mitizzata: le attese nei suoi confronti sono<br />
enormemente accresciute rispetto al passato e ciò, trova spiegazione,<br />
90
fondamentalmente, in due tipi di motivazioni: da un lato, vivendo in una società<br />
sempre più anonima e massificata dove i rapporti si fanno sempre più funzionali,<br />
si acutizza l’esigenza di essere “ riconosciuti”; da qui il rinforzarsi degli<br />
investimenti nei confronti della relazione affettivo-sessuale.<br />
Ma c’è una seconda spiegazione ancora più pertinente: si vive in una<br />
società sempre più amministrata, benché tutto si muova e si agiti nel segno della<br />
novità, viene meno la creatività, poiché tutto è precostituito: idee, sentimenti,<br />
desideri tendono ad essere incanalati dentro binari standard.<br />
C’è un’area però in cui il sistema, attraverso il martellamento dei mezzi di<br />
comunicazione di massa, induce a trovare tutta quella libertà che si nega in<br />
campo sociale: è l’area della sessualità, in direzione della quale naturalmente si<br />
dirigono e crescono le attese.<br />
Dall’altro lato la sessualità appare secolarizzata: il processo di<br />
secolarizzazione si esprime attraverso la tendenza a separare la sessualità dalla<br />
morale. Contro la tendenza moralizzante del passato che aveva fatto della<br />
sessualità l’area più “regolamentata”, oggi si può affermare che il campo della<br />
sessualità deve essere affidato alla spontaneità dell’individuo.<br />
Guardando però, all’attuale panorama, è evidente una nuova e pervasiva<br />
normativa a cui la sessualità è stata consegnata: la normativa medica.<br />
Non si vuole con questo demonizzare il costituirsi della conoscenza della<br />
sessualità come conoscenza scientifica e l’affermarsi nella società di una più<br />
consapevole domanda di salute, includendo quindi anche la salute sessuale e<br />
riproduttiva, si vuole piuttosto affermare la necessità che il paradigma<br />
“sanitario”, assunto dall’attuale cultura come quadro di definizione dell’etica<br />
sessuale, venga interpretato alla luce di una visione integrale della sessualità.<br />
L’orizzonte entro cui pensare la dimensione etica della sessualità è la sua<br />
multidimensionalità: tale risulta essere la condizione di base per la sua<br />
91
comprensione. Inoltre il riferimento ad essa, senz’altro utile a denunciare ogni<br />
approccio riduttivo, rimarrebbe comunque indeterminato qualora non si<br />
riconducesse la sessualità alla sua matrice e cioè la persona.<br />
E’nella circolarità tra sessualità e persona che prendono consistenza i<br />
significati umani della sessualità.<br />
Sorgente e connettivo della vita umana, la sessualità rivela il mistero della<br />
persona, come, a sua volta, il mistero della persona rivela la natura ultima della<br />
sessualità umana (Piana, 1983, p.314).<br />
4.2.2 Il significato personale della sessualità<br />
La sessualità è una dimensione costitutiva della persona. Questo vuol dire<br />
che essa non indica una parte, ma tutta la persona in quanto uomo o in quanto<br />
donna. La sessualità non è perciò riducibile a genialità che di essa è solo una<br />
funzione.<br />
Essa si esprime secondo diversi livelli di profondità connotati ognuno da<br />
una loro specificità e un loro valore:<br />
1) il “sesso” indica le radici biologiche della sessualità e ci radica nel<br />
respiro cosmico della vita;<br />
2) l’“eros” indica gli elementi più propriamente psicologici della sessualità:<br />
la forza del desiderio, la passione, la tenerezza e l’abbandono in tutte le sue<br />
molteplici espressioni;<br />
3) la “filia” indica la dimensione “amicale” della sessualità: la stima,<br />
l’ammirazione e l’interesse per il valore della persona dell’altro;<br />
4) l’“oblività” esprime della sessualità il livello del dono gratuito, del<br />
servizio centrato sul bene dell’altro.<br />
Un’altra acquisizione importante sottolineata dalla ricerca psicologica, in<br />
particolare dalla psicoanalisi, è la concezione dinamica della sessualità. Come<br />
92
parte costitutiva della persona nella sua totalità, la sessualità partecipa del<br />
processo evolutivo: si sviluppa cioè a tappe, interessando tutto l’arco della vita di<br />
una persona e determinandone in maniera sostanziale l’armonia e l’equilibrio.<br />
Si può, dopo aver considerato questo primo significato di sessualità,<br />
affermare che: “una sessualità ben integrata nella totalità della persona svolge<br />
un’importante funzione di crescita ed è per la persona, a tutti gli stadi, fonte di<br />
gioia di vivere” (Viafora, 2006, p.268).<br />
4.2.3 Il significato relazionale della sessualità<br />
Se la parola sessualità è una parola in un certo senso “inquinata” da una<br />
molteplicità contraddittoria di significati, la parola che traduce il significato<br />
interpersonale e che le attribuisce l’impostazione personalistica potrebbe essere:<br />
complementarietà.<br />
La sessualità indica la capacità della persona di dare e ricevere<br />
compimento. Inserita nel dinamismo relazionale della persona, la sessualità<br />
diventa umana e umanizzante nella misura in cui si fa espressione e linguaggio<br />
della relazione interpersonale.<br />
Integrata nell’amore, la sessualità diventa il luogo dove un uomo e una<br />
donna sono chiamati a guarire reciprocamente le ferite della propria solitudine; il<br />
luogo dove due esistenze si toccano nell’intimo e nella libertà abbracciano una<br />
relazione che va da cuore a cuore e che ha la capacità di rivelare l’unicità l’uno<br />
dell’altra.<br />
C’è, purtroppo, sempre la possibilità che la sessualità ricada in una chiusura<br />
narcisistica o in una reificazione dell’altro o anche reciproca; è per questo motivo<br />
che essa esige di essere costantemente umanizzata, il che significa che deve<br />
essere aiutata ad inserirsi nella dinamica della relazione interpersonale.<br />
93
Fuori da una relazione profonda, da una relazione vera, la sessualità si<br />
riduce a essere banale consumo.<br />
4.2.4 Il significato creativo della sessualità<br />
La fecondità esprime una connotazione essenziale dell’amore. Un rapporto<br />
di coppia autentico è portato a espandersi, a comunicarsi, a donarsi.<br />
La fecondità però non può essere intesa in modo riduttivo come sola<br />
fecondità fisica. Non c’è amore di coppia senza fecondità, ma d’altra parte non<br />
esiste fecondità in senso personale se essa non nasce dall’amore e non sia di esso<br />
solo espressione.<br />
E’ questo il senso profondo della fecondità, un valore aspramente criticato,<br />
perché troppo si è investito sull’aspetto biologico dell’avere dei figli, mentre la<br />
sua collocazione in una prospettiva personalistica e non solamente biologica<br />
implica che, pur essendo la fecondità fisica una forma tipica, essa non esaurisce<br />
la ricchezza della fecondità umana.<br />
E, d’altra parte, anche la coppia che non può avere figli è chiamata alla<br />
fecondità: una fecondità in senso umano, che indica l’impegno della coppia a<br />
“produrre più umanità”. Infatti nell’ottica di questa interpretazione del significato<br />
“creativo” della sessualità emerge, a fronte di una tendenza crescente alla<br />
privatizzazione dell’affettività, l’esigenza di dare più forza sociale all’amore,<br />
aumentando nelle attività feriali gli spazi della comunicazione e della solidarietà.<br />
E’stato merito di Fromm (1971,p.115) all’interno dell’orientamento sociale<br />
in psicoanalisi, quello di ridare, in maniera decisa e coraggiosa, dignità culturale<br />
al termine stesso “amore”, purificandolo dall’ambiguità in cui è avvolto nella<br />
cultura contemporanea.<br />
L’amore, secondo Fromm, è l’unico vero bisogno dell’uomo, l’unica<br />
soluzione valida al problema della vita: infatti il tema costante in tutti i suoi<br />
94
scritti è la solitudine dell’uomo in seguito al suo allontanamento dalla natura e<br />
dagli uomini.<br />
Per comprendere la concezione che Fromm ha dell’amore, bisogna inserirla<br />
all’interno di quel particolare orientamento psicosociale che egli chiama<br />
“orientamento produttivo”. Questo orientamento è proprio dell’uomo capace di<br />
servirsi delle sue forze e di attuare le sue potenzialità: l’uomo che preferisce<br />
“costruire” più che “trattenere”, “essere” più che “sembrare”.<br />
L’uomo produttivo ha un atteggiamento “attivo” nei confronti della vita; nel<br />
contesto dell’orientamento produttivo si inserisce l’amore (Fromm, 1977,<br />
p.186).<br />
4.3 Modelli etici ricorrenti<br />
Il clima multiculturale di oggi richiede di prendere atto delle giustificazioni<br />
profonde che le varie correnti di pensiero vogliono dare a prese di posizione<br />
contrastanti e opposte (Doldi, Picozzi, 2000, p. 54).<br />
Il problema non è non avere precomprensioni, impresa indimostrabile e<br />
impossibile, ma ricercarne ed esibirne il senso. A, si fornisce una rapida<br />
carrellata delle teorie ad oggi elaborate (Grillo, 2007, pp.47-52).<br />
4.3.1 Etica descrittiva e modello sociobiologista<br />
Per tale prospettiva, la società nella sua evoluzione produce e cambia valori<br />
e norme perché siano funzionali al suo sviluppo. Come esiste un’evoluzione della<br />
specie, così esiste un’evoluzione dei valori di riferimento al fine di meglio<br />
adattarsi al nuovo ecosistema. Non esiste nulla di assoluto e di definitivo per<br />
sancire il bene e il male; dipende dalla percezione della società nel momento.<br />
95
4.3.2 Etica liberale e soggettivista<br />
Questa teoria, afferma che soltanto la scelta autonoma del soggetto può<br />
fondare le ragioni del bene e del male. Non possiamo conoscere un bene<br />
oggettivo e se anche potessimo conoscerlo, non potremmo attribuirlo a tutti i<br />
soggetti che decidono. È in concreto l’affermazione della libertà di chi se la può<br />
permettere, la libertà del più forte, di chi può alzare la voce, di chi già dispone di<br />
potere. È pura esenzione da costrizioni e convinzione di potersi autodeterminare<br />
a tutto campo. E’ una libertà che si costruisce strada facendo, nella sicurezza<br />
percepita di non avere limiti, da nessuna parte, sul proprio desiderio.<br />
È difficile parlare di responsabilità dove si ritiene che non ci sia altro valore<br />
sopra la libertà, così come chiedere il rispetto della vita di tutti: il lasciar nascere,<br />
il lasciar crescere e svilupparsi negli anni. In questo clima non esiste tolleranza e<br />
lo Stato non può prendere una qualsiasi posizione in difesa della vita del più<br />
svantaggiato, pur sapendo che non può restare neutrale (Bausola, 1998, pp. 33-<br />
44, pp. 45-63).<br />
4.3.3 Modello pragmatico utilitarista<br />
Se la strada appena accennata è un vicolo cieco, occorre mediare un<br />
accordo intersoggettivo che possa rispondere a tre criteri:<br />
-massimizzare il piacere;<br />
- minimizzare il dolore;<br />
- ampliare la sfera delle libertà personali per il maggior numero di persone.<br />
C’è un rapporto costi-benefici nel benessere che non va mai dimenticato: a<br />
volte sembra che la dimensione economica (che appartiene al mondo delle cose)<br />
prevalga sulla dimensione della dignità della persona, del suo valore irriducibile<br />
a “cosa”. È una prospettiva che ogni tanto riaffiora, ma con scarso successo.<br />
96
4.3.4 Il sistema principalista<br />
È nato negli Stati Uniti come proposta limitata alla sperimentazione, tra il<br />
1974 e il 1978, per designazione della National Commission of the Protection of<br />
Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research.<br />
Ricercatori e Comitati etici erano invitati ad attenervisi per avere una base<br />
comune d’intesa. La realtà complessa degli Stati Uniti ha imposto ulteriori<br />
distinzioni e chiarimenti; è possibile trovare denominazioni analoghe dei<br />
principi, ma sostanzialmente corrispondono ai quattro seguenti (1979):<br />
- principio di autonomia (meglio sarebbe dire: principio di rispetto<br />
dell’autonomia): le persone meritano rispetto e non si può decidere contro la loro<br />
volontà, nella misura in cui sono capaci di intendere e volere;<br />
i vantaggi;<br />
- principio di beneficialità o beneficenza: minimizzare i rischi, ottimizzare<br />
- principio di giustizia gli interventi hanno benefici, costi e rischi che<br />
vanno soppesati nei limiti della sopportabilità economica ed umana, per il<br />
singolo e per la collettività;<br />
- principio di non maleficenza evitare di causare il male o con la massima<br />
latina, primum non nocere (Beauchamp, Childress, 1998).<br />
4.3.5 Il sistema personalista<br />
Condizionati dal peso di una lunga tradizione che ha presentato l’etica in<br />
termini marcatamente negativi, come sistema di regole poste per fissare l’area del<br />
proibito, ma fuorvianti anche da un diffuso pregiudizio che considera inautentico<br />
ogni riferimento della sessualità all’etica, diventa sempre più necessario porre<br />
alla radice il problema del rapporto tra etica, sessualità e procreazione (Cattolini,<br />
Reichlin, 1996, pp.37).<br />
97
La sessualità, come già affermato precedentemente, può essere una risorsa<br />
che rafforza la persona e a cui la persona attinge gusto di vivere, come può<br />
diventare invece a certe condizioni un’esperienza che destabilizza e fa regredire.<br />
Quali sono le condizioni per una sua gestione responsabile in maniera tale<br />
che la sessualità possa esprimere risorse positive di costruzione della persona, di<br />
relazione e, insieme, di apertura alla vita?<br />
Sono queste le domande in cui si innesta la dimensione etica della sessualità<br />
e tracciano il livello dove autenticamente collocare il rapporto tra etica e<br />
sessualità. In questa prospettiva, quella personalitica, la determinazione delle<br />
condizioni per una gestione responsabile della sessualità fanno riferimento da<br />
una parte, alla struttura della persona, attivando la circolarità tra sessualità e<br />
persona che ne orienta il processo di umanizzazione; dall’altra, agli specifici<br />
compiti che emergono nelle diverse tappe del cammino evolutivo.<br />
In questi due criteri, trovano espressione le acquisizioni più significative di<br />
coppia centrata sulla capacità di impostare una comunicazione profonda,<br />
l’integrazione della sessualità nella progettualità coniugale a partire dalla<br />
decisione di crescere insieme, la valorizzazione della fecondità in direzione<br />
dell’apertura alla vita e, più in generale, dell’impegno a “produrre più<br />
umanità”(Viafora, 2006, pp.271).<br />
Gli aspetti che maggiormente qualificano questi spunti di un’etica della<br />
sessualità in una prospettiva personalistica sono: da un punto di vista formale,<br />
l’orientamento verso gli agenti piuttosto che sugli atti; sugli atteggiamenti,<br />
piuttosto che sui comportamenti ed una positività degli orientamenti etici cioè,<br />
non una codificazione di divieti, ma piuttosto indicazioni in grado di aiutare a<br />
vivere le risorse della sessualità inserendole dentro un orizzonte di senso e<br />
all’interno di una progettualità intrinseca al progetto evolutivo.<br />
98
Accanto a questi due primi aspetti, un terzo aspetto interviene a<br />
caratterizzare un’etica della sessualità in prospettiva personalistica: l’attenzione<br />
posta sui sentimenti.<br />
Infatti, poiché, l’umanizzazione della sessualità passa attraverso un suo<br />
progressivo inserimento nella dinamica della relazione interpersonale e dei<br />
processi evolutivi, è chiaro che la mediazione tra etica e sessualità è affidata, per<br />
buona parte, all’educazione dei sentimenti.<br />
4.3.6 Il manifesto di bioetica laica<br />
Tale manifesto è uscito in Italia nel 1996 e costituisce una chiara corrente<br />
di pensiero, confermata da un documento specifico sulla fecondazione assistita.<br />
Afferma la sua laicità nel prendere le distanze dai principi religiosi, in<br />
quanto ritenuti non validi per influire sulla società.<br />
È vantaggioso per tutti un dialogo costruttivo, non senza alcune condizioni<br />
per evitare equivoci: anzitutto il mondo laico non è così monolitico da non<br />
riconoscere alla cultura cristiana la capacità di dire molto sui problemi della<br />
bioetica (Scarpelli, 1998) e inoltre il pensatore religioso può dare un contributo<br />
reale ad una migliore visione del mondo e dell’uomo; non per questo si sente<br />
schiacciato dalle indicazioni che gli vengono dall’essere credente.<br />
Egli avrà una visione diversa delle cose rispetto a chi intende muoversi<br />
“come se Dio non si ponesse neppure per ipotesi” e rispetto a chi vede in Dio un<br />
terribile concorrente alla libertà dell’uomo.<br />
La ricerca intelligente ha bisogno di quella tolleranza che è l’invenzione<br />
della verità come un fatto corale, senza pretesa di monopoli esclusivi, evitando<br />
ogni forma di fideismo e di fondamentalismo.<br />
Se esiste una “natura” con le sue leggi, sarà sempre una ragione umana che<br />
la scopre e interpreta con una coscienza mutevole e progressiva. Il problema<br />
99
morale in bioetica (e anche in ecologia) non è quello di modificare la natura che<br />
ci troviamo di fronte, ma piuttosto quello di discernere finalità, limiti e mezzi per<br />
interagire con la natura ivi compresa la natura biologica dell’uomo stesso<br />
(Chiavacci, 1998).<br />
È nella progettualità, che rende umana la vita che è scritta la parte attiva<br />
dell’uomo nel cosmo.<br />
Il mondo plurietnico e multiculturale di oggi è tanto diverso dal passato<br />
eurocentrico e monoculturale (Fluss, 1998). Già questa constatazione dice<br />
chiaramente come deve essere l’azione della ricerca e della politica: non di forza,<br />
ma di offerta/dono per determinare nuove forme di vita (Doldi, Picozzi, 2000,<br />
pp.85-86).<br />
4.4 Procreazione Medicalmente Assistita: l’impatto della tecnica<br />
sull’esperienza umana della procreazione<br />
4.4.1 Procreazione Assistita: la complessità dei valori in gioco<br />
Ancora oggi, per quanto la fecondazione assistita tenda ad essere sempre<br />
più riconosciuta, per quanto sia data come pratica acquisita e sempre più<br />
regolamenta, non cessa tuttavia di essere altamente controversa sul piano bioetico<br />
(Heitman,1999).<br />
“La cosa non è da stupire, ove si consideri come al riguardo vengano ad<br />
intrecciarsi non solo ardue questioni morali, ma anche problemi psicologici e<br />
sociologici, medici e giuridici, in nodi tematici di estrema complessità, la cui<br />
focalizzazione appare estremamente ardua”(D’Agostino, 1995, p.134).<br />
Dalle parole di Heiman e di D’Agostino si possono ricavare due preziosi<br />
suggerimenti: da una parte l’approccio globale attento a valutare l’impatto<br />
antropologico che a breve e a lungo termine produce l’intervento della tecnica<br />
nel processo procreativo umano; dall’altra, il suggerimento di un approccio<br />
100
normativo attento alla salvaguardia, contro ogni indebita ingerenza, di quel bene<br />
prezioso che è l’autonomia procreativa e attento insieme a confrontarla con le<br />
esigenze di natura relazionale e sociale costitutive dell’esperienza umana della<br />
procreazione (Mazzoni, 1998).<br />
Ciò che emerge chiaro da queste indicazioni metodologiche è la<br />
consapevolezza della complessità dei valori in gioco nello sviluppo elle<br />
tecnologie riproduttive.<br />
In una prospettiva più attenta alle persone implicate nel processo della<br />
generazione sarebbe più corretto parlare di procreazioni assistite (Thèvenot,<br />
1990, pp.84-108).<br />
Come sempre il linguaggio fa da spia al pensiero: esprimersi in termini di<br />
pro-creazione, invece che di riproduzione, vuol dire atteggiarsi diversamente di<br />
fronte alla genitorialità umana, all’investimento attivato (Foggio, 2000), alla fine,<br />
al sistema di significati impegnato: pro-creare significa molto di più che disporre<br />
di tutto il materiale per costruire una cosa secondo un piano ben prestabilito e la<br />
verifica della qualità in rapporto a costi e benefici. Pro-creare è sbilanciarsi in<br />
avanti nel tempo, accettare come una sfida qualsiasi genere di sorprese dove<br />
prima della speranza ci deve essere la fiducia nella vita; pro-creare è<br />
compromettersi a favore di qualcuno che ancora non c’è e in questo senso è<br />
ospitalità di padre e madre verso il figlio, ma è anche l’ospitalità che il figlio dà<br />
ai genitori accettandone la diversità, senza un cammino programmato (Thévenot,<br />
1990, pp. 89-91). A questa finalità deve essere orientata l’azione del tecnico.<br />
“Un padre e una madre che mettono in comune metà del loro corredo<br />
cromosomico per avere un figlio, non ottengono mai un bambino come copia<br />
autentica di se stessi, ma ciò che viene generato è il risultato di una “roulette”<br />
genetica. Questo bambino dovranno poi “adottarlo” perché diventi loro figlio.<br />
Ma affinché il processo di generazione riesca e sia completo, l’adozione è<br />
101
necessaria anche dall’altra parte: il figlio che non ha potuto, nascendo, scegliere i<br />
propri genitori, dovrà “adottarli” e perché questo avvenga, i genitori dovranno<br />
dimostrarsene degni (Spinsanti, 1998, pp. 87) .<br />
In altri termini: ogni procreazione è una scommessa di due persone che<br />
coinvolgono una terza persona, con cui dovranno intrecciare progressivamente<br />
rapporti sempre più definiti di reciprocità, di implicazione negli orizzonti di<br />
senso e di responsabilità. La futura capacità di relazione del piccolo con sé e con<br />
l’altro dipende dalla qualità delle esperienze che fa fin dalla nascita. La capacità<br />
di entrare in relazione, di costruire relazioni, mantenerle vitali e arricchenti,<br />
perciò relazioni caratterizzate dalla capacità di “amare”, è anche il risultato di<br />
come egli è stato accolto e come sia stato oggetto di cure, attenzioni e affetto.<br />
Se dare vita è, per così dire, la meta principale, non può essere dimenticata<br />
l’altra esperienza, non meno rilevante, cioè quella che fanno un uomo e una<br />
donna di una loro “vita nuova”, una volta diventati genitori e resi padri e madri<br />
dal loro figlio.<br />
4.4.2 Dall’etica al diritto: la regolamentazione giuridica delle nuove tecnologie<br />
riproduttive<br />
Non c’è forse un’altra area della bioetica dove appaia con altrettanta<br />
evidenza la necessità e insieme la problematicità di questo passaggio.<br />
Tuttavia, risulta importante che il diritto assuma i suoi propri compiti e cioè<br />
quelli di assicurare che l’ampliamento della libertà si eserciti nella garanzia dei<br />
diritti di tutti i soggetti coinvolti e poi il compito di favorire un’adeguata<br />
assimilazione culturale delle nuove modalità procreative, tessendo quei legami<br />
con la tradizione in grado di assicurare continuità e coerenza alla nostra<br />
convivenza, infine il compito di definire, all’interno di una società sempre più “al<br />
plurale”, quel minimo etico che per tutti segni il limite di ciò che non può essere<br />
102
tollerato. E’ per questi motivi che la gran parte dei Paesi europei, è intervenuta a<br />
regolamentare giuridicamente le nuove tecniche procreative.<br />
4.4.3 La regolamentazione Italiana della Procreazione Assistita: La Legge<br />
40/2004<br />
Con una maggioranza ampia e trasversale il Parlamento Italiano ha<br />
approvato le “Norme in materia di Procreazione Medicalmente Assistita”, Legge<br />
40 del 19 febbraio 2004. Questi in sintesi i contenuti:<br />
• Il ricorso alla PMA (Procreazione Medicalmente Assistita), è consentito<br />
solo in caso di sterilità o infertilità, documentate da un atto medico e non<br />
altrimenti risolvibili e cioè non unicamente dipendente dal desiderio<br />
individuale, ma in relazione ad effettive condizioni di sterilità o infertilità<br />
(Art.1, c.1-2).<br />
• Possono accedere alle tecniche di PMA coppie di maggiorenni, di sesso<br />
diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi<br />
viventi. Un divieto quindi a single, coppie omosessuali, donne in<br />
menopausa, fecondazione post-mortem (Art.5).<br />
• Sono ammesse solo le tecniche di PMA di tipo omologo, quelle cioè che<br />
utilizzano seme e ovociti della stessa coppia. E’ vietato il ricorso a tecniche<br />
di tipo eterologo (Art.4, c.3).<br />
• La Legge impone inoltre che le tecniche di produzione degli embrioni,<br />
qualunque di esse venga usata a scelta tra FIVET, GIFT, ICSI, non<br />
producano un numero di embrioni superiore a quello strettamente<br />
necessario ad un unico e contemporaneo impianto che comunque non deve<br />
essere più di tre.<br />
103
Si evita così la crioconservazione, ammessa solo qualora il trasferimento<br />
nell’utero non risulti possibile a causa dello stato di salute della donna, non<br />
prevedibile al momento della fecondazione (Art.14, c.1-2-3).<br />
• Per accedere alle tecniche di PMA, la Legge richiede il consenso informato<br />
scritto ad entrambi i coniugi, congiuntamente al medico responsabile della<br />
struttura sanitaria. Tra la manifestazione della volontà e la tecnica deve<br />
intercorrere un termine non inferiore a sette giorni, termine entro cui la<br />
volontà può essere revocata da entrambi i membri della coppia. A partire<br />
però dalla fecondazione sarà obbligatorio per la donna l’impianto degli<br />
embrioni prodotti (Art.6, c.1-3)<br />
• Per quanto riguarda lo stato giuridico dei bambini nati con tali tecniche, la<br />
Legge riconosce loro lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti dalla<br />
coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alla fecondazione assistita,<br />
con il divieto quindi, di disconoscimento della paternità e insieme il divieto<br />
dell’anonimato della madre (Art.8, c.1-2).<br />
• Considerando l’embrione umano soggetto a pieno titolo, nella prospettiva di<br />
garantirne i diritti come tutti gli altri soggetti coinvolti, la Legge indica in<br />
dettaglio le misure di tutela dell’embrione (Art.13). Sono parte di questa<br />
tutela, il divieto di qualsiasi sperimentazione che comporti la distruzione di<br />
embrioni umani; il divieto della produzione di embrioni umani a fini di<br />
ricerca e di sperimentazione; il divieto di ogni forma di selezione a scopo<br />
eugenetico e di qualunque manipolazione diretta ad alterare il patrimonio<br />
genetico dell’embrione; il divieto di clonazione tramite il trasferimento di<br />
nucleo o tramite scissione precoce dell’embrione; il divieto di riduzione<br />
embrionaria di gravidanze plurime; il divieto di diagnosi pre-impianto<br />
anche quando la donna sia portatrice di anomalie genetiche.<br />
104
4.5 La convivenza tra mondi etici<br />
Di fronte alle grandi questioni della bioetica, la pluralità di mondi morali è<br />
un dato di fatto, anche all’interno della stessa area culturale. Di fronte ad un<br />
mondo morale differente dal nostro abbiamo cinque alternative: la “guerra”; la<br />
“tolleranza”; la “regolamentazione”; la “gestione” del dissenso; la<br />
“conversazione” mirata alla comprensione e all’ampliamento dei punti di vista,<br />
nel pieno rispetto delle persone e della loro autonomia (Spinsanti, 1998).<br />
Mantenendo sullo sfondo lo scenario in continua e rapida evoluzione delle<br />
nuove tecnologie riproduttive, è possibile proporre un bilancio critico sulle<br />
posizioni etiche sull’argomento della Procreazione Medicalmente Assistita, alla<br />
luce della Legge 40/2004.<br />
4.5.1 Posizione cattolica sulla Legge 40/2004<br />
I sostenitori della legge sulla procreazione assistita insistono nell’affermare<br />
che la Legge 40/2004 non è affatto una “legge cattolica”.<br />
A sostegno di questa loro tesi, adducono i seguenti argomenti:<br />
1) la dottrina cattolica romana vieta ogni fecondazione assistita, anche<br />
quella omologa che è invece ammessa dalla legge. La legge quindi, sotto diversi<br />
e importanti profili, non corrisponde all’insegnamento etico della chiesa (Ruini,<br />
2005);<br />
2) la legge è stata approvata grazie al voto trasversale di deputati e senatori<br />
appartenenti a schieramenti diversi. Anche nella società civile si è registrata una<br />
convergenza di laici e cattolici sui valori fondanti la legge, valori che riguardano<br />
il rispetto della vita umana e gli interessi del nato (Mori, 2005);<br />
3) pur non essendo eticamente neutrale, la legge propone divieti che si<br />
riconducono alla tutela di fondamentali valori e diritti umani meritevoli di essere<br />
riconosciuti ed apprezzati al di là appartenenze laiche o confessionali: si tratta<br />
105
quindi di valori la cui validità dipende non da dogmi di fede o da considerazioni<br />
religiose, ma dall’analisi razionale.<br />
E’ quindi fuorviante dire che si tratta di una legge cattolica, perché questa<br />
etichetta porta a credere che la legge proponga i valori di un solo gruppo<br />
specifico e limitato e non dipenda da valori che invece sarebbero giustificati in<br />
base alla sola ragione che è comune a tutti gli uomini (Mori, D’Orazio, 2005).<br />
Di fatto il testo della legge è stato elaborato da associazioni di sicura fede<br />
cattolica, è stato approvato dai vescovi italiani ed anche dal papa, e viene<br />
strenuamente difeso dai cattolici.<br />
In questo senso più ampio la 40/2004 è la “legge cattolica” perché, pur non<br />
recependo in toto la dottrina cattolica romana, riesce a fare in modo che nelle<br />
attuali circostanze storiche questa riesca a trovare la massima attuazione<br />
possibile; di più non era realisticamente possibile fare e quindi si è accettato un<br />
testo che effettivamente non corrisponde all’insegnamento della dottrina ufficiale<br />
della Chiesa Cattolica Romana, ma questo non toglie che i valori proposti<br />
continuino ad essere il riflesso più o meno pallido o vivido del principio<br />
d’inscindibilità difeso dalla dottrina cattolica. Sia pure in forma attenuata, la<br />
legge continua a riflettere i valori di uno specifico gruppo di fedeli, quello dei<br />
cattolici romani.<br />
4.5.2 Posizione laica sulla Legge 40/2004<br />
La visione laica si differenzia dalla parte preponderante delle visioni<br />
religiose in quanto non vuole imporsi a coloro che aderiscono a valori e visioni<br />
diverse. Là dove il contrasto è inevitabile, essa cerca di non trasformarlo in<br />
conflitto, cerca l’accordo locale, evitando le generalizzazioni.<br />
Ma l’accettazione del pluralismo non si identifica con il relativismo, come<br />
troppo spesso sostengono i critici. La libertà della ricerca, l’autonomia delle<br />
106
persone, l’equità, sono per i laici dei valori irrinunciabili, sufficientemente forti<br />
da costituire la base di regole di comportamento che sono insieme giuste ed<br />
efficaci (Flamigni, 1996).<br />
Poiché oggi la PMA viene praticata su scala planetaria, da decenni si<br />
sentiva nel nostro Paese l’esigenza di una regolamentazione giuridica della<br />
materia. Purtroppo, come accaduto in passato per altre questioni, è innegabile che<br />
la legge 40/2004 sia stata frutto di uno scontro tra culture, una “guerra tra<br />
mondi”.<br />
Ne è prova il fatto che all’indomani della sua entrata in vigore erano già in<br />
attività le parti sostenenti la sua abrogazione attraverso lo strumento referendario:<br />
non sono certamente queste le condizioni necessarie per regolamentare una<br />
materia così specialistica e controversa.<br />
Nel tentativo di uscire dalla polemica, gli specialisti della PMA ritengono<br />
che l’unica strada percorribile sia quella della ragione, per dare la facoltà di<br />
parola all’evidenza medico-scientifica: a tale scopo, la visione laica, ritiene che la<br />
legge 40/2004 comprometta il diritto ai pazienti di ricevere un’assistenza ispirata<br />
ai principi di buona pratica medica.<br />
Se la legge venisse mantenuta sostanzialmente nella sua attuale<br />
impostazione, il nostro Paese, secondo il manifesto di Bioetica Laica, si<br />
troverebbe in una posizione di eccezionalità della pratica della PMA, senza<br />
eguali nel resto del mondo se si tiene conto che, anche normative particolarmente<br />
restrittive come quelle vigenti in Germania e Svizzera, sono su posizioni<br />
differenti da quella italiana (Luxic, 2005, p. 29).<br />
107
4.6 In sintesi<br />
In questo capitolo sono stati evidenziati sia il carattere fondamentalmente<br />
multidisciplinare della bioetica, sia i diversi aspetti rappresentativi della<br />
sessualità.<br />
Da qui nasce il tentativo di ricostruire un nuovo rapporto tra bioetica e<br />
sessualità per giungere ad una gestione responsabile di quest’ultima, come risorsa<br />
positiva di costruzione della persona, di relazione e, insieme, di apertura alla vita.<br />
Tale rapporto, vissuto all’interno di un protocollo di PMA, fa sì che la<br />
coppia possa vivere non solo il “dare la vita”, ma anche un’altra esperienza, non<br />
meno rilevante, cioè quella di “una loro vita nuova” nel divenire genitori.<br />
Non c’è, forse, un’altra area dove appaia con altrettanta evidenza la<br />
necessità che il diritto assuma i suoi propri compiti, cioè quelli di assicurare che<br />
l’ampliamento della libertà si eserciti nella garanzia dei diritti di tutti i soggetti<br />
coinvolti.<br />
108
CAPITOLO V<br />
CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI PERSONALI<br />
5.1 Conclusioni e considerazioni personali<br />
109<br />
“Viaggio dalle molecole al cosmo<br />
attraverso la consapevolezza dei<br />
sentimenti” (Dr. E.Muti, 2007).<br />
Vorrei esporre le conclusioni di questa mia tesi in modo un po’ particolare,<br />
o meglio, strettamente personale.<br />
Questo mio desiderio nasce dal cuore e da una serie di motivazioni che, di<br />
seguito, esporrò per render chiaro il vissuto che c’è dietro questo mio proposito.<br />
Questa tesi per me rappresenta non solo una elaborata trattazione che mi<br />
consentirà di raggiungere un tanto desiderato traguardo, ma molto di più.<br />
Ho iniziato la mia esperienza lavorativa in ospedale 25 anni fa acquisendo<br />
un diploma di laurea in tecnico analista medico biologico, che mi ha permesso di<br />
inserirmi nel mondo ospedaliero , da me amato, come analista clinico- biologico.<br />
Ho iniziato questo mio percorso occupandomi inizialmente di<br />
microbiologia, poi di reazioni radio-immmuno-ria, un settore del laboratorio che<br />
si occupa di valutazioni ormonali.<br />
Lavorando in questo settore ho conosciuto due ginecologi che iniziavano ad<br />
occuparsi di PMA, i quali mi hanno proposto una collaborazione di tipo<br />
biologico; ho così iniziato, quasi inconsciamente, ad occuparmi di sterilità di<br />
coppia.<br />
Sono circa 15 anni che presto servizio, ancora con loro e con molti altri<br />
colleghi, che nel frattempo si sono aggiunti al nostro primordiale team, in un<br />
centro di PMA nella città in cui vivo e lavoro.
Fatte le opportune premesse voglio spiegare come questa mia tesi<br />
rappresenti il mio diario di bordo ed ogni suo capitolo racchiuda in sé la mia vita<br />
lavorativa, e non solo.<br />
Nel primo e secondo capitolo sono stati analizzati gli aspetti bio-medici<br />
relativi alla sterilità di coppia , importanti al fine di condurre la coppia, in modo<br />
professionale e scrupoloso, durante un percorso lungo e faticoso.<br />
Nel terzo capitolo, fulcro della mia tesi, ho evidenziato l’importanza di una<br />
psicologia “impegnata” in un campo così importante e non privo di innumerevoli<br />
difficoltà.<br />
Questa consapevolezza nasce anche dall’aver constatato in questi 15 anni<br />
l’importanza di seguire le coppie, non solo da un punto di vista, assai importante,<br />
medico-biologico, ma di accompagnarle come persone nella loro totalità psico-<br />
fisica.<br />
Nel quarto capitolo ho voluto fare una trait d’union tra tre aspetti<br />
fondamentali, quelli della bioetica, della sessualità e del diritto, nella convinzione<br />
che una buona sessualità vada vissuta nel rispetto e nella complementarietà dei<br />
soggetti coinvolti: la donna, l’uomo e il futuro bambino.<br />
Questo è stato e sarà sempre il life- motive della mia attività: aiutare in<br />
modo rigorosamente scientifico, ma soprattutto largamente umano, i due che<br />
diverranno tre nell’assoluto, oserei dire “sacro”, rispetto della vita.<br />
110
111