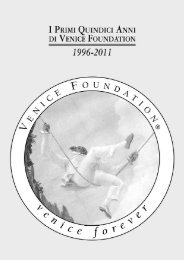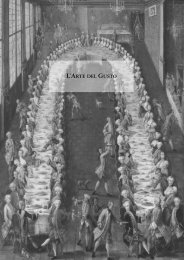NEWS N. 24 - The Venice International Foundation
NEWS N. 24 - The Venice International Foundation
NEWS N. 24 - The Venice International Foundation
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
[157-158] Impiraresse a Castello<br />
negli anni sessanta e, a destra, un<br />
fiore di conterie.<br />
Come lei stessa ha spiegato, per fare<br />
questi fiori si parte dalla s e s s o l a, antico<br />
contenitore di legno a forma di<br />
scatola, riempita di perle che le scaltre<br />
mani delle i m p i r a r e s s e con abile<br />
velocità infilano su fili di ferro sottili.<br />
All’inizio i lavori venivano fatti<br />
avvalendosi di incorniciature di ferro<br />
riempite orizzontalmente o verticalmente<br />
con fili di perle, sfumati nei<br />
colori, secondo i fiori prescelti. Con<br />
il passare del tempo, dalla metà circa<br />
dell’Ottocento, la lavorazione dei<br />
fiori viene semplificata, adottando un altro metodo. Si separano fin<br />
dall’inizio, lungo il filo, perle in numero esatto per l’a n i m a della foglia;<br />
poi a seconda della forma del petalo si dispone il filo in semicerchi<br />
concentrici a formare una spirale e si ferma<br />
sia nella parte alta che in quella bassa con<br />
uno o più giri, a seconda dell’effetto voluto,<br />
petalo dopo petalo, tono dopo tono.<br />
Composto il fiore, esso viene fissato<br />
allo stelo insetato su di un lungo<br />
ferro, così sboccia nel fiore voluto.<br />
Oggi la tradizione dei fiori di perle è<br />
tenuta in vita con successo dalla nipote di<br />
Nella, Giovanna Poggi Marchesi.<br />
Tavoli veneziani alle corti imperiali*<br />
ROBERTO DE FEO<br />
Alla caduta del dominio napoleonico la vice-capitale del<br />
Regno Italico, Venezia, con tutto il suo territorio, passava<br />
per la seconda volta alla corona austriaca. Il nuovo regime<br />
comportò ben pochi cambiamenti effettivi all’interno dell’assetto<br />
artistico locale, sovrinteso dall’Imperial Regia Accademia di Belle<br />
Arti. In laguna il gusto neoclassico, che già da qualche decennio<br />
aveva dettato la comune grammatica del mondo occidentale, si era<br />
imposto a fatica e solamente dagli ultimi anni del XVIII secolo, superando<br />
quella tenace corrente rococò che aveva dato al mondo veneziano<br />
la sua ultima splendida e autonoma stagione artistica, soprattutto<br />
grazie ai Tiepolo e alla loro scuola. I mutamenti politici<br />
in atto: la caduta della Serenissima per opera di Bonaparte nel<br />
1797, la prima dominazione austriaca (1797-1806), la successiva<br />
francese (1806-1814) e l’avvio del secondo governo asburgico videro<br />
essenzialmente un unico faro brillare, quasi sempre a distanza,<br />
sulle “Arti Sorelle”: Antonio Canova.<br />
Durante il secondo decennio dell’Ottocento, e oltre, Venezia<br />
versava in uno stato di depressione economica causata dai precedenti<br />
blocchi navali ed epidemie di peste e tifo che il nuovo governo<br />
del Regno Lombardo Veneto non era riuscito a risanare. È sulla<br />
base di queste premesse che il presidente dell’Accademia conte<br />
Leopoldo Cicognara, in occasione delle quarte nozze dell’imperatore<br />
Francesco I d’Austria con Carolina Augusta di Baviera nel novembre<br />
1816, chiese e ottenne di poter convertire il tributo richie-<br />
sto al territorio veneziano – diecimila<br />
zecchini – in commissioni<br />
di opere d’arte.<br />
L’iniziativa non avrebbe ottenuto<br />
esito positivo se anche Canova, con gesto munifico, non avesse<br />
fornito il marmo della Musa Polimnia. Cicognara ottenne, pure tramite<br />
Canova, che i migliori allievi e artisti dell’Accademia eseguissero<br />
una serie di opere allusive alle nozze e alla funzione di<br />
buon governo dei sovrani austriaci. Un volume in folio, edito nel<br />
1818 in due edizioni con tiratura limitata di 602 esemplari e intitolato<br />
Omaggio delle Provincie Venete alla Maestà di Carolina Augusta<br />
Imperatrice d’Austria, raccolse le incisioni tratte dalle opere.<br />
I manufatti dovevano servire per decorare l’appartamento della<br />
nuova sovrana alla Hofburg e comprendevano, oltre alla P o l i m n i a,<br />
pitture di Giovanni De Min, Francesco Hayez, Lattanzio Querena e<br />
di Liberal Cozza, vedute di Giuseppe Borsato e Roberto Roberti; le<br />
sculture Chirone ammaestra Achille di Rinaldo Rinaldi e il G i u r a<br />
mento di Annibale di Angelo Pizzi con la collaborazione di Bartolomeo<br />
Ferrari; due vasi ornamentali modellati, con leggere varianti,<br />
sul famoso antico Vaso Borghese; due are di Bartolomeo Ferrari ispirate<br />
alle due basi di candelabro del Museo Archeologico Nazionale<br />
di Venezia, già in collezione Grimani; lavori di oreficeria del vicentino<br />
Bartolomeo Bongiovanni. Chiudeva il cospicuo nucleo un sontuoso<br />
tavolo ideato da Borsato, presentato nell’O m a g g i o con queste<br />
parole: “Tavola di smalti e bronzi [...] Si limita il presente lavoro ad<br />
offrire sopra un piano di Smalti variamente lavorati e contesti ciò<br />
che rimane ancora di puramente indigeno della veneta arte vetraria:<br />
e piacerà riconoscere come possano imitarsi le preziose e peregrine<br />
produzioni della Natura e le più belle pietre ornamentali. Il diligente<br />
meccanismo della ruota pose ogni solerzia nella minutezza e<br />
precisione degli intagli di tali materie durissime; acciò più appariscente<br />
e decorativo riuscisse quest’omaggio veramente nazionale, la<br />
Toreutica e la Scultura vi hanno aggiunto col mezzo della fusione e<br />
del cesello i rilievi in bronzo, che sorreggono la tavola, prestandosi<br />
vicendevolmente soccorso le più nobili arti inventrici e le meccaniche<br />
discipline. Il lavoro di smalti e vetrificazioni è stato eseguito<br />
nelle Officine del Sig. Benedetto Barbaria di Venezia. L’ i n v e n z i o n e<br />
è del Sig. Giuseppe Borsato, Professore nella R. Accademia di Venezia;<br />
i bronzi fusi e cesellati sono opera del Sig. Bartolomeo Bongiovanni<br />
di Vicenza, e le meccaniche concessioni e l’insieme del Sig.<br />
Giacomo Bazzani di Venezia meccanista stipettaio”.<br />
Si deve a Giuseppe Dala l’incisione che illustrava il pezzo<br />
straordinario, riportandone l’esatta intitolazione: Tavola contesta di<br />
Smalti legati in oro e argento sorretta da un Tripode di Bronzi dorati.<br />
Una seconda versione, realizzata da<br />
Marco Comirato, fu inclusa nell’Ope -<br />
ra ornamentale, famoso volume apparso<br />
in due diverse edizioni nel<br />
1831 che raccoglieva il meglio della<br />
creatività decorativa di Borsato.<br />
Benché l’immagine sia stata ripro-<br />
dotta in numerosissime pubblicazioni<br />
sul mobile ottocentesco, il tavolo<br />
vero e proprio risultava disperso fino<br />
[159] Roberto Roberti, La corte<br />
austriaca al ponte di Rialto, 1817.<br />
[160] Incisione di Giuseppe Dala<br />
che raffigura il tavolo di Borsato.